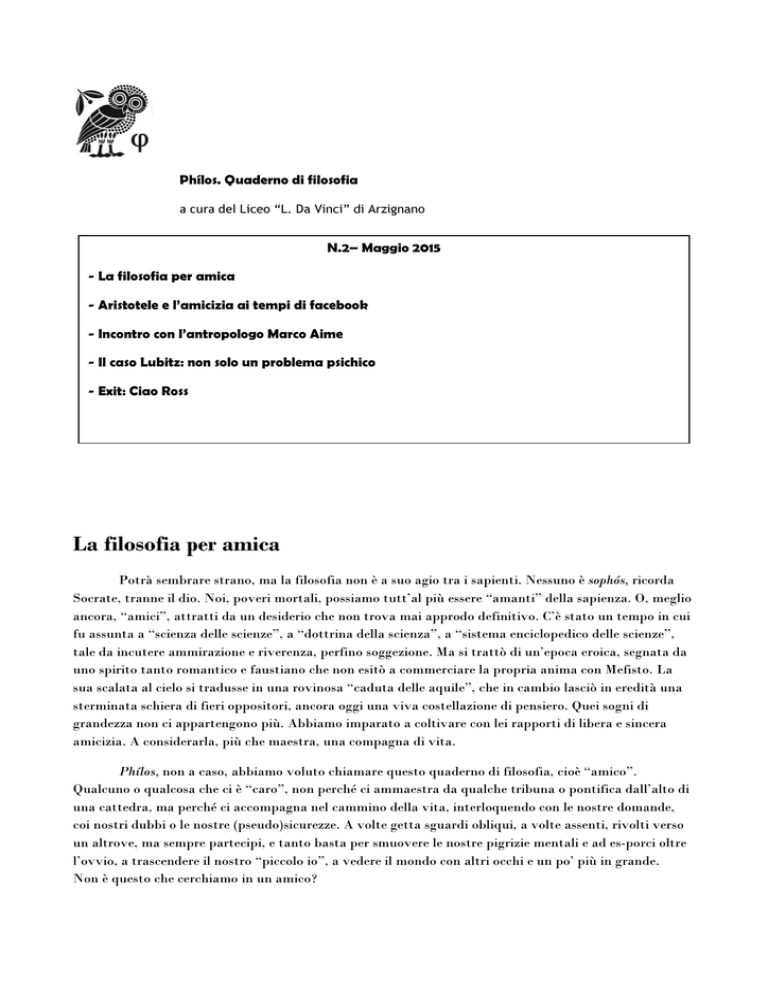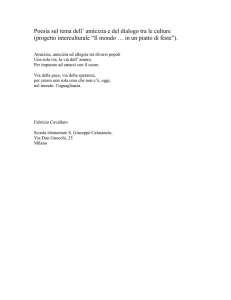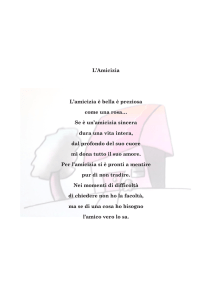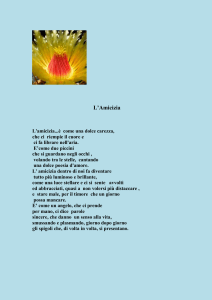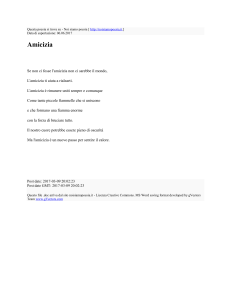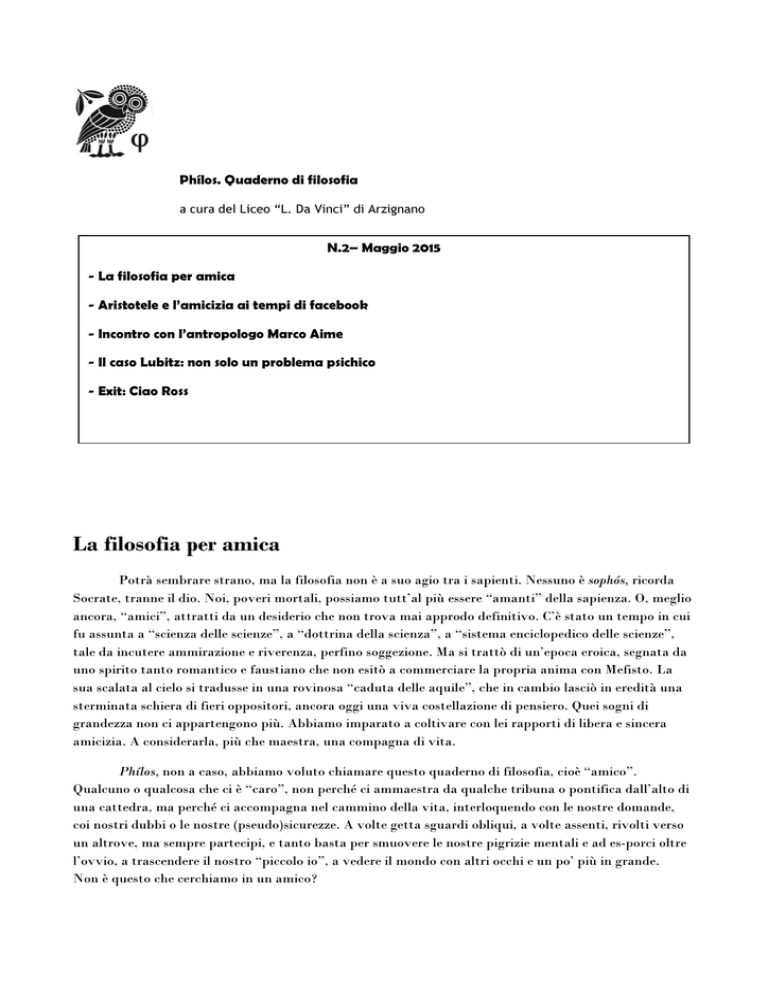
Phílos. Quaderno di filosofia
a cura del Liceo “L. Da Vinci” di Arzignano
N.2– Maggio 2015
- La filosofia per amica
- Aristotele e l’amicizia ai tempi di facebook
- Incontro con l’antropologo Marco Aime
- Il caso Lubitz: non solo un problema psichico
- Exit: Ciao Ross
La filosofia per amica
Potrà sembrare strano, ma la filosofia non è a suo agio tra i sapienti. Nessuno è sophós, ricorda
Socrate, tranne il dio. Noi, poveri mortali, possiamo tutt’al più essere “amanti” della sapienza. O, meglio
ancora, “amici”, attratti da un desiderio che non trova mai approdo definitivo. C’è stato un tempo in cui
fu assunta a “scienza delle scienze”, a “dottrina della scienza”, a “sistema enciclopedico delle scienze”,
tale da incutere ammirazione e riverenza, perfino soggezione. Ma si trattò di un’epoca eroica, segnata da
uno spirito tanto romantico e faustiano che non esitò a commerciare la propria anima con Mefisto. La
sua scalata al cielo si tradusse in una rovinosa “caduta delle aquile”, che in cambio lasciò in eredità una
sterminata schiera di fieri oppositori, ancora oggi una viva costellazione di pensiero. Quei sogni di
grandezza non ci appartengono più. Abbiamo imparato a coltivare con lei rapporti di libera e sincera
amicizia. A considerarla, più che maestra, una compagna di vita.
Phílos, non a caso, abbiamo voluto chiamare questo quaderno di filosofia, cioè “amico”.
Qualcuno o qualcosa che ci è “caro”, non perché ci ammaestra da qualche tribuna o pontifica dall’alto di
una cattedra, ma perché ci accompagna nel cammino della vita, interloquendo con le nostre domande,
coi nostri dubbi o le nostre (pseudo)sicurezze. A volte getta sguardi obliqui, a volte assenti, rivolti verso
un altrove, ma sempre partecipi, e tanto basta per smuovere le nostre pigrizie mentali e ad es-porci oltre
l’ovvio, a trascendere il nostro “piccolo io”, a vedere il mondo con altri occhi e un po’ più in grande.
Non è questo che cerchiamo in un amico?
Aristotele e l’amicizia ai tempi di facebook
Federica Selmo (3^E2)
“Senza amici nessuno sceglierebbe di vivere, anche se possedesse tutti gli altri beni”. Da questa
citazione di Aristotele (Etica nicomachea, VIII, 1155a), possiamo comprendere quanta importanza egli
attribuisse alla philía (il termine greco ha un significato molto più ampio dell’italiano “amicizia”, perché
comprende tutte le forme di legame affettivo, come ad esempio anche quello tra genitori e figli).
Il filosofo affermava che l’amicizia può essere fondata sull’utile, sul piacere o sul bene, cioè sul
volere il bene dell’altro in maniera disinteressata. Solo a quest’ultima condizione l’amicizia può dirsi
veramente tale. Inoltre gli amici veri sono pochi, poiché le amicizie hanno bisogno di tempo, della
consuetudine di una vita in comune per poter crescere nell’intimità del rapporto. Infatti “il desiderio di
amicizia sorge rapidamente, ma l’amicizia no”. Bisogna che sia consumata una certa “quantità di sale” –
aggiunge Aristotele – per poter dire davvero di conoscersi reciprocamente ed essersi manifestati degni di
essere amati.
Che cosa direbbe oggi Aristotele, vedendo che molte persone creano, o pensano di creare, rapporti
di amicizia su facebook? La maggior parte dei ragazzi vanta all’incirca più di mille “amici” su facebook –
ma possono veramente essere considerati tali? L’amicizia richiede tempo, continuità, costanza. Non si
può pensare di creare un legame con un clic a distanza, tramite messaggi, perché ciò che lega le persone
sono le esperienze fatte insieme, il conoscersi meglio giorno per giorno, ma ciò non è possibile sui social.
Non abbiamo tempo di dedicare tanto spazio a tutte le persone che “conosciamo”. Per questo i veri amici
sono pochi, il resto sono, appunto, solo dei “conoscenti”.
Ma ai giorni nostri l’amicizia – su che cosa è basata? Usciamo con gli amici per svagarci, per
parlare, per divertirci. E’ questa la vera amicizia? Secondo Aristotele non lo è. Dura lo spazio di una
serata, è tutto molto piacevole, ma … il piacevole è capriccioso, varia come le nuvole in cielo e, com’è
noto, “una rondine non fa primavera”. Oggi va così, domani non si sa. Non ha niente di stabile, niente
che abbia il carattere stabile della virtù, che si acquisisce con l’esperienza in comune.
L’amicizia si basa inoltre sull’uguaglianza tra gli individui. L’amico, in fondo, è un altro sé stesso.
Potrà esserci allora amicizia tra un maschio e una femmina? A sentire Aristotele, parrebbe di no, perché
in questo tipo di rapporti affettivi entrano in gioco fattori emotivi e sessuali che li rendono ben poco
disinteressati – e allora le cose si complicano.
Posso però affermare che l’amicizia è davvero importante. Le persone hanno bisogno di vivere in
società e l’esperienza dell’amicizia è la scuola migliore per imparare a relazionarci e a migliorarci come
persone. Insieme possiamo mirare a obiettivi che da soli non riusciremmo a raggiungere. Io credo
fermamente che l’amicizia sia qualcosa di indispensabile per crescere.
***
Elena Cazzanello (3^E2)
Tutti hanno bisogno di un amico, di una persona capace di rendere la vita bella e degna di essere
vissuta. Aristotele ha sostenuto con forza questo pensiero ed è impossibile dargli torto, soprattutto in un
tempo, come il nostro, in cui la società ha creato giovani sempre più malleabili, sempre più fragili.
L’amicizia aiuta ad essere più forti, a credere in sé stessi e all’amore che ci circonda. E’ una cosa
necessaria alla vita, un’esperienza dalla quale ricavare nuovi insegnamenti da mettere nel bagaglio delle
conoscenze.
Il filosofo sopra citato affermava che ci sono diverse specie di amicizia, cha vanno da un rapporto
fondato su un vantaggio o su qualcosa di piacevole, a un rapporto costruito invece su valori duraturi e
significativi e quindi basato su un qualcosa di stabile. Egli però non avrebbe mai immaginato che con il
passare del tempo si sarebbe formata una nuova tipologia di amicizia, ovvero quella virtuale. Al giorno
d’oggi diventare amico di qualcuno è la cosa più facile e immediata del mondo. Con un semplice clic hai
la possibilità di condividere ogni singolo aspetto della tua vita con qualcuno che nemmeno conosci, o
addirittura con chi vive a migliaia di chilometri di distanza da te. Quest’innovazione non convincerebbe
Aristotele, e nemmeno me. L’amicizia nasce dalla vicinanza, dallo stare insieme e dallo scambio
continuo. Come si può costruire qualcosa di saldo se a unire le persone è uno schermo colorato di pixel?
Che dialogo ci può essere? Spesso si tende a scegliere la strada più facile da percorrere, ma nella vita non
tutto ciò che ha valore coincide col facile e, soprattutto in casi come questi, con la fatica si ottengono
risultati più grandi e soddisfacenti. I veri rapporti d’amicizia non si instaurano premendo un minuscolo
tasto sulla tastiera, ma conoscendo la persona che sta al nostro fianco. Inoltre non è necessario avere
centinaia di amici ignoti, sconosciuti, perché si può dare intensamente affetto soltanto a pochi.
Sostengo pienamente questa riflessione di Aristotele, perché non credo che sia possibile legarsi
con tutti quelli che capitano. Il filosofo ci ricorda anche che l’amicizia dev’essere fondata
sull’uguaglianza fra gli individui, i quali devono essere accomunati da un carattere positivo e da una gran
voglia di vivere e di sorridere. Pur essendo una forma d’amore, quest’ultima non va intesa strettamente
come tale, ma come un legame basato sul bene e sul volere il bene dell’altro in sé. Penso, in conclusione,
che l’amicizia ci renda persone migliori, perché ci aiuta ad essere disponibili e altruisti, ma soprattutto ci
insegna a volere bene. Mi piacerebbe avere Aristotele come amico, perché so che sarebbe una persona
sulla quale poter contare.
Incontro con l’antropologo Marco Aime:
il viaggio, il corpo e i riti di passaggio
Greta Micheletto (4^E1)
“Il mondo è come un libro e chi non viaggia legge sempre la stessa pagina”
sant’ Agostino
E' con questa frase che inizia l'incontro con l'antropologo Marco Aime, che, nel suo libro “La
mente del viaggiatore”, affronta il tema del viaggio.
Il viaggio è la rottura dalla routine quotidiana, è qualcosa che interrompe le nostre abitudini e ci porta a
scoprire e a percepire qualcosa di nuovo. Il viaggio ci insegna a metterci in discussione, a interrogare noi
stessi sulla nostra quotidianità mettendoci in confronto con culture, e quindi con stili di vita, totalmente
diversi dalla nostra. Una volta partiti,entrando in contatto con tradizioni e usanze diverse, cambiamo il
nostro punto di vista che ci porta a ritenere giusto qualcosa che prima consideravamo sbagliato.
L'esperienza del viaggio ci induce a porci delle domande (ad esempio in Africa utilizzano parole diverse
per differenziare lo zio paterno da quello materno, mentre in Italia usiamo ugualmente la parola “zio”),
e quando torniamo a casa, dopo aver sentito sulla nostra pelle esperienze diverse, assumiamo un
atteggiamento più critico sulle nostre abitudini e sui nostri modi di fare. Possiamo quindi suddividere
l'esperienza del viaggio in tre fasi: la partenza (rottura dell'abitudine), il transito (cambiare punto di
vista) e l'approdo (tornare a casa).
In antropologia il viaggio è fondamentale poiché ci permette di conoscere realtà diverse, ma un
altro importante strumento per l'antropologo è il corpo. Il corpo è ciò che si nota al primo impatto, è
l'elemento visibile di una persona, è la pagina bianca su cui noi scriviamo per necessità. Ogni persona,
infatti, avverte l'esigenza di modificarsi, ad esempio con tatuaggi e scarificazioni, oppure facendo
palestra. Questa necessità dipende anche dalla cultura di appartenenza e dalla religione, come nel caso
delle infibulazioni e circoncisioni. Le diverse culture inoltre stabiliscono quali parti del corpo devono
essere coperte e quali invece possono essere scoperte.
Un altro argomento interessante, raccontato dall'antropologo, è stato quello riguardante la
magia. La magia ha la capacità di dare risposte a domande a cui l'uomo non è in grado di rispondere,
come la morte di un bambino o un qualsiasi evento spiacevole. Potremmo paragonare alla magia il
mondo della finanza: quando si tratta di risolvere problemi economici, solitamente si investe il denaro in
borsa per farne crescere il rendimento, così è la magia che tenta di risolvere problemi in modo misterioso
e a volte ingannevole.
***
Ylenia Pretto (4^E1)
Dall’incontro svoltosi il giorno 12 Marzo 2015 con l’antropologo e scrittore italiano Marco Aime
(Torino, 4 nov. 1956), docente di antropologia culturale presso l’università di Genova, abbiamo avuto
modo di trattare alcuni temi dell’universo dell’antropologia: il viaggio e il corpo, connesso quest’ultimo
alle modificazioni corporali che avvengono attraverso i cosiddetti “riti di passaggio”. Il suo intervento
inizia con le parole di sant’Agostino: “ Il mondo è come un libro e chi non viaggia legge sempre la stessa
pagina.”
Da qui emerge subito tutta l’importanza formativa del viaggio: dal momento in cui si viaggia,
infatti, si mette in discussione se stessi, i propri costumi, le proprie abitudini, si è in qualche modo
costretti a riflettere su ciò che siamo. Affinché ciò si realizzi è però necessario assicurarsi che l’uomo, nel
momento in cui si mette in viaggio, “abbia lasciato a casa se stesso”. Un aneddoto racconta di come un
giorno Seneca, rivolgendosi ad un battelliere, lo ammonì con queste parole: “Quando tu carichi un uomo,
assicurati che non si porti con sé”. Riflettendo su questa affermazione ci rendiamo conto di come sia
necessario “avere una mente libera” prima di mettersi in viaggio. Il viaggiatore che andando a visitare
un villaggio africano si meravigliasse troppo delle lunghe formule di saluto (quasi un rituale) che il capotribù gli offre, fino al punto di biasimarle e schernirle, incorrerebbe in quello che in antropologia si
chiama “etnocentrismo” (espressione del sociologo americano William G. Sumner, con cui si indica la
tendenza a considerare la cultura di appartenenza come unico punto di riferimento per valutare le altre),
atteggiamento che per molto tempo si è combattuto nel mondo.
Nel viaggio distinguiamo tre fasi: la partenza, il transito e l’arrivo. La partenza è vista come momento di
cesura, quando l’uomo deve prepararsi a nuove esperienze, nuovi sapori, nuovi odori (il viaggio è infatti
in primo luogo esperienza dei sensi ed è proprio l’olfatto il primo senso coinvolto nel ricevere segnali
quando ci troviamo in un posto nuovo). Segue un momento di movimento, durante il quale cambia il
nostro modo di leggere il mondo alla luce delle nuove esperienze; infine c’è l’arrivo, che può coincidere
con il ritorno a casa. È proprio in seguito a questo ritorno che l’antropologo riflette “sugli altri” (i popoli
incontrati per un tempo prolungato) per comprendere meglio “se stesso” (gli occidentali).
Talvolta il senso del viaggio può assumere un significato simbolico, come quando si parla di
esperienza di passaggio da uno status ad un altro, superiore, sancito attraverso i “riti di passaggio”
(espressione dell’antropologo francese Arnold Van Gennep, 1873-1957), rituali che segnano il
cambiamento di un individuo da uno status socio-culturale ad un altro.
Nel corso del rituale il singolo abbandona i vecchi costumi, rompe con la consuetudine, passa per un
momento di transizione durante il quale avviene la vera e propria prova (spesso di carattere fisico come
nuotare a grandi profondità o venire percossi sulla schiena senza mostrare segni di dolore), per entrare
infine nella nuova società. Vi sono ovviamente differenze nel modo di sentire e di vivere questi riti,
accompagnati da cerimonie, presenti anche nella società occidentale: i diciott’anni, la maturità, la laurea,
una volta anche il servizio di leva (per i maschi), il menarca e la menopausa (per le donne), la nascita e la
morte, o ancora il matrimonio segnano dei passaggi che, seppur vissuti in maniera individualizzata, ci
accomunano.
I riti di passaggio possono essere legati anche a prove che consistono in modificazioni artificiali
del corpo, come la circoncisione o l’infibulazione o, nelle forme più leggere, la pratica delle pitture
facciali, corporali o dei tatuaggi.
Quella di modificare il corpo è un’esigenza sentita da tutti i popoli, nessuno infatti lascia il corpo così
com’è, naturale. Lo stesso Marco Aime infatti ci invita a dubitare di fronte all’espressione “corpo
naturale”: quanto naturale può essere un corpo su cui, nella nostra società di oggigiorno, si applicano
cosmetici per correggere difetti o per migliorarsi, si regola il taglio di capelli e si modifica il colore della
carnagione in base ai canoni vigenti (la pelle chiara nel passato, quando ad essere abbronzati erano solo i
lavoratori nei campi, scura oggi, perché indicativa di aver frequentato posti esotici grazie al proprio
benessere economico)? Il concetto di bellezza legato al corpo risponde quindi a dei cambiamenti che
hanno luogo nella storia. Così i canoni di bellezza del secondo dopoguerra vedevano come modello
femminile una donna in carne, dalle forme prosperose, epoca, quella, in cui si soffriva ancora la fame.
Oggi il processo sembra essersi invertito: in una società che produce troppo, come la nostra, l’ideale di
bellezza femminile è la donna magra, quasi anoressica.
Il corpo è quindi un foglio bianco su cui possiamo scrivere a nostro piacere, pensiamo per esempio
ai tatuaggi, pratica nata in Nuova Zelanda presso i maori (“tatuaggio” deriva infatti da “tatau” che in
maori significa “punzecchiare” con ago e polvere di carbone), per identificare i membri di uno stesso
gruppo. In seguito il tatuaggio si diffonde perdendo il suo significato rituale; fra coloro che ne fecero uso
ci furono i marinai, in seguito alle navigazioni in segno di sopravvivenza. In molti casi poi divenne una
specie di marchio d’infamia per i carcerati e i detenuti presso i campi di concentramento. In Giappone il
tatuaggio torna ad avere uno scopo decorativo, mantenuto fino ai nostri giorni quando la pratica di
decorare il corpo è sentita come un vero e proprio must.
Il caso Lubitz: non solo un problema psichico
Una riflessione in classe 4^E1
“Un giorno tutti conosceranno il mio nome”. Sono le parole che Andreas Lubitz, il copilota sui/pluricida della Germanwings, confidò alla sua ex fidanzata. Quel giorno è arrivato e oggi tutti conosciamo
quel nome, e quello che ci sta(va) dietro. Ci sta dietro un giovane 27enne con uno smisurato sogno di
grandezza, minato alla radice da precarie condizioni psico-fisiche, nascoste a tutti per non compromettere una folgorante carriera. Ci sta dietro il delirio di onnipotenza di un piccolo dio malato, pilota-padrone di molte vite, che quelle vite scarica e cancella trascinandole con sé nel baratro. Ci sta dietro la
potenza tecnologica, capace di trasformare e moltiplicare un disagio individuale in una tragedia
collettiva. Come infatti è accaduto quel maledetto 24 marzo scorso, quando il volo, con 150 persone a
bordo, finì schiantato a 700 km all’ora sulle Alpi francesi. Ora, possiamo rafforzare tutti i sistemi di
sicurezza che vogliamo, ridurre al minimo i vuoti di controllo, ma – a meno di non fare completo
harakiri, affidando alle macchine stesse il completo dominio della macchina - al fondo resta la variabile
umana, sempre imprevedibile, l’insondabile abisso dell’animo umano, solo con sé stesso nella cabina di
comando.
Che dire? Mauro Magatti, sul Corriere della Sera del 28 marzo scorso: “ Al di là di tutto – scrive –
rimane la questione dell’educazione in un mondo altamente tecnicizzato. Se non vogliamo considerare
l’uomo semplicemente un problema, le nostre società devono tornare a dedicare più cura e più risorse alla
formazione dei giovani. Non basta formare bravi tecnici, occorre, soprattutto, formare persone. Ma su
questo terreno, se vogliamo essere onesti, dobbiamo ammettere che negli ultimi anni sono stati fatti dei
passi indietro”.
Sulla stampa, in questi stessi giorni, divampa la discussione sulla crisi del liceo classico e, in
generale, degli studi umanistici. C’è chi sostiene che, invece di studiare (o perdere tempo) con l’aoristo o
la perifrastica passiva, sarebbe più proficuo conoscere i mitocondri. Chi, a sua volta, propone di studiare
la logica invece del latino. La scelta dell’indirizzo e delle materie di studio dovrebbe essere fatta quindi in
base alla loro utilità. Di questo passo, ironizza qualcuno, potremmo arrivare a concepire un liceo che
insegna come cambiare gli pneumatici, invece della letteratura.
“In realtà – scrive Umberto Galimberti su la Repubblica del 7 marzo scorso – fino a 18 anni le
scuole, tutte le scuole, non sono scuole di avviamento al lavoro, ma scuole di formazione. Si tratta cioè di
formare l’uomo prima di insegnargli abilità o competenze che si possono acquisire tranquillamente nelle
specialità universitarie, perché un medico che non è un uomo, un ingegnere che non è un uomo, un
economista che non è un uomo, non faranno mai bene il loro lavoro. E qui mi pare di poter dire che gli
studi umanistici sono i più idonei a formare l’uomo e a insegnargli, come a più riprese ricorre nei testi
greci e latini, cos’è giusto, cos’è bello, cos’è buono, cos’è vero, cosa significano sofferenza, dolore,
disperazione, morte. Ma anche gioia, coraggio, ideazione, utopia, gusto per la ricerca e, mi si permetta di
dire, anche “figure della felicità”, perché se non si conoscono questi scenari, che solo la cultura
umanistica sa insegnare, come si fa a pensare che un uomo possa fare bene il mestier suo, senza aver ben
radicato dentro ciò che fa di un uomo, prima e a sostegno delle sue competenze, un uomo?”. La cultura
umanistica – aggiungiamo noi - non fa cose, è vero, ma fa gli uomini che fanno le cose. E il compito più
importante – ricorda Galimberti – è diventare umani.
Da questo punto di vista, il caso Lubitz rischia di essere troppo facilmente derubricato a mera
“problematica psichica” - megalomania, depressione, frustrazione – o a problemi generali di formazione
(la scuola - sempre chiamata in causa, salvo essere continuamente bastonata). C’è qui un ordine del
discorso che viene completamente trascurato, il discorso di natura etica. Quel giovane forse non era solo
malato, ma anche ragionava male, o non ha mai imparato a ragionare dal punto di vista morale. A meno
di non considerare la “ragion pratica” un inutile orpello, si deve ammettere che lì forse c’è la chiave di
tanti comportamenti assurdi o sbagliati, poiché spesso il male è pensare male, e la prima automedicazione
– peraltro gratuita e senza controindicazioni - è l’uso corretto del proprio pensiero.
Prendiamo ad esempio l’insegnamento di Kant. Come posso riconoscere se il mio agire è
moralmente corretto, cioè universalmente valido? Facile, basta leggere la prima formula dell’imperativo
categorico: “Agisci in modo che la massima della tua volontà possa sempre valere nello stesso tempo come
principio di una legislazione universale”. Che tradotto vuol dire: prova a vedere se quello che stai facendo,
puoi volere che lo facciano tutti gli altri per legge universale di natura. Si tratta del “test della
generalizzabilità”. Stai dicendo una menzogna: puoi volere che tutti siano bugiardi con te? Stai rubando:
puoi volere che tutti rubino, le tue cose comprese? Stai passando al semaforo col rosso: puoi volere che
tutti passino col rosso? Impossibile: dovresti diffidare di chiunque ti passi accanto o incroci la tua strada.
La tua stessa vita sarebbe continuamente esposta al pericolo. Ora, puoi volere che tutti muoiano con te,
seguendo il tuo personale desiderio di toglierti la vita? Impossibile: l’amor di sé che sopprime sé stesso è
in netta contraddizione con quello stesso principio – il conatus sese conservandi di Spinoza - che per
natura vuole la vita, anziché distruggerla. Se il suicidio che vuoi per te non è giustificato, a maggior
ragione non puoi volerlo per tutti gli altri, è contro ogni legge di natura. E la seconda formula
dell’imperativo categorico precisa appunto che occorre agire “in modo da trattare l’umanità, sia nella tua
persona sia in quella di ogni altro, sempre anche come fine e mai semplicemente come mezzo”. Lubitz ha
perso il senso della sua umanità nel momento stesso in cui ha voluto cancellare quella di tutti gli altri che
dipendevano da lui, dalle sue scelte, facendone solo un mezzo del suo (macabro) sogno di grandezza. Forse
non se ne è reso conto: il suo ego non conosceva misura, la misura dell’umanità che è in ogni uomo. Il suo
nome ora risplende su tutti, sì, ma nel cielo cupo dell’orrore e – possiamo ben aggiungere - dell’ignoranza
(o analfabetismo) morale.
Exit
Avevi a ruffa i capelli,
gli occhi rubati al sonno,
l’ultima volta,
e una scarpa slacciata.
Ma che importa,
la vita ha ben altre urgenze,
l’amore che graffia,
la musica che scalpita,
geme dentro le vene, e galoppa
come spirito zingaro
per le vie desolate
e mai sazie del cuore.
Perché è sempre
un appuntamento mancato
questo nostro dolore.
Ma ti bastava “una lacrima sul viso”
o un “la sai l’ultima?”
per cominciare col sorriso
un’altra giornata.
Mai potrà avere
quella piega sul volto
a luna saracena la pallida
stupida morte.
Matto d’un Ross,
quanto ci mancherai.