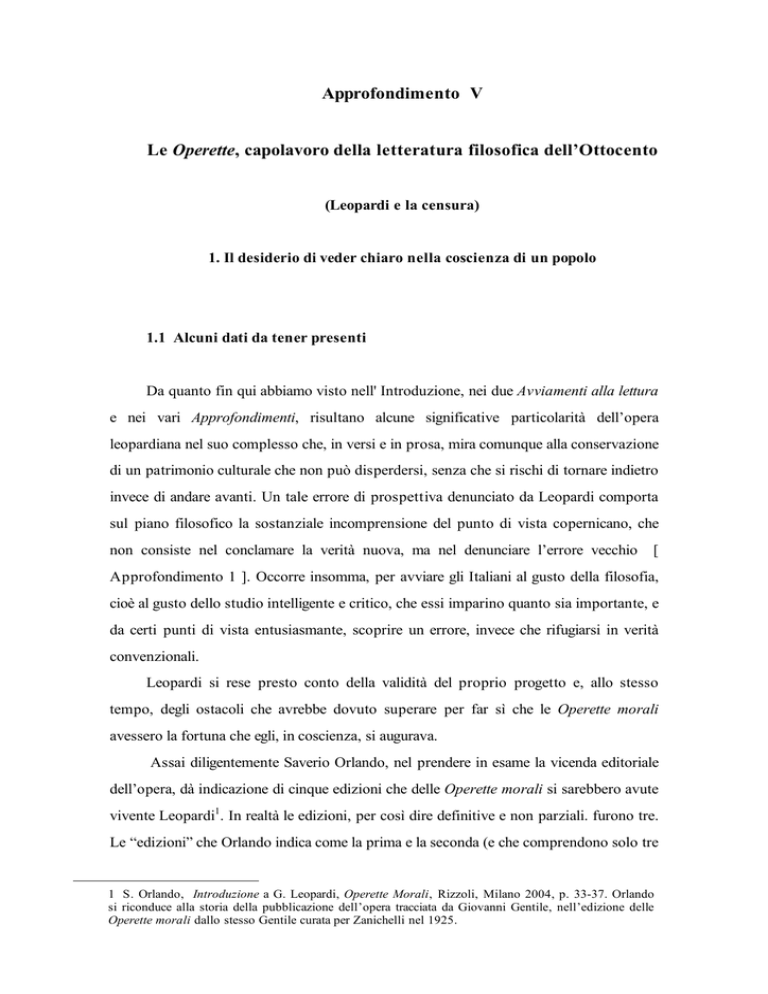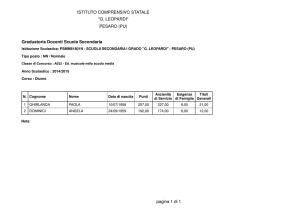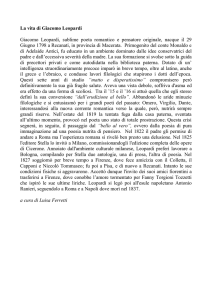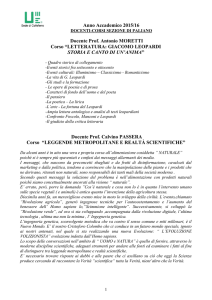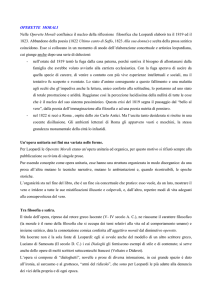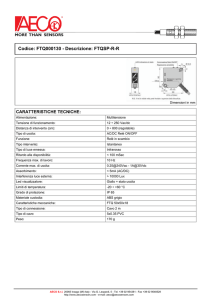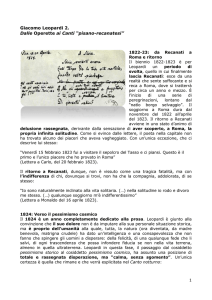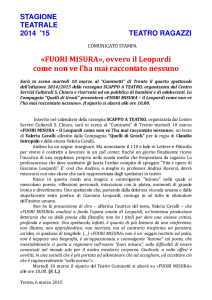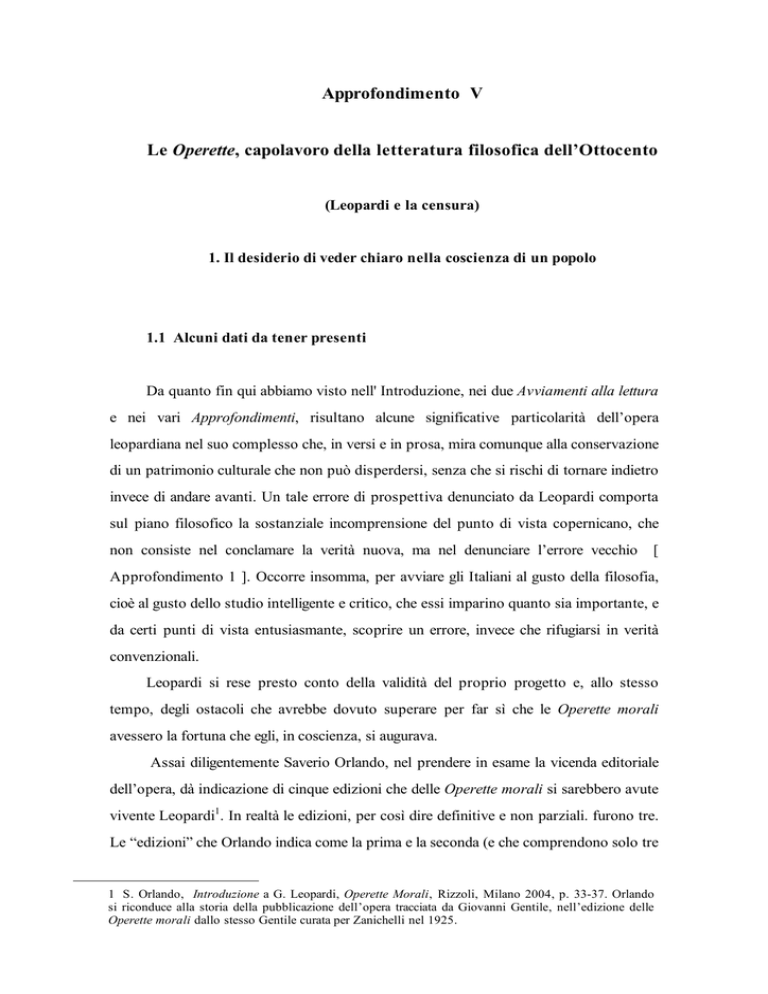
Approfondimento V
Le Operette, capolavoro della letteratura filosofica dell’Ottocento
(Leopardi e la censura)
1. Il desiderio di veder chiaro nella coscienza di un popolo
1.1 Alcuni dati da tener presenti
Da quanto fin qui abbiamo visto nell' Introduzione, nei due Avviamenti alla lettura
e nei vari Approfondimenti, risultano alcune significative particolarità dell’opera
leopardiana nel suo complesso che, in versi e in prosa, mira comunque alla conservazione
di un patrimonio culturale che non può disperdersi, senza che si rischi di tornare indietro
invece di andare avanti. Un tale errore di prospettiva denunciato da Leopardi comporta
sul piano filosofico la sostanziale incomprensione del punto di vista copernicano, che
non consiste nel conclamare la verità nuova, ma nel denunciare l’errore vecchio
[
Approfondimento 1 ]. Occorre insomma, per avviare gli Italiani al gusto della filosofia,
cioè al gusto dello studio intelligente e critico, che essi imparino quanto sia importante, e
da certi punti di vista entusiasmante, scoprire un errore, invece che rifugiarsi in verità
convenzionali.
Leopardi si rese presto conto della validità del proprio progetto e, allo stesso
tempo, degli ostacoli che avrebbe dovuto superare per far sì che le Operette morali
avessero la fortuna che egli, in coscienza, si augurava.
Assai diligentemente Saverio Orlando, nel prendere in esame la vicenda editoriale
dell’opera, dà indicazione di cinque edizioni che delle Operette morali si sarebbero avute
vivente Leopardi1. In realtà le edizioni, per così dire definitive e non parziali. furono tre.
Le “edizioni” che Orlando indica come la prima e la seconda (e che comprendono solo tre
1 S. Orlando, Introduzione a G. Leopardi, Operette Morali, Rizzoli, Milano 2004, p. 33-37. Orlando
si riconduce alla storia della pubblicazione dell’opera tracciata da Giovanni Gentile, nell’edizione delle
Operette morali dallo stesso Gentile curata per Zanichelli nel 1925.
dialoghi, cioè il Dialogo di Timandro e di Eleandro, il Dialogo di Cristoforo Colombo e
di Pietro Gutierrez e infine il Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare) sono
infatti un “assaggio” di quella che, realizzata nel ’27 dallo Stella, costituisce la prima vera
edizione delle Operette morali.
Non per questo devono trascurarsi quelli che abbiamo definito assaggi delle
Operette e che Orlando fa benissimo a prendere in considerazione, in ciò ripercorrendo,
magari con altre finalità, la via tracciata da Giovanni Gentile. Questi “assaggi” servono a
Leopardi per studiare, in vista dell’edizione completa, le reazioni del pubblico e della
censura. Non è neanche un caso che i tre dialoghi apparsi una prima volta sull’
“Antologia” di Firenze, venissero pubblicati nuovamente, a distanza di tre mesi, corretti
in alcuni punti, nel “Nuovo Ricoglitore” di Milano. Si tratta di un’operazione con cui lo
scrittore si accerta innanzitutto del favore che può incontrare presso il pubblico italiano
il genere del dialogo che da Platone, attraverso Cicerone, Luciano, gli umanisti e quindi gli
illuministi, è una costante della tradizione letteraria e culturale europea, da contrapporsi
utilmente al genere romanzo.
1.2 La questione della censura
Leopardi peraltro sa quel che sanno altri scrittori della sua epoca e innanzitutto
che la censura non fosse moderata perché, come scriveva Silvio Pellico al fratello Luigi
“essa lascia correre qualche volta alcune verità, ma solo nei volumi di grande spesa,
perché pochi li leggono, oppure inavvertitamente”2. Dal 1919, alla vigilia del “caso”
che si accenderà intorno al “Conciliatore” all’epoca in cui escono le Operette morali è
trascorso qualche anno ma su questo piano poche cose sono cambiate. Lo stesso
“Gabinetto Vieusseux”, animatore della vita culturale fiorentina e al quale farà
riferimento Leopardi, si era fatto promotore dell'Antologia”, per idealmente continuare
l'opera che Pellico e compagni avevano avviato col “Conciliatore”.
Perciò delle Operette morali, che non sono un libro di grande spesa e che si
ripromettono di fare un po’ di rumore in tutta Italia, appare un “assaggio” a Firenze e a
2 Lettera dell’agosto 1919 in Rinieri, Della vita e delle opere di Silvio Pellico, Torino, 1898, vol I, pp.
347-8.
Milano, su giornali di larga diffusione e “importanti”. Ciò comporta la possibilità di
dare alle stampe in tempi brevi un libro, sul quale si è creata un’atmosfera di attesa. Per
fare un po’ di rumore basta aggiungere con cautela qualche altro dialogo un po’ più
esplicito sul piano della critica all’ideologia del progresso e all’antropocentrismo,
attenuandone il sapore aspro con un po’ di ironia. Il progetto, per quanto possa far
venire un po’ di mal di pancia a qualche rigoroso censore, non può tuttavia essere
ostacolato più di tanto dalle stesse autorità di polizia. Leopardi aveva insomma studiato
bene le sue mosse.
Il punto è che proprio gli “amici di Toscana”, vale a dire quelli che avrebbero
dovuto aiutarlo a far passare il “messaggio”, ne attenuarono fortemente i toni
diffondendo la leggenda, così dura a morire, del pessimismo leopardiano.
Ci saranno però, a breve distanza di tempo l’una dall’altra, cioè rispettivamente
nel 1834 e nel 1835, l’edizione Piatti e l’edizione Starita. Come abbiamo già visto, a ogni
nuova edizione Leopardi compie, non senza problemi costituiti dalla difficoltà di aggirare
la censura, uno sforzo in più per farsi capire. Nell’edizione Piatti del 1834 figurano il
Dialogo di un Venditore di almanacchi e di un passeggere, nonché il Dialogo di Tristano
e di un Amico con cui, da allora in poi si chiude la raccolta delle Operette morali. Nella
edizione napoletana del 1835 per i tipi di Saverio Starita, e che è importante essendo
l’ultima apparsa vivente l’autore, è escluso il Dialogo di un Lettore di Umanità e di
Sallustio, mentre c’è una Notizia intorno a queste operette che non fa certo da
introduzione, trattandosi di una pura e semplice nota editoriale.
1.3 L’importanza delle Operette nella considerazione di Leopardi
Come spiegheremo più oltre, affrontando il tema relativo a Leopardi e alla censura,
l’ultima edizione delle Operette morali apparsa vivente l’autore, non ottenne il visto
della censura e fu pubblicata con l’espediente di modificarne il frontespizio. I “tagli” a
cui comunque l’autore si era dovuto adattare richiesero che in tempi migliori, cioè nel
1845, a otto anni dalla sua morte, il libro venisse ristampato a cura di Ranieri per la Le
Monnier di Firenze, in quella che sarà nel seguito utilizzata come base di riferimento per
tutte le successive.
E’ il suo stesso libro, nella forma definitiva in cui oggi lo leggiamo, a dare al lettore
la misura di quanto Leopardi tenesse a questa sua opera.
Nelle edizioni che precedono quella curata da Ranieri nel 1845 per l’editore Le
Monnier mancano alcune operette, assenti dalla raccolta per questioni legate alla censura.
Si tratta del Copernico e del Dialogo di Plotino e di Porfirio.
Abbiamo fin qui parlato di una struttura bipartita dell’opera che contrappone
moderni e antichi, struttura che l’opera ha fin dalla sua prima stesura. Ma abbiamo anche
parlato di un gruppo di Operette che chiudono il discorso e nelle quali appaiono delle
“maschere filosofiche”. E’ proprio in quest’ultima parte che, stillando il veleno
dell’ironia, Leopardi difende il proprio punto di vista, autoironizzando sull’opera svolta.
Sono alcune delle pagine più dense del libro e comportano delle difficoltà notevoli per
qualsiasi lettore, specialmente del lettore d’oggi che non abbia confidenza con la lingua di
Leopardi, così allusiva e al tempo stesso così propria.
Leopardi sapeva che i giornali, quelli che lui chiamava le “gazzette”, avrebbero
avuto un grande avvenire e forse sospettava anche che lo stile giornalistico si sarebbe
andato a mescolare con quello degli storici. Probabilmente però non era in condizione di
prevedere alcune conseguenze di questo incontro di linguaggi e di approcci, oltre che alla
cronaca anche alla storia. Certamente però ebbe percezione della inadeguatezza del
linguaggio giornalistico per quanto riguarda le questioni filosofiche e il modo di
diffondere e partecipare a un pubblico di lettori non professionali questioni emergenti
dalla viva attualità. Ora di questo particolare aspetto avremo occasione di ragionare più
avanti. Per il momento ci preme trattare, sia pure di sfuggita, l’altro quello cioè relativo
alla pretesa di ragionare di storia con il linguaggio della cronaca., perché questo ci aiuterà
a capire un po’ meglio quanto abbiamo per fugaci cenni detto circa il destino delle
Operette morali nell’Italia dell’Ottocento. Prima però dobbiamo ricordare la cronologia
degli eventi chiave. Pubblicate la prima volta nel 1827, assieme ai Promessi Sposi, le
Operette non entrano nell’epopea risorgimentale se non a fatica. Leopardi inoltre muore
nel 1837 e le critiche da lui avanzate agli “amici di Toscana” rischiano, come abbiamo
accennato, di fare del suo libro un libello addirittura reazionario. Mamiani, Tommaseo,
Cantù, Colletta e lo stesso Capponi, le cui posizioni sono da Leopardi apertamente
criticate e sconfessate nelle Operette, si guadagneranno sul campo il titolo di patrioti,
campioni delle aspirazioni nutrite dai giovani italiani, alcuni dei quali moriranno, altri
rischieranno la vita e affronteranno il carcere per aver corrisposto all’appello contenuto
nei loro scritti. Qui va precisato che a togliere luce alle leopardiane Operette morali ci
sono proprio e innanzitutto alcune opere di questi scrittori amici di Leopardi. Tali sono
la Storia del Reame di Napoli di Pietro Colletta; il Rinnovamento della filosofia in Italia
che Mamiani scrisse durante il suo esilio in Francia; il libretto dei Puritani, celebre opera
di Bellini, scritto da Capponi con il coro “Guerra, guerra!” che accese ancora nel
Quarantotto e nel Cinquantanove i petti di tanti italiani. Tutto questo per tacere dei
veleni sparsi da Tommaseo e da Cantù sull’opera di Leopardi. Stabilito questo e
ricordato che al mondo dei giornali è legata l’attività di questi intellettuali dell’Ottocento,
che hanno anche meriti che nessuno può loro negare, procediamo col vedere le
implicazioni di una storia raccontata come epopea.
1. 4 L’epopea risorgimentale
L’Ottocento è un secolo la cui storia è stata ricostruita avendo cura di parteciparla
a chi non l’aveva vissuta o l’aveva vissuta nella memoria privata, personale e familiare, in
modo del tutto marginale e aveva ora interesse a saperne qualcosa. Lo stacco
generazionale tra coloro che erano vissuti nell’epoca “eroica” del mazzinianesimo e del
garibaldinismo e quelli che nacquero quando l’unità d’Italia era cosa già fatta fu in realtà
più notevole di quanto noi possiamo oggi immaginare. A colmare la distanza tra gli
italiani del primo Ottocento e quelli del secondo Ottocento intervennero scrittori come
Edmondo De Amicis e critici e storici della letteratura come Francesco De Sanctis.
Furono loro a raccontare ai ragazzi nati dopo l’Unità che cosa fosse veramente accaduto
e svolsero un’opera che, come complessiva operazione culturale che mirava a elevare il
tono medio della cultura degli italiani, è stata almeno encomiabile. Gli italiani appresero
sui banchi di scuola, per merito di questi e di altri autori (fra cui vanno ricordati, secondo
noi meritatamente, anche Giuseppe Cesare Abba e Luigi Settembrini), molte cose della
loro storia recente che era indispensabile che apprendessero. Il punto è che questo
sapere di principi di convivenza civile e di civica moralità fu veicolato dalla diffusione di
un sentimentalismo di marca vagamente romantica, che mise in parentesi l’esigenza di un
approfondito e serio approccio filosofico (critico, se si preferisce) alle questioni del
momento. A tutto questo si aggiungano i danni prodotti da divulgatori assai poco accorti,
che scrivono rievocando dalle colonne dei giornali di provincia la loro storia; spesso
volgendo in testimonianza le innocenti leggende familiari che si tramandano (e che gli
elogi funebri spesso legittimano), sottoscrivendone in fretta la veridicità. Insomma quel
povero Enrico, protagonista del Libro cuore, è schiacciato e sommerso dalla storia
appena trascorsa e perfino il padre di quel suo compagno di scuola che si fa largo in
mezzo alla folla per salutare il re, il quale lo riconosce per un suo antico soldato, è una
specie di monumento vivente che falsa l’aspetto vivo e umano del risorgimento. Questo
sentimentalismo, e la retorica che ad esso è coerente, vanno in direzione opposta alle
indicazioni delle Operette che vorrebbero suscitare il senso critico e un atteggiamento
disincantato nel lettore. Sarà capace Enrico, una volta che sia arrivato al ginnasio, di
domandarsi perché in Italia si sia tornati a studiare Machiavelli, proponendo però ai
fanciulli delle scuole valori e modelli così anti-machiavellici? Il conseguimento dell’età
adulta deve necessariamente comportare la messa in parentesi di un mondo, quello della
scuola, da vedere come un mondo del gioco, della finzione, delle favole?
Particolarità del quadro storico-politico dell’Italia dell’Ottocento
2.1 Il compito dell’intellettuale
Che alcuni scrittori di cose serie portassero i lettori italiani in questa direzione è
sospetto che Leopardi non trascura di manifestare. Qui le Operette si aprono, come
opera fondamentale dello scrittore, vero vademecum scritto per gli altri, pensato per gli
altri, ma infine usato dallo stesso Leopardi come punto costante di riferimento anche
nell’opera poetica. Che la pedagogia possa convertirsi nella scienza utile a irretire le
menti dei giovani, creando illusioni e favole, è una possibilità che a Leopardi ripugna.
Eppure egli vede che la funzione delle “gazzette” rischia di riassumersi in questa
somministrazione di sonnifero, con cui il secolo XIX volta le spalle al secolo dei lumi,
come è lucidamente detto nella già ricordata Ginestra.
E’ un fatto che, con l’unità d’Italia alla letteratura, al romanzo in particolare, si
riconobbe una funzione pedagogica, non alla speculazione filosofica. A parte l’equivoco
di certi eroi di carta, che non sono reali ma finti, si colloca fuori della scena l’unico
eroismo nel quale Leopardi possa credere, che è quello di chi, professando come lui la
letteratura, insegni a lottare senza tregua negli scenari della vita per lui reale. Quello che
si delinea nell’ ultimo gruppo di Operette morali in cui intervengono quelle che abbiamo
voluto chiamare maschere filosofiche, è il terreno di scontro su cui Leopardi affronta i
suoi rivali. Il contrasto moderni-antichi si è chiuso nelle parole di Copernico e nella
celebrazione di Parini, al quale si riferisce il merito di avere restituito allo scrittore quella
dignità veramente principesca, che potrebbe farlo simile a Pico della Mirandola. Bisogna
riconoscere che l’idea della penna da impugnare come una spada sia una delle più geniali
verità messe a fuoco da Leopardi. Le ultime operette sono pura scherma verbale con
elegantissime stoccate e parate.
In altri termini c’è, a volerlo, dell’eroismo autentico in chi fa, in chi agisce, in chi si
pone in discussione, facendo cadere sistematicamente i veli dell’ipocrisia. Insegnare è
esattamente questo: insegnare a lottare, coerentemente ai principi che ispirano il nostro
modo di lavorare.
2.2 I “nuovi credenti”
L’errore di voler continuare a intendere l’ufficio del poeta come vaticinio mise i
“nuovi credenti” nella condizione di non considerare che la parola del vate è di per sé non
chiara, vuole essere interpretata e, pertanto non può onestamente impiegarsi a fini
pedagogici, a meno che il vate non si pieghi all’obbligo di spiegare come arriva ai suoi
vaticini, fatto che è però, oltre che imbarazzante, anche obiettivamente difficile. L’aver
puntato, per scopi educativi, sulla parola calda e suadente di bravi comunicatori fu un
errore di metodo, e come tale fu pagato dalla cultura italiana che non compì in quel
momento lo sforzo di ricostruire, assieme a una sua identità, la via per una più attiva
partecipazione al dialogo culturale con gli altri paesi europei. L’errore, per quanto
riguarda in particolare Leopardi, fu l’insistere a intenderlo quale “poeta”, in un contesto
culturale che negava al poeta un impegno speculativo autentico.
Perché accadde tutto questo?
Per rispondere alla domanda dovremo ora capire in che senso la filosofia di
Leopardi potesse creare disturbo a un disegno politico-culturale, ormai già decollato, ben
prima che lo scrittore morisse.
2. 3 Le verità scomode
A noi pare che si debba ricominciare col ricondurre l’opera di Leopardi al contesto
del dibattito culturale in corso al momento in cui le Operette morali fecero la loro
apparizione, vale a dire nel 1827, il che significa, per gli italiani dell’Ottocento che
leggono l’opera, l’epoca che segna il passaggio dagli anni Venti agli anni Trenta, epoca
durante la quale si parla e si ragiona delle Operette morali, delle quali oltretutto si
avranno fino al 1835 altre due edizioni. E’ un’epoca densa di avvenimenti storici
significativi, a cominciare dai moti del Cilento del 1828 per finire alla rivoluzione di luglio
del 1831 e ai moti carbonari che dal ducato di Modena minacciano di espandersi negli
altri potentati italiani.
Parlavamo, terminando il capitolo precedente, di verità scomode taciute da quella
che poi sarebbe diventata la cultura ufficiale, verità su cui sofferma al contrario la propria
attenzione Giacomo Leopardi.
La prima e fondamentale verità scomoda è che non esistono, alla luce del
ragionamento filosofico, argomenti sufficienti a giustificare l’esercizio delle tradizionali
virtù. Si sono cercate tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento alcune vie, ma
senza esiti certi. Basterebbe leggere il Breve schizzo dei sistemi di filosofia moderna e del
proprio sistema di Antonio Rosmini, per rendersi conto di quanto grave potesse
apparire la cosa. Si consiederi, per esempio, la posizione da Rosmini assunta circa la
filosofia di Étienne Bonnot de Condillac (1715 – 1780), capofila del sensismo, che
riusciva a una sorta di materialismo, nel momento in cui la cosiddetta attività mentale è
da questo filosofo ricondotta a funzioni biologiche legate all’apparato percettivo nel suo
complesso. Riferendosi all’opera di Condillac, Rosmini sostiene che “portò delle
conseguenze nocevolissime alla morale e alla religione, perché non avendo l’uomo altro
che la facoltà di sentire, ne veniva di conseguenza che il male e il bene non fossero altro
che sensazioni piacevoli e dolorose”3 e, accomunando un po’ disinvoltamente teorie che
hanno in comune il fatto di contraddire certe posizioni teologiche, prosegue dicendo che
“Questo immorale sistema fu svolto in Francia dall’Elvezio, e in Inghilterra fu applicato
alla prosperità pubblica dal Bentham, capo degli utilitaristi”4. Come si vede, sono
coinvolte le maggiori scuole filosofiche del tempo, incapaci appunto di fondare una
morale valida per tutti e in tutti i tempi. Il sensismo perché vi rinuncia in partenza,
l’utilitarismo perché giudica importante l’obiettivo da conseguire. Atteggiamenti di
questo tipo sono fondatamente intesi da alcuni come espressione di un preoccupante
relativismo. Il punto è che possono anche del tutto legittimamente essere qualificati
come rispondenti a una visione pluralistica, del tutto coerente allo sviluppo di una
società che, ampliando i modi e i sistemi della comunicazione, scopre l’esistenza di più
modelli e criteri di vita morale. Un aspetto della cultura illuministica non trascurato da
Leopardi è la letteratura di viaggio e la discussione circa i diversi stili di vita, le diverse
abitudini, in fatto per esempio di morale sessuale, che esistono in diversi popoli, a
cominciare dai popoli antichi. Tali abitudini e tali modelli, tra loro diversi sono tutti a
loro modo legittimi e, se non sicuramente legittimi, tuttavia possibili perché da altri
praticati. La filosofia non ha modo, in particolare, di giustificare la necessità di obbedire
alla volontà altrui, di spiegare le ragioni profonde di un ordine (pre-)costituito, per cui,
essendo il mondo preordinato in un dato modo, io debba poi uniformarmi ai comandi di
chi del tutto presuntamente (re o sacerdote che sia) sappia in quale modo quell’ordine
agisce. Qui va detto che al mantenimento di un ordine, ovvero allo stabilirsi di un nuovo
ordine di cose, tengono tutti coloro che in un mondo così concepito abbiano un ruolo,
una funzione, un grado che li collochi in una posizione avvertita come importante,
privilegiata, comunque diversa da quella di altri. Reazionari o rivoluzionari che siano, gli
uomini dell’Ottocento sono generalmente persone incapaci di rinunciare a questa
pregiudiziale: come il mondo risponde a delle leggi, ugualmente occorre che l’uomo si
uniformi a dei principi. Chi non ha principi, o li ponga in discussione, o accetti di tentare
un accordo con chi ne ha di diversi, appare una persona di cui diffidare. La parabola che
3 A. Rosmini-Serbati, Breve schizzo dei sistemi di filosofia moderna e del proprio sistema, glaux,
Napoli, s. d. ma , p. 34.
4 . Ibidem.
in Italia conosce la metafisica neoidealistica, l’unica che tenti (in realtà del tutto
anacronisticamente) una rifondazione dell’ordine morale e cosmico, conferma la
particolarità dei disagi di cui soffre una classe dirigente sulla quale incombe il timore di
un conflitto con le classi subalterne. Né ci pare un caso che nel punto culminante della
parabola, quando cioè il neoidealismo tocca i suoi picchi più alti, si consumasse il
sacrificio del più leopardiano fra tutti gli intellettuali italiani dell’epoca, Carlo
Michelstaedter sul quale grava, tetragona e ingrata, l’incomprensione di tutta una
generazione di studiosi5.
3. Leopardi dice la sua
3.1 Il relativismo morale
La verità del relativismo morale per cui i tempi, i luoghi e le culture modificano le
opinioni e i sentimenti che gli uomini hanno circa quel che è bene o male, è stata
nell’Ottocento taciuta, o fatta a fatica passare nelle maglie di discorsi pseudo-accademici.
Perciò, sebbene ci fosse chi in Italia sapeva con certezza queste cose, tuttavia il
relativismo morale non poteva avere libero corso. Ci furono perfino delle forme di
mistico compiacimento circa l’ impossibilità di dire, di cogliere, di vedere, di sapere, di
raggiungere l’irraggiungibile. Sono atteggiamenti di derivazione incrociata e composita, in
cui la tradizione cristiana si incontra con quella massonica e perfino con quella libertina,
riuscendo, in sede di affinamento dell’espressione artistica, a effetti veramente notevoli,
come nel caso della tomba di Antonio Canova, vera affascinante e inquietante
rappresentazione dell’indicibile. Leopardi però va oltre, varca quella soglia perché si
chiede se l’indicibile sia indicibile per pochezza d’ingegno o per viltà e scopre che non
5 . Sulla figura di Carlo Michelstaedter (Gorizia 1887 – 1910) può essere utile consultare i numerosi
saggi scritti da Sergio Campailla al quale si deve la pubblicazione di varie opere di Michelstaedter dal
più noto La persuasione e la rettorica alle poesie per finire con l’epistolario e una conferenza inedita.
Inoltre può utilmente leggersi A. Piromalli, Michlestaedter, Il Castoro, Firenze 1968.
solo il cuore ma anche la mente dell’uomo può essere vile. Questo non altro è il senso del
canto A Silvia, vera operetta morale in versi, dialogo del poeta col fantasma di una
fanciulla. L’uomo mette un velo sulle sue illusioni e il progresso, con la sua retorica
provvidenzialistica, è il nuovo mito collettivo dell’Ottocento. Immerso in questo sogno,
l’uomo moderno non vede le sue verità scomode e, nel divulgare la cultura, fa a infelici e
diseredati promesse che non sarà in condizione di mantenere. Si inganna e inganna.
3.2 La critica ai valori tradizionali
Questa riflessione critica intorno alle idee correnti nel secolo, che, stando a diverse
ricostruzioni ufficiali della letteratura e della cultura italiana del XIX e del XX secolo
appaiono generalmente cantate come generosi ideali, è alla coscienza di molti italiani
tuttora considerata pericolosa e pericolosissimo partecipare e diffondere l’esigenza di
approfondire qualsiasi ricerca in questa direzione. Di qui una sorta di demonizzazione
della tradizione illuministica, che aveva invece imboccato una strada che portava dritta
verso questa meta. A giustificare la prudenza che in tale materia occorre secondo i
romantici osservare, l’Amico di Tristano insisterà nel dire che bisogna tenere presente
che ci si trova “in un secolo di transizione”. Eccezione pretestuosa, come gli farà pesare
Tristano, visto che “tutti i secoli, più o meno, sono stati e saranno di transizione”.
Perciò il fatto non giustifica il compromesso che la nuova classe dirigente cerca con le
istituzioni del mondo medievale.
Il punto è che le folle eccitate fanno paura e, come in passato, si torna a temere di
quel che può accadere quando siano fatte partecipi del fondamento autentico della nuova
cultura: il dubbio. Analfabeti, straccioni, mendicanti sono visti come facenti parte di
un’umanità diversa a cui non si possono svelare gli errori (come Leopardi li chiama), o
anche semplicemente gli inciampi, gli strappi, le incoerenze di una cultura, che aveva
avuto il “merito” di costruire delle certezze. Invece di celebrare, platonicamente e
baconianamente, l’emancipazione dagli antichi pregiudizi, l’Ottocento e più ancora il
primo Novecento, si sentiranno orfani e piangeranno il venir meno delle certezze che ora,
più di prima, sono vacillanti, anzi inconsistenti. Sempre stando alle ricostruzioni di una
cultura ufficiale, sono pochi gli scrittori e gli intellettuali italiani che disinvoltamente
affrontano la caduta degli idoli. Se si eccettuano tra i principali, Luigi Pirandello, Gabriele
D’Annunzio, Guido Gozzano, Aldo Palazzeschi, Eugenio Montale, Giorgio Colli e
Emanuele Severino (i quali ultimi sentono il bisogno di rifarsi alla filosofia di Friedrich
Nietzsche, così vicina allo spirito leopardiano), l’intellettuale italiano negli ultimi
centocinquant’anni si è spesso disperato e strappato i capelli denunciando la crisi dei
valori, il vacillare delle certezze, come se le certezze diano la felicità e non complichino
invece la vita, obbligando maestri e padri a risposte evasive su “verità” che acquistano
sempre più l’aspetto di belle favole, e come se compito dei padri e dei maestri debba
essere quello di non dire ai giovani che il tempo delle illusioni prima o poi deve finire e
tutti dobbiamo diventare, chi prima chi dopo, adulti.
3.4 Verso una nuova morale
Non sfugga l’importanza che la cosa ha anche e soprattutto sul piano morale.
Fingere di non vedere o ostinarsi a ignorare un problema e stimolare negli altri una sorta
di sonno intellettuale per non correre il rischio di essere più infelici non ha nulla di grande
e di generoso. E’ un concetto relativo alla vita sociale oggi esprimibile in termini
piuttosto semplici eppur tuttavia rigorosi. Grazie infatti ai progressi compiuti sul piano
dell’ analisi dei fatti sociali, possiamo diversamente da quanto accadeva nell’età di
Leopardi, essere su questo punto chiari, diretti ed espliciti. In tutte le società esistono
dei tabù. Il riconoscerli per tali non comporta la loro demolizione, ma semplicemente la
messa a fuoco di un fenomeno della vita di una collettività che, senza sapersene fare una
precisa ragione, si astiene tuttavia dal fare qualcosa che è percepito come disonorevole,
peccaminoso, orribile, scellerato. Da questo punto di vista il filosofo, in quanto essere
umano, può condividere qualsiasi tabù appartenga alla comunità di cui fa parte e vivere
secondo le ritualità che la vita sociale gli impone e che l’educazione ricevuta hanno
radicato in lui. Questo però non l’autorizza a piegare la filosofia all’ufficio servile di chi,
chiamato a certificare quel che non può certificare, si affretta a inventare ragioni
inesistenti per dare al mito fondativo del tabù una giustificazione che non c’è perché il
tabù si giustifica da solo. A nostro avviso la deriva razionalista della cultura occidentale
da cui Leopardi si tiene prudentemente discosto, preferendo alla divinizzazione della
ragione, la ragionevolezza, descrive questa sorta di “follia” in cui caddero diversi
intellettuali dell’età che segna il passaggio dall’illuminismo al romanticismo, ovvero
dall’illuminismo al positivismo.
3.5 Esigenza di chiarezza
L’aspirazione a chiamare le cose con il loro nome è interna alla filosofia
leopardiana e questa esigenza, anzi questo rigore morale ha consentito a Leopardi di
imporsi anche su tanti che, potendo, l’avrebbero voluto avversare. Ci riferiamo a tanti
lettori di ispirazione cattolica e comunque notoriamente credenti, come per esempio
Federigo Tozzi il quale ha perfettamente inteso e rispettato la presenza di questa
singolare forma di onestà intellettuale appartenuta a Leopardi. In questo senso Tozzi
giunge a osservare:
Nell’apparente pessimismo del Parini, ovvero della gloria c’è invece una dolcezza della gloria
stessa, quasi una soddisfazione intensa ed elevata; una specie di superbia mitigata dalla grandezza di
animo e dalla sicurezza della coscienza. Non si sente nessun dubbio vero, nessuno sconforto, ma una
6
serenità ormai fuori d’ogni inciampo, libera e in grado di dire quel che vuole
.
Questa forza morale è tanto più piena di dignità quanto più si riferisce al grande
tema dell’educazione dei giovani, che costituisce appunto il tema centrale del Parini,
operetta nella quale si immagina che l’illustre riformatore degli studi si rivolga a un
discepolo “d’indole e di ardore incredibile”, apparentemente per distoglierlo dal
proposito di cercare la gloria letteraria, in realtà per saggiarne la forza d’animo.
A confrontare le idee che in fatto di educazione possiede Leopardi con quelle che
furono poi praticate nell’Italia unita, lascia sicuramente perplessi la scelta di indirizzare
risolutamente i giovani a coltivare i valori tradizionali, esitando invece nel prepararli a un
passo importante e decisivo della loro vita. Diventare adulti, oltre ad essere naturale, può
acquistare un aspetto piacevole, quanto più siamo preparati a diventarlo. In fondo
diventare “grande” è il desiderio naturale di qualunque ragazzo, che non vede l’ora di
potersi sentire libero di fare quello che i “grandi” fanno. L’eterna adolescenza, problema
dell’uomo d’oggi che indugia nell’irresponsabilità, non è un fatto positivo, né sul piano
6
personale né su quello degli effetti sociali che produce ed è figlia della cultura tardoottocentesca, con i suoi romanzi rosa per “signorine” (che, educate a queste letture
edificanti, dovranno scoprire la prosa della vita matrimoniale); e romanzi d’avventura per
“ragazzi”, che scopriranno loro malgrado che cos’è veramente la leva, la guerra e altri
momenti della vita, compreso l’amore, eccitanti quando si leggono su un libro e
diversamente dolorosi e sofferti, veri quando si vivono autenticamente. Tutto questo
mettendo da parte la prosa del lavoro, della carriera, del freno da dover mordere in attesa
di realizzare i propri progetti. Può essere allora utile spiegare che, oltre ai sentimenti,
vale un’intelligenza pratica e concreta che consiste nel saper gestire la propria vita,
compiendo scelte autonome e responsabili.
Scelte autonome e responsabili erano state anche quelle di coloro che avevano
combattuto per il risorgimento, i quali speravano che qualcosa cambiasse in meglio oltre
che per la patria, anche per sé stessi, per i propri amici, per i propri interessi. Che si
trattasse di un utile immediato, che fosse l’aspirazione a qualcosa di più alto e nobile,
non c’è dubbio che nessuno agisce se non in vista di uno scopo. Forse, c’è da dire, gli
educatori di Enrico, il protagonista del Libro Cuore, del quale abbiamo già parlato,
avrebbero fatto bene a dare al ragazzo qualche significativa indicazione in tal senso,
invece di porgli davanti figure di adulti troppo attenti a farlo restare bambino.
Ci pare ovvio che fosse questo un aspetto legato al fenomeno di un’educazione di
massa. La scuola in quell’epoca promuove ma al tempo stesso emargina, rimanda al
mondo del lavoro nei campi coloro che non studiano o non hanno i mezzi per proseguire
negli studi. L’educazione alla politica si compie nel neonato Stato liberale italiano
all’interno delle famiglie che hanno memoria storica di quel che significhi amministrare,
sia pure a livello locale, per conto di una pubblica autorità. Il modello educativo è
pertanto studiato per indurre all’obbedienza chi non assumerà mai responsabilità
pubbliche e per creare stimoli a conoscere in chi invece proseguendo negli studi imparerà
quel che c’è da imparare.
La concezione pedagogica di Leopardi è tutt’altra. Essa si informa a modelli
illuministici e consiste nell’ottenere che tutti siano posti nella condizione di aprire gli
occhi su certe verità che, esposte in modo chiaro nelle Operette, il poeta dichiarerà
apertamente e candidamente nella Palinodia, nei Nuovi credenti e nella Ginestra.
3. 6 Le ragioni di Leopardi
In tutto questo va per onestà detto che, a fronte di versioni purgate e emendate
delle Operette morali ci furono tanti che sentirono il dovere morale di una libera
circolazione di quello che parve subito un capolavoro. E, se noi oggi leggiamo senza
problemi le Operette lo dobbiamo alla sensibilità di alcuni intellettuali dell’Ottocento che,
pur non essendo d’accordo con quanto Leopardi sostiene, ritennero comunque che il suo
pensiero meritasse d’essere proposto ai lettori. Ciò accadde forse anche nella giusta ed
equilibrata valutazione che una critica non debba censurarsi per timore degli effetti che
può produrre, anche perché se produce effetti, allora è valida e quel che è valido non va
censurato. Da questo punto di vista vanno ricordati, tra gli studiosi che fecero “passare”
il messaggio di Leopardi, due nomi fondamentalmente. Il primo è Francesco De Sanctis
che trovò la maniera di far leggere l’opera del poeta anche nelle scuole; il secondo è
Carducci che si adoperò per la pubblicazione dello Zibaldone nell’occasione del primo
centenario della nascita di Leopardi. Ma sia l’uno sia l’altro dei due tentativi non furono
altro che un modo per far passare solo qualcosa del complesso messaggio elaborato da
Leopardi.
4. L’aspetto politico oltre quello pedagogico-morale
4. La morale degli italiani
C’è un curioso giudizio di Italo Calvino su Giacomo Leopardi :
Per me il padre ideale del nostro romanzo sarebbe stato uno che parrebbe lontano più d’ogni altro
dalle risorse di quel genere: Giacomo Leopardi. In Leopardi erano vive infatti le grandi componenti del
romanzo moderno, quelle che mancavano a Manzoni: la tensione avventurosa (quell’Islandese che se ne
va solo per le foreste dell’Africa, e quella notte tra i cadaveri nello studio di Federico Ruysch, e
quell’altra sulla tolda di Colombo), l’assidua ricerca psicologica introspettiva, il bisogno di dare nomi e
7
volti di personaggi ai sentimenti e ai pensieri suoi e del secolo .
7
I. Calvino, M
Il giudizio, che a qualcuno potrebbe apparire paradossale, si spiega con la
conoscenza che della realtà morale degli italiani Leopardi possiede. Chiunque abbia letto i
Canti e soprattutto chiunque abbia anche soltanto scorso l’epistolario leopardiano
capisce che il chiacchiericcio cittadino, lo struscio, le ipocrisie dei vicini, i ricatti grandi e
piccoli della vita sociale sono un bersaglio continuo verso cui Leopardi scaglia le sue
frecce. In effetti è questa l’Italia vera d’allora. Nelle Operette se ne colgono vari riflessi,
sia pure prevalentemente negativi. Ci riferiamo a quell’umanità statica e uniforme che
non ce la fa a star dietro ai vari Copernico, Colombo, Tasso, Parini e ne santifica la
memoria conferendo loro un’autorità che è la stessa contro cui quelli, da vivi, avevano
alzato la loro voce. In effetti poco importa a Leopardi che si pensi bene o male, purché si
pensi liberamente e ciascuno sforzandosi di dare un contributo. Questo è il senso, il
messaggio semplice e diretto, il sugo (per usare un’espressione cara ai manzoniani) delle
Operette morali.
C’è un’interessantissima pagina dello Zibaldone che va secondo noi messa in
relazione a una delle più vive, sentite e palpitanti operette: ci riferiamo al Parini, ovvero
della Gloria.
Scrive Leopardi in data 20 agosto 1821:
Quegli uomini straordinarii e sommi che danno colle loro opere un impulso allo spirito umano, e
cagionano un suo notabile progresso, restano dopo poco spazio inferiori nell’opinione e nella realtà, a
degl’ingegni molto minori, che profittando de’ suoi lumi, conducono lo spirito umano molto più avanti
di quello a cui egli non lo poté portare. Così quelle stesse opere che gli procacciarono gloria, cagionano
la di lui dimenticanza; e il gran filosofo con quel medesimo con cui cerca ed ottien rinomanza, travaglia a
8
distruggerla .
Leggiamo nel Parini:
Se poi (come non è cosa alcuna che io non mi possa promettere di cotesto ingegno) tu salissi col
sapere e colla meditazione a tanta altezza, che ti fosse dato, come fu a qualche eletto spirito, di scoprire
alcuna principalissima verità, non solo stata prima incognita in ogni tempo, ma rimota al tutto
dall’aspettazione degli uomini, e al tutto diversa o contraria alle opinioni presenti, anco dei saggi; non
pensar d’avere a raccorre in tua vita da questo discoprimento alcuna lode non volgare. Anzi non ti sarà
data lode, né anche da’ sapienti (eccettuato forse una loro menoma parte), finché ripetute quelle medesime
verità, ora da uno ora da altro, a poco a poco e con lunghezza di tempo, gli uomini vi assuefacciano prima
gli orecchi e poi l’intelletto. Perocché niuna verità nuova, e del tutto aleina dai giudizi correnti; quando
bene dal primo che se ne avvide, fosse dimostrata con evidenza e certezza conforme o simile alla
geometrica; non fu mai potuta, se pure le dimostrazioni non furono materiali, introdurre e stabilire nel
9
mondo subitamente; ma solo in corso di tempo, mediante la consuetudine e l’esempio
Quindi, proseguendo
…E’ sentimento, si può dire universale, che il sapere umano debba la maggior parte del suo
progresso a quegl’ingegni supremi, che sorgono di tempo in tempo, quando uno quando altro, quasi
8 . Zibaldone [1533]
9 .O.M. Il Parini, Cap. VIII
miracoli di natura. Io per lo contrario stimo ch’esso debba agl’ingegni ordinari il più, agli straordinari
10
pochissimo.
E’ un concetto alto, generoso, nobile (in senso morale) dell’ambizione nell’uomo,
un concetto che nel momento storico in cui Leopardi vive va gradatamente spegnendosi,
forse definitivamente. Ci pare che lo stesso scrittore non sappia nel suo profondo
dirimere la questione e stabilire quanto veramente, autenticamente, questa spinta possa
esaurirsi. Il timore che così sia è però in lui fortissimo, talvolta quasi angoscioso.
Allo storico della cultura che si addentri nel labirinto delle dispute, delle
discussioni, esaminando carteggi ed epistolari, dove più chiaramente e apertamente si
manifestano preoccupazioni, ansie e dubbi, risulta abbastanza chiaramente che nessun
secolo è stato più dell’Ottocento consapevole della impossibilità di legare fra loro fede e
ragione. Allo stesso modo nessun secolo è stato più dell’Ottocento attento a velare
questo messaggio, timoroso dei possibili stravolgimenti che ne sarebbero potuti sorgere
sul piano dell’ordine pubblico e della pace sociale.
E’ questa non altra la verità storica che legittima l’affermazione di Leopardi che,
rivolgendosi all’Ottocento dice nella Ginestra : qui mira e qui ti specchia, / secol superbo
e sciocco, / che il calle insino allora / dal risorto pensier segnato innanti / abbandonasti,
e volti addietro i passi, / del ritornar ti vanti, / e procedere il chiami (vv.52-58).
Un certo perbenismo borghese, che a mala pena si trova nella Milano di Verri, di
Beccaria e di Foscolo, appare invece evidente nel carteggio Tenca–Maffei11,
nell’epistolario di Pellico12, per tacere della carte di Manzoni che è un caso a parte, se è
vero che lo scrittore temeva che ogni cosa da lui scritta fosse poi destinata a essere
diffusa magari clandestinamente. E per questo suo pudore Manzoni, che è fra l’altro
senz’altro superiore per intelletto e carattere ai tanti che lo sostennero, va pure capito.
10
.ibidem
11
. Lina Jannuzzi, curatrice del carteggio apparso in tre volumi, sostiene: “A una visione
d’insieme gli stessi personaggi dell’ambito maffeiano appaiono in una nuova dimensione, avvolti nella
noia della vita di ogni giorno, sbiaditi e rimpiccioliti. Senza l’ausilio di notizie esterne difficilmente si
potrebbero identificare con i protagonisti delle Cinque Giornate e di altre avventurose imprese del decennio
di prova. La società ambrosiana è colta nel periodo in cui rinuncia a una dimensione europea per assumere
caratteristiche borghesi e municipali”.(L. Jannuzzi (a cura di) Carteggio Tenca – Maffei. Introduzione p.
VI).
12
. Le lettere di Pellico, pubblicate più volte in varie edizioni, abbracciano un arco di tempo che
dal 1815 giunge agli anni Cinquanta. C’è anche una lettera a Francesco Silvio Orlandini nella quale
Pellico, in vista della pubblicazione, chiede si apportino alcune modifiche a lettere da lui scritte diversi
anni addietro a Ugo Foscolo, nell’evidente preoccupazione che, riprodotte fedelmente, tali lettere inducano
nel lettore sentimenti che Pellico dichiara di non aver più. Non si tratta di modifiche particolarmente gravi,
ma colpisce in uno dei protagonisti della vicenda risorgimentale un così forte attaccamento alla propria
immagine pubblica, anche per quanto riguarda un passato ormai lontano.
Negli educatori poi è ricorrente e ossessiva l’idea di dare ai giovani esempi
edificanti. Si rileggano i libri concepiti per le scuole, a cominciare dal già ricordato Cuore,
così ricchi di esempi di virtù e poco invece di quelle verità relative ai contrasti sociali che
il naturalismo francese non ha paura a denunciare. In tutti la paura è una: che gli umili
possano ribellarsi. Anche per questo nacque la “rivoluzione”, che si ebbe fretta a fare,
nel timore che altri strappasse di mano l’iniziativa ai moderati. Teniamo a precisare che
tali conclusioni non discendono direttamente da tesi storiografiche “viziate” da un
qualche orientamento politico. Sono conclusioni a cui si giunge mettendo insieme i
tasselli di una critica storiografica che tien conto di giudizi che risalgono tanto a Gramsci
quanto a Tocqueville, per tacere di un Verga o di un De Roberto, che in un saggio
letterario dedicato a Leopardi potrebbero essere appropriatamente citati, essendo
Leopardi precursore di un’analisi storico-storiografica che si sarebbe nel tempo meglio
definita, in quanto meglio circoscritta all’aspetto sociale.
Il rivoluzionario, va detto, è un uomo d’ordine che si dà una disciplina. Il ribelle
no. Del ribelle l’Ottocento ha orrore e invidia. Lo disprezza moralmente ma ne canta le
gesta, si chiami Fra Diavolo, si chiami Napoleone Bonaparte, si chiami infine Giacomo
Leopardi.
4.2 L’Italia intellettuale di fronte alla questione morale al tempo di
Leopardi
Per poco che, nello sforzo di mettere insieme i tasselli di una ricerca storica che
miri alla ricostruzione di un clima morale, si capiscono tante cose dell’epoca in cui
Leopardi visse. Gli atteggiamenti moralistici del maestro di scuola, della madre di
famiglia, dell’onesto impiegato municipale sono nell’Ottocento dovuti essenzialmente
alla paura di cui parlavamo, circa la sollevazione di quella che allora si chiamava
“plebaglia”. Essi devono far credere, per conservare l’ordine sociale, che ci sia una
ragione al proprio virtuoso comportamento e paradossalmente non è per paura di chi li
governa ed esercita su di loro un potere, che essi si comportano bene, ma per il terrore
che la mancanza di valori morali autenticamente operativi nelle classi dirigenti, possa,
una volta che sia messa a nudo, suscitare nelle folle cittadine risposte pericolose e
indesiderate. Non è un caso che, continuandosi a sospettare di Machiavelli, Guicciardini
sembri ancora quasi impresentabile13. E’ questa la morale piccolo-borghese,
caratterizzata da quella particolare forma di alienazione che si rivela nell’autocensura, e
che, agli occhi di Leopardi, è forse più detestabile ancora della censura stessa, perché
indicativa di una congiura che silenziosamente agisce sulle coscienze14. E’ proprio per
aggirare l’obbligo dell’autocensura che Leopardi utilizzerà la maschera di Tristano
quando nell’edizione del 1834 inserirà il Dialogo di Tristano e di un amico, nel quale
come vedremo, l’autocensura è messa alla berlina.
E’ incredibile, eppure nella patria di Cesare Beccaria e di Pietro Verri, i quali
avevano mostrato l’inutilità di comminare certe pene, è ferma tuttavia l’opinione, ancora
oggi del resto corrente, che senza lo spauracchio di una pena e di un castigo, i popoli non
sappiano vivere civilmente. Ancora oggi c’è chi pensa, del tutto infantilmente, che il
crimine si combatta con leggi sempre più severe e con la limitazione delle libertà, dove è
ormai accertato in tutti i paesi civili del mondo, a cominciare proprio dall’Ottocento, che
molto di più può la bonifica dei quartieri poveri, la creazione di spazi per lo studio, per il
gioco, per l’organizzazione intelligente del tempo libero specialmente per i giovani. Al
contrario l’arresto, la carcerazione, il maltrattamento spesso acuiscono soltanto le
tensioni sociali. La ragione è addirittura banale: chiunque incappi nelle maglie della
giustizia, fa parte di una famiglia, di un gruppo, che tanto più violentemente risponde
quanto più senta, come purtroppo tante volte accade senza colpa di nessuno, che quella
giustizia sia ingiusta. Quante volte succede che l’arrestato, l’incarcerato, il maltrattato sia
innocente e, pur senza essere innocente, abbia tuttavia (dal suo punto di vista) delle
buone ragioni per violare la legge? Non sempre infatti la legge è giusta e non sempre tiene
conto delle realtà che premono gli individui concreti. La società evolve, gli ordinamenti
giuridici mutano lentamente e quando mutano, non sempre mutano in una direzione che
sia realmente conforme alle necessità del momento. Quale altra ragione hanno avuto in
Europa le rivoluzioni di qualunque ispirazione, liberali o socialiste che siano state, se non
13
.Nella Storia della letteratura di De Sanctis Machiavelli “passa”, Guicciardini no:
“Francesco Guicciardini, ancorché di pochi anni più giovane di Machiavelli e di Michelangiolo, già non
sembra della stessa generazione. Senti in lui il precursore di una generazione più fiacca e più corrotta,
della quale egli ha scritto il Vangelo ne’ suoi Ricordi….” (Cfr. F. De Sanctis, Storia della letteratura
italiana, vol. II, Laterza, Bari 1964. p. 105).
14
. E’ stato Alberto Moravia a osservare in Leopardi” il rifiuto del compromesso imposto
all’arte dalla società, da qualsiasi società, e che agisce come autocensura e inibizione” (Cfr. B. Cicchetti,
I Canti del Leopardi, SEI, Torino 1973, p. 150).
quella di far corrispondere il paese legale a quello reale? La “rivoluzione” è possibile e si
fa, quando la forbice tra la situazione reale e quella ipotizzata e implicitamente descritta
da un ordinamento giuridico si allarga troppo. Non è la forza delle idee ma quella dei fatti
a dirigere il corso della storia, perché i fatti hanno la forza di imporsi con evidenza; le
idee, per quanto belle e generose possano essere, appartengono al mondo dei desideri e
delle aspirazioni: affezionarcisi significa talvolta illudersi e restare indietro credendo di
andare avanti.
Da questo punto di vista Leopardi, e specialmente il Leopardi delle Operette
morali, colpisce per la sua lucidità.
In una celebre pagina di commento a Leopardi, importante anche perché portò a
nuove prospettive interpretative, Sebastiano Timpanaro scriveva nel 1965:
La tesi provvidenzialistica secondo la quale Dio o la natura consegue, pur attraverso l’infelicità dei
singoli individui, la felicità generale dell’umanità, o la variante della stessa tesi, secondo cui la civiltà
moderna assicurerebbe, se non la felicità degli individui, la felicità delle masse erano, a loro modo,
tentativi di superamento “dialettico” del pessimismo […] Ebbene il Leopardi, seguendo Voltaire e
andando molto oltre Voltaire, non si è mai stancato di respingere e di deridere tale soluzione “dialettica”,
proprio perché essa è una soluzione illusoria, una “negazione ideale” che maschera la reale incapacità di
15
liberare l’uomo dall’oppressione che su di esso esercita la natura. .
Sicuramente l’intento polemico verso i “nuovi credenti” costituisce una nota
costante dell’opera leopardiana, che attraversa gli aggiornamenti delle Operette vale a dire
le varie, successive, laboriose edizioni che seguirono la prima del 1827.
Attentissimo alla vita di società, per come questa si conduce, pronto con sicurezza
a individuare gli spazi nei quali si incontra un certo fervore intellettuale (biblioteche,
caffè, salotti) Leopardi ascolta e osserva. Se così non fosse, non avrebbe potuto
concepire quel piccolo capolavoro che è il Dialogo di Tristano e di un amico, fedele
riproduzione di conversazioni quasi certamente fatte da lui stesso, intorno alle questioni
che vi si agitano e alle ragioni per cui sarebbe (a parere dei benpensanti) opportuno
tacerne, mentre (secondo Leopardi) bisogna al contrario parlarne e parlarne
pubblicamente.
Nel descrivere il panorama morale della società italiana dell’epoca, noi partiremo
dall’assunto che la visione “dialettica” descritta da Timpanaro e le tesi ottimistiche e
provvidenzialistiche che ad essa si accomodano, fossero utili a velare certe situazioni,
certi pregiudizi, certe piccole ipocrisie che naturalmente si presentano in una società e
15
. S. Timpanaro, Classicismo e illuminismo nell’Ottocento italiano, Nistri – Lischi, Pisa 1965, p.
che a Leopardi piace però, da filosofo, fare in modo che emergano, che se ne ragioni
pubblicamente. Non per nulla uno dei pochi romanzi che gli piacciono è, a quanto
sembra, Il Vicario di Wakefield di Oliver Goldsmith, del quale ragiona con rispetto nei
Pensieri16.
4.3 La società italiana
Venendo ai fatti, va detto che la società in cui si vive all’epoca di Leopardi è
comunque diversa da quella di qualche decennio prima. I contrasti di classe sono meno
violenti, ma forse per il fatto d’essere latenti, fanno più paura. Basta pensare a una città
(e sulle città Leopardi ha pagine interessantissime anche nelle Operette!) e vedere come,
in verità assai imprudentemente, i quartieri si distinguano in base all’estrazione e alla
condizione sociale di coloro che li abitano. Non ci sono spazi autenticamente comuni
(promiscui, per usare un termine orribilmente snob) e perfino i negozi sono diversi e per
persone di condizione diversa, per non parlare del teatro e in genere di tutto quello che
ha a che fare con lo svago e col divertimento. Il pubblico si dispone in posti che
corrispondono all’appartenenza della classe sociale, perfino quando si vada a sentir
messa, con deroghe legate esclusivamente al censo, non certo alle capacità intellettuali e
morali, come dimostrano i funerali religiosi di prima, seconda e terza classe. Sono
contraddizioni tipiche della città industriale che Napoli, la città patria d’elezione per
Leopardi, assai tipicamente presenta con deroghe tanto imprevedibili quanto eccezionali.
Lì un conte può trovare sepoltura in una fossa comune, specie se si immagina che questo
sia un suo desiderio e non ci si cura che il fatto possa creare scandalo.
E’ l’imborghesirsi della società che comprensibilmente dispiace al conte Leopardi
che, da conte, ha comunque altra pratica nei contatti umani. Questo imborghesirsi dà vita
a situazioni intermedie, con i nuovi ricchi che, come abbiamo cercato di illustrare, non
sono signori e non sono più contadini. Questa classe media ha enormi responsabilità, di
cui non è peraltro pienamente consapevole perché non ha, come classe media, una sua
chiara identità. Abituata a porsi a metà strada tra i paradisi del potere, i cui segreti le
16
. G. Leopardi, Pensieri, CVIII
restano ancora nell’Ottocento in gran parte sconosciuti, e l’inferno della miseria e
dell’inedia, di cui non capisce gli abissi morali, essa guarda normalmente con
superficialità alle cose e questa superficialità ha costituito, per dirla marxianamente, la
sua “coscienza” di classe. La sua cosmologia è quella di un mondo fatto a scale, con la
pretesa tuttavia che queste scale, su cui scorrono gli scenari della vita reale per come il
borghese la vive, poggino obbligatoriamente su qualcosa di stabile. E’ l’illusione assai
poco generosa di tanti eroi della narrativa ottocentesca, a cominciare dai personaggi creati
dalla fantasia di Balzac, per arrivare alla conturbante e ingenua Madame Bovary di
Flaubert e per finire con Gesualdo Motta, il protagonista del Mastro-don Gesualdo di
Verga. L’unica cosa a cui serve la filosofia sta, per il borghese-tipo, nella garanzia che
essa offre circa il fatto che tutto debba poggiare su qualcosa. A partire dall’Ottocento, la
scienza suggerisce l’immagine di un progresso inarrestabile e ingenuamente il borghese,
che ha fretta di montare sulle rutilanti scale mobili del progresso, si affeziona alle
certezze della scienza, che non esita a divinizzare. Si illude che la ragione abbia un soffio
divino, né si domanda come possa l’imperfetta ragione umana aprire scenari su verità
definitive. Della religione ha concetti sempre più vaghi, riconducibili a pochi slogan circa
l’opportunità e la sensatezza della fede in Dio.
4.4 La rivoluzione dei gattopardi
Il punto centrale è che la “rivoluzione”, il “progresso” non suona altro alle orecchie
del borghese che come promessa di una “carriera”, di un “avanzamento”, di una
promozione sociale. Il fatto nuovo è che, dall’Ottocento in poi, la promozione sociale
non comporta più, come negli ultimi tre-quattro secoli era invece accaduto, che il
passaggio da una classe all’altra sia sancito dallo sforzo di acquisire veramente una nuova
cultura, cioè nuove abitudini, comportamenti e perfino gusti diversi, tipici della classe
dirigente. Il nuovo ricco non è più un Barry Lindon che ce la mette tutta per diventare
Lord e si addolora e soffre, vedendo che non vi riesce perché non ne ha il talento17. E’
17
. Ci riferiamo al protagonista del
di Barry Lindon. Il romanzo, apparso per
all’epoca della vita di Leopardi. Tuttavia il
nel suo romanzo è così prossimo nello
celebre romanzo di William Makepeace Thackeray Le memorie
la prima volta nel 1844, è posteriore, di quasi un decennio,
quadro della società dell’ultimo Settecento che Thackeray offre
spirito a certe critiche da Leopardi mosse alla società in
uno che si accontenta di quel che ha raggiunto come self-made man e mette su una certa
arroganza proprio perché pretende d’essere stato bravo e meritevole. Leopardi lo ha in
antipatia, come ha in antipatia tutto il suo mondo morale e culturale che gli appare
insufficiente. Questo nuovo tipo di personaggio legge il giornale, va alla Borsa, ha
leggiucchiato il Vangelo, sa che Virgilio era stato un poeta e Copernico un genio
precursore delle scienze moderne, tiene in casa propria qualche anticaglia di cui non
conosce il valore ed è, agli occhi di Leopardi, qualcosa come un asino in marsina, anzi ci
pare probabile che lo scrittore storcesse il naso nel vedere persone del genere mescolate a
quella cerchia di amici che lui stesso frequentava. Leopardi è però un filosofo e riesce a
trasformare questa naturale avversione in una singolare forma di comprensione. Invece di
prendere di mira il tipo del nuovo ricco, tenta di rivolgersi a lui, provocandone delle
reazioni magari intelligenti, di cui Leopardi sa che il suo interlocutore è capace. Ed è
perciò sull’intelligenza del lettore che punta risolutamente come autore di un testo
filosofico che valga ad avviare alla filosofia.
Sempre nel Dialogo di Tristano e di un amico leggiamo significativamente:
Amico mio, questo secolo è un secolo di ragazzi, e i pochissimi uomini che rimangono, si
debbono andare a nascondere per vergogna, come quello che camminava dritto in paese di zoppi. E questi
buoni ragazzi vogliono fare in ogni cosa quello che negli altri tempi hanno fatto gli uomini, e farlo
appunto da ragazzi, così a un tratto, senza altre fatiche preparatorie. Anzi vogliono che il grado al quale è
pervenuta la civiltà, e che l’indole del tempo presente e futuro, assolvano essi e loro successori in
perpetuo da ogni necessità di sudori e fatiche lunghe per divenire atti alle cose. Mi diceva, pochi giorni
sono, un mio amico, uomo di maneggi e di faccende, che anche la mediocrità è divenuta rarissima; quasi
tutti sono inetti, quasi tutti insufficienti a quegli uffici o a quegli esercizi a cui necessità o fortuna o
18
elezione gli ha destinati.
Tale sconfortante, ma assai graffiante considerazione circa gli uomini del proprio
tempo, non va letta, secondo noi, come una pessimistica valutazione di cose che possa in
qualche modo nascere dallo sgomento d’essersi scoperto malaticcio e infermo. E’
un’accusa. Tale accusa consiste nel rimproverare le paure, le ubbie nelle quali si avvolge
la mente di chi è sempre pronto, infantilmente, a scusare se stesso, assolvendosi da ogni
responsabilità. Invece gli errori ci sono, sono naturali e da essi si impara. Chi non accetta
questa logica non crescerà mai e resterà sempre ragazzo, prigioniero delle favole e di
un’ipocrisia che è incapace di cogliere e di vedere in se stesso.
trasformazione, che sogna il progresso, che il riferimento ci appare comunque opportuno.
18
. O. M., Dialogo di Tristano e di un amico
5. una dimensione europea della filosofia leopardiana
5.1 Il pubblico per come appare a Leopardi (e come lo tratta Hegel)
Questo fatto è importantissimo ai fini di ricostruire la genesi delle Operette morali.
Il pubblico a cui lo scrittore filosofo si rivolge non è il pubblico del Settecento, a dispetto
del fatto che settecentesche appaiano, e in certo modo anche siano, le idee da lui
propugnate. E’ chiaro che l’intento di Leopardi è quello di illustrare quale sia l’origine di
tante idee correnti nell’età sua, in un momento in cui tali
e tante confortanti e
ottimistiche opinioni vengono indicate come nuove. Gli equivoci di una fin troppo facile
divulgazione non verranno peraltro alla coscienza degli italiani, poco disposti a
interrogarsi criticamente su questa materia.
Il punto è che quello che noi oggi chiamiamo “cultura borghese”, e che consiste in
un sistema di idee, tenuto insieme da alcuni slogan, che fanno l’instabile fondamento di
quella cultura, è qualcosa che, mancando sia di organicità sia di spessore, ruba un po’
dell’uno e un po’ dell’altro ad altre culture che sono poi quelle che vuol demolire o con le
quali comunque è in competizione. Questo è il fatto nuovo del secolo XIX. Quanto a
Leopardi, si irrita, come abbiamo visto ragionando del Dialogo di Tristano e di un amico,
quando vede l’uomo dei suoi tempi inorgoglirsi di quel che gli viene dal grado di civiltà
raggiunto, al punto di sentirsi affrancato da qualunque obbligo circa le cose da imparare.
Situazione del tutto nuova. Fino ad allora, infatti il borghese che avesse dato la scalata al
successo, magari procurandosi un titolo nobiliare, non aveva preteso di eleggere il
proprio mondo morale a paradigma di un sistema di vita che potesse valere anche per gli
altri. La cultura era, come abbiamo detto, quella della classe dominante, una cultura
aristocratica, all’interno della quale non mancavano diversi orientamenti e diverse
concezioni del mondo. Ma si trattava di una cultura che aveva reso organica
l’articolazione del sapere, al quale ci si era sforzati di dare un’unità. Di qui alcune
filosofie, come quella cartesiana e quella leibniziana, che s’erano studiate di tracciare
un’ordinata mappa dei principi a cui attenersi. Una secolare pratica del potere era poi
riuscita a far sì che i veri problemi, il nocciolo duro delle grosse questioni, si esaminasse
all’interno di ambienti protetti, fuori dallo sguardo dei curiosi, a cui si lasciava conoscere
quel che, a sapersi, non produce gravi danni. Sicuramente la Massoneria fu la più diretta
e significativa espressione di una tale tendenza, ma non tanto nel senso che sancisse
l’esigenza di “coprire” una ricerca da condurre in segreto, quanto al contrario per ribadire
apertamente e senza veli un’importante verità, quella per cui allo studio, come alle arti e
alle professioni, si viene “iniziati”. La cultura aristocratica aveva per secoli proceduto a
tale iniziazione, ma senza celebrarne e divulgarne all’esterno la necessità. E’ storicamente
documentabile l’abisso di sapere che c’era stato nei secoli precedenti tra i molti
analfabeti che popolavano le campagne e un principe di Santa Madre Chiesa, che sapeva
di architettura e astronomia quasi quanto Copernico, sul cui nome s’era comunque steso
un velo di silenzio. Nelle corti e perfino in alcuni palazzi signorili, come in quello di
Monaldo Leopardi, c’era il modo, per chi lo volesse e vi si sapesse muovere, di risalire
almeno in parte al cuore dei problemi, al punto cruciale di una dotta questione. Insomma
le più aspre questioni di teologia, le più ardite concezioni circa la costituzione
dell’universo e, naturalmente, la scienza politica si dibattevano solo a certi vertici.
Il borghese che non svolgesse professioni particolarmente qualificanti sul piano
culturale, continuò a non avere accesso alle stanze segrete sia del potere sia del sapere e
quando pretese di inserirsi attivamente nel dibattito culturale, lo fece mettendo assieme
alcuni concetti generalmente veicolati da una cultura della divulgazione, senza cioè andare
veramente a fondo nelle questioni. Di qui una cultura che non ama il rigore e che al rigore
non è sollecitata dalla rapidità con cui spende i concetti che mette in campo. E’ una
cultura che in particolare non ama la filosofia, in essa vedendo un teoreticismo fine a se
stesso. C’è qui un’affinità profonda tra la filosofia leopardiana e quella hegeliana che ci
pare non sia stata sufficientemente notata. Se Leopardi è estraneo a un progetto che può
identificarsi con l’idealismo, in quanto i filosofi idealisti seguono una parabola di cui
Leopardi assolutamente diffida, non può ignorarsi che la stessa insondabile libertà del
pensiero che egli rivendica fosse rivendicata, in altro modo, da Hegel. Una dialettica di
finito e infinito: così i manuali amano sintetizzare la filosofia hegeliana in uno dei suoi
nodi decisivi. Se questa dialettica si compiace nell’attardarsi sulla contemplazione
ammirata delle potenzialità della mente umana e Leopardi, dal canto suo, trova
fuorviante tale significativa “posta” che nel percorso seguito trova l’idealista, non va
dimenticato che poi alla fine l’hegelismo consiste in una vanificazione della coscienza
finita (l’uomo appunto) che si specchia del tutto infelicemente in se stessa.
5.2 Nietzsche e Leopardi
Stando a quanto fin qui abbiamo detto può effettivamente concludersi che la
Fenomenologia dello spirito di Hegel contiene in parte il pessimismo leopardiano. Non
stupisce allora che, Schopenhauer a parte, Nietzsche, nell’ansia di superare l’hegelismo e
di aprire nuovi orizzonti alla filosofia tedesca, si incontrasse con Leopardi. Ora il
Leopardi che Nietzsche conosce è il Leopardi dei Canti e delle Operette morali, non
essendogli noto il Leopardi dello Zibaldone, che vide la luce solo nel 1898. Questo fatto
è per noi di capitale importanza perché rivela l’importanza che le Operette hanno sul
piano della cultura europea, nei confronti della quale intendono avere un forte impatto e
che, secondo noi, sono da mettere a confronto con l’opera di Hegel, forse indirettamente
e confusamente nota a Leopardi, ma che descrive non meno di quella leopardiana le
tensioni e il clima culturale di un’epoca.
Più che non un romanzo, la hegeliana Fenomenologia dello Spirito, letta anch’essa
come accade di tutti i capolavori, non senza qualche equivoca intepretazione, è una
visionaria narrazione che, proponendo le figure dallo spirito create nel corso della sua
storia, potrebbe dirsi la sceneggiatura del grande film della storia dell’umanità. Uno script
veramente affascinante, capace di incantare per come si avvolge su se stesso,
coinvolgendo il lettore-spettatore. Hegel è da annoverare fra gli inventori di un modo di
narrare cinematograficamente ancor prima che non letterariamente, in un’epoca in cui il
cinema doveva ancora nascere. Ora nulla è più autenticamente e assolutamente borghese
dello spettacolo cinematografico, che ha di fatto soppiantato il libro, strumento della
vecchia cultura aristocratica che, giunta con Leopardi a uno dei suoi punti più alti, in
Leopardi trova chi impugna la penna come una spada.
La voce di Hegel è invece una voce fuori campo, che descrive ora la desolazione ora
lo splendore di certi paesaggi immaginari, modificando il reale in immaginario e
l’immaginario in reale, in ciò anticipando l’esperienza concretamente storica che ai nostri
giorni fa chiunque segua un telegiornale o un reportage televisivo. Il borghese non vuole
criticare, vuole vedere, ma non accetta poi di vedere criticamente, balzando magari a un
vuoto atteggiamento ipercritico. La differenza è che Hegel, borghese e figlio della
borghesia, alla borghesia dà credito ed è in questo senso ottimista, ma della borghesia
conosce e descrive dall’interno gli aspetti morali più equivoci che ne decretano
l’instabilità dei valori. In questo si accorda con Leopardi il quale muove dall’esterno le
sue critiche a un mondo al quale sente di non appartenere.
5. 3 Il pargoleggiare del secolo nuovo
E’ all’epoca di Leopardi (e di Hegel) che si comincia a parlare di tradizioni
“popolari” da un lato e di cultura classica dall’altro, con l’intento di promuovere una
nuova attenzione verso le prime, interpretandole, e di sminuire l’autorità della seconda,
sottraendosi allo studio della retorica, della mitologia, della filosofia antiche. Di fatto si
cercò di creare una spazio mediano fra le due e la cultura romantica non è altro se non
una commistione di “saperi di vita”, presi a prestito ora dalle vite dei santi, ora
dall’esempio offerto dalle gesta degli eroi popolari o dall’impegno profuso da figure di
intellettuali e politici “amici del popolo”. Sono i cascami della cultura, quel che si legge
sui giornali, quello che si sente dire per le vie e nei caffé o si legge nei romanzi da poco
conto o nei libri di viaggi se non anche sugli almanacchi. Più che non l’arte, nel senso di
una professione da svolgere, interessa che il nuovo “filosofo” possieda il senso di un’arte
del vivere, difficile a definirsi, attenta a disciplinare i comportamenti umani secondo
l’utile di una civile convivenza. Di qui l’attenzione ai sentimenti, che non sono più
“passioni” o “idee”, ma naturali inclinazioni dell’animo. Ampliando un po’ il discorso, ci
si perdonerà se avanziamo l’idea che perfino il decadentismo, specie per come è stato
presentato al pubblico, non fece che proseguire in questo equivoco atteggiamento
mentale per cui si cerca qualcosa (un fondamento, un valore, un principio), senza
chiedersi se questa ricerca sia autentica e non nasconda, oltre a una costituzionale
incapacità di trovare qualcosa, anche una sostanziale indifferenza alla questione, che ci
pare emerga finalmente dalle pieghe di tanto esasperante egotismo che domina la cultura
contemporanea. Quasi che avesse colto le direttrici di una ricerca che equivocamente
muovesse in tale direzione, Leopardi interviene a demolirne con esasperante disinvoltura
e intelligenza la validità.
5.4 Il senso delle Operette
Le Operette morali sono, ci pare, un invito a specchiarsi veramente nei problemi e
nelle questioni di un mondo che cambia. Non va bene rivoltare le cose e continuare a
ragionare come prima, semplicemente ignorando i problemi. Non va bene criticare
l’ordine costituito perché mal costituito e non portare avanti la critica alla vecchia
cultura, ai vecchi valori, proponendo un’arte nuova, una filosofia nuova, una cultura
nuova. La mancata elaborazione di concetti autenticamente rispondenti alle nuove realtà
è per Leopardi inconcepibile. Vuoi essere critico? Devi esserlo fino in fondo, non a metà.
Perciò ottimismo e credulità sono i principali bersagli contro cui va a colpire. Ma l’errore
che più energicamente le Operette morali perseguono è la viltà di un pensare che consiste
nel continuare a cercare, come in passato si era fatto, delle regole a cui obbedire.
C’è in Leopardi una sorta di commovente machiavellismo, che dà delle autentiche
vertigini al lettore delle Operette, che prenda sul serio il percorso lungo il quale si mette
l’autore. E’ un machiavellismo che non interessa il principe, personaggio ormai destituito
di forza e di credibilità, ma del tutto imprevedibilmente l’intellettuale. Questa figura,
ormai totalmente decaduta e priva non solo di potere ma perfino di credibilità, era
all’epoca di Leopardi all’apice della sua storia e non stupisce che, guardando lucidamente
al prossimo futuro, questo grande intellettuale provasse orrore per il baratro nel quale
l’intellettuale si preparava a cadere. Leopardi sa che nell’Ottocento non sono i
Napoleoni a fare il mondo, a definirlo, a contenerlo, a governarlo, ma i Copernico e i
Galilei. Questi ultimi, secondo quanto abbiamo letto nello Zibaldone e nel Parini,
compiono il loro ufficio senza che nessuno se ne accorga, poi qualche mediocre ne
cavalca la tigre, facendosi grande agli occhi del mondo. Ma tant’è, il mondo deve pure
trovare chi se lo porti sulle spalle. Il dialogo tra Copernico e il Sole, che leggiamo nel
Copernico , ha in questo senso una valenza chiarissimamente metaforica, con il Sole che
si piega alla “vergogna” di ricevere istruzioni da un omino che “pensa e studia” invece di
comandare sui popoli.
Il machiavellismo applicato dai filosofi muta peraltro nel segno rispetto a quello a
cui i principi avevano fatto ricorso. Invece di “fregare il popolo” si tratta di studiare il
modo di renderlo partecipe, fino virtualmente a fargli intendere che il principe saggio e
virtuoso anche politicamente è quello che, agendo nell’interesse comune, arriva pure
all’impopolarità, secondo l’esempio di un Robespierre, schiacciato da due diverse
mentalità politiche, reso piccolo dalla sua grandezza e grande dalla sua mediocrità. E qui
ci piace ricordare il fascino che agli occhi di Leopardi e di molti italiani della sua
generazione ebbe la figura di Bruto.
Aspetti originali della filosofia leopardiana
Dalla politica passando alla filosofia o alla filosofia politica, la cosa importante che
si cela dietro questa novità è la rivendicazione di una libertà piena, totale, autentica del
pensiero, che non vuol saperne più di piegarsi a una disciplina quale che sia. Per
Leopardi l’intelletto umano è costitutivamente libero perché privo di barriere. E’ il primo
filosofo a supporre che non esistano confini oltre i quali la mente non possa andare. Può
essere che un tale insegnamento gli provenga da Platone, infatti come dice bene Stefano
Biancu, c’è un rischio “insito nella ricerca di una verità che non si limiti alle ristrette
secche del certo e del dato” Tale incerto (e tale rischio) – osserva sempre Biancu – abita,
nel pensiero di Leopardi lo spazio di un ‘oltre la soglia’, per il quale vale la pena di
arrischiare la vita. Perché il rischio, come insegna un Platone caro a Leopardi “è bello”
(Fedone, 114d)19. In ogni caso Leopardi ha capito che una tale pretesa aveva in passato
dato forza a un potere che non esitava a proibire di spingersi col pensiero oltre certe
barriere, dove le barriere erano poste dai religiosi. Quest’ultimo punto è importante e
merita un approfondimento. Governare le paure ancestrali è stato per secoli, e ancora
continua a esserlo, un’importante, anzi fondamentale, funzione sociale e culturale svolta
dalla religione. L’orrore del male è qualcosa che naturalmente si prova e con questo
disagio occorre imparare a convivere. Ma poi quest’orrore è così forte da scoraggiarci,
tanto che spesso ci fa vili. A questo punto impariamo a non pensare più, a non farci più
domande. A questo silenzio dell’anima Leopardi si ribella e riaffiora da quello che
vorremmo chiamare il naufragio nel mare del pensiero, con una nuova domanda.
Riferendosi a “quello che ha detto dell’essenza di Dio”, lo scrittore annota nello
19
. S. Biancu, La poesia e le cose: su Leopardi, Mimesis, Milano 2006, p. 64.
Zibaldone:
Lasciando in piedi tutto ciò che la fede insegna su questo punto, io non fo che spaziarmi in ciò
ch’è permesso al filosofo, cioè nelle speculazioni sull’arcana essenza di Dio, speculazioni non men lecite
al filosofo che al teologo, giacché anche questi dopo che ha lasciata intatta la rivelazione, e che scorre col
pensiero a quelle cose a cui la rivelazione non giunge, senza però escluderle né contraddirle, allora,
20
dico, il teologo si confonde col filosofo .
Leopardi insomma si domanda se sia vero che il pensiero possa “peccare”, e trova
che il pensiero è di per sé innocente. Di qui inizia quella che egli chiamò la sua
“conversione”. Completando il suo ragionamento, potremmo aggiungere che se, per
esempio, non credo in Dio, devo trovare la forza d’animo per confessare a me stesso
questa incredulità. Del resto, se nel profondo della mia coscienza a Dio non credo, ma mi
guardo dall’ammetterlo per paura, chi mi salverà dallo sguardo di questo giudice
tremendo e inesorabile, che interrogandomi, riuscirà a farmi riconoscere che io
effettivamente non avevo fede? Non c’è modo peggiore di spendere la propria vita, se
non fingendo d’essere chi non si è. Qui Leopardi è vicino a Kierkegaard e sente di dover
lottare contro la viltà, guardando bene alle paure dell’uomo, a costo di perdersi in quello
che gli pare il male della civiltà: il taedium vitae, nel quale peraltro scivola con un senso
quasi di piacere, consapevole della grandezza spirituale di cui il sentimento della noia è
spia.
E’ veramente strano a questo punto come non si sia valutato che il personaggio del
secolo, quello in certo modo speculare e, più che contrario, complementare all’ io
leopardiano che dall’immaginario si protende verso la vita reale, dandone una
rappresentazione fedele, sia la monaca di Monza che, per soggezione al padre butta via
la sua esistenza. D’intuito anche Manzoni ha affrontato la questione della paura di quel
che pensiamo, dell’autocensura, della soggezione all’autorità, usando a questo scopo lo
schermo di due personaggi, Don Abbondio e Gertrude. Lo scrittore preferisce, peraltro,
studiare la psicologia di lei, non quella di lui. La donna, del resto, non è vile, almeno nella
coscienza collettiva del nostro Ottocento, per definizione anche quando sia timorosa. Le
ansie e le paure che prova si rivestono infatti di sentimenti. Ma sarebbe da chiedersi,
uscendo fuori dalla finzione letteraria che pure presenta una verità storica, quanti uomini
dell’Ottocento e del Novecento siano stati in Italia, incapaci, come la monaca di Monza,
di interrogarsi a fondo sulle proprie scelte.
20
. Zibaldone [2178]
Nelle Operette morali ne troviamo un esempio nel tipo del Fisico che dialoga col
Filosofo. Il fisico, cioè il medico, pretende di aver trovato il modo per rendere più felici
gli uomini allungandone la vita. Il Filosofo gli spiega che meglio sarebbe stato se avesse
speso il suo tempo a rendere la vita degli uomini felice.
E qui vien da dire che avesse ragione Papini a dire che il punto è che chi è
veramente pessimista, non impiega il suo tempo a scrivere per far arrivare ad altri un
messaggio21.
E il messaggio morale di Leopardi, se bene abbiamo capito quel che egli vuol dire,
è che battere la Chiesa nel nome di una moderna pietas che insista a percorrere la via della
sincerità è nell’Ottocento troppo tardi. Combattere la Chiesa nel nome di Cristo, come
pure in passato qualcuno aveva fatto, è ormai impossibile e anacronistico. Non sono più
i tempi di Francesco d’Assisi o di Martin Lutero, e anche per questo forse la strada
scelta da Leopardi è così diversa da quella di Kant, il quale diversamente da lui, pone dei
limiti al pensiero dell’uomo e, proibendo al filosofo d’occuparsi di Dio e di metafisica,
lascia la metafisica ai teologi confessionali.
Nato suddito dello Stato Pontificio, Leopardi sa che la grande macchina
organizzativa con cui ai suoi tempi si reggono le sorti della cristianità non ha nulla a che
vedere con l’ecclesia, di cui nominalmente fanno parte a pari titolo tutti i fedeli. Il mondo
chiuso delle alte gerarchie della Chiesa non gli piace. Volterà perciò le spalle
all’opportunità che con insistenza la famiglia gli offre di iniziare una brillante, se non
brillantissima, carriera ecclesiastica. Non gli difettano né intelligenza, né cultura, né
nascita, né relazioni d’amicizia e parentela per poter ambire alla porpora di Cardinale.
Chissà! E’ in fondo il liberalismo, sia pure di marca piuttosto illuministica che non
romantica, a suggerirgli una nuova prospettiva di vita e di pensiero.
Il punto è che Leopardi trae ispirazione dal mondo classico, come, a nostro avviso
giustamente, seppe vedere Gioberti, il quale,come abbiamo già ricordato, riferì l’opera di
Leopardi a una tradizione pagana che si era a lungo mantenuta nel mondo letterario
italiano22. E’ il mondo classico a indicargli un ideale di virtù e di coraggio. Virtù e coraggio
che Leopardi vede mancare agli uomini del suo tempo.
A noi sembra che viltà e coraggio siano i due estremi di una possibile morale
21
22
. G. Papini
. vedi
leopardiana che tra questi due estremi raggruppa i vizi e le virtù degli uomini. La viltà è
male, il coraggio è bene. Questa persuasione si arricchisce peraltro di un aspetto nuovo e
inedito: come abbiamo visto, Leopardi scopre che non tanto l’anima quanto la mente può
avere o non avere coraggio. La viltà di cuore, la paura spesso istintiva del pericolo che ci
minaccia e che l’educazione un tempo impartita spingeva a vincere con prove
d’ardimento è scusata da Leopardi, che è invece severissimo di fronte alla pigrizia
intellettuale, alla paura di concedere al pensiero di spaziare il più liberamente che possa,
mettendo a nudo un tipo singolarissimo di viltà a cui cediamo solo per non rinunciare a
sciocchi pregiudizi sociali.
Come abbiamo già detto, non è un caso che di qui si origini la “conversione” di
Leopardi alla filosofia, come lui stesso la chiamò23. Anzi nelle Operette in particolare si
ricostruisce l’itinerario che porta alla scoperta di questo specifico modo d’essere vili e
l’ironia più che non un arma è un aratro che pulisce il campo da queste erbacce.
Per come gli viene presentata, Leopardi non ama la filosofia tedesca che sembra
sulla scia di Immanuel Kant perseverare nel tentativo di fissare dei limiti al pensiero che,
per Leopardi, non va governato perché si governa da solo. Si obietterà che questa è poi la
conclusione a cui arriverà lo stesso Kant. E’ vero, ma il fatto è che per Leopardi si tratta
di un assunto da cui partire e in questo senso non stupisce quel che della filosofia
tedesca egli scrive:
Ho detto che nessuna veramente strepitosa scoperta nelle materie astratte, e in qualsivoglia dottrina
immateriale è uscita dalle scuole ec. tedesche. Quali sono in queste materie le grandi scoperte di
Leibnizio, forse il più gran metafisico della Germania, e certo profondissimo speculatore della natura, gran
matematico ec? Monadi, ottimismo, armonia prestabilita, idee innate; favole e sogni. Quali quelle di
Kant, caposcuola ec. ec.? Credo che niuno le sappia, nemmeno i suoi discepoli. Speculando
profondamente sulla teoria generale delle arti, i tedeschi ci hanno dato ultimamente il romanzo del
romanticismo, sistema falsissimo in teoria, in pratica, in natura, in ragione, in metafisica, in dialettica in
24
parecchi di questi pensieri.
Il punto è che per Leopardi non si può pretendere di costruire una nuova cultura,
quale quella progettata dai primi umanisti che faticosamente erano usciti dal medioevo, al
medioevo tornando. Non si può procedere, tornando indietro e facendo appello alle
suggestioni che vengono da un mondo che vogliamo cambiare. Spunta qui, secondo noi, il
libertino erudito che non riconosce al filosofo il diritto di insegnare ad altri come si debba
pensare. Per Leopardi ognuno dev’essere filosofo per sé. Anche per questo non espone
23
24
Cfr.
Zibaldone [1857]
la sua filosofia, ma si limita a scandalizzare il lettore col suo pessimismo che non è
nient’altro se non la critica all’ottimismo dei benpensanti che hanno fretta a condividere
le opinioni di qualcuno. L’obbligo morale del lettore delle Operette è infatti questo:
provare a farsi un’idea, a pensare il mondo. In questo senso è vero quel che dice
Ugo
Dotti, cioè che Leopardi volesse dare con le Operette un saggio di come evitare che
“l’errore si trasformasse in pregiudizio, per liberare l’uomo dalle catene delle false
superstizioni”25
Non è un caso che gli eroi dei dialoghi che compongono la prima parte delle
Operette siano cosmologi, moralisti e viaggiatori, cioè persone che il mondo lo pensano
problematicamente, ora disegnandolo, ora interpretandolo, ora raccontandolo. Una
cosmologia, quella leopardiana che colpisce perché ricomprende anche la morte, che è un
problema (o se si preferisce un tema) cosmologico. Le cose del mondo infatti nascono
tutte e tutte muoiono.
25
U. Dotti, Lo sguardo sul mondo, op. cit. p. 9.