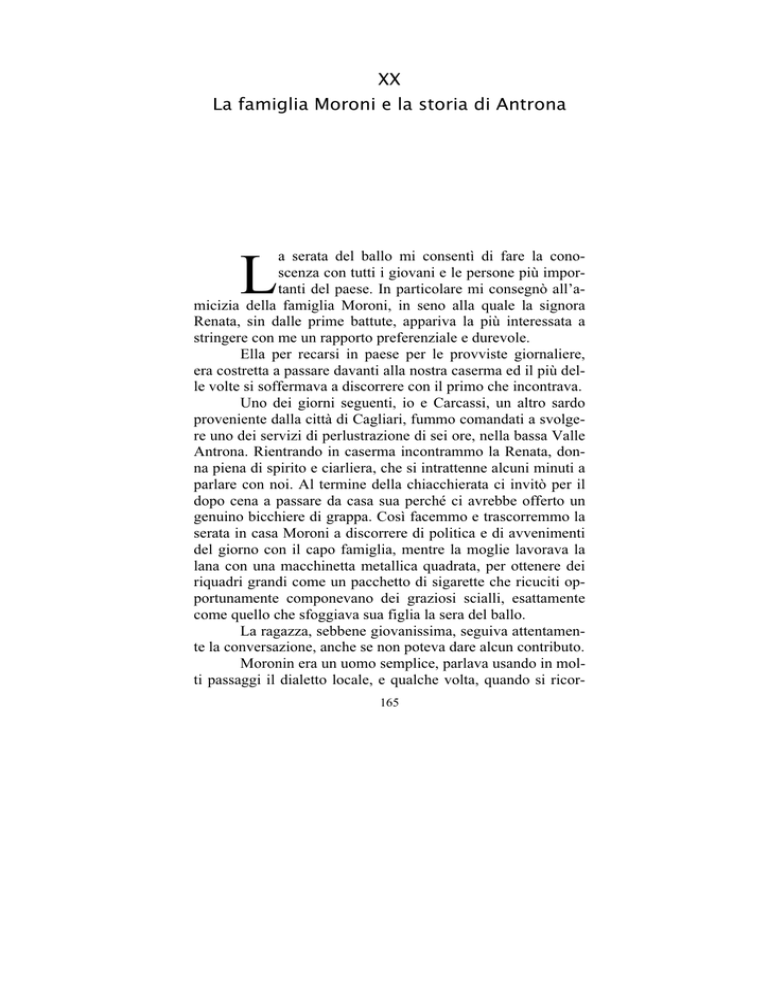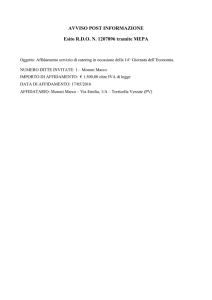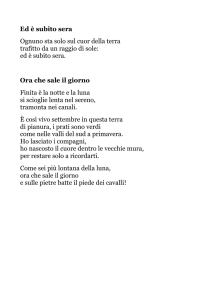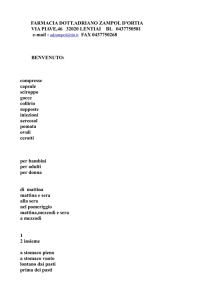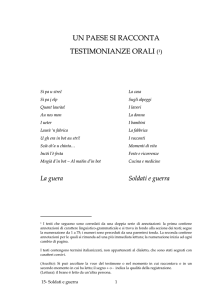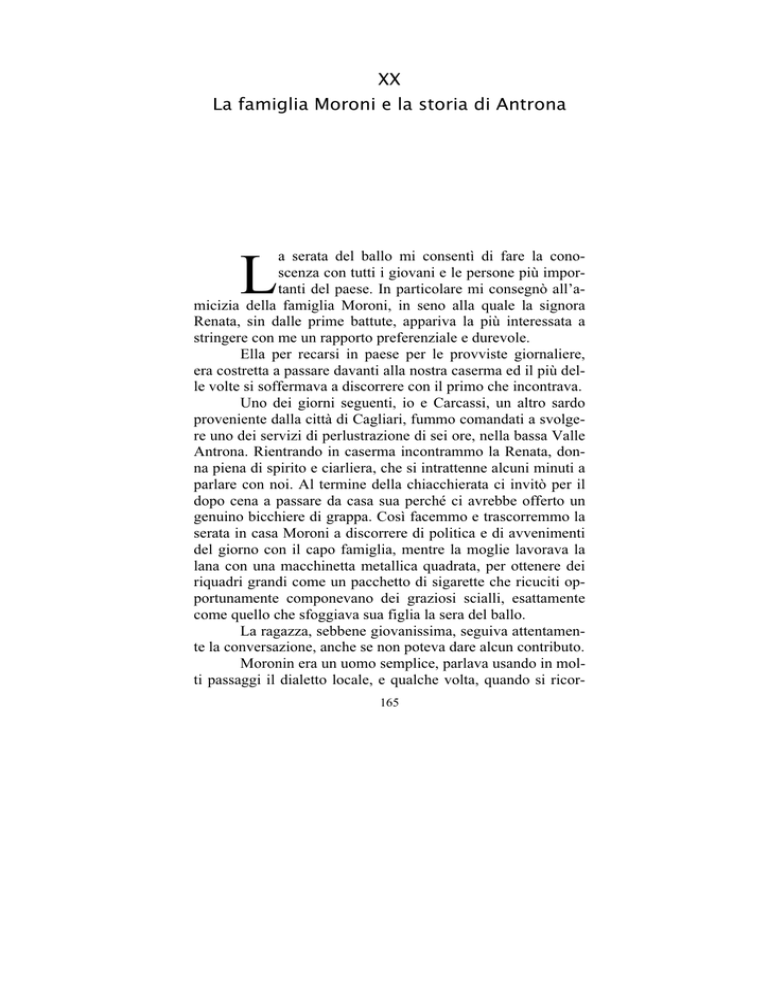
XX
La famiglia Moroni e la storia di Antrona
L
a serata del ballo mi consentì di fare la conoscenza con tutti i giovani e le persone più importanti del paese. In particolare mi consegnò all’amicizia della famiglia Moroni, in seno alla quale la signora
Renata, sin dalle prime battute, appariva la più interessata a
stringere con me un rapporto preferenziale e durevole.
Ella per recarsi in paese per le provviste giornaliere,
era costretta a passare davanti alla nostra caserma ed il più delle volte si soffermava a discorrere con il primo che incontrava.
Uno dei giorni seguenti, io e Carcassi, un altro sardo
proveniente dalla città di Cagliari, fummo comandati a svolgere uno dei servizi di perlustrazione di sei ore, nella bassa Valle
Antrona. Rientrando in caserma incontrammo la Renata, donna piena di spirito e ciarliera, che si intrattenne alcuni minuti a
parlare con noi. Al termine della chiacchierata ci invitò per il
dopo cena a passare da casa sua perché ci avrebbe offerto un
genuino bicchiere di grappa. Così facemmo e trascorremmo la
serata in casa Moroni a discorrere di politica e di avvenimenti
del giorno con il capo famiglia, mentre la moglie lavorava la
lana con una macchinetta metallica quadrata, per ottenere dei
riquadri grandi come un pacchetto di sigarette che ricuciti opportunamente componevano dei graziosi scialli, esattamente
come quello che sfoggiava sua figlia la sera del ballo.
La ragazza, sebbene giovanissima, seguiva attentamente la conversazione, anche se non poteva dare alcun contributo.
Moronin era un uomo semplice, parlava usando in molti passaggi il dialetto locale, e qualche volta, quando si ricor165
dava di essere di fronte a dei foresti, traduceva in italiano alcuni termini, per timore di non essere compreso. Era chiaro
che in famiglia si usava il dialetto, tanto che la Renata e la figlia facevano fatica a completare una frase senza utilizzare nei
passaggi più impegnativi il loro idioma. Io, dopo le prime battute in cui mi trovai disorientato, lentamente incominciai a capire più per logica o studio dei gesti che per altro.
Il nostro uomo incominciò poi a parlare delle lotte partigiane che avevano visto la Val d’Ossola teatro di feroci vendette durante le ultime fasi della “liberazione”. Alle ore 22,30
salutammo perché era l’ora della ritirata, non senza assicurare i
signori Moroni che saremmo ritornati a passare la sera in loro
compagnia quando volevamo.
Iniziai a frequentare quella famiglia anche da solo, data
la comodità di raggiungere l’abitazione, proprio lì a cinquanta
metri verso valle, in prossimità della curva sul ponte che attraversava il torrente Troncone e dove era posto il cartello stradale di arrivo in Antronapiana. Il Troncone più a valle si congiunge con il Loranco e forma il più grande Ovesca che prosegue sino a Villadossola dove si versa nel Toce (Foto n. 25).
Questa famiglia abitava in una vecchia e lunga baracca,
tutta posta a piano terra ed a forma rettangolare. Le pareti, il
pavimento ed il soffitto erano completamente in legno, e nel
vederla dall’esterno se non si notava il fumaiolo di zinco sporgente dalla costruzione si aveva l’impressione di entrare in un
deposito o magazzino (Foto n. 26).
Davanti aveva un ampio piazzale in terra battuta e nella
parte posteriore, più lontana dalla strada, si notava una casetta
in cui era situato il pollaio con una diecina di galline ed un gallo. In un angolo riparato, vicino alla porta di ingresso, c’era
una grossa catasta di tronchetti di legno molto bene allineati
che dovevano servire ad alimentare la stufa per riscaldare la
casa durante l’inverno.
Anche qui, all’interno, non mancava la tipica miscela
di odori di ambiente chiuso che avevo notato la prima sera nelle botteghe del paese, e che al primo impatto mi facevano rimpiangere la fresca e sana aria esterna. I locali erano angusti e
l’arredamento molto semplice. La sala più importante era con166
temporaneamente cucina e sala da pranzo. In un angolo era
posizionata la stufa a legna per la cottura dei cibi, un lavandino
con acqua corrente, ed a fianco una grossa credenza a vetri
all’interno della quale si vedevano ben riposti cibi e stoviglie.
Sulla parete opposta troneggiava un largo camino, sempre acceso, con alte lingue di fuoco perché doveva contribuire a riscaldare. Tra la stufa e il camino ben allineati dentro ad una
cassa di legno era deposta la legna asciutta, pronta per rinfocolare l’una e l’altro e tenere sempre ben caldo l’ambiente. Al
centro della saletta c’era un tavolo di legno non molto grande,
attorno al quale passavamo le ore a discorrere su argomenti vari e principalmente sulla storia della Valle. Il pavimento di legno scricchiolava sotto i nostri piedi ad ogni movimento mentre io ascoltavo con molto interesse i racconti dell’ultima guerra da parte del Moronin.
Quando passavo la serata in casa Moroni la signora si
prodigava nell’offrirmi assaggi di piatti particolari tipici locali.
Fu qui che una sera mi venne offerto una pietanza veramente
eccezionale: lo spezzatino di “gatto”, sì, proprio gatto, cucinato con maestria dalla signora Renata. A me sembrava più carne
di coniglio che altro. Ebbene mi fu spiegato che per togliere il
selvatico dalla carne di gatto, bisognava introdurre la bestia
uccisa in un sacco e tenerla per dodici ore immersa nell’acqua
corrente del torrente, in modo che scaricasse il sapore pungente. In loro compagnia imparai a gustare i profumati formaggi
di mucca, ottenuti dalla lavorazione del latte munto negli alpeggi. Imparai ad apprezzare il gusto ed il profumo del vero
sbrinz, un formaggio conosciuto sin dal ’500, quando il vescovo di Novara ne aveva mandato due casse in dono allo stesso
Papa.
I piatti locali erano principalmente a base di carne, polenta, zuppe di verdure o “masclota”, funghi in umido, e castagne bollite con acqua, vino, zucchero, sale e burro. Le castagne così cariche di gusto e di calorie, venivano consumate
con vino o latte fresco. Erano molto in uso anche piatti a base
di legumi, verdure e patate. Il mio interlocutore ci tenne però a
precisare che in montagna nelle malghe, durante l’alpeggio estivo, i pasti che consumavano gli antronesi erano molto più
167
semplici. Quando in primavera riportavano gli armenti nei pascoli oltre i mille metri, si trascinavano a spalle semplicemente
sacchi di polenta e bottiglioni di vino. Al mattino ed a sera abbinavano la polenta con il latte munto dalle loro mucche, oppure con il vino. Per i loro pasti adoperavano un grosso cucchiaio che immergendolo in una grossa ciotola lo riempivano
contemporaneamente con un boccone di polenta e un sorso di
latte o vino. Se la malga era in prossimità di uno dei cinque laghi del territorio, avevano la possibilità di arricchire la mensa
con la cottura sulla brace delle trote pescate, condite con il loro
burro, di cui erano bravi produttori e ghiotti consumatori. Con
questa sobria e salutare alimentazione, abbinata al movimento
continuo per seguire e controllare gli armenti al pascolo, i valligiani non avevano bisogno di particolari diete per mantenere
una corporatura asciutta e snella.
Il Moroni era uomo mite, di buona cultura, socievole e
desideroso di scambiare idee e opinioni; amava la sua Valle di
cui aveva più di altri approfondito gli usi ed i costumi e le origini remote. La mia innata curiosità non aspettava altro che incontrare un uomo così per apprendere idee e notizie di avvenimenti verificatisi in situazioni ed ambienti molto lontani dal
mio.
Da lui imparai a conoscere, sera per sera, tante notizie
sulla Valle e sui valligiani, sulle origini del luogo e sulla provenienza degli uomini che nei tempi andati erano venuti a popolare questa zona impervia e misteriosa. Quante novità dovevano arrivare alle orecchie di un “campano” da parte di un
“antronese”!
Mentre respiravo l’aria del Monte Rosa fortemente incuriosito dalle rivelazioni del Moronin, spesso il pensiero correva al mio lontano luogo di provenienza, poco distante dalle
falde del Vesuvio. Ascoltavo con grande attenzione le affascinanti notizie sui miti e sulle leggende che avvolgevano la Valle, sulle varie ipotesi riguardanti i primi suoi abitatori e imparai a conoscere il nome delle alte vette che proteggono e minacciano nello stesso tempo questa isolata vallata. Più raccontava e più cresceva in me la voglia di apprendere e approfondire; le serate invernali erano lunghe e pertanto giocavano un
168
ruolo tutto a mio favore e inoltre mi consentivano di beneficiare di un amichevole ambiente familiare, di un sito ben riscaldato e di una spontanea e disinteressata accoglienza.
Seppi che la montagna più alta del territorio è il Pizzo
Andolla, che tocca i 3656 metri di altezza. E’ questa la montagna sacra del versante italiano contrapposta all’elvetica Weissmies, che custodisce i segreti dei “Ses”, o dei “Sassi”. I cittadini antronesi si chiamano anche “Ses” (da sasso) al maschile
e “Sosa” al femminile, sempre riferiti ai sassi che erano sparsi
ovunque.
Moroni mi spiegò che sull’origine del paese non esistevano notizie certe, né date certe e che varie erano le ipotesi
formulate da studiosi negli ultimi tempi. Egli aveva attinto anche ad alcune leggende tramandate oralmente, da vecchi di
Antrona, allora purtroppo non più in vita. Era quindi pervenuto
ad una sua personale conclusione che mi avrebbe esposto in
quelle buie e fredde notti del gennaio 1956, se io avessi avuto
la voglia e la pazienza di ascoltarlo.
Ero come incantato e non mi sembrava vero di essere
divenuto inconsapevolmente amico dell’uomo giusto, e pertanto lo assicurai che sarei stato ben felice di apprendere a quali
conclusioni era arrivato sulle origini degli antichi abitatori di
quelle vette incontaminate, di quelle acque scroscianti e di
quelle terre conquistate ed abbandonate nel corso dei millenni.
Il mio narratore aveva circa cinquant’anni ed una buona cultura, e tra l’altro aveva l’abilità di tenermi legato alle sue
incessanti narrazioni, arricchite da termini prettamente locali,
ma soprattutto per la passione che scaturiva dalle sue parole.
In più sere appresi come in un film a puntate le varie soluzioni
possibili.
La prima ipotesi avanzata e ritenuta, a suo dire, la meno credibile riguardava l’arrivo in valle di una tribù di GalliLeponzi facenti parte della popolazione celtica. Riferì poi di
un’altra possibilità, ma anche questa scarsamente attendibile,
da parte sua, della invasione dei Normanni o Vichinghi provenienti dalle regioni scandinave. Aggiunse che questo popolo
feroce e privo di regole, poco conoscitore del Mediterraneo,
arrivato alla foce del Magra lo confuse con il Tevere e scam169
biò la città di Luni con quella di Roma a causa dei suoi sontuosi palazzi ricoperti di bianche lastre di marmo, per cui la rase al suolo.
Luni era un’antica città dell’Etruria situata sulla riva
sinistra del Magra, abitata sin dal paleolitico e in più fasi occupata dagli etruschi, dai liguri e anche dai romani. Intorno
all’anno 100 a.C. Roma vi stabilì una base militare con l’invio
di circa duemila uomini che ampliarono il porto per fornire alla Madre Patria blocchi sgrossati di marmo bianco, cavati dalle
vicine Alpi Apuane, necessari per scolpire statue, per pavimentare regge, per rivestire palazzi e per costruire templi nella
Città Eterna. Sino ad allora i romani avevano dovuto acquistare i marmi dalla vicina e non sempre amichevole Grecia. I Vichinghi intorno all’anno 900, giunti di fronte a questa grande e
lussuosa città, attraversata da un lungo fiume e situata a poche
miglia dal mare come Roma, e accecati dall’odio verso i romani, furono tratti in inganno dalla posizione di Luni, e perciò,come abbiamo detto, la incendiarono e la rasero al suolo.
Un gruppo di questi pirati, sconfitti dai romani accorsi in aiuto
di quella colonia, sarebbe sfuggito ad un caparbio inseguimento e, superata la valle padana, avrebbero raggiunto Antrona,
attraversando indenni tutto l’arco alpino.
Mi parlò poi anche della possibilità, maggiormente attendibile, della presenza in valle dei Sassoni; attendibilità dovuta all’assonanza del loro nome con il nomignolo di “Ses”,
attribuito agli abitanti di Antronapiana. Anche i Sassoni erano
un popolo che abitava a nord dell’attuale Germania, sconfitto a
più riprese in epiche battaglie da Carlo Magno, Imperatore del
Sacro Romano Impero, che con un editto intimò agli sconfitti
di convertirsi al cristianesimo o, in alternativa, subire la decapitazione. Una tribù per sottrarsi al genocidio, non volendo
abbracciare una nuova religione, ma conservare la credenza
nei propri idoli e totem, organizzò la fuga dalla propria terra e
iniziò un lungo vagabondare nel centro d’Europa. Attraversò
la Germania, la Svizzera, sostò nella Val di Saas, e attraverso
l’omonimo valico scese nella piana di Antrona. Avendola trovata disabitata, vi si stabilì.
L’uomo narrava con soddisfazione e piacere le varie
170
ipotesi da lui conosciute, mentre io ormai scalpitavo per conoscere quella che egli ritenesse la più attendibile. Insisteva nella
sua narrazione secondo un disegno preciso, e non si lasciava
influenzare da me che volevo rapidamente arrivare a conoscere
il popolo che con maggiori probabilità aveva dato origine a
quella gente mite e operosa. Più lui ritardava a dare una risposta convincente alle mie domande e più cresceva la mia curiosità. Con un sorriso compiaciuto e soddisfatto, una sera mentre
mi congedavo dalla sua casa, quasi per assicurarsi la mia presenza per la sera successiva, il Moronin mi promise che la volta seguente mi avrebbe parlato dell’ultima ipotesi, la più attendibile, secondo la sua personale convinzione e le sue conoscenze .
171