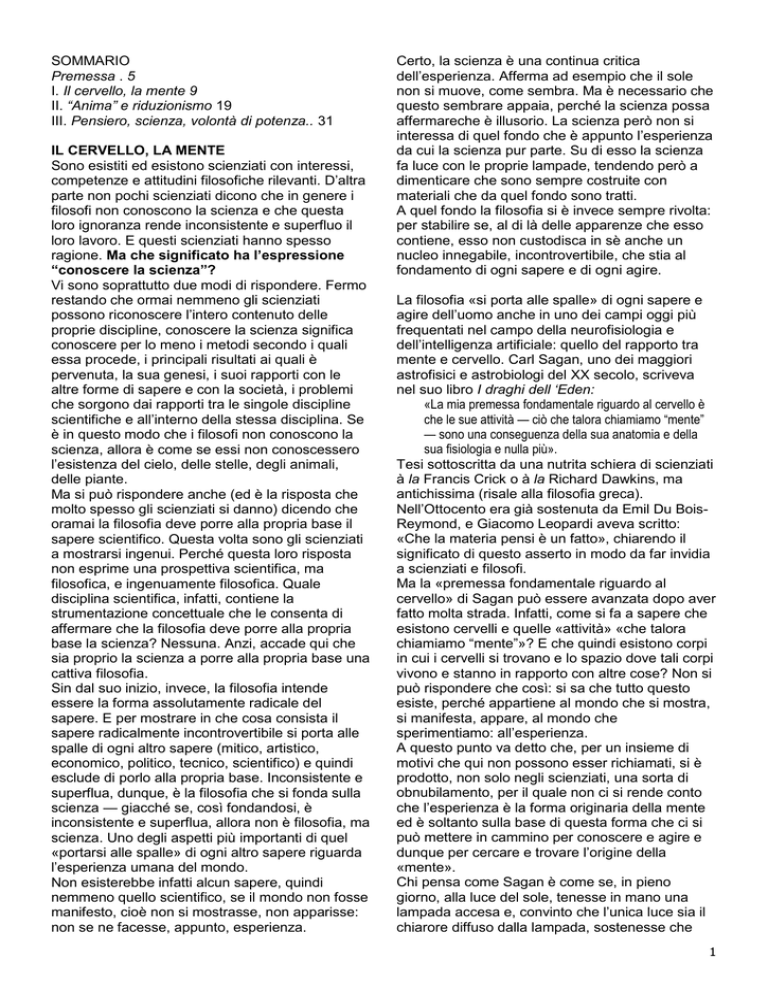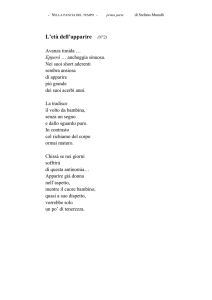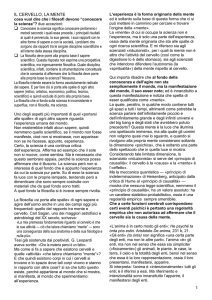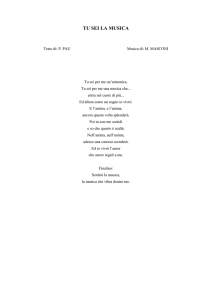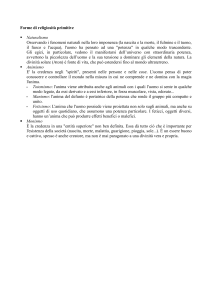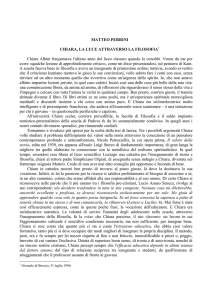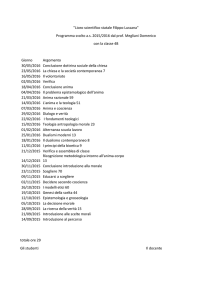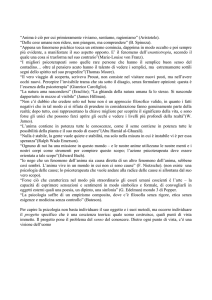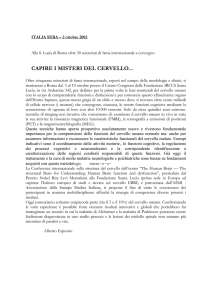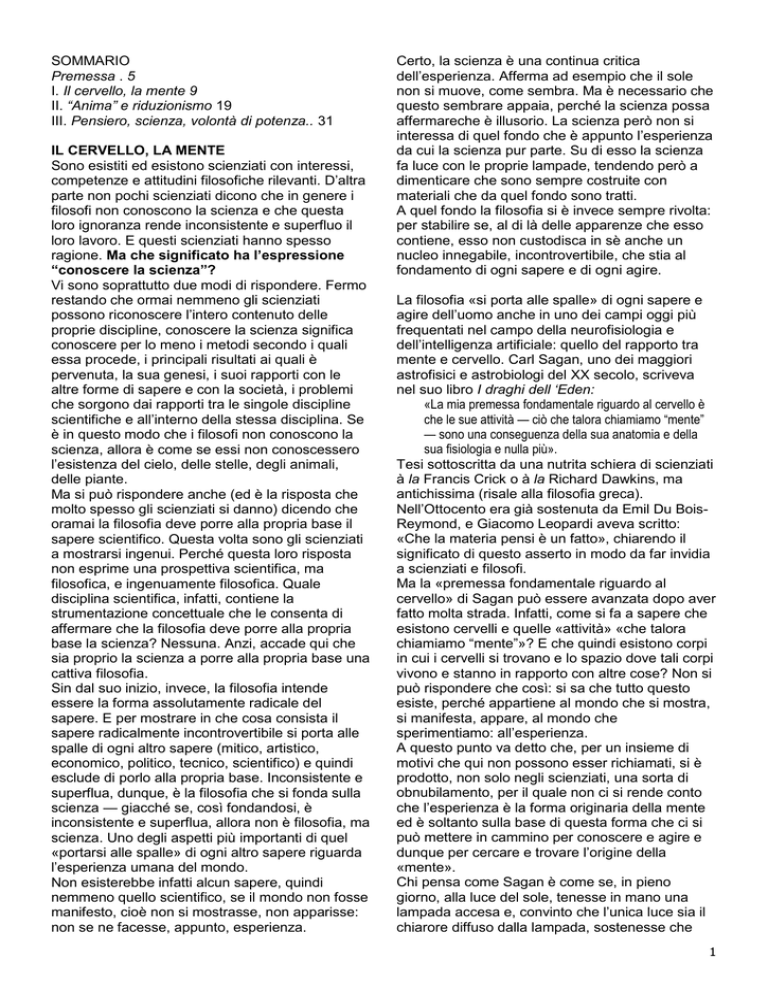
SOMMARIO
Premessa . 5
I. Il cervello, la mente 9
II. “Anima” e riduzionismo 19
III. Pensiero, scienza, volontà di potenza.. 31
IL CERVELLO, LA MENTE
Sono esistiti ed esistono scienziati con interessi,
competenze e attitudini filosofiche rilevanti. D’altra
parte non pochi scienziati dicono che in genere i
filosofi non conoscono la scienza e che questa
loro ignoranza rende inconsistente e superfluo il
loro lavoro. E questi scienziati hanno spesso
ragione. Ma che significato ha l’espressione
“conoscere la scienza”?
Vi sono soprattutto due modi di rispondere. Fermo
restando che ormai nemmeno gli scienziati
possono riconoscere l’intero contenuto delle
proprie discipline, conoscere la scienza significa
conoscere per lo meno i metodi secondo i quali
essa procede, i principali risultati ai quali è
pervenuta, la sua genesi, i suoi rapporti con le
altre forme di sapere e con la società, i problemi
che sorgono dai rapporti tra le singole discipline
scientifiche e all’interno della stessa disciplina. Se
è in questo modo che i filosofi non conoscono la
scienza, allora è come se essi non conoscessero
l’esistenza del cielo, delle stelle, degli animali,
delle piante.
Ma si può rispondere anche (ed è la risposta che
molto spesso gli scienziati si danno) dicendo che
oramai la filosofia deve porre alla propria base il
sapere scientifico. Questa volta sono gli scienziati
a mostrarsi ingenui. Perché questa loro risposta
non esprime una prospettiva scientifica, ma
filosofica, e ingenuamente filosofica. Quale
disciplina scientifica, infatti, contiene la
strumentazione concettuale che le consenta di
affermare che la filosofia deve porre alla propria
base la scienza? Nessuna. Anzi, accade qui che
sia proprio la scienza a porre alla propria base una
cattiva filosofia.
Sin dal suo inizio, invece, la filosofia intende
essere la forma assolutamente radicale del
sapere. E per mostrare in che cosa consista il
sapere radicalmente incontrovertibile si porta alle
spalle di ogni altro sapere (mitico, artistico,
economico, politico, tecnico, scientifico) e quindi
esclude di porlo alla propria base. Inconsistente e
superflua, dunque, è la filosofia che si fonda sulla
scienza — giacché se, così fondandosi, è
inconsistente e superflua, allora non è filosofia, ma
scienza. Uno degli aspetti più importanti di quel
«portarsi alle spalle» di ogni altro sapere riguarda
l’esperienza umana del mondo.
Non esisterebbe infatti alcun sapere, quindi
nemmeno quello scientifico, se il mondo non fosse
manifesto, cioè non si mostrasse, non apparisse:
non se ne facesse, appunto, esperienza.
Certo, la scienza è una continua critica
dell’esperienza. Afferma ad esempio che il sole
non si muove, come sembra. Ma è necessario che
questo sembrare appaia, perché la scienza possa
affermareche è illusorio. La scienza però non si
interessa di quel fondo che è appunto l’esperienza
da cui la scienza pur parte. Su di esso la scienza
fa luce con le proprie lampade, tendendo però a
dimenticare che sono sempre costruite con
materiali che da quel fondo sono tratti.
A quel fondo la filosofia si è invece sempre rivolta:
per stabilire se, al di là delle apparenze che esso
contiene, esso non custodisca in sè anche un
nucleo innegabile, incontrovertibile, che stia al
fondamento di ogni sapere e di ogni agire.
La filosofia «si porta alle spalle» di ogni sapere e
agire dell’uomo anche in uno dei campi oggi più
frequentati nel campo della neurofisiologia e
dell’intelligenza artificiale: quello del rapporto tra
mente e cervello. Carl Sagan, uno dei maggiori
astrofisici e astrobiologi del XX secolo, scriveva
nel suo libro I draghi dell ‘Eden:
«La mia premessa fondamentale riguardo al cervello è
che le sue attività — ciò che talora chiamiamo “mente”
— sono una conseguenza della sua anatomia e della
sua fisiologia e nulla più».
Tesi sottoscritta da una nutrita schiera di scienziati
à la Francis Crick o à la Richard Dawkins, ma
antichissima (risale alla filosofia greca).
Nell’Ottocento era già sostenuta da Emil Du BoisReymond, e Giacomo Leopardi aveva scritto:
«Che la materia pensi è un fatto», chiarendo il
significato di questo asserto in modo da far invidia
a scienziati e filosofi.
Ma la «premessa fondamentale riguardo al
cervello» di Sagan può essere avanzata dopo aver
fatto molta strada. Infatti, come si fa a sapere che
esistono cervelli e quelle «attività» «che talora
chiamiamo “mente”»? E che quindi esistono corpi
in cui i cervelli si trovano e lo spazio dove tali corpi
vivono e stanno in rapporto con altre cose? Non si
può rispondere che così: si sa che tutto questo
esiste, perché appartiene al mondo che si mostra,
si manifesta, appare, al mondo che
sperimentiamo: all’esperienza.
A questo punto va detto che, per un insieme di
motivi che qui non possono esser richiamati, si è
prodotto, non solo negli scienziati, una sorta di
obnubilamento, per il quale non ci si rende conto
che l’esperienza è la forma originaria della mente
ed è soltanto sulla base di questa forma che ci si
può mettere in cammino per conoscere e agire e
dunque per cercare e trovare l’origine della
«mente».
Chi pensa come Sagan è come se, in pieno
giorno, alla luce del sole, tenesse in mano una
lampada accesa e, convinto che l’unica luce sia il
chiarore diffuso dalla lampada, sostenesse che
1
esso è «conseguenza» dell’«anatomia» e della
«fisiologia» della mano che regge la lampada, «e
nulla più».
La «mente» di cui si occupa la scienza non è cioè
l’esperienza, che include tutto ciò a cui il sapere e
l’agire umano possono rivolgersi, ma è soltanto
una parte dell’esperienza, ossia della mente
originaria che sta alle spalle di ogni ricerca
scientifica. E parlando della «scienza» mi riferisco
sia agli scienziati «riduzionisti», per i quali la
mente non è altro che l’attività del cervello (così
come la digestione non è altro che l’attività dello
stomaco), sia agli scienziati che invece intendono
difendere l’autonomia (o addirittura la
«spiritualità») della mente rispetto al cervello e alla
materia. Non solo: mi riferisco, oltre che a molte
posizioni filosofiche del passato, anche a quella
filosofia che ormai si è lasciata convincere della
necessità di avere alla propria base il sapere
scientifico.
Certo, la parola «esperienza» può essere intesa in
modi del tutto inadeguati rispetto a quanto stiamo
dicendo. Qui importa ribadire che
al fondo della conoscenza e dell’agire non sta
semplicemente il mondo, ma la manifestazione
del mondo, il suo esser noto; ed è innanzitutto
a questa manifestazione e notizia che spetta di
esser qualificata come «mente».
La quale, peraltro, in qualche modo contiene tutti
gli spazi e tutti i tempi, altrimenti come potrebbe la
scienza parlare dell’infinitamente piccolo e
dell’infinitamente grande e degli infiniti universi e
del big bang e degli stati che avrebbero potuto
precederlo? Questa mente è la luce che illumina
uno spettacolo immenso, ma alla quale gli uomini
non volgono quasi mai lo sguardo, e quando si
rivolgono alla propria mente considerano soltanto
la dimensione «psichica», che è soltanto una parte
dello spettacolo che in quella luce si mostra.
Considerando tale limitata dimensione, lo
scienziato «riduzionista» si serve del «principio di
causalità»: il cervello è la «causa» e la «mente» è
l’«effetto».
Il neodarwinismo, che intende la «mente» come
effetto di una evoluzione estremamente
complessa, ha ridato vigore all’uso di quel
principio. Ma la meccanica quantistica — si pensi
al «principio di indeterminazione» di Heisenberg,
in qualche modo anticipato dalla critica dì Hume al
preteso valore assoluto del «principio di causalità»
— mostra che nessuna legge scientifica, quindi
nemmeno il «principio di causalità», può avere un
valore assoluto: ha un carattere statisticoprobabilistico, ossia è una regolarità empirica che
si ha avuto modo di constatare, ma che è sempre
smentibile.
Che a certe funzioni cerebrali corrispondano
certi eventi psichici è pertanto una regolarità
empirica che non autorizza ad affermare che il
cervello sia la causa della mente.
Per di più, in questo suo conferire valore assoluto
al «principio di causalità», lo scienziato
riduzionista smentisce la propria vocazione (o
filosofia) di fondo, che consiste nella volontà di
eliminare ogni illusione di sopravvivenza
dell’uomo: il corpo umano e il cervello — sostiene
— sono destinati alla corruzione e alla morte, e
quindi anche alla mente, che non è altro che
l’attività del cervello. Tuttavia per lo scienziato
riduzionista il «principio di causalità» presenta un
valore assoluto, è cioè una verità eterna e non
qualcosa di corruttibile e di mortale. Ma allora
come può accadere che il corruttibile e mortale
cervello dell’uomo sia legato alla mente da un
vincolo incorruttibile e immortale?
Le considerazioni qui sopra svolte non intendono
sostenere che la ragione stia dalla parte degli
antiriduzionisti. Qui non si tratta di stabilire chi
abbia «ragione», ma chi ha maggiore capacità di
trasformare la mente e il comportamento
dell’uomo conformemente a certi progetti.
«L’anima è in certo modo gli enti»: He psyché ta
ònta pòs estin. Questo afferma Aristotele nel De
anima, 231 b, 21.
«Gli enti» (ta ònta) non significa «una certa parte
degli enti, ma non le altre parti». Significa: «tutti gli
enti»: panta ta ònta. L’anima è «in certo modo»
(pòs) la totalità degli enti. L’espressione «In certo
modo» dalla tradizione aristotelico-scolastica a
Brentano e alla fenomenologia è intesa come già
Aristotele sostanzialmente la intende: l’anima «è»
gli enti, ma non nel senso che essa sia simpliciter
(«fisicamente» dicono gli scolastici) gli animali, le
piante, le case, la terra, il cielo e la totalità degli
enti, bensì nel senso che essa è la loro
rappresentazione, ossia il loro presentarsi,
manifestarsi, apparire.
Si interpreta: l’anima è «intenzionalmente» tutti gli
enti; è il riferirsi a essi. Ma riferimento e
intenzionalità sono innanzitutto l’apparire, il
manifestarsi degli enti.
2
“ANIMA” E RIDUZIONISMO
Il pensiero greco chiama phàinesthai tale
apparire. D’altra parte, la totalità degli enti non
appare tutta insieme, compiutamente, e quindi
Aristotele non intende affermare che l’anima sia
onnisciente, ma che essa è tutti gli enti che vanno
via via manifestandosi, cioè di cui essa è la
manifestazione; e insieme: che essa è sì la
manifestazione della totalità degli enti, ma che la
totalità si manifesta come processo, sviluppo,
«generazione» degli enti del mondo.
E tuttavia, in quanto apparire della totalità degli
enti (via via manifestantisi) l’anima non è un ente
particolare appartenente a tale totalità.
Ciò non significa che l’anima non possa apparire.
In Aristotele questo aspetto del discorso sull’anima
rimane implicito; ma la stessa affermazione che
l’anima è in certo modo gli enti è proprio l’apparire
di questa forma di identità dell’anima e della
totalità degli enti, sì che tale affermazione è
insieme l’apparire in cui l’anima ha come
contenuto se stessa.
Ma, si sta dicendo, ha come contenuto se stessa
non come uno tra gli enti particolari che appaiono,
ma come l’apparire della loro totalità.
L’apparire degli enti è il fondamento di ogni
ricerca, problema, conoscenza, scienza, opinione,
fede, e di ogni progetto, deliberazione, decisione,
azione: è il fondamento di ogni aspetto della vita
dell’uomo: anche di quelle convinzioni e indagini
che si rivolgono all’«anima» («coscienza»,
«mente», «spirito»), intesa questa volta come
parte della totalità degli enti.
Filosofia (e lo stesso pensiero aristotelico),
religione, scienza, arte hanno imboccato
questa strada, dove l’anima è uno degli enti
particolari che appaiono.
Per esempio, per millenni — e, dopo la parentesi
idealistica, tuttora — quelle forme culturali (guidate
da un sapere filosofico, che a sua volta si fa
guidare dal senso comune) credono che, al di là
del loro apparire, gli enti esistano in se stessi, cioè
indipendentemente dal loro apparire e dunque
dall’anima in quanto sia intesa come il loro
apparire.
Solo sul fondamento di questa credenza possono
farsi innanzi teorie come quella evoluzionistica,
che concepisce i fatti mentali come risultato di un
lunghissimo sviluppo delle specie viventi;
o come quella in cui consiste la «psichiatria», dove
la psiche, intesa come oggetto di una iatréia, è
circondata dalla «cura» come ogni altro ente
particolare curabile, e dove la cura è a sua volta
inscritta in un contesto sociale rinviante al mondo
intero.
In questo modo, si perde però di vista che queste
e ogni altra teoria che considerano l’anima come
parte — e innanzitutto quella credenza
dell’indipendenza degli enti dal loro apparire, sulla
quale esse si fondano — debbono peraltro da
ultimo fondare ogni loro pretesa di verità proprio
sull’apparire degli enti, cioè su quell’«anima» che
lungo la storia del pensiero occidentale è
sopravvissuta ed è stata pensata come pheinestai,
cogito, «Io penso», «Spirito come atto puro»,
«esperienza» (in quanto esperienza della totalità
degli enti che vanno via via mostrandosi).
Per quanto riguarda il concetto di esperienza, si
osservi che il «metodo sperimentale» è, per la
scienza stessa, l’indagine che pone a proprio
fondamento l’esperienza; sennonché
dell’esperienza in quanto tale la scienza non si
interessa: volta le spalle al senso fondamentale
dell’ «anima» per dedicare ogni sua attenzione
all’«anima» come ente particolare.
E se oggi si rivendica il carattere linguistico
dell’esperienza, va detto che anche con questo
carattere l’esperienza è il fondamento di ogni
attività teorica e pratica dell’uomo.
Ma anche Aristotele, oltre a intendere l’anima
come apparire della totalità degli enti, la intende
come parte della totalità. Tale apparire è infatti per
Aristotele l’identità del conoscente in atto e del
conosciuto in atto, ma questa identità è un
risultato.
Il cominciamento del processo che conduce a
questo risultato è, da un lato, la «capacità»
dell’anima di conoscere (ossia il suo esser
conoscente «in potenza»), dall’altro lato è la
«capacità» degli enti di essere conosciuti (ossia il
loro esser conosciuti «in potenza»).
Queste due capacità non sono lo stesso, non sono
identiche. L’identità di conoscente e conosciuto
si produce quando i due sono in atto ed essa è
appunto il risultato del processo che conduce
dalla potenza all’atto.
Ma quando l’anima è conoscente in potenza
(Aristotele parla in proposito di «intelletto
passivo») e differisce dal conosciuto in potenza —
ossia dagli enti che hanno la capacità di apparire
—, l’anima è una parte della totalità degli enti.
L’anima diventa parte anche quando l’apparire
della totalità degli enti è inteso come atto di un
«io» («persona», «soggetto»), e si afferma,
appunto, che «io penso» dove il «pensare» è
innanzitutto quell’apparire.
Anche qui, e nonostante tutti i dubbi che si nutrono
in proposito, è la filosofia greca, e dunque lo
stesso Aristotele, ad aprire questa prospettiva.
Si ritiene che esista un produttore del pensare e
che tale produttore sia un «io», una «persona», un
«soggetto». (Variante di questa convinzione è la
tesi, oggi centrale soprattutto in campo biologico,
che a pensare sia il corpo, il cervello, la materia.)
3
«è manifesto che è quest’uomo singolo a
pensare» — manifestum est quod hic homo
singularis intelligit, si afferma nel De unitate
intellectus contra averroistas di san Tommaso.
Quest’uomo singolo è l’io.
Che quest’uomo singolo sia il pensante
(Tommaso) e che il cogitare sia il cogitare di un
ego (Cartesio) appartengono alla stessa
prospettiva. Alla quale appartiene gran parte della
cultura non solo filosofica — peraltro con notevoli
eccezioni (ad esempio Nietzsche, Lichtenberg,
Russeli, Wittgenstein, Mach, Avenarius).
In tale prospettiva, l’io, la persona, il soggetto (ma
anche il corpo, la materia, il cervello) sono parti
della totalità che appare.
L’intelligere di «quest’uomo singolo» è il campo di
ciò che è manfestum e «quest’uomo singolo» è
una parte di questo campo — ossia dell’apparire
della totalità degli enti.
A questo punto, si tratterebbe di mettere in
luce la contraddizione di questa prospettiva.
Ci si limiterà qui a un’indicazione sommaria.
Se in quella prospettiva «io penso» significa «io
sono produttore del pensiero», il pensiero non è
d’altra parte inteso come qualcosa che sia ignoto
all’io. L’io ha notizia del pensiero da lui prodotto.
Ma l’aver notizia è l’apparire. E a sua volta il
«pensiero» è innanzitutto l’apparire degli enti.
L’«io penso» viene infatti quasi sempre unito (in
modo più o meno esplicito) a «gli enti appaiono a
me»: io, che penso, sono appunto l’io a cui
appaiono gli enti.
L’«a cui» è la notizia che l’io ha di essi. Dire quindi
che gli enti appaiono a me significa dire che
l’apparire degli enti appare a me — appunto
perché «a me» non può non significare, in questa
prospettiva, «apparire a me»; sì che dire che
l’apparire degli enti appare a me significa dire che
l’apparire degli enti appare all’apparire a me... et
sic in indefinitum.
Nella variante riduzionistica di tale prospettiva,
«il cervello pensa» (o «il corpo pensa»).
Ma in questa variante non si intende sostenere
che il pensiero — cioè gli enti che appaiono — è il
loro apparire «al cervello», e quindi in tale variante
non è presente la contraddizione che invece
compete alla prospettiva di cui il riduzionismo è,
appunto, una variante.
Al riduzionismo compete un’altra
contraddizione, che ho considerato in altre
occasioni e che è cioè I’analogon del riduzionismo
teologico.
La riduzione della mente al cervello è cioè
l’anàlogon mondano della riduzione teologica del
mondo a Dio.
Infatti, se il mondo è totalmente riducibile a Dio,
non c’è mondo; e se la mente è totalmente
riducibile al cervello, non c’è mente. In entrambi i
casi, se la riduzione non è totale c’è un residuo
irriducibile.
Ma se la riduzione è totale, essa nega ciò che
essa stessa afferma: nega quella mente e quel
mondo che essa riconosce esistenti proprio per la
sua volontà di ridurli, rispettivamente, al cervello e
a Dio.
In altri termini, che gli enti appaiano «a me» non
significa, in quella prospettiva, che essi appaiono a
un sasso o a un albero, ma che appaiono a una
coscienza, cioè a un apparire; e se si intende
tener fermo che l’apparire è sempre un apparire
«a un io», «a una coscienza», allora l’apparire «a
me» è l’apparire all’apparire a me, dove l’«a me»
determina un progressus in indefinitum.
Con la conseguenza che, se ciò a cui appaiono gli
enti viene indefinitamente spostato e allontanato,
gli enti non appaiono più a qualcuno, e chi crede
che l’apparire possa essere solo un apparire a
qualcuno è costretto a concludere che non appare
alcun ente. E questa è la contraddizione della
prospettiva per la quale «io penso» e «gli enti
appaiono a me».
4
PENSIERO, SCIENZA, VOLONTÀ DI
POTENZA
In una lettera inviata a Max Born alla fine del 1926,
Albert Einstein scrive:
«Nessuna quantità di esperimenti potrà
dimostrare che ho ragione; un unico
esperimento potrà dimostrare che ho
sbagliato».
Da dieci anni aveva incominciato a render nota la
teoria della relatività generale, in cui viene dedotta
l’esistenza delle «onde gravitazionali», ora
finalmente osservate da un laser di altissima
tecnologia. L’«osservazione» è un
«esperimento».
In esso viene constatato un «fatto», ossia una
certo evento — ad esempio un punto luminoso
(interpretato come «stella») che in un telescopio
opportunamente predisposto coincide con una
lineetta nera del reticolato. Ma, dice Einstein,
«nessuna quantità di esperimenti potrà dimostrare
che ho ragione» — e che quindi egli aveva ragione
nel prevedere, ad esempio, l’esistenza delle «onde
gravitazionali».
Si può dire che in sostanza l’affermazione di
Einstein si muova nell’ambito del concetto
aristotelico di «induzione» (epagoghé):
si può osservare per un numero di volte alto
quanto si vuole che le cose di una certa specie
hanno una certa proprietà ma da queste
osservazioni non si può concludere che tutte le
cose di quella specie abbiano questa proprietà e
che quindi mostreranno, nelle osservazioni
successive, di avere tale proprietà.
Non si può infatti escludere che, dopo un gran
numero di conferme, il laser che ha consentito di
sperimentare le «onde gravitazionali» non abbia
più a mostrarne l’esistenza. È improbabile quanto
si vuole ma non impossibile.
Queste considerazioni non scalfiscono
minimamente l’enorme importanza della
sperimentazione di quelle onde. Anche perché la
seconda parte dell’affermazione di Einstein — «un
unico esperimento potrà dimostrare che ho
sbagliato» — non è così fuori discussione come
può sembrare (soprattutto dopo gli sviluppi che
essa ha avuto nell’epistemologia di Karl Popper).
Infatti, se è possibile che il laser di cui si sta
parlando, abbia a mostrare l’opposto di quel che
ha mostrato, è anche possibile che in seguito torni
a mostrare quel che in primo tempo ha mostrato.
Se per «aver ragione» intorno a una tesi si intende
che nessun esperimento potrà far osservare
qualcosa di opposto a essa, allora, certamente, un
unico esperimento può mostrare che questa tesi è
sbagliata. Ma che dire di un laser che nella
maggior parte dei casi abbia a mostrare
l’esistenza delle onde gravitazionali e solo in uno o
in pochi altri casi non abbia a mostrarla?
Che dire di un motore che una volta o poche volte
non ha funzionato ma che per lo più funziona
bene? Lo si butterà via?
La scienza ha imparato a non buttar via le
conoscenze che funzionano come questo motore.
Anzi, quando riesce a guardare se stessa, si rende
conto che nessuno dei suoi principi «ha ragione»
nel senso qui sopra indicato: nessuno è
universalmente valido e definitivamente vero.
L’estrema potenza che la scienza e la tecnica
sanno oggi produrre è proprio dovuta al rifiuto
di conoscenze che abbiano la pretesa di
essere universali e definitive.
La potenza si è tolta la maschera della verità ed è
diventata il valore supremo.
Il valere non è forse l’avere potenza?
E i supremi principi della tradizione filosoficoscientifica? Ad esempio il «principio di non
contraddizione»?
Per essa non può venire smentito dai «fatti».
Tale principio afferma: è impossibile che, nel
medesimo tempo, una cosa abbia e non abbia una
certa proprietà. La tradizione ha creduto che come
non può essere smentito dai «fatti», così non è
affermato in base alla loro osservazione.
Che un segmento di retta — crede la tradizione —
non possa essere nel medesimo tempo maggiore
e minore di un altro segmento non lo si afferma
perché finora non abbiamo osservato segmenti di
retta che nello stesso tempo siano maggiori e
minori di altri; ed è impossibile che lo si osservi in
futuro. Certo, queste sono le intenzioni della
tradizione.
Negli ultimi due secoli è emersa la tendenza a
ritenere che quel principio non è una verità
assoluta e definitiva ma ha un valore pratico (si
pensi a Nietzsche o a Lukasiewicz). Se si vuol
esser potenti, bisogna che, quando lo si è, non si
sia contemporaneamente impotenti. E d’altra
parte, se la contraddizione (per esempio il mentire)
rende potenti, perché non contraddirsi? Ma la
questione è estremamente complessa, e non può
essere qui districata.
Limitiamoci ad alcune osservazioni.
I due contributi fondamentali della fisica
contemporanea — teoria della relatività e fisica
quantistica — mostrano, almeno sinora, di
essere tra loro in contraddizione. Ma nessun
fisico rinuncerebbe per questo a servirsi di
entrambi. E se Kurt Gòdel ha dimostrato la
possibilità che lo sviluppo del sapere matematico
abbia a implicare delle contraddizioni, qualora ciò
avvenisse i matematici non volterebbero le spalle
alla matematica esistente.
5
L’esperimento che ha fatto osservare l’esistenza
delle onde gravitazionali è stato salutato con
legittima soddisfazione perché non smentisce la
teoria della relatività. Ma che cosa significa non
smentirla? Significa che non l’ha contraddetta.
Se l’avesse contraddetta, i fisici avrebbero
incominciato a dubitare della sua validità ma non
smetterebbero di praticarla. In questo modo la
fisica mostra la volontà di non contraddirsi.
La quale è insieme volontà che la realtà non sia
contraddittoria: volontà, pertanto, che i «fatti» che
smentiscono il contenuto di una teoria e questo
contenuto non abbiano a coesistere. Si mette da
parte, si pensa, il mito della verità assoluta e
definitiva del «principio di non contraddizione»; ma
è «meglio» — «opportuno», «conveniente»,
«utile», «fortificante» — evitare la contraddizione.
Che nelle opere e nelle conoscenze sia «meglio»,
in molti casi, non contraddirsi è un precetto
ampiamente seguito.
D’altra parte i grandi principi della cultura
occidentale, come appunto il «principio di non
contraddizione», si presentano come dogmi, miti
che non riescono a mostrare la loro innegabilità.
Ho inteso mostrare alcuni aspetti del farsi largo,
nel nostro tempo, della volontà di potenza.
Poi, la gran questione è il senso di tale volontà.
Essa è presente sin dall’inizio della storia
dell’uomo.
E continua ad esserlo anche quando il popolo
greco, dando inizio alla storia dell’ Occidente,
incomincia a pensare il senso della verità
innegabile, cioè a credere nella differenza tra
volontà e verità. Oggi la volontà di potenza si sta
liberando della verità.
Sta diventando estremamente coerente.
Ma siamo sicuri che non si tratti della coerenza
della Follia?
C’è oggi una certa propensione ai «fatti»,
all’«esperienza», piuttosto che ai «principi»;
perfino in campo matematico.
Tra la previsione teorica delle onde gravitazionali,
operata dalla logica e dalla matematica della teoria
della relatività, e l’esperimento che ha fatto
osservare la loro esistenza, è questo secondo,
tendenzialmente, ad avere l’ultima parola.
Una tendenza diffusa, ovunque si tratti di
confrontare le teorie ai «fatti» — e, questo, anche
se è a sua volta diffusa la convinzione che i «fatti»
non siano puri fatti ma «carichi di teoria» (come si
sostiene, sia pure in modi diversi, in un certo
settore della filosofia del nostro tempo e nella
fisica quantistica).
Presente, questa tendenza, anche negli ambiti
apparentemente più distanti dalle questioni qui
considerate. Ad esempio in ambito giuridico. In
sede giudiziaria, la deduzione logica dell’esistenza
di un «fatto» (la deduzione che propone una
«teoria») non ha la stessa forza di convinzione di
una testimonianza affidabile. Il testimone è infatti
colui che sperimenta un fatto. Se i giudici decidono
che la sua testimonianza sia affidabile, essa è da
loro ritenuta più affidabile della teoria consistente
nella deduzione logica che conduce all’
affermazione o alla negazione dell’esistenza di
quel fatto. Questo, anche se il decidere che una
testimonianza sia affidabile è un enorme «carico»
che viene messo sulle spalle del fatto testimoniato.
6