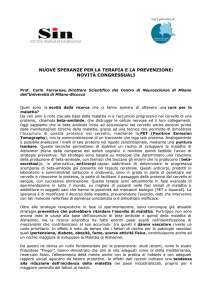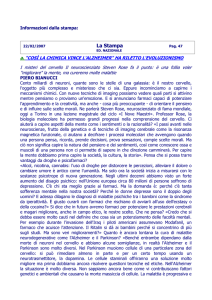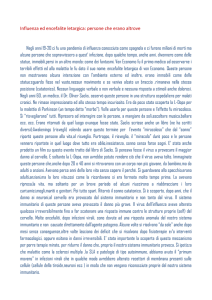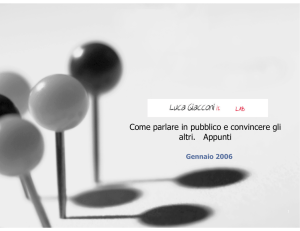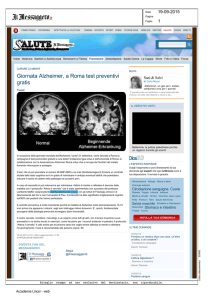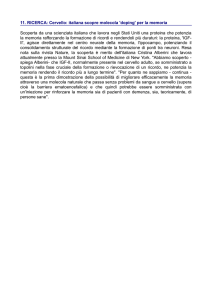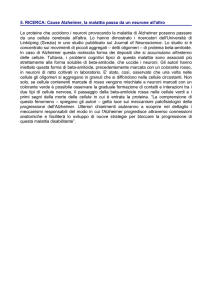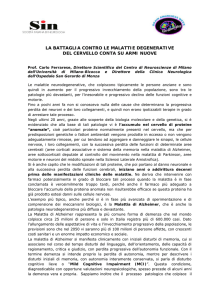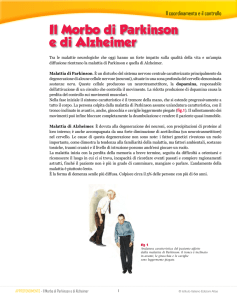70
MILANO FINANZA
SALUTE
Personal
29 Ottobre 2016
Nuove
N
u
molecole consentono di combattere e prevenire Parkinson e Alzheimer
Amici per il cervello
di Elena Correggia
N
uovi farmaci in via di autorizzazione, neurotecnologie, biomarker e approcci innovativi per la
prevenzione e la diagnosi precoce
accendono nuove speranze per contrastare
alcune delle più invalidanti malattie neurologiche, dal Parkinson all’Alzheimer alla
sclerosi multipla. Dal congresso nazionale
della Società italiana di neurologia, che si è
svolto nei giorni scorsi a Venezia, è emerso
che le malattie del cervello costituiscono
la condizione patologica più diffusa nel
mondo occidentale,
soprattutto a causa
dell’invecchiamento
della popolazione.
Per quanto riguarda
il morbo di Parkinson,
malattia multifattoriale che colpisce in
Italia circa 200 mila
persone, sono in arrivo nuove formulazioni di levodopa, che si
conferma il farmaco
di riferimento per il
trattamento. «Già introdotta in commercio negli Stati Uniti
è per esempio una
combinazione di due
tipi di levodopa, una
a pronto rilascio che
agisce nel giro di 15-30 minuti e un’altra
invece a rilascio lento, di alcune ore, per
rendere più efficace la terapia», spiega
il professor Leonardo Lopiano, direttore
della Struttura complessa di neurologia
dell’ azienda ospedaliera-universitaria
Città della Salute e della Scienza di Torino,
«a breve saranno inoltre disponibili una
levodopa somministrabile per infusione
sottocutanea continua e una per via inalatoria, per risolvere i blocchi improvvisi del
paziente grazie a un rapido assorbimento».
La ricerca sta intanto mettendo a punto
nuovi possibili biomarker che consentano
di identificare il Parkinson nelle sue fasi
prodromiche. Si stanno in particolare
elaborando algoritmi di probabilità per
testare a livello sperimentale la validità
dei nuovi biomarker su soggetti a rischio
in base ad alterazioni molecolari e di neuroimaging che non sono ancora in fase
conclamata. Poiché quando si arriva alla
diagnosi il 60-70% dei neuroni dopaminergici della sostanza nera del cervello sono già
compromessi, le terapie neuroprotettive
non hanno offerto risultati. L’obiettivo ora
è quello di verificare l’efficacia di questi
interventi in una fase antecedente della
malattia.
Il pacemaker in testa. Nuovi sviluppi
riguardano poi la stimolazione cerebrale profonda per il controllo dei sintomi,
adatta per pazienti selezionati in fase
non iniziale, che presentano fluttuazioni
e movimenti involontari che i farmaci non
riescono più a controllare stabilmente.
La tecnica consiste nell’invio di impulsi
elettrici mediante l’inserimento di un
elettrodo in un punto specifico del cervello
collegato a un generatore posto sottocute, nella regione del torace. «Il beneficio
prodotto dalla neuromodulazione profonda dei circuiti cerebrali alterati dal
Parkinson è già noto da tempo, ma oggi
è migliorata la qualità dell’intervento in
termini di precisione nel posizionamento
dell’elettrodo, del diametro di appena un
millimetro», continua Lopiano, «inoltre,
l’uso di elettrodi direzionali consente al
medico di decidere dove dirigere il campo elettrico all’interno del cervello per
rendere il trattamento più efficace ed
evitare effetti collaterali nelle aree non
coinvolte dalla patologia». Si sta inoltre
lavorando allo sviluppo di tecnologie che
permettano una stimolazione adattativa,
ovvero non costante ma modulata in base
alla condizione del momento del paziente
nell’arco della giornata, situazione rilevata
attraverso il segnale biologico recepito
dall’elettrodo. Un sistema per ridurre gli
effetti collaterali e l’energia consumata dai
dispositivi e migliorare il controllo delle
fluttuazioni motorie.
Più cure per la sclerosi multipla. Malattia infiammatoria del sistema nervoso
centrale, la sclerosi multipla ha decorso
cronico e rappresenta il più comune disturbo neurologico disabilitante di origine
non traumatica in giovani adulti. Per
contrastarla si sta ampliando il ventaglio
delle terapie (14 quelle approvate oggi,
che si estenderanno a breve a 20) sia come trattamenti di prima linea sia come
terapie di seconda linea, per le forme inizialmente più aggressive e per quelle che
non rispondono alle terapie iniziali. «Gli
ultimi studi hanno confermato la validità
anche a lungo termine di alemtuzumab,
un anticorpo monoclonale già in
u da alcuni anni, che agisce
uso
c
contro
un recettore dei linfociti
B e T, con una riduzione delle
r
ricadute
e della progressione
d
della
malattia a distanza di sei
a
anni
dalla terapia», afferma il
p
professor
Gianluigi Mancardi,
d
direttore
della clinica neurolog dell’Università di Genova.
gica
T
Trattandosi
di una sostanza che
s lega ai linfociti, eliminandoli,
si
r
rimane
il rischio di sviluppare
m
malattie
autoimmuni e problemi
r
renali,
per cui è necessario monit
torare
il paziente con frequenti
e
esami
del sangue. Benché la scler sia sempre stata ritenuta
rosi
p
principalmente
dovuta all’attiv
vazione
di linfocitiT autoreattivi,
recenti studi hanno dimostrato
l’efficacia di farmaci diretti all’eliminazione dei linfociti B. Fra queste molecole c’è
ocrelizumab, in fase di registrazione, un
anticorpo monoclonale umanizzato con un
meccanismo di azione simile al già noto
rituximab, anticorpo monoclonale murino,
ma con un profilo di tollerabilità che pare
migliore, in quanto rituximab può talvolta
dare allergie. «L’azione contro i linfociti B
è importante perché risulta utile anche
per le forme primariamente progressive
della malattia, contro le quali prima non si
disponeva di terapie», prosegue Mancardi.
Già approvato dall’Ema per le forme a
ricadute e remissione è poi daclizumab, che
agisce contro il recettore dell’interleuchina
2 presente sui linfociti attivati, mentre
in fase di registrazione è Cladribina, un
immunosoppressore tradizionale che con
20 giorni di dosaggio orale nel corso di due
anni ha dimostrato efficacia nel ridurre la
frequenza delle ricadute e nel rallentare la
progressione della disabilità fino a quattro
anni, con un profilo di tossicità accettabile,
anche a lungo termine.
Agire in anticipo contro l’Alzheimer.
Circa 600 mila persone soffrono di Alzheimer in Italia, ma oggi è possibile identificare le alterazioni biologiche che espongono al
rischio di sviluppare la malattia. Alla base
di essa vi è infatti un accumulo progressivo
nel cervello della proteina beta-amiloide,
che distrugge le cellule nervose portando
alla neurodegenerazione. Questa proteina
comincia ad accumularsi anche decenni
prima delle manifestazioni cliniche e si
può riconoscerne la presenza attraverso
un esame Pet con la somministrazione
di un tracciante che lega la proteina e,
similmente, analizzando i livelli della proteina nel liquido cerebrospinale mediante
puntura lombare.A questi esami si possono
sottoporre i soggetti con declino cognitivo
lieve, che rappresenta la fase prodromica
dell’Alzheimer, al fine di avviare strategie
terapeutiche preventive per modificare
il decorso della malattia, prevenendo o
ritardando l’esordio. «A questo scopo sono
in fase avanzata di sperimentazione alcune
molecole testate a livello internazionale su
migliaia di pazienti», spiega il professor
Carlo Ferrarese, direttore scientifico del
Centro di neuroscienze dell’università di
Milano - Bicocca, «una prima tipologia di
farmaci, a somministrazione orale, è diretta al blocco degli enzimi che producono la
beta-amiloide, con la sua conseguente riduzione. Un altro gruppo è rappresentato invece da anticorpi sintetizzati in laboratorio
e iniettabili, che in parte riescono a penetrare nel cervello rimuovendo la proteina e
in parte circolano nel sangue, facilitando il
passaggio della beta-amiloide dal cervello
al sangue e quindi la sua eliminazione».
Fra i pazienti che sono stati arruolati
negli studi ci sono non solo soggetti con
declino cognitivo lieve, ma anche soggetti
sani che a causa dell’età avanzata o della
familiarità alla malattia hanno deciso di
sottoporsi alle indagini diagnostiche, da cui
è emersa positività dei marcatori biologici
(Pet o liquorali). «Accanto a quelle in fase
di studio esistono però strategie preventive
già attuabili, come il contrasto del danno
vascolare che riveste un ruolo importante
nel favorire l’accumulo di beta amiloide»,
precisa Ferrarese, «studi scientifici hanno
documentato infatti come ipertensione,
diabete, obesità, fumo, ipercolesterolemia, mancanza di attività fisica e una
dieta squilibrata incrementino il rischio
di sviluppare demenza. Al contrario la
dieta mediterranea, un corretto esercizio
fisico e l’allenamento della mente agiscono
come fattore protettivo». (riproduzione
riservata)