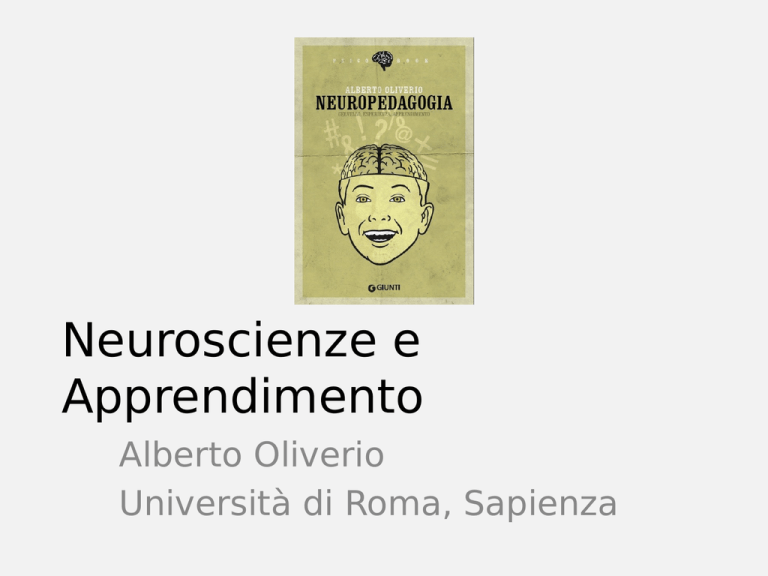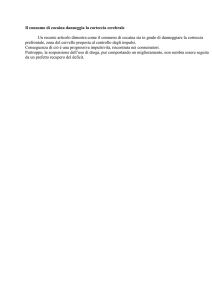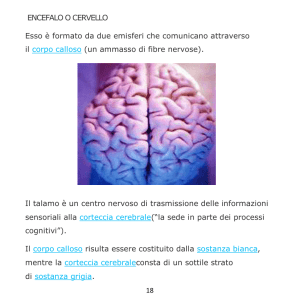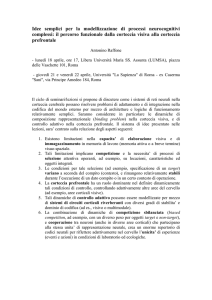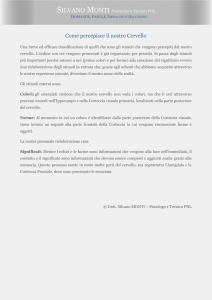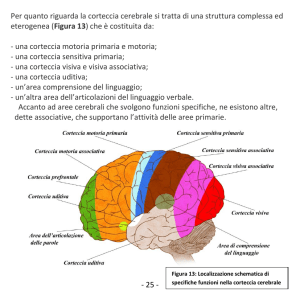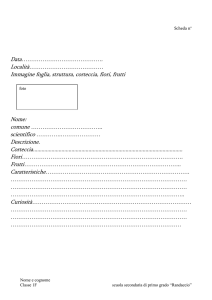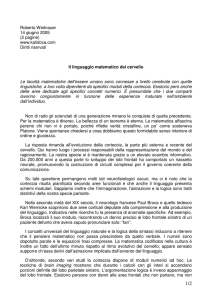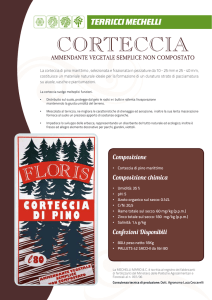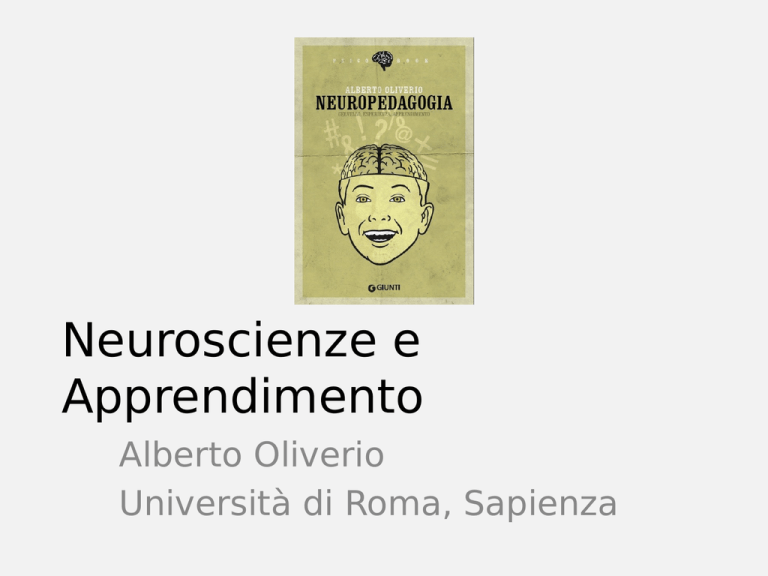
Neuroscienze e
Apprendimento
Alberto Oliverio
Università di Roma, Sapienza
La sostanza grigia aumenta nel corso del
primo anno e riguarda soprattutto le
aree corticali sensorimotorie (frontali
superiori, temporali inferiori e parietali).
La grigia frontale aumenta nel corso
dell’adolescenza per poi diminuire.
Anche la maturazione dell’ippocampo
(posteriore) che consente di formare
delle rappresentazioni mnestiche,
prosegue tra i 4 e i 24 anni, il che
contribuisce alla formazione dei ricordi
in cui possiamo compiere un viaggio e
cambiare punto di vista: ciò dipende dal
L’importanza
dell’azione.
Il controllo motorio è in qualche
modo il contrario di quanto si
verifica nella percezione. Percepire
significa costruirsi una
rappresentazione del mondo
esterno. L’azione, invece, inizia con
un’ipotesi sulle conseguenze
desiderate di un movimento e poi
continua nella sua esecuzione.
Nel corso del suo processo
evolutivo, il cervello ha bisogno di
fare esperienze tattili e motorie
perché si sviluppino quelle aree
sensorimotorie che rappresentano il
punto di partenza per la
Esperienze tattili e
motorie
Nel corso del suo sviluppo, il
cervello ha bisogno di fare
esperienze tattili e motorie:
giocare con la sabbia e con
l’acqua, fare costruzioni con i cubi,
praticare giochi di movimento,
perché si sviluppino quelle aree del
cervello che sono il punto di
partenza per la maturazione delle
aree del linguaggio e del pensiero
complesso.
La realtà virtuale non è l’ambiente
ideale per favorire lo sviluppo della
mente infantile che è concreta,
Rappresentazioni motorie e
apprendimento
L “apprendimento recitato” favorisce
le associazioni tra rappresentazioni
motorie e apprendimento. La tecnica
sfrutta il fatto che le memorie motorie
sono particolarmente robuste mentre
quelle semantiche (per esempio, le
memorie legate al significato delle
parole) sono più fragili.
L’apprendimento recitato è stato
utilizzato per migliorare
l’apprendimento di una seconda
lingua: i bambini devono recitare in
gruppo una serie di vocaboli
accompagnandoli con gesti e
movimenti che ne rappresentino il
Motricità e linguaggio.
Le aree linguistiche e quelle che si
riferiscono al corpo, all’ambiente e al
contesto in cui esso opera interagiscono tra
di loro, il che è bene evidente in quelle
situazioni in cui il movimento entra in
conflitto con la formulazione di parole.
Chiedete a un amico di parlare e ripetete ciò
che sta dicendo mentre lui parla, come se
foste la sua “ombra”. A questo punto
cominciate a tamburellare con il dito medio
della mano destra seguendo un ritmo
regolare; provate ora con il dito medio della
mano sinistra. Per la maggior parte delle
persone è più difficile tamburellare con il
dito medio della mano destra (controllato
dalla corteccia motoria dell’emisfero
Attività aerobica e
concentrazione
Dopo meno di 30 minuti di attività
fisica aerobica (correre) la
capacità di concentrazione
migliora notevolmente: queste
conoscenze dovrebbero tradursi
in un’anticipazione dell’ora di
educazione fisica all’inizio della
giornata scolastica o nel fare
brevi pause di attività fisica nel
corso delle ore scolastiche. Più in
generale, si è visto che nei
bambini che presentano deficit di
attenzione la pratica di esercizi
basati sul controllo motorio
Immaginazione, movimento,
percezione.
Il nostro cervello è un enorme archivio di repertori
motori, complessi schemi che lo psicologo russo
Alexander Lurija ha defi nito “melodie cinetiche”.
Le tecniche di imaging hanno contribuito alla
conoscenza degli schemi motori: se si chiede a una
persona di pensare di muovere la mano, come se
volesse afferrare un oggetto, la sua corteccia
premotoria, situata davanti a quella motoria, nel lobo
frontale, diviene attiva, il che indica come vi siano
aree del cervello che predispongono il movimento e
aree che lo realizzano.
Questo parallelismo tra anticipazione e azione vale
anche per l’immaginazione e la sensazione: così, il
solo immaginare un oggetto, ad esempio una rosa,
porta all’attivazione delle aree della corteccia visiva
che vengono attivate quando quell’oggetto viene
Parole e immagini.
Rappresentare la realtà tramite
immagini significa memorizzare
in modo più efficace e, di
conseguenza, imparare meglio
di quanto non avvenga a mezzo
della trasmissione orale o della
lettura, cioè attraverso codici
“semantici”, basati sul
significato.
Le esperienze visive sono 3-4
volte più efficaci di quelle
uditive, quelle audiovisive sono
a loro volta 2 volte più efficaci di
quelle visive, il che indica che un
metodo di apprendimento che
passi prevalentemente
Immagini e
concetti
Numerose
esperienze ed
apprendimenti
infantili si basano
su associazioni tra
immagini e
concetti:
l’apprendimento
viene così
facilitato, in
quanto le
immagini si
Relazioni semantiche in 3 diversi soggetti
fissano facilmente
Huth et al, Neuron, 2015
nella mente
Attenzione e
apprendimento
La maggior parte delle persone
non analizza le situazioni in
modo sistematico. Per superare
questo stadio e sviluppare vere
capacità di concentrazione e
memoria dobbiamo imparare ad
analizzare correttamente i
messaggi, soprattutto quelli
visivi.
L’attenzione selettiva implica,
anzitutto, un coinvolgimento dei
sensi. In secondo luogo, si basa
sull’individuazione dell’aspetto
fondamentale o essenziale del
I due emisferi
Funzioni emisferiche
Da un lato siamo dotati di attività
di tipo logico-simboliche che si
riallacciano alle strutture e alle
funzioni del linguaggio, tipiche
dell'emisfero sinistro, dall'altro di
attività "gestaltiche", basate sulla
capacità di cogliere diversi aspetti
della realtà anche per i loro
risvolti emozionali, tipiche
dell'emisfero destro.
II due
due emisferi
emisferi cerebrali
cerebrali hanno
hanno competenze
competenze molto
molto diverse.
diverse.
SINISTRO
SINISTRO
•• VERBALE:
VERBALE: utilizza
utilizza parole,
parole, vocaboli,
vocaboli,
per
per nominare
nominare per
per definire
definire
•• ANALITICO:
ANALITICO: analizza
analizza cose
cose ee realtà
realtà
nelle
nelle loro
loro parti
parti
•• SIMBOLICO:
SIMBOLICO: usa
usa stimoli
stimoli ee segni
segni
•• ASTRATTO:
ASTRATTO: da
da un
un dettaglio
dettaglio
rappresenta
rappresenta la
la realtà
realtà nella
nella sua
sua
completezza
completezza
•• TEMPORALE:
TEMPORALE: dispone
dispone cose
cose ed
ed
eventi
eventi in
in sequenza
sequenza temporale
temporale
•• RAZIONALE:
RAZIONALE: arriva
arriva aa conclusioni
conclusioni
fondate
fondate sulla
sulla ragione
ragione
•• DIGITALE:
DIGITALE: usa
usa ilil metodo
metodo numerico
numerico
•• LOGICO:
LOGICO: trae
trae conclusioni
conclusioni su
su
principi
principi logici
logici
•• LINEARE:
LINEARE: pensa
pensa in
in termini
termini
sequenziali
sequenziali
DESTRO
DESTRO
•• NON
NON VERBALE:
VERBALE: conscio
conscio della
della realtà
realtà ma
ma
incapace
incapace di
di descriverla
descriverla verbalmente
verbalmente
•• SINTETICO:
SINTETICO: unisce
unisce le
le parti
parti formando
formando un
un
tutto
tutto
•• CONCRETO:
CONCRETO: rappresenta
rappresenta le
le cose
cose come
come
sono
sono nel
nel momento
momento presente
presente
•• ANALOGICO:
ANALOGICO: vede
vede le
le somiglianze,
somiglianze, non
non
comprende
comprende relazioni
relazioni metaforiche
metaforiche
•• ATEMPORALE:
ATEMPORALE: senza
senza senso
senso del
del tempo
tempo
•• NON
NON RAZIONALE:
RAZIONALE: non
non richiede
richiede
fondamenti
fondamenti razionali
razionali dei
dei fatti
fatti
•• SPAZIALE:
SPAZIALE: percepisce
percepisce le
le cose
cose in
in
relazione
relazione spaziale
spaziale con
con altre,
altre, come
come parti
parti
di
di un
un tutto
tutto
•• OLISTICO:
OLISTICO: vede
vede le
le cose
cose nel
nel loro
loro
insieme,
insieme, talora
talora in
in contrasto
contrasto col
col sinistro
sinistro
L’emisfero sinistro
percepisce questa
matrice in modo
analitico
L’emisfero destro
percepisce questa
matrice in modo
globale
Disegno e emisferi cerebrali
Razionalità e emozione
Ragione e sentimento
In Ragione e sentimento Jane
Austen mette in scena il contrasto
tra la razionalità e l’emozione:
l’impulsività di Marianne è
all’origine di scelte sbagliate,
mentre la sorella Elinor, logica e
razionale, sceglie fin dall’inizio il
marito giusto…
Esiste un contrasto insanabile tra
ragione e sentimento? Anni or sono
Daniel Goleman ha affrontato la
differenza tra “mente razionale” e
“mente emozionale”, spiegando
come la prima sia una modalità di
comprensione della quale siamo
solitamente coscienti, mentre la
L’INTELLIGENZA EMOTIVA
I rapporti tra emozione e
cognizione dipendono da quelli
tra la corteccia cerebrale e il
sistema limbico. La corteccia
cerebrale ha il compito di
integrare le reazioni dei nuclei
del sistema limbico coinvolti
nell’emozione e di paragonarle
con quelle che hanno avuto
luogo nel passato in occasione di
eventi simili: in tal modo le
informazioni del presente
vengono allacciate a quelle del
passato, il che assicura una
dimensione temporale alla
memoria. L’emozione conferisce
Empatia
Le risposte empatiche
attivano i circuiti
dell’emozione e
agiscono sui processi
della memoria
Giochi di movimento
I giochi di movimento o
simbolici hanno un ruolo
essenziale nella costruzione
della socializzazione e
nell’intelligenza emotiva, la
capacità di saper leggere le
emozioni degli altri e di
mettere in atto risposte
appropriate dal punto di vista
dell’empatia. Un gioco di
gruppo all’aria aperta
comporta sensazioni,
percezioni, emozioni,
movimenti e, soprattutto, un
vero e proprio esercizio
cognitivo.
Bambini e
apprendimento
Modello funzioni esecutive di Miyake:
inibizione, flessibilità mentale, aggiornamento.
Inibizione= capacità sopprimere informazioni non pertinenti interne o
esterne, flessibilità= passare alternativamente da un’operazione
mentale a un’altra (es dalla divisione alla moltiplicazione),
l’aggiornamento implica modificare il contenuto della memoria di
lavoro a seconda dell’informazione più recente.
Queste 3 componenti non sono ben differenziate sino ai 5 anni
dopodiché divengono più autonome. I bambini piccoli devono mettere
in campo delle strategie abbastanza generiche per bloccare il compito
in corso ed evitare di perseverare nella mansione precedete e passare
alla successiva.
È soltanto nell’adolescenza che queste tre funzioni divengono
autonome. Gli adolescenti sanno padroneggiare la loro flessibilità
mentale per adattarsi a nuovi compiti. Sino a 7 anni i bambini non
utilizzano la ripetizione subvocale (per attuare un compito) mentre in
seguito cominciano a farlo muovendo le labbra. Anche il doppio codice
verbale e visivo non entra in funzione che dopo i 7 anni, sino a quel
punto i bambini si basano soltanto su informazioni visuo-spaziali,
meno efficaci di quelle basate su un doppio codice. La quantità di
informazione manipolata (ad es. il numero di cifre) aumenta
progressivamente a partire dai 5-6 anni
Memoria di lavoro: A 6 mesi un lattante mantiene
in mente un oggetto, a 12 mesi può mantenerne in
memoria 4, ciò dipende dalla maturazione della
corteccia frontale.
L’associazione di informazioni, ad esempio
identificare su un disegno, il cosa e il dove, procede
lentamente. Ogni integrazione tra più elementi
migliora sino alla tarda adolescenza a causa di un
potenziamento della memoria di lavoro.
La memoria di lavoro di un bambino tiene conto di
vari fattori: La motivazione, l’attenzione, la capacità
di non distrarsi, le caratteristiche della personalità.
Nel corso dello sviluppo le prestazioni aumentano rapidamente
per quanto riguarda i contenuti che condividono la stessa
modalità, aumentano progressivamente e in modo lineare per
quanto riguarda i contenuti spaziali, si verifica un brusco
miglioramento tra i 9 e i 10 anni per quanto riguarda i
contenuti temporali.
L’evoluzione delle capacità di memorizzazione tra i 6 e i 10
anni procede rapidamente per quanto riguarda il “cosa” (ad
es. coppie di immagini), più lentamente per il “dove”
(posizione spaziale di immagini) e ancor più lentamente per
quanto riguarda il “quando” (ordine di presentazione delle
immagini).
I bambini tra i 3 e i 5 anni non sono ancora capaci di viaggiare
mentalmente nel tempo. Similmente, a 3.4 anni confondono il
contenuto di un sogno con la realtà.
La memoria prospettica differisce da quella retrospettiva in
quanto riguarda la capacità di ricordarsi di compiere una o più
azioni nel futuro. È indispensabile per la vita quotidiana e
migliora sino all’adolescenza.
Dipende da 4 fattori:
1. La capacità di ricordarsi del contenuto dell’azione da
realizzare che migliora con l’età.
2. La metacognizione (le conoscenze che abbiamo sulla nostra
memoria) influenza le nostre strategie cognitive.
3. La capacità di proiettarsi nel futuro facilita la preparazione di
un’azione.
4. Le funzioni esecutive, come la memoria di lavoro,
permettono di modificare le nostre rappresentazioni e di
adattarci a nuove situazioni.
Più la codificazione è personalizzata e prossima al bambino,
maggiore la capacità di memorizzare.
Anche il recupero dell’informazione è maggiore quando gli
indici che si forniscono si avvicinano alle tappe della
codificazione.
Tutti gli apprendimenti che hanno una dimensione concreta
e multimediale (ascoltare la lingua della nazione di cui si
parla, vedere immagini fotografiche, girare per le strade con
Google maps ecc.) e/o che richiedono al bambino di essere
attivo hanno maggiore successo (es. disegnare una carta
geografica, appuntare delle bandierine sui luoghi di cui si parla
ecc.).
Associare a gesti un fonema, parola, concetto ecc. (Suzanne
Borel-Maysonny), associare a un’emozione…
Borel-Maisonny S., 1969, Éducation et perception, Neuchâtel, Delachaux et
Niestlé
La teoria modulare
Dehaene e Pinker sostengono una
concezione modulare dell’intelligenza
basata su complesse reti.
Il modulo del linguaggio dipenderebbe
da strutture situate prevalentemente nei
lobi frontale e temporale sinistri,
la capacità spaziale dall’interazione delle
funzioni somatosensoriali e visive con le
strutture parietali dell’emisfero destro,
la capacità matematica è invece
associata alla regione frontale di sinistra e
ai lobi parietali di entrambi gli emisferi. Le
aree parietali utilizzano rappresentazioni
visivo-spaziali della quantità (contare con le
dita). Le aree frontali permettono di
Processi logici e
analogici
Il potere dell’analogia
Analogia: euristiche
precoci, sviluppo
mente infantile,
scienza.
Esempi:
Vitruvio e Maxwell
(onde liquidi e onde
sonore) Franklin
(fulmine ed elettricità)
Kekulé (serpentello e
chimica benzene)
Analogie, metafore,
cervello…
La mente è capace di cogliere
istintivamente le metafore
primarie attraverso un processo
comune alle sinestesie
Giro
angolare
Le persone che presentano lesioni del giro
angolare di sinistra non comprendono le
metafore, pur comprendendo bene il
linguaggio
Es: Non è tutt’oro quel che luccica.
Interpretazione: bisogna stare attenti quando
si comprano dei gioielli
(V. Ramachandran, 2005)
(Nella produzione di analogie si
verifica un’attivazione selettiva
della corteccia prefrontale dorsolaterale (DLPFC: Area di Broadman
9 -BA 9-, BA 46/9d, BA 46 e della
corteccia frontopolare (FPC: BA 10)
(Christoff et al., 2001; Kroger et al.,
2002). . L’attivazione della corteccia
prefrontale destra dimostra che il
ragionamento analogico interessa
l’emisfero destro, cosa che non
accade invece per il ragionamento
deduttivo (Goel, 1998).
La categorizzazione è alla base dell’analogia.
Attività Analogica (ANA), di categorizzazione (CAT) e di recupero semantico (SEM)
A) Confronto ANA>CAT: la corteccia frontopolare sinistra è cerchiata in azzurro. B)
ANA>SEM (in verde) e CAT>SEM (in rosso). Le aree in giallo mostrano come CAT e
ANA condividano l'attivazione di un esteso network parieto-frontale, indicando che la
categorizzazione sia alla base dell’integrazione analogica (Green et al., 2006b).
Pensare per analogie
Il pensiero analogico è una strategia
mentale che permette di vedere al di
là di ciò che è noto.
Il pensiero analogico può essere e
sviluppato e potenziato per facilitare la
nostra comprensione della realtà e le
nostre decisioni.
I processi logici e analogici sono
“estesi”
Funzioni implicite ed
esplicite, primarie e
secondarie
Processi impliciti e espliciti.
Le attività cognitive si dividono in esplicite (che si
verificano a livello prevalentemente conscio) e
implicite (spesso eseguite in modo automatico e
inconscio).
Le funzioni esplicite sono basate su regole, i loro
contenuti possono essere espressi verbalmente e sono
accessibili in modo consapevole mentre quelle
implicite sono basate su abilità e procedure, il loro
contenuto non può essere espresso verbalmente ma
solo attraverso le prestazioni in un determinato
compito.
Dal punto di vista delle strutture nervose, il sistema
esplicito è associato alle funzioni cognitive superiori
della corteccia prefrontale e di quella temporale
mediale. Il sistema implicito dipende invece dalle
strutture dei gangli della base e del cervelletto che
assicurano una notevole efficienza ai compiti loro
affidati e possono anche farsi carico di funzioni
esplicite ricorrenti, eseguite in modo semi-automatico e
prevalentemente inconscio.
Il cervello dei
creativi
Attività cognitiva e
processi primari
Processi primari
(associazioni analogiche)
sogno
Rossetti 1865
Processi secondari
(astratti, logici, orientati
verso la realtà)
I creativi hanno un
maggior accesso ai
Chagall, 1931
Processi primari e secondari.
I processi primari del pensiero (come le
associazioni che caratterizzano il sogno o
gli stati di confine -detti anche rêverie o
sogno ad occhi aperti- da cui possono
emergere analogie e associazioni creative)
si svolgono a livelli di attivazione mediobassa e si verificano anche a livello
inconscio.
Gli stati di pensiero secondari (in cui
l’approccio cognitivo è astratto, logico e
orientato verso il mondo reale) si verificano
a livello prevalentemente conscio e
implicano livelli di maggiore attivazione, in
particolare della corteccia prefrontale.
Processi primari e secondari.
I processi primari facilitano la scoperta di nuove
reazioni tra elementi diversi.
E’ però semplicistico limitare la creatività a uno
stato di ridotta attività della corteccia prefrontale
che invece caratterizza alcune funzioni mentali
come il cosiddetto flow o “flusso” (un elevato
livello di motivazione e concentrazione mentale).
Il flow, tuttavia, non coincide con la creatività ma
con il perseguimento e realizzazione di un’idea o
traguardo.
Focalizzarsi su un obbiettivo.
Il flow dipende dai sistemi cognitivi
impliciti, gangli della base in primo luogo, e
si accompagna a una ridotta attività della
corteccia prefrontale, il che consente di
focalizzarsi su un obbiettivo, silenziando
invece le altre funzioni cognitive ed
esecutive (attenzione, memoria di lavoro,
scelte e decisioni ecc.) della corteccia
prefrontale.
Focalizzare l’attenzione su un compito
specifico fa sì che il sistema esecutivo
striatale lo esegua al massimo livello di
competenza ed efficienza
Produzione e selezione delle idee
creative: una strategia darwiniana.
Il sistema implicito striatale reagisce alla
novità e genera un ventaglio di nuove
risposte al fine di fronteggiare situazioni
nuove: ma successivamente è la corteccia
prefrontale a selezionare e farsi carico dei
comportamenti acquisiti di recente.
Sulla base del continuo brusio tra strutture
sottocorticali che generano novità e
corteccia prefrontale che le analizza, la
creatività può essere assimilata a un
processo darwiniano basato sulla classica
procedura della variazione-selezione: i
gangli della base generano innovazione in
tutte quelle situazioni che sono alle radici
della creatività, come i comportamenti
esplorativi, il gioco infantile o il pensiero
analogico, mentre la corteccia prefrontale è
il meccanismo che seleziona e può
trasformare le novità in comportamenti
La corteccia frontale e la
creatività
Associazioni e
soggettività
inconscia.
In ogni momento
facciamo
esperienza di
singoli
oggetti/stimoli:
questi sono
distribuiti in una
rete di associazioni
(analogie,
Dove si verificano i processi
creativi?
Quando si individua una soluzione si verifica
una rapida attivazione dei circuiti frontoparieto-temporali dell’emisfero destro, sede di
processi analogici: questa attivazione precede
di circa mezzo secondo la consapevolezza di
aver individuato la risposta giusta.
L’attivazione dell’area temporale destra è a
sua volta preceduta da un cambiamento
dell’attività del lobo frontale, l’area implicata
nel controllo di numerose funzioni cognitive e
nell’attenzione selettiva e nel blocco di quei
pensieri irrilevanti che interferiscono con la
L’«interruttore frontale».
Il manifestarsi di un’idea o di una
soluzione creativa dipende dal fatto che
la corteccia frontale «spenga» l’attività di
altre aree corticali e focalizzi l’attenzione
a livello dell’area parieto-temporale
dell’emisfero destro in cui si verificano,
spesso a livello inconscio, analogie e
associazioni creative.