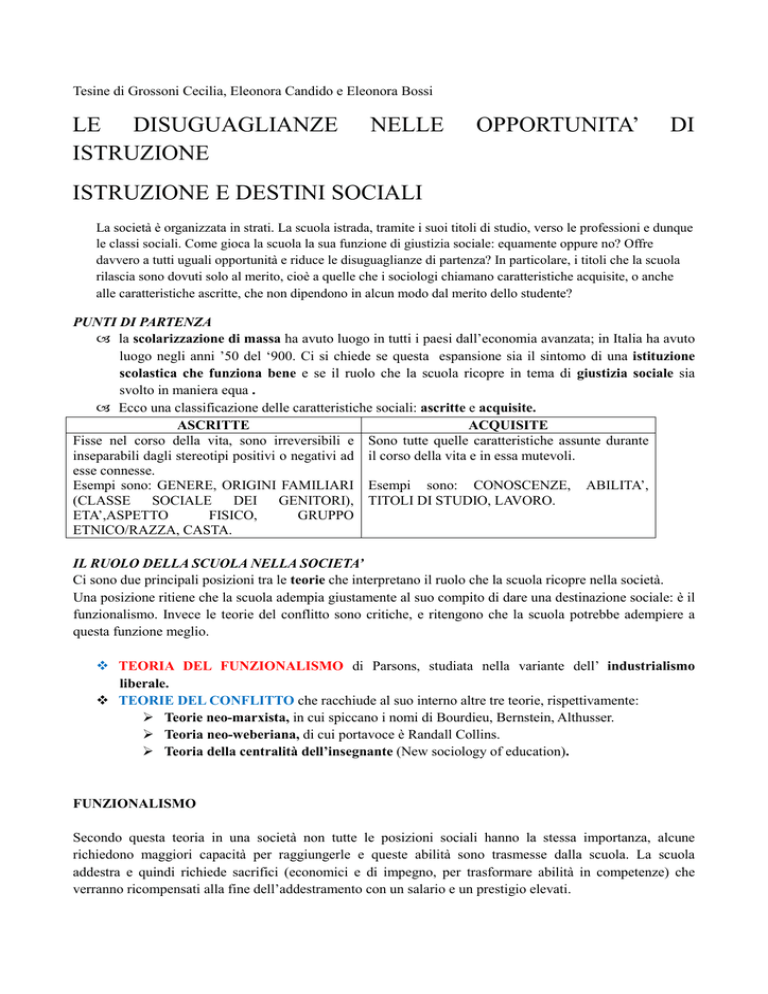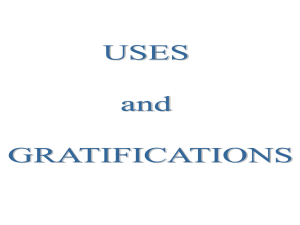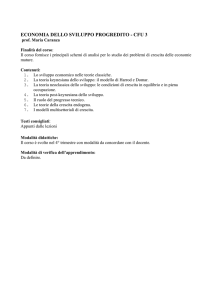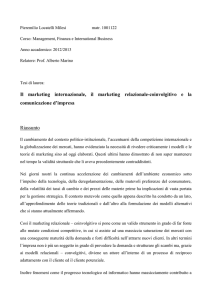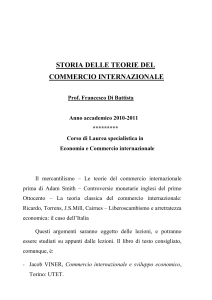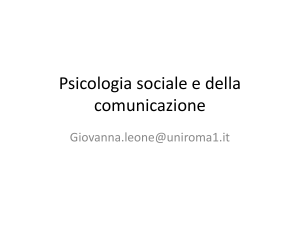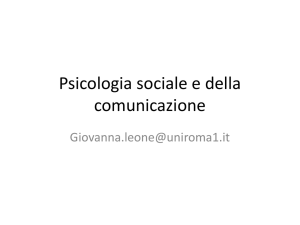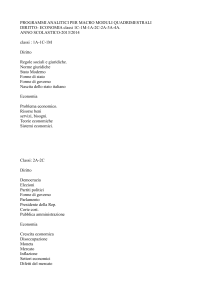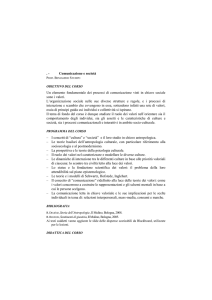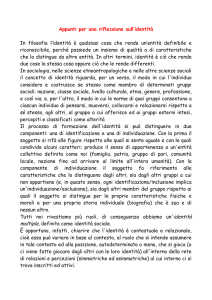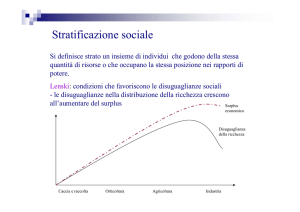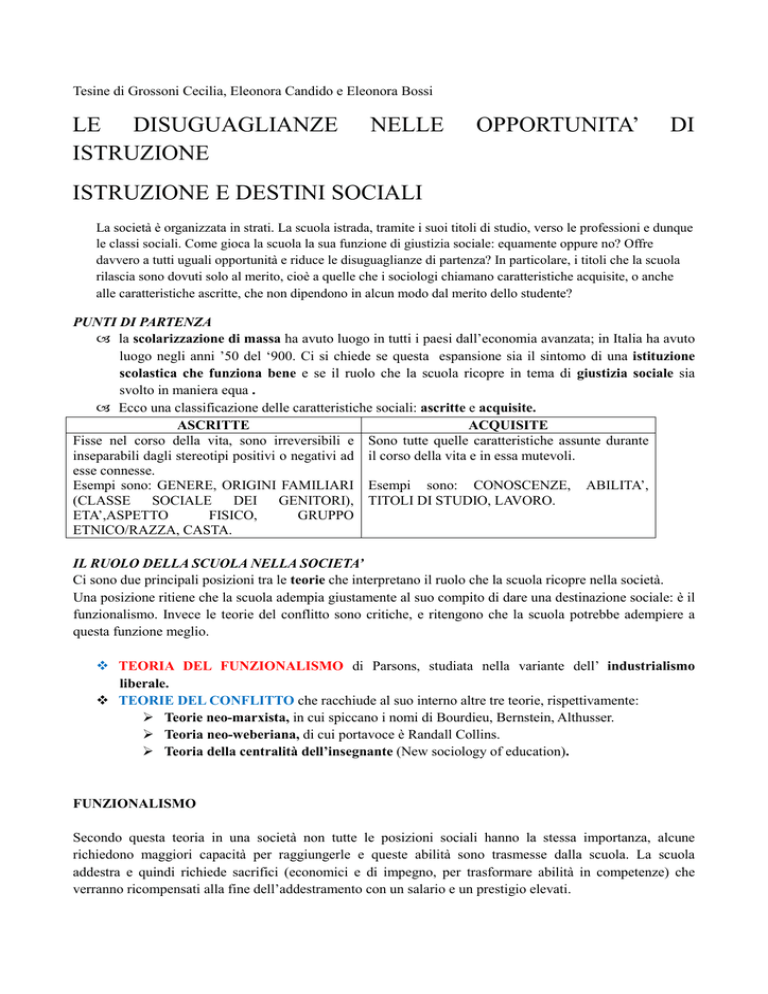
Tesine di Grossoni Cecilia, Eleonora Candido e Eleonora Bossi
LE DISUGUAGLIANZE
ISTRUZIONE
NELLE
OPPORTUNITA’
DI
ISTRUZIONE E DESTINI SOCIALI
La società è organizzata in strati. La scuola istrada, tramite i suoi titoli di studio, verso le professioni e dunque
le classi sociali. Come gioca la scuola la sua funzione di giustizia sociale: equamente oppure no? Offre
davvero a tutti uguali opportunità e riduce le disuguaglianze di partenza? In particolare, i titoli che la scuola
rilascia sono dovuti solo al merito, cioè a quelle che i sociologi chiamano caratteristiche acquisite, o anche
alle caratteristiche ascritte, che non dipendono in alcun modo dal merito dello studente?
PUNTI DI PARTENZA
la scolarizzazione di massa ha avuto luogo in tutti i paesi dall’economia avanzata; in Italia ha avuto
luogo negli anni ’50 del ‘900. Ci si chiede se questa espansione sia il sintomo di una istituzione
scolastica che funziona bene e se il ruolo che la scuola ricopre in tema di giustizia sociale sia
svolto in maniera equa .
Ecco una classificazione delle caratteristiche sociali: ascritte e acquisite.
ASCRITTE
ACQUISITE
Fisse nel corso della vita, sono irreversibili e Sono tutte quelle caratteristiche assunte durante
inseparabili dagli stereotipi positivi o negativi ad il corso della vita e in essa mutevoli.
esse connesse.
Esempi sono: GENERE, ORIGINI FAMILIARI Esempi sono: CONOSCENZE, ABILITA’,
(CLASSE
SOCIALE
DEI
GENITORI), TITOLI DI STUDIO, LAVORO.
ETA’,ASPETTO
FISICO,
GRUPPO
ETNICO/RAZZA, CASTA.
IL RUOLO DELLA SCUOLA NELLA SOCIETA’
Ci sono due principali posizioni tra le teorie che interpretano il ruolo che la scuola ricopre nella società.
Una posizione ritiene che la scuola adempia giustamente al suo compito di dare una destinazione sociale: è il
funzionalismo. Invece le teorie del conflitto sono critiche, e ritengono che la scuola potrebbe adempiere a
questa funzione meglio.
TEORIA DEL FUNZIONALISMO di Parsons, studiata nella variante dell’ industrialismo
liberale.
TEORIE DEL CONFLITTO che racchiude al suo interno altre tre teorie, rispettivamente:
Teorie neo-marxista, in cui spiccano i nomi di Bourdieu, Bernstein, Althusser.
Teoria neo-weberiana, di cui portavoce è Randall Collins.
Teoria della centralità dell’insegnante (New sociology of education).
FUNZIONALISMO
Secondo questa teoria in una società non tutte le posizioni sociali hanno la stessa importanza, alcune
richiedono maggiori capacità per raggiungerle e queste abilità sono trasmesse dalla scuola. La scuola
addestra e quindi richiede sacrifici (economici e di impegno, per trasformare abilità in competenze) che
verranno ricompensati alla fine dell’addestramento con un salario e un prestigio elevati.
Il prestigio sociale è dato da un buon lavoro che, a sua volta, determina la collocazione sociale. Ovviamente,
l’ingresso nel mondo del lavoro e in particolare il prestigio dell’impiego dipendono dal percorso scolastico
effettuato; quindi non tutti possono accedere alle professioni maggiormente pagate e prestigiose. Il fattore
discriminante non è da cercarsi nelle caratteristiche ascritte bensì in quelle acquisite e questo elemento di
merito fa della scuola un’importante e adeguato portatore di giustizia sociale. Nell’ottica funzionalista è la
scuola a trasformare le capacità di cui dispone un soggetto in competenze e a dare a ciascuno secondo il suo
merito.
Il mondo del lavoro necessita sempre più di personale specializzato, ampliando l’accesso al suo interno
anche alle persone provenienti dalle classi più basse.
Il tasso di mobilità sociale aumenta all’aumentare dello sviluppo della società.
La democratizzazione ha portato a far prevalere il criterio di merito rispetto a quello di prestigio sociale e
quindi ad affermare che, in questa prospettiva, la società è una società giusta.
Secondo questa teoria, le disuguaglianze nelle opportunità di istruzione sono mutate nel tempo; ora c’è più
equità.
Come accade per ogni teoria, è necessario verificare se e in quali casi questa è validata e se e in quali è
confutata.
Bisogna distinguere, all’interno delle disuguaglianze nelle opportunità di istruzione, tre disuguaglianze
ASSOLUTE e RELATIVE.
Si parla di disuguaglianze assolute in riferimento al numero complessivo di persone interessate
all’istruzione. Su questo tipo di disuguaglianze hanno effetto agenti come: l’organizzazione del
sistema scolastico, le politiche scolastiche, la richiesta di lavoro in ambito economico e il valore di
mercato dei titoli di studio.
Si parla di disuguaglianze relative per spiegare la relazione tra opportunità di studio e la classe di
provenienza.
(fin qui, ha scritto Cecilia Grossoni)
LE DISUGUALIANZE ASSOLUTE NELLE OPPORTUNITA’ DI ISTRUZIONE DIPENDONO DA
o
o
o
o
Organizzazione del sistema scolastico (più o meno stratificato) che determina le possibilità di accesso
all’istruzione
Politiche per il diritto allo studio (borse di studio per i meritevoli privi di mezzi) che determina il numero
di persone che rimangono nella scuola fino ai livelli più elevati di istruzione
Domanda di forza lavoro in ambito economico (più aumentano le richieste per un lavoro qualificato più
aumentano le richieste di formazione)
Valore di mercato dei titoli di studio (tanto più un titolo di studio dà accesso a lavori qualificati, tanto più
è desiderabile ottenerlo e molti proseguono con gli studi).
LE DISUGUALIANZE RELATIVE NELLE OPPORTUNITA’ DI ISTRUZIONE REGISTRANO SOLO
o
L’EFFETTO DELLA CLASSE SOCIALE DI APPARTENENZA
La disuguaglianza relativa esprime solo l’effetto in campo formativo dei vantaggi e degli svantaggi di ordine
materiale o immateriale dovuti all’estrazione sociale.
Andiamo a guardare l’effetto della classe sociale dei genitori sul titolo di studio che conseguono i figli.
Ricordiamo che la classe sociale della famiglia da cui si proviene è una tipica caratteristica sociale ascritta, cioè
che non ha a che vedere con il merito di uno studente.
Quindi, se la teoria funzionalista fosse vera, l’appartenenza di classe dovrebbe essere irrilevante ai fini dei titoli di
studi conseguiti e di conseguenza per la destinazione sociale raggiunta alla fine del percorso scolastico.
Il grafico mostra
come nel corso del
XX sec., in Italia,
l’istruzione di base
è stata raggiunta
da tutta la
popolazione
italiana, indipendentemen-te
dalla classe sociale
di provenienza dei
genitori.
Questo
evidenzia
l’annulla
mento
delle disuguaglianze assolute per l’istruzione primaria e secondaria di primo grado in Italia.
La teoria funzionalista è quindi convalidata dai dati che riguardano la frequenza della scuola dell’obbligo
in Italia.
Il raggiungimento della
maturità (in Italia)
Osservando il grafico notiamo
come la curva di
scolarizzazione secondaria
cresca per tutte le classi sociali
tra gli anni ’30 e gli anni ’50
poi rimane costante.
Si nota come la classe con il
tasso maggiore di diplomati è
quella borghese seguita dalla
classe media impiegatizia
(40% nel ’28 e 75% e oltre nel
’58).
Al contrario le altre classi, se
mai raggiungono il 50% di diplomati, lo fanno solo dopo gli anni ’50.
Questo dato contrasta le tesi dell’industrialismo liberale che vuole tutte le classi sociali coinvolte in
un continuo aumento della partecipazione scolastica, per effetto della democratizzazione degli accessi
all’istruzione superiore.
I laureati (in Italia)
Il grafico presenta in questo caso un andamento
piuttosto stabile nel corso del XX secolo.
Le classi borghesi e media impiegatizia contano nelle
loro file il 25% dei laureati negli anni ’30, con un
incremento fino al 40% circa negli anni ‘50
Tutte le altre classi seppur con un minimo
miglioramento, producono al massimo il 10-15% di
figli laureati.
Anche questo dato contrasta le tesi
dell’industrialismo liberale.
CONCLUSIONI
La teoria funzionalista è quindi corroborata per ciò che riguarda le disuguaglianze di opportunità di
istruzione assolute primaria e secondaria di primo grado, che si sono annullate nel tempo.
Ma è confutata nella scelta della scuola secondaria, nell’accesso all’università, e nella scelta della
facoltà universitaria.
É confutata anche per le disuguaglianze nelle opportunità di istruzione relative, poiché queste sono
rimaste costanti nel tempo.
Teorie NEOMARXISTE
I neo-marxisti individuano 2 effetti dovuti alla classe sociale di origine:
Primario: abilità, cultura e motivazione dello studente sono trasmesse dalla famiglia d’origine e
condizionano la riuscita formativa dello stesso.
Secondario: risorse economiche e di potere della famiglia e capacità della stessa di sostenere costi diretti e
indiretti dell’istruzione.
Alcuni neo-marxisti (Bowles e Gintis, 1976) sostengono che l’espansione del tasso di scolarizzazione è usato
dalle classi sociali sovraordinate per:
A) integrare nel loro modello culturale di divisione del lavoro le classi subalterne (rendere i ragazzi di classe
sociale svantaggiata disciplinati e abituati al lavoro ripetitivo ed esecutivo della fabbrica)
B) legittimare le struttura sociale esistente e l’appartenenza a una classe, a partire dal criterio del merito
(mentre invece la scuola non farebbe che certificare differenze culturali che i ragazzi portano con sé
all’ingresso a scuola e che derivano dalla famiglia).
C) generare falsa coscienza nelle classi subalterne
Per Althusser, un altro autore neo-marxista,
La scuola non ha una reale influenza sulle carriere professionali e sociali delle persone, ma si limita a:
1)
dare una giustificazione meritocratica alle differenze sociali precedenti.
Queste differenze rimangono immutate durante e dopo il percorso scolastico.
2) sviluppare, negli individui provenienti dalle classi sociali più basse, comportamenti utili all’organizzazione
produttiva capitalistica (obbedienza, disciplina, ...)
(Althusser 1965)
Sono neo-marxiste le TEORIE DELLA DEPRIVAZIONE CULTURALE
Gli studenti di diverse classi sociali, per effetto della diversa socializzazione, hanno un diverso:
A) CAPITALE CULTURALE: Bourdieu
B) CODICE LINGUISTICO: Bernstein
A) Vista l’equa distribuzione delle capacità intellettuali nelle diverse classi sociali, si suppone siano i meccanismi
di trasmissione culturale a stabilire le diseguaglianze sociali e i conseguenti svantaggi in ambito scolastico.
Bordieu sostiene che gli studenti di bassa estrazione sociale hanno peggiori prestazioni scolastiche a causa
dell’habitus, inteso come sistema integrato di conoscenze, valori e atteggiamenti verso la cultura, quindi rispetto ai
colleghi delle classi più alte si trovano quindi in una condizione di svantaggio.
B) Bernstein sostiene invece che gli studenti della classi più basse sono addestrati ad utilizzare un codice
linguistico ristretto (anche in pubblico), rispetto agli studenti delle classi medie e borghesi i quali padroneggiano
anche codici più articolati che sono quelli tipici della scuola e riconosciuti nella valutazione scolastica.
CLASSE DI ORIGINE, ISTRUZIONE E DESTINAZIONE SOCIALE
In questo grafico vediamo come
le origini sociali hanno influenza,
(freccia azzurra) principalmente sulle
opportunità di istruzione (0.39) mentre
l’istruzione influisce maggiormente
sulla destinazione di classe (0.55).
La situazione sociale d’origine infatti
influisce direttamente sulla destinazione
sociale con un coefficiente pari a 0.19.
Osserviamo l’effetto complessivo delle origini sociali sulla destinazione sociale, composto dai coefficienti
'Origine sociale su istruzione' e 'Istruzione su destinazione sociale': quindi, l'effetto complessivo è uguale
all'effetto diretto moltiplicato l'effetto indiretto delle origini sociali, cioè si moltiplica 0,39 * 0,55 = 0,21. Si
somma a questo l’effetto 'Origine sociale su destinazione sociale' che risulta pari a 0,21 + 0,19 = 0,40. Si
tratta di tutti gli effetti cumulati delle caratteristiche ascritte.
Se lo paragoniamo all’effetto dell’istruzione sulla destinazione sociale dall’altra parte (cioè il peso delle
caratteristiche acquisite), che è di 0,55, l’effetto complessivo della classe sociale di provenienza risulta essere
pari a 0,40 minore, ma di poco, dell’effetto del merito scolastico, che, come abbiamo visto, è pari a 0,55.
Quindi se ne può concludere che il sistema con cui la scuola decide la destinazione sociale degli studenti non è
pienamente giusto.
CONCLUSIONI
Questi dati parlano più a favore delle teorie critiche che del funzionalismo.
La corrente neo-marxista trova conforto in questi dati: le origini sociali hanno effetti sui destini sociali. Quindi
non tutto è deciso dal merito, molto è deciso dalla appartenenza di classe della famiglia in cui nasciamo, su cui
non abbiamo alcuna influenza.
TEORIE NEO-WEBERIANE
Si parte dalla teoria di Weber per cui i ceti sono dei gruppi chiusi.
Chi appartiene ai ceti elevati tende a reclutare (quindi chiama a svolgere i lavori tipici del proprio ceto) gli
appartenenti al suo stesso ambiente (quindi i figli delle famiglie già appartenenti a quel ceto).
I titoli di studio sono usati per monopolizzare l’accesso alle posizioni più alte nella società. Per cui chi appartiene
alle classi inferiori anche se aspira a conseguire un titolo di studio elevato, incontra numerose difficoltà dato che
le classi più elevate fanno in modo che classi più basse vi accedano con difficoltà. La scuola, infatti, oltre a dare
conoscenze e competenze, fornisce anche titoli di studio, cioè credenziali per accedere alle professioni. Sono le
credenziali date agli studenti nel loro percorso formativo ad essere distribuite in modo diseguale.
NEW SOCIOLOGY OF EDUCATION
Teoria della centralità dell’insegnante
Secondo questa teoria gli studenti delle classi inferiori non sono culturalmente deprivati, ma hanno una loro
cultura propria con pari dignità di quella delle classi superiori. Tuttavia gli appartenenti alle classi benestanti
condividono con gli insegnanti una cultura di classe media. I docenti quindi sarebbero, secondo tale teoria,
orientati a considerare inadatti alla scuola e socialmente inappropriati il sistema di valori, di comportamenti e
gli stili cognitivi degli studenti delle classi inferiori.
Questo giudizio si riscontra nei voti bassi spesso ricevuti dai figli delle classi subalterne, dai richiami per
comportamenti ritenuti inadeguati dagli insegnanti e dall’atteggiamento di sopportazione nei loro confronti
da parte degli insegnanti. Le aspettative degli insegnanti sono decisive per la riuscita scolastica degli
studenti.
Le teorie sono convalidate o confutate dai dati? Andiamo a vedere.
VOTI DI MATURITA’
I dati raccolti sul voto di maturità mostrano come le valutazioni siano equamente distribuite sia tra gli studenti di
classe
borghese che di quella operaia.
Questo dato, che si riferisce alla
scuola italiana, confuta le teorie:
deprivazione culturale
(teorie neo-marxiste di Bourdieu e Bernstein)
neo-weberiana (insegnanti, che appartenenti alla classe
media, non favoriscono gli studenti di classe
medio/alta, ma trattano tutti allo stesso modo.
In più molti laureati di oggi sono nipoti di operai
o persone di classe operaia)
centralità dell’insegnante (gli insegnanti non sono la causa delle differenze sociali e sanno riconoscere come valide le
prestazioni degli studenti di diversa provenienza sociale).
TRANSIZIONE ALL’UNIVERSITÀ
(ovvero quanti si iscrivono all’università, in funzione del voto di maturità e differenziando tra studenti di famiglia
borghese e operaia)
Il grafico mostra come i maturi di famiglia borghese si iscrivono
più frequentemente all’università mentre i maturi di
famiglia operaia lo fanno di meno. Questo accade in un
campione in cui i voti di maturità sono distribuiti
uniformemente tra le due popolazioni.
Questo dato corrobora la tesi neo-marxiste.
Le teorie del conflitto sono quindi corroborate considerata l’influenza che la famiglia d’origine ha sulle scelte di
studio e formazione degli studenti.
SCELTA DELLA SCUOLA SECONDARIA
Riguardo la scelta dell’indirizzo di scuola secondaria si nota come la classe borghese e la classe media
impiegatizia hanno maggiore accesso all’istruzione liceale (71% e 45%).
La piccola borghesia urbana e quella agricola privilegiano l’istruzione tecnica (48% e 45%), così come la classe
operaia urbana (47% circa). Mentre la classe operaia agricola è fortemente orientata verso l’istruzione
professionale.
SCELTA DELLA FACOLTA’ UNIVERSTARIA
Per quanto riguarda i diplomi universitari, osservando il grafico notiamo come man mano che si sale nella
gerarchia delle facoltà troviamo presenti maggiormente membri delle classi più alte.
Questo convalida le tesi neo-marxiste
Conclusioni
Si sente l’effetto della classe sociale della famiglia di origine sulla classe sociale di destinazione dei figli,
passando dalla scuola.
1.
le origini influiscono sulle chance di raggiungere i titoli di studio
2.
i titoli di studio influiscono sulle chance di raggiungere le classi sociali più elevate
3.
le origini moltiplicano il valore dei titoli di studio – un figlio di borghese con la laurea ha molte più
probabilità di collocarsi in una classe sociale elevata di un figlio di operaio, con la stessa laurea e
ottenere un migliore posto di lavoro
QUESTO CONVALIDA LE TESI NEO-MARXISTE E NEO-WEBWEBERIANE.
GENERE ISTRUZIONE E LAVORO
Studi di genere sui tipi di maturità conseguiti negli anni ’70 mostrano come le donne conseguano principalmente
diplomi di tipo liceale 41% e tecnico 33% e hanno il primato per la maturità magistrale 10% (la quasi totalità)
Gli uomini conseguono invece principalmente diplomi tecnici 50,2% seguiti da quelli di tipo liceale 29% e quelli
professionali 13%.
Riguardo le scelte universitarie le donne prediligono le Facoltà di Lettere e Filosofia 23% e Magistero e
Psicologia (9,3%).
Gli uomini invece scelgono con maggiore frequenza facoltà di economia (25%) e ingegneria (16%).
NB Sono le studentesse a ottenere un numero maggiore di titoli universitari rispetto agli studenti
Tuttavia i titoli più prestigiosi sono conseguiti dagli studenti, e così gli impieghi lavorativi più redditizi.
(Eleonora Candido)
Istruzione e destini sociali in sintesi:
Le teorie neo-weberiane riguardano i ceti, i gruppi chiusi. Esse affermano che i titoli
di studio sono utilizzati dalle classi sovraordinate per monopolizzare le posizioni
sociali più vantaggiose ed esse fanno in modo che le classi sociali più basse abbiano
ad essi un accesso limitato.
Le teorie neo-marxiste sostengono che la scuola non ha una reale influenza sulle
carriere professionali e sociali delle persone, ma si limita a dare una giustificazione
meritocratica alle differenze sociali già esistenti che non vengono modificate dal
percorso scolastico effettuato.
Le teorie della centralità dell’insegnante asseriscono che gli studenti delle classi
sociali più svantaggiate hanno una loro cultura, valori, modelli di comportamento e
stili cognitivi che sono differenti da quelli dell’insegnante che appartiene, in
prevalenza, alla classe media. Per questo motivo l’insegnante tenderebbe a dare voti
sistematicamente più bassi e ad assumere un comportamento penalizzante nei
confronti di questi studenti.
Queste teorie sono confutate dal dato secondo cui molti laureati di oggi sono nipoti
di nonni poco scolarizzati, fatto dovuto alla scolarizzazione di massa.
Sempre a sfavore delle tre teorie critiche (della teoria della centralità dell’insegnante,
del credenzialismo e delle teorie neo-marxiste della deprivazione culturale) vi sono i
dati riguardanti i voti di maturità dei figli di borghesi e di operai:
I dati riguardanti (a) la scelta dell’indirizzo scolastico nella secondaria di secondo
grado, (b) la transizione all’università secondo la classe sociale d’origine e il voto di
maturità e (c) la scelta della facoltà confutano la teoria funzionalista e confermano
le teorie neo-marxiste. Si può notare come sia la classe sociale e non il voto ricevuto
a influire sul passaggio o meno all’università, infatti a parità di voto è maggiore la
percentuale dei figli di borghesi che vanno all’università rispetto ai figli di operai.
Sempre a favore delle teorie neo-marxiste sono i dati che confrontano la classe di
provenienza con la scelta degli indirizzi scolatici (a) e accademici (b). Esiste una
forte corrispondenza tra la gerarchia sociale e il percorso accademico scelto, questo a
conferma dell'influenza della classe sociale di appartenenza sulle scelte di istruzione
accademica.
A confermare le teorie neo-marxiste e neo-weberiane sono i dati secondo cui la classe
sociale della famiglia di origine ha effetto sulla classe sociale dei figli; infatti:
Le origini sociali influiscono sulle chance di raggiungere i diversi titoli di
studio
I titoli di studio influiscono sulle possibilità di raggiungere posizioni sociali
elevate
Le origini sociali moltiplicano il valore dei titoli di studio. Un figlio di
borghese laureato ha più possibilità di collocarsi in una classe sociale più
elevata di quante ne abbia un figlio di operaio con la stessa laurea.
Questo indica che i titoli di studio sono credenziali come sostenuto dai neo-weberiani
ma anche che la classe di origine ha una grande importanza, che prevale sul merito
come sostenuto dalle teorie neo-marxiste.
Il livello di istruzione non dipende solo dalla classe sociale ma anche dal genere.
Dalla tabella si può notare come alcuni indirizzi siano privilegiati dalle donne come
ad esempio l'istruzione magistrale e quella liceale. Una interpretazione possibile di
questi dati è questa: la scelta dell'istituto magistrale è effetto di pregiudizi e
aspettative di stampo tradizionale sul ruolo e le occupazioni della donna.
La scelta del liceo potrebbe essere dovuta al fatto che le donne che vogliono
raggiungere determinate posizioni lavorative devono avere un titolo di studio
superiore a quello della loro controparte maschile. Ciò spiega anche i risultati di
rendimento scolastico e accademico per cui le ragazze prendono in media votazioni
superiori a quelli dei ragazzi, perché devono dimostrare di essere più brave di loro per
poter essere prese in considerazione per le professioni più retribuite e prestigiose.
(Sintesi di Eleonora Teresa Bossi)