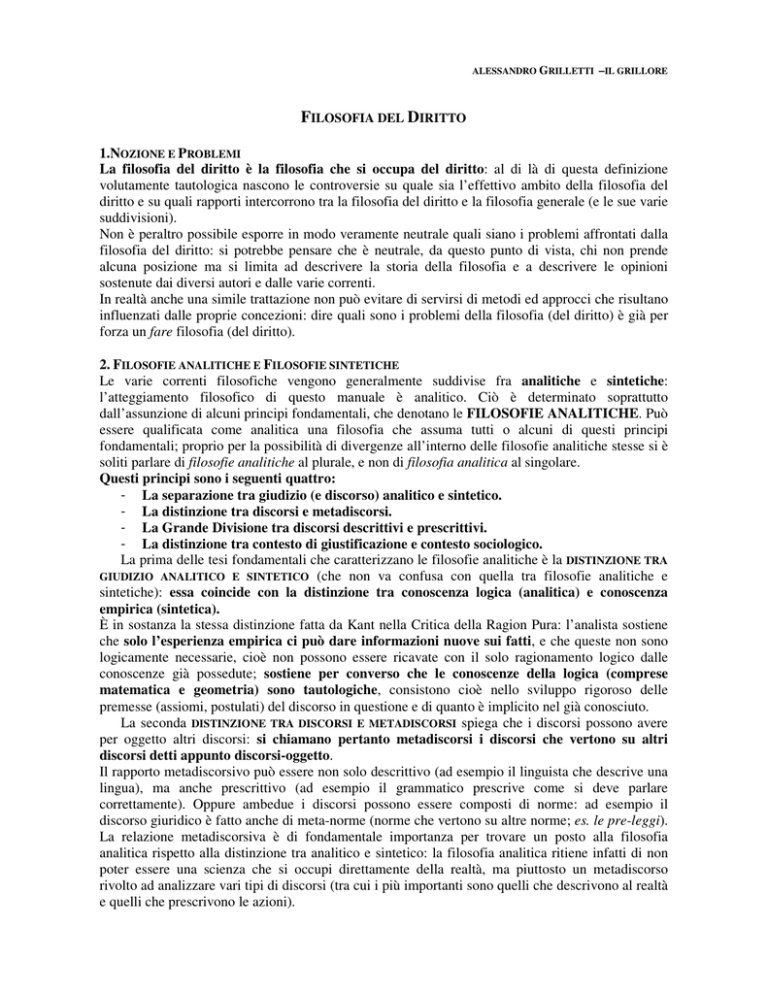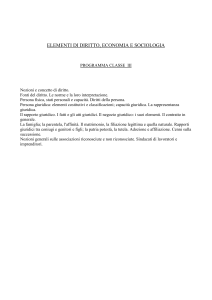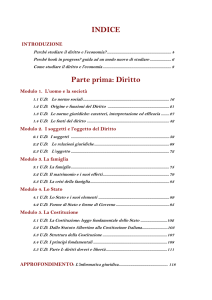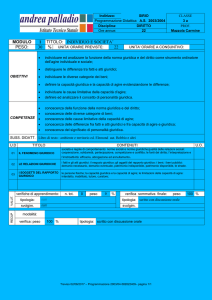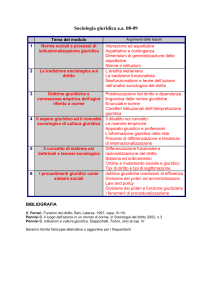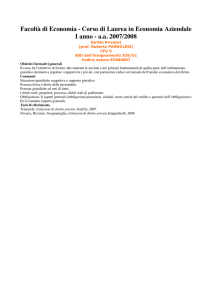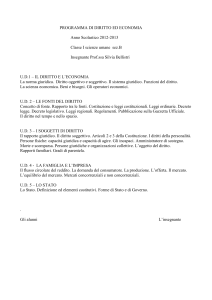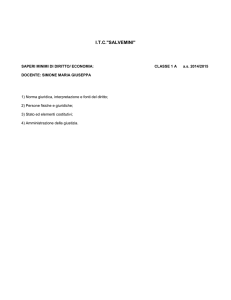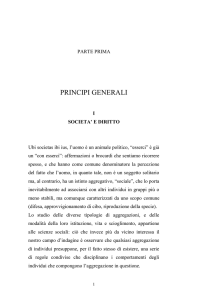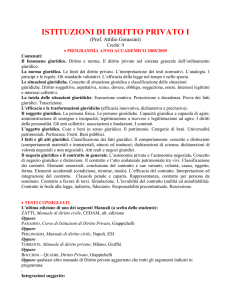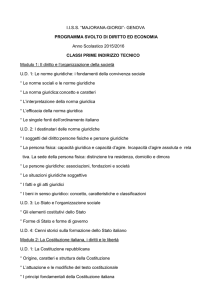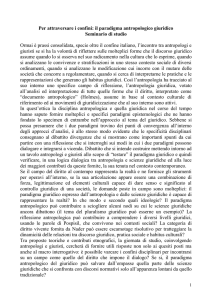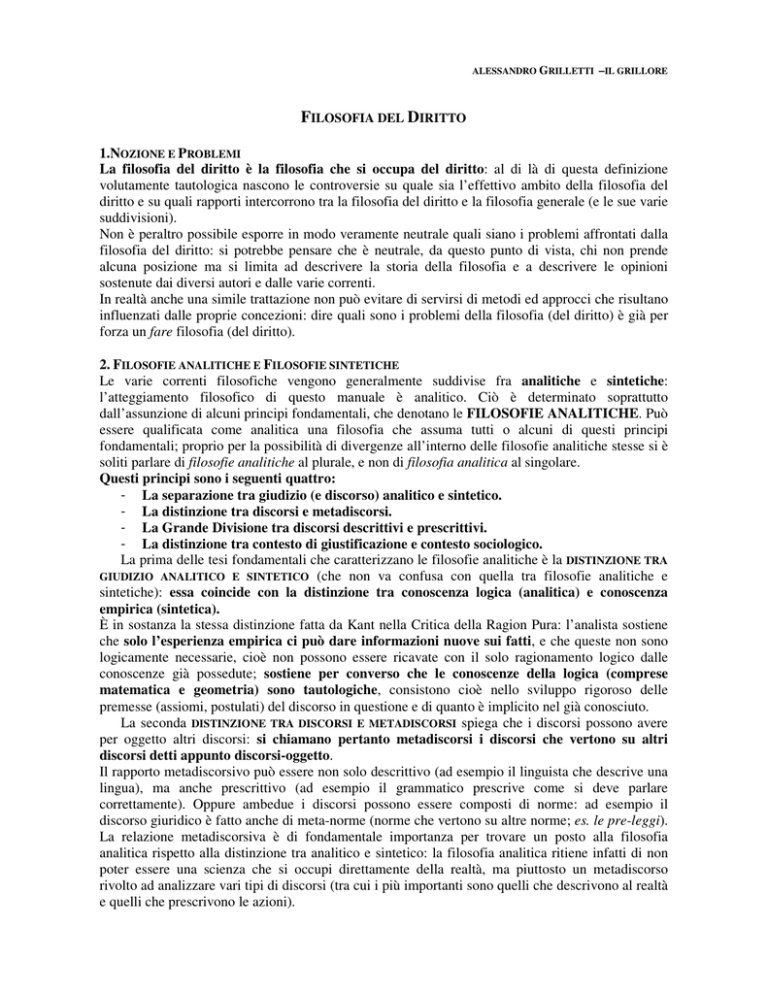
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
FILOSOFIA DEL DIRITTO
1.NOZIONE E PROBLEMI
La filosofia del diritto è la filosofia che si occupa del diritto: al di là di questa definizione
volutamente tautologica nascono le controversie su quale sia l’effettivo ambito della filosofia del
diritto e su quali rapporti intercorrono tra la filosofia del diritto e la filosofia generale (e le sue varie
suddivisioni).
Non è peraltro possibile esporre in modo veramente neutrale quali siano i problemi affrontati dalla
filosofia del diritto: si potrebbe pensare che è neutrale, da questo punto di vista, chi non prende
alcuna posizione ma si limita ad descrivere la storia della filosofia e a descrivere le opinioni
sostenute dai diversi autori e dalle varie correnti.
In realtà anche una simile trattazione non può evitare di servirsi di metodi ed approcci che risultano
influenzati dalle proprie concezioni: dire quali sono i problemi della filosofia (del diritto) è già per
forza un fare filosofia (del diritto).
2. FILOSOFIE ANALITICHE E FILOSOFIE SINTETICHE
Le varie correnti filosofiche vengono generalmente suddivise fra analitiche e sintetiche:
l’atteggiamento filosofico di questo manuale è analitico. Ciò è determinato soprattutto
dall’assunzione di alcuni principi fondamentali, che denotano le FILOSOFIE ANALITICHE. Può
essere qualificata come analitica una filosofia che assuma tutti o alcuni di questi principi
fondamentali; proprio per la possibilità di divergenze all’interno delle filosofie analitiche stesse si è
soliti parlare di filosofie analitiche al plurale, e non di filosofia analitica al singolare.
Questi principi sono i seguenti quattro:
- La separazione tra giudizio (e discorso) analitico e sintetico.
- La distinzione tra discorsi e metadiscorsi.
- La Grande Divisione tra discorsi descrittivi e prescrittivi.
- La distinzione tra contesto di giustificazione e contesto sociologico.
La prima delle tesi fondamentali che caratterizzano le filosofie analitiche è la DISTINZIONE TRA
GIUDIZIO ANALITICO E SINTETICO (che non va confusa con quella tra filosofie analitiche e
sintetiche): essa coincide con la distinzione tra conoscenza logica (analitica) e conoscenza
empirica (sintetica).
È in sostanza la stessa distinzione fatta da Kant nella Critica della Ragion Pura: l’analista sostiene
che solo l’esperienza empirica ci può dare informazioni nuove sui fatti, e che queste non sono
logicamente necessarie, cioè non possono essere ricavate con il solo ragionamento logico dalle
conoscenze già possedute; sostiene per converso che le conoscenze della logica (comprese
matematica e geometria) sono tautologiche, consistono cioè nello sviluppo rigoroso delle
premesse (assiomi, postulati) del discorso in questione e di quanto è implicito nel già conosciuto.
La seconda DISTINZIONE TRA DISCORSI E METADISCORSI spiega che i discorsi possono avere
per oggetto altri discorsi: si chiamano pertanto metadiscorsi i discorsi che vertono su altri
discorsi detti appunto discorsi-oggetto.
Il rapporto metadiscorsivo può essere non solo descrittivo (ad esempio il linguista che descrive una
lingua), ma anche prescrittivo (ad esempio il grammatico prescrive come si deve parlare
correttamente). Oppure ambedue i discorsi possono essere composti di norme: ad esempio il
discorso giuridico è fatto anche di meta-norme (norme che vertono su altre norme; es. le pre-leggi).
La relazione metadiscorsiva è di fondamentale importanza per trovare un posto alla filosofia
analitica rispetto alla distinzione tra analitico e sintetico: la filosofia analitica ritiene infatti di non
poter essere una scienza che si occupi direttamente della realtà, ma piuttosto un metadiscorso
rivolto ad analizzare vari tipi di discorsi (tra cui i più importanti sono quelli che descrivono al realtà
e quelli che prescrivono le azioni).
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
Per questo le filosofie analitiche vengono spesso chiamate FILOSOFIE LINGUISTICHE o, un po’
impropriamente, filosofie del linguaggio: tuttavia l’aspetto fondamentale delle filosofie analitiche
non è l’attenzione per il linguaggio (che pure è l’aspetto che colpisce maggiormente); essa risulta
più che altro un carattere derivato. Ciò perché l’approccio analitico discende dai principi indicati, di
cui l’attenzione per il linguaggio è conseguenza.
Poiché hanno per oggetto altri discorsi e discipline, le filosofie analitiche tendono alla
specializzazione, e si suddividono in varie branche della filosofia: filosofia della scienza, filosofia
della matematica, filosofia della morale, filosofia del diritto. Le filosofie analitiche tendono pertanto
al discorso particolare e settoriale piuttosto che alla grande costruzione sistematica (atteggiamento
questo, perseguito dalle filosofie sintetiche).
Il terzo principio fondamentale delle filosofie analitiche è quello della DISTINZIONE FRA ESSERE
E DOVER ESSERE, comunemente noto tra gli analisti come la Grande Divisione: ossia che non è
possibile dedurre logicamente un giudizio di valore o normativo (cioè prescrittivo) da uno fattuale
(cioè descrittivo); non è possibile fondare in modo conclusivo un discorso di dover essere su un
discorso meramente fattuale. Inoltre non è possibile neppure l’inverso: non è possibile dedurre
conclusioni di fatto da prescrizioni (la cosiddetta SCIENZA NORMATIVA); questa preclusione crea
molti problemi per chi cerca di giustificare analiticamente la scienza giuridica tradizionale, che
sembra fare proprio questo. Chi cerca di superare queste barriere tra essere e dover essere viene
accusato di fallacia naturalistica (vedi la voce in:Giustizia).
Un quarto principio fondamentale delle filosofie analitiche è la DISTINZIONE TRA CONTESTO DI
GIUSTIFICAZIONE E CONTESTO SOCIOLOGICO:per molti analisti bisogna distinguere il
(meta)discorso che descrive le regole di formazione, giustificazione e controllo di un discorso
oggetto (discorso di giustificazione), dalla descrizione del modo in cui di fatto viene usato il
discorso oggetto , lo studio della sua influenza sulla società, delle condizioni fattuali che lo
determinano e della sua storia fattuale (discorso sociologico e storico).
Il discorso di giustificazione è naturalmente un’astrazione; esso individua regole e strutture di
regole (ragioni) che possono anche non essere sempre effettivamente tra le cause che producono il
discorso stesso: le ragioni possono non essere i motivi che effettivamente muovono le persone che
fanno il discorso.
Se queste sono le caratteristiche di fondo delle filosofie analitiche, possiamo chiamare, molto
sommariamente, FILOSOFIE SINTETICHE quelle che non ammettono, per ragioni diverse,
neppure la rilevanza di tali principi e l’importanza di tali distinzioni. Nella descrizione di
filosofie non analitiche, il filosofo analitico (ricordiamo che il manuale è di impostazione analitica),
non può fare a meno di lasciar trasparire la propria diversa impostazione: per esempio nella
descrizione di molti discorsi metafisici sintetici l’analista noterà che essi gli sembrano violare
contemporaneamente la distinzione tra sintetico e analitico e tra descrittivo e prescrittivo: infatti
molti sistemi metafisici tradizionali sembrano derivare nuova conoscenza dai concetti, o
prescrivono nuovi significati ai termini ordinari con la pretesa (inaccettabile per l’analitico) di
fondare la prescrizione sulla contemplazione della verità.
Lo sfavore verso ogni forma di metafisica, che in alcuni momenti iniziali (della cosiddetta fase
“eroica”) delle filosofie analitiche è giunta fino al dileggio, si è ora notevolmente attenuato:
superata la fase eroica le filosofie analitiche sono tornate ad usare un senso positivo della
metafisica, come discorso che verte sulle premesse della ricerca filosofica, premesse che non
possono essere dimostrate, ma devono essere assunte come fondamento della ricerca successiva.
Così possono essere considerati “la metafisica” delle filosofie analitiche i quattro principi
precedentemente esposti.
Pertanto, nella nuova prospettiva, il contrasto tra filosofie analitiche sintetiche non è un contrasto tra
filosofie metafisiche e non-metafisiche, ma piuttosto tra metafisiche diverse: anzi è possibile
distinguere, ancora analiticamente (in modo quindi non neutrale), tra metafisiche descrittive e
metafisiche prescrittive; le prime mirano a ricostruire i presupposti del pensiero filosofico esistenti
e diffusi nella cultura; le seconde propongono, per quanto fattibile, principi nuovi, cercando di
innovare le abitudini fondamentali di un certo settore culturale.
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
Se per i filosofi sintetici il punto forte delle filosofie sintetichesono le mancate distinzioni (che
per i loro critici analitici sono il punto debole), quello delle filosofie analitiche sono le
distinzioni medesime (questa volta a pareri invertiti): le filosofie analitiche sono irretite di
distinzioni, che creano spesso gravi limiti alla possibilità di fondazione dei discorsi e delle
dimostrazioni; le filosofie sintetiche in genere permettono forme più “potenti” di conoscenza, e
soprattutto di conoscenza dei valori e conoscenza della realtà profonda, o essenza ontologica al di là
del contingente: agli analitici queste forme di conoscenza, è inutile dirlo, paiono di frequente non
fondate e non fondabili.
Va infine ricordato che, di recente, alcune TEORIE DELL’ARGOMENTAZIONE E DELL’ERMENEUTICA
hanno cercato di collocarsi in una zona intermedia tra i due approcci sopra menzionati: cercando di
fornire un’analisi che contemporaneamente contenesse una descrizione del modo di parlare e
ragionare dei giuristi e una valutazione positiva di tale modo di ragionare, una conferma implicita
della legittimità di tali forme linguistiche. Per l’analista questa strada è tuttavia resa difficile dal
sospetto che si cerchi di passare in tal modo dal descrittivo (descrizione di come di fatto si
argomenta) al prescrittivo (prescrizione che il metodo descrittivo è lecito e buono).
3. LA FILOSOFIA DEL DIRITTO
Ci si limiterà qui a menzionare i vari problemi trattati, cercando di ordinarli in modo
filosoficamente significativo.
Come primo problema della filosofia del diritto va menzionati il problema della definizione del
concetto di diritto: questa priorità spetta non solo per tradizione, ma anche per ragioni filosofiche (si
tratta di un problema di tipo qualitativamente diverso dagli altri problemi di filosofia del diritto):
infatti il CONCETTO DI DIRITTO è il luogo dove si cercano di risolvere i problemi fondamentali
della filosofia giuridica, o meglio dove si cerca di sintetizzare e coordinare queste soluzioni. Tali
problemi possono essere problemi metafisici (quali siano i presupposti necessari o contingenti
della conoscenza o della pratica del diritto), problemi epistemologici (come si può conoscere il
diritto e in che modello di scienza rientri questo tipo di conoscenza), problemi metodologici (come
deve procedere il giurista nelle sue operazioni) e problemi etico-politici (quali scelte d’azione e
pratiche nei confronti del diritto sono giuste e buone). Tutti questi vari problemi possono essere
“compressi” nella definizione del CONCETTO DI DIRITTO: non si tratta pertanto di una mera questione
di definizione o di significato (come afferma G.Williams), ma di un insieme complesso di problemi
e soluzioni che trovano espressione mediante una definizione e un concetto.
Tra gli altri problemi importanti della filosofia del diritto, vanno ricordate le questioni principali
dell’epistemologia e della metodologia giuridica (es. il problema della norma, dell’interpretazione,
della conoscenza e derivazione del diritto, del significato dei concetti giuridici): talora si tende a
raggruppare questi problemi, che vengono chiamati PROBLEMI CENTRALI DEL DIRITTO (a metà
strada tra i problemi fondamentali e il diritto positivo) e di cui si occupa la TEORIA GENERALE DEL
DIRITTO; essa è dunque distinta dalla FILOSOFIA DEL DIRITTO che si occupa dei PROBLEMI
FONDAMENTALI.
La rilevanza di questa distinzione consiste nel mettere in evidenza che qualunque discussione sui
problemi centrali rimanderà inevitabilmente ai problemi fondamentali; ciò spiega perché molte
discussioni filosofiche non riescono a giungere da buon fine: perché partono da premesse differenti.
In tempi recenti, la scelta di occuparsi di determinati problemi accompagna di solito un particolare
orientamento filosofico: i problemi di epistemologia e di metodologia giuridica vengono perlopiù
trattati dalle filosofie analitiche; i problemi etico-politici interessano maggiormente le filosofie
sintetiche (nel campo etico, la filosofia analitica si è interessata più che altro di meta-etica, cioè del
metodo di determinazione dei valori morali). Se i giusfilosofi analisti si sono occupati del problema
dei valori molto meno rispetto ai sintetici, è soprattutto perché essi ritengono di non essere in grado
di risolvere filosoficamente detti problemi (cioè di non poter fondare le risposte etiche, ma solo
analizzarne la coerenza per individuarne le premesse e i principi etico-normativi): i problemi di
valore del diritto vengono in genere studiati da filosofie non analitiche, che ritengono di poter
giungere
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
a conclusioni tramite dimostrazione filosofica (che si rifanno a movimenti più generali quali
l’esistenzialismo, il marxismo, l’hegelismo ecc.).
In generale, i problemi proposti dalla filosofia del diritto si dividono in tre grandi gruppi: problemi
assiologici o di valore, riguardanti il diritto come dovrebbe essere; problemi ontologici,
riguardanti l’esame del diritto come esso è; problemi fenomenologici, che riguardano l’esistenza
del diritto nella società; più di recente è stata aggiunta un’altra voce, i problemi metodologici, che
riguardano appunto il metodo di conoscenza e applicazione del diritto.
CONCETTO DI DIRITTO
1.NOZIONE E PROBLEMI
Il concetto di diritto è l’insieme delle tesi fondamentali di ciascun approccio al diritto, cioè
delle scelte primitive di ciascuna concezione del diritto.
Tali scelte non sono unicamente epistemologiche (riguardanti cioè il modo di conoscere il diritto),
ma anche etiche e politiche. Sovente, tra gli studiosi del diritto, esse non sono nemmeno esplicite,
consapevoli e coerenti.
Proprio per questo, il semplice parlare di concetto di diritto non è un approccio neutrale e da tutti
accettabile, perché presuppone che queste scelte fondamentali:
- Ci siano e siano rilevanti
- Possano e debbano essere esplicitate
- Possono essere rese in termini generali; e siano dunque coerenti tra loro e con le idee di chi
le sostiene
In particolare i GIURISTI POSITIVI contemporanei tendono a vedere questo concetto con sfavore
(poiché lo considerano un concetto non giuridico, ma filosofico), sostenendo che non ce ne sia
alcun bisogno, perché il diritto è per loro identificato da norme giuridiche positive (: formulate ed
imposte), e non da concetti filosofici.
Di concetto di diritto non è comunque possibile dare una definizione neutrale neppure per i filosofi,
perché essi discutono non solo su quale sia il vero concetto di diritto, cioè sulla sua definizione, ma
anche su quale sia la corretta definizione di concetto. Inoltre, anche che cosa sia una definizione è
un complesso problema filosofico.
Tradizionalmente comunque, il problema del concetto di diritto è stato considerato il centro della
filosofia del diritto: trovare la definizione di diritto vuole dire innanzitutto trovare i caratteri
essenziali del diritto, o almeno quelli differenziali, che lo distinguono cioè da altri concetti affini
e con esso confondibili, come la morale e i costumi sociali.
Un concetto può essere presente in un discorso in forma esplicita o implicita: diventa esplicito
quando il suo uso è descritto o regolato da una definizione. Tutti usiamo i concetti, più o meno
esplicitamente: il dubbio non è dunque se essi siano utili o meno (sono anzi “necessari” al discorso),
ma se sia necessario o meno renderli espliciti e modificarne o regolarne l’utilizzo tramite l’uso di
definizioni. Si consideri il termine “mamma”: è ovvio che un bambino sa utilizzare questo termine,
ma non sarebbe capace di formularne una definizione generale esplicita. I concetti smettono di
funzionare bene in questo modo implicito quando intervengono situazioni che fanno sorgere
problemi di confine. Nel caso di “mamma” il problema in genere non sorge (ma potrebbe sorgere in
presenza di genitori adottivi o matrigne).
Ora, il diritto è un’entità assai meno delimitate e familiare delle mamme: a maggior ragione i
giuristi non possono fare a meno di usare un qualche concetto (implicito o esplicito) di diritto
quando trattano i propri affari giuridici e parlano di diritto. Tuttavia, in casi estremi, il
concetto di diritto può essere messo in crisi: qui interviene la filosofia, per affermare con forza che
il concetto di diritto è uno strumento misconosciuto dalla SCIENZA GIURIDICA POSITIVA, ma
comunque utilizzato ed indispensabile.
Un ramo della filosofia contemporanea, la FILOSOFIA ANALITICA, ha sottoposto ad indagine
sistematica questo problema, giungendo a conclusioni piuttosto radicali: si è sostenuto infatti
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
che un concetto non è altro che il significato di un termine (o di più termini che hanno lo
stesso significato), e la sua definizione non è altro che la scelta tra i suoi possibili significati.
Questa scelta può essere compiuta sulla base di ragioni e criteri diversi: secondo questa concezione,
pertanto, la tradizionale ricerca del concetto di diritto deve essere considerata fra queste due
possibilità:
1) La ricerca del senso “ordinario” (nei discorsi comuni o dei giuristi) della parola DIRITTO.
2) La modifica più o meno profonda di questo senso ordinario per soddisfare le esigenze
teorico-descrittive o valutative del giurista.
Nella nostra cultura la parola diritto ha significato ordinario certo approssimativo, ma comunque
costante.
Come DEFINIZIONE MINIMALISTICA si può accettare quella di Kelsen, per il quale “è diritto la
coazione applicata in modo sistematico e organizzato, con sufficiente effettività”.
È evidente che questa definizione è valida per il diritto statale contemporaneo in condizioni sociali e
politiche relativamente pacifiche: è l’esistenza di quest’uso ordinario che dà l’impressione che
esista qualcosa che precede la ricerca definitoria che va scoperto (l’essenza del diritto, il vero
concetto di diritto, la definizione propria).
In verità però anche il concetto di diritto (come tutti i concetti complessi e importanti), ha confini
incerti e margini d’applicazione dubbi. I casi marginali sono quelli che presentano alcune, ma non
tutte le caratteristiche dei casi centrali ed indubbi di diritto: sono di questo tipo certi diritti
primitivi, il diritto internazionale, i diritti di stati e luoghi in situazione di rivoluzione in atto o
di guerra civile.
La definizione minima già data può però essere considerata con una certa tranquillità come la
definizione lessicale di diritto, cioè quella descrittiva dell’uso ordinario del termine diritto e del
concetto, cioè anche delle espressioni e dei termini sinonimi.
Pochi filosofi si sono però accontentati di prendere atto della definizione minima: né è nata una
discussione senza fine, che non ha portato a conseguenze, ma è anzi apparsa ad alcuni del tutto
inutile e male impostata.
Così il giurista britannico Glanville Williams, in un saggio pionieristico dell’approccio analitico al
diritto, Il diritto internazionale e la controversia della parola diritto (1945), imposta il problema
della definizione in termini radicalmente nominalistici, sostenendo che il problema del
concetto di diritto debba essere ridotto a quello di scegliere il senso con cui si preferisce usare
la parola diritto: si tratterebbe per Williams di un problema privo di interesse intrinseco, a
parte la necessità di una chiarezza terminologica.
Secondo Williams, ben più feconde di queste dispute verbali sono le discussioni sui vari caratteri
posseduti da fenomeni che sono stati considerati giuridici sulla base delle diverse concezioni o
definizioni di diritto.
La tesi di G. Williams è ispirata alla fase cosiddetta “eroica” della filosofica linguistica o analitica,
in cui si riteneva che tutti i problemi filosofici potessero essere risolti attraverso la costituzione di
un linguaggio rigoroso: pur avendo, come afferma Williams, un effetto salutare nei confronti di
alcune “polverose discussioni”, questa tesi è eccessivamente radicale e riduttiva. Non tutte le
discussioni sui concetti sono infatti inutili, anche per chi non creda che i concetti esistano
indipendentemente dalle definizioni e dagli usi.
Non tutte le discussioni filosofiche sono dovute ad equivoci sul senso delle parole: pertanto la
definizione di diritto, se aderisce al senso comune, può al massimo individuare con una certa
approssimazione l’area entro cui una cultura colloca il concetto e il fenomeno di diritto; se
riformulata in tutto o in parte, può invece essere usata per precisare l’idea di giuridicità al di
là del senso ordinario.
Questa operazione si chiama definizione esplicativa, e non risolve solo questioni terminologiche,
perché non è vero che qualunque scelta definitoria sia equivalente: infatti, con la definizione di
diritto, il filosofo del diritto e il giurista pongono le basi del loro approccio al diritto, da un punto di
vista teorico, metodologico e etico-politico.
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
Definendo il concetto di diritto dunque si possono annunciare al mondo le proprie scelte, e
precisamente:
- Come si ritiene che si debba parlare di diritto (metodo)
- Quali aspetti del diritto devono essere descritti e messi in luce e come (teoria)
- Quali aspetti del diritto è importante valutare i in che modo (etica e politica)
Questi possono essere considerati problemi fondamentali o primitivi, dei quali si occupa la
FILOSOFIA DEL DIRITTO.
Assai spesso però il giurista e il filosofo confondono e mescolano questi tre tipi di problemi e scelte,
e la distinzione è resa particolarmente difficile dal fatto che molti altri problemi generali stanno in
una posizione intermedia tra lo studio del diritto positivo e la filosofia del diritto.
Per questa ragione questi ultimi possono essere chiamati problemi centrali: si tratta di problemi
che presuppongono la soluzione delle questioni metodiche, metafisiche e di fondazione dei valori, e
quindi non possono essere assimilati a problemi fondamentali, ma sono sempre di portata così
ampia che quando si affrontano non si può prescindere dalle risposte date alle domande filosofiche
fondamentali.
In una disciplina scientifica quasi sempre i più rilevanti problemi teorici hanno questa natura
centrale: costituiscono insieme una applicazione delle idee filosofiche di fondo ed una precisazione
del loro significato.
(Esempio tipico di problema centrale del diritto è il problema della norma: posto che il diritto sia
un’insieme di norme, che cosa è una norma? La risposta a questo problema presuppone una serie di
prese di posizione fondamentali di filosofia generale e giuridica, cioè la risposta a quei problemi
primitivi già enunciati).
Nel diritto dei problemi centrali si occupa prevalentemente la TEORIA GENERALE DEL DIRITTO,
specialmente quando fatta “dal basso” a partire dal punto di vista dei GIURISTI POSITIVI).
2. VARIE DEFINIZIONI DI DIRITTO
Quasi tutte le grandi concezioni della filosofia del diritto attuale possono essere analizzate in base
alla definizione di diritto che esse propongono o presuppongono: nel primo caso esplicitamente,
nel secondo implicitamente.
Solo se è possibile rinvenire sotto le pratiche e i discorsi dei giuristi un concetto di diritto (nel senso
ampio qui usato), è possibile ricondurre tali pratiche e discorsi a principi e regole di procedura
comprensibili e coerenti.
Se guardiano agli atteggiamenti individuali, spesso si dovrà riconoscere che non esiste un solo ed
unico concetto di diritto al di sotto dell’atteggiamento del singolo, il che denota una certa
incoerenza. Ciò è possibile anche agli stessi GIURISTI POSITIVI, perché i diritti positivi moderni
lasciano loro tuttora ampi spazi di discrezionalità: così un giurista (o un giudice) può adottare
diversi stili interpretativi o diverse teorie della costituzione.
Se guardiamo agli atteggiamenti collettivi dei giuristi rispetto ad una data situazione che lascia
spazio ad una certa discrezionalità, esse tenderanno spesso all’uniformità. Tuttavia anche qui si
trovano correnti e divergenze.
La critica più grave che si può muovere ad una teoria giuridica è proprio quella di essere
incoerente: senza un metodo coerente infatti, che possa anch’esso essere riassunto nel concetto di
diritto, non sarebbe possibile distinguere tra operazioni giuridiche corrette e scorrette, e quindi
qualunque conclusione giuridica risulterebbe equivalente alle altre.
In questa prospettiva si può iniziare a chiarire la portata metodologica, teorica ed etico-politica delle
principali concezioni contemporanee di diritto. Esse vengono generalmente presentate a coppie
contrapposte e incompatibili: ma questa distinzione può essere fuorviante, perché le posizioni
effettivamente assunte dai giuristi sono spesso meno radicali e più sfumate, e possono pertanto
risultare parzialmente compatibili con posizioni normalmente considerate antitetiche (anche queste,
se assunte in modo meno radicale).
La complessità delle tesi che compongono ciascuna concezione del diritto rende estremamente
difficile non solo identificarle con chiarezza, ma anche stabilire in modo chiaro e semplice dei
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
rapporti di compatibilità o incompatibilità tra di essere. Si menzioneranno qui, a titolo di
esempio, due delle principali visioni generali del diritto, allo scopo di mostrare come la discussione
sul concetto di diritto sollevi e presupponga tutti i principali problemi della teoria generale e
filosofia del diritto.
La prima contrapposizione è quella fra GIUPOSITIVISMO (O POSITIVISMO GIURIDICO) e
GIUSNATURALISMO: il Giuspositivista identifica il diritto con il diritto positivo,
indipendentemente da qualunque valutazione etica; invece, per il Giusnaturalista, è diritto solo il
diritto giusto, sia esso positivo o no, che egli chiama diritto naturale.
La contrapposizione può portare di volta in volta ad un dissenso teorico, metodico, etico-politico o a
tutte queste cose insieme: il Giuspositivista tipico ritiene che la descrizione della realtà giuridica
(norme, istituzioni, decisioni giudiziarie…) possa e debba avvenire indipendentemente da
qualunque valutazione etica, e lasci del tutto impregiudicata la questione se vi si debba obbedire o
meno; per il Giusnaturalista tipico la giustizia è una qualità oggettiva del diritto rilevabile
razionalmente e scientificamente: il diritto che non sia giusto non è diritto; al diritto giusto, al vero
diritto, si deve sempre obbedire. Queste sono tutte differenze sul piano metodologico.
Come si vede, le due concezioni di diritto sono la conseguenza di due approcci non diversi non solo
al diritto, ma all’intero ragionamento pratico (cioè riguardante le scelte d’azione) e alla fondazione
dei valori etici: queste differenze, a loro volta, discenderanno da ancor più generali differenze
filosofiche, vere differenze metafisiche.
Dal dissenso sul metodo per conoscere ed affrontare il diritto discendono ovviamente dissensi
teorici (quali sono gli aspetti teoricamente importanti del diritto?) e dissensi etico-politici (come si
valuta un diritto?).
Il dissenso però si attenua se prendiamo in considerazione posizioni meno radicali: un
giusnaturalista (inteso in senso più debole e meno radicale) può ritenere che il diritto non possa
essere adeguatamente compreso senza far riferimento ad alcune idee e norme morali che ne fanno
parte e lo completano. Si penserebbe che un giuspositivista debba sostenere il contrario: ma in
effetti egli può ammettere che i fattori morali siano già recepiti dal diritto, essendo parte integrante
delle sue fonti di produzione.
La seconda contrapposizione è quella fra NORMATIVISMO e GIUSREALISMO (O REALISMO
GIURIDICO): alcuni Normativisti non solo identificano il diritto con le norme, ma ritengono che
esso possa essere descritto in modo speciale, come mondo normativo o del dover essere (in
quanto mondo predeterminato); si parla allora di normativismo in senso metodologico, perché
riguarda non soltanto l’oggetto del discorso giuridico, ma anche il modo in cui detto discorso
giuridico deve essere costruito e procedere. Questa tesi è sostenuta, per esempio, da Hans Kelsen.
Al normativismo metodologico si oppone il Giusrealismo metodologico (una variante del
giusrealismo), che definisce il diritto come fatto empirico, e sostiene quindi che vada descritto come
tale da una scienza empirica del diritto.
Con la contrapposizione fra Normativismo e Giusrealismo (questa volta “semplici”) si intende
talora altra cosa, una divergenza teorica, e solamente teorica: ciò significa che si è d’accordo sul
metodo da impiegare per parlare e studiare il diritto (in particolare sulla natura di scienza empirica e
sociale della giurisprudenza), e si discute invece sul ruolo delle norme e della loro importanza nella
vita giuridica e dell’influenza sulle decisioni giudiziarie: il giusrealismo definisce il diritto come
un’insieme di decisioni giudiziarie (decisionismo), il normativismo come un insieme di norme
coattive.
A complicare la discussione contribuisce il fatto che un giusrealista quanto al metodo (che sostiene
che la giurisprudenza sia scienza empirica e sociale) può essere normativisti nel senso teorico, cioè
sostenere che le norme siano importanti fattori della vita del diritto: questa è, per esempio, la
posizione di Alf Ross.
Infine la divergenza fra le due concezioni può diventare etico-politica nella misura in cui si
discute se le norme generali debbano o meno lasciare discrezionalità ai tribunali: in questo caso si
intende il normativismo nel senso di LEGALISMO, e il giusrealismo inteso come concezione del
diritto libero.
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
Infine, anche altre divergenze meno radicali, ma pur sempre importanti e generali, sia a livello
teorico sia politico, possono riflettersi ed avere influenza sulla (o derivare dalla) definizione di
diritto di determinata concezione.
CONCEZIONI DEL DIRITTO
1. NOZIONE E PROBLEMI
Non tutte le concezioni del diritto contemporanee prestano la stessa attenzione agli stessi fattori:
alcune sono palesemente preoccupate soprattutto dell’aspetto etico e politico della giuridicità, altre
a realizzare anche in campo giuridico una particolare teoria metafisica; altre ancora ad applicare una
specifica idea epistemologica o un certo modello di scienza.
È comunque particolarmente importante rendersi conto del livello a cui diverse concezioni del
diritto formulano le proprie caratteristiche principali e scelgono di distinguersi, o opporsi alle altre:
per alcune si tratta di una distinzione a livello di problemi filosofici fondamentali (Giusnaturalismo,
Giuspositivismo, Giusrealismo, Marxismo); per altre a livello di tesi centrali, ma non direttamente
fondamentali: sono di questo tipo le concezioni descritte in questa voce che individuano un
componente ultimo del diritto è norma, rapporto giuridico, imperativo o istituzione (cioè
Normativismo, Teoria del rapporto giuridico, Imperativismo, Istituzionalismo): per questo queste
concezioni sono solitamente componenti di una concezione dei problemi fondamentali cui si
appoggiamo; la discussione filosofica su questo ultimo tipo di discussioni rischia di rimanere
incerta finché non si individuano le loro tesi fondamentali.
Non ci si deve aspettare perciò che tutte le concezioni del diritto qui descritte si contraddicano
palesemente fra di loro: alcune di queste concezioni (tranne quelle effettivamente opposte, es.
Giusnaturalismo e Giuspositivismo) sono tra loro compatibili e componibili.
2. GIUSNATURALISMO
Il GIUSNATURALISMO è l’insieme delle concezioni del diritto che si fondano sull’esistenza di un
DIRITTO NATURALE. Esse sono spesso assai diverse tra loro, tanto quanto sono diversi i sensi del
diritto naturale a cui fanno riferimento e diversi sono i modi proposti per individuarlo.
Nelle forme più estreme e più chiare di giusnaturalismo il diritto naturale è un insieme di norme
assolute e sempre giuste, oggettivamente esistenti come tali indipendentemente dal fatto di essere
accettate da qualcuno (si tratta quindi di una concezione del diritto oggettivista), e
indipendentemente dalla loro accettazione o recezione da parte del diritto positivo. Il diritto
naturale, in questo senso, è ovviamente una parte della morale, considerata come oggettivamente
assoluta ed eterna, e che riguarda quindi anche il campo delle azioni giuridiche.
Secondo questa concezione, quando il diritto positivo non corrisponde al diritto naturale, sorge un
conflitto che toglie legittimità alla protesa di obbedienza avanzata dal diritto positivo, che viene
considerato un non-diritto.
Tuttavia sull’atteggiamento da assumere verso tale non-diritto ingiusto i vari giusnaturalisti hanno
posizioni discordi: rivolta e rivoluzione, resistenza attiva individuale, resistenza passiva, obbedienza
passiva, critica ecc.
In questa versione estrema del giusnaturalismo convivono dunque due caratteristiche di fondo:
1) Una concezione assoluta, oggettiva e/o statica della morale
2) Una tendenza a giudicare sulla legittimità di un diritto (e ad attribuirgli tale titolo) in base
alla morale
La seconda questione si tratta solo di una mera questione terminologica: non ha in effetti grande
importanza definire un particolare diritto “diritto ingiusto” o “non-diritto-perché-ingiusto”.
La prima questione, cioè se esista una concezione assoluta e oggettiva (sul fatto che possa essere o
meno statica vedi a fine paragrafo il diritto naturale mutevole), è invece estremamente importante:
perché è fondamentale stabilire se esistono criteri oggettivi ed eterni di giudizio morale, e qualora
esistono stabilire se possono essere conosciuti, permettendo quindi di dichiarare veri (o falsi) i
nostri giudizi morali.
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
È ovvio che su questo punto, cioè il problema della dimostrazione dei valori, i giusnaturalisti
hanno l’onere di presentare criteri di prova adeguati: essi tuttavia non manifestano grande accordo a
riguardo, spaziando da prove quali l’autoevidenza dei principi del diritto naturale, all’intuizione o
senso morale di ciascun soggetto; infine alcuni sostengono che è naturale ciò che è costante nelle
diverse situazioni e società, per cui sarebbero diritto naturale tutte le norme che risultano presenti in
tutte le società storiche. All’impiego di diversi mezzi corrispondono spesso le diverse varianti del
giusnaturalismo. In tempi moderni comunque il criterio ha cui il giusnaturalismo fa riferimento più
frequentemente è la natura razionale dell’uomo: il diritto naturale vuole dire in questo caso diritto
razionale, che è dimostrato essere giusto oggettivamente dalla ragione dell’uomo; è ovvio però che
questa precisazione lascia ancora delle incertezze. Una parte della critica contemporanea ha infatti
sostenuto che i principi eterni del diritto naturale che risulterebbero auto-evidenti alla ragione (come
ad esempio i principi classici del diritto romano: dare a ciascuno il suo, non danneggiare nessuno,
vivere onestamente), sono in realtà vuoti e formali, perché non è possibile stabilire esattamente il
significato di tali espressioni.
Sul piano psicologico e del senso comune si può dire che il giusnaturalismo di questo tipo ha dalla
propria parte la costante esigenza di certezza e di una fondazione sicura delle scelte morali, e per
questo viene continuamente riproposto in modi più o meno nuovi. Contro di sé il giusnaturalismo
estremo ha invece la grandissima variabilità delle opinioni morali nella storia, e l’esperienza del
fatto che qualunque sistema di filosofia morale ha suscitato nel tempo sia adesione che opposizione
qualificate e ragionate.
Queste critiche all’esistenza dei diritti naturali sono di grande importanza, perché mettono in forse
una dottrina (il giusnaturalismo appunto) le cui idee hanno forgiato la storia, lo stato e il diritto
moderno: in primo luogo l’idea dei DIRITTI INALIENABILI DELL’INDIVIDUO.
Questi diritti soggettivi sono certamente nati come diritti soggettivi naturali, sorti storicamente in
polemica con i diritti positivi considerati insufficienti ed ingiusti. Anche se essi sono stati in larga
misura recepiti da molti diritti positivi, sotto forma di garanzie costituzionali e diritti dei cittadini,
molti ritengono tuttora più prudente continuare a considerarli come diritti naturali e inalienabili,
indipendenti e prioritari rispetto al diritto positivo, in un mondo in cui molti stati non li tutelano
adeguatamente.
Tuttavia, la discussione teorico-filosofica non può essere decisa in base a questi due meri fatti
(bisogno di certezza, variabilità dei valori), e la difficoltà del giusnaturalismo sta proprio nella
difficoltà di una fondazione teorica e razionale della propria teoria. Dunque la critica più grave che
si può rivolgere al giusnaturalismo è di tipo metodologico e gnoseologico: essa prende la forma
dello scetticismo (non cognitivismo) rispetto alla facoltà umana di conoscere e descrivere
oggettivamente i valori morali.
Questa concezione cognitiva dell’etica è accusata dai non cognitivista di FALLACIA
NATURALISTICA (vedi voce in:Giustizia), cioè di voler indebitamente derivare conclusioni
prescrittive dalla descrizione dei fatti.
Mentre l’esigenza della fondazione obbiettiva dell’etica è difesa oggi anche da altre teorie (accanto
al giusnaturalismo sono sorti i più recenti utilitarismo e contrattualismo), una difesa flessibile del
giusnaturalismo è difesa di chi abbandona un modello di morale statica per passare a parlare di
DIRITTO NATURALE MUTEVOLE: si sostiene che esiste un modo oggettivo di individuare il diritto
naturale, ma che esso muta nello spazio e nel tempo, andando sempre a coincidere con la morale
positiva di un dato tempo e un dato luogo.
Molti critici dubitano che questo metodo possa portare al risultato desiderato di un’obbiettiva e
certa fondazione dell’etica, anche perché risulta assai difficile individuare una morale positiva
univoca, con confini e fattezze sufficientemente precisi, in una data situazione spazio-temporale:
quando questa precisione viene raggiunta i critici sospettano che dietro tale omogeneità sia derivata
da un elemento semplificatore e prescrittivo, ossia le scelte morali del filosofo stesso.
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
3. IMPERATIVISMO
L’imperativismo è una teoria del diritto che configura la norma giuridica come IMPERATIVO,
cioè comando di fare o astenersi dal fare: più che di una concezione del diritto si tratta di una
componente di varie concezioni giuridiche più ampie. L’imperativismo ha avuto la sua
determinazione più classica da parte di John AUSTIN, autorie di La determinazione del campo della
teoria del diritto (1832): Austin definisce il diritto come norma, e la norma come comando, cioè
manifestazione della volontà espressa in forma imperativa e sostenuta dalla minaccia di una
sanzione. Il diritto è dunque considerato come un insieme di comandi emanati da un sovrano, cioè
da chi possiede il potere supremo di dare gli ordini e non dovere ubbidire a nessuno (non
necessariamente un re, nel caso inglese cui Austin si riferisce è il Parlamento), che viene
abitualmente obbedito perché i suoi comandi sono sanzionati. L’imperativismo si accompagna
facilmente al formalismo interpretativo, cioè la teoria per cui esiste sempre un’interpretazione
corretta e vera delle leggi, ed eventuali divergenze di interpretazione vanno imputate ad errori e
mancanza di conoscenze adeguate. La controversia sulla norma andrebbe risolta facendo leva sulla
volontà del sovrano.
Oggi l’imperativismo in questa sua forma originaria è generalmente criticato dai teorici del diritto,
perché non riesce a spiegare molti fenomeni giuridici che non sono qualificabili come comandi: ad
esempio il diritto consuetudinario e il diritto internazionale (quest’ultimo per Austin va
considerato come un caso di morale positiva), oppure le norme a cui è soggetto il sovrano stesso,
come quelle permissive o attributive di poteri.
In questi casi il carattere sanzionatorio del diritto viene meno, e ciò dovrebbe, secondo
un’applicazione coerente dell’imperativismo, mettere in dubbio la stessa natura giuridica di tali
norme (ovviamente ciò è impensabili).
Infine la teoria dell’interpretazione come ricostruzione di una volontà appare poco realistica e
impossibile da applicare quando gli organi produttivi di norme sono corpi collettivi (come i
parlamenti), o quando le norme giuridiche sopravvivono ai loro produttori (che sono morti o non
più in carica).
Il problema di fondo è che solo una piccola parte dei fenomeni giuridici è spiegata dal modello
imperativistica, sostanzialmente soltanto certi aspetti del diritto penale.
È vero che i concetti di minaccia e di abitudine all’obbedienza offrono alla teoria del comando
una certa capacità di spiegare l’insorgere e la persistenza di rapporti sociali non meramente
occasionali di obbedienza e sottomissione, ma è anche vero che la capacità esplicativa del modello
imperativistico diminuisce notevolmente quando viene a mancare non solo la situazione concreta
del comando, ma anche le persone concrete del comandante e del comandato.
Il diritto infatti è un insieme di rapporti sociali in larga misura impersonali, spesso puramente
potenziali tra persone non attualmente in contatto tra loro; per questo le nozioni di comandante e
comandato vi si applicano per lo più solo metaforicamente: il più frequente di questi usi è quello per
cui i giuristi parlano di un legislatore come se fosse una persona dotata di una volontà; in realtà
esso è un’istituzione complessa, retta essa stessa da norme impersonali. In realtà il legislatore non è
neppure un comandante vero e proprio, poiché emana norme impersonali applicate da terzi.
Si deve specialmente al realismo giuridico scandinavo l’aver messo in luce i pericoli nascosti dietro
la metafora, apparentemente chiarificante ed innocua, dell’imperativismo: Olivecrona ha avanzato
quindi la teoria del diritto come composto di imperativi indipendenti, cioè impersonali.
Molti critici dell’imperativismo e del giuspositivismo, come lo stesso Olivecrona, tendono a
identificare le due posizioni giudicandole logicamente interdipendenti: costoro ritengono che ogni
confutazione dell’imperativismo lo sia anche del giuspositivismo; tuttavia ci sono importanti
versioni del giuspositivismo che non sono imperativistiche, e concezioni imperativistiche che non
sono giuspositivistiche. Tuttavia l’importanza attuale dell’imperativismo sta proprio nella sua
influenza enorme e persistente sulle concezioni non articolare dei giuristi positivi: mentre come
concezione filosofica è ormai poco popolare, esso è probabilmente la concezione implicita della
normatività giuridica più diffusa tra i giuristi.
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
4. GIUSPOSITIVISMO
Anche se sotto il nome di Giuspositivismo (o positivismo giuridico) si collocano in realtà varie
concezioni del diritto molto diverse, possiamo darne la seguente definizione minima: esso è LA
CONCEZIONE DEL DIRITTO COME DIRITTO POSITIVO. È importante però ricordare che cosa si
intenda per diritto positivo, e che molto dipende soprattutto dal modo in cui il giuspositivista
intende descriverlo o conoscerlo. È infatti su tali aspetti che si hanno divergenze fra i vari
giuspositivismi. È bene sgombrare subito il campo da una prima confusione: il giuspositivismo fa
riferimento al diritto positivo come diritto posto da un volontà umana; come tale non ha rapporti
necessari col positivismo filosofico (Comte & Co.), infatti il positivismo filosofico in campo
giuridico ha sostenuto perlopiù un approccio sociologico e non giuspositivistico, dando luogo alla
sociologia del diritto e alla giurisprudenza sociologica (si ha la seconda quando la componente
politico-valutativa prevale su quella descrittiva: la giurisprudenza sociologica ritiene che il diritto
sia più ampio dei codici e delle leggi e debba essere più attento alla realtà sociale e alle sue esigenze
e interessi). Nonostante la diversa origine e impostazione, il giuspositivismo ha in comune con la
sociologia del diritto la pretesa di essere un approccio scientifico descrittivo e neutrale al diritto,
lasciando le questioni prescrittive su come il diritto dovrebbe essere alla politica del diritto, che per
essi deve essere rigorosamente separata dalla scienza giuridica.
Da una parte sta dunque la giurisprudenza descrittiva e scientifica, che si occupa di conoscere il
diritto; dall’altra la giurisprudenza valutativa, che si occupa della critica etico-politica del diritto:
l’approccio descrittivo e quello valutativo al diritto vengono chiamata giurisprudenza espositiva e
giurisprudenza censoria nella classica terminologia di Bentham. Questa stessa distinzione deve
essere applicata con uguale scrupolo sia nell’interpretazione che nell’applicazione del diritto: da
una parte stanno le operazioni basate meramente sull’obbedienza al diritto, in quanto le prescrizioni
di questo accertabili mediante descrizione scientifica, dall’altra sta il campo della discrezionalità
del giurista e del giudice, laddove nessuna descrizione potrebbe penetrare la vaghezza o la
lacunosità del diritto, e dove quindi l’interprete è costretto ad opere scelte pratiche all’interno della
cornice fornita dal diritto chiaro e certo.
Si noti bene che il positivismo giuridico non afferma l’obbligo di obbedire necessariamente al
diritto positivo: è vero che la concezione giuspositivistica identifica il diritto con la forza, ma non è
vero che sostenga il dovere morale di obbedire sempre a tale diritto identificato con la forza:
l’accuso di reductio ad Hitlerum che viene generalmente mossa al giuspositivismo (cioè di
incoraggiare l’asservimento ai regimi totalitari) è pertanto infondata (o almeno lo è se non ci si
riferisce a particolari versioni del giuspositivismo). Queste tesi nel loro complesso costituiscono la
teoria giuspositivistica fondamentale, cioè la separazione tra diritto e morale, per cui il diritto può
e deve essere separato dalla morale: i contrasti col giusnaturalismo sono evidenti.
La possibilità di una scienza giuridica è fondamentale nel giuspositivismo, perché senza il giurista
non potrebbe neanche applicare il diritto, neanche volendolo: infatti se nessun giurista fosse in
grado di conoscere e descrivere il diritto in modo obbiettivo, sarebbe costretto a ricrearlo dal nulla
in ogni atto applicativo, lo volesse o meno e ne fosse consapevole o meno. (L’idea che il diritto sia
liberamente ricreato ad ogni applicazione è sostenuta dal giusliberismo). Tuttavia quest’esigenza di
conoscenza e di scientificità viene soddisfatta dal giuspositivista mediante una scienza giuridica
assai peculiare, che si occupa del diritto non in quanto realtà sociale, ma per quello che prescrive.
Il primo giuspositivismo ha ritenuto di potersi occupare del diritto considerato esclusivamente come
il prodotto posto da una volontà; questo spiega perché il giuspositivismo originario abbia dato
importanza centrale nella descrizione del diritto positivo alle leggi come il tramite attraverso cui si
manifesta la volontà del sovrano. Quando il legislatore può essere considerato nella teoria
giuspositivistica il sovrano, la persone collettiva che emana i comandi, allora la volontà del sovrano
si identifica con la VOLONTÀ DEL LEGISLATORE (concetto questo, molto usato con notevole
disinvoltura dai giuristi). La teoria imperativo del diritto come comando del sovrano politico può
essere considerato l’aspetto centrale della forma più semplice e diretta di giuspositivismo, il che
l’accomuna con l’imperativismo. Questa versione imperativistica del giuspositivismo è basata in
realtà su alcune notevoli semplificazioni teoriche: soprattutto una nozione personalistica del diritto,
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
ricondotto ai concetti di comando e volontà; ma nell’esistenza di grandi organizzazioni sociali,
come sono le moderne istituzioni rette dal diritto, questi fenomeni possono avere solo ruoli
secondari o metaforici. Da queste nozioni centrali del giuspositivismo imperativistico discendo altre
sue costanti e caratteristiche tesi, tutte problematiche: la teoria della completezza del diritto e
quella della sua coerenza, le quali congiuntamente garantiscono agli occhi del giuspositivista
l’autonomia e l’autosufficienza delle forme di regolamentazione giuridica.
Il giuspositivismo in queste sue forme imperativistiche è stato tacciato dai suoi critici di ideologia,
nel senso di nascondere le scelte di valore compiute nell’accostarsi al diritto, cioè sul metodo della
giurisprudenza: esso farebbe falsamente apparire come inevitabili e necessari a una concezione
scientifica del diritto il legalismo, lo statualismo, le teorie della completezza e coerenza,
dell’interpretazione meccanica ecc.
Alcuni teorici giusrealisti hanno criticato in special modo il formalismo interpretativo dei
giuspositivisti, ed hanno visto in ciò un importante aspetto della conservazione dell’assetto esistente
del potere sociale.
Inoltre il movimento del diritto libero e la giurisprudenza sociologica, hanno criticato il
giuspositivismo soprattutto sul piano etico-politico, come ideologia dello statualismo e delle grandi
codificazioni: il giuspositivismo sarebbe un ostacolo al progresso giuridico, perché renderebbe il
diritto incapace di adattarsi ai continui mutamenti sociali. I marxisti hanno invece criticato il
giuspositivismo sia sul piano politico che su quello scientifico, accusandolo di mascherare la vera
natura del diritto e di essere pertanto, come il diritto stesso, uno strumento della conservazione del
potere della classe dominante. Molte di queste critiche si sono rivelate indubbiamente giustificate se
rivolte a particolari versioni del giuspositivismo imperativista, legalista e statualista. I critici non
sempre vedono però che le idee fondamentali del positivismo giuridico non sono necessariamente
legate a questi.
A parecchie di queste critiche ha infatti risposto la versione normativistica del giuspositivismo, il
cui massimo esponente è HANS KELSEN, il più grande filosofo del diritto del ‘900, di cui va
ricordata in particolare la Dottrina pura del diritto (in due edizioni: 1934 e 1960).
Il giuspositivismo normativista kelseniano (chiamato da Kelsen DOTTRINA PURA DEL
DIRITTO), presente il diritto non più come l’insieme di leggi volute da una o più persone, ma
come un insieme di norme impersonali, collegate a una volontà metaforica, che si riduce in realtà al
significato oggettivo attribuito ad atti e situazioni da norme giuridiche. Queste sono collegate tra
loro da altre norme giuridiche in un ordinamento giuridico.
Le leggi statali risultano pertanto essere solo un tipo di norma giuridica; sono norme giuridiche
anche le norme superiori alle leggi (costituzioni) o inferiori (regolamenti, sentenze, contratti…): in
ordinamenti primitivi possono essere norme giuridiche anche norme di origine non statale, in primo
luogo quelle derivanti dalla consuetudine.
L’interpretazione è interpretata dalla dottrina pura del diritto come attività solo in parte conoscitiva,
di conoscenza e descrizione dei significati posseduti dalle norme, e in parte anche creativa,
nell’area di vaghezza che ogni norma generale e astratta abbandona inevitabilmente alla
discrezionalità dell’interprete.
Per il giuspositivismo kelseniano il diritto è un mezzo particolare di CONTROLLO SOCIALE: infatti il
diritto è sempre coattivo, perché il diritto è regolamentazione della coazione, e dunque è una
tecnica per ottenere qualunque fine possa essere perseguito mediante norme coattive: questa tesi è
molto importante, perché attribuisce al diritto la natura di mezzo, cioè indica che esso non è
caratterizzato da alcun fine specifico, e in particolare come dalla necessità di soddisfare valori
morali: ovviamente questa tesi è in netto contrasto con il giusnaturalismo.
Inoltre il normativismo kelseniano si occupa di descrivere le norme nella loro dimensione
normativa, che Kelsen chiama la loro esistenza specifica, senza preoccuparsi della loro effettività:
ciò non significa che per Kelsen l’effettività di un diritto non abbia alcuna importanza, altrimenti
non sarebbe possibile distinguere gli ordinamenti reali da quelli immaginari o non più in vigore.
L’ordinamento normativo privo di effettività cessa di esistere, come avviene per i diritti del passato,
studiati dalla storia del diritto, non dalla giurisprudenza.
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
Le conseguenze di queste idee generali sono profonde sia per la teoria del diritto sia per la scienza
giuridica: secondo Kelsen infatti tutto il diritto deve essere ricondotto a norme che imputino una
sanzione: ciò implica che anche i diritti soggettivi e in genere le modalità giuridiche debbano
essere riconducibili a obblighi sanzionati.
Anche questa più sofisticata o matura versione del giuspositivismo è stata fatta oggetto di critiche
radicali: si è osservato che in esso si troverebbero riuniti due elementi incompatibili, uno scientifico
e uno ideologico, quest’ultimo nascostamente valutativo: per il primo il diritto è considerato come
fatto (norme socialmente effettive), per il secondo è considerato normativamente (norme
socialmente effettive). Si è ritenuto pertanto che il giuspositivismo dovrebbe essere diviso in questi
due elementi: l’uno, l’esigenza di una scienza dei fatti giuridici, dovrebbe essere ricondotto alla
sociologia del diritto; l’altro, cioè il normativismo, dovrebbe ammettere di essere un’ideologia
politica favorevole alle norme effettive, un’ideologia conformista.
Chi ha avanzato queste critiche sostiene che il giuspositivismo normativista nasconde un’adesione o
accettazione di fondo del diritto stesso: nonostante il giuspositivismo dichiari di non prendere e
non richiedere nessuno specifico atteggiamento morale verso il diritto positivo considerato, sia esso
favorevole o sfavorevole.
Altri critici del giuspositivismo rilevano il fatto che esso fissa comunque l’attenzione di una
istituzione importante ed influente, la giurisprudenza pratica e teorica, su certe norme piuttosto che
su altre (per esempio trascura le norme del diritto naturale); questo significa comunque porle in una
posizione di vantaggio, come prime e più serie candidate a una possibile accettazione.
Identificare le tesi fondamentali del giuspositivismo non è facile: in primo luogo numerose idee del
giuspositivismo originario oggi sono accantonate anche dalla maggior parte dei giuspositivisti. Si
tratta proprio di molte delle idee più caratteristiche: imperativismo, teorie della completezza e
coerenza del diritto, formalismo interpretativo. Parimenti, molte altre idee del giuspositivismo sono
ormai diffuse anche tra i non giuspositivisti (normativismo, diritto strumento coattivo, distinzione
tra diritto e morale, parziale discrezionalità interpretativa).
Possiamo perciò oggi parlare con una certa sicurezza di giuspositivismo quando siano presenti i due
suoi aspetti più importanti: un atteggiamento ideologico-politico è uno scientifico. L’atteggiamento
ideologico politico si fonda su una concezione solo strumentale del diritto, visto come mezzo di
controllo sociale mediante la coazione. Quello scientifico, di possibilità e necessità di una
descrizione scientifica del diritto, è sussidiario al primo, che ha senso soltanto se è possibile
descrivere non creativamente le norme generali e astratte trasmettendone il contenuto. Il
giuspositivismo richiede e favorisce lo sviluppo di una categoria di professionisti della tecnica
normativa (giuridica), considerata in se stessa, e un linguaggio giuridico specializzato, con
caratteristiche di notevole precisione prescrittiva e impersonalità, cioè indipendenza dalle opinioni
sia dell’organo emittente sia del singolo interprete.
In questo modo il giuspositivismo si rivela basato su una complessa idea etico-politica, la cui
accettazione o rigetto dipendono da quello che si pensa sull’opportunità e possibilità di una
consapevole razionalità sociale operante tramite coazione distribuita mediante norme, in primo
luogo norme generali e astratte.
5. REALISMO GIURIDICO
Realismo giuridico o GIUSREALISMO è qui inteso in senso molto ampio, per comprendere un
gruppo di concezioni anche molto diverse tra loro, che hanno in comune il fatto di prestare
particolare attenzione all’effettività del diritto, all’esistenza del diritto nella società e nei
comportamenti sociali: in special modo all’attività dei tribunali.
Se si caratterizza il realismo giuridico in modo così generico rientrano al suo interno varie
concezioni: il giusrealismo americano e quello scandinavo (i cosiddetti “realismi giuridici in
senso stretto”), ma anche la giurisprudenza sociologica, il giusliberismo, l’istituzionalismo e la
teoria del rapporto giuridico. Gli elementi comuni alle varie forme di realismo giuridico risultano
più chiari se visti sullo sfondo del giuspositivismo e in opposizione ad esso: specie al
giuspositivismo implicito nella mentalità dei giuristi del nostro secolo.
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
Tutte le concezioni ora menzionate hanno in comune, oltre all’attenzione per l’effettività, anche la
loro opposizione al formalismo giuridico e al legalismo, presenti soprattutto nel giuspositivismo.
Tutte le concezioni realistiche del diritto propongono un elenco di fonti del diritto più ampio di
quello dei giuristi positivi: per essi vi rientrano anche le consuetudini sociali, le regolamentazioni
derivate da interessi protetti ecc.
Si potrebbe pensare che questa concezione del diritto sia senz’altro più scientifica di quella
giuspositivista, perché considera più fatti ed è maggiormente attenta alla società e alle concrete
situazioni sociali: in realtà si tratta piuttosto di una diversa valutazione etico-politica nei confronti
del diritto e non di una sua diversa descrizione empirico-fattuale: si ritiene opportuno che il diritto
venga definito in modo da includere anche certe norme effettive che la concezione tradizionale e
giuspositivista tendono ad escludere. Qualunque valutazione, positiva o negativa, si dia di questo
tipo di realismo giuridico, non si può considerarlo scienza: alcuni chiamano giurisprudenza
sociologica questo ramo del realismo giuridico con forti componenti etico-politiche, per
distinguerlo dalla sociologia del diritto, la scienza del diritto empirico-fattuale.
Alcune correnti del realismo giuridico favoriscono una concezione predittiva della
giurisprudenza, che non dovrebbe occuparsi del diritto che sta scritto sulla carta, ma di quello che
vive ed opera soprattutto nei tribunali: sarebbe da coltivare la previsione dei comportamenti delle
corti, secondo alcuni perché è utile al giurista pratico, secondo altri perché fonda una scienza di tipo
sociologico.
In generale dunque le correnti giusrealiste possono essere descritte in quelle che hanno
un’impostazione soprattutto empirica e descrittiva, e quelle che hanno un impostazione prescrittiva
ed etico-politica. Inoltre va notato che le prime condividono di solito un’etica non cognitivista, le
seconde credono nella possibilità di soddisfare valori obbiettivi, anche se legati alla realtà sociale.
I giusrealisti hanno poi opinioni diverse circa l’influenza effettiva delle norme giuridiche sui
comportamenti giudiziari; in questo senso alcuni sono normativisti e altri no: i primi credono che le
norme generali e astratte abbiano notevole influenza sul diritto vero e proprio (quello dei tribunali),
i secondi considerano ben più importanti indagini su fatti più direttamente influenti, quali le
tendenze giurisprudenziali.
Tutti i giusrealisti hanno un’interpretazione piuttosto scettica dell’interpretazione giuridica:
sottolineano infatti l’indeterminatezza ineliminabile delle norme generali e astratte e la natura
creativa (almeno in parte) della loro applicazione ai casi concreti: la misura di questo scetticismo è
connessa con la possibilità per il giusrealismo di essere o meno normativistico.
Le concezioni di estremo scetticismo interpretativo negano l’influenza delle norme generali nella
loro applicazione giuridica: ogni interpretazione viene considerata come interamente creativa. Le
concezioni più moderate ammettono un nucleo di certezza nella norma ed un’area di
discrezionalità lasciata all’interprete.
In definitiva tutte queste correnti giusrealiste si caratterizzano per ciò a cui si oppongono: il
formalismo interpretativo del giuspositivismo e la metafisica del giusnaturalismo (anzi alle due cose
insieme, perché il giuspositivismo viene considerato una variante subdola e ideologica del
giusnaturalismo).
Una valutazione equilibrata del complesso di tesi che vanno sotto il nome di giusrealismo richiede
che in conclusione vengano esaminati separatamente i suoi aspetti etico-politici e i suoi aspetti
scientifici: quanto al programma politico della giurisprudenza sociologica e del giusliberismo va
osservato che esso non si presenta come un obbiettivo autonomo, ma come correttivo del legalismo
e del formalismo giuspositivista.
Quanto all’esigenza scientifica e previsione del realismo giuridico, va osservato che essa è
certamente legittima in una scienza del diritto che voglia essere empirica allo stesso modo delle
scienze sociali: tuttavia c’è da chiedersi se essa non sia troppo riduttiva verso la funzione
prescrittiva del diritto; il diritto infatti non primariamente uno strumento predittivo, per permettere a
uno scienziato di prevedere i comportamenti dei giudici, ma una prescrizione di comportamenti che
si vogliono in tal modo controllare. È proprio perché il diritto prescrive questi comportamenti che
può anche servire a prevederli: di conseguenza i più coerenti tra i giusrealisti sembrano ammettere
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
anch’essi una natura significante del linguaggio giuridico, come linguaggio prescrittivo di
comportamenti.
Più precise osservazioni richiedono che si distingua fra i vari tipi di giusrealismo: il GIUSREALISMO
AMERICANO, il GIUSREALISMO SCANDINAVO, la giurisprudenza sociologica, il giusliberismo,
l’istituzionalismo e la teoria del rapporto giuridico; si ricordi però che, a parte i primi due, tutti
questi orientamenti non si presentano affatto come giusrealisti.
5.1.1. GIUSREALISMO AMERICANO
Il GIUSREALISMO AMERICANO ha come obbiettivo dare una descrizione del diritto che permetta di
prevedere il più efficacemente possibile le decisioni giudiziarie concrete. Questi giusrealisti
americano sostengono che al centro del diritto non stanno le norme generali e astratte, ma piuttosto
la somma del singole decisioni giudiziarie: si tratta pertanto di un tipo di DECISIONISMO. Essi
sostengono che le norme abbiano al più una funzione predittiva, cioè permettono di prevedere
quale sarà il vero diritto, quello dei tribunali.
È meno chiara di quanto sembri la ragione per cui le decisioni giudiziarie abbiano una posizione
così privilegiata in questa concezione del diritto: probabilmente perché il diritto a livello
dell’applicazione giudiziaria sembra essere realmente effettivo; va però notato che le decisioni dei
giudici hanno particolare importanza nel sistema di common law in vigore negli Stati Uniti.
Il realismo giuridico americano è inoltre caratterizzato da forme estreme di scetticismo
interpretativo: essi sono convinti che le norme generali e astratte dicano molto poco a riguardo di
quali saranno le effettive decisioni dei giudici. I più tipici esponenti della corrente giusrealista
americana sono Jerome Frank e Karl Llewellyn. In particolare Llewellyn formula chiaramente le
idee fondamentali del giusrealismo: egli nega la capacità delle norme giuridiche generali e astratte
di determinare significativamente le azioni giuridiche (in specie i processi); sostiene che la
giurisprudenza scientifica deve limitarsi a cercare di prevedere il comportamento delle corti; e nutre
idee stremante scettiche sull’interpretazione, che avrebbe sempre elementi di creatività nascosti ma
decisivi. Llewellyn ha inoltre in comune con gli altri giusrealisti l’interesse per l’effettività delle
norme, che spinge di solito i giusrealisti a occuparsi molto di sociologia dell’attività giudiziaria.
5.1.2. GIUSREALISMO SCANDINAVO
Il GIUSREALISMO SCANDINAVO è un’altra corrente del realismo giuridico in senso stretto. Essa parte
dalla critica epistemologica del tradizionale discorso dei giuristi positivi, e in particolare della
tradizionale scienza giuridica; la critica si estende al modello giuspositivistico e kelseniano della
scienza giuridica. Il realismo giuridico scandinavo ha in comune con la corrente nordamericana un
interesse prevalente per l’effettività del diritto.
A differenza della controparte americano non è però sempre antinormativista sul piano teorico,
nel senso che non sempre nega l’importanze delle norme giuridiche generali e astratte per la
previsione e comprensione dei fenomeni giuridici e soprattutto giudiziari. I giusrealisti scandinavi
sostengono che i giuristi positivi, anche giuspositivisti, producono una scienza che è incompatibile
con il modello delle scienze empiriche e sociali contemporanee e fanno inoltre uso di un linguaggio
normativo intessuto di presupposti metafisici e di termini astratti e privi di senso, come: diritto
soggettivi, rapporti giuridici, validità eccetera. In tal modo la giurisprudenza tradizionale e
giuspositivista fornisce la descrizione di come le norme dovrebbero essere applicate, non di come
esse sono applicate di fatto: e questa è senz’altro un’operazione ideologica.
I giusrealisti scandinavi vogliono invece ridurre la scienza giuridica a discorso empirico predittivo
dei comportamenti giuridici, adeguandola all’obbiettivo che viene attribuito anche alla sociologia
del diritto. Come si vede, su questa concezione, americani e scandinavi si trovano d’accordo. Per i
sostenitori più moderati di queste posizioni, i termini giuridici astratti non sono necessariamente da
eliminare dal discorso giuridico, purché li si consideri come mezzi per riassumere e formulare le
norme giuridiche (senza attribuire però ad essi una vera “entità giuridica”): in questo il giusrealismo
scandinavo viene a trovarsi molto vicino alle tesi normativistiche kelseniane.
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
Le critiche precedenti hanno stretti rapporti con la critica al formalismo interpretativo: anche il
giusrealismo scandinavo è scettico riguardo alla teoria dell’interpretazione (vedi Giusrealismo in
genere), e sottolinea l’estrema libertà interpretativa concessa all’interprete dalla formulazione
generale e astratta delle norme giuridiche.
Da parte di queste correnti del giusrealismo è stata prestata grane attenzione ai problemi di
fondazione dei valori, e si trova spesso sostenuta una teoria relativistica o non cognitivistica dei
valori: in altre parole si nega la possibilità di conoscenza e fondazione oggettiva dei valori, dei
giudizi etici e in particolare di quelli di giustizia.
I valori vengono da questi giusrealisti empiricamente considerati come fatti sociali tra gli altri, il cui
influsso sul diritto può essere certamente descritto, ma non può essere approvato o disapprovato.
A differenza di quanto avviene per il giusrealismo americano, e il fondamento del giusrealismo
scandinavo è dunque soprattutto filosofico e metodologico: si tratta infatti di purificare il discorso
dei giuristi dai suoi elementi mitici e ideologici, e di produrre una vera scienza giuridica empirica
e non nascostamente valutativa.
I due filosofi del giuriamo scandinavo più importanti sono Olivecrona e soprattutto Alf Ross, autore
di Diritto e giustizia (1953) e Direttive e norme (1968). Con Olivecrona e con Ross, e soprattutto
con quest’ultimo, che fu anche allievo di Kelsen, il realismo giuridico affronta alcuni dei problemi
fondamentali della teoria giuridica contemporanea, affrontati anche da Kelsen; soprattutto la
separazione della questione della giustizia da quella dell’individuazione e descrizione del diritto, e
la pretesa di autonomia del pensiero giuridico dei giuristi positivi rispetto a scelte filosofiche e in
genere extra-giuridiche. Il maggior punto di distacco tra questo realismo e Kelsen sta proprio nella
concezione della scienza del diritto: per giusrealisti infatti la scienza giuridica tradizionale e
giuspositivistica e irrimediabilmente ideologica, compromessa da una nascosta scelta etico-politica
a favore del diritto descrittio; mentre una vera scienza del diritto deve essere sociologica e
revisionale e occuparsi dell’effettività del diritto (si torna sempre alla storia dei tribunali…).
Ross respinge l’idea di una specifica validità a priori del diritto, e sostiene, in polemica con Kelsen,
che le norme non hanno alcuna specifica realtà e non esistono a meno che non vengono osservate e
sentite come vincolanti dai loro destinatari. Ross è inoltre d’accordo con Kelsen sul fatto che le
norme di competenza siano riconducibili a norme di condotta, e che norme giuridiche vere e proprie
siano solo quelle che disciplinano i comportamenti umani osservabili.
Infine, sul compito e la natura della scienza giuridica, Ross la qualifica come empirica e
predittiva: essa dovrebbe indagare sulle tendenze decisionali giudiziarie e formulare previsioni
concernenti il comportamento futuro dei tribunali.
5.2. GIURISPRUDENZA SOCIOLOGICA E GIUSLIBERISMO (NON SINTETIZZATO)
La concezione del diritto libero è un movimento di pensiero che attribuisce ai giuristi il potere, o
addirittura il dovere, di ricercare «liberamente» il diritto, al di là di quelle che sono invece
considerate fonti del diritto dalle concezioni più ristrette, come ad esempio il giuspositivismo. Ne
consegue che le soluzioni giuridiche date dai giusliberisti dovrebbero risultare più ricche e meglio
adatte alla esigenze sociali di quelle date da giuristi che seguono un metodo «meno libero»: questi
ultimi, in blocco, sono polemicamente chiamati formalisti dai sostenitori del giusliberismo.
Il movimento si è sviluppato tra la fine dell'
Ottocento e i primi del Novecento, soprattutto in
Germania, ed accomuna studiosi per molti versi dissimili: ha quindi più il carattere di un
atteggiamento giuridico-culturale parzialmente comune a diverse teorie del diritto che non quello di
una vera e propria scuola di pensiero. Con parecchia approssimazione, si possono trattare insieme
da questo punto di vista gli esponenti del movimento del diritto libero, della giurisprudenza degli
interessi, della giurisprudenza sociologica.
Anche secondo la giurisprudenza sociologica, l'
operatore giuridico (giurista e giudice) non si deve
limitare alla ricerca e applicazione delle leggi statali, ma deve prendere le proprie decisioni su una
base più ampia, considerando come fonti del diritto anche fatti sociali normativi diversi dalla
legislazione. Come si vede si tratta qui di una tesi politico-giuridica, più che di un programma
esclusivamente descrittivo e scientifico.
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
E in una direzione decisamente politica si muove la maggior parte delle correnti anti-formalistiche
del pensiero giuridico contemporaneo; specie la scuola del diritto libero; esse sostengono che
accanto al diritto statale e legislativo esiste un diritto di uguale o maggiore importanza, fatto di
consuetudini e norme effettive, anche se non formalmente emanate. È evidente che questa tesi non è
da considerare solamente descrittiva, ma anche prescrittiva, con l'
esortazione ai giuristi e soprattutto
ai giudici di tenere conto di queste norme nelle loro decisioni. Si tratta pur sempre di un movimento
culturale di reazione alle codificazioni e alla loro pretesa di completezza e alla cultura giuridica che
le accompagna.
Precursore della giurisprudenza sociologica è comunemente considerato Rudolf Jheríng (18181892), giurista e storico del diritto tedesco, nella seconda fase del suo pensiero, quale fondatore
della giurisprudenza degli interessi. Nelle opere Lo scopo del diritto (1877-1883); Faceto e serio
nella giurisprudenza (1884), Jheríng infatti sostiene che la scienza del diritto deve seguire H
metodo teleologico, cioè deve ricercare gli interessi o scopi che permeano oggettivamente la società
e che costituiscono il principio unificatore del diritto.
Il maggior esponente di quella «giurisprudenza degli interessi» che può esser fatta risalire alle tesi
del secondo Jhering è il tedesco Philipp Heck (18581943), autore di: Il problema della produzione
del diritto (1912), La formazione dei concetti e [a giurisprudenza degli interessi (1932). Heck
sostiene che la giurisprudenza e la scienza del diritto devono occuparsi non solo delle norme
giuridiche, ma anche degli interessi che le norme mirano a tutelare. L'
autore nega la, completezza
degli ordinamenti giuridici; le lacune possono essere colmate dai giudici solo tramite
l'
individuazione degli interessi.
A questo movimento, in verità assai variegato, appartiene anche il polacco Hermann Kantorowicz
(1877-1940), da alcuni considerato il padre del movimento, con l'
opera La lotta per la scienza del
diritto (1906). Egli sostiene che accanto alle leggi dello Stato e alle norme che possono essere da
queste ricavate mediante operazioni logiche, esiste un diritto sociale, prodotto da giuristí e da
giudici, che precede il diritto statale e non ne dipende. Il diritto legislativo e statale inoltre non è
completo: le lacune possono e devono essere colmate attraverso una interpretazione creativa (o
libera, appunto).
Uno dei più significativi esponenti del movimento giusliberista è il francese François Gény (18611959), tra le cui opere fondamentali sono: Metodo e fonti nel diritto privato positivo (1899) e
Scienza e tecnica nel diritto privato positivo (1914-1924). Gény critica la concezione
dell’interpretazione che fa della legge l'
unica fonte delle decisioni giuridiche; egli teorizza il metodo
della libera ricerca del diritto, il quale supera la considerazione delle sole fonti legali e formali del
diritto, per individuare la natura delle cose, i concreti rapporti sociali che sono diritto anch'
essi.
Come si vede, gli aspetti più tipici e importanti del movimento del diritto libero sono il rifiuto di
alcune posizioni proprie del positivismo giuridico: in particolare il giusliberista rifiuta lo
statualismo (la tesi che il diritto è tutto di provenienza statale), rifiuta anche il principio della
supremazia della legge (statale) sulle altre fonti del diritto, la tesi che gli ordinamenti giuridici non
contengono lacune, la teoria dell’interpretazione come mera descrizione applicazione della legge.
Per il giusliberista la legge non può fornire un’indicazione esauriente e sicura per risolvere (tutte) le
controversie: infatti, per il giusliberista, il diritto è creato piuttosto dalla decisione giudiziaria, ed è
la volontà, non la ragione, a guidare il giudice nella scelta, sia tra le disposizioni legislative, sia tra i
significati che possono essere attribuiti a queste a posteriori per giustificare la decisione.
5.3. ISTITUZIONALISMO
L’Istituzionalismo è una teoria giuridica che definisce il diritto come organizzazione e istituzione.
Questa teoria ha fra i suoi principali esponenti nel francese Maurice Hariou, e nel giurista
giuspubblicista italiano Santi Romano, la cui opera principale è L’ordinamento giuridico (1971).
L’istituzionalismo critica la pretesa del normativismo di fare della norma l’elemento fondamentale e
primario del diritto. Ciò che è prioritario, per l’istituzionalismo, è l’elemento dell’organizzazione
sociale, la quale non solo preesiste alle norme, ma costituisce anche lo sfondo che ne permette
l’interpretazione e ne colma le lacune; inoltre costituisce in qualche modo il limite alla validità
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
delle norme, che possono essere in ogni momento superate dalle norme derivate dalle due grandi
fonti del diritto non scritto: la consuetudine e la necessità.
Una critica immediata all’istituzionalismo è: cosa può formare un’organizzazione se non l’insieme
delle norme?
Inoltre ci si può chiedere, riguardo alle pretesi fonti del diritto non scritto, quali criteri individuino
la consuetudine giuridica e la necessità giuridica nel marasma delle consuetudini e forze sociali.
In realtà la concezione istituzionalistica è ancora abbastanza moderata, e incline a una versione
abbastanza ortodossa del diritto: essa risente soprattutto della maggiore inclinazione di Romano
verso il diritto pubblico rispetto al diritto privato, e ne deriva un’impostazione prevalentemente
statualistica: il diritto pubblico è infatti diritto statale. Ma nascosta sotto l’istituzionalismo moderato
esiste una concezione assai più radicale, che respinge il normativismo in modo radicale, vedendo le
norme superate dalla realtà dei rapporti sociali: gli uomini e le loro decisioni fanno la realtà, non le
norme: questo decisionismo estremo è un atteggiamento conoscitivo e un punto di vista eticopolitico. L’idea del governo delle leggi piuttosto che il governo degli uomini è solo un’ideologica
credenza consolatrice: l’ideologia dello Stato di diritto va osteggiata perché sacrifica alla certezza
l’ideale della giustizia.
Sono rare le teorie che sviluppino coerentemente queste premesse; la più coerente è quella del
tedesco Carl Schmidt, il quale teorizza la concezione concreta dell’ordinamento e giunge fino ad
appoggiare l’antinormativismo del nazionalsocialismo; opponendo alla vuota astrazione del mondo
normativo che sarebbe propria di molte concezioni del diritto la concretezza delle decisioni del
potere.
Il decisionismo è senza dubbio un’idea filosoficamente profonda e assai inquietante per ogni
giurista contemporaneo; è come, per così dire, il sospetto con cui ogni giurista pratico e teorico deve
fare i conti e con cui deve combattere ogni giorno. Pertanto il decisionismo è incorporato, in forme
più o meno apparenti, in molte teorie giuridiche, e in particolare in molte forme di realismo
giuridico.
5.4. TEORIA DEL RAPPORTO GIURIDICO (NON SINTETIZZATO)
Rapporto giuridico è, nel senso più semplice, qualunque rapporto regolato dal diritto, Alcune
concezioni del diritto invertono però in un certo qual modo la nozione, sostenendo che certi rapporti
sociali sono intrinsecamente normativi e giuridici, e producono la propria regolamentazione
giuridica; per queste concezioni, quindi, il rapporto giuridico è al centro del diritto, l'
elemento da
cui è necessario prendere le mosse per spiegarlo.
Alcune concezioni del diritto come rapporto sono critiche soprattutto verso il normativismo, poiché
negano appunto che le norme siano l'
elemento centrale e qualificante del fenomeno giuridico. Tali
teorie danno grande importanza, naturalmente, al momento sociale della vita giuridica e tendono a
vedere diritto in ogni gruppo e rapporto sociale stabile: ben al di là quindi del diritto statale.
Si tratta, come si vede, di una concezione del diritto, o di un aspetto di concezioni più ampie, che si
avvicina assai alla giurisprudenza sociologica e alla teoria istituzionale del diritto.
Ci si chiede tuttavia come sia possibile parlare di rapporto giuridico senza che questo dia luogo a
norme che attribuiscono al rapporto stesso una qualificazione normativa (ad esempio, lo
qualifichino come obbligatorio, vietato o come l'
esercizio di un potere); e senza un qualche criterio
prescrittivo (metanorma) che permetta di distinguere tra i rapporti normativi giuridici e gli altri
rapporti normativi, per esempio le valutazioni normative che derivano dai costumi sociali.
Come tutte le forme di giurisprudenza sociologica in senso lato la teoria del rapporto giuridico
sembra cadere in qualche modo nella fallacia naturalistica, nella confusione indebita tra giudizi di
fatto e di valore. In questo caso il teorico del rapporto giuridico sembra presupporre il giudizio di
valore per cui è bene che le regole diffuse nella società ottengano un riconoscimento giuridico; il
concetto di diritto viene adattato in modo da ottenere questo effetto, da assicuramela sensibilità alle
esigenze sociali.
Oltre a questa obiezione filosofica di principio va anche considerato che le regole e gli interessi
sociali sono quasi sempre in conflitto e (quando non lo sono) confusi; occorrerà quindi pur sempre
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
un'
opera di scelta politico-giuridica per adottare alcuni tra di essi a preferenza degli altri: un
compito che il giuspositivismo lascia compiere, alla luce del sole, al legislatore politicamente
legittimato. Invece, la teoria del rapporto giuridico come tutte le giurisprudenze sociologiche,
mediante la propria definizione di diritto, vorrebbe attribuire la scelta a un non meglio precisato
gioco dei rapporti sociali, affidandola al giurista o al giudice che «interpretano» il senso dei rapporti
sociali.
6. NORMATIVISMO (NON SINTETIZZATO)
È la concezione del diritto come norma (giuridica). Quando si parla di norma in questo caso si
intende in primo luogo una norma generale e astratta, una formulazione linguistica già esistente (o
comunque qualcosa formulabile linguisticamente) in termini generali e astratti, cioè suscettibili di
applicarsi a una classe illimitata di casi concreti. Occorrerà poi trovare un criterio per distinguere le
norme giuridiche dalle altre norme.
Il normativismo per lo più non è una specifica e autonoma concezione generale del diritto: esso è
piuttosto un insieme di tesi comuni a molte correnti del pensiero giuridico moderno e
contemporaneo, e compatibile con concezioni del diritto differenti, basate anche su differenti
atteggiamenti filosofici e giuridici. In particolare il normativismo è compatibile con i principali
indirizzi della filosofia giuridica contemporanea descritti in questa voce, il giuspositivismo, il
realismo giuridico, il giusnaturalismo.
Il normativismo consiste dunque essenzialmente nella convinzione che il diritto sia fatto solo di
norme, sia analizzabile integralmente in termini di norme. Non è sempre facile neppure chiarire
cosa sia una norma; in queste pagine, quando non si dice altrimenti, si intende per norma un
significato prescrittivo portato dal linguaggio. La concezione del diritto come norma costituisce
l’elemento centrale della definizioni del concetto di diritto attualmente più diffusa nella cultura
occidentale: il diritto infatti vi viene definito come norma coattiva o come ordinamento di norme
sanzionate.
I diversi orientamenti filosofico-giuridici poi specificano diversamente il concetto minimo di
norma. C'
è chi ritiene che i significati normativi si identifichino sempre con gli enunciati linguistici
che li esprimono, per cui un enunciato corrisponderebbe sempre a una norma e viceversa: questa
tesi è alla base della teoria dell'
interpretazione nota come formalismo interpretativo. Altri ritengono
che le norme, come significati, siano ricavate mediante interpretazione dalle formulazioni
linguistiche del diritto, che sono in sé suscettibili di diversi significati e soprattutto di diverse
applicazioni ai singoli casi concreti: queste teorie portano a concezioni ancora normativistiche, ma
più vicine al giusrealismo.
Queste differenze sul modo di intendere il concetto di norma si collegano spesso a diverse
concezioni della semiotica e della teoria del linguaggio: le norme possono essere infatti considerate
enti linguistici e/o semiotici, cioè significati o qualcosa di strettamente connesso con i significati (ad
esempio gli enunciati che hanno quei significati).
Secondo alcuni è possibile interpretare un'
enunciazione linguistica in relativo isolamento
dall'
ambiente o situazione in cui ha luogo; secondo altri la autonomia del linguaggio, incluso quello
giuridico, è del tutto illusoria, e comprendere il diritto vuol dire far riferimento alla società di cui fa
parte.
Da queste divergenti concezioni discendono divergenti teorie dell’interpretazione. Altre divergenze
sul concetto di norma riguardano la sua realtà sociale: ha senso dire che le norme (giuridiche)
esistono meramente come significati, o esse devono esistere nei comportamenti sociali ?
Il senso minimo di normativismo giuridico va distinto dalla versione specifica di normativismo
contenuta nella teoria del diritto di Kelsen, con cui invece spesso viene fatto coincidere. Infatti per
Kelsen le norme giuridiche sembrano essere entità realmente esistenti in una sfera di realtà diversa
da quella fisica e materiale, esistono nel mondo del dover essere, e sono conoscibili attraverso
un'
apposita scienza «normativa», la scienza giuridica, che deve essere «pura» da considerazioni
fattuali, così come da considerazioni etiche. I critici talora dimenticano che questa tesi kelseniana
riguardante il metodo della scienza giuridica e la descrizione giurisprudenziale non è
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
necessariamente conseguente alla convinzione minima implicita nel normativismo che A diritto sia
composto da norme. Lo dimostra il fatto che molti teorici del diritto normativisti non sono
kelseniani: in primo luogo i (pochi) giusrealisti normativisti, come Alf Ross.
7. MARXISMO E DIRITTO
Poiché il pensiero di Karl Marx aspira ad essere una concezione globale ed onnicomprensiva della
realtà ci si aspetterebbe di trovarvi una concezione del diritto pienamente formulata. La prima
difficoltà che sempre sorge con Marx e quello di distinguere tra il pensiero di Marx (ed Engels) e
quello dei suoi seguaci: si usa convenzionalmente distinguerli chiamando marxiano il pensiero di
Marx ed Engels e marxista quello dei seguaci.
Marx fu senza dubbio un filosofo politico, e questi interessi politici di Marx influenzano
profondamente la sua concezione del diritto: egli non considera il diritto un fattore storico
autonomo, e dunque non abbiamo opere da lui dedicate specificamente al diritto: importanti
risultano però la Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico (1843) e L’ideologia tedesca
(1846).
Per Marx occorre che la filosofia non si limiti a comprendere il mondo, ma si proponga di
trasformarlo (radicalmente). La storia è per lui movimento dialettico di ciò che per Hegel era
MATERIA (cioè solo una parte della realtà in quanto Spirito), che per Marx è la vera realtà, costituita
dal sistema dei rapporti di produzione dei beni. La filosofia di Marx si auto-denomina dunque
materialismo, non in senso volgare, bensì in senso hegeliano.
Gli altri fattori sociali sono per il materialista solo una parte della sovrastruttura, realtà derivata e
dipendente.
Un certo stadio di rapporti di produzione produce uh certo tipo di sovrastruttura: anche il diritto fa
parte della sovrastruttura, e il metodo di produzione industriale capitalistica genera per marx il
diritto del XIX secolo.
La storia è per Marx essenzialmente LOTTA DI CLASSE, infatti i rapporti economici sono sempre
rapporti di sfruttamento di una classe sulle altre.
Il DIRITTO in Marx è dunque parte della sovrastruttura, ed è quindi impossibile cercare di giudicarlo
o comprenderlo in isolamento: il diritto di ciascun periodo storico è la volontà della classe
dominante, ed è rivolto a mantenere lo sfruttamento di classe. Cercare di valutare la giustizia di un
certo diritto vuol dire rimanere prigionieri della sovrastruttura, cercando di valutare l’ideologia
degli sfruttare mediante essa stessa.
Anche l’etica e i giudizi di giustizia sono sovrastruttura. Il solo giudizio scientifico per Marx è
quello realtivo al mutamento dialettico: è considerato positivo ciò che facilità il movimento
dialettico, negativo ciò che lo ostacola.
Secondo Marx la società è destinata a cambiare, cioè a rovesciarsi per effetto della rivolta delle
classi sfruttate contro la borghesia sfruttatrice: il risultato sarà una società senza classi e senza
sfruttamento, il che porterà all’estinzione di diritti e stati, quando verrà meno lo sfruttamento e
quindi la necessità di mantenere l’apparato di forza che lo sostiene. Nascerà così per Marx, dopo
l’intermezzo della dittatura socialista, la società comunista, senza sfruttamento, senza classi e senza
false rappresentazioni quali l’idea di giustizia.
La prima difficoltà per una teoria marxiana o marxista del diritto viene dal fatto che i passi in cui
Marx si occupa del diritto sono assai scarsi e tra di essi è difficile isolare quelli che contengono
affermazioni teoriche significative da quelli, più numerosi, orientati a una critica ideologica ed
etico-politica del diritto nella società capitalistica moderna. Ciò è reso ancora più difficile
dall'
esistenza di una interpretazione del pensiero marxiano e marxista per cui non è lecito
distinguere tra affermazioni di fatto (sulla realtà sociale del diritto) e affermazioni etico-politiche
(sulla giustizia o ingiustizia di un diritto positivo): le due cose vengono considerate come
indistinguibili in certe visioni marxiste. È evidente che una simile posizione epistemologica è
incompatibile con molte metodologie «borghesi» della scienza, e collide direttamente con un
fondamento della metodologia sia giuspositivista sia di una parte considerevole del giusrealismo.
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
Si capisce pertanto che più che di una teoria. marxista del diritto oggi si tenda a parlare di diverse
teorie marxiste del diritto, diverse tra loro sotto molti aspetti importanti. Un elemento che sembra
accomunarle è la visione del diritto come prodotto di una società divisa in classi sociali
antagonistiche; esso sarebbe impiegato (spesso se non sempre) dalla classe dominante come
strumento per consolidare e proteggere il proprio dominio sulle classi sottomesse. Il diritto in questo
quadro non è però un elemento autonomamente decisivo nella lotta di classe; esso, come si è detto,
è considerato elemento della sovrastruttura, che è determinata dai fattori fondamentali della realtà
sociale, quelli economici. La sovrastruttura, cioè il dominio ideologico (politico, culturale e
giuridico), si limiterebbe a rafforzare il dominio economico sui mezzi di produzione, il solo
essenziale e decisivo: può modificare la fondamentale dinamica sociale, ma non sovvertirla.
Pertanto le caratteristiche del diritto di ciascuna società dovrebbero rispecchiare la sua struttura, che
è sempre struttura economica. Il nostro diritto occidentale moderno, secondo questa concezione, è
diritto di una società capitalistica.
Le tesi sopra menzionate sono oggetto di molte varianti. Alcuni pongono l'
accento sulla critica
all'
ideologia borghese: in questo caso si farà della critica all’ideologia giuridica come un aspetto
particolare di quest'
ultima.
Ovvero, come accadeva soprattutto nei teorici del diritto sovietici, ci si può concentrare sui
problemi della legittimazione del potere e dell'
attività giuridica nei paesi del «socialismo reale»: in
questo caso si incontrava la grave difficoltà di dare una valutazione positiva dello stato e del diritto
«socialisti», nonostante che il diritto e lo stato abbiano nei testi marxiani un collegamento
ineliminabile con la società di classe e con lo sfruttamento. Per far quadrare questo cerchio si è
cercato di sfruttare la teoria della progressiva estinzione dello Stato e del diritto nella «vera» società
comunista, ancora di là da venire e dove, secondo Marx e i marxisti, lo stato e il diritto dovrebbero
finalmente venire meno perché vi sarebbero venuti meno sfruttamento e classi sociali a cui il diritto
è funzionale.
Giungiamo così ai giuristi e teorici del diritto sovietici (del XX secolo): Nikolaj Lenin, autore di
Stato e rivoluzione (1917); Petr Stucka (1865-1932), autore di La funzione rivoluzionaria del diritto
e dello Stato (1921); Evgenij B. Pasukanis (1891-1937?), scomparso certamente vittima delle
purghe staliniane, è autore di varie opere tra cui la Teoria generale del diritto e marxismo (1924) e
forse il teorico di maggior valore nel pensiero giuridico sovietico.
Questi pensatori, con varia profondità teorica e coerenza, cercano di risolvere i gravi problemi
interni del pensiero marxista sul diritto e il problema non meno difficile della giustificazione dal
punto di vista marxista della sopravvivenza del diritto e dello stato in una società socialista quale
pretende di essere quella sovietica (il tutto avviene in un ambiente culturale irreparabilmente
compromesso dai più brutali interventi del potere politico).
Un altro limite della filosofia giuridica marxista viene dal fatto che sui temi specifici che oggi
vengono comunemente ritenuti rilevanti per una teoria del diritto, il pensiero marxista e marxiano,
comunque individuato, non ha dato significativi contributi. Questa relativa mancanza di impegno e
di risultati può essere spiegata in vari modi; ma sicuramente è stata determinante la visione
marxiana e marxista del diritto come momento della sovrastruttura politica, come «appendice»
dell'
aspetto fondamentale economico (struttura).
Per il marxista sono i fatti della struttura economica della società che determinano le caratteristiche
dei diritti e non viceversa: per questo il pensiero marxista non ha attribuito dignità autonoma ai
problemi della teoria giuridica rispetto a quelli di teoria politica e dello Stato, e a questi ultimi
rispetto all'
analisi globale della base economica: la maggior parte dei marxisti ha continuato a
ritenere (sia pure con accenti diversi) di poter spiegare tutto ciò che è importante nei fenomeni
politici e giuridici mediante l'
analisi economica dei rapporti di produzione.
A ciò si è ovviamente accompagnata una decisa ostilità verso ogni approccio puramente
«sovrastrutturale» all'
analisi dei fenomeni giuridici, cioè che cercasse di parlare del diritto con un
discorso interno al diritto stesso, ovvero che si muovesse al solo livello dei fatti culturali;
l'
approccio marxista è stato invece per lo più caratterizzato in senso globalistico: non si è dedicato
all'
analisi delle singole peculiarità del diritto e dei diritti, ma si è volto a individuare in primo luogo
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
le connessioni tra fenomeni ideologici o sovrastrutturali, cioè giuridici, politici e sociali in senso
lato, in secondo luogo i rapporti tra «struttura» economica e «sovrastruttura» giuridica.
Gli approcci marxisti hanno dunque cercato di spiegare il diritto solamente come un momento di
una più generale interpretazione della società: si è venuta così creando una situazione per alcuni
versi strana. Da un lato, sul piano della teoria del diritto, è difficile operare un confronto tra
soluzioni e contributi marxisti e non marxisti: non si hanno infatti diverse soluzioni a problemi
comuni, ma diversità di problemi considerati teoricamente rilevanti. Dall'
altro lato i giuristi positivi
marxisti frequentemente finiscono con l'
impiegare concetti che provengono dalle teorie del diritto
non marxiste, suggerendo l'
idea che sul merito di queste discussioni il marxismo nulla dica perché
nulla ha da dire.
Alcune correnti del marxismo hanno invece cercato di superare la nozione, invero sempre meno
diffusa, della scienza come comprensione globale della società. Il settore della riflessione sul diritto
in cui queste hanno più significative applicazioni non è forse la teoria giuridica ma la sociologia del
diritto.
DIRITTO E STATO
1.NOZIONE E PROBLEMI
Lo Stato è una organizzazione politica della società caratterizzata dalla territorialità e da un
notevole grado di accentramento e di autonomia. I giuristi sono soliti individuare tre elementi
costitutivi dello Stato: il TERRITORIO, il POPOLO e la SOVRANITÀ. Quella dello Stato è una realtà
storica e sociologica peculiare del mondo moderno e contemporaneo (la stessa espressione
“Stato” è di origine rinascimentale): solo in esso si è verificato in modo preponderante e
generalizzato il fenomeno della concentrazione del potere coattivo su un dato territorio.
Il concetto di Stato è naturalmente fondamentale nella filosofia politica; esso gioca però un ruolo
centrale anche nella filosofia del diritto, nel momento in cui questa affronta il problema dei
rapporti tra il concetto di diritto e il concetto di Stato, e il problema del fondamento e della
giustificazione del potere coercitivo statale che si esercita attraverso il diritto. È possibile pertanto
classificare e distinguere le varie concezioni del diritto anche in base al ruolo che attribuiscono al
concetto di Stato e alla nozione di Stato che esse assumono.
Sotto il primo profilo è possibile distinguere fra concezioni STATUALISTE e ANTISTATUALISTE (o
non stataliste):
- STATUALISMO (o statalismo) è l’idea comune a diverse teorie del diritto per cui solo il
diritto statale è vero diritto (agli ordinamenti normativi non statali va negato il titolo di diritto,
ovvero va riconosciuta una giuridicità solo embrionale, non compiutamente sviluppata).
Lo statualismo è un’idea diffusa tra i teorici del giuspositivismo ottocentesco, che alle sue
origini si presenta come una concezione radicalmente statualista: del resto l’imperativismo e il
volontarismo che la caratterizzano si sposano assai bene con l’identificazione del diritto col diritto
dello stato. Si può comprendere e giustificare lo statualismo ottocentesco come un atteggiamento
legato ad un dato periodo storico, ossia la presa d’atto di quel fenomeno che è stato poi denominato
statalizzazione del diritto. Non è però giustificabile l’atteggiamento definitorio ad esso
sottostante: una definizione restrittiva del concetto di diritto; un atteggiamento che nega la
qualifica di “vero” diritto a tutti i fenomeni normativi non promananti dallo Stato (detti diritti in
forma “primitiva”).
Tra questi diritti in forma primitiva rientrerebbe soprattutto il Diritto Internazionale, caratterizzato
appunto dalla mancanza di uno stato mondiale con le strutture accentrate tipiche di uno stato: di un
organo centralizzato per la produzione del diritto, del monopolio della coazione, di un apparato
giudiziario con giurisdizione vincolante.
La questione del carattere davvero” giuridico del diritto internazionale (che il giuspositivista John
Austin trattava come parte della morale positiva), ha dato luogo ad infinite dispute fra i giuristi.
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
Fra le teorie ANTISTATUALISTICHE figurano invece tutti quegli orientamenti giusfilosofici che
al contrario rivendicano l’importanza o addirittura la centralità delle norme giuridiche
consuetudinarie e comunque non statali.
Tali tendenze sfociano spesso nel cosiddetto PLURALISMO GIURIDICO (o teoria della pluralità degli
ordinamenti giuridici), ossia nell’idea che in un ambito territoriale possano vigere
contemporaneamente, accanto al diritto statale, altri ordinamenti giuridici indipendenti da (o
addirittura in contrasto con) esso. In Italia il maggior fattore del pluralismo giuridico è Santi
Romano: sulla scorta delle idee di Romano si è parlato di diritto dei privati, di diritto della
mafia, di ordinamento giuridico barbaricino (ovvero della Barbagia Sarda), intesi come
ordinamenti giuridici esistenti accanto al diritto statale o all’interno di esso. A muovere una critica
alla centralità del concetto di Stato nella teoria del diritto rivendicata dallo statualismo sono spesso
le teorie giuridiche di carattere antinormativista, antivolontarista, per le quali il diritto nasce dalla
realtà dei rapporti e delle organizzazioni sociali, e quindi non è (o non è solo) il diritto positivo
rappresentato dalla legge dello Stato.
Tuttavia, la critica allo statualismo non può più avere come bersaglio principale il positivismo
giuridico: questo attualmente, nella sua fase matura, ha abbandonato le convinzioni
statualistiche. Così con Kelsen il concetto di Stato perde la sua centralità nella teoria del diritto: per
Kelsen il diritto è un ordinamento di norme che disciplinano l’uso della forza, indipendentemente
dalla provenienza statale o meno di tali norme.
Nella DOTTRINA DEL DIRITTO è anzi il concetto di diritto che gioca un ruolo decisivo riguardo alla
nozione di Stato: infatti Kelsen estremizza il processo che è stato chiamato di giuridicizzazione
dello Stato, già avviato dalla dottrina giuspubblicistica tedesca ottocentesca, che ha rivendicato
alla scienza del diritto lo studio dell’organizzazione statale e della sovranità, campi solitamente
considerati di pertinenza della morale, della religione e della politica: con la dottrina
giuspubblicistica tedesca ottocentesca nasce una scienza del diritto pubblico del tutto nuova, che ha
influenzato profondamente anche la realtà concreta degli stati moderni, per cui si può parlare di
giuridicizzazione dello Stato e non solo del concetto di Stato.
Kelsen giunge a sostenere che quello di Stato è un concetto esclusivamente giuridico, che
occorre analizzare soltanto in termini di meccanismo normativi: l’espressione “Stato” indica
soltanto un tipo particolare di ordinamento giuridico, caratterizzato dalla presenza di organi
accentrati per la produzione giuridica e per l’esecuzione delle sanzioni. Concepita in questo
modo lo Stato diventa parte del diritto, e la Teoria dello Stato diventa parte della Teoria del Diritto.
Ma naturalmente il problema dello Stato può essere affrontato anche come PROBLEMA
SOCIOLOGICO, e lo stato può essere visto come un’entità sociologica: nasce così la distinzione tra
sociologica e scienza politica da un lato, e filosofia politica dall’altro. Il terreno specifico delle
riflessioni della filosofia politica è dunque non sociologico, bensì concettuale e normativo: tra
questi problemi sono specialmente importanti il problema della LEGITTIMITÀ, ossia della
giustificazione etico-politica del potere dello Stato, e il problema speculare dei LIMITI
DELL’OBBLIGAZIONE POLITICA.
In filosofia del diritto tale ambito di problemi ha l’esatto corrispondente nel problema della giustizia
del diritto e del fondamento dei limiti dell’obbligo di obbedire al diritto.
Tratteremo nei paragrafi seguenti le idee-chiave in tema di rapporti tra Stato e diritto elaborate dalle
correnti di filosofia politica e giuridica dell’Ottocento e Novecento di stampo illuministicopositivistico-liberale: queste idee sono lo stato di diritto, la separazione dei poteri, il principio di
legalità, il garantismo. Ci si concentrerà su questo filone della filosofia politica e giuridica perché le
concezioni da esso formulate hanno avuto enorme influenza nella cultura e nella mentalità giuridica
contemporanee; si trascureranno invece altri accostamenti al problema dei rapporti tra stato e diritto,
in particolare quel filone del pensiero filosofico politico caratterizzato da un atteggiamento negativo
nei confronti dello stato: fra queste rientra la teoria marxiana e marxista, che ha avuto larga
diffusione culturale ma scarsa influenza sul piano istituzionale (anche negli stessi paesi socialisti).
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
Nella concezione marxiana lo Stato, come il diritto, è visto come una sovrastruttura
determinata dalla base economica: lo Stato borghese è quindi visto come conseguenza del
dominio economico della classe capitalistica, e il diritto borghese come strumento del
rafforzamento del dominio economico di tale classe; pertanto verrà anch’esso capovolto nella
rivoluzione sociale. Sembra invece appartenere ad Engels, o alla letteratura marxista successiva, la
cosiddetta TEORIA DELL’ESTINZIONE DELLO STATO: l’idea per cui, dopo la fase transitoria della
dittatura proletaria, Stato e Diritto (strumenti di dominio di una società divisa in classi) deperiranno
e si estingueranno.
2. STATO DI DIRITTO
Lo STATO DI DIRITTO è lo stato in cui comandano le leggi e non gli uomini; l’espressione inglese
equivalente, rule of law, letteralmente può essere resa appunto con “dominio del diritto”. Con una
formula meno sintetica ma più realistica, lo Stato di diritto può essere definito il tipo di stato
qualificato da caratteristiche del suo diritto che attribuiscono, come risultato complessivo, una
notevole importanza alle norme giuridiche generali e astratte, specialmente alle leggi. Nello Stato di
diritto come è oggi concepito ogni potere deve essere esercitato in modo legale, ossia in conformità
alla legge e al diritto: il rispetto della legge è richiesto non soltanto per gli atti degli organi inferiori,
ma anche per quelli dello stesso legislatore, vincolato nei paesi moderni al rispetto di una Carta
costituzionale che ne circoscrive formalmente e sostanzialmente le competenze.
La stretta legalità rappresenta una limitazione ed una forma di controllo del potere medesimo: essa
assicura di conseguenza al cittadino una sfera di libertà nei confronti dello Stato; questa sfera può
essere più o meno estesa, ma è comunque positiva la capacità del cittadino di conoscere in anticipo
quali libertà il diritto gli concede.
Appare chiaro che l’espressione “Stato di diritto” è portatrice di una carica valutativa
fortemente positiva: esso si contrappone allo STATO ASSOLUTO, il cui potere non è sottoposto a
vincoli formalmente definiti.
L’idea della superiorità del governo delle leggi su quello degli uomini, rappresenta un tema
ricorrente dei teorici politici medievali, e può essere ritrovata anche negli autori classici, da Platone
(nelle Leggi) e Aristotele in poi. Tale convinzione fa leva sull’impersonalità, generalità e stabilità
delle leggi, rispetto alla personalità, arbitrarietà e mutevolezza delle passioni umane.
L’idea più specifica e pregnante del controllo del potere dello Stato da parte del diritto è tipicamente
moderna: quello di Stato di diritto rappresenta un modello ideale difeso e perseguito da concezioni
di ispirazione specialmente liberale quali il giusnaturalismo illuminista, il contrattualismo, il
costituzionalismo.
Come ideologia politica, l’ideale prescrittivo dello Stato di diritto è assai semplice e netto, ma
anche assai poco realistico: nel modello ideale non solo tutti i poteri discendono dal diritto
(principio di legalità), ma sono anche interamente da esso regolati e circoscritti nel loro
esercizio formale e sostanziale (principio di stretta legalità).
Ciò vale specialmente per il potere legislativo, ossia il potere politico supremo, anche se questo è
esercitato dal popolo a maggioranza: anche il popolo può farsi tiranno. Per evitare che il legislatore
divenga tiranno, creandosi leggi su misura (…), si è ricorso storicamente ad alcuni artifici
principali:
- Il primo artificio è l’idea di un LIMITE NATURALE AL POTERE: essa è accolta in particolare
dal giusnaturalismo illuminista, che identifica questo limite nei diritti naturali e inviolabili
degli individui, e che giustifica anche la ribellione al tiranno nel caso in cui questo imponga
una legge che non li rispetti (diritto di resistenza).
Troviamo la classica formulazione di questo principio in John Locke (Due trattati sul governo,
1790), che teorizza il diritto di resistenza, resistenza a un governo e a un diritto che violino i diritti
naturali e quindi il patto sociale su cui sono fondati e da cui sono limitati i doveri di obbedienza dei
cittadini.
Il secondo artificio consiste nell’introduzione di una COSTITUZIONE RIGIDA, che non sia cioè
modificabile con le ordinarie procedure legislative, ma che richieda procedure più gravose.
-
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
Lo Stato di diritto diviene così STATO COSTITUZIONALE, in cui anche il potere del legislatore
trova fondamento e limiti. Il principio di legalità si trasforma così in principio di legalità
stretta.
L’idea dei diritti naturali e quella della normazione costituzionale si intrecciano storicamente,
perché la Carta costituzionale è il documento in cui si proclamano i diritti fondamentali degli
individui e i limiti invalicabili: ad esempio nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo,
del 1776, e nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, del 1789.
Fra costituzione e diritti naturali può determinarsi tuttavia un conflitto, qualora i diritti
costituzionali siano intesi solamente come diritti positivi interamente creati, e non piuttosto
riconosciuti, da una data Costituzione.
La trasformazione dello Stato di diritto in Stato costituzionale richiede pertanto che nella
Costituzione, ai limiti che circoscrivono i poteri, si accompagnino le libertà fondamentali dei
cittadini. Nel significato odierno è Stato di diritto solo quello che, nel vincolare giuridicamente tutti
i poteri, riconosce e garantisce ai cittadini un catalogo di libertà civili (le cosiddette LIBERTÀ
NEGATIVE): libertà personale, di pensiero, di opinione, di associazione ecc.
Oltre alla Costituzione, altri istituti giuridici concorrono alla creazione dello Stato di diritto nei
paesi moderni:
- Innanzitutto va menzionata la teoria della SEPARAZIONE DEI POTERI, formulata dal teorico
francese Montesquieu nell’opera in fluentissima Lo Spirito delle Leggi (1748).
Il principio della separazione dei poteri si basa sulla semplice considerazione per cui la
reciproca indipendenza tra i poteri dello Stato è condizione perché ciascuno di essi
possa essere limite per gli altri.
(Paradossalmente, la operazione dei poteri si è realizzata in modo assai limitato in
Inghilterra, paese a cui si ispirava Montesquieu, in cui si è passati dalla monarchia
medievale limitata (dai diritti feudali ed ecclesiastici), alla nozione moderna di rule of law,
applicata però in un sistema in cui il Parlamento è considerato giuridicamente onnipotente.)
La distinzione storicamente originaria e principale dei poteri è quella fra potere legislativo
ed esecutivo: il primo veniva di solito rivendicato da un Parlamento rappresentativo, il
secondo dal monarca, poi sostituito da un Governo (che nei paesi europei è parlamentare,
cioè necessita della fiducia del Parlamento, il che è una delle principali eccezionali al
principio della separazione e divisione dei poteri.
Di fondamentale importanza è anche la separazione fra i primi due poteri ed il terzo, quello
giudiziario, necessaria affinché il loro operato sia effettivamente imparziale: da ciò viene la
giustificazione dell’indipendenza del potere giudiziario e dell’inamovibilità dei giudici.
Vi è poi da ricordare la sottomissione delle leggi a giudizio di legittimità da parte di uno speciale
organo giudiziario (CORTE COSTITUZIONALE).
Da quanto appena detto dovrebbe risultare evidente che la nozione di Stato di diritto non coincide
affatto con quella di DEMOCRAZIA: infatti, mentre il primo è un complesso apparato normativoistituzionale, la seconda è semplicemente un metodo di decisione politica basato sul principio di
maggioranza, metodo che nella democrazia indiretta (come quella italiana) si concreta
nell’elezione dei rappresentanti politici destinati a comporre il parlamento. Anche il voto popolare
democratico ha, nello Stato di diritto, una limitazione (per evitare una “dittatura della
maggioranza”): nel modello ideale di Stato di diritto sono sottratti alla disponibilità del voto
popolare tutti i principi costitutivi della stretta legalità, venendo meno i quali verrebbe meno lo
Stato di diritto medesimo.
3. PRINCIPIO DI LEGALITÀ
I filosofi politici sono soliti contrapporre la legalità alla legittimità, e trattare questi concetti come
due distinti attributi del potere. Un potere è considerato legale quando è esercitato in conformità
alle leggi, è illegale in caso contrario. La legittimità indica invece la giustificazione etico-politica
del potere. Un potere è qualificato come legittimo quando è esercitato in base ad un titolo
considerato giusto, è illegittimo in caso contrario.
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
Nella teoria giuridica, la legalità attiene pertanto ai modi di esercizio del potere, la legittimità al suo
fondamento. Il problema della legalità riguarda dunque principalmente l’effettività o violazione del
diritto; la legittimità del diritto è invece un aspetto fondamentale della teoria della giustizia.
Viene qui menzionato un terzo attributo del potere, la sua EFFETTIVITÀ: la circostanza che un
potere riesca ad imporsi in modo duraturo su una data comunità sociale e in un dato ambito
territoriale viene talvolta considerata una giustificazione sufficiente del potere medesimo:
l’effettività diventa cioè il titolo su cui si fonda la legittimità.
Le critiche ad una simile concezione sono numerose, e sono rivolte soprattutto al positivismo
giuridico, che pretenderebbe di ricavare la validità del diritto dalla sua efficacia e sarebbe quindi
un’ideologia che teorizza l’asservimento al potere effettivo. Va tuttavia ricordato che l’appello
all’effettività non è sempre indicativo di un’adesione morale al potere nudo: spesso l’effettività di
un potere viene valutata positivamente perché è vista come un prodotto del consenso e
dell’approvazione morale dei cittadini.
Tralasciando in questa sede l’effettività e prendendo in considerazione i soli giudizi di legalità e
legittimità, si nota che ci troviamo di fronte a due diverse valutazioni del potere, che possono
anche non sovrapporsi: la prima è apparentemente neutra; la seconda è invece apertamente
compromessa moralmente. In realtà la neutralità del giudizio di legalità è solo apparente:
innanzitutto la constatazione della conformità del potere al diritto può celare un atteggiamento
LEGALISTA; in secondo luogo, con l’espressione legalità, si allude oggi quasi sempre all’esercizio
del potere in conformità non ad un ordinamento giuridico qualunque, ma ad un ordinamento
giuridico qualificabile come Stato di diritto. in quest’ultimo senso la contrapposizione tra legalità e
legittimità è meno netta: il principio di legalità diventa un modo per conferire legittimità al potere e
per giustificare sul piano etico-politico lo Stato di diritto.
L’idea generica della legalità ha avuto storicamente due versioni, una versione debole (mera o
lata legalità) e una versione forte (legalità stretta): la mera legalità richiede che il potere degli
organi dello Stato sia conferito per legge; la stretta legalità richiede che tutti gli atti di tali
organi siano disciplinati solo dalla legge, ossia che la legge sia fonte esclusiva di tali atti. In
base alla prima versione affinché un potere sia legale è sufficiente che sia conferito dalla legge e
che il suo esercizio avvenga in modo non incompatibile con essa; in base alla seconda versione gli
atti di esercizio del potere devono essere conformi alla legge anche quanto al loro contenuto:
affinché avvenga è necessario che il vincolo normativo al potere non sia vacuo, ossia che la legge (e
la Costituzione) abbia un contenuto per quanto possibile determinato e che siano inoltre previsti
meccanismo di controllo di tale vincolo.
Il principio di stretta legalità esige dunque che lo stesso titolare del potere supremo eserciti questo
conformemente a norme di livello superiore: tipicamente una Costituzione scritta e rigida, che
preveda altresì un controllo della legittimità costituzionale delle leggi.
Il principio di legalità esige poi che il potere venga esercitato tramite leggi, ossia norme generali e
astratta: la generalità della legge non è solo garanzia dell’impersonalità del potere, ma è una
precondizione della stessa separazione dei poteri: il legislatore che operasse secondo leggi
individuali si sostituirebbe all’amministrazione e ai giudici. L’astrattezza a sua volta e garanzia di
stabilità temporale e della certezza del diritto: lo strumento legislativo serve così a garantire i valori
dell’impersonalità del potere, della certezza del diritto e dell’uguaglianza dei cittadini nell’ambito
delle categorie determinate dalle leggi. Se si guarda infine all’applicazione del principio di legalità
ai casi singoli, esso esige che i giudici decidano le controversie non per caso o secondo equità,
ma limitandosi ad applicare lo standard generale precostituito per legge: è chiaro che questo
aspetto del principio esige che l’interpretazione compiuta dagli organi di applicazione, e
specialmente dai giudici, non sia necessariamente e interamente creativa, ma per quanto possibile
solo dichiarativa di diritto preesistente.
Nel campo dell’azione amministrativa il principio di legalità si traduce nella legalità
dell’amministrazione, che deve trovare nella legge fondamento e limite almeno negativo
(discrezionalità amministrativa), e che deve essere sottoposta a controlli da parte di organi
indipendenti.
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
Nel diritto penale, il principio di stretta legalità si esprime nella regola, accolta dalla maggior parte
dei codici penali moderni, secondo la quale nessuno può essere punito se non in forza di una legge
che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, né con pene che non siano da essa previste: si
tratta di un ulteriore garanzia a tutela del cittadino dalle limitazioni della libertà personale arbitrarie
perché non previste per legge. Il principio di legalità penale, espresso dalla formula nullum crimen,
nulla pena sine lege, rappresenta pertanto un valore positivo dei sistemi penali che lo accolgono,
anche se per altri versi possono essere giudicati iniqui.
Si tratta di un valore liberale e garantista la cui diffusione nella cultura e nei sistemi giuridici
contemporanei si deve specialmente al movimento illuminista.
4. GARANTISMO
GARANTISMO è l’espressione oggi usata per indicare la concezione giuridico-politica dello
Stato costituzionale di diritto, che soddisfa principalmente il valore della tutela o garanzia dei
diritti individuali di libertà.
Per il garantismo solo lo Stato costituzionale di diritto è legittimo, perché solo esso è in grado di
assicurare una sfera certa e tangibile di libertà individuale: è questa stessa libertà il criterio di
legittimazione del potere.
Tra le libertà negative spicca anzitutto la libertà personale: per questo il garantismo nasce nel diritto
penale, in cui il pregiudizio a carico della libertà del cittadino è più grave e immediato.
Contrariamente a quanto potrebbe apparire, la teoria del garantismo è legata storicamente e
pragmaticamente, anche se non logicamente, al non-oggettivismo etico: infatti una condizione
fondamentale della subordinazione di ogni potere giuridico alla legge è che lo Stato non venga
considerato il depositario di alcuna verità morale, né investito del compito di imporre coattivamente
una morale ai cittadini; chi ritiene che non esista una morale oggettiva, sarà massimamente più
incline ad un sistema politico che garantisca a ciascun individuo la facoltà di formare e antere le
proprie idee morali. Per il garantismo gli unici pubblicamente rilevanti e suscettibili di imposizione
coattiva sono quelli incorporati nelle varie Carte costituzionali, sotto forma di limiti al potere
giuridico e politico, e di diritti e doveri dei consociati: tali limiti, diritti e doveri rappresentano il
vero contratto sociale su cui si fonda il potere dello Stato.
Il garantismo è una teoria complessa di legittimazione del potere, di cui assume come rilevanti non
solo i profili normativi, ma anche l’effettività: la realizzazione dello Stato costituzionale di diritto è
un modello ideale difficilmente realizzabile nella sua pienezza, ma è anche un modello la cui
realizzazione almeno parziale dipende da numerosi fattori empirici, e non solo da contenuti
normativi. Sul piano normativo è richiesto che i poteri giuridici siano circoscritti, limitati e
disciplinati nel loro contenuto. Sul piano semantico è necessario che ciò si traduca in contenuti
normativi precisamente determinati e, nel caso di materie come il diritto penale, tassativi.
Inoltre il rispetto dei limiti normativi da parte dei poteri statali deve essere soggetto a controlli
disciplinati a loro volta normativamente, e questi controlli devono essere a loro volta in larga misura
effettivi, per non essere vacui.
Infatti, dal punto di vista del garantismo molte concezioni tradizionali dei limiti al potere
risultano insufficienti perché si accontentano della astratta previsione normativa dei limiti al
potere, disinteressandosi della loro ineffettività, e contribuendo ad occultare la violazione del
diritto da parte degli organi di produzione giuridica.
Un ultimo presupposto del garantismo è una teoria dell’interpretazione né scettica né formalista:
lo scetticismo interpretativo, se avesse ragione, comporterebbe l’impossibilità e illusorietà radicale
dell’ideali dello Stato di diritto; viceversa il formalismo interpretativo alimenta la convinzione,
anch’essa illusoria, che sia sufficiente la previsione astratta di una rete di regole ed un giudice che le
applichi fedelmente perché lo Stato di diritto possa trovare piena realizzazione: il garantismo
presuppone invece che l’interpretazione possa essere in buona misura non creativa: pur consapevoli
dei margini amplissimi di libertà interpretativa di cui godono gli organi dell’applicazione, tali
margini possono essere suscettibili di delimitazione e controllo. Il Garantismo è nato in primo
luogo sul terreno del diritto penale: un diritto penale può essere considerato garantista solo
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
quando le fattispecie penali siano state determinate in maniera tassativa, sia vietato il ricorso
all’analogia, il potere giudiziario sia il meno possibile discrezionale, il linguaggio con cui sono
formulate le norme incriminatici sia il più preciso possibile, il processo penale sia caratterizzato da
una serie di accordi procedurali atti a rendere possibile l’accertamento obbiettivo della verità dei
fatti. I vari principi necessari a comporre un modello garantista di diritto penale sono sintetizzati in
questi dieci assiomi:
- NESSUNA PENA SENZA CRIMINE (principio di retributività della pena per il reato commeso)
- NESSUN CRIMINE SENZA LEGGE (principio di legalità)
- NESSUNA LEGGE SENZA NECESSITÀ (principio di economia del diritto penale)
- NESSUNA NECESSITÀ SENZA LESIONE (principio di offensività)
- NESSUNA LESIONE SENZA AZIONE (principio di esteriorità dell’azione penalmente rilevante)
- NESSUNA AZIONE SENZA COLPA (principio di colpevolezza o responsabilità personale)
- NESSUNA COLPA SENZA GIUDIZIO (principio di giurisdizionalità)
- NESSUN GIUDIZIO SENZA ACCUSA (principio accusatorio o della separazione tra giudice e causa)
- NESSUNA ACCUSA SENZA PROVA (principio dell’onere della prova)
- NESSUNA PROVA SENZA DIFESA (principio del cotnradditorio o della difesa)
5. LEGALISMO
LEGALISMO è la teoria della giustizia, nota anche come formalismo etico, che fa coincidere la
giustizia con la pura e semplice conformità alla legge. Legalismo è un’espressione dotata di
carica valutativa fortemente negativa: sia perché spesso coincide con la tendenza a seguire
pedissequamente e alla lettera la legge, anche nei suoi dettagli puramente esteriori, sia perché
consiste in una degenerazione del principio di legalità, che porta a considerare la legge non più
soltanto un mezzo utile per conseguire risultati positivi (certezza e uguaglianza di trattamento), ma
essa stessa un valore finale, e la considera dunque il criterio ultimo di giustizia delle azioni.
Per il legalista la legge e ogni altro criterio d’azione generale e predeterminato meritano di per sé
approvazione morale; la giustizia del diritto viene dunque ridotta alla sua validità e fatta dipendere
completamente da questa.
Per il filosofo tedesco Immanuel Kant, l’atteggiamento legalistico vale a distinguere la sfera del
diritto da quella della morale: l’azione morale è solo quella compiuta per obbedienza al dovere (la
legge morale); l’azione compiuta in conformità alla legge dello Stato è legale, ma non morale: si
tratta di una conformità solo esteriore e formale, priva di significato etico. Per questo il legalismo è
altresì definito FORMALISMO ETICO.
Il legalismo può essere considerato espressione peculiare di un atteggiamento morale più generale,
il CONFORMISMO ETICO: cioè il considerare giusti la legge e il diritto positivo perché si tratta di
ordinamenti vigenti ed effettivi; il principio sottinteso è che bisogna comunque assoggettarsi alle
norme effettive e più in generale alla tradizione morale e giuridica, astenendosi dalla critica
dell’esistente normativo e dal mettere in discussione i valori tradizionali. Si tratta di un
atteggiamento tipicamente premoderno, che porta a far coincidere validità, giustizia ed efficacia
del diritto.
Il legalismo e il conformismo etico, sono generalmente attribuiti dai suoi critici, ai GIURISTI
POSITIVI, tanto che si è parlato di GIUSPOSITIVISMO ETICO: il giuspositivismo sarebbe colpevole di
prestare adesione al diritto positivo solo in quanto positivo; lo statualismo dei giuristi positivi
sarebbe in realtà statolatria. L’accusa più grave mossa in questa direzione al giuspositivismo è nota
come reductio ad Hitlerum, acquiescenza e dunque complicità morale coi regimi dittatoriali di
questo secolo per li errori da essi perpetrati. Tuttavia, come sappiamo, il principio cardine del
giuspositivismo, è proprio la scissione fra diritto e morale.
I teorici del diritto tendono a ritenere che il Legalismo sia un’ideologia poco diffusa tra i giuristi:
è vero che costoro si occupano soltanto di sistemi normativi effettivi (o presunti tali), ma ciò non
significa adesione morale al diritto descritto. Se i giuristi non possono essere colpevoli di
conformismo etico, lo sono però di conformismo metodologico: tale atteggiamento risulta dalla
scelta di occuparsi solamente di sistemi normativi effettivi (o addirittura sedicenti effettivi), senza
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
che questa scelta venga giustificata espressamente e senza che essa trovi neppure una
giustificazione implicita nel quadro del lavoro svolto dal giurista sul diritto, che certo non è
riconducibile al modello della scienza empirica.
6. ILLUMINISMO GIURIDICO
L’ILLUMINISMO GIURIDICO è il complesso delle idee e degli atteggiamenti assunti dalla filosofia
illuminista riguardo al diritto: anche se il termine potrebbe ingannare, non si tratta di una filosofia
compatta e omogenea. In ogni caso è però possibile indicare alcune linee di tendenza e
atteggiamenti comuni.
Si può certamente affermare che anche riguardo al diritto l’atteggiamento degli illuministi si
caratterizza come RAZIONALISTICO, e in genere radicalmente critico nei confronti della tradizione e
delle istituzioni giuridiche del loro tempo: più che nell’elaborazione concettuale il contributo
dell’Illuminismo risiede nel VIGORE POLEMICO e nella CRITICA verso l’esistente normativo, verso
le convinzioni giuridiche tradizionali, le istituzioni giuridiche e politiche vigenti. Il terreno sul quale
la filosofia illuminista ha dato i maggiori frutti è dunque quello che Bentham chiama
“giurisprudenza censoria” e Austin “scienza della legislazione”, e corrisponde a quella che con la
terminologia moderna viene chiamata POLITICA DEL DIRITTO. Molti dei programmi di riforma
giuridica degli illuministi sono oggi patrimonio della cultura giuridica contemporanea dei
paesi occidentali e si sono talora tradotti in reali istituzioni giuridiche.
La critica illuministica è connotata al desiderio di riformare (e spesso rivoluzionare) il proprio
oggetto: l’illuminismo, infatti, si accompagna alla fiducia che la ragione umana sia in grado di
migliorare anche radicalmente le istituzioni forgiate dalla tradizione e dalla storia (e dal potere non
illuminato). La fiducia nella ragione si combina con l’INDIVIDUALISMO, la tesi che attribuisce un
valore positivo all’individuo umano, attribuendogli cospicui diritti verso la società e lo stato,
nonché, sul piano di uguaglianza, verso gli altri individui.
Un altro componente dell’illuminismo politico giuridico è l’UTILITARISMO, si tratta della tesi etica
per cui è moralmente buono solo ciò che promuove l’utilità generale, calcolata in vari modi (non
sempre tuttavia compatibili tra loro). L’utilitarismo è anch’esso un potente strumento di critica della
morale e delle istituzioni tradizionali, specie quelle a fondamento teologico, basate sulla morale
cristiana.
Gli illuministi parlano di diritto naturale, nel senso di non-soprannaturale, vale a dire espressione
della natura, ossia della ragione dell’uomo: tale diritto naturale è spesso concepito come un catalogo
di diritti astratti e universali, tra i quali primeggiano la libertà e la proprietà, di cui gli individui
godono anche prima della nascita della società civile, ossia nello stato di natura. Il tema dello stato
presociale ricorre, come anche l’idea di un contratto sociale quale fondamento della legittimazione
del potere statale: tuttavia esso diventa strumento di critica del potere, allorché lo Stato violi i patti
stipulati con i cittadini.
L’Illuminismo si ricollega dunque al GIUSNATURALISMO, ma è un tipo di giusnaturalismo che
dà uno spesso operativo all’idea di diritto naturale, avanzando l’esigenza che questo venga
tradotto in diritto positivo: sicché lo Stato, specialmente nella persona del sovrano illuminato,
deve e può avviare il processo di riforma del diritto positivo esistente per adeguarlo alle norme del
diritto naturale attraverso lo strumento legislativo.
La fondamentale esigenza dell’Illuminismo giuridico è dunque quella della razionalizzazione
del diritto esistente: il primo e più importante passo in questo senso è quello di rendere
indipendente il diritto dalla religione, nell’informarlo al principio di tolleranza religiosa. Questa tesi
è rilevante soprattutto sul piano del DIRITTO PENALE: la ragione illuministica vuole che il diritto
penale non si occupi di una serie di atti che sono rilevanti solo da un punto di vista morale e
religioso: è l’affermazione del principio di separazione tra diritto, morale e religione.
Come si è detto, lo strumento fondamentale di razionalizzazione del diritto per gli illuministi è la
legge: sul piano concettuale l’assoluta preminenza di questa fonte del diritto sulle altre collega
questo movimento al giusnaturalismo (contrariamente a quanto può apparentemente sembrare): la
legge è infatti considerata come uno strumento razionale in quanto espressione della ragione umana;
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
essa inoltre rappresenta uno strumento assai adeguato in quanto ha carattere generale e astratto, non
è una forma spontanea ma riflessa di produzione del diritto, ed è tale da disciplinare anticipatamente
le situazioni. Le leggi devono dunque essere conoscibili in anticipo (predeterminate), e devono
essere applicate meccanicamente dal giudice, il quale deve essere, secondo una famosissima
espressione di Montesquieu, la “bocca della legge”. La forma di stato più adatta ad adoperare la
legge conformemente alla ragione è quella dell’ASSOLUTISMO ILLUMINATO.
Nel campo del diritto penale le esigenze di razionalizzazione si fondono con un atteggiamento di
relativismo morale, dando luogo ad una concezione nel complesso garantista con tre atteggiamenti
fondamentali:
- Il proporzionalismo riguardo al rapporto tra reato e pena.
- L’umanitarismo riguardo al trattamento del reo.
- L’utilitarismo riguardo alla funzione della pena.
L’utilitarismo suggerisce la costruzione di un sistema sociale improntato più alla prevenzione del
danno sociale che alla retribuzione del male morale.
È d’obbligo menzionare, nell’ambito dell’illuminismo penale, l’operetta di Cesare Beccaria, Dei
delitti e delle pene (1764): Beccaria, applica le tesi utilitaristiche al diritto penale, e sostiene che le
pene giuridiche sono giustificate in quanto contribuiscono ad aumentare la felicità generale,
dovendosi infliggere quindi ai colpevoli sofferenze minori di quante l’applicazione delle pene stesse
evita alle vittime dissuadendo dal commettere reati. Questo di Beccaria, è un invito alla
mitigazione delle pene, che troverà attuazione anch’esso nei grandi movimenti riformatori e
rivoluzionari ispirati all’Illuminismo.
FORMALISMO GIURIDICO
1. NOZIONE E PROBLEMI
FORMALISMO GIURIDICO, secondo la nozione più corrente, è la posizione che darebbe maggiore
importanza alla “forma” che non alla “sostanza” delle questioni giuridiche: questa posizione è
vista perlopiù in modo negativo, e il diritto e i giuristi vengono spesso criticati per il loro
formalismo.
Questa critica viene mossa in vari sensi: il più frequente è forse quello di FORMALISMO
INTERPRETATIVO, cioè l’idea che le norme abbiano un’unica interpretazione corretta; ma il senso più
ampio e importante è quello di FORMALISMO PRATICO, il fatto che i giuristi non decidono in base al
merito di ogni singolo fatto, ma seguendo criteri formali generali e astratti, cioè in base a norme;
infine, un terzo modo di intendere il formalismo giuridico è come FORMALISMO SCIENTIFICO, che
può assumere differenti significati.
2. FORMALISMO PRATICO
Le critiche al formalismo del diritto si appuntano talora sulla tecnica con cui i giuristi scelgono le
ragioni pratiche mediante le quali giustificare le proprie scelte d’azione: tali ragioni sono perlopiù
norme, che operano le scelte in modo generale e astratto; cioè non prendono in considerazione le
singole azioni concrete, bensì CLASSI di azioni.
Le norme giuridiche non considerano quindi gli aspetti particolari delle singole questioni che
regolano, ma si limitano a classificarle in base alle loro caratteristiche di genere: per questo
qualcuno sostiene che il diritto, in quanto norma, trascuri la “sostanza” irripetibile del singolo caso
concreto, e non permette un equo trattamento.
Se si intende il formalismo giuridico in questo senso di formalismo pratico gran parte delle critiche
che gli vengono mosse risultano mal dirette: il formalismo pratico dei giuristi risulta essere una
tecnica di scelta di azione e decisione alla quale si accompagnano svantaggi e vantaggi: il fatto di
predeterminare le norme permette di garantire certezza ed equità, e di evitare l’arbitrarietà
delle decisioni.
Va comunque precisato che vantaggi e svantaggi vengono “moltiplicati” dal fatto che le norme
giuridiche sono stabilite non in base alla loro bontà individuale, ma ad altre norme che prescrivono i
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
criteri di scelta (metanorme): una norma rientra in un ordinamento perché coerente con l’intero
sistema, non per i suoi attributi particolari.
Il formalismo pratico, in ogni caso, non è affatto esclusivo dei giuristi: morale, religione e
politica si servono allo stesso modo di questo strumento di standardizzazione e facilitazione
delle scelte pratiche.
È evidente il motivo per cui la critica al formalismo pratico si è particolarmente concentrata sul
diritto, che è il campo in cui questa tecnica ha avuto il suo massimo, sistematico e visibile sviluppo:
il diritto contemporaneo e moderno è determinato non solo da ciò che contiene, ma anche da ciò che
esclude, cioè dall’essere un SISTEMA CHIUSO DI GIUSTIFICAZIONI NORMATIVE; dal fatto che
qualunque argomento a favore di qualunque scelta non viene assunto senz’altro in base ai suoi
meriti (comunque essi siano misurati), ma solo se risponde ai CRITERI DI ACCESSO nell’ordinamento
giuridico. Questi criteri fanno riferimento non solo alla coerenza del contenuto della
prescrizione con l’intero sistema, ma anche a requisiti di procedura e competenza.
I REQUISITI DI PROCEDURA (fissati naturalmente da altre norme giuridiche) stabiliscono che una
norma può entrare in vigore solo se è stata “creata” o “posta” nei modi previsti; i REQUISITI DI
COMPETENZA sono strettamente connessi a quelli di procedura: la norma è valida solo se è “posta”
da certe persone o gruppi di persone, che divengono in tal caso delle AUTORITÀ. L’esercizio di
poteri giuridici da parte delle autorità avviene sempre tramite certe procedure o modalità: ciò
avviene, anche nei diritti più “informali”, quantomeno per distinguere l’attività giuridica da quella
privata delle autorità stesse.
Questi ultimi aspetti del diritto (procedure e competenze) sono spesso considerati dai non-giuristi
come quelli più inutilmente formalisti: in realtà l’utilità del formalismo in questo senso (procedure e
competenze) consiste soprattutto nell’evitare che si protraggano indefinitamente sia le controversie
su quale sia la migliore scelte delle norme giuridiche (l’esercizio del potere legislativo è riservato
all’autorità cui viene affidato, cioè al legislatore – organo anch’esso selezionato con norme
giuridiche), sia le controversie sulla migliore applicazione di queste norme generali (l’esercizio dei
poteri esecutivo e giudiziario sono riservati ad altre autorità predeterminate).
È importante notare che questa concezione dell’ordinamento normativo permette di considerarlo in
linea astratta come una macchina razionale per prendere decisioni, a funzionamento deduttivo.
Questa natura deduttiva è stata spesso negata, poiché se è vero che è possibile dedurre i contenuti
di una norma da una norma più generale, ciò non vale per i rapporti dinamici, quali sono quelli
stabiliti tramite procedure e competenze: non è possibile dedurre quali norme promanerà il
legislatore dalle semplici procedure di elezione del legislatore. (Ma in questo caso si può ribattere
che il rapporto deduttivo esiste comunque nel senso che è valida solo la norma che segue suddette
procedure ed è emanata dalle relative competenze).
Validità qui significa che chi accetta l’ordinamento deve per forza accettare le norme valide; la
connessione logica importante, sul piano del comportamento concreto, è la seguente: chiunque
accetti una autorità deve necessariamente accettare anche le norme che essa produce
legittimamente; accettare una autorità significa accettare di regolare il proprio comportamento
secondo le decisioni di tale autorità.
Complessi problemi giuridici e morali sono sollevati da un’autorità che emette una norma
illegittima, la cui soluzione dipende dal tipo di illegittimità, dal tipo di morale e dal tipo di diritto
considerati.
3. FORMALISMO INTERPRETATIVO
Il formalismo giuridico è spesso stato inteso anche come formalismo interpretativo: in questo
caso si tratta di una teoria dell’interpretazione della giustizia, che sostiene che esiste
l’interpretazione corretta o propria di ogni aspetto del diritto. Poiché tutti sanno che di fatto i giuristi
non sono d’accordo su un numero rilevante di interpretazioni, il formalista interpretativo deve
spiegare l’esistenza di tale discordia: prendendo in prestito un classico argomento dalla teologia, il
formalista spiega che ciò avviene perché raggiungere la corretta interpretazione giuridica non è
affatto facile e molti non ci riescono mai.
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
Semplificando parecchio la questione, si potrebbe dire che il formalismo interpretativo è una teoria
sbagliata della interpretazione basata su una concezione falsa e ingenua del modo in cui possono
funzionare i linguaggi e i discorsi, perlomeno i discorsi dei diritti positivi; in questo spirito di
semplificazione si potrebbe dire che l’interpretazione giuridica vera non esiste, perché non esiste
una interpretazione vera di nessun linguaggio.
La versione del formalismo interpretativo sopra descritta, in realtà, esiste solo come posizione
implicita, in verità diffusa i giuristi positivi. Tra i teorici troveremo piuttosto posizione più sfumate,
e più convincenti: che la verità interpretativa esiste come idea limite, di fatto irraggiungibile, ma
ugualmente importante per il suo uso regolativo, come criterio per misurare quale delle imperfette
interpretazioni è migliore delle altre; se l’interpretazione ottima non è raggiungibile, la
(relativamente) migliore è quella che ha più argomenti a sostegno rispetto alle altre.
Una seconda complicazione, che pure può rendere plausibile la ricerca dell’interpretazione
migliore, viene dal fatto che molti negano che il diritto sia solamente un testo da interpretare; per
accettare il formalismo interpretativo basterebbe accogliere una concezione del diritto che non
riduca il diritto positivo a discorso e linguaggio: per esempio considerandolo un qualcosa di reale
(come per i giusnaturalista), non riducibile ai soli discorsi normativi. Tuttavia in questo caso ci
saremmo allontanati dall’ipotesi stessa di formalismo interpretativo, che è l’ipotesi stessa di
ricavare l’interpretazione vera o propria dal solo testo normativo.
Il formalismo interpretativo ha la seguente connessione con il formalismo (pratico) come tecnica
decisionale: esso dà al giurista l’illusione che le parole di un testo normativo possano guidare
interamente le scelte pratiche; al contrario, tali scelte sono inevitabili, data la relativa (e voluta)
indeterminatezza di qualunque testo normativo.
La funzione reale del formalismo interpretativo in un ordinamento giuridico è pertanto opposta
rispetto a quello che appare: esso sembra auspicare la più rigida adesione alle norme, ma apre in
realtà la strada ad usi e abusi ed arbitrarietà di ogni tipo (sotto la maschera dell’unica
interpretazione), in cui viene spacciata per interpretazione corretta quella che in realtà è
l’interpretazione preferita.
In un senso molto diverso di formalismo, il diritto è considerato come forma della realtà giuridica;
secondo questo senso le norme danno un significato (giuridico) alle azioni e alle situazioni: si dice
allora che le norme sono strumento di qualificazione della realtà. Si può dire che una simile
descrizione di forma giuridica della realtà sociale sia anch’essa un discorso formale o un discorso
riguardante la forma (il significato) delle azioni sociali.
4. FORMALISMO SCIENTIFICO
L’espressione FORMALISMO SCIENTIFICO copre vari significati, attribuiti al metodo operativo della
Scienza giuridica.
In uno di questi significati, il formalismo della Scienza giuridica consiste nell’essere una
CLASSIFICAZIONE SISTEMATICA, basata su un sistema di concetti classificatori: nella classificazione
sistematica ogni oggetto considerato dalla scienza appartiene ad un gruppo di oggetti dotati di
caratteristiche che li contraddistinguono; ciascun gruppo è caratterizzato da sottogruppi, a loro volta
distinti da altri sottogruppi. Così il gruppo degli atti giuridici (distinto dai fatti in senso stretto)
comprende il sottogruppo dei negozi, che comprende il sottogruppo dei contratti. Cos’ la materia
dei codici moderni è organizzata sistematicamente in questo senso.
Si parla poi di formalismo scientifico in senso diverso, rilevando che la giurisprudenza omette
sistematicamente di occuparsi di una parte della realtà sociale, la “sostanza”, preoccupandosi solo
della forma giuridica. Questo senso pare connesso con quello sopra menzionato quale forma
giuridica della realtà sociale; in realtà è connesso piuttosto con il senso centrale di formalismo
(pratico) come scelta mediante norme e ordinamenti: la scienza formale o normativa si occupa non
di descrivere l’intera realtà sociale, ma di raccogliere solo il materiale utile alla applicazione del
formalismo pratico; per questo descrive solo le norme e gli atti e i fatti rilevanti in base alle norme.
In conclusione, una critica indirizzata al formalismo giuridico inteso come formalismo pratico può
ben essere giustificata in
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
determinate circostanze: perché per esempio l’impiego di norme con determinati contenuti non è
in grado di raggiungere certi obiettivi; ovvero perché l’impiego di certe tecniche formalistiche può
risultare inutile o addirittura dannoso al raggiungimento di certi fini.
Sembra invece privo di senso il rigetto del formalismo pratico in quanto tale; salvo che non abbia
ragione chi ritiene addirittura impossibile che le norme guidino effettivamente il comportamento,
perché ritiene che una totale libertà di scelta venga riacquistata dall’interprete al momento
dell’interpretazione della norma al caso concreto.
GIURISPRUDENZA
1. NOZIONE E PROBLEMI
La GIURISPRUDENZA è l’attività di chi si occupa del diritto in modo continuo e professionale; è
anche il prodotto di questa attività, e quindi l’insieme dei diversi tipi di discorsi sul diritto,
purché prodotti appunto da giuristi.
Giurista è qui usato in senso lato, come persona dotata di conoscenze specializzate in materia di
diritto: nei discorsi di giurisprudenza bisogna ricordarsi che questa definizione è volutamente
provvisoria e approssimativa (allo scopo di essere ecumenica).
Il problema principale per un approccio analitico alla giurisprudenza è vedere se e come i discorsi
sul diritto si possono differenziare dai discorsi del diritto: questa definizione di giurisprudenza come
discorso sul diritto va molto al di là di quanto viene considerato generalmente giurisprudenza,
perché comprenderebbe, oltre alla scienza giuridica, ogni tipo di discorso sul diritto (dalla
sociologia del diritto, alla storia del diritto, alla criminologia ecc.). La definizione analitica di
giurisprudenza come discorso sul diritto sul discorso giuridico evita ancora volutamente la
discussione teorica e politica più importante: il problema se la giurisprudenza possa essere solo
conoscenza e discussione del diritto, o se sia anche modifica e creazione del diritto, e vada pertanto
annoverata tra le fonti del diritto.
2. DISCORSI SUL DIRITTO
Con l’espressione “giurisprudenza” raramente si intende ogni tipo di discorso sul diritto, ma ci si
riferisce generalmente alla GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA, cioè alle interpretazioni del diritto date
dai giudici nelle loro sentenze, o meno di frequente alla GIURISPRUDENZA DOTTRINALE (altresì
chiamata semplicemente dottrina), prodotta dagli esperti studiosi di diritto che non rivestono
particolare autorità giuridica, e oggi specialmente agli studiosi universitari di diritto.
Il problema della natura scientifica della giurisprudenza è particolarmente acuto per la
giurisprudenza dottrinale: dopotutto, se essa non è scienza rischia di non trovare più alcuna ragion
d’essere. Ma il problema della scientificità esiste anche per la giurisprudenza giudiziaria: infatti,
essa è in primo luogo applicazione del diritto, e quindi non è attività meramente conoscitiva e
scientifica; anche se ciò significa che si basa su un diritto già creato (essendone applicazione),
potrebbe però mantenere una funzione di creazione del diritto riferita ai casi particolari. In ogni caso
è importante scoprire se la giurisprudenza giudiziaria abbia un proprio momento scientifico per
capire se questa attività è quello che sembra essere.
Il problema della scientificità della giurisprudenza è tra i più complessi della teoria del diritto,
perché una risposta dipende da molteplici fattori: in primo luogo dal concetto di scienza che
adottiamo; in secondo luogo dal diritto positivo adottato e dalla realtà giuridica di un dato momento
storico (vedi poi l’esempio del Diritto Romano); in terzo luogo dal concetto di diritto che si
impiega.
- Se accogliamo, ad esempio, una concezione larga di giuridicità, che includa nel diritto
tutte le norme coattive ed effettive,
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
risulterà che la giurisprudenza ha avuto grande importanza nella formazione del diritto,
contribuendo a stabilire norme generali di origine giurisprudenziale estremamente effettive e
seguite (comprendendo anche le norme di origine giurisprudenziale che risultano
dall’interpretazione delle norme legislative). Questo vale per la giurisprudenza dottrinale o
accademica nella misura in cui essa gode di prestigio e autorità, ma vale a maggior ragione per la
giurisprudenza giudiziaria: le corti di grado superiore indicano linee interpretative che fungono da
norme per le corti di grado inferiore (si noti che ciò differisce dal common law, che pone
ufficialmente le decisioni giudiziarie fra le fonti del diritto; esse risultano vere e proprie norme
giuridiche, e non linee da seguire nell’interpretazione delle norme legislative).
- Si noti che una concezione più ristretta di diritto, che limiti il diritto al solo DIRITTO POSITIVO,
ritiene che la effettività sia un mero dato sociologico, incapace di modificare realmente il diritto: in
una simile concezione, o il diritto positivo pone ufficialmente la giurisprudenza tra le fonti del
diritto (come avviene nel common law), oppure tutte le norme giurisprudenziali, PER QUANTO
EFFETTIVE, verranno considerate extragiuridiche.
- La concezione larga a cui si è accennato non deve essere confusa con i casi in cui la
giurisprudenza può essere considerata fonte del diritto, in ragione delle particolarità contingenti di
un determinato diritto positivo: ad esempio la giurisprudenza (dottrinale) dei più autorevoli
giuristi era considerata fra le fonti del Diritto Romano. Valga altresì il sopraccitato esempio del
common law, ove si considera fonte del diritto il precedente giudiziario.
La creazione di norme giuridiche da parte della giurisprudenza (dottrinale o giudiziaria) avviene
comunque in forme assai diverse da quelle di un legislatore:
- Il giurista accademico è limitato nella sua possibilità dalla mancanza di autorità giuridica:
egli non ha poteri decisionali, ma soltanto autorevolezza scientifica. Per questo è essenziale
sapere se tale giurisprudenza sia o meno scienza: le sue proposte saranno poco efficaci se
presentate come scelte personali di politica legislativa o interpretativa; saranno molto più
ascoltate se presentate come descrizioni del diritto com’è.
- Il giudice è limitato nella sua possibilità di intervento dalla necessità di attendere che si
presenti il caso concreto su cui emanare una sentenza: non può “cercare” autonomamente i
problemi giuridici da risolvere, come fa il legislatore. Inoltre il giudice è limitato dalla
necessità di fornire argomentazioni a sostegno delle proprie decisioni: anche in questo caso
il legislatore non ha l’obbligo giuridico di giustificare le proprie leggi.
In ogni modo è stato osservato che la modifica del diritto da parte della giurisprudenza ha l’aspetto
di una evoluzione lenta ma continua (a differenza dei radicali cambiamenti apportati dalla
legislazione): ciò ha dato luogo ad importanti discussioni di politica del diritto, circa i vantaggi
relative delle due tecniche o delle varie combinazioni; queste discussioni, come è ovvio e naturale,
sono vive soprattutto nei momenti in cui le grandi legislazioni entrano in crisi.
3. METAGIURISPRUDENZA
La METAGIURISPRUDENZA è il discorso (perlopiù fatto da filosofi) che si occupa della
giurisprudenza: il problema principale che essa tratta è se la giurisprudenza possa essere
considerata o meno scienza; infatti è ormai evidente che molte discussioni sulla giurisprudenza sono
rese oscure dalla diversità di atteggiamenti a livello di metagiurisprudenza; sono cioè diverse non
solo le risposte, ma anche le domande che ci si pone riguardo alla giurisprudenza.
Da un punto di vista analitico, la fondamentale differenza a livello di metagiurisprudenza p quella
tra metagiurisprudenza descrittiva e metagiurisprudenza prescrittiva.
La METAGIURISPRUDENZA DESCRITTIVA è la descrizione di quello che i giuristi fanno, dei discorsi
sul diritto che abitualmente emettono e del linguaggio che abitualmente usano per produrre tali
discorsi (una simile descrizione deve essere inoltre correlata da indicazioni temporali e spaziali,
perché si presume che la cultura giuridica muti: si parlerà pertanto di giurisprudenza italiana
dell’ottocento o del diritto nei sistemi anglosassoni contemporanei ecc…). poiché la giurisprudenza
è essa stessa un metadiscorso (sul diritto), la metagiurisprudenza è un meta-meta-discorso. D’altra
parte, questa struttura stratificata
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
complessa è una delle ragioni per cui la discussione su questi problemi è così difficile e (spesso)
poco feconda, specialmente per chi non possegga lo strumento analitico della teoria dei livelli
linguistici.
- La METAGIURISPRUDENZA PRESCRITTIVA prescrive invece un modello del discorso
giuridico; di solito la prescrizione è rivolta ai giuristi (ma sarebbe meglio parlare di
esortazioni, perché raramente in queste materie si tenta di emettere dei comandi). Il modello
prescritto può essere già praticato o nuovo, e ciò non muta la natura prescrittiva
dell’operazione: nel caso che sia già praticato viene detto ai giuristi che il metodo della
giurisprudenza va bene così com’è, cioè viene detto loro di continuare nello stesso modo;
nel caso che sia un metodo nuovo viene detto ai giuristi di cambiare metodo (ad esempio:
viene detto ai giuristi di adottare un metodo scientifico, abbandonando il metodo attuale che
non sembra veramente scientifico; questa ad esempio è la posizione di molti giusrealisti, che
negano la scientificità della giurisprudenza attuale e propongono ai giuristi di adottare un
metodo empirico e revisionale di descrizione del diritto.
È dunque di fondamentale importanza tenere conto del diverso modo in cui, spesso
inconsapevolmente, ci si accosta alla giurisprudenza, descrivendo o prescrivendo un modello di
discorso ai giuristi.
La distinzione tra questi due approcci alla giurisprudenza ci conduce verso complicazione ancora
maggiori. Molto spesso, infatti, non è facile determinare la natura prescrittiva o descrittiva di un
discorso sulla giurisprudenza. È evidente che il teorico prova una forte tentazione a sostenere che le
proposte prescrittive che rivolge ai giuristi siano in realtà descrizioni di come essi già operano,
perlomeno nei momenti migliori: in tal modo è più probabile che il tentativo (così “occultato”) di
far cambiare metodo venga accolto.
A complicare le cose, la descrizione di un metodo ha comunque in sé un forte elemento di
semplificazione, e in questo senso di prescrittività: essa non rileva ogni singolo atto
giurisprudenziale, ma solo quelli che i giuristi considerano giustificati e giustificabili. Inoltre essa
non può coincidere con la pura rilevazione sociologica delle pratiche: deve descrivere regole che
individuano il metodo che una certa comunità dice di voler praticare.
Per poter parlare di descrizione di un metodo scientifico e di pratica scientifica esistente bisogna
dunque essere in grado di distinguere tra l’elemento prescrittivo insito in ogni descrizione
metodologica e la prescrizione di un nuovo metodo: quanto più questa distinzione è difficile tanto
più è facile per il teorico presentare una innovazione metodologica come la descrizione di una
pratica già in uso. Molti teorici della giurisprudenza che fanno riferimento alla pratica effettiva dei
giuristi non sembrano minimamente turbati da questi problemi, il che fa sospettare che nei loro
discorsi l’elemento prescrittivo (implicito) sia molto più decisivo di quanto sembri.
Nell’ambiente giuridico occidentale si tende a parlare di metodo positivo e di giurista positivo con
chiaro riferimento alla descrizione delle pratiche effettive (metagiurisprudenza descrittiva): c’è chi
sostiene che tale metodo si identifichi con la concezione del diritto giuspositivistica; il
giuspositivismo ritiene che la giurisprudenza è scientifica (o può diventarlo senza bisogno di
clamorosi cambiamenti di metodo), purché proceda con il metodo consigliato e si sottragga ad
alcune contaminazioni ideologiche. Si sostiene dunque che i giuristi positivi (che si limitano a
prendere in considerazione il diritto positivo) sono già scienziati così come sono. C’è invece tra i
teorici un gruppo radicalmente critico delle pratiche correnti, che sostiene che la giurisprudenza
positiva non solo non sia scienza, ma che non sia nemmeno attività legittima: secondo questi critici
i giuristi credono di fare scienza, ma svolgono attività senza alcun metodo legittimo alla luce
dell’epistemologia accettata dal critico. La ragione per cui tali illusioni e tali errori persistono è la
loro funzione ideologica: si tratta di attività apparentemente scientifiche che svolgono la reale
nascosta funzione di sostenere una valutazione favorevole del diritto; i giuristi che fanno
giurisprudenza credendo di fare scienza, in realtà non farebbero altro che rafforzare e facilitare
l’obbedienza al diritto positivo.
È meno frequente il coso in cui il teorico riconosca la natura
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
prescrittiva della giurisprudenza in sede di metagiurisprudenza descrittiva, e tuttavia la approvi in
sede di metagiurisprudenza prescrittiva: questo significa che è accettabile un dato modello di
giurisprudenza che non si limiti a descrivere, perché si ispira o sostiene valori etici e politici, un
discorso cioè che riconosce di non essere scienza (e quindi non neutrale).
Concezioni che approvino la giurisprudenza proprio perché non è scienza propongono anche ad
essa un ruolo “interventista”: sono cioè portate a ritenere opportuno che i giuristi (e soprattutto i
giudici) intervengano anche sulle scelte delle norme giuridiche generali, completando o
modificando il senso delle norme generali e astratte; ciò metterebbe però in crisi la teoria dello Stato
di diritto: giudici e giuristi non godono infatti di nessuna legittimazione politica ad intervenire nella
creazione del diritto, perché non sono eletti democraticamente.
4. SCIENZA DEL DIRITTO
La SCIENZA DEL DIRITTO (o scienza giuridica) è la descrizione del diritto condotta con un
metodo scientifico; come si è visto, secondo molti teorici del diritto la giurisprudenza si identifica o
si dovrebbe identificare con la scienza giuridica, o perlomeno dovrebbe contenere una parte
descrittiva scientifica. Pertanto con l’espressione scienza giuridica si indica una problema della
giurisprudenza, più che un oggetto separato.
Oggi è infatti motivo di viva discussione se esista un scienza giuridica: con ciò si intende dire se
esista un metodo conoscitivo specifico, diverso da quello delle scienze umane che si occupano del
diritto (quali la sociologia del diritto e la storia del diritto). La diversa, anzi opposta, soluzione che
viene data a questo problema contribuisce a distinguere tra loro due delle maggiori concezioni
contemporanee del diritto: il giuspositivismo e il giusrealismo.
- Per il POSITIVISMO GIURIDICO la scienza giuridica si distingue nettamente dalle scienze umane e
sociali, perché studia il diritto facendo astrazione dalla effettività delle singole norme giuridiche
descritte, anche se non dall’effettività dell’intero ordinamento. La scienza giuridica sarebbe
secondo tale concezione una scienza normativa (che si occupa della validità delle norme e delle
norme in quanto valide); una scienza classificatoria (che elabora un sistema di concetti giuridici,
per questo spesso chiamata sistematica – vedi poi); essa inoltre tratterebbe le norme giuridiche
quali punto di partenza esclusivo delle proprie descrizione, trattandole come dogmi: per questo è
chiamata anche dogmatica (vedi poi).
Questa concezione è spesso considerata dai suoi critici un esempio del formalismo dei giuristi;
per distinguere questa critica dagli altri sensi possibili di formalismo giuridico si suole dire che i
giuristi sono accusati di formalismo scientifico.
- Per il REALISMO GIURIDICO la scienza giuridica praticata dai giuristi positivi non è affatto una
scienza empirica: c’è chi sostiene che una vera scienza empirica, nel campo giuridico, dovrebbe
limitarsi a studiare le opinioni dei giuristi e l’influenza sociale sia del diritto sia della cultura
giuridica, e non dovrebbe però accoglierne e avvallarne le scelte metodologiche. Le astrazioni e le
omissioni della tradizionale scienza giuridica ne fanno un tipo di formalismo, senza per questo
farne una vera scienza formale in senso moderno come la logica, la matematica o la geometria. Il
formalismo selettivo dei giuristi ne fa un ibrido che guarda alla realtà ma con limitazioni derivanti
dal principio di autorità. Secondo i giusrealisti l’attuale scienziato del diritto dovrebbe
trasformarsi in un vero scienziato empirico, cercando di dedicarsi al compito di prevedere i
comportamenti giuridici rilevanti e in primo luogo quelli giudiziari. Naturalmente nessuno gli
vieterà di dedicarsi anche alla politica del diritto, per essere sia un politico della legislazione
(consigliere del legislatore sul contenuto delle leggi), sia un politico dell’interpretazione e
applicazione (consigliere dei giudici sul contenuto delle sentenze).
È evidente che questa discussione sulla scienza giuridica e sulla scientificità della giurisprudenza
non può evitare di proporre un MODELLO DI SCIENZA, e di essere quindi trascinata in una
discussione filosofia generale di teoria della conoscenza scientifica (epistemologia). In epoca
contemporanea pertanto i filosofi del diritto hanno “importato” dall’epistemologia diversi modelli
di scienza per applicarli alla giurisprudenza, modelli di volta in volta diversi a seconda dei
mutamenti in campo epistemologico: la maggiore fonte di modelli negli ultimi secoli è stata
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
la filosofia delle scienze naturali. Ciò che veniva preso in considerazione non era però la scienza
stessa, bensì l’immagine che di essa veniva data dalla filosofia: si è passati pertanto dal modello
positivistico, a quello neopositivistico, a quello popperiano, ed ora alle confuse concezioni postpositivistiche.
Essendo il diritto palesemente un fenomeno sociale, in questa discussioni si incontreranno oltre
naturalmente ai problemi delle scienze in generale, anche quelli più specifici del metodo delle
scienze sociali: non ci si può chiedere solamente se sia una scienza empirica la giurisprudenza, ma
bisogna prendere parte anche alla discussione sullo statuto delle scienze sociali, ed in particolar
modo della storia e della sociologia.
5. DOGMATICA
La DOGMATICA GIURIDICA è lo studio del diritto positivo condotto con un metodo particolare:
esso considera le norme giuridiche come proprio oggetto di studio privilegiato e
irrinunciabile, allo stesso modo in cui una teologia considera i dogmi della propria religione;
inoltre, proprio come i dogmi per la teologia, le norme giuridiche sono per la dogmatica il punto di
partenza e di arrivo per la elaborazione dei propri concetti descrittivi (cioè descrittivi di norme e
qualificazioni normative di norme). Quindi la dogmatica non è una disciplina separata dalla
giurisprudenza, ma uno speciale approccio ad essa.
Essa può essere intesa sia come ALTA DOGMATICA, cioè la parte della descrizione del diritto che
elabora i concetti di più ampia portata e maggiore complessità, sia come BASSA DOGMATICA, che si
limita a cercare di interpretare le norme giuridiche ad un minor livello d’astrazione: la prima
sarebbe affidata agli studiosi di professione (universitari), la seconda dai giudici e dai giuristi
nell’esercizio delle operazioni giuridiche concrete.
Il fatto stesso che i giuspositivista chiamino dogmatica la propria scienza viene talora ritorto contro
di loro: l’impiego di dogmi è infatti l’assunzione di punti di vista precostituiti ed estranei alla
scienza; i critici della giurisprudenza affermano infatti che essa sia una disciplina pseudo-scientifica
sottomessa alle scelte dell’autorità e del potere giuridico positivo.
Il giuspositivismo, nelle sue diverse versioni, ha invece cercato una giustificazione della dogmatica
nel quadro della scienza: si sente perciò spesso parlare di dogmatica giuridica anche da chi ne
approva ed usa il metodo, sostenendo che lo scienziato del diritto deve occuparsi solo si norme, anzi
di norme in quanto individuate da altre norme, cioè di norme valide in un ordinamento giuridico
positivo.
6. SISTEMA
Un sistema in senso stretto è qualunque insieme di proposizioni o norme che abbiano relazioni
di significato di tipo deduttivo. In un sistema in senso più lato si ammette qualunque relazione di
significato: in tal senso una classificazione è un caso tipico di sistema.
Nel diritto abbiamo sistemi di diverso tipo che possiamo distinguere sotto diversi punti di vista: da
un lato c’è la distinzione tra sistemi strettamente logici e sistemi logico-semantici; dall’altro la
distinzione tra sistemi inerenti alle norme e sistemi descrittivi dottrinali.
Per quanto riguarda la prima distinzione, possiamo dire che le norme di un sistema sono sempre
collegate da rapporti logico-deduttivi, che possono però presentare due diversi tipi di deduzione: la
DEDUZIONE STRETTAMENTE LOGICA, che sfrutta i connettivi logici o quantificatori (“non uccidere”
da cui deriva “non uccidere Caio”, fa parte di un micro-sistema deduttivo nel senso più stretto del
termine) oppure la DEDUZIONE LOGICO-SEMANTICA, che sfrutta cioè i rapporti che intercorrono tra i
significati dei termini (per esempio le norme sul contratto riguarderanno anche la compravendita
che è un tipo di contratto).
Per quanto riguarda la seconda distinzione, un sistema può essere composto da norme giuridiche
oppure può essere un sistema di concetti usati dalla giurisprudenza dottrinale per descrivere il
diritto e da quella giudiziaria per conoscerlo e applicarlo. Questi due tipi di distinzioni ovviamente
si possono sovrapporre tra loro.
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
Si parla quindi dei sistemi normativi che connettono le norme secondo un ordine, o una
classificazione; abitualmente si parla in questo caso di sistematica: ciò acquista grande importanza
e notevole complessità nelle grandi opere di legislazione unitaria come le grandi codificazioni (qui
le norme sono classificate per genere e differenza specifica: come esempio si considerino le norme
sui reati, che comprendono norme sui delitti, che comprendono norme sui delitti contro lo stato, che
comprendono norme sui vari tipi di delitto contro lo Stato).
È comunque possibile che in una legislazione complessa si sovrappongano diversi criteri di
ordinamento e classificazione: che i giuristi si servono di questa complessità e varietà di sistemi con
grande abilità, sebbene spesso non siano consapevoli a livello di teorizzazione metodologica e
riflessione sul modo del proprio operare.
Ma vanno anche ricordati, ovviamente, i nessi deduttivi tra le norme nel senso più stretto, quelli
riguardanti i termini logici: essi sono infatti una tecnica produttiva all’interno dell’ordinamento
giuridico, con l’applicazione della norma generale e astratta al caso concreto. Invece i nessi
sistematici tra norme nel senso più largo in primo luogo servono al loro più agevole reperimento, e
in secondo luogo a facilitarne l’interpretazione, con il metodo detto dell’interpretazione logica o,
appunto, sistematica.
La distinzione fra sistemi di norme e sistemi dottrinali di descrizione delle norme ci ricorda che un
sistema può anche essere usato dalla scienza giuridica per descrivere il diritto classificandolo
mediante concetti sistematici descrittivi riuniti appunto in un sistema: si tratta quindi di un sistema
logico in senso più lato, e la scienza che descrive il diritto in questo modo viene anch’essa spesso
chiamata sistematica.
È assai significativo che di rado si cerchi di distinguere chiaramente tra sistematica inerente a diritto
e sistematica come strumento descrittivo della giurisprudenza: con ciò non si intende dire che la
distinzione sia facile (è evidente la strettissima parentela e dipendenza tra questi sistemi, che
giustifica la difficoltà di tale operazione, resa ancor più ardua dal fatto che spesso il diritto positivo
recepisce sistemi elaborati dalla giurisprudenza stessa).
Che la distinzione sia difficile e problematica non la rende, naturalmente, trascurabile e ignorabile:
al contrario, è ancora più importante che lo studioso del diritto positivo si renda conto del problema:
troppo spesso la dottrina giuridica moderna usa concetti e sistemi di concetti teorici estremamente
complessi e astratti, dando implicitamente per scontato non solo che essi siano ricavati interamente
dalle norme, ma che solo un’adesione totalmente passiva alla sistematica inerente alle norme sia
legittima: entrambe queste tesi sono però errate.
La discussione sulla natura del sistema dei concetti giuridici, cioè se sia prodotto dai giuristi o
rinvenuto dalle norme, è tipica di tutte le scienze sociali, le quali si chiedono in che misura la
descrizione deve servirsi dei concetti esistenti come parte della realtà stessa descritta, e in che
misura sia possibile tra concetti presenti in rebus e concetti usati dalla scienza per descrivere la
realtà.
L’unica soluzione, a nostro avviso, è quella di seguire una condotta diametralmente opposta a quella
diffusa nella dottrina giuridica moderna: in primo luogo non ci sono ragioni per cui sia illegittimo, o
addirittura deformante, l’uso di concetti nuovi utilizzati dal teorico stesso che descrive il diritto (si
pensi alla categoria dei negozi, di pura elaborazione dottrinale); in secondo luogo teorici e studiosi
del diritto hanno l’obbligo di mostrare la bontà descrittiva dei propri strumenti classificatori e
descrittivi, senza cadere nell’ingenuo nominalismo per cui basta usare gli stessi termini del
legislatore per essere sicuri che i concetti vadano bene: il feticismo per i nomi, diffuso nella
giurisprudenza, per cui bisogna sempre usare la terminologia del legislatore, copre spesso con la
disinvoltura sostanziale con cui la giurisprudenza, anziché descrivere, riforma o deforma il diritto
senza fornire argomenti a giustificazione di ciò. Questa disinvoltura è facilitato da un costume
metodologico che, al riparo della fedeltà terminologica, nasconde la frequente mancanza di più
modesti ma plausibili argomenti veramente adatti a sostenere la bontà sempre relativa di ogni
soluzione teorica e sistematica in quanto descrizione di un diritto positivo.
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
7. EFFETTIVITÀ
In teoria generale, l’EFFETTIVITÀ di una norma giuridica è soprattutto intesa come la generale
osservanza della norma da parte dei suoi destinatari. Questa nozione di effettività non è l’unica,
ed è comunque più complessa di quanto sembri: in primo luogo è necessario decidere che cosa
significhi che una norma viene osservata (si deve decidere, ad esempio, se è sufficiente che non
venga violata; ovvero se è necessario che non venga violata proprio in osservanza della norma,
perché essa esercita un effetto psicologico e causale sulla mente degli agenti); in secondo luogo, per
poter parlare di effettività di norme devono essere decise molteplici questioni di tipo quantitativo e
tipicamente sociologiche (quali percentuali e comportamenti di violazione sono tollerabili perché la
norma risulti comunque effettiva?).
La teoria prescrittivistica offre nel concetto di FRASTICO uno strumento per l’analisi semantica
formale di che cosa sia l’osservanza di una norma. Per FRASTICO si intende l’elemento comune ad
un enunciato prescrittivo (norma) e a quello enunciato (descrizione della realtà): ad esempio fra gli
enunciati “Pietro deve chiudere la porta” e “Pietro sta chiudendo la porta” l’elemento comune è
“Chiudere la porta da parte di Pietro”.
La questione viene trattata come un confronto fra entità linguistico-semantiche e solo indirettamente
come un confronto fra entità linguistiche e fatti: si tratta di confrontare i frastici rispettivamente
della norma e della descrizione della situazione di fatto rilevante. Il frastico della norma individua
un modello di comportamento prescritto, la fattispecie normativa; il frastico della descrizione
individua i comportamenti reali rilevanti: se coincidono e se la descrizione è nel complesso (cioè
entro i parametri scelti) vera, ciò significa che la norma è efficace (nel complesso).
Va osservato che l’effettività di parecchie norme giuridiche può essere valutata solo indirettamente;
ciò accade per le norme che non prescrivono comportamenti ma effetti giuridici: ad esempio non
può essere direttamente accertata l’effettività di una norma che dispone della nullità di un contratto
a certe condizioni; a rigore tali norme non possono essere violate, perché l’effetto giuridico segue di
diritto e senza l’intervento dell’uomo. Alcune di queste norme vengono dette costitutive, proprio
perché costituiscono direttamente, o tramite il compimento di un atto, il proprio oggetto anziché
limitarsi a regolarlo: gli effetti prodotti saranno, ovviamente, effetti normativi e giuridici (sorge una
obbligazione, viene riformata una sentenza, abrogata una legge…)
L’uomo può solo mancare di riconoscere, nei suoi ulteriori comportamenti, che questo sia avvenuto:
pertanto in questi casi si può parlare di effettività e non effettività della norma solo in questo senso
indiretto, dicendo che la norma è effettiva se i suoi effetti sono riconosciuti in ulteriori
comportamenti giuridici.
Se non è facile appurare l’effettività di una singola norma è ancor più difficile appurare l’effettività
del diritto nel suo complesso: essa potrà essere valutata solo attraverso l’effettività delle sue
norme. Ma norme differenti possono avere livelli di effettività molto differenti (e come stabilire se
una grande effettività di alcune norme possa supplire ad una scarsa effettività di altre? Oppure, quali
sono le norme di maggiore importanza la cui effettività è maggiormente rilevante?)
Il problema di determinare che cosa si intenda per effettività di un sistema normativo è complicato
dalla presenza di norme che vertono su altre norme (o meta-norme): queste possono avere
un’effettività sia diretta che indiretta: quanto alla prima esse regolano il comportamento degli
organi normativi; quanto alla seconda esse sono eventualmente effettive tramite le norme oggetto: i
regolamenti parlamentari sono effettivi, come parti di un ordinamento giuridico, sia in base
all’osservanza diretta dei medesimi, sia in base all’osservanza indiretta delle leggi emanate dal
parlamento.
È evidente che questi due tipi di effettività possono configgere: una norma procedurale può avere
grande effettività diretta (viene osservata dagli organi normativi) e poca effettività indiretta (la
gente non osserva le leggi).
È ovvio che tutte queste definizioni diventano altamente problematiche se non si è in grado di
chiarire la nozione di effettività di un diritto o ordinamento nel suo complesso.
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
Infine, viene ritenuto utile distinguere tra EFFETTIVITÀ e EFFICACIA del diritto e delle norme: per
efficacia in questi casi si intende la capacità delle norme di raggiungere il proprio fine.
Il fatto che una norma venga osservata nelle condizioni previste, cioè sia effettiva, non assicura in
questo caso il risultato: una norma può essere estremamente effettiva, ma se è inadeguata non
raggiunge comunque il fine che si è proposta (es. norme penali che pur venendo effettivamente
applicate in modo non hanno effetti sul piano della prevenzione sociale perché non diminuiscono i
reati).
Comunque l’efficacia di una norma si riconnette alla distinzione tra norme primarie e secondarie:
una norma è in questo senso secondaria proprio perché il suo fine non è realizzato dalla sua
effettività: nel caso delle norme penali il fine non è solitamente di punire i malfattori, ma di evitare
che i malfattori ci siano; le norme aspirano chiaramente ad essere efficaci e non solo effettive.
In particolari settori del nostro diritto si usa talora “efficacia” in un senso assai diverso: si parla di
EFFICACIA GIURIDICA di atti e fatti per intendere la loro capacità di far dipendere effetti giuridici.
Un contratto è efficace se ha le caratteristiche da cui il diritto fa dipendere i tipici effetti giuridici
dell’atto o perlomeno alcuni di essi.
Queste qualificazioni saranno alla fine rilevanti per dirigere comportamenti in quanto costituiscano
parte del complesso di condizioni di applicazione di una normagiuridica.
A questo punto sarà possibile vedere se le norme rilevanti sono o non sono efficaci e/o effettive. È
evidente che questa nozione di efficacia giuridica non ha molto a che fare con l’effettività o
efficacia delle norme giuridiche nei sensi sopra precisati.
8. SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
La SOCIOLOGIA DEL DIRITTO è lo studio con metodo sociologico dei fenomeni giuridici: questa
definizione rimanda, ovviamente, ad alcune delle più complesse discussioni della filosofia
contemporanea, riguardanti la natura della sociologia e la possibilità di spiegare con metodo
scientifico i fenomeni sociali.
Si discute se il metodo delle scienze umane sia diverso dal metodo delle scienze naturali
contemporanee: si discute se le varie scienze umane (storia, sociologia) seguano lo stesso metodo.
Si discute perciò se la sociologia sia una SCIENZA CAUSALE, o non debba piuttosto essere
considerata una scienza dei significati (SCIENZA COMPRENDENTE); se la sociologia debba essere
considerata una SCIENZA INDIVIDUALIZZANTE, simile alla storia nel limitarsi a descrivere
l’irripetibile svolgersi degli eventi singoli, piuttosto che spiegarli connettendoli in affermazioni
(LEGGI) generali e universali: dunque il problema è se esistano e siano individuabili leggi
sociologiche simili alle leggi individuate dalle scienze fisiche.
Una fondamentale distinzione tra i diversi tipi di sociologia (che si riproduce anche in sociologia
del diritto) è quella tra SOCIOLOGIE GLOBALI e SOCIOLOGIE EMPIRICHE (o ANALITICHE):
- Le sociologie globali cercano di produrre una visione complessiva della società e in specie
del posto del diritto nella società (può rientrarvi ad esempio la concezione marxiana del
diritto, come un elemento della sovrastruttura in una società di classe); concezioni di questo
genere (che per alcuni sarebbero filosofia sotto un altro nome) hanno come difetta la
difficoltà o l’impossibilità di confermare le loro affermazioni generalissime sulla base di
specifiche osservazioni empiriche.
- Le sociologie empiriche si occupano di descrivere specifici e particolari fatti giuridici e
sociali; di individuare e verificare empiricamente i caratteri di particolari fenomeno giuridici
e le loro relazioni con altri fenomeni (es. la misura dell’osservanza di una norma giuridica):
le ricerche di questo genere avvengono con modalità tipiche della sociologia empirica:
indagini sul campo e rilevazioni empiriche perlopiù da elaborare con metodi dell’analisi
statistica. I problemi di questo tipo di sociologia sono da una parte la difficoltà di ottenere
dati e rilevare correlazioni in una materia così complessa, dall’altra la necessità, anche per
una sociologia strettamente empirica, di avere alle spalle una qualche teoria generale del
diritto e della società, sia pure in forma provvisoria ed elastica.
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
Un altro punto essenziale e assai discusso dai sociologi è la natura avalutativa o meno della
disciplina: le sociologie empiriche aspirano all’avalutatività; parecchie sociologie globali
sostengono che tale avalutatività non è né possibile né desiderabile.
Secondo la concezione del diritto proposta da Hans Kelsen, la descrizione del diritto tipica della
giurisprudenza dovrebbe collocarsi in una posizione intermedia tra la sociologia del diritto e la
politica del diritto. la sociologia del diritto, nella concezione giuspositivista e normativisti
kelseniana, dovrebbe occuparsi del diritto, cioè delle norme giuridiche, in quanto queste sono causa
ed effetto di fenomeni sociali: si noti che Kelsen presuppone, tra l’altro, che la sociologia debba
essere una scienza causale. La sociologia si occuperebbe con metodo diverso dello stesso oggetto di
cui si opera la giurisprudenza: il diritto e i suoi istituti, che verrebbe studiato con un metodo
empirico-causale dalla prima, con metodo normativo dalla seconda.
Il problema più grave di questa distinzione tra sociologia del diritto e scienza del diritto
(giurisprudenza) è che per il giuspositivismo anche la scienza del diritto ha un legame con la realtà
sociale: il diritto studiato deve essere il diritto positivo, cioè un insieme di norme nel complesso
effettive (non è una distinzione da poco: se la scienza giuridica vi rinunciasse non sarebbe più in
grado di distinguere il diritto in vigore da quello estinto o anche solo immaginato – si pensi al
diritto naturale dei giusnaturalisti).
La distinzione fra sociologia del diritto e scienza del diritto è ancora più urgente per chi crede che la
sociologia non possa essere scienza causale, ma debba essere una scienza comprendente
(descrizione dei significati degli eventi sociali). In questo caso oltre all’identità di oggetto sopra
menzionata si avrebbe anche difficoltà ad individuare un metodo differente per le due discipline:
non è un caso che alcuni teorici del diritto abbiano negato che non esistano differenze di metodo e
sostenuto che la giurisprudenza va ricondotta ad uno studio del diritto di tipo sociologico.
Non bisogna tuttavia dimenticare che il “sociologismo” di almeno una parte del realismo giuridico è
altamente prescrittivo, e lungi dal condurre veramente i giuristi verso una sociologia del diritto
empirica prescrive piuttosto una modifica delle fonti del diritto (suggerisce infatti, prescrittivamente
e valutativamente, che queste non si debbano limitare alle fonti statali, ma che vengano considerate
diritto tutte le norme sociali – usi – consolidate).
È stato spesso sostenuto che la differenza tra giurisprudenza normativa e sociologia del diritto è
quella tra una disciplina funzionale e una disciplina strutturale: ciò rimanda a divergenze
grandissime fra gli stessi sociologi, circa i concetti di funzione e di struttura. Certamente il concetto
di funzione è di grande importanza in sociologia come in molte teorie sociologiche del diritto.
tuttavia da una parte esso non è affatto esclusivo della sociologià né sconosciuto alla
giurisprudenza; dall’altra è stato sostenuto che non è possibile in realtà contrapporre i concetti di
funzione e struttura, poiché inestricabilmente collegati.
Una struttura infatti è un insieme di “parti” che sono caratterizzate dal fatto di svolgere funzioni
nella struttura; e viceversa si può ritenere che le funzioni di un sistema o delle sue parti risalgano
alla sua struttura, ai rapporti e natura delle sue parti funzionanti.
GIUSTIFICAZIONE DELLA PENA
1.NOZIONE E PROBLEMI
La PENA può essere definita come una sofferenza inflitta intenzionalmente per la trasgressione
di norme giuridiche (reato), di solito all’autore della trasgressione (reo), da un’autorità a ciò
preposta dall’ordinamento giuridico la cui norma è stata violata. Dunque la pena è una specie
del genere “sanzione”.
(Alcuni concezioni, come quella kelseniana, pongono questa nozione al centro della propria
definizione del concetto di diritto: nella teoria kelseniana la norma giuridica è concepita come un
giudizio ipotetico che imputa una sanzione, di stampo sostanzialmente penalistico, ad un illecito. )
La pena è una sofferenza inflitta coattivamente ad esseri umani, perlopiù in base a norme generali
e astratte: pertanto essa deve rispondere a dei criteri generali, così da essere sofferenza
indipendentemente dalle particolarità individuali.
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
La pena giuridica consisterà pertanto perlopiù nella privazione di beni primari:
- Nella inflizione di dolori o danni corporali
- Nella privazione temporanea o definitiva della libertà personale
- Nella privazione di un bene di carattere patrimoniale
- Nella privazione della vita, in quegli ordinamenti giuridici che prevedono la pena di
morte.
Nella nostra società hanno larga prevalenza le pene detentive, sia perché considerazioni umanitarie
fanno oggi scartare le pene corporali e capitali, sia perché il tempo della propria vita è considerato il
bene riguardo al quale gli uomini sono relativamente più uguali.
Larga diffusione hanno pure le pene pecuniarie, pure largamente usate, ma considerate non a torto
profondamente ingiuste: infatti, esse colpiscono diversamente gli individui a seconda della capacità
economica.
Il problema della giustificazione della pena è assai antico, ma assume un valenza particolare
nella società contemporanea, propensa a considerare l’infliggere sofferenza come un qualcosa
di sbagliato: pertanto è necessaria una giustificazione morale del perché l’apparato dello stato
infligga intenzionalmente una sofferenza.
Negli ordinamenti contemporanei il cui diritto penale si ispira al principio di stretta legalità, l’atto di
esecuzione trova la sua motivazione in una sentenza con la quale si irroga, sentenza a sua volta
giustificata dalle norme della legge penale di cui è applicazione. Tali norme devono esse stesse
trovare giustificazione, e questa giustificazione non può essere trovata nel diritto penale vigente,
giacché anche quest’ultimo necessita di essere giustificato.
Infatti, il fatto che il diritto penale abbia certe caratteristiche non costituisce argomento sufficiente
per la sua valutazione come giusto o ingiusto, almeno per chi accetta il principio fondamentale della
intransitabilità dalle descrizioni alle prescrizioni, ossia la Grande Divisione tra essere e dover
essere.
Pertanto occorre trovare una giustificazione alla sofferenza prodotta dalla sanzione penale:
questo è il problema fondamentale delle cosiddette Teorie della Pena. Questo compito viene
talora riassunto, assai riduttivamente, nella domanda “perché punire?”; va però ricordato che le
Teorie della Pena (così come le Teorie della Giustizia, di cui rappresentano un settore), non sono
discorsi scientifici o conoscitivi (quindi empirici): esse sono viceversa discorsi di etica normativa
(quindi razionalistici).
Una Teoria della Pena è una complessa argomentazione di carattere etico-politico, dunque
direttivo, circa le ragioni che consentono di giustificare le norme che prevedono l’imposizione
di punizioni e le condotte che le infliggono. Essa non risponde alla domanda “perché, di fatto, si
punisce?” o “perché i diritti penali hanno le caratteristiche che hanno?”; bensì alla domanda “in
quali circostanze ed entro quali limiti è moralmente giustificato infliggere pene?”.
2. TEORIE DELLA PENA
Il problema della giustificazione della pena è dunque il problema di indicare le ragioni che
rendono giusta la pratica di inflizione delle pene. La domanda “perché punire?” comprende varie
questioni: la determinazione delle condotte da punire e dunque dei comportamenti da proibire; la
determinazione dei soggetti ai quali applicare le pene; la determinazione delle procedure richieste
per l’irrogazione delle pene; la determinazione della natura ed entità delle pene medesime.
Tutti questi quesiti possono essere sintetizzati in questa formula: “se e come proibire, giudicare e
punire”.
Tradizionalmente si ritiene possibile rispondere a tutte queste varie domande adducendo un
principio finale giustificativo unico, che possa dar ragione di tutti questi vari aspetti della pratica
penale utilizzando un’unica, coerente idea giustificativa a seconda del principio finale giustificativo
adottato si è soliti dividere le teorie della pena in due grandi gruppi, spesso trattati come antitetici
e mutuamente esclusivi:
- Il gruppo delle teorie della pena che guardano indietro, o ASSOLUTE, che giustificano la pena
in base alle caratteristiche dell’evento passato, cioè il reato.
-
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
Il gruppo delle teorie che guardano avanti, o RELATIVE, che cioè giustificano la pena in base
alle sue conseguenze.
2.1. TEORIE RETRIBUTIVE
È considerata esempio paradigmatico delle teorie che guardano indietro la TEORIA DELLA
RETRIBUZIONE: essa tratta la pena come fine a se stessa, in quanto corrispettivo del reato
commesso. La pena dunque non è vista come un mezzo giustificabile in vista delle sue conseguenze
positive, bensì essa stessa come un fine, che trae giustificazione nel principio di “rendere male per
male”: al male del reato deve seguire il male della punizione.
Formulata in questo modo la teoria non è però autosufficiente, in quanto non spiega ancora quali
comportamenti retribuire con pene e dunque considerare reati. Rispondono a queste domande la
Teoria della retribuzione morale e la Teoria della retribuzione giuridica, che sono le due varianti
principali dell’idea di retribuzione.
La TEORIA DELLA RETRIBUZIONE MORALE vede il reato come violazione dell’ordine etico
compiuta volontariamente da un soggetto: essa dunque avanza l’esigenza di punire i
comportamenti moralmente malvagi per ripristinare l’ordine etico violato.
La TEORIA DELLA RETRIBUZIONE GIURIDICA vede il reato come una ribellione della volontà
individuale contro quella della legge, e tratta la pena come la riaffermazione dell’ordine
giuridico violato. Questa teoria va interpretata come un versione della retribuzione morale che
sostiene la bontà morale del diritto positivo, e quindi la doverosa punizione delle violazioni delle
sue norme.
È in genere considerato principale sostenitore della Teoria della retribuzione giuridica il filosofo
G.W.F. Hegel.
Il nostro caro Hegel ritiene che la pena sia necessaria per annullare la negazione del diritto
prodotta dal reato; essa è la negazione di questa negazione, e come tale ripristina il diritto
violato e realizza pertanto la vera libertà anche per il reo. È doveroso ricordare che Hegel
intende la libertà come libertà di obbedire alla volontà della legge, manifestazione della volontà
dello Spirito Assoluto: è una libertà intesa evidentemente di tutt’altro senso che non la libertà
ordinaria e di senso comune.
L’idea di retribuzione ha assunto storicamente infinte formulazioni e varianti: oltre alle due
principali è importante ricordare la cosiddetta TEORIA DENUNCIATORIA, in base alla quale la pena
ha la funzione di dare il suggello all’indignazione morale nei confronti dei delitti, sotto forma di
denuncia solenne e autorevole della malvagità morale del reato da parte della comunità, di cui
dunque rafforzerebbe la coesione.
L’adozione dell’idea di retribuzione come principio giustificativo porta con sé alcuni importanti
limiti morali alla pena: in primo luogo può essere punito solo il trasgressore (quindi non è ammessa
la responsabilità indiretto o collettiva); in secondo luogo la violazione deve presupporre la colpa o
la responsabilità (quindi sono immuni soggetti incapaci o che abbiano agito in presenza di
condizioni scusanti, e non è ammessa la responsabilità oggettiva neppure per fatto proprio; in terzo
luogo è necessaria una certa proporzione tra pena e reato (:la severità della pena non può eccedere
la gravità del reato).
L’idea retributivista si connette dunque ad una serie di limiti negativi al potere punitivo dello
stato a tutela della libertà individuale: questi limiti possono essere condivisi, e di fatto è
storicamente accaduto, anche da teorie di carattere non retributivista.
La critica principale al retributivismo fa leva sul carattere metafisico dell’idea per cui la
giustapposizione del male della pena al male del reato possa dar luogo a un bene morale:
l’idea che un nuovo male possa disfare il male compiuto sarebbe per i critici soltanto un
travestimento ipocrita o illusorio del primigenio sentimento di vendetta.
Ma la critica più incisiva è quella che tende a sottolineare come la retribuzione (come
giustificazione esclusiva e totalizzante della pena) non rappresenti affatto un valore finale,
dato che deve presupporre necessariamente dei valori di livello superiore che specifichino perché è
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
moralmente giustificato punire, e quali condotte è giustificato punire. Il retributivismo non dà
affatto una risposta esauriente al quesito “se e come proibire, giudicare e punire”.
A meno che la pena sia dotata di valore morale intrinseco (cosa che, ovviamente, i critici del
retributivismo non accettano), ci si può chiedere perché scegliere questa via e non, ad esempio,
quella del perdono.
Infine, si è osservato che l’idea di retribuzione può essere coerentemente sostenuta solo nel quadro
di una metafisica indeterminista: il determinismo infatti, considerando ogni azione umana non
come scelta, ma come il risultato di una concatenazione causale determinata appunto da cause
interne o ambientali, esclude la volontà del singolo, e quindi il presupposto che alla violazione del
diritto si possa additare la colpa o la responsabilità.
Se fosse provato che gli individui non possono agire per libero arbitrio, si potrebbe al più
considerare la pena in vista delle conseguenze future che potrebbe generare, ma non come
reazione al reato moralmente giustificata.
(La posizione determinista in morale fornisce peraltro, a chi la adotti, un argomento radicalmente
distruttivo contro qualunque teoria della pena, e non solo contro quella retributiva).
È probabile che l’alternativa tra determinismo e in determinismo non sia risolvibile se non con una
scelta metafisica, una scelta ultimativa fra due visioni dell’uomo radicalmente opposte: in base alla
visione determinista l’uomo non può essere considerato altro che organismo, e come tale
casualmente determinato; in base alla visione indeterminista l’uomo dovrebbe essere considerato,
oltre che come organismo, anche come persona.
Va comunque ricordato che il determinismo, considerato fino al secolo scorso il fondamento
filosofico delle moderne scienze della natura, è stato messo in crisi, all’inizio del secolo, proprio sul
terreno di una scienza della natura come la fisica (a partire dal PRINCIPIO DI INDETERMINAZIONE DI
HEISENBERG).
2.2. TEORIE PREVENTIVE
Alle teorie delle pena che guardano indietro vengono tradizionalmente contrapposte le teorie che
guardano avanti: questo secondo gruppo di teorie è unificato dal riferimento all’idea di
prevenzione.
La pena, per le Teorie preventive, è giustificata in base alle sue conseguenze positive, ossia per
la sua idoneità a prevenire (ovvero a dissuadere dal compiere il reato) mediante timore la
commissione di reati.
Formulate in questo modo, le teorie preventive non forniscono neppure esse una giustificazione
autosufficiente, in quanto non chiariscono la ragione per cui si deve prevenire e non indicano quali
azioni prevenire.
Non sono dunque autonome né quanto ai mezzi, né quanto ai fini: quanto ai mezzi perché la
prevenzione può avvenire con la dissuasione, con la rieducazione o con altri mezzi; quanto ai fini
perché rimane da determinare che cosa prevenire
In genere l’idea di prevenzione viene completata con l’affermazione che la pena ha la funzione
di prevenire danni sociali tramite la punizione delle azioni socialmente dannose. È una teoria
di stampo utilitaristico.
Le varianti all’interno delle teorie preventive sono molto numerose, e possono essere raggruppate in
relazione al modo in cui viene configurato l’effetto preventivo:
Abbiamo innanzitutto le TEORIE DELLA PREVENZIONE GENERALE, che fanno risiedere l’effetto
preventivo nella minaccia della pena contenuta nella legge penale. Tali teorie hanno natura
GARANTISTA perché si ispirano ai principi di legalità e di certezza del diritto e postulano di solito la
necessità della responsabilità personale. Tuttavia esse sono teorie incomplete, perché non dicono
che cosa vada punito, e quindi non giustificano le proibizioni medesime. Inoltre l’idea della
prevenzione generale, qualora non sia limitata da altre considerazioni, può condurre ad ammettere
la massima asprezza punitiva, fino alla pena di morte per tutti i reati affinché la minaccia possa
sortire l’effetto desiderato.
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
1) Un secondo gruppo di teorie connette l’effetto positivo alla dissuasione generale prodotta
dall’applicazione concreta delle pene. Queste TEORIE DELLA PENA COME ESEMPIO, presentano
l’inconveniente di giustificare appunto le cosiddette “pene esemplari”, sproporzionate rispetto
alla gravità del reato commesso, e incuranti dell’effettiva colpevolezza del trasgressore (o
addirittura inflitte consapevolmente all’innocente), qualora i vantaggi sociali (in termini di
dissuasione dai reati) così conseguiti siano superiori alle sofferenze prodotte dal soggetto
sottoposto a pena. In breve, il difetto di queste concezioni è di ammettere l’uso degli
individui come mezzi per conseguire fini sociali, per quanto desiderabili e lodevoli tali fini
possano essere.
2) Un terzo gruppo è rappresentato dalle TEORIE DELLA PREVENZIONE SPECIALE: queste teorie
attribuiscono alla pena una funzione di prevenzione di ulteriori delitti commessi dal reo
cui la pena è inflitta. Questo filone ha una variante per così dire POSITIVA, che mira alla
rieducazione del reo, ed una variante NEGATIVA, che fa leva sulla sua neutralizzazione o
incapacitazione. Siffatte concezioni si concentrano sulla persona del reo piuttosto che sul reato
e sull’applicazione concreta della pena piuttosto che sulla sua formulazione astratta: l’idea di
prevenzione speciale ha come necessaria conseguenza l’adattamento della pena alle
caratteristiche del reo in questione, il che comporta vari rischi (innanzitutto la concessione di
una discrezionalità potenzialmente illimitata agli organi dell’applicazione, col rischio di mettere
in pericolo il principio di legalità, oltre a condurre ad una violazione dello stesso principio di
uguaglianza).
In quest’ultimo gruppo di teorie, note anche come TEORIE DELLA DIFESA SOCIALE, la nozione
di pena tende a mutare in quella di intervento differenziato sui singoli rei, finalizzato alla
manipolazione della loro personalità tramite rieducazione o alla loro neutralizzazione mediante
trattamento medico: vengono meno numerosi presupposti della pena, come la colpevolezza
(sostituita dalla pericolosità sociale) e la predeterminazione della durata (la pena dura finché
non viene meno l’esigenza terapeutica).
Un filone importante delle teorie di prevenzione speciale è costituito dalle TEORIE DI EMENDA O
RIEDUCAZIONE, in parte accolte anche nella nostra costituzione. Neppure queste teorie sono
giustificazioni autosufficienti della pena, richiedendo di essere integrate da una spiegazione e
dimostrazione di quando e perché tale rieducazione e correzione sia richiesta. Ma la critica più
grave alla teoria dell’emenda è che essa ha una portata fortemente autoritaria e illiberale, giacché
tratta il reo come soggetto da redimere moralmente, ammette la manipolazione della sua personalità
e viola perciò una libertà fondamentale dello Stato di diritto: la libertà, non certo di delinquere,
ma di formare e mantenere le proprie idee ed opinioni, sia pure immorali o antisociali. Infine suona
strano sostenere che si punisce al fine di rieducare i trasgressori, anziché per evitare che tutti, e non
solo i trasgressori, commettano reati. Con le teorie della pena come rieducazione e trattamento ci
troviamo ai confini del problema della giustificazione della pena: ci troviamo di fronte a un sistema
di IGIENE SOCIALE, in cui la difesa della società contro il crimine va condotta esclusivamente
secondo schemi terapeutici. Ciò porta a dover rinunciare ad alcuni concetti e principi cardine dei
diritti penali moderni: concetti quali colpevolezza e responsabilità personale; può diventare
irrilevante addirittura il fatto che il soggetto sia proprio l’autore del reato.
Questa versione estrema delle teorie rieducative è in genere sorretta da una metafisica
determinista.
Se l’individuo è determinato nelle sue scelte, non solo è moralmente iniqua la retribuzione, ma cade
anche il concetto di dissuasione: occorrerebbe perciò sostituire completamente la pena con il
trattamento curativo.
(Si può obbiettare però che anche il timore della pena può concorrere a determinare il
comportamento del reo).
In ogni caso, in una prospettiva determinista, la questione della giustizia non riguarderà tanto la
responsabilità morale del singolo, quanto la scelta dei fini sociali e dei mezzi con cui realizzarli.
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
3. TEORIE DELLA PENA SEMPLICI E COMPLESSE
Si è visto che i due principi giustificativi fondamentali esaminati, retribuzione e prevenzione,
si prestano a critiche di vario genere: se assunti come principi morali esclusivi giustificanti
essi possono dar luogo a conseguenze in contrasto con considerazioni morali generalmente
diffuse e radicate.
Quanto alle teorie retributive, agli occhi della morale comune appare aberrante concepire le
punizioni come dovere morale anche laddove non danno luogo ad effetti positivi. Quanto alle teorie
preventive, appare aberrante che esse che queste giungano a giustificare pratiche penali quali la
punizione dell’innocente, la pena esemplare, l’imposizione coattiva di valori morali, la
manipolazione della personalità del reo.
Inoltre è stato sottolineato che né la retribuzione né la prevenzione indichino dei principi
giustificativi autosufficienti: esse indicano valori strumentali che possono servire a perseguire fini
ultimi anche distanti tra loro.
Un aspetto di questa considerazione è che spesso i due concetti della retribuzione e della
prevenzione si mescolano dando luogo a teorie della pena miste, che fanno leva su ambedue gli
aspetti, cercando di evitare gli inconvenienti dell’adozione unilaterale dell’uno o dell’altro.
Abbiamo dunque TEORIE DELLA PENA COMPLESSE, che cercano di giustificare la pena adducendo
una pluralità di principi giustificativi, anziché uno solo. Le più interessanti e nuove teorie della pena
sono quelle che cercano di addurre principi giustificativi diversi in rapporto ai diversi problemi che
la pratica penale solleva: non si tratta di teorie sincretiste (che cercano di comporre valori diversi tra
loro), ma di teorie che trattano autonomamente i singoli aspetti del problema della giustificazione
della pena, affrontando ciascuno di essi a suo modo.
In quest’ordine di idee il filosofo inglese H.L.A. Hart ha notato che il problema della
giustificazione della pena nasconde in realtà due problemi distinti: il problema dello scopo
generale giustificante (“perché punire?”) e il problema della distribuzione della pena (“chi e in
quale misura deve essere punito?”).
Hart sostiene che tali problemi necessitino di principi giustificativi differenti, per formulare una
teoria della pena che non sia troppo in conflitto né con la morale comune, né con i principi accolti
dai sistemi penali attuali.
Secondo Hart il problema dello scopo generale giustificante va risolto ispirandosi all’idea di
prevenzione, il problema della distribuzione della pena va risolto secondo l’idea di
retribuzione: bisogna pertanto punire per prevenire il danno sociale, ma bisogna punire soltanto i
trasgressori per la loro trasgressione (compiuta in certe condizioni mentali).
L’idea centrale è quella di una sostanziale autonomia del principio preventivo di
giustificazione della pena dal principio retributivo di distribuzione della sanzione penale: ciò
permette di tutelare valori ulteriori rispetto alla scelta di uno dei due sistemi preso singolarmente.
Il principio che esige di punire solo l’autore del reato, che abbia agito in determinate condizioni
mentali (di non incapacità di intendere e volere ecc.), potrebbe essere giustificato dalla
considerazione che solo in questo caso viene riconosciuto un valore alla libera scelta degli individui
di violare o no il diritto; inoltre il fatto che i trasgressori siano solo puniti, e non anche rieducati,
testimonia che essi vengono trattati da persone moralmente responsabili. In questo quadro acquista
plausibilità la tesi hegeliana relativa al diritto del reo di essere punito, inteso come diritto di essere
solamente punito, e non sottoposto anche ad un trattamento rieducativo.
La difficoltà delle teorie della pena complesse, come quella di Hart, deriva dal fatto che i
valori e i principi diversi che esse assumono possono entrare in conflitto reciproco: va pertanto
affrontato il problema del loro coordinamento in un sistema coerente e dei limiti di tollerabilità del
sacrificio, che spesso si renderà necessario, di alcuni di questi valori in favore di altri.
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
INTERPRETAZIONE
1. NOZIONE E PROBLEMI
L’INTERPRETAZIONE in generale è perlopiù intesa come l’attività di accertamento del
significato degli enunciati linguistici e anche come il risultato di tale attività; c’è però chi
accoglie una definizione più ampia, comprendo anche interpretazione di cose differenti dai
linguaggi (di un comportamento, dei sogni ecc.).
In teoria del diritto una simile nozione lata di interpretazione tende ad accompagnarsi a concezioni
aperte del diritto, che annoverano fra i fenomeni giuridici anche la realtà sociale, i valori, i
costumi ecc.
Nel diritto dunque interpretazione è il procedimento di determinazione del contenuto
prescrittivo del diritto: essa è intesa come l’identificazione delle norme giuridiche, cioè del
significato degli enunciati normativi giuridici. Questa nozione presuppone che il diritto sia
composto di norme intese come significati, che vadano ricavati da specifici ed individuabili
enunciati: l’interpretazione delle norme giuridiche può essere generalmente dottrinale o giudiziaria.
Sia parla di INTERPRETAZIONE DOTTRINALE in riferimento agli studiosi di diritto non dotati di
particolare autorità giuridica; si parla di INTERPRETAZIONE GIUDIZIARIA in riferimento ai giudici
nell’applicazione del diritto. (Tuttavia, nella storia del diritto, si è assistito a casi di interpretazione
che non rientrano in questi: ad esempio culture in cui la funzione legislativa, amministrativa e
giudiziaria non sono distinguibili, come nel caso di un legislatore che è anche applicatore delle
norme).
2. PROBLEMI SEMIOTICI DELL’INTERPRETAZIONE
Una teoria della interpretazione giuridica dovrà prima di tutto distinguere tra gli aspetti che il
linguaggio giuridico ha in comune con ogni altro linguaggio o discorso, e gli aspetti specifici del
linguaggio giuridico.
2.1. DUE TEORIE ESTREME DELL’INTERPRETAZIONE
Lo stesso enunciato normativo può avere più di un significato (ambiguità) o un significato incerto
(vaghezza); inoltre, enunciato differenti possono avere lo stesso significato (in tal caso si dicono
sinonimi): questi fatti elementari sono però alla base delle maggiori difficoltà per la teoria e la
pratica dell’interpretazione giuridica.
Il problema teorico e pratico è il seguente: mentre gli enunciati giuridici sembrano facilmente
individuabili mediante lo studio empirico delle espressioni linguistiche considerate giuridiche, i loro
significati sembrano variabili, inafferrabili e privati, cose esistenti solo nella mente degli interpreti.
Sullo sfondo della maggior parte delle teorie contemporanee dell’interpretazione c’è dunque
l’assunto che individuare gli enunciati giuridici sia molto più facile che individuare i loro
significati: questo fatto è giustificato per il diritto moderno per la facilità di reperire empiricamente
le norme grazie ad archivi e codificazioni, ma non perché il ritrovamento degli enunciati giuridici
(disposizioni giuridiche) sia un’operazione unicamente empirica: infatti nessun enunciato, in
nessuna lingua o discorso, può essere individuato senza l’applicazione e l’interpretazione delle
principali regole semiotiche rilevanti (senza cioè attribuire dei significati ai vari segni che
compongono l’enunciato).
Per quanto riguarda l’individuazione degli enunciati che costituiscono disposizioni giuridiche, sarà
inoltre necessario interpretare le regole che individuano come tali le altre norme giuridiche,
comunemente dette fonti del diritto: sono le specifiche caratteristiche del diritto contemporaneo
occidentale a rendere relativamente semplice l’operazione di individuazione degli enunciati
giuridici, perché le norme sulle fonti del diritto hanno in questo diritto raggiunto un grado di grande
precisione e obbiettività (per contro, si pensi alla situazione del Diritto Romano prima
dell’operazione di riordino avvenuta sotto l’impero di Giustiniano).
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
Alcune teorie dell’interpretazione giuridica si fondano sull’idea estrema che ogni individuazione di
significato sia in realtà una creazione di significato. Secondo questa tesi, detta dello SCETTICISMO
INTERPRETATIVO, nulla assicura che persone diverse diano lo stesso significato allo stesso
enunciato normativo; anzi, la versione più estrema sostiene che tale concordia non possa mai
realizzarsi, almeno in materie complesse come il diritto.
Un simile scetticismo è l’idea centrale di alcune concezioni del diritto, quali alcune forme di
realismo giuridico.
Nel diritto questo scetticismo linguistico ha comunque il merito di aver efficacemente criticato il
cosiddetto FORMALISMO INTERPRETATIVO, teoria antitetica, che sostiene che sia possibile trovare
l’interpretazione giusta o propria di ciascun enunciato giuridico, adatta a risolvere in modo
giuridicamente esatto ciascun caso concreto.
Tuttavia anche lo scetticismo interpretativo è criticabile come teoria unilaterale dell’interpretazione,
specie nelle sue versione estreme: in primo luogo perché esso ripone un’eccessiva fiducia nella
possibilità di individuare empiricamente (senza interpretarli) indipendentemente dal loro significato
(la semiotica contemporanea ha mostra che un enunciato, senza un’interpretazione minima del suo
significato, non è nemmeno individuabile); in secondo luogo perché si può ritenere che tutte le
espressioni linguistiche, quindi anche gli enunciati giuridici, abbiano normalmente un nucleo certo
di significato, che l’interprete comprende e può descrivere, a cui si accompagnano sempre aree di
vaghezza e incertezza, riguardo alle quali egli opera le sue scelte interpretative.
Ciò che le norme non riescono a predeterminare viene comunemente chiamato area di
discrezionalità che il diritto lascia e non può evitare di lasciare a chi lo interpreta.
2.2. PROBLEMI SINTATTICI E SEMANTICI DI INTERPRETAZIONE
I problemi di significato degli enunciati giuridici possono essere affrontati solo risolvendone i
problemi sintattici: si tratta che di problemi che il nostro legislatore, nell’art. 12 delle Disposizioni
preliminari a Codice Civile, chiama di “connessione delle parole”; se diamo di sintassi una
nozione ampia, comprendente anche la logica, vi rientreranno anche problemi logici di
coordinamento delle norme tra loro.
Tra i primi problemi spiccano le difficoltà di accertamento della natura sintattica degli enunciati
(in enunciati spesso assai complessi e poco curati dal punto di vista sintattico-grammaticale). Tra i
secondi è importante soprattutto il problema delle antinomie, cioè l’incompatibilità logica di alcune
norme dello stesso ordinamento.
Il problema dell’accertamento è attribuzione di significato giuridico è inoltre, come è ovvio, un
problema semantico in senso stretto: in primo luogo di attribuzione di significato ai singoli termini
del discorso giuridico (quindi di definizioni, anche se implicite nell’uso dei termini); in secondo
luogo l’interpretazione non può essere meramente lessicale, ma almeno parzialmente creativa
(assumere un termine nel suo significato lessicale può causare vaghezza e ambiguità; pertanto il
termine va interpretato in base al suo significato nell’uso ordinario).
Due altri problemi fondamentali sono tuttavia posti dall’uso particolare che fa il diritto dei termini,
utilizzandoli con significati tecnici o speciali: sapere quando ciò avviene e sapere in che misura
ciò avviene.
- Quanto al primo problema (SAPERE QUANDO CIÒ AVVIENE), bisogna tenere presente che è assai
raro che il legislatore affermi esplicitamente di far riferimento al senso ordinario del termine; e
talora non è neppure agevole capirlo in base al contesto.
Quanto al secondo problema (SAPERE IN CHE MISURA CIÒ AVVIENE), esso riguarda la necessità o
meno della recezione, insieme ai termini nel significato ordinario, anche dei valori presupposti
comunemente dal loro uso: assumere un linguaggio significa infatti assumere non solo un
dizionario, ma una enciclopedia, cioè i suoi principali presupposti culturali psicologici, teorici e
morali. Ma il diritto può anche assumere, e spesso assume, un termine nel suo significato tecnico,
che è quello che possiede in una disciplina scientifica non giuridica (medicina, psichiatria, scienza
alimentare ecc.): in questo caso ci sui chiede se l’interpretazione
-
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
debba essere compiuta da un esperto di diritto o di quella disciplina. Infine il diritto assume dei
termini in significato tecnico-giuridico, ma ciò può avvenire anche secondo una definizione
implicita nell’uso del termine: per evitare equivoci sarebbe necessario chiarire sempre il
significato con una definizione stipulativa (cioè esplicativa), ma non sempre ciò avviene.
Il sorgere di un lessico e di un linguaggio tecnico giuridico non avviene però ex novo, nel vuoto di
una costruzione artificiale o immaginata: infatti quando il diritto legislativo si allontana dal lessico
comune o della sua interpretazione ordinaria lo fa piuttosto per fare riferimento alla tradizione
giuridica e alla cultura giuridica degli specialisti, cioè dei giuristi di professione, e incorpora nel
linguaggio anche molti dei loro presupposti concettuali, piuttosto che forgiare liberamente un
sistema di concetti e termini.
Questo fenomeno ha delle istanze estreme nel caso di una cultura giuridica e di un legislatore che
osservino una lingua naturale diversa dalla lingua madre dei destinatari del diritto: si pensi all’uso
del latino nel diritto romano dell’Europa medievale; ciò ha l’effetto di staccare maggiormente il
discorso giuridico dai condizionamenti culturali della società regolata, potendo avere sia un effetto
innovativo (nel caso descritto), sia reazionario (si pensi all’uso di una forma di francese medievale
nel diritto inglese dei secoli successivi).
Da queste premesse si conclude che non è possibile dare un’interpretazione letterale dei termini
giuridici, se con questo si intende un’interpretazione che faccia riferimento al solo termine in
isolamento assoluto, perché ciò significherebbe privarlo della stessa natura di segno e quindi della
possibilità di avere un significato.
Il problema dell’analisi lessicale del significato dei termini è una delle parti fondamentali della
semiotica, ma non è la sola che sia rilevante per il diritto: non è infatti ipotizzabile che
l’interpretazione del diritto consista unicamente nel sommare le interpretazioni delle singole parole
che compongono gli enunciati giuridici.
In primo luogo, la stessa analisi del significato non può essere ridotta allo studio lessicale (i vari
termini sono portatori di una gamma di significati fra i quali la scelta dipende essenzialmente dal
contesto in cui sono posti); inoltre, anche la semantica, intesa come studio del significato in senso
stretto, gode essa stessa di una assai relativa autonomia dalle altre considerazioni semiotiche, cioè
sintattiche e pragmatiche.
Tra i problemi semantici che riguardano il significato non solamente delle singole parole, ma degli
enunciati normativi, in primo luogo deve essere affrontato risolto quello di individuare gli enunciati
normativi compiuti, in grado di regole compiutamente i casi concreti, i quali esprimono in questo
senso norme giuridiche compiute: è piuttosto evidente che questa unità non corrisponde esattamente
alla divisione più facilmente percepibile del testo giuridico, quella in singolo commi, articoli o
leggi. Cosa deve fornire una norma perché si possa dire che il suo significato è compiuto? Il senso
comune ci dice che deve poter fare da sola, cioè evitare di far riferimento ad altre norme per capire
cosa prescrive. Nel caso del diritto questo problema è però assai complesso, per via della fattissima
rete di riferimenti e rimandi su cui l’ordinamento giuridico è costruito: per esempio ogni norma di
diritto sostanziale rimanda alle norme procedurali e ogni norma di legge rimanda a quelle
costituzionali ecc.
Interpretare il diritto vuol dire dunque sempre comporre e collegare i significati rilevanti di
moltissime disposizioni giuridiche, fino a individuare la regolamentazione compiuta del caso
effettivo o ipotetico. L’interpretazione e applicazione giuridica sono dunque in effetti la
identificazione di una rete vastissima di interconnessioni di significato, rete che talora può coprire
un settore dell’intero ordinamento giuridico: spesso questa interconnessione è solamente implicita e
presupposta, ma affiora allorché sorgono dubbi e problemi.
Si comprende meglio la ragione per cui il linguaggio giuridico tende a diventare un linguaggio
comprensibile solo da specialisti e professionisti di diritto: per comprendere una norma bisogna
collocarla nelle rete di disposizioni di cui fa parte, il che è possibile unicamente per chi possiede
una preparazione giuridica generale, cioè i giuristi di professione.
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
2.3. PROBLEMI PRAGMATICI E TECNICHE INTERPRETATIVE
La distinzione fra problemi semantici e logico-sintattici è solo un artificio analitico, dal momento
che tutti i fenomeni linguistici, e quindi anche quelli giuridici, vanno considerati nella loro
interezza.
Quando si cerca di comprendere un discorso giuridico vanno affrontati insieme non solo i problemi
sintattici e semantici, ma anche quelli pragmatici dell’interpretazione: questi ultimi sono legati al
fatto che il diritto deve poter svolgere la propria funzione comunicativa, che si tratterà
principalmente di una funzione di guida dei comportamenti in certo contesti tipici o normali; la
considerazione di tali contesti è necessaria alla determinazione dei significati, perché porta
all’esclusione di quelle interpretazioni che sarebbero sì semanticamente e sintatticamente possibili,
ma pragmaticamente assurde o strane.
La prima regola pragmatica di interpretazione è il buon senso generico, che fa sì che si interpreti
l’enunciato giuridico in quanto enunciato prescrittivo sensato, che sia cioè in grado di svolgere una
qualche funzione di direzione dei comportamenti e secondo lo scopo che presumibilmente può
essere attribuito alle norme in una situazione “normale”. Per esempio, se una norma ci dice che a
diciotto anni si diviene maggiorenni, il buon senso ci porta a concludere che sotto quest’età non si
sia maggiorenni: si tratta di un significato ovvio, anche se non presente nel senso letterale
dell’enunciato.
Altre volte il buon senso generico non riesce a risolvere i problemi di interpretazione (o non lo fa in
modo soddisfacente per l’interprete): in questi casi si ricorre al buon senso giuridico, cioè il buon
senso “specializzato” del giurista che ha familiarità con le norme giuridiche ed i problemi del
diritto. i due tipi di buon senso possono configgere in molti modi: si pensi alle interpretazioni date
dal giurista che al profano sembrano troppo cavillose (il fatto stesso che si parli di cavillo significa
che il giurista, a torto o a ragione, sta ignorando le regole pragmatiche del buon senso ordinario).
I complessi e sfuggenti argomenti del buon senso generico e giuridico sono spesso sviluppati dai
giuristi in vere e proprie tipologie di argomenti interpretativi, o tecniche di interpretazione: talora
tali tecniche si limitano ad usare più sistematicamente e coerentemente argomenti pragmatici di
buon senso; ma spesso portano l’interpretazione giuridica ben al di là della portata del buon senso
comune e anche di quello dei professionisti di diritto.
I principali argomenti interpretativi sono: l’argomento della coerenza (il diritto va interpretato in
modo da renderlo il più possibile coerente); l’argomento economico (ogni norma va interpretata in
modo da essere il più possibile rilevante, quindi non inutile o identica a norme affini); l’argomento
a contrario (come nel caso del raggiungimento della maggiore età – il caso non regolato va regolato
in modo difforme da quello simile ma esplicitamente regolato); l’argomento a simili (il caso simile
va interpretato come il caso simile – vedi analogia).
Alcuni di questi argomenti sono tradizionalmente detti argomenti oggettivi, perché si concentrano
sul testo oggetto di interpretazione; altri sono detti argomenti soggettivi, perché cercano di
utilizzare le intenzioni o altre circostanze riguardanti il legislatore per giustificare
dell’interpretazione. Il problema nell’uso di queste tecniche è la mancanza di un criterio di scelta tra
di esse, e il fatto che ciascuna è suscettibile di condurre a risultati diversi e spesso diametralmente
contrastanti (si pensi agli argomenti a simili e a contrario).
Pertanto l’area in cui operano questi argomenti assai spesso rimane area di grande discrezionalità
interpretativa, salvo che non intervengano norme specifiche (cioè metanorme), norme di
interpretazione di altre norme, da non confondere con le norme sull’interpretazione, di cui si
parlerà nel paragrafo seguente.
Una norma giuridica può infatti determinare, almeno in parte, ciò che le regole linguistiche della
lingua naturale usata dal diritto non riescono a determinare, prescrivendo un’interpretazione di
determinate altre norme giuridiche (es. il termine “x” nella disposizione “y” va interpretato nel
senso di “z”).
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
Di questo (norme di interpretazione) tipo sono le cosiddette interpretazioni autentiche, che il
legislatore può dare su una norma controversa mediante una ulteriore esplicita legge. Questo
strumento è relativamente poco usato; sono invece molto più rilevanti altri tipi di norme provenienti
da organi diversi dal legislatore: consuetudini interpretative giuridicamente vincolanti, ad
esempio nella forma del precedente giudiziario; oppure l’interpretazione giuridicamente
vincolante, fornita da una autorità inferiore a ciò delegata.
2.4. NORME SULL’INTERPRETAZIONE
Il legislatore contemporaneo può essere abbastanza consapevole di questi problemi, ma i rimedi
generali che si trovano anche oggi nei vari diritti spesso sono semioticamente poco realistici e
quindi poco efficaci.
Esempio di metanorma generale sull’interpretazione delle altre norme giuridiche è l’art. 12 delle
Disposizioni sulla legge in generale del Codice Civile del 1942, che recita: «Interpretazione della
legge. Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal
significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore» la
norma prosegue indicando il ricorso all’analogia e ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
Norme di questo genere sono state tradizionalmente guardate con diffidenza da giuristi e giudici: ai
primi esse talora sembrano sconfinare sul terreno della scienza di pertinenza dello studioso e non
dell’autorità giuridica; ai secondi esse sembrano talora una limitazione eccessiva della
discrezionalità considerata opportuna per l’esercizio della funzione giurisdizionale. Vanno poi
considerate un caso intermedio fra le norme sulla interpretazione e quelli di interpretazione le
definizioni giuridiche contenute nelle norme: esse infatti dicono come si deve intendere un termine
in tutte le norme di quel diritto o almeno di un suo settore.
2.5. CASI FACILI E CASI DIFFICILI
L’indagine delle operazioni interpretative alla luce della semiotica induce a considerare
problematica la tradizionale tripartizione delle interpretazioni quanto al risultato: interpretazioni
dichiarative (chi si limiterebbero a riconoscere il significato letterale delle norme); interpretazioni
estensive (che lo amplierebbero); interpretazioni restrittive (che lo restringerebbero). Cosa è
infatti il significato letterale di un enunciato? Possiamo continuare a parlare di significato letterale
solo intendendolo come il nucleo di significato certo nel senso comune e nella interpretazione
ordinaria dei discorsi, riconoscendo però che in tal caso fa parte, un po’ paradossalmente, di questo
significato una certa dose di ambiguità e/o vaghezza. Possiamo poi attribuire all’enunciato ulteriori
e diversi e magari più precisi significati ottenuti con l’applicazione dell’una o dell’altra tecnica
interpretativa. (?)
Per avere una immagine equilibrata dei problemi dell’interpretazione giuridica bisogna ricordare
che è sempre possibile immaginare o trovare effettivamente casi che mettano in crisi l’interprete: si
tratta dei cosiddetti casi difficili, indicati spesso con l’espressione inglese HARD CASES. Tuttavia è
bene tenere presente che la maggior parte delle situazioni giuridiche rientra pacificamente nella
regolamentazione giuridica, e proprio per questo tali casi “facili” sono meno evidenti e certo meno
discussi.
È dunque possibile, sul piano semiotico, far dire a qualunque testo qualunque cosa voglia
l’interprete? Dalla risposta a questa domanda dipendono molte delle nostre fondamentali istituzioni
giuridico-politiche: coma la distinzione tra applicazione e creazione del diritto e tra i relativi organi
(e dunque la separazione dei poteri); il valore della certezza del diritto, e in definitiva la stessa
esistenza non illusoria dello Stato di diritto.
Molte concezioni della semiotica giuridica ritengono teoricamente possibile che il linguaggio
normativo possa dirigere significativamente le azioni umane, per cui data un’azione si può dire se
essa viola o meno una norma senza compiere con questo un giudizio interamente arbitrario; tuttavia
anche queste concezioni riconoscono che il margine di discrezionalità interpretativa lasciato
all’interprete dipenderà alla fin fine dal modo i cui sono formulati i testi giuridici e da una serie di
altri fattori.
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
Oggi, tutte le concezioni consapevoli della semiotica giuridica ammettono comunque la presenza
ineliminabile in tutte le disposizioni giuridiche di un margine di discrezionalità interpretativa,
maggiore o minore.
3. ANALOGIA
ANALOGIA in diritto è una particolare somiglianza di situazioni o fatti, considerata rilevante
dall’interprete; essa è alla base di una operazione chiamata “ragionamento per analogia” o
“estensione analogica” o “interpretazione analogica”. Queste diverse espressioni nascondono la
polemica fra chi ritiene che analogia ed interpretazione estensiva siano operazioni diverse tra loro, e
chi invece le assimila: in ogni caso tutte le espressioni indicano un procedimento interpretativo per
che dà regolamentazione a un caso non regolato da una norma specifica applicandovi una norma
che regola un caso ritenuto dall’interprete simile al primo. Simile viene inteso ogni caso non
regolato che abbia in comune con il primo i necessari aspetti rilevanti. L’analogia è dunque un
mezzo per colmare le LACUNE degli ordinamenti giuridici con elementi interni ad essi
(autointegrazione): per chi crede nella capacità dell’analogia di colmare le lacune diviene più
facile credere nella completezza degli ordinamenti stessi, che si otterrebbe dopo che l’interprete è
intervenuto colmandone le lacune.
Per i giuristi la somiglianza è considerata rilevante quando i due casi hanno in comune le
caratteristiche che si pensa abbiano motivato la regolamentazione giuridica del caso già regolato, gli
scopi che la norma persegue: tutto ciò si chiama comunemente RATIO LEGIS, la ragione per cui è
stata posta quella norma giuridica. La RATIO LEGIS è in altri termini il principio giuridico che sta alla
base della norma: l’analogia è dunque possibile quando per entrambi i casi vale la stessa RATIO
LEGIS.
Il problema dell’analogia è che la RATIO LEGIS è spesso incerta, poiché l’individuazione di una
RATIO LEGIS è una scelta profondamente intrisa di scelte di valore: la ratio sarebbe il fine, dunque il
valore che, secondo l’interprete, la norma dovrebbe perseguire.
Per questo indubbiamente il ricorso all’analogia lascia molta discrezionalità all’interprete e
applicatore, e per questo è vista con diffidenza dal giuspositivismo. Per la stessa ragione l’analogia
è esclusa dalla maggior parte dei diritti penali moderni (italiano compreso): l’art. 14 delle preleggi
recita: “Le leggi penali e quelle che fanno eccezione alle regole generali o ad altre leggi non si
applicano oltre i casi e i tempi considerati”.
È possibile sostenere che la ratio dei due divieti è diversa: per le leggi penali è un’estrinsecazione
del principio di stretta legalità, a tutela dei cittadini, e si collega al principio di riserva di legge
(nullum crimen sine lege), per cui la materia può essere regolata solo per legge; per le norme
eccezionali esso è stato criticato, perché non si vede la ragione per la quale non si debba applicare
l’analogia a casi che presentano la stessa ratio legis “eccezionale” di quelli regolati.
In ogni caso questo ostacolo è facilmente aggirabile con un’interpretazione estensiva, che non è
invece mai vietata.
4. LACUNE
Lacuna in diritto è la mancanza della regolamentazione di un caso concreto, che di solito si presenta
all’attenzione come caso concreto in sede di controversia giudiziaria, ma può essere anche un caso
ipotetico.
L’esistenza di lacune nel diritto è negata da varie teorie giuridiche, che sostengono che il diritto è
completo (tesi della completezza dell’ordinamento giuridico): ciò può sembrare assurdo di fronte
all’effettiva esistenza di lacune, ma in realtà questa tesi sarebbe possibile dalle cosiddette norme
generali di chiusura.
Tra queste ha particolare importanza la c.d. NORMA GENERALE ESCLUSIVA, che qualifica come
permessi tutti i comportamenti non qualificati come obbligatori o vietati dalle singole norme: tutti i
casi non regolati da norme giuridiche sarebbero dunque giuridicamente irrilevanti.
L’introduzione di una norma generale esclusiva riesce forse ad eliminare le lacune, ma non elimina
ogni problema: rimane il problema di decidere se applicare o meno l’analogia (che infatti è talora
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
chiamata NORMA GENERALE INCLUSIVA); si ha cioè non mancanza ma eccesso di norme, ovvero si
tratta di un’antinomia di 2° grado.
I sostenitori della completezza degli ordinamenti giuridici concludono che le lacune che appaiono
agli occhi dei giuristi sono lacune apparenti o LACUNE IDEOLOGICHE: esse in realtà consisterebbero
nella mancanza di una norma che l’interprete considera giusta, in una divergenza tra il diritto reale e
ciò che l’interprete considera diritto reale.
Altro fenomeno sono poi le LACUNE TECNICHE: ciò avviene quando ad esempio una norma fa
riferimento a un organo alla cui formazione il diritto non ha preveduto; per i sostenitori della
completezza dell’ordinamento qui si ha un caso in cui il legislatore si limita a una regolamentazione
generale, lasciando alla discrezionalità dell’interprete il completamento della norma: questa
discrezionalità può essere intenzionale (perché il legislatore si è avveduto dell’impossibilità o
inopportunità di regolare minutamente un comportamento), oppure non intenzionale (nel caso in cui
la mancanza di norme produce un comportamento inapplicabile e quindi insensato, come nel
succitato esempio della mancanza dell’organo previsto dalla norma).
Alcuni teorici dell’interpretazione hanno dato grande rilievo alla differenza ora accennata tra
discrezionalità intenzionale e discrezionalità non intenzionale, concesse all’interprete dalla
norma superiore: si dice che la indeterminatezza alla base della discrezionalità può essere
intenzionale quando il legislatore si è avveduto dell’impossibilità o inopportunità di regolare
minutamente un comportamento; ma può essere anche non intenzionale; quest’ultimo è un aspetto
ineliminabile e sempre presente in ogni attribuzione di significato: ogni norma giuridica comporta
una discrezionalità di questo genere. Quanto alla prima essa richiede che sia possibile appurare la
volontà del legislatore, cosa non sempre agevole. Tuttavia è palese che i moltissimi casi di delega
all’interprete e applicatori sono casi di discrezionalità intenzionali; si pensi ad esempio al diritto
amministrativo.
Le lacune cui non ritenga di applicare una norma generale di chiusura possono essere colmate con
vari procedimenti, sia di auto-integrazione sia di etero-integrazione: la scelta tra queste procedure
spesso dipende dall’adozione di una specifica concezione del diritto, ad esempio dal possibile
ricorso a qualche diritto naturale.
Va ricordato che il diritto italiano (art. 12 Disp. prel.) prevede il ricorso ai principi generali del
diritto, un mezzo interpretativo ancora più potente dell’analogia: si è discussi se tali principi
vadano considerati fra i mezzi di auto-integrazione o di etero-integrazione; la seconda tesi è
sostenuta da qualche teorico giusnaturalista e in tal caso si tratterebbe ovviamente di principi del
diritto naturale. Il testo dell’art. 12 incoraggia poco questa tesi, si parla infatti di “principi generali
dell’ordinamento giuridico”: comunque un interpretazione di parte giusnaturalistica potrebbe
includervi anche il diritto naturale, che per questa dottrina fa parte dell’ordinamento giuridico; un
giusrealista vi comprenderà invece una parte degli interessi sociali; per un legalista si limiterà
soltanto alle leggi.
Insomma, l’interpretazione in genera e la integrazione delle lacune in specie sono i luoghi cruciali
in cui spesso divergono le concezioni del diritto di giuristi contemporanei, che pure fanno
riferimento al medesimo diritto.
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
GIUSTIZIA
1. NOZIONE E PROBLEMI
GIUSTIZIA è un valore positivo che può essere riferito sia ai comportamenti e alle scelte
pratiche sia alle ragioni addotte per giustificare questi e quelle. Chiamiamo giusta una scelta o
un’azione, ma anche la loro giustificazione; inoltre chiamiamo giuste anche le persone e le
istituzioni.
Come vedremo, nel valore della giustizia è di solito compreso il valore dell’uguaglianza: giusto è il
trattamento uguale di casi uguali per gli aspetti considerati rilevanti dalla particolare concezione del
diritto che si accoglie; è altresì giusto trattare casi diseguali in modo diseguale. Anche quando
l’uguaglianza è considerata condizione necessaria alla giustizia, essa tuttavia è raramente
considerata sua condizione sufficiente: ben di rado infatti si sostiene che tutti debbano ricevere un
identico trattamento sotto ogni profilo, a prescindere da ogni differenza.
Al di là di questa approssimativa caratterizzazione iniziano le secolari discussioni sul concetto di
giustizia.
2. FORMULE DI GIUSTIZIA
La giustizia è stata efficacemente definita come la più giuridica delle virtù: tra tutte le possibili
valutazioni morali del diritto e dei vari diritti positivi, quella di giustizia è infatti certamente la
principale e onnicomprensiva.
Spesso si è ritenuto che la filosofia del diritto dovesse occuparsi essenzialmente del concetto di
giustizia; recentemente questo problema è stato etichettato come PROBLEMA ASSIOLOGICO
(fondamentale), per distinguerlo da questioni meno fondamentali considerate anch’esse di
pertinenza del filosofo del diritto.
Questa impostazione e questo modo di presentare i compiti della filosofia del diritto non sono però
affatto neutrali: esse tradiscono invece un’impostazione giusnaturalistica, che ritiene che esista un
diritto naturale, vale a dire un criterio obbiettivo di giustizia a cui il diritto positivo deve uniformarsi
per essere vero diritto.
Per il giusnaturalista è dunque possibile l’accertamento obbiettivo della giustizia di un diritto, il
che determina l’atteggiamento da tenere nei confronti del diritto spesso: il diritto giusto deve essere
sempre obbedito.
Il giusnaturalista ritiene che il problema della giustizia possa e debba essere affrontato come un
problema conoscitivo di indagine filosofica, ossia di ricerca e descrizione del vero concetto di
giustizia.
Alcuni filosofi criticano questa impostazione generale e tendono a descrivere le secolari discussioni
filosofico-giuridiche sulla giustizia come una storia di sterili dispute generate dall’illusoria
convinzione di poter cogliere l’essenza della giustizia e formularne la definizione reale; specie per i
giuspositivisti la pretesa di cogliere l’essenza della giustizia tramite una definizione è
inesorabilmente destinata al fallimento: tutte le definizioni correnti di giustizia, a partire da quelle
date dai giuristi romani (neminem ledere, unicuique suum tribuere, honeste vivere) sono formule prive
di contenuto prescrittivo per l’impossibilità di dare una giustificazione obbiettiva dei significati di
ledere, suum, honeste ecc.
Tuttavia, neppure i più accaniti critici delle formule di giustizia giungono a trattare come del tutto
inutile la ricerca di una definizione del concetto di giustizia: c’è la sensazione che vi sia qualcosa in
comune tra le varie definizioni di giustizia, un significato costante e minimo del termine “giustizia”
in tutti i suoi infiniti e mutevoli usi.
Tale sensazione viene talora precisata facendo uso dell’opposizione tra concetto e concezione: il
concetto in questo caso sarebbe il significato minimo (componente semantica imprescindibile),
mentre la concezione, o le concezioni, costituirebbero il significato eccedente, che entra in
discussione ed è storicamente variabile.
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
In questo senso l’idea o CONCETTO DI GIUSTIZIA, come già riteneva Aristotele (a Pintò, ma ne
siamo sicuri?)può essere identificato con l’idea di uguaglianza, di trattamento uguale di casi uguali,
conseguenza logica dell’applicazione di un criterio o regola generale, mentre le concezioni di
giustizia sono i criteri di uguaglianza, ossia coincidono con l’indicazione delle classi da sottoporre
ad uguale trattamento.
Intesa nel significato minimo di uguaglianza la giustizia rappresenta anche un metodo di decisione
di carattere generalizzante, una tecnica decisionale basata sull’applicazione di uno standard
generale, che si contrappone alle scelte di carattere individualizzante basate sulle peculiarità di ogni
singolo caso (vedi voce: Equità – più avanti).
Si fa dunque riferimento al significato minimo costante del termine quando si parla di giustizia
come legalità: si tratta di un valore formale e si parla di giustizia formale, desiderabile perché
comporta l’esclusione dell’arbitrio e garantisce la prevedibilità delle decisioni, un valore che può
tuttavia coesistere con l’ingiustizia delle norme.
Dunque, l’identificazione del concetto di giustizia con l’idea di uguaglianza risolve ben pochi
problemi etici, e anzi ne solleva di nuovi: in primo luogo il problema della bontà o preferibilità della
tecnica generalizzante rispetto a quella individualizzante (vedi voce: Equità – più avanti); in
secondo luogo il problema di determinare le classi di situazioni da sottoporre ad uguale trattamento,
ed è proprio su questo punto che si scontrano le varie concezioni di giustizia.
Si osservata giustamente come la tendenza dei diritti occidentali specialmente nell’ultimo secolo sia
stata quella di prendere in considerazione un numero sempre minore di differenze tra gli individui:
oggi le differenze di sesso, razza, stato civile, capacità patrimoniale sono addotte sempre meno di
frequente come motivo di una disciplina differenziata. Viceversa si è sviluppata l’abitudine di
valorizzare le differenze nei casi in cui ciò comporta un trattamento più favorevole per gli individui
portatori di caratteristiche ritenute socialmente svantaggiose.
Nasce dunque la discussione sulla cosiddetta DISCRIMINAZIONE ALLA ROVESCIA: è giusto
quell’insieme di interventi pubblici tesi a favori individui o gruppi socialmente svantaggiati
(minoranze razziali o religiose, portatori di handicap, donne), quando contemporaneamente si
afferma che tali differenze devono essere irrilevanti?
Per il non oggettivista, ossia per colui che non creda in una fondazione razionale dei giudizi di
giustizia (e in generale dei giudizi di valore) la determinazione delle classi al cui interno applicare
l’uguale trattamento è sempre il risultato di una scelta arbitraria e non dimostrabile. Secondo il
non oggettivista è dunque possibile valutare solo la giustizia nel diritto (cioè l’applicazione coerente
di esso), ma non la giustizia del diritto.
Secondo alcuni filosofi del diritto, come Kelsen e Ross, non è possibile nemmeno discutere di
giustizia, poiché essa è un’idea irrazionale. Così ross afferma espressamente che “invocare la
giustizia è come battere il pugno sul tavolo”: in ambedue i casi c’è una mera espressione di
emozioni.
Queste sono comunque due visioni estreme: secondo versioni più moderate del non oggettivismo
una discussione razionale sulla giustizia è possibile entro certi limiti; anche per questo tipo
moderato di non oggettivista i principi etici ultimi sono sempre frutto di una scelta arbitraria, ma,
una volta che due interlocutori condividano almeno uno di questi principi, è possibile fra loro una
discussione genuinamente razionale. Infine, soprattutto nel caso del diritto, sorge un’intera classe di
problemi per così dire di secondo grado, quando il valore dell’uguaglianza contrasta con valori
sostanziali: fino a che punto è bene applicare e osservare scrupolosamente una legge malvagia nel
contenuto?
3. EQUITÀ
L’EQUITÀ è spesso definita come la giustizia del caso concreto. Nel diritto essa viene considerata
una virtù del giudice e un valore della decisione giudiziaria, e contrapposta alla GIUSTIZIA, intesa
come trattamento generalizzante e considerata una virtù del legislatore e un valore della legge.
La contrapposizione dell’equità alla giustizia sottintende tesi di vario genere: può essere anzitutto
interpretata come un’alternativa tra due ricerche di scelta pratica e decisione: la tecnica che
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
fa ricorso a criteri generali e astratti e la tecnica basata sulla valutazione, fatta di volta in volta, delle
peculiarità di ogni singolo caso. La rivendicazione dell’equità contro la giustizia rappresenta allora
la preferenza per una tecnica individualizzante: un favore per questo tipo di tecnica è stato espresso,
nella storia, da molte dottrine filosofiche, come l’irrazionalismo e l’esistenzialismo.
Raramente però tali orientamenti chiariscono se la preferenza per una tecnica di scelta pratica
individualizzante rappresenti il frutto di una scelta in favore di un punto di vista morale considerato
superiore, ovvero una scelta obbligata, il destino inevitabile dell’uomo, come è chiaro per alcune
versioni dell’esistenzialismo.
Agli orientamenti filosofici favorevoli ad un atteggiamento etico individualizzante si oppongono
quelle dottrine etiche, di matrice specialmente cristiana e kantiana, giungono per contro a far
coincidere il punto di vista morale con l’atteggiamento generalizzante: queste dottrine ritengono che
l’esigenza di coerenza implicita nella massima “tratta i casi uguali in modo uguale” sia intrinseca al
concetto stesso di morale; ci si chiede se quest’esigenza, nota come PRINCIPIO DI
UNIVERSALIZZABILITÀ, sia davvero una caratteristica logica, coessenziale all’atteggiamento
morale, così come la presentano i suoi sostenitori. È più probabile invece che tale esigenza di
coerenza sia un valore morale sostanziale, e che sia così radicato nella nostra cultura e nel nostro
modo di ragionare da apparire un aspetto logico necessario alle scelte morali, quasi una componente
della definizione stessa di morale.
Il principio di universalizzabilità non fornisce una giustificazione ultima dei nostri principi morali,
ma asserisce unicamente che essi deviano essere imparziali: ciò significa che, qualunque contenuto
abbiano, dobbiamo essere pronti ad accettarne le conseguenze anche nel caso in cui siano per noi
svantaggiose; insomma, condizione per l’adozione del punto di vista morale è che i principi morali
non vengano piegati al proprio tornaconto. Questa condizione è per la verità molto blanda, perché
può essere soddisfatta da molte morali, anche sbagliate (si immagini un ebreo nazista tanto coerente
da essere disposto a finire in un lager pur di sterminare gli altri ebrei).
L’universalizzazione rappresenta tuttavia un potente strumento di critica per tutti quei ragionamenti
morali quotidiani che spesso assegnano tacitamente una posizione di privilegio a chi li formula (es.
tutti devono pagare le tasse ma io no perché tengo famiglia). Quale che sia la posizione da assumere
nella controversia tra tendenze generalizzanti o individualizzanti è importante sottolineare che
spesso la scelta è resa meno netta dall’inevitabile vaghezza delle norme: infatti più una norma è
vaga, meno sarà in grado di predeterminare le scelte, le quali pertanto dovranno essere compiute
volte per volta dall’interprete.
3.1. L’EQUITÀ NEL DIRITTO
Il favore verso l’equità del diritto è caratteristico di tutte le correnti antiformalistiche,
antipositivistiche, di alcune forme del giusnaturalismo e dell’idealismo. Sovente le ragioni di tale
scelta sono di tipo semiotico (o traducibili in termini semiotici): infatti molte teorie asseriscono
l’importanza dell’equità nel diritto perché vogliono sottolineare l’indeterminatezza semantica
delle norme generali e astratte e criticare sul piano teorico il formalismo interpretativo.
Questa è una posizione tipica di correnti come giusrealismo, e spesso assume le vesti di una
definizione antinormativistica del concetto di diritto: in tal modo l’equità viene proposta come
unico valore delle decisioni pratiche, mentre la giustizia viene presentata come un’illusione.
Solo di rado la preferenza per la scelta equitativa dipende da ragioni di natura apertamente pratica e
di politica del diritto: i fautori di tali teorie ritengono opportuno che la decisione giuridica si fondi
essenzialmente sulle peculiarità del caso concreto. Nella sua forma moderata questa istanza
contiene una critica al legalismo, considerato il prodotto degenerativo e inevitabile delle
legislazione generale e astratta: il legalismo sarebbe spesso produttivo di iniquità.
Nella sua forma più estrema la rivendicazione dell’equità implica che ci si affidi pressoché
interamente al giudizio individualizzante del giudice: il favore per l’equità indica dunque un favore
per la massimizzazione della libertà giudiziaria, ma ci si chiede in che cosa esattamente si concreti
il giudizio di equità; escluso dai suoi fautori che questo si identifichi come un giudizio arbitrario del
giudice si hanno almeno due interpretazioni di esso:
ALESSANDRO GRILLETTI
-
–IL GRILLORE
In base alla prima i criteri del giudizio di equità sono forniti al giudice dalla propria
coscienza morale, la quale sarebbe un rispecchiamento della coscienza sociale.
- Secondo la seconda i criteri vanno ricavati dalle peculiarità del caso in esame; il cosiddetto
criterio della natura della cosa, ossia che il giudizio sarebbe desumibile dall’osservazione
della natura del caso da giudicare.
Entrambi le tesi si espongono alla critica di chi ritiene tali scelte assolutamente arbitrarie e
soggettive. Va ricordato che negli ordinamenti moderni il giudizio di equità è ammesso solo in rari
casi particolari e su richiesta delle parti.
4. TEORIE DELLA GIUSTIZIA
Per giudicare della giustizia o ingiustizia di un diritto positivo occorre raffrontare questo diritto con
un altro sistema normativo campione, che funge da metro di giudizio; che viene denominato
“TEORIA DELLA GIUSTIZIA”.
Bisogna però in primo luogo precisare che le teorie della giustizia più articolate, come l’utilitarismo
e il contrattualismo (di cui si parlerà più avanti), hanno di solito un contenuto più ampio,
consistendo in un complesso più o meno organico di norme, principi e valori morali che fungono da
criterio di giustificazione o critica di un intero assetto sociale. Esse dunque non si limitano a
proporre un modello di giustizia giuridica, ma propongono una risposta a tutti i problemi morali
suscitati dalle relazioni individuali; si parla a questo proposito di etica pubblica, che si occupa delle
virtù pubbliche dei cives, contrapposta all’etica privata che riguarda l’individuo e i rapporti
interpersonali non rilevanti socialmente almeno in modo diretto. In secondo luogo, bisogna
precisare che l’espressione “teoria” assume significati differenti a seconda che la si consideri
nell’opposizione “teoria-ideologia” o con “teoria-pratica”: la seconda opposizione è quella giusta in
questo caso; infatti le teorie della giustizia non sono discorsi conoscitivi e scientifici (cioè non
ideologici), ma discorsi prescrittivi e valutativi.
È noto che importanti filoni della filosofia morale, come il giusnaturalismo e l’utilitarismo, negano
invece ambedue questi assunti, e pretendono che i principi regolativi di una società e di un diritto
giusti possano essere ricavati dalla descrizione della natura, della ragione e delle tendenze umane.
Per il filosofo non oggettivista questa pretesa è doppiamente criticabile: essa comporta infatti un
indebito passaggio da descrizione a prescrizione, ed inoltre esime dall’onere di esplicitare e
giustificare, fin dove è possibile, le scelte morale che necessariamente sottostanno ai principi di
giustizia così formulati. Per un oggettivista tutte le teorie della giustizia hanno dunque dignità solo
come politiche del diritto, ed in quanto tali dovrebbero dichiarare apertamente la loro natura pratica
e prescrittiva; nessuna di queste teorie ha in ultima analisi comunque alcun titolo, ad eccezione della
preferenza soggettiva, per essere considerata migliore delle altre.
Non tutti i filosofi del diritto si sono però rassegnati a tale conclusione, e ciò testimoniano molti
tentativi di elaborazione di una teoria della giustizia che, pur partendo da posizione oggettivista, sia
in grado di rispecchiare adeguatamente l’enorme complessità sia delle istituzioni esistenti, sia dei
nostri ordinari giudizi morali.
Le teorie della giustizia che si imperniano su un unico criterio di giudizio, come l’utilitarismo, sono
criticabili perché non riescono a render contro dei valori assai complessi a cui si ispirano le
istituzioni sociali attuali.
I critici dell’utilitarismo e di altre teorie della giustizia semplici ritengono che questi difetti possano
essere evitati mediante l’elaborazione di teorie morali complesse o miste, basate su più valori, anche
i potenziale conflitto, da coordinare in modi appropriati, e mediante l’adozione di una pluralità di
criteri di giustificazione di tali valori.
Così ad esempio il filosofo statunitense John Rawls ha proposto un modello di ragionamento
morale, chiamato equilibrio riflessivo, che si impernia proprio sull’influenza dialettica reciproca fra
istituzioni morali, principi morali e valutazione delle conseguenze dell’applicazione dei principi.
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
Nei paragrafi seguenti si esamineranno in breve due delle principali teorie della giustizia,
l’utilitarismo e il contrattualismo. Per quanto riguarda l’altro grande gruppo di teorie morali e
giuridiche, i giusnaturalismo, si rimanda alla voce dedicatavi fra le Concezioni del diritto.
4.1. UTILITARISMO
I filosofi morali sono soliti dividere le teorie della giustizia in teleologiche e deontologiche: le
prime giudicano l’azione dalle sue conseguenze (da
= scopo), le seconde dalle proprietà
intrinseche dell’azione medesima, ad esempio dalla circostanza che essa sia compiuta in
adempimento di un dovere (da
= dovere).
L’utilitarismo è considerato la teoria teleologica per eccellenza, che assume la
massimizzazione dell’utilità (o benessere, o felicità) come criterio di valutazione della giustizia
delle azioni; si basi che l’utilitarismo parla di utilità generale, e non ha quindi nessun rapporto con
l’egoismo etico, che valuta le azioni dall’utilità che esse hanno per il soggetto agente. Ci si chiede
cosa abbia a che fare con la giustizia (valore di uguaglianza e formale), una teoria così
spiccatamente teleologica come l’utilitarismo: in realtà esso compre una vasta famiglia di dottrine
morali, che si differenziano tra loro per in base alla diversa nozione di utilità addotta.
Da un punto di vista per così dire quantitativo si possono distinguere le varie teorie utilitaristiche
dal metodo con cui calcolano l’utilità (ad esempio a che più persone siano felici, o a che le persone
siano più felici, o alla media ponderata fra queste utilità); da un punto di vista per così dire
qualitativo si è soliti distinguere tra l’utilitarismo edonistico, come quello di Bentham (di matrice
epicurea), che fa coincidere l’utilità con la felicità individuale soggettivamente intesa, e
l’utilitarismo ideale, come quello di Moore, che fa coincidere l’utilità con il raggiungimento di un
certo stato intellettuale definito indipendentemente dalle inclinazioni individuali.
Più importante è la distinzione tra UTILITARISMO DELL’ATTO e UTILITARISMO DELLA REGOLA: il
primo qualifica giusta l’azione se ha come conseguenza la massimizzazione dell’utilità; il secondo
giudica giusta un’azione se è compiuta in conformità ad una regola che è quella che produce la
maggiore utilità: è evidente che questa seconda, e più sofisticata, forma di utilitarismo è assai più
adatta a fondare un sistema di convivenza sociale e a fornire i criteri per l’azione individuale, come
anche ad accettare una concezione della giustizia come trattamento uguale).
L’utilitarismo nasce, specie con Bentham, come teoria morale di ispirazione empirista (valuta gli
effetti delle azioni), ostile alla convinzione del giusnaturalismo di una giustizia razionale e a priori;
tuttavia entrambe hanno in comune il fatto di essere teorie oggettivistiche della morale: ambedue
ritengono possibile fondare su basi descrittive i precetti morali; per l’utilitarista questa fondazione è
empirica e basata sull’accertamento degli interessi e dei bisogni individuali, per il giusnaturalista è
una fondazione metafisica e razionale.
Ma per i critici la pretesa di dare un fondamento ala morale è fallace, perché neppure il principio di
utilità può essere ricavato dall’esperienza (vedi: Fallacia naturalistica – più avanti). La critica più
grave e ricorrente all’utilitarismo è però un'
altra, ovvero di ritenere possibile adoperare gli individui
anche come mezzi (contravvenendo alla seconda legge kantiana) in virtù del principio di
massimizzazione dell’utilità: da un punto di vista strettamente teorico la morale utilitaristica sarebbe
disposta a calpestare tutti i principali diritti della persona se questo potesse causare un aumento
complessivo della felicità generale.
Ma, pur ammettendo che queste critiche siano filosoficamente morale, occorre però considerare che
la dottrina utilitaristica si è sempre presentata, storicamente come una dottrina individualista e
liberale: essa ha contribuito all’evoluzione in senso garantista degli ordinamenti giuridici e specie
nel campo del diritto penale all’evoluzione dei sistemi penali nel senso dell’umanizzazione delle
pene, dell’abolizione della pena di morte, dell’affermazione del principio di legalità (vedi:
Giustificazione della Pena).
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
4.2. CONTRATTUALISMO
Con questo termine vengono solitamente indicate tutte le dottrine filosofico-politiche che pongono a
fondamento della società e del potere politico un CONTRATTO SOCIALE fra i consociati, che segna il
passaggio da uno stato di natura presociale alla società civile: si tratta di un pactum unionis, tramite
il quale gli individui costituiscono una società, ma anche di un pactum subiectionis, tramite il quale
si assoggettano ad un potere.
Il contrattualismo nasce storicamente con i giusnaturalisti dei secoli XVII e XVIII, spesso costoro
giustificano infatti i poteri dello stato e il diritto esistente con un contratto sociale, esplicito o
implicito.
Possiamo pertanto parlare di un fondamento individualistico ed egualitario del contrattualismo
moderno; è importante notare che la necessità di questo fondamento rimane anche quando le
conclusioni sono a favore di uno stato assoluto in cui l’individuo non ha diritto giuridici: così,
secondo Hobbes, che nel Leviatano (1651) postula una delle più coerenti concezioni
dell’assolutismo politico, lo stato è la conseguenza del patto osciale, con cui gli individui si
spogliano totalmente, definitivamente (o quasi) e irrevocabilmente dei propri diritti naturali
posseduti, per soddisfare il proprio desiderio primario e interesse a sopravvivere, abbandonando il
pericoloso stato di natura dominato dalla lotta di tutti contro tutti (il cosiddetto homo homini lupus).
Occorre poi sottolineare che il volontarismo della concezione contrattualista assume un carattere
più o meno pregnante a seconda che il contenuto del patto sociale sia già predeterminato oppure sia
liberamente determinabile dai contraenti: le dottrine contrattualistiche variano dunque
profondamente sia come configurano lo stato di natura e il contratto sociale, sia per gli esiti che
attribuiscono alla stipulazione del contratto.
Una prima distinzione riguarda lo stato di natura, che è sempre uno stato in cui manca il potere e gli
uomini si trovano in una posizione di uguaglianza, ma che talora viene concepito come un fatto
realmente avvenuto, talaltra come una mera ipotesi concernente la posizione umana fuori dalla
società (così lo concepisce Rousseau, autore del Contratto Sociale, 1762). Talora lo stato di natura
viene individuato positivamente o addirittura idealizzato (la classica età dell’oro), altre volte è
considerato una situazione mostruosa (quella hobbesiana).
Diversi sono anche gli esiti del contratto: esso conduce in Locke e Kant ad una società liberale, in
Hobbes ad una assolutistica, in Rousseau in una democratica. Variano anche gli esiti della
violazione del patto da parte di chi detiene il potere: in Hobbes non hanno alcuna conseguenza, in
Locke giustificano il diritto alla resistenza.
Le dottrine contrattualiste godono oggi di un rinnovato successo grazie soprattutto al pensiero del
filosofo statunitense John Rawls, la cui opera fondamentale, Una teoria della giustizia (’71), ha
avuto enorme importanza.
Il contratto sociale ha per Rawls un carattere chiaramente fittizio: è una situazione presociale
ipotetica, in cui sono chiamati a scegliere il giusto assetto sociale individui sì liberi e razionali, ma
che ignorano le conseguenze della propria azione: in una tale situazione costoro sceglierebbero,
secondo Rawls, per ragioni egoistiche ma prudenziale una struttura sociale in cui domini il principio
di uguaglianza nella distribuzione delle libertà basilari ed in cui le disuguaglianze sociali sono
ammesse solo se favoriscono i meno avvantaggiati socialmente e sono legate a posizioni e incarichi
ugualmente aperte a tutti.
Il contrattualismo contemporaneo, in particolare quello di Rawls, si pone in aperta polemica con
l’utilitarismo e il giusnaturalismo, ed è convinto di poter superare i difetti di entrambi: l’idea è
che il contratto possa assicurare agli individui una sfera di intangibilità, diritti e garanzie, senza
dover giustificare filosoficamente un diritto naturale ed escludendo il rischio che, per massimizzare
il benessere sociale, essi possano essere violati.
Tuttavia, anche l’artificio del contratto sociale così concepito si espone a critiche: in primo luogo
infatti è chiaro che le conseguenze del contratto variano in relazione ai presupposti adottati (es.
Rawls presuppone una certa concezione della natura umana, mutando la quale muterà anche
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
il contratto); in secondo luogo, non si vede perché una società si debba reggere su un contratto
stipulato una volta per tutte, e gli individui non siano invece liberi di modificarlo e rimettere in
discussione le clausole concettuali. Un’altra critica contro le versioni più recenti del contrattualismo
è di fungere da strumento di legittimazione: esso condurrebbe ad una giustificazione dell’attuale
ordinamento delle moderne società industriali occidentali (con alcune più o meno significative
concezioni).
Si è infine osservato che l’attribuzione di un valore decisivo allo strumento del contratto presuppone
che si attribuisca ai contraenti un valore ancora più elevato: dunque sarebbero ancora i diritti
soggettivi individuali, più che il contratto, a fondare la società politica e fissare i limiti di potere: si
spiega così che i filosofi disposti a riconoscere soggettività morale ad esseri senzienti non umani,
come gli animali, includano anche costoro tra i soggetti contraenti.
5. DIVISIONISMO ETICO
Si suole distinguere le teorie morali in oggettiviste e non oggettiviste. Le prime ritengono che i
valori e le norme morali abbiano carattere oggettivo; le seconde negano tale oggettività, e ritengono
che i valori siano sempre tali solo per chi li sceglie. Di solito l’oggettivismo etico viene a sua volta
suddiviso in naturalista e non naturalista: per il primo il valore morale è una qualità naturale delle
cose, come la dolcezza per il frutto; per il secondo è una qualità no naturale, non percepibile dai
sensi, eppure dotata di obbiettività.
Le teoria della conoscenza morale addotta di solito dagli oggettivisti è nota come COGNITIVISMO
ETICO: in base ad esso i valori morali sono conoscibili attraverso l’esperienza empirica (per i
naturalisti) o l’intuizione morale (per i non naturalisti). La teoria della conoscenza morale addotta
dai non oggettivisti è nota come non COGNITIVISMO ETICO: per essa i valori morali non sono
conoscibili, e non è possibile fondare le norme, anche etica, sulla base della sola conoscenza dei
fatti.
Non va confuso con questo il RELATIVISMO ETICO, che è la tesi per la quale i valori etici non
sarebbero sempre validi, ma appunto mutevoli a condizioni rilevanti: sostenere che i valori non
siano conoscibili non significa dire che essi mutino.
Il non oggettivismo e non cognitivismo etico presuppongono in genere due tesi di ordine diverso:
- In primo luogo la tesi semiotica nota come Grande Divisione, ossia la distinzione semanticopragmatica tra discorsi descrittivi e prescrittivi.
- In secondo luogo la tesi (meta)logica nota come Legge di Hume, ossia la convinzione
dell’impossibilità di passare con mezzi esclusivamente logico-linguistici dal descrittivo al
prescrittivo (e viceversa), da cui deriva l’impossibilità di derivare, e quindi di fondare, una
prescrizione sulla base di una descrizione.
5.1. FALLACIA NATURALISTICA
I divisionisti accusano di FALLACIA NATURALISTICA coloro che pretendono di derivare conclusioni
prescrittive da premesse puramente descrittive, o viceversa conclusioni descrittive da premesse
puramente prescrittive.
“Fallacia naturalistica” è la traduzione della locuzione naturalistic fallacy, usata per la prima volta
dal filosofo inglese Moore per confutare il naturalismo etico (ed ora coerentemente utilizzata per
criticare qualunque variante dell’oggettivismo etico. Si ritiene che il primo a censurare questo vizio
sia però stato il “grande” David Hume nel Trattato sulla natura umana (1740): perciò la tesi
(meta)logica corrispondente al rifiuto della fallacia naturalistica è detta Legge di Hume.
(Si noti che non sempre l’accoglimento della tesi della Grande Divisione porta al rifiuto della
fallacia naturalistica: c’è chi accetta la divisione tra prescrittivo e descrittivo ma accetta i “salti”
logico-linguistici tra questi due ordini di discorsi).
Tra i molteplici tentativi di confutare la Legge di Hume ne vanno ricordati due di impostazione
analitica: quello imperniato sulla nozione di fatto istituzionale e quello imperniato sulla nozione di
implicazione pragmatica.
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
-
Nel primo caso si è sostenuto che una conclusione prescrittiva è derivabile da una premessa
descrittiva che verta su fatti istituzionali, cioè disciplinati da norme costitutive, ad esempio
una promessa.
- Nel secondo caso si è sostenuto che esistono particolari regole di inferenza che consentono
di superare il salto logico tra descrittivo e prescrittivo: tali regole governano la così detta
implicazione pragmatica: ad esempio il fatto che io descrivo che “piove”, implica che io
sia convinto che piova; così il fatto che io dichiari il mio atteggiamento morale
implicherebbe automaticamente il corrispondente giudizio di valore.
Sarebbe dunque possibile derivare per implicazione pragmatica giudizi di valore e norme da
asserzioni concernenti i ragionamenti umani.
Ambedue i tentativi appena accennati di colmare il salto logico tra descrittivo e prescrittivo sono
stati criticati: nel primo caso la derivazione è solo apparente (la promessa non implica che io la
mantenga a meno che non accetti di farlo); nel secondo caso si è osservato che l’implicazione non è
affatto strettamente logica, e quindi non è adatta a fondare una dimostrazione. Quest’ultima
conclusione deriva dal carattere puramente analitico e tautologico delle inferenze: la conclusione di
un’inferenza se è corretta, non può implicare nulla che non sia già contenuto nella premessa (come
nel caso della pioggia); è pertanto impossibile far derivare premesse descrittive (i miei
atteggiamenti morali) conclusioni prescrittive (le norme e i giudizi di valore).
Tuttavia queste considerazioni non sono tassative, perché si fondano anch’esse su una teoria, quella
dell’impossibilità di derivare prescrizioni da descrizioni (Legge di Hume) che è a sua volta
indimostrabile: infatti per dimostrarla bisognerebbe derivare il divieto della fallacia naturalistica
(prescrizione) dalla descrizione del pensiero e del linguaggio ordinari: molti divisionisti sono ormai
disposti ad ammettere l’indimostrabilità della tesi dell’imposssibilità del salto logico dal descrittivo
al prescrittivo, ma piuttosto a considerarla come un postulato filosofico, frutto di una opzione in
ultima analisi arbitraria e non giustificabile.
L’accettazione come postulato di tale fatto caratterizza la metafisica del filosofo analitico, ed è uno
dei criteri di distinzione fra filosofie analitiche e sintetiche.
Come si diceva, la Legge di Hume vieta anche il passaggio dal prescrittivo al descrittivo: ciò
significa che da norme e valori non si possono dedurre i fatti, e la conseguenza di questo (con un
piccolo sforzo per arrivarci…) è che l’unica forma di conoscenza ammessa è quella empirica.
6. CERTEZZA DEL DIRITTO
La certezza del diritto consiste nella possibilità, da parte del cittadino, di conoscere la valutazione
che il diritto dà delle proprie azioni e di prevede le reazioni degli organi giuridici alla propria
condotta. Tale prevedibilità è considerata pressoché unanimemente un valore positivo dei diritti che
la rendano possibile: infatti il diritto dotato di certezza fornisce al cittadino la garanzia che gli spazi
di libertà, piccoli o grandi, a lui riconosciuti, saranno effettivamente rispettati. La certezza di diritto
è pertanto un valore positivo sia per il buon cittadino desideroso di ottemperare alle prescrizioni
giuridiche, sia per il cattivo cittadino desideroso di infrangerle: anzi le nozioni medesime di cattivo
e buon cittadino acquistano senso preciso solo sul presupposto che una conoscenza del diritto ed
una previsione delle reazioni degli organi pubblici siano davvero possibili.
La possibilità di prevedere le reazioni del diritto, com’è ovvio, è particolarmente importante nel
campo del diritto penale: in suddetto campo la realizzazione del valore della certezza del diritto è
legata al principio nullum crimen, nulla pena, sine lege, che vieta la posizione di reati effettuata
altrimenti tramite legge retroattiva; vieta inoltre l’estensione analogica alle norme penali esistenti;
infine, vi si è aggiunta l’esigenza che il linguaggio con cui sono formulate le leggi penali sia
tassativo, ossia il più possibile preciso e dettagliato nel descrivere le situazioni di fatto che
integrano le varie fattispecie penali.
La certezza è un valore distinto dalla giustizia del diritto e sovente contrapposto alla giustizia
sostanziale o bontà del contenuto del diritto un diritto può essere certo ma ingiusto, oppure giusto e
apprezzabile quanto ai contenuti, ma incertamente applicato. Si può naturalmente sostenere che la
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
malvagità sostanziale anche estrema di un sistema giuridico può essere almeno temperata dal suo
uniformarsi al principio della certezza del diritto; ma si può fare anche la considerazione inversa,
cioè che l’incertezza di un diritto ingiusto può servire a evitare almeno qualche “ingiustizia”.
La certezza del diritto è quindi un valore “formale”, che funge da complemento della giustizia in
senso “sostanziale”, ossia della giustizia contenuto delle prescrizioni giuridiche. Spesso le teorie
formalistiche che privilegiano la certezza sono state contrapposte alle teorie antiformalistiche che
privilegiano la giustizia.
Dal primo filone di teorie la certezza del diritto è stata presentata come caratteristica essenziale e
addirittura costitutiva del diritto si è detto che il diritto incerto non è neppure diritto.
Da parte antiformalistica è stato detto che la certezza è pura illusione, se non addirittura “mito”:
così, per Kelsen, l’attività interpretativa ha un carattere creativo ineliminabile, il che rende
impossibile separare il momento della creazione da quello dell’applicazione del diritto, cioè
predeterminare integralmente le decisioni degli organi esecutivi e giudiziari. Per Jerome Frank,
teorico appartenente all’ala estrema del realismo giuridico americano, la certezza del diritto è
semplicemente un “mito” rassicurante, necessario per credere di avere una sorta di guida infallibile;
Frank ritiene che la certezza non sia neppure un valore degno di essere perseguito, perché è
opportuno che il diritto sia flessibile e in grado di adeguarsi agli imprevedibili mutamenti sociali;
per Frank il diritto non è fatto di norme, ma di decisioni giudiziarie del tutto imprevedibili, poiché
non sono mere applicazioni di regole preesistenti.
Ma, per chi ritiene possibile e desiderabile perseguirlo, il valore della certezza del diritto richiede
che siano soddisfatti numerosi precetti relativi all’organizzazione e all’attività giuridica:
- In primo luogo la supremazia della fonte legislativa sulle altre fonti del diritto, soprattutto
sul diritto consuetudinario e giurisprudenziale. Infatti per realizzare il valore della certezza il
diritto deve essere composto da norme generali, astratte e non retroattive: provenienti cioè
da un organo legislativo.
- In secondo luogo il tipo ideale di diritto certo è quello che incorpora la prescrizione che
l’interpretazione sia solo dichiarativa del diritto già esistente e non creativa di diritto nuovo.
Affinché sia possibile prevedere le decisioni giuridiche queste devono essere in altre parole
applicazione mera di un diritto creato da altri organi giuridici e in un momento cronologico
precedente.
- In terzo luogo occorre che l’ordinamento giuridico fornisca univoche prescrizioni d’azione,
e quindi sia privo di lacune e non contenga antinomie, o almeno possegga critici pubblici e
chiari per la loro eliminazione.
Come si vede, il modello di diritto sopra descritto coincide con quello che il giuspositivismo
illuminista e liberale ritenne possibile realizzare tramite l’opera di CODIFICAZIONE; ora la
convinzione generale è meno reale e più pragmatica, ma comunque abbastanza prossima a quella
degli illuministi: il diritto codificato, chiaro, completo, agevolmente conoscibile e razionalmente
sistemato è quello che, pur non potendo raggiungere la perfezione, si avvicina maggiormente
all’ideale della certezza di diritto.
Proprio per questo, si parla di DECODIFICAZIONE se si va incontro al fenomeno inverso: ciò avviene
quando la produzione normativa è caotica e alluvionale, caratterizzata da vaghezza e ambiguità
delle norme, assenza della sistematicità della produzione normativa, sovrabbondanza di norme e
quindi antinomie tra le stesse.
Si parla purtroppo, definendoci alla nostra situazione odierna, di “età della decodificazione”,
proprio perché si tratta di un’età in cui i codici hanno perso la loro centralità sistematica e sono
ormai sommersi dall’alluvione delle leggi speciali e dal disordine della decretazione d’urgenza.
L’argomento della decodificazione, ossia della degenerazione del diritto legislativo, non è peraltro
del tutto nuovo: esso è stato adoperato anche dalle dottrine antiformalistiche della fine dell’800,
dottrine ostili al diritto legislativo, cui contrapponevano il diritto giudiziario, elastico e adattabile
alle esigenze sociali: un “diritto libero”.
ALESSANDRO GRILLETTI
–IL GRILLORE
7. IDEOLOGIA
La parola IDEOLOGIA, di origine tardo-settecentesca, originariamente stava a indicare lo studio delle
idee, ma oggi il termine è usato in una famiglia di significati diffusi da Marx e in sensi derivati.
Si possono distinguere tre sensi fondamentali dell’espressione:
- In un primo senso per ideologia si intende qualunque idea o complesso di idee considerate
come fattori sociali, in grado influenza la società o di esserne influenzati. In questo senso è
qualificabile come ideologia qualunque visione del mondo (weltanschauung), di un
individuo o un gruppo sociale, ossia il complesso di credenze e atteggiamenti nei confronti
della realtà, che è esso stesso un fenomeno sociale.
- In un secondo senso, l’ideologia è falsa coscienza o falsa scienza, complesso di idee e
discorsi solo apparentemente neutrali, conoscitivi e scientifici, ma che in realtà tali non
sono, e per la loro falsa apparenza riescono a suggerire valori e norme. Questo senso di
ideologia presuppone l’intenzionalità e la consapevolezza della natura ingannevole del
proprio discorso, ed indica una visione (a differenza della prima, assolutamente neutrale)
carica di connotazioni etico-politiche.
- In un terzo senso, l’ideologia è una concezione globale e onnicomprensiva del mondo, che
determina sia giudizi di valore sia conoscenze: in questo senso ogni discorso viene
considerato come ideologico e si ritiene possa essere valutato sulla base dei suoi effetti e
delle sue cause sociali, dei valori pratici che promuove o che lo promuovono. Questo terzo
senso è solo di rado esplicitamente teorizzato, ma emerge ogniqualvolta si fa confusione tra
i primi di sensi di ideologia; chi ne fa uso non solo nega che si possa valutare una teoria a
prescindere dai suoi effetti o dalle sue cause sociali, ma afferma che l’unico possibile
criterio di giudizio debba ridursi alla constatazione di questi ultimi; perciò esso nega anche
legittimità alle strutture giustificative giuridiche: nega dunque la validità di qualunque
discorso di giustificazione distinto dal discorso sociologico (e quindi nega la giustificazione
razionale delle norme).
Per Marx sono ideologie (in questi tre sensi) tutte le idee politiche, morali e filosofiche che sono
espressione e giustificazione dei rapporti di produzione dominanti: in quanto tali esse sono elementi
sovrastrutturali, perciò prive di autonomia e capacità di determinare la storia, il cui corso dipende
dai fattori strutturali (cioè economici).
Naturalmente, a seconda del senso con cui si adoperare, la qualificazione come ideologia del diritto
assume una valutazione radicalmente diversa:
- Nel primo senso, dire che il diritto è ideologia o prodotto di ideologie è fare un’affermazione
piuttosto innocua e pacifica: significa dire che è espressione di una visione del mondo,
cioè di un atteggiamento nei confronti della realtà (diciamo che è un’affermazione ovvia e
quasi superflua).
- Nel secondo senso, parlare di diritto come ideologia significa qualificarlo come espressione
di falsa coscienza, e quindi si tratta di un’accusa assai grave. Per Marx ed i marxisti, ad
esempio, il diritto borghese è ideologico, perché rispecchia i rapporti capitalisti di
produzione e rappresenta uno strumento della classe dominante di rafforzamento del proprio
potere; pertanto sono illusori tutti gli aspetti più caratteristici del diritto borghese:
l’uguaglianza fra tutti i cittadini, l’uso di categorie generali e astratte, i diritti e le garanzie
giuridiche conferiti dalla legge. Questo diritto è ugualitaristico solo da un punto di vista
“formale”, mentre nella sostanza (sul piano economico) gli individui sono profondamente
diseguali; ed è ideologico perché occulta queste disuguaglianze.
Colpevole di ideologia è anche, per il marxismo, la Scienza giuridica ufficiale, che lungi
dal compiere un’opera di smascheramento della mistificazione operata dal diritto borghese,
si limita a descriverne le prescrizioni giuridiche, e perciò si rende complice dell’inganno da
esso perpetrato.
ALESSANDRO GRILLETTI
-
–IL GRILLORE
La critica all’ideologicità della Scienza giuridica tradizionale proviene peraltro anche da
Kelsen, che però si scaglia soprattutto verso la Scienza giuridica giusnaturalista, e cioè
all’idea che non tutto il diritto si riduca al diritto positivo, e che quest’ultimo per essere
“vero” diritto debba adeguarsi al diritto naturale: Kelsen trova quest’ideologia celata in tutti
i dualismi tratteggiati dalla Scienza giuridica tradizionale, come quello tra diritto privato e
pubblico, tra diritto soggettivo e oggettivo, tra diritto e stato: il fine di questi dualismi, celato
sotto l’apparente descrizione, è di imporre al diritto positivo certi contenuti
Il terzo senso di analogia nasce sovente come risultato della commistione tra i primi due:
così nella critica che il marxismo giuridico muove alla scienza del diritto borghese affiora
anche questo terzo senso, nel momento in cui viene negata ogni legittimità teorica delle
strutture giustificative giuridiche, cioè delle norme in isolamento dai fatti sociali, ed anzi
asserisce che l’unico modo legittimo di accostarsi al diritto sia quello di ricercare i fattori
sociali che costituiscono la causa o l’effetto del suo modo di essere. Chi usa questo terzo
senso di ideologia nega la distinzione tra il contesto di giustificazione e il contesto di
motivazione (vedi: Formalismo giuridico): lo studio del contesto di giustificazione viene
considerato privo di dignità teorica, e ridotto a mistificazione ideologica, poiché non si
limita ad occuparsi delle cause e degli effetti sociali, ossia del contesto di motivazione.
8. MORALE E DIRITTO
La questione dei rapporti tra diritto e morale costituisce un problema tradizionale e centrale della
riflessione filosofica della giustizia. I contrasti filosofici su tali rapporti non riguardano tanto le
relazioni fattuali, storiche e sociologiche fra queste due sfere normative (infatti è ovvio che ci sia
un’influenza della morale sul diritto ed anche un’influenza del diritto sulla morale), né riguardano
dissensi di valore (ossia riguardanti i valori che il diritto o la morale deve difende): questi dissensi
sono invece soprattutto METODOLOGICI, cioè riguardanti il metodo mediante cui operare il
confronto, i tipi di ragionamento adatti a sostenere i valori etici con cui il diritto deve essere
confrontato: sulla necessità, o viceversa l’impossibilità, che il confronto fra diritto e morale sia parte
integrante del discorso giuridico e sulle implicazioni morali di talune posizioni giuridiche.
Le due teorie fondamentali , e antitetiche, sotto questo punto di vista sono GIUSNATURALISMO e
GIUSPOSITIVISMO.
Questo settore può essere esaminando adoperando la distinzioni tra problemi metodologici, teorici,
ed etico politici (vedi: Concetto di diritto): il dissenso fondamentale fra queste due teorie è di
carattere metodologico, e riguarda la descrivibilità (o indescrivibilità) di un diritto
indipendentemente dalla sua giustizia.
- Dal punto di vista metodologico, il giuspositivista ritiene che il diritto possa e debba essere
descritto indipendentemente dalla sua giustizia, cioè dalla sua conformità ad un ordine
morale oggettivo, e nega dunque l’esistenza di alcuna connessione necessaria e concettuale
tra diritto e morale: per il giuspositivista il diritto positivo va descritto in quanto tale,
indipendentemente dal fatto che lo si consideri giusto o ingiusto, e di conseguenza che si
ritenga di dovervi prestare obbedienza o meno. Dal suo punto di vista il nesso tra diritto e
morale può essere affermato solo da un punto di vista fattuale, o sul piano etico-politico,
quando si propongono i criteri morali a cui dovrebbe ispirarsi. Viceversa il giusnaturalista
sostiene che vi sia una connessione necessaria tra diritto e giustizia: ne deriva un diritto che
non può essere considerato come giuridico se non rispecchia e salvaguarda certi valori
morali. Le due posizioni sottintendono ovviamente scelte e assunzioni di vario genere: il
giusnaturalismo ha sempre dietro di sé una concezione oggettivistica dei valori e una
concezione cognitivistica in tema di conoscenza etica; viceversa il giusnaturalista di solito
abbraccia la metaetica opposta, e cioè il non oggettivismo e non cognitivismo.
Va però notato che alcuni teorici giuspositivisti, come Bentham e Austin, abbracciano una morale
utilitaristica (che non è non cognitivista), e propugnano la separazione tra il diritto com’è e il diritto
come deve essere per scongiurare confusioni di carattere concettuale e
ALESSANDRO GRILLETTI
-
-
–IL GRILLORE
nelle scelte pratiche degli individui: costoro infatti potrebbero essere indotti alla
commistione tra diritto e morale a considerare non giuridiche le leggi ingiuste, ovvero a
considerare perciò stesso giuridiche le norme morali giuste (con risultati pratici assai
pericolosi).
I giuspositivisti che siano anche, come invece in genere accade, non cognitivisti,
argomentano l’esigenza della separazione tra diritto e morale richiamandosi al valore
dell’avalutatività della scienza, che verrebbe inevitabilmente compromesso dall’intrusione di
preferenze morali nel discorso di descrizione di un diritto. Va però notato che la convinzione
giuspositivistica si incrina allorquando il giuspositivista si rende conto che la scelta
medesima di descrivere il diritto positivo è sospettabile di essere una scelta eticamente non
neutrale, ma al contrario compromessa moralmente e politicamente nel senso di essere
conformismo verso gli ordinamenti positivi e quindi effettivi.
Alle differenze radicali di impostazione metodologica che separano il giusnaturalismo dal
giuspositivismo si accompagnano differenze assai meno radicali e fondamentali, di carattere
teorico, riguardante specialmente l’elenco delle fonti del diritto ammesse: il giusnaturalista
è a favore di una concezione larga e aperta delle fonti del diritto, che comprenda anche la
morale positiva, l’equità, la coscienza sociale; il giuspositivista tende ad adottare un
atteggiamento assai più restrittivo, considerando come vero diritto solo il diritto positivo, e
prendendo in considerazione i rimandi alla morale, all’equità ecc. solo quando siano
appositamente menzionati dal diritto positivo.
I dissensi circa il modo di configurare i rapporti fra diritto e morale investono anche il piano
etico-politico: il caso più semplice di conflitto è quello in cui diritto e morale danno
valutazioni incompatibili o divergenti dello stesso atto o situazioni, per cui ciò che per una
morale è permesso o prescritto, per il diritto è vietato o viceversa. Casi ancora più complessi
sono quelli in cui un diritto dà valutazioni di una morale, per dichiararla permessa,
obbligatoria o vietata, ad esempio; o in cui una morale valuta positivamente o negativamente
uno o più diritti. Tutte le teorie giuridiche incorporano delle tesi che sono state chiamate di
morale critica, per distinguerle dalla morale positiva, circa il modo in cui tali conflitti
vanno affrontati e risolti.