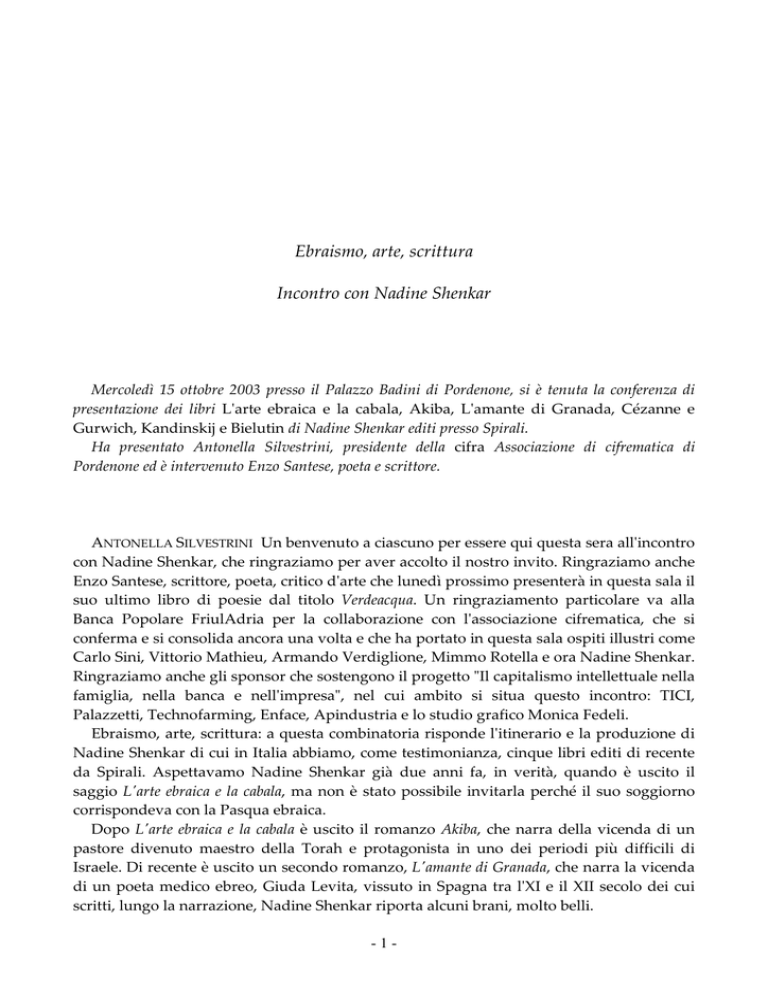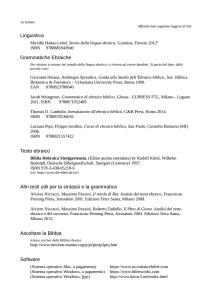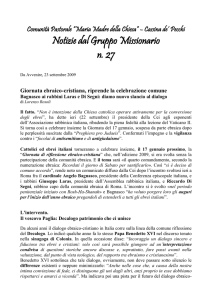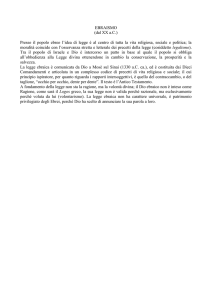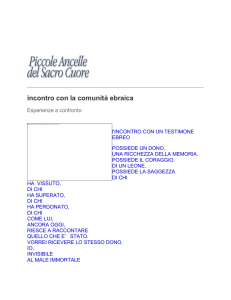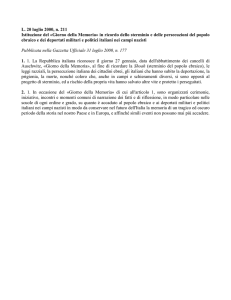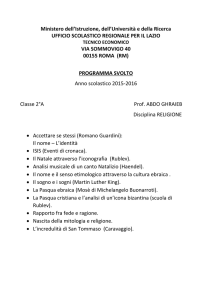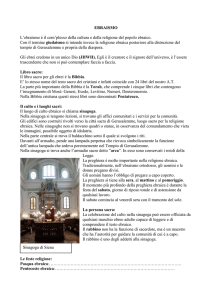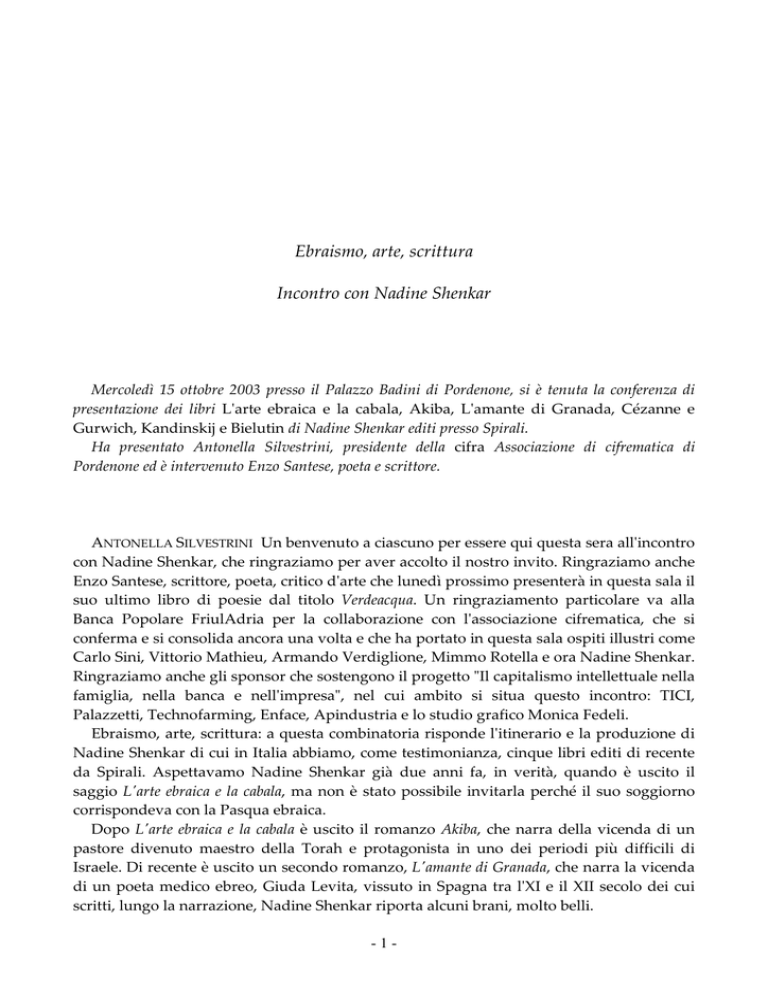
Ebraismo, arte, scrittura
Incontro con Nadine Shenkar
Mercoledì 15 ottobre 2003 presso il Palazzo Badini di Pordenone, si è tenuta la conferenza di
presentazione dei libri L'arte ebraica e la cabala, Akiba, L'amante di Granada, Cézanne e
Gurwich, Kandinskij e Bielutin di Nadine Shenkar editi presso Spirali.
Ha presentato Antonella Silvestrini, presidente della cifra Associazione di cifrematica di
Pordenone ed è intervenuto Enzo Santese, poeta e scrittore.
ANTONELLA SILVESTRINI Un benvenuto a ciascuno per essere qui questa sera all'incontro
con Nadine Shenkar, che ringraziamo per aver accolto il nostro invito. Ringraziamo anche
Enzo Santese, scrittore, poeta, critico d'arte che lunedì prossimo presenterà in questa sala il
suo ultimo libro di poesie dal titolo Verdeacqua. Un ringraziamento particolare va alla
Banca Popolare FriulAdria per la collaborazione con l'associazione cifrematica, che si
conferma e si consolida ancora una volta e che ha portato in questa sala ospiti illustri come
Carlo Sini, Vittorio Mathieu, Armando Verdiglione, Mimmo Rotella e ora Nadine Shenkar.
Ringraziamo anche gli sponsor che sostengono il progetto "Il capitalismo intellettuale nella
famiglia, nella banca e nell'impresa", nel cui ambito si situa questo incontro: TICI,
Palazzetti, Technofarming, Enface, Apindustria e lo studio grafico Monica Fedeli.
Ebraismo, arte, scrittura: a questa combinatoria risponde l'itinerario e la produzione di
Nadine Shenkar di cui in Italia abbiamo, come testimonianza, cinque libri editi di recente
da Spirali. Aspettavamo Nadine Shenkar già due anni fa, in verità, quando è uscito il
saggio L'arte ebraica e la cabala, ma non è stato possibile invitarla perché il suo soggiorno
corrispondeva con la Pasqua ebraica.
Dopo L'arte ebraica e la cabala è uscito il romanzo Akiba, che narra della vicenda di un
pastore divenuto maestro della Torah e protagonista in uno dei periodi più difficili di
Israele. Di recente è uscito un secondo romanzo, L'amante di Granada, che narra la vicenda
di un poeta medico ebreo, Giuda Levita, vissuto in Spagna tra l'XI e il XII secolo dei cui
scritti, lungo la narrazione, Nadine Shenkar riporta alcuni brani, molto belli.
-1-
Accanto a questi due romanzi storici, sono appena stati pubblicati due libri d'arte nella
collana trilingue di Spirali “L'arca. Pittura e scrittura”, in cui intellettuali, poeti, scrittori
scrivono e confrontano pittori di oggi con i grandi maestri della pittura. In Kandinskij e
Bielutin e Cézanne e Gurwich Nadine Shenkar scrive senza attenersi agli stereotipi della
critica d'arte. Dipinge. Le sue tele stanno accanto alle tele dei due artisti. Sono due libri
molto poetici perché narrano le vicende dei colori e le loro combinazioni.
Cartagine, Parigi e Gerusalemme: la cifra di un viaggio interessantissimo, le cui perle si
ritrovano nel testo di Nadine Shenkar. Accanto agli studi di filosofia, di letteratura, di
linguistica, di filologia e del Talmud.
Nell'Arte ebraica e la cabala Nadine scrive:
Una delle idee principali dell'ebraismo è il concetto […] di un popolo che mira a una
terra ma che rimane sempre in viaggio in un altrove; di uno spazio come trappola del
radicamento; di una Gerusalemme non già posseduta ma sempre da acquisire; […].i[i]
La sua testimonianza é una testimonianza di vita. Nasce a Cartagine, compie i primi
studi a Tunisi, e poi, adolescente, va a Parigi. Si laurea all'Ecole Normale e comincia a
insegnare alla Sorbonne. Dopo qualche anno decide di andare a vivere a Gerusalemme,
dove vive tuttora e insegna filosofia all'Accademia di Belle Arti Bezalel.
La scrittura e la testimonianza di Nadine Shenkar sono indispensabili per capire il
contributo culturale che l'ebraismo ha dato alla psicanalisi e alla cifrematica. Alcune
acquisizioni culturali dell'ebraismo sono davvero indispensabili, essenziali: nell’ebraismo
il testo non é già dato, come vorrebbe il fondamentalismo. L’approccio al testo esige un
costante e incessante lavoro di traduzione, di lettura e di restituzione. Nadine constata
l’importanza del paradosso, costitutivo della pulsione, da cui procedono l'umorismo e il
motto di spirito. La pulsione non consente che la vita possa rimanere nelle rigidità del
sistema, qualunque esso sia, confessionale, professionale, sociale. Le norme e le regole
sono imprescindibili. La dissidenza non significa vivere senza norme e senza regole.
Cogliere questo è straordinario per la vita di ciascuno di noi.
Altro contributo dell’ebraismo è lo sforzo di andare oltre il naturalismo delle cose, che
non sono contabili e non vanno mai prese come tali. Il senso non è già dato: è sempre da
acquisire. Ciascuno di noi si trova preso in un nomadismo, l'indice dell'infinito della
parola.
Ben distante dall'atteggiamento contemplativo del discorso occidentale e filosofico,
Nadine Shenkar scrive:
Potremmo dire che l'ebraismo vede nell'arte, non l'esperienza fissata dalle forme, ma la
vita stessa. Soltanto la vita nel suo eterno e inquietante mutamento è l'arte suprema. Al
limite, l'ebraismo, lungi dall'essere una religione, è un'arte di vivere.ii[ii]
Con questa nota passo la parola a Enzo Santese.
ENZO SANTESE Nel momento in cui la dottoressa Silvestrini mi ha proposto di
partecipare a questo incontro, pensavo che il repertorio di opere pubblicate in italiano
-2-
fosse più limitato. Ero rimasto alle notizie che mi aveva dato un amico, un pittore di
talento, padovano di nascita e veneziano di adozione, Tobia Ravà, il quale fa entrare di
peso la sua cultura ebraica dentro la sua operatività artistica. Più volte abbiamo avuto
occasione di parlare di Nadine Shenkar.
Dico questo perché in realtà i libri di Nadine Shenkar — bisogna dirla tutta perché
stiamo presentando le cose non in forma celebrativa, ma in forma analitica, come ama
essere lei — sono difficili. Solitamente in queste situazioni si dice che l'opera si legge tutta
d'un fiato. Sì, si può leggere tutta d'un fiato, però per evitare di rimanere ubriacati dalla
gran mole di contenuti, di sostanza che contengono questi libri — è un consiglio che do
anche a voi — essi devono essere centellinati lungo un periodo che permetta una
sedimentazione critica dei libri stessi.
Sono critico militante —termine tecnico anche se infelice, che serve a dire che sono uno
di quei critici che non scrive stando dietro il tavolino del suo studio, ma va negli atelier
degli artisti, anche nelle condizioni più infelici. Di recente sono stato a Sarajevo, per capire
qualche cosa di quello che fanno, di quello che dicono, di quello che è il polso e la
temperatura dell'arte contemporanea.
Visto che sono un critico militante, è chiaro che la mia adesione, non dico totale, ma
quasi, va al libro L'arte ebraica e la cabala. È un libro straordinario. Potrei dire delle cose
anche sugli altri, però, mi consenta Nadine Shenkar, che è un'intellettuale insigne, che ama
anche il contraddittorio, stranamente, per esempio nel romanzo storico, l'ho vista
raffrenata nella necessità di definire tutto. Tutto è lindo, definito. Esattamente il contrario
di quanto prevede l'arte ebraica. Questo depone a favore della sua ricchezza, perché lì
mantiene un tono saggistico in una determinata direzione, quello della storia. È un libro
che si fa leggere con una certa facilità, quello. Anche quello è denso di nozioni, di stimoli e
questo sul piano culturale lo trovo estremamente valido perché richiede il continuo
confronto con un repertorio di nozioni che molte volte ci sfuggono o perché le abbiamo
avute in un'età scolare, o perché non le abbiamo avute per nulla.
L'arte ebraica e la cabala non l'avevo letta interamente se non per alcuni passi grazie al
personaggio di cui ho parlato prima. Questa volta, con molto piacere l'ho letto. In qualche
punto l'ho letto più volte. Qualche volta sono andato a verificare citazioni, episodi, perché,
dicevo, questo è un libro che richiede questo tipo di approccio.
La cabala è un monumento immane, chiamiamolo così. Babelico. È in pratica la
tradizione ebraica. Questo monumento è ingigantito dalla somma di contributi critici che
lo hanno riguardato lungo il corso dei decenni, anzi dei secoli. Questo libro inizia con una
serie di citazioni. Già qui allarma, da un punto di vista. Quando il lettore arriva a metà
libro, capisce che senza quelle citazioni il libro stesso non avrebbe ragioni di esistere.
Queste citazioni, di cui voglio leggervene alcune, hanno un senso diretto con quanto vado
affermando. La prima, dall'Esodo (20, 2-5): "Non avrai altro Dio all'infuori di me". Però
laddove cominciamo a chiederci problematicamente, ad accostarci problematicamente alle
affermazioni, o alle negazioni, c'è quest'altro punto: "Non ti farai idolo né immagine
alcuna di ciò che è lassù nel cielo né di ciò che è quaggiù sulla terra né di ciò che è nelle
acque sotto la terra. Non ti prostrerai dinanzi a loro".
-3-
Il problema dell'idolatria, uno dei problemi centrali di questo saggio, ha turbato le
coscienze di molti intellettuali ebraici, perché molte volte si è pensato, e si pensa tuttora,
che senza l'immagine non vi sia il supporto necessario per entrare nella dinamica delle
cose.
Questo libro inizia con questa serie di citazioni da cui, poi, discende tutta una serie di
riflessioni connesse con la problematica che vi ho citato poc'anzi. Una cosa interessante, a
mio avviso, è quel cumulo di spazi vuoti tra una citazione e l'altra che lungi dall'essere
delle pause funzionali, sono dei momenti che servono per connettere l'una citazione
all'altra. È come se noi cogliessimo il senso implicito delle citazioni stesse, proprio a partire
da quelle pause.
D'altro canto un intellettuale di un certo valore, Walter Benjamin affermò che il suo
sogno era quello di scrivere un libro tutto di citazioni, perché, diceva, la citazione non è
conchiusa in sé, non è raffrenata dal contesto. La citazione è un'occasione per tutta una
serie di proliferazioni e germinazioni intellettuali che possono portare verso approdi i più
diversi.
Il primo capitolo di L'arte ebraica e la cabala si intitola "Fatti e paradossi". I fatti sono
quelli che appaiono iscritti nei libri sacri e sono a essi correlativi. Sui paradossi in questo
libro si parla parecchio. Il paradosso sta già nel comandamento: "Non creare delle
immagini". L'immagine può essere l'origine di un processo peccaminoso che è quello che
porta all'idolatria. Il paradosso sta già nel comandamento. "Non ti farai idolo né immagine
alcuna di ciò che è lassù nel cielo". Non si può rappresentare Dio perché è
irrappresentabile. Non si può neanche nominarlo, perché Dio non è nominabile. Su questo
c'è una serie di riflessioni che Nadine Shenkar propone alla nostra attenzione. Dico
"propone alla nostra attenzione" non a caso perché in questo libro non c'è nulla di
conchiuso. È una serie di questioni aperte, nelle quali siamo invitati a entrare dando il
nostro contributo. È un po' lo stesso meccanismo procedurale, con il quale Nadine Shenkar
si avvicina alle opere d'arte: le legge. Prima, giustamente, Antonella Silvestrini ha detto
che dipinge il suo parere… Hai detto così?
ANTONELLA SILVESTRINI Le sue tele.
ENZO SANTESE Le tele. Ero disattento per l'ennesima volta. Dipinge le sue tele con la
parola. Questo è il suo procedimento. La sua lettura è una concatenazione di parole in cui
rimaniamo intrappolati dalla seduzione della pittura. Non è un veicolo attraverso cui
arriviamo all'opera d'arte. È, come dire, una replica dell'opera d'arte attuata attraverso la
parola.
Questi sono libri molto belli. Tra parentesi li trovo molto aderenti a quella necessità di
far avvicinare il pubblico alla pittura. Io che milito in una determinata area operativa,
debbo riconoscere che molte volte ci facciamo prendere la mano dal gusto della parola, più
che dal senso di ciò che essa rappresenta. E il gusto della parola ci porta lontano dalle cose,
ci porta lontano dalle persone, ci porta lontano dai pensieri. Nadine Shenkar, con il suo
esempio — perché qui c'è teoria, ma soprattutto prassi — ci dice che nell'opera d'arte
bisogna entrare. E bisogna entrare con il peso della nostra sensibilità. Ognuno di noi ha la
-4-
capacità per dire qualcosa di un'opera d'arte, per individuare all'interno di un'opera un
elemento che possa poi essere amplificato in un'analisi qualsivoglia.
La questione dell'immagine. La constatazione che l'immagine è irrappresentabile e
invisibile sembra un paradosso anche questo. Ciò che ognuno vede non è l'immagine. Lo
dice supportando la sua argomentazione con dei convincenti argomenti. E poi la questione
del nome. L'ho già detto prima. “Non nominerai il nome di Dio“, perché il nome è
innominabile e anzi — usa questo termine — anonimo. Sembra addirittura un ossimoro.
Nella prospettiva ebraica l'oggetto artistico non esiste in sé. Non ha alcuna ragione di
essere se non è il veicolo dello spirituale e del sacro. Allora da qui notiamo come in alcuni
periodi della storia talune personalità ebraiche siano ricorse all'immagine, ma vi siano
ricorse o per una finalità meramente decorativa, oppure per una finalità conoscitiva.
La prima creazione ebraica fu l'inizio e fu anche il massimo dell'espressione ebraica, la
Tenda del Tempo, il Tabernacolo del deserto eseguito da Bezaleel e da altri artisti "secondo
misure e formule fornite loro direttamente dall'alto", per una sorta di ispirazione divina.
Quindi non hanno avuto un modello a cui rapportarsi. Hanno avuto l'ispirazione
direttamente dall'alto del cielo. Il tabernacolo è una sorta di microcosmo del mondo.
Quando gli uomini vi entrano, ricevono contemporaneamente, oltre che i rudimenti della
religione, anche lezioni di fisica e di astrofisica.
Questa prima opera degli ebrei si chiamava, nel linguaggio originale Spazio-Tempo.
Questo concetto, secondo me, è autenticamente rivoluzionario perché è come dire che
tremila anni fa si enunciava, pur in embrione, il concetto dello spazio tempo ripreso poi
nel XX secolo da Einstein. C'è anche da dire che la Tenda del Tempo è movimento. E anche
quando è a riposo, la sua anima è la mobilità del servizio che prende vita in essa. C'è il
canto, la musica, le preghiere.
Fin dalle prime battute in questo libro si capisce una cosa che è peraltro fondamentale
per comprendere l'anima ebraica. Per gli ebrei il movimento è tutto. L'opera d'arte, come la
concepiamo noi occidentali, è di per sé troppo statica, una sorta di prigione provocata da
quella forma di auto compiacimento che può anche portare all'inerzia. Invece movimento
significa continua attività nello spazio e nel tempo.
C'è un'interessante connessione tra la cabala e la scienza contemporanea. Tra la fine del
quattrocento e gli inizi del cinquecento, i nostri umanisti, i primi intellettuali del
rinascimento, cominciano a studiare la lingua ebraica. Studiano la lingua, scoprono la
cabala, i testi della sapienza, della saggezza legata a questa tradizione.
Ma a questo punto c'è da dire, lo dice esplicitamente Nadine Shenkar, che cosa sia la
tradizione. È la parola scritta. La parola tradizione traduce anche la parola tempo e taglio.
A questo punto mi viene in mente — non è tanto difficile questo collegamento — il taglio
di Fontana che, anzi, risulta paradigmatico. L'origine della parola tempo, in qualche modo,
si può rapportare anche a alcuni esiti dello Spazialismo del nostro autore. Taglio fra che
cosa? Taglio fra il passato che non torna più e il futuro che ancora non esiste. Questo taglio
che cosa sarebbe? È il presente. E quindi, di nuovo, una situazione assolutamente fluida
nella mentalità e nella cultura ebraica.
C'è al fondo della sensibilità ebraica una sorta di pessimismo. Questo non emerge da
questi libri, anzi. Un autore, di cui si parla ampiamente nell'Arte ebraica e la cabala, e non
poteva essere diversamente, è Chagall, forse l'autore più rinomato nel campo della cultura
-5-
ebraica. C'è in Chagall questo tentativo, a dir la verità ben riuscito, di staccare l'uomo da
terra, ma di non allontanarlo troppo dalla terra stessa che l'ha generato. In questo si
testimonia sia il senso di gravità verso la terra, che è sempre molto presente nell'arte
ebraica, sia la tensione verso l'alto che è espressa attraverso la musica: il suonatore di
violino o di organetto.
Nadine Shenkar opera come insegnante all'Accademia di Belle Arti Bezalel di
Gerusalemme. Chi abbia visto l'ultima Biennale di Venezia, si rende conto come la cultura
figurativa ebraica sia sempre all'avanguardia per certi aspetti. È una cultura che prospetta
le cose senza mai richiedere all'interlocutore il momento della contemplazione. C'è sempre
un momento in cui il fruitore entra o in conflitto con questa cultura o la sposa appieno. Io
sono rimasto a metà strada. Vi ringrazio.
ANTONELLA SILVESTRINI Passo la parola a Nadine Shenkar.
NADINE SHENKAR Buonasera a tutti. Veramente grazie per tutte le parole. Sono
completamente d'accordo con Antonella. Anche con Enzo, ad eccezione di una piccola
cosa che discuteremo tra poco.
È veramente impossibile, adesso, parlare di cinque libri insieme che sono tanto, tanto
differenti. Akiba è un romanzo ambientato nel I secolo, L'amante di Granada nell'Andalusia
del Medioevo, L'arte ebraica e la cabala è un saggio filosofico e di estetica. I due libri della
collana "L'arca" sono sull'arte stessa. Dunque è molto difficile. Ma io penso di trovare, qui
con voi, il denominatore comune, perché c'è un filo rosso in tutti questi libri. Prenderò, per
esempio, il libro Gurwich e Cézanne. Comincerò con questo e poi ci sarà l'apertura sulla
questione ebraica, l'arte e la scrittura, che è proprio il titolo del nostro incontro.
Bisogna dire che un libro su Cézanne e Gurwich non fu in nulla una mia idea.
Veramente in nulla perché, quantunque lavori all'Accademia di Belle Arti Bezalel a
Gerusalemme, io insegno qualche cosa di totalmente diverso: il modo di pensare ebraico,
la filosofia ebraica e la cabala, per dare una certa ispirazione agli studenti su qualche cosa
di molto differente dallo spirito occidentale. Non insegno l'arte occidentale.
Un giorno ho scoperto a Senago, alla Villa San Carlo Borromeo, bellissima villa vicino a
Milano, una collana che si chiama "L'arca. Pittura e scrittura", in cui l'editore Armando
Verdiglione chiese, per esempio, a Fernando Arrabal di scrivere un saggio su Goya e Dalì,
oppure al filosofo francese Bernard-Henry Lévy, un saggio su Piero della Francesca e
Mondrian. Veramente per me fu una cosa quasi strana. Armando Verdiglione, una sera,
mi chiese, alla Villa Borromeo, dopo una conferenza, un saggio su Cézanne e Gurwich e
un altro su Kandinskij e Bielutin. Due pittori: uno famoso, l'altro un po' meno, come
Gurwich, che in Russia è molto famoso, nell'Occidente un po' di meno. Per fortuna ho
capito subito che Armando Verdiglione, editore, non voleva per nulla un libro in più
sull'estetica di Cézanne. Ci sono tanti libri di specialisti. Voleva qualcosa di totalmente
differente. Voleva lo sguardo, se si può dire, di una scrittrice che si occupa di filosofia e di
cabala, o Qabbalah, sul maestro francese. Dunque una certa lettura d'arte, non l'analisi di
una specialista.
Cézanne, Verdiglione non lo sapeva, era uno dei miei pittori favoriti. L'ho studiato
quando ero a Parigi con Claude Ferraton, che era curatore al museo del Louvre. Ma
-6-
Gurwich veramente non lo conoscevo. Per nulla. Nel museo della Villa Borromeo — c'è un
gran museo, splendido — ho visto molte, molte opere di Gurwich. Si può dire che
l'avventura incominciò. Fu un piacere unico. Scrivere a Gerusalemme, di fronte al deserto,
sul pittore di Aix -en-Provence, sul maestro francese, è una cosa incredibile. E tutto questo
grazie a un incontro a Milano con l'editore che ha avuto questa idea strana di fare un
saggio su questi due artisti.
Ciò che mi ha sempre affascinato di Cézanne, a Parigi piuttosto che a Gerusalemme, fu
soprattutto la lontananza dai sistemi di tutte le scuole. La solitudine immensa, l'aspetto
rivoluzionario di Cézanne era, per me, familiare. Era l'aspetto dei profeti di Israele che
conosco bene.
La dimensione del deserto è per me essenziale: ogni giovedì, per esempio, me ne vado
nel deserto da sola per mezz'ora, o un'ora, verso il Mar Morto, il punto più basso nel
pianeta, cosa straordinaria, per meditare o per vedere lo spettacolo incredibile del deserto
di Giudea e di questo mare insolito. La dimensione del deserto, per me, è una cosa molto
importante.
Penso sia necessario, adesso, forse difficile, parlare ebraico con voi, perché senza questa
lingua non si può capire assolutamente nulla. Il deserto in ebraico, in francese, in italiano,
in inglese, è qualche cosa in cui non c'è niente. In ebraico la parola, il vocabolo, è midbar.
Voi sapete che ogni vocabolo di questa lingua si svolge intorno a tre lettere. Dunque in
ebraico midbar e medaber sono lo stesso vocabolo. Medaber vuol dire “parlare” [lett.
“parlo”, “parla”, “parlante”] e midbar “deserto”. Il deserto parla: Ha-midbar medaber. È
incredibile, ma è normale per la lingua ebraica. Dunque, quando ci troviamo nel midbar,
nel deserto, sentiamo la parola, sentiamo il silenzio, sentiamo la parola interiore. Non ci
sono i media e la televisione che ci sono qui. Ha-midbar medaber. La parola sorge dal
deserto. La parola primordiale. Il segreto dell'alef, la prima lettera dell'alfabeto ebraico,
sorge dal deserto.
Come i profeti di Israele, Cézanne si è allontanato da tutte le influenze. La sua vita fu
solitaria. Fu una vita abbastanza dura. Una vita di meditazione sul valore della sua pittura.
Ha cercato, nella visione interiore, l'aldilà della natura. Cézanne, per me, ha cercato
veramente l'aldilà della natura. Non di vivere al livello della natura, che è molto
occidentale, greco, non di vivere al livello del sette, ma dell'otto.
Spiego questa cosa strana. Vivere al livello della natura è fare ciò che la natura
domanda. Per esempio c'è una tavola e io posso mangiare tutto. Invece per gli ebrei —
questi pazzi — non è possibile mangiare tutto. Il maiale, ad esempio, no. Questi non sono
riti religiosi: è un errore considerarli tali. È una tecnica che la Bibbia ha elaborato per
essere sempre svegli. Nella vita sessuale è lo stesso. La conclusione è che sempre la mente
controlla l'istinto. C'è un controllo permanente della mente sulle abitudini. Dunque vivere
al livello del sette o dell'otto, non è la stessa cosa. Do-re-mi-fa-sol-la-si oppure do-re-mi-fasol-la-si-do non è lo stesso.
Il candelabro, la menorah, ad esempio, che era nel mishkan, nella Tenda del Tempo, in
questo spazio-tempo nel deserto — splendido tabernacolo dai sette bracci — è la
perfezione della natura e, secondo i sacri testi — la Torah, il Talmud e la Qabbalah — il
candelabro è il simbolo e la metafora dell'albero della Vita. È la perfezione della natura.
-7-
Invece, la hannukiah che ha otto bracci, non si trova in un tempio: si trova in casa.
Quando c'è la festa di hannukah, poco prima di Natale, la festa della luce. La hannukiah è il
simbolo dell'otto. Per esempio la circoncisione del bambino si fa all'ottavo giorno della sua
vita. È un cambiamento sulla natura. Che cosa dice l'ebreo? La natura non è perfetta.
L'uomo vuole perfezionare e cambia. È una cosa assolutamente incredibile per un greco,
per esempio. Come cambiare qualche cosa di naturale? È vivere al livello dell'otto!
Cézanne sapeva che l'arte è costruzione permanente della vita. Ha comunque cercato
una regola, si può dire una Torah personale, e cercandola senza fine, lui è risalito
all'origine. Ha ricusato il mondo dell'immagine che è idolatria per un ebreo, e l'ha
modificato con la costruzione e con la modulazione. Questo cammino solitario è difficile.
Cézanne ha incontrato, secondo me, l'infinito. Questo è quello che io sento con Cézanne. E
comunque molte opere di Cézanne non sono compiute. Questo è interessante. Scriveva: "Io
devo lavorare costantemente, ma non già per giungere al finito che attira l'attenzione degli
imbecilli". Scriveva così. E Baudelaire, il poeta francese, aveva già scritto nel 1845 sulla
differenza tra un pezzo fatto e un pezzo finito. C'è una differenza essenziale.
Nella tensione compiuto-incompiuto, Cézanne rimane sempre nel movimento, nella
fuga pazza del famoso testo della Bibbia il Cantico dei cantici. Un canto molto melodico e
anche speciale dal punto di vista del tempo e dello spazio. "È la voce del mio amato. Lui
viene varcando i monti, saltellando i fossi" [cf. Ct 2,8]. Se avete letto questo testo, in
italiano, in francese, in inglese, questo è veramente di fuga permanente, di movimento. Lui
la cerca, lei lo cerca. Sempre. Non sono mai insieme. Sempre in viaggio l’uno verso l’altro.
E quando lui viene nel suo giardino, metafora dell'incontro con la donna, subito lei dice:
"Fuggi, amato, come una gazzella" [cf. Ct 2,17]. È incredibile. Si vedono e non si vedono
mai.
E questa ricerca — per cui Rabbi Akiba, un famoso maestro del I secolo, ha detto che il
Cantico dei cantici è il passaggio più importante della Torah, è il Kodesh ha kodashim, il Santo
dei Santi — è la metafora del viaggio permanente del popolo di Israele. È una ricerca
infinita. E questo infinito è davanti o dietro di noi nella parola originaria, nel bereshit, nel
Genesi. Per me Cézanne fu veramente il pittore del bereshit. Con lui tutto incominciò. Con
lui tutto fu fondamentalmente nuovo. Nessuna imitazione, nessuna ricreazione, ma un
movimento permanente. Per esempio nei Giocatori di carte o nella Casa dimenticata,
vediamo che c'è sempre una meditazione sull'aldilà del tempo, sul tempo originario. Nelle
sua nature morte, per esempio, Cézanne nominava, come Adamo nel giardino, le cose per
la prima volta. La vita è linguaggio. L'artista è immagine delle corrispondenze. Nei
paesaggi, ad esempio nella famosa montagna Saint Victoire, la montagna diviene subito,
per lui, l'uomo stesso nella ricerca infinita, nella domanda laggiù, nella nudità dell'essere.
Il paesaggio, per Cèzanne, diviene passaggio, diviene transito come nei ritratti.
Molteplicità, per esempio, delle prospettive. Tempo che non sarà mai lineare. In questo
punto c'è una differenza essenziale tra la visione del tempo ebraico e la visione del tempo
greco.
Lei, Santese, ha detto che c'è un pessimismo nell'ebraismo. Non è vero. Io difenderò
questo punto… Come ha detto? Un critico…
ENZO SANTESE …militante.
-8-
NADINE SHENKAR Perfetto. Anch'io, su questo punto, sono militante: è proprio il
contrario.
ENZO SANTESE Dovrei avere il microfono anch'io per militare.
NADINE SHENKAR Bisogna, bisogna.
Nella filosofia greca, prima di tutto, Platone scrive nel Timeo — questo famoso testo
sulla creazione — che non ci fu mai creazione. L'atomo, per i greci, è eterno. Non è stato
mai creato. La materia è sempre là e il demiurgo è venuto come un artista a creare il
mondo. È totalmente differente. Nel pensiero greco, non c'è bereshit, non c'è genesi [bereshit
significa lett. “in principio”, e indica il primo libro della Torah]. Non c'è inizio e non c'è
fine. C'è un tempo eterno, l’immagine mobile di un'eternità immobile [Ndr:“L’immagine
mobile dell’eternità”: Platone, Timeo 38b]. Il tempo greco è, in Platone, in Aristotele, in
Democrito, in tutti i greci, un circolo chiuso, perché non c'è creazione. Il mito greco l'ha
detto benissimo. Cronos, il dio del tempo, mangia i figli. Che cosa vuol dire? Questo
tempo è il tempo della disperazione. Il popolo ebraico e il popolo greco sono molto vicini
nel paesaggio, nel tipo fisico e in molte altre cose. Ma sono tanto differenti nel modo del
pensiero. E si sono affrontati.
Se si vede, per esempio, la tragedia greca, Edipo deve sposare la madre e uccidere il
padre, perché? Il destino l'ha deciso. E lui non può scappare da questo destino. Invece, per
la Torah, è totalmente l'inverso: la storia di Babele, il diluvio, le catastrofi. Ci sono questi
momenti e, tuttavia, anche momenti come nei salmi e nella mistica. C'è tutto. Se c'è un
popolo nel mondo che è il simbolo dell'ottimismo è il popolo ebraico. Dopo tutto ciò che è
successo a noi, occorre veramente fede per essere vivi.
Non è questione di ottimismo o di pessimismo, è questione metafisica. Se c'è bereshit, se
c'è un inizio, il tempo ebraico è una spirale, non è un circolo chiuso. È una differenza
essenziale. Per esempio, il filosofo francese ebreo e francese Bergson non aveva mai letto,
forse, i testi ebraici. Non li conosceva. Ma era ebreo. C'è, dunque, un modo del pensiero
ebraico e fu Bergson che a criticare in La pensée et le mouvant e in altri testi, il tempo
occidentale. Ha detto che il tempo occidentale è chiuso. È un tempo di fatalità e totalmente
lineare. Non è un tempo di movimento, un tempo di creazione, un tempo psichico. Per
esempio, si dice "un momento, un momento, un istante!". In ebraico non si può dire. Per
dire, ad esempio, in autobus: "Un momento, un momento", in ebraico si dice: "Regah,
regah". Regah non è un tempo lineare, è il battito del cuore.
Attraverso la luce, la prospettiva, i colori, i pensieri, i sensi, Cézanne evoca sempre il
suo paesaggio interiore. Si può dire che dipinga un paesaggio metafisico.
Per quanto riguarda Gurwich, era un pittore ebraico russo, lo chiamavano il Cézanne
russo. C'è un incontro tra Cézanne e Gurwich. Dappertutto si nota la stessa complessità di
piani. Tra i due, si nota la stessa deformazione leggera degli oggetti o l'esagerazione:
l'assenza di prospettiva centrale e l'orchestrazione degli elementi al punto che l'idea
prevale sulla realtà. Gurwich, come Cézanne, traduce le impressioni sensoriali in una
meditazione sull'essere e sul suo posto nel mondo. Come diceva Cézanne, bisogna
introdurre una somma sufficiente di azzurrati per far sentire l'aria. Per Gurwich c'è la
-9-
stessa tensione compiuto incompiuto. Il motivo, per Gurwich, non è mai il soggetto.
L'ossessione, è un'ossessione per l'infinito o per il principio femminile. Per Gurwich è
molto importante — lo vediamo dalle sue tele — il principio femminile e il suo mistero, la
sua solitudine. Eva rivelatrice di Adamo. Cézanne e Gurwich sono, per me, tutti e due
legati all'avvenire, perché sono legati al loro passato originale.
E qui c'è una cosa per me molto curiosa. Si dice, per esempio in latino, e anche in
francese e in inglese, progresso, progress. Gresso, andare e pro, davanti. È logico: progress è
andare avanti. Ma gli ebrei, che fanno tutto all'inverso di tutti gli altri, scrivono che il
progresso non si dice progress. L'idea è progress, ma in ebraico si dice qidmah. La radice è di
tre lettere, lo abbiamo già imparato: qdm (qedem). Qidmah, radice qedem: tre lettere. Questo
qedem vuol dire l'originario. Dunque l’ebraico qidmah per progress, andare via, andare
avanti, si può dipingere così: i piedi dell'ebreo davanti e la testa nell'origine. Una danza. Il
Talmud. Per l'uomo che è capace di andare, bisogna che la sua testa sia all'origine, con il
riferimento della memoria. Altrimenti, non c'è nessun tragitto. Questo è il Talmud che è
totalmente differente dall'idea di progresso.
Abbiamo parlato e sentito cose veramente molto interessanti sulla questione dell'arte,
dell'immagine e dell'idolatria. Il vero problema dell'arte ebraica, come avete già sentito, è
che nel pensiero ebraico il concetto del tempo e della natura sono completamente diversi
dalla nozione greca di tempo. Do un esempio personale. Parlavo essenzialmente il
francese e l'italiano a casa. Ho studiato il latino e l'inglese e un giorno ho voluto anche
studiare l'ebraico. Mio fratello aveva un maestro, studiava l'ebraico e perché io no? Ho
deciso dunque di imparare l'ebraico da sola. Ho preso la Bibbia ebraica e una traduzione
francese e ho cominciato a studiare. Avevo quindici anni e fu un'esperienza veramente
molto strana. Ad esempio, nel testo, vaiomer vuol dire “lui diceva”, ma io ho capito subito
che nella grammatica ebraica era futuro. La forma grammaticale vaiomer è un futuro: ma
perché, allora, la traduzione francese, come quella italiana, dice che è un passato?
Veramente una cosa incomprensibile. Dall'altra parte “Ve-ahavta lereakha kamokha” [Lv
19,18], “tu dovrai amare l'altro prossimo come te stesso”, la forma grammaticale ahavta è
un passato. Assolutamente. E la traduzione di Ve-ahavta è un futuro: “tu dovrai amare”.
Sono diventata pazza. Questo futuro si traduce con un passato e il passato con un futuro.
Dopo tre mesi di riflessione intensa, per non avere avuto l'umiltà di chiedere a un
professore, ho capito che una lettera, la vav, cambia il futuro nel passato e il passato nel
futuro [Ndr: la Shenkar allude alla regola del waw o vav “inversivo” (vav hahipuk): Scholem
diceva che quello del vav hahipuk è un tempo “messianico”; il vav “inversivo” modifica la
qualità dell’azione espressa dalla forma verbale, trasformando l’azione incompiuta in
compiuta, e viceversa]. Dunque, quando un ebreo legge la Bibbia ebraica, gli occhi vedono
un futuro, ma la mente legge un passato. Quando gli occhi vedono un passato, si legge un
futuro. Il risultato di questa avventura è che non c'è passato, non c'è futuro, non c'è tempo.
Non ci sono altri tempi nella Bibbia. Non è come il francese in cui ci sono quindici tempi. È
semplice. Un futuro che è un passato e un passato che è un futuro. È Einstein prima del
tempo. E l'entusiasmo è incominciato da quel giorno. La follia dello spirito ebraico.
Per gli ebrei l'arte non è una cosa fissata, un'immagine. Un'immagine per un ebreo é
qualche cosa di morto. Occorre il movimento. Avete visto che in Israele o a New York gli
ebrei sono sempre in movimento. Molto agitati. Non sono gente di meditazione. C'è un
- 10 -
movimento permanente: un'idea qui, un'idea là. Non sono tranquilli. Mai. Non ho mai
visto un ebreo tranquillo. Sarebbe un titolo bello per un nuovo libro: Non ho visto mai un
ebreo tranquillo.
Per gli ebrei l'arte è soprattutto parola e scrittura. È l'ossessione ebraica, la parola.
Parlano tutti molto, moltissimo. Dunque c'è la necessità di fuggire nel deserto ogni
giovedì. Per gli ebrei tutto è scrittura e tutto è parola, come nella dialettica del Talmud in
cui tutto è domanda e tutto è paradosso. Il Talmud incomincia con una domanda e finisce
con una domanda. Settanta trattati, incredibili, è il Talmud. E se si fa una domanda a un
ebreo, lui risponde con un'altra domanda. È automatico. Dunque una moltitudine di
domande, di voci, di interpretazioni, secondo il proprio modo, il proprio pensiero e la
propria sensibilità. La scrittura come permanente rottura dei vasi. Senza questa rottura,
l'essenza della parola non sarebbe sopportabile. La luce ci farebbe tutti ciechi. E questa
parola è veramente emergenza del deserto, come abbiamo detto. Deserto che è apertura,
separazione dal conformismo, dall'universo chiuso. Noi ebrei non solo siamo usciti
dall'Egitto, ma usciamo ogni anno nella Pasqua del deserto. Usciamo sempre dall'Egitto.
Non è una cosa storica, finita, chiusa. Bisogna uscire sempre dall'Egitto. Questa si chiama
libertà.
Il deserto di Giudea, dove i profeti hanno scoperto la parola; o il deserto del Negev —
dove Abramo andava con la sua idea dell'infinito, del Dio che non si vede, dell'En sof,
come si dice nella Qabbalah —, o il deserto del Sinai, in cui Mosè andò ai confini della
parola. Nel testo ebraico è scritto achar ha-midbar [cf. Es 3,1]: “fuori dal deserto”, più
lontano dalla parola che si ascolta. Come diceva Emmanuel Lévinas, il grande filosofo
ebreo francese, il popolo ebraico è sempre in viaggio altrove, perché il luogo dell'ebreo è il
luogo della parola. Il deserto parla, l'abbiamo detto: ha-midbar medaber. L'ebreo non è
soltanto una parola, l'ebreo è divenuto un libro.
Come diceva Edmond Jabès, questo magnifico scrittore francese, egiziano e ebreo — è
tradotto in italiano — , nel suo modo meraviglioso: “L'ebreo scrive il libro che Dio gli ha
dato”. Un paradosso incredibile. L'ebreo scrive il libro che Dio gli ha dato, nella sua
infinita libertà. Interpretazione infinita del nome che non si può nominare, il nome di Dio.
Jabès scrive “Scrivere è proprio rivoluzionario. È proprio ebraico perché si prende la
penna dove Dio si ritirò dalla parola. Scrivere è il tentativo suicida di colpire la parola fino
alla sua ultima sparizione (…)”. Dove è la parola? La parola è sempre in cammino, è
sempre nella decostruzione dell'alef.
L’alef, la prima lettera dell'alfabeto, è così: c'è una piccola lettera, la jota greca, yud, la
vav, di cui abbiamo già parlato, e un'altra yud. Questo è l'alef: vav, yud, yud. Se adesso faccio
una meditazione sull’alef, avviene qualche cosa di molto, molto curioso. Voi sapete che le
lettere ebraiche sono anche cifre. Non ci sono mai nei libri antichi cifre arabe. Sono lettere.
Sempre. Soltanto nell'Israele moderno ci sono numeri. Ma, in effetti, non ci sono numeri:
solo lettere. La lettera alef è uno. Ma in ebraico la parola alef vuol dire anche elef, “mille”.
Adesso se si vede l’alef, ci sono tre lettere: yud, vav, yud. L’alef è fatta di tre lettere. Questo
yud corrisponde a dieci e vav è corrisponde a sei. Dunque io posso dire senza esagerazione
che l’alef è l'uno, assolutamente l'uno. L’alef è mille e anche dieci, dieci, sei: ventisei. Ma
ventisei non è a caso perché è il tetragramma, le quattro lettere del nome di Dio. Si può
dire che uno è anche echad. Echad è tredici. Dunque la relatività straordinaria che abbiamo
- 11 -
ascoltato è questa: non si può dire che l’alef è un sistema, l'uno. No. L’alef è uno, è mille, è
tredici, è ventisei.
Nel Sefer Yetzirah, un libro antichissimo della Qabbalah, forse uno dei primi — il libro
della creazione — c'è una citazione molto interessante. È scritto che Dio creò il mondo con
ventidue lettere dell'alfabeto e con le dieci sefirot. Le sefirot sono modi di pensiero e sono
dieci. Dunque trentadue sentieri della hokmah, della sapienza sul trono. E lo creò con sfar.
Una cosa incredibile. È la stessa parola. Sfar è la cifra, il numero. Sefer è il libro e sippur è il
racconto che c'è nel libro. Dunque, come Dio creò il mondo? Con il numero, con il libro e
con il racconto. È bellissimo. È impossibile da tradurre: “Lasciate ogni speranza voi
ch'entrate”.
Il midrash [ndr: tecnica rabbinica di esegesi biblica, dal verbo darash, “cercare”,
“domandare”: si distingue in midrash halakhah, di contenuto legale e normativo, e midrash
aggadah, di carattere omiletico-edificante, più libero], l'allegoria, il Midrash Rabbah, un libro
molto interessante e importante di duemila anni fa, scriveva che ci furono seicentomila
ebrei nel Sinai, quando la Torah fu data. E ci sono — dice lo stesso testo — seicentomila
lettere nella Torah antica. È vero. Quindi ogni ebreo ha la sua lettera nella Torah. Quindi
ognuno è una lettera. Io sono una lettera. Non so quale. Dunque quel mondo sarà un
mondo senza morte, perché la parola non ha fine. Questa parola è primordiale: è vita, non
è un margine, come Kafka diceva. Diceva: “Noi non siamo un popolo di pittori”. È vero.
Non c'è Tiziano, non c'è Leonardo da Vinci, non c'è nulla. Chagall, Modigliani, Soutine,
Pissaro: alcuni ebrei, ma non è la bellezza dell'arte italiana. È qualche cosa d'altro.
L'arte ebraica è l'arte della vita. È più importante, per un ebreo, fare un uomo con
valori, con spina dorsale, che fare opere d'arte. È una concezione. Al Davide di
Michelangelo — che è a Firenze — e che è tanto bello, l'ebreo preferisce il Davide della
Bibbia che all'inizio è un piccolo gangster e poi un pastore e poi ancora un re che non ha
fatto cose non tanto belle. Tutto questo è Davide. Non è una statua. Le mille facce di un
uomo. Scrivere è rompere tutte le appartenenze, tutto il déjà vu. Scrivere è divenire parola.
Questo è interessante perché in ebraico, quando dico divenire parola, non è un modo di
dire: è molto serio. In ebraico “parola” si dice davar. E “atto” si dice davar. Se io penso
qualche cosa e non lo faccio, non esiste. Parlare di carità e non fare, è nulla. Nella Bibbia,
devarim sono le parole che lui ha detto. Devarim sono i fatti, gli atti. Ed é la stessa parola.
Shem, in ebraico è il nome. C'è un paradosso, per me, straordinario: lo shem, l'essenza.
Per esempio, io posso dire: Antonella la conosco. Questo nome, Antonella, è il nome di
una persona che io conosco benissimo. Non in ebraico perché la parola shem è anche sham.
Sham vuol dire, in ebraico, lontano. Sham: laggiù. Dunque l'essenza non è l'immagine. Non
conosco Antonella. È impossibile. Il nome, shem, è sempre laggiù, sham. La stessa parola.
Per finire, perché probabilmente sarete molto stanchi di tutto questo ebraico, per
concludere sull'arte e la scrittura e questi miei libri, o piuttosto per non concludere, se ogni
conclusione è morte, o forse per dire che scrivere è il passare del visibile (l'immagine),
all'invisibile — Shema Israel [ndr: “Ascolta, Israele”, preghiera quotidiana degli ebrei,
formata attorno ad alcuni passi biblici: Dt. 6,4-9; 11,13-21; Nm 15,37-41] è ascoltare, non
vedere — e il passare del finito all'infinito? Come diceva Edmond Jabès nel suo libro
meraviglioso, uno dei primi, Dal deserto al libro, che fu edito nel 1983 dall'editore italiano
Elitropia: "Se l'ebreo è l'altro, è perché cercando di essere a ogni costo se stesso è ogni volta
- 12 -
di più un essere di nessun luogo". Qui si scrive la sua differenza. È la distanza in cui si
mantiene. Grazie.
ANTONELLA SILVESTRINI Non ci si stanca mai di ascoltare la musica delle parole di
Nadine Shenkar e l'eco della scrittura millenaria di cui dà testimonianza. Con le sue parole
salutiamo e ringraziamo Enzo Santese per il suo intervento. Ringraziamo ancora la Banca,
gli sponsor, ciascuno di voi e Nadine Shenkar per il suo poema, per il suo canto.
i[i]
N. SHENKAR, L'arte ebraica e la cabala, Spirali 2000, p. 71.
Ibid., p. ?.
ii[ii]
- 13 -