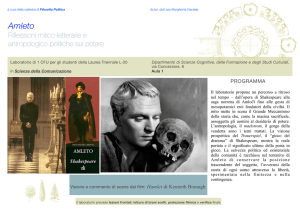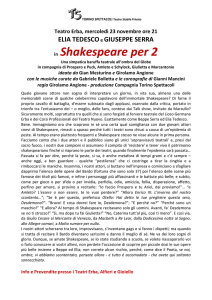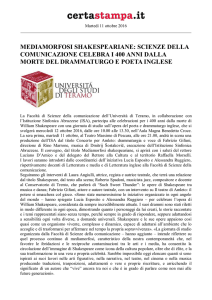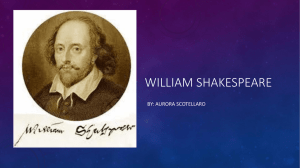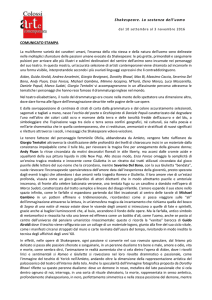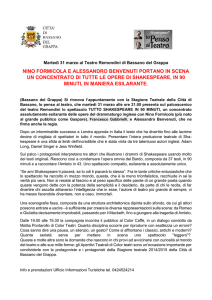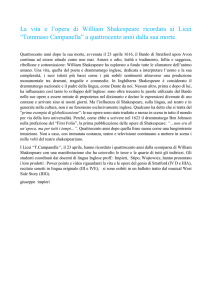Seminario Primaverile
26-29 marzo 2015
Reg. Num. 6188 – A
VILLA NAZARETH
Tutto il mondo
è palcoscenico
Villa Nazareth – Fondazione “Comunità Domenico Tardini” ONLUS
Via D. Tardini 33-35, 00167 Roma – Tel. 06-895981, Fax. 06-6621754
Siti web: www.villanazareth.org, collegio.villanazareth.org, www.vnservizi.it
E-mail: [email protected], info@vnservizi.
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
PROGRAMMA
“TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO”
Giovedì 26 Marzo
In giornata: arrivo a Villa Nazareth ed accoglienza
Ore 19:00 Celebrazione Eucaristica
Ore 20:00 Cena e saluto del card. Achille Silvestrini, di mons. Claudio
Maria Celli, della prof.ssa Angela Groppelli, del prof. Carlo Felice Casula,
del dott. Piersilverio Pozzi, della dott.ssa Rosarita Di Gregorio, del dott.
Massimo Gargiulo, del dott. Stefano Pepe e della dott.ssa Anna Berloco
A seguire: Presentazione del seminario a cura degli studenti della
Commissione Cultura
Venerdì 27 Marzo
Ore 10:00 Conferenza:
“Shakespeare e la pratica scenica oggi”
Relatore:
Gabriele Lavia attore e regista
Moderatore: Chiara Strano
Ore 13.00 Pranzo
Ore 16.00 Conferenza:
“I commedianti non sono capaci di tener segreti: dicono tutto”
Relatori:
Piero Boitani Professore Ordinario di Letterature Comparate presso
Sapienza – Università di Roma
Moderatore: Roberto De Biasi
Ore 19:20 Celebrazione Eucaristica
2
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
Ore 20:00 Cena
Ore 21:30 Via Crucis
Sabato 28 Marzo
Ore 08:15 Presentazione ed incontro dei nuovi Gruppi Regionali
Ore 10:00 Laboratorio degli studenti:
“Inside Mr. Shakespeare”
Relatore:
Simeone Latini attore, regista e autore
Moderatrice: Chiara Mantini
Ore 13:00 Pranzo
Ore 17:00 Conferenza:
“Sappiamo ciò che siamo, ma non ciò che potremmo essere”
Relatori:
Franco Ricordi filosofo, attore e direttore del Teatro Stabile d’Abruzzo
Moderatrice: Gaia Coltorti
Ore 19:30 Primi Vespri della Domenica delle Palme
Ore 20:00 Cena
Ore 21:00 Rappresentazione teatrale:
“Sogno di una notte di mezza estate”
Domenica 29 marzo
Ore 11:30 Benedizione delle Palme e Celebrazione Eucaristica
Ore 13:00 Pranzo e conclusione del seminario. Saluti e partenze
3
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
INDICE
Introduzione, p. 5
Biografie dei relatori, p. 6
Articolo n. 1: “La
vita di un uomo di teatro” di Giorgio Melchiori, p. 9
Articolo n. 2: “Il
teatro elisabettiano” di Giorgio Melchiori, p. 18
Articolo n. 3: “Il
teatro di Shakespeare” di Agostino Lombardo, p. 20
Articolo n. 4: Introduzione a “Il
Articolo n. 5: “Amen
Vangelo secondo Shakespeare” di Piero Boitani, p. 28
per la caduta di un passero” di Piero Boitani, p. 34
Articolo n. 6: Introduzione a “Shakespeare
Articolo n. 7: “Passione
filosofo dell’essere” di Franco Ricordi, p. 47
e violenza in Romeo e Giulietta” di René Girard, p. 53
Articolo n. 8: “Shakespeare
inventò una lingua nuova” di Nadia Fusini, p. 63
Articolo n. 9: “How
much did the Jesuits influence Shakespeare?” di Clare Asquith, p. 66
Articolo n. 10: “Tuh
beh oar nat tuh beh? That was the question” di Charlie Cooper, p. 68
Bibliografia e Filmografia Parziale, p. 70
Ringraziamenti, p. 74
4
John Everett Millais, Ofelia (1852); Londra, Tate Gallery.
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
INTRODUZIONE
Questo seminario su Shakespeare nasce per indagare più a fondo questa figura
impareggiabile della letteratura inglese e probabilmente mondiale. Ci troviamo, tra il 450°
anniversario della sua nascita e il 400° della morte, in un irripetibile “biennio
shakespeariano”; e mentre in tutto il mondo si susseguono spettacoli, riadattamenti e
festival, ci è sembrato non solo opportuno, ma persino obbligatorio tornare a interrogarci
sull’enorme eredità che il “cigno dell’Avon” ci ha lasciato.
Insieme ai nostri ospiti Piero Boitani e Franco Ricordi cercheremo di capire come
Shakespeare, attraverso la miriade di personaggi che popolano le sue opere, abbia
influenzato molti miti del moderno e abbia, per dirla con Bloom, “inventato l'umano”,
lasciando su di noi, a tutt'oggi, un'impronta significativa. Inoltre, insieme a Simeone Latini e
Gabriele Lavia, ci addentreremo nella pratica scenica e non solo scopriremo come il testo
shakespeariano diventa parola viva e capace ancor oggi di emozionare, ma anche cosa
significa essere interprete di Shakespeare oggi.
Gaia Coltorti
5
Johann Heinrich Füssli, Prospero, Miranda e Calibano – particolare (1812);
Londra, Tate Gallery.
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
BIOGRAFIE DEI RELATORI
Piero Boitani
Professore Ordinario di Letterature Comparate all’università "La Sapienza" di Roma, dove
si laurea in Lettere nel 1971. Nel 1975 ottiene il Ph.D. in Letteratura Inglese e Italiana
dall‘Università di Cambridge e ivi insegna Lingua e Letteratura Italiana come Lector.
Insegna poi Letteratura Americana e Lingua e Letteratura Inglese nelle Università di Pescara
e Perugia come Professore Incaricato; è professore Ordinario di Lingua e Letteratura Inglese
dal 1981, mentre nel 1985 è chiamato alla "Sapienza" di Roma su quella cattedra per
passare poi nel 1998 a Letterature Comparate. Tra gli altri, è autore dei seguenti
volumi: Schemi della cultura inglese nel Medioevo, The Tragic and the Sublime in Medieval
Literature, L‘ombra di Ulisse, Il genio di migliorare un’invenzione, Letteratura europea e
medioevo volgare, Il grande racconto delle stelle, Il Vangelo secondo Shakespeare,
Riconoscere è un dio. Ha tradotto e curato, tra gli altri, Sir Gawain e il cavaliere
verde, Cimbelino di Shakespeare, La nube della non conoscenza. Ha curato le opere di
Chaucer per Einaudi. È stato Presidente dell‘Associazione Italiana di Anglistica e della
Società Europea di Studi Inglesi (di cui è Presidente Onorario); è Fellow della British
Academy e della Medieval Academy of America, e socio dell'Accademia dei Lincei.
Franco Ricordi
Filosofo e uomo di teatro, nasce nel 1958 a Milano. Esordiente nel 1978 con Luca Ronconi,
poi attore con Paolo Stoppa, Gabriele Lavia, Eduardo de Filippo, si laurea in filosofia nel
1983 specializzandosi sull'ermeneutica con Hans Georg Gadamer. Inizia poi la carriera
registica, che lo ha visto spesso interprete dei suoi allestimenti, i quali hanno riscosso un
caloroso successo di critica e pubblico; in particolare si è dedicato a Shakespeare, alla
drammaturgia antica, al teatro tedesco dell'età romantica, ma si è anche costantemente volto
ai contemporanei introducendo in Italia autori come Rohmer e Noren. Di Shakespeare ha
diretto e interpretato Romeo e Giulietta, Macbeth, Amleto, Il mercante di Venezia. Si
ricordano, tra gli altri, Medea e Fedra di Seneca, Anfitrione di Heinrich Von Kleist, Canti
nel
deserto e Gli
inganni
dell'infinito di Giacomo
Leopardi, Le
ceneri
di
Roma e Orgia di Pier Paolo Pasolini, Creditori di August Strindberg. È autore dei libri Lo
spettacolo del nulla, Essere e libertà, Shakespeare filosofo dell’essere, Pasolini filosofo
della libertà, e dei saggi Le mani sulla cultura, Ideologia di Amleto, Filosofia del bacio. Nel
marzo 2003 è stato nominato Direttore del Teatro Stabile d'Abruzzo, con sede a L'Aquila.
Simeone Latini
Attore, regista e drammaturgo cagliaritano. Nei primi anni ’90 diviene attore giovane
dell’attuale Teatro Stabile di Sardegna. Dopo due anni di esperienza in tutti i teatri
dell’Isola, si trasferisce a Roma, dove rimane per quasi dieci anni, alternando esperienze
televisive in Rai e Mediaset (fiction e pubblicità internazionali) ad un’intensa attività sul
palco nei più prestigiosi teatri italiani, ma anche all’estero, dove mette a frutto la
conoscenza delle lingue inglese e spagnola, in Inghilterra, Croazia, Portogallo, Spagna,
6
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
Francia e Messico, dove vince il premio nazionale della critica, con una pièce pirandelliana.
Esaurita l’esperienza romana si trasferisce a Londra, divenendo voce ufficiale di National
Geographic Channel e della FAO, ed entra in contatto con le principali compagnie di teatro
britanniche. Da qualche anno è nuovamente in Sardegna, dove avvia una fruttuosa
collaborazione con le principali realtà teatrali sarde, come attore, protagonista di alcune
produzioni, e regista. Le stesse attività le svolge anche in ambito cinematografico, nazionale
ed internazionale, come autore/regista di cortometraggi pluripremiati in Europa, e di un
feature film, recentemente in programmazione nelle sale.
Gabriele Lavia
Nato a Milano nel 1942, si diploma nel 1963 all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica
Silvio d’Amico di Roma. È stato diretto da importanti registi – fra cui G. Strehler, G.
Sbragia, M. Missiroli – per i quali ha interpretato personaggi classici (Re Lear, 1973, e
Amleto, 1978 di W. Shakespeare; I masnadieri di F. Schiller, 1982; Il principe di Homburg,
di H. Von Kleist, 1982; Don Carlos di F. Schiller, 1983). Tra i suoi primi spettacoli c’è Il
Drago di Schwarz prodotto nella stagione 1966/67 dal Teatro Stabile di Genova, con il
quale ha uno stretto rapporto di collaborazione dal 2000. È stato interprete di numerose
produzioni cinematografiche tra le quali: Girolimoni (1972) di Damiani, Profondo rosso
(1975), Inferno (1980) e Non ho sonno (2001) di Dario Argento, Voci (2000) di Giraldi, Il
quaderno della spesa (2003) di Tonino Cervi e Salvatore - Questa è la vita (2006) di Gian
Paolo Cugno, oltre a, fra i più recenti, La leggenda del pianista sull’oceano (1998) e Baarìa
(2009) di G. Tornatore, e Ricordati di me (2003) di G. Muccino. Dal 1980 al 1987 è stato
condirettore del Teatro Eliseo di Roma. Dal 1997 al 2000 è stato direttore del Teatro Stabile
di Torino. Dirige inoltre la propria Compagnia Lavia. Nel 2004 ha vinto il Premio “Olimpici
del Teatro” per la miglior regia e per il migliore spettacolo di prosa con L’avaro. Dal
dicembre 2010 al dicembre 2013 è stato Direttore del Teatro di Roma. Dal primo febbraio
2014 è consulente artistico presso il Teatro della Pergola di Firenze. È stato regista di
numerosi spettacoli teatrali. Di Shakespeare ha diretto Riccardo III (1989), Otello (1993),
Riccardo II (1996), Molto rumore per nulla (2006), Misura per Misura (2007), Macbeth
(2007). Oltre a questi si ricordano: L’uomo, la bestia e la virtù (1992), Il giuoco delle parti
(1996) e Sei personaggi in cerca d’autore di L. Pirandello. Per il cinema ha diretto Il
principe di Homburg (1983), Sensi (1986) e La lupa (1996). Contemporaneamente, si è
occupato di regie di opere liriche fra cui la mozartiana Così fan tutte (2008) e Attila (2011)
di G. Verdi.
7
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
William Blake, Oberon, Titania, Puck con fate danzanti (c. 1786);
Londra, Tate Gallery.
8
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
Articolo n. 1: “La vita di un uomo di teatro”, Giorgio Melchiori
Da G. Melchiori, Shakespeare: genesi e struttura delle opere, Laterza, Bari 2004
Questa consapevolezza (del fatto che, grazie al suo grande mestiere, Shakespeare sapeva
meglio di ogni altro che i testi che egli forniva agli attori si sarebbero realizzati solo in
quanto spettacolo, e nel corso di questa realizzazione avrebbero subito necessariamente
alterazioni di ogni sorta, ndr), che trova la sua conferma proprio nello stato in cui i testi dei
suoi drammi sono giunti fino a noi, fa giustizia sommaria delle fantasiose teorie secondo cui
l’attore Shakespeare, la cui effettiva esistenza è testimoniata da pochi documenti biografici,
avrebbe soltanto prestato il suo nome come drammaturgo ad altri personaggi che si facevano
scrupolo di rivelare la loro identità, che per ragioni politiche – come Christopher Marlowe,
che avrebbe preferito farsi credere morto nel 1592, ma avrebbe continuato a fornire copioni
attraverso di lui –, chi per ragioni di dignità di rango, come Francesco Bacone Lord
Verulam, o – secondo le più recenti appassionate argomentazioni d un agguerrito manipolo
di cosiddetti “antistratfordiani” – Edward De Vere conte di Oxford. I documenti cui si è
accennato sono una manciata di atti di battesimo, di matrimonio, di morte, qualche contratto
e altre carte di carattere legale che lo rivelano accorto uomo d’affari, e il suo testamento.
Perfino il giorno della sua nascita (terzo degli otto figli dell’agiato commerciante di pellami
John Shakespeare nella prospera cittadina di Stratford-upon-Avon, nella quale aveva
ricoperto cariche pubbliche durante il regno di Maria la cattolica) è congetturale: il
certificato di battesimo è datato 26 aprile 1564 e si è voluto che la nascita risalisse a tre
giorni prima, il 23 aprile, per coincidere con il giorno della morte, che si sa con sicurezza
avvenuta il 23 aprile di cinquantadue anni dopo, nel 1616. L’insistenza su questa data si lega
alla creazione del mito di Shakespeare come bardo della nazione inglese, in quanto il 23
aprile è il giorno di san Giorgio, patrono dell’Inghilterra. Ma le date che contano, più di
quelle legate alla vita privata (il precoce matrimonio il 28 novembre 1582 con Anne
Hathaway, di otto anni più anziana di lui, la nascita nel maggio 1583 della figlia Susanna, e
nel febbraio 1585 dei gemelli Judith e Hamnet – quest’ultimo morto all’età di undici anni)
sono quelle relative alla carriera di un uomo di teatro. Sugli inizi non si sa praticamente
nulla, benché in una recente indagine sui suoi “anni perduti” (Shakespeare: The Lost Years,
Manchester 1985) Ernst Honigmannn abbia messo in luce i suoi legami con famiglie
cattoliche del Lancashire.
L’apprendistato teatrale. Che nel 1592 egli fosse già noto negli ambienti teatrali
londinesi è testimoniato dal violento attacco del poligrafo e drammaturgo Robert Greene,
morto il 3 settembre di quell’anno, in un opuscolo pubblicato postumo dall’amico Henry
Chettle sotto il titolo Un soldino di spirito acquistato con un milione di penitenza:
un corbaccio venuto dal niente, fattosi belle con le nostre penne, che, col suo cuore di tigre nascosto
sotto la pelle di attore crede di poter declamare versi sciolti meglio di tutti voi; ed essendo un
assoluto Johannes factotum, si ritiene nella sua presunzione di l’unico Scuoti-scema [Shakescene]
nazionale.
Va detto che poco dopo il Chettle fece ammenda per aver pubblicato gli insulti del
suo amico scomparso, rendendosi garante dell’integrità professionale del giovane attore.
9
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
L’attacco del Greene contrine edue allusioni indirette a drammi storici che vanno sotto il
nome di Shakespeare, quasi a testimoniare la reputazione da lui raggiunta, oltre che come
attore, anche come autore – autore entro i limiti correnti per le opere destinate ai teatri
pubblici, che erano sempre frutto della collaborazione fra varie persone impegnate
nell’industria dello spettacolo. E infatti i pochi testi a stampa di opere drammatiche
appaiono senza nome d’autore, a partire dal Titus Andronicus, pubblicato nel 1594 con
l’indicazione che era stato rappresentato da ben tre compagnie minori: i Derby’s (o Lord
Strange’s) Men, i Pembroke’s Men e i Sussex’ Men, tutte scomparse durante la peste che
infuriò dagli ultimi mesi del 1592 fino alla metà del 1594, provocando la chiusura quasi
continua dei teatri pubblici londinesi. Fu appunto l’epidemia di peste a segnare uno
spartiacque nella carriera teatrale di Shakespeare, quale la si può ricostruire da questo e da
altri documenti. Gli inizi sono quelli di un qualunque aspirante attore del tempo, che viene
assunto a giornata dall’una o dall’altra compagnia in ruoli secondari; ma Shakespeare
dovette rivelare ben presto non solo le sue qualità mimiche, ma che la sua eccezionale
capacità di collaboratore alla stesura dei copioni, tanto da divenire talora il principale
responsabile di un lavoro che, prendendo a prestito il termine dal linguaggio
cinematografico, si potrebbe definire di sceneggiatore.
Nascono così la tragedia senechiana Titus Andronicus, le prime tre parti, sul
travagliato regno di Enrico VI, di quella che diverrà una tetralogia storica, e almeno una
commedia, The Taming of the Shrew. È a questo punto che gli viene chiesto di collaborare
alle modifiche da apportare a un dramma che avrebbe potuto incontrare difficoltà censorie,
Sir Thomas More, e forse a un altro dramma storico, Edward III. Quando la peste costringe i
teatri a chiudere, egli doveva probabilmente aver già completato – questa volta quasi
esclusivamente in proprio – la stesura di un altro paio di commedie, The Comedy of Errors,
The Two Gentlemen of Verona, e della grande tragedia storica Richard III, ed aveva forse già
avviato opere che, nell’incertezza del presente, si sarebbero potute affidare ai ragazzi dei
teatri privati, non soggetti ai provvedimenti di chiusura dei locali pubblici: tale potrebbe
essere l’origine di Love’s Labour’s Lost, A Midsummer Night’s Dream, e della tragedia lirica
Romeo and Juliet, concepite forse inizialmente per un uditorio più “letterato”. Si noti che
Love’s Labour’s Lost è il primo dramma a stampa di Shakespeare che rechi (nel 1598) il
nome dell’attore nel frontespizio, quasi per conferirgli dignità letteraria.
Poeta e letterato. È significativo che proprio negli anni in cui infuria la peste
Shakespeare pubblichi, questa volta con tanto di nome sul frontespizio, i due poemetti Venus
and Adonis (1593) e The Rape of Lucrece (1594), dedicandogli al conte di Southampton:
vuol così dimostrare a un nobile patrono di non essere soltanto “poeta” di teatro, rimasto
inoperoso nella stagione morta. La dimostrazione è completamente riuscita: benché si tratti
di una rivisitazione di modelli poetici tradizionali e particolarmente in voga in quegli anni,
Shakespeare li riscopre e li arricchisce di una nuova densità di significato, come fa del resto
anche con tutti i “generi” drammatici da lui affrontati nella sua carriera. La grande qualità di
Shakespeare non consiste nell’inventare nuovi modelli espressivi nel campo del teatro come
in quello della poesia, ma di trasformare dall’interno quelli esistenti, si tratti del poemetto
ovidiano della tragedia di vendetta o classica o d’amore, della commedia plautina, di quella
borghese, romantica o romanzesca, della cronaca storica o leggendaria. Al pari dei drammi, i
due poemetti sono opere di carattere pubblico, sia pur rivolte al lettore colto anziché allo
10
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
spettatore partecipe. Un diverso tipo di partecipazione è quello invece richiesto da un’altra
forma tradizionale di espressione poetica, anch’essa particolarmente coltivata dai letterati
inglesi nell’ultimo decennio del Cinquecento: il sonetto. Certamente Shakespeare aveva
cominciato assai per tempo a comporre sonetti, e probabilmente continuò a scriverne di
quando in quando fin verso il 1609, allorché un editore li diede alle stampe senza il
consenso dell’autore. Ma in tal caso i destinatari, come già nel 1598 faceva osservare un
letterato che ne era a conoscenza, erano “i suoi amici privati”, fra i quali quei componimenti
circolavano manoscritti.
Chamberlain’s Men. La grande occasione viene per Shakespeare con la riapertura dei
teatri nel 1594, al termine dell’epidemia di peste. L’intero mondo dello spettacolo si
riorganizza, scompaiono alcune delle compagnie più importanti del passato, come i Queen’s
Men, e, accanto ai sopravvissuti Admiral’s Men gestiti dall’impresario Philip Henslowe con
il grande attore Edward Alleyn, si costituiscono, attingendo i migliori elementi delle
compagnie dissolte, i Chamberlain’s Men, guidati dall’astro sorgente della nuova
generazione di attori, Richard Burbage, figlio a sua volta di un altro impresario teatrale. È di
questa compagnia che Shakespeare entra a far parte fin dalla sua fondazione, in qualità di
full sharer, ossia compartecipe a quota intera, con Burbage e altri consoci, nella gestione
dell’impresa teatrale. Un’impresa che, sotto il patronato del Lord Ciambellano, Henry Carey
Lord Hunsdon, diviene ben presto la più temibile rivale degli Admiral’s Men, gestiti da
Henslowe, benché non disponendo di un teatro proprio, fosse talora costretta ad operare in
locali di proprietà dello stesso Henslowe. La fortuna della compagnia si fonda non soltanto
sulla qualità e sull’affiatamento dei singoli attori, ma anche sull’aver trovato in William
Shakespeare il fornitore ideale di copioni di successo, nell’ambito sia della tragedia e del
dramma storico sia della commedia. La reputazione raggiunta nel giro di pochi anni da
Shakespeare come “poeta di teatro” è testimoniata già nel 1598 da Francis Meres, che nel
suo trattato Palladis Tamia, fondato puntigliosamente sul principio del parallelismo tra
antichi e moderni, scrive:
Come si riteneva che l’anima di Euforbio vivesse in Pitagora, così la dolce anima arguta di
Ovidio vive nel mellifluo Shakespeare dalla lingua mielata, come testimoniano il suo Venus and
Adonis, la sua Lucrece, e suoi zuccherosi sonetti che circolano fra i suoi amici privati ecc. come
Plauto e Seneca vengono considerati i migliori per la commedia e la tragedia fra i Latini, così fra gli
Inglesi Shakespeare eccelle in entrambi i generi sulla scena; per la commedia lo testimoniano il suo
Gentlemen of Verona, il suo Errors, il suo Love’s Labour’s Lost, il suo Love’s Labour’s Won, il suo
Midsummer Night’s Dream, e il suo Merchant of Venice; per la tragedia i suoi Richard II, Richard
III, Henry IV, King John, Titus Andronicus, e il suo Romeo and Juliet.
L’elenco, più preoccupato di simmetrie formali (sei commedie e sei tragedie) che
della completezza dell’informazione, è certamente approssimativo: non vi figurano ad
esempio i tre drammi sul regno di Enrico VI o la commedia The Taming of the Shrew,
mentre vi appare un misterioso Love’s Labour’s Won, del quale non esiste alcun’altra traccia;
ma testimonia che Shakespeare, oltre ad aver assicurato alla sua nuova compagnia i copioni
già scritti in precedenza, continuava a produrne altri, dalla tragicommedia The Merchant of
Venice, all’avvio di un nuovo ciclo di drammi di storia inglese, con Richard II ed Henry IV.
Fu proprio quest’ultimo dramma storico, nel quale spiccava il personaggio comico e
11
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
codardo di Sir John Oldcastle, a mettere per qualche tempo in crisi la compagnia tra il 1596
e il 1597; infatti, il Lord Ciambellano suo patrono morì nell’agosto 1596, e la sua carica,
che esercitava un esteso controllo sugli spettacoli pubblici e privati, passò, anziché a suo
figlio, a un altro nobile, William Brooke Lord Cobham, discendente di quel Sir John
Oldcastle presentato in maniera tanto irrispettosa quanto divertente in Henry IV. La
compagnia rimase fedele alla famiglia del suo patrono, assumendo il nome di Lord
Hunsdon’s Men, ma fu costretta dal nuovo Lord Ciambellano a ritirare il dramma
considerato infamante per il suo antenato. Si rimediò allora cambiando il nome del
personaggio che aveva recato offesa da Sir John Oldcastle a Sir John Falstaff: è questa
l’origine casuale di un nome che è divenuto patrimonio dell’umanità intera. La figura di
Falstaff, il grasso e maturo esponente di tante debolezze umane, con la sua formidabile
carica di vitalità e simpatia, venne sviluppata la punto che non bastò un solo dramma a
contenerla: ad una prima parte di Henry IV ne seguì una seconda, e in seguito Shakespeare
dovette costruire intorno al personaggio una commedia tutta sua, The Merry Wives of
Windsor. Nel frattempo, comunque, nel marzo 1597, il Lord Ciambellano Cobham era
morto e la carica ritornò alla famiglia di Lord Hunsdon, così che dopo un intervallo di sette
mesi la compagnia poté continuare indisturbata la sua attività con il nome di Chamberlain’s
Men. I successi ottenuti con i drammi storici e con commedie come Much Ado about
Nothing inducono la compagnia ad una nuova avventura: quella di costruirsi un teatro
nuovo, dato che le autorità della City non le avevano permesso di utilizzare la sala chiusa
del Blackfriars recentemente acquisita. Il grande Globe, con il suo motto simbolico, Totus
Mundus agit istrionem, che identifica appunto il teatro con il mondo, si apre nel 1599, ed è
Shakespeare a fornire i primi copioni ad esso destinati quell’anno: la conclusione del grande
ciclo storico, Henry V, è la prima tragedia romana Julius Ceasar. Le certezze offerte dallo
spazio privilegiato occupato dalla compagnia sembrano agire da stimolo creativo al
drammaturgo per un’attività sempre più intensa: ecco e commedie festose, As you like it,
Twelfth Night, e la tragedia destinata ad aprire una nuova era nel teatro moderno, benché
prendesse le mosse da una tradizionale tragedia di vendetta: Hamlet. Ad essa seguiranno i
drammi concettualmente più complessi di Shakespeare, Troilus and Cressida, All’s Well
That Ends Well e Measure for Measure, variamente denominati “commedie nere”, o
“drammi problematici”, in quanto in essi, come del resto in Hamlet, quel che conta non è
più l’esito lieto o tragico, ma il dibattito interno, il processo dialettico attraverso il quale si
giunge ad una conclusione che rimane necessariamente aperta.
King’s Men. Il primato della compagnia in Inghilterra è consacrato definitivamente
nel 1603, allorché, alla morte della regina Elisabetta, il nuovo sovrano, Giacomo I, la prende
direttamente alle sue dipendenze. I Chamberlain’s Men divengono King’s Men, gli attori del
re. È, fra il 1603 e il 1608, la stagione delle grandi tragedie, moderne e classiche: Othello,
King Lear, Macbeth, Antony and Cleopatra, Coriolanus, oltre all’enigmatico e forse
incompiuto Timon of Athens. Shakespeare continua coerentemente a presentare la sua
visione del mondo e del teatro, della quale Hamlet era stata la premessa. Una visione
insieme tragica e aperta, consapevole dell’impossibilità di raggiungere certezze; una visione
ancora dialettica, intesa a mettere a nudo piuttosto che a sciogliere i nodi essenziali della
condizione umana. Il suo dominio dell’espressione scenica è totale – i suoi personaggi,
modellati sapientemente sulle capacità mimiche dei suoi compagni di lavoro, sono sempre
12
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
più ambigui e complessi, il loro linguaggio è sempre più denso e polisemico, e per questo
tanto più autenticamente poetico.
Ma proprio nel momento del suo massimo raggiungimento, il mondo teatrale deve
affrontare una nuova e più grave crisi: il predominio della componente puritana nella
borghesia londinese, dovuto, come si è avuto occasione di dire, a fattori eminentemente
politici e sociali, tende a togliere ai teatri pubblici l’elemento di base del loro uditorio.
Quando, nel 1608, una nuova epidemia di peste provoca ancora una volta la chiusura per
qualche mese dei teatri pubblici, le compagnie maggiori entrano (o rientrano) in possesso
delle sale private, approfittando del fatto che, per ragioni politiche, le compagnie dei ragazzi
ne erano state bandite. Pur conservando il glorioso Globe, i King’s Men fanno ormai sempre
più uso dell’elegante sala del Blackfriars, ex refettorio del convento dei frati bigi,
espropriato all’epoca della Riforma protestante.
Blackfriars. In base a diversi documenti che lo vedono ormai più attento a quanto
accade nella nativa città di Stratford anziché a Londra, si è pensato che intorno al 1608
Shakespeare, pur rimanendo uno dei principali gestori della compagnia dei King’s Men,
rinunziasse alla sua attività di attore per ritirarsi a Stratford, seguitando a fornire da lì
copioni ai suoi compagni. Quello che cambia sostanzialmente è il genere dei copioni forniti,
in quanto essi dovevano ormai rispondere alle esigenze non soltanto e principalmente del
pubblico estremamente composito e partecipe di un teatro come il Globe, ma anche e
soprattutto di quello più sofisticato del Blackfriars. Nuovi nomi di drammaturghi di
successo si sono nel frattempo affermati, fornendo copioni essenzialmente alle compagnie
di ragazzi; e con la crisi di queste ultimi, essi offrono i loro servigi a quelli di adulti che
subentrano ai ragazzi nei teatri privati. Il genere più nuovo e in voga è ormai quello
variamente designato come tragicommedia, o pastorale, o romance – dramma romanzesco.
È ad esso che si adegua ora Shakespeare – ma lo fa in maniera del tutto originale,
trasformando ancora una volta il “genere” dall’interno, arricchendolo di complessi
significati simbolici, che stabiliscono una continuità fra queste sue ultime opere – Pericles,
Cymbeline, The Winter’s Tale, The Tempest – e i drammi dialettici e le grandi tragedie dei
primi anni del secolo. L’ultimo dei suoi romances, ossia The Two Noble Kinsmen, del 1613,
è addirittura scritto in collaborazione con un giovane esperto del genere, John Fletcher, e gli
attori che raccoglieranno in seguito le opere drammatiche di Shakespeare si faranno
scrupolo di annoverarlo fra esse. Verrà stampato soltanto nel 1634, con un frontespizio che
annuncia la sua rappresentazione con grande successo al Blackfriars da parte dei “Servitori
di Sua Maestà”, i King’s Men, e aggiunge: “Scritto dai memorabili luminari [memorable
worthies] del loro tempo, Mastro John Fletcher e Mastro William Shakespeare,
Gentiluomini”.
È probabilmente con lo stesso Fletcher che Shakespeare collabora anche per la sua
ultimissima fatica teatrale, un inatteso ritorno al dramma storico. La sorte di quest’opera,
Henry VIII, è emblematica: ad una delle sue prime rappresentazioni pubbliche nel teatro
Globe, il 29 giungo 1613, a causa di una salve di artiglieria che faceva parte degli effetti
scenici la paglia del tetto prese fuoco e il teatro intero fu completamente distrutto dalle
fiamme. È ben vero che esso venne ricostruito nel giro di pochi mesi, ma ormai la sede
usata dai King’s Men per i loro spettacoli era quasi esclusivamente il Blackfriars. La
distruzione del primo Globe conferma il ritiro definitivo di Shakespeare dall’attività teatrale.
13
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
La rinuncia al teatro non può che preludere, per chi del teatro aveva fatto la sua vita, alla
rinuncia della vita stessa. E infatti, meno di tre anni dopo, il 23 aprile 1616, Shakespeare
muore nella sua casa di Stratford. Il testamento, preparato e firmato con mano incerta un
mese prima, quando evidentemente sentiva prossima la morte, contiene lasciti di 28 scellini
e 8 pence a testa, per l’acquisto di anelli-ricordo da consegnare “ai miei compagni John
Heminge, Richard Burbage e Henry Condell”: ancora una volta il teatro. Richard Burbage
era il versatile attore intorno al quale si era costituita la compagnia nel 1594, l’attore sulla
cui presenza fisica e vocale Shakespeare aveva costruita la splendida galleria dei suoi
personaggi più memorabili, a partire dai sovrani come Riccardo III, Riccardo II, Enrico V –
e poi Amleto, e ancora, con l’avanzare degli anni, Otello, Lear, Macbeth, Antonio,
Coriolano; non molto più giovane di Shakespeare, Burbage morì il 13 marzo 1619, solo tre
anni dopo la scomparsa di chi aveva nutrito con la magia della parola la sua arte di attore.
Restava così ad altri due attori, anch’essi tra i fondatori della compagnia dei Chamberlain’s
Men, John Heminge (forse il “creatore” del ruolo di Falstaff) e Henry Condell, il compito di
erigere il monumento più duraturo al compagno scomparso. Essi raccolsero nel 1623 in un
unico volume in-folio – il formato della Bibbia – Commedie, Drammi Storici e Tragedie di
Mastro William Shakespeare, ossia tutti i copioni che seppero recuperare, benché qualcuno
sfuggisse alle loro ricerche, e quasi tutti, come si è detto, fossero ben lontani dall’essere
presentati “così come egli li aveva concepiti”. Sono proprio i caratteri di provvisorietà di
questa Bibbia shakespeariana a ricordarci che l’arte di Shakespeare sta nel suo mestiere,
nella sua consapevolezza che il teatro non è mai uguale a se stesso, ma è creazione collettiva
che si rinnova di giorno in giorno – non immagine della vita fissata una volta per sempre,
ma la vita stessa nella sua infinita varietà.
Le pagine che seguono si propongono di fornire una guida al teatro di Shakespeare
secondo un percorso che, al di là delle classificazioni legate a vicende biografiche, è non già
condizionato, ma piuttosto segnato dal suo mestiere di uomo di teatro.
14
Johann Heinrich Füssli, Amleto, Orazio, Marcello e il Fantasma (1780-1785);
Zurigo, Kunsthaus Zürich.
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
15
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
16
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
17
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
Articolo n. 2: “Il teatro elisabettiano”, Giorgio Melchiori
Da G. Melchiori, op. cit.
Il contesto entro il quale si svolge l’intera parabola della vita e dell’opera di
Shakespeare è tutt’altro che univoco e uniforme. È ancora frequente designare con la
definizione di «teatro elisabettiano» l’intera produzione drammatica del periodo che va dagli
anni 1570-1590 (quando furono costruiti a Londra i primi edifici adibiti esclusivamente a
rappresentazioni teatrali) al 1642 (allorché il Parlamento puritano dispose la chiusura dei
teatri). Si perde così la prospettiva storica di quei settant’anni che videro un’evoluzione
radicale della struttura socio-economica dell’Inghilterra, determinando anche in campo
teatrale almeno due fasi ben distinte: le opere prodotte durante il regno di Elisabetta I, ossia
fino al 1603, hanno caratteri ben diversi anche a livello linguistico, strutturale, e dello
spazio scenico utilizzato, da quelle apparse nei regni di Giacomo I (1603-1625) e di Carlo I
(1625-1642). Naturalmente la transizione dall’una all’altra fase non fu brusca e improvvisa,
e l’equivoco di una costante nel teatro di tutto il periodo è rafforzato dal fatto che la figura
dominante, Shakespeare, attivo dal 1590 circa al 1616, si colloca al suo centro fungendo da
cerniera più che da ponte fra i due momenti. La storiografia teatrale inglese distingue ora
perfino nella sua opera un periodo propriamente elisabettiano, che comprende la maggior
parte dei drammi di storia inglese, una decina di commedie e talune tragedie in qualche
modo sperimentali quali Titus Andronicus e Romeo and Juliet, e una fase definita Jacobean,
giacomiana (dal re Giacomo I), che va dalle grandi tragedie, attraverso un gruppo di
tragicommedie amare, fino ai drammi romanzeschi degli ultimi anni della sua carriera.
L’utilità di una tale distinzione, pur tanto approssimativa, sta nel suo rimando all’evoluzione
del contesto storico, che converrà ora illustrare sommariamente.
L’avvento al trono d’Inghilterra della regina Elisabetta nel 1558 non era avvenuto
senza contrasti: c’era stato infatti durante il breve regno della sorellastra Maria, che l’aveva
preceduta, un sanguinoso tentativo di restaurazione del cattolicesimo contro la Riforma
protestante già operante nel paese. Elisabetta, perseguendo con fermezza una politica di
espansione commerciale oltre che territoriale all’estero, e di sviluppo economico accelerato
all’interno, sembrò impersonare le aspirazioni dell’intero paese, specialmente dopo la
distruzione, nel 1588, della Invencible Armada spagnola, che rese l’Inghilterra la maggiore
potenza mondiale sul mare. Ma proprio questo straordinario sviluppo della potenza
soprattutto economica inglese creava nuove tensioni all’interno del paese. La classe
mercantile che si veniva formando sgretolava il potere tradizionalmente nelle mani
dell’aristocrazia terriera; la Chiesa d’Inghilterra, che faceva capo alla persona della sovrana,
doveva confrontarsi non soltanto con una piccola minoranza cattolica legata alla Chiesa di
Roma, ma con le forze crescenti delle varie denominazioni di origine calvinista e puritana
diffuse nel ceto medio, e particolarmente fra gli artigiani e i commercianti che costituivano
la maggioranza della popolazione della City londinese. Alla fine del Cinquecento sorsero
anche altre preoccupazioni: la vecchia regina nubile non aveva eredi diretti, e gruppi di
potere interni all’aristocrazia entrarono in conflitto fra loro per assicurarsi posizioni
privilegiate al momento della successione. Lo sfortunato tentativo di ribellione del conte di
Essex, già favorito della regina, nel 1601, nel quale fu coinvolta anche la compagnia teatrale
di cui faceva parte Shakespeare, è l’episodio più significativo e clamoroso di questo
18
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
conflitto; ed è anche la conferma di quanto si è detto sulla funzione del teatro come unico
mezzo di comunicazione di massa: la compagnia dei Chamberlain’s Men era stata indotta a
rappresentare nel giorno fissato per la rivolta il Richard II di Shakespeare (che mostrava la
deposizione di un sovrano inglese) per preparare l’animo popolare all’evento.
Alla morte di Elisabetta nel 1603 il problema della successione venne risolto
richiamando al trono d’Inghilterra il re di Scozia Giacomo VI (figlio di quella regina Maria
Stuarda che Elisabetta aveva fatto decapitare), il quale poteva vantare consanguineità con la
regina scomparsa in quanto pronipote di una sorella di Enrico VIII. La scelta parve felice
perché realizzava l’unione dei due regni d’Inghilterra e di Scozia, da secoli in conflitto, e
sembrava promettere anche la pace religiosa, dato che il sovrano discendeva dalla dinastia
Stuart nota per le simpatie cattoliche. Tanto maggiore fu la delusione dei cattolici inglesi
quando il nuovo sovrano, che aveva assunto il titolo di Giacomo I, confermò la rigida
politica religiosa di Elisabetta; tale delusione è all’origine del complotto di esponenti
cattolici per uccidere il re e i membri del Parlamento, noto col nome di Congiura delle
Polveri (1605). Ma, dopo la repressione anticattolica, l’ostilità maggiore al sovrano venne
dal suo stesso Parlamento, composto da esponenti della nuova borghesia di orientamento
puritano, che, conscia della propria forza, non tollerava le continue pressioni fiscali del re
che aveva trovato le casse dello Stato depauperate e voleva mantenere una corte che potesse
competere con quelle degli altri Stati d’Europa. È un conflitto che durò per alcuni decenni
anche sotto Carlo I, succeduto a Giacomo nel 1625, e portò alla rivoluzione borghese che
depose questo sovrano — un conflitto che vide fin dall’inizio il progressivo distacco
dell’aristocrazia dalla borghesia.
19
Johann Heinrich Füssli, Lady Macbeth afferra i pugnali (1812); Londra, Tate Gallery.
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
Articolo n. 3: “Il teatro di Shakespeare”, Agostino Lombardo
Dal sito www www.ccdc.it – 18 marzo 1998
Il mio intervento non può essere altro che una introduzione a Shakespeare, in quanto
il tema in sé è troppo importante e complesso. Il punto di vista da cui mi muovo è quello del
’900, perché ritengo sia questo il secolo che ha capito meglio Shakespeare, anche alla luce
del recente “boom shakespeariano”. La domanda può sorgere spontanea: come mai oggi
siamo così interessati a Shakespeare? Soltanto una volta Shakespeare scrisse che il suo
teatro poteva durare; nella sua epoca si riteneva che solo la poesia stampata potesse resistere
nel tempo. Solo i sonetti, dunque, potevano aspirare all’immortalità. Il teatro era costituito
da copioni da dare, da dimenticare; questo era l’atteggiamento del massimo “teatrante” che
il mondo abbia avuto nell’età moderna. Il momento in cui egli sembra avere un senso del
futuro delle proprie opere si verifica quando, nel Giulio Cesare, dopo l’uccisione del celebre
condottiero, Cassio dice: “Quanti secoli venturi vedranno rappresentata da attori questa
nostra grandiosa scena in regni ancora non nati, e in linguaggi ancora non inventati!” Questa
è una profezia orgogliosa ed è l’unica che Shakespeare faccia. C’è, all’inverso, anche
testimonianza di profezie di segno opposto, come quella di Voltaire, che pure lo scoprì
all’Europa e poi, mano a mano, se ne staccò. Disse di lui: “Ha scritto molti versi felici, ma i
suoi drammi possono piacere solo a Londra e nel Canada”.
Shakespeare, a mio parere, ha rappresentato l’esperienza intellettuale più vasta e più
profonda dell’età moderna, e a spiegarlo non basta la straordinaria qualità del drammaturgo
e insieme la ricchezza della stagione teatrale alla quale appartiene, il teatro elisabettiano. Ci
sono altri autori, da Eschilo a Marlowe fino a Molière, ci sono altri grandi momenti di
civiltà teatrale che ci attraggono fortemente e tuttavia con essi, nemmeno con la tragedia
greca, non si crea un rapporto così stretto, fecondo e creativo. Già Keats diceva con frase
straordinaria: “Shakespeare is enough for us” [lettera a R. Haydon, 10 maggio 1817],
Shakespeare è abbastanza per noi, e tuttavia ancora adesso potremmo ripetere questa
memorabile frase. Perché?
Radicato nella cultura del medioevo, che seguitò ad agire in Inghilterra assai più a
lungo che in Italia, il teatro elisabettiano, pur trasformando forma e contenuti di quello
medievale, ne mantiene un elemento fondamentale, che è la straordinaria qualità non
naturalistica. È sempre legato alla vita, ma esso non si propone di esserne la riproduzione o
la imitazione, quindi diversamente dal teatro europeo contemporaneo a quello elisabettiano,
non obbedisce a nessuna delle norme che seguono invece quelle opere che intendono
imitare la vita. Di qui innanzitutto quella mescolanza di comico e tragico che era oggetto di
aspra condanna da parte dei teorici settecenteschi. Shakespeare non esita a inserire momenti
comici anche nelle situazioni più cupe, come nell’Amleto, con le battute irriverenti e i giochi
di parole del suo protagonista, i suoi becchini-clown, le sue figure risibili. Lo stesso vale per
l’Otello, dove Iago si assume la parte del buffone, o anche per il Re Lear, opera intollerabile
per alcuni momenti di asprezza, di dolore, che però è tutta intessuta di elementi comici. Si
potrebbero fare molte citazioni, dato che tutte le sue opere sono così; comico e tragico si
intersecano e i generi si dissolvono. Il fatto è che la distinzione rinascimentale tra commedia
e tragedia è completamente ignorata da Shakespeare e dai drammaturghi elisabettiani, che
proprio non conoscevano queste regole, quindi non le applicavano in nessun modo.
20
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
Così un analogo rifiuto del concetto di imitazione nel teatro shakespeariano è alla
base della libertà rispetto alle unità di tempo, di luogo e di azione. Luogo e spazio sono
affrontati in maniera completamente diversa da quella dei trattatisti del Cinquecento e assai
vicina a quella degli anonimi drammaturghi del medioevo, che non esitavano a portare in
scena l’intera storia dell’uomo. Questo avviene in tutto il teatro e in misura estrema in
Shakespeare, in quanto egli immette nell’opera molto più delle ventiquattr’ore, descrive
decenni, secoli addirittura, riversando l’intera vita di un uomo o di un regno o dilatando al
massimo un momento reale. Talvolta ci sono decenni che si esauriscono in poche battute e
poi c’è invece un momento cruciale che invade il palcoscenico, tanto è spregiudicato l’uso
dello spazio, del luogo. Pensiamo ad Antonio e Cleopatra, dove i personaggi si muovono su
ben tre continenti, ma anche alle opere più regolari, come l’Otello, che pure si svolge prima
a Venezia e poi a Cipro. L’unica regola che agisce in Shakespeare è quella intrinseca alle
necessità dell’azione drammatica, alle necessità espressive. Diceva Eduardo De Filippo: “La
sola verità del teatro è la finzione”. Questo è il vero messaggio del teatro e dell’arte in
genere. Da qui la spregiudicatezza nell’adattare le fonti storiche alla propria materia, o nel
modificare la geografia, inventando navi a Milano o in Boemia, perché suggestivo, ma
verosimile ai nostri occhi.
Anche i drammi di Seneca invadono e pervadono il teatro elisabettiano; riempiono
questi drammi scritti per lo studio e vengono presi alla lettera, riempiendo la scena di orrori,
di elementi sovrannaturali, sensazionali. Di fronte ad opere come queste ci rendiamo conto
che ogni criterio naturalistico applicato al linguaggio shakespeariano non può che portare ad
una deformazione e in ogni caso ad una riduzione del significato di queste opere.
Un teatro e un linguaggio come questi, se venivano pienamente recepiti da un
pubblico come quello elisabettiano, che vedeva le opere medievali e quindi aveva un suo
modo di intendere le rappresentazioni, non potevano essere compresi pienamente dal
Settecento. Voltaire scopre Shakespeare ma, a mano a mano, finisce per parlarne come del
“barbaro” non privo di ingegno. Nemmeno l’Ottocento, che combatté anche nel nome di
Shakespeare la propria battaglia romantica, lo comprese a fondo: c’è nella critica romantica
un elemento psicologistico che rende impossibile capire veramente l’autore. Per questo dico
che è il Novecento il secolo che può capirlo meglio, perché la cultura si può avvalere
dell’immenso materiale di studio, di critica, di filologia che i secoli precedenti avevano
elaborato. Tuttavia l’importanza del rapporto del Novecento con Shakespeare è data dal
fatto che l’arte, grazie al simbolismo, al cubismo, al cinema, alle esperienze teatrali delle
Avanguardie si è liberata da ogni concetto di teatro come imitazione, come verosimiglianza,
come mera riproduzione del reale. Sembra paradossale, ma è vero: si possono saltare alcuni
secoli e trovare un punto di incontro più fecondo tra il linguaggio di Shakespeare e il
linguaggio dell’arte contemporanea. Non è un caso che tutta l’Avanguardia italiana ed
europea degli ultimi decenni sia sempre partita da Shakespeare. Uno come Carmelo Bene
muove da Shakespeare per poi produrre le sue invenzioni teatrali. Il Novecento allora scopre
molte cose che la critica precedente non aveva individuato così pienamente; scopre, per
esempio, la teatralità di Shakespeare e degli altri grandi elisabettiani. Infatti, pur essendo
grandi poeti e letterati, essi sono innanzitutto teatranti e Shakespeare più di ogni altro, lui
che fu anche attore e comproprietario di teatri. Sono autori, anche i più colti come Marlowe
e Johnson, che considerano le loro opere come copioni nei quali tener conto anche degli
attori che hanno davanti. Shakespeare aveva alcuni grandi attori senza i quali certe parti non
21
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
sarebbero state concepite. Per esempio, il “Fool” del Re Lear non si sarebbe compreso senza
un grande Fool come Robert Armin che sapeva danzare e fare il comico. Shakespeare non
curava mai la stampa delle sue opere; scriveva copioni dei quali si disinteressava, si curava
solo del momento supremo del teatro che è la rappresentazione, dove gli attori recitano,
parlano davanti ad un pubblico. Tutto questo segna i guai che al testo sono derivati da
questo atteggiamento: dopo tanti secoli, ancora adesso non siamo pienamente sicuri che una
parola sia la medesima che Shakespeare abbia scritto. Questo atteggiamento, di Shakespeare
più che di ogni altro, fa in modo che l’autore abbia una piena partecipazione ai problemi, ai
sentimenti, agli umori dei contemporanei, abbia cioè quel rapporto con la vita e con la
società che fa del teatro la meno solitaria delle arti. È inconcepibile un teatro che non si
rivolga agli altri, che non sia comunicazione. Il teatrante deve conoscere anche i problemi,
la mentalità, la sostanza che compone il suo pubblico. Così la parola dev’essere capace di
creare una scenografia, di scavare nel significato dell’azione, di creare ogni parte del
dramma; rimane sempre la “parola del teatro”, e non la “parola della letteratura”. Io ho
faticato a capire questo, e mi è avvenuto solo a contatto con i registi, con il teatro in sé;
allora si capisce che anche i brani più alti, quelli detti d’antologia, di suprema bellezza e
suggestione, non si capiscono se non consideriamo la battuta di un dramma per quello che è,
se non la inseriamo quindi nel contesto generale. Amleto può essere compreso molto meglio
se ricordiamo che nel momento in cui lui parla ci sono persone che di nascosto lo stanno a
sentire, e allora la cosa cambia aspetto; la descrizione di Cleopatra avviene quando Antonio
crede di averla potuta abbandonare e l’evocazione da parte di Enobarbo della sua bellezza ci
dice che Cleopatra non si può dimenticare e che presto tornerà da regina ingannatrice.
Solo il Novecento ha capito questa teatralità totale delle opere shakespeariane, con la
riflessione sullo specifico teatrale, sui linguaggi di ogni strumento espressivo come il
cinema; insomma, ha capito la qualità metateatrale. Sono convinto che ogni opera d’arte
parli anche di se stessa. L’artista rappresenta una situazione, ma anche il dramma personale,
il proprio rapporto con la parola. In Shakespeare questo è estremamente evidente, egli fa
sempre metateatro. Ad esempio dietro ad alcuni suoi personaggi c’è evidente la metafora
dell’attore, come in Macbeth, le cui ultime parole ricordano l’attore: “E spegniti, breve
candela! La vita non è che un’ombra in cammino; un povero attore che si pavoneggia e si
agita per quell’ora sulla scena e del quale poi non si ode più nulla”.
Questi accenni all’esperienza teatrale sono continui, come nella parte centrale
dell’Amleto, che è dedicata alla compagnia di guitti che porterà teatro nel teatro. Dietro ci
sono attori e attrici: Cleopatra è un’attrice e vuole morire da attrice, tanto che prima di
uccidersi si fa mettere il manto, si sistema la corona in testa e muore come la gran
primadonna che è nella vita come sulla scena. Questo elemento del metateatro, della
riflessione sull’artista, della riflessione sul linguaggio, è uno degli aspetti che lega il
Novecento a Shakespeare. Ora che possiamo vedere il nostro secolo nella sua interezza
notiamo che, in fondo, nel romanzo come nel teatro, l’eroe è sparito, è un artista. I grandi
eroi della letteratura del Novecento, da Thomas Mann a Svevo a Joyce, sono gli artisti,
perché è come se lo scrittore, in un mondo difficile che ha perso le sue coordinate,
riconoscesse la figura umana solo guardando se stesso. Credo sia sul comune terreno di una
condizione di crisi che l’artista e l’uomo del Novecento possono riconoscersi in
Shakespeare. Per esempio, nei drammi storici e nelle tragedie con le loro vicende di sangue,
di lotta per il potere, le loro immagini di violenza e crudeltà si può trovare una metafora
22
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
Johann Heinrich Füssli, Gertrude, Amleto e il Fantasma del padre di Amleto (c. 1785);
Mamiano di Traversetolo, Fondazione Magnani Rocca.
23
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
penetrante di certi aspetti della condizione esistenziale, politica, sociale novecentesca. Allo
stesso modo gli elisabettiani trovavano una metafora del loro tempo nelle corti
rinascimentali italiane o nelle figure stravolte degli eroi senechiani. In questo senso ha
ragione J. Kott in un libro famoso, Shakespeare nostro contemporaneo, un’opera suggestiva
e, secondo me, insidiosa, che è stata dietro tutte le ricerche dell’avanguardia negli ultimi
decenni. Kott ha ragione quando vede questa vicinanza tra Shakespeare e noi, con la
differenza che lui lo legge soprattutto alla luce delle esperienze polacche dell’est europeo
senza guardare veramente alla realtà storico - politica dell’autore. In un certo modo
Shakespeare non è nostro contemporaneo, però è nostro padre, cioè la crisi che il suo teatro
vive, indaga e rappresenta ci riguarda da vicino non perché rispecchia o suggerisce la nostra,
ma perché ne è all’origine. Essa infatti rappresenta il passaggio dal Medioevo all’Età
Moderna in Inghilterra e il travaglio da cui l’uomo moderno è nato. È proprio la nascita
dell’uomo moderno che fa di Shakespeare il grande poeta del mondo moderno, come già
notava De Sanctis, che vedeva un passaggio di staffetta tra Dante e l’inglese, il primo che
rappresentava il mondo medievale e poi passava il testimone al secondo. Del resto Harold
Bloom nel libro discutibile, ma interessante sul canone della letteratura occidentale pone
Dante e Shakespeare al centro di quest’ultimo. [Harold Bloom, Il canone occidentale: i libri
e la scuola delle ere, Bompiani 1996].
Della trasformazione del mondo a tutti i livelli, scientifico, filosofico, letterario,
politico, economico, sociale, il teatro di Shakespeare è veicolo e specchio, ma non solo
questo. Io non credo all’arte come puro rispecchiamento, essa è anche creazione, fa la storia.
Penso che noi saremmo diversi senza Amleto dietro di noi. Per comodità empirica noi
professori accettiamo la divisione canonica della sua arte in quattro periodi: il primo dal
1590 al 1595, che culmina in una grandissima opera come Romeo e Giulietta; il secondo tra
il 1595 e la fine del secolo, che vede lo sviluppo dei drammi storici; il terzo massimo
periodo tra la fine del secolo e il 1608 con le grandi tragedie (Amleto, Antonio e Cleopatra,
Otello, Macbeth…) e il quarto tra il 1609 e il 1613 con i sonetti, scritti in precedenza, e i
drammi romanzeschi che culminano ne La tempesta. Questa divisione è accettabile, utile,
tutti dobbiamo pur avere dei parametri di riferimento, però ogni interpretazione, se vuole
andare al di là della cronologia, deve andare più a fondo e deve studiare l’atteggiamento del
poeta dinanzi a questa crisi, a questa trasformazione. Solo in questo modo possiamo
comprendere la complessità, per noi uomini moderni, di quanto Shakespeare dice e
rappresenta. In quest’epoca anche Dio è più nostalgia di Dio che realtà operante, in cui c’è
un senso struggente del passato. Da poeta, l’autore sa che deve rappresentare la realtà che
conosce, che è molto diversa, è inquieta, ambigua. Nei primi periodi la crisi è sotterranea,
poi finalmente esplode, come in Giulio Cesare, che è del 1599-1600. Quest’opera, che
dovrebbe essere una celebrazione della romanità, in realtà rappresenta la fine di ogni mito,
la caduta degli eroi, il crollo di ogni certezza. È una realtà molto inquieta quella che il
Giulio Cesare rappresenta; in fondo Shakespeare non prende nemmeno una netta posizione
di fronte alla congiura, di fronte all’uccisione di Cesare. Ci sono momenti in cui i
personaggi dicono che non sanno dov’è il nord, il sud, l’est, l’ovest. Il grande John Donne,
che è contemporaneo di Shakespeare, nella stupenda poesia Anatomia del mondo dice che il
mondo non sa più dov’è il sole e l’uomo non riesce più a trovarlo.
Sono situazioni che viviamo anche noi dopo la teoria della relatività e certe altre
scoperte: ad esempio, dopo la clonazione noi siamo sgomenti di fronte a un mondo che non
24
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
comprendiamo più, di cui non abbiamo più le coordinate. Questo viene notato dall’autore
nel Giulio Cesare e nell’Amleto, opera straordinaria del 1600-01, un dramma presente più di
qualsiasi altro dramma e opera nella cultura occidentale. Io non so di poeta o scrittore che,
ad un certo punto, non abbia nominato Amleto o non l’abbia usato. L’inesauribile fascino
dell’Amleto nasce naturalmente da mille ragioni. La motivazione basilare di questo interesse
risiede nell’intuizione, anche scenica, di questo personaggio diverso dagli altri, di questa
immagine drammatica della coscienza moderna individuata nel travaglio della sua nascita e
che da un lato rifiuta l’eredità del passato (malgrado tutto Amleto non crede alle parole dello
specchio) e dall’altro cerca di farsi strada nel labirinto del presente diventato molto incerto.
È un presente senza certezze, dove ogni aspetto della realtà, le reazioni umane e quelle
sociali, gli affetti e le idee, i sentimenti e le fedi, è sottoposto al grande dubbio, sollecitato
da Montaigne, del grande giovane Amleto alla sua grande domanda, alla sua grande
interrogazione sull’uomo, sul mondo, su Dio. La grande intuizione e la grande lezione
dell’Amleto è che l’uomo deve convivere col dubbio, deve vivere malgrado l’assenza di
punti certi. Keats già parlava di Shakespeare e della sua straordinaria capacità di vivere fra
certezze e dubbi. Quanto l’intuizione amletica sia feconda lo dimostrano le grandi tragedie,
il cui valore e spessore risulterebbe sommamente ridotto se noi le radicassimo, come pure è
stato fatto, in uno stato d’animo di personale pessimismo. D’altro canto bisogna andare al di
là delle passioni dominanti che noi vediamo in queste opere e che però non ne costituiscono
l’elemento più significativo, come ad esempio la gelosia, l’ambizione, l’ingratitudine filiale.
Ci sono analisi di straordinaria finezza di queste passioni, di questi sentimenti. La gelosia
nessuno l’ha esaminata con tanta acutezza come Shakespeare nell’Otello; però queste
passioni dei grandi personaggi vanno tutte inserite in un più ampio contesto che le veda
anche come gli strumenti con cui l’autore dà concretezza scenica. Il teatro, come l’arte, non
vive di astrazioni.
È la fine di un mondo, di un ordine, di una coerenza che sempre si profila dietro la
vicenda drammatica, sia essa quella di Otello o di Macbeth, ed è anche la nascita di un
mondo nuovo. Ci sono sempre i due mondi insieme nelle grandi tragedie, uno vecchio che
finisce e uno nuovo che faticosamente avanza, nel bene e nel male. La condizione di questo
mondo nuovo è la crisi davanti alla disgregazione dell’ordine del passato a cui non viene
contrapposto un ordine del presente perché non c’è, perché l’uomo lo sta ancora cercando. Il
mondo rimane fuor di sesto, la fine della tragedia non può più coincidere con la catarsi,
perché non coincide se non in apparenza con la restaurazione dell’ordine che la vicenda
tragica ha ferito. Le ferite inferte alla società, allo stato, alla comunità umana, potevano
rimarginarsi nella tragedia greca, perché al di sopra di quello degli uomini c’era un mondo
di dei nettamente separato, che aveva il potere di ricomporre il dissidio che si era creato,
magari dietro loro spinta. Nella moderna tragedia shakespeariana le ferite non si
rimarginano, la tragedia nel senso classico è impossibile perché presuppone un mondo che
abbia un ordine dentro di sé, dei parametri, dei punti di riferimento. Questo invece è un
mondo senza certezze e senza assoluti, un mondo immanente tutto umano, dove Dio è
presente più come nostalgia di Dio che come ente che intervenga nelle sorti umane, dove la
sola conoscenza che all’uomo è data è quella che può faticosamente acquistare con
l’esperienza. È qui che Shakespeare idealmente si incontra con Bacone. Ci sono i soliti
studiosi che, non si sa perché, devono uccidere Shakespeare per far nascere Bacone e
viceversa. In realtà il vero punto d’incontro è questo, nel porre l’esperienza del mondo in
25
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
crisi al centro della vita. In questo mondo allora non possono sopravvivere gli eroi tragici, lo
dimostra Amleto che lo vorrebbe essere, ma non ci riesce. La sua stessa morte non ha nulla
di tragico, nel senso classico del termine; è una morte che avviene per uno scambio di
spade, per un duello fra un principe e un borghese com’è in fondo Laerte. I protagonisti di
queste opere non sono eroi, ma sono uomini. Anche quando sono re e principi lo saranno nel
senso di Machiavelli; non potranno far rivivere quel concetto di regalità proprio di un ordine
scomparso. Sono uomini destinati a vivere in un mondo insicuro, fondato sul dubbio,
uomini soli con sé stessi e con la propria coscienza, responsabili del proprio destino e la cui
forza nascerà proprio dall’accettazione di quell’umana finitudine di cui scrivono Hegel o
Keats, dalla capacità negativa di stare tra incertezze, misteri e dubbi che viene attribuita a
Shakespeare. L’autore elaborò un’ideologia della crisi che sostanzia la vicenda dell’uomo
moderno, ma elabora anche una forma in grado di rappresentarla compiutamente.
La presa di coscienza della crisi e l’individuazione dei caratteri dell’uomo nuovo
sono tutt’uno con la creazione di una forma che ha molti tratti in comune con quella usata
dai primi drammaturghi, ma la sostanza se ne distacca fortemente. Per quanto poggiata su
una decisa trasgressione rispetto ai classici, la forma dei drammaturghi precedenti nasceva
da una visione della realtà in cui il concetto di commedia e tragedia era ancora valido. Di
fronte alla scoperta di un mondo poggiato sul dubbio, sull’ambiguità, su una mai risolta
conflittualità, sull’umana finitezza, nemmeno quella forma pur così aperta e adeguata poteva
bastare, e la fuga dai generi diventa elemento strutturale e dominante. Il poeta crea una
struttura teatrale estremamente aperta, duttile, inclusiva, in cui la polivalenza del reale si
riflette nella polivalenza di una forma che spezza ogni barriera tra commedia e tragedia.
Non è più questione, ormai, di una mescolanza, ma di una vera e propria impossibilità di
rimanere nell’ambito del genere codificato. In effetti, di fronte alla trasformazione del
mondo e dell’uomo l’uso di una forma chiusa sarebbe stato non solo inadeguato, ma
ingannevole. Ed è da questa intuizione che nasce la forma nuova delle grandi tragedie, una
forma che usa le strutture e le convenzioni della tragedia tradizionale per rappresentare la
morte e muovere in una nuova direzione, una forma mai conclusa, la forma del dubbio,
sempre aperta, sempre ambigua e problematica. Si pensi a Macbeth, che proprio l’anno
scorso è stato rappresentato a Brescia, apparentemente la più tradizionale di queste
immagini teatrali, ma tutta internamente lacerata, imperniata su una permanente
conflittualità e ambiguità, su un interno dubbio che corrode le singole parole. Non abbiamo
una ricomposizione tra mondo del passato e del presente, ma il passato fa luogo senza
continuità al presente, l’ordine non torna, la ferita non si rimargina così come avviene nel
Re Lear o in Antonio e Cleopatra, dove la nuova forma della tragedia sembra raggiungere la
massima esemplarità. Infatti siamo di fronte a un’opera dai mille tempi e spazi, dai mille
volti, dalle mille ambiguità e prospettive, a una tragedia davvero manieristica nel senso più
alto del termine, in cui il dubbio sulla realtà e la domanda che Amleto esplicitamente si
poneva è tutt’uno con la rappresentazione. C’è un’infinita varietà che viene attribuita a
Cleopatra, ma anche quella di questo mondo inafferrabile, una tragedia dove è la realtà ad
essere una domanda e in cui nessuna risposta è possibile.
Non ci sono mai risposte in Shakespeare, come non è possibile di Cleopatra
disegnare il volto inafferrabile. In questa grandissima tragedia di amore e di esaltazione
della bellezza non c’è un solo passo in cui si descriva la protagonista; è inafferrabile, è come
la bellezza assoluta, indescrivibile. Attraverso tale forma si attua nella concezione del teatro
26
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
una rivoluzione che soltanto il ’900, con i suoi massimi autori, avrebbe potuto comprendere,
recepire e far propria. Questo linguaggio non nasce da una visione predeterminata e anche
trascendente dalla vita, esso non pretende né di imitarla, né di comporre l’irresolubile
dissidio in un ordine formale che rifletta dantescamente l’ordine del cosmo e della società.
Dante è finito, così come il suo mondo straordinariamente armonioso. Siamo di fronte ad un
mondo disarmonico di cui Shakespeare è il grande cantore e se c’è un ordine è quello
dell’arte, perché anche se il mondo è nel caos, l’arte, per essere tale, non è mai fuor di sesto,
deve sempre cercare una forma ed è questo il suo contributo alla nostra vita.
In questa forma nuova di Shakespeare il teatro diventa uno strumento di conoscenza;
l’artista rinuncia a dominare il destino dei personaggi, ma partecipando alla loro condizione
conferisce al teatro una funzione conoscitiva, a cui tutte le altre funzioni sono subordinate. Il
teatro rimane spettacolo perché spettacolo dev’essere, ma diventa soprattutto esperienza
attraverso cui conoscere. Questa è la suprema proposta teatrale che l’autore affida alle
grandi tragedie, che poi rielabora nelle opere successive, specialmente ne La tempesta,
un’opera dove l’uso stesso eccezionale delle unità serve a creare un dramma in cui lo
spazio, l’isola, non finge la vita, ma rappresenta la vita; il tempo teatrale non è la
successione dei mesi del tempo reale, ma è il tempo reale; l’azione dei personaggi è
un’azione che è un processo conoscitivo che conduce ancora una volta, perché il punto
d’arrivo è sempre quello, alle ferite del mondo.
Questa azione non è lo spettacolo che lo spettatore contempla, ma è soprattutto
l’esperienza conoscitiva che lo spettatore compie.
27
Johann Heinrich Füssli, Re Lear caccia Cordelia (c. 1784-1790);
Toronto, Art Gallery of Ontario.
.
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
Articolo n. 4: Introduzione a “Il Vangelo secondo Shakespeare”, Piero Boitani
Da P. Boitani, Il Vangelo secondo Shakespeare, Il Mulino, Bologna 2009
Hai l’aspetto della Pazienza stessa,
che contempla le tombe dei re
sorridendo dell’accadere
della più alta sventura.
Se c'è qualcosa che porta buone novelle, sono i drammi romanzeschi di Shakespeare:
nel senso più immediato, perché essi contengono tutti un lieto fine. Io credo che essi
formino la sua buona novella, il suo Vangelo. Voglio dire con questo che Shakespeare ha
costantemente presente il Vangelo cristiano, ma compone, da drammaturgo supremo e libero
quale egli è, un testamento (sono le sue ultime opere) suo: il Nuovo Testamento di William
Shakespeare.
Non è possibile infatti ignorare la complessità di motivi e forme che lo ispirano (dal
dramma pastorale alla Commedia dell'Arte, dal romanzo tardo-antico al dumb show al
masque) e neppure la singolare, geniale inclusività e mescolanza delle quali fa mostra: la
sovrapposizione sincretistica di divinità pagane e Dio biblico, l'accostamento di magia e
religione, l'intreccio di politica e passioni, il contrasto e la complementarietà di natura e
cultura, di Natura e Arte. Ma non è neanche possibile ignorare che la sequenza che esamino
qui, da Amleto alla Tempesta, si apre con una citazione del Vangelo e termina con un'altra
citazione del Vangelo: Amleto, infatti, dichiara a Orazio, riprendendo la frase da Matteo e da
Luca, “C'è una speciale provvidenza anche nella caduta di un passero”, e Prospero, alla fine
della Tempesta, si congeda dai suoi spettatori (da noi) con le parole che chiudono il Padre
nostro “E la mia fine/è la disperazione,/ a meno che / non sia salvato dalla preghiera / che va
tanto a fondo / da vincere la pietà / e liberare dal peccato. / Come voi per ogni
colpa/implorate il perdono, / così la vostra indulgenza / metta me in libertà”.
Se tale sequenza ha un senso, vuol dire che Shakespeare, a partire dalla seconda parte
di Amleto1, medita sulla Provvidenza, sul perdono, sul bene e la felicità, e lo fa in termini
cristiani. A me non interessa affatto cercare di determinare - come pur legittimamente
interessa a molti oggi – se Shakespeare fosse, nei suoi ultimi anni, o a qualsiasi altro punto
della sua vita, protestante o cattolico (non era, per certo, un puritano, perché irride i puritani
più di una volta), credesse o no nel Purgatorio o nella transustanziazione, si ritenesse fedele
delle Chiesa di Roma o di quella d'Inghilterra. Ci sono elementi contraddittori a favore
dell'una o dell'altra ipotesi. Per esempio, la Provvidenza “speciale” di Amleto sembra
provenire dalle idee di Calvino. Ma di questo non c'è traccia nella Tempesta, che pure ha
l'azione della Provvidenza al suo centro. Ancora: si ritiene che Shakespeare abbia usato la
Bibbia di Ginevra, la grande traduzione protestante inglese del 1560, ma non si può
escludere che talvolta guardi alla versione di Douai-Rheims (1582-1610), cioè alla
traduzione cattolica, e neppure, credo, a quella anglicana, la Bibbia di Re Giacomo,
pubblicata nella sua interezza nel 1611.
Per un protestante, per un anglicano, il Purgatorio non esiste, eppure il fantasma del
Fin dal “primo” Amleto, dove ai versi 2125-2126 Amleto dice: “C’è una provvidenza predestinata nella caduta di un
passero” (ed. Serpieri, pp. 192-193)
1
28
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
padre di Amleto dichiara al figlio di essere condannato “per un dato tempo a vagare / di
notte e di giorno a digiunare tra le fiamme / finché i delitti compiuti nei miei / giorni terreni
non siano bruciati e purgati”. Di nuovo, non c'è segno di questo possibile purgatorio nella
Tempesta, dove si parla soltanto di Inferno e Paradiso (Terrestre). Non si può neppure
cancellare del tutto l'ipotesi che negli anni successivi all'ascesa al trono di Giacomo I Stuart,
Shakespeare pensasse a un riavvicinamento tra Londra e Roma. La scena finale di
Cimbelino – nella quale l'Indovino annuncia il compimento della profezia secondo la quale
si stabilirà ora una nuova unione fra “la nostra aquila imperiale, Cesare, e il radioso
Cimbelino”, e dove il re inglese fa marciare assieme, sotto bandiere affiancate, le truppe
romane e le britanne attraverso la città di Londra – potrebbe essere allusione alla translatio
imperii da Roma all'Inghilterra, ma anche presentare la velata speranza di un incontro fra
Papato e Corona (cioè Chiesa) inglese.
Si tratta di problemi intriganti, che lascio però agli storici, e a quelli della cultura e
delle mentalità in particolare. A me sembra altrettanto affascinante notare che quel discorso
di Amleto, e la sua vita, terminino con un amen, e che allo stesso modo, con due amen,
termini la rappresentazione della Tempesta; che da Amleto e da Re Lear in poi la fantasia di
Shakespeare si dominata da tempeste, naufragi, pirati, morti per acqua; da fiori e rigoglio
della natura; da relazioni fra padri e figlie e fra mogli e mariti; da riconoscimenti,
rivelazioni, epifanie, apocalissi. In particolare, la scena di riconoscimento fra Lear e
Cordelia costituisce una sorta di archetipo di quelle fra Pericle e Marina, fra Imogene e
Cimbelino, fra Leonte e Perdita, così come l'agnizione fra Pericle e Taisa ritorna in quelle
fra Imogene e Postumo e fra Leonte e Ermione. Nella Tempesta, poi, i riconoscimenti
vengono sostituiti dalle rivelazioni, ma abbiamo anche qui, cruciale, un rapporto fra padre,
Prospero, e figlia, Miranda.
I legami fra questi drammi sono, perciò, stretti. Seguirne lo sviluppo è il compito che
mi sono prefisso in questo libro. Naturalmente, è anche vero che le allusioni bibliche sono
costantemente presenti nell'opera di Shakespeare, e che tempesta, naufragio e
riconoscimento sono rinvenibili già, per esempio, nell'incantevole commedia La dodicesima
notte. Ma nella sequenza della quale parlo tali elementi rientrano in un disegno
complessivo, provvidenziale appunto, delle vicende umane, e sono inserite all'interno di una
visione che non saprei definire se non “teologica”: di un discorso, cioè, che riguarda i
rapporti fra l'uomo e Dio, e in particolare il problema della giustizia divina. Amleto parla di
una “divinità” che “dà forma ai nostri piani”, dice che il “Cielo” gli è stato d'aiuto. Lear si
prefigura un futuro, in prigione con Cordelia, da “spia” di Dio, e l'ultima parte del dramma
contiene una discussione serrata del comportamento divino nelle vicende dell'uomo. Pericle
contesta gli dèi, li rimprovera, li accusa – poi li invoca, li ringrazia, è sopraffatto dalla loro
grazia, sente la musica delle sfere. In Cimbelino, Imogene appare come una “divinità” con
gli anni di un ragazzo, contro gli dèi c'è una vera e propria rivolta degli antenati di postumo,
e a loro Giove in persona risponde in una teofania. Nel Racconto d'inverno assistiamo alla
resurrezione di Ermione. La Tempesta presenta Prospero come Dio, Miranda come dèa,
Ferdinando come un dio: Calibano come il diavolo. Setebos, la divinità dei Patagoni, è
invocata, e compaiono, infine, le dee pagane Iride, Cerere e Giunone.
Non si tratta però mai di discussioni astratte, accademiche, della teodicea (l'unico che
si avvicina alle disputazioni scolastiche è Amleto). Si tratta di esperienze di vita: cioè di
29
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
dibattiti che Shakespeare fa nascere da ciò che i suoi personaggi soffrono e godono nelle
loro esistenze. In particolare, mi pare che il sentimento della presenza di una divinità nasca
in loro, all'inizio, dal dolore, dal patimento di ciò che è oscuro e tragico, dall'esperienza
della morte. Così in Amleto e soprattutto in Lear e Gloucester, così ancora in Pericle e in
Leonte. Il termine patientia riassume bene questo tipo di esperienza: significa, spesso,
Passione (come nella Passione di Cristo) e allo stesso tempo, “pazienza”, sopportazione. La
Passione di Giobbe e di Gesù sono di Lear, che talvolta raccomanda a se stesso la pazienza.
Infinitamente patiens è Pericle, e Pazienza compare come una statua nella scena di
riconoscimento tra lui e Marina, in grado di contemplare le tombe dei re (sorridendo
dell'accadere della più alta sventura). Pazienza, consiglia Edgar in uno dei momenti più alti
di re Lear: la pazienza dell'essere nati e del morire. La sopportazione emerge come unico
atteggiamento possibile nel Cimbelino. Anche Paolina, nell'ultima scena del Racconto
d'inverno, continua a intimare la pazienza a Leonte: come capacità di pazientare nell'attesa
del miracolo. E ancora: Prospero nella Tempesta non fa che ingiungere pazienza: ad Ariele,
a Ferdinando e a Miranda, a Gonzalo e Alonso.
Attendere. Ce lo impone Shakespeare, ritardando e rimandando con suspense
abilissima la felice soluzione dei drammi romanzeschi. Ma un'altra accezione dell'attesa si
situa tra la “readiness”, l'essere pronti alla morte che viene ad Amleto dal Vangelo, e la
“ripeness”, la maturità, che Edgar proclama in Re Lear: fra la potenza e l'atto, fra l'annuncio
e il compimento. La “consumazione” che Amleto si augura prima di partire per l'Inghilterra,
quella che fornirebbe il suicidio liberandoci dal male di vivere, diventa la “consumazione”
nella pace che Guiderio e Arvirago augurano a Fedele che essi ritengono morto. Ma un'altra
consumazione – cioè compimento – è quello che si prefigura Lear andando in prigione con
Cordelia: cantare come uccelli in gabbia, scambiarsi benedizioni, chiedersi perdono,
pregare, raccontarsi antiche favole, ridere delle farfalle variopinte, prendere su di sé il
mistero delle cose ed essere spie di Dio.
Né ad Amleto, né a Lear e Cordelia, è concessa una consumazione del genere. Ma il
discorso di Lear prefigura con precisione quanto accadrà nei drammi romanzeschi – che
sono poi le “antiche favole” delle quali egli parla. “Consummatum est” lo potranno
esclamare soltanto, come il Gesù morente ma vittorioso di Giovanni, Pericle, Leonte,
Cimbelino, Prospero: Marina e Taisa, Perdita ed Ermione, Imogene e Postumo, Miranda e
Ferdinando e Gonzalo. C'è, nelle scene finali dei romances di Shakespeare, una plenitudine
– una grazia – quale solamente gli episodi dopo la Resurrezione disegnano nei Vangeli.
“Sui sacrifici come i nostri, Cordelia mia, / gli dèi stessi gettano incenso”, annunzia
Lear. Quei “sacrifici” sono le vicende di sofferenza e purificazione che trasformano i
“romances” in “rituals”, i drammi romanzeschi in rituali. Perché ciò avvenga sono
necessari, oltre alla pazienza, almeno altri quattro atteggiamenti: il pentimento, il perdono, il
piegarsi su se stessi e verso il prossimo.
Appaiono incerti, all'inizio della sequenza: non si riesce a capire se Amleto e Laerte
si perdonino davvero, se non in punto di morte, e certo Amleto non si pente di nulla né
perdona lo zio. Lear non perdona affatto le figlie malvagie, e deve, in un processo già
enunciato dall'apostolo Paolo, attraversare la follia per giungere alla conoscenza di sé: però
mostra, durante la tempesta, una improvvisa e intensa compassione verso i poveri, e
confessa e chiede perdono a Cordelia: “Vi prego, ora, dimenticate e perdonate. Sono
vecchio e sciocco”. Pericle non ha bisogno né di pentimento né di perdono: è un Giobbe
30
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
innocente e mite. Ma l'uno e l'altro sono necessari in Cimbelino, a Iachimo come a Postumo,
colpevoli l'uno di aver suscitato alla Iago la gelosia del secondo, l'altro di aver voluto far
uccidere Imogene. Il pentimento è richiesto anche a Leonte, geloso al punto di far morire il
figlio e la moglie e di volere eliminare la figlia neonata. Pentimento e perdono, ancora,
dominano le scene finali della Tempesta, dove il secondo è ispirato a Prospero dal suo servo,
lo spirito Ariele, e il primo manca, in conclusione, soltanto ad Antonio e Sebastiano. Nella
stessa Tempesta, però, un ultimo passo è compiuto: quando Prospero prende su di sé il male
e il peccato, riconoscendo Calibano, questa “cosa del buio”, come sua.
Re Lear e la Tempesta sono legati da un lungo filo: la richiesta del perdono dal padre
al figlio. Mentre Lear e Cordelia stanno andando in prigione, il vecchio re dice alla figlia:
“quando tu chiederai la mia benedizione, io m'inginocchierò / per chiederti perdono”. Alla
fine della Tempesta, è Alonso a rivolgersi al figlio Ferdinando: “quanto strano suonerà / che
io chieda perdono a mio figlio”. Questo giungere a dimenticare se stessi e inchinarsi,
offrendosi in umiltà, agli altri – tanto più se a compierlo sono i padri nei confronti dei figli –
è una delle più alte e preziose fra le buone novelle dei drammi romanzeschi.
Tento, nei capitoli che formano il libro, di seguire questi movimenti, e le loro
diramazioni, nei singoli drammi: ma mi pare sin da ora ce essi disegnino un cammino verso
l'amore per Dio e per il prossimo che, incerto e mai totalmente attinto (e quando mai è del
tutto raggiunto se non dai santi?), si conforma tuttavia alla predicazione evangelica. I
drammi romanzeschi di Shakespeare non sono allegorie: semmai antiche favole, forse
parabole. Shakespeare non dice mai esplicitamente, né suggerisce con assoluta chiarezza,
che, per esempio, il fantomatico convinto negato della Tempesta è il banchetto nuziale o
l'Ultima Cena del Vangelo. Racconta storie: nelle quali Lear e Pericle compaiono a tratti,
indirettamente, “in aenigmate”, in vesti di Giobbe o di Cristo; dove Marina prende le
fattezze della Via, della Verità, della Vita ed Ermione risorge come Lazzaro in virtù della
musica che la colpisce, se gli astanti risvegliano la loro fede; in cui Ferdinando e Miranda
appaiono come Adamo ed Eva. Shakespeare lascia allo spettatore e al lettore di cogliere le
somiglianze, le affinità, le diversità.
Perciò, dobbiamo prestare attenzione e cercare di cogliere tutte le allusioni ai testi,
sacri e non. Perché Shakespeare è artista troppo consumato per costruire mere equivalenze o
semplici “moralities”: ama l'obliquità, la stratificazione di ombre, la sovrapposizione di miti
tempi e luoghi. La Boemia, ricordiamolo, viene da lui collocata sul mare. L'isola incantata
della Tempesta deve trovarsi da qualche parte tra Tunisi e Napoli, ma è anche, chiaramente,
ombra dell'Africa e del Nuovo Mondo. È il Paradiso Terrestre e un labirinto, l'Età dell'Oro,
in mezzo al Mediterraneo del Rinascimento, e un'Ogigia ai confini del mondo. La statua di
Ermione è stata scolpita da Giulio Romano, allievo di Raffaello che ha mirabilmente
costruito e affrescato Palazzo Te a Mantova, ma del quale non si conoscono sculture. Perdita
è la Perfezione, la Primavera, la Natura. Le tempeste che squassano le navi dei protagonisti
nei drammi romanzeschi sono quelle di Omero e Virgilio, e delle caravelle che fanno
precaria vela verso l'America: e assieme quella che affonda il battello sul quale l'apostolo
Paolo tenta di giungere a Roma, o addirittura lo sconvolto abisso primordiale della Genesi e
della seara', il turbine da cui Dio parla a Giobbe.
Non si ritroveranno, in questi drammi, le Beatitudini di Matteo, le Nozze di Cana, la
moltiplicazione dei pani e dei pesci, la Crocefissione, l'Ascensione. Vi emergeranno invece,
in maniera allusiva ma rilevante, l'afflizione, la mitezza, la purezza di cuore di un Pericle; le
31
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
nozze di Marina, Perdita e Miranda; la crescita e la moltiplicazione del genere umano nella
Tempesta; Lear, legato a una ruota di fuoco; l'augurio di Orazio a un Amleto spirante, “il
volo degli angeli ti porti cantando al tuo riposo”; la grazia che tutto soffonde nella scena
finale di Cimbelino; Ermione risorta; Prospero, il Dio che si fa uomo.
Il disegno generale, però, sembra coerente. Amleto intravede una luce incerta e
lontana, guarda alla sorte dei passeri, e degli esseri umani, e di se stesso, quasi fosse sulla
soglia delle Scritture. Lear soffre una Passione, mostra compassione verso i poveri, risorge,
immagina un futuro beatifico di preghiera e perdono, di reciproca benedizione. Poi, di
canto, e racconto, e sorriso: di semplicità, umiltà e assunzione su di sé del mistero delle
cose. Lear, che fra poco vedrà morta Cordelia, che fra poco perirà egli stesso, si adombra
sacerdote di un sacrificio divino, profeta di Dio. Pericle lo diviene: il ritrovamento di
Marina gli dischiude l’armonia celeste, quella che le sfere, muovendosi, producono
cantando come angeli. Pericle, con la figlia e la moglie, fanno esperienza della beatitudine,
della consumazione sulla terra del regno dei cieli. La stessa cosa accade con il ritorno alla
vita della statua di Ermione, con l'incontro fra Ferdinando e Miranda. Si tratta insomma di
Vangeli fondati sull'immanenza, sulla realizzazione terrena; che appare ombra di quella
celeste. E la cui ultima parola è: ritorno di Dio (di Prospero) alla storia, sulla terra, appunto.
Dopo aver preso su di sé non più il mistero delle cose, ma la responsabilità per la “cosa del
buio”, per il male del mondo.
Parte integrale di tale disegno è il ruolo che vi gioca la donna. Il Vangelo secondo
Shakespeare, è meravigliosamente declinato e predicato al femminile. Anche qui, vi è un
itinerario preciso. Ofelia, che potrebbe forse salvare Amleto, è da lui respinta e muore.
Muore Cordelia, che ha in effetti salvato, sia pur per lo spazio di poche ore, Lear. Con
straordinaria progressione, poi, Marina e Taisa, Imogene, Perdita ed Ermione, e infine
Miranda, appaiono quali le vere portatrici della grazia. Marina, la vergine che non è nata “su
nessuna costa” eppure è mortale, genera colui che l’ha generata, e Pericle diviene figlio di
sua figlia: pare, Marina, un'ombra di Maria. Taisa è colei toccando le cui labbra Pericle si
sente sul punto di dissolversi e sparire per sempre. Imogene è la mulier, il “mollis aer”, l'aria
e l'aura “dolce” che avvolge con la sua costanza e la sua fedeltà tutto il Cimbelino. Ermione,
che la vita ha redento dalla morte, restituisce l'amore a Leonte e benedice la figlia. Miranda
dà il suo amore a Ferdinando, scoprendo un mondo nuovo e bello negli uomini che vede alla
fine.
La Buona Novella che gli ultimi anni di Shakespeare ci portano – chiudo qui questo
discorso introduttivo, rimandando al suo compimento nelle Conclusioni – è che si può
raggiungere la felicità sulla terra e che questa può essere la vera “vita eterna”.
Ricongiungersi ai propri cari, riscoprirli, riconoscerli, costituisce la felicità: niente di più,
ma neppure niente di meno. “Riconoscere chi si ama è un dio”, diceva già l'Elena di
Euripide. Ma riunirsi alla propria figlia, o alla propria moglie, dopo averle credute morte,
riesce a farci sentire la musica delle sfere, a farci sciogliere e scomparire per sempre nel
nulla che è tutto: dunque è ombra della beatitudine.
32
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
Johann Heinrich Füssli, Oberon spreme il succo del fiore sugli occhi di Titania dormiente (1793);
Zurigo, Kunsthaus Zürich.
33
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
Articolo n. 5: “Amen per la caduta di un passero”, Piero Boitani
Da P. Boitani, op. cit.
C’è una speciale provvidenza nella caduta di un passero
Che succede ad Amleto durante il viaggio che lo dovrebbe portare dalla Danimarca
all'Inghilterra, e che lo conduce poi a casa? Che gli accade, dico, sul piano psicologico,
mentale, morale: insomma, al suo stato d'animo, al suo modo di pensare. Perché sappiamo –
più o meno – cosa gli capita materialmente. Lo zio Claudio, fratello del padre e usurpatore
del trono di lui, nonché rapidissimo sposo della vedova (Gertrude, madre del Principe) non è
convinto che la presunta pazzia di Amleto sia dovuta, come sostiene il cortigiano Polonio,
all'amore respinto di lui per Ofelia. Claudio ha assistito a uno spettacolo teatrale, per la regia
dello stesso Principe, nel quale l'assassinio del padre di Amleto, denunciato dal suo
fantasma al figlio come opera dello stesso Claudio, è stato messo in scena con nomi diversi
e ambientazione viennese. Ne è turbato e impaurito. Pensa perciò, subito, di spedire il nipote
in Inghilterra, per liberarsi di lui. Accidentalmente, Amleto uccide quindi Polonio, che spia
dietro una tenda il colloquio fra lui e la madre, e re Claudio capisce bene che, se a trovarsi
nel nascondiglio fosse stato lui, Amleto lo avrebbe trafitto senza pietà. Ragione di più –
politica, sostiene Claudio, perché il popolo mormorerà contro di lui per l'assassinio di un
personaggio dal largo seguito – per sbarazzarsi del Principe. Amleto sa benissimo, e lo dice
alla madre Gertrude al termine del loro incontro, che il viaggio in Inghilterra è una trappola.
E infatti, alla fine della breve udienza di Claudio ad Amleto, quando questi, scortato dalle
guardie e accompagnato da Rosencrantz e Guildenstern, si avvia verso la nave, il re svela al
pubblico il suo piano. Amleto “infuria nel suo sangue come la febbre”, e l'Inghilterra deve
guarirlo. L'Inghilterra è in debito nei confronti della Danimarca. Non potrà rimanere fredda
dinanzi al “mandato sovrano” che le impone, “con lettere rivolte a questo fine”, la morte
immediata di Amleto.
L'Inghilterra dovrà uccidere Amleto. Il Principe parte. Ma mentre Re e Regina
assistono allo scoppiare della follia in Ofelia e ritorna, pieno di propositi di vendetta contro
Claudio, il fratello di lei, Laerte, giungono dei marinai che portano a Orazio, l'amico fedele
di Amleto, una lettera del Principe. In essa, Amleto chiede a Orazio di fare in modo che i
marinai siano ricevuti dal re, al quale dovranno consegnare delle missive. Ingiunge anche
all'amico di raggiungerlo il più o presto possibile (i marinai condurranno Orazio dove
Amleto si trova) perché ha parole da dirgli all'orecchio che, per quanto “leggere per il
calibro della faccenda”, lo “renderanno muto”. Spiega, anche, cosa è successo:
Non eravamo in mare nemmeno da due giorni che una nave pirata in pieno assetto di guerra
ci diede la caccia. Scoprendo d'essere troppo lenti di vela, indossammo la maschera dei coraggiosi,
e io andai all'arrembaggio e balzai sulla loro nave. Ma immediatamente dopo, essi si liberarono
della nostra e io rimasi il loro unico prigioniero. Mi hanno trattato da ladroni misericordiosi. Ma
sapevano quel che facevano. Da me vogliono un favore… Rosencrantz e l'amico sono in viaggio
per l'Inghilterra. Di loro ho molto da dirti1.
1
Amleto IV vi 15-28, trad. it. A Lombardo, Milano, Feltrinelli, 1995.
34
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
Si rivelerà, questo messaggio, solo metà della storia. Intanto i marinai portano a
Claudio, che è a colloquio col furibondo Laerte, la lettera di Amleto. La quale dice
semplicemente che il Principe è rientrato, “nudo” e “solo”, in Danimarca, e chiede udienza
per l'indomani. Allora, rivelerà al re che le ragioni del suo “improvviso e ancora più strano”
ritorno.
Niente di tutto questo accade. Invece, molto più tardi, dopo il funerale e la sepoltura
di Ofelia, Amleto racconta a Orazio l'altra metà della vicenda. Conferma la “battaglia per
mare”, di cui aveva scritto nella lettera (“e quello che ne seguì già lo conosci”, aggiunge,
tuttavia nel dramma non c'è traccia di cosa effettivamente sia accaduto dopo lo scontro con i
pirati), ma sostiene che la notte prima, uscito “d'impulso dalla sua cabina sulla nave con la
mantella d'incerata sulle spalle, aveva cercato Rosencrantz e Guildenstern, trafugato il loro
messaggio, aperto il sigillo, e trovato l'ordine di Claudio agli inglesi di tagliargli la testa non
appena fosse sbarcato sulla loro terra. Mostrando il documento a Orazio, Amleto narra poi
di avere forgiato “con bella calligrafia” un nuovo ordine del re, con richiesta esplicita di
mandare subito a morte i latori del medesimo, e di averlo chiuso apponendogli il sigillo del
padre. “E così, Rosencrantz e Guildenstern sono a posto”, commenta Orazio.
Questo dunque è quanto è materialmente accaduto ad Amleto durante il viaggio vero
l'Inghilterra: prima, il ritrovamento della prova che i suoi sospetti erano nel giusto e il suo
rapidissimo torcerla contro i due nemici (per così dire) che si erano prestati al gioco del re;
poi lo scontro con i pirati. Tuttavia, Amleto non rivela né ad Orazio né ad altri cosa gli sia
successo interiormente.
Riassumiamo. L'Amleto che è partito per l'Inghilterra era in preda a una finta pazzia e
a una profonda malinconia. Prima ancora di vedere e parlare con quello che dice di essere il
fantasma di suo padre, Amleto aveva detto allo zio e alla madre che, al di là dei “fronzoli” e
delle “maschere” esteriori del dolore, egli aveva dentro “ciò che non si mostra”. Quando
Gertrude gli ricorda che tutto ciò che vive “deve morire, passando dalla natura all'eternità” e
lo invita perciò a dismettere gli abiti e i modi del lutto per la morte del padre, Amleto
concorda con lei che la morte è cosa comune. E quando ella gli domanda perché, allora, gli
sembri “così speciale”, risponde:
“Sembra”, signora? No, è.
Io non conosco “sembra”. Buona madre,
Non è solo il mio mantello color dell'inchiostro,
Né gli abiti di circostanza di solenne nero,
Né le raffiche di sospiri e il fiato mozzo,
No, e nemmeno il fiume copioso nell'occhio
Né l'atteggiarsi sconsolato del viso,
Insieme a tutte le forme, le espressioni,
I modi del dolore, a poter dire la mia verità.
Questi invero “sembrano” perché sono
Azioni che un uomo può recitare.
Ma io ho dentro ciò che non si mostra Fuori ci sono i fronzoli e le maschere del dolore2.
I ii 76-86: “Seems, madam! Nay it is; I know not “seems”. / ‘Tis not alone my inky cloak , good mother, /
Nor customary suits of solemn black, / Nor windy suspiration of forced breath, / No, nor the fruitful river in
the eye, / Nor the dejected ‘haviour of the visage, / Together with all forms, moods, shapes of grief, / That
2
35
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
Sempre assoluto e preciso, Amleto, sul piano intellettuale: non l'apparenza, ma
l'essere. Riservato, però, in pubblico, su quello che è veramente ha “dentro”. Rimasto solo,
Amleto da tuttavia voce, nel primo dei suoi celebri monologhi, ai propri sentimenti,
iniziando con una di quelle riflessioni generali, introspettive e malinconiche che saranno
così tipiche del suo carattere. Egli desidera che “questa troppo troppo solida carne / possa
disfarsi, squagliarsi e sciogliersi in rugiada”. Si lamenta che Dio abbia vietato all'uomo di
uccidersi: “o se l'Eterno non avesse scritto / la propria legge contro il suicidio”. Sente che
“tutte le usanze di questo mondo sono, per lui, “stantie, banali e senza profitto”, che il
mondo stesso è “un giardino non sarchiato / che va in seme. A possederlo sono solo le cose
marce e grossolane”3.
Più tardi, dopo che il colloquio con il fantasma ha confermato ciò che la sua “anima
profetica” aveva presentito, Amleto ritorna, davanti a Rosencrantz e Guildenstern, a questa
sua visione del mondo: al senso di radicale inanità del tutto che gli affligge il cuore. Uomo
del Rinascimento, studente universitario a Wittenberg, non può non percepire la maestosa
bellezza dell'universo, non avvertire che l'uomo stesso è un “capolavoro”. Ma contro tali
considerazioni si rizza la sua mancanza di allegria, la sua “cupa disposizione”:
Io ultimamente – ma il perché non lo so – ho perso tutta la mia allegria, e abbandonato ogni
esercizio fisico. E invero la mia disposizione è così cupa che questa bella architettura, la terra, mi
sembra uno sterile promontorio. Questo stupendo baldacchino, l'aria – guardate –, questo bel
firmamento sospeso in alto, questo soffitto maestoso trapunto di fiamme d'oro – ebbene, non mi
sembrano altro che una sporca e pestilenziale congrega di vapori. Che capolavoro è l'uomo, com'è
nobile nella ragione, com'è infinito nelle sue facoltà, com'è preciso e ammirevole nella forma e nel
movimento, com'è simile a un angelo nell'azione, com'è simile a un dio nell'intendimento: la
bellezza del mondo, il paragone degli esseri animati. Eppure cos'è per me questa quintessenza di
polvere?4
Amleto è certo in preda alla malinconia. Definisce il proprio secolo “fuor di sesto”;
considera “sorte maledetta” essere nato per “rimetterlo a posto”; e si comporta in modo
strano, bizzarro, perché ritiene “opportuno / recitare la parte del matto”.
È una malinconia a due facce: da una parte l'incertezza, l'indecisione, l'inazione, la
paralisi; dall'altra l'assolutezza del pensiero, la sua originalità, l'invenzione logica e la
penetrazione metafisica. Si può persino pesare – e Amleto pensa – che sia la seconda a
determinare la prima. Per esempio, quando a Elsinore arrivano gli attori, Amleto propone al
can denote me truly. These indeed seem, / For they are actions that a man might play: / But I have that within
which passeth show; / These but the trappings and the suits of woe”.
3
I ii 129-137: “O, that this too too solid flesh would melt / Thaw and resolve itself into a dew! / Or that the
Everlasting had not fix’d / His canon ‘gainst self-slaughter! O God! God! / How weary, stale, flat and
unprofitable, / Seem to me all the uses of this world! / Fie on’t! ah fie! ‘tis an unweeded garden, / That grows
to seed; things rank and gross in nature / Possess it merely”.
4
II ii 294-308: “I have of late – but wherefore I know not – lost all my mirth, forgone all custom of
exercises, and indeed it goes so heavily with my disposition that this goodly frame, the earth, seems to me a
sterile promontory, this most excellent canopy, the air, look you, this brave o’erhanging firmament, this
majestical roof fretted with golden fire, why, it appears no other thing to me than a foul and pestilent
congregation of vapours. What a piece of work is a man! how noble in reason! how infinite in faculty! in
form and moving how express and admirable! in action how like an angel! in apprehension how like a god!
the beauty of the world! the paragon of animals! And yet, to me, what is this quintessence of dust?”
36
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
capocomico di recitare il racconto di Enea e Didone, e in particolare l'uccisione di Priamo.
Dà lui stesso il la, cominciando “l'irsuto Pirro, le cui scure armi, nere / come il suo intento,
somigliavano alla notte”. Poi, fa continuare l'attore, lo imbecca, vuole che arriva a Ecuba.
“Ma chi, ahimè, avesse visto la Regina imbacuccata”, attacca quello. “La regina
imbacuccata?”, interrompe Amleto, subito seguito da Polonio: “Questa è buona. 'La regina è
imbacuccata' è buona.” Ma il primo attore prosegue, infervorato, narra l'uccisione di Piramo
da parte di Pirro, le urla di Ecuba. Amleto è soddisfatto, e congeda la troupe invitando gli
attori a preparare un Assassinio di Gonzago, al quale egli stesso aggiungerà una dozzina di
versi, per il giorno dopo. Poi, usciti anche Polonio, Rosencrantz e Guildenstern, rimane
solo. E pronuncia uno dei suoi grandi monologhi:
Oh, che vigliacco
E malfattore sono! Non è mostruoso
Che questo attore, in una mera finzione,
In un suo sogno di passione, possa tanto forzare
La sua anima al concetto che per il suo operare
Tutto il suo volto è impallidito, lacrime
Nei suoi occhi, disperazione nel suo aspetto,
La voce rotta, e l'intera funzione
Che s'adattava con le forme nella sua idea?
E tutto per niente. Per Ecuba! Cos'è
Ecuba per lui, o lui per Ecuba,
Che debba piangere per lei? Che farebbe
Se avesse il motivo e la spinta alla passione che ho io?5
Dunque, cos'è Ecuba per l'attore che ne recita la disperazione? cos'è un personaggio
della “fiction” per un uomo in carne e ossa? Perché lui dovrebbe piangere per lei, visto che
fra i due non c'è alcuno rapporto? “Tutto per niente”, dice Amleto. Il personaggio mitico, e
letterario, è semplicemente una finzione. Non c'è motivo di prestare a essa alcuna
“passione”, di “forzare” l'anima al “conceit”, al concetto e al trucco. Amleto sta ovviamente
parlando di un'azione teatrale: perché immedesimarsi nel personaggio sulla scena? Il suo,
fin qui, è un dubbio che riguarda il modo di recitare. Tuttavia, Amleto lo formula, all'inizio,
in maniera radicale, ontologica: cos'è Ecuba per lui? Cos'è un personaggio mitico, letterario,
per un essere umano in carne e ossa?
Che questo sia il problema fondamentale lo chiarisce la seconda parte di quel verso,
quando Amleto, in maniera apparentemente causale, retorica, forse trasportato dal suo stesso
discorso, dice: “or he to her”, o lui per Ecuba. Come, lui per Ecuba!? Cos'è l'uomo in carne
e ossa per una “finzione”, per un personaggio immaginario? È un paradosso, e anche un
abisso ontologico. Si, certo, è ancora questione di teatro, anche: ma non meno paradossale.
Cos'è l'attore che recita una parte per il personaggio le cui vicende egli recita? Se “Ecuba” è
un personaggio immaginario, e rappresenta quindi la finzione in generale, che senso ha
II ii 547-559: “O, what a rogue and peasant slave am I! / Is it not monstrous that this player here, / But in a
fiction, in a dream of passion, / Could force his soul so to his own conceit / That her working all his visage
waned, / Tears in his eyes, distraction in his aspect, / A broken voice, and his whole function suiting / With
forms to his conceit? And all for nothing. / For Hecuba! / What’s Hecuba to him, or he to her, / That he
should weep for her? What would he do / Had he the motive and the cue for passion / That I have?”.
5
37
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
Johann Heinrich Füssli, Macbeth consulta la visione della Testa Armata (1793);
Washington, Folger Shakespeare Library.
38
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
chiedere se la realtà significhi qualcosa per la finzione, come sembra implicare la seconda
parte della domanda di Amleto? Se Amleto si pone questa domanda, dobbiamo concludere
che sta sovvertendo l'ordine stabilito delle priorità, pretendendo che la “rappresentazione”
rifletta la natura, ma che la natura si interroghi davanti allo specchio. Il concetto stesso di
realtà viene così a cadere.
Questa incertezza diviene subito indeterminazione e inazione. Amleto si scontra
continuamente con la tragica impossibilità di un riconoscimento empirico e razionale
dell'identità del fantasma e della colpa di Claudio, mentre è il riconoscimento della propria
inattività che lo spinge a organizzare la rappresentazione con cui spera di procurarsi una
prova contro lo zio. II confronto con l'“invenzione” dell'attore fa scattare il primo passaggio,
che termina con l'impossibilità di pronunciar verbo, con un silenzio gnoseologico totale
proprio nel bel mezzo di uno dei più lunghi e articolati discorsi del protagonista: “Eppure io,
/ canaglia fangosa e ottusa, perdo tempo / come un idiota, incurante della mia causa / e non
so dire niente”6.
Come Pirro nella storia dell'attore, Amleto resta “indifferente alla volontà / e
all'intelletto”. Ma il problema consiste nel fatto che, avendo riconosciuto ciò, non ha idea
del perché debba essere così. Ancora una volta, un'ignoranza incolmabile emerge dalla sua
conoscenza. Ora, proprio mentre sta partendo per l'Inghilterra, Amleto riflette sulla propria
inazione. Ha visto Claudio inginocchiato in preghiera (il Re confessa lì la sua colpa, però il
Principe non lo sente), ma ha deciso di non ucciderlo per non mandarlo in paradiso. Inizia la
propria meditazione addirittura dalla Creazione dell'uomo: che non è stato fatto a vivere
come bruto, ma per seguir almeno conoscenza, se non anche virtù. L'essere umano è stato
dotato di un “intelletto vasto” di una ragione simile a quella di Dio. Non è possibile che essa
ammuffisca senza essere usata. Ma è proprio l'eccesso di ragionamento, lo “scrupolo” di
pensare al fatto con troppa precisione (“Of thinking too precisely on th'event”), a bloccare
Amleto: a fermarlo addirittura sulla soglia della conoscenza di sé (Io non so perché):
Come tutte le occasioni mi muovono accuse
E spronano la mia pigra vendetta! Che cos'è
Un uomo se deve impiegare tutto il suo tempo
Solo a dormire e a nutrirsi? Una bestia,
Nient'altro. Certo colui che ci fece
Con un intelletto così vasto, capace di guardare
Il prima e il dopo, non ci chiede
Quella facoltà e divina ragione
Perché ammuffisse in noi senza essere usata.
Ora, si tratti di un bestiale oblio,
O d'un qualche scrupolo vile che fa pensare
Con troppa pedanteria al risultato – un pensiero
Che, diviso in quattro, ha una sola
Parte di saggezza e tre di viltà Io non so perché vivo ancora per dire
“Questa cosa s'ha da fare”, avendo
Motivi, e intenzioni, e forza, e mezzi
II ii 563-566: “Yet I, / A dull and muddy-mettled rascal, peak / Like John-a-dreams, unpregnant of my
cause, / And can say nothing –”.
6
39
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
Per farla7.
Amleto parla sempre di principi generali. Qui, parte dal Principio stesso, al quale –
sarà bene notare – mostra di credere. Ma non riesce a vedere la fine. Nel monologo più
famoso della storia del teatro, prima del conturbante, disastroso colloquio con Ofelia, egli si
interroga, con articolazione all'inizio precisamente Scolastica (Amleto è stato all'università,
dove certo si sarà insegnato per mezzo delle tradizionali quaestiones) se essere o non essere.
Non formula la propria domanda seguendo il senso vero del proprio pensiero: continuare a
vivere o uccidersi. Sceglie invece i termini filosofici di una tradizione che risale a
Parmenide e Gorgia, e che il suo contemporaneo, il Faustus di Marlowe, mostra di
conoscere altrettanto bene8: essere o non essere, on kai me on (essere e non essere), esse aut
non esse.
Ecco, più o meno, come suonerebbe la domanda di Amleto in un'aula di Oxford, della
Sorbona, di Bologna, di Wittemberg: “Esse aut non esse. Haec est quaestio: utrum nobilius
sit in animo pati adversitates fortunae, aut pugnare contra et terminare eas. Ad primum
dicendum quod dormire, mori, est optima consumatio, quia cum somno mortis finem
ponimus malibus cordis et generaliter carnis. Sed contra dicendum quod somnus potest
habere somnia, quorum naturam in somno mortis, qui est sine sensibus corporis,
noscimus.”:
Essere o non essere – questa è la domanda.
Se è più nobile per la mente sopportare
Le sassate e le frecce dell'oltraggiosa fortuna
O prendere le armi contro un mare di guai
E, combattendo, finirli. Morire, dormire –
Nient’altro – e con un sonno dire che poniamo
Fine al mare del cuore e ai mille
Travagli naturali di cui la carne è erede.
Questa è consumazione da desiderare devotamente.
Morire, dormire – dormire, forse sognare.
Ah, qui è l'intoppo. Perché in quel sonno
Di morte, quali sogni possano
Venire quando ci siamo liberati
Di questo groviglio mortale, è cosa
Che deve farci meditare9.
IV iv 32-46: “How all occasions do inform against me, / And spur my dull revenge! What is a man, / If his
chief good and market of his time / Be but to sleep and feed? a beast, no more. / Sure, he that made us with
such large discourse, / Looking before and after, gave us not / That capability and god-like reason / To fust in
us unused. Now, whether it be / Bestial oblivion, or some craven scruple / Of thinking too precisely on the
event, / A thought which, quarter’d, hath but one part wisdom / And ever three parts coward, I do not know /
Why yet I live to say “This thing’s to do”; / Sith I have cause and will and strength and means / To do’t”.
8
Christopher Marlowe, Il Doctor Faustus A i 12, a cura di N. D’Agostino, Milano, Mondadori, 1983.
9
III i 56-68: “To be, or not to be: that is the question: / Whether ‘tis nobler in the mind to suffer / The slings
and arrows of outrageous fortune, / Or to take arms against a sea of troubles, / And by opposing end them?
To die: to sleep; / No more; and by a sleep to say we end / The heart-ache and the thousand natural shocks /
That flesh is heir to, ‘tis a consummation / Devoutly to be wish’d. To die, to sleep; / To sleep: perchance to
dream; ay, there’s the rub; / For in that sleep of death what dreams may come / When we have shuffled off
this mortal coil, / Must give us pause”.
7
40
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
Qui non è questione di bene disserere, di argomentare bene: che, come ci dice il
Faustus di Marlowe, est finis logices, è il fine della logica. Qui si tratta di vita o di morte.
Infatti, non c'è respondeo dicendum, nella quaestio di Amleto, la quale si sbriciola nella sua
articolazione Scolastica proprio davanti all'“intoppo”, al muro del sogno nella morte.
Amleto non conosce risposta. “Questa”, ha appena concluso, “è consumazione da desiderare
devotamente”. “Consummation”: cioè fine, ma anche compiutezza, secondo le parole di
Cristo sulla croce nel Vangelo di Giovanni: “consummatum est”10.
Amleto desidera morire. Davanti ai mille “natural shocks” di cui la carne è erede,
preferisce il non essere. Equipara, però, il morire al dormire, secondo un topos antichissimo,
cui dà, immediatamente, una svolta nuova. “Morire, dormire – dormire, forse sognare”.
Certo, se si dorme, si sogna, anche. Ma per l'appunto, quali sogni possono venire “quando ci
siamo liberati da questo groviglio mortale”? I sogni sono del corpo, della carne, di quella
spira che ci avvolge nella mortalità. E queste sono le cose che gli esseri umani perdono
quando muoiono. “Sognare” vale dunque, metaforicamente, esperienze dell'anima dopo la
morte. Ed è proprio l'immaginare queste che ferma la mano di chi vorrebbe morire: “è
questo il pensiero che dà alla sofferenza una vita così lunga”. Nessuno, infatti,
sopporterebbe “la frusta e l'ingiuria del tempo”, l'ingiustizia del mondo, le prevaricazioni,
l'amore respinto, la pena del vivere
Se non fosse che la paura di qualcosa dopo la morte,
La terra inesplorata dai cui confini
Non torna nessun viaggiatore, paralizza la volontà
E ci fa sopportare i mali che abbiamo
Piuttosto che fuggire verso quelli
Che non conosciamo. Così la coscienza
Ci rende tutti codardi, e così
La tinta naturale della risolutezza
È resa livida dalla pallida impronta del pensiero11.
Dunque, paura della morte significa paura del qualcosa che potrebbe esserci dopo il
morire, vuol dire timore dinanzi all'ignoto. Amleto conosce e crede al Principio, ma nulla
sembra sapere della fine. È certo abbastanza curioso che egli dichiari che da quella terra
inesplorata non ritorna nessun viaggiatore, quando pur vive in una cultura la quale sin
dall'epoca di Platone proclama l'immortalità dell'anima, in una cultura che crede, poi, alla
resurrezione del Cristo, e quando egli stesso ha appena visto il fantasma di suo padre tornare
dalle fiamme purificatrici del purgatorio12. Ma le contraddizioni di Amleto fanno parte
dell'inesauribile complessità umana del personaggio, e in realtà non scalfiscono la logica
naturale del suo ragionamento e delle sue emozioni. Tutti noi sappiamo, infatti, che è
10
Giovanni 19, 30.
III i 78-85: “But that the dread of something after death, / The undiscovered country, from whose bourn /
No traveller returns, puzzles the will, / And makes us rather bear those ills we have / Than fly to others that
we know not of? / Thus conscience does make cowards of us all; / And thus the native hue of resolution / Is
sicklied o’er with the pale cast of thought”.
12
Il purgatorio non esiste nell’aldilà anglicano, ma il contesto di I v 9-13 è chiaro: il fantasma dice di essere
condannato a errare nella notte per un certo periodo, e a digiunare nel fuoco durante il giorno sino a quando i
crimini che ha commesso in vita non siano “burnt and purged away”, bruciati e purgati. Cfr. S. Greenblatt,
Amleto in Purgatorio, trad. it. Roma, Carocci, 2002.
11
41
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
proprio quel “dread”, quel timore e tremore, che paralizza la nostra mente e rende livido il
nostro pensiero dinanzi alla prospettiva della morte. Al problema della fine non c'è risposta
se non accettandone la totale ineluttabilità, oppure nell'ambito di una fede religiosa.
Questo è dunque l'Amleto che parte per l'Inghilterra. Quando ritorna, è
misteriosamente cambiato. Forse, ha sperimentato il rischio di morte con il recupero della
lettera di Claudio agli inglesi, e durante l'attacco dei pirati. Certo, tocca la morte
concretamente con mano, quando solleva il teschio di Yorick dalla fossa, e apprende che la
tomba scavata dai becchini è destinata a Ofelia. È ancora capace di bene disserere, di
disquisire perfettamente, ma l'esperienza della morte lo muta. Riesce, ora, a inseguire
Alessandro Magno, con implacabile logica, dopo la morte, sino al presente. Amleto si trova,
con l'amico Orazio, al cimitero dove i due becchini stanno preparando la fossa per Ofelia.
Scambia una serie di atroci, beffarde battute con uno di loro, finché questi non tira fuori alla
terra il cranio di Yorick, il buffone di corte. Quante volte Yorick aveva portato Amleto sulle
spalle, quante volte Amleto lo aveva baciato! E ora, che orrenda immagine si offre al suo
ricordo! Lo stomaco e la bocca di Amleto si stingono, mentre pronuncia un dolente ubi sunt
sulle beffe, le capriole, le canzoni, le scariche d'allegria di Yorick. D'improvviso, allora, il
Principe si rivolge a Orazio: “Credi che sotto terra anche Alessandro Magno avesse questo
aspetto?”. “Sì, proprio questo”, risponde l'amico. “E quest'odore”, riprende Amleto, mentre,
schifato, getta in terra il teschio di Yorick.
Sin qui, Amleto non ha fatto che riecheggiare meditazioni antiche sulla Morte che
tutto e tutti livella: Luciano, nel Dialogo sui morti (XII- XIV), cita proprio Alessandro, e
Marc'Aurelio (VI, 24) commenta sull'eguaglianza della polvere di Alessandro e del suo
servo. Poi, si è lanciato in un obliquo contrappunto a Plutarco: in vita, il Macedone, aveva
“un bel colorito chiaro” e “un odore così dolce che le sue vesti prendevano un olezzo
delizioso, quasi fossero profumate”13. Morto, Alessandro ha l'aspetto del povero Yorick, ed
emana lo stesso puzzo. Ma adesso Amleto si getta in un'argomentazione tutta sua. “Chi ci
impedisce di seguire con la fantasia”, dice a Orazio, “la nobile polvere di Alessandro fino a
trovarla, creta, a far da tappo al cocchiume di una botte?”. Quando Orazio replica che
pensare in questi termini sarebbe davvero eccessivamente ingegnoso, Amleto presenta la sua
inoppugnabile dimostrazione, guidata, dice, dall'umiltà e dalla verosimiglianza (“with
modesty enough, and likelihood to lid it”): “Ecco: Alessandro morì; Alessandro fu sepolto;
Alessandro torna polvere; la polvere è terra; con la terra facciamo la calce; e perché in
quella calce in cui è stato mutato non si può tappare un barile di birra?”14.
Con inesorabile consequenzialità, il ragionamento segue l'intero processo di
“similitudine”, che, attraverso la morte e la polvere, trasforma Alessandro Magno in tappo
da barile. Un eccesso di ingegnosità, di sottigliezza, di minuzia – come direbbero Orazio e
ogni persona sensata – porta Amleto vicino alla vuotezza dell'ergo del becchino. Tuttavia,
dal punto di vista logico, l'esteso sillogismo del Principe è ineccepibile: l'immaginazione
può in effetti “tracciare” il percorso che conduce da A, Alessandro, sino a Bb, il barile di
birra. Forse è qui, in questa modesty e likelihood, in questa probabilità appesa all'umiltà e
sospesa sull'improbabile che si coagula l'animo di Amleto.
13
Così Harold Jenkins nel commento a Hamlet, Arden Shakespeare, 1982, V i 191 e 191-4, p. 387.
V i 205-208: “Alexander died, Alexander was buried, Alexander returneth to dust, the dust is earth, of
earth we make loam, and why of that loam whereto he was converted might they not stop a beer-barrel?”.
14
42
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
Pochi istanti dopo, però, lo vediamo preda di un furore per la prima volta aperto.
Quando capisce che destinata alla tomba appena scavata è Ofelia, viene avanti, scontrandosi
con il fratello di lei Laerte. Adesso, conosce il proprio dolore, e pronuncia con orgoglio il
proprio nome, echeggiando il titolo che aveva dato al fantasma del padre. Adesso,
soprattutto, riconosce davanti a tutti, saltando nella fossa, il proprio amore per Ofelia:
Chi è quello il cui tormento ha una violenza
Così grande, le cui parole di dolore
Stregano le stelle vaganti e le fanno
Star ferme come ascoltando un prodigio?
Quello sono io, Amleto il danese.
…
Io amavo Ofelia. Quarantamila fratelli
Non potrebbero con tutto il loro amore
Raggiungere il mio totale15.
Può darsi che l'esperienza della morte e il riconoscimento del proprio amore per la
fanciulla morta16 spingano Amleto su una strada già intrapresa. Fatto sta che poco dopo, a
Orazio che tenta di convincerlo a dar retta ai presentimenti del suo cuore e dunque a
rinunciare o rimandare la sfida con Laerte, Amleto replica in maniera stranamente oracolare:
Nient'affatto. Sfidiamo i presagi. C'è una speciale provvidenza anche nella caduta di un
passero. Se è ora, non sarà dopo. Se non sarà dopo, sarà ora. Se non è ora, tuttavia sarà. Essere
pronti è tutto. Poiché nessun uomo sa qualcosa di ciò che lascia, che importa lasciare prima del
tempo? Sia così17.
There is special providence in the fall of a sparrow: c'è una speciale provvidenza
anche nella caduta di un passero18. I commentatori richiamano giustamente il Vangelo di
Matteo: “due passeri non si vendono forse per un sol soldo? Eppure neanche uno di essi
cadrà a terra senza che il padre vostro lo voglia”19. Ma forse, oltre alla special Providence
calvinista, Shakespeare ha presente anche un brano parallelo del Vangelo di Luca, dove i
passeri diventano cinque20, ma che prosegue con un invito da parte di Gesù a essere pronti,
alla readiness di cui parla Amleto: “Siate pronti, con la cintura ai fianchi e le lucerne
V i 250-254 e 265-267: “What is he whose grief / Bears such an emphasis? whose phrase of sorrow /
Conjures the wandering stars, and makes them stand / Like wonder-wounded hearers? This is I, / Hamlet the
Dane… I loved Ophelia: forty thousand brothers / Could not, with all their quantity of love, / Make up my
sum”.
16
Annegata: forse suicida. Ofelia compie ciò che Amleto soltanto desidera e finge: impazzisce veramente e
(forse) uccide se stessa. l’Ofelia impazzita che fa “ghirlande di violacciocche, ortiche, margherite, / e lunghe
orchidee” (IV vii 166 ss.) sembra l’archetipo della “fanciulla e i fiori” nei drammi romanzeschi.
17
V ii 213-218: “Not a whit. We defy augury. There is special providence in the fall of a sparrow. If it be
now, ‘tis not to come. If it be not to come, it will be now. If it be not now, yet it will come. The readiness is
all. Since no man knows aught he leaves, what is’t to leave betimes? Let be”.
18
H. Jenkins sottolinea nel suo commento ad loc. che gli Elisabettiani credevano sia in una provvidenza
generale, la quale si manifesta nel sistema della creazione, sia, entro questa, in una provvidenza singolare o
speciale che si manifesta in un evento particolare. Calvino insisteva su quest’ultima.
19
Matteo 10, 29.
20
Luca 12, 6.
15
43
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
accese… Anche voi tenetevi pronti, perché il Figlio dell'uomo verrà nell'ora che non
pensate”21.
Abbandonarsi alla Provvidenza, ed essere pronti alla morte, che può giungere in
qualsiasi momento: questo il messaggio evangelico. Ma come può Amleto farsi portatore di
una tale umile sapienza, sostenere, come fa poco prima22, che “una divinità dà forma ai
nostri piani / per quanto rozzamente li abbozziamo”?23 Da dove viene ad Amleto questo
teleologismo cristiano?
In tutta la prima parte del dramma, come abbiamo constatato, Amleto non aveva visto
nel mondo alcun senso: a lui, esso appariva come “un giardino non sarchiato che va in
seme”, “uno sterile promontorio”, “una sporca e pestilenziale congrega di vapori”. Nessuna
traccia, là, di un potere provvidenziale, che si prenda cura di poveri passeri o conti tutti i
capelli sul nostro capo. Allora, Amleto si interrogava se essere o non essere, se fosse meglio
continuare a vivere, sopportando tutte le pene cui l'uomo è sottoposto, o affrontare la morte,
andarle incontro volontariamente, uccidersi. To be or not to be, questionava. Ora, proclama:
Let be – lascia stare, sia così: amen. E lo ripeterà nel momento supremo, in punto di morte:
Let it be24.
Per capire l'importanza di ciò che Amleto sta veramente dicendo con il suo amen,
basta paragonarlo ancora una volta alle parole del Faustus di Marlowe. Il quale dichiara, nel
suo monologo d'ingresso, che dopo la logica (“essere e non essere”, appunto), la medicina e
la giurisprudenza, forse la cosa migliore è lo studio della Scrittura, la teologia. Anche
Faustus, e proprio leggendo la Vulgata di Girolamo, si scontra con la morte: “salario del
peccato è la morte”, pronuncia ad alta voce, e “se diciamo che siamo senza peccato,
inganniamo noi stessi e la verità che è in noi”, citando la Lettera di Paolo ai Romani e la
Prima Lettera di Giovanni25. Faustus ne ricava un'inappuntabile sillogismo (il quale non
tiene conto del fatto che, in un'ottica cristiana, Cristo redime dal peccato): di sicuro
pecchiamo, e di conseguenza dobbiamo morire. E va oltre: “Sì, dobbiamo morire una morte
eterna”. Che razza di dottrina è mai questa, si domanda allora. Se la Scrittura e la teologia
predicano l'inevitabile dannazione dell'uomo, a che servono? Così, Faustus conclude dando
addio alla “divina scienza” per passare alla negromanzia: “Che sarà, sarà: What will be,
shall be”26.
Faustus cita il detto italiano con fatalismo deterministico: nella traduzione in inglese
che ne offre, dice a tutti gli effetti: “quel che sarà, dovrà essere”. Non c'è nessuna
Provvidenza speciale, nelle sue parole, e nessun amen. Faustus è già, potenzialmente,
dannato. La logica stringente di Amleto (“Se è ora, non sarà dopo. Se non sarà dopo, sarà
ora. Se non è ora, tuttavia sarà”) conduce invece alla prontezza.
Sarà sufficiente dire che Amleto non è più in preda alla malinconia? Eppure, proprio
un attimo prima di rivolgersi a Orazio con la frase evangelica sul passero, Amleto ha
dichiarato una malattia più profonda dell'ipocondria: “non puoi immaginare che male senta
21
Luca 12, 35-40, e Matteo 24, 44, come suggerisce H. Fisch in The Biblical Presence, Oxford, Clarendon
Press, 1999, p. 113.
22
V ii 10-11.
23
V ii 10-11: “There’s a divinity that shapes our ends, / Rough-hew them how we will”.
24
V ii 342-343.
25
Romani 6, 23; 1 Giovanni 1, 8.
26
Doctor Faustus A i 37-47, qui 46-47.
44
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
intorno al cuore”. Sembra esserci, in lui, una pena della vita così radicale da essere
inesprimibile. Né basta pensare che l'avere vissuto e superato la trama di Claudio contro di
lui sia segno sufficiente della “provvidenza”. Nel raccontare tale esperienza a Orazio,
Amleto ricorda di aver chiuso la lettera al re d'Inghilterra che ha mandato a morte i suoi
latori, Rosencrantz e Guildenstern, con il sigillo di suo padre, che aveva nella borsa: “Anche
in questo”, dice, “il Cielo è stato d'aiuto”27. Il viaggio in Inghilterra e gli eventi ad esso
legati, ci viene fatto capire, sono stati in qualche modo cruciali. Ma nulla ci viene detto che
possa chiarire il processo interiore del protagonista dal dubbio buio dell'inizio verso l'incerto
chiarore finale. The rest is silence: il resto è silenzio. La caduta del passero sembra essere il
suo ultimo approdo.
Non va oltre, Amleto. Non si mette nella posizione del passero stesso come fa il
salmista. Il Salmo 102 recita: “Si dissolvono in fumo i miei giorni, e come brace ardono le
mie ossa. Il mio cuore abbattuto come erba inaridisce, dimentico di mangiare il mio pane...
Veglio e gemo come passero solitario sopra il tetto” (4-8)28. Ma poi aggiunge: “Tu, Signore,
rimani in eterno, il tuo ricordo per ogni generazione. Tu sorgerai, avrai pietà di Sion, perché
è tempo di usarle misericordia: l'ora è giunta” (13-14). No, Amleto guarda alla sorte dei
passeri, e degli esseri umani, e di se stesso, quasi fosse sulla soglia delle Scritture. Che il
volo degli angeli lo porti cantando al suo riposo è augurio e benedizione di Orazio dopo la
morte dell'amico. Non c'è fulgore di fede, nelle ultime scene di Amleto: c'è piuttosto la
comparsa di un lume lontano. La provvidenza speciale nella caduta di un passero rimane un
mistero intravisto: compreso, forse, dal protagonista, mai rivelato allo spettatore. A meno,
naturalmente, che questi non identifichi la caduta del passero con quella di Amleto: con la
morte dell'eroe. Amen29.
27
V ii 48.
Passero solitario nella Vulgata, e anche nella “Authorized Version” inglese, non nell’originale ebraico. È il
capostipite di tutti i passeri solitari della poesia occidentale, compresi quelli di Petrarca e Leopardi: v. G.
Pozzi, Alternatim, Milano, Adelphi, 1996, pp. 45-71 e 169-72.
29
In Amleto in Purgatorio, cit. Stephen Greenblatt esamina il problema dell’immaginario religioso in
Amleto, collocandolo da par suo nel contest storico-culturale dell’epoca. Mi chiedo se l’autore (e i tanti
recensori) non abbiano mancato quella che mi pare la questione più pertinente nell’ottica del libro stesso di
Greenblatt, una domanda che nasce inevitabilmente nell’immaginario medesimo evocato dall’autore. Dove
(se Shakespeare dovesse immaginare un luogo), dopo la morte, va a finire l’anima di Amleto? In Cielo, si è
irresistibilmente tentati di rispondere con il “Buona notte, dolce principe, e voli di angeli ti portino cantando
al tuo riposo” che Orazio pronuncia alla morte dell’amico (il commento di Harold Jenkins ad loc. sembra
concordate). Questo può bensì essere il pio desiderio di Orazio, e come tale non dovrebbe essere messo in
questione. Ma Amleto è, in una prospettiva radicalmente cristiana, indubbiamente colpevole
dell’eliminazione Rosencrantz e Guildenstern (per la quale, come si è visto, dice che il Cielo è stato in ultima
analisi “d’aiuto”), e di tentare e alla fine riuscire, sebbene sulla spinta dell’attimo, a uccidere Claudio.
Benché Amleto e Laerte si scambino una, strana e parziale, forma di perdono, Amleto stesso non si pente
mai esplicitamente di questi altri “peccati” (che Orazio conosce), per non parlare del suo perdonare lo zio.
Neppure il purgatorio potrebbe dunque essere la sua destinazione finale. Lo studioso, Orazio, non conosce
allora neppure la più elementare teologia, protestante o cattolica che sia? O desidera semplicemente benedire
Amleto, come farebbero i cristiani tradizionali con i loro parenti o amici morenti? E cosa potrebbe “dire”
Amleto, pochi secondi prima di morire, a coloro che sono “attori muti di questo dramma” se avesse quel
tempo che “questo duro gendarme, la Morte, inflessibile nel suo arresto”, non gli concede? Una silenziosa
“lagrimetta” in punto di morte è abbastanza per salvare il Buonconte da Montefeltro di Dante in Purgatorio
V e, condotto dall’“angelo di Dio“, egli finisce in purgatorio (mentre suo padre Guido, proprio perché non si
è pentito pur avendo ottenuto l’assoluzione preventiva del Papa, finisce all’inferno in Inferno XXVII). Il
28
45
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
Johann Heinrich Füssli, Lady Macbeth sonnambula (c. 1784); Parigi, Louvre.
silenzio di Amleto è, qui, una sorta di confessione? Finirà, come suo padre, in purgatorio? Queste non sono
domande oziose, ma fondamentali e inevitabili. Se leggessimo o guardassimo il dramma non come critici del
XXI secolo, ma come esseri umani del XVII – o, in generale, come cristiani – queste sono proprio le
domande che, avendo sentito il fantasma del padre di Amleto dire all’inizio che viene dal purgatorio, ci
porremmo alla fine. Shakespeare, naturalmente, non è Dante, e in Amleto V ii appare evidente una strana
mescolanza di prospettive etiche e metafisiche. Quando Amleto uccide Claudio, Laerte dichiara quest’ultimo
“servito giustamente” (occhio per occhio), ma poi chiede ad Amleto di scambiarsi il perdono con lui (un
gesto cristiano). Amleto replica da cristiano, “Il Cielo te ne assolva!”. Dopo essersi rivolto a Orazio con “se
avessi tempo… potrei dirvi”, Amleto lo prega di vivere e raccontare lui e la sua causa nei termini giusti “a
chi è dubbioso”: cioè di informare e di giustificare le sue azioni. E su questo insiste, parlando del “nome
ferito” che lascerà dietro di sé, e implorando l’amico di narrare la sua storia. Amleto, insomma, sembra
preoccupato della propria reputazione (e del defunto politico della Danimarca) piuttosto che della propria
morte (o vita) eterna. La sua parola finale non è né paradiso, né inferno, né purgatorio, ma significativamente
“silenzio”.
46
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
Articolo n. 6: Introduzione a “Shakespeare filosofo dell’essere”, Franco Ricordi
Da F. Ricordi, Shakespeare filosofo dell’essere, Mimesis Edizioni, Milano 2011
William Shakespeare non è stato soltanto il più grande poeta e drammaturgo inglese
e, forse, dell’Occidente; è stato anche un grandissimo e abissale filosofo. La filosofia,
ovvero la consapevolezza del proprio pensiero, è espressa chiaramente, anche se non in
forma sistematica, nel senso che tradizionalmente si attribuisce a coloro che come afferma
Hannah Arendt, sono filosofi di professione. Shakespeare raccoglie e sedimenta una
peculiarità filosofica che, nella drammaturgia occidentale, è sempre esistita: la crisi
dell’essere ovvero dell’identità delle dramatis personae (si pensi al mito più riciclato, la
tragicomica vicenda di Anfitrione e del suo servo Sosia) che è ben lungi dal proporre
enunciati o dottrine filosofiche; al contrario, fa vivere la filosofia come concreta situazione
umana, in carne ed ossa, pur rappresentando il problema fondamentale del pensiero, la
domanda sul senso dell'essere, che pervade la storia dell’Occidente. Nel secolo XX, dopo i
forti rivolgimenti del pensiero occidentale dovuti anzitutto all’opera di Nietzsche e di coloro
che lo hanno anticipato o seguito, il senso stesso e l’impostazione della filosofia hanno
subito una profonda mutazione, in particolare per la tensione sempre più forte che si è creata
nei rapporti diretti o indiretti tra filosofia e arte, pensiero e poesia.
La filosofia di Nietzsche costituisce una forte carica esplosiva, una vera e propria
rivoluzione nei confronti di ciò che fino ad allora – ma ancora oggi – prende il nome di
estetica, la riflessione filosofica sul bello e in particolare sulle arti. Se non esiste una estetica
nietzschiana, nel senso che tutto il suo pensiero è profondamente e costantemente permeato
anche a livello stilistico di una nuova relazione e tensione con l'idea dell’arte, allo stesso
modo bisogna pensare di Shakespeare: in questo modo il pensiero ontologico-estetico di
corrisponde al pensiero filosofico di Shakespeare, che enuncia e ripete in varie dimensioni e
situazioni: Tutto il Mondo è Teatro. È questo un topos antico, presente nella filosofia pagana
come in quella cristiana, ma che solo in Shakespeare raggiunge il valore filosofico che verrà
accolto da Nietzsche e dalla filosofica moderna e contemporanea. Inoltre il pensiero di
Nietzsche ha profondamente rivalutato il senso metafisico dell’uomo in quanto attore, inteso
anche nella sua peculiarità corporea, e ha influito così anche sulla cultura teatrale
novecentesca, da Artaud a Grotowski fino ai nostri giorni; tanto più si chiarirà come
Nietzsche sia stato profondamente influenzato da Shakespeare e in maniera analoga da un
altro grande poeta-filosofo, Giacomo Leopardi.
La metafora del Mondo come Teatro possiede una dimensione tragica, per eccellenza,
il pensiero che riconosce la centralità della tragedia (ma anche necessariamente della
commedia) quindi del dramma, nell’evoluzione del pensiero occidentale. E diviene in tal
modo una vera e propria “filosofia del dramma”, del tragico come del comico, che peraltro
non si interessa precipuamente al livello mondano, ma supera la storia proprio attraverso
questa stessa dimensione filosofica.
È questa, anzitutto, la struttura del pensiero di Shakespeare, quella stessa
“impalcatura del mondo” che Macbeth vorrebbe distruggere, ma che rappresenta il più forte
riferimento linguistico-filosofico del Bardo inglese, la possibilità che il mondo intero “non
47
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
sia”, cada a pezzi, si frantumi e disintegri, acceda al non-essere1. Ma proprio al cospetto di
questa possibilità, di un divenire del mondo che rappresenti o possa rappresentare la propria
stessa distruzione, nasce l'esplicita ontologia shakespeariana, nasce il suo più importante e
discusso personaggio (il più esaminato a livello mondiale), nasce il filosofo Hamlet con la
sua reiterata proposizione del problema cardinale dell’essere: da Heidegger a Jaspers a
Sartre fino a Gunther Anders, da Levinas a Gadamer e in maniera determinante con
Emanuele Severino, la filosofia moderna e contemporanea ha inequivocabilmente
risollevato – argomentando in maniera diversa – la Domanda sull’essere, per Heidegger la
Seinsfrage, anche se non sempre si è riferita direttamente al Principe di Danimarca, o ad
altri passi shakespeariani che rimandano la medesima Question: ma è proprio tale Question
che ci introduce nel modo migliore all’interno del pensiero di Shakespeare, della sua
filosofia che, dal pensiero di Amleto, ci trasporta sopra una riflessione storica, geografica,
linguistica politica, economica, psicoanalitica, estetica, scientifica, critico-letteraria,
teologica (e la riflessione sull’essenza del Cristianesimo è assolutamente insuperata, per
quanto anticipi le critiche di Leopardi e Feuerbach, Marx, Schiller e Strindberg, ma anche
per come poi il Poeta riconosca sempre nel Cristianesimo l’evento religioso-politico più
importante dell’Occidente) e poi su tutte le arti che, sicuramente, ha pochi contendenti
anche nei nostri tempi.
Vogliamo peraltro specificare che questa nostra lettura non intende qualificarsi come
una “visione prettamente filosofica” di Shakespeare: al contrario, riteniamo proprio che la
drammaturgia shakespeariana sia stata e sia una inesauribile fonte filosofica. Non vogliamo
leggere Shakespeare “in una chiave”, ma ascoltare la sua stessa Question che a noi risulta
tutt’altro che astratta: vedere in Shakespeare un autore prevalentemente politico, come nei
propositi di Ekkehart Krippendorff, di Schmitt e di altri, significa limitare inevitabilmente il
suo straordinario campo d’azione: la filosofia di Shakespeare è anche politica; ma nella
stessa misura in cui è anche una filosofia della storia, del linguaggio, dell’economia e del
denaro, della religione, delle arti tutte (in pittura un posto privilegiato lo conquista Füssli,
che avvicina Shakespeare a Kleist e al Romant) e della musica in particolare (e non
possiamo non sottolineare la straordinaria interpretazione che di lui ci ha lasciato i nostro
più grande musicista, Giuseppe Verdi), e naturalmente del teatro; poi della malinconia (si
pensi all'influenza di Shakespeare su Walter Benjamin) come della follia (e l’insania gioca
un ruolo speciale nell’impalcatura del suo pensiero, che viene ripresa persino dallo
Strutturalismo novecentesco); quindi della Natura e, nella maniera più strutturata,
dell’Essere.
La filosofia di Shakespeare è in tal senso una filosofia “prima”, e si qualifica come
tale proprio perché riesce ad abbracciare un così vasto e complesso terreno. Questo non
significa che non si possa intravedere assai bene articolazione di un forte discorso politico
shakespeariano: ed è quello che vorremmo sottolineare, pensando in particolare a tutti i
drammi romani, a cominciare dal Tito Andronico, fino al Coriolano (che supera da solo
l’impostazione brechtiana del Teatro Politico novecentesco) ai drammi greci, in particolare a
Troilo e Cressida (con il grande discorso di Ulisse sul degree) e Timone d’Atene; a tutti i
drammi inglesi e italiani, con influenze che passano per tanti altri drammi e commedie e che
si coagulano in quella che ci sembra la “sintesi più costruttiva“ del Teatro Politico
Emmanuel Lévinas, Altrimenti che essere, o al di là dell’essenza..., trad. it. S Petrosino e M. T. Aiello, Jaca
Book, 1983, p.6.
1
48
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
shakespeariano, la grande commedia problematica Misura per misura. Già lo stesso titolo,
che ricorre in maniera laica e spregiudicata a veri passi della Bibbia, è sufficiente ad
indicare il forte moderatismo che ispira il discorso politico di Shakespeare. E tuttavia, come
il suo Amleto, Shakespeare rimane uno “scettico-moderato”, un alfiere del moderatismo che
non rinuncia mai a quell'atteggiamento di dubbio metodologico che certo Montaigne è
riuscito a trasmettergli profondamente. Ma anche se l’influenza di Montaigne è stata
importante per il senso metodologico del suo dubbio, la filosofia di Shakespeare non si può
certo limitare alla saggistica montaignana e ai suoi sedimenti in Cartesio e Hume; si tratta
invece di una chiara anticipazione di quella che appare oggi come una consapevole
interrogazione – tanto più evidente e incalzante – sul senso dell’essere.
E tale domanda si struttura nel rapporto che le sue dramatis personae vengono a
stabilire con la sua entità ingannevole; il teatro shakespeariano descrive in maniera
insuperata la dialettica che si stabilisce nell’occidente tra essere e uomo; le sue dramatis
personae sono sempre, in una maniera o nell’altra, ingannate o ingannanti nell’essere.
Questa situazione filosofica non si ferma a Montaigne e Cartesio, ma coinvolge
semplicemente tutta la cultura e la filosofia moderno-contemporanea. Per tale motivo ci
appare un limite, quello dei recenti studi che si avvicinano ad una idea di filosofia
shakespeariana che sembra restringersi al raffronto e alla dialettica con lo scetticismo, ma
non alle evoluzioni ad esso posteriori2.
La filosofia di Shakespeare è ciò che ha più influenzato, sotterraneamente, l’intera
sedimentazione della cultura europea e occidentale. Spesso il poeta critica la filosofia, non
solo in due celebri battute di Amleto, ma anche attraverso tanti altri importanti personaggi e
Di vera e propria “filosofia di Shakespeare” si è parlato solo recentemente. I due studi cui ci riferiamo sono
quelli di Stanley Cavell, Disowning Knowledge in Seven Plays of Shakespeare, trad. it. Davide Tarizzo, Il
ripudio del sapere, lo scetticismo nel teatro di Shakespeare, Einaudi 2004. E quello di Colin McGinn
Shakespeare’s Philosophy, Discovering the meaning behind the plays, trad. it. Fabrizio Saulini, Shakespeare
filosofo, il significato nascosto nella sua opera, Fazi 2008. Pur nella grande stima di entrambi, dobbiamo
rilevare due limiti fondamentali: per il fatto che in tutti e due si noti sostanzialmente l’influenza dello
scetticismo su Shakespeare ovvero di questi nei confronti dei grandi filosofi scettici a lui posteriori. E
tuttavia non si voglia riconoscere come gran parte della filosofia moderna, dal romanticismo a oggi, è stata
sistematicamente e ripetutamente influenzata da Shakespeare. Siamo inoltre convinti come non sia
sufficiente soltanto a 7-8 fra i testi shakespeariani più noti, anche se certo fra i suoi più significativi, per poter
evincere l’impostazione di un suo verosimile pensiero filosofico. La possente produzione poetica e
soprattutto drammaturgica del Bardo può e deve essere affrontata nella sua integralità. È questo un aspetto di
cui si accorge bene René Girard nel volume A theatre of Envy, William Shakespeare, trad. it. Giovanni
Luciani, Shakespeare, il teatro dell’invidia, Adelphi, 1998, cfr. Introduzione, pp. 22-23. Altro studio su
Shakespeare che potremmo chiamare “filosofico” è quello di Northrop Frye, Fools os Time, Studies in
Shakespearean Tragedy, e The Myth of Deliverance. Reflection on Shakespeare’s Problem Comedies,
Toronto, 1967-1983, trad. it. Maria Pia De Angelis e Valentina Poggi, Tempo che opprime, tempo che
redime: riflessioni sul teatro di Shakespeare, Il Mulino 1986. Dovremmo inoltre tenere presente lo studio di
Waltre Kaufmann, edito da Princeton nel 1959, dal titolo From Shakespeare to existenzialism, e insieme
anche i recenti libri di Harold Bloom, Il canone occidentale, e Shakespeare: l’invenzione dell’umano. Anche
Bloom parla esplicitamente di un contenuto ovvero di un sapere filosofico che, in Shakespeare, supera di
gran lunga anche i più grandi protagonisti della filosofia contemporanea, da Heidegger a Wittgenstein.
Tuttavia non andiamo oltre, anche perché in tale prospettiva si potrebbero in parte considerare come
filosofiche tutte le più grandi opere saggistiche sul Bardo di Stratford, dagli studi di Jan Kott a quelli di
Agostino Lombardo, a tutti quelli che ulteriormente citeremo. Peraltro va rilevato come il concetto di
“filosofia di Shakespeare” si possa considerare una novità degli ultimi anni.
2
49
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
situazioni: ma in tal caso la “filosofia” viene intesa come astratta costruzione che non ha
nulla a che fare con la realtà e con le possibilità concrete – e anche artistiche –
dell’espressione umana. Tuttavia proprio tale critica alla filosofia va letta oggi, attraverso le
rivoluzioni operate da Nietzsche, Marx, Heidegger ai nostri giorni, come la più importante e
coraggiosa presa di posizione filosofica, volta ad evidenziare la necessità di un nuovo e
incondizionato accesso al problema dell’essere, la domanda fondamentale della filosofia,
intesa anche nella sua concreta locuzione di “poter essere” del mondo: l’essere o non essere
universale; la possibilità propria soltanto del XX secolo che l’essere non sia più, non
soltanto per l’inganno della Natura, madre e matrigna, come nella filosofia di Leopardi; ma
anche in riferimento alla “mano armata” dell’uomo, la filosofia delle armi che, come
vedremo, Amleto farà propria. L’ontologia e il nichilismo shakespeariani, che anticipano il
percorso filosofico che passa per lo scetticismo, il romanticismo, l’esistenzialismo ma anche
la filosofia del linguaggio (laddove questo senso metalinguistico sarà più che mai implicato
dalle interpretazioni shakespeariana di Freud e Wittgenstein) fino all’ermeneutica, sono la
concreta domanda sulle risorse esistenziali del mondo che “ha preso le armi contro un mare
di guai” e si trova di fronte alle possibilità del proprio essere o non-essere, come specificato
assai bene da Gunther Anders3.
La domanda di Amleto, come notato anche da Colin McGinn, non è “Vivere o non
vivere”, bensì “Essere o non essere”. E, come vedremo, è una questione che pervade tutti i
testi shakespeariani e nella quale sono presi tutti i più grandi personaggi: proprio perché
riguarda la quintessenza del rapporto fra mondo e teatro, la possibilità stessa del teatro come
arte, il nostro essere o non essere in quanto dramatis personae. E si tratta di una
straordinaria riflessione metateatrale sul linguaggio, sulle possibilità del nostro linguaggio,
dove la metafora del mondo come teatro rappresenta la rima fase di accesso al linguaggio, al
gioco linguistico che da sempre crea la dramatis persona, la possibilità di recitare, di essere
nel teatro. E in questa costellazione poetico-filosofica crediamo che Shakespeare si possa
inserire come terzo ma essenziale riferimento della riflessione sul nichilismo come è stata
proposta dal pensiero di Emanuele Severino: se infatti Eschilo e Leopardi rappresentano i
due poeti-filosofi che segnano l'inizio e il compimento della storia del nichilismo, crediamo
che Shakespeare possa essere considerato il terzo essenziale interlocutore di tale dialettica;
attraverso Seneca (che rimane uno dei padri profondi del teatro elisabettiano), Shakespeare
interpreta infatti la drammaturgia occidentale, di cui Eschilo è il primo padre fondatore,
nella misura in cui Amleto si può considerare come una riscrittura in chiave cristiana e
luterana dell'Orestea. Ma con la figura epocale di Bruto nel Giulio Cesare, e nella creazione
della sua finale Tempesta, Shakespeare sembra anticipare lo stesso discorso sulla Storia e
sulla Natura che soltanto Leopardi sarà in grado di impostare adeguatamente nell'età
moderna.
È evidente che ci troviamo in un percorso in cui pensiero e poesia, quindi teatro e
filosofia, pur nella loro rigorosa distinzione, risultano inscindibili. E sotto tale aspetto
dovremo anche indagare il senso e la peculiarità spettacolare del nichilismo che si è
affacciato nel XXI secolo. E risulterà chiaro come l'influenza del Bardo di Stratford sul
mondo che abbiamo vissuto e viviamo rappresenti qualcosa di sublime nella sua
complessità, forse ancora non compresa in tutti i suoi aspetti. Si tratta di una vera e propria
“influenza astrale”, e l'Autore è realmente come un astro che illumina, ma che pure ha
3
Gunther Anders, Essere o non essere, trad. it. R. Solmi, Linea d’ombra, 1995
50
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
suggestionato la nostra storia. Nessuno come Shakespeare è stato tanto determinante nella
cultura occidentale: ancora oggi viviamo in un'epoca che si può definire shakespeariana
[…]. Ma non possiamo scordare che gli stessi eventi di terrorismo dell'11 settembre 2001,
attraverso cui si è aperto il nuovo secolo e millennio cristiano, sono caratterizzati da una
matrice che può apparire fortemente spettacolare, quindi anche shakespeariana,
nell'insensata violenza ma anche nell'accettazione di un guerra d'immagine che
drammaticamente continua e sembra non poter finire. Così, pure in un'epoca in cui l'arte di
Shakespeare – il Teatro – appare sempre più disconosciuta, mistificata e dimenticata a
favore di una spettacolarizzazione di tutte le prerogative umane, la sua potente metafora del
Theatrum Mundi si ripropone ancora oggi come la più profonda realtà concreta e al
contempo metafisica della nostra esistenza.
[…] Shakespeare interpreta il suo passato, e si ramifica nel futuro: in questa maniera
ci ha lasciato una straordinaria testimonianza del mondo a lui contemporaneo, ma anche una
ben precisa visione della storia e una fortissima pre-visione dell'Europa e del mondo che
sono venuti dopo di lui. Per questa parliamo di filosofia di Shakespeare, di un retaggio di
pensiero che si sedimenta sempre di più nei secoli a lui posteriori, e si inserisce in ciò che
Harold Bloom ha definito epicentro del Canone Occidentale. Shakespeare non è assoluto
ma, come scrive Goethe, senza fine. E qui subentra proprio quella “alta fantasia” che,
sembrerebbe, qualcosa di totalmente antitetico a ciò che denominiamo filosofia di
Shakespeare. È invece la sua stessa fantasia poetica che assume una impostazione al
contempo realistica ma anche favolistica del mondo in cui soggiornano i suoi drammi.
La fantasia di Shakespeare non è soltanto la folle descrizione della regina Mab da
parte di Mercuzio, ma anche il suo atteggiamento nei confronti della realtà geografica:
Shakespeare avverte quello che, dopo due secoli, scriverà Leopardi: “E figurato è il mondo
in breve carta; / Ecco tutto è simile, e discoprendo / solo il nulla s'accresce”. Il mondo è
figurato in una cartina, e i “Nostri sogni leggiadri ove sono giti?” La fantasia non è
inconsapevole della realtà, l'odierna globalizzazione che rischia di distruggere la stessa
realtà fantastica che, per sua natura, è più vera e poetica della realtà mondana. La fantasia è
la stessa mimesis shakespeariana, il principio della sua poesia teatrale, che per sua
quintessenza non sarà mai nulla di realistico e “visibile” nel senso dell'odierna percezione
televisiva e spettacolare del mondo. Quindi la filosofia dell'essere di Shakespeare è
strettamente legata al senso del suo teatro: è il suo teatro, la sua poesia. Ed è un tutt'uno con
la fantasia che lo sostiene nella sua produzione. E la fortissima, straordinaria ironia che
sottende tutte le sue opere (anche quelle più cupe, come vedremo per il Macbeth) è una
prova altrettanto evidente della sua filosofia. La filosofia di Shakespeare risiede nella stesa
ironia, comica ma anche tragica, leggera ancorché terribile e insinuante, che sostiene l'arco
intero delle sue opere poetiche e teatrali. Pertanto Shakespeare è il primo autore che, in
epoca moderna e in maniera portentosa, abbatte queste secolari barriere culturali,
coniugando teatro e filosofia, poesia e pensiero, fantasia e scienza: una fantasia che supera
la realtà ma proprio per spiegarci, in maniera inedita e insuperata, il senso più concreto della
nostra situazione esistenziale.
51
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
Johann Heinrich Füssli, Robin Goodfellow-Puck (1787-1790);
Shaffhausen, Museum zu Allerheiligen.
52
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
Articolo n. 7: “Passione e violenza in Romeo e Giulietta”, René Girard
Da R. Girard, Geometrie del desiderio, Raffaello Cortina Editore, 2012
Nelle commedie shakespeariane tutti gli innamorati si credono incarnazioni
dell'amore “vero”. L'amore è vero purché i due partner si interessino esclusivamente l'uno
all'altro e restino indifferenti a tutti gli intermediari, mezzani e terzi. L'amore “vero” è
l'equivalente elisabettiano di quello che noi definiremmo un grande amore: l'amore
passionale, l'amore eterno. Esprimendo l'indipendenza dal resto del mondo e dagli altri,
questo concetto è impregnato d'individualismo moderno. Se questo amore “vero” fosse così
indipendente come pretende di essere, i due amanti si accontenterebbero della loro mutua
presenza senza mai impelagarsi con gli altri.
Invece, nelle commedie di Shakespeare, le cose vanno in modo molto diverso.
L'amore vero scoppia sempre in presenza di qualche ostacolo. È quello che Lisandro spiega
alla sua beneamata Ermia all'inizio del Sogno di una notte di mezza estate:
Ahimè, per tutto quello che ho potuto leggere,
Ho sentito raccontare e la storia insegna,
Un amore vero non è mai filato liscio.
Gli amanti non si ritengono responsabili dei contrattempi di un amore vero. Si
considerano vittime di genitori tirannici, amici gelosi e altri rompiscatole. Il Sogno di una
notte di mezza estate è la celebrazione di questo mito, di cui propone contemporaneamente
una decostruzione umoristica. Occorreva anche mettere in scena quattro amanti al posto di
due. Lo chassé-croisé a cui si dedicano i personaggi in questa torrida notte estiva riceve la
scusante più carina e futile che si possa immaginare: al fine di aiutare gli amanti a superare
il loro imbarazzo, i folletti maliziosi avrebbero scambiato le coppie somministrando un
filtro amoroso...
L'illusione dell'amore “vero” ricupera un desiderio mimetico. Invece di trarre origine
dagli amanti in persona, i loro flirt sono causati dalla loro perpetua imitazione reciproca e
dei racconti che hanno potuto leggere. Giocoforza, i nostri quattro innamorati finiscono per
disputarsi lo stesso oggetto: i due ragazzi la stesa ragazza, le due ragazze lo stesso ragazzo.
Questi adolescenti capricciosi e scriteriati hanno un sacco di tempo da perdere. Più li
ascoltiamo esaltare l'amore vero, meno li vediamo metterlo in pratica. A causa di queste
simmetrie perfette, questo balletto di disarmonia mimetica è stato spesso interpretato come
il trionfo della forma sul contenuto e giudicato non abbastanza all'altezza del genio
shakespeariano. In un saggio precedente1 avevo osato dire che l'amore “vero” non ha posto
nelle opere giovanili di Shakespeare. E avevo tralasciato di citare Romeo e Giulietta, l'opera
che sembra smentire platealmente questa conclusione. Si potrebbe sostenere che qui il
legame amoroso non dura abbastanza a lungo per dimostrare la sua solidità. Tuttavia, non si
può non riconoscere che Romeo e Giulietta sono testardamente leali e sinceri l'uno con
l'altro. Per dimostrare la sua “sincerità” o la sua “autenticità”, Giulietta si rifiuta di fare la
1
R.Girard, Shakespeare, il teatro dell'invidia, trad. it. Adelphi, Milano 1998
53
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
preziosa a meno che il suo spasimante non glielo chieda espressamente:
O nobile Romeo,
Se mi ami, dillo a chiare lettere.
Ma se pensi che abbia ceduto troppo in fretta,
Metterò cipiglio, sarà caparbia e mi negherò [...]
Atto II, scena I
[…] I due sono talmente incapaci di sotterfugi e inganni che nulla di veramente
tragico, nulla di drammaticamente emozionante può venire a incrinare la loro relazione. In
opere teatrali come il Sogno di una notte di mezza estate, i rapporti che intrattengono i
personaggi sono sufficientemente volatili per provocare delle peripezie fatte apposta per
distrarre il pubblico. Non è il caso di Romeo e Giulietta. Per quanto auspicabile possa essere
nella vita reale, questa assenza di possibilità drammatiche è disastrosa sulla scena, a meno
che, naturalmente, il drammaturgo non trovi il modo di ovviare all'inadeguatezza teatrale
dell'amore “vero”. Shakespeare non ha dovuto aspettare Gide per capire che coi buoni
sentimenti non si fa buona letteratura.
In Romeo e Giulietta tutti gli effetti drammatici sono mutuati dall'esterno della storia
d'amore. Il sotterfugio è la lite cruenta che divide le due famiglie veronesi. Dalla prima
all'ultima battuta, l'odio che si giurano i Montecchi e i Capuleti occupa un posto
fondamentale. Shakespeare deve ritornaci sopra in continuazione per rendere piccante
questa storia d'amore irrimediabilmente piatta e deve anche ricorrere a parecchie
stratagemmi, fra cui spicca la famosa scena del balcone. Nelle scene tradizionali del balcone
la suspense è dovuta al fatto che la damigella minaccia di chiudere la finestra, o addirittura
di avvertire i genitori. Qui questa risorsa non è utilizzabile. Giulietta ha fatto capire a
Romeo che lui è il benvenuto sul balcone. Il messaggio è chiaro. Romeo lo sa, e lo
sappiamo anche noi. Shakespeare si è affrancato così bene dai meccanismi abituali della
suspense da essere costretto a utilizzare un altro espediente. In Romeo e Giulietta è una
faida intestina impersonata dai feroci cugini di Giulietta che dovrebbero essere appostati tra
i cespugli e che, per una affronto molto meno grave della scalata al balcone, non
esiterebbero a trucidare una decina di Montecchi […].
Questi terribili cugini, però, non si materializzano mai. […] Tuttavia, fino all'ultimo
istante Romeo e Giulietta non smettono mai di nominarli. I Capuleti si rivelano
indispensabili, se non altro per tenere viva la conversazione. In effetti, come quasi tutti i
giovani innamorati, Romeo e Giulietta non hanno molto da dirsi. Romeo fa finta di temere
la possibile indifferenza di Giulietta, ai suoi occhi più temibile di un'intera armata di
Capuleti. Ma non è molto convincente e la tentazione di liquidare i suoi discorso come una
semplice galanteria è forte. Non c'è da stupirsi se una faida instaura un clima di paura e
violenza. In Romeo e Giulietta quello che semmai stupisce è vedere fino a che punto questa
faida influenzi il linguaggio della passione e, in particolare, l'espressione dell'amore di
Giulietta per Romeo. La faida diventa una sorta di artificio letterario, e questa è una
funzione insolita per quella che in fondo è soltanto una serie ininterrotta di vendette. Al fine
di chiarire questo punto, occorre tornare su un problema ampiamente dibattuto un centinaio
di anni or sono. Il problema della retorica flamboyante di Romeo e Giulietta. Lo stilema più
appariscente è l'ossimoro, la giustapposizione di due emozioni contrarie: gioia e tristezza,
piacere e dolore e soprattutto amore e odio. Della poesia amorosa dei primordi dell'Europa
54
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
moderna sappiamo che si caratterizza per una spiccata tendenza ad associare parole d'amore
appassionato ad altre di feroce ostilità. All'inizio del XX secolo i critici letterari inciampano
nell'ossimoro in cui vedono una contraddizione intrinseca. Essendo per definizione i contrari
incompatibili, sembra illogico amalgamarli in un unico identico stilema. Un'opera
sovraccarica di ossimori è giudicata troppo irrazionale per essere ammirevole. L'ossimoro è
stato visto come un segno di svogliatezza da parte dell'autore o addirittura un peccato di
gioventù nel caso di Romeo e Giulietta.
La mania dell'ossimoro non è stata tanto deprecata da giustificare l'esclusione di
quest'opera dall'elenco dei capolavori Shakespeare? Se oggi questo dibattito sembra
piuttosto insulso, allora nessuno avrebbe dubitato della sua legittimità. In questo caso una
delle scommesse è la preminenza dell'amore “vero” in Romeo e Giulietta. Bisogna sapere
che i critici di una volta avevano un temperamento romantico che faceva un po' a pugni con
la serietà di cui si sentivano investiti. Per loro l'amore vero era l'emozione più nobile del
cuore umano. E siccome nel teatro shakespeariano è una rarità, perfino secondo le letture
più ottimiste, ai loro occhi Romeo e Giulietta rivestiva un'importanza particolare. Non era
forse lecito aspettarsi che il più grande drammaturgo di lingua inglese avesse dedicato
almeno uno dei suoi capolavori all'esaltazione dell'amore vero? Romeo e Giulietta sembrava
il candidato ideale. Di qui la volontà di annoverare questa pièce fra i capolavori del poeta. Il
principale ostacolo era la pletora di ossimori. Non era un segno evidente che anche il suo
autore non le riconosceva la serietà che merita un vero capolavoro?
La più spettacolare collezione di ossimori interviene quando Giulietta viene a sapere
che Romeo ha assassinato Tebaldo, il suo primo cugino e amico d'infanzia:
Oh, cuore di serpe nascosto sotto un viso florido!
Ha avuto mai un drago una spelonca così bella?
Stupendo tiranno, diavolo angelico!
Corvo dalle piume di colomba, agnello vorace
Come un lupo!
Sostanza spregevole dall'aspetto divino!
L'esatto contrario proprio di come apparivi...
Un santo maledetto, un furfante onorato!
Oh, natura, osa diavolo avevi da fare all'inferno
Quando hai rinchiuso lo spirito di un demonio
Nel paradiso mortale di un corpo così dolce?
C'è mai stato un libro dal contenuto così abietto
Rilegato così bene? Ahi, l'inganno doveva albergare
In una magione così sfarzosa?
Atto III, scena II
In se e per sé questi ossimori non hanno senso. Prendiamo la formula “diavolo
angelico”: un diavolo e un angelo sono antitetici e sembra un'assurdità volerli associare.
Giulietta sputi il rospo e dica una volta per tutte se considera romeo un diavolo o un angelo!
Mischiare i due epiteti per fare di Romeo un diavolo angelico è un'incresciosa
contraddizione. Questa è l'obiezione che di solito si solleva contro l'ossimoro, ma così si
dimentica che, perfino nell'esistenza più tranquilla, avvenimenti sconvolgenti dalle
conseguenze diametralmente opposte possono succedersi con una tale rapidità da
accavallarsi fra di loro e provocare il caos. Ed è esattamente quello che accade a Giulietta,
55
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
che si è innamorata di un uomo che ora più che mai dovrebbe considerare un assassino
perché ha appena provocato la morte di Tebaldo. L'odio ancestrale fa a pugno con l'amore
nascente, sicché il suo cuore è alle prese con sentimenti opposti che si scontrano senza posa
fra di loro. La vera domanda non riguarda la razionalità intrinseca degli ossimori ma la loro
pertinenza alla situazione caotica del personaggio che li formula. Da innamorata Giulietta
benedice Romeo; da cugina di Tebaldo, lo maledice. Anche Giulietta è un ossimoro vivente.
La spiegazione che propongo dell'ossimoro è semplicemente una questione di buonsenso,
nella misura in cui esso è richiesto dalla trama. Ma qui l'intreccio non è tutto e non basta a
spiegare l'impressione suscitata dalla tirata di Giulietta. Gli ossimori non sono troppo
numerosi, troppo spettacolari, persino troppo stereotipati – la maggior parte ritorna in tre
tragedie dello stesso autore – per non sospettare in questo caso un'intenzione ironica, una
voglia di parodia.
Shakespeare cerca di fare il ritratto di Giulietta o il suo in quanto creatore compulsivo
di ossimori? Senza dubbio ha un obiettivo più interessante e consono alla natura di questa
pièce. Insomma qual è il bersaglio di questa ironia? La stranezza è che il monologo appena
citato non allude minimamente all'omicidio di Tebaldo né, tanto meno, a Tebaldo medesimo,
e non contiene alcun riferimento alla causa presunta di questo mirabolante collage retorico.
Se dovessimo lettere questo testo come una poesia isolata in un'antologia, quale effetto
produrrebbe su di noi? Se fossimo all'oscuro del contesto, non ci verrebbe in mente che è
innescata dalla morte violente di un parente, e vedremmo nel monologo il discorso di una
donna i cui dispiaceri sono causati dal suo innamorato e dipendono direttamente dalla storia
d'amore in quanto tale, dal suo comportamento amoroso, e non dalla morte di un parente
stretto. Diremmo che colei che parla fa bene a diffidare dell'uomo di cui si è follemente
invaghita. La donna sembra temere che il suo amore non sia contraccambiato. Quello che
sospetta è terribile, molto più terribile della morte di un cugino: sospetta un'infedeltà.
In questo contesto, così come ce lo siamo immaginato, invece di essere annacquata
da un qualsiasi tradimento del giovanotto, la passione della donna che parla è attizzata oltre
ogni misura e lei si sente umiliata, prova una grande vergogna di se stessa. La donna
dovrebbe rispondere all'indifferenza del colpevole con un'indifferenza ancora più grande,
dovrebbe restituirgli pan per focaccia, ma Giulietta non arriva a tanto e si sente atrocemente
sconfitta. Giulietta non può dimenticare l'angelo che si nasconde dietro il nemico diabolico
che è diventato ai suoi occhi il suo amore: Romeo risponde davvero alla definizione di
“diavolo angelico” […].
Ci aspetteremo che questo tipo di accostamento produca un ottundimento generale
della passione di Giulietta per Romeo. Quando l'odio si sovrappone all'amore, dovrebbe
risultarne una sottrazione, una diminuzione della carica erotica, e non un aumento. Una
miscela di caldo e di freddo dovrebbe produrre un desiderio tiepido. Ma non è così che
funziona l'ossimoro. Invece di temperare la passione, la attizza. La miscela d'amore e di
odio suggerisce un amore molto più forte di quello che non è venato di odio e che
produrrebbe la semplice accumulazione di termini affettuosi e positivi. […]
Ecco il paradosso dell'ossimoro: in un certo contesto un “diavolo angelico” sembrerà
più desiderabile di un angelo tout court. Perché? I sentimenti negativi (gelosia, collera,
rancore, ecc.) che, a rigor di logica, dovrebbero spegnere la passione, in realtà la rafforzano.
E' chiaro che l'amore di Romeo e Giulietta, pur volendo passare per innocente e dolce,
obbedisce a questa legge inesorabile. Senza ossimori, l'amore di Giulietta sembrerebbe
56
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
57
Sir Frank Dicksee, Romeo e Giulietta (1884); Southampton City Art Gallery, Hampshire.
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
meno nevrotico e intenso del dovuto. Per analizzare questa alchimia occorre inquadrare
l'ossimoro nel contesto del desiderio mimetico, cui ho appena accennato a proposito del
Sogno di una notte di mezza estate. Il soggetto di un desidero mimetico imita l'altrui
desiderio e lo fa proprio, con la conseguenza quasi inevitabile che desidera lo stesso oggetto
del suo modello, la stessa donna per esempio, come nel caso dei due ragazzi nel sogno.
All'inizio della commedia tutti e due sono innamorati di
Ermia; più tardi, durante la
notte, si innamoreranno di Elena. I due passano da una ragazza all'altra e, poiché lo fanno
sempre sotto l'influenza l'uno dell'altro, la loro rivalità non è per niente casuale. L'accordo
mimetico dei due ragazzi è, in verità, il peggiore disaccordo immaginabile. Questa
constatazione vale, ovviamente, anche per le due fanciulle. In questo sistema l'unico
costante è la rivalità universale, causa di una frustrazione universale...
La legge del desiderio mimetico è la frustrazione universale. E sbaglieremmo a immaginare
che questa legge faccia eccezione ogni volta che un rivale ha la meglio sull'altro. Il vincitore
fa suo l'oggetto conteso, ma il piacere che ne ricava non dura. L'oggetto di cui ci si è
assicurati il possesso è un oggetto che nessun modello e rivale potente ci indica e che ci
mette poco a perdere il suo richiamo mimetico. Gli unici oggetti che restano sempre
desiderabili sono gli oggetti inaccessibili, quelli che sono indicati da modelli troppo potenti
per essere sconfitti. In questo universo di individui ipermimetici che è la corte elisabettiana
o la nostra società dei consumi, il principio di frustrazione è inesorabile. Se l'amore “vero”
non è mai stato e non sarà mai un lungo fiume tranquillo, è perché in fondo non ha niente di
vero: è un desiderio mimetico che non può e non vuole riconoscere la propria natura, un
desiderio che riscopre tutta la sua intensità ed eternità soltanto quando è frustrato dalla
vittoria di un rivale – modello. In realtà tutti i “tossici” mimetici dipendono dall'indifferenza
e dal rifiuto. E' la loro droga. In questo non bisogna, però, vedere un masochismo
nell'accezione enfatica della psicoanalisi, un “desiderio di soffrire”. E' semplicemente un
dato di fatto. Il meccanismo mimetico genera la propria nemesi, preferendo sempre il
mediato all'immediato, l'inaccessibile all'accessibile. Gli innamorati mimetici non possono
continuare a desiderare colei che contraccambia le loro avances, così come non possono
restare insensibili a colei che ostenta indifferenza. Spesso la donna inaccessibile assomma i
ruoli di oggetto e di modello, o di mediatore, e sa tenere a distanza il proprio spasimante per
assicurarsene l'asservimento. E' così che la “dark lady” dei sonetti shakespeariani si
comporta con il poeta. Grazie alla sua abile padronanza del gioco mimetico, lo fa ingelosire
e sfrutta a suo vantaggio le leggi del desiderio mimetico. Combinazioni a parte, il desiderio
mimetico obbedisce sempre a questa legge ineluttabile: l'intensità è inversamente
proporzionale alla possibilità di appagamento.
Esso è la ricetta infallibile di una frustrazione infinita, impersonata dal duca Orsino
ne La dodicesima notte. Poiché è sempre inappagato, l'amore viscerale suscita un forte
rancore verso la beneamata.
L'ossimoro esprime alla perfezione questa combinazione di passione e risentimento.
Non esiste amore che non sottintenda un certo odio e, reciprocamente, non esiste odio che
non sia capace di trasformarsi misteriosamente in una grande amicizia, magari soltanto per
un attimo, come nel caso di Coriolano e Aufidio, il re dei Volsci. Invece di essere uno
stilema “artificiale”, come vorrebbe l'ottimismo borghese, l'ossimoro traduce il carattere
mimetico dei legami amorosi quando sono costantemente ostacolati da una rivalità reale o
presunta.
58
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
[…] Sotto le sembianze di una contesa famigliare Shakespeare può reintrodurre in
Romeo e Giulietta queste unioni di contrari che non dovrebbero turbare due innamorati la
cui intesa sfiora la perfezione. Shakespeare sa che il pubblico è incapace di concepire un
desiderio viscerale se non sotto forma di un ossimoro, cioè in termini di frustrazione
estrema. L'assassinio di Tebaldo e la faida famigliare gli permettono di portare
surrettiziamente l'ossimoro in primo piano. Il duello fatale a Tebaldo non costituisce un
delitto perché Romeo ha fatto di tutto per evitarlo ed è soltanto un pretesto per mettere in
moto una valanga di ossimori.
Se avesse giocato in tutta onestà il gioco dell’amore vero, Shakespeare avrebbe rinunciato
all’ossimoro, anche a costo di deludere le attese dei suoi contemporanei. L’amore che unisce
Romeo e Giulietta doveva essere immune da ogni violenza per essere autenticamente
“vero”. Per dargli un’intensità sufficiente, Shakespeare ha dovuto inserire una figura
retorica più consona alle rimostranze e alle infedeltà che gli amanti mimetici si sciroppano.
E per legittimare questa violenza, invece di ancorarla laddove dovrebbe in realtà stare, cioè
proprio nelle relazioni amorose, Shakespeare l’ha sistematicamente dislocata sulla faida
familiare. L’amore vero dovrebbe rappresentare il desiderio più inteso; in realtà, è un
sentimento troppo perfetto e mite perché il pubblico si accontenti. Gli manca il mordente
che soltanto la violenza fra innamorati può conferire alla loro relazione. Shakespeare ha
bisogno delle perturbazioni mimetiche suggerite dagli ossimori, ma non può attribuire a
Giulietta i soliti motivi di screzio fra innamorati senza appannare l’immagine perfetta del
loro amore e senza distruggere il mito che ha deciso di propinarci. Per preservare la verità e
la forza dell’amore vero, Shakespeare non può che ricorrere alla faida familiare e se la tiene
stretta. In nome dell’omicidio di Tebaldo, Giulietta può scatenarsi contro Romeo e
inventarsi un folle attacco di gelosia senza avere alcun motivo plausibile di essere gelosa.
Shakespeare fa risalire tutto alla faida familiare, così Giulietta da libero sfogo a un torrente
di ossimori senza comunque assomigliare alla dark lady dei Sonetti. L’amore vero che lega
Romeo a Giulietta doveva essere al di sopra di tutte le carognate mimetiche che gli
innamorati si sciroppano. Ora, se avesse rispettato alla lettera questa consegna, Shakespeare
avrebbe scritto una tragedia sentimentalmente inappuntabile ma insipida. Per evocare il
sentimento d'intensa passione che il pubblico si aspetta da lui senza, tuttavia, doverne
pagare il fio, Shakespeare deve contrabbandare la violenza, ed è esattamente quello che la
faida gli consente di fare. La morte di Tebaldo surroga il tradimento che avrebbe dovuto
perpetrare Romeo per giustificare i sentimenti espressi dagli ossimori di Giulietta. Per il
tramite della contesa familiare, Shakespeare dà l’impressione di una forte gelosia senza
inficiare la prezza dell’amore vero che unisce Romeo e Giulietta.
La vecchia balia è l’unico testimone della tirata di Giulietta. Questa comare,
completamente devota al clan dei Capuleti, si augura di tutto cuore che Giulietta rinunci alla
sua passione per Romeo. Quando sente Giulietta proferire delle parole cariche d’odio
all’indirizzo del giovanotto, la balia la prende in parola e prova un gran sollievo. Giulietta
sembra tornare a parlare come una leale Capuleti e la nutrice si rallegra di questo
voltafaccia. Per incoraggiarla, esclama: “Romeo si vergogni!”. Questa tontolona non
comprende la logica dell’ossimoro. Applicando il suo solido buonsenso al monologo, ne
fraintende il significato. Quando vede che delle parole astiose si mescolano all’elogio che di
solito Giulietta fa di Romeo, ne deduce che l’odio ha rimpiazzato l’amore e cade nella
trappola che tutti gli innamorati nevrotici tendono al loro entourage: dà per scontato che
59
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
Giulietta dica quello che pensa e pensi quello che dice. Ma quando sente che la balia insulta
Romeo, Giulietta s'inalbera:
La tua linguaccia si copra di afte
Per un simile auspicio! Lui non è fatto per la vergogna.
Sulla sua fronte la vergogna si vergogna di stare,
Perché è un trono dove l’onore può essere incoronato
Monarca assoluto dell'universo.
Oh, che sciocca sono stata a sgridarlo!
Atto III, scena II
Giulietta, che ha capito perfettamente la svista della balia, ribatte in un modo che,
stavolta, non può essere frainteso. Una scena simile coinvolge frate Lorenzo e Romeo.
Quando il francescano esorta il suo protetto a rinunciare al vaniloquio, Romeo gli spiega
senza peli sulla lingua perché ha preferito Giulietta a Rosalina: quest’ultima non si era
degnata di accettare le sue avances.
La collera di Giulietta contro la sua balia è la stessa degli scrittori di fronte a un
pubblico ottuso, refrattario alle allusioni più sottili. La nutrice non ha capito che la tirata di
Giulietta tradiva un aumento e non già una diminuzione della passione per Romeo.
Puntando sulla rivalità fra i due clan, Shakespeare ha la botte piena e la moglie ubriaca in un
colpo solo: può addebitare alla faida familiare una violenza che, in realtà, gioca un ruolo
positivo nel discorso dei due innamorati e gli dà una nota di vera passione. Come tutte le
tecniche letterarie che hanno una lunga storia alle loro spalle, lo stile ossimorico di Romeo e
Giulietta è meno artificiale di come appare a prima vista. ネ una testimonianza oggettiva, più
oggettiva di quanto i critici letterari vogliano riconoscere, delle relazioni amorose in un
mondo ipermimetico. I critici hanno espunto quello che l’ossimoro aveva di veritiero perché
non hanno colto il carattere mimetico dei nostri desideri e le sue conseguenze.
Personalmente vedo nell’ossimoro un segno precursore del diluvio di violenza e di
pornografia che oggi si abbatte sui resti della nostra cultura.
Con il pretesto della morte di Tebaldo Giulietta, pur restando legata a doppio filo a
Romeo, è dilaniata come dovrebbe essere un’amante appassionata. Invece di rappresentare
un ostacolo, la contesa familiare è indispensabile per dare l’impressione di una forte
passione che si sprigiona da una relazione che, da sola, non potrebbe generare l’intensità
conflittuale richiesta da un legame che dovrebbe essere infuocato. Il monologo che segue
l’omicidio di Tebaldo è caricaturale non perché non sarebbe riuscito a integrare i diversi
elementi di questo artificio letterario ma perché qui, a mio avviso, il suo proposito è
zavorrato da un umorismo didattico. Shakespeare vuole essere sicuro che gli spettatori più
perspicaci scoprano il bluff. Questo brano ha una tonalità parodistica che fatalmente ne
compromette la resa estetica. Preoccupato com’è di sbandierare le sue intenzioni,
Shakespeare spinge ai limiti l'ossimoro e mette in caricatura la sua tecnica per renderla
grossolanamente evidente agli spettatori più smaliziati. Nelle altre scene della stessa
tragedia i diversi elementi che compongono l'insieme si concatenano così armoniosamente
fra di loro che non siamo tentati di analizzarli uno alla volta. La fusione dei lessici amoroso
e bellicoso è abbastanza convincente per esprimere un amore così forte che sarebbe
sacrilego metterlo in dubbio. A titolo d’esempio prendiamo alcune battute di Giulietta subito
dopo il suo primo abboccamento con Romeo, quando viene a sapere che il ragazzo di cui si
60
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
è appena invaghita è l’erede universale dei Montecchi. Ecco qui la sua reazione:
Dal mio unico odio è sbocciato il mio unico amore,
Visto troppo presto senza conoscerlo, conosciuto
Troppo tardi.
Mostruoso parto dell’amor è per me
Che debba amare un nemico odioso!
Atto I, scena V
Giulietta non potrebbe riassumere più chiaramente la situazione in cui si trova: si è
invaghita di un nemico mortale della usa famiglia. Proprio come nel caso della morte di
Tebaldo, Giulietta non può evocare la sua situazione senza reinventare l’ossimoro. Questi
quattro versi sfruttano lo stesso principio della tirata che abbiamo commentato a lungo.
Ogni affermazione assomiglia a un ossimoro e funziona come tale senza, però, esserlo nella
misura in cui non c'è niente di metaforico: è una semplice constatazione imposta dalla
situazione familiare. Nessuna allusione suggerisce che un conflitto interiore divampi nel
cuore di Giulietta; eppure, attraverso il semiossimoro fornito dalla contesa familiare, questi
quattro versi sembrano più appassionati di come sarebbero stati se Shakespeare non avesse
incorporato la faida nella storia d’amore. Se nel primo verso la parola “amore” non fosse
controbilanciata dalla parola “odio”, risuonerebbe falsa. Lo stesso vale per l’ultimo verso
dove il verbo “amare”, se non riguardasse un “nemico odioso”, non avrebbe la stessa
identica forza. L’aura di sacralità arcaica che circonda e santifica questa passione dipende
dalla violenza della faida e, una volta eliminata quest’ultima, scompare del tutto. Malgrado
la violenza dei propositi di Giulietta, la usa relazione con Romeo continua a essere di una
purezza assoluta. E questo, in fondo, è l’obiettivo di tutti questi giochi di prestigio retorici.
Lo stile “ossimorico” di Romeo e Giulietta è una contaminazione reciproca fra l’idillio e la
guerra, che produce miracoli poetici e qualche effetto volutamente ridicolo. Per Giulietta
Romeo è un nemico odioso non perché si amano ma perché fa parte del clan dei Montecchi.
Tuttavia, è chiaro che l’amore di Giulietta non è soltanto amplificato, ma anche reso più
profondo dal carico di odio. In realtà, la compenetrazione della guerra e dell’idillio, che ci
viene presentata come una coincidenza, è uno stratagemma del drammaturgo che sa
perfettamente di dover introdurre nella usa opera un po’ di violenza in modo che, invece di
compromettere il loro amore, lo rafforzi ai nostri occhi. Esteticamente questi quattro versi
sono più efficaci del lungo monologo di Giulietta perché la loro funzione “retorica” è meno
evidente, dato che qui tutto è giustificato non solo poeticamente ma anche dai fatti. Nella
tirata di Giulietta Shakespeare finge di essere maldestro, come un insegnante che
armeggiasse per mostrare come procedere a un esperimento delicato, rendendo più agevole
l'emulazione da parte degli allievi. Di recente Olivier Maurel2 ha sottolineato che gli
innamorati delle tragedie erano non meno mimetici dei personaggi delle commedie. Se
avesse davvero ideato la sua pièce secondo il solito gusto “romantico”, Shakespeare avrebbe
2
Scrittore e ricercatore nella sfera della violenza educativa. Nei suoi Essais sur le mimétisme ha studiato,
sulla scorta della teoria di René Girard, oltre a Romeo e Giulietta, Fedra, Le relazioni pericolose,
Candido, Lorenzaccio, L'educazione sentimentale e Zelig, il film di Woody Allen. Ha pubblicato Œdipe et
Laios. Dialogue sur l'origine de la violence (2003, con lo psicoanalista Michel Pouquet) e Oui, la nature
humaine est bonne! (2009).
61
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
scelto di mostrare fin dall’inizio un Romeo innamorato di un’altra Capuleti, quella Rosalina
che innaffia a pioggia di cliché poetici riservati in seguito a Giulietta? Se avesse voluto fare
di Romeo e Giulietta i modelli dell’amore vero, li avrebbe rappresentati con i tratti di piccoli
snob mimetici? E’ esattamente quello che fa all’inizio della tragedia quando, dopo un primo
bacio scambiato con Romeo, Giulietta esclama: “Tu baci a regola d’arte!” non per biasimare
la sua mancanza di spontaneità, ma per elogiare la sua perfetta aderenza alle regole in voga.
Donna Capuleti non si fa illusioni sullo snobismo della figlia. Per farle digerire quello che
lei e il marito hanno scelto come sposo, la lusinga recitando in suo onore un poemetto
manierato del tipo che Giulietta avrebbe potuto comporre per Romeo. Olivier Maurel ha
colto nel segno: Romeo e Giulietta assomigliano a tutte le figure classiche del desiderio
mimetico che attraversano la letteratura occidentale. Artificialmente Shakespeare ha difeso
la loro storia d’amore dalle conseguenze per turbanti di questo desiderio. Shakespeare vuole
che Romeo e Giulietta superino agevolmente la prova dell’amore “vero”. Quanto agli
orpelli che arricchiscono il mito di Romeo e Giulietta, come l’artificio del doppio suicidio,
Shakespeare sarà costretto a metterli platealmente in ridicolo nel Sogno di una notte di
mezza estate, dove le avventure di Piramo e Tisbe possono essere lette come una parodia di
Romeo e Giulietta. Se non avesse un po’ manipolato il nostro desiderio mimetico,
Shakespeare non sarebbe riuscito a fare della storia di Romeo e Giulietta il mito romantico
che è diventata. Lo sfruttamento della violenza in questa tragedia ha un che di surrettizio
perché Shakespeare insiste sul fatto che la violenza della contesa familiare è totalmente
estranea a Romeo e Giulietta che, nel prologo e ancora nella scena finale sono presentati
come le vittime sacrificali di una faida ancestrale. […]
62
Johann Heinrich Füssli, Il risveglio di Titania (1785-1789), Winterthur, Kunstmuseum.
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
Articolo n. 8: “Shakespeare inventò una lingua nuova”, Nadia Fusini
Dal sito www.simonamaggiorelli.com – 26 ottobre 2010
Nelle sue tragedie e ancor più nelle commedie Shakespeare ribaltò con ironia l’immagine
femminile angelicata. «Non più figura inerte ma soggetto attivo del proprio desiderio». A
colloquio con Nadia Fusini, studiosa e traduttrice del grande bardo
Professoressa Fusini, il genio Shakespeare nasce anche da un cambio di orizzonti
culturali?
Il momento shakespeariano fu una congiuntura straordinaria e complessa: di crisi politica (la
regina Elisabetta moriva senza eredi) ma al contempo di apertura di orizzonti legata ai
viaggi transoceanici e a “scoperte” di nuove terre. Alla fine del Cinquecento Londra era una
metropoli, con mille razze e mille lingue. Un clima elettrizzante. In quella koiné
Shakespeare inventò una lingua estremamente mobile, varia, espressiva. Fu un periodo
pieno di vitalità e insieme di ansie, di paure di qualcosa di apocalittico, mentre il nuovo
stava emergendo.
La teologia, lei scrive, non era più vista come la scienza dominante nell’Inghilterra
protestante di William Shakespeare.
C’è un nuovo sapere che si afferma, un sapere dell’uomo. La domanda che più volte torna in
Shakespeare è proprio: che cos’è l’uomo? Si comincia a non cercare più la risposta nella
teologia cristiana. C’è un nuovo sguardo. S’intuisce che bisogna scoprire l’umano nel
rapporto con la natura e nelle relazioni con gli altri esseri umani. Anche gli studi di
medicina contribuirono a riportare la “creatura” a terra.
Shakespeare filosofo? Come scrive Colin McGinn in un libro uscito due anni fa per
Fazi?
Shakespeare non è un filosofo. Semmai è un poeta filosofo, come diceva T. S. Eliot, perché
è uno che lavora con la lingua, che crea immagini. E attraverso le immagini che inventa
passano emozioni, passano pensieri. Shakespeare pensa per immagini.
Conobbe il pensiero di Giordano Bruno che fu Oltremanica dal 1582 al 1585?
Un contatto indiretto ci fu. Shakespeare della sua epoca coglie le idee più vive, fa parte di
circoli di persone che discutono nuove ipotesi. Shakespeare non incontrò personalmente
Giordano Bruno ma incontrò certi suoi pensieri. E, per quanto fossero diversi anche nella
scrittura, lo stesso Bruno per far passare ciò che pensa usa una lingua drammatica.
Come per Bruno, per Shakespeare l’immaginazione è positiva, non una maligna
fantasia come invece dicevano invece Hobbes e Spinoza?
Assolutamente sì. Shakespeare sta dal lato bruniano della questione. Al contempo
63
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
Shakespeare drammatizza la polisemia della parola, che vuol dire anche fiction e finzione.
Allora che cos’è la verità? Domande così percorrono e dinamizzano tutti i suoi testi.
«Dagli occhi delle donne lui impara», fa dire Shakespeare a un suo personaggio. Le
donne sono rappresentate in modo nuovo nelle sue opere?
Shakespeare stigmatizzava con ironia il Dolce Stil Novo. Lasciandosi alle spalle l’idea
poetica di una donna “sovrana” da corteggiare ma che il cavaliere non conquisterà mai.
Anche in Romeo e Giuletta, per citare la tragedia più romantica, c’è comunque un
personaggio come Mercuzio che, a suo modo, prende in giro l’immagine angelicata della
donna.
Del resto Shakespeare è anche l’autore de La bisbetica domata, dove Caterina si ribella
all’idea della donna obbediente e silenziosa. Come lei stessa ha scritto nel libro I volti
dell’amore...
Qui l’idea dell’amore angelicato viene addirittura ribaltata. Io penso che la ricchezza di
Shakespeare stia proprio nel mostrare molti punti di vista e, riguardo ai personaggi
femminili, molti tipi di donne. Soprattutto nelle commedie sono ragazze molto sveglie e che
sanno come conquistare l’amore. In Tutto è bene quel che finisce bene, per esempio, c’è
un’eroina, Elena, che parte per andare a cercare l’uomo che ama e che l’ha rifiutata per
banali motivi di classe. E lei riesce a “conquistarlo”. La donna non è più figura inerte, qui è
soggetto attivo del proprio desiderio. Ofelia, certo non è così. Ma Shakespeare sa
rappresentarla nel momento in cui sboccia; è una bellissima immagine, però, come
accennavo, non si iscrive nel Dolce Stil Novo. Anche il fatto che lei impazzisca a causa
della freddezza di Amleto rende ancora più drammatica questa figura di fanciulla che si
trova vittima di una trama psicologica e politica che la supera. Ma pensi anche a una figura
come Cordelia di Re Lear, è un personaggio femminile che dice quello che pensa, che va
alla corte di Francia per difendere il padre. Non possiamo dimenticare un fatto storico,
ovvero che fino al 1603 Shakespeare vive in un Paese in cui sul trono c’è una donna. Vive in
una cultura misogina ma concretamente c’è comunque Elisabetta, una donna, al comando.
Insomma una figura che, per quanto regale, faceva pensare che la donna non fosse
necessariamente il sesso debole.
Da ultimo, una domanda a Nadia Fusini traduttrice. Quanto si perde leggendo
Shakespeare in italiano?
È il grande sconforto di chi come me prova a tradurre. Io so bene che la lingua in cui
trasporto Shakespeare non è assolutamente all’altezza. Non è per fare una boutade ma non è
un caso che Shakespeare non sia nato in Italia. L’italiano è una lingua che non credo
avrebbe mai potuto partorire un autore come lui. L’italiano è una lingua diversa e non
consente quelle arditezze, quelle acrobazie straordinarie. L’inglese di Shakespeare è una
lingua molto concreta, onomatopeica, una lingua di suoni aspri, gutturali, è molto difficile
tradurla nella nostra lingua, qualcosa necessariamente si perde.
64
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
Ma forse nemmeno l’inglese di oggi, molto standardizzato, sarebbe adatto a renderne
l’espressività?
L’inglese di oggi è molto più facile da tradurre, perché è molto più povero. L’inglese di
Shakespeare ha un vocabolario molto ma molto grande. Attinge da un lato alle radici latine,
dall’altra alle radici sassoni, c’è una ricchezza originalissima.
65
Johann Heinrich Füssli, Titania e Bottom con la testa d’asino; Zurigo, Kunsthaus Zürich.
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
Articolo n. 9: “How much did the Jesuits influence Shakespeare?”, Clare Asquith
Dal sito http://www.catholicherald.co.uk - 3 dicembre 2014
The Society of Jesus had a huge influence on European drama at the time
Imagine the unexpected discovery of anonymous 16th century play which is at once
moving, inspiring, many-faceted, entertaining, funny, tear-jerking, scholarly, streetwise,
profound. A play which is at once tragic and comic, classical and Christian, humanist and
low-life: a universal play, which reminds its watchers what it is to be human. If you were to
ask anyone whether such a play might have been written by Lyly, Greene, Peele, Kyd,
Marlowe or Shakespeare, the answer will be immediate – it must be Shakespeare. It is not
just genius which sets him apart from his immediate contemporaries – it is his distinctively
complex, multi-layered blueprint.
What has been sidelined for centuries, however, is the possibility that this blueprint was
conceived, not by Shakespeare himself, certainly not by his English predecessors, but by the
acknowledged educators of Europe – the Jesuits. Central to the revolutionary Jesuit system
of education was drama, and that drama had certain qualities. It had to have a high moral
purpose – to win spectators ‘from worldly vanity’. But it was far from pious. Its intended
audience was often influential and mainly secular, and included both Protestant and
Catholic, nobleman and artisan, an eager audience as it turned out who from the mid 16th to
the mid 18th century packed the burgeoning Jesuit theatres across Europe from Prague to
Messina, constantly demanding more, and pouring money into ever more lavish
productions. The Jesuit mission was not simply to entertain, it was to instill a ‘worldfriendly spirituality’ into ordinary people as well as emperors, in pursuit of the common
good and a better society. They used the best writers they could find, ideally actors, and
deployed them throughout their network of theatres to spread their winning method,
incorporating both profane and spiritual into their work along with music and dance in order
to promote the common good and what Ignatius called ‘the help of souls’.
If thousands of these plays were written, why do we know so little about them? Partly
because, though some vernacular was used, on the whole they were written in the lingua
franca, Latin; and partly because, rather like cinema today, these performances were seen as
multi-sensory events, in which music, acting, scenery and direction were as important as the
script, which was often discarded. In London however, where the precarious public theatre
was viewed with suspicion and dislike by the Puritan authorities, a full, portable, selfexplanatory and above all vernacular script was a lifeline to the survival of a play. It might
seem extraordinary that Shakespeare’s works have never been connected with their natural
source, the Jesuit school of drama, were it not for the later demonization, in England in
particular, of everything to do with Ignatius. Literature scholars have always had difficulty
relating Shakespeare’s fully formed dramatic virtuosity with the limited works of his
predecessors. Their strengths are largely poetic, and have none of Shakespeare’s 3D
technical skill and decisive moral purpose and depth.
66
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
The discovery of a first folio left behind by the Jesuit school at St Omer, annotated for
performance, should not surprise us: though forged in the crucible of the English
predicament, it was to the breadth, scope and experienced professionalism of the
international Jesuit school of drama that it probably owed its existence in the first place.
67
Johann Heinrich Füssli, Macbeth, Banquo e le Streghe (1793-1794);
Petworth House and Park, West Sussex.
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
Articolo n. 10: “Tuh beh oar nat tuh beh? That was the question”, Charlie Cooper
Dal sito http://www.independent.co.uk/- 17 marzo 2012
This radically different pronunciation is, according to a new scholarly recording of
Shakespeare's works, much closer to the way the line would have been spoken
"To be, or not to be, that is the question." Or is it "Tuh beh oar nat tuh beh"? If you were to
ask the Bard himself, he'd probably say the latter.
This radically different pronunciation is, according to a new scholarly recording of
Shakespeare's works, much closer to the way the line would have been spoken by the
company of actors who first performed Hamlet 400 years ago. Far from the haughty clipped
vowels we are used to hearing from a thousand actors since Laurence Olivier, the "real"
Shakespeare sounds more like a West Country farmer, with a dash of Irish and even a hint of
east coast American.
"People from all over the country were coming to Elizabethan London and their accents
were fusing," said Ben Crystal, an actor, director and expert in OP (original pronunciation)
Shakespeare. "Not long after Shakespeare's time people started getting on the boats to
America, and later Australia. Some sounds in modern accents from these places, are the
same sounds that would have been heard on the tongues of Shakespeare's contemporaries."
Attempts to get back to the original sounds of Shakespeare have been made before, most
notably at The Globe in London, and in a performance of Hamlet in Reno, Nevada in which
Crystal played the lead role, with an accent reminiscent of a Devon farm labourer. Now,
working with his father, the linguistics expert David Crystal, he has produced an extensive
recording of some of Shakespeare's best known speeches and sonnets for the British Library,
all in the original pronunciation.
The result is a more muscular Shakespeare that sounds harder and much closer to the
common man than we have become accustomed to. "Romeo, Romeo," becomes "Rohm-yo,
Rohm-yo"; two short syllables that sound like Sam Gamgee from The Lord of the Rings
saying "Frodo, Frodo". Henry V's "Once more unto the breach" becomes "Ons moar un-tuh
thuh braych", which, when roared out to an imaginary army, makes King Henry sound more
like a bar-room brawler than the prim aristocrat that Olivier portrayed in the 1944 film.
The original pronunciation also makes the language move faster. Crystal's OP version of
Hamlet, though abbreviated no more than most productions, was about half an hour shorter
than most. "When we hear original pronunciation used in relation to Shakespeare, we enter a
new auditory world," said David Crystal. "Rhymes that don't work in modern English
suddenly work. Puns missed in modern English become clear."
The Crystals are "95 per cent sure" of the accuracy of their method. Taking as their sources
the archaic spellings used in Shakespeare's First Folio and an early grammar textbook
written by his contemporary Ben Jonson, they were able to trace the sounds of Shakespeare
in the rhythms and rhymes of his plays and poems. Rhymes that do not work in modern
English, such as "love" and "prove" suggest an older pronunciation. As Ben Crystal puts it,
68
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
"no-one other than Elvis Presley ever extended the vowel sound in love", the rhyme must be
on "prove" – so "love" for Shakespeare sounded like "loove".
New and old: The Bard's English
As You Like It
"All the world's a stage,
And all the men and women merely players"
"Al thuh warrld'z uh stehdge, Und al thuh men und who-men meerlee play-uhrz"
King Lear
"Blow, winds, and crack your cheeks! Rage! Blow! You cataracts and hurricanoes"
"Blow, weinds und crack yoar cheks! Rehge! Blow! Yew kat-arr-aks und hurr-ee-kan-ohs"
Richard III
"A horse, a horse! My kingdom for a horse!"
"Uh hoarse, uh hoarse! Muh kin'dum furrah hoarrse!"
69
Johann Heinrich Füssli, Le tre streghe di Macbeth (1783); Zurigo, Kunsthaus Zürich.
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
BIBLIOGRAFIA PARZIALE
OPERE
W. Shakespeare, A. Lombardo “Antonio e Cleopatra. Testo originale a fronte”, Feltrinelli
2000
W. Shakespeare, A. Lombardo, “Re Lear. Testo inglese a fronte”, Feltrinelli 2014
W. Shakespeare, “Le allegre comari di Windsor”, Mondadori 1999
W. Shakespeare, A. Calenda, “Come vi piace”, Mondadori 1992
W. Shakespeare, A. Cozza, “Riccardo II. Testo inglese a fronte”, Garzanti 2005
W. Shakespeare, A. Lombardo, “Amleto. Testo inglese a fronte”, Feltrinelli 2013
W. Shakespeare, A. Lombardo, “Coriolano. Testo inglese a fronte”, Feltrinelli 2002
W. Shakespeare, A. Lombardo, “Il Mercante di Venezia”, Feltrinelli 2013
W. Shakespeare, A. Lombardo, “Il racconto d'inverno. Testo inglese a fronte”, Feltrinelli
2007
W. Shakespeare, A. Lombardo, “La dodicesima notte”, Feltrinelli 2013
W. Shakespeare, A. Lombardo, “La tempesta. Testo inglese a fronte”, Feltrinelli 2014
W. Shakespeare, A. Lombardo, “Macbeth. Testo originale a fronte”, Feltrinelli 2013
W. Shakespeare, A. Lombardo, “Misura per misura”, Feltrinelli 2003
W. Shakespeare, A. Lombardo, “Otello. Testo inglese a fronte”, Feltrinelli 2013
W. Shakespeare, A. Lombardo, “Romeo e Giulietta. Testo inglese a fronte”, Feltrinelli
2014
W. Shakespeare, A. Lombardo, “Timone d'Atene. Testo inglese a fronte”, Garzanti 2009
W. Shakespeare, A. Lombardo, Giulio Cesare. Testo inglese a fronte”, Feltrinelli 2013
W. Shakespeare, A. Serpieri, “Pericle, principe di Tiro. Testo inglese a fronte”, Garzanti
2008
W. Shakespeare, M. A. Marelli, “I sonetti”, Garzanti 2012
W. Shakespeare, N. D'Agostino, “Molto rumore per nulla”, Garzanti 2012
W. Shakespeare, N. D'Agostino, “Pene d'amor perdute. Testo inglese a fronte”, Garzanti
2006
W. Shakespeare, N. Fusini, “Sogno di una notte di mezza estate. Testo inglese a fronte”,
70
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
Feltrinelli 2009
W. Shakespeare, S. Perosa, “La bisbetica domata “, Garzanti 2011
W. Shakespeare, S. Sabbadini, “Re Giovanni. Testo inglese a fronte”, Garzanti 1995
W. Shakespeare, V. Gabrieli, “Riccardo III. Testo inglese a fronte”, Garzanti 2008
CRITICA LETTERARIA
A. Lombardo, “Shakespeare e il Novecento”, Bulzoni 2002
A. Burgess, “Shakespeare”, Vintage 1996
A. Lombardo, “Eduardo e Shakespeare. Parole di voce e non d'inchiostro”, Bulzoni 2004
A. Lombardo, “L'eroe tragico moderno”, Donzelli editore 2005
A. Lombardo, “La grande conchiglia. Due studi su «La tempesta»”, Bulzoni 2002
A. Lombardo, “Lettura del Macbeth”, Feltrinelli 2010
A. Lombardo, E. Tarantino, “Storia del teatro inglese. L'età di Shakespeare”, Carocci
2001
A. Lombardo, I. Imperiali, “Storia del teatro inglese. Dalle Medioevo al Rinascimento”,
Carocci 2001
A. Serpieri, “Polifonia shakespeariana”, Bulzoni 2002
F. Ricordi, “Shakespeare filosofo dell'essere”, Mimesis 2011
G. Melchiori, “Shakespeare”, Laterza 2005
H. Bloom, “Shakespeare. L'invenzione dell'uomo”, Bur Rizzoli 2003
J. Kott, “Shakespeare nostro contemporaneo”, Feltrinelli 2006
M. Cacciari, “Hamletica”, Adelphi 2009
N. Fusini, “Di vita si muore”, Mondadori 2013
P. Boitani, “Il Vangelo secondo Shakespeare”, Il mulino 2006
R. Girard, “Shakespeare il teatro dell'invidia”, Adelphi 1998
S. Greenblatt, “Vita, arte e passioni di William Shakespeare, capocomico. Come
Shakespeare divenne Shakespeare”, Einaudi 2005
71
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
FILMOGRAFIA PARZIALE
“Shakespeare in Love”, regia di John Madden, 1998
“Looking for Richard”, regia di Al Pacino, 1996 (documentario che riadatta alcune scene
di Richard III e al contempo esamina la rilevanza di Shakespeare nella cultura popolare)
“Anonymous”, regia di Roland Emmerich, 2011
“Hamlet”, regia di Laurence Olivier, 1948
“Hamlet”, regia di Gregory Doran, 2009 (filmato per BBC Television)
“Hamlet”, regia di Franco Zeffirelli, 1990
“Hamlet”, regia di Kenneth Branagh, 1996
“Hamlet”, regia di Michael Almereyda, 2000
“Un Amleto di meno”, regia di Carmelo Bene, 1972
“Amleto (da Shakespeare a Laforgue)”, regia di Carmelo Bene, 1974
“Homelette for Hamlet, operetta inqualificabile”, regia di Carmelo Bene, 1978
“Rosencrantz & Guildenstern sono morti", regia di Tom Stoppard, 1990
“The Tempest” regia di Julie Taymor, 2010
“Romeo e Giulietta”, regia di Franco Zeffirelli,1968
“Romeo+Juliet”, regia di Baz Luhrmann, 1996
“As You Like It”, regia di Kenneth Branagh, 2006
“A Midsummer Night's Dream", regia di Michael Hoffman, 1999
“Coriolanus”, regia di Gregory Doran 2012 (versione filmata per BBC Television)
“King Lear”, regia di Brian Blessed, 1999
“Othello”, regia di Orson Welles, 1952
“Henry V”, regia di Kenneth Branagh, 1989
“Chimes at Midnight”, regia di Orson Welles, 1966 (adattamento che propone una serie di
scene tratte da Richard II, Henry IV, Henry V e The Merry Wives of Windsor)
“Cesare deve morire”, regia di Paolo e Vittorio Taviani, 2012
“Richard III”, regia di Richard Loncraine, 1995
“Richard III”, regia di Laurence Olivier, 1955
“Riccardo III”, regia di Carmelo Bene, 1977
72
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
“Richard the Second”, regia di John Farrell, 2001
“William Shakespeare - His Life & Times”, regia di Mark Collingham e Robert Knights, 1978
(documentario in sei parti che tratta la vita di Shakespeare)
“Giulio Cesare”, regia di Joseph L. Mankiewicz, 1953
“Macbeth”, regia di Orson Welles, 1948
“Il trono di sangue”, regia Akira Kurosawa, 1957
“Ran”, regia di Akira Kurosawa, 1980
Johann Heinrich Füssli, Titania e Bottom (c. 1790);
Londra, Tate Gallery.
73
26-29 MARZO
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
RINGRAZIAMENTI
Un ringraziamento particolare a tutti gli studenti e le studentesse che hanno
offerto la loro collaborazione e il loro supporto nella realizzazione del
seminario:
Chiara Strano, Roberto De Biasi, Chiara Mantini, Francesco Santi, Mattia
Sirgiovanni, Michele Brescia, Stefano Argyrou, Ivana Schirinzi, Giulia Santi,
Rosa Maria Vassalli.
Gaia Coltorti
Martina Murabito
Giuseppe Melcore
Gennaro Cataldo
Vittorio Ruggieri
74
Johann Heinrich Füssli, Falstaff nel cesto della biancheria (1792);
Zurigo, Kunsthaus Zürich.
.
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
APPUNTI
75
TUTTO IL MONDO È PALCOSCENICO
26-29 MARZO
APPUNTI
76