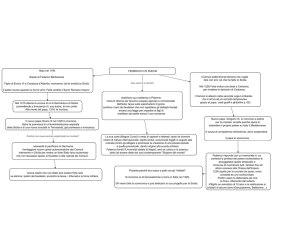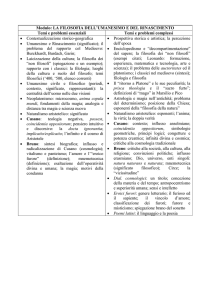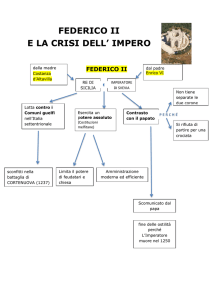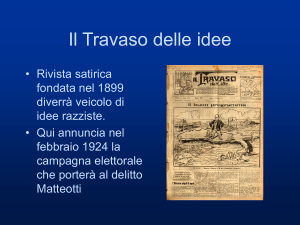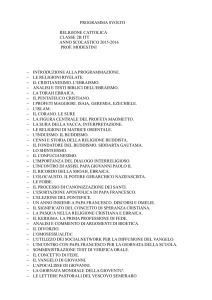BIBLIOTECA DELL’OFFICINA DI STUDI MEDIEVALI
15
In copertina: Battaglia della Falconara dell’1 dicembre 1299. Tratto da: Il Villani illustrato.
Firenze l’Italia medievale nelle 253 immagini del ms. Chigiano L VIII 296 della
Biblioteca Vaticana.
Medioevo e dintorni
Lezioni della sezione di Trapani dell’Officina di Studi Medievali
a cura di
Giuliana Musotto
2011
Medioevo e dintorni : Lezioni della sezione di Trapani dell’Officina di Studi Medievali / a cura di
Giuliana Musotto. – Palermo : Officina di Studi Medievali, 2011
(Biblioteca dell’Officina di Studi Medievali ; 15)
1. Mistica – Teologia – Medioevo – Atti di convegni
I. Musotto, Giuliana
230.01 CDD-21
ISBN 978-88-6485-020-7
ISBN 978-88-6485-022-1 (pdf e-book)
CIP: Biblioteca dell’Officina di Studi Medievali
Manuela Girgenti ha collaborato all’organizzazione degli incontri curando la segreteria, la logistica e
l’Ufficio Stampa.
Copyright © 2011 by Officina di Studi Medievali
Via del Parlamento, 32 – 90133 Palermo
e-mail: [email protected]
www.officinastudimedievali.it
www.medioevo-shop.net
ISBN 978-88-6485-020-7
ISBN 978-88-6485-022-1 (pdf e-book)
Ogni diritto di copyright di questa edizione e di adattamento, totale o parziale, con qualsiasi mezzo è
riservato per tutti i Paesi del mondo. È vietata la riproduzione, anche parziale, compresa la fotocopia,
anche ad uso interno o didattico, non autorizzata dall’editore.
Prima edizione, Palermo, luglio 2011
Stampa: FOTOGRAF – Palermo
Grafica editoriale: Alberto Musco
Indice
Premessa di Alessandro Musco
IX
Introduzione di Salvatore Girgenti
XI
Manuela Girgenti, Filone d’Alessandria e il giudaismo rabbinico1
Antonio Bica, I vangeli Gnostici e il Cristianesimo delle origini19
Giuseppina Mammana, La ricerca di sé come ricerca di Dio e
dell’anima nel pensiero di S. Agostino
33
Fabio Cusimano, Il monachesimo benedettino. Origini, tradizioni e cultura47
Manuela Girgenti, Il concetto di giustizia nell’età antica e medievale57
Giuseppe Allegro, Medioevo e teologia. Scienza e ricerca di Dio
79
Luciana Pepi, Alcune considerazioni sulla presenza ebraica in Sicilia
nel Medioevo91
Salvatore D’Agostino, La Sicilia di Federico III d’Aragona105
Vincenzo M. Corseri, Religione e politica in Europa nella prima metà
del Quattrocento. Cusano e Piccolomini a Basilea119
Flavia Buzzetta, Aspetti della magia in epoca tardo-medievale
131
Salvatore Girgenti, Le radici politiche e religiose dei templari:
una ipotesi di ricerca149
Filippo Grammauta, La pergamena di Chinon. La prova
dell’assoluzione dei dignitari templari dall’accusa di eresia
161
Salvatore D’Angelo, La medicina nel Medioevo169
VIII
Indice
Abstracts, Curricula e Parole chiave185
Indice dei nomi (a cura di Giliana Musotto)
195
Premessa
Da quando l’Officina di Studi Medievali, su proposta di Salvatore Girgenti,
mio collega universitario a Palermo negli anni che furono e poi prestigioso collega
nella comune passione per gli studi storici e filosofici, unitamente ad un gruppo di
appassionati amanti del Medioevo, ha deciso – con grande e positiva convinzione
- di aprire una sede staccata a Trapani, le attività e le iniziative del “gruppo trapanese”, sono state un vero esempio di intelligenza culturale, di capacità di proposta e di
grande coinvolgimento di tantissime persone!
In due anni si sono tenuti incontri, conferenze e lezioni, sempre largamente
partecipati, che hanno toccato vari aspetti dei saperi medievali, siano essi riferiti al
contesto locale trapanese e siciliano, sia a quello mediterraneo od, ancora, a quello
più vasto della dimensione europea e continentale; aspetti storici, culturali, letterari,
filosofici, teologici, artistici etc… si sono susseguiti e sono stati affrontati da graditissimi studiosi ed esperti, locali e non, che hanno dato la loro affettuosa e “gratuita”
disponibilità ad offrire stimolanti momenti di riflessione e di dibattito che, qui, ora
ed in queste pagine, trovano espressione.
Già per il prossimo anno sociale 2011-2012, con inizio dall’autunno del 2011,
si profilano nuovi incontri e nuovi momenti di studio: segno evidente di una vivacità
di interessi e di passioni degni di nota e sempre attivi: cosa non comune a Trapani
ma non solo a Trapani!
Azioni, fatti, eventi ed impegni cui dobbiamo – io per primo - il massimo rispetto!
Grazie alla piena disponibilità del Prof. Ignazio Crimi, antico mio amico personale in comuni battaglie ed impegni politico-sociali, titolare dell’Istituto Europa
srl, l’Officina ha a Trapani una sua sede stabile che accoglie, tra l’altro, anche tutte
le sue pubblicazioni curate in questi trent’anni dalla fondazione, disponibili per il piu
vasto pubblico, per i giovani universitari, oltre che per i soci. A lui devo un ringraziamento particolare per l’attenzione e la sensibilità che ha sempre dimostrato: doti
oggi sempre più rare anche nel mondo della scuola e della cultura.
Come pure, devo un grazie convinto alla Banca di Credito Cooperativo “Sen.
Pietro Grammatico” di Paceco ed ai suoi vertici, per la decisione di voler finanziare questa pubblicazione che raccoglie ben tredici saggi frutto delle attività curate
dall’Officina a Trapani. Non è qui raccolto tutto quanto è stato fatto ma un’ampia e
significativa scelta, ricca di tematiche e di letture del vasto contesto medievale.
X
Premessa
Sono certo che gli amici trapanesi continueranno su questa linea e che ci offriranno ancora altre pagine da leggere e meditare su un patrimonio che mai potrà finire
di stupirci e di appassionarci. A tutti loro il nostro grazie convinto.
Alessandro Musco
Introduzione
I lavori raccolti in questo volume sono il frutto di alcuni seminari, svoltisi
presso la sede dell’Officina di Studi Medievali di Trapani, su argomenti e tematiche
prettamente medievali e concernenti, in particolare, la storia delle idee filosofiche,
politiche e sociali. L’obiettivo, oltre alla diffusione dei saperi medievali, è quello di
gettare le basi per lo sviluppo sul territorio di una nuova ricerca sul Medioevo, libera
da dogmatismi e capace quindi di scrollarsi di dosso pregiudizi e incrostazioni che
attraverso i secoli ne hanno condizionato i risultati, poiché è innegabile che sullo
sfondo vi è sempre stata la presenza enigmatica e, allo stesso tempo, inquietante del
potere e delle sue strutturazioni storiche.
In questa eterna lotta fra l’esigenza del libero sviluppo speculativo dell’uomo e quella rappresentata dalle forme culturali di istituzionalizzazione del potere,
è quest’ultima che il più delle volte si è affermata, legittimando una cultura assolutistica ed esaustiva con la pretesa di cancellare ogni pensiero che non obbedisca al
rigido binario dell’ortodossia. Non dimentichiamo che molto spesso nei testi scolastici siamo stati soliti leggere che il Medioevo è stato un periodo buio della nostra
storia. Ma ciò non è assolutamente vero. In realtà, il Medioevo è stato un periodo
ricco di fermenti culturali e di intelligenze speculative di grosso spessore, costrette il
più delle volte a navigare “in apnea” per evitare di incappare nelle soffocanti maglie
sanguinarie dell’Inquisizione. Condizionata da un tale clima, la cultura filosofica
medievale in occidente si è trovata appiattita su un’accezione sostanzialmente cristiana del pensiero filosofico, trascurando coscientemente il grande apporto della
filosofia araba e di quella ebraica, considerandole e leggendole, tutt’al più, come
forme di anticipazione dei grandi autori della Scolastica.
L’Officina di Studi Medievali guarda invece al Medioevo, come è suo costume, nel senso più lato e inclusivo con proiezioni sulle sue radici nelle culture antiche
e sui suoi lasciti alle culture moderne.
Il nostro augurio è che questi contributi, nella piena libertà di pensiero, possano produrre nuovi sviluppi o, quanto meno, nuove ipotesi di ricerca in una visione di
continuità tra il soggetto medievale e quello moderno.
Salvatore Girgenti
Manuela Girgenti
Filone d’ Alessandria e il giudaismo rabbinico
Premessa
L’ebraismo, dal XIII secolo a.C. sino all’avvento del cristianesimo, si è principalmente caratterizzato come dottrina di vita, privilegiando l’approccio pratico, in
luogo di quello teoretico, verso i grandi temi della vita spirituale dell’uomo. La storia
di questo popolo è stata consegnata alle Sacre Scritture, un insieme di testi nei quali
si riteneva che Dio avesse parlato per bocca di uomini da lui prescelti. Il cuore delle
scritture per l’ebraismo è il pentateuco, una raccolta di leggi che, secondo la tradizione, erano state scritte da Mosè su ispirazione di Dio e così chiamato perché conteneva i libri della Genesi, dell’Esodo, del levitico, dei Numeri e del Deuteronomio.
Mosè è proprio il personaggio chiave della storia del popolo ebraico. A lui Dio affidò
il compito di riportare in Palestina il popolo israelita, liberandolo dalla schiavitù in
Egitto, dove si erano trasferiti in seguito ad una carestia. La liberazione dall’Egitto
ebbe anche come conseguenza una alleanza fra Dio e il popolo di Israele, di cui
Mosè fu il mediatore. Mantenendo fede a questo patto, Jahvè, non solo avrebbe fatto
loro dono della terra promessa, ma lo avrebbe anche considerato come suo popolo
eletto. Così, stando al libro dell’esodo, sul monte Sinai Mosè ricevette da Dio il Decalogo (i dieci comandamenti) dal cui rispetto dipendeva la solidità del patto di alleanza. In realtà, la penetrazione nella terra promessa da parte del popolo ebraico non
avvenne pacificamente, ma attraverso una serie di lotte con le popolazioni locali. Nel
722 a. C., poi, il regno di Israele, dopo una debole resistenza, dovette piegarsi alla
potenza assira. Momenti di grande drammaticità si registrarono, inoltre, nel 538 a.C.,
in seguito all’occupazione della Palestina da parte del re Nabucodonosor. In quella
circostanza gli ebrei, non solo subirono l’onta di vedere distrutto il loro Tempio,
ma andarono incontro a una nuova deportazione. Alla luce di queste esperienze non
pochi ebrei cominciarono a nutrire dubbi sul patto di alleanza con Dio e, in particolare, sulla predilezione di Jahvè nei loro confronti. È in questo clima che attorno alla
metà dell’VIII secolo a. C. si va sempre più affermando la predicazione dei profeti,
uomini illuminati che parlavano per volere e a nome di Dio. A detta di questi ultimi,
gli avvenimenti drammatici che avevano colpito il popolo di Israele scaturivano dal
2
Manuela Girgenti
fatto che quest’ultimo aveva infranto la legge, ricadendo spesso nell’antico peccato
di adorare falsi idoli e, quindi, di essersi allontanato da Dio. I profeti, in poche parole, lanciarono un messaggio di conversione e, nel contempo, un invito a tornare alla
fede in Jahvè e a rimanere fedeli all’alleanza mosaica.
L’osservanza delle leggi, dunque, che, come abbiamo già detto, erano state
scritte da Mosè su ispirazione di Dio, costituiva per gli ebrei un irrinunciabile imperativo categorico. Un atteggiamento, quest’ultimo, che chiarisce il motivo per cui
gli ebrei, prima dell’incontro con la filosofia greca, si mostrarono poco propensi ad
occuparsi di speculazioni filosofiche, disinteressandosi a livello culturale di tutto ciò
che non riguardasse lo studio della legge. Il Deuteronomio, infatti, il primo grande
codice religioso del popolo ebraico redatto non oltre l’anno 621 a. C., accoglieva
quella che era stata la principale occupazione dell’età profetica: la volontà,cioè, di
assicurare l’ordinamento morale, mediante la giustizia e, nello stesso tempo, di ricordare che il popolo di Israele è il figlio prediletto di Jahvè, Dio dell’Universo, non per
i suoi meriti, ma per un dono misericordioso dello stesso Jahvè, dovuto al suo amore
e alle promesse fatte ai patriarchi. E, in realtà, i testi sacri degli ebrei, il Talmud e la
Torah, con la varietà inesauribile del loro contenuto, sembravano appagare la loro
sete di conoscenza e le loro più immediate esigenze spirituali.
L’osservanza della legge diventava così l’unico mezzo per raggiungere la santità e la salvezza. Per i farisei, infatti, una delle principali sette dell’ebraismo e dalle
cui fila provenivano i rabbini più autorevoli, «non l’intenzione decide della moralità
della vita, ma la somma delle azioni, prese come unità esteriorizzata in rapporto
alla loro corrispondenza ai precetti legali».1 Lo spirito religioso si esauriva, quindi,
in una applicazione esatta delle norme legali. Di conseguenza, la casta sacerdotale,
essendo l’unica interprete autorizzata dalla legge, venne ad assumere un ruolo di
primo piano. Trasse origine così la Midrash, una specie di giurisprudenza intorno ai
precetti della legge, che si attardava in una casistica minuta, irretendo la coscienza in
una folla di schemi e di norme.
Con questa integrazione delle norme legali – rileva il De Ruggiero – la religiosità giudaica viene ravvolta in una solida rete esteriore, che ne frena ogni slancio; il convincimento dell’antico Israele, che il vivere moralmente equivalga
ad osservare le usanze israelitiche, viene respinto; la moralità consiste invece
nella osservanza della legge posta da Dio.2
Da tale stato di fatto ne consegue un oggettivismo formalistico e legale, che si
traduce in una esegesi minuta dei libri della legge e in un continuo sforzo per adeguare
il proprio comportamento a quella casistica intellettuale, soffocando, di conseguenza,
1
2
G. De Ruggiero, La filosofia del cristianesimo, vol. I, Bari, 1941, p. 82.
Ibid, pag. 80.
Filone d’ Alessandria e il giudaismo rabbinico
3
ogni sentimento intimamente religioso e ogni ispirazione spiccatamente individuale.
Questo spiega perché l’ebraismo nel corso del suo sviluppo, pur senza demonizzare la filosofia, non avvertì mai la necessità di ulteriori approfondimenti metafisici. La legge, la Torah e il decalogo, che il popolo era tenuto a conoscere e rispettare
fedelmente in modo da saper distinguere il bene dal male, rappresentano una vera e
propria incarnazione della sapienza di Dio e hanno il potere di rendere felice la vita
di quanti la mettono in pratica.
Diversamente da tutti gli altri popoli dell’antichità, che cominciarono a porsi
l’idea di Dio, partendo dalla natura, la fede del popolo d’Israele nasce e si sviluppa
in seguito al manifestarsi di Dio attraverso uomini da lui prescelti. La storia religiosa
di questo popolo è la storia di un dialogo diretto che si instaura tra Jahvé e il suo
popolo che concepisce il peccato o il male morale quando viene meno al patto con
Dio e, quindi, con un atto di disobbedienza.
Quando, nel 333 a.C., a seguito delle conquiste di Alessandro Magno, la cultura
greca si diffuse in tutto il bacino del Mediterraneo orientale, molti ebrei vivevano già
fuori dalla Palestina e finirono inevitabilmente col subirne l’influenza, soprattutto sul
piano linguistico. Inoltre, il contatto con la civiltà greca suscitò negli ebrei ellenizzati
di Alessandria un forte interesse per la filosofia, considerandola un nuovo strumento
da mettere al servizio della religione, tanto che, a partire da Filone, arrivarono ad affermare che i filosofi greci non furono altro, in realtà, che discepoli di Mosè.
Filone d’Alessandria: il primo incontro tra giudaismo e filosofia
Sulla vita di Filone d’Alessandria non si hanno molte notizie. Nacque, probabilmente, tra il 15 e il 10 a. C. e discendeva da una delle famiglie più influenti di
Alessandria. Grande studioso di Filosofia e giurisprudenza, la sua preparazione culturale risente dell’influenza giudaica (studio della Scrittura) e di quella ellenistica,
tanto che egli fu considerato il principale rappresentante del tentativo di conciliazione tra cultura greca e teologia giudaica.
Filone – scrive la Pepi – è il rappresentante del giudaismo della diaspora e in
particolare del giudaismo alessandrino. Il giudaismo alessandrino è di particolare importanza, perché costituisce il primo incontro tra pensiero ebraico e
pensiero greco. In quell’epoca, come è noto, Alessandria è uno dei centri più
fiorenti della cultura greca. Gli ebrei colti di Alessandria acquisiscono la cultura greca, ma rimangono fedeli alla loro religione e cercano di dare a questa una
forma, un’espressione greca.3
L. Pepi, Filone Alessandrino in D. Di Cesare - M. Morselli (a cura di), Torah e filosofia,
Firenze 1993, p. 47.
3
4
Manuela Girgenti
Gli ebrei ellenizzati, in sintesi, vedono nella sapienza dei greci una conferma
della verità della loro legge e pensano che i greci abbiano potuto sviluppare la loro
sapienza solamente attraverso un contatto diretto con i profeti. Filone coglie, in particolare, nel pensiero di Platone il grande valore della critica alla religione mitica e
al suo antropomorfismo: «chi crede che Dio abbia qualità – sostiene il filosofo alessandrino – fa ingiuria a se stesso, non a Dio».4
Con questa premessa, Filone non può con la sua critica al mito non coinvolgere la Bibbia, nella quale spesso si riscontrano linguaggi narrativi ed episodi
che ricordano da vicino la mitologia dei greci. Ora, poiché l’autorità della Bibbia è
indiscutibile, in quanto libro divino ispirato direttamente da Dio, Filone è del parere
che l’esegesi letterale del testo sacro è destinata alla gente comune, mentre quella allegorica, rivolta a recepire sensi diversi da quelli letterali e di conseguenza destinata
a pochi individui colti, è superiore in quanto coglie il significato più profondo della
parola rivelata e permette, nel contempo, di superare molte delle incongruenze e
delle ingenuità del testo sacro.5 In tal senso, la descrizione del paradiso terrestre e del
peccato originale, secondo Filone, non vanno intese letteralmente, come se vi fosse
stato realmente un albero, un serpente, un frutto etc., ma piuttosto come allegoria di
una realtà psicologica e spirituale: quella dell’uomo diviso tra la tendenza al male e
il richiamo divino. Ed ancora. L’attraversamento del deserto, percorso dagli ebrei in
fuga dall’Egitto, si presta, attraverso la rielaborazione filoniana, a diversi livelli di
lettura e di interpretazione allegorica. In un succedersi di sofferenze e interventi divini, il deserto si trasforma in un percorso educativo, un itinerario, attraverso il quale
gli ebrei cercheranno la propria strada verso l’alto. Le privazioni fisiche sono per Filone il riflesso esteriore di una mancanza (la conoscenza di Dio) e allo stesso tempo
sono prove per il superamento di questa incompletezza interiore. L’itinerario a Dio,
quindi, si apre attraverso insidie che rendono gli uomini «prostrati nel corpo e battuti
nello spirito e li sottopongono a delle padrone dure e crudeli: la fame e la sete».6
Attraverso i prodigi di una storia del passato - l’Esodo - Filone offre dunque
riflessioni che annullano il tempo: il filosofo alessandrino si rivolge a tutti gli uomini per dire loro che sempre è possibile intraprendere un’ascesa etica e conoscitiva,
nonostante le difficoltà. Il deserto, quindi, è quell’elemento che unisce il passato
dell’Esodo al pensiero e al tempo di Filone, per il quale l’uomo saggio deve conti-
4
Filone Alessandrino, Legum allegoriae, I, 49. I testi di Filone sono citati secondo le abbreviazioni in uso. Si veda a proposito la tabella pubblicata in G. Reale - R. Radice, Introduzione a La
filosofia mosaica, Milano 1987. Di questi testi sono qui utilizzate le seguenti edizioni: Philonis Alexandrini opera quae supersunt, VII vol., ediderunt L. Cohn, P. Wendland, S. Reiter, Berlin 1896-1930; Les
oeuvres de Philon d’Alexandrie, publiées sous le patronage de l’Université de Lyon par R. Arnaldez, C.
Mondésert, J. Pouilloux, Paris 1961.
5
Id., De vita contemplativa, 78 e Leg. All., II, 14.
6
Id., De vita Mosis, I, 191.
Filone d’ Alessandria e il giudaismo rabbinico
5
nuamente ricercare la libertà e, in libertà, la contemplazione di Dio. Tutta la filosofia
di Filone – rileva opportunamente il Reale – è in ultima analisi un itinerario a Dio e
la stessa interpretazione allegorica di molti personaggi e vicende narrati nella Bibbia
è appunto una storia, di cui quei personaggi e quelle vicende sono simboli, delle
tappe percorse dall’anima nel suo itinerario verso Dio.7
Filone – aggiunge a tal proposito la Pepi – usa l’allegoria per universalizzare il
messaggio biblico. Così vuole mostrare che la Torah ha un valore universale.
La Torah non è legge giudaica, ma è legge universale; il suo contenuto è allegorico, la storia di Israele non è altro che la storia di ogni anima che cerca Dio
[…] In un certo senso è proprio la lettura allegorica che consente di introdurre
la filosofia nella Bibbia. Grazie all’uso della filosofia greca per interpretare il
testo biblico, Filone getta le basi per una profonda sintesi che è stata definita
“filosofia mosaica”.8
Ma quale funzione può avere la filosofia nella conoscenza delle verità religiose? In che rapporto si trova la filosofia con la rivelazione? È opinione comune che il
problema dei rapporti tra fede e religione sia sorto col cristianesimo, ma, ancor prima
dei Padri della Chiesa e della Scolastica, il primo ad occuparsene, pur non con uno
studio sistematico, è stato proprio Filone. Secondo il filosofo alessandrino, la ragione
umana da sola non è in grado di condurre l’uomo ad una vera conoscenza di Dio. Ma
Dio, in realtà, non ha voluto restare ignoto all’uomo ed è per questo che è disceso al
livello dell’uomo, concedendogli il dono della sua rivelazione.9 È quindi attraverso
il dono della fede che l’uomo può acquisire una conoscenza vera e completa di Dio.
Stando così le cose – lo ripetiamo – che funzione può avere la filosofia nella conoscenza di Dio? Può essere d’aiuto o può mettersi da parte? Filone, sostenendo una
teoria che, come abbiamo già detto, sarà fondamentale per i Padri della Chiesa e per la
Scolastica, è del parere che la filosofia, esplica “una subordinazione ancillare” rispetto
alla rivelazione, in quanto cerca di rischiarare le verità da quest’ultima manifestate.10
Lo scopo di Filone nel cogliere i limiti della filosofia, giacché ci sono delle
domande alle quali l’uomo non potrà mai dare una risposta razionale, quali, ad esempio, sul senso della sua vita o su Dio, non è quello di negare l’esistenza della verità,
come avevano fatto gli scettici, ma solo di far comprendere che l’uomo con i suoi
soli mezzi, con la sola ragione, non potrà mai raggiungerla.
Secondo il Bréhier, la sfiducia di Filone nella filosofia scaturisce da una specie
G. Reale - R. Radice, La genesi e la natura della filosofia mosaica, in Filone: commentario
allegorico alla Bibbia, Milano 1994, p. CXLVII.
8
L. Pepi, Filone Alessandrino, cit., pp.48-49.
9
H. H. Wolfson, Philo, Harvard 1948, vol. I, pp. 138-155.
10
Filone, De congressu eruditionis grazia, 79.
7
6
Manuela Girgenti
di resistenza da quest’ultima mostrata
all’ideale mistico della conoscenza di Dio, resistenza ch’egli ha condannato
nella sofistica. Non si può arrivare alla virtù mediante l’educazione intellettuale che sorpassando continuamente l’insegnamento acquisito. In se stesso e
da solo esso è più nocivo che utile. Filone sembra mettere continuamente in
dubbio gli effetti dell’educazione ellenica, questa cultura dell’intelligenza per
se stessa, senza risultati pratici, quest’esercizio del talento che non migliora
affatto l’uomo. Per quanto grande sia il posto che Filone dà a tutta la cultura
greca, egli riconosce che il minimo sforzo morale vale di più di tutte le scienze.
Esse non sono che inutili ornamenti e vana ostentazione.11
La verità, dunque, viene fatta conoscere all’uomo solamente dalla rivelazione,
la quale, secondo Filone, «è una specie di divinazione: è la divinazione intuitiva, non
imparata con lo studio, la quale si oppone alla divinazione tecnica e artificiale; in
essa lo spirito divino si sostituisce allo spirito umano».12
In questo passaggio non si può non cogliere nel pensiero di Filone un ben
preciso influsso platonico, considerato che per il filosofo greco «i più grandi doni ci
provengono proprio da quello stato di delirio, datoci per dono divino».13 Ma ancora
più esplicitamente nello Ione aggiunge:
tutti i bravi poeti epici non per capacità artistica, ma in quanto ispirati e posseduti compongono tutti questi bei poemi […] poiché il poeta è un essere etereo,
alato e sacro e non è capace di comporre prima di essere ispirato e fuori di
sé e prima che non vi sia più in lui il senno. Finché lo possiede, ogni uomo
è incapace di poetare e di vaticinare […] per questi motivi il dio, facendoli
uscire di senno, si servì di questi vati e dei profeti divini come ministri, perché
noi ascoltatori potessimo comprendere che non sono costoro nei quali non c’è
senno coloro che compongono versi tanto pregevoli, ma è proprio il dio che
parla e per mezzo di questi poeti ci fa sentire la sua voce […] non abbiamo
dubbi sul fatto che queste belle poesie non siano opere umane, né di semplici
uomini, ma divine e di dei e che i poeti nient’altro siano che interpreti degli
dei, quando sono invasati.14
Il tema della rivelazione viene ancora affrontato da Platone nel Fedone, quando i personaggi del dialogo affrontano il problema dell’immortalità dell’anima.
E. Bréhier, Les idées philosophiques et religieuses de Philon d’Alexandrie, Paris 1925, pp.
294-295 in B. Mondin, Il problema dei rapporti tra fede e ragione in Platone e in Filone Alessandrino
in «Le parole e le idee», Napoli 1967, p. 16.
12
Ibid, pag. 80.
13
Platone, Fedro, 244a. Traduzione italiana di P. Pucci, Bari-Roma 2004.
14
Platone, Ione, 533e, 534b, d, e. Traduzione italiana di G. Giardini, Roma 2005.
11
Filone d’ Alessandria e il giudaismo rabbinico
7
Su argomenti del genere – afferma Simmia, uno dei personaggi principali del
dialogo – non è possibile se non fare una di queste cose: o apprendere da altri
quale sia la verità; oppure scoprirla da se medesimi; ovvero, se ciò è possibile,
accettare, fra i ragionamenti umani, quello migliore e meno facile da confutare,
e su quello, come su una zattera, affrontare il rischio della traversata del mare
della vita: a meno che non si possa fare il viaggio in modo più sicuro e con
minor rischio su più solida nave, cioè affidandosi ad una rivelazione divina.15
Se dunque – e la domanda è legittima – dal piano della ragione non si può risalire a quello della fede e che, per effettuare l’ascesa è necessario mettere in disparte,
non solo i sensi e la fantasia, ma anche la ragione,16 in che modo la ragione, la filosofia
può essere d’aiuto alla rivelazione? Per Filone, la risposta è semplice: essa può essere
utile esercitando un’azione indiretta, nel senso, cioè, di fare apprezzare la rivelazione,
facendola comprendere, poiché se uno la comprende non può non apprezzarla.
In poche parole, Filone ha mostrato in concreto nelle sue opere in cosa deve
consistere la funzione ancillare della filosofia rispetto alla rivelazione: «essa non
consiste tanto nel rendere razionale il dato rilevato, poiché il mistero rimane sempre
mistero, indipendentemente dalla forma concettuale con cui viene rivestito, quanto
nell’esprimerlo mediante le categorie mentali proprie di una data cultura».17
È evidente che l’opera di Filone non è altro che il tentativo di far vedere che
i singoli testi biblici si potevano tradurre in espressioni della cultura ellenica e, contemporaneamente, di preparare il materiale per la costruzione di un sistema teologico, basato sulle categorie della filosofia greca.
Ma è nel concetto di creazione che meglio si evidenzia la sintesi operata da
Filone, tra cultura greca e teologia giudaica. Nel De opificio mundi la teoria della
creazione si ispira alla Genesi e, pur andando molto al di là del puro platonismo, al
Timeo di Platone. Quest’ultimo aveva pensato ad una generazione del mondo delle
idee ad opera di un demiurgo, Filone, invece, pensa che esista un Dio supremo e che
tra lui e il mondo stia il Logos, cioè il complesso delle idee che ordinano l’universo.
Dio, quindi, è presentato da Filone come
autore di una doppia creazione: del mondo intellegibile e del mondo sensibile.
Infatti, volendo creare il mondo sensibile, crea prima il mondo intellegibile,
modello incorporeo, cui ispirarsi. Così il concetto di creazione, tratto dalla Genesi, e la produzione demiurgica, tratto dal Timeo, vengono armoniosamente
sintetizzati nella teoria della doppia creazione.18
Platone, Fedone, 85c, d. Traduzione italiana di G. Reale, Brescia 2001.
Filone, Quis rerum divinarum heres, 69-76.
17
B. Mondin, Il problema dei rapporti tra fede e ragione in Platone e in Filone Alessandrino in
Le parole e le idee, Napoli 1967, p.14.
18
L. Pepi, Filone Alessandrino, cit., p. 49.
15
16
8
Manuela Girgenti
Superfluo sottolineare che la dottrina filoniana del Logos, come intermediario
tra la divinità e il mondo, eserciterà un notevole influsso sulla dogmatica cristiana
e, in particolare, sulla teoria cristiana della Trinità. In quanto è un’essenza mediatrice, ha in sé del divino e dell’umano e, conseguentemente, anche l’uomo, in quanto
possiede l’intelletto che non è altro che un elemento divino, esercita per Filone una
funzione mediatrice tra il mondo sensibile e il mondo intellegibile. Non a caso lo
chiama spesso “l’Adamo celeste”.19 Il Logos, dunque, è creato da Dio e per suo mezzo la divinità ha creato il mondo e per suo mezzo, ancora, agisce nel mondo. Esso e,
da un lato, ragione immanente e, dall’altro, ragione espressa.
È in questo modo che «tra Dio e il singolo individuo, si instaura un rapporto
sconosciuto al pensiero precedente»;20 ed è proprio attraverso questo passaggio che
sarà facile per i cristiani chiamare con il nome filoniano di Logos il mediatore per
eccellenza, cioè il Cristo. In questa dottrina filoniana, infatti, il Logos è Dio e insieme uomo, ma non Dio che si fa uomo. Prelude, ma non assume la concretezza di
una vera incarnazione. «Troppo aderente alle sue fonti elleniche, esso è – come il
demiurgo di Platone – la personificazione simbolica della realtà intelligibile».21
È attraverso la coscienza di questo processo che l’uomo, secondo Filone, può
aspirare alla salvezza. L’uomo non è composto semplicemente, come sosteneva Platone, di anima e corpo ma, maturando una concezione più avanzata, anche di spirito
(pneuma), che proviene da Dio. L’anima, dunque, contrariamente a quanto sosteneva
Platone, sarebbe di per sé mortale se Dio non vi soffiasse il suo spirito, ma, in realtà,
per renderla immortale il semplice soffio di Dio non è sufficiente. Essa può diventarlo solamente e nella misura in cui sa vivere secondo lo spirito.
«L’immortalità, dunque, non è un dato ontologico, come, per esempio, sosteneva Platone, ma è un premio e una grazia concessi solo a chi li merita. Non tutte le anime sono immortali, ma solo quelle dei sapienti: l’immortalità è conquista personale».22
In questo lungo e difficile cammino verso Dio, l’uomo, da Filone definito
anche “progrediente”, deve predisporsi interiormente ad accogliere la rivelazione
con la fede. La fede, in poche parole, deve assumere essenzialmente il significato
d’assoluta fiducia in Dio, «una fiducia che implica che Dio è la causa unica, davanti
alla quale gli avvenimenti esteriori non sono nulla».23 Ma migrare dal mondo non è
ancora sufficiente. L’uomo deve anche migrare da sé e dal proprio intelletto e riconsegnarsi totalmente a Dio, riconoscendo la propria nullità.24
Per Filone infatti
Filone, De opificio mundi, 138.
L. Pepi, Filone Alessandrino, cit., p. 49.
21
G. De Ruggiero, La filosofia greca, vol. II, Bari 1950, p. 248.
22
L. Pepi, Filone Alessandrino, cit., p. 49.
23
E. Bréhier, Les idées philosophiques et religieuses de Philon d’Alexandrie, cit., pp. 221-222.
24
Filone, Leg. All., III, 195-198.
19
20
Filone d’ Alessandria e il giudaismo rabbinico
9
la condizione necessaria per incontrare Dio è che l’uomo riconosca il proprio
nulla […] Nello sviluppare il tema dell’oudéneia dell’uomo, Filone è vicinissimo al pensiero biblico. La certezza della nullità dell’uomo e dell’onnipotenza
divina è fondamentale nella Scrittura. Si può a questo riguardo citare Isaia
(40,6-8): ogni mortale è come l’erba, tutta sua gloria come i fiori di campo,
l’erba si secca, il fiore appassisce, ma la parola del nostro dura per sempre.25
L’ascesi, però, non è il momento più alto della purificazione. L’obiettivo finale
è la contemplazione del divino. In una parola: l’estasi. «Per virtù di essa, il saggio
è profeta: egli non trae nulla dal suo fondo, ma in lui abita lo spirito divino, ed egli
vibra senza suo volere, come le corde di uno strumento».26
Lo stesso Filone descrive i suoi momenti di estasi, quando, ponendosi al lavoro senza idee, all’improvviso “si sentiva riempito” e i pensieri venivano invisibilmente giù dall’alto e cadevano come la neve e la semenza. Come invasato da un Dio, egli
dimenticava il luogo dov’era, le persone presenti e se stesso e ciò che aveva detto e
scritto. Con l’estasi, così, in una vera e propria unione mistica con Dio, l’uomo transumanato si annega nell’infinito da cui si origina.27 In questo modo Filone anticipa
quell’itinerario a Dio, che, successivamente, da Agostino in poi, diverrà canonico.
Il giudaismo rabbinico dal II al XII secolo
Il pensiero di Filone, troppo legato all’ellenismo, non ebbe largo seguito tra
gli ebrei di lingua diversa dalla greca e, fra l’altro, va anche rilevato che la nascita
ad Alessandria della scuola neoplatonica contribuì ad oscurarne la gloria, giacché la
scuola di Filone, pur tentando di unificare il giudaismo con lo spirito animatore del
pensiero ellenico, nella realtà pretendeva di asservire la mentalità ellenica al giudaismo.28 Ciononostante, dopo la scomparsa del giudaismo alessandrino, la filosofia
ricomparirà proprio in seno al giudaismo rabbinico che, sviluppatosi sostanzialmente in oriente tra Palestina e Babilonia, dal 70 dell’era volgare al 1040 sarà il punto di
riferimento di tutte le pratiche e credenze ebraiche.
Inizialmente gli ebrei babilonesi furono influenzati da quelli palestinesi,
mentre dopo il 135 e.v., quando numerosi ebrei fuggirono dalla Palestina verso la
Mesopotamia, dove esistevano condizioni politiche e sociali migliori, riuscirono ad
imporre la loro supremazia nel campo della letteratura rabbinica, tanto che le accademie di studio babilonesi, dal VI al X secolo, rappresentarono il centro culturale
L. Pepi, Filone Alessandrino, cit., p. 51.
G. De Ruggiero, La filosofia greca, cit., p. 252.
27
Filone, De specialibus legibus, III, 1-2.
28
G. De Ruggiero, La filosofia greca, cit., p. 253.
25
26
10
Manuela Girgenti
dell’ebraismo orientale ed occidentale.29 Le accademie babilonesi di Sura e Pumbedita, infatti, continuarono le tradizioni talmudiche sotto l’autorità dei Geonim (plurale di Gaon,”Eccellenza”), guadagnandosi fama e autorità tali da accogliere richieste
di pareri su questioni giuridiche e teologiche, che venivano loro indirizzate dalle
comunità sia d’Oriente che d’Occidente.
In questo periodo il pensiero giudaico si sviluppa nella sua pienezza, ma nel
senso del proprio retaggio e al riparo delle barriere elevate contro l’ambiente
circostante, soprattutto contro il pensiero greco. E questo nonostante che l’influsso ellenistico fosse stato rilevante e che i problemi teologici non venissero
elusi; ma le risposte date a questi problemi si ponevano su un piano prettamente religioso e solo di rado sul piano razionale, se si dà al termine “ ragione” il
significato attribuitogli dai filosofi.30
Non a caso, infatti, alcuni studiosi definiscono l’ebraismo rabbinico come la
religione della “duplice Torah”, perché, oltre a una Torah scritta (le Scritture ebraiche) riconosce una “Torah orale” o tradizione, attraverso cui quella scritta viene
interpretata e completata.31
Per comprendere meglio tale sviluppo bisogna calarsi nel clima che si venne a
determinare dopo la seconda rivolta giudaica, che culminò nel 135 con la distruzione di Gerusalemme da parte dei romani. L’odio accumulato da questi ultimi contro
gli ebrei fu tale, che alcuni storici non hanno esitato a parlare di una vera e propria
guerra di sterminio, nel corso della quale l’unica logica condivisa era quella di annientare, sterminare e sradicare i ribelli.
«Agli ebrei, che alla fine della sommossa contarono ben 585.000 vittime, fu
persino proibito di mettere piede a Gerusalemme o di guardare con nostalgia da lontano le sue rovine».32
Il 135 e.v. segnò, dunque, un punto di non ritorno ed è da questa data che ebbe
inizio la vera, grande diaspora del popolo ebraico. I cristiani interpretarono questo
luttuoso evento come il ripudio degli ebrei da parte di Dio e la conferma di essere
nel giusto nel credere in Gesù come Messia e figlio di Dio; gli ebrei, viceversa, lo
interpretarono come una punizione per i loro peccati. A questo punto per gli ebrei
occorreva un’opera di auto definizione. Questo compito fu assunto dai rabbini, i
quali, partendo da una fede assolutamente indiscutibile in Dio, nella sua rivelazione
attraverso la Torah e nella sua “elezione” di Israele, definirono l’ebraismo in termini
G. Stemberger, Il giudaismo classico: cultura e storia del tempo rabbinici (dal 70 al 1040),
Roma 1991.
30
C. Sirat, La filosofia ebraica medievale, Brescia 1990, p. 27.
31
N. Solomon, Ebraismo, Torino 1999, p. 21.
32
R. Calimani, Gesù ebreo, Milano 1998, p. 105.
29
Filone d’ Alessandria e il giudaismo rabbinico
11
di Mitzvot, o comandamenti divini, che spaziavano da “ama il prossimo come te
stesso” e “ama il Signore, tuo Dio”, fino alle minuzie concernenti i rituali religiosi. I
rabbini, in poche parole, continuarono a comportarsi come se il cristianesimo (anche
se da questo fronte l’ebraismo veniva definito una religione obsoleta e, in quanto
nemico di Cristo, disonorevole) non fosse mai esistito o non fosse una minaccia,
proseguendo nella loro opera di esposizione della Torah e di commento delle sue
leggi. Questi commenti costituiscono ancora oggi il nucleo principale della letteratura sacra ebraica, la prima delle quali, terminata intorno al 200 e.v., è rappresentata
dalla Mishnàh. Per i successivi tre secoli questo documento costituì un vero e proprio codice legale, il sistema giudiziario della nazione ebraica nella sua terra e nelle
comunità della diaspora, tanto che nel giro di qualche decennio la Mishnàh fu canonizzata, assumendo pari dignità della Bibbia ebraica. Le discussioni nate attorno alla
Mishnàh, avvenute sia in Palestina sia durante la diaspora babilonese, originarono
altri due testi fondamentali: il Talmud palestinese (inizio del V secolo) e il Talmud
babilonese (VI secolo). Quest’ultimo rappresenta il grande compendio della legge e
della tradizione ebraica ed è considerato il maggior testo di studio delle accademie
rabbiniche tradizionali, tanto che tutti gli ebrei sono invitati a studiarlo.33
Infine, la letteratura rabbinica ha originato le collezioni esegetiche, a cui è
stato dato il nome di Midrash (interpretazioni ). La letteratura midrashica si è sviluppata nel corso di diversi secoli (II-XIII) e si presenta sotto forma di commenti
dei versi biblici, spesso di difficile datazione. Esse si articolano in due registri: la
halakhah e la aggadah. La prima tratta delle disposizioni in senso giuridico,che determinano una condotta di vita ispirata alla Torah e alle sue applicazioni, così come
esse vengono stabilite dalla tradizione; la seconda è la trasmissione delle riflessioni
degli esegeti sulla Scrittura, i quali cercano di cogliere in essa un senso travalicante
il primo significato letterale del testo. Il Midrash, dunque, deve essere considerato
come l’interpretazione biblica ufficiale del popolo ebraico, la cui esegesi resta perpetuamente connessa al presupposto che ogni passo biblico sia dotato di una pluralità
di sensi e di spiegazioni che si susseguono. Presuppone, di conseguenza, l’esistenza
di un dialogo permanente tra il testo e la comunità interpretante.34
In base a tale teoria, rileva opportunamente Scholem
lo sforzo di chi cerca la verità non sta nel concepire qualcosa di nuovo, bensì
nell’inserirsi nella continuità della tradizione della parola divina, sviluppando
in relazione alla propria epoca il mandato che da essa gli deriva […] Fino a che
i saggi (gli esegeti) non si rivolgono ad essa con le loro ricerche, la Torah resta
incompiuta, a mezzo. Ma per le loro ricerche essa diventa un libro compiuto.
Infatti, in ogni generazione la Torah viene indagata (interpretata) secondo i
33
34
A. Rosemberg, L’ebraismo: storia, pratica, fede, Milano 1995, p. 101.
G. Stemberger, Il giudaismo classico, cit., p. 159.
12
Manuela Girgenti
bisogni di questa generazione, e Dio dà luce agli occhi di tale generazione,
perché essa possa beneficiare della Torah che le conviene. In altri termini: non
il sistema, ma il commento costituisce la forma legittima in cui può essere
sviluppata la verità. La verità deve essere espressa attraverso lo sviluppo di
un testo, in cui essa già in precedenza stava celata. Il commentario divenne,
così, la tipica forma di espressione del pensiero ebraico della verità, ovvero di
quello che si potrebbe chiamare il genio rabbinico.35
Dal punto di vista ebraico tra rivelazione scritta e rivelazione orale c’è, dunque, un processo di continuità che si è sviluppato attraverso la via dell’interpretazione. Un aspetto, quest’ultimo, su cui Paul Ricoeur invita a riflettere, sottolineando
che «come figli della critica, gli uomini dovrebbero riuscire, mediante la critica, ad
andare al di là di essa, non per avere meno significato, ma per averne di più, in altre
parole, per foggiare un’ermeneutica che ripristini il significato. Il credere è integralmente riferito all’interpretare».36
I rabbini, in poche parole, ripresero il patrimonio letterario della religione
ebraica antica, forgiandolo in un nuovo e inedito significato attualizzante, mediante
la redazione di un corpus di opere oggi conosciute come testi della Torah orale. In
virtù dei valori e dei principi espressi nel nuovo canone della letteratura sacra ebraica
riuscirono ad imporre la propria supremazia nella guida del popolo, poggiando la loro
autorità sul concetto che «quando Dio rivelò la Torah sul Sinai vi comprese le opinioni dei rabbì viventi e dotati di autorità: su questo mito, il mito della Torah, poggia la
totalità del sistema e della struttura del giudaismo nella sua formulazione classica».37
La Torah scritta e orale, dunque, solo se mediata dai rabbini può diventare una vera guida per la vita sia individuale che collettiva e soltanto loro, ancora,
possono fornire un orientamento autentico, ereditando, custodendo, interpretando e
attualizzando l’antico patrimonio rivelato.38 In tal modo la Mishnah, per i suoi tratti
peculiari acquistò il carattere di una vera e propria costituzione ufficiale del popolo
ebraico, caratterizzandosi sempre più, oltre alla sua valenza religiosa, come documento pubblico e politico. La legge scritta nella Mishnah divenne presto, così, uno
strumento di controllo sociale e, di conseguenza, gli uomini che conoscevano la Mishnah, i rabbini per l’appunto, acquisirono in breve il controllo della vita di Israele.
Naturalmente la pretesa di esercitare l’autorità e il diritto di imporre pesanti sanzioni,
in accordo con la Mishnah, non fu universalmente condivisa. I caraiti, infatti, come
vedremo se ne dissociarono, ma al di là della condivisione o meno del fenomeno,
non si può non essere d’accordo sul fatto che il giudaismo rabbinico ebbe il merito di
G. Scholem, Concetti fondamentali dell’ebraismo, Milano 1986, p. 87.
P. Ricoeur, Ermeneutica biblica, Morcelliana, Brescia 1978, p. 12.
37
J. Neusner, I fondamenti del giudaismo, Firenze 1992, p. 23.
38
G. Stemberger, Il giudaismo classico, cit., pp. 154-161.
35
36
Filone d’ Alessandria e il giudaismo rabbinico
13
mantenere viva e unita l’identità ebraica nelle comunità della diaspora.
Per fare accettare la Mishnah all’intero popolo d’Israele i rabbini riplasmarono il significato della parola Torah, attraverso un processo esegetico che collegava
le affermazioni della Mishnah con i versetti della Scrittura. Non a caso, le opere che
vennero redatte dopo la Mishnah fino al 600 e.v. furono tutte intese a spiegare l’origine di questo documento fondativo, collegandolo alla Torah scritta, facendo sorgere
la necessità, all’interno del processo di interpretazione della Mishnah, di raccogliere
e sistematizzare queste esegesi in correlazione alla stessa Mishnah, letta riga per riga
e paragrafo per paragrafo,39 poiché «null’altro significa esegesi se non interpretare il
testo, traendone fuori il significato».40
In realtà è proprio su questo concetto che si regge l’ermeneutica del giudaismo
rabbinico, poiché, secondo la tradizione ebraica, «la parola rappresenta il luogo della
rivelazione, lo spazio in cui abita la divina presenza».41 Ciò che si vuole mettere in
evidenza è che l’ermeneutica del giudaismo rabbinico verte sulla consapevolezza
che le parole umane impiegate a spiegazione della Scrittura non possono esaurire il
contenuto del messaggio divino, se non tramite continue approssimazioni. L’unico
veicolo che il saggio possiede per avvicinarsi il più possibile al significato delle
parole rivelate è la pluralità di sensi. Questo spiega l’accusa, rivolta spesso alla letteratura rabbinica, di essere percorsa da interpretazioni contrastanti; un limite – secondo Perani – che molto probabilmente scaturisce «dalla mancanza di un’autorità
centrale, capace di vigilare sull’uniformità delle credenze religiose, simile al ruolo
svolto nella religione cristiana dalla figura del pontefice e dal fatto che nella storia
del giudaismo non sono mai avvenuti concili ecumenici per fissare il dogma e che,
di conseguenza, non si è mai sviluppata una dogmatica».42 Nel giudaismo rabbinico,
in realtà, ha sempre regnato una grande libertà di opinioni divergenti, a volte anche
contrapposte; una diversità di opinioni che in genere è stata sempre interpretata come
la conseguenza necessaria della ricchezza della parola di Dio, condizione che connota la cultura ebraica come civiltà del commento.
Ed ancora la ricerca del significato “altro”, polisemico, narrativo, lungi dal
costituire un problema particolare per gli esegeti, creando delle combinazioni di significato eterogenee e delle posizioni antitetiche, rafforza l’essenza di una teologia
concepita essenzialmente come racconto e di una ermeneutica ricca di valori etici.
Bisogna, infatti, ricordare che, secondo la religione ebraica, Israele è stato scelto per
rivelare l’amore che Dio porta a tutta l’umanità, ragion per cui l’uomo deve proporsi
di allontanare da sé tutto ciò che contrasta col volere di Dio e, nello stesso tempo, di
J. Neusner, I fondamenti del giudaismo, cit., pp. 127-128.
B. Maggioni, Esegesi biblica in P. Rossano – G. Ravasi – A. Ghirlanda (a cura di), Nuovo
dizionario di Teologia biblica, Ed. Paoline 1988, p. 497.
41
P. Stefani, Lettura ebraica della Bibbia, in Nuovo dizionario di Teologia biblica, cit., p. 816.
42
. M. Perani, Personaggi biblici nell’esegesi ebraica, Firenze 2003, p. 147.
39
40
14
Manuela Girgenti
consacrarsi al suo servizio, resistendo a tutti quegli impulsi che fanno dell’egoismo
l’essenza della natura umana. In poche parole: di obbedire a un’etica incentrata sul
servizio del prossimo. I precetti e le prescrizioni, infatti, presenti copiosamente nei
testi sacri giudaici, non servono solamente a coltivare e sviluppare le più elevate
qualità umane, ma contengono una carica di dinamismo morale, capace di trasformare l’individuo e, per suo tramite, la società di cui egli fa parte.
A fondamento della morale troviamo, inoltre, l’equità e la giustizia, che deve
estrinsecarsi nell’accettazione dei doveri, specialmente nei riguardi del povero, del
debole, del derelitto, amico o nemico che fosse. Un senso della giustizia che deve
anche manifestarsi nella maniera di concepire i beni terreni, poiché il loro possesso
deve considerarsi non come un diritto naturale, ma come un debito con Dio. Sotto
questo aspetto, l’etica nel pensiero giudaico si manifesta, in contrasto con tutti i codici dell’antichità, in tutta la sua originalità, poiché la Torah oppone alla difesa della
proprietà il concetto di “protezione della personalità”. I limiti imposti al potere, da
parte dei libri sacri, dimostrano quanto fortemente fossero sentiti nella spiritualità
ebraica i diritti della persona.
Al padrone è proibito sfruttare gli operai (Levitico:19,13); al creditore è proibito, in ogni caso, offendere la dignità del debitore (Deuteronomio: 24,10-11); persino lo schiavo conserva i suoi diritti di persona (Esodo: 21,26-27). La Torah rifiuta
ogni distinzione tra re e nobile, cittadino e schiavo, indigeno o straniero (ama lo
straniero come te stesso, Levitico: 19,34), essendo tutti uguali di fronte alla legge di
Dio. Nel giudaismo, infatti, le distinzioni tra ebrei e non ebrei sono solo di ordine
religioso, mentre non esistono distinzioni sociali o politiche. La legge è uguale per
tutti, poiché la fedeltà del Signore è commisurata secondo l’amore che l’uomo gli
dimostra con l’adempimento della legge. Alla base di tutta l’etica giudaica – è bene
ribadirlo – sta il concetto della santità individuale, che, oltre al rispetto della legge,
poggia anche sul controllo delle passioni.
Ma il controllo di queste ultime non deve essere confuso con l’ascetismo, poiché gli ideali di un ascetismo fine a se stesso sono estranei allo spirito del giudaismo.
Essenzialmente ottimista, l’ebraismo non vede nel mondo il male e non crede che
la vita sia gravata da una maledizione. La vita, anzi, è bellissima e Dio vuole che
l’uomo gioisca di tutte le cose belle di cui la terra è piena (e Dio vide tutto quello
che aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona, Genesi: 1,31). Né l’ebraismo ha mai
considerato il corpo come cosa impura o gli appetiti umani come radicati nel male
(l’uomo farà lieta la moglie che ha sposato, Deuteronomio: 24,5). Il corpo umano è
il sacro vaso in cui si cela una scintilla divina, l’anima, e come tale bisogna conservarlo in buona salute, in buone condizioni e pulito. Trascurare il corpo e i bisogni
fisici significa offendere Dio e lavarsi ogni giorno è un dovere religioso.
Non solo, ma anche astenersi da quelle cose che non sono condannate dalla
legge è peccato. Una massima del Talmud dice: «l’uomo deve rendere conto nell’aldilà di tutti i piaceri dai quali non si sarà astenuto» (Talmud di Gerusalemme, trat-
Filone d’ Alessandria e il giudaismo rabbinico
15
tato Kiddushin: 4,12). L’autocontrollo anche se estirpa il vizio, non basta. Bisogna,
dunque, coltivare quelle qualità positive che danno all’uomo il senso di ciò che egli
deve fare e non solo di ciò che non deve fare. La prima di queste virtù consiste
nell’accontentarsi, nell’essere in pace con se stessi. La contentezza scaturisce però
da una consapevole fede nel divino ordinamento della vita umana, provvidenziale e
benefico. Ne derivano una calma e una serenità che assumono il colore più intenso
della gioia, la “gioia in Dio”. La fede in Dio comporta anche che l’uomo riconosca
di dipendere da Dio e di essere insufficiente e debole senza di lui. Ciò conduce all’umiltà, che impedisce all’uomo di inorgoglirsi per i valori e le conquiste materiali.
L’amore per Dio conduce, poi, alla santificazione del Nome, che consiste in ogni
atto di abnegazione, di rinuncia, di sacrificio fatto per amore di Dio e degli uomini.
Un metodo di studio e una impostazione esegetica, quella rabbinica, che si
protrarrà sino al secolo VII dell’era volgare e che il Zonta non esiterà a definire come
«la vecchia struttura del giudaismo rabbinico»,43 una struttura che gli appare ormai
concentrata in massima parte sull’interpretazione di una tradizione giuridica tardiva
(quella del Talmud) e sentita, di conseguenza, come priva di un afflato ideologico e
salvifico. Dal secolo di Filone a questo periodo, infatti, come abbiamo già visto, il
pensiero giudaico ha sempre sviluppato la tradizione talmudica, restando sempre ancorato alle proprie tradizioni e opponendo una forte resistenza ad ogni contatto culturale esterno, soprattutto greco. «E questo nonostante che l’influsso ellenistico fosse
stato rilevante e che i problemi teologici non venissero elusi; ma le risposte date a
questi problemi si ponevano su un piano prettamente religioso e solo di rado sul
piano razionale, se si dà al termine “ragione” il significato attribuitogli dai filosofi».44
Ma, a partire dal 634 e.v., il clima culturale ebraico subì un profondo mutamento. Ciò fu dovuto alla progressiva occupazione del vicino e medio Oriente (dalla
Persia all’Egitto) dei musulmani d’Arabia, che crearono un impero sotto l’alta sovranità di un califfo, residente prima a Damasco (661-750) e poi a Bagdad (dopo il 762).
Il passaggio dei centri culturali ebraici più rilevanti sotto il dominio islamico
– rileva Zonta – ebbe conseguenze di non poco peso per la storia, anche religiosa, del giudaismo: ebbe, infatti, inizio in questo periodo quella simbiosi tra
cultura araba e cultura ebraica che caratterizzò tutta la filosofia ebraica medievale, facendo sì che ogni fenomeno culturale verificatosi nel mondo islamico
producesse analoghi fenomeni, non solo di imitazione ma anche di emulazione, nel mondo ebraico vicino - orientale e mediterraneo.45
Inizialmente le autorità arabe furono molto tolleranti nei confronti delle reli-
M. Zonta, La filosofia ebraica medievale, Roma-Bari 2002, p. 11.
C. Sirat, La filosofia ebraica, cit., p. 27.
45
M. Zonta, La filosofia ebraica, cit., p. 10.
43
44
16
Manuela Girgenti
gioni ufficiali dei territori da loro occupati e, in particolare, della religione giudaica.
Ma successivamente, vuoi per la propaganda religiosa islamica, vuoi per le pressioni
del potere politico, si registrò in quel periodo una notevole massa di conversioni
all’Islam nei territori occupati. Tale stato di cose provocò, come è naturale, una dura
reazione sia da parte dei cristiani, che cercarono di avviare una sistematizzazione
razionale della complessa dogmatica cristiana, mediante l’uso di una metodologia
filosofica ispirata innanzitutto al pensiero aristotelico, sia da parte degli ebrei ortodossi che ricevettero nuovi impulsi per un ritorno ad uno studio esegetico della
Bibbia, non solo come fonte giuridica, ma come fonte per una interpretazione del
mondo fisico e metafisico. Tale clima spinse gli arabi a dotarsi di una propria teologia, solidamente edificata sulle basi proposte dalla filosofia greca, dando vita così
alla letteratura del Kalam. Si trattò di una vera e propria fibrillazione culturale, che
scaturiva dalla necessità di spiegare e giustificare l’Islam di fronte alle altre religioni
e di far prevalere una concezione “razionale” dell’Islam di fronte alle altre religioni.
Il Kalam (che in arabo letteralmente vuol dire “discorso”) ebbe inizio intorno
alla metà del secolo VIII e rappresentò una apologia dei punti caratterizzanti della
religione islamica, condotta per lo più mediante un metodo razionale, logico-dimostrativo, sfruttando argomentazioni ispirate indirettamente al pensiero antico.
Non si tratta – precisa Zonta – precisamente di una forma di filosofia: infatti,
i metodi filosofici impiegati dal Kalam non sono finalizzati al puro raggiungimento della conoscenza di per sé. Bensì sono strumenti per difendere postulati
già dati per veri a priori, perché desunti dalla rivelazione; le parti di interesse
propriamente filosofico dei testi dei teologi del Kalam sono dunque relativamente circoscritti.46
Delle sette del Kalam, la scuola mu’tazilita fu la più importante e il concetto
di ragione, elaborato in questa scuola, si ritroverà negli autori ebrei, tanto rabbaniti
quanto caraiti. Ma va subito chiarito che il concetto di ragione dei mu’taziliti non è
quello a cui ci hanno abituato i filosofi greci, per i quali la ragione è ciò che permette
di distinguere il vero dal falso, ma si deve intendere come legge morale che ci fa dire
che una cosa è buona o cattiva, che ci rende riconoscenti verso chi ci fa del bene e
ci induce a ricondurre il malvagio sulla retta via. «Questa legge morale è universale e trascende le razze e le religioni: ogni uomo normale ne riconosce in se stesso
l’esistenza e, dal momento che la stessa legge si applica anche a Dio, noi possiamo
stabilire con certezza l’esistenza di un Dio buono, del quale possiamo fidarci».47
Il Kalam mutazilita appare imperniato su cinque principi fondamentali: unità
e giustizia di Dio, verità delle promesse e delle minacce di Dio per quanto concerne
46
47
Ibid, pp. 12-13.
C. Sirat, La filosofia ebraica, cit., p. 38.
Filone d’ Alessandria e il giudaismo rabbinico
17
la vita futura, la condizione dell’uomo reo di peccato capitale, promozione del bene e
impedimento del male. Questi a loro volta vengono divisi in razionali e tradizionali:
i primi spiegabili alla luce della ragione umana, i secondi vanno, invece, accettati per
rivelazione. Ma è ai primi due principi che i mutaziliti annettevano una grande importanza, tanto da definirsi “sostenitori della giustizia e proclamatori dell’unità divina”.48
Il Kalam mutazilita, pur essendo una teologia islamica, subisce l’influsso del
deismo razionalista aristotelico poiché, anche per loro, Dio pur se vincolato dalle
leggi di necessità che regolano l’universo, è la causa prima e il primo motore. Se ne
distacca, però, per le sue posizioni nettamente atomistiche in fisica, poiché, secondo
i mutaziliti, «i corpi si compongono di una mescolanza di atomi di sostanza, che ne
costituiscono l’essenza fondamentale, e di atomi di accidenti, che conferiscono loro
diverse qualità (si hanno, per esempio, atomi di calore, di umidità etc.)».49
In ogni caso, pur con le dovute differenziazioni, il Kalam nella storia delle
idee viene indicato come l’anello di collegamento fra l’antichità classica, l’islamismo e la filosofia successiva.
Contemporaneamente, e in reazione al Kalam islamico, si andò formando gradatamente un Kalam ebraico, i cui testi teologici, scritti per la maggior parte in lingua araba, erano finalizzati ovviamente non alla difesa dell’Islam, ma del giudaismo.
Naturalmente – rileva opportunamente Zonta – i teologi ebrei dovettero inserire
nello schema dei cinque principi mutaziliti le dottrine, tipicamente ebraiche,
della centralità del ruolo della Legge, della funzione privilegiata ed esclusiva attribuita, nella loro teologia, al popolo eletto, della redenzione finale di Israele ad
opera del Messia; essi dovettero così compiere un’operazione più complessa di
quella svolta dai teologi islamici, i quali non si trovavano di fronte una religione
già irrigidita in una complessa codificazione giuridica come il giudaismo.50
Se, dunque, il giudaismo rabbinico non aveva mai espresso una posizione
teologica sistematica e non si era mai posto veramente la domanda sul perché della
creazione, considerata, tutt’al più, l’indispensabile presupposto alla rivelazione, il
Kalam ebraico rappresentò un grande sforzo interpretativo per conferire alle proprie
credenze religiose un’accresciuta legittimità davanti al tribunale delle idee: In sintesi, il Kalam ebraico si sforzò di dare un quadro razionale alle proprie convinzioni
religiose, senza rimettere in discussione la loro essenza profonda. Del Kalam ebraico
Saadiah Gaon (882-942) fu la figura più rappresentativa. Fu lui a dare dell’ebraismo
una presentazione logica e sistematica.
Il suo classico filosofico il Libro delle credenze e delle opinioni contribuì a
Ibid., p. 31.
M. Zonta, La filosofia ebraica, cit., p. 13.
50
Ibid., p. 14.
48
49
18
Manuela Girgenti
introdurre la teologia speculativa dei musulmani in seno all’ebraismo. Buon conoscitore di falasita (filosofia aristotelica) e di Kalam (teologia islamica), credeva nella
supremazia della ragione, che comprende in sé il senso morale e, in base a tale convincimento, rivolge a Dio un profondo e sentito ringraziamento per avere creato gli
esseri umani forniti di ragione.
Antonio Bica
I vangeli Gnostici e il Cristianesimo delle origini
La scoperta dei manoscritti gnostici a Nag Hammadi, Alto Egitto, nel 1945,
insieme al rinvenimento del Vangelo di Giuda nel deserto egiziano verso la fine degli
anni ’70, costituisce un evento storico senza precedenti. Dai testi, emerge il pensiero
della corrente gnostica del Cristianesimo primitivo che vide il suo sviluppo dal I
al IV secolo e che fu tenuto nascosto dalla Chiesa dei seguaci di Gesù, sepolto dal
prevalere della corrente ortodossa allora al potere. Dagli insegnamenti segreti degli
gnostici, vengono a galla verità alternative sul Cristianesimo delle origini. Gli albori
del Cristianesimo ci appaiono illuminati da una luce nuova che per troppo tempo è
rimasta offuscata, sepolta dal peso dell’autorità delle prime gerarchie ecclesiastiche.
Mi piace, per iniziare a parlare della questione gnostica, ricordare un antefatto che
mi indusse a riflettere sui concetti di religione e di indottrinamento e sul pericolo che
quest’ultimo poteva rappresentare.
Era tutto il pomeriggio che pioveva a dirotto nonostante fosse già primavera
inoltrata quando, messa da parte una vecchia copia dell’Apocalisse di Giovanni che
tenevo fra le mani, mi alzai dal letto e andai a telefonare ai miei figli per sentire come
stavano. Mi rispose Fabio, il maggiore; gli domandai di suo fratello, che da poco aveva
subito un intervento chirurgico alla mano, mi rispose con tono sicuro: «Silvio sta benone, lo sai papà, lui riesce sempre a cavarsela in ogni situazione!». Quando ci salutammo
e riagganciai il telefono ero tranquillo in apparenza, ma l’eco di quell’ultima frase buttata lì da mio figlio Fabio a proposito del fratello, condusse un filo della mia memoria e
la pipa che stringevo fra le dita verso un episodio accaduto molti anni prima.
Silvio era piccolo e andava all’asilo dalle suore dell’Immacolata. Dopo avere
attraversato la strada all’improvviso, finì sotto una macchina e non si sa come ne
uscì illeso. Un paio di suorine accorse ad abbracciare il redivivo al grido di “Dio
l’ha salvato!”; una di loro disse: «sia lodato Gesù Cristo!». Le due affermazioni mi
crearono un certo imbarazzo, ma avvertivo anche la necessità di dovere rispondere
qualcosa. Fu così che dissi, senza quasi pensarci su: «Grazie, anche a lei!». Mi resi
conto subito di non aver dato la risposta esatta. Sondando nella memoria dei lontani
tempi del catechismo, ricordai che quando ti dicono “sia lodato Gesù Cristo”, tu
devi rispondere con “sempre sia lodato” o ancora meglio “oggi e sempre sia lodato”.
20
Antonio Bica
Quella mia assurda frase di rimando, quel “grazie, anche a lei!”, era fuori luogo, fin
troppo inappropriato. Nel frattempo, l’altra suorina si mise a recitare una sorta di
giaculatoria infinita, muovendo impercettibilmente le labbra. Il mio disagio si fece
ancora più grande. Mi venne spontaneo chiedermi perché le suorine parlassero a quel
modo, e se fossero consapevoli del significato di tante altre parole pronunciate forse
più per abitudine che per convinzione. Anche a me erano state insegnate quelle frasi
da piccolo, ma senza cognizione, senza i supporti per un minimo di analisi critica.
Di una cosa ero certo: le suorine, anche quando nella normalità del quotidiano
si scambiavano quelle frasi fatte, non avevano alcun senso critico, come non l’aveva
la suora che quasi otto lustri prima m’impartiva le lezioni di catechismo perché fossi
pronto il giorno della mia prima comunione. E se quelle suorine fossero nate sessanta o settanta chilometri più a sud della mia Sicilia e fossero cresciute sotto un altro
cielo e con altri profumi, cosa si sarebbero dette adesso parlando fra loro?
E come si sarebbero rivolte ora a me? Forse con qualcosa del tipo Alhamdulillah, Subhanahuwatala, che in arabo suona pressappoco “sia lodato Dio, gloria a Lui
l’Altissimo”. E ancora, se fossi nato anch’io in un paese del Magreb, come si sarebbe
svolto il mio catechismo, e quale sarebbe stata la mia educazione? Io mi ricordo che
andavo al catechismo tre volte la settimana. Dell’insegnante, una suorona di quasi
due metri con due spalle da lottatore, ricordo la sua paura del socialismo, parola che
io, a quel tempo, sconoscevo totalmente.
Mi diceva che i socialisti sono come il diavolo sulla terra, ancor più che i comunisti, poi si faceva il segno della croce, ed io non capivo, e più ci pensavo più non
capivo. La prima cosa con cui mi sono dovuto misurare è stata la necessità di imparare a disimparare; lentamente, piano piano, giorno dopo giorno ho dovuto ripulirmi
e ricominciare daccapo, cancellare tutto ciò che mi avevano obbligato ad imparare a
memoria sin da bambino.
Quando diventai più grande, appresi come, nel cristianesimo delle origini, le
sette cristiane erano molteplici, ciascuna aveva una sua idea di Gesù e ribadiva che
la propria fosse quella giusta, quella veramente ispirata; non esisteva una struttura
normativa unitaria come più o meno siamo abituati a vedere oggi, era come dire che
coesistevano tanti cristianesimi differenti fra loro.
Imparai anche, e questo non fu che l’inizio soltanto, che i Vangeli non erano
solo quattro, ma ne circolavano diversi a quel tempo; accanto ai quattro Vangeli che
verranno in seguito considerati canonici, ve ne erano altri, utilizzati in seno alle varie
sette e ai vari gruppi, più o meno adattati a secondo delle proprie tradizioni storiche,
politiche, culturali.
Ma procediamo per ordine.
Verso la fine degli anni settanta del secolo appena trascorso, nel Medio Egitto,
nei pressi della località di El Minya, in un villaggio sulla sponda destra del Nilo,
uno scavatore di tombe porta casualmente alla luce un documento incredibile che
si riteneva perduto dalla notte dei tempi. Si tratta di un testo trascritto in un dialetto
I vangeli gnostici e il cristianesimo delle origini
21
della lingua copta, il sahidico, anche se in origine fu probabilmente redatto in lingua
greca. Il copto, che fu poi soppiantato dall’arabo, altro non è che la lingua egiziana
nel suo stadio finale, ed era soprattutto utilizzato come lingua rituale.
È interessante ricordare come la lingua copta, nella sua forma scritta, utilizzava
i caratteri dell’alfabeto greco. La data di composizione del testo dovrebbe risalire alla
metà del II secolo; ad ipotizzare una tale datazione si giunge in seguito ad un’affermazione di Ireneo, vescovo di Lione, che parla dell’esistenza di un Vangelo di Giuda
nel suo trattato Contro le Eresie, composto in lingua greca attorno al 180 e di cui ci
è pervenuta una traduzione latina del IV secolo. Il quadro generale che questi testi ci
propongono, ribalta la visione cristiana contemporanea, gettando una nuova luce sul
cristianesimo primitivo o forse è meglio dire sui vari cristianesimi delle origini.
Ciò apre la via a nuove soluzioni di lettura di un periodo storico affascinante
per la ricchezza dei suoi contenuti, e ci fa prendere in considerazione aspetti alternativi del messaggio di Gesù.
Uno dei movimenti più conosciuti a quel tempo era il movimento Zelota.
Quella degli ebrei Zeloti era una specie di setta, un importante gruppo politico estremista cui aderivano squadre di militanti, combattenti estremisti fondamentalisti, il
cui obiettivo era la guerriglia armata contro l’invasore, contro Roma.
Il movimento di resistenza Zelota, che riscuoteva le simpatie di una buona
parte del popolo ebraico, si prefiggeva di rovesciare il potere politico dell’Impero di
Roma utilizzando una strategia sovversiva mirata. Tutta questa gente era accomunata
da un ideale politico di forte impronta nazionalista, erano impegnati in una lotta senza
confine contro l’occupazione romana e per l’indipendenza della nazione ebraica. Avevano propensioni ideologiche estreme da un punto di vista politico, ed appartenevano
a raggruppamenti religiosi ebraici che si costituivano in partiti religiosi nazional sionisti la cui unica missione consisteva nella liberazione del popolo d’Israele dall’odiato nemico, esercitando azioni di resistenza popolare e di guerriglia armata.
È in un contesto di crisi politica e ideologica che emergono movimenti o sette
ciascuno dei quali crede di avere una sua ricetta segreta per risolvere i problemi del paese. Gli ebrei pensavano di avere raggiunto l’apice storico della crisi del loro rapporto
col Dio del Vecchio Testamento; era la crisi di tutto il giudaismo e della sua stessa identità religiosa e culturale. Molti ebrei vivevano nella speranza dell’avvento di un messia
che venisse in aiuto al popolo eletto; le aspettative messianiche erano al culmine, tanto
che in seno al movimento zelota alcuni ribelli estremisti proposero se stessi come prescelti, inviati dal Dio d’Israele per liberare la Palestina ed instaurare un nuovo regno.
Una figura inquietante, oscura e controversa del movimento Zelota, è Giuda
Iscariota. Egli è forse deluso dal comportamento di Gesù fino al punto di sentirsi
tradito egli stesso. Giuda si aspettava un messia rivoluzionario, un guerriero armato
di spada che si ponesse a capo di un esercito o di un movimento politico estremista,
un uomo d’azione che ricorresse all’uso della forza per ristabilire l’ordine in Israele.
Quando incontra un ebreo mite che si fa ungere con unguenti profumati da una don-
22
Antonio Bica
na, Giuda il fondamentalista, l’estremista nazionalista, intuisce che Gesù, accettando
il gesto dell’unzione, accetta implicitamente il suo stesso sacrificio.
Che fine ha fatto il Signore che doveva combattere contro le nazioni? Dov’è il
Messia guerriero tanto atteso, il figlio ed erede di Davide, discendente della dinastia
reale d’Israele, prescelto per salvare il popolo oppresso? Gesù non è la soluzione del
problema politico degli ebrei, è piuttosto un uomo che ha scelto per sé un ruolo di
perdente, andando incontro ad un inutile sacrificio di se stesso. Giuda è ferito, deluso, vede fallire davanti ai suoi occhi un programma politico già tracciato, ecco che
allora tradisce l’amico e lo consegna alle autorità del Tempio. Dai racconti evangelici non emerge la figura di un messia Gesù venuto a rovesciare il potere di Roma, e fu
proprio questo a non essere accettato dalle fazioni politiche più oltranziste.
Ma torniamo a Nag Hammadi, località dell’Alto Egitto. La scoperta dei testi
Gnostici risale al 1945. È un contadino a riportare casualmente alla luce, dopo un
silenzio di 1600 anni, una giara di terracotta nel cui interno è custodita una raccolta
di 52 testi gnostici.
Le preziose fonti testuali rinvenute dall’inconsapevole contadino arabo, e che
oggi vanno a costituire la biblioteca di Nag Hammadi, hanno contribuito a modificare
radicalmente la nostra idea del Cristianesimo primitivo, dimostrando quanto variegato
e polimorfo fosse il fenomeno alle sue origini. I 13 papiri di Nag Hammadi risalgono
al IV sec. d. C. e si presentano ai nostri occhi come trascrizioni da testi greci più antichi, databili attorno al II sec. d. C. Colui o coloro che nascosero i papiri, con il chiaro
intento di metterli al sicuro, salvarono certamente i testi dalla distruzione sistematica
operata dai cristiani proto-ortodossi; questi rappresentavano la corrente principale,
una fra le tante correnti e sette del Cristianesimo primitivo, l’unica ad uscire vittoriosa
dalla guerra per la supremazia in atto in quel periodo, l’unica ad avere l’opportunità
di dettare i canoni, la dottrina, i principi fondamentali di quella che sarebbe diventata
la religione professata nella maggior parte del mondo conosciuto.
Quando, riferendoci al cristianesimo primitivo, parliamo di divisione in sette
e correnti innumerevoli, non bisogna meravigliarsi tanto; il fenomeno non era poi
così dissimile, dal punto di vista della varietà almeno, da ciò che si prospetta agli
occhi del cristiano dei tempi moderni. Proviamo ad immaginare fra quante correnti
un cristiano di oggi può operare la sua scelta; millenaristi, mormoni, testimoni di
Geova, avventisti cristiani e avventisti del settimo giorno, poi ci sono i quaccheri, i
presbiteriani, e ancora metodisti, battisti, pentecostali, congregazionalisti, anglicani.
Se c’è qualcosa che veramente accomuna tutti gli accoliti, è la ferma convinzione di
ciascuno di possedere l’unica verità, di appartenere alla corrente o alla setta che fra
le altre è la migliore perché meglio interpreta i dettami della vera fede. Ebbene, la
situazione era più o meno simile già a partire dalla fine del primo secolo dopo Cristo.
Tutto il prodotto della cultura della corrente religiosa gnostica, fu dichiarato estraneo al pensiero cristiano, così anche i testi della letteratura gnostica furono
considerati eretici e sequestrati per essere bruciati o distrutti. Ecco perché, fino alla
I vangeli gnostici e il cristianesimo delle origini
23
metà del secolo scorso, poco o nulla si sapeva del Vangelo di Tommaso, il Vangelo
di Filippo, il Vangelo degli Egiziani, il Vangelo di Verità, l’Apocalisse di Paolo, l’Apocalisse di Pietro, il Libro Segreto di Giacomo ed altri testi ancora che fanno parte
della biblioteca di Nag Hammadi. L’eliminazione sistematica dei documenti gnostici, bollati come proibiti e da sempre rifiutati dalla Chiesa ufficiale, è il risultato della
lotta per il predominio fra le tante correnti e sette che s’incontrarono e si scontrarono
agli albori del Cristianesimo.
Poiché fu la fazione ortodossa a vincere e poiché la storia, da sempre, la scrive
chi vince, gli ortodossi ci trasmisero un canone testamentario che comprende solo
i quattro Vangeli ufficiali che oggi conosciamo, distruggendo ed escludendo tutti
gli altri considerati eretici e pertanto devianti; in seno al variegato e multiforme
universo polemico del cristianesimo primitivo, fu sempre l’ortodossia, vittoriosa nei
duri conflitti del II e III secolo, a stabilire quali libri potevano entrare a far parte
del Nuovo Testamento e quali no, fu l’ortodossia a gettare le basi ideologiche del
Cristianesimo come oggi noi lo conosciamo in Occidente, a decretare quale doveva
essere la vera fede, la dottrina, la gerarchia, le pratiche cultuali di ciò che sarebbe
diventata la tradizione cristiana fino ai nostri giorni. Ovviamente l’ortodossia definì
minuziosamente ciò che doveva essere escluso e ciò che andava ripulito prima che
fosse consegnato ai posteri.
Ma viene da chiedersi cosa sarebbe successo se i fatti si fossero svolti diversamente, se avesse prevalso un’altra corrente, una fra quelle dichiarate eretiche; di
sicuro oggi avremmo una forma diversa di Cristianesimo, le Sacre Scritture comprenderebbero altri Vangeli, diversi dai quattro canonici, la cultura medievale, quella
rinascimentale, sarebbero state qualcosa di diverso da come le conosciamo, la nostra
stessa cultura occidentale si sarebbe sviluppata su modelli differenti, e magari al
posto del monoteismo ebraico avremmo un pantheon politeista.
La scoperta dei testi gnostici ha senz’altro aperto la strada a nuove soluzioni,
differenti interpretazioni e chiavi di lettura che ci proiettano verso una conoscenza
alternativa, in una direzione opposta a quella tracciata dalla via stantia del dogmatismo. È anche questo il significato di Nag Hammadi, è come se chi nascose i preziosi
documenti 1600 anni fa, sperasse in un ritrovamento, magari casuale, da parte di
qualcuno nel futuro della storia, perché quei testi potessero urlare “c’eravamo anche
noi, e queste erano le nostre idee!” In effetti è proprio ciò che è successo.
Ma quale fu l’elemento catalizzatore della vittoria dell’ortodossia, ciò che
permise al Cristianesimo di sopravvivere e prosperare fino ad oggi? Cosa tolse ogni
speranza agli eretici e li costrinse a nascondersi e a nascondere le loro letterature per
salvarle dal fuoco e dalla distruzione? La conversione dell’imperatore Costantino
e la proclamazione del Cristianesimo a religione dell’impero, costituì un momento
decisivo che pose, per così dire, il sigillo al trionfo dell’ortodossia. Costantino, assegnando il merito dei suoi successi in campo politico e militare al Dio dei cristiani,
cominciò a concedere loro tutta una serie di benefici, ottenendo che la conversione al
24
Antonio Bica
Cristianesimo diventasse un fatto di convenienza oltre che di moda.
L’imperatore decretò la soppressione di tutte le sette eretiche e ordinò che i
loro beni fossero trasferiti alla Chiesa Cattolica. Finalmente, la corrente ortodossa,
una delle tante correnti nel mare infinito del plurisettarismo del Cristianesimo delle
origini, si era trasformata in una struttura piramidale organizzata, con le proprie e
solo le proprie scritture ordinate in un Canone, con un credo ed una gerarchia potente
come mai prima. L’ortodossia aveva vinto, una vittoria, la sua, sia sul piano religioso
sia su quello politico, che non sarebbe stato possibile realizzare senza il favore incondizionato dell’imperatore Costantino aveva scelto.
Ma cosa sarebbe accaduto se, nella lotta per la supremazia della fede autentica,
avessero vinto i cristiani ebioniti, che erano molto vicini alle pratiche dell’ebraismo e si
attenevano alle leggi del Vecchio Testamento? Forse i cristiani di oggi avrebbero considerato se stessi come una costola dell’ebraismo, e allora la suorina avrebbe onorato il
sabato e mangiato kasher? E se a vincere fossero stati gli eretici di Marcione, che pure
costituivano un potente movimento in seno alla Chiesa delle origini, che rifiutavano
tutto ciò che era ebraico e non credevano vi fosse un solo Dio, ma due Dei, il Dio iracondo degli ebrei e del Vecchio Testamento e il Dio buono del Nuovo Testamento, in
che modo avremmo professato noi, oggi, il politeismo di stampo marcionita?
Se da ragazzo ponevo domande del tipo “perché c’è il male nel mondo?” (che
poi ho scoperto essere la stessa domanda che si erano posti i profeti della tradizione biblica e gli apocalittici ebrei del III sec. a. C.) oppure del tipo “ma Gesù, sulla
croce, sentiva veramente dolore?”, precorrendo quelli che sarebbero stati da adulto
i miei studi sul Docetismo (che è la dottrina, risalente al Cristianesimo delle origini,
di quanti negavano la natura corporea ed umana di Gesù, il cui corpo, esistendo
soltanto come involucro apparente, non poteva essere andato incontro ad una reale
passione e morte), mi veniva risposto che queste erano “cose ampie”, che la mente
dell’uomo non poteva penetrare.
Un’altra cosa che ricordo, erano le lezioni sul “rispetto” e l’obbedienza alle gerarchie ecclesiastiche. “Obbedite al parroco sempre, ma più di tutti obbedite al vescovo”, ci dicevano. Obbedire alle gerarchie, significava innanzi tutto, anche al tempo di
Giuda, riconoscere le gerarchie ed era poi un modo, oggi come allora, per appianare
eventuali dispute dottrinali sorte all’interno di una stessa fazione. Da grande ho appreso come Ignazio, vescovo di Antiochia, nei primi del II secolo, partendo dal presupposto che i capi delle gerarchie ecclesiastiche sapessero sempre cosa fare e come agire
e fossero pertanto infallibili, in una sua lettera ai cristiani di Filadelfia, città dell’Asia
minore, li esortava a ‘prestare ascolto al vescovo, al presbitero e ai diaconi’, al fine di
evitare sul nascere i possibili problemi dottrinali in seno alla comunità.
La mia suora, a pensarci bene, mi diceva la stessa cosa e con le stesse parole,
1800 anni dopo, e sarà stata d’accordo anche con Ireneo, vescovo di Lione, nel dire
che “fuori della Chiesa non c’è religione vera né Dio vero”. Ebbene, gli Gnostici la
pensavano in maniera diversa.
I vangeli gnostici e il cristianesimo delle origini
25
Il termine gnosticismo deriva dalla parola greca gnosis, che vuol dire conoscenza e che riassume un insieme di cognizioni segrete e in parte esoteriche riservate ad una
élite spirituale; insomma una sorta di comprensione, di intuizione profonda, che porta
l’uomo alla piena consapevolezza di sé. Nello Gnosticismo convergono vari elementi
che si riallacciano principalmente alla filosofia greca e, in particolare, alla metafisica
platonica, al mondo ellenistico, alle religioni misteriche, al giudaismo alessandrino, a
pratiche religiose e concezioni esoteriche e cosmologiche del lontano Oriente.
Altro elemento caratterizzante del pensiero gnostico è l’applicazione del mito
alla cosmologia, per spiegare l’origine del mondo e della divinità stessa. L’universo
fisico, rappresentato dalle stelle e dai pianeti, influenzerebbe le vicende degli uomini. Nel Vangelo di Giuda, Gesù dice al suo discepolo che sarà proprio una stella nel
cielo a guidare la sua anima, e invita Giuda a seguire quella stella. Tale costruzione
mitologica va a supportare l’apparato dottrinale dello Gnosticismo.
Dopo la distruzione di Gerusalemme per opera dei Romani, avvenuta nel 70 d.
C., si assiste ad una crisi dei valori e della tradizione religiosa ebraica e dell’impianto
dottrinale del giudaismo rabbinico.
Gli Ebrei vivono una crisi d’identità senza precedenti, che è anche crisi del
loro rapporto con Dio; è proprio da questo primo momento di smarrimento culturale,
di perdita dell’identità della nazione, di inquietudine politica e incertezza religiosa
che origina il pensiero gnostico, la cui fioritura avviene ad Alessandria a partire
dalla fine del primo secolo d. C. Alcune frange del popolo ebraico fanno ricorso ad
un ritorno alla filosofia greca per rimodulare il loro pensiero e adattarlo al momento
storico particolare. A giudicare dalla molteplice letteratura intrisa di ideali gnostici,
tale movimento di pensiero dovette esercitare un fascino enorme sui suoi seguaci,
tanto da costituire un pericolo così forte per l’ortodossia cristiana in fase di organizzazione, che questa usò ogni mezzo lecito ed illecito per combatterlo.
Oggi sappiamo infatti che l’ortodossia considerò il Cristianesimo Gnostico
alla stregua di un movimento sovversivo ed eretico.
Una delle caratteristiche fondamentali del pensiero gnostico, è il ricorso al concetto di dualismo tanto caro alla tradizione filosofica greca e platonica in particolare.
Secondo tale forma di radicalismo ideologico proprio della filosofia greca, esiste una
contrapposizione fra il mondo dello spirito, positivo, e il mondo della materia, negativo e malvagio. Platone, ad esempio, parlava di mondo delle idee e mondo reale. Nel
I e II secolo dopo Cristo, i seguaci del pensiero gnostico e di quello medioplatonico,
sono accomunati entrambi dall’idea che vi sia una divinità eterna, incorruttibile, ineffabile, trascendente, indefinibile, un Dio unico dal quale, con un movimento fluido
che va dalla dimensione spirituale a quella materiale, si staccano entità divine inferiori chiamate “eoni”, che si riuniscono a formare un regno definito “pleroma”.
È in seguito ad una sorta di catastrofe cosmica che si genera una frattura nel
pleroma e si origina il mondo materiale, che è un mondo imperfetto, popolato da
forze cosmiche malvagie. Una delle domande che hanno tormentato la mente degli
26
Antonio Bica
autori della Bibbia ebraica, è stata “perché esistono nel mondo il male, il dolore e la
sofferenza? Perché mai il Dio del Vecchio Testamento, dopo secoli di schiavitù del
popolo d’Israele, fughe, persecuzioni, distruzioni, crisi politiche, problemi economici
e sociali a non finire, non è intervenuto per aiutare i figli d’Israele?” Secondo la spiegazione tramandataci dalla tradizione profetica, il popolo e la nazione soffrono perché
gli uomini hanno peccato contro Dio e non hanno accolto pienamente i dettami della
legge mosaica. Però, se il popolo d’Israele si fosse redento, prestando ascolto al suo
Dio, Dio stesso avrebbe concesso il suo aiuto conducendo Israele alla salvezza.
Ma quando, nonostante la contrizione del popolo ed il suo impegno a vivere nel
rispetto della legge, non cessavano i lutti, la sofferenza e la schiavitù, allora si pensò
che la spiegazione doveva essere un’altra. Fu così che un gruppo di pensatori ebrei
appartenenti alla cosiddetta “apocalittica” ebraica, (dal greco apokalypsis che significa “rivelazione”, infatti erano convinti che Dio avesse rivelato loro i segreti della
creazione e il motivo dell’esistenza del male cosmico), tentò di spiegare il problema
con la presenza di un personale avversario e nemico di Dio, il Diavolo, responsabile dell’imperversare nel mondo di forze malvagie e distruttici. Alla fine, però, Dio
sarebbe intervenuto a salvare i figli d’Israele, sconfiggendo le forze del male e colui
che era colpevole, responsabile della loro esistenza. Pertanto, secondo la tradizione
profetica, sarebbe Dio stesso a provocare la sofferenza, secondo la tradizione ebraica
apocalittica, è invece il Diavolo, nemico di Dio, ad esserne responsabile.
La stessa interpretazione apocalittica, comunque, prevede in tempi brevi un
intervento salvifico da parte del Dio buono. Ma che succede se il tanto atteso intervento non giunge, e anzi, i lutti e la schiavitù continuano come prima se non peggio?
Vuol dire che la spiegazione del perché c’è il male nel mondo deve stare da un’altra
parte ancora. Ma dove? Ecco, allora, che partendo da una reinterpretazione del pensiero filosofico platonico, comincia a svilupparsi quella che sarà l’intricata visione del
mondo da parte dello Gnosticismo protocristiano, secondo cui è Dio stesso a causare
sofferenza e dolore, perché è un Dio malvagio e inferiore; insomma, al di sopra del
Dio terribile del Vecchio Testamento, creatore di un mondo imperfetto dove gli uomini sono prigionieri della loro stessa esistenza, esiste un Dio buono e perfetto, un Dio
non nominabile, non qualificabile, totalmente esistente in sé e bastante a se stesso.
È da questo Dio, secondo un complesso sistema di cosmologia mitologica, che
originano altre entità divine inferiori ed imperfette, che creano un mondo imperfetto,
popolato da altrettanti esseri imperfetti. È la cosmogonia gnostica che utilizza il mito
per spiegare la misteriosa origine dell’uomo sulla terra, in un mondo generato da un
errore cosmico.
Ma può l’uomo tornare al Dio ineffabile dal quale proviene? E cosa deve fare,
ammesso che ciò sia possibile? Gli Gnostici pensavano che gli esseri umani, anche
se non tutti, potevano fare ritorno alla dimora celeste e ricongiungersi col Padre,
semplicemente rifuggendo dal mondo e allontanandosi dal regno dell’imperfezione.
Solamente in alcuni uomini appartenenti ad una ristretta cerchia, un’élite spirituale,
I vangeli gnostici e il cristianesimo delle origini
27
sopravvive una specie di scintilla divina; è proprio attraverso la gnosis, la conoscenza segreta che conduce alla salvezza, che questi uomini possono liberarsi dalla
prigionia della materia in cui sono caduti.
La gnosis giunge attraverso colui che la rivela, cioè Gesù. Nella concezione
gnostica, pertanto, Gesù è portatore di conoscenza, anzi ne è il rivelatore, è l’emissario divino che viene dal regno del Padre.
La gnosis si acquisisce solo per rivelazione e non è quel tipo di conoscenza
che deriva dall’esperienza empirica, non la conoscenza di Epicuro o di Lucrezio del
tipo species ratioque naturae, cioè l’osservazione immediata e l’intuizione razionale
della natura, ma è esperienza, conoscenza e consapevolezza di se stessi. Secondo
la concezione gnostica, Gesù è spirito puro delimitato da un involucro, da un corpo
materiale; Gesù rappresenta di fatto l’uomo che riceve dall’alto lo spirito con l’atto
del battesimo, e la sua morte costituisce la scena finale, quella con cui fugge dalla
materia, liberandosene, e ritornando ad essere lo spirito puro originario.
Giuda, consegnando Gesù alle autorità, diventa l’artefice di questo miracolo.
Il Cristo gnostico, nulla ha a che vedere con la contrizione o la redenzione dal peccato, non ci salva offrendo se stesso alla croce, il Cristo gnostico è il Cristo dell’illuminazione, della conoscenza profonda, è il Cristo della comprensione del mistero
primordiale dell’animo umano, è il Cristo della consapevolezza e della maturità spirituale dell’uomo. Il proprio corpo costituiva per gli Gnostici un elemento corrotto
da cui rifuggire, qualcosa insomma di cui liberarsi. Essi contemplavano un’etica
volta all’ascetismo al fine di punire il corpo malvagio; negare al corpo ogni piacere
significava distaccarsi, allontanarsi da esso.
Lo Gnostico partecipa ad un’esperienza soggettiva illuminante, imparando a
guardare dentro se stesso, cogliendo la vera luce nell’ascetismo e nel silenzio della
meditazione. La salvezza vera, dunque, non è legata in alcun modo al corpo fisico,
piuttosto essa si ottiene con la fuga dal corpo. Così, il corpo di Gesù, essendo solo
un involucro, non può essere intaccato dal dolore fisico. Il significato del Cristo va
ben oltre la croce e la morte, il suo spirito non può né soffrire né morire, e lo stesso
accade agli spiriti che, attraverso la conoscenza profonda di se stessi, giungono alla
comprensione del Cristo e partecipano della conoscenza di Dio.
Alla fine, conoscere se stessi è lo stesso che conoscere Dio, perché con l’acquisizione dei segreti della gnosi, il sé individuale diventa identico a Dio; è una rivoluzione, si può conoscere Dio senza l’intervento di preti, vescovi e diaconi. Questa
identità fra l’uomo e Dio, oltre che nel Vangelo di Giuda, la si può riscontrare in un
altro testo gnostico ritrovato a Nag Hammadi, il Vangelo di Tommaso, laddove Gesù
dice a Tommaso: «chi beve dalla mia bocca diventerà come me; io stesso diventerò
come lui e i misteri gli saranno svelati» (Vangelo di Tommaso, 108).
Per gli Gnostici, appartenenti ad una ristretta cerchia di privilegiati, la forza
della loro idea e del loro messaggio, non poteva avere un effetto dirompente nel suo
incontro con le masse.
28
Antonio Bica
La massa, infatti, non poteva accettare l’idea di non appartenere al gruppo
degli eletti; inoltre, non avendo tutti in sé la scintilla divina, non potevano neanche
ricevere la gnosi, la conoscenza segreta che avrebbe condotto alla salvezza. Faceva
più comodo alle masse l’accettazione di una religione dove si professava che Gesù
era venuto a redimere, con la propria morte, tutti gli uomini dal peccato, e questa era
la tesi dell’ortodossia. Gli Gnostici erano fortemente motivati dalla loro stessa esclusività, pensavano che ogni forma di speculazione dottrinale, sia che si trattasse della
propria o di altre, non fosse che il mezzo, la via da percorrere per avvicinare l’uomo all’unica verità, e questo dimostra come nella loro argomentazione escatologica,
cioè riguardante il destino ultimo dell’uomo nell’universo, non v’era affatto posto
per lo scetticismo, ma c’era la reale, determinata convinzione di poter conseguire,
mediante la consapevolezza di sé, il fine ultimo della partecipazione al Dio supremo.
Questa loro posizione ideologica nei confronti della dottrina, li poneva molto
distanti dai loro fratelli che aderivano all’ortodossia, poiché questi ultimi identificavano sempre più spesso la verità con la loro stessa dottrina, come dire che la mia dottrina non è per me soltanto un mezzo, una strada che mi porterà al raggiungimento
di un obiettivo, ma essa stessa vi coincide, essa è l’obiettivo. Insomma verità, fede e
dottrina sono per gli ortodossi elementi coincidenti. Il cristiano, una volta che ha accettato come unica ed autentica fede ciò che gli ha trasmesso la Chiesa tramite la sua
gerarchia di vescovi, non ha null’altro da cercare, ha già raggiunto il suo obiettivo.
Continuare per la strada di un qualsiasi tipo di ricerca spirituale, non ha alcun senso
poiché bisogna accettare passivamente i cosiddetti limiti della comprensione umana.
Questi cristiani che accettano, per fede, di credere in un Gesù che li ha salvati
con la morte in croce, che da quella morte è risorto per ascendere al cielo, colgono
soltanto l’idea del fine salvifico del Cristo, senza tuttavia riuscire a compenetrare il
mistero della sua natura. Gli Gnostici, invece, giungono alla comprensione della vera
natura del Cristo perché hanno ricevuto la gnosi, la conoscenza segreta che, portando la propria più intima natura al cospetto della natura di Dio, li identifica con Dio
stesso. Ecco che gli Gnostici mettevano in discussione tutto, la dottrina, i riti, il ruolo
di mediazione ed il potere stesso dei vescovi e della gerarchia ecclesiastica; essi non
cercavano intermediari per mettersi in relazione con Dio. I vescovi con i preti e i
diaconi non erano altro che gli inutili accessori di un sistema organizzativo che si
andava lentamente trasformando in istituzione, in una struttura che sarebbe divenuta
talmente potente da sopravvivere fino a noi.
Già verso la fine del primo secolo l’ortodossia cristiana aveva definito dei
criteri generali per identificare l’appartenenza alla Chiesa; per essere cristiani bisognava accettare il rito del battesimo, la professione del credo, bisognava inoltre
partecipare ai culti e soprattutto prestare obbedienza ai vescovi e al clero.
Non era difficile in tal modo per la Chiesa fare proseliti ed accogliere quanta
più gente possibile, adottando una politica volta alla comunità dei potenziali credenti
piuttosto che ad una élite ristretta. I criteri degli Gnostici erano ovviamente diversi,
I vangeli gnostici e il cristianesimo delle origini
29
erano criteri più di tipo qualitativo; per essere un buon cristiano non bastava prendere
parte ai riti o accettare il battesimo, né tanto meno obbedire al clero; bisognava piuttosto dare prova di un’autentica maturità spirituale, di possedere capacità più profonde,
di essere capaci di seguire percorsi intuitivi non alla portata di tutti. Naturalmente i
vescovi si opposero e criticarono la validità dei criteri qualitativi nello specificare
l’appartenenza alla Chiesa; una valutazione di questo tipo, infatti, non avrebbe creato
molti proseliti, ed era proprio di questo che la Chiesa aveva bisogno per poter affermare sempre più la propria autorità e costituirsi come struttura organizzata.
Il fatto di non riconoscere l’autorità delle gerarchie dell’ortodossia, unitamente alla pretesa di possedere un sapere iniziatico ed elitario, fece degli Gnostici dei
sovversivi in seno al Cristianesimo dei primordi e ne determinò la bollatura per
eresia e la maledizione da parte delle autorità ecclesiastiche. E’ inutile dire che le
accuse formulate contro il Cristianesimo Gnostico, diedero luogo ad aspre contese
dottrinali e non. Affermare il principio di libertà individuale, senza l’ingerenza dei
vescovi, da un lato poteva apparire illuminante per i dotti gnostici, ma dall’altro mal
si accordava con tutto l’impianto dottrinale ortodosso che prevedeva una serie interminabile di riti, dogmi, ed una interpretazione delle Scritture che non travalicasse di
una sola spanna i rigidi confini della lettura ortodossa, l’unica possibile, la sola che
si poteva accettare.
Alla fine del II secolo, Ireneo vescovo di Lione, affermava che non poteva
esistere che una sola Chiesa, e non poteva esserci alcuna salvezza né redenzione al
di fuori di essa. Così formulava la sua teoria del ‘vangelo quadriforme’. Poiché erano
quattro gli angoli della terra e quattro i venti principali, la Chiesa aveva bisogno di
quattro vangeli e di questi soltanto; tutto il resto, tutta la preziosa letteratura gnostica,
che oggi è giunta fina a noi solo per un caso del destino, andava distrutto col fuoco e
dichiarato eretico e falso. Nessun cristiano poteva considerarsi tale se non si riconosceva nel vangelo quadriforme.
Ed ecco che il vescovo di Lione utilizza Giovanni come baluardo da opporre
all’idea gnostica di Gesù. Giovanni dice che Gesù è luce divina che si manifesta agli
uomini, Gesù è la forma umana di Dio e per avvicinarsi a Dio è necessario credere
in Gesù. Ma il Gesù Gnostico è un’altra cosa; nel Gesù Gnostico, la luce divina che
egli incarna, è condivisa da tutti gli uomini, e per avvicinarsi a Dio non bisogna semplicemente credere in Gesù, ma piuttosto accogliere il suo invito ad indagare dentro
di sé fino a scoprire la luce interiore, quella “scintilla divina” che alberga nel nostro
cuore. Evidentemente Ireneo punta a contrapporre alla visione gnostica di Gesù, la
visione ortodossa di Giovanni. Il solco tracciato da Ireneo col vangelo quadriforme,
col sostegno delle gerarchie ecclesiastiche successive, è stato seguito sin dai tempi
del trionfo dell’ortodossia e così fino ai nostri giorni. Certo, Ireneo, partiva dal presupposto che due dei quattro evangelisti, Matteo e Giovanni, fossero stati testimoni
oculari dei fatti narrati.
Oggi, in realtà, nessuno può dire chi abbia materialmente redatto i Vangeli
30
Antonio Bica
così come li conosciamo; soprattutto, poi, quando si fa riferimento al Vangelo di
Giovanni, viene spontaneo agli studiosi chiedersi come avrebbe potuto quel pescatore di Genezaret, fratello di Giacomo e figlio di Zebedeo, pescatori anch’essi, comporre un Vangelo con uno stile letterario così elegante e quasi impeccabile.
Un cenno a parte merita la concezione gnostica della resurrezione, contrapposta a quella della tradizione ortodossa. Cominciamo col ricordare Luca (dal Vangelo
di Luca, cap. 24, vers. 36-43: «Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona apparve in mezzo a loro e disse: «pace a voi!». Stupiti e spaventati credevano
di vedere un fantasma. Ma egli disse: «perché siete turbati, e perché sorgono dubbi
nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: Sono proprio io! Toccatemi e
guardate; un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho». Dicendo questo
mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la grande gioia ancora non credevano ed
erano stupefatti, disse: «avete qui qualcosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro»).
È chiaro come Gesù voglia dimostrare qui l’evidenza della realtà corporea della
sua resurrezione. Questa è certamente una delle questioni più radicali della fede cristiana.
Non è un fantasma che riprende a vivere ma un corpo, sangue e ossa, carne
e nervi, che ritorna alla vita, stravolgendo completamente l’esperienza umana della
vita e della morte acquisita dalla notte dei tempi. Non è un impianto dottrinale ad essere capovolto, ma la stessa legge della natura. Il Cristianesimo ortodosso, sul solco
tracciato dalle testimonianze degli apostoli, afferma e condivide una concezione ed
un’interpretazione letterale della resurrezione. Ma perché? Può avere tutto questo un
valore politico ed un significato ben preciso nell’assegnazione della leadership che
gestirà il potere nei secoli successivi? Certo l’autorità degli undici rimasti (Giuda era
già morto) come testimoni dell’apparizione di Gesù risorto è indiscussa; nel Vangelo
di Giovanni (cap. 21, vers. 15-19), Gesù assegna a Pietro il compito di pastore del
gregge, e sarà proprio lui che, dopo la morte di Gesù, assumerà il ruolo di leader
del gruppo. Anche se, secondo Giovanni e Marco, fu Maria di Magdala e non Pietro
ad essere la prima testimone della resurrezione, la tradizione ortodossa fa risalire a
Pietro la propria autorità. Poiché non fa parte del gruppo dei Dodici, Maria non può
mettersi in corsa per conquistare il ruolo di leader.
Alcuni Gnostici, gli Gnostici Setiani, che si credevano discendenti di Set, terzo figlio di Adamo ed Eva, credevano che Gesù apparve in forma corporea soltanto
ad alcuni dei suoi seguaci, e a questi rivelò la gnosi e con essa la capacità di intendere
la resurrezione da un punto di vista spirituale e di esperienza interiore del Cristo.
Maria Maddalena era una di loro.
Poiché soltanto gli apostoli hanno avuto esperienza di Gesù da vivo e poi da
resuscitato, ed erano stati gli ultimi ad essere testimoni degli eventi narrati, l’autorità
religiosa di questi è inconfutabile. Avviene così che le prime gerarchie ecclesiastiche
si considerano legittime depositarie dell’autorità nella successione e fanno risalire la
loro eredità alla tradizione apostolica. Fu un fatto politico di enorme rilevanza per
I vangeli gnostici e il cristianesimo delle origini
31
i vescovi, i preti e i diaconi delle prime gerarchie del Cristianesimo ortodosso che
diventarono detentori di un potere che dura tutt’oggi. Se c’è un’unica verità, ed è
quella apostolica, c’è una sola Chiesa che può tramandarla e una sola gerarchia che
ne ha l’autorità spirituale.
È in tal modo che i primi Cristiani ortodossi gettano le fondamenta per l’istituzionalizzazione del loro movimento.
Il punto di vista gnostico, com’è ovvio, si trova totalmente agli antipodi. Se la
concezione ortodossa interpreta la resurrezione in senso letterale, vale a dire come
resurrezione della carne, l’esperienza gnostica della resurrezione vede in essa un
momento d’illuminazione spirituale e di esperienza tutta interiore del Cristo. Per gli
Gnostici, l’esperienza personale e interiore di Cristo supera perfino la tradizione ed
il valore della testimonianza apostolica.
È veramente un’idea sovversiva, un durissimo colpo di scure per il potere della Chiesa. Chiunque vede Cristo tramite la gnosi, può guadagnarsi il rapporto diretto
con Dio scavalcando le gerarchie della Chiesa e potendo negarne l’autorità. Ecco un
altro motivo per cui, fra tutti i movimenti in lotta per il potere nel vasto panorama del
Cristianesimo delle origini, quello degli Gnostici fu considerato sovversivo e la sua
dottrina eretica. La loro teoria, che implicava un avvicinamento diretto a Dio tramite
la gnosi, se accettata dalla massa dei credenti, avrebbe spiazzato politicamente tutto
l’impianto dell’ortodossia in termini di autorità assoluta, di legittimazione dell’autorità stessa, e soprattutto di potere di successione.
Tutto questo non è poco se pensiamo che la massima autorità della Chiesa è
considerata “successore di Pietro”.
A proposito dell’atteggiamento di Gesù nei confronti dei suoi discepoli, c’è
un Gesù che ride spesso nel Vangelo di Giuda, contrariamente a quanto accade nei
Vangeli Neotestamentari. Gesù ride della morte, fattore questo che non ha una connotazione negativa, piuttosto è il punto di passaggio ad una condizione di maggiore
dignità, l’istante in cui abbandoniamo tutto ciò che è inutile, compresa la nostra
fisicità corporea. Gesù ride perché i discepoli non sanno chi egli è veramente né
da dove viene; semplicemente lo credono il figlio del Dio degli Ebrei. Secondo la
concezione di Dio nello Gnosticismo Setiano, esiste un Essere Infinito, al di sopra di
ogni cosa, che non è identificabile col Dio minore del Vecchio Testamento, creatore
di quel disastroso mondo materiale pieno di forze malvagie che tengono gli uomini
intrappolati e da cui bisogna allontanarsi con la fuga.
Anche Gesù dovrà rifuggire da questo disastro cosmico rappresentato dal
mondo della quotidianità, dovrà separarsi dal suo corpo per ricongiungersi al regno
del Padre da cui proviene.
Secondo la concezione gnostica, Dio raggruppava in sé sia l’elemento maschile che quello femminile, in accordo col racconto della creazione riportato da Genesi
(cap. 1, vers. 26-27): «e Dio disse: “Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra
somiglianza […]; Dio creò l’uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò; ma-
32
Antonio Bica
schio e femmina li creò». Secondo questa descrizione, se l’uomo fu creato maschio
e femmina ad immagine di Dio, allora anche in Dio dovevano coesistere maschio e
femmina, Padre e Madre che vivevano un rapporto di compartecipazione armoniosa.
In termini dualistici, il riferimento rimanda agli opposti che si attraggono e vivono in
armonia, concezione questa molto vicina alle filosofie orientali, dove la forza negativa,
femminile dell’universo, lo yin, si armonizza in maniera complementare con la forza
positiva, maschile, lo yang, anche se tutto ciò è lontano sia dalla concezione ebraica
sia da quella del Cristianesimo ortodosso. D’altra parte, nella definizione di Dio in
termini trinitari, introdotta dai Cristiani, si parla di un Padre, un Figlio ed uno Spirito,
che in termini greci è pneuma, ma la parola ebraica che definisce lo Spirito è Ruah, che
è di genere femminile, pertanto il terzo elemento che si unisce al Padre ed al Figlio, in
questa visione gnostica della Trinità, è un elemento femminile, è la Madre.
Noi sappiamo oggi che tutti i libri segreti degli Gnostici furono dichiarati eretici e in gran parte distrutti dall’ortodossia cristiana emergente, pertanto già a partire
dal III secolo, viene spazzato via ogni riferimento alla rappresentazione in termini
femminili di Dio. Siamo inoltre a conoscenza di come, all’interno dei gruppi gnostici, le donne avessero pari dignità degli uomini, e svolgessero ruoli di sacerdotesse,
predicatrici, annunciatrici del vangelo.
Quei movimenti in cui le donne avevano un ruolo di leader, come fra gli Gnostici appunto, dovettero soccombere in quanto accusati di eresia dalle prime chiese
cristiane. Così le donne dovettero ritornare alle posizioni marginali e di secondo piano cui erano relegate dalla cultura ebraica tradizionale, e questo sia nei movimenti in
campo religioso, che politico. Le differenti posizioni filosofico-religiose, unitamente
alle diverse concezioni dottrinali, diedero vita ad un molteplice divenire di correnti
e di sette ciascuna con le proprie vocazioni, da quelle di stampo più sociale-progressista, a quelle di matrice politica estremista-nazionalista, ad altre ancora con più
spiccate tendenze verso lo spiritualismo e l’ascetismo.
Se avessero vinto gli Gnostici, oggi noi avremmo un’idea diversa del comunismo, o piuttosto non si sarebbe mai parlato di comunismo, o ancora avremmo avuto una specie di comunismo universale, come forma di reazione alla élite gnostica
vittoriosa e, di conseguenza, una parallela Chiesa cattolica comunista e reazionaria.
Una cosa è certa, il pensiero gnostico, il Vangelo di Giuda, il Vangelo di Tommaso, il Vangelo di Filippo e tanti altri scritti cosiddetti “eretici”, sono la prova documentata che il desiderio, il bisogno, l’istinto dell’uomo nella ricerca di Dio, rappresentano qualcosa che trascende i confini della singola appartenenza, della tradizione
politica o religiosa di una corrente di pensiero piuttosto che di un’altra.
Nel suo personale cammino alla ricerca di Dio, l’uomo travalica il limite di se
stesso, del sé materiale, divenendo Dio egli stesso in quel momento, poiché proietta
il suo pensiero verso un pensare universale ed eterno; diventa sogno perché Dio è
sempre stato il grande sogno degli uomini e forse, se un Dio c’è veramente, tutti noi
non possiamo che essere il grande sogno di Dio.
Giuseppina Mammana
La ricerca di sé come ricerca di Dio e dell’anima nel pensiero
di S. Agostino
Il prevalere del Cristianesimo nel mondo occidentale determinò un nuovo indirizzo della filosofia. Ogni religione implica un insieme di credenze,che non sono
frutto di ricerca perché consistono nell’accettazione di una rivelazione . La religione
è l’adesione ad una verità che l’uomo accetta in virtù di una testimonianza superiore. Tale infatti è il Cristianesimo. L’accettazione di una verità testimoniata dall’alto
sembra escludere qualsiasi ricerca. Tuttavia, riconosciuta la verità nel suo valore
assoluto, quale viene rivelata e testimoniata da una potenza trascendente, nasce
nell’uomo l’esigenza di avvicinarsi ad essa e di comprenderla nel suo significato
autentico, per vivere veramente con essa e di essa.
Dalla religione cristiana è nata così la filosofia cristiana.
Il messaggio di Cristo consiste in un rinnovamento spirituale che deve realizzarsi nella interiorità delle coscienze. Gesù è stato mandato dal Padre per annunciare
il suo regno,”che non è di questo mondo”. Il regno di Dio non esige un mutamento
politico: “date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio” ha detto
Gesù. È piuttosto una realtà invisibile e interiore dell’uomo. Dio è il Padre di tutti
gli uomini ed è fonte di amore, di grazia e di perdono. Dio è Colui che è, l’Essere,
Cristo il logos, il Verbo, il mediatore tra Dio e gli uomini,lo Spirito Santo è l’amore
che spira reciproco tra il Padre e il Figlio.
Il Cristianesimo non è soltanto rivelazione: esso è una nuova filosofia ed una
rivoluzione storica. Tutti gli uomini sono figli di Dio ed hanno pari dignità.
L’uguaglianza , la fratellanza, la giustizia e l’amore per tutti, soprattutto per i
nemici - se amate solo quelli che vi amano, che merito avete? (Mt 5, 44-48) – sconvolgevano gli equilibri del sistema politico e della società dominata dall’Impero romano. Ricordiamo che per i Romani gli schiavi non habent personam. Per il diritto
romano lo schiavo è cosa, oggetto anziché soggetto del diritto. Solo in età tarda e
nel linguaggio extragiuridico il termine persona risulta adoperato con riferimento al
concetto astratto di individualità umana. Il significato originario del termine persona
era maschera teatrale.
Gesù afferma esplicitamente di non essere venuto a portare la pace, ma la
34
Giuseppina Mammana
spada (Mt 10,34). I Cristiani vengono perseguitati e la nuova religione soggetta ad
attacchi polemici. Occorreva quindi difendersi, chiarire i propri presupposti teoretici
e organizzarli in un sistema di dottrine. Questo compito fu assolto dai padri apologisti del II secolo.
Il periodo di questa elaborazione dottrinale è la patristica. Padri della Chiesa
sono gli scrittori cristiani dell’antichità, che hanno contribuito ad ordinare e diffondere i principi del Cristianesimo. L’opera dei padri è stata accettata e fatta propria
dalla Chiesa.
La prima fase della Patristica, che va dal 200 al 450 circa, è dedicata alla formulazione dottrinale delle credenze cristiane. L’ultima, che va dal 450 sino alla fine
della Patristica, è contrassegnata dalla rielaborazione e sistemazione delle dottrine
già formulate. È questa la Patristica latina, nella quale campeggia la gigantesca figura di S. Agostino, il Padre della Chiesa.
Aurelio Agostino nacque a Tagaste (oggi Souk-Ahras, Algeria), nell’Africa
romana nel 354 e morì a Ippona nel 430.
Suo padre Patrizio era pagano, la madre Monica, cristiana. Il padre era indifferente alla religione, la madre, invece, era profondamente religiosa ed esercitò una
grande influenza sul figlio, che, nella sua opera maggiore Le Confessioni, la nomina
più volte, ricordando la sua costante presenza, specie nei momenti difficili della sua
vita. Trascorse la fanciullezza e l’adolescenza tra Tagaste, Madaura e Cartagine.
Le Confessioni, opera in latino in 13 libri, scritta tra l’anno 397 e il 400, è la
più famosa e la più letta dell’immensa produzione letteraria agostiniana;ha lasciato
duecentotrentacinque scritti.
Oltre a Le Confessioni ricordiamo: Contra academicos, Confutazione dello scetticismo, De libero arbitrio, De Magistro, De Vera Religione, De Trinitate, De Civitate Dei.
I tredici libri de Le Confessioni li scrisse da Vescovo, per dar lode a Dio; essi
lodano Dio giusto e buono per i miei mali e per i miei beni e verso di Lui sollevano
la mente e gli affetti degli uomini, come egli stesso dice; sono confessione di fede,
e anche confessione dei suoi peccati. È un’opera autobiografica, che ci fa conoscere
l’uomo Agostino, dall’infanzia alla maturità, la sua vita tormentata, il suo temperamento ardente, perennemente alla ricerca della verità sul senso della vita,della sua
vita,inconsapevolmente alla ricerca di Dio.
In uno sguardo retrospettivo molto preciso egli giudica con severità e rigore il
suo comportamento prima della conversione.
Fin dall’infanzia si rifiutava di obbedire ai genitori e ai maestri di scuola.
«Dio, Dio mio, quale sofferenza provavo allora, quando mi dicevano, certamente
prendendosi gioco di me, che per vivere rettamente è necessario ubbidire a coloro
che ci istruiscono» (Le Confessioni, libro I, p. 36).
Proprio a scuola, per imparare a leggere e a scrivere e far di conto, ebbe inizio
il suo tormento ad opera dei maestri che lo bacchettavano senza pietà e lo punivano
con altri strumenti di tortura.
La ricerca di sé come ricerca di Dio e dell’anima nel pensiero di S. Agostino
35
Non capisco - egli dice- perché noi bambini dovevamo essere martirizzati con
la complicità dei genitori, che pur ci volevano bene, ma non capivano le nostre
sofferenze. Non era certo un grave peccato se nello scrivere , nel leggere e nello studiare non facevamo quanto si esigeva da noi. Non mi mancava l’ingegno
o la memoria che , grazie a te, Dio, ne avevo a sufficienza a quella età, ma mi
piaceva giocare e venivo punito proprio da quelli che giocavano al par di me
[…] ma i giochi degli adulti si chiamano affari; anche i giochi dei ragazzi, per
essi sono affari, eppure vengono puniti dagli adulti ( Le Confessioni, libro I,
pp. 37-38).
Anche nella maturità Agostino non riesce a dimenticare il tormento della scuola e delle punizioni, pur riconoscendo di peccare, disubbidendo ai genitori e ai maestri.
Secoli dopo, nel 900, Maria Montessori, analizzò il conflitto tra l’adulto e il
bambino e si adoperò concretamente perché egli venisse rispettato e aiutato a vivere
in una scuola rinnovata e organizzata a sua misura.
In una pagina critica ella scrive:
I premi e i castighi si adottano per costringere i bambini a seguire le leggi del
mondo anziché quelle di Dio. Le leggi del mondo per i fanciulli sono dettate
quasi sempre dall’arbitrio dell’uomo adulto che investe se stesso di una esagerata, sconfinata autorità. Troppo spesso egli comanda perché è forte e vuole che
il bambino ubbidisca perché è debole.1
Le considerazioni di Agostino sul Primus Magister e sulla noia e il tormento
di dovere imparare a scrivere, leggere e far di conto sono illuminanti anche oggi.
Ricordiamo che a quel tempo esistevano tre tipi di insegnanti: il primus magister che risponderebbe al nostro maestro delle scuole elementari, il grammaticus che
avviava gli alunni alla lettura e alla spiegazione della letteratura e alla composizione
e risponderebbe al professore delle scuole medie e medie-superiori, poi il retor, che
risponderebbe al nostro professore universitario.
Agostino odiava il greco ma amava il latino, quello insegnato dai cosiddetti
maestri di grammatica. Detestava imparare a memoria le favole di un certo Enea,
dei suoi infelici amori e della infelicissima Didone. «Queste favole - egli dice - uccidevano la mia anima, o Dio, vita mia, ed io andavo tranquillo senza una lacrima di
pentimento! Io mi uccidevo dilettandomi delle cose ignobili e sprofondavo sempre
più in basso» (Le Confessioni, libro I, p. 43 ).
Lo eccitavano i poemi omerici, ma erano scritti in lingua greca e lo studio del
greco era odioso, soprattutto perché veniva imposto. Il latino riusciva ad impararlo
1
M. Montessori, La scoperta del bambino, Milano 1993, p. 15.
36
Giuseppina Mammana
senza castighi e minacce, anzi iniziò ad apprenderlo tra le affettuose carezze delle
nutrici, nell’allegria dei giochi e nella spensieratezza dei divertimenti.
«È chiaro che si impara meglio sollecitati da una libera curiosità , che non
costretti da una petulante necessità. La libertà però è regolata dalle tue leggi, o Dio,
come dalle tue leggi derivano le sferzate dei maestri e le torture dei martiri» (Le
Confessioni, libro I, p. 47).
Tuttavia il suo giudizio sulla scuola è ambivalente , perché da un lato le riconosce il merito di avergli offerto i mezzi per esprimere e leggere i suoi pensieri e
dall’altro di propinargli tante favole e tante sciocchezze che lo allontanavano da Dio
e lo inducevano a condurre una vita senza freni, disordinata e peccaminosa; era sempre alla ricerca dei piaceri dei sensi, in compagnia di falsi amici che con lodi stupide
ed inutili alimentavano la sua vanità come, ad esempio, essere il primo nelle gare
poetiche e sapere rubare le pere al vicino. Si illudeva di giustificare la sua esistenza
con il vuoto divertimento e la disobbedienza totale ai genitori e ai maestri.
«La madre, piangendo – egli dice – mi chiedeva come ricordo bene nel profondo del cuore la angosciosa apprensione che trapelava dalle sue parole-di astenermi dalla fornicazione e specialmente dall’adulterio» (Le Confessioni, libro II, p. 65).
Il padre modesto impiegato nel Municipio di Tagaste, si interessava soprattutto agli studi del figlio: non si preoccupava della sua castità; a lui premeva che diventasse bravo nella dissertazione per un avvenire brillante e agiato; sognava anche di
avere tanti nipotini.
Intanto bisognava trovare i soldi per mandare il figlio all’università di Cartagine. Ma i soldi non c’erano e Agostino dovette interrompere gli studi. Aveva 16 anni
e, costretto all’ozio per mancanza di mezzi, «i rovi delle passioni-confessa- coprirono la mia testa e nessuna mano venne a sradicarli» (Le Confessioni, libro II, p. 64).
A Madaura, cittadina vicina a Tagaste, aveva compiuto gli studi di letteratura
ed eloquenza. All’età di 17 anni raggiunge Cartagine: lo attraggono gli amori peccaminosi, e il teatro che riproduce sulle scene i vizi delle divinità pagane. La partecipazione all’azione scenica è così intensa da soffrirne fino al pianto. Negli spettacoli
teatrali ritrovava riproposte le sue miserie e il fuoco delle sue passioni.
«La mia anima non godeva buona salute, era piena di ulcere e si proiettava
all’esterno, miserabile, avida soltanto di quelle emozioni che si trovano soltanto attraverso contatti carnali» (Le Confessioni, libro III, p. 80)
A Cartagine si innamora di una giovane donna che gli dà un figlio Adeodato,
non voluto, ma poi amatissimo.
Cartagine, chiamata lussuriosa per le oscenità che venivano rappresentate nei
teatri e per la vita immorale che vi si conduceva, era la città più importante dell’Africa romana. Vi fiorirono le lettere e il Cristianesimo: Apuleio, Arnobio, Tertulliano,
San Cipriano e S. Agostino uscirono dalle scuole cartaginesi.
In questo vivace contesto sociale e culturale il giovane Agostino si impegnava
nello studio della retorica e dell’eloquenza ed era fiero di essere il migliore e il più
La ricerca di sé come ricerca di Dio e dell’anima nel pensiero di S. Agostino
37
quieto degli alunni.
L’amore per lo studio dell’oratoria e dell’eloquenza lo spinsero a leggere un
libro di Cicerone: Ortensio, un dialogo scritto tra il 46 e il 45 a. C., redatto nella
solitudine dei colli romani, dopo le delusioni politiche e le sofferenze per la morte
della figlia Tullia. Il dialogo prende il nome da uno dei suoi interlocutori, Ortensio
appunto, che ha un atteggiamento ostile alla filosofia. Cicerone difende la validità
della filosofia, dimostrandone l’innegabilità, perché anche chi la nega fa filosofia.
L’Ortensio è andato perduto, i frammenti rimasti li troviamo quasi tutti nelle opere
di Agostino (Le Confessioni, libro III, p. 86 ), ma per lui costituì un forte incitamento
alla filosofia: «mi fece bramare la sapienza immortale con incredibile ardore; come
ardevo, o Signore, mio Dio, come ardevo di riprendere il volo verso di Te! e non
avvertivo che eri tu ad agire in me. La sapienza infatti , risiede presso di te».
L’amore alla sapienza ha un nome greco: filosofia. Purtroppo però vi sono
alcuni che usano questo nome per colorare e falsificare i loro errori. Ha ben ragione
l’apostolo Paolo quando ammonisce: «badate che nessuno vi inganni con i suoi raggiri, ispirati alla tradizione umana, secondo gli elementi del mondo e non secondo
Cristo» (Col. 2,8). Le parole di Cicerone lo infiammavano a cercare la vera sapienza
ma nel suo libro non c’era il nome di Cristo. Si propose allora (aveva 19 anni) di leggere le Sacre Scritture, ma gonfio di orgoglio, non riuscì a penetrarne il significato.
Incappò invece nella rete di uomini superbi e farneticanti, carnali e ciarlatani all’eccesso: i manichei, appartenenti alla setta fondata dal persiano Mani (216-277 d.C.).
Il principio che stava a fondamento di questa religione è l’opposizione eterna
tra il bene e il male, di cui è formata tutta la realtà, Dio e l’uomo compresi. Questi
due principi stanno sempre in guerra. I manichei negavano il Vecchio Testamento e
combattevano la Chiesa che imponeva la fede ai suoi fedeli.
Agostino si avvoltolò in quel fango d’abisso, e in quelle tenebre di errore, per
altri nove anni.
Di gradino in gradino raggiunsi il profondo degli inferi, affaticato, stanco, assetato di verità che non riuscivo a trovare. Mi confesso a Te, o Dio mio, che
hai avuto misericordia di me quando io ancora non ti conoscevo. Mi confesso
e riconosco che allora ti cercavo, non con l’intelligenza che tu mi hai donato e
che mi distingue dalle bestie, ma secondo l’appetito carnale. Tu infatti eri dentro di me, nel mio intimo, più di quanto non lo fossi io, e altamente al di sopra
della mia intelligenza (Le Confessioni, libro III pag. 93).
Già nel libro I de Le Confessioni, p. 22, aveva detto: «tu o Signore, ci hai fatto
per te e il nostro cuore è inquieto, finché non trova riposo in Te (inquietum est cor
nostrum donec requiescat in te, Domine)».
Intanto la madre, vedova casta e pia pregava e piangeva incessantemente; supplicava il Vescovo di Milano, Ambrogio, nutrito nella Chiesa ed esperto nelle Sacre
Scritture, ad incontrare il figlio.
38
Giuseppina Mammana
Il Vescovo si rifiutava e Monica insisteva, finché l’incontro avvenne, ma Agostino non era ben disposto, preso com’era dall’eresia manichea. E alle continue suppliche della madre che lo sollecitava ad altri incontri, il presule fiducioso e un po’
infastidito, rispondeva: “Suvvia, vai in pace! Non potrà mai essere che un figlio di
tante lacrime perisca!”.
Intanto Agostino continua ad occuparsi di cultura filosofica; scrive un trattato
sulla bellezza dal titolo La bellezza e la convenienza, andato perduto. Insegnava in
pubblico le cosiddette arti liberali (quelle del trivio - grammatica, dialettica e retorica - e quelle del quadrivio - aritmetica, geometria ,astronomia e musica), chiamate
così perché ad esse potevano accedere solo gli uomini liberi e venivano studiate dai
Romani, i quali ne attribuivano la paternità a Platone e Aristotele.
Lesse e comprese da solo il libro di Aristotele sulle categorie (il I libro dell’Organon). Con facilità leggeva, imparava e insegnava.
«Non esisterei, se tu, Dio mio, non fossi in me, perché da Te proviene ogni
cosa, in Te e per Te sono tutte le cose» (Le Confessioni, libro I, p. 23).
Nei Soliloqui Agostino dichiara lo scopo della sua ricerca: «io desidero conoscere Dio e l’anima (Deum et animam scire cupio)». La ricerca di sé e di Dio non si
svolge separatamente l’una dall’altra, ma consiste in una serrata analisi esistenziale
dell’io, della persona nella sua singolarità irripetibile e nella apertura a Dio.
Io stesso ero diventato per me un grosso problema, factus eram ipse mihi
magna quaestio e in tutta la sua opera cerca di chiarire il suo rapporto con Dio con
la concretezza di fatti, di sentimenti, di scelte di vita a volte difficili e dolorose , ma
sempre autonome e scaturite dalla sua interiorità. Agostino cerca la verità mediante
la sapienza, ma la magna quaestio rimane insoluta.
Per un uomo soggetto alla morte che si porta dietro la testimonianza dei suoi
peccati, non resta altro che invocare Dio, cercarlo e lodarlo con il rigore della
ragione e della fede, perché come dice il salmo: “loderanno il Signore coloro
che lo cercano”, infatti, coloro che lo cercano lo troveranno e quelli che lo
troveranno lo loderanno (crede ut intelligas , et intellige ut credas), cioè credi
per capire e capisci per credere (Le Confessioni, libro I p. 23).
Ma dove cercare Dio ? Se si cerca una cosa, è perché l’abbiamo posseduta,
poi perduta ed ora non ce la troviamo più, per questo la cerchiamo. Così avviene per
ricercare Dio. L’uomo cerca Dio, se lo cerca è perché l’ha posseduto, ma l’interesse
per le cose materiali glielo ha nascosto, glielo ha fatto dimenticare. Non andare fuori
di te, ritorna in te stesso, nell’interno dell’uomo abita la verità; e se troverai mutevole
la tua natura, trascendi anche te stesso. Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore
homine habitat veritas, et si tuam naturam mutabilem inveneris,trascende et te ipsum (De vera religione, 39, 72).
La verità, come ai tempi dei sofisti, era stata colpita a morte specialmente dallo scetticismo. Socrate aveva trovato il criterio della verità nella ragione umana con
La ricerca di sé come ricerca di Dio e dell’anima nel pensiero di S. Agostino
39
il concetto, mediante il quale, si poteva raggiungere la conoscenza universale della
realtà. Aveva posto l’uomo al centro della scienza e della sapienza. Al pensiero di
Socrate si erano riallacciati i sistemi filosofici di Platone e Aristotele. Ma il pirronismo e gli Accademici avevano assestato un duro colpo ai due geni della filosofia antica e Sant’Agostino sente di dover confutare lo scetticismo che lui interpreta come
teoria del dubbio universale. «Si può sbagliare e dubitare, seppure m’inganno, io
che m’inganno esisto (si fallor sum). Non si può ingannare chi non esiste: se dunque
m’inganno, per ciò stesso io sono» (La città di Dio, XI, 26).
Il principio nuovo della filosofia di Agostino è l’autocoscienza e l’interiorità
dell’uomo. Dobbiamo trovare la verità dentro noi stessi, perché il fatto stesso di cercarla dimostra che noi la possediamo come dono di Dio, ma ci trascende. La verità è
immutabile e perfetta e possiede totalmente se medesima, mentre noi siamo mutevoli
e imperfetti. La verità non può essere che Dio, il quale come vivida luce inonda la
nostra mente permettendole di apprendere (teoria dell’illuminazione).
Cristo, maestro interiore, Luce Verità e Vita, è artefice della capacità di apprendere.
Se il nostro pensiero è illuminato , significa che esso è la luce che si accende ad
un’altra luce. Il pensiero è la mia luce, ma non sono io l’origine del mio lume. I
lumi degli uomini si accendono e si affievoliscono, ora brillano e ora sembrano
spegnersi; la mia luce, come quella dei miei simili, non è dunque la luce. Per
conseguenza, la mia ragione, ogni individuale intelligenza e ragione creata, sono
testimonianza dell’esistenza della luce assoluta (Michele Federico Sciacca).2
Dio, verità assoluta, trascende l’uomo, non è mai pienamente posseduta
dall’uomo e rimane sempre un mistero che in questa vita non è dato svelare, ma
riconoscere e amare.
La scoperta della verità non è la conclusione di un procedimento logico-sillogistico e gnoseologico; è di natura intuitiva. Agostino non procede mai con sistematicità deduttiva: egli parte sempre dalla coscienza e dall’esperienza interiore. L’itinerario costante delle speculazioni agostiniane è questo: cogitatio, fides, intellectus,
pensiero che indaga sul contenuto della fede e prende coscienza della verità di essa.
Dio è Colui che è, l’ Essere Assoluto; è Verità, è Bellezza e Bontà; quindi Egli è anche il criterio in noi dell’estetica e della moralità.
Bisogna ritornare alla sua vita inquieta e passionale, ai suoi incontri, alle sue amicizie e alla sua sapienza, per capire come avvenne la sua conversione al cristianesimo.
Insegnava a Tagaste. La morte di un giovane amico lo addolora profondamente
e fugge a Cartagine, dove il tempo e il conforto di altri amici sanano la profonda ferita.
Ma anche Cartagine gli diventa insopportabile e si trasferisce a Roma. Si am2
N. Abbagnano – G. Fornero, Protagonisti e Testi della Filosofia, vol. 1, Torino 1996, p. 533.
40
Giuseppina Mammana
mala gravemente di malaria. Sua madre non sa nulla, ma continua a piangere e a
pregare per lui.
I manichei lo aiutano nelle sue necessità, ma ormai, non ha più fiducia nella
loro religione. Durante la militanza nella loro setta, aveva accumulato molti dubbi,
ed ora se ne distacca.
Tuttavia, gli ostacoli al raggiungimento della verità si ripresentano con lo scetticismo, diffuso a Roma dagli accademici, i quali avevano affermato che bisogna
dubitare di tutto e avevano sentenziato che l’uomo non potrà mai raggiungere e
comprendere la verità.
«Ero diventato pigro nella ricerca di altre dottrine,specialmente non avevo più
fiducia di trovare la verità nella Chiesa Cattolica» (Le Confessioni, libro V, p. 74).
Lo attanagliava il problema del male; la sua domanda unde malum? non trovava una risposta soddisfacente. Vittima del materialismo, non riesce a risolvere né
il problema di Dio, né il problema del male.
Intanto, da Milano, allora capitale dell’Impero, avevano richiesto a Roma al
prefetto Simmaco un professore di retorica da inviare subito a spese dello Stato.
Così il prefetto Simmaco, dopo una prova di oratoria, lo inviò a Milano. Appena giunto a Milano, andò ad ossequiare il vescovo Ambrogio, uno tra i migliori,
conosciuto in tutto il mondo, celebre per la sua eloquenza.
Ambrogio era nato a Treviri, città fondata da Augusto, ai confini tra Germania
e Francia, dove il padre era prefetto. Appartenendo all’alta società romana, ricevette
un’ottima educazione letteraria greca e latina, intraprese il cursus honorum e a 34
anni era prefetto della Provincia di Emilia e Liguria, allorché, a furor di popolo, venne consacrato vescovo, a Milano il 7 dicembre del 373.
Quando Agostino arrivò a Milano (nel 384) aveva 30 anni. A Milano lo raggiungono la madre e la giovane donna cartaginese che amava e rispettava come
moglie insieme al figlio Adeodato.
La Chiesa di Milano era molto vivace, impegnata nel sociale e unita profondamente al suo vescovo Ambrogio. Agostino incomincia a frequentare il Circolo culturale, retto dal santo e colto prete Simpliciano e animato da uomini colti, aperti alla
filosofia neoplatonica. Si accosta alla Chiesa cattolica, sostenuto dalla predicazione
di Ambrogio, che lo aiuta a capire e a leggere le Scritture e le Lettere di S. Paolo,
aggiungendo alla lettura materiale anche quella spirituale allegorica. Il vescovo lo
accoglie con benevolenza come un padre e Agostino incomincia ad amarlo. Frequenta assiduamente le sue catechesi ed il piacere di ascoltarlo supera il suo desiderio
di apprendere. «Insieme alle parole che ascoltavo con piacere, scendevano nel mio
animo quelle parole, quegli argomenti verso i quali mi mostravo distratto» (Le Confessioni, libro V, p. 181).
La sua eloquenza, la serenità e la sicurezza della sua fede, lo affascinavano
e lo avvicinavano sempre più alla dottrina cattolica. Agostino si distaccò definitivamente dalla eresia manichea. Diventò catecumeno e nella notte tra il 24 e il 25
La ricerca di sé come ricerca di Dio e dell’anima nel pensiero di S. Agostino
41
aprile, durante la veglia pasquale del 387, ricevette il battesimo dalle mani del vescovo Ambrogio. Agostino ha sempre attribuito il radicale cambiamento, oltre che alla
grazia divina, al suo soggiorno milanese e al provvidenziale incontro con il vescovo
Ambrogio.
In realtà il vescovo Ambrogio non aveva molto tempo da dedicare all’illustre retore africano e certamente «non conosceva – dice Agostino – il groviglio dei miei travagli, né il pericolo che correvo di cadere in una fossa» (Le Confessioni, libro VI, p. 191).
I tre anni fra il 384 e il 387 trascorsi a Milano, furono decisivi per la sua conversione.
Insieme alla madre, al figlio e agli amici più cari si ritira in Brianza, a Cassiciaco, dove trova finalmente la serenità interiore. Trascorre le giornate pregando
e lavorando, studiando e discutendo sui massimi problemi della filosofia: la verità ,
la felicità e l’ordine. Chiede perdono al Signore delle sue passate iniquità e recita il
salmo (il 115) di ringraziamento a Dio Salvatore: «o Signore, io sono tuo servo, io
sono tuo servo e figlio della tua ancella. Hai spezzato le mie catene. A Te offrirò sacrifici di lode», e poi: «Padre, sia non come voglio io, ma come vuoi tu» (Mt 26,39).
Decide di dimettersi dal suo insegnamento, ma senza chiasso; è affetto da una
lesione polmonare; per l’eccessivo lavoro scolastico respira a fatica e accusa forti
dolori al petto. Del resto, egli dice: «non volevo che la mia lingua seguitasse a vendere chiacchiere e che gli alunni, invece di meditare la tua legge e cercare la tua pace,
apprendessero da me l’arte del mentire» (Le Confessioni, libro IX, p. 317).
Appena si libera dall’insegnamento, si dedica all’attività letteraria, messa ormai al servizio di Dio e scrive : i tre dialoghi avuti con i suoi amici : Contro gli accademici, La Vita beata, l’Ordine e quelli avuti con se stesso: I Soliloqui.
Insieme al figlio Adeodato, frutto del suo peccato, scrive un libro intitolato Il
Maestro. È un colloquio tra i due sul tema dell’insegnamento della verità.
Per Agostino la verità non può essere comunicata da un insegnante esterno,
ma dal maestro interiore, Cristo, che è la Verità. Adeodato aveva una straordinaria
intelligenza e a 16 anni era maturo per essere battezzato assieme al padre.
Dopo il battesimo, decide di tornare in Africa insieme alla madre, al figlio e
agli amici. Nella sosta ad Ostia Tiberina, Monica si ammala e muore a 56 anni.
Ma prima della morte madre e figlio godono insieme il momento sublime
dell’estasi: è la premessa della gioia del Paradiso.
Buona parte del IX libro è dedicata alla santa madre e scrive di lei ciò che di
più bello un figlio può scrivere di sua madre.
Agostino ha finalmente trovato se stesso e nelle coscienza scopre Dio come
Essere, Verità e Amore: come Padre, come Figlio e come Spirito Santo. Dio è Colui
che è, Essere Assoluto, Verità che si rivela come Logos, come Verbo in Cristo ed è
Amore, Spirito Santo. «Amare Dio significa amare l’Amore, ma non si può amare
l’Amore, se non si ama chi ama. Non è amore quello che non ama nessuno. L’uomo
perciò non può amare Dio, che è l’Amore, se non ama l’altro uomo. L’amore fraterno
42
Giuseppina Mammana
fra gli uomini non solo deriva da Dio, ma è Dio stesso» (Sulla Trinità VIII, 12).
«Dio è amore. Non ho dubbi, sono certo, o Signore: io ti amo. Hai folgorato
il mio cuore con la tua parola e io ti ho amato. Il cielo, la terra, e tutto ciò che in essi
si trova, ecco da ogni parte mi invitano ad amarti» (Le Confessioni, libro X, p. 370).
E allora chi è il mio Dio?
«Interrogai la terra, il mare, gli abissi e i rettili “che hanno anima vivente” (Genesi 1, 20) i venti e tutto il cielo con i suoi abitanti […] ho chiesto a tutti gli esseri che
mi circondano […] e a gran voce tutti in coro risposero: il tuo Dio ? È colui che ci ha
fatto» (Le Confessioni, libro X, p. 371). Infine Agostino si rivolge a se stesso e chiede:
tu chi sei ? Un uomo con corpo e un’anima, l’uno esterno, l’altra interiore.
A quale dei due dovrò chiedere dove è il mio Dio? Per mezzo del corpo l’ho
chiesto alla terra e al cielo, e tutte le cose in esse dicevano: non siamo noi il
tuo Dio oppure il tuo Dio è colui che ci ha fatto. Meglio interrogare ciò che
vive nel corpo: l’anima. A lei infatti giungevano tutte le risposte alle domande
del corpo, come a colei che presiede e giudica tutto quello che il cielo, la terra
e tutte le cose in esse dicevano. L’uomo interiore arriva alla conoscenza di
queste cose attraverso i sensi dell’uomo esteriore. Io uomo, “uomo interiore”,
ho conosciuto queste cose, io, si, proprio io, “anima” attraverso i sensi del mio
corpo (Le Confessioni, libro X, p. 371).
Solo gli uomini possono interrogare la magnificenza del creato, poiché come
dice l’Apostolo: «dalla creazione del mondo in poi , le perfezioni invisibili di Dio
possono essere contemplate con l’intelletto nelle opere da Lui compiute, come la sua
potenza e divinità» (Rm 1, 20). «Anima mia, tu sei la creatura migliore! Il tuo Dio,
Lui solo, è la vita della tua vita» (Le Confessioni, libro X, p. 373). Dio trascende la
sensibilità dei nostri sensi. Il pensiero è un tratto immanente, costitutivo dell’anima.
Conoscere perciò non è il platonico riconoscere, ma è essere illuminati dal
Verbo. Non è neanche l’intelletto agente aristotelico, che mediante un processo di
astrazione perviene alla conoscenza dell’essere, non ha quindi carattere gnoseologico e psicologico, ma carattere essenzialmente metafisico, legato al principio della
presenza di Dio e del divino in noi. L’uomo è una creatura che ha anima e corpo,
ma la cui essenza e natura propria è appunto l’anima razionale. L’uomo è un animale razionale, che si serve di un corpo mortale e terrestre. Come dire che la vita del
corpo è in funzione dell’anima, principio vivificante e spirituale, impresso da Dio ad
Adamo, nell’atto creativo.
Si avverte in questa concezione un dualismo di tipo platonico, ma solo in
parte, perché l’anima per Agostino è illuminata da Dio; la sua presenza trascendente
e misteriosa, vivifica il corpo e guida la mente nella conoscenza e nelle opere. È criterio di verità ed ha un carattere prettamente metafisico. È una sostanza tesa interiormente a quella verità e quei valori interiori che il Verbo le fa brillare dentro, vivente
com’è, essa non è inerte e indifferenziata: essa si articola in se stessa in una triplici-
La ricerca di sé come ricerca di Dio e dell’anima nel pensiero di S. Agostino
43
tà di funzioni-facoltà che ognuno può riconoscere come essere, pensiero e volontà
(esse – nosse – velle), cioè memoria, conoscere, amore. Essere ossia memoria, in
quanto il nostro essere è appunto la somma attuale di quanto l’anima è stata ed è, in
tutti i momenti successivi e in tutta la varietà del suo contenuto: l’anima è il presente
ontologico di tutto il suo passato. Conoscere in quanto l’anima è intelligenza, pensiero ed ha coscienza di sé e in sé delle cose. Volere o amore, in quanto è desiderio, è
attività ad un fine e può decidere e operare liberamente. Quindi l’uomo è, conosce e
ama proprio come Dio è essere, il Padre, intelligenza il Figlio e amore Spirito Santo,
perché Dio lo ha creato a sua immagine e somiglianza e cercando se stesso trova in
sé la trascendenza divina che lo chiama, lo illumina e lo ama.
L’intera esperienza della vita di Agostino ne è la testimonianza. Ed il corpo
non è la prigione dell’anima, ma il tempio dell’anima.
Ma l’essere umano con la sua volontà può volere e disvolere, può lasciarsi dominare dalle passioni, dall’egoismo, dall’orgoglio e dalla superbia; può allontanarsi
da Dio e usare la libertà per peccare.
La costituzione dell’uomo come immagine di Dio, se gli dà la possibilità di
rapportarsi a Lui, non gli garantisce la realizzazione necessaria di questa possibilità.
L’uomo è infatti in primo luogo l’uomo vecchio, l’uomo esteriore o carnale, che
nasce, cresce, invecchia e muore. Ma in secondo luogo può essere anche uomo nuovo
o spirituale, può rinascere spiritualmente e sottoporre l’anima alla legge divina.
Può indebolire e rompere il suo rapporto con Dio, e cadere nella menzogna
e nel peccato oppure vivere secondo lo spirito, rinsaldando il proprio rapporto col
Padre e prepararsi a partecipare alla sua stessa eternità.
Si Deus est, unde malum? Questa domanda Agostino se la poneva anche durante la sua militanza manichea, ma dopo la conversione, convinto che Dio è il bene,
afferma che il male non può essere stato creato da Lui.
Il problema si presentava arduo e drammatico, poiché è inconciliabile la realtà
del male con la bontà perfetta di Dio. Quindi, il male non deriva e non è stato creato
da Dio, Essere e Bene assoluto. Non ha una sostanzialità metafisica, è una rinuncia
all’Essere, ovvero una forma di non essere. La causa del male è il libero arbitrio della
nostra volontà.
Una cosa certa, sicura mi sollevava verso la tua luce: sapevo di avare una volontà come ero certo di avere una vita; infatti io vivevo. Ero certissimo che ero
io a volere o non volere una cosa, nessun altro poteva volere o non volere per
me; e sempre meglio comprendevo che la causa del peccato risiede nella mia
volontà. Solo l’uomo è capace di commettere il male (Le Confessioni, libro
VII, pp. 234-235).
Il male ha origine nella condizione ontologica della creatura, nella quale può
prevalere il defectus essendi che si ha quando vengono a mancare misura, forma e
ordine (modus, species et ordo).
44
Giuseppina Mammana
In questa condizione, si può sviare la stessa volontà libera dell’uomo: e nasce
così il male morale. L’anima, volgendosi ai beni di grado inferiore, anziché a Dio,
devia e decade. Quando al Bene supremo sostituiamo un bene inferiore a Lui – peggio poi se è inferiore a noi stessi – noi pecchiamo. Il male morale è dovuto al libero
arbitrio che, scegliendo fra i beni opera male la sua scelta: anche per le azioni vale
quanto per gli esseri: le azioni sono buone quando hanno misura, forma e ordine:
quando non sono in difetto rispetto alla perfezione. Da questo deviamento proviene a sua vota il male fisico, il dolore, l’inquietudine spirituale, l’ansia, gli squilibri
dell’organismo, le malattie.
Rispettare l’ordine dell’universo imposto da Dio, significa rispettare la sua
eterna legge ed operare secondo verità e amore per il bene.
Solo la grazia divina, dono sovrannaturale e imperscrutabile, salva l’uomo.
Dopo il peccato originale egli è decaduto ed ha perso la possibilità di essere partecipe
della natura divina. Solamente con la grazia è salvo, senza grazia è impotente e si perde.
La grazia è un dono gratuito di Dio. Nulla può infatti valere a meritarla, nulla
può costituire un diritto a riceverla. Ma anch’essa non può operare contro la nostra
volontà. Sussiste quindi il libero arbitrio per accettarla o rifiutarla. Il primo libero arbitrio (libertà minore) quello che fu dato ad Adamo consisteva nel “poter non peccare”. Perduta questa libertà per la colpa originaria che costringe l’uomo a “non poter
non peccare”, l’individuo può vincere il peccato solo mediante l’aiuto della grazia
divina, concessa in virtù dei meriti di Cristo.
Infine, l’ultima libertà che Dio darà come premio ai beati, è quella di non poter
peccare (libertà maggiore). Con questo dono divino l’uomo può liberarsi totalmente
dal peccato e dal male. È questa una possibilità fondata sulla grazia divina: «Dio
stesso è la nostra possibilità», dice Agostino (Soliloqui II, 1).
Posto che la grazia divina sia in ogni caso indispensabile per la salvezza, sorge una domanda: viene concessa a tutti indistintamente o solo ad alcuni? Agostino
risponde che tutti gli uomini costituiscono una “massa di dannati” e Dio concede a
tutti la grazia sufficiente alla salvezza, pur lasciando a tutti la possibilità di perdersi.
Solo gli “eletti”, che l’Onnipotente ha predestinato ab aeterno, si salvano.
È un mistero penetrare nell’eterno consiglio.
Lutero, monaco agostiniano, che riteneva implacabile la giustizia di Dio, affermava che solo con la fede e con la conoscenza delle Sacre Scritture, è possibile
ottenere la grazia misericordiosa della salvezza.
Calvino ha invece affermato – con la teoria della doppia predestinazione – che
Dio predestina alcuni alla salvezza ed altri alla perdizione.
Agostino appare più propenso ad affidare a Dio, più che all’uomo o alla cooperazione uomo-Dio, l’impresa della salvezza. In realtà, insieme alla conoscenza
delle Sacre Scritture, alla certezza della presenza di Dio in noi, c’è in Agostino una
fede immensa che rappresenta il porto sicuro che acquieta l’anima, dopo l’estenuante
ricerca di dare un senso alla sua vita.
La ricerca di sé come ricerca di Dio e dell’anima nel pensiero di S. Agostino
45
Alcuni critici parlano di ambiguità del suo pensiero e di contraddizioni.
Ma la lezione che ci lascia, consiste nell’incoraggiamento a cercare la nostra
identità con la ragione e con la fede; la fede ci aiuta a prendere coscienza della sacralità della vita ed a sperare che dopo la morte la nostra anima possa continuare a vivere alla luce del creatore. La Fede e la Ragione costituiscono come due ali per mezzo
delle quali lo spirito umano si eleva alla contemplazione della verità. Con questo
pensiero di innegabile bellezza, che ben esprime il sentire comune della Chiesa nei
secoli, il compianto Pontefice Giovanni Paolo II iniziava una delle più importanti
encicliche del suo lungo pontificato: Fides et Ratio.
L’Essere è eterno, ma il mondo creato dal Padre e dal Figlio è mutevole, pur
avendo in se le forme e le ragioni immutabili delle cose.
Chi può fermare – anche per un momento – il moto del tempo per contemplare lo splendore dell’eternità, che è sempre un continuo presente, e paragonarla con
il flusso ininterrotto del tempo? L’eternità è sempre un presente. Il tempo non può
mai avere un presente: il passato è sospinto via dal futuro, il futuro subentra sempre
al passato, e il passato e il futuro provengono sempre e si muovono in Colui che è
l’eterno presente (Le Confessioni, libro XI, p.459).
In realtà Dio è l’autore non solo di ciò che esiste nel tempo, ma del tempo stesso.
Prima della creazione non c’era tempo: non c’era dunque un prima e non ha
senso domandarsi che cosa facesse “allora”. L’eternità è al di sopra di ogni tempo: in
Dio nulla è passato e nulla è futuro, perché il suo essere è immutabile e l’immutabilità è un presente eterno in cui nulla trapassa.
Ma che è il tempo? In realtà è nulla di permanente. Il passato è tale perché non
è più, il futuro è tale perché non è ancora e, se il presente fosse sempre presente e
non trapassasse continuamente nel passato, non sarebbe tempo ma eternità. Eppure,
nonostante questa fuggevolezza del tempo, noi continuiamo a misurarlo, parlando di
tempo lungo e di tempo breve. In realtà, il tempo è una dimensione dell’anima che
conserva la memoria del passato, ha l’attenzione al presente che passa e l’attesa del
futuro nella continuità interiore della coscienza.
Non è esatto dire che esistono tre tempi. Sarebbe meglio dire: si, sono tre, ma
sono “il presente” del passato, “il presente” del presente e “il presente” del
futuro. Questi tre tempi sono nella mia mente, non li vedo altrove: il presente
del passato è la memoria, il presente del presente è lo sguardo, il vedere , il
presente del futuro è l’attesa (Le Confessioni, libro XI, p. 471).
Partito alla ricerca della realtà oggettiva del tempo, Agostino giunge invece
a chiarirne la soggettività. Ancora una volta il ripiegarsi della coscienza su stessa
appare come il metodo risolutivo di un problema fondamentale.
Nello spirito è la misura del tempo.
Ed io ho perso tempo nello studiare il tempo, del quale non conosco affatto
46
Giuseppina Mammana
l’ordine, e la mia mente, le viscere della mia anima, sono state lacerate dalla
molteplicità ossessiva dei suoi movimenti. Purificato da queste vicende e, liquefatto nel fuoco del tuo amore, attendo di confluire in te e riposare in pace
(Le Confessioni, libro XI, p. 488).
La riflessione di Agostino è volta al recupero del tempo nell’unità dell’anima,
che trattenendo i momenti del tempo (passato, presente e futuro) diventa imitazione
dell’eternità.
Il pensiero di Agostino è di grande attualità anche nel nostro tempo. La sua
vita e la sua filosofia sembrano particolarmente rispondenti alla tormentata sensibilità dell’uomo di oggi.
Fabio Cusimano
Il monachesimo benedettino. Origini, tradizioni e cultura
Ci troviamo al limite dell’Alto Medio Evo, agli inizi del VI secolo. In quel
periodo, a Nursia (l’odierna Norcia), un piccolo centro tra le montagne dei Monti
Sibillini, lo Spirito che ubi vult spirat soffia nell’anima di un uomo, per trasmettergli
un’idea che avrebbe segnato per sempre la storia; stiamo parlando di san Benedetto
da Norcia e del monachesimo nell’Europa occidentale.
Sull’argomento, di vastissima portata storica, religiosa, culturale, esistono decine e decine di studi, sia generali che particolari. Noi però ne metteremo in evidenza
solamente alcuni aspetti fondamentali.
Alcune caratteristiche della tradizione benedettina, che unisce l’Europa medievale da un capo all’altro, possono essere utili ad illuminare il cammino dell’umanità nel nuovo millennio. Infatti l’idea di san Benedetto, contenuta nella celeberrima
Regola,1 si sviluppa in un contesto storico quanto mai drammatico. Caduto l’Impero romano d’Occidente (476), l’ostrogoto Teodorico diviene il signore dell’Italia e
dell’Occidente, con il tacito assenso dell’imperatore bizantino Zenone. La successiva guerra gotica, protrattasi fino al 553 con la vittoria dell’esercito di Giustiniano
1
La Regola dell’Ordine di san Benedetto, o Regola benedettina (in latino denominata Regula
monachorum o Sancta Regula) viene composta da san Benedetto da Norcia intorno al 534. Essa consta
di 1 Prologo e di 73 capitoli. Al suo interno possiamo distinguere tre grandi partizioni:
– Prologo + capitoli 1/7: è preminente il carattere spirituale e i temi trattati sono essenzialmente quelli dell’ascesi individuale.
– Capitoli 8/66: vi si tratta di diversi istituti monastici: l’opus Dei – l’ufficio divino – e la
preghiera (capp. 8/20); il codice penitenziale (capp. 23/30); le varie attività della giornata
monastica (capp. 31/57); i responsabili preposti ad esse (capp. 21-2/63-6); l’accesso al
monastero e le forme di reclutamento (58/62); le mansioni del portinaio de monastero ed
esortazioni a leggere frequentemente la Regola (cap. 66).
– Capitoli 67/72: vi si propongono i fondamenti spirituali della prassi cenobitica; l’accento
viene posto sui rapporti orizzontali quelli che si stabiliscono tra i fratelli della comunità.
– Capitolo 73: è l’epilogo dove si dichiara che la Regola non è proposta come un ideale di
perfezione, ma solo come uno strumento per avvicinarsi a Dio ed è intesa principalmente
come una guida per chi comincia il suo cammino spirituale.
48
Fabio Cusimano
guidato dai generali Belisario e Narsete, provoca in Italia danni gravissimi. La società è attraversata da un diffuso sbandamento politico, carestie ed epidemie si susseguono. L’agricoltura è gravemente colpita dalle devastazioni degli opposti eserciti.
In questa drammatica situazione, un nuovo colpo alla sicurezza delle popolazioni
italiche viene, poi, dall’invasione longobarda (568).
Ora, in un momento di passaggio politico quanto mai cruciale, si sviluppa da
Subiaco l’istituzione monastica benedettina, che tanta fortuna avrà nella sua formula
così indovinata, tale da caratterizzare il Medio Evo europeo occidentale in maniera
assolutamente decisiva.
Desiderio di Dio
San Benedetto, nato a Norcia verso il 480, da famiglia nobile, sentendo in sé
la vocazione eremitica, si trasferisce a Subiaco, in una grotta, che ancora oggi è meta
di venerazione e di attrazione turistica, detta il Sacro Speco. Qui vive da eremita;
attratte dalla sua santità, alcune nobili famiglie romane gli inviano i propri figli, per
essere istruiti da lui. La cosa suscita, però, l’invidia del clero locale, che lo calunnia,
mentre alcuni suoi confratelli, contrari alla durezza della sua disciplina, tentano di
avvelenarlo. Si trasferisce, allora, a Montecassino, dove raduna, assieme alla sorella
santa Scolastica, una prima comunità di monaci di cui sarà abate.2 Qui compone la
celebre Regula monachorum, e qui muore il 21 marzo del 547.
È da notare che per quanto grande sia la figura di quest’uomo, altrettanto incerta è la sua storia: infatti non esistono biografie scritte da suoi contemporanei e la
prima testimonianza della sua vita è riportata da papa Gregorio Magno nel II libro
dei suoi Dialogi, scritti verso il 593-594.3
Abate: dall’ebraico abbà, cioè padre.
Unica fonte che ci faccia conoscere la vita di san Benedetto, il secondo libro dei Dialogi poggia sulla testimonianza di quattro abati, che Gregorio cita all’inizio dell’opera. Due di loro, Costantino e
Simplicio, sono i successori di san Benedetto a Montecassino. Un altro, Valentiniano, un tempo monaco
dello stesso monastero, è per lungo tempo superiore di una comunità romana costituita vicino al Laterano, residenza dei papi. Quanto all’ultimo, Onorato, è ancora vivo e dirige i monaci di Subiaco. Completato da altri due testimoni, questo gruppo d’informatori fornisce abbondante materia che il narratore
ordina a modo suo e costella di riflessioni spirituali spesso mirabili. Ma per leggere con profitto questa
vita, non bisogna cercarvi un ritratto individuale che mostri una personalità originale e un destino particolare. Ciò che interessa Gregorio e i suoi contemporanei non è questa fisionomia singolare dell’uomo
Benedetto, ma al contrario i tratti comuni che fanno di lui un santo ordinario, per così dire, un santo
di modello corrente, in tutto simile ai grandi uomini di Dio della Bibbia. Di questa figura dall’aspetto
biblico, uno dei tratti più evidenziati è il dono dei miracoli: è nella linea della Scrittura e dei vangeli che
i nostri padri nella fede credono volentieri a questi fatti straordinari, nei quali si manifesta la potenza
invisibile di Dio. Come l’insieme dei Dialogi, la Vita di Benedetto racconta ad ogni pagina qualche
2
3
Il monachesimo benedettino. Origini, tradizioni e cultura
49
La prima comunità benedettina è formata in grande maggioranza da laici che
desiderano perfezionarsi nella vita spirituale ed ascetica, e che per questo vivono
assieme nel monastero di Montecassino, secondo la Regola scritta per loro da san
Benedetto. Questa Regola riprende regole monastiche ed ascetiche della precedente
tradizione monastica, scritte soprattutto da san Pacomio e da san Basilio.
La prima esigenza dei monaci (quindi anche dei benedettini) è quella di distaccarsi dal mondo, che appare ai loro occhi violento, spesso sanguinario, infido,
in cui guerre, invasioni e congiure di palazzo sono all’ordine del giorno. C’è desiderio di pace, di sicurezza, e l’intuizione che solo la fuga dal mondo (il contemptus
mundi), non solo in senso spirituale, ma anche fisico, è l’unico modo per ritrovare
il rapporto con Dio e con il prossimo. Si forma, dunque, una comunità di laici (cenobio) che canta, loda il Signore, prega ad ore fisse della giornata, in cui è alternata
preghiera comunitaria e individuale.
Il desiderio di Dio si attua anche nella povertà personale, mettendo tutto in comune, e si attua nella fraternità, nella vita comune. Il quotidiano contatto dei monaci,
che rimangono stabilmente nel monastero in cui pronunciano i voti (fondamentale,
infatti, è il voto della stabilitas loci, uno dei pilastri del monachesimo cenobitico
benedettino), forma fra gli stessi confratelli un’unità spirituale che, sotto la direzione
dell’abate, da i suoi frutti anche dal punto di vista umano.
Infatti, soprattutto dopo Carlo Magno, lo sviluppo dei monasteri significa non
solo progresso spirituale e culturale, ma anche materiale, con l’estensione delle coltivazioni, lo sfruttamento dei boschi e dei corsi d’acqua.
La comunità monastica stimola al suo esterno l’economia locale, base dei secoli alto medievali. Ma il perno attorno a cui gira tutta la realtà del monastero è la
preghiera, una preghiera continua, che copre praticamente giorno e notte. Era ed
è questo il segreto che unisce i monaci nella vita cenobitica, e che si prolunga poi
nella meditazione, nelle veglie, nel magnifico canto gregoriano, nella lode e nell’intercessione perenne, incessante. Questa preghiera continua vuole rendere il cenobio
miracolo, ed è percorrendo questa collezione di prodigi che si scopre l’itinerario spirituale del santo.
La classica edizione dell’opera è la seguente: Gregorii Magni Dialogi libri IV, a cura di U. Moricca, Roma 1924. Ma si veda ora la nuova edizione: Gregorio Magno, Storie di santi e di diavoli (Dialoghi), vol. I (libri I-II), introd. e comm. di S. Pricoco, testo critico e trad. ital. di M. Simonetti, Milano
2005; vol. II (libri III-IV), testo critico e trad. ital. di M. Simonetti, comm. di S. Pricoco, Milano 2006.
I quattro libri in cui si articola l’opera di Gregorio Magno hanno differente estensione (il primo
è di gran lunga più breve degli altri) e struttura. Il primo ed il terzo libro comprendono miracoli relativi
a santi non particolarmente noti (nel primo libro si tratta esclusivamente di taumaturghi, mentre nel terzo la tipologia è più varia e differenziata). Il secondo libro è interamente dedicato alla figura e all’opera
di san Benedetto, costituendo in questo una delle più antiche testimonianze (anche se certo non sempre
attendibile, per la preponderanza dell’elemento prodigioso che la caratterizza) sul Santo da Norcia. Il
quarto libro, infine, si distacca vistosamente dai primi tre, in quanto non vi si tratta più di storie di santi
e di miracoli, ma del destino dell’anima dopo la morte.
50
Fabio Cusimano
benedettino, in tutte le sue espressioni ed i vari ordini che a quello si sono ispirati,
simile alla Gerusalemme celeste descritta nell’Apocalisse.
Il desiderio di Dio non si esprime, però, solo nello slancio di fede di tanti monaci. Esso è alimentato attraverso la lettura e la meditazione della Bibbia,4 ma anche
dei grandi classici latini, il che comporta la necessità d’istruirsi, di saper leggere e
scrivere in latino, per trasmettere, tramite l’attività di copiatura amanuense, la cultura latina e la spiritualità cristiana alle generazioni future.
Ogni monastero organizza, quindi, un luogo preposto all’attività di copiatura
amanuense (scriptorium), una scuola per insegnare ai monaci la lettura e la scrittura
del latino; tutto ciò concorre allo sviluppo delle biblioteche monastiche. Uno dei
compiti del monaco è quindi quello di trasmettere, attraverso questo lavoro faticoso di copiatura e di miniatura dei codici, l’amore per la Parola di Dio, di cui gli
Evangeliari, gli Antifonari e i Corali sono ancora oggi splendide e preziose testimonianze. La Bibbia, ma anche i grandi classici dell’antichità, sono passati attraverso
quelle migliaia di mani piene d’amore per la Parola di Dio e per le parole dell’uomo,
espresse in una cultura classica, che così è giunta fino a noi. Questa fede e questo
amore si sono espressi anche nel canto liturgico, nei salmi musicati, negli inni della
preghiera delle ore, di cui ancora oggi ammiriamo gli splendidi codici.
Il desiderio di preghiera e di approfondimento non è solo un fatto personale, ma
è soprattutto comunitario, ed è questa una delle caratteristiche che distinguono il monachesimo occidentale da quello orientale, tendenzialmente più solitario ed ascetico.
Preghiera, meditazione, riflessione, studio, approfondimento razionale e spirituale divengono una formula vincente non solo religiosa, ma anche culturale, capace
di resistere nel tempo, e che esprime geni del pensiero occidentale come sant’Anselmo e san Bernardo. Non c’è infatti divisione tra riflessione razionale e preghiera, fra
lettura della Bibbia e lettura dei grandi classici latini: la mente, illuminata da Dio per
mezzo della riflessione sulla Bibbia, è resa capace di illuminare anche la cultura profana e pagana in tutto ciò che ha di positivo, di assimilabile alla fede. Questa visione
unitaria, armonica, diventerà tipica del Medio Evo europeo; essa è anche molto distante dalla nostra visione del mondo, che distingue il piano razionale e culturale dal
piano religioso. Il rischio è quello di perdere di vista i punti di riferimento spirituali
per un solido sviluppo culturale e sociale.
Il lavoro manuale
Oltre alla preghiera, i monaci hanno il dovere di lavorare. Il monastero è infatti l’immagine perfetta della città di Dio, in cui ognuno è impegnato a sostenere tutta
4
R. Grégoire, Il monaco e la Bibbia, Abbazia San Benedetto, Seregno 2008.
Il monachesimo benedettino. Origini, tradizioni e cultura
51
la comunità. In passato, oltre al lavoro di copiatura dei codici, erano molto importanti soprattutto i lavori agricoli, di artigianato, di vettovagliamento a sostegno della
comunità monastica, il tutto sotto la tutela dell’abate.
Questo obbligo risponde a due esigenze. La prima è di carattere penitenziale:
nella società antica e alto medievale i lavori manuali sono svolte per lo più da schiavi
o da persone di basso rango, mentre i nobili normalmente non lavorano. Nel monastero benedettino, invece, tutti lavorano e si impegnano: all’interno della comunità,
infatti, non ci sono differenze di stato sociale o di provenienza. Viene poi soddisfatta
una seconda esigenza, quella di rendere il più possibile autonomo il monastero, viste
le condizioni di insicurezza esistenti fuori del monastero e le precarie condizioni
dell’economia di scambio che caratterizzano i secoli dell’alto Medio Evo. Se pensiamo che l’Europa occidentale, fino a circa l’XI secolo, subisce gli attacchi di Ungari
e Saraceni, e che ogni signore rurale difende a malapena durante questi momenti la
propria casa, possiamo immaginare quale sia il destino di molti monasteri e delle
popolazioni rurali, completamente prive di ogni protezione.
Il tipo di lavoro che coinvolge il monastero è soprattutto di carattere agricolo,
e questo comporta che i signori feudali donino porzioni dei loro territori ai monasteri, per permetterne il sostentamento. In cambio i monaci assicurano ai loro benefattori le loro preghiere e le loro messe, dopo la morte dei donatori stessi.
I lavori agricoli sono durissimi. L’unica forza motrice è quella di buoi o di animali da soma, mentre il grano può essere macinato, nella migliore delle ipotesi, nei
mulini ad acqua. La terra produce poco: l’aratro asimmetrico viene introdotto solo
dopo il Mille, come anche l’uso del cavallo per tirarlo, al posto del bue: fu modificato
anche l’attacco dell’animale dal collo al petto, con evidente sollievo per l’animale e
con rendimento maggiore della produzione agricola.
I monasteri, cellule sociali autarchiche, sono quindi centri di lavoro locale,
vere e proprie aziende agricole e artigianali, le cui rendite terriere sono a volte veramente notevoli. Così il lavoro è parte integrante del monastero, ed i monaci e i
conversi, loro aiutanti, si impegnano nel lavoro come parte integrante della loro vita
claustrale. Dal momento che il lavoro entra nel cuore stesso della Regola, ed è posto
accanto alla preghiera con pari dignità, esso è innalzato a strumento di salvezza, di
purificazione, di santificazione. In tal senso, si trova forse qui, rispetto alla nostra
sensibilità, il punto più rivoluzionario e moderno della Regola benedettina: il lavoro
ha un legame indissolubile con la preghiera, e quest’idea contribuisce molto alla
grande diffusione dell’intuizione benedettina. Il lavoro è un mezzo di salvezza, da alternare con la preghiera, da vivere come una preghiera. In tal senso, cristianizzando
la realtà del lavoro, san Benedetto ha un’intuizione che produce effetti incalcolabili.
Tutte le attività umane infatti non sono accessorie, ma necessarie al conseguimento
della salvezza. Come i canti e i salmi recitati in coro sono l’aspetto laudativo della
vita dei cristiani-monaci, così il lavoro è l’aspetto faticoso, doloroso, penitenziale
della preghiera, ma non per questo meno nobile agli occhi di Dio.
52
Fabio Cusimano
Come si vede il messaggio è di sorprendente attualità: non viene messo il lavoro al di sopra di tutto, ma neanche si vive fuori della realtà e dell’impegno sociale.
San Benedetto tenta, con la sua Regola, di trovare un punto di equilibrio tra attività
e contemplazione.
L’ospitalità
Un altro degli aspetti del monastero era (e lo è tutt’oggi) il dovere di ospitalità. Queste imponenti costruzioni, fortificate ed edificate in luoghi isolati, sono dei
veri e propri punti di riferimento per i tanti disperati del Medio Evo: poveri, malati,
stranieri, pellegrini che tornano o si recano ai tanti santuari della cristianità. Ciò è
possibile proprio per la natura stessa della comunità cenobitica e del monastero,
dove autarchia, indipendenza sociale e capacità di ricezione sono presenti in un’unica struttura fisica, umana e spirituale. A tale scopo vengono istituite nei monasteri
alcune strutture apposite destinate ad ospiti, benefattori in visita, poveri e pellegrini.
È lo stesso abate ad avere il dovere di accogliere personalmente i pellegrini che, a
proprio rischio e pericolo, percorrono le strade verso i luoghi santi.
L’apertura alla hospitalitas si è conservata nei monasteri fino ai nostri giorni,
cosicché chi vuol passare qualche giornata di riposo e di spiritualità assieme ai monaci, può sempre attingere a momenti comuni di preghiera o di fraternità.
C’è l’esigenza spirituale di accogliere in quegli eremi sperduti persone di ogni
genere, di ogni estrazione sociale e di provenienza, per accoglierle nel cenobio come
fratelli. E in tempi difficili come quelli in cui nascono i monasteri benedettini, qualcuno che accolga le persone sbandate, sole o povere è veramente raro: l’accoglienza
di tutte le persone è il segno tangibile del distacco da se stessi per accogliere il Cristo
e mettersi alla sua sequela, la sequela Christi.
Le ondate monastiche
Un’altra caratteristica peculiare del monachesimo, sia occidentale che orientale, è quello di nascere in un luogo dove un santo o un asceta forma una piccola
comunità, per poi spostarsi, in cerca di solitudine, oppure in cerca di altri luoghi
da evangelizzare. Limitandoci al monachesimo occidentale, vediamo san Patrizio
che da Lerinum, vicino a Nizza, si porta in Irlanda e la evangelizza, fondando un
monastero nei pressi di Belfast. Il suo discepolo più importante, san Colombano,
dall’Irlanda si muove verso l’Europa continentale, per fondare nuovi monasteri ed
evangelizzare i popoli, spingendosi fino in Svizzera ed in Italia; qui fonda rispettivamente i monasteri di S. Gallo e di Bobbio. Anche una generazione dopo, san Boni-
Il monachesimo benedettino. Origini, tradizioni e cultura
53
facio e Willibrord evangelizzano le popolazioni tedesche fino quasi a spingersi verso
gli slavi. Questi ultimi saranno evangelizzati soprattutto dai santi Cirillo e Metodio,
e successivamente dai santi orientali Clemente di Ochrida e Gregorio Sinaita.
Da san Benedetto da Norcia si sviluppa un movimento monastico fortemente
caratterizzante per l’Europa occidentale, la cui diffusione ha riscontro in Oriente con
la Regola di san Teodoro Studita al Monte Athos, monastero fondato nel 963 dal
monaco Atanasio, e tuttora centro del monachesimo orientale.
La Regola benedettina viene ripresa a Cluny, dove il conte Guglielmo d’Aquitania fonda un monastero. I benedettini di Cluny, per essere liberi dalle influenze
del sistema feudale, che coinvolge anche le gerarchie della Chiesa, si pongono sotto
l’autorità diretta del papa. Essi mettono in evidenza l’importanza della liturgia e della preghiera continua e della povertà, dando il via di fatto alla “riforma gregoriana”.
Lo spirito cluniacense si diffonde in tutta l’Europa occidentale, ponendosi al centro
della vita della Chiesa nel X ed XI secolo. La centralità di questa esperienza è sottolineata dalla presenza sul soglio pontificio di monaci cluniacensi come Gregorio VII,
Urbano II, Pasquale II.
La ricerca di solitudine e di penitenza porta anche alla nascita di nuove forme
di vita contemplativa, sempre sul filone dell’esperienza di san Benedetto. Tali sono i
Vallombrosani di san Giovanni Gualberto, i Camaldolesi di san Romualdo e soprattutto i Certosini di san Bruno, fondatore della grande Chartreuse, presso Grenoble.
Egli si spinge fino alla Calabria, presso Squillace, dove fonda il celebre monastero di
Vivarium sotto la protezione dei Normanni.
I limiti del movimento sorto a Cluny si evidenziano soprattutto nella pretesa
di incarnare in un solo ordine monastico l’essenza del cristianesimo. Alla fine del XI
secolo sorge l’istituzione di Citeaux, con l’intento di recuperare l’equilibrio fra lavoro e preghiera, nell’amore fraterno. La Regola cistercense, scritta da Stefano Harding
e portata alla sua attuazione da S. Bernardo a Clairvaux, è definita nella Charta Caritatis. Anche i cistercensi conoscono una grandissima diffusione, e favoriscono, nel
periodo delle crociate, lo sviluppo degli ordini cavallereschi.
Ormai, però, la società è in rapida evoluzione, la civiltà comunale si sta sviluppando rapidamente. Il monachesimo benedettino entra in crisi. Il suo posto sarà
soppiantato dal grande messaggio di povertà e di nuova evangelicità veicolato dagli
ordini mendicanti e predicato da san Francesco e da san Domenico.
C’è un denominatore comune in tutte le varie espressioni della vita monastica,
che non è prerogativa esclusiva della Regola benedettina. Esso è anche uno dei tipi
fondamentali dell’esperienza cristiana, cioè quello della contemplazione. Questa caratteristica è molto seguita e sentita nei secoli centrali del Medio Evo (sec. IX-XII). Nel
Medio Evo, sia per le condizioni difficili della società ed a volte anche della Chiesa,
sia perché i papi stessi promuovono a volte riforme anche profonde (come quella gregoriana), la vita contemplativa è oggetto di desiderio spirituale per molti cristiani. Periodicamente singoli individui (soprattutto nobili non primogeniti, chierici o cavalieri),
54
Fabio Cusimano
mossi dallo Spirito, si ritirano da soli in preghiera e in penitenza in qualche montagna
o foresta isolata, impervia, o comunque distante dalle chiassose città. È l’esperienza
della fuga dal mondo, per ritrovare Dio nel silenzio, per rinnovare lo spirito nella purezza dei consigli evangelici. La fama di santità ed i prodigi che accompagnano la vita
dell’eremita attirano alcuni discepoli. Si forma una comunità che prega e, dovendo
provvedere al proprio sostentamento, lavora la terra o alleva animali domestici.
Bisogna tener conto che questa idea non è originale di san Benedetto, nel senso che il monachesimo ha origini orientali:5 il primo monaco di cui viene trasmessa
la vita è l’egiziano sant’Antonio Abate. Anche Pacomio e Basilio scrivono regole
monastiche. Lo scopo primo di queste regole è quello di dare indicazioni di massima sia alla solitudine degli asceti, sia alle comunità che si formano. La novità di
san Benedetto, rispetto al monachesimo orientale, è rappresentata dall’accento posto
sulla vita comune. I monaci hanno certo i loro momenti di solitudine, di preghiera e
di contatto singolo con Dio mediante l’obbligo della lettura della Bibbia. Però i momenti più importanti sono quelli della preghiera comunitaria, fatta ad ore stabilite
durante la giornata: questo è il punto fondamentale della Regola.
Grandezza e decadenza del monachesimo benedettino medievale
Essere monaci rappresenta, per i cristiani medievali, quasi uno status symbol,
la meta della perfezione cristiana. Molte famiglie cercano a tale scopo di dare come
oblati i propri figli al monastero, soprattutto se questi non possono rivendicare parte
dell’eredità paterna (i “cadetti”), spettante normalmente al primogenito. La teologia
stessa ha, lungo quasi tutto il Medio Evo, i suoi maggiori esponenti tra i monaci.
Anche il sistema feudale, tipico della mentalità medievale, distingue tre ordini
sociali: bellatores (guerrieri), laboratores (lavoratori), oratores (coloro che pregano, cioè i monaci). Ma proprio nel momento del maggior splendore si cominciano
a vedere segni di decadenza nel monachesimo occidentale. Le notevoli ricchezze
accumulate dai monasteri, le rendite materiali ed il potere che ne deriva rendono
insofferente la popolazione. Lo sviluppo della società comunale, lo spostamento
Il concetto di monachesimo Europeo proviene dal Medio Oriente; infatti l’ascetismo religioso
e la vita monastica non sono peculiari solo del Cristianesimo, ma rappresentano forme in cui l’anima
ha cercato in ogni tempo di tradurre la propria sete del divino. Nel IV secolo, in Egitto, in Palestina e in
Siria, sulla scia di Antonio il Grande e di altri Padri del deserto, si fecero sempre più numerosi coloro
che abbandonavano completamente il mondo per vivere nella solitudine (eremos, da cui il termine di
eremita, per indicare gli asceti viventi nel deserto) oppure per associarsi insieme in conventi o cenobi
(dal termine greco coinobios, indicante vita in comune), onde ricercare una comunione più intensa con
Dio ed innalzarsi verso la santità. In ambito cristiano, Antonio è considerato l’iniziatore della via eremitica e Pacomio di quella cenobitica.
5
Il monachesimo benedettino. Origini, tradizioni e cultura
55
dell’asse commerciale verso le città, lasciano spesso i monasteri fuori dalle grandi
vie di comunicazione. La popolazione si sposta verso le città, sviluppa il commercio
e l’artigianato, con il conseguente decadimento del sistema agrario curtense che caratterizza gran parte dell’Alto Medio Evo.
A livello spirituale, poi, i movimenti pauperistici, che predicano “dal basso” il
ritorno alla purezza evangelica ed alla primitiva povertà della Chiesa, si combinano
con il movimento “dall’alto”, che porta alla riforma di Gregorio VII e al tentativo
di riforma pauperistica di papa Pasquale II. C’è un’esigenza di ritorno alle origini
evangeliche della Chiesa, alla sua vita apostolica, fatta di predicazione e di povertà.
Bisogna anche dire che il monachesimo pretende ad un certo punto di incarnare
l’ideale cristiano, quando mai, nella storia della Chiesa un singolo movimento é
riuscito a riassumere in sé l’intera realtà cristiana.
La nascita degli ordini mendicanti, francescani e domenicani assesta il colpo
finale ad una crisi del monachesimo che ormai cova da tempo.
Alcuni Benedettini celebri…
Innanzitutto san Benedetto da Norcia e sua sorella santa Scolastica. Poi, a
dimostrazione dell’importanza raggiunta dal monachesimo benedettino nel Medio
Evo, ben nove papi “benedettini” si succedono sul soglio di Pietro:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Papa Bonifacio IV (608-615);
Papa Gregorio II (715-731);
Papa Pasquale I (817-824);
Papa Pasquale II (1050-1118);
Papa Gregorio VII (1073-1085);
Papa Vittore III (1086-1087);
Papa Urbano II(1088);
Papa Celestino V (1294);
Papa Clemente VI (1342-1352).
Di fondamentale importanza per la diffusione “europea” del monachesimo
benedettino in epoca Carolingia (IX secolo) è l’operato di Benedetto d’Aniane (750821); a volte definito “il secondo san Benedetto”, egli può essere considerato il vero
fondatore del monachesimo benedettino che, sebbene le tante modifiche subite nei
secoli, è giunto fino ai nostri giorni.
Altri personaggi:
– San Mauro Abate (IV secolo): è il principale discepolo di san Benedetto
56
Fabio Cusimano
–
–
–
–
–
da Norcia assieme a san Placido. Di lui poco si conosce, se non quello che
tramanda papa Gregorio Magno nei suoi Dialoghi.
Guido Monaco (991 ca. – 1033 ca.): è un importante teorico musicale ed è
considerato l’ideatore della moderna notazione musicale e del tetragramma, che rimpiazzano l’allora dominante notazione neumatica. Monaco
benedettino, cura l’insegnamento della musica nell’Abbazia di Pomposa,
sulla costa Adriatica vicino a Ferrara.
Costantino l’Africano (1020 – 1087): medico, letterato e monaco arabo.
Traduce dall’arabo al latino numerose opere che consentono all’Occidente
cristiano-latino di riscoprire alcuni classici del mondo greco e di apprezzare i progressi degli arabi nel campo della medicina. Entra nell’ordine
benedettino e termina la sua vita nell’abbazia di Monte Cassino ai tempi
in cui è abate Desiderio, futuro papa Vittore III.
Pietro Abelardo (1079 – 1142): filosofo, teologo e compositore francese.
È uno dei più importanti e famosi filosofi e pensatori del medioevo, precursore della Scolastica e fondatore del metodo logico. Intorno agli anni
Venti del XII secolo si ritira nell’Abbazia di Saint-Denis, dove diviene un
monaco benedettino. Per alcune sue idee viene considerato eretico dalla
Chiesa cattolica in base al Concilio Lateranense II del 1139.
Jean Mabillon (1632 – 1707): monaco francese della congregazione benedettina di San Mauro, si dedica agli studi storici e di erudizione ed è
considerato il fondatore della Paleografia e della Diplomatica. È ricordato
soprattutto per i sei libri del De re diplomatica (1681), ritenuta l’opera
fondativa della Paleografia e della Diplomatica moderna.
Dom Pérignon (1639 – 1715): monaco presso l’abbazia benedettina di
Moremont, all’età di trent’anni si sposta presso l’abbazia di Saint-Pierre
d’ Hautvillers, dove ricopre l’incarico di cellario fino alla sua morte, nel
1715. Qui si occupa delle proprietà terriere, dei prodotti coltivati e lavorati ed in particolar modo delle vigne, dei torchi e delle cantine. Grazie a
questo incarico, attorno ai quarant’anni, si ritiene abbia inventato (seppure l’affermazione appaia infondata) la bevanda che lo ha reso celebre: lo
Champagne...
Manuela Girgenti
Il concetto di giustizia nell’età antica e medievale
Il problema della giustizia, come anche quello del buon governo di uno Stato,
è presente nel pensiero filosofico sin dall’antichità, non tanto per l’esigenza, in nome
della comune umanità, di assicurare pari dignità ad ogni singolo individuo, quale che
sia la sua estrazione sociale o fede religiosa, ma quanto per sensibilizzare e orientare
il potere legislativo alla promulgazione di leggi che abbiano come fine ultimo il bene
comune e, soprattutto, la capacità di regolare e tenere a freno la contrastante molteplicità degli interessi e delle passioni individuali.
Per i greci solamente le leggi promulgate sotto i dettami della retta ragione,
in quanto rispondenti ad una etica universalmente condivisa, possono consentire la
crescita di una società e assicurarne il benessere. La Costituzione di uno Stato è infatti perfetta, secondo Crisippo, «se esprime la preminenza della moralità; la legge
è la retta ragione che comanda quello che si deve fare e vieta quello che non si deve
fare; educazione e saggezza sono requisiti indispensabili per ispirare l’organizzazione delle comunità umane e per perseguire concretamente la giustizia».1 Ma, spesso,
queste esigenze di moralità entravano in rotta di collisione con la realtà dei fatti,
«dove operavano personaggi senza scrupoli, magari abili nell’arte retorica e nella
manipolazione delle coscienze, ma spinti da scopi utilitari e di affermazione personale e non da spirito di servizio. È difficile pensare che uomini politici di tale natura
potessero garantire quelle esigenze di moralità di cui sopra si è detto: non a caso Diogene di Babilonia era certo di poter dire che un retore, anche se dotato di esperienza,
non potrà fare del bene alla patria se è digiuno di filosofia».2
Ora, se il diritto è un fenomeno sociale, in quanto non può esistere al di fuori
della società e una società può esistere e durare indefinitivamente nel tempo solo
quando in essa esista un sistema giuridico reale,3 le storture di un sistema giuridico o
G. Maglio, L’idea costituzionale nel medioevo, Verona 2006, pp. 10-11.
Ibid. Cfr. anche: Diogene di Babilonia, in R. Radice (a cura di), Stoici Antichi, Milano 1998,
frammento n.125, p. 1451.
3
G. Barberis, Il regno della libertà, Napoli 2003.
1
2
58
Manuela Girgenti
la consapevolezza di una giustizia ingiusta non ledono tanto il concetto del diritto in
sé, quanto il suo attuarsi e rivelarsi nel rapporto tra autorità e diritto e, in particolare,
nell’eterna e mai superata lotta tra le esigenze di libertà e di sviluppo della collettività in tutte le sue componenti sociali e gli opportunismi e gli interessi di quelle caste
o minoranze che occupano il potere in tutte le sue forme istituzionali.
Nulla esprime meglio dei vecchi detti proverbiali la sfiducia del popolo nei
confronti dello Stato, del diritto e delle istituzioni in genere. La certezza del diritto,
al di là delle mere dichiarazioni di principio, si traduce, spesso, nella parzialità del
diritto, dove di fatto ogni forma di egualitarismo o di assoluta imparzialità viene
calpestata. L’ingiustizia nella società, come è evidente , è dunque un problema antico. Già per i sofisti, «il giusto non è altro se non l’utile del più forte» e, in maniera
ancora più chiara, aggiungono «che ogni governo emana appunto le leggi conformi
al proprio utile».4 Trasimaco non ha dubbi nell’affermare che
ogni governo stabilisce le leggi in base al proprio utile; e una volta che le hanno stabilite proclamano ai sudditi che il proprio utile è giusto e puniscono chi
le trasgredisce come persona che viola le leggi e commette ingiustizia. Il giusto
è, dunque, l’interesse del potere costituito. Esso ha dalla sua la forza, tanto che
il giusto si identifica ovunque con l’interesse del più forte.5
E Ippia aggiunge che «la legge, che è tiranna degli uomini, forza contro la
natura molte cose»6 e, pertanto, ne deriva che non hanno senso le distinzioni che
dividono i cittadini di una città da quelli di un’altra, né le distinzioni che all’interno
delle singole città possono ulteriormente dividere cittadino da cittadino, mostrando,
nel contempo, un ideale cosmopolita ed ugualitario, che per la grecità era non solo
nuovissimo, ma rivoluzionario.7
Platone, poi, sull’onda dello sdegno per la notizia della condanna a morte di
Socrate non esitò ad ammettere in preda allo sconforto che «la giustizia consiste
essenzialmente nel giovare agli amici e danneggiare i nemici».8
Da questi giudizi non si discosta molto Erodoto, secondo il quale «la città
umana è cattiva e ingiusta per sua essenza e che in tutte le forme con le quali si presenta (monarchia, aristocrazia, democrazia) non rispecchia che una unica e identica
realtà: la realtà del potere dispotico».9
«Come non potrebbe essere così? – risponde Clinia all’Ateniese, quando nel
M. Untersteiner (a cura di), Sofisti. Testimonianze e frammenti, fasc. III, Firenze 1967, p. 35.
Platone, Repubblica, a cura di E. V. Maltese, Newton, Roma 2005, 338c.
6
Id., Protagora, a cura di G. Reale, Bompiani, Milano 2006, 337d.
7
G. Reale, I problemi del pensiero antico, vol. I, Milano 1972, p. 252.
8
Platone, Repubblica, cit., 334a.
9
A. Koyrè, Introduzione a Platone, Firenze 1973, p. 252.
4
5
Il concetto di giustizia nell’età antica e medievale
59
corso del dialogo gli chiede: forse, pensi, che quando una democrazia, o una qualsiasi altra costituzione, o un tiranno, risultino vittoriosi fisseranno di loro spontanea
volontà delle leggi che innanzitutto non mirino a nient’altro se non al vantaggio di
mantenere a se stessi il comando?».10 È un argomento sul quale, per Platone, occorre riflettere molto, poiché «in quello stato in cui la legge sia comandata e priva di
autorità, in quel luogo vedo che la rovina è imminente: laddove, invece, detenga il
potere assoluto sui governanti, e i governanti siano asserviti alla legge, intravedo la
salvezza, e tutti quei beni che gli dei affidarono agli stati».11
Bisogna, quindi, stare molto accorti nello scegliere gli uomini a cui affidare le
sorti dello Stato, poiché, «se si è giovani, irresponsabili e stolti non esiste natura d’anima mortale che possa mai reggere il supremo potere fra gli uomini»,12 ma, viceversa,
una città sarà ben governata «se i governanti saranno ricchi non di oro, ma della ricchezza che deve possedere l’uomo felice, ossia di una vita onesta e saggia. Ma – ribadisce ancora una volta – se le cariche pubbliche sono occupate da individui poveri
e affamati di proprietà privata, che pensano di dovere ricavare il proprio guadagno,
questa possibilità non potrà sussistere, in quanto il potere diventa oggetto di contesa e
una simile guerra intestina e civile manda in rovina loro e il resto della città».13
In realtà, fu proprio la condanna a morte di Socrate, “il migliore degli uomini e
il più sapiente”, che spinse Platone ad allontanarsi dalla politica; non solo, ma anche
a consigliare al filosofo «di evitare la strada per la piazza e di non conoscere né dove
si trova il tribunale, la sede del consiglio, né di alcun altro consesso della città»14 Ma
non era una strada né un consiglio praticabile. Platone si rese ben conto che il saggio
non poteva vivere isolato come un eremita o dedicarsi alla contemplazione senza
alcun rapporto con i suoi simili. Solamente gli animali possono vivere all’interno
di una foresta o in solitudine, ma non certamente l’uomo che è un essere sociale. E,
allora, come trasformare la città iniqua e ingiusta, riformandola in maniera tale che
le sue istituzioni, le sue leggi possano assicurare ad ogni cittadino il rispetto verso
il suo prossimo, il culto della virtù e l’amore per il sapere? La risposta per Platone è
semplice. Occorre uno Stato nel quale i suoi governanti si propongano di impartire
ai propri cittadini “una educazione permanente”, mediante la traccia delle leggi, imponendo che la condotta sia conforme ad esse e punendo, per raddrizzarlo, chi se ne
discosta.15 Ma c’è di più. Poiché tra politica e filosofia c’è una perfetta connessione,
Platone, Leggi, a cura di E. V. Maltese, Newton, Roma 2005, IV, 714d.
Ibid., 715d.
12
Ibid., III, 691c.
13
Id., Repubblica, cit., 521.
14
Platone, Teeteto, a cura di E. V. Maltese, Newton, Roma 2005, 173d.
15
M. Vagetti, Protagora, autore della Repubblica, in G. Casertano (a cura), Il Protagora di
Platone: struttura e problematiche, Napoli 2004, pp. 145-58.
10
11
60
Manuela Girgenti
in quanto la prima è l’arte dell’anima e la seconda è ciò che la cura,16 ne consegue
per Platone che solamente i filosofi potranno guidare al meglio uno Stato, in quanto
gli unici capaci di soffocare ogni vocazione totalizzante e di educare il popolo all’acquisizione della virtù e della felicità.
Non è abbastanza naturale o almeno ragionevole – sostiene Platone – che si
conferisca il potere a colui che sa distinguere il bene e il male, la verità e
l’errore, ciò che è reale e l’apparenza? Non è forse più ragionevole lasciare al
filosofo la direzione dell’educazione dei giovani, la selezione e la formazione
della classe dirigente, la scelta e l’educazione dei futuri governanti della città.
Il sapere ha forse meno diritto d’influenzare la direzione dei pubblici affari di
quanto ne abbia il coraggio, la ricchezza e il talento oratorio?17
Che, dunque, i filosofi debbano essere i governanti di uno Stato è l’idea di
fondo della Repubblica di Platone, ma successivamente, di fronte agli sviluppi storici della sua epoca e ad altre esperienze personali, Platone si rese conto che le idee
politiche da lui delineate nella Repubblica difficilmente avrebbero potuto trovare
pratica attuazione, poiché – a suo dire – molto spesso la struttura ontologica della
corporeità si oppone all’azione ordinatrice e razionale della divinità, consentendo,
così, il male e il disordine.
Infatti – sostiene Platone – in principio la divinità ha realizzato il cosmo
in modo più preciso; alla fine, invece, in modo più fiacco: causa di questo è
la sua parte corporea che vi è nella mescolanza, che è la proprietà congenita
della natura di un tempo, poiché partecipava di un grande disordine prima di
giungere all’ordine attuale. Tutto il bene di cui è provvisto lo possiede in virtù
di colui che lo ha escogitato: ma da quella sua condizione di un tempo riceve
tutte quante le difficoltà e i difetti che sono nel cielo, e le riproduce negli animali viventi.18
Poiché, dunque, la natura umana si oppone alla sapienza ordinatrice del Demiurgo, rendendo, così, utopistico il governo dei filosofi, Platone ripiega su un assetto politico-istituzionale che quanto meno sorga ad imitazione di quello ideale, ma,
soprattutto, capace di elaborare un sistema legislativo che garantisca la giusta misura
e che sia eticamente orientato al rispetto della volontà divina.
«Conoscere la giusta misura – scrive Platone – è proprio dei grandi legislatori»19
e «quando in un uomo si vengono a trovare la massima forza, unita all’intelligenza
Platone, Gorgia, a cura di G. Reale, Bombiani, Milano 2001, 464b.
A. Koyrè, Introduzione a Platone, cit., p. 69.
18
Platone, Politico, a cura di E. V. Maltese, Newton, Roma 2005, 273b-c.
19
Id, Leggi, cit., III, 691d.
16
17
Il concetto di giustizia nell’età antica e medievale
61
e alla saggezza, allora nascono la migliore forma di costituzione e le leggi migliori,
altrimenti non può nascere nulla di tutto questo».20 Ma c’è una difficoltà, a questo
punto, non certamente marginale. Per Platone, infatti, non tutti gli uomini possono
dedicarsi all’attività politica, «poiché la scienza che si occupi del potere che viene
esercitato sugli uomini è la più difficile e la più importante da procurarsi»,21 così
come tra mille o duemila persone è difficile trovare un individuo che eccella nel
giuoco degli scacchi. A questo punto, come rileva opportunamente il Ferrari, la logica conclusione è che, poiché «le costituzioni umane, sia monarchiche che democratiche, rischiano inevitabilmente di servire gli interessi di chi governa a scapito
dell’intera comunità, solamente un governo in cui il potere provenga dalla divinità,
e sia dunque eteronomo rispetto alla comunità umana, garantisce il raggiungimento
della felicità e del benessere collettivo».22
Ora, pur sorvolando sull’altalenante scelta di campo di Platone in merito alla
sua preferenza su un governo autonomo o eteronomo o sulla difficile possibilità di
potere imbattersi in “un uomo regale, sapiente ed assennato”, evento che considera assolutamente fondamentale per potere realizzare uno Stato quanto più possibile
perfetto, tanto che, sostiene, «anche se una legge comprendesse perfettamente ciò
che è migliore e nello stesso tempo più giusto per tutti, non sarebbe mai in grado di
dare gli ordini migliori senza la forza dell’uomo regale assennato»,23 un fatto appare
chiaro fra le sue tormentate riflessioni: conoscendo la natura umana, con la precisa
coscienza che gli ostacoli contro cui lotta sono insormontabili,24 sembra quasi seppellire ogni possibilità di buon governo o di un corpus giuridico che nasca sotto i
dettami della retta ragione. E con un pessimismo, neppure eccessivamente velato,
conclude: «in verità, le faccende umane non sono meritevoli di gran cura; tuttavia è
necessario occuparsi con passione di esse; il che non è facile».25
Anche Aristotele, pur mostrando, rispetto a Platone, una visione ben più pratica della società, non affronta in maniera chiara ed univoca il problema dell’ingiustizia e dell’intimo rapporto tra potere ed autorità. Ma di questo indubbiamente non
possiamo farcene una colpa. Nel V secolo, infatti, l’aspetto etico occupa una posizione centrale nel pensiero politico dei greci, tanto che
le leggi – rileva opportunamente Maglio – riflettono sostanzialmente precetti
morali e non emerge ancora l’individuazione del concetto di obbligatorietà
giuridica distinto dall’obbligatorietà che discende dall’imperativo etico. Anche
Ibid., IV, 712a.
Id., Politico, cit., 292d.
22
F. Ferrari (a cura di), I miti di Platone, Milano 2006, p. 189.
23
Platone, Politico, cit., 294a-b.
24
G. Colli, Platone politico, Milano 2007.
25
Platone, Leggi, cit., VII, 803b.
20
21
62
Manuela Girgenti
la distinzione a noi ben nota fra la nozione di diritto pubblico e quella di diritto
privato viene di fatto ignorata o comunque non tematizzata dalla riflessione
greca; è prevalente una visione unitaria della vita sociale dove il cittadino e
lo Stato non si contrappongono in separate sfere di competenza ma in sostanza si identificano in una visione organica. Quando pertanto riflettiamo sulla
presenza di un’idea costituzionale, quale principio regolativo dei rapporti fra
il cittadino e lo Stato, in Platone o in Aristotele, dobbiamo evitare l’errore
di pensare in termini giuridici: l’affermazione della centralità delle leggi non
significa ancora che la politeia, termine aristotelico che possiamo rendere con
costituzione vigente in una determinata polis, sia l’atto giuridico fondamentale
di un ordinamento tale da consentire dei meccanismi di controllo. È quest’ultima un’idea moderna, ancora lontana dalla cultura e dalla sensibilità dei greci
che conoscono un solo modo per opporsi alle leggi che appaiono ingiuste: il
rovesciamento del sistema politico che impone l’osservanza di quei precetti
contro la volontà dei cittadini, ossia il rovesciamento del regime dispotico. Si
tratta di una convinzione che il pensiero medievale farà propria.26
Infatti – sostiene lo Stagirita – «quando le costituzioni mirano all’interesse comune sono giuste in rapporto al giusto assoluto, quando, invece, mirano solo all’interesse personale dei capi sono sbagliate tutte e rappresentano una deviazione dalle
rette costituzioni».27
Il diritto, dunque, è inteso come il principio ordinatore della comunità statale e
la giustizia come determinazione di ciò che è giusto. Ad Aristotele, d’altra parte, non
interessa tanto indicare un sistema politico ideale, quanto di mettere a confronto aspetti
positivi e negativi delle costituzioni del suo tempo e, per quanto ci riguarda, individuare
la validità di un sistema legislativo capace di frenare gli egoismi di chi detiene il potere
e di far progredire ogni componente della comunità verso la felicità e il bene.
A tal fine si chiede: «è più conveniente essere governati dall’uomo migliore o
dalle leggi migliori?».28 Aristotele non ha alcun dubbio nell’affermare che una società può progredire verso il bene solamente quando è governata dalle leggi migliori,
perché la legge è immune dai sentimenti, non si piega ad interessi di parte e non muta
col mutare dei governanti.
«Ciò che non ha affatto – sostiene – l’elemento affettivo è meglio di quel che
lo ha per natura: ora la legge non possiede tale elemento, mentre ogni anima umana
lo ha necessariamente».29
A ulteriore sostegno di questa tesi aggiunge:
G. Maglio, L’idea costituzionale nel Medioevo, cit., p. 6.
Aristotele, Politica, a cura di R. Laurenti, Laterza, Roma-Bari 2002, I, 1253a.
28
Ibid., III, 1286a.
29
Ibid.
26
27
Il concetto di giustizia nell’età antica e medievale
63
la legge, data una conveniente istruzione, impone ai magistrati di giudicare
ed amministrare il resto secondo il parere più giusto; inoltre dà loro la possibilità di introdurre quell’emendamento che ad essi, dopo varie esperienze,
sia sembrato migliore dalle disposizioni stabilite. Quindi chi raccomanda il
governo della legge sembra raccomandare esclusivamente il governo di dio e
della ragione, mentre chi raccomanda il governo dell’uomo, v’aggiunge anche
quello della bestia, perché il capriccio è questa bestia e la passione sconvolge,
quando sono al potere anche gli uomini migliori. Perciò la legge è ragione
senza passione.30
È vero, la legge non ha passione; lex, dura lex recita un vecchio adagio; ma
Aristotele lascia insoluto il problema di fondo: se sono i governanti a stabilire le
leggi e se i magistrati possono apportare emendamenti ad esse, in base all’esperienza acquisita, quali garanzie hanno i cittadini in merito alla bontà del loro fine? Ma
ancora. Esiste un uomo, pur saggio, che non cede mai al capriccio, alla passione o,
in parole povere, ricco solo di ragione, ma povero di sentimenti? In tal caso, non
avremmo mai un uomo, ma un essere che di umano ha ben poco.
In merito a tale questione lo Stagirita non entra nel merito, ma si limita ad
aggirare il problema, prospettando due soluzioni che nella realtà non danno alcuna
garanzia alla comunità in merito all’imparzialità della legge e al rispetto della dignità
e libertà di ogni cittadino da parte dei governanti. Nella prima è dell’idea che sotto il
profilo giuridico ogni comunità faccia riferimento al diritto naturale, le cui consuetudini, essendo per tradizione condivise dalla società in cui si vive, appaiono indipendenti dal capriccio dei governanti e rispecchiano maggiormente gli interessi della
collettività. Come seconda alternativa non vede altra soluzione che quella di affidare
ad un uomo, universalmente riconosciuto come il più saggio, il compito di stilare un
ordinamento legislativo a cui tutti, governanti e cittadini, dovranno sottostare. Ma,
in particolare, nel merito, il concetto di fondo è quello di seguire la retta ragione e di
educare le giovani generazioni nel culto della tradizione, ma, soprattutto, a coltivare
la virtù; strumenti, questi ultimi, che certamente potrebbero contribuire a ridurre
al minimo il pericolo di scosse o sconvolgimenti politici e sociali. Fra l’altro, le
perplessità di Aristotele su tale argomento appaiono ancora più evidenti nell’Etica
Nicomachea, quando sostiene che
le cose moralmente belle e le cose giuste, intorno alle quali verte la politica,
hanno molta diversità ed instabilità […] ciascuno giudica bene le cose che conosce e di questo è buon giudice. Di conseguenza in ogni settore è buon giudice chi in esso si è acculturato, ed è buon giudice in assoluto chi si è acculturato
in ogni campo. Per questo il giovane non è un ascoltatore adatto delle lezioni
30
Ibid., 1287a.
64
Manuela Girgenti
di politica; egli, infatti, è inesperto delle azioni della vita, ed i ragionamenti di
questa scienza procedono da queste e vertono intorno a queste. Inoltre, essendo incline a seguire le passioni, ascolterà invano ed inutilmente, poiché il fine
della politica non è la conoscenza, ma l’azione. E nulla importa che sia giovane
per età o giovanile di carattere, giacché il difetto non è dovuto al tempo, ma
ha la sua causa nel vivere secondo passione e nel perseguire qualunque tipo di
cosa si presenti. Per le persone di questo genere, infatti, la conoscenza è inutile,
come lo è per gli intemperanti.31
Per quanto concerne, infine, il concetto di giustizia, Aristotele appare lontano
anni luce dalla sensibilità moderna. Non solo sostiene la superiorità dell’uomo sulla
donna e, di conseguenza, giudica del tutto normale che il primo comandi e che l’altra, in quanto inferiore, venga comandata, ma giustifica a pieno titolo la schiavitù,
giudicando la subordinazione una necessità naturale, poiché è giusto che gli uomini
migliori, capaci di dominare gli istinti bestiali, abbiano a loro sottomessi quelli dotati
più di forza fisica e quindi idonei a servire come schiavi.
Comandare e essere comandato – sostiene Aristotele – non sono solo tra le
cose necessarie, ma anzi tra le giovevoli e certi esseri, subito dalla nascita,
sono distinti, parte a essere comandati, parte a comandare […] quindi quelli
che differiscono tra loro quanto l’anima dal corpo o l’uomo dalla bestia (e si
ritrovano in tale condizione coloro la cui attività si riduce all’impiego delle
forze fisiche ed è questo il meglio che se ne può trarre) costoro sono per natura
schiavi, e il meglio per essi è star soggetti a questa forma di autorità.32
Già nel mondo antico, dunque, molti filosofi, pur riconoscendo l’inadeguatezza
del loro sistema giuridico e della gestione del potere, più che mettere in luce i difetti del
loro sistema politico e giuridico, hanno preferito disegnare un loro modello politico,
descrivendo come – a loro modo di vedere – dovrebbe essere idealmente uno stato modello. La conclusione è stata che focalizzando la loro attenzione sulle utopie politicoistituzionali, hanno finito col trascurare le storture esistenti, consentendo nel tempo a
queste ultime di accreditarsi di legittimità e di rafforzarsi all’interno del tessuto sociale.
Sotto questo aspetto, la visione filosofica-politica di Epicuro è scevra da una
visione ottimistica della natura umana. Per quest’ultimo, gli uomini che si dedicano
alla politica sono mossi esclusivamente dal desiderio di potenza, ricchezza e gloria. Di
conseguenza, il diritto, le leggi e la giustizia non hanno come fine il benessere collettivo, ma unicamente il vantaggio di pochi. Epicuro, infatti, tiene a sottolineare che se lo
Stato avesse come fine ultimo l’affermazione dei valori morali e la tutela di ogni singolo uomo, ci troveremmo di fronte a un diritto universalmente valido per ogni popolo.
31
32
Aristotele, Etica Nicomachea, a cura di M. Zanatta, Bur, Milano 2002, 1194b-1195.
Id., Politica, cit., I, 1254a-b.
Il concetto di giustizia nell’età antica e medievale
65
«Nell’aspetto generico – scrive Epicuro – il diritto è uguale per tutti, perché è qualche cosa di utile nei rapporti socievoli; ma, per le particolari differenze dei vari luoghi e
d’ogni maniera di condizioni, ne consegue che non il medesimo è per tutti il diritto».33
«Ridicola giustizia – scriverà molti secoli dopo Pascal – limitata da un fiume!
Verità al di qua dei Pirenei, errore al di là […] Che c’è di più ridicolo di questo: che
un uomo abbia il diritto di uccidermi solo perché abita sull’altra riva e perché il suo
sovrano è in lite col mio, sebbene io non ne abbia alcuna con lui».34
La giustizia, di conseguenza, non ha una valenza universale, ma relativa, che
sembra avere principalmente come fine il raggiungimento dell’utile per una ristretta casta. Con una visione assolutamente rivoluzionaria, per i tempi, sono stati gli
stoici a coltivare una visione meta politica e universalistica del diritto. Vi è, infatti,
in questi ultimi, una maggiore attenzione al concetto di diritto naturale, sviluppato
in chiave razionalistica, nel senso che per loro «la legge umana non è altro che l’espressione di una legge naturale eterna, che nasce dal logos stesso che plasma tutte
le cose, il quale, in virtù della sua razionalità, stabilisce ciò che è bene e ciò che è
male e, dunque, impone obblighi e divieti».35
La simbiosi fra diritto naturale e retta ragione si traduce, così, in un diritto
universale, dove, affermando l’uguaglianza fra tutti gli uomini, non trova più giustificazione la distinzione fra nobili e plebei o fra uomini liberi e schiavi. L’idealismo
degli stoici, che affrontava il problema delle leggi e dello Stato in una prospettiva
essenzialmente etica, cozzava però contro una realtà nella quale «operavano personaggi senza scrupoli, magari abili nell’arte retorica e nella manipolazione delle
coscienze, ma spinti da scopi utilitari e di affermazione personale».36
In sintesi, il pensiero politico dello stoicismo trovava la sua radice nella centralità del concetto di diritto, un concetto che si diffonderà in ampi strati dell’elite intellettuale romana, da Seneca a Marco Aurelio, e in particolare in Cicerone, secondo il quale
la legge di natura, o legge della ragione, è eterna e immutabile e vale per tutti gli uomini
e tutte le latitudini. Solo la legge di natura, per Cicerone, incarna la giustizia ed è superiore a tutte le leggi umane positive.37 Ma se le leggi sono generalmente poste da chi
detiene il potere, da dove vengono le leggi cui dovrebbe obbedire lo stesso governante?
Il dilemma è solo apparente, poiché, sottolinea Bobbio, le risposte date dagli antichi
a questa domanda hanno messo in evidenza che «oltre alle leggi poste dai governanti
vi sono altre leggi che non dipendono dalla volontà dei governanti e sono o le leggi di
natura, derivate dalla stessa natura dell’uomo vivente in società, oppure le leggi la cui
Epicuro, Massime capitali, a cura di E. Bignone, Laterza, Roma-Bari 2007, n. 37.
B. Pascal, I pensieri, Milano 1966, pp. 294-295.
35
G. Reale, I problemi del pensiero antico, cit., p. 303.
36
G. Maglio, L’idea costituzionale nel Medioevo, cit., p. 11.
37
Cicerone, De legibus, Zanichelli, Bologna 1985.
33
34
66
Manuela Girgenti
forza vincolante deriva dall’essere radicate in una tradizione».38
Nella realtà, il concetto di una giustizia intesa come una qualità dell’anima
che, rispettata la comune utilità, accorda a ciascuno la sua dignità, pur affiorando
nell’antichità, come abbiamo già visto, in qualche pensatore illuminato, stentava
ad affermarsi. Il problema non era semplice, poiché occorreva distinguere tra chi
concepiva la legge non in sé, ma in riferimento ad altro, e tra coloro, invece, che
concepivano la legge in sé, considerandola solamente uno strumento di giustizia e di
progresso sociale. Sotto questo aspetto, ma sempre con le dovute cautele, un clima
nuovo sembrò potersi respirare a Roma nel periodo repubblicano, quando le decisioni delle assemblee della plebe vennero parificate a quelle dei più antichi ed aristocratici comizi curiati e centuriati, equiparando con ciò le leges ai plebiscita. «Questo
sistema di assemblee – rileva Maglio – rendeva di fatto possibile un vero e proprio
controllo popolare anche allo scopo di impedire che le supreme cariche dello Stato
romano superassero i confini della legalità, trasformandosi in organi autoritari».39
Ma, quando Roma cominciò ad allargare i suoi confini e di conseguenza si impose
la necessità di legiferare con immediatezza e senza vincoli formali, l’importanza
delle assemblee popolari diminuì sino a ridursi a un valore di carattere simbolico.
Spegnendosi la forza propulsiva del periodo repubblicano,
la concentrazione del potere nelle mani di una sola persona si tradusse anche
nella concentrazione delle fonti di produzione del diritto […] la lex diventa
sempre più espressione del volere dell’imperatore, figura ormai affrancata da
limiti giuridici e soggetta a deboli influenze politiche, anche per la decadenza
dell’autorità del Senato.40
Ora, seppure non si può negare che furono proprio le istituzioni romane a gettare le basi per lo sviluppo del pensiero politico e a vedere nell’ordinamento giuridico e, quindi, nel diritto la centralità dello Stato, dall’altro è pur vero che nella realtà
siamo ancora lontani da una comunità politica dove le ingiustizie e le disuguaglianze
sociali siano state debellate. Anzi, sia pure con una sommaria e superficiale lettura
della storia romana, appare vero il contrario.
Fu solo con l’affermarsi del cristianesimo che la dignità di ogni singolo individuo, in quanto creato da Dio, acquistò un valore assoluto e infinito. In tal senso,
oltre al discorso della montagna di Gesù, apparvero rivoluzionarie le parole di Paolo:
«non c’è più giudeo né greco; non c’è più schiavo né libero, non c’è più uomo né
donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù».41
N. Bobbio, Stato, governo, società, Torino 1985, p. 87.
G. Maglio, L’idea costituzionale nel Medioevo, cit., p. 14.
40
Ibid., pp. 16-17.
41
Paolo, Lettera ai Galati, a cura di D. Manetti - S. Zuffi, Mondadori, Milano 2006, 3, 28.
38
39
Il concetto di giustizia nell’età antica e medievale
67
Ma anche il cristianesimo, ad eccezione di alcune eccellenze o santità, nel momento in cui cominciò ad imporsi come potere politico, oltre che religioso, e quindi
a doversi rendere disponibile ai gravi compromessi cui l’esercizio della politica costringe la spiritualità, disilluse ben presto i suoi fedeli. Paolo, infatti, la più brillante
intelligenza politica del cristianesimo delle origini, dapprima lanciò un nuovo messaggio di amore e carità sociale, capace di fare breccia fra le masse di emarginati, ma
contemporaneamente si preoccupò di non urtare le istituzioni.
Ciascuno – scrive Paolo – stia sottomesso alle autorità costituite; perché non
c’è autorità se non da Dio e quelle che esistono sono stabilite da Dio. Quindi
chi si oppone all’autorità, si oppone all’ordine stabilito da Dio. E quelli che si
oppongono si attireranno addosso la condanna […] perciò è necessario stare
sottomessi.42
In sintesi, malgrado le parole di speranza in un mondo più umano, i cristiani
dovevano continuare a rassegnarsi ad essere servi o schiavi, a vedere calpestati i loro
diritti umani e a sopportare le ingiustizie. Anzi, che offrissero a Dio le loro sofferenze, le umiliazioni e i soprusi, perché Dio li ricompenserà nell’altra vita, quando
entreranno di diritto in un regno che non è di questo mondo.
La posizione di Agostino di Tagaste non si discosta molto da quella paolina.
Secondo quest’ultimo, infatti, la dipendenza di un uomo da un altro uomo e l’ingiustizia che riscontriamo spesso in questo mondo sono una conseguenza del peccato
originale e della natura corrotta di ogni singolo individuo. «Si deve capire – scrive
Agostino – che a buon diritto la condizione servile è stata imposta all’uomo peccatore […] Il Padrone di tutti dice: Chiunque commette peccato è schiavo del peccato;
per questo molti fedeli sono schiavi di padroni ingiusti ma non liberi perché ciascuno
è aggiudicato come schiavo a colui dal quale è stato vinto».43
Lo schiavo, dunque, accetti con rassegnazione il suo stato, offrendo a Dio le
sue pene nell’ottica di una sofferenza in un corso di cammino che lo eleverà moralmente e spiritualmente.
Perciò l’Apostolo consiglia anche che gli schiavi siano sottomessi ai loro padroni e che prestino loro servizio in coscienza con buona volontà. Così, se non
possono essere lasciati in libertà, essi stessi rendano libera la propria schiavitù,
non prestando servizio con perfida paura, ma con affetto leale perché abbia
fine l’ingiustizia e siano privati di significato la supremazia e il potere umano,
e Dio sia tutto in tutti.44
Ibid., Lettera ai Romani, 13, 1-6.
Agostino, La città di Dio, Città Nuova, Roma 2000, p. 1057.
44
Ibid., p. 1058.
42
43
68
Manuela Girgenti
Quella di Agostino appare come una politica sociale particolarmente anestetizzante. Se è la giustizia divina che ha diviso il mondo terreno fra padroni, schiavi
e servi, in seguito alla caduta del peccato originale e all’uomo peccatore, anche la
povertà, così, nell’ottica della morale cattolica svolge una funzione etica, poiché, senza il povero, il ricco non potrebbe guadagnarsi alcun merito. Ecco, quindi, il ruolo
privilegiato del povero all’interno della società. Quest’ultimo, simile al Cristo, pur
nelle sue quotidiane sofferenze, tiene in mano le chiavi del paradiso con le quali potrà
consentire al ricco, attraverso le elemosine, di guadagnarsi il regno celeste. Ma, nel
contempo, raccomanda ai sovrani, ai ricchi e ai potenti di non lasciarsi prendere dalla
brama del signoreggiare, «ma dal dovere di provvedere, non nell’orgoglio dell’imporsi, ma nella compassione del premunire».45 Quello che, dunque, deve prevalere in
ogni uomo, per Agostino, sia esso padrone o servo, è il senso della giustizia, che consiste nel dare a ciascuno il suo. Di un comportamento contrario, ogni uomo ne risponderà a Dio, che tutto vede e a tutto provvede. «Qualsiasi male si infligge dai potenti
ingiusti non è per i giusti pena di un delitto, ma prova della virtù. Quindi, la persona
onesta, anche se è schiava, è libera; il malvagio, anche se ha il potere, è schiavo e non
di un solo individuo, ma, che è più grave, di tanti padroni quante sono le passioni».46
Se manca la giustizia, se non viene rispettata dai governanti, che cosa sono gli
Stati – sostiene Agostino – se non delle grandi bande di ladri? Non sono forse anche
le bande dei briganti dei piccoli Stati?
È pur sempre un gruppo di individui che è retto dal comando di un capo, è
vincolato da un patto sociale e il bottino si divide secondo la legge della convenzione. Se la banda malvagia aumenta con l’aggiungersi di uomini perversi
tanto che possiede territori, stabilisce residenze, occupa città, sottomette popoli, assume più apertamente il nome di Stato che gli è accordato ormai nella
realtà dei fatti, non dalla diminuzione dell’ambizione di possedere, ma da una
maggiore sicurezza nell’impunità.47
A tal proposito, ricorda la risposta data ad Alessandro il Grande da un pirata
che era stato fatto prigioniero. Il re gli chiese che idea gli era venuta in testa per
infestare il mare. E il pirata con franca spavalderia: «la stessa che a te per infestare
il mondo intero; ma io sono considerato un pirata perché lo faccio con un piccolo
naviglio, tu un condottiero perché lo fai con una grande flotta».48 Ma se gli Stati non
assicurano la giustizia, se il succedersi degli imperi nel corso della storia si macchiano di atroci delitti contro l’umanità, come, ad esempio, l’impero romano, le cui con-
Ibid., p. 1056.
Ibid., p. 171.
47
Ibid.
48
Ibid.
45
46
Il concetto di giustizia nell’età antica e medievale
69
quiste non furono solamente una conseguenza del valore dei suoi soldati, ma anche
una politica senza scrupoli che non arretrava nemmeno davanti allo sterminio totale
di popolazioni pacifiche, come può alla lunga l’uomo continuare a nutrire fiducia
nella provvidenza divina? La risposta per Agostino è semplice. L’operare divino
nella storia trascende i nostri disegni e la provvidenza divina prevede e oltrepassa
le intenzioni degli uomini. Nella lotta tra il bene e il male, tra la civitas terrena e la
civitas Dei quel che veramente conta è il cammino verso la meta ultraterrena.
Quel che noi, in sintesi, chiamiamo progresso o divenire della storia non avviene a caso o ad opera di alcuni uomini, ma attraverso un processo diretto da Dio. In
questo senso la grandezza degli imperi è solo un aspetto transitorio, per cui, ad esempio, la vera grandezza della Roma imperiale fu quella di mantenere la pace sulla terra
come condizione per la diffusione del Vangelo. In questo senso, dunque, «il progresso non è altro che un interminabile pellegrinaggio verso un fine ultraterreno».49 Ma,
quel che è peggio in questa peregrinatio, che educa attraverso il dolore e che non
ci permette di potere cogliere il senso dello sviluppo voluto da Dio, è il concetto
agostiniano – a meno che non si preferisca il caos – della necessità di dovere spesso
ingannare il popolo per il suo bene e, soprattutto, di convincerlo che sia ragionevole
ciò che precedentemente era stato introdotto senza ragione. In poche parole, con un
machiavellismo ante litteram, che al disordine sociale sia preferibile l’ingiustizia.
Da un lato, quindi, un pensiero cristiano che fa appello ad una diversa concezione della vita e della storia dell’uomo, ma dall’altro per opportunismo politico lo
stesso pensiero si pone come garante, nei confronti del potere laico, di una stabilità
politica e sociale, attraverso un accecamento delle coscienze. Ma, da un lato, va pure
rilevato che il processo di divinizzazione del potere imperiale e, dall’altro, la progressiva affermazione del cristianesimo con la sostanziale svalutazione delle istituzioni
terrene, concorsero a marginalizzare la trattazione dei rapporti fra lo Stato e i cittadini.
Il cristianesimo dei primi secoli, infatti, animato dall’ansia ultraterrena e dalla
convinzione che il Regno di Dio non è di questo mondo, fu dell’idea che «la salvezza
dell’anima deve essere la vera occupazione del cristiano, perché la libertà vera non
può esistere nel tempo, ma solo nella comunione dei Santi».50 In attesa, dunque,
della venuta del Regno di Dio e per una sostanziale ripugnanza per le cose di questo
mondo, si registra nel pensiero cristiano, come naturale conseguenza, una sorta di distacco e di scarso interesse per il diritto. Sotto questo aspetto, appare più interessante
e ricco di stimoli speculativi, pur nella sua apparente semplicità, il pensiero ebraico
e, in particolare, quello maimonideo che, seppure volutamente ignorato, non mancò di influenzare grandi pensatori cristiani come, ad esempio, Tommaso d’Aquino.
Essenzialmente ottimista, l’ebraismo non vede nel mondo il male e non crede che la
49
50
K. Lowith, Significato e fine della storia, Milano 1972, p. 195.
G. Maglio, L’idea costituzionale nel medioevo, cit., p. 20.
70
Manuela Girgenti
vita sia gravata da una maledizione.
La vita, anzi, è bellissima e Dio vuole che l’uomo gioisca di tutte le cose belle
di cui la terra è piena (e Dio vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era cosa molto
buona, Genesi: 1,31). Né l’ebraismo ha mai considerato il corpo come cosa impura o
gli aspetti umani come radicati nel male (l’uomo farà lieta la moglie che ha sposato,
Deuteronomio: 24,5). Il corpo umano, ogni corpo umano, è il sacro vaso in cui si cela
una scintilla divina, l’anima, e come tale bisogna conservarlo in ottima salute. Nel
giudaismo, inoltre le distinzioni fra ebrei e non ebrei sono solo di ordine religioso e
non esistono distinzioni sociali o politiche. Bisogna, infatti, ricordare che, secondo
la religione ebraica, Israele è stato scelto per rivelare l’amore che Dio porta a tutta
l’umanità, ragion per cui l’uomo deve proporsi di allontanare da sé tutto ciò che
contrasta col volere di Dio e, nello stesso tempo, di consacrarsi al suo servizio, resistendo a tutti quegli impulsi che fanno dell’egoismo l’essenza della natura umana. In
poche parole: di obbedire a un’etica incentrata sul servizio del prossimo.
I precetti e le prescrizioni, presenti copiosamente nei testi sacri giudaici, non
servono solamente a coltivare e sviluppare le più elevate qualità umane, ma contengono una carica di dinamismo morale, capace di trasformare l’individuo e, per suo
tramite, la società di cui egli fa parte. A fondamento della morale troviamo, infatti,
l’equità e la giustizia, che deve estrinsecarsi nell’accettazione dei doveri, specialmente nei riguardi del povero, del debole, del derelitto, amico o nemico che fosse.
Un senso della giustizia che deve anche manifestarsi nella maniera di concepire i
beni terreni, poiché il loro possesso deve considerarsi non come un diritto naturale,
ma come un debito con Dio. Sotto questo aspetto, l’etica nel pensiero giudaico si manifesta, in contrasto con tutti i codici dell’antichità, in tutta la sua originalità, poiché
la Torah oppone alla difesa della proprietà il concetto di protezione della personalità.
«Il massimo della virtù umana – scrive Maimonide – sta nell’assimilarsi a
Dio secondo le possibilità dell’uomo, ossia nel rendere i nostri atti simili ai Suoi».51
Secondo il filosofo di Cordova, è solo attraverso l’azione etica che l’uomo può conoscere Dio e portare a compimento la missione per cui è stato creato: imitare e
assimilarsi a Dio. La religione ebraica è, dunque, «la religione dell’atto, dell’azione,
non la religione del dogma, della teoria».52
Ne deriva, così, che l’azione ricopre un ruolo superiore a quello svolto dalla
teologia con i suoi dogmi, poiché
conoscere Dio non vuol dire capirne intellettualmente l’essenza, ma seguirlo
nelle sue vie, fare quello che egli fa o che ordina che si faccia. Seguire Dio nelle sue vie presuppone, dunque, che l’uomo possegga un grande spessore morale e che la sua azione scaturisca da una volontà altamente etica. Conoscere Dio,
51
52
Maimonide, La guida dei perplessi, Utet, Torino 2003, p. 202.
D. Lattes, L’idea di Israele, Firenze 1999, p. 72.
Il concetto di giustizia nell’età antica e medievale
71
infatti, vuol dire adempiere al bene, amare Dio vuol dire amare gli uomini.53
L’azione presuppone, quindi, un atteggiamento etico dell’uomo, rivolto non
esclusivamente a Dio, ma a tutto il creato e, in particolar modo, agli uomini. La vera
conoscenza di Dio – afferma più volte Maimonide – è la conoscenza non del suo
essere, ma della sua attività: l’uomo può conoscere di Dio, in senso positivo, soltanto
quegli attributi che sono definibili come “attributi d’azione”, cioè il fatto che egli ama
gli uomini ed esercita giustizia verso di loro. La conoscenza di Dio, di conseguenza,
non isola l’uomo solamente nella contemplazione, ma lo spinge anche a tornare tra gli
uomini per vivere con loro e per insegnare loro la verità. Dio rappresenta il modello
delle azioni umane e l’uomo assume Dio come suo modello, quando, amandolo più
di ogni altra cosa, agisce nel mondo amando le sue creature e praticando la giustizia
verso di esse. È solo attraverso l’osservanza della Legge, animata dalla conoscenzaamore di Dio, che gli esseri umani possono contribuire all’attuazione di un’età in cui
il nome divino sarà riconosciuto da ogni popolo e da ogni individuo.
Ogni essere umano che agisce secondo carità ed equità nei confronti degli altri
uomini, innanzitutto coloro che gli sono prossimi, affretta – secondo Maimonide –
quell’era messianica che riguarderà, infine, tutta l’umanità. È chiaro, a questo punto,
che il problema fondamentale dell’ebraismo non è quale sia l’azione giusta né quale
sia l’intenzione giusta, ma quale è il modo di vivere giusto. Ne deriva che l’ebraismo
ha una visione integrale e individuale della vita dell’uomo, di maniera che la sfera
interiore non è mai distaccata dalle azioni.
Viceversa, la causa dell’insuccesso dell’etica nella vita individuale e sociale
deriva dal fatto che, mentre ammiriamo gli ideali, tralasciamo di procurarci i relativi
strumenti per raggiungerli. Per Maimonide, le mizvoth sono i veicoli, gli strumenti
con i quali avanziamo verso la realizzazione dei fini spirituali e dei valori. Le idee
si devono convertire in azioni, le intuizioni metafisiche in disegni per l’azione, i
principi più elevati devono essere rapportati alla condotta di tutti i giorni. La Legge
è, quindi, strumento propedeutico per il conseguimento di rette opinioni, in quanto
le opinioni non durano se non sono accompagnate da azioni che le fortificano e le
perpetuano nella massa.
Di conseguenza, la legge e i precetti non sono «una cosa vacua e senza fine
vantaggioso, e se a voi sembra che in uno dei precetti le cose stiano così, la manchevolezza sta nella vostra comprensione»54 e, pertanto,«il complesso dei precetti
ha necessariamente una causa ed è stato fissato in vista di una qualche utilità».55 La
Legge, dunque, è di per sé una forza pedagogica che conduce alla perfezione etica ed
Ibid., p. 59.
Maimonide, La guida dei perplessi, cit., p. 611.
55
Ibid., p. 612.
53
54
72
Manuela Girgenti
intellettuale e, quindi, un efficace strumento di educazione e di edificazione.
La Legge richiede, in quanto tale, di essere compresa ed apprezzata, obbedita
e messa in pratica. In particolare, Maimonide distingue nei precetti tre finalità: principi di utilità e giustizia sociale per il conseguimento di una collettività civile, principi di bontà e di amore del prossimo per lo sviluppo di una personalità etica e, infine,
principi di perfezione intellettuale per una vera conoscenza ed esperienza di Dio.
Per Maimonide, dunque, il perfezionamento materiale e il miglioramento del
livello della socialità sono indispensabili per il raggiungimento del livello ultimo della
perfezione spirituale, perché se non c’è una pace sociale, se non c’è una società ordinata e pacifica, l’individuo non può concentrasi e acquisire la conoscenza metafisica.
La riscoperta dei testi aristotelici, grazie ai commentari dei filosofi arabi e al
non indifferente apporto della filosofia ebraica, seppur guardati con sospetto dalla
Chiesa per il timore che il loro contenuto potesse contaminare il pensiero cristiano,
favorì una ripresa degli studi politici con una prospettiva più attenta al sociale rispetto al passato. In questa ottica, Tommaso D’Aquino, in particolare, cercò di cogliere
il rapporto determinante fra ragione umana e principi di diritto naturale, un rapporto,
fra l’altro, finalizzato alla ricerca di una armonia universale nella quale i due termini
di paragone, anziché entrare in conflitto, tendessero a coincidere. Sotto questo particolare aspetto, è innegabile che il pensiero di Tommaso non abbia subito l’influsso
di Aristotele, ma, come abbiamo già visto, anche quello di Maimonide.
D’altra parte non può essere diversamente, se consideriamo che l’aristotelismo napoletano, nel cui ambito si formò Tommaso D’Aquino è maimonideo, mentre quello parigino, dove nella maturità si sarebbe formato l’Aquinate, è averroista.
Basterebbe ricordare che Mosè da Salerno, il primo commentatore del capolavoro
filosofico di Maimonide, La guida dei perplessi, fu in rapporto con Pietro d’Irlanda,
domenicano, professore nello Studium di Napoli e maestro di Tommaso.
Come se non bastasse, l’Aquinate cita più volte Maimonide nei suoi scritti, nei
quali si trovano ben ventiquattro rimandi. In ogni caso, all’interno della teologia cristiana, è merito di Tommaso il tentativo di dare nuova dignità all’uomo cittadino, calato in un mondo che non necessariamente debba essere il regno del male; tutt’altro.
Tommaso, infatti, è dell’idea che la ricerca della felicità naturale, anche se imperfetta
e non una vera e propria beatitudine, possa essere un obiettivo non riprovevole.56
Ciò scaturisce dalla convinzione che la legge che regola l’universo è emanazione della volontà di Dio, che ordina ogni cosa in vista del meglio. Ora gli uomini,
in quanto forniti di ragione, partecipano dell’eterna legge divina, di cui quella naturale è il riflesso. La legge naturale, dunque, di per sé prescrive tutto ciò che giova a
conservare la vita dell’uomo e proibisce tutto ciò che va contro questo fine, per cui
Tommaso D’Aquino, Summa Theologiae, a cura di R. Coggi, ed. Studio Domenicano, Bologna 1996, I-II, q.5, a.3.
56
Il concetto di giustizia nell’età antica e medievale
73
«le sue prescrizioni sono finalizzate al bene comune […] essa prescrive di fare il
bene e di evitare il male; di non fare del male a coloro con i quali viviamo; di tendere
a una vita in cui si realizzi la natura razionale dell’uomo».57
Tommaso, però, non ignora che nell’uomo possano anche albergare bassi istinti
e che le passioni, la cupidigia o anche una semplice forma di egoismo possano allontanarlo dalle azioni virtuose, ostacolando, così, la sua visione teleologica, secondo la
quale la ragione e la volontà operano costantemente per realizzare nel mondo terreno
forme più perfezionate di convivenza e forme istituzionali, capaci di assicurare la
giustizia, la pace sociale e di garantire, quindi, la realizzazione della felicità terrena
dell’uomo. Gli Stati, il diritto e le leggi, in quest’ottica, servono proprio ad evitare che
le passioni o gli istinti più bassi dell’uomo possano prendere il sopravvento.
Lo Stato, quindi, non è, come per Agostino, un male inevitabile, conseguente
al peccato originale, ma una istituzione che rientra nei fini imperscrutabili di Dio.
Esso ha il compito di educare gli uomini alla virtù, di favorire la loro crescita spirituale e di orientare ogni loro singola azione verso il bene comune. La legge, di
conseguenza, è finalizzata non a vantaggio di un singolo o di pochi, ma all’utilità di
tutti i cittadini. Interviene, inoltre, per dare il giusto castigo a quanti ostacolano il
processo teleologico della realtà nella piena convinzione di una giustizia che deve
dare a ciascuno il suo. Ogni società – sostiene l’Aquinate – deve avere «un principio
unificatore, perché una massa di individui in cui ognuno pensasse a procurarsi ciò
che va bene per sé si sfalderebbe, se non ci fosse anche qualcuno che si interessasse
del bene della moltitudine».58 E più oltre aggiunge: «se colui che la governa la ordina comunque al bene di tutti avremo un governo retto e onesto […] al contrario se
il governo è ordinato non al bene comune della società, ma agli interessi privati di
colui che comanda, si attuerà un regime ingiusto e perverso».59
Compito dello Stato, in sintesi, è quello, non solo di assicurare ai cittadini una
sufficiente quantità di beni materiali, senza i quali non ci sarebbero condizioni di vita
serena, e di adoperarsi per un continuo miglioramento degli stessi, ma anche di educarli ad una vita virtuosa, finalizzata «ad un fine superiore che consiste nel godere di
Dio».60 Ma se un sovrano dovesse calpestare le leggi e più che al bene comune mostrasse di curare il proprio vantaggio, quale dovrebbe essere la reazione del popolo?
Qui la posizione dell’Aquinate risulta particolarmente ambigua.
Da un lato sostiene che la ribellione sarebbe giusta, ma dall’altro è del parere,
escludendo in ogni caso l’uccisione del despota, che sarebbe meglio non ribellarsi
al fine di evitare disordini sociali che potrebbero portare mali peggiori. In una tale
S. Petrucciani, Modelli di filosofia politica, Torino 2003, p. 69.
Tommaso D’Aquino, De regimine principum, in Opuscoli politici, a cura di L. Perotto, Bologna 1997, libro I, cap.1, pp. 32-33.
59
Ibid., libro I, cap. 2, p. 36.
60
Ibid., libro I, cap.15, pp. 93-94.
57
58
74
Manuela Girgenti
eventualità è preferibile rivolgersi a Dio e richiedere il suo intervento provvidenziale,
«perché Dio fa si che dopo la bufera che essi avranno scatenato sul popolo vengano
eliminati e ciò riporta la pace».61 In breve, Tommaso ripropone una teocrazia pontificia, giacché, pur distinguendo le due sfere (potere politico e potere religioso), nella
realtà, subordina il primo al secondo, se compito del sovrano è principalmente quello
di educare il popolo ad acquisire le virtù religiose in vista della beatitudine eterna.
Il sovrano deve, dunque, assicurare pace sociale, giustizia e mezzi sufficienti
per vivere, ma il tutto deve essere finalizzato ad un fine più alto che non è altro che la
beatitudine celeste. È inevitabile che con questi presupposti il potere politico venga
subordinato a quello religioso e che a buon diritto il pensiero dell’Aquinate possa
essere considerato come uno dei principali pilastri teoretici di una visione politica
teocratica. Malgrado nel suo pensiero non manchi una maggiore attenzione per i
problemi sociali in genere, è pur vero che l’idea di giustizia presente in Tommaso è
molto parziale, blanda e sotto certa aspetti strumentale.
Prevalendo la vox Dei, manca nell’Aquinate il concetto di indipendenza del
diritto. Silete theologi in munere alieno si affermava nei secoli passati per rivendicare al diritto la sua autonomia dal dogma religioso, «poiché ogni volontà che vuole
trasformarsi in diritto […] deve farsi procedura, passare al filtro di numerosi controlli, istituzionalizzarsi e, dunque, oggettivarsi. Fuori di ciò, nel sentimento spontaneo
o nella volontà di chicchessia, non c’è diritto, ma distruzione del diritto».62
Va inoltre rilevato, sempre in riferimento allo svolgersi del pensiero di Tommaso D’Aquino, che non sempre ciò che è ragionevole obbedisce a una istanza etica
universale. Spesso in nome della libertà e della giustizia si arriva a negare proprio la
libertà e la giustizia. Bisogna tenere presente che nella promulgazione di un codice
legislativo la valutazione di ciò che rientra nel concetto di libertà o di giustizia è sempre in riferimento a ciò che si presuppone sia collegato al contenuto del codice stesso.
Tutto ciò che resta fuori è eversione e, in quanto tale, degno di condanna e di pena.
Considerare, a tal proposito, più o meno legittimo un comportamento, in riferimento
ai precetti di un credo religioso, è un’idea che nasconde molte ambiguità e nega ogni
principio di libertà. L’Aquinate non si sognerà mai, infatti, di difendere i diritti delle
minoranze e, in particolare, quelli di chi dissente o non si allinea. Anzi, era dell’idea
che l’eretico meritasse di essere bruciato, così come per Bernardo di Chiaravalle uccidere un eretico non era un omicidio, ma un malificio, benedetto da Dio.
Il tentativo di fondare, in opposizione ad una teocrazia pontificia, una seria e
innovativa teoria della sovranità popolare si deve a Marsilio da Padova. Un tentativo
non facile per quest’ultimo, tenendo anche conto che le tendenze organiche ed unitarie dell’aristotelismo avevano enormemente contribuito a dare man forte alla nuova
61
62
Id., De regimine principum, in Opuscoli, cit., libro I, cap. 11, p. 78.
G. Zagrebelsky, Contro l’etica della verità, Roma-Bari 2008, p. 121.
Il concetto di giustizia nell’età antica e medievale
75
prassi dell’accentramento politico. In poche parole, avevano contribuito a rompere
l’empirico compromesso che, dal V all’XI secolo, aveva caratterizzato il potere temporale e quello religioso, tra cui vigeva una coesistenza pacifica, senza pretese di
dominio dell’uno sull’altro.
Era opinione largamente condivisa che ciascuno dei due poteri derivasse direttamente da Dio e che ognuno fosse indipendente dall’altro nella propria sfera. I testi
politici di Aristotele, come dicevamo, sollevarono la questione del primato tra i due poteri. Nella contesa, il Sommo Pontefice «riuscendo più tempestivamente ad affermare
la propria monarchia, e avendo a suo favore il privilegio della più alta natura spirituale
della propria funzione, conseguiva le prime vittorie e, da Gregorio VII a Bonifacio
VIII, fissava in una forma definitiva, la dottrina della teocrazia ecclesiastica».63
Una posizione, quest’ultima, che scaturiva dalla convinzione che se il papa ha
la potestas ligandi in caelo et terra, ne consegue che ha il potere di giudicare, non solo
sulle cose celesti e spirituali, ma anche sulle cose temporali. Ogni autorità imperiale nasce, di conseguenza, dalla delega del papa, che ha il potere di rimuovere ogni sovrano
che non si attiene alle sue direttive. È facilmente comprensibile che in un clima culturale e politico siffatto, nel quale la presenza e il controllo della Chiesa è soffocante, non ci
possa essere il minimo spazio per la libertà, la giustizia e il confronto dialettico. Contro
tali pretese si schierò in aperta e violenta polemica, come dicevamo, Marsilio Ficino, a
tal punto che, sebbene l’idea moderna di sovranità fosse estranea al mondo medievale,
pur tuttavia è in questo intellettuale che va ricercata la sua genesi.
Per il Ficino, infatti, la sovranità risiede solamente nel popolo, che non potrà
mai alienarla o, tutt’al più, delegarla a un governante supremo o a dei magistrati non
in senso assoluto, ma solo relativo. Il legislatore deve solamente preoccuparsi, nel
pieno rispetto della volontà popolare, di assicurare il bene comune, la pace, la concordia e la giustizia, senza subire alcuna influenza da parte delle strutture gerarchiche
della Chiesa. I governanti, in sintesi, nella loro azione politica sono legittimati solo
ed esclusivamente dal consenso del popolo in senso lato, poiché, secondo Ficino,
differenziandosi anche sotto questo aspetto dalla visione aristocratica di Aristotele,
anche le forze produttive della città dovevano entrare a far parte della Universitas
civium, a riprova «dell’importanza che il lavoro umano aveva assunto nella matura
civiltà medievale: un mondo del fare e dell’operare inserito a pieno titolo nella concezione dell’uomo e della società che si andava affermando».64 Conseguentemente
per il Ficino, con l’esclusione della casta sacerdotale, l’autorità di correggere e controllare i governanti tocca solamente ai cittadini e «ai fabbri, ai pellettieri e a tutti gli
altri che accudiscono alle arti meccaniche».65
G. De Ruggiero, La filosofia del cristianesimo, vol. III, Bari 1941, p. 222.
G. Maglio, L’idea costituzionale nel Medioevo, cit., p. 144.
65
Marsilio da Padova, Defensor minor, II, 7, a cura di C. Vasoli, Napoli 1975, p. 92.
63
64
76
Manuela Girgenti
Solo così, per il filosofo di Padova, all’interno di una società potrà essere assicurata la pace, la giustizia e il benessere, poiché le leggi che la guidano sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi che essa persegue nell’universale «giudizio
di quanto è giusto e civilmente vantaggioso e del suo opposto».66 Ma contro coloro
che ostacolano la società nel suo cammino verso il benessere generale, la legge deve
anche contenere un precetto coattivo e immediato.
Naturalmente non tute le leggi possono rispondere universalmente a norme di
giustizia (lex imperfecta), poiché
talvolta diventano legge conoscenze false di ciò che giusto e vantaggioso,
quando viene emanato un comando per la loro obbedienza, oppure quando
vengono fatte grazie al comando; così come è evidente nelle regioni di alcuni
popoli barbari che ritengono giusto che un omicida sia assolto completamente
dalla colpa e dalla punizione civile pagando un certo prezzo per un tale delitto, benché questo sia semplicemente ingiusto e, di conseguenza, le loro leggi
assolutamente imperfette.67
Ora, secondo Marsilio, una legge anche se imperfetta, priva di una condizione richiesta, cioè del vero e proprio ordinamento di ciò che è giusto, possedendo il
comando coattivo di obbedienza ad essa, richiede la sua osservanza. Spetterà alla
sovranità della Universitas civium attivare le procedure necessarie, affinché certe decisioni attinenti al bene comune possano essere abrogate o corrette. In ogni caso, la
legge può essere solamente disattesa, quando entra in contrasto con la legge divina,
poiché se l’imperatore comandasse alcunché di contrario alla legge della salvezza eterna, ossia all’esplicito precetto di Dio, in questo non si dovrebbe obbedire all’imperatore; e se il papa stabilisse alcunché secondo questa legge,
ossia la legge divina, sebbene non possa costringere nessuno nel mondo presente a obbedire alla legge divina, bisognerebbe obbedire a lui piuttosto che
all’imperatore.68
Marsilio, dunque, è per una netta divisione dei poteri. Al sovrano spetta quello
temporale, mentre al Papa solo ed esclusivamente quello spirituale. Alla chiesa, alla
casta sacerdotale bisogna solo guardare come guida spirituale e come modello nel
cammino verso Dio, poiché l’Universitas fidelium è la vera sponsa Christi e non la
gerarchia ecclesiastica. Il messaggio di Cristo – sostiene Marsilio – è stato unicamente di carattere spirituale; non si è mai arrogato il diritto di un potere coattivo contro coloro che contrastavano la sua volontà o che si opponevano contro il suo mesId., Il difensore della pace, I, cap.10, 3, Bur, Milano 2001, p. 103.
Ibid., p. 105.
68
Ibid., II, cap.V. 4, p. 375.
66
67
Il concetto di giustizia nell’età antica e medievale
77
saggio religioso.69 L’uso indiscriminato della scomunica, da parte dei vescovi, oltre
ad invadere i poteri dello Stato laico, rappresenta una grave lesione dei diritti civili di
ogni uomo, poiché ingiustamente lo esclude dalla Universitas civium, depredandolo
spesso delle sue proprietà e della sua stessa vita. Poiché, per Marsilio, è solamente
il governante, per concessione del legislatore, che ha giurisdizione su tutti i casi in
cui nella vita presente si ricorre ad una forma di costrizione, esercitando un giudizio
coattivo e infliggendo pene nella persona e nei beni; spetta a lui, di conseguenza, «la
facoltà di esercitare il proprio giudizio coattivo sugli eretici e su qualsiasi altro infedele o scismatico, nonché il potere di infliggere loro pene nella persona e nei beni».70
Ma ciò, per Marsilio, potrebbe essere poco opportuno, poiché tocca solamente
a un tribunale divino giudicare coloro che peccano contro la legge di Dio. Infatti,
«Cristo volle e stabilì che tutti i trasgressori della legge divina fossero giudicati con
giudizio coattivo e puniti solo nella vita futura e non in questa».71 Compito dei vescovi, dunque, «non è quello di ergersi a giudici, ma di insegnare, esortare, riprendere e
correggere coloro che peccano contro la legge divina e, in particolare, nell’atterrirli
con un giudizio che prevede la loro dannazione e la punizione che riceveranno nella
vita futura dell’unico giudice coattivo secondo la legge divina, ossia Cristo».72
Quantunque innovativa sul piano del costituzionalismo, della sovranità popolare e, quindi, della giustizia sociale, il pensiero di Marsilio Ficino resterà pressoché
inascoltato; anche perché
la realtà politica e sociale del tempo procedeva oramai, sia pure fra contrasti e
contraddizioni, verso forme assolutistiche e di potere personale, svincolate dal
controllo popolare; un panorama inadatto a cogliere la novità anticipatoria del
pensiero di Marsilio nella sua proclamazione, senza riserve, dell’autonomia
della città dell’uomo.73
G. Maglio, Autonomia della città dell’uomo e religione in Marsilio da Padova, Verona 2003.
Marsilio da Padova, Il difensore della pace, cit., II, X, 1, p. 495.
71
Ibid., p. 497.
72
Ibid.
73
G. Maglio, L’idea costituzionale nel Medioevo, cit., p. 161.
69
70
Giuseppe Allegro
Medioevo e teologia. Scienza e ricerca di Dio
Nei riguardi del Medioevo si sono compiute, nel lontano ma anche nel recente passato, operazioni culturali che, partendo da presupposti ideologici di diverso
orientamento, hanno di fatto ricercato in quei secoli la conferma dei propri assunti,
mediante il reperimento di prove testimoniali, documenti, fonti o mediante la loro
interpretazione forzata. Perciò deve continuare quel processo di abbattimento di una
serie di pregiudizi che ancora oggi, nonostante decenni di studi e di serie ricerche,
oscurano la comprensione della cosiddetta Età di mezzo. Il primo fra questi, come
rilevava a suo tempo, con una analisi ancora valida, De Lubac nel suo capolavoro
Esegesi Medievale,1 è «il luogo comune della ingenuità del Medioevo», un pregiudizio che sta alla radice di atteggiamenti «di disprezzo o di scherno verso gli uomini di
quel tempo», e che porta a considerare anche i più grandi medievali – con quel senso
di superiorità che contraddistingue chi si considera “moderno” – quasi come dei
“grandi bambini”. Un altro pregiudizio è il punto di vista “troppo finalista” che tende
a spiegare tutte le sintesi del passato con le nostre sintesi attuali, come se gli autori
del Medioevo fossero vissuti solo per preparare il terreno alla modernità, collegando,
come un ponte, l’antica età Classica al Rinascimento. Il terzo pregiudizio, che qui
ci interessa più da vicino, è quello “teologico”, per il quale il rapporto certamente
stretto fra Medioevo e teologia si trasforma, agli occhi sia degli estimatori che dei
denigratori di turno, in una identità (Medioevo è teologia), e legge il pensiero medievale come un insieme di dottrine non autonome, ma tutte sbilanciate sul versante
teologico. Da qui la lettura della filosofia come mera ancilla theologiae).
Rispetto a quest’ultimo punto, comincerò con il proporre un ripensamento
del tema bonaventuriano della reductio artium ad theologiam che apparentemente
sembra andare proprio nella direzione di una svalutazione delle scienze profane e
della esaltazione del ruolo della teologia, ma che invece, ad una attenta disamina,
apre prospettive diverse. A questo scopo possiamo fare riferimento all’analisi che ne
1
H. De Lubac, Esegesi medievale. I quattro sensi della Scrittura. Milano, Edizione Paoline Jaca Book 2006, 4 volumi (prima ed. francese a partire dal 1953).
80
Giuseppe Allegro
fa il saggio di Elisa Cuttini.2 Per l’autrice sono molteplici le sfumature di significato
e gli usi del termine reductio in Bonaventura. Se ci fermiamo alla lettura di Gilson
sembrerebbe che reductio debba essere quasi interpretato come resolutio, nel senso
che «ciò che è ricondotto non avrebbe valore in se stesso» e quindi deve essere
«necessariamente riportato al fondamento da cui dipenderebbe». In questo senso
anche le scienze dovrebbero essere ricondotte alla teologia perché venga messo in
luce che la loro vera funzione non sarebbe quella di conoscere le cose, ma Dio attraverso le cose.3 Nel De reductione artium ad Theologia sarebbe rappresentata allora
la «tendenza a considerare la filosofia esclusivamente come una particolare sezione
della teologia». Seguendo Gilson allora, dal punto di vista razionalista della filosofia
moderna la dottrina di san Bonaventura appare come la più medievale delle filosofie
del medioevo. Insomma, la filosofia non sarebbe coltivata per se stessa, ma solo in
funzione della teologia.4
Nella lettura della Cuttini invece il tema della riconduzione-riduzione di tutto
il sapere alla teologia, caro al pensatore francescano, non va interpretato né come
progetto di nullificazione del valore della conoscenza profana né come il progetto
dell’assorbimento (e asservimento) passivo della scienza e della filosofia agli interessi religiosi; esso testimonia bensì l’attestazione di un grande slancio unitario
di sintesi dei saperi, e anzi la consapevolezza del loro accrescimento di valore: «la
Scrittura rivela che le scienze sono portatrici degli insegnamenti divini, e perciò le
eleva a una dignità ancora maggiore rispetto a quella che esse hanno in quanto conoscenze di uno specifico settore della realtà. Il loro valore, lungi dall’essere “ridotto”,
è accresciuto».5 Si tratta quindi, come si vede, di una rilettura che muta sostanzialmente il tradizionale modo di vedere la percezione dei medievali del sapere profano.
Una controprova del fatto che i pensatori medievali non svalutano sempre e
comunque il sapere mondano in nome di quello sacro, come spesso si è tentati di
credere, ci può pervenire dalla lettura di alcuni testi di Ugo di san Vittore. Nel Didascalicon, opera che si occupa del tema dell’insegnamento e della trasmissione del
sapere, il teologo medievale dice: Omnia disce. Videbis postea nihil esse superfluum.
Coarctata scientia iucunda non est («Impara tutto, e poi ti renderai conto che nulla
è superfluo. Un sapere limitato non dà vera soddisfazione»).6 È interessante qui l’u-
2
E. Cuttini, Ritorno a Dio: filosofia, teologia, etica della mens nel pensiero di Bonaventura da
Bagnoregio, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino 2002.
3
E. Gilson, La philosophie de saint Bonaventure, Paris, Vrin 1924.
4
Per dirla con Nardi, i pensatori medievali opererebbero «la reductio artium ad theologiam che,
mentre redime e fa sua la cultura antica, ne segna il limite e l’utilizza al servizio della rivelazione» (B.
Nardi, Il pensiero pedagogico del Medioevo, Firenze 1956, p. VII).
5
E. Cuttini, Ritorno a Dio, cit., p. 73.
6
Ugo di San Vittore, Didascalicon 6,3, PL 176, 801A; tr. it. V. Liccaro, Milano, Rusconi
1987, p. 193.
Medioevo e teologia. Scienza e ricerca di Dio
81
so del verbo coarcare, che letteralmente significa comprimere, restringere, ma che
può indicare il soffocamento, lo strangolamento, mentre in senso figurato indica il
chiudere, l’imprigionare. Ma altrettanto significativo mi pare l’aggettivo iucunda.
La vera scienza è “gioconda”, gioiosa, porta con sé una intrinseca letizia che, come
traduce il curatore, “dà soddisfazione”. Affermazioni di questo tenore vanno sicuramente in direzione opposta a quelle di autori medievali - solitamente molto più citate
- che bollano il sapere mondano come vana curiositas.
Non si può trascurare inoltre l’attenzione profonda degli uomini dell’età di
mezzo per la cultura del passato, per ciò che può costituire una fonte preziosa per
il sapere: le cosiddette auctoritates. Siamo come «nani sulle spalle di giganti, così
che possiamo vedere più cose di loro e più lontane, non certo per l’altezza del nostro
corpo, ma perché siamo sollevati e portati in alto dalla statura dei giganti» (Bernardo
di Chartres, prima metà XII secolo).7 Qui emerge l’amore per la conoscenza (tutta
la conoscenza, nulla escluso) e l’interesse per la elaborazione di un sapere che tenga
conto di tutto la conoscenza trasmesso dal passato; sono del tutto coerenti con questa
impostazione mentale l’enciclopedismo, la nascita delle università, l’affermazione
del cosiddetto metodo scolastico, la riscoperta e la penetrazione di Aristotele nel
mondo latino, il dialogo interreligioso con il mondo islamico ed ebraico, la costruzione delle summae (vere e proprie “cattedrali di parole” rispetto alle cattedrali di
pietra, per dirla ancora con Gilson), tutti segnali precisi di una grande idea culturale
e filosofica: la preminenza assoluta accordata alla costruzione, organizzazione e trasmissione del sapere, nella convinzione di essere debitori nei confronti dei grandi
del passato (“nani sulle spalle dei giganti”, appunto) e delle loro acquisizioni (le
auctoritates), nonché di avere al contempo un debito altrettanto grande nei confronti
delle generazioni future: perciò le scholae, le università, gli amanuensi, l’attenzione
per l’erudizione e la pedagogia. È appena il caso di ricordare che senza il lavoro
dei copisti praticamente nulla del mondo classico ci sarebbe pervenuto. Ci può dare
un’idea della grande apertura mentale dei medievali nei confronti della sapienza
tutta e della necessità della sua trasmissione ai giovani studenti ancora l’importante
testo pedagogico del XII secolo, il Didascalicon di Ugo di San Vittore; in esso l’autore ammonisce il giovane a leggere tutto, a consultare ogni libro, a non ritenere di
poco conto nessuna scienza, nessuna disciplina, a pensare che non ci sia autore che
non abbia detto qualcosa di buono da imparare: Prudens lector omnes libenter audit, omnia legit; non scripturam, non personam, non doctrinam spernit […] Nullam
scientiam vilem teneas, quia omnis scientia bona est.8
Un discorso simile si può fare a proposito di un altro grande autore vissuto
7
Il passo ci è pervenuto attraverso Giovanni di Salisbury, Metalogicon 3,4, ed. C. Webb, Oxford, Clarendon Press 1929: Dicebat Bernardus Carnotensis nos esse quasi nanos gigantium humeris
insidentes, ut possimus plura eis et remotiora videre (p. 136).
8
Ugo di San Vittore, Didascalicon, cit., 3, 13, PL 176, 774BC.
82
Giuseppe Allegro
nel secolo successivo rispetto a Ugo, Alberto Magno. La sua lotta per affermare con
forza la dignità e l’autonomia della filosofia è innegabile, come testimoniano le sue
parole accorate contro chi nega valore alla ricerca filosofica. All’interno dell’ordine
domenicano, del quale Alberto faceva parte, era diffusa infatti in quel momento una
certa ostilità nei confronti della philosophia, a causa della sua origine e ispirazione
pagana. Nelle Costituzioni del 1228 si prescriveva perciò che i frati non si dovessero
dedicare alla lettura dei libri “dei pagani e dei filosofi” (in libris gentilium et philosophorum non studeant), sebbene fosse consentito loro studiare le scienze profane
previa una specifica dispensa.9 Pure nelle Vitae fratrum del cronista domenicano Geraldo di Frachet alcuni episodi condannano la curiositas filosofica. Ne cito due: a un
predicatore che voleva usare ragionamenti filosofici nei suoi sermoni appare Cristo
per ricordagli come la bellezza della Bibbia non abbia bisogno di essere alterata: «in
Inghilterra un frate aveva intenzione di abbellire la predica che doveva tenere a degli
studenti, con argomenti filosofici. Mentre in cella ci stava pensando, di addormentò
e vide in sogno il Signore Gesù che gli porgeva una Bibbia esternamente molto rovinata. Siccome il frate gli fece notare la cosa, Gesù l’aprì e, mostrandogli quanto fosse
bella all’interno, disse: – vedi che è molto bella, ma voi la rovinate con la vostra
filosofia». Il secondo episodio è ancora più istruttivo. Un frate lombardo, in dubbio
tra lo studio della filosofia e quello della teologia, vede in sogno una figura che tiene
in mano un interminabile elenco di uomini «dannati a causa della loro filosofia: «Un
frate lombardo era perplesso se dedicarsi allo studio della filosofia o della teologia.
Gli apparve in sogno un personaggio con in mano un rotolo, nel quale potè leggere i
nomi dei defunti dei quali si diceva che erano stati gravemente puniti. Ne domandò
la ragione e gli fu risposto: – A causa della loro filosofia –. Quel frate capì che era
meglio per lui studiare Teologia».10
Eppure, in questo contesto di diffusa ostilità verso il sapere profano Alberto
si assume il compito di rivendicare con forza la legittimità dell’indagine filosofica,
anche a costo di polemizzare persino con i suoi stessi confratelli. Egli anzi annuncia
con coraggio il suo progetto di “rendere intellegibile” Aristotele ai latini. Quasi in
risposta agli aneddoti delle Vitae fratrum, Tommaso di Cantimpré racconta che Alberto gli confidò come il diavolo gli fosse apparso un giorno a Parigi sotto l’aspetto
di un frate che intendeva dissuaderlo dallo studio.11 Fare uso della filosofia contro chi
9
Constitutiones Ordinis Praedicatorum II, 28: [Fratres] In libris gentilium et philosophorum
non studeant, etsi ad horam inspiciant. Seculares scientias non addiscant, nec etiam artes quas liberales vocant, nisi aliquando circa aliquos magister ordinis vel capitulum generale voluerit aliter dispensare; sed tantum libros theologicos tam iuvenes quam alii legant (Chart. 1, n. 57, p. 112).
10
Geraldo di Frachet, Vitae fratrum 20, pp. 208–9.
11
Tommaso di Cantimpré, Bonum universale de apibus, 2, 57, 34: Albertus Theologus, frater
ordinis Praedicatorum narravit mihi, quod Parisiis illi daemon in specie cujusdam fratris apparuit, ut
eum a studio revocaret (cit. in P. Mandonnet, Siger de Brabant et l’averroisme latin au XIIIe siècle 1,
Medioevo e teologia. Scienza e ricerca di Dio
83
si oppone alla fede non è quindi per Alberto affatto sconveniente. La filosofia non
è semplicemente propedeutica nei confronti della teologia, ma conserva un ruolo e
una dignità autonomi. Filosofia e teologia sono distinte e indipendenti ciascuna nel
proprio ambito, ma fra esse non vi è contrapposizione: la filosofia è una via aperta a
chi cerchi la verità «mediante un lavoro comune e fecondo», fondato sullo scambio
intellettuale. E tutto questo contro coloro che per la loro incapacità di comprendere
ne sanno vedere solo gli errori. Alberto si esprime al riguardo con appassionata durezza: «a conforto della loro incapacità, negli scritti degli altri non vanno cercando
che difetti […] tali esseri hanno ucciso Socrate e cacciato in esilio Platone. Nell’organismo della comunità scientifica essi sono ciò che nel corpo umano è il fegato.
Come la bile, che esce dal fegato, amareggia tutto il corpo, così anche nella vita
scientifica vi sono certi uomini acerbi e pieni di bile, che amareggiano e inaspriscono
la vita degli altri, rendendo loro impossibile il cercare la verità mediante un lavoro
comune e fecondo».12 L’ultima espressione suona, in latino, in dulcedine societatis:
il lavoro intellettuale non può essere svincolato dalla rete di relazioni, dal dialogo
costante, che lo rendono non solo proficuo ma anche “dolce”; la ricerca comune ha
la dimensione della dulcedo, un termine che riecheggia la iucunditas di Ugo.
Quanto finora emerso ci serve come indispensabile preludio al tema centrale
di questa relazione, che è la concezione della teologia medievale nel suo duplice
senso di scienza, cioè di conoscenza razionalmente fondata e argomentata di Dio, e
di ricerca, sempre in fieri e mai definitiva, di Dio. I due aspetti non devono essere
visti in opposizione, bensì come complementari. Se da una lato è vero che la teologia
si costruisce come una disciplina rigorosa che pretende di essere accreditata come
scienza, avendo quale oggetto di indagine nientemeno che Dio, dall’altra parte essa è
ricerca, indagine, proprio perché il suo punto di riferimento rimane il mistero divino,
che per sua natura è insondabile e inattingibile per la mente umana. Possiamo scorgere i due aspetti presentando brevemente alcuni altri testi emblematici.
Teologia e scienza. La costruzione del discorso su Dio
Sul tema della scientificità della teologica incontriamo Pietro Abelardo (10791142), autore di opere di riflessione teologica di grande profondità speculativa. Nel
prologo del Sic et Non Abelardo rivendica la dialetticità del sapere, affermando che
Institut supérieur de philosophie de l’université, Louvain 1911, p. 35).
12
Alberto Magno, Politica 8, 6, ed. Borgnet, pp. 803–804: Qui in communicatione studii sunt,
quod hepar in corpore: in omni autem corpore humor fellis est, qui evaporando totum amaricat corpus,
ita in studio semper sunt amarissimi et fellei viri, qui omnes alios convertunt in amaritudinem, nec
sinunt eos in dulcedine societatis quaerere veritatem).
84
Giuseppe Allegro
la prima chiave che apre le porte della sapienza è il “mettere in questione”: haec
quippe prima sapientiae clavis definitur assidua scilicet seu frequens interrogatio.
Dubitando quippe ad inquisitionem venimus; inquirendo veritatem percipimus. Iuxta
quod et Veritas ipsa: Quaerite, inquit, et inuenietis, pulsate et aperietur uobis.13
La pericope evangelica (Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate
e vi sarà aperto) viene interpretata da Abelardo, alla luce dello pseudo Agostino, in
questo modo: «“Chiedete pregando, cercate disputando, bussate domandando”, cioè
interrogando».14 L’arte del quaerere, del domandare, dell’interrogare, è l’arte dialettica; è questo uno dei significati più autentici, per il magister bretone, della dialetticità intrinseca al pensare. In questo senso ci guida la testimonianza di Cristo stesso
che, da assoluta verità e sapienza, per darci il giusto insegnamento non esitò a farsi
trovare in mezzo ai dottori del tempio nell’atto di interrogare, quasi fosse bisognoso
di chiedere, di fare egli stesso il percorso verso la sapienza. È questa, dunque, la via
per costruire il sapere, anche quello teologico.
La riflessione sul mistero trinitario condotta da Abelardo rappresenta uno dei
momenti decisivi nello sviluppo della teologia occidentale, intendendo con “teologia” un sapere contrassegnato da una strutturazione rigorosa e da una precisa procedura argomentativa, due caratteri che ne fanno un insegnamento distinto e autonomo rispetto a tutti gli altri ambiti della letteratura cristiana medievale fino ad allora
praticati.15 Questa tesi implica l’idea che bisognerebbe anticipare di più di mezzo
secolo la nascita della teologia quale disciplina “scientifica”, cosa che in genere,
nella tradizione critica e a livello manualistico, viene collocata nei primi decenni del
XIII secolo, nell’ambito della piena affermazione della scolastica e dopo la completa
ricezione dei nuovi testi aristotelici.
Non vi sono precedenti diretti, nella tradizione latina, dell’uso che fa Abelardo del titolo theologia per denotare un trattato sulla Trinità o, comunque, un’opera
riguardante i contenuti della fede cristiana. I termini usualmente utilizzati erano altri,
come sacra eruditio e divinitas. L’unico testo che annovera un titolo del genere, e
che Abelardo può avere conosciuto, è la Theologia mystica di Dionigi l’Areopagita, che a quell’epoca era stata tradotta in latino più volte. Non sorprende dunque il
fatto che un’opera di riflessione sui contenuti fondamentali della fede cristiana con
il titolo theologia suscitasse un senso di stupore e di diffidenza. Di fronte all’ultimo
trattato, la Theologia Scholarium è proprio la parola theologia a muovere il primo
interesse e, con esso, i primi sospetti. Guglielmo di Saint-Thierry non fa mistero
del fatto che era stato il titolo a destare la sua curiosità verso un testo al quale si era
13
103-104.
14
Pietro Abelardo, Sic et non ed. B. B. Boyer - R. McKeon, Chicago-London 1976- 1977, pp.
Ps.-Agostino, Tractatus de oratione et elemosyna “De misericordia”, PL 40, 1227.
Su questo tema Cfr. G. Allegro, Teologia e metodo in Pietro Abelardo, Palermo, Officina di
Studi Medievali 2010.
15
Medioevo e teologia. Scienza e ricerca di Dio
85
accostato, a suo dire, “per caso”.16 Quando esploderà lo scontro teologico incentrato
sull’elenco di proposizioni abelardiane incriminate, e si infiammeranno i toni della
polemica, l’atteggiamento di Bernardo di Chiaravalle verso questa novità del titolo
sarà di totale condanna. Le sue parole di scherno a questo proposito sono eloquenti:
Bernardo arriva a chiamare la teologia di Abelardo Stultilogia.17
Il termine theologia dunque rappresenta bene il profondo mutamento di prospettiva operato dal magister bretone rispetto alla tradizionale organizzazione del sapere sacro del suo tempo; la theologia si costituisce infatti come un peculiare sapere
che non rientra, propriamente, in nessuno dei generi della letteratura sacra fino a quel
momento praticati: non è annoverabile fra i commentari scritturistici, come i testi
esegetici; né fra le opere parenetiche e contemplative, come i testi a carattere spirituale e morale; non ha un taglio apologetico, come molti scritti di stampo dottrinale
coevi (opuscoli, libelli, sermoni, epistole); condivide con i testi dottrinali e con le
raccolte di sentenze dell’epoca, almeno in alcuni aspetti, il carattere argomentativo,
ma non si riduce a questo. Si tratta insomma di un sapere che riguarda essenzialmente il dato rivelato, e che si organizza sulla base di una impostazione razionale e di
un orientamento squisitamente teoretico; una sorta di inedita disciplina autonoma, la
quale fa trasparire una procedura rigorosa che, dopo avere tratteggiato l’intera articolazione del sapere sacro in un sistema organico e completo, procede allo svolgimento
dei propri contenuti secondo un percorso che vuole essere ordinato e completo. Questo percorso consiste nel porre anzitutto il dato rivelato, espresso nella sua sintesi più
contratta e al contempo più organica e completa (che Abelardo chiama summa fidei)
quale principio primo di discorso, inconfutabile e indimostrabile, alla stregua dei
primi principi assiomatici, e da qui procedere per via argomentativa e confutatoria,
mediante la predisposizione un lungo e articolato dibattito – di un insieme di quaestiones – nei cui passaggi fondamentali emerge dapprima l’insorgenza della serie
delle obiectiones e quindi la loro puntuale risoluzione.18
16
Casu nuper incidi in lectionem cuiusdem libelli hominis illius, cui titulus erat: Theologia
Petri Abaelardi. Fateor, curiosum me fecit titulus ad legendum (Guglielmo di Saint-Thierry, Opuscula
adversus Petrum Abaelardum, ed. Verdeyen, p. 13).
17
Denique in primo limine Theologiae, vel potius Stultilogiae suae (Bernardo di Chiaravalle,
Epistola 190, ed. Babolin, p. 116. L’ironia e il sarcasmo sono presenti tutte le volte che Bernardo si
riferisce ad Abelardo per qualificarlo come theologus. Che il problema qui sia il titolo theologia si
evince dalla stessa testimonianza di Abelardo, il quale ricorda a Bernardo il motivo della polemica: Dudum autem grauiter ingemuisse audieram, quod illus opus nostrum de sancta Trinitate, prout Dominus
concessit a nobis compositum, Theologiae intitulaueram nomine. Quod ipse tandem minime perferens
Stultilogiam magis quam Theologiam censuit appellandam (Pietro Abelardo, Epistola contra Bernhardum Abbatem, ed. Leclercq, p. 104).
18
Primum itaque ponendum est totius disputationis thema et summa fidei breuiter concludenda,
de unitate scilicet diuinae substantiae ac trinitate personarum quae in deo sunt, immo deus sunt unus.
Deinde obiectiones aduersus positionem fidei, tandem solutiones subiciemus (Petri Abaelardi Theo-
86
Giuseppe Allegro
La considerazione di questi elementi caratterizzanti l’opera teologica abelardiana, qui delineati in estrema sintesi, assieme alla semplice constatazione del
particolare interesse di Abelardo per la logica aristotelica, del quale egli stesso è
specialista ed interprete, autorizzano a pensare alla theologia abelardiana come a
una disciplina la cui strutturazione (il suo “statuto epistemologico”, si direbbe oggi)
ricorda assai da vicino alcuni connotati tipici della scienza aristotelicamente intesa; l’impostazione metodologica del nuovo “sapere sacro” può insomma in qualche
modo permettere un accostamento ai parametri della episteme teorizzata da Aristotele nei Secondi Analitici. Si tratta, in particolare, della procedura argomentativa
con la quale viene elaborata la conoscenza scientifica e, più specificamente, dei caratteri delle premesse sulle quali, aristotelicamente, essa si edifica: anteriorità, immediatezza, verità, indimostrabilità; caratteri che possono in qualche modo essere
ravvisabili anche nella concezione abelardiana della summa fidei e nel conseguente
procedimento argomentativo che procede, a partire da essa, a discutere e a confutare
le obiectiones. Criteri in qualche modo analoghi a quelli della scienza aristotelica,
che precedono di fatto un’impostazione che diverrà patrimonio acquisito e condiviso dalla comunità dei teologi e dei filosofi medievali solo più tardi, nella cosiddetta
“scolastica matura”.
Tuttavia una serie di considerazioni rendono problematico questo accostamento fra la concezione abelardiana del sapere teologico e quella aristotelica di scienza.
L’acquisizione dei nuovi testi logici di Aristotele – la cosiddetta logica nova, e in
particolare i Secondi Analitici – i quali resero disponibili agli autori medievali gli
strumenti concettuali che permisero di collocare il sapere teologico fra le conoscenze
di carattere scientifico avvenne qualche tempo dopo; ma su questo le ricerche non
hanno ancora raggiunto risultati certi e, ancor meno, definitivi. È possibile ipotizzare
che Abelardo abbia avuto modo di venire a contatto con tali opere aristoteliche o che,
almeno, ne abbia avuto una indiretta ma essenziale conoscenza mediata da un altro
autore suo contemporaneo? I dati sui quali basarsi per avanzare delle ipotesi convincenti non sono né chiari né univoci. Uno dei punti ancora problematici riguarda la
datazione. Non c’è consenso unanime circa il momento esatto nel quale furono effettuate le prime traduzioni in latino dei testi logici aristotelici non ancora conosciuti
all’Occidente latino. Né è ancora possibile determinare in quale preciso momento
essi cominciarono a essere letti e utilizzati dalla comunità scientifica di allora. Di
solito si tende a ritenere che le traduzioni aristoteliche siano posteriori, anche se di
poco, rispetto alla data della morte di Abelardo. Ma la questione rimane aperta.19
logia Summi boni, 2, 28, ed. E. M. Buytaert - C. J. Mews, in Petri Abaelardi Opera theologica III.
Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis 13, Turnholti 1987).
19
Sulla questione è utile consultare C. J. Mews, On Dating the Works of Peter Abelard, in «Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge» 52 (1985), pp. 73-134; S. Ebbesen, Echoes of
the Posterior Analytics in the Twelfth Century, in M. Lutz-Bachmann - A. Fidora - P. Antolic (eds.),
Medioevo e teologia. Scienza e ricerca di Dio
87
Teologia e mistica. incomprensibilità e ineffabilità di Dio
Lo stesso Abelardo, che elabora questo progetto di un nuovo sapere teologico,
ci presenta pagine dal significato inequivocabile circa la limitatezza della razionalità
umana nei riguardi del mistero divino. L’eccedenza del mistero trinitario rispetto ai
limiti della ragione umana è affermata da lui chiaramente e senza incertezze:20 non
vi è alcuna possibilità per la umana ragione, con le sole proprie forze, di rendere in
qualche modo comprensibile quegli enunciati. Essi sono appunto delle espressioni
di fede, e come tale sono fuori dalla possibilità della dimostrazione per via razionale. Abelardo non esita a ricorrere al celebre detto di Gregorio Magno secondo il
quale nec fides habet meritum, cui humana ratio praebet experimentum.21 Nessuno,
in questa vita, può accostarsi a una così elevata conoscenza (ad celsitudinem illam
intelligentiae acceditur, non quidem pervenitur, quamdiu scilicet in hac mortali carne vivitur).22 La visione di Dio è riservata solo alla futura beatitudine (ipsa quippe
visio divinitatis ipsa est futura beatitudo, de qua dicit apostolus: Nunc videmus per
speculum in enigmitate, tunc autem facie ad faciem). Se Dio stesso non si manifesta,
la nostra natura è incapace di vederlo (nisi enim seipse deus manifestet, nec tunc natura nostra eum videre sufficiet). Perciò i mortali, che non sono in grado neanche di
analizzare se stessi, né la natura di qualsiasi cosa, non debbono tentare di comprendere ciò che è incomprensibile attraverso i loro “piccoli ragionamenti”: nedum nunc
mortales[…] ratiunculis suis comprehendere incomprehensibilem nitantur, qui nec
seipsos nec quantulecumque naturam creature discutere ratione sufficiunt).
Oltretutto, la comprensibilità di Dio mediante le umane ratiunculae ed esprimibile con la lingua dei mortali sarebbe cosa assai sconveniente per la fede: Quae
etiam maior indignatio fidelibus habenda esset quam eum se habere deum profiteri
quem ratiuncula humana possit comprehendere aut mortalium lingua disserere?).
Rafforza queste convinzioni la raccolta delle testimonianze, come quella del Timeo,
molto nota ai latini: «È così difficile scoprire l’artefice e il padre dell’universo, quanto è impossibile parlarne degnamente, una volta che lo si sia scoperto», e quella tratta
dal commento di Macrobio al Sogno di Scipione di Cicerone: «egli non osò dire
Erkenntnis und Wissenschaft. Probleme der Epistemologie in der Philosophie des Mittelalters, Berlin
2004, pp. 69-92.
20
Tuttavia, questo non contraddice l’asserto abelardiano secondo il quale la rivelazione trinitaria raggiunge non solo gli ebrei, mediante l’intervento dei profeti, ma anche i gentili, che sono pervenuti
alla conoscenza della Trinità proprio grazie alla ragione (diuina inspiratio et per prophetas iudeis et
per philosophos gentibus dignata est reuelare: (Petri Abaelardi Theologia Summi boni, 1, 5, ed. cit.).
Sapere che Dio è Trinità, e non solo uno, non significa ancora, ovviamente, comprenderne pienamente
l’essenza.
21
Gregorio Magno, Homiliarum in Evangelia libri duo. Hom. 26, 1 (PL 76, 1197C).
22
Per questo e i passi successivi si veda Petri Abaelardi Theologia Summi boni, cit., 2, 11-24.
88
Giuseppe Allegro
cosa fosse Dio, poiché sapeva solo che agli uomini è impossibile sapere cosa sia».
Il richiamo al passo di Ambrosiaster, citato come agostiniano, in cui si afferma che
neanche i Cherubini e i Serafini possono comprendere pienamente cosa è Dio completa la chiosa abelardiana a Macrobio: «neppure gli stessi spiriti celesti, che sono
dotati di una sapienza più grande, possono conoscerlo pienamente». Sono, questi,
passaggi dal tenore apofatico, che richiamano alla mente i celebri testi dionisiani,
molto in auge in quel momento nell’Occidente latino. Ed è Dionigi l’Areopagita, che
Abelardo chiama magnus ille philosophus, ad essere evocato subito dopo, ancorché
solo per ricordare il famoso episodio del Dio ignoto descritto in At. 17, 23.
Il dogma trinitario, pur reso in qualche modo disponibile mediante la rigorosa
formulazione che la fides universalmente tenet incommutabiliter, rimane un mistero
ineffabile, di fronte al quale ogni tentativo di argomentare si riduce a un vano blaterare. Chi osa tentare di dipanare il mistero non si accorge che le sue apparentemente
elevate argomentazioni di fronte al mistero divino non sono altro che miseri ragionamenti, ratiunculae. Mediante le parole usate per indicare il mistero divino esso deve
essere, più che capito, gustato.
Pur essendo “scienza”, la teologia non potrà mai aspirare a comprendere appieno l’oggetto del suo discorso. Lo stesso Alberto Magno nel suo Commento alla
Teologia Mistica dello pseudo Dionigi mette in risalto il lato mistico della teologica.
Affrontando l’interpretazione della singolare tesi dionisiana secondo la quale è mediante il non vedere e il non conoscere che si può vedere e conoscere Dio (questione
XI).23 Alberto elenca tre modi possibili nei quali una cosa può essere “nota”: in se
stessa (per se), in quanto effetto di una causa (propter quid), in quanto causa di un
effetto (quia). Ebbene, nessuno dei tre modi suddetti può essere invocato efficacemente a proposito della conoscenza di Dio: Neque per se notus est sicut principia,
neque propter quid, quia non habet causam, neque quia, quia non habet effectum
proportionatum.24 Dio non è noto né in se stesso (per se), come lo sono i principi,
né in quanto effetto di qualcosa che lo produce (propter quid), poiché non ha causa
da cui possa derivare, né in quanto causa (quia), dal momento che non produce un
effetto a lui proporzionato. A lui non si può insomma pervenire in nessuno dei modi
naturali mediante i quali si acquisisce la conoscenza: in deo vacant omnes modi
cognoscendi naturales nobis, quibus scientias acquirimus. Resta allora il fatto che
la nostra mente può cogliere, al di sopra della sua natura, «una certa luce divina che
la eleva al di sopra di tutti i modi naturali di vedere le cose». È solo grazie a questa
23
«Noi preghiamo di trovarci in questa tenebra luminosissima e mediante la privazione della
vista e della conoscenza poter vedere e conoscere ciò che sta oltre la visione e la conoscenza con il
fatto stesso di non vedere e non conoscere» (Dionigi Areopagita, Teologia Mistica 2, tr. it. P. Scazzoso,
Milano, Rusconi 1981, p. 410).
24
Alberto Magno, Super mysticam theologiam Dionysii, ed. P. Simon, in Opera omnia […]
curavit Institutum Alberti Magni coloniense, vol. 37/2, Aschendorff, Münster i. Westf. 1978, p. 466.
Medioevo e teologia. Scienza e ricerca di Dio
89
luce divina che si può giungere alla visione di Dio; una visione tuttavia non distinta,
ma confusa (“non determinata”, in termini albertiani), la quale può permettere una
conoscenza di Dio non per se, ma solo quia, permette cioè di conoscerlo non in se
stesso ma in quanto causa di tutte le cose. L’intelletto creato non può raggiungere
perfettamente Dio, in una maniera tale cioè che nulla che riguardi la conoscenza
di lui rimanga fuori dell’intelletto. Ci si può unire a lui solo in maniera confusa e
indistinta, come a qualcosa che stia oltre. Infatti di Dio non possiamo conoscere né
il quid, l’essenza, dal momento che essa è infinita, né il propter quid, la causa, in
quanto Dio non ha causa, e nemmeno, in modo determinato, il quia, il fatto “che è”
causa, poiché i suoi effetti non sono a lui proporzionati.25
La conclusione di questo discorso è posta significativamente all’inizio del testo da Alberto. Si tratta della celebre espressione del profeta Isaia: «veramente tu sei
un Dio nascosto, Dio di Israele, salvatore».26 Lo stesso Tommaso d’Aquino riprenderà questi temi e affermerà che pur essendo possibile, con l’aiuto dell’illuminazione
della grazia, “vedere” Dio, almeno nello stato beatifico, non sarà mai possibile comprenderlo pienamente, essendo l’essenza divina infinita.27
Conclusioni
Abbiamo analizzato brevemente il ruolo giocato da pensatori del XII e del
XIII secolo, in particolare Pietro Abelardo e Alberto Magno a proposito del processo
di “costruzione della teologia medievale”, per citare il titolo di un recente libro di
Inos Biffi28 (teologia intesa in questo senso ampio di summa, di sintesi e vertice del
sapere). La loro opera teologica può essere letta come il tentativo di edificare un
sapere razionale, ancorché fondato sui dati della rivelazione cristiana, grazie all’uso
accorto della filosofia e degli strumenti logici aristotelici; un sapere nel quale trova ampio spazio, e anzi diviene metodo, la discussione dialettica, l’argomentazione
razionale, la confutazione. Tuttavia, la teologia non è solo scienza di Dio (scienza
secondo i canoni aristotelici, cioè un sapere costruito con metodo, mediante argomentazioni razionali, e che ha come punto di partenza, come le altre scienze, principi
indimostrabili e inconfutabili); è anche ricerca di Dio, una ricerca mai risolutiva,
mai conclusa, essendo il suo oggetto, propriamente parlando, ineffabile e irraggiungibile (secondo il modello della teologia negativa e mistica).
25
Ibid.
Is. 45, 15.
27
Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, I, q. 12.
28
I. Biffi, Mirabile Medioevo. La costruzione della teologia medievale, Milano, Jaca Book
26
2009.
90
Giuseppe Allegro
Studiare oggi la teologia medievale secondo queste considerazioni può non
essere un mero esercizio di erudizione storica, come se si analizzasse un evento culturale superato del passato. La costruzione della teologia come ricerca di Dio e, al
contempo come scienza di Dio e come la summa che riconduce ad unità i saperi, può
indicare una possibile strada da percorrere per rispondere alla frammentazione culturale e alla crisi di fondamento che attanaglia il nostro tempo, al di là delle appartenenze religiose e ideologiche. Recuperare il senso della unitarietà della sapienza che
fu propria dei medievali e della loro epoca di complessi incroci culturali e religiosi
può essere un valido richiamo a una rinnovata autentica prassi del dialogo fra le fedi,
le culture, le prospettive diverse.
Luciana Pepi
Alcune considerazioni sulla presenza ebraica in Sicilia nel Medioevo
Negli ultimi decenni sono stati pubblicati molti studi specialistici sugli ebrei
in Sicilia,1 sulla loro presenza nelle diverse città siciliane, focalizzando l’attenzione
anche sulla specificità di ogni singola comunità: gli ebrei a Palermo, a Sciacca, e così
via. Alcuni studi hanno esaminato taluni aspetti della loro vita: quello economico,
sociale-culturale. In questo intervento, invece, saranno proposte delle brevi riflessioni su alcune caratteristiche comuni alle molte comunità presenti nell’isola. Inoltre,
mettendo insieme alcuni importanti tasselli, si cercherà di far luce sulle condizioni di
vita degli ebrei siciliani. La comunità ebraica, presente in Sicilia già dall’epoca romana, fu una delle comunità più consistenti, che visse in mezzo ai cristiani, sia pure
con l’obbligo di contraddistinguersi. La loro presenza è documentata già a partire dal
590, grazie alle lettere di papa Gregorio Magno. La cacciata degli ebrei dai territori
dei re cattolici Ferdinando d’Aragona ed Isabella di Castiglia, nel 1492, interruppe
bruscamente la continuità della presenza ebraica in Sicilia, che era durata circa un
millennio e mezzo. Vennero così disperse le comunità giudaiche, fino ad allora saldamente insediate nell’isola, con un proprio ordinamento giuridico, rappresentato
dalla giudecca, dotata di istituzioni civili e religiose del tutto autonome. Nonostante
in tempi recenti gli studi sull’ebraismo siciliano si siano notevolmente incrementanti
permangono ancora diverse lacune e numerosi problemi legati soprattutto alle fonti.2
Inoltre come ha rilevato Shlomo Simonsohn,3 la documentazione relativa alla presenza ebraica in Sicilia è quasi completamente di origine governativa, notarile e così
via. La documentazione ebraica interna manca quasi del tutto. Anche le fonti lettera-
Per una visione complessiva si veda la breve bibliografia posta alla fine del presente intervento.
Molto schematicamente le fonti disponibili possono essere così riassunte:
1) le poche tracce archeologiche; 2) le epistole del papa Gregorio Magno (590); 3) i documenti
della gheniza del Cairo (riguardano la vita ebraica dal nono al dodicesimo secolo); 4) i documenti di archivio (iniziano dal 1200); 5) diari di viaggiatori: Iibn Haqwkal, Beniamino da Tudela, Ovadia da Bertinoro.
3
Una notevolissima mole di documentazione è stata messa a disposizione degli studiosi mediante la pubblicazione di ponderosi volumi nella collana Documentary History of the Jews, diretta da
Shlomo Simonsohn, di questi il diciassettesimo volume è stato pubblicato a marzo 2010.
1
2
92
Luciana Pepi
rie ebraiche sono scarse. La perdita completa di documenti delle comunità ebraiche
è dovuta all’improvvisa interruzione della loro presenza,4 probabile conseguenza del
carattere dirompente che ebbe il decreto di espulsione, che lasciava tre mesi di tempo
agli ebrei per decidere tra la conversione e l’esilio.
Le fonti archivistiche, assai scarse per il periodo della dominazione araba,
sono più numerose a partire dall’epoca normanna e poi sveva e si trovano abbondanti, per il secolo quindicesimo, nei fondi degli organi statali e in quelli notarili
degli istituti archivistici della Sicilia e presso l’Archivio della Corona di Aragona a
Barcellona. Per il periodo medievale, le fonti relative alla storia degli ebrei sono in
gran parte sparse negli archivi e nelle biblioteche. Raramente sono disponibili fondi
che contengano solamente (o prevalentemente) materiale ebraico.
Ciò comporta naturalmente qualche difficoltà nel reperimento della documentazione utile. Come accennato, gran parte della documentazione disponibile è costituita da materiale “esterno” al mondo ebraico, elaborato dalla società dominante, e che
quindi non sempre consente di comprendere a pieno l’organizzazione interna della
società ebraica medievale. Una fonte essenziale è costituita dai fondi notarili. Nella
maggioranza dei casi si tratta di registri privi di indice, e il reperimento della documentazione può avvenire solo attraverso il paziente spoglio dei singoli protocolli.
Gli archivi comunali ed ecclesiastici conservano spesso fondi nei quali è possibile reperire materiale utile alla ricostruzione della storia degli ebrei. Purtroppo non
sempre tali archivi sono di facile uso: in alcuni casi, gli archivi ecclesiastici sono aperti al pubblico a discrezione dell’archivista di turno e mancano di inventari adeguati;
un discorso analogo vale spesso – almeno per l’Italia – per gli archivi comunali.
Un gran numero di biblioteche conserva codici ebraici e documentazione in
volgare. In alcuni casi, cataloghi recenti consentono di reperire il materiale che interessa con una certa facilità. Qualsiasi riflessione sulla presenza ebraica in Sicilia,
a mio avviso, non può prescindere da due dati molto rilevanti: la durata millenaria
della presenza ebraica nell’isola, ininterrottamente dal primo secolo e.v. al quindicesimo secolo,5 e la consistenza demografica: nel medioevo. Infatti, vi erano in Sicilia
più ebrei che nel resto d’Italia.
Nell’isola nel corso del susseguirsi delle varie dominazioni, da quella romana,
bizantina, a quella aragonese e infine castigliana, nel corso di circa undici secoli la
popolazione ebraica fu sempre presente, fu popolazione stanziale, diversa religio-
4
S. Simonsohn, Prolegomena ad una storia degli ebrei in Sicilia, in Atti del Convegno Italia
Judaica V, 1995, pp. 17-18.
5
Si è soliti dividere tale presenza in due fasi: la prima, dal primo secolo al nono, attestata soprattutto nella Sicilia orientale. Tale ebraismo si esprime in lingua greca ed è caratterizzato dagli stretti
rapporti con la Palestina. La seconda fase si apre con l’invasione musulmana. Molti ebrei giungono in
Sicilia dal nord Africa. Questo ebraismo è di stampo magrebino e si esprime in arabo con i caratteri
dell’alfabeto ebraico.
Alcune considerazioni sulla presenza ebraica in Sicilia nel Medioevo
93
samente e politicamente dalla popolazione maggioritaria dominante, ma comunque
costantemente presente.6
L’interesse per la storia dell’ebraismo siciliano di studiosi, quali Ashtor, Abulafia, Bresc, Goitien, Roth, Simonsohn, è stato incrementato dal fatto che nel medioevo, come scrive Carmelo Trasselli: «nessuna regione italiana aveva tanti gruppi
numerosi quanti ne aveva la Sicilia».7
Al momento dell’espulsione la cifra si aggira tra i trentaciquemila e i cinquantamila.
Per capire il valore di tale numero bisogna tener presente che gli ebrei italiani
nello stesso periodo, compresi i siciliani, si aggiravano sui settantamila, mentre in
Spagna erano duecentomila.
La popolazione ebraica costituiva il cinque per cento della popolazione isolana.8
La giudecca di Palermo e di Siracusa constava di cinquemila ebrei, Messina e
Trapani di duemila e cinquecento; Agrigento e Catania duemila.
Tali numeri sono importanti perché rendono l’idea precisa della loro massiccia
presenza, tanto da poter parlare di città ebraiche situate all’interno delle città cristiane.
Scrive Attilio Milano:
Palermo era il maggiore centro di vita ebraica di tutta Italia. Questo primato
demografico si era andato formando durante la prospera età dell’emirato arabo;
si mantenne poi saldo durante le due dominazioni normanna e sveva le quali,
con Palermo opulenta capitale del regno di Sicilia, significarono per gli ebrei
un’era di benessere ancora più accentuato […] questo primato numerico, il
concentramento di ebrei in tutta la Sicilia trovarono la loro maggiore forza coesiva nel fatto che, anche durante il periodo normanno, la coesistenza nell’isola
di ceti diversi per origine etnica e per religione, ma tutti parimenti influenti,
imponeva un trattamento politico equiparato nei riguardi di ciascuno, o per lo
meno distinzioni non troppo stridenti. Così, nelle leggi normanne, gli ebrei
vengono riconosciuti come cittadini di pieni diritti […].9
Nel 1492, in Sicilia esistevano una cinquantina di giudecche. Le giudecche
erano per alcuni aspetti quartieri ebraici situati all’interno delle varie comunità cristiane; per altri aspetti erano invece enti amministrativi autonomi dotati di personalità giuridica propria. L’amministrazione della giudecca era diversa dall’amministrazione cittadina. Con il nome giudecca si intende tutta la comunità ebraica di una data
F. Renda, Gli ebrei prima e dopo il 1492, in Italia Judaica V, cit., p. 35.
C. Trasselli, Sulla diffusione degli ebrei e sull’importanza della cultura e della lingua ebraica in Sicilia, particolarmente in Trapani e in Palermo nel scec. XV, Palermo 1954, pp. 376-382.
8
Ad esempio David Abulafia sostiene che nonostante sia difficile stabilire un numero preciso è
probabile che gli ebrei costituissero il cinque per cento della popolazione totale. Cfr. D. Abulafia, Gli
ebrei di Sicilia sotto i Normanni e gli Hohenstaufen, in Ebrei e Sicilia, Palermo 2002, p. 70.
9
A. Milano, Storia degli ebrei in Italia, Torino 1963, p. 92.
6
7
94
Luciana Pepi
località e si intende anche la civitas giudaica, ossia l’organizzazione istituzionale
e relativa rappresentanza amministrativa e religiosa. In quanto civitas giudaica, la
giudecca era di pari dignità della civitas cristiana, e come tale era dotata di organi
propri preposti al governo della comunità, al culto, alla scuola, all’osservanza degli
usi, costumi e pratiche conformi alla legge mosaica. Le leggi delle città erano quelle
cristiane, le leggi delle giudecche erano quelle mosaiche. In tal senso, la comunità
giudaica era a tutti gli effetti, sia di fatto che di diritto, una città dentro la città.
L’ebreo siciliano era giuridicamente, anagraficamente, socialmente, cittadino
siciliano, ma in quanto ebreo era, nello stesso tempo un servo della Regia Camera,
servi regiae camerae, condizione che lo accomunava all’ebreo della maggior parte
dei paesi europei: gli ebrei e i loro beni appartenevano al re. L’istituzione del servo
della Regia camera era un regime ambiguo, che di fatto nella condizione siciliana
nulla toglieva alla libertà personale, politica e religiosa dell’ebreo singolo, anzi di
quella libertà era per molti aspetti garante. Il termine servi era il segno di una particolare condizione giuridica di totale subordinazione al potere sovrano sotto la cui
giurisdizione si trovavano, ma anche della particolare protezione di cui godevano,
che si esercitava però solo quando tale potere riusciva ad imporsi, escludendo interventi di altre autorità laiche o ecclesiastiche tendenti ad imporre obblighi e a vantare
diritti sulle varie comunità ebraiche dell’isola.
Come mette bene in luce il Lagumina:
il titolo aveva due lati: il buono e il cattivo. Il buono perché l’autorità politica
di Sicilia sempre pretese che i servi della Corona fossero lasciati vivere in
pace, con piena libertà l’esercizio del loro culto religioso; ed il cattivo perché
la vita dei protetti della suprema autorità politica era veramente penosa. Gli
ebrei erano “proprietà” del re. Si cercava in tutti i modi di spillare loro quanto
più denaro si potesse […]. I giudei di Sicilia erano sempre alle prese con il
regio fisco per le tasse, per le contribuzioni e per le gabelle cui erano sottoposti
tutto questo doveva produrre un grande avvilimento morale […].10
Numerosissime, infatti, erano le tasse che gli ebrei siciliani erano costretti
a pagare: su svariati alimenti (quali, ad esempio, formaggio, tonno), su qualsiasi
scambio di merci, ed inoltre quelle attinenti all’osservanza delle prescrizioni religiose, come le gabelle sulla mattazione degli animali e sui vini.11 Svariate erano le
occasioni per richiedere gravami straordinari.
B. e G. Lagumina, Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia, Palermo 1884/1909, 3 voll. Ristampa a cura della Società Siciliana di Storia Patria, Palermo 1990, vol. III, pp. VIII-IX.
11
Per quanto riguarda la descrizione dettagliata di tutte le varie tasse e gabelle si vedano A.
Milano, cit., pp. 174-175; D. Abulafia, Le attività economiche degli ebrei siciliani attorno al 1300, in
Italia Judaica V, 1995, cit., pp. 89-95.
10
Alcune considerazioni sulla presenza ebraica in Sicilia nel Medioevo
95
L’appartenenza alla Regia camera, inoltre, impediva l’assimilazione della popolazione ebraica con la popolazione locale.12 I segni esteriori della discriminazione
non decaddero mai: dalla rotella sugli abiti al panno rosso esibito dalle botteghe.13 La
rotella rossa, il segno distintivo che i giudei erano obbligati a portare per distinguersi
dai cristiani, era il segno della loro infamia, che li rendeva oggetto di disprezzo e di
scherno da parte dei loro oppressori. L’imperatore Federico II l’aveva stabilita contra judeos, ut in differentia vestium et gestorum a cristianis discernantur.14
Nelle costituzioni melfitane gli ebrei vengono trattati allo stesso modo dei
musulmani, cioè come una minoranza cui l’imperatore garantisce la sua protezione.
Nel paragrafo I 18 viene stabilito che ebrei e musulmani devono avere la possibilità
di iniziare procedimenti legali, «perché non vogliamo che innocenti vengono perseguitati soltanto perché sono ebrei o musulmani». In un altro paragrafo (I 28) viene
stabilito che nel caso che i colpevoli di un omicidio non possano essere individuati,
gli abitanti della comunità, in cui il delitto è avvenuto, debbano pagare una multa
collettiva: per l’omicidio di un cristiano cento augustali, per quello di un ebreo o un
musulmano soltanto cinquanta. La vita di un ebreo o di un musulmano valeva quindi
soltanto la metà di quella di un cristiano.
La condizione giuridica degli ebrei siciliani era quella di cittadini di secondo grado.
Essi si trovavano, come accennato, alle dirette dipendenze del re, il quale aveva così titolo per ingerirsi di tutto quanto si riferiva loro, poteva avanzare richieste
di contributi ordinari e straordinari, e nello stesso tempo aveva interesse ad avere di
fronte a sé una collettività unita con cui poter trattare. Di contro, gli ebrei potevano
domandare l’intervento diretto del sovrano per raddrizzare i torti subiti, avevano la
garanzia del rispetto delle concessioni loro fatte a compenso di tutti i “contributi”
versati. Gli ebrei avevano riconoscimento ed autonomia come collettività; tutela in
tutti i loro servizi religiosi, potevano possedere una sinagoga, un cimitero, un bagno
rituale ed un mattatoio.
Attilio Milano osserva:
l’interesse parallelo, nel sovrano svevo prima e nell’aragonese dopo, di avere
di fronte a sé una collettività ebraica unita e responsabile, e negli ebrei di potergli opporre un fronte solido d’azione o di resistenza secondo il caso, fece sì che
in nessun altro periodo o in nessun’altra parte d’Italia si ebbe una collettività
ebraica così rigidamente e integralmente organizzata come in Sicilia.15
Ibid.
N. Bucaria, Sicilia judaica, Palermo 1996, p. 20.
14
F. Lionti, Documenti relativi agli ebrei di Sicilia, in Archivio Storico Siciliano, VIII-IX
(1883-84), p. 156. Obbligo ribadito poi, nel 1366, da Federico III.
15
A. Milano, Storia degli ebrei in Italia, cit., p. 176.
12
13
96
Luciana Pepi
Gli ebrei siciliani avevano libera scelta di attività, essendo loro preclusa solo
la via dei pubblici uffici; potevano stabilirsi dove volevano, potevano possedere beni
immobili, in città o in campagna. Ebbero, a volte, anche ruoli importanti, come Samuel Sala da Trapani che per due volte, nel 1403 e nel 1409, fu incaricato di trattare
la pace tra il re di Sicilia e quello di Tripoli.16
Potevano possedere case, terre e potevano svolgere qualsiasi attività economica. Si dedicarono all’agricoltura, alla pesca, al commercio e all’artigianato.
La loro presenza è attestata in quasi tutte le attività, erano: rinomati conciatori,
carpentieri, calzolai, banchieri, notai,17 medici, veterinari.
Famosi come abili lavoratori di ferro, di rame, di legno, di pelli, di metalli preziosi.
Anche le lettere della gheniza hanno notevolmente contribuito a far luce sulle
molteplici attività commerciali degli ebrei siciliani.18 Un importante ruolo ebbero
nell’esportazione di vari prodotti quali: metalli, minerali, lino, pelli, mandorle, tessuti, seta.
A Trapani la pesca e la lavorazione del corallo erano monopolio degli ebrei.
Descrivendo la vita economica ebraica a Trapani, Angela Scandaliato scrive:
i Sala, i Sammi, gli Atono, i Cuyno, i Romano […] occupano parecchi registri
notarili e denunciano un fervore di attività economiche che dà un’impronta
inconfondibile alla Trapani del Quattrocento, con le sue botteghe di coralli e
corallari, gli orafi, il suo porto dove si agita una umanità variopinta di mercanti
mediterranei barbarosi, […] le sue tonnare e i laboratori di tonnina dove voci
in volgare siciliano si mescolavano a suoni in arabo maghrebino.19
Emerge da diverse fonti che la maggior parte degli ebrei esercitavano comunque mestieri artigiani. L’attività più diffusa era l’arte tintoria, nella quale essi
avevano acquisito una posizione quasi monopolistica. A questa attività erano legati
la produzione ed il commercio di seta e di stoffe pregiate. Soprattutto gli ebrei palermitani erano noti per la lavorazione della seta e della tintoria.20 La tintoria era
un’occupazione così prettamente ebraica che in alcuni casi il termine era usato come
sinonimo di giudecca.21
16
304, 499.
B.
e
G. Lagumina, Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia, cit., vol. III, I, 176, 250, 257,
17
Sulle dinastie di notai ebrei a Trapani cfr. A. Scandaliato, Momenti di vita ebraica a Trapani
nel Quattrocento, in Gli ebrei in Sicilia dal tardoantico al medioevo, Palermo 1988, pp. 170-171.
18
I documenti della gheniza del Cairo hanno creato le basi di un imponente studio della civiltà
ebraica nel Mediterraneo del primo medioevo. Cfr. S. D. Goitein, A mediterranean society. The jewish
communities of the arab world as portrayed in the documents of the Cairo Geniza, 1967-1988, 5 voll.
19
Ibid., p. 169.
20
A. Milano, Storia degli ebrei di Italia, cit., p. 93.
21
R. Straus, Gli ebrei di Sicilia dai Normanni a Federico II, Palermo 1992, p. 69.
Alcune considerazioni sulla presenza ebraica in Sicilia nel Medioevo
97
Federico II affidò loro i monopoli della seta e della tintoria. La seta siciliana
era famosa in tutto il Mediterraneo, in epoca normanna, la lavorazione della seta e
la fabbricazione delle stoffe raggiunsero altissimi livelli, anche grazie all’arrivo di
alcuni ebrei greci fatti prigionieri da Ruggero II nel 1147.22
Dai numerosi atti notarili che sono stati studiati si apprendono preziose informazioni sulla compravendita di beni mobili o strumentali: stoffe, manufatti, metalli,
spezie. Vi sono pure contratti di lavoro stipulati per periodi stagionali, come per
esempio la suolatura di scarpe, o il trasporto di merci.
Quindi alla luce degli studi più recenti, non è corretto immaginare che gli
ebrei svolgessero solo lavori umili. Anzi, esaminando le attività svolte dagli ebrei,
quindi la loro partecipazione alla vita dell’isola, si può dedurre che la posizione
sociale che loro occupavano, spaziava da incarichi di notevole importanza sino ai
mestieri più umili.23 Come accennato molto considerevoli erano le attività imprenditoriali, professionali e mercantili.24
Numerosi ebrei si dedicavano alla produzione del vino e delle uve, spinti
dall’obbligo rituale di fornire vino kasher alla comunità, anche se risulta da vari documenti che essi si interessavano delle uve non solo al fine di poter disporre di vino
conforme all’uso rituale, ma anche in quanto forma di investimento redditizia; vino
e uva, infatti, venivano acquistati anche dai cristiani.25
Gli ebrei siciliani si occupavano anche della coltivazione di canna da zucchero, di cui la Sicilia era grande esportatrice. Noti anche per la produzione di: olio,
formaggio, datteri, hennè ed indaco.
Molti di loro erano abili lavoratori di tonno, alimento che ben si adatta alle
loro rigide regole alimentari. Come è noto, in Sicilia le tonnare erano numerose ed
in esse erano presenti un gran numero di lavoratori ebrei, che si occupavano sia della
pesca sia della lavorazione che della conservazione. Attilio Milano osserva: «in tutte
le città della Sicilia non dovettero rimanere estranei ad alcun mestiere, qualificato od
umile che fosse».26
Vi erano anche ebrei esperti nel campo della farmacopea vegetale e della fitoterapia. Tali conoscenze di medicina naturale facevano parte di remoti studi, infatti
nei testi tradizionali antichi, quali il Talmud, erano indicate terapie a base di vegetali
per curare i comuni malanni.27 La loro esperienza nell’arte medica era favorita dal
Questi ebrei provenivano da Tebe e Corinto, centri importantissimi della lavorazione della seta.
Occorre ricordare che gli ebrei dovevano occuparsi di alcune mansioni umilianti come la
pulizia dei castelli e dei palazzi reali e quella di dover fornire il boia per le esecuzioni capitali, come
avveniva a Palermo e a Messina. Cfr. A. Milano, Storia degli ebrei in Italia, cit., p. 174.
24
D. Abulafia, Le attività economiche degli ebrei siciliani attorno al 1300, cit., pp. 89-95.
25
Ibid., p. 94.
26
A. Milano, Storia degli ebrei in Italia, cit., p. 177.
27
G. Cosmacini, Medicina e mondo ebraico, Laterza 2001, p. 40.
22
23
98
Luciana Pepi
vantaggio di poter accedere con facilità ai testi di medicina scritti in arabo, lingua
che possedevano perfettamente.28 In ogni luogo e in ogni tempo i medici ebrei furono
molto apprezzati per le loro competenze e spesso la loro bravura era premiata dalle
varie autorità locali con l’acquisizione di privilegi, come l’esenzione del pagamento
delle tasse, o l’esonero dal portare il segno distintivo.
È degna di nota la massiccia presenza di medici ebrei a Polizzi Generosa.
Come osserva Angela Scandaliato: «Polizzi Generosa nelle Madonie, fu indubbiamente tra Trecento e Quattrocento, città di medici, non si tratta di presenze individuali registrate dalle fonti ufficiali, ma di vere e proprie dinastie familiari che stanno
emergendo attraverso i contratti notarili […]».29
Come le giudecche di Sciacca e Caltabellotta erano note per la presenza di
rabbini la cui cultura è testimoniata dai libri in loro possesso, quella di Polizzi era
nota per il numero e la perizia dei suoi medici.30
È importante tener presente che nel corso della loro lunga permanenza in Sicilia, con
il succedersi delle diverse dominazioni, la sorte della popolazione ebraica cambiò più volte.
Quando ad esempio dal periodo musulmano si pervenne al Normanno avvennero alcuni cambiamenti, ed ancora maggiori cambiamenti si ebbero con la dominazione aragonese. Come sottolineano vari studiosi 31 se inizialmente le loro comunità
erano indipendenti e bene inserite nelle città ospitanti, gradualmente la loro condizione peggiorò; si diffuse l’intolleranza, soprattutto con gli aragonesi, nel 1300, che
pian piano li isoleranno. Le norme emanate da Federico III miravano essenzialmente
alla netta separazione tra ebrei e maggioranza cristiana.32
Nei periodi arabo, normanno e svevo, essi conobbero una relativa prosperità
e il loro numero aumentò. Nel XIV secolo e nei primi anni del XV si registrò una
progressiva emarginazione degli ebrei; la politica dei sovrani continuò ad avere un
carattere contraddittorio. Essi, da una parte, consideravano gli ebrei una fonte di
entrate particolarmente preziosa in un’epoca di costante crisi delle finanze e, dall’altra, non erano insensibili alla predicazione antiebraica degli ordini mendicanti e alle
posizioni ugualmente ostili agli ebrei dei loro consiglieri di corte.33
28
Attilio Milano, osserva giustamente che: «due cause ponevano gli ebrei in condizioni più
favorevoli dei cristiani nel loro slancio verso la medicina: una, era la loro possibilità di consultare
nell’originale i grandi trattati di medicina arabi, e l’altra, che alcune delle norme rituali imponevano
loro l’osservanza di principi igienici, che poteva suggerire soltanto chi aveva una esatta conoscenza del
corpo umano e delle sue reazioni: non si dimentichi a tal proposito che, secondo la Bibbia, purità morale
e purità fisica non possono andare disgiunte» (cit., p. 626).
29
A. Scandaliato, Judaica minora sicula, Giuntina 2006, p. 129.
30
Ibid., p. 227.
31
D. Abulafia, La comunità di Sicilia dagli arabi all’espulsione, in Storia d’Italia, Annali 11:
Gli ebrei in Italia, Einaudi 1996, pp. 47-83.
32
Ibid., p. 66.
33
Id., Il mezzogiorno peninsulare dai bizantini all’espulsione, in Storia d’Italia, Annali 11: Gli
Alcune considerazioni sulla presenza ebraica in Sicilia nel Medioevo
99
A tal proposito un tema classico della storiografia ebraica, che è però stato riaffrontato criticamente negli ultimi decenni, è quello che concerne il deterioramento
della condizione ebraica nel corso degli ultimi secoli del Medioevo e l’intensificarsi
di persecuzioni ed espulsioni.
Si è riesaminato il peso delle persecuzioni legate allo svolgimento della prima
e della seconda crociata, ed anche il risvolto della peste di metà Trecento nelle regioni del nord-Europa, ridimensionando in parte il ruolo dell’epidemia nel deteriorarsi
delle relazioni ebraico-cristiane. Allo stesso modo, moltissimi studi hanno ripreso
negli ultimi decenni, questioni quali l’accusa di omicidio rituale e di dissacrazione
dell’ostia, esaminando o riesaminando criticamente le fonti, soprattutto processuali.
Il ruolo della predicazione dei Minoriti ha certamente contribuito a diffondere
sentimenti antiebraici.
I frati predicatori, francescani e domenicani, con le loro prediche, aizzavano il
rancore e il sentimento di vendetta della popolazione per la morte di Gesù.
Tra il 1474 e il 1475, la Sicilia fu scossa da un’ondata di antisemitismo che
coinvolse molti centri dell’isola. Vi furono episodi isolati, verso singoli ebrei, ed
episodi di massa come i massacri di un gran numero di vittime di Noto e Modica.34
Soprattutto nel periodo della Pasqua cristiana, a causa dei sermoni quaresimali
che ricordavano il martirio di Gesù, si verificavano attacchi contro gli ebrei. Così nel
venerdì santo del 1333, a Palermo, avvenne un gravissimo tumulto contro gli ebrei
visti come i discendenti dei martirizzatori di un tempo, e qualcosa di analogo accadde a Trapani nel 1373.35
Non sempre la vita degli ebrei fu facile e tranquilla.
Secondo alcuni studiosi tali difficili condizioni di vita determinarono il poco
impegno nella attività culturali, nello studio.36
ebrei in Italia, Einaudi 1996, p. 26.
34
A Noto le vittime furono più di 500, mentre a Modica il numero degli ebrei uccisi fu di circa 360.
35
A. Milano, Storia degli ebrei in Italia, cit., p. 170.
Anche a Polizzi nel 1413 e a Taormina nel 1455 il venerdì santo si ripeterono attacchi analoghi
contro gli ebrei. Numerosi documenti attestano che spesso i sovrani dovevano intervenire per proteggere gli ebrei da tali attacchi. A Marsala, nel 1399, re Martino si adoperò per liberare gli ebrei dalla
consuetudine di doversi recare, nel giorno di Santo Stefano, alla chiesa di San Tommaso, per ascoltare
le prediche conversionistiche. L’obbligo di assistere a simili prediche era diffuso in tutta la Sicilia; ma
a Marsala all’uscita, era norma che fossero fatti oggetto di una fitta sassaiola da parte del popolino, a
ricordo del martirio subito da Santo Stefano. Cfr., A. Milano, Storia degli ebrei in Italia, cit., p. 171.
36
È importante ricordare che nell’ebraismo lo studio è un precetto, una mitzwah, quindi difficilmente viene trascurato. Lo studio, la conoscenza dei testi fondanti della tradizione ebraica, sono da sempre
una caratteristica peculiare della vita ebraica ed hanno reso possibile il mantenimento della loro identità. Il
popolo ebraico non è solo il “popolo del libro” ma il “popolo che commenta, che studia, il libro”.
Tale studio costituisce l’essenza della vita dell’ebreo che intende praticare il culto di Dio. Lo
studio della Torah non è considerato un mezzo per l’acquisizione di nozioni, ma costituisce esso stesso
il contenuto della vita spirituale dell’uomo. Scrive Y. Leibowitz: «per “studiare la Torah” non si intende
100
Luciana Pepi
Certamente la vita culturale degli ebrei siciliani fu determinata dalla storia politica dell’isola e dalla posizione geografica tra mondo islamico e cristiano, incontro
di cultura araba e latina.
In Sicilia, terra di confluenza e d’immigrazione, venivano mercanti del Maghreb, dell’Egitto, di Malta, della Spagna. Molteplici erano dunque gli scambi commerciali e culturali.
Sulla vita culturale degli ebrei siciliani le ipotesi degli studiosi sono diverse e
spesso discordanti. Scrive Angela Scandaliato:
è purtroppo ancora diffuso il pregiudizio, (nemico delle ricerche), che dalla
limitata presenza nell’isola di maestri di legge e di esperti della halakah, specie
in comunità della Sicilia orientale come Messina e Siracusa, tradizionalmente
considerate aree più aperte alla cultura di tipo mediterraneo, e dalla carenza di
codici e manoscritti ebraici siciliani, si debba desumere il basso livello culturale degli ebrei siciliani.37
Illuminanti sono gli studi di Henri Bresc,38 che tramite l’analisi dei testi contenuti nelle biblioteche di alcuni ebrei siciliani ha messo in luce gli autori e gli argomenti letti e studiati durante il medioevo. Oltre a studiare i testi fondanti della
tradizione ebraica, quali: Torah,39 Mishnah40 e Talmud,41 particolare attenzione era
solo apprendere quanto è scritto nella Torah, ma pensare ad essa, riflettere su di essa, interpretarla e
trarne delle conclusioni». Lezioni sulle “Massime dei padri” e su Maimonide, Firenze 1999, p. 43.
37
A. Scandaliato, Judaica minora sicula, cit., pp. 474-475.
38
H. Bresc, Livres et Societé en Sicilie, ed. Accademia di Scienze Lettere ed Arti di Palermo,
Palermo 1971, pp. 239-241.
39
Il termine Torah, solitamente tradotto con Legge, deriva dalla radice verbale y r h che significa
insegnare mostrare. La torah è l’insegnamento per eccellenza. Essa, infatti, insegna a vivere in modo
corretto. Non si deve dunque intendere come legge, intesa in senso giuridico, ma come istruzione, insegnamento. Indica spesso l’intera Scrittura ebraica anche se propriamente designa i cinque libri del Pentateuco.
«La Torah è l’insegnamento che Dio dà al suo popolo, è la via privilegiata che conduce a Lui.
Essa insegna all’uomo come vivere rettamente. La Torah propone uno stile di vita, non la credenza in
determinate dottrine. La Torah è anche la storia del popolo ebraico che incarna per tutta l’umanità il
difficile cammino dell’uomo verso la Divinità e verso una vita più degna di essere vissuta». A. Cagiati,
Settanta domande sull’ebraismo, Edizioni Messaggero, Padova 1997, p. 17.
40
La Mishnah fu redatta tra il I e il III sec. e. v. Il termine mishnah deriva dal verbo shanah (
radice s n h) che significa ripetere, in quanto solo la frequente ripetizione consente di fissare realmente
nella memoria quel che viene insegnato. Essa è codificazione di leggi, tradizioni, esegesi del testo biblico. Anche la Mishnah, a sua volta, fu oggetto di ulteriore studio, di commento, il risultato di tale studio
fu la Ghemarah (completamento). L’insieme di Mishnah e Ghemarah forma il Talmud.
41
Esistono due redazioni del Talmud: quello di Gerusalemme (o palestinese) terminato sul finire del IV sec. e.v. e quello di Babilonia (scuola di Sura), più ampio ed articolato, terminato nel VI sec. e.
v. Il Talmud, testo molto vario e complesso, contiene: riflessioni morali, filosofiche, racconti, leggende,
osservazioni scientifiche, discussioni giuridiche, temi religiosi (dal culto quotidiano ai rapporti umani),
Alcune considerazioni sulla presenza ebraica in Sicilia nel Medioevo
101
rivolta ai testi di Mosè Maimonide e di halakah (la normativa).42
Inoltre, in Sicilia è documentata la presenza non solo di libri arabi tradotti in
ebraico ma anche di traduzioni effettuate in Catalogna e in Provenza, nelle biblioteche
sono presenti testi di Ippocrate, Galeno, Porfirio, Avicenna, Arnaldo di Villanova.43
È nota l’importanza degli ebrei come traduttori, conoscendo bene oltre l’ebraico anche l’arabo, il latino e il greco ebbero un fondamentale ruolo nella trasmissione del sapere.
Tradussero testi filosofici, esegetici e scientifici, molte delle opere che nel
medioevo sono giunte nel mondo latino-cristiano hanno essenzialmente subito la
mediazione delle traduzioni dei filosofi ebrei.
Presso la corte di Federico II di Svevia diversi intellettuali ebrei collaborarono
all’immenso lavoro di traduzione.44 La consuetudine dell’ebreo traduttore di corte fu
mantenuta anche da re Manfredi e dai suoi successori angioini.45
Anche in Sicilia la cultura ebraica mostra il suo carattere di apertura, confronto, collaborazione con l’ambiente circostante.
In realtà tratto caratteristico dell’ebraismo, contrariamente a quanto spesso si
affermi, è la sua “apertura” alle culture prossime.46
David Abulafia, ad esempio, sottolinea bene come la vita culturale, economica, legislativa e religiosa degli ebrei siciliani fu profondamente influenzata tanto
dalla cultura del vicino Nord Africa che da quella spagnola.
Così scrive:
gli ebrei della Sicilia portano i caratteri particolarmente marcati del nord Africa […] Gli arabi hanno lasciato agli ebrei una eredità linguistica, l’arabo è
esegesi della Scrittura.
Il termine talmud deriva dal verbo lamad studiare (radice l m d ) e letteralmente significa studio.
Il Talmud raccoglie un insieme di norme, leggi, tradizioni; esso tratta di problemi giuridici,
economici, agricoli, rituali, morali. In esso si trovano anche credenze popolari, leggende e soprattutto
ogni genere di interpretazioni della Scrittura.
42
Il termine halakah deriva dalla radice verbale h l k che vuol dire camminare e dunque letteralmente significa cammino. L’halakah è la via da seguire, la strada che l’ebreo deve percorrere per
essere un buon ebreo.
43
R. Gianni, Sulla cultura Siciliana nel XV secolo, “La Fardelliana” XVII, Trapani 1998, pp. 7-51.
44
Cfr. Anatoli Ja’aqov, Il pungolo dei discepoli. Il sapere di un ebreo e Federico II, introduzione, traduzione e note a cura di L. Pepi, (Machina Philosophorum, 7), Officina di Studi Medievali,
Palermo 2004.
45
A. Milano, Storia degli ebrei in Italia, cit., p. 654; C. Sirat, La filosofia ebraica alla corte di
Federico II, in Federico II e le scienze, Palermo 1994, pp. 185-197.
46
P. Stefani, Introduzione all’ebraismo, Queriniana, Brescia 2004, p. 297. G. B.Sermoneta,
Federico II e il pensiero ebraico nell’Italia del suo tempo, in A. M. Romanici (a cura di ), Atti della
Settimana di studi su Federico II e l’arte del 200 italiano, Roma 10 – 20 maggio1978, Galatina 1980,
pp. 186-196.
102
Luciana Pepi
rimasta “lingua parlata” degli ebrei siciliani fino al quattordicesimo secolo
[…] Anche il loro sistema giuridico fu determinato da quello islamico […] La
cultura degli ebrei siciliani fu influenzata da quella nordafricana almeno fino
alla conquista catalano-aragonese dell’isola alla fine del tredicesimo secolo,
quando l’influenza spagnola, presente da tempo, divenne ancora più forte[...]
La storia degli ebrei siciliani è quindi quella di una comunità che esprime qualcosa del carattere della stessa Sicilia: un’isola che fa da ponte tra cristianesimo
e mondo islamico, e situata a cavallo delle vie di commercio tra l’economia
in espansione dell’Europa occidentale e i grandi porti del mondo islamico.47
La cultura ebraica è dunque una cultura aperta alle altre culture, anche perché
storicamente, a causa della diaspora, è nata e si è sviluppata nel diretto contatto con
le culture “altre”.
Come afferma Mauro Zonta:
anche nella filosofia si rivelano con evidenza gli aspetti più significativi del
rapporto tra la cultura ebraica e le culture prossime (quella greca antica, quella
arabo-islamica e quella latino-cristiana medievale), e specialmente la capacità
di rifondere temi e testi ripresi da altri ambienti, adattandoli alle proprie esigenze nazionali e religiose. La lettura dei testi della filosofia ebraica medievale, infatti, consente di vedere riflesso, come in uno specchio, l’avvicendarsi
delle diverse tendenze del pensiero e della letteratura di area mediterranea tra
l’800 e il 1500, mostrando quella ebraica non come una cultura puramente
esoterica, chiusa in se stessa, ma come una cultura aperta alle più differenti
influenze - quale, al di là dell’approccio più miope diffuso in certi studi anche
recenti, essa è stata riconosciuta fin dagli inizi della giudaistica moderna, nel
secolo XIX.48
Ed evidenzia Giulio Tamani: «non c’è stato un pensiero ebraico che, nel corso
dei secoli, si è sviluppato in modo costante e autonomo ma ci sono stati pensatori
ebrei che, sollecitati dai movimenti culturali che circolavano nella loro epoca negli
ambienti non ebraici, hanno voluto confrontare il loro patrimonio culturale con quello degli altri».49
La continua interazione con la cultura della società dominante rappresenta un
fattore di rilievo: il mondo ebraico, lungi dall’assorbire acriticamente ciò che veniva
elaborato in ambito cristiano e musulmano, contribuì a sua volta ad influenzare il
sapere del mondo circostante, soprattutto in alcuni settori.
47
D. Abulafia, Gli ebrei di Sicilia sotto i Normanni e gli Hohenstaufen, in Ebrei e Sicilia,
Flaccovio 2002, pp. 70-71.
48
M. Zonta, La filosofia ebraica medievale, Bari 2002, p. V.
49
G. Tamani, Introduzione a S. Pines, La filosofia ebraica, Brescia 2008, p. 7.
Alcune considerazioni sulla presenza ebraica in Sicilia nel Medioevo
103
E così fu anche il Sicilia, dove si incontravano e si confrontavano diverse
tradizioni culturali.
Inoltre, come osserva Anna Foa, nel primo Medioevo, periodo in cui gli ebrei
sono sparsi nel Mediterraneo, l’Italia meridionale è il centro di una presenza ebraica
fitta e culturalmente assai importante. E’ infatti proprio attraverso l’Italia meridionale che il Talmud penetra in Occidente.
È un ruolo decisivo di tramite quello che l’ebraismo dell’Italia meridionale
assume in questi secoli, diffondendo il Talmud nelle comunità ebraiche spagnole,
in quelle del Mediterraneo e poi attraverso la penisola, verso il Nord dell’Europa.
Roma e l’Italia meridionale, quindi, si pongono, fin verso la fine del primo millennio,
come i centri principali della diaspora occidentale.50
Infine vorrei fornire qualche rapido cenno sulla dibattuta questione della lingua usata dagli ebrei siciliani. Secondo i più recenti studi sembra conoscessero l’arabo, l’ebraico e quelli più colti, come i notai, anche il siciliano e il latino.
È certo, come attestano numerosi documenti, che scrivevano in giudeo arabo,
ossia in lingua araba con caratteri ebraici.
Molto probabilmente gli ebrei siciliani parlarono, fino all’espulsione, la lingua
araba, o meglio una sorta di dialetto magrebino.51
L’ebraico fu sempre lingua liturgica e dei documenti interni alla comunità.
L’uso dell’arabo, nella lingua parlata, rispondeva alla necessità di mantenere
l’identità culturale di fronte ai siciliani di religione cristiana e lingua neolatina; l’uso
dell’alfabeto ebraico li distingueva invece dagli arabi musulmani.
In tal modo gli ebrei siciliani, come sempre nella loro millenaria storia, si districavano tra mille difficoltà con la forte e perenne volontà di mantenere la propria identità.
Per concludere: queste pagine riassuntive sulla vita giuridica, economica, sociale, culturale delle svariate comunità sparse in Sicilia, a mio avviso, fanno emergere
ancora una volta che le condizioni di vita degli ebrei non sempre furono facili e felici.
Al contrario, i diversi obblighi cui erano sottoposti, le svariate “angherie” e
i veri e propri attacchi che subirono, attestano che in Sicilia, come nell’Europa del
tempo, al cui vertice stavano il papa e l’imperatore, era dominante l’ideologia del
perfidus judeos.
Negli stati in cui dominava la Chiesa gli ebrei erano una presenza accettata,
essi convivevano con i cristiani, ma tale convivenza era fondata su un’inferiorità
giuridica molto netta e definita. Era un equilibrio fondato sulla sottomissione, in cui
A. Foa, Ebrei in Europa. Dalla Peste Nera all’emancipazione. XIV-XIX secolo, Laterza 2004, p. 77.
B. Rocco, Le tre lingue usate dagli ebrei di Sicilia dal secolo XII al secolo XV, in Italia
Judaica V, pp. 355-369; id., Il giudeo-arabo e il siciliano nei secoli XII e XV. Influssi reciproci, in G.
Ruffino (a cura di ), Atti del XXI congresso internazionale di linguistica e filologia romanza, Palermo
18-24/9/1995, Palermo 1998; G. Sermoneta, La traduzione siciliana di Alfabetin di pentecoste e la
prova dell’esistenza di un dialetto siciliano, in Italia Judaica V, pp. 341-347.
50
51
104
Luciana Pepi
i due piatti della bilancia stanno uno sopra e uno sotto. Gli ebrei sono ciechi perché
non vedono la verità del Cristo, e sono naturalmente servi. Una servitù morale, evidentemente, che il diritto canonico riassume nella formula di perpetua servitù.
L’ebreo persistendo nel suo errore di negare la verità del cristianesimo doveva
essere tenuto in stato di sottomissione sociale e politica. Così il decreto di espulsione
di Ferdinando il Cattolico sarà l’ultimo atto di una storia di sofferenze, di soprusi, di
squallide prevaricazioni.
Concordo con quanto espresso dal Lagumina nell’introduzione al Codice: «la
popolazione cristiana non diede mai pace alla giudaica finché questa non fu violentemente scacciata. A me piacerebbe il provare coi documenti la tesi contraria, ma
non posso».52
E sulla stessa linea osserva Fabio Oliveri:
tollerante coi giudei in Sicilia non è nessuno. Né i musulmani né i normanni
né gli svevi né gli spagnoli: è il giudaismo che si tollera, perché rende bene.
Non i giudei in quanto uomini, che si preferisce discriminare. I giudei sono
servi della Regia camera, cioè proprietà dello stato: la loro funzione è produrre
ricchezza materiale e pagare tasse.53
Forse tutto questo, questa intolleranza, insieme alla cacciata del 1492, ha contribuito a far dimenticare, quasi a cancellare dalla memoria storica collettiva la numerosa presenza ebraica in Sicilia. È un dato di fatto che, esclusi gli specialisti della
materia, la maggior parte dei siciliani ignori che nel passato in Sicilia abitarono per
lungo tempo gli ebrei.
Occorre, a mio modesto avviso, interrogarsi sul senso di tale ignoranza54 e
certamente incrementare le ricerche e gli studi.
B. e G. Lagumina, Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia, cit., p. IX.
F. Oliveri, Giudei, fenici e musulmani di Sicilia, in Italia Judaica V, cit., p. 300.
54
Alcuni studiosi ipotizzano che si possa trattare di rimozione collettiva. Il fatto che la società
dominante avesse una visione negativa degli ebrei, insieme ai diversi attacchi ed eccidi di cui furono
vittime, ha possibilmente contribuito al fenomeno della rimozione. È necessario adoperarsi affinché ciò
non accada, e da poco stanno nascendo delle interessanti iniziative. Così, ad esempio nella città siciliana di Modica, dove nel 1474 furono uccisi 360 ebrei, nel 2007 il comune ha organizzato un convegno
sull’Ebraismo in Sicilia e a Modica, partendo dal dato che i modicani stessi non erano a conoscenza
dell’eccidio di ebrei avvenuto nella loro città.
52
53
Salvatore D’Agostino
La Sicilia di Federico III d’Aragona
Io son Manfredi,
nepote di Costanza imperadrice;
ond’ io ti priego che, quando tu riedi,
vadi a mia bella figlia, genitrice
de l’onor di Cicilia e d’Aragona,
e dichi ‘l vero a lei, s’altro si dice
(Dante, Purg., III, 112-117)
Morto Federico II Hohenstaufen (1250), Imperatore del Sacro Romano Impero d’Occidente e Rex Siciliae, lo scontro tra i due poteri universali, impero e papato,
non si placò.
La sua morte, infatti, avrà un grande riverbero sui successivi sviluppi degli
equilibri politici in Europa e nel mediterraneo.
Secondo le disposizioni testamentarie dell’imperatore svevo, alla sua morte,
il figlio Corrado avrebbe dovuto assumere sia il titolo imperiale che quello di Rex
Siciliae e, Manfredi, principe di Taranto, sarebbe divenuto vicario dell’Impero e reggente in Sicilia.
Papa Innocenzo IV, approfittando della delicata situazione interna del regno,
sempre particolarmente turbolente a causa della rissosa e insoddisfatta nobiltà regnicola, intervenne cercando di trovare una soluzione, a lui favorevole, alla successione
del trono di Sicilia, da sempre considerato feudo del papato.
Il pontefice, infatti, avviò una serie di trattative diplomatiche, con le più importanti corti europee, alla ricerca di un nuovo sovrano per l’Italia meridionale.
La prima scelta cadde su Riccardo di Cornovaglia, fratello di re Enrico III
d’Inghilterra e successivamente su suo figlio, Edmondo di Lancaster.
Intanto veniva anche sondata la disponibilità di Carlo d’Angiò, fratello di Luigi IX il Santo, re di Francia.
Le trattative tra la corte papale e quella inglese si protrassero per lungo tempo
senza mai riuscire a giungere ad un accordo definitivo.
Intanto, Manfredi, nel 1258, approfittando della favorevole situazione, si face
106
Salvatore D’Agostino
incoronare re a Palermo.
Questi impedimenti, comunque, non posero fine alla politica anti sveva del papato, anzi, con l’elezione al soglio pontificio del francese Urbano IV (1261), questa
acquisto nuova linfa.
Il nuovo pontefice puntò decisamente ad una soluzione francese per la corona
siciliana. Dichiarato decaduto Edmondo di Lancaster, visto che non aveva mai versato le somme dovute alla Chiesa per la sua nomina a re di Sicilia, la corona venne
offerta a Carlo d’Angiò.
Carlo, sfruttando anche degli interessi del fratello Luigi per l’Impero d’Oriente, accettò l’investitura e, il 6 gennaio 1266, si fece incoronare re. Il 26 febbraio dello stesso anno sconfisse, a Benevento, Manfredi ponendo fine all’ultima resistenza
sveva nel Regnum.1
Divenuto re, Carlo non riuscì a domare i siciliani. L’opposizione anti angioina,
infatti, si sviluppò molto velocemente, pilotata da alcune delle famiglie più in vista
del regno, come quella dei Capece, dei Filangeri, dei Lancia, dei Ventimiglia, e da
personaggi quali l’ammiraglio Ruggero Lauria e Giovanni da Procida, rimasti fedeli
all’ideologia imperiale sveva. Questi, morto Corradino, figlio Corrado IV e ultimo
degli Hohenstaufen, da loro scelto quale successore al trono di Sicilia, intrapresero
una serie di trattative con le corti europee alla ricerca di nuovo re e per denunciare gli
abusi commessi dagli angioini sull’isola. La scelta cadde, questa volta, su Federico
di Turinga, discendente per parte materna dall’imperatore svevo. Questa scelta, che
aveva risvegliato le coscienze della corrente ghibellina, tuttavia si rivelò fallimentare. Più fortuna ebbero in Aragona, dove Giacomo I il Conquistatore, interessato a
rafforzare la sua politica mediterranea al fine di trovare nuovi mercati per le compagnie catalane, aveva dato in moglie all’infante Pietro Costanza, figlia del defunto
re Manfredi di Sicilia.2
Il 31 marzo 1282, a Palermo, questo malcontento sfociò in una serie di tumulti, che passeranno alla storia come la rivolta dei Vespri. Scrive Amari:
La pasqua di resurrezione fu amarissima per nuovi oltraggi in Palermo; capitale antica del regno, che gli stranieri odiarono sopra ogni altra città, come
più ingiuriata e più forte. Sedeva in Messina Erberto d’Orléans vicario del
re nell’isola: il giustiziere di val di Mazzara governava Palermo; ed era questi Giovanni di San Remigio, ministro degno di Carlo. I suoi officiali, degni
del giustiziere e del principe, testè s’erano sciolti a nuova stretta di rapine
e di violenze. Ma il popolo sopportava. E avvenne che cittadini di Palermo,
1
F. Giunta, Il Vespro e l’esperienza delle Communitas Siciliae». Il baronaggio e la soluzione
catalano-aragonese dalla fine dell’indipendenza al Viceregno spagnolo, in Storia della Sicilia, vol. 3,
Napoli 1980, pp. 307-310.
2
Ibid., pp. 311-315.
La Sicilia di Federico III d’Aragona
107
cercando conforto in Dio dalle mondane tribolazioni, entrati in un tempio a
pregare, nel tempio, nei dì sacri alla passione di Cristo, tra i riti di penitenza
e di pace, trovarono più crudeli oltraggi. Gli scherani del fisco adocchian tra
loro i debitori delle tasse; strappanli a forza dal sacro luogo; ammanettati li
traggono al carcere, ingiuriosamente gridando in faccia all’accorrente moltitudine: «Pagate, paterini, pagate». E il popolo sopportava. Il martedì appresso
la pasqua, cadde esso a dì trentuno marzo, una festa si celebrò nella chiesa di
Santo Spirito. Allora brutto oltraggio a libertà fu principio; il popolo stancossi
di sopportare. Del memorabil evento or narreremo quanto gli storici più degni
di fede n’han tramandato [...] Per questo allor lieto campo, fiorito di primavera,
il martedì a vespro, per uso e religione, i cittadini alla chiesa traeano: ed eran
frequenti le brigate; andavano, alzavan le mense, sedeano a crocchi, intrecciavano lor danze: fosse vizio o virtù di nostra natura, respiravan da’ rei travagli
un istante, allorchè i famigliari del giustiziere apparvero, e un ribrezzo strinse
tutti gli animi. Con l’usato piglio veniano gli stranieri a mantenere, dicean essi,
la pace. A ciò mischiavansi nelle brigate, entravano nelle danze, abbordavan
dimesticamente le donne: e qui una stretta di mano; e qui trapassi altri di licenza; alle più lontane, parole e disdicevoli gesti. Onde chi pacatamente ammonilli se n’andasser con Dio senza far villania alle donne, e chi brontolò; ma
i rissosi giovani alzaron la voce sì fieri, che i sergenti dicean tra loro: «Armati
son questi paterini ribaldi, ch’osan rispondere»; e però rimbeccarono ai nostri
più atroci ingiurie; vollero per dispetto frugarli indosso se portasser arme; altri
diede con bastoni o nerbi ad alcun cittadino [...] In questo una giovane di rara
bellezza, di nobil portamento e modesto, con lo sposo, coi congiunti avviavasi
al tempio. Droetto francese, per onta o licenza, a lei si fa come a richiedere
d’armi nascose; e le dà di piglio; le cerca il petto. Svenuta cadde in braccio
allo sposo; lo sposo, soffocato di rabbia: «Oh muoiano, urlò, muoiano una
volta questi Francesi!». Ed ecco dalla folla che già traea, s’avventa un giovane; afferra Droetto; il disarma; il trafigge; ei medesimo forse cade ucciso
al momento, restando ignoto il suo nome, e l’essere, e se amor dell’ingiuriata
donna, impeto di nobil animo, o altissimo pensiero il movessero a dar via così
al riscatto. I forti esempi, più che ragione o parola, i popoli infiammano. Si
destaron quegli schiavi del lungo servaggio: «Muoiano, muoiano i Francesi!»
gridarono; e ‘l grido, come voce di Dio, dicon le istorie de’ tempi, eccheggiò,
per tutta la campagna, penetrò tutti i cuori. Cadono su Droetto vittime dell’una
e dell’altra gente: e la moltitudine si scompiglia, si spande, si serra; i nostri con
sassi, bastoni, e coltelli disperatamente abbaruffavansi con gli armati da capo a
piè; cercavanli; incalzavanli; e seguiano orribili casi tra gli apparecchi festivi,
e le rovesciate mense macchiate di sangue. La forza del popolo spiegossi, e
soperchiò. Breve indi la zuffa; grossa la strage de’ nostri: ma eran dugento i
Francesi, e ne cadder dugento. Alla quieta città corrono i sollevati, sanguinosi,
ansanti, squassando le rapite armi, gridando l’onta e la vendetta: «Morte ai
Francesi!» e qual ne trovano va a fil di spada. La vista, la parola, l’arcano linguaggio delle passioni, sommossero in un istante il popol tutto. Nel bollor del
tumulto fecero, o si fece dassè condottiero, Ruggier Mastrangelo, nobil uomo:
108
Salvatore D’Agostino
e il popolo ingrossava; spartito a stuoli, stormeggiava per le contrade, spezzava
porte, frugava ogni angolo, ogni latebra: «Morte ai Francesi!» e percuotonli, e
squarcianli; e chi non arriva a ferire, schiamazza ed applaude.3
Il parlamento siciliano, riunito a Palermo, sfruttando l’occasione favorevole,
cercò una via autonoma e inviò i suoi ambasciatori a Pietro III d’Aragona, che si
trovava, in quei giorni, a Port Fangos pronto per salpare per le coste tunisine, e gli
offrirono la corona siciliana. La risposta di Pietro non si fece attendere. Immediatamente diresse la sua flotta, comandata dall’ammiraglio Ruggero Lauria, verso la
Sicilia e il 30 agosto 1282 sbarcò a Trapani. L’insurrezione, così, si trasformò in vero
e proprio conflitto che vedeva opposti, da una parte, siciliani ed aragonesi, dall’altra
angioini, papato e francesi.
Il 26 settembre 1282 re Carlo d’Angiò, sconfitto, faceva ritorno a Napoli, lasciando la Sicilia nelle mani degli aragonesi. Nello stesso anno papa Martino IV
scomunicò Pietro e tutti i siciliani per essersi opposti alla sua volontà.
Pietro, nominato dal parlamento re di Sicilia, prese l’impegno di tenere distinti
i regni di Sicilia e di Aragona: il re avrebbe nominato un luogotenente che in sua
assenza avrebbe regnato in Sicilia. Così quando Pietro fu richiamato in Aragona, per
assumerne la corona, lasciò la luogotenenza al figlio Alfonso III.
Il 19 giugno 1291 Alfonso, re d’Aragona dal 1285, morì improvvisamente
lasciando il regno al fratello Giacomo II e disponendo che la Sicilia andasse al fratello più giovane Federico; ma Giacomo dopo essersi fatto incoronare a Saragozza
nel mese di luglio, come successore di Pietro III e non di Alfonso III, ne trascurò il
testamento e si tenne il regno di Sicilia, a scapito di Federico. L’infante Federico,
nello stesso 1291, fu nominato luogotenente del fratello in Sicilia.
Il primo obbiettivo di re Giacomo fu di porre fine alla situazione che vedeva
l’Aragona in perenne lotta contro il papato e la Francia per la corona siciliana. La
situazione si sbloccò dopo l’elezione al papato, 23 dicembre 1294, di Bonifacio VIII,
che, elaborando la proposta del suo predecessore, papa Celestino V, ad Anagni, il
12 giugno del 1295, stipulò un trattato con Giacomo II e con Carlo II d’Angiò. Con
questo accordo, Giacomo acconsentì a cedere la Sicilia; in cambio avrebbe ottenuto
i feudi di Sardegna e di Corsica, se li avesse saputi conquistare, e avrebbe sposato la
figlia di Carlo II d’Angiò; mentre Federico, che perdeva il governatorato della Sicilia
sarebbe stato compensato dal matrimonio con l’erede dell’impero d’oriente, Caterina Courtenay, figlia dell’imperatore Filippo I di Courtenay e Beatrice d’Angiò, con
l’impegno di aiutare il futuro suocero a riconquistare l’impero.
Il re di Francia, Filippo IV il Bello, pur approvando il Trattato di Anagni,
rifiutò di accettare quest’ultima clausola e, in quello stesso anno, il fidanzamento tra
3
M. Amari, La guerra del Vespro siciliano, Parigi 1843, pp. 56-57.
La Sicilia di Federico III d’Aragona
109
Federico e Caterina fu rotto.
Federico, amareggiato, oltre che dalla rottura del fidanzamento, anche dal fatto che Giacomo non aveva ottemperato al testamento di Alfonso, accettò le offerte
dei Siciliani che, sentendosi traditi dal nuovo re Aragonese, lo dichiarano decaduto,
e elessero al trono di Sicilia Federico.
L’11 dicembre 1295, a Palermo, Federico fu proclamato Signore della Sicilia
e, il 15 gennaio 1296, il Parlamento siciliano riunito al Castello Ursino di Catania lo
riconobbe Federico III Re di Sicilia. L’incoronazione ufficiale avvenne, il 25 marzo
del 1296, nella Cattedrale di Palermo.
A farsi interprete del sentimento popolare fu l’ammiraglio Ruggero Lauria nel
suo discorso rivolto a Federico in occasione della sua elezione. Secondo la cronaca
di Muntaner, l’ammiraglio espose, nel suo discorso, i tre motivi che dimostravano
come il giovane Federico fosse quel terzo Federico designato dalla profezia4 e destinato ad essere, come i suoi predecessori, il signore del mondo.5
I motivi, secondo Lauria, erano evidenti: Federico era il terzo figlio di re Pietro,
nato dopo Alfonso e Giacomo; egli era il terzo Federico che dominava sulla Sicilia;6
egli era quel Federico che, secondo la profezia, sarebbe dovuto diventare imperatore di
Germania e che avrebbe condotto l’umanità ad uno stato di pace e felicità.7
Nel titolo che egli assunse, una volta incornato, era già esplicito il programma di governo, cioè quello di restaurare l’antico regno siciliano. La Sicilia ebbe in
Federico d’Aragona il suo primo re «nazionale». La sua elezione, avvenuta qusi per
vim raptus, era una creazione del popolo siciliano. Lo stesso Federico non esitò mai
a riconoscerlo.8
Francesco Testa, nel ricordare il giorno dell’incoronazione di Federico, scrive:
[...] Federico, che allora contava venticinque anni, fu salutato re di Sicilia, duca
di Puglia e principe di Capua nella cattedrale di Palermo; dall’arcivescovo di
Palermo [...] fra la grande affluenza di vescovi, di nobili e di popolo, e con
4
La profezia cui si fa riferimento fece la sua comparsa dopo la morte di Corradino e si faceva
risalire all’abate Gioacchino da Fiore. Secondo questa profezia, il leone di Francia avrebbe strappato la
corona regale dal capo di Manfredi. Allora sarebbe giunto il figlio dell’aquila che avrebbe indebolito il
leone ma non sarebbe riuscito a sconfiggerlo. Il leone avrebbe regnato per poco tempo perché sarebbe
arrivato un Federico che avrebbe sconfitto ed annientato il leone. Questo Federico avrebbe dominato il
mondo durante il tempo, avrebbe catturato il papa e disperso il clero. Infine, spagnoli e tedeschi, insieme, avrebbero sconfitto la Francia.
5
A. De Stefano, Federico III d’Aragona Re di Sicilia (1296-1337), Bologna 1956, p. 98.
6
Il calcolo comprendeva tra i dominatori della Sicilia anche Federico Barbarossa che, combinando il matrimonio del figlio Enrico con Costanza, aveva determinato il passaggio della Sicilia alla
casa sveva.
7
Ibid., cit., p. 99.
8
Ibid., pp. 102-103.
110
Salvatore D’Agostino
tanta gioia e sontuosità, come mai se ne vide. Le strade erano cosparse di mirto
e addobbate le chiese; i fiori, i portici, le piazze, i vicoli e ogni altro luogo della
città, sia pubblico che privato [...] Tutta la città echeggiava di suoni di trombe,
timpani, arpe, sitri, lire, cetre accompagnati da ogni genere di musiche e di
canti. Si allestirono giochi, tornei e altri spettacoli. Non si trascurò nulla che
non mostrasse il plauso generale e la gioia. E ciò non solo a Palermo: in tutta
l’Isola non ci fu una sola città, ciascuna secondo le proprie facoltà, che non abbia gareggiato con la capitale nei festeggiamenti, sicché si vide tutta la Sicilia
esultare di letizia. I Siciliani non finivano di godere e compiacersi di avere un
proprio sovrano nel fiore degli anni, cui non difettava alcuna dote del corpo e
dello spirito, cresciuto e allevato presso di loro, che amava la Sicilia come la
propria patria, ornato di virtù e saggezza, che era adatto non solo a difendere lo
Stato, ma anche ad esaltarlo.9
Federico, forte di questa investitura, riprese la guerra del Vespro e prendendo
l’iniziativa nei confronti degli Angioini e portando la guerra in Calabria e nel napoletano. Allora, Bonifacio VIII, agli inizi del 1297, convocò a Roma sia Giacomo II che
Carlo II d’Angiò e li spronò a riconquistare la Sicilia secondo il Trattato di Anagni.
In conseguenza a quest’accordo Giovanni da Procida e Ruggero di Lauria dovettero
abbandonare la Sicilia, per ordine di Giacomo, e alla fine anche la regina madre
Costanza dovette abbandonare il figlio prediletto Federico e raggiungere Giacomo.
Giacomo intervenne, a fianco degli Angioini, contro il fratello Federico ed i
siciliani e con la flotta aragonese, affiancata da quella napoletana, a Capo d’Orlando, nel luglio del 1299, sconfisse Federico che si riuscì a salvare con solo 17 galee.
Giacomo, l’anno dopo, vista la tenace resistenza del fratello, fece ritorno in Aragona.
La guerra ora era in Sicilia, dove il duca di Calabria, Roberto, col fratello, Filippo
I di Taranto, avevano conquistato Catania e cinto d’assedio Messina. Federico però
riportò una notevole vittoria nella piana di Falconara (Trapani) e resistette a Messina
e Calabria, facendo prigioniero Filippo. Allora il papa, nel 1300, chiamò in aiuto
i templari, gli ospitalieri ed i riluttanti Genovesi, ma ad eccezione di una nuova
brillante vittoria della flotta di Lauria su quella siciliana, il 14 giugno del 1300, la
situazione non progredì. Infine Bonifacio VIII si rivolse al re di Francia, Filippo IV
il Bello, che inviò un esercito al comando del fratello, Carlo di Valois, che, arrivato
in Sicilia, nel maggio del 1302, bruciando e depredando, l’attraversò sino a Sciacca,
dove però arrivò distrutto dalla malaria e, per la paura di un deciso attacco da parte
di Federico, accettò la pace che gli venne offerta. Allora, da Carlo di Valois, Carlo
II d’Angiò e dal papa, fu proposto a Federico di sposare Eleonora, la figlia di Carlo
II lo Zoppo e di Maria d’Ungheria e sorella del duca di Calabria Roberto; durante
9
F. Testa, Vita e opere di Federico II re di Sicilia. Introduzione di S. Fodale. Traduzione di E.
Spinnato, Palermo 2006, pp. 51-52.
La Sicilia di Federico III d’Aragona
111
la trattativa fu offerto a Federico, in cambio della Sicilia, il regno di Albania, creato
per lui oppure il regno di Cipro, dopo averlo tolto alla famiglia Lusignano. Federico
rifiutò, ma, nell’agosto del 1302, fu trovato un compromesso che prevedeva che
Federico III mantenesse il potere sulla Sicilia col titolo di Rex Trinacriae (il titolo di
Rex Siciliae spettava solo al re di Napoli) fino alla sua morte, dopo la quale l’isola
sarebbe dovuta passare nuovamente agli Angiò.
La guerra dei Vespri siciliani terminò con la pace di Caltabellotta: il 31 agosto
del 1302, probabilmente nel castello del Pizzo, si firmò il trattato di pace. Questo
trattato, modificato dal papa il 12 maggio 1303, comunque confermò che Federico
III mantenesse il potere sulla Sicilia, portatagli in dote dalla moglie Eleonora, col
titolo di Re di Trinacria e dopo la sua morte l’isola sarebbe dovuta passare nuovamente agli Angiò. Il matrimonio con Eleonora venne celebrato nel maggio 1303, a
Messina. Comunque Eleonora era al suo secondo matrimonio, avendo sposato in
prime nozze, nel 1299, Filippo di Toucy, futuro Principe di Antiochia (dalla madre,
Luisa di Antiochia) futuro Signore di Terza (dal padre, Nariot di Toucy). Il matrimonio era stato annullato dalla bolla di papa Bonifacio VIII, il 17 gennaio 1300, per la
troppo giovane età della sposa.
Nonostante il trattato fosse stato firmato non fu vera pace. Il termini dell’accordo, infatti, soddisfacevano più le esigenze del papato che quelle dei due regni,
Napoli e Sicilia.
Gli angioini, con la creazione di un regno siciliano indipendente, vedevano
notevolmente ridotti i propri territori e, in particolar modo, perdevano forze e risorse,
la cui mancanza non avrebbe reso possibile una politica espansionistica.
Il re di Trinacria, che vedeva legittimato il proprio titolo, perdeva ogni garanzia di successione dinastica al trono di Sicilia.
La pace, in realtà, durò solo pochi anni. Già nel 1313, la guerra tra angioini
e aragonesi era ripresa. Il parlamento siciliano, il 12 giugno 1314, disattendendo
l’accordo siglato con la Pace di Caltabellotta, riconosceva il figlio di Federico, Pietro
come erede al trono, e quindi, alla sua morte, successore di Federico, e, il 9 agosto,
confermava Federico re di Sicilia e non più di Trinacria. Seguirono due anni di guerra, in cui Roberto d’Angiò cercò di conquistare l’isola (1314), a cui seguì una tregua
di due anni, sino al 1316.
Allo scadere della tregua, Roberto attaccò la Sicilia occidentale e si diresse su
Palermo, su cui confluiva anche la flotta napoletana. Federico, preso alla sprovvista
e preoccupato di essere sconfitto, nel 1317, chiese una tregua che gli fu concessa a
patto di restituire agli angioini tutte le posizioni che ancora deteneva sul continente
(quasi tutte in Calabria). La nuova tregua sarebbe scaduta a Natale del 1320.
Finita la tregua, Federico, nel 1321, inviò una flotta con reparti di cavalleria
di fronte a Genova, in aiuto dei ghibellini che combattevano contro la repubblica
di Genova, ma Roberto d’Angiò, alleato di Genova, inviò 82 galee che costrinsero
la flotta siciliana a ritirarsi e rientrare in Sicilia. Nel settembre dello stesso anno, la
112
Salvatore D’Agostino
flotta siciliana tornò a Genova e coordinando gli attacchi con le truppe dei ghibellini
lombardi, capitanati da Marco Visconti, riuscì a creare grandi difficoltà per i difensori, senza però riuscire a fare cadere la città. A causa del cattivo tempo, la flotta fu
molto danneggiata e dovette rientrare definitivamente in Sicilia.
Sempre nel 1321, Federico aveva fatto incoronare il figlio Pietro come reggente e suo successore, attirandosi le ire di papa Giovanni XXII, che scagliò l’interdetto sulla Sicilia (lo tolse solo nel 1334, poco prima di morire).
Il trattato di Caltabellotta più che una soluzione definitiva rappresentò un tentativo di tregua che consentiva ai due re di preparasi per un ulteriore svolgimento
dell’azione politica e militare.10
La Sicilia usciva da questo periodo di incertezze particolarmente indebolita.
Infatti, il continuo stato di guerra con gli Angiò aveva reso impossibile qualsiasi tipo
di crescita economica. Le città costiere erano continuamente esposte alle scorribande e alle razzie della marina angioina. L’entroterra era arretrato e in mano ai grandi
feudatari. I mercanti catalani e del nord Italia, presenti sull’isola, erano interessati
esclusivamente al commercio del grano incentivando, in questo modo, la monocultura e indebolendo il sistema agrario.
Particolarmente critica era, anche, la situazione religiosa. I beni ecclesiastici,
prima dell’arrivo degli aragonesi sull’isola, era stati oggetto delle aggressioni degli
angioini e, successivamente, da parte dei baroni, tanto che la Chiesa giunse a considerarsi il capro espiatorio della società. Federico cercò con ogni mezzo di trovare il
giusto equilibrio tra la propria intensa religiosità e il desiderio di trattare la Chiesa
con la dovuta deferenza.
Scrive Backman:
Caltabellotta liberò d’un sol colpo due decenni di energia spirituale repressa
nella popolazione, sia nelle classi sociali alte che in quelle più umili, giacché
un interdetto ecclesiastico aveva proibito a lungo in Sicilia la celebrazione dei
sacramenti che erano ritenuti necessari per la salvezza. Tutti i sostenitori del
regime catalano (per non dire il regime stesso), inoltre, erano stati denunciati
ripetutamente e scomunicati da ogni papa fin da quando, il 7 maggio 1282,
Martino IV li aveva paragonati alla folla che aveva voluto la crocifissione di
Cristo. Ad ogni modo i Siciliani, animati dal fatto che erano riusciti a scacciare gli Angioini con successo, difficilmente avrebbero potuto sostenere un tale
castigo con serenità. Il divieto di celebrazioni dei sacramenti era stato assoluto
[...] Le conseguenze furono enormi. La lunga separazione della Chiesa suscitò
nei Siciliani più anziani grande ansia, risentimento e incertezza [...] Che beneficio avevano tratto all’indipendenza politica conquistata, se in quel processo
avevano perso la loro anima? Gli anni del Vespro furono costellati da paure di
10
A. De Stefano, Federico III d’Aragona, cit., pp. 127-128.
La Sicilia di Federico III d’Aragona
113
questo genere e i numerosi doni destinati alle chiese locali e ai monasteri erano
un riflesso di questa preoccupazione.11
Federico, che fin dalla sua giovinezza, si era mostro pio e animato da un grande spirito religioso, dal 1305 divenne discepolo di Arnaldo di Villanova, un medico
catalano, divenuto mistico, che aveva trovato rifugio in Sicilia dopo essersi inimicato, a causa delle sue teorie, sia il re d’Aragona Giacomo II sia il pontefice. Arnaldo
aveva identificato in Federico di Sicilia il «re eletto da Dio», di cui si parla nelle
profezie di Gioacchino da Fiore, che avrebbe avuto il gravoso compito di condurre
tutta la cristianità contro le armate dell’Anticristo, la cui venuta era ormai imminente. Divenuto consigliere spirituale del re, Arnaldo, durante il suo soggiorno siciliano,
dedicò al suo sovrano un tratto, l’Allocutio Christini. In questa, partendo dall’asserzione che l’uomo è l’unico essere creato da Dio in grado di comprenderne il piano
della salvezza, il principe ha il compito di portare a termine i cambiamenti e le riforme necessarie per la purificazione della cristianità. Arnaldo, dunque, esorta Federico
ad intraprendere una riforma della vita spirituale siciliana e ad amministrare il regno
con uno spirito conforme ai doveri del perfetto re cristiano.
Dal 1305 in poi, infatti, tutta la corte siciliana partecipò al programma di riforma
spirituale del sovrano, incrementando la restaurazione ecclesiastica, la fondazione di
chiese e aumentando lo sforzo per sradicare la corruzione nell’amministrazione.
Nel 1310, in occasione di un suo secondo soggiorno in Sicilia, Arnaldo compose un altra opere per re Federico, l’Informació espiritual, scritta in lingua catalana,
dove esorta il sovrano a mantenere un impegno più rigoroso nella riforma personale
e ad una osservanza dei due maggiori doveri di un veri re cristiano: promuovere l’utilità pubblica e garantire la giustizia a tutti i sudditi, ricchi o poveri, nativi o stranieri.
Anche alla regina Eleonora vennero affidati, nell’Informació espiritual, due
compiti fondamentali: durante le periodiche visite agli indigenti la regina avrebbe
dovuto indossare, insieme alle sue due ancelle, vesti di lino, in modo da simboleggiare la Fede accompagnata dalla Speranza. In secondo luogo, la regina avrebbe
dovuto censurare tutti quei libri che erano incentrati sulla vita mondana e avrebbe
dovuto leggere, in vernacolo, alla prole reale, la Sacre Scritture ogni domenica e in
tutte le festività. La corte rispose con grande entusiasmo alle iniziative di Arnaldo,
redigendo una nuova legislazione che rispecchiava in pieno i consigli del medico
catalano e che per lungo tempo furono catalogate tra i suoi scritti.12
Il periodo di tregua che segue Caltabellotta è caratterizzato, anche, dall’espansionismo siciliano verso le coste africane e il mar Egeo.
11
C. R. Backman, Declino e caduta della Sicilia medievale. Politica, religione ed economia
nel regno di Federico III d’Aragona Rex Siciliae (1296-1337). Edizione italiana a cura di A. Musco,
Palermo 2007, pp. 179-180.
12
Ibid., pp. 193-197.
114
Salvatore D’Agostino
La prima occasione per Federico si presentò nel 1305. Gli abitanti dell’isola
di Gerba, feudo dell’ammiraglio Lauria, dopo la sua morte, erano insorti, istigati dal
signore di Tunisi.
Federico, allora, decise di intervenire in aiuto di Ruggerone, figlio dell’ammiraglio, che si trovava presso la corte siciliana.
Scrive De Stefano:
pervenutane notizia alla Corte siciliana, presso la quale trovavasi Ruggero (o
Ruggerone) figlio del grande ammiraglio, questi, con l’aiuto di re Federico,
apparve nella primavera dello stesso anno con 6 galere armate nelle acque
della grande Sitri. Ma già i Saraceni, avuto sentore della spedizione siciliana,
avevano si dalla metà di marzo abbandonato l’isola ai cristiani.13
In realtà re Federico non riuscì mai ad assicurarsi il controllo definitivo dell’isola,
sempre turbolenta, fino a quando, nel 1336, fu costretto ad abbandonare l’impresa.
Federico non fu più fortunato nella riscossione del tributo, dovuto da Tunisi, sin
dall’epoca dei normanni, al re di Sicilia. Su di esso vantavano diritti, stabiliti nei recenti
trattati, sia il re di Francia sia il re d’Aragona, oltre che quello di Napoli e di Sicilia.
Le mire espansionistica della Sicilia si rivolsero anche verso l’oriente, che da
sempre aveva attirato le attenzioni degli isolani.
Dopo la pace di Caltabellotta si presentò l’opportunità: l’imperatore bizantino, Andronico II Paleologo, chiese l’appoggio della Sicilia contro i Turchi che minacciavano, da tempo, la Grecia.
I siciliani, ansiosi di reindirizzare l’ampio numero di mercanti catalani, utili
ed indispensabili durante la guerra ma pericolosi durante il periodo di pace, e degli
almogàvers, un gruppo specializzato della fanteria catalana, che non conosceva altra
attività che la guerra, accolsero l’invito dell’imperatore. La «Compagnia Catalana»,
mandata in suo aiuto, ottenne numerose vittoria contro i Turchi, tanto che lo stesso l’imperatore era preoccupato che Ruggero da Flor, comandate della Compagnia, aspirasse,
per se e i suoi compagni, ad una ricompensa maggiore di quella pattuita. Andronico, allora, comandò l’omicidio di Ruggero. Questo provocò il risentimento della Compagnia,
che si alleò con i Turchi contro cui aveva combattuto fino al quel momento.
Nel 1311, la «Compagnia Catalana» invitò Federico a dichiararsi sovrano del
ducato di Atene. Federico nominò il figlio Manfredi, duca di Atene e, l’altro figlio,
illegittimo, Alfonso Federico, capitano-generale del ducato. L’idea di Federico di
mantenere il controllo del ducato e di usarlo come base per estendere il suo dominio in oriente fu subito evidente. Tuttavia la presenza siciliana in Grecia comportò
un ulteriore peso sulle già scarse risorse del regno e inasprì la posizione di papato
e angioini. Entrambi intendevano minare la base economica e politica della Sicilia
13
A. De Stefano, Federico III d’Aragona, cit., p. 130.
La Sicilia di Federico III d’Aragona
115
invadendo, o minacciando di invadere, l’isola o il ducato d’Atene.
La Sicilia beneficiò poco di questi domini orientali. L’impossibilità di stabilire
una relazione efficace tra il regno e il ducato, fecero si che questo diventasse per la
Sicilia un peso che più una fonte di benefici, un territorio debole che continuava a
mantenersi grazie alle continue elargizione del demanio regio.14
La tensione tra aragonesi e angioini continuava a rimaneva tesa. Questa si
inasprì nuovamente quando Federico III decise di appoggiare la campagna in Italia
del nuovo imperatore Enrico VII di Lussemburgo.
Papa Clemente V, che si trovava lontano da Roma, nominò suo vicario Roberto d’Angiò al fine di tutelare i propri domini e la fazione guelfa messi in serio
pericola da questa nuova alleanza. Federico, intanto, inviava i suoi ambasciatori per
concludere gli accordi con l’imperatore. Questi, nominò Federico III ammiraglio
della flotta imperiale, prefetto delle regioni costiere e comandante supremo delle
forze marittime. Nel 1313 Federico salpava con la sua flotta, compresa quella pisana, alla volta delle coste calabre, dove in pochi giorni riuscì a conquistare Reggio.
Nonostante le vittorie riportate il re di Sicilia fu costretto a dirigersi verso Gaeta, per
ordine dell’imperatore, dove tutte le forze si sarebbero congiunte e avrebbero tentato
di varcare i confini del regno angioino. Mentre la flotta si dirigeva verso il luogo stabilito per il ricongiungimento Federico III fu raggiunto dalla notizia della prematura
morte dell’imperatore Enrico.15
Federico si trovò nuovamente solo contro i molti nemici coalizzati contro di lui e
tutte le sue ambizioni subirono una battuta d’arresto e fu costretto a ritornare in Sicilia.
Nel decennio che va dalla morte di Enrico VII alla venuta di Ludovico il Bavaro, Federico, che da sempre aveva impresso alla sua politica un carattere aggressivo ed espansionistico, si ripiegò su se stesso preoccupato di difendersi dai continui
tentavi di Roberto d’Angiò di riconquistare l’isola.16
Scrive Testa:
E invece Roberto, che ormai aveva deciso di rinnovare la guerra contro Federico perché aveva cospirato con Enrico alla sua rovina, furibondo ed eccitato
non solo dallo stimolo che già da tempo lo faceva smaniare di occupare la
Sicilia, ma anche di vendicare la recente ingiuria, si affrettava ad utilizzare
contro Federico quello stesso esercito che aveva pronto per respinger le forze
di Enrico [...] Mentre Federico disponeva queste cose a sua protezione, aveva
infuso coraggio in Roberto un responso sull’esito della spedizione, dato dagli
indovini consultati da alcuni cardinali [...] secondo cui avrebbe preso la Sicilia
14
C. R. Backman, Declino e caduta, cit., pp. 59- 63.
F. Testa, Vita e opere di Federico II, cit., pp. 166-169.
16
A. De Stefano, Federico III d’Aragona, cit., p. 184.
15
116
Salvatore D’Agostino
e ne avrebbe riportato le spoglie.17
Nel 1327 morì Giacomo II re d’Aragona. In quello steso anno un altro imperatore preparava una campagna militare in Italia: Ludovico il Bavaro. A differenza del
suo predecessore Enrico, Ludovico era in aperto conflitto con il papato e un deciso
sostenitore della fazione ghibellina. Federico, nonostante la precedente avventura
si fosse dimostrata un fallimento, cercò un’alleanza con il nuovo imperatore. Il 17
marzo 1326, a Messina, i delegati delle due parti siglarono un trattato di alleanza difensiva e offensiva. L’accordo prevedeva, anche, che Elisabetta, figlia di re Federico,
andasse in moglie a Stefano, futuro duca di Baviera, secondogenito dell’imperatore.
L’alleanza, secondo una clausola, sarebbe entrata in vigore solo se Ludovico fosse
giunto in Italia entro l’anno. Ciò non avvenne, poiché l’imperatore era impegnato a
pacificare la Germania, e l’accordo decadde. L’anno successivo, 1327, ne fu firmato
un altro, identico nei termini a quello di Messina, ma questa volta perpetuo.
Questa alleanza nelle intenzioni di Ludovico doveva principalmente servirgli
alla deposizione del papa e a sconfiggere la resistenza dei suoi nemici in Italia; per
Federico, invece, questa doveva servire ad indebolire la potenza angioina ma non
intaccare l’autorità spirituale della Chiesa della quale egli si dichiarò sempre figlio
sincero e devoto.18
Nel 1328 Ludovico, a Roma, nominò un anti papa e si fece incoronare imperatore. Vista la situazione favorevole, la flotta siciliana, comandata da re Pietro, figlio
di Federico, il 6 agosto, salpò alla volta di Roma dove avrebbe dovuto ricongiungersi
con l’esercito imperiale. Ma la speranza dei siciliani fu tradita. Infatti, Ludovico
decise di abbandonare Roma. I futuri incontri tra le due delegazioni si rivelarono un
fallimento. Il 28 settembre, l’imperatore con il suo esercito e le sue insegne abbandonarono l’Italia. Pietro, con la sua flotta, decimata da una violenta tempesta, face
ritorno in Sicilia.
Federico morì il 25 giugno del 1337.
Il re di Sicilia aveva dichiarato nel testamento di voler esser sepolto a san
Francesco nella città di Barcellona, accanto al fratello Alfonso d’Aragona e alla madre Costanza. Tale allontanamento da Palermo sarebbe stato inaccettabile per i siciliani e quindi modificò le sue volontà e dispose per una sepoltura nella cattedrale
nel capoluogo. La salma venne quindi tumulata provvisoriamente nella Cattedrale
di Catania, in attesa traslazione a Palermo. A causa del perdurare della guerra del
Vespro la salma rimase definitivamente a Catania.
Scrive De Stefano:
17
18
F. Testa, Vita e opere di Federico II, cit., pp. 170-171.
A. De Stefano, Federico III d’Aragona, cit., p. 223.
La Sicilia di Federico III d’Aragona
117
[…] L’aquila che, secondo l’espressione della letteratura profetica, aveva affrontato con tanta baldanza il leone, appariva ora stanco ed inerte. Il suo animo
si andava riempiendo di tristezza […] Quante occasioni mancate che erano
sembrate decisive, quante speranze tramontate erano parse certezza. Dopo 40
anni di regno, colmo di avvenimenti drammatici e di situazioni impensate,
dopo aver lottato con parecchi papi, e aver avuto alleati o nemici parecchi re
ed imperatori, dopo essere stato più di una volta sfiorato dall’ala della vittoria,
egli era appena riuscito a difendere e salvaguardare l’indipendenza del regno,
e solo a prezzo della prosperità del paese. Lasciava, è vero, il trono al suo
figliuolo Pietro ma un trono più che mai sbattuto dalle tempeste […] Il suo
animo era colmo di ansie, di preoccupazioni, di timore, per il presente e ancor
più per l’avvenire, quando, nel maggio del 1337, egli aveva voluto recarsi a
Castrogiovanni per passarvi l’estate. Per via, a Resuttana, un grave malore lo
colse improvvisamente. Presago della sua fine imminente, volle essere trasportato a Catania, presso le reliquie di Sant’Agata, a cui egli era particolarmente
devoto. Ma tra Paternò e Catania, in un convento di Cavalieri di S. Giovanni,
il 25 giugno 1337, moriva.19
19
Ibid., p. 244-245.
Vincenzo M. Corseri
Religione e politica in Europa nella prima metà del Quattrocento.
Cusano e Piccolomini a Basilea
Il presente contributo1 è volto a sfatare – anche se in un preciso ambito fattuale e cronologico, quello del Concilio ecumenico di Basilea (1431-1449) – gli idola
ereditatici da una certa storiografia che vuole mostrarci il Quattrocento ancora come
il secolo dell’ottimismo ad oltranza. Grazie alle recenti analisi di alcuni eminenti
storici della cultura filosofica e religiosa dell’Umanesimo italiano – come Eugenio
Garin, Kurt Flasch, Remo L. Guidi ecc. –, è stato finalmente possibile far emergere le veridiche peculiarità di quest’epoca, contrassegnata da fragilità, dal continuo
riproporsi dell’idea della morte, dal problematicismo esistenziale degli uomini più
rappresentativi; è una condizione socio-culturale, quella del XV secolo, indubbiamente complessa, sfaccettata e drammatica, che può essere considerata per prima
cosa in riferimento «allo smarrimento del popolo ad opera di una classe politicoecclesiastica senza idee (impressionanti risultano le stroncature dei papi), e nell’attesa sofferta per una palingenesi che avrebbe dovuto rinnovare un mondo, ormai,
inabile a risollevarsi».2 La fase inquieta, quella della storia europea ed italiana in
particolare, è, pertanto, una fase che presenta una società in continua tensione in cui
molti maturano la dolente consapevolezza di aver perso ogni orientamento, «di sentirsi sbattuti dalla violenza di grandi acque, di non ricevere congrue garanzie dagli
studia humanitatis, di vivere in una posizione altalenante tra dialettica della fede e
la diffidenza del raziocinio, tra voglia di darsi a gesti intrepidi e quella di deprimersi
con capitolazioni pusillanimi».3
Vedremo come questa condizione riguarderà, tra luci e ombre, anche l’attività
1
Questo scritto è stato anticipato, in versione ridotta, su «Mediaeval Sophia» 7 (gennaio-giugno
2010). Si ringraziano i proff. Walter A. Euler, dell’Institut für Cusanus-Forschung di Treviri, e Sandro
Mancini, dell’Università degli Studi di Palermo, per gli emendamenti e i consigli seguiti alla lettura
del testo.
2
R. L. Guidi, L’inquietudine del Quattrocento, Roma 2007, p. 6 ss.
3
Ibid.
120
Vincenzo M. Corseri
politica e speculativa di Nicola Cusano ed Enea Silvio Piccolomini, due indiscussi
protagonisti di quel periodo storico. Entrambi, seppure su piani operativi diversi, rappresenteranno il meglio della cultura umanistica europea intervenuta, in un perfetto
connubio di vita activa e vita contemplativa, a risolvere una tra le più difficili questioni
politico-culturali del tempo. Ed è su questo sfondo che si delineeranno le figure di questi due prelati che, in un certo senso, pur agendo visibilmente tra perplessità ed evidenti
contraddizioni, si faranno latori della presa di coscienza della loro epoca.
Nel febbraio del 1432, a meno di dieci anni dal conseguimento della laurea in
diritto (con il titolo di doctor decretorum) nella prestigiosa Università di Padova, e
dopo essere stato a Colonia, dove fu attivo come giurista e docente di diritto canonico presso l’Università locale (1425 ca.),4 Cusano si presenta al Concilio di Basilea,
come cancelliere e segretario del conte Ulrich von Manderscheid, per sostenere, in
qualità di canonista, la causa del suo signore – che aspira all’arcivescovado di Treviri, contestatogli da Giacomo di Sierck, eletto dalla maggioranza del capitolo. In
quella sede, sebbene perda la causa, riuscirà a farsi apprezzare come brillante oratore
e raffinato canonista al punto da diventare, poche settimane dopo il suo arrivo, su
delega del Concilio, membro della Deputazione della fede.5 Affronterà, quindi, la
“questione Boema” nelle sue Epistolae ad Boemos e, nel mese di novembre, presenterà il primo libro di quello che sarà il suo capolavoro politico ed ecclesiologico, il
De concordantia catholica,6 un’opera dedicata allo scottante tema del conciliarismo
e della riforma dell’Impero.
A Basilea, nei primi anni Trenta del XV secolo, si raccolsero le voci più autorevoli della cultura e della politica ecclesiastica europea: giuristi, teologi, i vescovi delle maggiori diocesi d’Europa, diversi cardinali.7 I Padri conciliari, in aperta polemica
con il ruolo che la figura del pontefice è andata assumendo in epoca tardo-medievale,
a Basilea convengono sulla ferma convinzione che solo Cristo ha una autorità reale,
assoluta, sulla Chiesa e che l’esplicito ruolo del Concilio è quello di rappresentare un
4
Nella città tedesca, il giovane giurista ebbe parallelamente modo di iscriversi alla facoltà di
Filosofia e Teologia e, con buona probabilità, di conoscere e frequentare, fin da quel periodo, Eimerico
da Campo, che, di lì a poco (1428), sarebbe diventato magister, poi cancelliere e rettore di quell’Università.
5
Per una guida introduttiva al pensiero e alla figura storica di Nicola Cusano, cfr. G. Federici
Vescovini, Il pensiero di Nicola Cusano, Torino 1998; si veda anche il prezioso volumetto di G. Santinello, Introduzione a Nicolò Cusano, Bari-Roma 20086.
6
De concordantia catholica. I-III, edidit atque emendavit G. Kallen, Hamburgi 1964/1965/1959.
L’edizione cui faremo riferimento per i passi riportati in traduzione italiana è: La concordanza universale, in Opere religiose, a cura di P. Gaia, Milano 2009 (la mondadoriana collana “I classici del pensiero”, vol. 64, ripropone, in una nuova veste tipografica, l’edizione Torino 1971).
7
Una sintetica quanto esauriente presentazione storica e teorico-politica del Concilio di Basilea
è quella pubblicata dalla Cambridge University Press a firma di A. Black: Monarchy and Community.
Political Ideas in the Later Conciliar Controversy (1430-1450), Cambridge 1970.
Religione e politica in Europa nella prima metà del Quattrocento...
121
potere derivante direttamente da Cristo. I conciliaristi, insomma, sostengono che la
sovranità della Chiesa prima di tutto si basa sul potere conferito da Cristo agli apostoli e che la figura di Pietro ha fondamentalmente un ruolo di primus inter pares, con
una funzione esclusivamente rappresentativa. Il Concilio, quindi, una volta riunito,
deve essere autosufficiente e autonomo su tutti i fronti decisionali, in quanto riceve la
sua forza dal potere di legare e di sciogliere concesso da Cristo alla Chiesa e al sacerdozio. Inoltre Cristo è certamente presente in mezzo ai Padri riuniti nel suo nome, ed
è lo Spirito Santo ad ispirarli quando essi sono unificati nella concordia.
I capisaldi del movimento conciliare basileese, i fattori che ne hanno caratterizzato il percorso storico verranno a fondarsi inizialmente su due punti d’appoggio:
1) il potere pontificio che si era configurato troppo, nella sua struttura organizzativa, all’impianto dell’Impero medievale;
2) il bisogno, all’interno della Chiesa, di una vera e propria riforma religiosa
che non era mossa da una precisa divergenza dogmatica, bensì dalla paradossale
lotta volta, nello specifico, ad attuare la tanto necessaria riforma.
Questo può ben essere inteso come il risultato di un lungo processo religioso che
potremmo simbolicamente far cominciare dall’epistola con la quale san Colombano,
scrivendo a papa Bonifacio IV, ammetteva, nel pontefice, la possibilità di errare. È un
cammino che passa, poi, dalla condanna che Onorio I subisce da ben tre Concili, e che
prosegue, quindi, con il processo che in Francia, durante la lacerante lotta contro Bonifacio VIII, dimostra l’incompetenza di qualsiasi tribunale, facendo maturare l’idea
che solo il Concilio potesse essere l’unico tribunale competente.8 I modelli teologici
sono diversi. Si pensi, ad esempio, alla strenua difesa del conciliarismo da parte di
Corrado di Gehlhausen nel corso del Concilio di Costanza (1414-1418), o alla Epistola
pacis nella quale Enrico di Langenstein propone il trasferimento del potere ai fedeli.
È, quest’ultima, una prospettiva ripresa e opportunamente meglio articolata da Jean
Gerson, nel De potestate Ecclesiae, allorquando sostiene con chiarezza che l’autorità
che Cristo conferisce a Pietro e ai suoi successori risiede principalmente nell’organo
che rappresenta la Chiesa universale (catholica), il Concilio Ecumenico.9
Dal termine del Concilio di Costanza, dovranno trascorrere ancora sette anni
perché la Chiesa stabilisca di affrontare coralmente i principali problemi (interni ed
esterni a essa) che si andavano via via drammaticamente sviluppando nel Mediterraneo cristiano di quegli anni. In Germania la tensione tra i principi era forte, con
evidenti ripercussioni di carattere religioso e sociale all’interno dell’intero territorio tedesco. In Boemia l’eresia hussita non è ancora stata domata, e, a Oriente, le
pressioni turche spingono a promuovere una crociata in difesa della cristianità. Il
8
H. Jedin, Breve storia dei Concili. I ventuno Concili ecumenici nel quadro della storia della
Chiesa, Brescia 2006.
9
G. Alberigo, Chiesa conciliare. Identità e significato del conciliarismo, Brescia 1981 (in
partic., pp. 9-46).
122
Vincenzo M. Corseri
Concilio di Basilea, convocato da Eugenio IV e aperto ufficialmente nel 1431, fu
presieduto sin dall’inizio dal cardinale-legato Giuliano Cesarini.10 Giurista insigne,
uomo di grande equilibrio e dalla profonda visione unitaria della Chiesa, Cesarini
fu professore presso l’ateneo di Padova almeno fino il 1421 e lì ebbe come devoto
scolaro Nicola Cusano, che gli dedicherà in seguito le tre fondamentali opere della
sua produzione giovanile: il De concordantia catholica, il De docta ignorantia11 e il
De coniecturis.12 Egli ebbe un compito estremamente delicato, a Basilea: quello di
moderare le tensioni emerse fra i Padri conciliari in seguito all’imprudente decisione
del papa di sciogliere il Concilio per convocarlo in una più vicina città italiana.13
Tra quelle dei principali intellettuali accorsi a Basilea per sostenere la causa
conciliare, la personalità di Enea Silvio Piccolomini merita di sicuro un’attenzione
particolare. A condurre il giovane umanista – nato alle porte di Siena, a Corsignano,
l’odierna Pienza, nel 1404 –14 nella città del Concilio è l’incarico, da poco conseguito, di segretario di Domenico Capranica. Questi era stato eletto cardinale da Martino
V e poi si era visto revocare da Eugenio IV la nomina conferitagli dal predecessore.
Al Concilio era andato, dunque, per rivendicare il diritto del suo porporato. Partendo
per Basilea al seguito di Capranica, Enea sapeva bene che si sarebbe messo contro la
volontà del papa e che sarebbe stato costretto dagli eventi ad abbracciare cause sempre più radicali. Al pari di Cusano, il senese a Basilea si farà valere per vivacità di
pensiero, il coraggio delle scelte e le non comuni doti oratorie che caratterizzeranno
sempre la sua attività di politico e di religioso: un talento che poco meno di trent’anni
dopo lo porterà al soglio di Pietro con il nome di Pio. Negli anni di Basilea egli servì
diversi vescovi, tutti accomunati da una certa diffidenza nei confronti del pontefice
e «il conciliarismo, vivendo il Piccolomini circondato da persone fortemente ostili a
Roma, doveva pian piano conquistarlo definitivamente».15
Ma lasciamo momentaneamente la descrizione dettagliata dei complessi fatti
10
J. Gill, Personalities of the Council of Florence and other Essays, Oxford 1964, pp. 95-103;
M. Watanabe, Authority and Consent in Church government: Panormitanus, Aeneas Sylvius, Cusanus,
in «Journal of the History of Ideas» 33,2 (1972), pp. 217-236.
11
De docta ignorantia, ediderunt Ernst Hoffmann et Raymundus Klibansky, Lipsiae 1932.
12
De coniecturis, ediderunt Iosephus Koch et Carolus Bormann, Ioannes Gerhardo Senger
comite, Hamburgi 1972.
13
C. Vasoli, La maturità del pensiero teologico umanistico in Italia, in G. d’Onofrio (a cura
di), Storia della Teologia, vol. III, Casale Monferrato 1995, pp. 201-218 (par. 1: Il concilio di FerraraFirenze e il confronto teologico tra Latini e Greci).
14
Tra i moltissimi scritti dedicati alla vita di E. S. Piccolomini, si ricordino almeno: E. Garin,
Ritratto di Enea Silvio Piccolomini, in Ritratti di umanisti, Firenze 1967, pp. 9-39; L. M. Veit, Pensiero
e vita religiosa di Enea Silvio Piccolomini prima della sua consacrazione episcopale, Roma 1964; G.
Paparelli, Enea Silvio Piccolomini: l’umanesimo sul soglio di Pietro, Ravenna 1978; M. Pellegrini,
Pio II, in Enciclopedia dei papi, vol. II, Roma 2000, pp. 663-685.
15
L. M. Veit, Pensiero e vita religiosa di Enea Silvio Piccolomini, cit., p. 117.
Religione e politica in Europa nella prima metà del Quattrocento...
123
del Concilio. Ci preme puntualizzare, adesso, alcune idee essenziali della concezione ecclesiologica cusaniana, riferendola, nella prospettiva di una sintetica “lettura
in parallelo”, alle scelte mosse, sempre in ambito ecclesiologico, da Piccolomini, ai
drammi spirituali da loro vissuti, e, infine, alla “svolta”16 attuata da entrambi, in un
secondo momento, a favore del partito papale.
Nel suo celebre trattato sulla Chiesa, Niccolò da Cusa espone un’indagine sulla concordia universale articolata in tre libri.17 Nel primo, l’autore avvia una investigatio de ecclesia; nel secondo si sofferma ad analizzare la materia principalis Conciliorum; nel terzo – aggiunto in un secondo momento – riflette sul de sacro imperio,
elaborando il proprio discorso anche in base ad alcuni spunti suggeriti dalla lettura
del Defensor pacis marsiliano.18 L’obiettivo fondamentale dell’opera cusaniana è
quello di dare al Concilio di Basilea alcuni suggerimenti concreti finalizzati a risollevare la situazione generale della Chiesa, ivi accorsa attraverso i suoi più autorevoli
rappresentanti, che certamente non era tra le più felici. Con la sua opera, Cusano
propone diverse soluzioni ecclesiologiche – in un’ottica rigorosamente concordista
–, non velleitarie, restando in continuità con la fede della Chiesa e della Tradizione;
tanto più che egli sottopone questo lavoro all’auctoritas del Concilio, offrendo a tutti
i presenti la libera facoltà di accettarlo o meno. Una ricerca sulla concordia universale – sottolinea giustamente Giuseppe Alberigo –19 richiede, nell’argomentazione di
Cusano, un’analisi dell’unione del popolo fedele con l’anima (sacerdozio) e il corpo
(Impero) della Chiesa. Tale unione è appunto la Chiesa cattolica, intesa nelle sue
articolazioni interne, nella natura intrinseca su cui si costituisce, nel suo fondamento.
Dice Alberigo:
Cusano lascia intravedere, sia pure molto sinteticamente, la propria prospettiva ecclesiologica, caratterizzata da una composizione di elementi tipicamente
medievali con altri attinti alla tradizione più antica ma presentati in modo da
rispondere a esigenze profonde del rinnovamento in atto nella cristianità oc-
16
J.W. Stieber, The “Hercules of the Eugenians” at the crossroads: Nicholas of Cusa’s decision for the pope and against the Council in 1436/1437. Theological, political and social aspects, in I.
Bocken (Ed.), Conflict and Reconciliation. Perspectives on Nicholas of Cusa, Leiden 2004, pp. 221255.
17
Per una panoramica sul pensiero e la biografia di Nicola Cusano, si dimostra ancora utile la
monografia di E. Vansteenberghe, Le cardinal Nicolas de Cues (1401-1464). L’action - La pensée, Paris 1920: rist. anast., Frankfurt am M. 1963 (in part. pp. 33-139); si veda, oltre la lucida introduzione di
P. Gaia alla raccolta, in traduzione italiana, delle Opere religiose, cit., pp. 19-76, anche: A. Landi, Niccolò Cusano, riformatore a Basilea, in M. Thurner (hrsg.), Nicolaus Cusanus zwischen Deutschland
und Italien, Berlin 2002, pp. 305-313.
18
G. Santinello, Da Marsilio a Niccolò Cusano: insegnamenti da un trapasso storico, in «Studia Patavina» 27 (1980), pp. 296-299.
19
G. Alberigo, Chiesa conciliare. Identità e significato del conciliarismo, cit., pp. 241-354.
124
Vincenzo M. Corseri
cidentale. Non si può non sottolineare l’impostazione essenzialmente unitaria,
ma nel medesimo tempo articolata e dinamica che deriva all’ecclesiologia cusaniana dal preporre una trattazione della Chiesa come insieme composito, in
cui spiccano come fattori costitutivi il clero (anima) e l’Impero (corpo), insieme costituito però dall’intero popoli dei fedeli. Ne consegue che la Chiesa non
può essere ridotta al corpo sacerdotale né alla res publica christiana, ma ha una
consistenza propria nella fede.20
Certamente, il De concordantia, offrendo un punto di vista più ampio sulla
Chiesa e sulla contingenza dei problemi ad essa intrinseci, favorisce una luce superiore che elimina le principali incognite e tenta, al contempo, nell’incessante ricerca
di una superiore unità dialettica, di presentare la Chiesa come una «profonda e divina
armonia» la cui concordanza «è il principio secondo il quale si armonizzano l’uno
(l’unico Signore) e i molti (i molteplici sudditi)». Una concordanza – si badi – che
deriva anche dalla tradizione canonistica e che concepisce questo concetto come
opposto di contrarietas:21
Se il nome della Chiesa deriva dall’essere questa unione ed un’assemblea vivente nella concordia, si può pensare che essa sia costituita dalla fraternità,
della quale niente propriamente è più contrario che la divisione, cioè lo scisma.
Infatti sebbene il filo che lega la Chiesa in unità sia l’unica fede, tuttavia la
varietà delle opinioni sostenute senza ostinazione può talvolta coesistere con
tale unità.22
Cusano affronta, nel confutare l’autocrazia pontificia (romana e papalista),
una disamina storica serrata in cui evidenzia con cura le principali differenze fra la
ecclesia catholica, la Chiesa universale con la sua rappresentanza nel Concilio, e la
ecclesia romana (definita in alcune parti del trattato anche sedes apostolica o cathedra romana), ovvero il papa, la diocesi di Roma, o ancora, talvolta, l’intera Chiesa
metropolitana romana insieme al patriarcato romano d’Occidente. Si appella, inoltre,
agli scritti dei Padri della Chiesa e rifiuta esplicitamente le tesi dei curialisti romani,
atte a tutelare la classica tesi che vuole che la legittimità del Concilio dipenda totalmente dal papa e che nessun decreto sia valido senza il consenso positivo e la conferma formale del pontefice. Il pensatore di Cusa – interpretando le idee e le speranze
dei maggiori esponenti della “teologia progressista” riunitasi a Basilea – afferma nel
secondo libro del De concordantia che anche il pontefice deve indefettibilmente sottostare al giudizio della maggioranza, dato che egli è solo membro del sinodo, e che
non potrebbe mai rappresentare da solo, pur essendone vescovo universale e rector,
20
Ibid., p. 303.
Ibid., p. 302.
22
N. Cusano, La concordanza universale, in Opere religiose, cit., libro I, cap. 5, p. 151 ss.
21
Religione e politica in Europa nella prima metà del Quattrocento...
125
la volontà dell’intera Chiesa:
Perciò quando il Concilio ecumenico – nel quale si riuniscono i vescovi ed i legati per discutere e risolvere problemi sui quali, nei propri concili provinciali,
emersero dei dubbi e delle incertezze che resero impossibile il consenso di tutti
i membri – ha emesso dei decreti relativi a questioni che in qualunque modo
riguardavano la salvezza dei fedeli – purché il Concilio sia stato regolarmente
e legittimamente convocato, vi abbiano partecipato tutti i membri convocati,
sia stato celebrato con la massima libertà e sia terminato correttamente con il
consenso unanime di tutti i membri –, tale Concilio, come attesta la storia, non
ha mai errato, poiché rappresenta in modo più prossimo e immediato tutta la
Chiesa cattolica, e poiché, attraverso i vescovi delegati, esprime il consenso di
tutti i fedeli. […] E sebbene abbia addotto molte testimonianze e molti scritti
dei santi Padri, secondo cui il potere del pontefice romano viene da Dio, mentre secondo altri viene dall’uomo e dai concili ecumenici, tuttavia la conclusione a cui pervenni, e che mi pare una via di mezzo che armonizzi le posizioni
contrastanti dei testi, tende in sostanza ad affermare che il potere del pontefice
romano, con le sue caratteristiche di preminenza, priorità e primato, venga da
Dio attraverso la mediazione dell’uomo e dei concili, cioè mediante il consenso espresso nell’elezione.23
È una visione della Chiesa, quella che Cusano sostiene nei suoi interventi
basileesi pronunciati nel corso dei primissimi anni del Concilio, condivisa anche
da Piccolomini, tenendo conto – è ovvio – delle rispettive sensibilità e della diversa
formazione culturale di provenienza. Entrambi hanno chiaramente percepito le vere
dimensioni dei conflitti e le diverse tensioni che, su piani differenti, andavano rimodellando l’immagine europea. L’uno e l’altro, incaricati nel tempo delle più importanti missioni diplomatiche, seguendo un’evoluzione parallela, partecipano molto
attivamente e con immensa attenzione alle principali attività del Concilio. Di comune accordo con Cusano, Enea sostiene che la Chiesa è il corpo stesso di Cristo e, alla
stregua di molti conciliaristi, afferma pure che essa trova una sua piena e adeguata
rappresentanza solo nel Concilio generale.
Egli è anzitutto un umanista. La sua è una formazione prevalentemente letteraria e politica, “toscana” insomma, e non teologica e giuridica, così come la si deve
intendere invece per Cusano. Da buon umanista, ed essendo per carattere amante
della libertà e dei diritti della persona, il futuro pontefice si sente incline a difendere
la posizione conciliarista che trasformava il Concilio in un legittimo e autorevole
parlamento ecclesiastico in cui possono accedere anche i laici come lui. Egli ritiene
che il ruolo del papa, all’interno della Chiesa, sia anzitutto “amministrativo” e “rappresentativo” e che la superiorità assoluta spetti al Concilio: «la Chiesa è superiore
23
Ibid., libro II, cap. 34, pp. 376-377.
126
Vincenzo M. Corseri
al romano Pontefice così come il figlio è inferiore alla propria madre».24
Piccolomini riesce subito a farsi ammirare, con i suoi discorsi, come oratore
di talento e si procura molto presto la benevolenza di buona parte dei Padri. Passa
successivamente al servizio di Bartolomeo della Scala, vescovo di Frisinga, e, nelle
sue prime sortite, elogia l’autorità del pontefice, pur assumendo, al contempo, verso
il papa una posizione piuttosto indifferente: in piena sintonia con l’ambiente conciliare che incontra. Rafforza la propria amicizia con il vescovo di Novara, il potente
Bartolomeo Visconti, conciliarista convinto e fratello del Duca di Milano, a quel
tempo ostile a Eugenio IV, e diventa infine segretario del cardinale Niccolò Albergati, per conto del quale si reca in missione presso il re di Scozia. Rientrato a Basilea,
la sua vivace cultura umanistica e il suo talento di oratore gli guadagnano l’importante carica di “abbreviatore” del Concilio, cioè di estensore dei documenti ufficiali.
Il 26 giugno del 1439, il Concilio depone papa Eugenio IV. Piccolomini, difensore
convinto della causa conciliare, è nominato poi maestro delle cerimonie del conclave scismatico che eleggerà l’antipapa Felice V – l’ultimo antipapa della storia della
Chiesa – nella persona del compassato Amedeo VIII di Savoia (del quale Piccolomini diviene, com’era prevedibile, segretario). Nel giro di qualche anno, tuttavia, il
vivace umanista si rende conto della precarietà del partito scismatico e, inviato dal
Concilio alla Dieta di Francoforte (1442), si mette al servizio dell’imperatore Federico III, che lo incorona poeta e gli dà un impiego a Vienna nella cancelleria imperiale.
Inizia qui un veloce percorso à rebours, che, cominciando da un graduale
distacco da Felice V, lo avrebbe portato nel giro di pochi anni a un riavvicinamento
definitivo alla curia di Roma. Il 1445 è l’anno dell’implorato perdono al papa Eugenio IV. L’incontro fra questi due grandi esponenti della Chiesa romana, in uno dei
momenti più tesi e appassionanti della sua storia, viene descritto da Piccolomini con
parole che meritano tutta la nostra attenzione. Egli è davvero un figlio esemplare
del suo tempo. Il suo è un attivismo che sottende maggiormente ad una filosofia
dell’agire più che alla contemplazione. Da una parte abbiamo il giovane umanista
che diventerà, poco dopo un decennio, Pio II: il grintoso pontefice che cercherà di
attenuare la traumatica catastrofe costantinopolitana (1453) con un’intensa attività
politica e religiosa volta a favorire la costituzione di una «lega italica» e con l’esplicito obbiettivo di dichiarare una crociata contro il Turco in modo da ristabilire, anche
se sappiamo che il progetto non avrà mai un suo seguito, il «trionfo dello spirito sulla
brutalità della forza». Dall’altra c’è il veneziano Eugenio IV (Gabriele Condulmer),
l’autoritario pontefice che si fa latore, in contrasto al movimento conciliare, di una
concezione del papato di indubbia ascendenza medievale e che dopo una lotta serrata, durata più di un quindicennio, riuscirà ad avere la meglio sul Concilio ristabilen-
24
Aeneas Sylvius Piccolominus (Pius II), De Gestis Concilii Basiliensis Commentariorum:
Libri II, edited and traslated by D. Hay and W. K. Smith, Oxford 1967.
Religione e politica in Europa nella prima metà del Quattrocento...
127
do una centralizzazione romana del potere.
Enea nel suo capolavoro storiografico, i Commentarii,25 vergato quando sarà
già pontefice, tratteggia in terza persona i momenti peculiari di quest’incontro con le
seguenti, memorabili parole:
Quando Enea, dunque, si trovò al cospetto di Eugenio, e fu ammesso a baciargli i piedi, le mani e il viso, presentò le lettere credenziali e, invitato a parlare,
così disse: “Santissimo presule, prima di riferire il messaggio di Cesare, dirò
poche parole al mio riguardo. So che sono state fatte giungere alle tue orecchie
molte voci su di me non favorevoli e che non conviene ripetere. Ma coloro
che ti hanno parlato di me non hanno mentito. Durante il mio soggiorno a
Basilea io ho detto, scritto e fatto molte cose contro di te. Non lo nego. Ma la
mia intenzione non era di nuocere a te, quanto piuttosto di giovare alla Chiesa
di Dio. Perseguitando te, io pensavo di prestare ossequio a Dio. Sbagliai, chi
potrebbe negarlo? Ma sbagliai assieme a non pochi altri, e non dico di poco
conto. Ho seguito l’esempio di Giuliano cardinale di Sant’Angelo,26 di Niccolò
arcivescovo di Palermo,27 di Ludovico Pontano notaio della tua curia, che erano reputati acuti interpreti e maestri della verità. E c’è bisogno che ricordi l’Università di Parigi e altre scuole del mondo, che numerose ti furono avverse?
Chi non avrebbe errato in compagnia di persone tanto autorevoli? È vero, lo
confesso, che quando io mi accorsi dell’errore dei Basileesi, non passai subito
dalla tua parte, come molti fecero; e invece, temendo di cascare d’uno in altro
errore – poiché spesso avviene che chi vuole evitare Cariddi finisca per cadere
su Scilla – mi unii a coloro che si tenevano neutrali, per evitare di passare da
un estremo all’altro senza prima aver riflettuto e meditato a lungo. […] Ora
eccomi qui: ti prego di perdonarmi, perché ho peccato di ignoranza”.
Eugenio rispose: “Sappiamo che hai mancato gravemente verso di noi. Ma non
possiamo non perdonare a chi confessa di avere errato. La Chiesa è una madre
pia che non risparmia la giusta punizione a chi non riconosce i propri errori,
ma a chi li confessa sempre concede il perdono. Tu ormai possiedi la verità.
Bada di non abbandonarla. […] Ora sei in una situazione in cui puoi difendere
la verità ed essere di aiuto alla Chiesa […]”.28
Quella appena descritta dall’allora alto funzionario della cancelleria asburgica, è una rappresentazione emblematica del realismo dell’uomo del Quattrocento. La
sua è la fede nel fare etico dell’uomo, nella virtus, nel positivo operare che da questa
25
L’edizione di riferimento in lingua italiana, con testo latino a fronte, de I commentarii di E. S.
Piccolomini è quella a cura di L. Totaro, 2 voll., Milano 2008.
26
Il cardinale Giuliano Cesarini.
27
Il grande canonista siciliano Niccolò Tudeschi, detto il Panormitano; cfr. M. Watanabe, Authority and Consent in Church government: Panormitanus, Aeneas Sylvius, Cusanus, cit.
28
E. S. Piccolomini, I commentarii, cit., pp. 59-61.
128
Vincenzo M. Corseri
ne scaturisce, fosse anche in ambito religioso. Piccolomini, una volta incoronato
pontefice, sarà anche un grande costruttore e protettore delle arti e delle lettere, un
politico e un artista convinto di poter cogliere la cifra essenziale di ogni evento, la dimensione dinamica della storia percepita nel suo perenne, ininterrotto rinnovamento.
In un certo senso, sebbene la sua azione politica sarà sempre sostenuta da
un profondo zelo religioso e dal rigore etico previsto dalla dottrina della Chiesa, lo
stesso cambiamento di prospettiva nei confronti delle posizioni, sempre più tese ed
esasperate, dei Padri conciliari avverrà anche nell’attività politica e teologica di Nicola Cusano. A Basilea egli segue personalmente ogni fase del Concilio, procedendo
sulla linea dell’attuazione di una Ecclesiae Reformatio in capite et in membris. Nel
1434 si presenta all’intera assemblea conciliare la questione dell’ammissione – e
della presidenza – dei tre legati papali inviati da Eugenio IV a Basilea. Cusano, in
quell’occasione, è invitato a fornire un parere tecnico, data la delicatezza del caso, e
rende pubblico il De auctoritate praesidendi in concilio generali29 in cui sintetizza
opportunamente le parti peculiari del suo De concordantia catholica; vi esprime le
sue tesi con precisione ed elasticità argomentativa e usa uno stile di scrittura piano,
diretto, icastico nella formulazione giuridica dei temi ivi esaminati.
Egli infatti distingue ammissio dei legati (che è una necessità, altrimenti il concilio sarebbe nullo) da praesidentia – scrive Pio Gaia nella sua introduzione
all’edizione italiana degli scritti religiosi del filosofo –, e questa a sua volta è
considerata in due accezioni, come praesidere concilio (e questo compete solo
a Cristo, vero capo del concilio) e come praesidere in concilio. Quest’ultima
praesidentia può essere autoritativa e giudicativa (che spetta solo alla Chiesa e
quindi al concilio stesso), oppure direttiva, ordinativa e ministeriale, cioè una
presidenza onorifica con poteri organizzativi e direttivi dei lavori conciliari,
senza alcun diritto giurisdizionale o potere decisionale, e questa spetta al papa
come supremus in administrazione, e quindi ai suoi legati.30
Pochi anni dopo, nella lettera a Rodrigo Sánchez de Arévalo (1442),31 egli
definisce il cambiamento di rotta che lo induce a passare dalle teorie conciliariste
analizzate nel De concordantia alla teorizzazione della cosiddetta «supremazia
papale».32 Alcuni lo considerano, senza giri di parole, un vero e proprio tradimento,
29
De auctoritate praesidendi in concilio generali, ed. G. Kallen, Heidelberg 1935; per un’edizione in lingua italiana, cfr. N. Cusano, Trattato del Maestro Nicolò Cusano sul potere presidenziale
nel Concilio generale, in Opere religiose, cit., pp. 549-563.
30
P. Gaia, Introduzione a N. Cusano, Opere religiose, cit., p. 48.
31
N. Cusano, Opere religiose, cit., pp. 597-616.
32
Per un’analisi meticolosa della delicata questione della “supremazia papale”, inquadrata
nell’ambito della riflessione politico-filosofica cusaniana tra “repraesentatio” e “complicatio”, cfr. M.
Merlo, Vinculum concordiae. Il problema della rappresentanza nel pensiero di Nicolò Cusano, Milano
Religione e politica in Europa nella prima metà del Quattrocento...
129
ma la critica più attenta ha saputo evidenziare di questa scelta gli aspetti più drammatici, essendo quella di Cusano una visione dell’esistenza radicata in una vivente
coincidentia oppositorum – principio fondamentale del neoplatonismo – che va considerata come «un segno, estremamente importante, di una notevole “disponibilità”
intellettuale e di una rara capacità di accogliere ed accompagnare con una singolare
riflessione critico-creativa, le profonde mutazioni sociostrutturali delle varie contingenze storiche».33 Con le tensioni interne, la deposizione di Eugenio IV e l’elezione
di un antipapa, il Concilio, attuando il cosiddetto “piccolo scisma” d’Occidente, dimostra – rileva Cusano – di non essere più la sede ideale per discutere ponderatamente dei problemi costitutivi della Chiesa del tempo. Il pensatore tedesco in questa
lettera muove un discorso che parte da una nuova concezione metafisica della realtà
in cui nell’unità del Verbo di Dio è unitariamente contenuto tutto ciò che è molteplice. Il Verbo, esplicandosi nel molteplice, origina gli esseri finiti. Ed essi “partecipano” all’unico essere assoluto che è presente in tutto ciò che è. Ecco una chiara
elaborazione della metafisica della processualità, che, in chiave ecclesiologica, Cusano riesce ad applicare al rapporto che unisce la Chiesa a Cristo, la cui grazia viene
ad irraggiarsi e dispiegarsi (explicatio) nel mondo (“Chiesa invisibile”). Nell’ambito
della “Chiesa visibile”, il nostro afferma invece che non c’è nessun potere assoluto al
di fuori del potere del sommo Dio e che il potere del papa è anch’esso, a suo modo,
assoluto, in quanto in esso è compendiata la Chiesa stessa.34
Qui si apre una nuova fase del pensiero di Nicola Cusano, uomo di Chiesa e
filosofo, improntata ad una dinamica tensione innovatrice che, anche a seguito della
redazione di un altro importante capolavoro filosofico-religioso, il De pace fidei,
includerà in questo originalissimo percorso speculativo concetti fondamentali quali
pax, concordantia, harmonia, tutti rapportabili costantemente al tema principale di
una convergente concordantia tra ratio e fides. Ed è anche in virtù di questa raffinata
visione della Chiesa che Enea Silvio Piccolomini, una volta eletto papa della Chiesa
cattolica (1458), chiamerà Cusano a Roma come Legato pontificio e Vicario generale in temporalibus a conferma che, seppure intesi nelle loro differenze, i loro spiriti
furono sempre accomunati da una complementare visione della vita.35
1997 (in part., cap. 6, pp. 167-201).
33
M. L. Arduini, “Ad hanc supermirandam harmonicam pacem”. Riforma della chiesa ed
ecumenismo religioso nel pensiero di Nicolò Cusano: il De pace fidei, in «Rivista di Filosofia neoscolastica» 72,2 (1980), pp. 224-242.
34
N. Cusano, Lettera a Rodrigo Sánchez de Arévalo, in Opere religiose, cit., p. 607.
35
Wilhelm Baum ha problematizzato la concordia discors umanistica intercorsa tra Cusano e
Piccolomini in un suo recente, documentatissimo lavoro: Nikolaus von Kues und Enea Silvio Piccolomini – eine Humanistenfreundschaft?, in M. Thurner (hrsg.), Nicolaus Cusanus zwischen Deutschland
und Italien, cit., pp. 315-337.
Flavia Buzzetta
Aspetti della magia in epoca tardo-medievale
Premessa
Nell’affrontare alcuni aspetti salienti di un tema vasto e complesso quale è
quello delle forme e dei caratteri della magia nel corso del Medioevo, ritengo utile
specificare l’approccio metodologico con il quale prendo in esame questa particolare
forma di sapere. Assumo la magia come una specifica forma organizzata di sapere,
una visione del mondo in cui confluiscono e si integrano tradizioni ed elementi culturali eterogenei. In tale prospettiva, la “magia”, assunta nel suo senso più lato, nelle
stratificazioni della sua configurazione e nella complessità del suo statuto, costituisce
un interessante capitolo della storia del pensiero medievale e rinascimentale, presentandosi come una specifica modalità di interpretazione del reale, come un peculiare
tipo di “razionalità”, scevra da preconcette valenze negative, sottesa all’elaborazione
di una strutturata visione del mondo in cui concorrono un complesso di istanze fisiche, cosmologiche, metafisiche, teologiche, etiche, antropologiche.
Nel mio intervento, guardando in generale all’epoca basso-medioevale e umanistico-rinascimentale, mi soffermo su alcuni tratti generali della magia, assunta nei
suoi aspetti filosofici e nei princìpi che ne fondano lo statuto. In tale ottica, miro a
mostrare come, nell’epoca presa in esame, la magia si presenti, in generale, come
una determinata forma di sapere, legata alle prospettive della deificatio hominis, essenzialmente caratterizzata da risvolti pratico-operativi, secondo cui il mago è visto
come dominator mundi, capace di riprodurre, sulla base di conoscenze esoteriche,
le dinamiche dell’atto divino creativo, manipolando e trasformando in vari modi il
reale sulla base di un complesso di tecniche e atti rituali.
In questo mio intervento prendo in esame aspetti della magia vista come sapere complesso, stratificato in una frastagliata molteplicità di conoscenze e tradizioni
esoteriche tra loro interrelate. In particolare, faccio riferimento alle tradizioni dotte
della magia, con particolare riferimento alle elaborazioni filosofiche medievali nelle
quali essa diviene un sapere scientificamente fondato, come “magia naturale” (magia naturalis), secondo un modello che ha in Giovanni Pico della Mirandola uno dei
suoi più insigni teorici; ma guardo alla magia popolare, classificabile anche come
132
Flavia Buzzetta
“stregoneria”, consistente in una varietà di pratiche rituali i cui testi di riferimento
sono costituiti da ricettari e manuali di magia operativa. Ciò nella consapevolezza
della manifesta labilità e della natura puramente indicativa del confine tra magia
“dotta” e magia “popolare”. Guardando all’universo magico medievale e procedendo per exempla, dedico anche qualche cenno ad aspetti di magia alchemica, con
riferimento alle tecniche per la manipolazione dei corpi in vista della creazione di
esseri artificiali.
Forme della magia medievale
Richard Kieckhefer, nel suo saggio su La magia nel Medioevo, nel prendere
in esame i caratteri peculiari della magia in epoca medievale, con riferimento a questioni di definizione la presenta come un crocicchio in cui convergono e da cui si
diramano religione, superstizione e scienza.1 L’aspetto religioso della magia è visto
nel fatto che essa è caratterizzata da un particolare tipo di ritualità i cui destinatari
possono essere entità spirituali, naturali o celesti; l’elemento superstizioso è ravvisabile nel fatto che nella magia confluiscono credenze popolari, di cui essa si alimenta;
la componente scientifica, invece, va colta nel fatto che la magia medievale, in talune
sue teorizzazioni, si lega alle coordinate delle scientiae medievali: in particolare, mi
riferisco in quest’ultimo caso alla “magia naturale” (magia naturalis), la quale mira
ad agire sulle virtutes occulte della natura, sulla base di una loro retta conoscenza, e può essere considerata come una branca della filosofia della natura. In questa
prospettiva, la magia naturale si presenta come una disciplina epistemologicamente strutturata che s’inquadra in un complesso di coordinate fisico-cosmologiche e
metafisico-teologiche. Ma la magia, secondo una possibile lettura, è a suo modo
scienza anche in quanto è vista, per certi versi, come un prodromo della moderna
rivoluzione scientifica.
Sul piano tipologico e definitorio, se per un verso la magia si presta ad essere
analizzata in rapporto ad altro, con riferimento a configurazioni culturali relative
agli orizzonti della religione, delle credenze popolari e della conoscenza scientifica,
per altro verso va anche considerata e studiata come un fenomeno a sé stante, nel
suo peculiare statuto identitario. Come tale, in epoca medievale, la magia, fatta oggetto di riflessione teorica, appare fondamentalmente contrassegnata da una valenza
sapienziale. Tale valenza è già colta nel nome stesso di magia, derivato dal nome
greco di magheia, con il quale si indicava un complesso di conoscenze sapienziali
tradizionali dei Persiani, in una prospettiva in cui la magia, nobilitata e assunta come
retaggio culturale intrinsecamente positivo, è distinta dalla goeteia, la quale invece
1
R. Kieckhefer, La magia nel Medioevo, trad. it. di F. Corradi, Roma-Bari 2004, pp. 3-5.
Aspetti della magia in epoca tardo-medievale..
133
indica un complesso di spregevoli pratiche e tecniche rituali fondate sull’evocazione
del potere dei demoni. Esemplare, al riguardo, è l’osservazione di Giovanni Pico
della Mirandola, il quale, nel distinguere la magia demoniaca (goeteia) dalla magia
naturale (magheia), presenta quest’ultima, sulla scorta di una particolare fruizione di
fonti greche, come “perfetta e somma sapienza”:
i Greci, avendole entrambe presenti, chiamano l’una stregoneria [goeteia], non
degnandola affatto del nome di Magia [magheia], quasi somma e compiuta
sapienza. Infatti, come dice Porfirio, in lingua persiana mago significa quello
che da noi è interprete e cultore di cose divine.2
E altrove afferma:
questo vocabolo “mago” non è né latino né greco, bensì persiano, e nella stessa
lingua persiana significa ciò che presso noi è il sapiente [sapiens]. Sapienti
presso i Persiani sono lo stesso che presso i Greci sono detti filosofi, così chiamati da Pitagora che prima li chiamava sapienti.3
Se quindi, per un verso, in determinati contesti del pensiero medievale la magia è vista come una forma di sapere, come la “sapienza” nella sua più alta espressione, per altro verso talvolta resta ambigua e problematica, di fatto se non di principio, la sua distinzione e separazione dalla magia demoniaca (la quale, potremmo
dire, in una certa ottica costituisce una pseudo-magia). Sul piano teorico, s’impone
comunque la differenza tra l’unica vera magia intesa, in quanto “sapienza”, come un
sapere lecito, intrinsecamente positivo, radicato nella verità, il quale non si oppone
ma anzi si lega alla religione cristiana, e la magia demoniaca, rigettata come illecita
ed esecrabile, in quanto fondata sulla potenza del male e contraria alla vera religione.
Se come “magia naturale” la magia tardo-medievale si presenta come legittimanente praticabile, secondo altre sue connotazioni essa, nella sua costitutiva ambiguità, oscilla tra il lecito e l’illecito. Secondo una possibile classificazione tipologica, la magia tardo-medievale, nelle sue varie manifestazioni, si presenta come una
“magia destinativa”: Nicolas Weill-Parot utilizza l’espressione di magie adressative
per indicare una prassi magica rivolta a un destinatario intelligente – sia esso spirito,
angelo o demone –, capace di decodificare il messaggio rituale che il mago gli invia e
di agire di conseguenza. Forme di magia destinativa sono la magia ermetica e la magia angelica. La magia ermetica, così chiamata perché i testi in cui è espressa sono
2
Giovanni Pico della Mirandola, De hominis dignitate, a cura di E. Garin, Pisa 1985 (riproduzione anastatica del testo pubblicato originariamente a Firenze nel 1942), p. 53.
3
Joannis Pici Mirandulani Apologia, Francesco del Tuoppo, Napoli 1487, p. 51 (traduzione
italiana mia).
134
Flavia Buzzetta
attribuiti prevalentemente alla figura mitica di Ermete Trismegisto, è soprattutto una
magia astrale finalizzata a captare le potenze degli spiriti celesti; ne è un esempio
il Picatrix. La magia angelica, invece, ha come interlocutori gli angeli e i demoni.
Una forma di magia angelica è la magia salomonica, la quale, secondo la tradizione
testuale, è una sapienza rivelata in cui si utilizzano sigilli e caratteri magici per attirare gli angeli o i demoni. Un altro tipo di magia angelica è l’ars notoria (con testi
attribuiti alle figure esemplari di re Salomone e di Apollonio), la quale è una sorta
di arte della memoria in cui l’operatore invoca le potenze spirituali recitando ritualmente i nomi degli angeli, al fine di raggiungere un grado superiore di conoscenza.
Può essere considerata come una forma di magia angelica la cosiddetta ars paulina,
la quale è un tipo di ars notoria caratterizzata dal rituale salomonico. Va notato come
nel Medioevo tali forme di magia appaiano spesso difficilmente distinguibili e separabili, segnate come sono da scambi reciproci, commistioni, condivisioni di pratiche
ed elementi caratterizzanti.
Elemento costante della magia è la sua configurazione come attività rituale
tecnico-poietica, come una prassi taumaturgica legata al conseguimento di effetti
giudicati come mirabili. Un profilo generale della magia, ad esempio, è prospettato
da Jean-Patrice Boudet, per il quale la magia si configura come un’attività capace,
tramite riti, procedimenti occulti e artifici tecnici, di produrre fenomeni considerati
come straordinari allo stato delle credenze religiose e conoscenze naturali di contesti
di una data epoca.4 La magia è un “sapere pratico”. Come tale, essa fa riferimento
a una base di conoscenze che fondano la prassi rituale, la quale, in ogni caso, si
presenta come l’aspetto basilare e caratterizzante della magia. La magia può essere
considerata come un sapere “ergetico”, con un termine coniato da Amos Funkenstein
e mutuato da Moshe Idel, il quale, nello specifico contesto della magia ebraica, lo
utilizza per definire “un tipo di conoscenza ottenuto attraverso l’azione”.5
La magia come scientia: la “magia naturale”
Con la riflessione sulla magia naturale in autori medievali, si assiste comunque allo sforzo di determinare, sul piano di una dotta teorizzazione filosofica, lo
specifico statuto epistemologico, i fondamenti cosmologico-metafisici, le modalità
procedurali e le autentiche finalità del sapere magico. Nel corso del Basso Medioevo
si assiste nell’Occidente latino, all’elaborazione di una teoria filosofica della magia,
4
J.-P. Boudet, Entre Science et Nigromance. Astrologie, divination et magie dans l’Occident
médiéval (XIIe-XVe siècle), Paris 2006, p. 119.
5
M. Idel, Il Golem. L’antropoide artificiale nelle tradizioni magiche e mistiche dell’ebraismo,
trad. it. di A. Salomoni, Torino 2006, p. 18.
Aspetti della magia in epoca tardo-medievale..
135
alla luce di talune coordinate concettuali della coeva filosofia della natura. Diffusamente indicata nei secoli altomedievali con l’espressione di ars magica con riferimento al suo statuto di prassi operativa, la magia a partire dal XIII secolo comincia
ad essere inquadrata nei suoi legami strtutturali con la “scienza della natura” ed è
ripensata nei suoi fondamenti teorici sulla base di un insieme di istanze riconducibili
al neoplatonismo e all’ermetismo.
Questa tendenza alla sistematizzazione “scientifica” della magia è riscontrabile soprattutto nella cultura di corte, in particolare nei circoli intellettuali attivi durante le regnanze di Federico II e di Alfonso X, e appare legata alla fruizione di testi
magici arabi e ebraici che per la prima volta vengono tradotti in latino. Ricordiamo,
ad esempio, le traduzioni latine di testi magici di varie tradizioni culturali, come il
Picatrix e il Sefer Raziel, effettuate alla corte di Alfonso X, le quali ricoprono un’importanza rilevante negli sviluppi del pensiero magico nei secoli successivi.
Il Picatrix, che è una traduzione latina di un testo arabo noto con il titolo di
Gayat al-hakim, “Il fine del saggio”, è un trattato di magia astrale.6 In quest’opera
ritroviamo vari elementi che confluiscono nella teorizzazione tardo-medievale della
magia. L’anonimo autore presenta la magia, che egli chiama “nigromanzia” (distinta
dalla “necromanzia”, che è una forma di divinazione attraverso l’evocazione delle
anime dei morti), in termini di scienza.
Tale magia è presentata come una scienza operativa, il cui esercizio è in potere
dell’uomo e le cui opere difficilmente possono essere da questi comprese, in quanto
essa è una scienza “troppo profonda per l’intelletto”. Come tale, la nigromanzia è
una scienza esoterica, relativa a cose nascoste che solo pochi uomini sono in grado
di spiegare la magia descritta nel Picatrix ha dunque il peculiare carattere sapienziale
di una scienza occulta, che si occupa di ciò che è nascosto alla maggior parte degli
uomini. Scienza pratica che riguarda il corpo e lo spirito, il materiale e l’immateriale,
la nigromanzia ha anche una parte teorica, consistente nell’astrologia, vista nelle sue
implicazioni magiche, in quanto lo studio della “posizione delle stelle fisse”, delle
“figure celesti” e delle “forme dei cieli” è fondamentalmente finalizzato alla fabbricazione di talismani capaci di veicolare le forze astrali.
Oltre che delle virtutes astrali, la nigromanzia si occupa anche delle virtutes
delle “parole”, le quali sono considerate come dotate di un’intrinseca virtù magica.
La potenza performativa di tipo magico-rituale propria delle parole caratterizza la
nigromanzia come una forma di prassi magica che utilizza il linguaggio per produrre
mutamenti e trasformazioni nella realtà. Le “parole” magiche, diffuse nelle varie
tradizioni e contesti della magia antica e medievale, possono essere suoni vocalizzati tanto significativi quanto non significativi. Nelle loro varie forme e applicazioni,
Per una traduzione italiana di questo trattato cfr. P. A. Rossi (a cura di), Picatrix. Ghayat alhakim: “Il fine del saggio” dello Pseudo Maslama Al-Magriti, Milano 2000.
6
136
Flavia Buzzetta
esse concorrono a formulare una magia della voce che mira a riprodurre l’atto divino
della creazione.
Un altro testo fondamentale per le teorie medievali della magia è un’opera
araba di al-Kindi, tradotta in latino con il titolo di De radiis, ma nota anche come la
Teoria delle arti magiche.7 Secondo l’autore, la realtà è attraversata da raggi che legano tra loro le varie regioni dell’essere in una fitta trama occulta di interconnessioni, di influssi e di corrispondenze. Gli enti celesti e terrestri agiscono mediante raggi
e tutto ciò che accade nel mondo elementare è causato da questi. Il sapiente deve
conoscere i rapporti causali di interazione radiale tra gli agenti e i riceventi. La magia
è conoscenza dei legami occulti tra il mondo elementare e le sfere celesti, della trama
segreta di rapporti che legano le varie regioni del cosmo in un tutto unitario, organico
e armonico, in cui le varie parti sono interconnesse tra loro secondo rapporti di “simpatia” e di “antipatia”. I legami cosmici fondati sulle interazioni radiali degli astri e
la peculiare compenetrazione di cause ed effetti – secondo cui le cause si trovano negli effetti e gli effetti nelle cause – rendono possibile la prassi magica. Se dunque nel
Picatrix la magia è assunta come “scienza”, in particolare come scienza delle virtù
occulte che animano il cosmo, nel De radiis ricorre la teoria della causalità magica
basata sui vincoli simpatetici che uniscono i vari piani del reale.
Il legame tra la simpatia universale e la prassi magica, già teorizzato nell’ambito del neoplatonismo greco, diviene un motivo ricorrente della magia tardo-medievale intesa come scienza. Esso si riscontra nella già menzionata “magia naturale”,
teorizzata nel XIII secolo per la prima volta da Guglielmo d’Alvernia. La magia naturalis o nigromantia secundum phisicam studia le virtutes naturali ed è considerata
come una parte della “scienza naturale”.
La “magia naturale” in Giovanni Pico della Mirandola
Massimo teorico della “magia naturale”, tra il tramonto del Medioevo e l’alba
del Rinascimento, può essere considerato Giovanni Pico della Mirandola, il quale,
nel suo progetto di codificazione di un sapere universale che segni la pax philosophica, include una specifica trattazione tematica della magia quale specifica tradizione sapienziale di grande dignità e d’intrascurabile importanza. Nelle opere di Pico,
fondamentalmente nella trilogia legata alle vicende del periodo romano, costituita
dalle Novecento Conclusioni, dall’Orazione (nota anche con il titolo Sulla dignità
dell’uomo) e dall’Apologia, è rintracciabile, a mio avviso, una coerente e omogenea
teoria filosofica generale della magia, vista nei suoi fondamenti teorici universali e
Per una traduzione italiana di quest’opera cfr. Ya’qub Ibn Ishaq al-Kindi, De Radiis. Teorica
delle arti magiche, a cura di E. Albrile e S. Fumagalli, Milano 2001.
7
Aspetti della magia in epoca tardo-medievale..
137
nei suoi rapporti costitutivi con la “parte pratica della scienza della cabala”, anch’essa concepita in termini magici.
Un elemento basilare della teoria pichiana della magia, funzionale alla sua
piena riabilitazione e valorizzazione sapienziale, è la nota distinzione tra la magia
demoniaca, falsa e dannosa, condannata come illecita, e la magia naturale, intrinsecamente salutare, accolta e difesa come lecita:
Tutta la Magia che si pratica presso i moderni e che la Chiesa a buon diritto respinge non ha nessuna solidità, nessun fondamento, nessuna verità. Essa
dipende, invero, dalla mano dei nemici della prima verità, potenze di queste
tenebre: e tali potenze spargono tenebre di falsità su intelligenze disposte al
male.8
La Magia naturale è lecita, non sottoposta a divieti […].9
Se la magia demoniaca si fonda sul potere malvagio dei demoni, la magia
naturale agisce invece sulle strutture profonde e sulle forze occulte della natura in
base a una retta conoscenza delle leggi che la regolano, al fine di conseguire legittimi benefici di tipo essenzialmente spirituale. Intesa come magia naturale, la magia
è concepita come uno specifico versante della scienza naturale, le cui operazioni si
svolgono in conformità ed entro i limiti dell’ordine naturale stabilito da Dio. Pensata
come la pars practica della scientia naturalis, la magia naturale rientra di diritto
nell’ambito del sapere universale come una specifica disciplina “filosofica” incentrata sull’attività della ragione e trova il suo fondamento nella strutturazione simpatetica della natura, concepita come una totalità organica attraversata da una rete di
occulte corrispondenze che legano insieme e coordinano le varie parti che la costituiscono. La magia naturale opera per agentia naturalia, unificando e attualizzando le
virtutes che in natura sono separate tra loro, ma potenzialmente congiungibili, e allo
stato potenziale e seminale, e dunque attualizzabili:
non vi è nè in cielo nè in terra virtù allo stato potenziale e separata che il mago
non possa portare allo stato attuale e unificare.10
Le meraviglie dell’arte magica non avvengono che per unione ed attuazione di
cose che in natura esistono allo stato di potenza e di separatezza.11
[…] come il contadino sposa gli olmi alle viti, così il Mago marita la terra al
cielo, e cioè le forze inferiori alle doti e alle proprietà superne.12
Giovanni Pico della Mirandola, Conclusiones nongentae. Le novecento tesi dell’anno 1486,
a cura di A. Biondi, Firenze 1995, p. 117 (Conclusione magica secondo opinione propria I).
9
Ibid. (Conclusione magica secondo opinione propria II).
10
Ibid., p. 119 (Conclusione magica secondo opinione propria V).
11
Ibid. (Conclusione magica secondo opinione propria XI).
12
De hominis dignitate, cit., p. 57.
8
138
Flavia Buzzetta
Il mago, dunque, “marita il mondo”, congiunge le virtù terrene a quelle celesti, obbedendo alle leggi che regolano la natura. In tale visione, attestata in molto
pensiero umanistico (per esempio in Marsilio Ficino), se la natura è vista in qualche
misura come regnum hominis, l’uomo, come mago, è visto come naturae ministrum,
fedele servitore e amministratore della natura, sottoposto alle sue leggi e al Creatore
che le ha istituite. Si riscontra, così, una chiara formulazione del topos rinascimentale secondo cui il mago, con la sua arte, è interprete della magia della natura e agisce
in osservanza delle leggi divine.
Nella sua strutturazione pratica, la magia naturale ha per Pico un fine essenzialmente contemplativo e una destinazione teologico-religiosa: attraverso le trasformazioni causate per artem in seno alla natura, infatti, la magia naturale permette di
scoprire nei segreti della natura le mirabili azioni di Dio e, in tal modo, conduce al
perfezionamento delle acquisizioni della scienza naturale (intesa come filosofia della
natura), di cui essa costituisce la più nobile parte (nobilissima pars). Come tale, la
magia naturale non soltanto è “filosofia”, ma costituisce “l’assoluto compimento
della filosofia naturale” (naturalis philosophiae absoluta consummatio), “l’apice e il
fastigio dell’intera filosofia” (apex et fastigium totius philosophiae), di una filosofia
vista come preparazione della teologia. In quest’ottica, per Pico, la magia naturale,
operando sulla natura e scoprendo in essa meravigliose opere divine, conduce al
riconoscimento della gloria del Dio creatore e ordinatore della “mondana dimora”;
gloria della quale, secondo il testo di Isaia 6:3, “sono pieni i cieli e la terra”, cioè
i due piani della natura su cui la magia agisce. In ciò la magia promuove “il culto
e l’ardente amore rivolti all’Artefice”. Così si rivela come intrinsecamente benefica, salutare, salvifica, perfettamente conciliabile con la fede cattolica, imponendosi come un prezioso segmento dell’itinerario che conduce a Dio quale fine ultimo
dell’uomo.
Per Pico quindi l’efficacia della magia naturale, intesa come scienza, è legata
all’intervento umano sulle virtutes naturali sulla base di una retta conoscenza del suo
ordine interno; il fine della magia è indicato nell’elevazione a Dio, nell’ambito di un
percorso di progressiva trasformazione morale, sapienziale e spirituale; l’esercizio
della magia consiste non in una sottomissione della natura a un dominio dispotico
dell’uomo, ma in una salutare sottomissione dell’uomo alla natura, che è da lui amministrata, e a Dio, che è il Creatore dell’ordine naturale e che è conoscibile nella sua
gloria tramite la prassi magica.
In Pico la magia naturale pichiana è strettamente connessa alla “cabala pratica” (cabala practica) la quale costituisce quale parte operativa della cabala, l’antica
sapienza iniziatica ebraica che il Mirandolano interpreta in chiave cristiana. La cabala pratica è il fondamento e, insieme, il coronamento della magia naturale, dalla
quale si distingue per la sua base teorica e per la modalità della sua prassi operativa.
Ogni operazione magica, secondo Pico, risulta efficace in quanto si rivela strutturalmente congiunta a una concomitante operazione cabbalistica (opus cabalae): «nes-
Aspetti della magia in epoca tardo-medievale..
139
suna operazione di magia può essere di efficacia alcuna, se non abbia annessa l’opera
cabbalistica, esplicita o implicita».13
La costitutiva dipendenza della prassi magica dall’annessa prassi cabbalistica
è dovuta alla capacità di quest’ultima di operare su piani del reale e livelli di causalità superiori a quelli su cui è capace di agire la prima, con riferimento alle Sefirot
(le originarie Manifestazioni della Divinità, diffusamente tematizzate nei testi della
qabbalah ebraica), ai Nomi divini, alle Intelligenze angeliche. Pico rinvia in questo
caso all’assunto metafisico, di stampo neoplatonico, secondo cui nella concatenazione causale le cause gerarchicamente inferiori, sulle quali agisce la magia naturale,
dipendono dalle cause gerarchicamente superiori, sulle quali invece agisce la cabala
pratica; cause, queste ultime, che manifestano una maggiore estensione causale rispetto alle inferiori, e che agiscono mediatamente in queste. Se il raggio d’azione
della magia naturale, operante sulle cause secondarie, non supera i limiti della natura, quello della cabala pratica, operante sulle cause primarie, va oltre quest’ultima,
elevandosi agli agenti soprannaturali. Se infatti i termini di riferimento della prassi
magica sono le virtutes naturales, quali potenze latenti disseminate da Dio nella
natura per il bene dell’uomo “contemplativo”, i termini di riferimento della prassi
cabbalistica sono invece le superiori virtutes spirituales delle intelligenze angeliche,
delle manifestazioni sefirotiche, dei nomi divini. Ciò, in ogni caso, sullo sfondo di
una visione unitaria ed organica della totalità della realtà, secondo la quale i vari piani di essa, pur secondo una distinzione tra immanenza e trascendenza e una dialettica
tra continuità e separatezza, manifestano una trama occulta di rapporti, e tutto è a
suo modo in tutto.
Va notato come per Pico la magia naturale, assunta quale parte pratica della
scienza naturale e riconosciuta come sapienza legittima e salutare, nelle sue operazioni dipenda fondamentalmente da Dio, dispensatore di virtutes agli “uomini contemplativi di buona volontà”:
Qualsiasi opera che susciti stupore, sia essa di tipo magico o di tipo cabalistico
o di qualsiasi altro genere, deve in primissima istanza essere riferita a Dio glorioso e benedetto, la cui grazia fa piovere quotidianamente acque sopracelesti
di mirabili virtù sopra gli uomini contemplativi di buona volontà.14
Alcune pratiche dell’arte magica “popolare”
La teoria pichiana della magia, incentrata sul peculiare legame tra la magia
13
14
Conclusiones nongentae, cit., p. 119 (Conclusione magica secondo opinione propria XV).
Ibid. (Conclusione magica secondo opinione propria VI).
140
Flavia Buzzetta
naturale e la cabala pratica, elabora il modello di una magia cabalistica, articolata in
varie parti distinte e interconnesse, operante sui vari piani del reale sulla base di una
pluralità di procedure e tecniche rituali. In questa dotta teorizzazione della magia
confluiscono e si raccordano elementi provenienti da eterogenee tradizioni magiche,
ripensati in un tentativo di legittimazione e di fondazione scientifica. Si potrebbe
anche dire, anzi, che la magia “dotta” trae i suoi materiali da quella “popolare”, secondo processi di fondazione teorica e di rimodulazione del loro senso.
Riguardo alla cultura magica tardo-medioevale, dunque, se appare criticamente possibile distinguere tra magia dotta e magia popolare, si riscontra in ogni caso
uno stretto rapporto tra questi due ambiti. Può essere classificata come popolare un
tipo di magia dai risvolti essenzialmente pratici: l’uomo, grazie agli artifici magici,
produce degli effetti mirabili con cui modifica a proprio vantaggio la realtà. L’operatività magica è rivolta all’utile; essa assicura la guarigione dalle malattie e il benessere fisico, la ricchezza, l’amore, il successo nelle proprie attività, il superamento delle
difficoltà e il raggiungimento di fini prefissati, ma può essere utilizzata anche per
arrecare danno a cose e persone. Tale magia, nella sua operatività, non fornisce spiegazioni sulle cause degli effetti che essa è in grado di produrre, le quali possono essere ignorate dall’operatore. Le fonti medievali di quest’arte magica sono costituite
da vari testi che per lo più rimandano in misura rilevante alla sincretistica tradizione
magica greco-romana della tarda antichità e consistono in raccolte di varie formule e
ricette, non accompagnate da esplicazioni teoriche relative alla loro efficacia.
Alcuni esempi:
Se pronuncerai il nome a un posseduto da un demonio e accosterai al suo naso
zolfo e bitume, immediatamente parlerà e il demonio si allontanerà.15
Se vorrai uccidere un serpente, devi dire: «Fermati! Tu sei Aphyphis». Prendi
il cuore da un ramo verde di palma, dividilo in due e pronuncia per sette volte
il nome; immediatamente il serpente si spezzerà e scoppierà.16
Nelle due ricette sopra citate, accompagnate dalle relative indicazioni d’uso,
abbiamo come elementi caratterizzanti del rituale magico finalizzato al conseguimento di benefici (la guarigione dalla possessione demoniaca, l’uccisione di un animale giudicato pericoloso quale è un serpente) il legame sinergico tra le potenzialità
della natura e le potenzialità del linguaggio, la virtus naturalis e la virtus verborum:
alla sapiente manipolazione rituale di elementi naturali (zolfo e bitume nel primo
caso, il ramo della palma nel secondo caso) è associata la recitazione rituale sterotipata di elementi e formule linguistiche dal valore pratico-performativo (il nome
15
Testo contenuto in G. Luck (a cura di), Arcana Mundi, vol. I, Magia, Miracoli, Demonologia,
Milano 2005, p. 171.
16
Ibid.
Aspetti della magia in epoca tardo-medievale..
141
dell’indemoniato nel primo caso; l’ordine di arresto e il nome magico nel secondo
caso), il cui concorso permette di raggiungere i risultati desiderati.
Traggo un altro esempio dai testi magici della Genizah del Cairo:
nel nome del Signore di Israele. Possa aiutarci in ciò che facciamo: riguardo ad
Abul: possa il Signore benedire il tuo negozio e l’opera delle tue mani […] Nel
nome di (sigillo) io ti invoco, invoco le sante lettere di indirizzare ogni uomo e
donna e ogni mercante nel negozio di […].17
In questo caso si evidenzia un tipo di magia linguistica di matrice ebraica,
dalle manifeste finalità pratiche legate all’utile materiale negli affari, caratterizzata
dal ricorso alla recitazione di formule rituali legate all’uso di sigilli (in ebraico chotam) in cui sono incise lettere magiche, connesse al nome del Signore. La potenza
benefica del Nome divino è veicolata dalle lettere dell’alfabeto ebraico in cui esso si
esprime, sapientemente combinate. Va ricordato che le lettere, specialmente quelle
ebraiche, con le loro valenze numerologiche (secondo una connessione tra la magia
del linguaggio e la magia aritmetica) e le relative tecniche di combinazione e permutazione, costituiscono dei ricorrenti strumenti operativi della magia. Particolarmente
rilevante è l’incidenza delle lettere nella magia cabalistica ebraica, quale magia basata sull’occulta potenza poietico-performativa del linguaggio, capace di riprodurre
la potenza demiurgica dell’atto linguistico divino della creazione e del governo del
mondo.
Un interessante esempio di magia popolare basata sulla fruizione delle potenzialità del linguaggio, è contenuto nel manoscritto di Wolfsthurn. Per liberare
un indemoniato, l’autore suggerisce di leggere una formula in latino e greco “maccheronici” e caratterizzata dalla presenza di nomi misteriosi e parole dal significato
arcano: «Amara Tonta Tyra post hos firabis ficaliri Elypolis starras poly polyque
lique linarras buccabor vel barton vel Titram celi massis Metubor o priczoni Jordan
Ciriacus Valentinus».18
Un altro significativo esempio si legge in un manuale di negromanzia risalente
al XV secolo. Vi si trova una tecnica mirata ad ottenere uno stato di invisibilità attraverso l’invocazione di entità spirituali, accompagnata da precise pratiche rituali e
catartiche e dalla riproduzione di immagini magiche:
se vuoi essere invisibile e impercettibile a tutte le creature razionali e irrazionali, nel momento in cui la luna è crescente, un mercoledì, durante la prima ora
17
Il testo è riportato in L. H. Schiffman - M. D. Swartz, Hebrew and Aramaic Incantation Texts
from the Cairo Genizah. Selected Texts from Taylor-Schechter Box K1, Sheffield 1992, pp. 107-108
(traduzione italiana mia).
18
Testo citato in R. Kieckhefer, La magia nel Medioevo, cit., p. 7.
142
Flavia Buzzetta
del giorno, devi essere casto da tre giorni, i tuoi capelli e la tua barba devono
essere tagliati, devi essere vestito di bianco, in un luogo segreto esterno alla
città, sotto un cielo limpido, traccia nel suolo quello che ti mostro (immagine)
[…] inginocchiati verso Occidente e pronuncia queste parole: “io vi congiuro
o Fryel, Mememil, Berith, Taraor, spiriti potenti, magnifici e illustri, nei quali
io confido per la Santa Trinità, per il Dio unico, per il cielo e la terra, per tutti i
principi, per il Dio in cui credete, perché voi veniate da me con grande umiltà
e facciate la mia volontà essendo legati, obbligati e congiurati.” Essi risponderanno: “dicci ciò che desideri e noi ti ubbidiremo”. E tu risponderai: “voglio
una cappa d’invisibilità […]”.19
Va notato che il rituale magico in questione consiste nel conseguire i mirabili
risultati sperati attraverso la “legatura” degli spiriti, i quali sarebbero magicamente
costretti, con tale “congiurazione”, a piegarsi alla volontà del mago e a soddisfarne
le richieste con i loro poteri. Siamo così in presenza di una magia “destinativa” che
si indirizza a entità spirituali per beneficiare della loro potenza nel mondo naturale.
Al riguardo si può anche ricordare come nelle pratiche della magia popolare
una funzione di rilievo è ricoperta dall’uso di specifici oggetti rituali costituiti da
amuleti e talismani. Gli amuleti sono oggetti di origine naturale, come pietre, piante
o parti del corpo di un animale, i quali presuppongono una magia simpatetica e sono
illustrati in una varietà di erbari e lapidari medievali. I talismani, invece, sono oggetti artificiali, ai quali si imprime ritualmente una virtù magica, una potentia agendi.
Sia gli amuleti che i talismani possono essere corredati da formule magiche che ne
attivano le potenzialità. In genere, si può rilevare come gli amuleti siano considerati
efficaci in quanto dotati di una virtus intrinseca, naturale, e i talismani, invece, in
quanto dotati di una virtus estrinseca, artificiale, non posseduta per natura dal’oggetto, ma acquisita tramite una sua consacrazione rituale. Differenza, questa, che
sovente si rivela puramente indicativa e non è priva di ambiguità.
Ma l’azione magica ricorre anche all’uso di altri oggetti rituali, come le “immagini” (imagines) di vari tipi, artefatti che rinviano a una magia di tipo mimeticosimpatetico. Esse sono riproduzioni che permettono di agire sulle realtà di cui sono
copie in virtù del legame di corrispondenza con esse e delle potenze spirituali attivabili tramite le immagini. Tra esse figurano anche le statutette o i disegni di uomini,
predisposti per agire su essi, il cui uso appare ricorrente nella cosiddetta “magia
nera”. Esempi di questa diffusa pratica magica sono contenuti nel De generatione
hominis, un testo tardomedievale di magia ebraica di matrice chassidico-ashkenazita,
pervenutoci nella traduzione latina effettuata dall’ebreo converso siciliano Guglielmo Raimondo Moncada alias Flavio Mitridate per Giovanni Pico della Mirandola,
J.-P. Boudet, Entre Science et Nigromance. Astrologie, divination et magie dans l’Occident
médiéval (XIIe-XVe siècle), Paris 2006, p. 563 (traduzione italiana mia).
19
Aspetti della magia in epoca tardo-medievale..
143
contenuto nel Ms. Vaticanus Ebraicus 189 (Biblioteca Vaticana, Roma), ff. 398r509v, di cui mi sto occupando nelle mie attuali ricerche.
Vi si legge, per esempio:
invece con l’arte magica si fa questo: le maghe modelleranno un’immagine
fatta di cera come questo o quell’uomo, e non faranno altro che pronunciare
un discorso su quella [immagine], e quello che è fatto all’immagine di cera
è fatto all’uomo. Se infatti si punge quella immagine in qualcuna delle sue
membra, similmente [accade] all’uomo. Se la si seppellisce, l’uomo morirà e
sarà seppellito, [e questo] si fa con il suo nome. E similmente si disegna sul
muro un’immagine dello stesso ladro che si sospetta sia l’artefice di un furto,
si pungerà l’occhio di quell’immagine con un ago e l’occhio del ladro proverà
dolore. Questo perché i prefetti dell’immagine e i prefetti di chi forgia l’immagine andranno da quel prefetto che è preposto al ladro, gli indicheranno questa
cosa e il prefetto del ladro farà sentire dolore al ladro.20
Nel passo sopra riportato, l’istanza secondo cui l’immagine – una statutetta o
un disegno – va associata al nome di colui che è riprodotto in essa, connette la magia
delle immagini alla magia del linguaggio, e l’efficacia di tale pratica magica è legata
all’azione intermediaria dei prefecti, entità spirituali (angeliche o demoniache) “preposte” al mondo corporeo, le quali sono indotte ad agire in un modo o nell’altro sulla
base di operazioni rituali di tipo destinativo. L’uomo, dunque, in qualche misura può
controllare magicamente gli agenti spirituali preposti ad agire nel mondo, piegandoli
alla propria volontà e sfruttando i loro poteri per conseguire i fini desiderati. Notevole è anche il fatto che questa pratica sia specificamente attribuita alle maghe (magae
mulieres), secondo un topos dell’immaginario magico medievale che individua sovente nelle donne gli operatori della magia popolare.
Un’altra pratica magica legata alla fruizione di immagini, descritta in questo
trattato, è una tecnica di tipo lecanomantico, consistente nel divinare il proprio futuro
tramite l’osservazione della propria immagine riflessa nell’acqua, le cui fattezze permettono di svelare la disposizione dell’angelo preposto al singolo uomo e al suo fato:
c’è anche una notte nell’anno in cui se si riempie un vaso di acqua, chi guarda
in esso e osserva attentamente, quando guarda e osserva, deve aprire i suoi
occhi e la sua bocca e deve considerare se vede la sua immagine [riflessa]
in quell’acqua. Se infatti vedrà nell’acqua l’immagine o la sua effigie con la
bocca e gli occhi aperti come egli stesso li mostra, sarà certo che nel corso di
quell’anno egli resterà vivo. Se invece egli mostrerà [gli occhi e la bocca] aperti e [nell’immagine] li troverà chiusi, allora [in quell’anno] non vivrà, perché
il suo arcangelo, che è a sua immagine e somiglianza, si trova tra il suo volto e
20
Ms. Vat. Ebr. 189, f. 456v (traduzione italiana mia).
144
Flavia Buzzetta
tra i morti. E per questo l’immagine è come l’immagine dell’angelo preposto
su di lui, sotto il suo arcangelo.21
Un ultimo esempio significativo che desidero riportare in questo mio breve
excursus, riguarda una particolare operazione classificabile come una pratica rituale
di magia alchemica, consistente nella produzione artificiale di un essere vivente.
Un’attestazione di tale pratica è contenuta nel Liber vaccae o Liber aneguemis sive
leges Platonis, opera anonima di magia araba redatta intorno al IX secolo d.C. che
tratta di esperimenti magici fatti su animali e fa leva su una concezione vitalisticopampsichista della natura. Le ricette di questo manuale riguardano manipolazioni
di organi o umori animali o vegetali, finalizzate alla creazione di animali animati
artificiali, irrazionali o razionali, da utilizzare a scopi magico-operativi.
Il primo esperimento descritto nel Liber vaccae riguarda la creazione di un
animale razionale. L’operatore mescola il suo liquido seminale con polvere di pietra
solare e introduce il composto nel corpo vivo di una mucca o di una capra. L’essere
che nascerà avrà l’aspetto di un uomo, sarà un antropoide artificiale che potrà essere utilizzato in operazioni magiche. Il sangue di questa creatura, ad esempio, può
trasformare gli uomini in animali. Si tratta di una magia “organica” con cui l’uomo
assurge a demiurgico imitatore dell’atto creatore divino tramite la sapiente manipolazione di ingredienti tratti dai vari regni della natura.
Tecniche di manipolazione della materia finalizzata alla creazione di esseri viventi artificiali sono attestate nella tradizione ebraica, in particolare in testi riconducibili alla corrente del chassidismo hashkenazita. A differenza della tecnica esposta
nel Liber vaccae, tali tecniche magiche possono essere considerate come espressioni
di un’alchimia delle lettere, perché la generazione magica della vita avviene grazie a
una sapiente fruizione delle lettere ebraiche (attraverso la loro combinazione e recitazione), le quali, come componenti del linguaggio poietico divino ed elementi costitutivi dell’intera realtà, si rivelano cariche di potenza creatrice. Il Commentum Sefer
Yesirae, un’opera attribuibile a Rabbi Eleazar di Worms (XIII secolo), pervenutaci
in una traduzione latina fatta da Flavio Mitridate per Giovanni Pico della Mirandola
e conservata nel Ms. Vaticanus Ebraicus 191 (Biblioteca Vaticana, Roma), ff. 1r-12r,
riporta la più antica ricetta pervenutaci per la creazione rituale di un essere vivente
artificiale:
qualora qualcuno voglia operare, si purificherà e indosserà abiti bianchi e non
opererà solo […]. Prenda della terra vergine da un luogo incolto e ammorbidisca quella terra con l’acqua di una fonte viva e modelli una figura combinando
sopra di essa [le lettere] secondo il numero dell’alfabeto e delle 221 lettere
numerali per ciascun membro, come è scritto nel testo del Sefer Yetsirah, e
21
Ibid., f. 501r (traduzione italiana mia).
Aspetti della magia in epoca tardo-medievale..
145
inizi da quello girando e pronunciando [le lettere] fino a quando abbia indotto
la vita.22
La combinazione alfanumerica delle lettere ebraiche, tseruf, effettuata attraverso la tecnica combinatoria-permutativa della “rotazione alfabetica” nelle 221
combinazioni, assimilate alle “Porte della Sapienza”, permette all’uomo di vivificare
la materia inerte e creare un antropoide artificiale. Con tale pratica l’uomo riproduce
l’atto creativo di Dio – il quale plasma l’uomo dalla terra e lo anima con il suo soffio
vitale – e in tal modo può giungere in modo “ergetico” alla conoscenza di Dio stesso.
In questo testo si afferma che attraverso la combinazione misteriosofica delle lettere
dell’alfabeto ebraico, capace di conferire il potere creativo, gli uomini diventano
simili a Dio.23
Qualche considerazione conclusiva
A conclusione di questo rapido sguardo su taluni aspetti della magia medievale, quale complessa galassia culturale in cui convergono e si mescolano elementi di
svariate tradizioni magiche antiche, ritengo opportuno rimarcare la difficoltà che si
registra nel tracciare differenze tipologiche e linee di confine tra tradizioni e saperi
magici, i quali interagiscono tra loro, si compenetrano e si confondono. Elementi e
istanze delle ricette della magia popolare entrano a far parte delle elaborazioni scientifiche nella magia dotta, in cui il mago, possessore di questo arcano “sapere pratico”, è presentato come un accorto amministratore della natura, il quale agisce in una
realtà concepita come totalità organica e simpatetica, come macrocosmo segnato da
virtutes occulte e abitato da entità spirituali che possono interagire con l’uomo e da
cui l’uomo, in vari modi, può trarre vantaggio per il raggiungimento dei suoi scopi.
Nelle sue varie ed eterogenee manifestazioni, la magia medievale, vista in
una certa ottica, appare come una forma di sapere dotata di una propria ratio, di uno
statuto con il quale essa tende a strutturarsi come una disciplina autonoma in cui
si esprime una complessa visione del mondo nella quale, sulla scorta del concorso
di elementi derivati da diverse tradizioni e contesti, concorrono e si compendiano
istanze mutuate dalle credenze religiose, dalle concezioni filosofiche, dalla cultura
e dall’immaginario dell’epoca. Condivido, dunque, l’opinione di Vittoria Perrone
Compagni24 – espressa dalla studiosa con riferimento alla magia ermetica –, secondo
Ms. Vat. Ebr. 191, f. 12r (traduzione italiana mia).
Ibid., f. 10v (traduzione italiana mia).
24
Cfr. V. Perrone Compagni, La magia ermetica tra Medioevo e Rinascimento, in F. Meroi (a
cura di), La magia nell’Europa moderna, Firenze 2007, p. 17.
22
23
146
Flavia Buzzetta
cui la questione della magia non va posta nei termini di una contrapposizione tra
progresso e superstizione, considerandola ora come anticipazione della rivoluzione scientifica, ora come superstizioso errore. In una prospettiva critica, la magia si
presta ad essere inquadrata e studiata come fenomeno a sé stante, all’interno delle
coordinate culturali dell’epoca presa in esame.
Tracce bibliografiche
Indico di seguito una selezione di studi critici, da me consultati e utilizzati, sui
temi trattati in queste mie pagine:
J.-P. Boudet, Entre Science et Nigromance. Astrologie, divination et magie
dans l’Occident médiéval (XIIe-XVe siècle), Paris 2006.
J. N. Bremmer - J. R. Veenstra (eds.), The Metamorphosis of Magic from Late
Antiquity to the Early Modern Period, Leuven-Paris-Dudley Ma 2002.
G. Federici Vescovini, Medioevo Magico. La magia tra religione e scienza nei
secoli XIII e XIV, Torino 2008.
K. E. Grözinger, Between Magic and Religion - Ashkenazi Hasidic Piety,
in K. E. Grözinger & J. Dan (eds.), Mysticism, Magic and Kabbalah in Ashkenazi
Judaism. International Symposium Held in Frankfurt, Berlin-New York 1995, pp.
28-43.
W. J. Hanegraaff (ed.), Dictionary of Gnosis & Western Esotericism, in collaboration with A. Faivre, R. van den Broek, J.-P. Brach, Leiden-Boston 2006, in
particolare le voci Magic I: Introduction, di W. J. Hanegraaff (pp. 716-719) e Magic
III: Middle Ages, di C. Fanger e F. Klaassen (pp. 724-731)
M. Idel, Il Golem. L’antropoide artificiale nelle tradizioni magiche e mistiche
dell’ebraismo, tr. it. Torino 2006.
R. Kieckhefer, La magia nel Medioevo, tr. it. Roma-Bari 2004.
F. Pastore, La ragione e l’occulto. La filosofia di fronte a scienza e magia,
Milano 2009.
V. Perrone Compagni, La magia ermetica tra Medioevo e Rinascimento, in F.
Meroi (a cura di), La magia nell’Europa moderna, Firenze 2007, pp. 3-23.
Aspetti della magia in epoca tardo-medievale..
147
L. Thorndike, A History of Magic and Experimental Science during the First
Thirteen Centuries of our Era, 8 voll., New York 1923-1958.
J. Trachtenberg, Jewish Magic and Superstition, Phialdelphia 2004.
C. Vasoli, Magia e scienza nella civiltà umanistica, Bologna 1976.
C. Vasoli, Le tradizioni magiche ed esoteriche nel Quattrocento, in Id., Le
filosofie del Rinascimento, a cura di P. C. Pissavino, Milano 2002, pp. 133-153.
N. Weill-Parot, Les « images astrologiques » au Moyen Âge et à la Renaissance, Paris 2002.
Ch. Wirszubski, Pico della Mirandola’s Encounter with Jewish Mysticism,
Cambridge (Mass.) 1989 (trad. francese: Pic de la Mirandole et la Cabale, par J.-M.
Mandosio, Paris-Tel-Aviv 2007, con note del curatore).
P. Zambelli, L’ambigua natura della magia, Milano 1991.
P. Zambelli, L’apprendista stregone. Astrologia, cabala e arte lulliana in Pico
della Mirandola e seguaci, Venezia 1995.
P. Zambelli, Magia bianca e magia nera nel Rinascimento, Ravenna 2004.
Salvatore Girgenti
Le radici politiche e religiose dei templari:
una ipotesi di ricerca
Nessuna pagina della storia è così densa di misteri come quella dei templari.
È stato creato per operare in Medio Oriente – ha opportunamente rilevato Markale –, ma ha agito anche in Europa occidentale. È stato un ordine religioso,ma
anche militare. È stato indispensabile alla politica del papato e dei sovrani
europei, ma anche una milizia parallela dai fini oscuri. È stata una associazione
di monaci cavalieri pronti a morire per la fede cristiana, ma anche un gruppo
di uomini che rinnegavano Gesù, che portavano con fierezza la croce rossa, ma
anche che sputavano sulla croce. Il gonfalone del Tempio, il famoso baucent,
era bianco e nero: non esiste un simbolo che esprima meglio la dualità, o la
realtà a due facce, dell’ordine.1
Per comprendere le motivazioni per cui nacque l’Ordine del Tempio, almeno
a livello ufficiale, bisogna calarsi nel clima e nell’ambiente del tempo.
Le circostanze, come sappiamo, sono quelle delle crociate. Il 27 novembre
1095 papa Urbano II, parla al concilio regionale riunito a Clermon. In tale occasione, dopo aver preso una dura e violenta posizione contro quei cavalieri che vivono
nella lussuria e, in contrasto con la legge della Chiesa, violano la pace di Dio, come
i peggiori briganti, offre loro una possibilità di remissione: invece di battersi contro
i cristiani, invece di assassinare i propri fratelli, questi cavalieri buoni solo a gratuiti
ed esecrabili atti di violenza, non hanno che andare in Terra Santa a liberare il Santo
Sepolcro dalle mani degli infedeli. «D’ora in poi diventino Cavalieri di Cristo, coloro che non erano che briganti! Lottino a buon diritto contro i barbari, coloro che
si battevano contro i loro fratelli e genitori! Otterranno la ricompensa eterna, coloro
che per pochi miserabili soldi diventavano mercenari».2 L’appello è subito accolto
con grande entusiasmo.
1
2
J. Markale, I templari custodi di un mistero, Sperling Kupfer, Milano 2000, p. 65.
A. Demurger, I templari, un ordine cavalleresco cristiano nel medioevo, Milano 2006, p. 19.
150
Salvatore Girgenti
Per capire meglio il fenomeno, ancora una volta, bisogna calarsi nel clima
politico e sociale dell’Europa dell’XI secolo dove, e particolarmente in Francia, le
file della piccola nobiltà e dei cavalieri sono particolarmente affollate e inquiete. Per
i sovrani e per la chiesa, questi guerrieri turbolenti, sono una vera e propria spina nel
fianco. Ma ecco che viene loro offerta la possibilità di soddisfare appetiti e bellicosi entusiasmi: potranno acquisire ricchezze e nuove terre e stabilirsi in regioni che
diverranno di loro proprietà. Non solo, ma anziché scontrarsi con la giustizia regale
ed incorrere nella riprovazione della chiesa, sono assolti in anticipo e sono sicuri di
ottenere il paradiso.3 Un sistema che sarà utilizzato più volte nel corso della storia.
Quando un insieme di individui diventa troppo ingombrante e minaccia una
nazione dell’interno, lo si manda all’esterno. «il vantaggio è duplice: lo Stato può
guadagnare nuovi territori e gli uomini mandati altrove, che sopravvivano o che
muoiano, di solito non ritornano. Che liberazione!».4 Questo è il vero senso delle
crociate: da un lato, sebbene rivestite di spiritualità, servono per liberare l’Europa
dai cavalieri indesiderabili, e allo stesso tempo sono un investimento per il futuro.
L’appello di Clermont, come dicevamo, suscita reazioni entusiaste. Una folla
invasata, ma indisciplinata si mette in marcia: uccide e depreda tutte le comunità
ebraiche che incontra lungo il cammino, non disdegnando di uccidere contadini cristiani e cittadini di Bisanzio. I sovrani di cui attraversano il territorio cercano di farli
passare il più velocemente possibile e, a volte, non esitano a schierare contro i loro
eserciti, per ridurli a più miti consigli. Finalmente il 13 luglio del 1099 conquistano
Gerusalemme. Vengono quindi fondati i regni latini del medio Oriente.
Molti crociati rimangono in Palestina e in Siria, ma la maggior parte fa ritorno
in patria. Dopo la liberazione dei luoghi santi, i cristiani sono colti da una nuova
passione: recarsi a pregare sul sepolcro di Cristo. Diventa quindi necessario proteggere questi pellegrini, visto che le strade di accesso a Gerusalemme sono esposte ad
agguati da parte dei musulmani, per non dire che sono dei campi di battaglia permanenti. Baldovino, conte di Edessa e primo re di Gerusalemme, dopo la morte di
Goffredo di Buglione, non ha truppe sufficienti per potere proteggere i pellegrini. Le
zone occupate dai cristiani sono costantemente minacciate dai musulmani. A questo
punto interviene un piccolo nobile della Champagne, Ugo de Payns.
Nello stesso anno 1119 alcuni nobili cavalieri, pieni di devozione, religiosi
e timorosi di Dio, mettendosi a disposizione del signor patriarca per servire
Cristo, professarono di voler vivere per sempre secondo le regole dei canonici,
osservando la castità e l’obbedienza e rifiutando ogni proprietà.5
S. Runciman, Storia delle crociate, Torino 1993; J. Flori, Le crociate, Bologna 2003.
Ibid., p. 67.
5
M. Barber, La storia dei templari, Casale Monferrato 2001, p. 15. Si veda anche William of
Tyre, A History of deeds done beyond the sea, New York 1943.
3
4
Le radici politiche e religiose dei templari...
151
Così scrive Guglielmo di Tiro, cancelliere e poi arcivescovo di Gerusalemme.
Tuttavia, poiché era nato nel 1130, non poteva conoscere le origini del Tempio.
La sua testimonianza è, comunque, la più antica che possediamo. Un secolo
dopo Jacques de Vitry, vescovo di Acri, torna sull’argomento e riferisce che questi
cavalieri, con voti solenni pronunciati davanti al patriarca di Gerusalemme, si impegnarono a difendere i pellegrini contro i briganti e i rapinatori, a proteggere le vie
di accesso a Gerusalemme e a servire come cavalieri il re sovrano. Infine, aggiunge
che fecero voto di povertà, castità e obbedienza, come i canonici regolari.6 Si tratta
del primo documento che riferisce dello scopo di questo nuovo ordine: controllare le
vie di pellegrinaggio in Terra Santa. Ma il testo, come dicevamo, è scritto più di un
secolo dopo gli avvenimenti e in realtà non abbiamo alcuna prova che de Payns e i
suoi primi compagni avessero effettivamente questo compito di sorveglianza.
Non si è nemmeno certi dell’anno della loro istituzione. Guglielmo di Tiro
parla del 1118, ma riferendoci al Concilio di Troyes del 1128, nel corso del quale
vennero codificate le regole dell’Ordine, i cronisti registrano l’evento nel nono anno
dalla fondazione dell’ordine cavalleresco e, quindi, l’anno di nascita dovrebbe spostarsi al 1119. C’è addirittura chi sostiene che l’ordine sia stato fondato ancora prima
del 1114 se bisogna dar credito ad una lettera, inviata dal vescovo di Chartres al conte di Champagne, che proprio in quell’anno si preparava a partire per la Terrasanta.
In questa lettera, infatti, c’è un punto particolarmente interessante per l’argomento in
oggetto, perché, oltre ai soliti convenevoli, il vescovo aggiungeva: «abbiamo appreso che prima di partire per Gerusalemme avete fatto voto di entrare nella “milice du
Christ”, che desiderate arruolarvi in questo esercito evangelico».7
La Milice du Christ è il nome con il quale venivano indicati i templari e, certamente, non si può fare confusione con i crociati, «poiché il vescovo passa poi a
parlare del voto di castità che la decisione comportava. E difficilmente un voto del
genere poteva venire richiesto a un comune crociato».8
Ma il dubbio sull’anno di nascita dell’ordine è un problema di poco conto,
perché ancora più strane appaiono le modalità e le motivazioni della sua fondazione.
Ufficialmente ad istituire l’ordine monastico-guerriero fu Ugo de Payens, nobilotto
della vecchia contea di Champagne, assieme ad altri otto cavalieri, quasi tutti nativi,
tranne qualcuno proveniente dalla Borgogna, della stessa regione.
Ma c’è di più. Ugo de Payens è in stretti rapporti di parentela con i Montbard,
famiglia alla quale apparteneva, per parte di madre, il potente monaco cistercense
Bernardo di Chiaravalle. Come se ciò non bastasse, tra i membri fondatori dell’ordine figura anche Andrea di Montbard, zio dello stesso monaco.
6
Giacomo di Vitry, Historia Hierosolimitana, a cura di J. Bongars in Gesta Dei per Francos,
vol. I, tomo II, Hannover 1611.
7
M. Baigent-R. Leigh-H. Lincoln, Il Santo Graal, Milano 2004, p. 8.
8
Ibid.
152
Salvatore Girgenti
«L’ordine dei templari appare, dunque, sin dall’inizio come un’impresa provinciale, quasi familiare. Si forma un circolo di cospiratori che rappresentava un’unione ideale per proteggere eventuali segreti».9
Non meno emblematica è la posizione di Bernardo di Chiaravalle, che, per inciso, nutriva un culto particolare per la Madonna Nera. Fu istruito, infatti, nella chiesa di Saint Vorles, a Chatillon-sur-Seine, dove si venerava una Madonna Nera. La
leggenda vuole che Bernardo, trovandosi in preghiera avanti la Vergine, chiedesse:
monstra te matrem. Maria premette il seno e tre gocce di latte caddero sulle labbra
di Bernardo. L’allegoria è alchemica. Essa può significare che Bernardo, nutrito del
latte della Vergine Nera, si è dissetato alle fonti profonde della tradizione druidica.
Infatti, egli stesso indica come propri maestri le querce e gli elci, i due alberi sacri.
In un primo tempo, il monaco cistercense mostrava di disprezzare la cavalleria
del suo tempo, considerandola frivola, rammollita, senza fede e priva di valori. La
definiva “malizia”, cioè vera e propria peste della società. Bernardo era contro la
violenza e lo spargimento di sangue. Poi, come per illuminazione divina, si registra
in lui una completa inversione di rotta, trasformandosi nel teorico della guerra santa.
Nel 1130 pubblica, addirittura, la Lode della nuova milizia, spianando ancora una
volta la strada verso la legittimizzazione del nuovo ordine cavalleresco.10
Giunse, persino, a glorificare l’uccisione dei pagani, poiché per i templari, essendo soldati di Cristo, «la vittoria non è legata alla grandezza delle armate, ma alla
forza che viene dal cielo e alla potenza delle legioni del Signore».11
Indubbiamente, Bernardo di Chiaravalle doveva godere di grosso credito
all’interno della Chiesa e della cristianità in genere, poiché quanto disse e scrisse a
favore dei templari non era, per quei tempi, impresa di poco conto.
Un ordine religioso-cavalleresco costituiva, infatti, per la mentalità religiosa del
tempo, qualcosa di scandaloso. Chi faceva parte del clero non poteva macchiarsi le mani
di sangue. La sola idea di uccidere, non solo ripugnava, ma veniva rigettata. Ad un uomo
consacrato a Dio non era permesso di spargere sangue, né tantomeno di darsi al saccheggio. L’ordine dei templari nacque, così, in un clima di diffidenza e di sospetto.
In realtà, i templari crearono un certo imbarazzo per quanto concerne una
delle distinzioni fondamentali della società medievale. I riformatori della Chiesa
avevano deciso di impedire agli uomini le cui mani si fossero macchiate di sangue di
toccare gli oggetti sacri. Anche nel caso di nobili cavalieri che si pentissero e che in
età matura si votassero alla vita monastica, quelli che erano vissuti nel monastero sin
dall’infanzia erano spesso riluttanti a riservare loro una buona accoglienza. La nostra
concezione moderna, influenzata dall’idealistico lustro conferito alla cavalleria dai
M. Bauer, Il mistero dei templari, Roma 2002, p. 40.
A. Demurger, I templari, Milano 2006; S. Cerrini, La revolution des templiers, Perrin 2007;
B. Frale, I templari, Bologna 2004.
11
M. Bauer, Il mistero dei templari, cit., pp. 35-39.
9
10
Le radici politiche e religiose dei templari...
153
romantici, vede un’armonia tra spada e altare; nulla potrebbe essere più lontano dalla
realtà medievale. La Chiesa non voleva avere a che fare con degli indesiderabili di
tal fatta, sempre pronti a infrangere ogni legge, in particolare quella sul matrimonio.
Fino ad allora la cavalleria era per molti aspetti considerata un affare illecito in cui il
clero non doveva immischiarsi.
Essendo questo il clima culturale del tempo, secondo il quale uomini votati
allo spargimento di sangue non avrebbero dovuto essere considerati come appartenenti all’ordine clericale, fu un compito arduo per San Bernardo legittimarne la
nascita. Quest’ultimo, in poche parole, doveva fare appello alle sue capacità persuasive per riuscire a trovare argomenti validi al fine di giustificare l’uccisione dei
miscredenti e introdurre un’importante varietà a quella che sino ad allora era stata
l’unanime dottrina della chiesa medievale: che ad un uomo consacrato a Dio non
era permesso spargere sangue. Lo fece con uno dei suoi soliti metodi disincantati di
discussione.12
In verità – scrisse – i cavalieri di Cristo combatterono le battaglie del loro Signore senza correre rischi, senza in alcun modo sentire di aver peccato nell’uccidere il nemico, non temendo il pericolo della loro stessa morte visto che si a
dare la morte, sia il morire quando sono fatti in nome di Cristo non sono per
nulla atti criminosi, ma addirittura meritano una gloriosa ricompensa […] il
soldato di Cristo uccide sentendosi sicuro: muore sentendosi ancora più sicuro.
Non per nulla egli porta la spada! Egli è lo strumento di Dio per la punizione
dei malfattori e per la difesa dei giusti. Invero, quando egli uccide un malfattore non commette omicidio, ma malificio, e può essere considerato il carnefice
autorizzato da Cristo contro i malvagi.13
Lo stesso Ugo de Payns, primo Gran Maestro dei cavalieri del Tempio, ribadì
più volte che i soldati di Cristo non dovevano cedere alla tentazione di pensare di
avere ucciso in preda a odio e furore, né di essersi impadroniti del bottino in preda
a cupidigia, siccome i templari non odiavano gli uomini, ma l’ingiustizia umana; e
quando si impadronivano del bottino dei miscredenti compivano un atto di giustizia,
per via dei peccati dei miscredenti e anche perché si erano meritati il bottino con le
loro fatiche: chi lavora si è guadagnato il proprio salario. Una ingenua giustificazione, che attesta come i templari dedicassero tempo ed energia al saccheggio.
In maniera ancora più radicale S. Bernardo si era fatto convinto che era meglio
che i miscredenti venissero uccisi, piuttosto che continuassero a incombere minacciosi sul destino dei veri credenti. All’obiezione che un cristiano non debba uccidere,
12
Sugli esordi dell’ordine templare e il ruolo di San Bernardo: F. Cardini, I poveri cavalieri di
Cristo. Bernardo di Clairvaux e la fondazione dell’ordine templare, Rimini 1992.
13
J. Markale, I templari custodi di un mistero, cit., p. 76.
154
Salvatore Girgenti
Bernardo rispondeva:
e allora? Se al cristiano non fosse consentito l’uso della spada in alcuna circostanza, perché mai, allora Giovanni Battista raccomandò ai soldati di accontentarsi della propria paga (Luca 3:14): perché, piuttosto, non proibì loro ogni
forma di servizio militare?14
A questo punto, la domanda che dobbiamo porci è: che cosa spinse Bernardo di
Chiaravalle a gettare alle ortiche le sue vecchie convinzioni e a proteggere in maniera
sfacciatamente di parte il neo ordine monastico-guerriero?15 Difficile dare una risposta.
Probabilmente, ma sono solo delle ipotesi, Bernardo non volle alienarsi la
simpatia dei propri parenti o forse volle manifestare la propria riconoscenza a Ugo di
Champagne, altra eminenza grigia dei templari, che pochi anni prima aveva donato
ai Cistercensi un vasto possedimento, dove successivamente fu edificato il monastero di Clairvaux, di cui ne sarebbe diventato abate proprio Bernardo.
Ma chi era il conte Ugo di Champagne? Per quello che riguarda la storia dei
templari, certamente una figura enigmatica. Secondo alcuni storici della Champagne
nel 1104 partì per la Terrasanta, dove rimase per ben quattro anni. Non si sa cosa
fece, né il motivo per cui rimase così a lungo in Outremer. Al suo ritorno volle incontrarsi con Stefano Harding, l’abate di Citeaux, e successivamente, con frequentazioni sempre più assidue, con i rappresentanti di alcune delle più prestigiose famiglie
della contea, fra cui Andrè de Montbard, zio, come abbiamo detto, di Bernardo di
Chiaravalle. Nel 1114, il conte Ugo fece ritorno in Terrasanta, dove stavolta rimase
appena un anno. Al suo rientro ripresero gli incontri con l’abate di Citeaux e con i
suoi vassalli più fidati.
Sarà una coincidenza, ma proprio in questo periodo l’ordine dei Cistercensi,
prima del 1112 economicamente in uno stato paurosamente disastroso, conobbe un
periodo di grande splendore e di espansione. Nel 1153, nel giro quindi di una quarantina di anni, furono, infatti, istituite poco più di 300 abbazie e, di queste, 69 dal solo
S. Bernardo. Sarà sempre una coincidenza, ma nello stesso periodo in cui il conte
di Champagne e l’abate Harding cominciarono frequentarsi assiduamente, i monaci
cistercensi iniziarono a specializzarsi nello studio dei testi sacri ebraici, mentre già
dal 1070 alla corte del conte di Champagne era fiorita una prestigiosa scuola di studi
cabalistici ed esoterici.
Contemporaneamente nasce l’ordine dei templari, che a sua volta, nel giro di
pochi anni, acquistò un immenso potere e grandi ricchezze. Alla luce di queste considerazioni non è azzardato anticipare al 1114 l’anno di nascita dell’ordine monasticoP. Partner, I templari, Torino 1991, p.10.
G. Viti (a cura di), Atti del I Convegno su I templari e san Bernardo di Chiaravalle, Certosa
di Firenze 23-24 ottobre 1992, Firenze 1995.
14
15
Le radici politiche e religiose dei templari...
155
cavalleresco, tanto più che dieci anni dopo il conte di Champagne abbandonerà la
sua famiglie e i suoi beni per entrare a far parte ufficialmente dell’ordine templare.
È fuor di dubbio, a questo punto, che il conte di Champagne abbia giuocato
in tutta questa vicenda un ruolo di primo piano, tanto che sono in molti a nutrire il
sospetto che egli fu l’ideatore, il principale finanziatore e il primo vero capo dell’ordine dei templari.
Probabilmente, nel corso dei suoi viaggi in Terrasanta il conte Ugo entrò in
possesso di documenti riservati, che indubbiamente richiedevano riscontri più concreti; ma appare molto più convincente la tesi che lo stesse fosse già in possesso
di carte e documenti dai contenuti esplosivi e che, in ultima analisi, i suoi viaggi a
Gerusalemme avessero un preciso carattere esplorativo.
È quest’ultima un’ipotesi che apre nuovi scenari, in quanto potrebbe portarci
a reinterrogarci sulle vere motivazioni delle crociate e a smascherare le strumentali
argomentazioni di un gruppo di potere all’interno della Chiesa, che facendo leva sul
sentimento religioso del popolo, si illuse di potere instaurare un governo teocratico,
in un progetto dai contorni alquanto nebulosi e dalle alleanze ancor meno chiare.
L’esaltante epopea militare e i tragici avvenimenti che contrassegnarono la
fine dell’Ordine del Tempio – come ha rilevato giustamente – finiscono inevitabilmente per catalizzare l’attenzione degli studiosi a detrimento di quella che fu la
sua attività sociale, nonostante la fondamentale importanza che questa storicamente
riveste. Anzi per quest’ultimo costituiva la vera missione segreta di cui i Templari
erano investiti e che chiarisce il vero motivo della complicità con la Santa Sede.
Secondo l’autore i vertici della Chiesa auspicavano un programma di modifica profonda della struttura della società e dei suoi meccanismi, capace di realizzare in
terra la Gerusalemme celeste. Ma come riuscirci? E soprattutto come imporre ad
una classe di feudatari, che rispondeva principalmente alla logica della forza e delle
armi, nutrendosi soltanto di valori militari, una diversa concezione della vita? Era,
quindi, necessario disporre di una forza militare in grado, oltre che di costituire un
deterrente, anche e soprattutto di parlare lo stesso linguaggio della classe feudale,
uno strumento, in sintesi, che fosse per sua natura parte integrante di questa classe,
alla quale sarebbe divenuto impossibile contrastarlo e ignorarne i messaggi. Andava
quindi creata una struttura in grado di indicare una via alternativa alla gestione del
potere feudale, che costituisse un esempio concreto di quella che era la concezione
cristiana della convivenza sociale, favorendo, nel contempo, la nascita di una nuova
consapevolezza anche nel popolo minuto e nelle nascenti forze socio-economiche
che andavano affermandosi.16
Perché l’operato templare risultasse efficace e credibile, rappresentando oltre
che un esempio anche un deterrente, era sufficiente che fosse stimato, temuto e po-
16
D. Lancianese, I templari e la missione segreta, Firenze 2006, p. 85.
156
Salvatore Girgenti
tente. Queste caratteristiche, che avrebbero consentito di essere prese seriamente in
considerazione dai detentori del potere feudale, non potevano che essere acquisite
sul campo di battaglia. Quando l’Ordine Templare fosse riuscito a imporre, con il
suo coraggio e le sue imprese militari, rispetto e ammirazione al mondo feudale, allora avrebbe avuto il prestigio e la forza necessaria per agire in modo incisivo perfino
là dove la battaglia andava veramente vinta, cioè nel contesto sociale. Il vero attacco
al potere andava portato sul piano della società civile, determinando le condizioni
necessarie e sufficienti al superamento dello stato feudale, infiltrandosi lentamente in
esso fino a modificarlo radicalmente dall’interno, impadronendosi dei centri nevralgici della sua struttura, politica ed economica. Per questo motivo, «attraverso le confraternite i Templari si erano uniti con legami di fratellanza a un esteso settore della
classe nobile e anche popolare».17 Bisognava sorreggere i commerci e le corporazioni,
impadronirsi del flussi monetari, controllare le vie di comunicazione, la cultura, la
tecnologia e la scienza, in breve tutto ciò che consideriamo fondamentale nella società
moderna e che veniva completamente ignorato dal potere feudale, assorbito da ben
altre preoccupazioni. In realtà, se ben ci riflettiamo questa attività sociale, economica
e politica non aveva nulla a che vedere con un impegno bellico, anzi era del tutto
avulsa, contrastante e stridente con la concezione cavalleresca in epoca medievale.
Martin Bauer sottolinea che fu «grazie alla intercessione di Bernardo di Chiaravalle che si instaurò un rapporto simbiotico tra il papato e l’ordine e da allora i
cavalieri servirono il sacro Soglio come un’armata privilegiata».18
Perché fossero alte le possibilità di successo del progetto – sottolinea ancora
Lancianese – era necessario che il prestigio militare e quello religioso si mantenessero al di sopra di ogni critica e di ogni immaginazione e per questo la regola
non prevedeva in alcun caso la riturata in battaglia, così come, dal punto di vista
morale, imponeva ciò che al massimo grado poteva risultare convincente, e cioè una
autentica e severa vita monastica. Per il Lancianese, la funzione socio-politica a cui
i templari erano chiamati non poteva ovviamente essere resa di pubblico dominio e
veniva giustamente custodita come il più importante dei segreti dei vertici dell’Ordine, come pure da quelli della Chiesa. L’autore, per evidenziare l’importanza che
la Chiesa attribuiva al progetto e all’attività laica che i templari dovevano svolgere,
invita a riflettere sui privilegi accordato all’ordine del Tempio e che in pari misura
non furono mai accordati a nessun altro ordine monastico-militare, né a nessun’altra
organizzazione ecclesiastica o laica, con la sola eccezione, guarda caso, dei cistercensi. Ai cappellani dell’Ordine fu persino attribuito un potere di remissione pari
a quello dei vescovi. Concordiamo con il Lancianese sul fatto che all’origine dei
Templari ci siano una serie di occulti obiettivi socio-politici, una vera e propria mis-
17
18
P. Partner, I templari, Torino 1991, p. 72.
M. Bauer, Il mistero dei templari, cit., p. 34.
Le radici politiche e religiose dei templari...
157
sione segreta, del tutto prevalente su quella che è sempre apparsa come la sua unica
motivazione ufficiale, vale a dire la crociata permanente contro l’Islam. Lo stesso
Louis Charpentier sottolinea che «la difesa della Terra Santa non è che un mezzo,
uno strumento per conquistare il potere. L’Ordine del Tempio è il risultato finale
del processo di incivilimento dell’Occidente e questo risultato era stato preparato
da tempo».19 Non concordiamo, invece, sul patto segreto tra Templari e Chiesa e, in
particolare, su quelle teorie che vorrebbero la nascita dei templari come filiazione di
un progetto vaticano, finalizzato a scardinare il sistema feudale per l’attuazione di
un sistema politico teocratico, di cui i templari rappresentavano l’attuazione pratica
o, più volgarmente, il braccio armato.
Non meno interessante, a questo punto, è cercare di individuare le radici religiose dei templari. Ma, come la solito, anche qui è difficile dare una risposta. Alcuni studiosi del fenomeno templare avanzano l’ipotesi che fossero molto vicini al
sufismo. Ora, pur non potendo non rilevare che tra le religioni orientali il sufismo è
il movimento religioso che ha più punti di contatto con il cristianesimo, il raffronto
non regge. È vero che il sufismo punta a soffocare e annullare nell’uomo ogni forma
di individualismo e di egoismo – così come si proponevano i templari – ma è pur
vero che il forte misticismo, di cui il sufismo è caratterizzato, è lontano mille miglia
dal modus vivendi dei templari. Riflettendo, come già si è evidenziato, sulla storia
delle origini del potente ordine militare, valutare le possibilità di un nucleo teoretico
ebraico nelle radici religiose dei templari, può anche risultare una indagine interessante. Soffermiamoci, per esempio, sulla frattura o sulla diversità che segna la linea
di demarcazione tra ebraismo e filosofia greca e occidentale.
La prima è incentrata sulle categorie dell’esodo, dell’esilio, del rispetto
dell’altro. La seconda ha i suoi pilastri teoretici nell’ontocentrismo e nell’assorbimento dell’altro nel medesimo. Emmanuel Lévinas ha contrapposto all’itinerario di
Ulisse, le cui avventure si concludono nel ritorno ad Itaca, la storia di Abramo, che
lascia la sua terra per sempre per una terra sconosciuta e che proibisce al suo servo
di ricondurre persino suo figlio a quel punto di partenza: alla filosofia-logos di Ulisse
si contrappone la filosofia nomade di Abramo. Quello di Ulisse è un ritorno su se
stesso, che si chiude a ciò che è diverso. Contestualizzando potremmo dire oggi che
esprime l’incapacità e l’impotenza della filosofia contemporanea di reinventare nuovi cominciamenti, di ripartire dal nulla, condannata com’è a ripercorrere sentieri già
tracciati e mete già prestabilite. All’uomo dei nostri tempi tutto ciò potrà apparire di
poca importanza. Ma provate a calarvi nel clima sociale del XII secolo. All’ordine
templare aderiscono cavalieri, che, pur abituati a vivere nella ricchezza e negli agi,
a godere di tutti i privilegi e vantaggi che la loro appartenenza di classe riserva,
decidono di rinunziare a tutto pur di adempiere alla loro missione religiosa, sociale
19
L. Charpentier, I misteri dei templari, cit., p. 75.
158
Salvatore Girgenti
e politica. Molti di loro saranno massacrati e decapitati dai musulmani. Eppure, nei
confronti di questi ultimi, il loro atteggiamento sarà improntato al rigoroso rispetto
dei codici cavallereschi del tempo. Nei templari è alto il senso dell’onore e della
giustizia. Persino gli storici musulmani del tempo, pur odiando i franchi, come comunemente chiamavo tutti i crociati, apprezzavano il senso di giustizia e di rispetto
per l’altro dei poveri cavalieri di Cristo. Una politica, dunque, di massima tolleranza,
aperta al dialogo e al confronto fra culture orientali e occidentali. Il Verbo, la parola
era alla base del loro credo religioso.
Ma è proprio nella tradizione ebraica, nel giudaismo rabbinico che la “parola”
rappresenta lo spazio in cui abita la divina presenza. La stessa diversità di opinioni,
spesso riscontrabile nel giudaismo rabbinico, più che negativamente, viene avvertita
positivamente, in quanto la diversità di opinioni viene interpretata come la conseguenza necessaria alla ricchezza della parola di Dio. Ed ancora. La ricerca del significato “altro” rafforza l’essenza di una teologia e di una ermeneutica ricca di valori
etici. L’uomo deve proporsi di allontanare da se tutto ciò che contrasta col volere
di Dio e, nello stesso tempo, di consacrarsi al suo servizio, resistendo a tutti quegli
impulsi che fanno dell’egoismo l’essenza della natura umana. In poche parole: di
obbedire ad un’etica incentrata sul servizio nei confronti del prossimo. Concetti,
questi ultimi, che in larga parte ritroviamo nello Statuto dei cavalieri del Tempio. I
precetti, le prescrizioni, abbondantemente presenti nei testi sacri giudaici, ma anche
all’interno dell’Ordine Templare, non servono solamente a coltivare e sviluppare le
più elevate qualità umane, ma contengono una carica di dinamismo morale in grado
di trasformare l’individuo e, per suo tramite, la società di cui egli fa parte. Ma non
sono i soli punti in comune con l’ebraismo.
A fondamento della morale troviamo l’equità e la giustizia, che deve estrinsecarsi nella accettazione dei doveri, specialmente nei riguardi del povero, del debole,
del derelitto, amico o nemico che fosse. Nell’ebraismo la pratica della giustizia è
fondamentale nel cammino verso Dio. Nell’ingiusta crociata contro gli Albigesi, in
Provenza, i templari rifiutarono di parteciparvi. Con i catari, indubbiamente, c’erano
forti contrasti religiosi, ma non tali da determinare una strage. Bernardo di Chiaravalle, inviato in un primo momento per cercare di ricondurli a più miti consigli,
scrisse nella sua relazione al Papa di non essere riuscito a sanare i contrasti religiosi
che dividevano questi ultimi dalla chiesa romana, ma in ogni caso confessò che se
tutti i cristiani si comportassero come i catari avremmo maggiori possibilità di realizzare in terra la Gerusalemme celeste. In realtà, la crociata fu un vero e proprio atto
di violenza, conseguenza di una volontà finalizzata a volere affermare l’incontrastato
dominio della chiesa di Roma. I templari, infatti, non solo non vi parteciparono, ma
giunsero ad offrire ai catari rifugio e protezione nelle loro commende.
Alcuni furono addirittura investiti del cavalierato in modo da renderli intoccabili, protetti dal mantello bianco. «i templari – era solito dire Ugo de Payns – non
Le radici politiche e religiose dei templari...
159
uccidono in preda a odio e furore; non odiano gli uomini, ma l’ingiustizia umana».20
A tal proposito, potremmo ricordare un altro episodio. Nel 1252 un gran dignitario
dell’Ordine, rivolgendosi a Enrico II d’Inghilterra, disse: o re, finché userai giustizia,
tu regnerai. Ma se la violerai, cesserai di essere re. Alcuni storici, in questa frase,
hanno visto l’affermazione di un potere che neppure il papato osava reclamare tanto
apertamente: quello di creare o deporre i monarchi; nella realtà, non si può non sottolineare l’alto concetto di giustizia dei templari, che li spingeva ed entrare in rotta di
collisione contro tutti coloro che lo calpestavano, senza riguardi per nessuno. Come
abbiamo già visto, nel loro programma di modifica profonda della società e dei suoi
meccanismi, i templari dovevano innanzitutto riuscire ad essere accettati, rispettati e
temuti dalla classe dei feudatari.
Ma come riuscire ad imporsi a degli uomini che rispondevano principalmente
alla logica delle forza e delle armi? Solamente dimostrandosi abili e temuti guerrieri
potevano riuscire a guadagnarsi il rispetto dei feudatari e dei loro vassalli e in questo, come sappiamo, ci riuscirono magnificamente. Ma dovevano anche distinguersi
eticamente con la loro condotta e con le loro azioni. Ecco un altro punto in comune
con l’ebraismo. Secondo alcuni filosofi ebrei medievali, noi non possiamo conoscere
alcun attributo di Dio, se non quello d’azione. Questi ultimi, rifacendosi a un commento talmudico e in particolare all’episodio narrato in Esodo (33-34), in cui Mosè
domanda a dio di mostrargli il suo volto, quest’ultimo gli risponde che lo nasconderà
in una cavità della roccia. Dio passa davanti a Mosè, che non può vederlo, e Mosè
ha solamente la possibilità di guardare la traccia che il passaggio di Dio ha lasciato.
Dalla traccia di Dio Mosè percepisce delle qualità divine, che sono esclusivamente morali: gli attributi d’azione, che nella realtà non indicano caratteri propri
dell’azione di Dio, quanto modelli per l’uomo, norme per l’agire umano e, quindi
esempi, per l’uomo. Seguire costantemente questi modelli, significa per ogni uomo,
nel corso della vita, imitare costantemente nel comportamento. L’azione, quindi, per
il popolo ebraico è fondamentale, tanto che è inconfutabile la constatazione che la
religione ebraica è la religione dell’atto, dell’azione e non la religione del dogma o
della teoria. Così come è innegabile che i templari, attraverso l’azione, abbiano portato a compimento la missione per cui erano stati creati: imitare e assimilarsi a Dio.
L’apertura al confronto, la difesa del debole e l’alto senso di giustizia che ha sempre
caratterizzato i templari, trovo un riscontro nella religiosità ebraica, secondo la quale
conoscere Dio vuol dire adempiere al bene; amare Dio vuol dire amare gli uomini.
L’azione, quindi, presuppone un atteggiamento etico dell’uomo, rivolto non
esclusivamente a Dio, ma a tutto il creato e, in particolar modo, agli uomini.
20
P. Partner, I templari, cit., p.10
Filippo Grammauta
La pergamena di Chinon.
La prova dell’assoluzione dei dignitari templari dall’accusa di eresia
Il 13 ottobre 1307, un venerdì, per ordine del re di Francia Filippo IV detto
“il Bello”, più di mille cavalieri templari presenti sul suolo francese furono arrestati
contemporaneamente con la falsa accusa di eresia.
All’arresto non sfuggirono i dignitari dell’Ordine, e cioè Jacques de Molay,
Gran Maestro dell’Ordine del Tempio, Hugues de Pèrraud, Visitatore di Francia (carica che lo poneva un gradino al di sotto del Gran Maestro), Raymbaud de Caron,
Precettore d’Oltremare, Geoffroy de Gonneville, Precettore in Aquitania e Poitou,
Geoffroy de Charny, Precettore in Normandia. Cominciò così, una lunga partita a
scacchi tra il re di Francia e papa Clemente V. Il primo con l’aiuto dei suoi astuti
ministri, primi fra tutti Guglielmo di Nogaret e Guglielmo di Plaisians, ha costruito
le false accuse contro l’Ordine per farlo sopprimere e impossessarsi dei suoi beni. Il
secondo invece, pur costretto a cedere ai ricatti e alle pressioni del re, avrebbe voluto
utilizzare l’immenso patrimonio templare per organizzare una nuova crociata.
Subito sottoposti a tortura o a forte pressione psicologica, quasi tutti i Templari confessarono le gravi colpe che erano state loro addebitate. In particolare confermarono che dopo la cerimonia di accoglienza nell’Ordine, il novizio veniva portato
in disparte e, lontano da occhi indiscreti, era costretto a rinnegare Cristo, a sputare
sulla croce, a sottoporsi alla pratica dei baci osceni e invitato a praticare la sodomia
tra i confrati qualora non fosse riuscito a superare la tentazione della carne o se qualche fratello glielo avesse chiesto espressamente. Parecchi confessarono - sia perché
lo videro di persona sia per sentito dire da altri - che in occasione della celebrazione
del Capitolo assieme alle altre sacre reliquie veniva esposto un idolo (detto Bafometto), di cui fornirono le più svariate descrizioni (a forma di testa di uomo, di animale,
con la barba bianca e nera, con la calotta d’avorio, d’argento, con due facce, con due
o con quattro piedi, ecc).
Tra la fine di ottobre ed il mese di novembre anche i dignitari dell’Ordine
confessarono le medesime colpe. Il Gran Maestro Jacques de Molay confessò parte delle colpe addebitate in occasione del primo interrogatorio che subì in carcere,
probabilmente sotto tortura, il 24 ottobre 1307 davanti all’Inquisitore di Parigi, e le
162
Filippo Grammauta
confermò il giorno successivo davanti ad una assemblea di canonici, laici e studenti
universitari della Sorbona riuniti dai funzionari regi nella casa dei Templari a Parigi.
A questo punto il papa, che aveva già trasferito a Poitiers la Curia pontificia,
per verificare se le accuse rivolte ai Templari avessero un fondamento di verità, mandò a Parigi due cardinali di propria fiducia, Bérenger Frédol ed Etienne de Suisy, con
l’incarico di interrogare i dignitari del Tempio; ma il re non diede l’assenso. Quando
il 24 dicembre dello stesso anno i cardinali, questa volta autorizzati dal re, chiesero
a de Molay se la confessione da lui resa era vera, il Gran Maestro ritrattò tutto, disse
che quella confessione gli era stata estorta e, toltisi gli abiti, mostrò i segni della
tortura che aveva subito.
Scossi da quanto avevano visto e udito a Parigi, al loro rientro a Poitiers i
cardinali riferirono tutto al papa, il quale nel mese di febbraio 1308 sospese dall’incarico il grande inquisitore di Parigi Guglielmo Imbert ed avocò a sé e alla Curia
ogni competenza sull’inchiesta. Sentendosi sfuggire di mano l’iniziativa, il re con
grande seguito armato, nel mese di maggio del 1308, si recò a Poitiers per indurre il
pontefice a sciogliere l’Ordine.
Per sottrarsi alle continue e costanti pressioni di Filippo IV, il papa il 29 maggio convocò un concistoro pubblico al quale parteciparono anche i funzionari regi
guidati da De Nogarét e da De Plaisians, i quali in più occasioni minacciarono il papa
di accusarlo di eresia se non avesse accolto le richieste del re.
In tale occasione si concordò di nominare una commissione di cardinali presso
la Curia di Poitiers con il compito di avviare una nuova inchiesta sui Templari. Della
commissione, che sarebbe stata presieduta personalmente dal papa, avrebbero fatto
parte anche i cardinali Bérenger Frédol, nipote del papa ed espertissimo canonista,
ed Etienne de Suisy. Il re da parte sua, sotto minaccia del papa che si rifiutava di
adottare provvedimenti contro l’Ordine se prima non gli fosse stato consentito di
interrogare personalmente i Templari che continuavano a restare sotto custodia regia,
volendo dare prova di grande disponibilità dispose che un folto gruppo di Templari
fosse trasferito a Poitiers, dove si trovava la Curia pontificia.
Pertanto, nel mese di giugno 1308, 72 Templari (scelti accuratamente fra quelli propensi ad autoaccusarsi), caricati su carri ed incatenati l’uno all’altro, lasciarono
Parigi alla volta di Poitiers. Quando il convoglio giunse a Chinon (località distante
da Poitiers una sessantina di chilometri) i dignitari dell’Ordine, cioè Jacques de Molay, Hugues de Pèrraud, Raymbaud de Caron, Geoffroy de Gonneville e Geoffroy
de Charny, furono separati dagli altri e rinchiusi nella fortezza locale. E così mentre
gli altri Templari proseguirono per Poitiers per essere interrogati, i dignitari dell’Ordine, con la scusa che erano gravemente ammalati, furono trattenuti a Chinon per
impedire che il papa li potesse interrogare e magari, sentite le loro ragioni, li potesse
addirittura assolvere. Con questa mossa il re voleva indebolire l’inchiesta pontificia;
infatti, se il papa avesse assolto i vertici dell’Ordine, l’inchiesta regia avrebbe perso
valore perché non avrebbe più riguardato i membri più rappresentativi, quelli cioè
La pergamena di Chinon. La prova dell’assoluzione dei dignitari templari...
163
che portavano le maggiori responsabilità all’interno del Tempio.
Il papa, tra la fine di giugno ed i primi di luglio, interrogò di persona i Templari che erano giunti a Poitiers e alla fine impose loro di chiedere perdono per le
colpe che comunque avevano commesso (anche se costretti a farlo sotto minaccia),
cioè gli atti di rifiuto e di oltraggio della religione. Poi concesse loro l’assoluzione e
li reintegrò nei sacramenti e nella comunione della Chiesa. Interrogando di persona
i Templari, egli capì perfettamente che il rinnegamento a parole di Cristo e lo sputo
sulla croce non esprimevano lo stato d’animo del novizio, ma rappresentavano un
rituale d’ingresso che serviva a saggiarne la tempra; il postulante che chiedeva di
entrare nell’Ordine era messo a confronto con le violenze che i musulmani compivano sui Templari catturati per costringerli a rinnegare Cristo e ad oltraggiare la croce.
Terrificante ed imposto sotto minaccia di morte, il rituale era una messinscena che
doveva spaventare il postulante e metterlo alla prova; ciò consentiva ai suoi superiori
di verificare fin dall’inizio la tempra del futuro cavaliere e la sua capacità di autocontrollo e di subordinazione totale ai superiori. Il rituale era stato tollerato per tanto
tempo perché veniva considerato formativo della recluta.
Il re, che dal mese di maggio si trovava Poitiers, il 24 luglio ritornò a Parigi
lasciando sul posto il fidato ministro Guglielmo de Plaisians con il compito di vigilare su eventuali iniziative che il papa avrebbe potuto assumere a favore dei Templari.
Il 12 agosto 1308 il papa tenne un concistoro nel quale fece dare lettura della
bolla Faciens misericordiam firmata quattro giorni prima, con cui venne indetto un
concilio ecumenico da tenersi entro due anni a Vienne per discutere i problemi più
urgenti della cristianità, fra cui l’indizione di una nuova crociata per la riconquista
della Terrasanta e l’esame della questione templare. Lo stesso 12 agosto Clemente
V emise la bolla Regnans in coelis diretta al re di Francia e agli altri regnanti della
cristianità, ma dai toni duri nei confronti dei Templari.
Nel concistoro si decise anche di avviare inchieste diocesane per processare i
singoli Templari detenuti nelle rispettive circoscrizioni e venne nominata una commissione di otto cardinali con il compito di indagare sull’Ordine nel suo complesso; il
papa, tuttavia, si è riservato il diritto di occuparsi personalmente dei dignitari del Tempio. Rasserenato così il clima di tensione che gravava su Poitiers, il 13 agosto Clemente V decretò l’inizio delle ferie estive, che sancì l’interruzione dell’attività amministrativa e giudiziaria della Curia pontificia e il rientro a Parigi dei funzionari regi rimasti a
Poitiers dopo la partenza del re. Quindi, all’alba del 14 agosto inviò a Chinon Bérenger
Frédol, cardinale prete del titolo dei Santi Nereo e Achilleo, Etienne de Suisy, cardinale
prete del titolo di San Ciriaco in Termis e Landolfo Brancacci cardinale diacono del
titolo di Sant’Angelo, con il preciso incarico di svolgere in sua vece quell’inchiesta sui
dignitari templari che Filippo IV di fatto gli impediva di compiere.
In tal modo il papa, che possedeva un’ottima preparazione giuridica ed era
stato per molti anni un abile diplomatico, tentò di neutralizzare la mossa del re, il
quale aveva relegato nella fortezza di Chinon Jacques de Molay e gli altri dignitari
164
Filippo Grammauta
per evitare che potessero essere interrogati direttamente dal pontefice.
A partire da sabato 17 agosto i dignitari Hugues de Pèrraud, Raimbaud de Caron, Geoffroy de Gonneville e Geoffroy de Charny vennero ascoltati dai tre cardinali
in presenza di quattro notai apostolici e di quattro testimoni; il Gran Maestro Jacques
de Molay venne ascoltato per ultimo il 20 agosto. Tutti confessarono le colpe ma,
giurando sui sacri vangeli, abiurarono all’eresia e chiesero di essere riammessi in
seno alla Chiesa. I cardinali, accogliendo le richieste dei confrati, impartirono loro il
beneficio dell’assoluzione secondo le forme della Chiesa, riaccogliendoli nell’unità
della stessa e restituendoli alla comunione dei fedeli e ai sacramenti ecclesiastici.
Ascoltata la versione dei fatti resa dai cardinali al loro rientro a Poitiers, il papa
emise una seconda versione (versione aggiornata e retrodatata) della bolla Faciens misericordiam, con la quale si ribadivano i concetti contenuti nella prima versione della
bolla, ma si precisava che i vertici dell’Ordine erano stati assolti dall’accusa di eresia e
che pertanto da quel momento nessuno, eccetto il papa, poteva più interrogarli.
Con tale iniziativa il papa ritenne di avere preservato i dignitari templari da
più gravi sciagure. Come si sa invece gli eventi volsero verso un tragico destino, che
portò sul rogo, il 18 marzo 1314, il Gran Maestro Jacques de Molay ed il Precettore
di Normandia Geoffroy de Charny.
Per tanto tempo si è creduto che di quanto avvenne a Chinon non esistesse un
vero e proprio resoconto scritto. Le notizie che si avevano sugli avvenimenti svoltisi
a Chinon derivavano dall’Appendice n. 10595 – Inquisizione svolta a Chinon dai
cardinali Berengario, Stefano e Landolfo, (dei documenti registrati nelle Appendici
è data solo la sintesi dell’argomento, non il testo completo)1 e richiamato nell’opera
che l’insigne storico tedesco Heinrich Finke pubblicò nel 1906;2 dal rapporto che
Jean Bourgogne, procuratore di Giacomo II d’Aragona presso la Curia pontificia,
inviò al proprio sovrano su quanto aveva appreso già sei giorni dopo la partenza
dei cardinali per Chinon;3 dagli atti del processo svoltosi a Parigi nel 1309 dai quali
risulta che nella seduta del 26 novembre, per consentire a Jacques de Molay di preparare un’adeguata difesa dell’Ordine, gli fu data lettura delle lettere apostoliche che
definivano i poteri della Commissione che lo stava giudicando, di alcuni atti del processo e del resoconto delle sue confessioni rese a Chinon;4 dal resoconto dell’inchiesta di Chinon come trascritto nel registro di Pierre d’Etampes, membro della cancelleria di Francia, resoconto inteso come trascrizione sintetica di una comunicazione al
re da parte dei tre cardinali mediante una lettera inviata al re dai cardinali Bérenger
Frédol, Etienne de Suisy e Landolfo Brancacci; inviati dal papa a Chinon, i quali
confermerebbero che all’interrogatorio avrebbero assistito anche gli amati cavalieri
S. Portolan, Sul processo per eresia dei Templari, Ed. Penne & Papiri 1999, pp. 12-16.
H. Finke, Papsttum und Untergand des Templerordens, Munster 1906.
3
B. Frale, Il Papato ed il processo ai Templari, Ed. Viella 2003, p. 146.
4
M. Barber, Processo ai Templari, Ed. ECIG 1993, p. 158.
1
2
La pergamena di Chinon. La prova dell’assoluzione dei dignitari templari...
165
G. e G. e Jean de Jamville. Il testo è conservato nel manoscritto latino n. 10919 della
Biblioteque Nationale di Parigi;5 .dalla bolla Vox in excelso, nella quale si conferma
– in forma sintetica – la vicenda di Chinon.6 L’assoluzione dall’accusa di eresia era
invece riportata nella versione aggiornata della bolla Faciens misericordiam.7
Nel mese di settembre 2001 la ricercatrice Barbara Frale, oggi Officiale dell’Archivio Segreto Vaticano, rileggendo per l’ennesima volta l’inventario dei documenti
sul processo ai Templari conservato nel “Fondo di Castel Sant’Angelo dell’Archivio
Segreto Vaticano” rimase incuriosita da un documento allegato agli atti dell’inchiesta
diocesana svoltasi a Tours.8 Il Berengario del titolo dei Santi Nereo ed Achilleo citato
in apertura del documento in realtà era il cardinale Berénger Frédol, nipote e braccio
destro del papa nonché l’uomo più importante del collegio dei cardinali.
Era improbabile che un personaggio di così alto rango si occupasse di una
modesta inchiesta diocesana. Il documento certamente doveva riferirsi a qualcosa di
importante. E infatti l’attenta lettura della pergamena svelò la verità: quel documento, successivamente diventato noto come La pergamena di Chinon, era la trascrizione degli interrogatori svoltisi a Chinon tra il 17 ed il 20 agosto 1308 e conteneva
in forma scritta l’assoluzione dei dignitari dell’Ordine del Tempio. La pergamena
(580x700 mm), portata a Roma assieme agli altri documenti sui processi ai Templari,
nel 1628 venne catalogata da Giovanbattista Confalonieri (Custode dell’Archivio
di Castel Sant’Angelo) in modo errato e nel 1912 venne ulteriormente censita in un
dettagliato catalogo. Non la riconobbe neanche l’autorevole storico Conrad Shottmüller che pure l’avrà esaminata alla fine del XIX sec., ma che probabilmente l’avrà
scambiata per un documento appartenente ad una delle tante inchieste diocesane che
si svolsero in Francia contro i Templari.9
Il contenuto del documento getta una nuova luce sulla figura di Clemente V,
da sempre considerato debole e succube del sovrano francese.
L’Ordine del Tempio era parte integrante della Chiesa ed il papa non poteva
accettarne la distruzione al solo scopo di consentire a Filippo IV di usare i suoi
beni per finanziare una guerra contro il re d’Inghilterra, anch’egli cattolico. Il clero
francese era soggiogato da Filippo IV ed un altro conflitto tra la Chiesa e la corona
5
Il documento originale è conservato nel manoscritto latino n. 10919 della Bibliotheque Nationale di Parigi (Cfr. B. Frale, Il Papato ed il processo ai Templari, cit., p. 151). La sua trascrizione
è riportata in P. Dupuy, Histoire de l’Ordre militaire des Templiers, 1751. Si tratta di una riedizione
dell’opera scritta nella prima metà del 1600 da Pierre Dupuy, Consigliere e responsabile della biblioteca
del re di Francia, morto a Parigi il 26 dicembre 1651. L’opera è inoltre consultabile in forma digitalizzata all’indirizzo di Google libri: http://books.google.it
6
Conciliorum Oecumenicorum Decreta, a cura dell’Istituto per le scienze religiose, 1973, pp. 336-343.
7
Regestum Clementis Papae V, Roma 1885-1895, documento n. 3402.
8
B. Frale, Il Papato ed il processo ai Templari, Ed. Viella 2003, pp. 10-16.
9
La Pergamena di Chinon è conservata presso l’Archivio Segreto Vaticano, Archivium Arcis,
Armadium D 217 (B. Frale, Il Papato ed il processo ai Templari, cit., p. 220).
166
Filippo Grammauta
avrebbe causato uno scisma. Il papa non poteva rischiare che ciò accadesse e pertanto, dopo l’ultimo tentativo di assolvere i capi templari, fu costretto ad abbandonare
l’Ordine al suo destino.
Con la bolla Vox in excelso del 22 marzo 1312, letta pubblicamente a Vienne
alla presenza dei Padri conciliari il 3 aprile 1312, l’Ordine del Tempio fu sospeso in
perpetuo (ma si tratta, di fatto, di una vera e propria soppressione). Con la bolla Ad
providam Christi Vicarii del 2 maggio dello stesso anno i beni dei Templari furono
assegnati all’Ordine degli Ospitalieri di San Giovanni e immediatamente dopo, con la
bolla Nuper in generali del 16 maggio, detti beni vennero trasferiti a questi ultimi, i
quali negli anni successivi dovettero versare alla corona l’ingente somma di un milione
di tornesi a titolo di risarcimento delle spese sostenute per sradicare l’eresia templare.
Perché il documento di Chinon non fu reso noto? Come mai è scivolato misteriosamente tra i documenti dell’inchiesta diocesana svoltasi a Tours (nella cui
circoscrizione ricadeva Chinon) dal momento che la vicenda in esso descritta era
comunque nota, come era nota l’assoluzione dei dignitari templari, riportata nella
Faciens misericordiam?.
Cosa poteva accadere se il documento fosse stato divulgato integralmente?
Dai documenti disponibili emerge una figura del pontefice determinato, all’inizio dell’intera vicenda, ad impedire in tutti i modi che il re si impossessasse dei
beni del Tempio e ne pretendesse lo scioglimento. Sembra pure, però, che con il passare del tempo il papa maturasse la consapevolezza di non potere resistere a lungo
alle pressioni di Filippo IV, che lo minacciava di accusarlo di eresia e di simonia e
di aprire il processo postumo a Bonifacio VIII se non avesse accettato il suo volere.
Alla fine però, accortosi che l’apparato messo in piedi dal re era risuscito a fare confessare i Templari, li abbandona al loro destino.
Ma non ebbe il coraggio di farlo apertamente, tant’è che ancora nel 1308 e
nel 1309, nei documenti ufficiali che si presumeva sarebbero stati letti dai Templari
(i quali, fino all’ultimo, rimasero convinti che alla fine il papa li avrebbe salvati), i
toni erano concilianti, mentre nei documenti diretti al re di Francia e agli altri sovrani
della cristianità i toni erano certamente duri e severi nei confronti dei Templari.
Probabilmente un barlume di coscienza ha indotto il papa a cercare spunti per
salvare dall’accusa di eresia i vertici templari e con essi tutto l’Ordine, magari dopo
avergli dato un nuovo ruolo e dopo averne riformato i costumi e la disciplina.
La vicenda di Chinon sembra avvalorare questa ipotesi e la pergamena ritrovata ne sarebbe la conferma storica, ma è anche la conferma dell’ambiguità o, se si
vuole, della debolezza di Clemente V.
Il papa forse sperava in qualche fatto nuovo che avrebbe potuto indurre il
re a desistere dal proprio progetto e l’esibizione del documento redatto a Chinon
gli avrebbe consentito di presentarsi come il salvatore dei Templari. Il papa invia i
tre cardinali a Chinon ad interrogare i cinque dignitari con il mandato di assolverli
dall’accusa di eresia dopo il loro pentimento. Stranamente i cardinali, partiti all’alba
La pergamena di Chinon. La prova dell’assoluzione dei dignitari templari...
167
del 14 agosto da Poitiers, iniziarono gli interrogatori sabato 17 agosto. Li finiscono
il 20 e subito ritornano a Poitiers per riferire al papa. Sembrerebbe che il viaggio di
andata sia stato più lungo di quello di ritorno. A meno che, prima di iniziare gli interrogatori, i tre cardinali, probabilmente alla presenza dei funzionari regi, non abbiano
impiegato parecchio tempo per convincere i dignitari del Tempio (che non sapevano
ancora che con la Faciens misericordiam il loro destino era stato già segnato) che la
loro confessione in cambio dell’assoluzione pontificia avrebbe assecondato il progetto che il papa aveva in animo di attuare per tentale di salvare l’Ordine.
L’ipotesi è plausibile visto l’atteggiamento di sconforto e di stizza tenuto dal
de Molay il 26 novembre 1309, quando, durante una udienza del processo diocesano
che lo vedeva protagonista, gli venne letto il resoconto della confessione che lo stesso aveva reso a Chinon ai tre cardinali inviati dal papa.
Ma se è così, il documento integrale che riportava in forma pubblica gli eventi di Chinon non poteva essere reso noto subito; era meglio diffondere la notizia
dell’assoluzione solo attraverso documenti scritti in forma sintetica, per potere avere
più tardi la possibilità di negarne parzialmente il contenuto, ovvero di renderlo pubblico integralmente se il decorso degli eventi fosse stato favorevole ai Templari. Poi
le condizioni mutarono a favore del re e la pergamena di Chinon non solo non venne
resa pubblica, ma scomparve tra gli atti dell’inchiesta diocesana di Tours.
Le successive iniziative adottate da Clemente V contro l’Ordine del Tempio
testimoniano quanto il papa fosse debole e succube di Filippo IV. La pergamena di
Chinon non migliora l’immagine del papa; certifica solamente uno dei molteplici
tentativi che egli mise in atto per contrastare l’arroganza e la cupidigia di Filippo IV,
ma anche – alla luce degli eventi successivi – un espediente messo in atto dalla Curia
pontificia per indurre i vertici templari a confessare le colpe loro attribuite.
Salvatore D’Angelo
La medicina nel Medioevo
Siamo come nani sulle spalle di giganti, così che possiamo vedere più cose di
loro e più lontane, non certo per l’altezza del nostro corpo, ma perché siamo sollevati e portati in alto dalla statura dei giganti.1
Così si esprimeva nel XII secolo Giovanni di Salisbury riprendendo riflessioni
di Bernardo di Chartres volendo indicare come il progresso che raggiunge una generazione di uomini sia sempre legato alle acquisizioni delle generazioni precedenti.
Se guardiamo al Medioevo vediamo che appunto in quell’era sono state inventale le cose che vediamo ogni giorno: le banche, le organizzazioni no-profit, le
università e gli ospedali. Ed anche il concetto di solidarietà collettiva.
San Benedetto nel dettare la regola monastica creò i monasteri come luoghi di
vita sobria, ma non misera, luoghi di povertà personale, del singolo monaco, ma non
di indigenza o di squallore collettivo. Da questi luoghi lontani dalle città si affermò un
nuovo tipo di società basata sul concetto cristiano della solidarietà collettiva. La storia
della medicina nel medioevo è intrinsecamente connessa al monachesimo occidentale,
perché quella che chiamiamo medicina conventuale nacque nei monasteri benedettini.
Nell’Altomedioevo nei monasteri benedettini un monachus infirmarius, vedendo in loro la persona di Cristo (San Benedetto, Regula monachorum, C. 31, 4253), si prendeva cura oltre che dei confratelli malati anche dei pellegrini e dei malati
estranei al monastero. Gli strumenti di cui poteva disporre questo monachus infirmarius, a prima vista, possono sembrare veramente miserevoli infatti aveva a disposizione soltanto estratti di vegetali. L’intelligenza e la sapienza nell’uso di questi rimedi erano assolutamente necessari per ottenere il risultato sperato di guarigione del
malato. Soltanto con lo studio attento che Cassiodoro nel 544 nelle sue Institutiones
divinarum et humanorum raccomanda ai monaci si poteva imparare le proprietà dei
(rimedi) semplici e dei rimedi composti.
G. Steiner, Una certa idea di Europa, Prefazione di M. Vargas Llosa, Prologo di R. Riemen,
Garzanti 2006, p. 23.
1
170
Salvatore D’Angelo
Et ideo discite quidem naturas herbarum com mixtionesque specierum sollicita
mente tractate […] Quod si uobis non fuerit graecarum litterarum nota facundia, in primis habetis Herbarium Dioscoridis, qui herbas agrorum mirabili proprietate disseruit atque depinxit. Post haec legite Hippocratem atque Galienum
latina lingua conuersos.2
Questo monachus infirmarius, pur dedicandosi all’assistenza non era un medico in senso specifico, si applicava nei limiti delle sue capacità, per rendere effettivo il
principio della hospitalitas, cioè l’accoglienza dei pellegrini e l’ospitalità dei malati.
Isidoro di Siviglia, dottore della chiesa, il più grande erudito del suo tempo,
recentemente elevato per il suo enciclopedismo a santo patrono di Internet ci testimonia che nell’Altomedioevo le conoscenze mediche della classicità greco-romana
non furono affatto perdute. Nel VI secolo Isidoro è stato l’autore dell’Etymologiae
o Origines, (Originum sive etymologiarum libri viginti) che può essere considerata la prima enciclopedia della cultura occidentale. In una pagina di un manoscritto
attualmente conservato a San Gallo si può notare l’argomento del quarto libro: De
Medicina. Allo stesso modo come lo è per noi, per Isidoro era chiaro che la medicina
razionale, potremmo dire scientifica, rappresenta il superamento delle due più arcaiche forme di medicina: quella sacrale e quella empirica.
Prima Methodica Inventa est ab Apolline, quae remedia sectatur et carmina.
Secunda Enpirica, experientissima id est, Inventa est ab Aesculapio, quae non
indiciorum signis, sed solis constat experimentis. Tertia Logica, id est rationalis, ab Hippocrate Inventa. [2] aetatum discussis Iste enim, regionum, aegritudinum vel qualitatibus, artis curam rationabiliter est perscrutatus, infirmitatum
per quam causas perscrutetur adhibita ratione, [curam rationabiliter perscrutatus est].3
La medicina ieratica o sacrale è stata la più antica forma di medicina. Esercitata da sacerdoti o da “maghi”, è basata su preghiere o formule salvifiche, su atti rituali o uso di amuleti, confina in modo evidente con la superstizione. Non dobbiamo
credere che sia scomparsa perché ai giorni nostri i maghi e i guaritori la esercitano
per quei creduloni che pensano che il malocchio sia all’origine delle loro malattie.
Accettando questo tipo di medicina e credendo all’intervento divino Omero nell’Iliade ci dice che il dio Apollo irritato: «contra i Greci/ pestiferi vibrò dardi mortali./
Perìa la gente a torme, e d’ogni parte/ sibilanti del Dio pel campo tutto/ volavano
gli strali». Le nostre conoscenze mediche attuali ci dicono che la malattia degli as-
2
Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus Senator, Institutiones divinarum et saecularium litterarum, XXI, 1.
3
Isidorus Hispalensis, Etymologiarum sive originum, libro IV, IV. De Tribus haerresibus medicorum.
La medicina nel medioevo
171
sedianti di Troia era in realtà una infezione batterica grave, verosimilmente era la
morva. Fin dalla notte dei tempi l’uomo ha imparato a distinguere, in maniera empirica e casuale, erbe, radici, foglie, frutti e semi commestibili da quelli velenosi, ed
ha capito appieno che gli animali hanno la capacità innata di riconoscere i vegetali
velenosi, e conseguentemente ha incominciato a servirsi delle piante per curarsi.
Con l’osservazione e l’esperienza l’uomo ha progressivamente scoperto le qualità
curative presenti nei vegetali. Queste conoscenze sono alla base della medicina empirica, tuttavia questa forma di medicina é del tutto priva di un qualsiasi orizzonte
teorico coerente. La medicina razionale, la forma più evoluta di medicina, si basa
sull’osservazione e sull’esperienza, e possiede una precisa e coerente impostazione
teorica. È appunto questa la nostra attuale medicina, la facciamo risalire direttamente
ad Ippocrate, che visse tra il 460 e il 370 a.C. Nelle genesi di tutte le malattie Ippocrate nega in modo netto l’intervento divino. Oltre ad Ippocrate i grandi teorici della
medicina greca classica sono stati: Teofrasto (371-288 a.C.), Dioscoride (40-90 d.C.)
e Galeno (131-202 d.C.).
Nell’Altomedioevo i monaci salvarono dalla distruzione definitiva sia le opere
letterarie e filosofiche che le opere di Ippocrate, di Galeno, di Dioscoride, e per mezzo di queste si impadronirono delle conoscenze mediche dell’antichità classica, tuttavia per loro fu del tutto inevitabile accettare acriticamente l’impostazione teorica
che stava alla base della medicina greco-romana, pertanto la medicina conventuale
appartiene alla medicina razionale. I principi teorici della medicina di Ippocrate e di
Galeno sono ripresi da Isidoro nelle Etymologiae:
Sicut autem quattuor sunt elementa, sic et quattuor humores, et unusquisque
humor suum elementum imitatur: sanguis aerem, cholera ignem, melancholia terram, aquam flemma. Et sunt quattuor humores, sicut quattuor elementa,
quae conservant corpora nostra.4
Non dobbiamo affatto stupirci oggi della posizione dottrinale espressa nel periodo classico che semplificando moltissimo concepiva l’intero corpo umano costituito dalla mescolanza di quattro umori (sangue, flegma, bile gialla, bile nera). In
questa concezione l’egemonia di uno degli umori dava origine a quattro possibili
temperamenti: sanguigno, flemmatico, collerico o bilioso e melanconico o ipocondriaco. Ippocrate e Galeno non ebbero mai a disposizione un microscopio e non
avevano le nozioni di cellula, di DNA, di ormoni, fattori di crescita, ecc. Tuttavia
alla base della nostra attuale medicina c’è il principio del contraria contraris (la sostanza attiva deve avere un’azione contraria agli effetti della malattia), ed è derivato
da Ippocrate, il quale utilizzava per le cure farmaci di origine vegetale, minerale,
animale che provenivano dalla tradizione medica egiziana e orientale. Ad esempio
4
Ibid., V. De quattuor humoribus corporis.
172
Salvatore D’Angelo
le proprietà del salice erano conosciute da Ippocrate, infatti consigliava infusi di
corteccia di salice per le doglie del parto e come analgesico. Nel salice il principio
attivo è l’acido salicilico che è particolarmente irritante: soltanto alla fine del XIX
secolo F. Hoffmann con un processo di acetilazione ottenne l’acido acetilsalicilico,
cioè l’aspirina. Ippocrate oltre che medico fu maestro di chirurgia, infatti insegnò
a ridurre e immobilizzare le fratture, a incidere gli ascessi, a cauterizzare le ferite.
Questo aforisma di Ippocrate è chiarissimo: ciò che i medicinali non curano, il coltello cura; ciò che il coltello non cura, il cauterio cura; ciò che il cauterio non cura,
si deve considerare incurabile. Anche Achille Mario Dogliotti indimenticato maestro
di cardio-chirurgia affermò che la chirurgia rappresenta il fallimento della medicina,
volendo significare che la dove non è possibile una risoluzione della malattia con i
farmaci è necessario che intervenga il chirurgo.
Tutti i monasteri avevano al loro interno l’herbularius, il giardino delle erbe
semplici in cui da 16 a venti piante erano coltivate (iris, giglio, levistico, trigonella,
rosmarino, erisimo, santoreggia, salvia, rucola, cumino, finocchio, fagiolo, menta,
balsamita major e rosa).
Dalla più antica planimetria conosciuta (quella dell’abbazia di San Gallo
dell’820) sappiamo che il monastero benedettino prevedeva: la domus medicorum,
l’infermeria situata al sol levante e l’armarium pigmentorum una specie di riserva
di farmaci gestita da un monaco apotecario. I monaci somministravano infusi di
erbe, applicavano cataplasmi, praticavano i salassi. I petali dell’iris venivano ridotti
in poltiglia e applicati in caso di contusioni. Il bulbo del giglio era considerato un
rimedio efficace contro l’epilessia e si pensava che lenisse ferite e scottature (in
effetti oggi si sa che contiene un lenitivo per la pelle). Si usavano le radici e i frutti
di levistico o “sedano di montagna” per i suoi effetti diuretici. La trigonella o fieno
greco era utilizzato nel trattamento di malattie renali ed epatiche, nelle febbri e nelle
intossicazioni. Il rosmarino veniva usato come fumigante per disinfettare le stanze
dei malati. L’erisimo era utilizzato per alleviare le infiammazioni della gola, per
risolvere la raucedine e l’afonia conseguenti a laringiti, faringiti e tracheiti acute o
croniche e in genere le irritazioni delle prime vie aeree dovute a tosse, infuenza e
raffreddore. La santoreggia era usata per disinfettare le piccole ferite ed era conosciuta anche col nome di erba spezia o erba acciuga, godeva della fama di essere
afrodisiaca (il nome santureja significa erba del satiro). La medicina moderna ha
in parte confermato questa tradizione, riconoscendo alla santoreggia la proprietà di
stimolare le funzioni cerebrali e fisiche in chi la consuma. Curaro, atropina, chinidina, colchicina, chinino, valeriana, rutina e ancora molti altri sono farmaci estratti da
vegetali che sono nell’uso attuale a dimostrazione continuità dell’utilizzo dei rimedi
ottenuti dalle piante.
La farmacopea medievale comprendeva complessivamente sei classi di rimedi
corrispondenti a stati patologici precisi: le piante contro le febbri, le piante delle donne, le piante vulnerarie, le purghe, le piante dei mal di ventre, le piante antiveleno. La
La medicina nel medioevo
173
diffusione dei monasteri e delle abbazie avvenne lungo la via Francigena, il cammino
di Santiago, ed altre vie di pellegrinaggio, e ciò finì con il creare una rete di luoghi
di cura per tutta l’Europa. La diffusione delle conoscenze mediche fu considerata
importante da Carlo Magno che con il capitolare di Thionville dell’805 ordinò l’insegnamento della medicina, in quel tempo era chiamata phisica, insieme a quello della
altre arti: grammatica, retorica, dialettica, aritmetica, geometria, astronomia e musica.
Secondo la concezione medievale deve esserci un legame stretto tra medicina
e filosofia, quindi il medico esperto dove essere uno studioso istruito nella filosofia
naturale: la physica. È questa concezione quella che sta alla base dell’equivalenza
terminologica tra medicina e physica, possiamo notare che l’equivalenza sopravvive nella parola inglese Physician, che indica il medico.L’ispiratore della Scuola
Palatina di Aquisgrana, Alcuino di York, scrisse un ricettario medico: il ricettario di
Lorsch. La parte introduttiva del ricettario sviluppa il concetto di una motivazione
cristiana con cui si possono affrontare gli studi della medicina. Questo è un frammento del ricettario, conservato nel monastero di Lorsch. Dalla iniziale figura del
monaco-infermiere, si arrivò progressivamente al medico-monaco. Questi medici
cominciarono con il passare del tempo ad esercitare la medicina anche fuori dalle
mura dei monastero.
È anche sorprendente constatare come nel Medioevo hanno potuto anche operare donne con profonde conoscenze di medicina come la monaca Ildegarda di Bingen
(1098 –1179), che scrisse due opere importanti: Physica (Storia naturale o Libro delle
medicine semplici) e Causae et curae (Libro delle cause e dei rimedi o Libro delle
medicine composte). Ildegarda per curare la febbre di qualsiasi genere prescriveva:
«quando una persona ha febbre, non importa per quale motivo, prenda radici di Angelica e le pesti un po’. Così pestate o schiacciate, le copra con un mezzo bicchiere di vino
e le lasci riposare tutta la notte [...] il mattino dopo aggiunga ancora un po’ di vino e ne
beva ancora a digiuno, faccia questo per tre o cinque giorni e verrà guarito».5
A partire dal XI secolo nell’ambito della medicina ha origine un lento processo di differenziazione tra le figure sanitarie e quelle religiose. Si fa strada l’idea che
Dio interviene non solo direttamente, ma anche col dare al medico il donum scientiae. La svolta fu influenzata dalle decisioni del Concilio di Reims del 1131, dove
papa Innocenzo II proibì ai canonici e monaci di esercitare la medicina a scopo di
lucro, e di quelle del 1163 a Tours dove fu proibito ai monaci l’esercizio esterno della
medicina. Nell’XI secolo nacquero in Europa le prime due scuole mediche: a Salerno e a Montpellier. Nasceva nell’Occidente la medicina laica. Montpellier per il fatto
di essere posta al confine con il mondo arabo accolse studiosi arabi ed anche allievi
di religione islamica, ciò è testimoniato da una disposizione del 1180 di Guglielmo
VII signore di Montpellier secondo la quale l’accesso agli studi doveva esse consen-
5
R. Schiller, Le cure miracolose di Suor Ildegarda, Piemme 1994, p. 77.
174
Salvatore D’Angelo
tito a tutti, senza alcuna discriminazione religiosa o di etnia. La fondazione ufficiale
della scuola di Montpellier si deve al cardinale Corrado, legato di papa Onorio III il
17 aprile del 1220, tuttavia l’attività di insegnamento fu certamente precedente. Non
abbiamo notizie certe sull’anno di fondazione della Scuola salernitana, sappiamo
che nell’820 l’arcidiacono benedettino Adelmo, proveniente da Montecassino, fondò
un ospizio per malati a Salerno, tuttavia questa notizia non ci autorizza a credere che
questo sia l’anno di fondazione della scuola medica.
Il processo di fondazione delle scuole mediche nell’occidente cristiano avvenne con l’apporto delle conoscenze dottrinali derivate dagli autori arabi, in coincidenza con la fine della fase di espansione araba nel Mediterraneo. Rhazes e Avicenna
sono stati i medici arabi più importanti del periodo che va dal IX al X secolo, e sono
la diretta espressione della integrazione tra la medicina greca e gli studi arabi di fisica e chimica. Gli invasori mussulmani, dopo l’iniziale avversione verso la cultura
greco-ellenistica culminata con la distruzione della biblioteca di Alessandria ordinata dal califfo Omar (furono bruciati i rotoli di pergamena di circa 750.000 volumi), si
lasciarono sedurre dalla cultura greca. Gli arabi trovarono in Siria e in Persia scuole
mediche nutrite dalla scienza greca ne assorbirono le conoscenze e tradussero nella
loro lingua le opere dei grandi autori. La conoscenza delle opere di Rhazes e Avicenna fu fondamentale per lo sviluppo della Scuola medica salernitana, e facilitò il
passaggio dalla medicina conventuale a quella laica. Rhazes (Abu Bakr Mohammad
Ibn Zakariya al-Razi, 864 - 930) fu il primo a capire che la febbre era un meccanismo
di difesa naturale del corpo umano. Criticò la teoria di Galeno riguardo al fatto che
il corpo umano fosse composto da quattro umori, e che le malattie derivassero da
uno squilibrio fra essi. A lui si deve la prima descrizione conosciuta del vaiolo, che
ritroviamo nel al-Jadarī wa al-hasbah (Libro sul vaiolo e il morbillo). La comparsa
del vaiolo è preceduta da febbre continua, dolore al dorso, prurito nel naso, assieme
anche a bruciori che i pazienti sentono su tutto il corpo, gonfiore del viso che, con il
tempo, va e viene, rossore intenso negli occhi, forte spossatezza i cui sintomi sono lo
sbadigliare e lo stirarsi, dolore alla gola e al petto, con una leggera difficoltà nel respirare, tosse, secchezza del respiro, saliva spessa, e voce rauca, dolori e pesantezza
della testa, inquietudine, nausea e un rosso intenso e brillante delle gengive.
Il vaiolo è l’unica infezione virale mortale completamente eradicata, l’ultimo
caso è stato individuato in Africa nel 1977. Ceppi del virus sono ancora mantenuti
presso due laboratori, ad Atlanta negli USA e a Novosibirsk in Russia.
Rhazes identificò: l’asma allergica, le riniti primaverili allergiche e le accomunò con il raffreddore da fieno. Fu il primo a capire che la febbre era un meccanismo di difesa naturale del corpo umano. Kitāb al-hāwī fī tibb, (Il libro che raccoglie
le notizie sulla medicina) fu tradotto da Gherardo da Cremona. Questa enciclopedia
in nove volumi fu conosciuta in Europa con il titolo di Continens Liber.
La raccolta postuma dei quaderni di appunti di Rhazes: Al-Hāwī’ comprende
osservazioni originali su malattie e le relative terapie, basate sulla sua esperienza
La medicina nel medioevo
175
clinica. È stata tradotta in latino nel 1279 da Faraj ben Sālim (Ferraguth), un medico
ebreo che lavorò in Sicilia alla corte di Carlo d’Angiò. Secondo un aforisma di Rhazes, “la verità in medicina è un obiettivo irraggiungibile, e l’arte descritta nei libri è
ben lungi dalla conoscenza di un esperto e saggio medico”.
Avicenna (Ibn Sina, 980–1037) scienziato oltre che medico scrisse il Kitab alQanun (Il canone della medicina), tradotto da Gerardo da Cremona o da Gerardo da
Sabioneta in latino come Liber canonis medicinae, l’opera diverrà il manuale medico più seguito fino al 1700. Per Avicenna la medicina è la scienza per cui la salute si
conserva e l’arte per ristabilirla dopo averla persa. Fu il primo medico a identificare
la tubercolosi polmonare come una malattia infettiva e a riconoscerne l’associazione
col diabete. Sviluppò il metodo della quarantena per limitarne la diffusione. Nel
Canone introdusse la sperimentazione sistematica in fisiologia, ipotizzò la presenza
dei microrganismi, raccomandò l’esecuzione di test, per ogni nuova sostanza medicinale, all’inizio sugli animali e poi sull’uomo, prima di iniziare ad usarla come
medicina. Avicenna classificò le malattie, sperimentò nuovi medicamenti, si soffermò sulle misure igieniche da adottare. È considerato un precursore della medicina
psicosomatica e della psicofisiologia, per il fatto che studiò con attenzione gli stati di
malessere causati da forti emozioni e ideò un sistema per associare i cambiamenti del
battito cardiaco con le forti emozioni, anticipando di qualche secolo i test psicanalitici. Descrisse dettagliatamente la malinconia, gli stati depressivi e certi tipi di fobie.
Quando i Normanni conquistarono la Sicilia si creò un contesto fertilissimo
per gli scambi tra le culture presenti: l’araba, l’ebraica e la cristiana. In Sicilia, nell’Italia meridionale ma soprattutto in Spagna si sviluppò la traduzione in latino dei
manoscritti, che poi si diffusero in Occidente. Nacque la figura del “traduttore”.
Importantissima fu la città di Toledo che, pur riconquistata dai cristiani nel
1085, mantenne inalterata la presenza sia della comunità araba che di quella ebraica.
Raimondo, vescovo di Toledo dal 1125 al 1152, costituì una scuola di traduttori. Nel
XII secolo per le traduzioni non si faceva uso di dizionari, bensì era necessaria la
collaborazione di diversi personaggi: uno che conosceva l’arabo e il castigliano (per
lo più si trattava di un ebreo) e l’altro che conosceva il castigliano e il latino (quasi
sempre un cristiano). Gli ebrei avevano spesso la duplice funzione di traduttore e di
autore in lingua araba o ebraica. Il traduttore Domenico Gundisalvi collaborava con
l’ebreo cristianizzato Giovanni di Siviglia (Johannes Hispalensis), Platone Tiburtino
collaborava con l’ebreo Savasorda (Abraham bar Hiyya di Barcellona). Il traduttore più produttivo fu Gherardo di Cremona (Cremona, 1114 - Toledo, 1187), che
tradusse 92 opere in latino, fra cui gli Elementi di Euclide, e opere di Archimede,
Apollonio, Tolomeo, Ippocrate, Galeno, Aristotele, Al-Kindi, Al-Farabi, Avicenna.
Nella scuola medica di Salerno si costituì un ambiente multiculturale tanto che
le lezioni venivano impartite in quattro lingue: arabo, ebraico, latino, greco. Alfano
di Salerno, monaco benedettino e vescovo di Salerno nel 1058 scrisse il trattato dal
titolo De quattuor humoribus, una delle prime opere della scuola salernitana. Costan-
176
Salvatore D’Angelo
tino l’Africano (1015 c.-1087), originario di Cartagine, convertitosi al cristianesimo,
introdusse nella civiltà latina le conoscenze della medicina araba e le opere mediche
dell’antichità greca, nel 1060 fu alla corte di Roberto il Guiscardo a Salerno, successivamente si ritirò nel monastero di Montecassino, dove tradusse in latino l’Ars
medica di Galeno, i commenti di Galeno agli Aforismi e Pronostici di Ippocrate, la
Pantegni di Hali Abbas al-Magusi, il testo medico arabo più importante prima del
canone di Avicenna, e altre opere di medici arabi (Ibn Al-Djassar), ed ebrei (Ishaq
Al-Israili), spesso senza rivelare il nome dell’autore dell’opera.
All’anno 1099 circa viene fatta risalire la composizione del Regimen sanitatis,
opera in 380 esametri latini che raccoglie i consigli medici e le ricette della Scuola
Medica Salernitana.
L’impostazione teorica divenne più complessa e furono considerate come appartenenti intrinsecamente all’uomo le sette res naturales: elementi, umori, complessioni, membra, virtù, operazioni e spiriti. La teoria classificava le membra o parti
principali (cervello, cuore, fegato e testicoli) e accessorie (i nervi, le arterie, le vene,
i dotti spermatici). Alcune parti erano dotate di una propria autonoma facoltà (ossa,
cartilagini, membrane, muscoli, grasso e carne), alte parti traevano vigore dal quelle
principali (lo stomaco, i reni, gli intestini). Le tre facoltà o virtù erano l’animale,la
spirituale e la naturale. Erano considerate possibili due tipi di operazioni. Nel primo
tipo rientravano quelle proprie: l’appetito per il cibo e la digestione. Quelle composte, si articolano in due componenti, ad esempio, il desiderio si componeva di due
facoltà, appetitiva e sensitiva. Gli spiriti erano classificati così: il primo o naturale,
originato dal fegato; il secondo o vitale, originato dal cuore; il terzo o l’animale, originato dal cervello. Sonno e veglia, esercizio e riposo, fame e sete, cibo e bevande,
replezione e deplezione, moti dell’animo (emozioni) erano le res non naturales. Le
malattie che evolvevano in quattro fasi: principium, augmentum, status, declinatio
erano classificate come res contra naturales. La guarigione si aveva con la espulsione dal corpo della materia peccans (da cui l’uso dei diuretici, dei purganti, degli
emetici e del salasso, praticato sia con tagli da cui far fuoriuscire il sangue, sia con le
sanguisughe). L’urina era considerata il riflesso dell’equilibrio o dello squilibrio dei
quattro umori dell’organismo. Così per emettere una diagnosi, il medico osservava
le urine del paziente in un vaso chiamato matula, cioè praticava l’uroscopia.
Presso la scuola salernitana fu iniziata l’utilizzazione dell’alcol sotto due forme: aqua ardens a 60° e aqua vitae a 90°. Questo nuovo solvente fu ampiamente
utilizzato per le preparazioni di rimedi. Numerosi furono i vocaboli usati per designarlo: anima del vino, acqua flagrante, spirito sottile, prima essenza, quintessenza.
Anche la spongia o spugna soporifera, mediante la quale venivano inalate sostanze
narcotiche (oppio, mandragora, ecc.) per anestetizzare i pazienti durante le operazioni chirurgiche, fu utilizzata a Salerno per indurre l’anestesia. La spugna veniva
preparata imbevendola di queste sostanze narcotiche e poi essiccata: al momento
dell’uso si inumidiva con acqua calda e il principio attivo veniva assunto o bevendo
La medicina nel medioevo
177
il succo o per inalazione. Naturalmente il metodo comportava frequenti rischi da sovradosaggio, che potevano comportare anche la morte. Poiché la dissezione veniva
condotto sperimentalmente in genere sul maiale le conoscenze di anatomia umana
erano generiche. In realtà gli schemi anatomici avevano lo scopo principale di far
capire la funzione degli organi più che di descriverli con accuratezza. Ciononostante
alcuni termini già allora in uso, ad esempio, “congiuntiva”, “vitreo”, “cristallino”, lo
sono tuttora con riferimento alle stesse parti anatomiche.
Il termine “cataratta” è stato coniato nel Medioevo e traduce il termine arabo
nuzul-el-ema che vuol dire “cadere in basso”. Si pensava, infatti, che la malattia fosse dovuta a strani umori, che scendevano dall’alto ad oscurare la vista. Una traccia di
questo si ritrova ancora oggi nell’espressione popolare “la cataratta scende”.
La pratica che maggiormente portava alla morte il malato, per azione diretta
del medico, era certamente la chirurgia.
Presso la scuola salernitana nell’uso delle erbe si applicava la dottrina della
segnatura (analogia), secondo questa visione, nel caso di analogie di forma tra piante e corpo umano, si dovevano usare specifiche parti vegetali per curare quelle con le
quali c’era una similitudine formale: similia similibus. L’iperico le cui foglie presentano una moltitudine di piccoli fori somigliano a occhi serve per le affezioni oculari.
I tubercoli del colchico ricordano le dita dei gottosi. Il principio attivo, la colchicina,
è specifico dell’accesso di gotta. Il salice e la Regina dei Prati (Spirea Ulmaria), crescendo in luoghi umidi sono utili contro i reumatismi, queste due piante contengono
dei salicilici. coincidenza fortunata, un derivato di essi è l’aspirina. La Celidonia, secernendo un lattice giallo-arancione, è indicato nelle malattie del fegato. La foglia di
Polmonaria, la cui forma ricorda quella del polmone è rinfrescante ed espettorante.
Lo stesso principio analogico valeva anche per l’uso terapeutico dei cibi di origine
animale, ad esempio, si mangiava il cervello per aumentare la memoria, ecc.
Alla fine del XII secolo Salerno divenne il più importante centro di studi medici
dell’Occidente, tanto importante che un medico salernitano, Giovanni di Castellomata di Salerno, fu il primo medico personale di un papa: Innocenzo III, come possiamo
leggere nel testamento di Maria di Montpellier, moglie di Pietro III d’Aragona.
La prima precisa regolamentazione statale dell’attività medica mai introdotta
si deve a Ruggero II di Sicilia che nel 1140 introdusse l’esame di abilitazione alla
professione di medico, successivamente gli studi di medicina e la professione medica furono riformati da Federico II nelle Costituzioni di Melfi, promulgate nel 1240.
Secondo la legislazione federiciana chi voleva studiare la scienza medica doveva
prima studiare per un triennio scienza logica. L’approvazione come medico presupponeva il superamento di un esame di stato. L’unica scuola autorizzata a rilasciare
diplomi validi era la scuola medica salernitana.
178
Salvatore D’Angelo
Articolo XLVI
Poiché non si può mai sapere di scienza medica se prima non si sappia alquanto di logica, stabiliamo che nessuno studi scienza medica se prima non studi
almeno per un triennio scienza logica. Dopo il triennio, se vorrà proceda allo
studio della medicina, nel quale studi per un quinquennio, e così pure apprenda
la chirurgia la quale è parte della medicina, nel tempo predetto; dopo di che, e
non prima, gli si conceda licenza di praticare, previo esame secondo modalità
della curia [reale] e assolutamente avendo ottenuto testimonianza magistrale in suo favore sul predetto periodo di studio. Questo medico visiterà i suoi
ammalati almeno due volte al giorno e a richiesta dell’infermo una volta nella
nott. Non contragga società con i preparatori [di farmaci], né accolga alcuno
di essi sotto la sua protezione a spese di una certa quota di ricavato, né egli
stesso abbia una propria impresa. Stabiliamo che nessun chirurgo sia ammesso a praticare se non offra dichiarazioni testimoniali di maestri, che leggono
nella facoltà medica, che per un anno almeno abbia studiato quella parte della
medicina, che specialmente abbia imparato l’anatomia dei corpi umani nelle
scuole.6
Articolo XLIV
Chiunque voglia esercitare la medicina si presenti ai Nostri ufficiali e ai giudici. A questo si provvede, affinché nel Nostro regno i sudditi non corrano
pericoli per imperizia di medici.
Articolo XLV
Affinché nessuno osi praticare, se non sia stato approvato in commissione pubblica di maestri di Salerno. D’ora in poi nessun pretendente al titolo di medico
osi affatto esercitare o praticare la medicina se non prima approvato da giudizio pubblico in commissione di maestri di Salerno.
Articolo XLVII
Con la presente legge stabiliamo anche che nessuno legga in medicina nel
regno se non presso Salerno, né assuma nome di maestro, se non diligentemente esaminato in presenza di Nostri ufficiali e di maestri dell’arte stessa.
Coloro poi alla cui fede le cose predette sono commesse, se siano provati di
avere commesso frode nell’ufficio affidato, ordiniamo che siano condannati a
supplizio capitale.
Le Costituzioni di Melfi sono consultabili nella pagina web: http://www.museovirtualescuolamedicasalernitana.it/public/Costituzioni_di_Melfi.pdf
6
La medicina nel medioevo
179
Nel Concilio di Montpellier del 1195 si decretò la assoluta proibizione dello
studio della medicina per i religiosi, tranne che per i chierici, ciò determinò la nascita
nel XIII secolo delle corporazioni di maestri e studenti.
Le università non sorsero dappertutto allo stesso modo: a Bologna si formò
un’associazione di soli studenti, che avendo la necessità di acquisire maggiori conoscenze chiamavano i più grandi studiosi da tutta Europa e li pagano di tasca loro
perché diventino i loro insegnanti. A Parigi studenti e professori (universitas magistrorum et scolarium Parisiensium) fondano insieme la loro università. Quella di
Napoli venne fondata nel 1224 per iniziativa di Federico II. La corporazione degli
intellettuali costituiva in ogni sede un gruppo sociale omogeneo dal punto di vista
di genere. Le donne, che nell’istituzione monastica avevano avuto insieme agli uomini l’accesso alla cultura, non furono invece ammesse nelle università. Il modello
adottato per le università invertiva una tradizione consolidata che aveva consentito
alle Mulieres Salernitanae la frequenza della Scuola Medica Salernitana, e che in
alcuni casi ne erano diventate docenti: Trotula de’ Ruggiero, Abella di Castellomata,
Rebecca Guarna, Mercuriade, Costanza Calenda, e altri.
Tra i medici delle università vanno ricordati:
Taddeo Alderotti o Alderòtto (Firenze 1223 - Bologna 1295) che fu uno dei
più illustri medici del XIII secolo. Insegnò medicina a Bologna assistette papa Onorio IV. Esigeva altissime parcelle. I Bolognesi, per i suoi meriti, lo esentarono, insieme ai suoi eredi, da qualunque tassa.
Pietro Ispano (1215?-1277) che nel 1276 venne eletto Papa con il nome di
Giovanni XXI. Dante lo menziona nel XII canto del Paradiso, fu autore di una serie
di opere di medicina.
Nel XIII secolo il monaco cistercense Giovanni da Toledo, espertissimo in
erbe officinali, divenne il medico di papa Innocenzo IV, la tradizione vuole che sia
stato l’inventore del pesto alla genovese.
Arnaldo da Villanova (1240-1311 circa), uno dei più grandi medici dell’epoca, fu alla corte di Bonifacio VIII e lo guarì per la calcolosi renale.
Matteo Silvatico, medico salernitano, che elaborò nel 1317 l’Opus Pandectarum Medicinae o Liber cibalis et medicinalis Pandectarum o semplicemente Pandette, un dizionario dei semplici di origine vegetale e minerale.
L’anatomia moderna nacque in Italia ad opera di Remondino da Bologna che
per primo dissecò pubblicamente i cadaveri, lasciandoci preziose tavole anatomiche
(1315). L’opera di Remondino vide la luce dopo un lunghissimo periodo di silenzio
che datava da Galeno. I successori di Remondino da Bologna furono: Eustachio e
Silvio, il cui vero nome era Giacomo Duboys.
Mondino de Luzzi discepolo di Taddeo Alderotti si laureò in medicina all’ateneo bolognese intorno al 1292. Nel 1321 diventò lettore pubblico nell’ateneo bolognese ove insegnò medicina e soprattutto tenne corsi di anatomia.
Il 27 maggio 1368, il Maggior Consiglio di Venezia stabilì che il Collegio dei
180
Salvatore D’Angelo
Medici e Chirurghi di Padova dovesse compiere almeno una dimostrazione annuale
su un cadavere. Le lezioni di anatomia svolgevano nell’arco di due o tre settimane
nel periodo più freddo dell’inverno. Tenevano la lezione tre professori (due di medicina teorica o pratica e un chirurgo): un docente leggeva l’Anatomia di Mondino
de Liuzzi; l’ostensore spiegava e mostrava nel cadavere quanto asserito nel libro di
testo e l’incisore incideva e dissecava il corpo).
L’epidemia di peste del 1347 fu la più drammatica emergenza sanitaria del
Medioevo, la malattia divenne quasi inarrestabile e tutte le cure risultarono inefficaci. Lo stesso Boccaccio, nel suo Decamerone (giornata I, introduzione), la considerò
come «per le nostre inique opere da giusta ira di Dio a nostra correzione mandata
sopra i mortali». Un terzo della popolazione dell’Europa (venti milioni di persone)
tra il 1347 e il 1351 ne fu vittima, in alcune città morì il 60% della popolazione. La
prima regione europea ad essere colpita nell’ottobre 1347 fu la Sicilia. Il francescano
Michele da Piazza nella Historia Siculorum riporta che a portare il morbo furono
dodici galee genovesi che raggiunsero il porto di Messina. Sulla peste furono elaborate stravaganti teorie e una di queste fu quella di Gentile da Foligno, medico umbro
che fu egli stesso vittima del contagio e morendone a Perugia nel giugno del 1348. È
conosciuta come il “Paradigma del soffio pestifero”.
Secondo il Gentile il 20 marzo del 1345 esalazioni insalubri erano state risucchiate dal mare e dalla terraferma nell’aria, avevano subirono un riscaldamento
ed erano state nuovamente gettate sulla terra come “venti corrotti” (aer corruptus).
L’ispirazione di tale soffio pestifero era la causa della raccolta di vapori velenosi al
cuore e ai polmoni, che addensandosi diventavano una “massa velenosa”, capace
di contagiare altri uomini con l’aria espirata. Nel corso dell’epidemia un medico
di Tolosa, Augier Ferrier, constatando l’impotenza dei medici nella cura, prescrisse
la pillola ai tre avverbi: scappare via veloci, andare lontani, tornare tardi. I malati
potevano morire all’improvviso e Boccaccio dice nel Decamerone (giornata I, introduzione) che molti giovani nel pieno del vigore la mattina «la sera vegnente appresso
nell’altro mondo cenaron con li lor passati!».
Dedicherò questa parte della relazione alla nascita degli ospedali nelle città.
Gli ospizi per lebbrosi diffusi in tutta l’Europa non possono essere considerati come
vere istituzioni assistenziali di tipo ospedaliero per il fatto che era del tutto assente
qualunque intendimento di cura. La lebbra o “Morbo Fenicio” già nel 643 era un problema sanitario, infatti, l’Editto di Rotari prescriveva l’isolamento dei malati. Attorno all’anno 1000 la malattia si espanse con i commerci, i pellegrinaggi e le crociate.
La sua diffusione fu favorita dall’affollamento nelle città e dalla mancanza di igiene
collettiva. La malattia raggiunse tutta l’Europa e colpì: poveri e ricchi, vescovi, feudatari e re. Dopo il XIV la sua diffusione diminuì per l’espandersi della tubercolosi e
per la epidemia della peste del 1300, che decimò la popolazione europea.
Il primo vero ospedale cittadino fu fondato a Parigi nel 651 dal vescovo Landrio. Nel 1157 in un diploma di Luigi VII compare, in lingua francese, la denomina-
La medicina nel medioevo
181
zione Hôtel-Dieu per designare questo grande ospedale di Parigi. L’Hôtel-Dieu, che
è sopravvissuto a incendi, rivoluzioni, guerre, oggi offre ai parigini moderni servizi
medici. Le diapositive mostrano: l’attuale ingresso dell’ospedale, i suoi giardini,
l’organigramma attuale di uno dei suoi reparti. Quali dovessero essere i compiti
degli ospedali ci viene detto dall’arcivescovo di Firenze Antonino Pierozzi, vissuto
dal 1389 al 1459: ricovero per viandanti e poveri, luogo in cui distribuire cibo per gli
affamati, orfanotrofio, ospizio per anziani e malati. La loro gestione poteva essere
affidata indifferentemente ad ecclesiastici o laici.
Gli edifici adibiti all’hospitalitas erano dotati di un infirmarium, con una prima sala denominata cubiculum valde infirmorum che serviva per la degenza dei malati gravi, una stanza per clisteri e salassi ed un locale con un armarium, che poteva
fungere da piccola biblioteca o come farmacia, e un giardino per la coltivazione di
piante medicinali. In questi luoghi venivano ospitati non solo i pellegrini in viaggio,
ma anche gli orfani e i vecchi senza risorse, nonché gli infermi.
Il primo ospedale in Italia fu quello di Santo Spirito in Saxia. Fu fatto costruire nel 1204 da Papa Innocenzo III (1198-1216), che affidò l’organizzazione ai
Cavalieri Ospitalieri dello Spirito Santo di Gerusalemme (Chevaliers Hospitaliers
du Saint-Esprit de Jérusalem), ordine cavalleresco fondato da Guy de Montpellier.
Nell’ospedale era compreso il brefotrofio, ed è ancora visibile la prima ruota degli
esposti. Una volta la settimana i religiosi di Santo Spirito percorrevano la città alla
ricerca di infermi abbandonati, che venivano trasportati all’ospedale mediante carriole, antesignane delle moderne ambulanze. Le monache dell’Ordine attendevano
alla assistenza dei malati e il cambio della biancheria avveniva, senza termini fissi,
ogni volta che si rendesse necessario.
A Firenze l’ospedale di Santa Maria Nuova fu fondato nel XIII secolo, più
precisamente nel 1288, da Folco Portinari, il padre di Beatrice amata da Dante. La
struttura era suddivisa in due aree, femminile e maschile, dove potevano avere accoglienza circa duecento ricoverati. Specialmente nel XV secolo l’ospedale godette
di una notevole floridezza economica e a quest’epoca risalgono gli interventi di ampliamento dell’edificio, come l’aggiunta nel 1420 del chiostro delle Medicherie, nei
primi decenni del XV secolo furono decorate le corsie.
L’ospedale di Santa Maria della Scala di Siena sorse nel 1090 sulla via Francigena, di fronte alla cattedrale, e fu uno dei primi esempi europei di ricovero per i
pellegrini, sostenere i poveri e i fanciulli abbandonati ed ospedale, con una propria
organizzazione autonoma. La sua istituzione si deve ai canonici del Duomo. È rimasto attivo fino al 1992. Uno dei suoi pazienti più famosi fu Italo Calvino, che nel
1985 vi morì. Sin dagli inizi del Trecento uno statuto ne regolava la vita e l’autonomia. Sappiamo dai dati di archivio che nel 1399 le entrate dell’ospedale ammontavano a 12.000 fiorini annui, ricavati dalla vendita del frumento e dalle alienazioni di
proprietà in periodo di penuria, dalla rendita degli affitti, dalle elemosine e da altre
voci. Le centinaia di registri che compongono l’archivio consentono l’analisi delle
182
Salvatore D’Angelo
diverse transazioni. I documenti indicano anche la presenza, fin dalla fine del XIII
secolo, di un tipo di dono “a termine”, che era un modo di donare per la propria sicurezza, garantendosi una rendita vitalizia. L’ospedale concorse alla nascita del Monte
dei Pegni con 2.000 fiorini a fondo perduto, all’ospedale, in assenza del titolare o
degli eredi, sarebbe andato in deposito l’avanzo del ricavato della vendita all’asta dei
pegni non riscossi, nel caso esso eccedesse la somma del capitale con le spese di gestione. A seguito di lasciti e donazioni, tra la fine del Duecento e i primi del Trecento,
l’ospedale iniziò a suddividere ed organizzare il proprio patrimonio terriero in vaste
aziende agrarie denominate grance (la grancia era un fabbricato fortificato con funzioni di magazzino e di granaio). Nel tempo si pervenne ad un patrimonio enorme,
che copriva vaste aree della Val d’Orcia, della Val d’Arbia, delle Masse, delle Crete
e della Maremma, tanto che nel suo insieme costituiva la più grande concentrazione
fondiaria dello Stato senese.
Ai nostri giorni che io sappia c’è un solo ospedale che per alcuni versi può
paragonarsi all’antico ospedale di Santa Maria della Scala di Siena. È la Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo: l’ospedale di S. Pio da Pietralcina.
Alcuni benefattori hanno donato a Padre Pio nel corso degli anni alcune masserie che
assicurano alla Casa Sollievo della Sofferenza l’approvvigionamento di prodotti alimentari. Una di queste masserie è un antico edificio del 1700 circondato da 70 ettari
di uliveto, nel suo frantoio si produce olio di oliva biologico “estratto a freddo”. Una
seconda masseria di 200 ettari di terreno, utilizzati per la coltivazione di foraggio
biologico destinato all’alimentazione di circa 600 bovini, garantisce la produzione di
latte, formaggi e carne per le i malati ricoverati nella Casa Sollievo della Sofferenza.
In ultimo accennerò al nostro Ospedale S. Antonio Abate di Trapani che ha
avuto la sua origine al tempo delle Crociate. I marinai e i crociati che non potevano
continuare il loro viaggio venivano sbarcati nel porto di Trapani, ed erano ricoverati
in una casa, posta in vicinanza della chiesa di S. Pietro concessa dalla famiglia Luna.
A questa casa vennero aggiunte in seguito altre limitrofe, donate da altri cittadini,
sicché si creò un vero ospedale con una piccola chiesa dedicata a S. Antonio. In seguito l’ospedale accolse anche i poveri della città.
Il re Martino d’Aragona il 19 giugno 1399 dispose di far aggregare l’ospedale al
Grande Ospedale S. Antonio di Vienne. L’amministrazione dell’ospedale fu affidata ad
una deputazione composta da tre Rettori, nominati annualmente dal Senato della città.
Intorno alla fine del 1400 i consoli dei marinai di Trapani acquistarono con i
proventi delle elemosine un’area di proprietà dell’ebreo Macalufo de Saya, e nell’anno 1455 i nobili Giacomo Blindano Fardella, Stanislao Clavica e Girolamo Staiti
Tipa decisero di far costruire un nuovo ospedale nell’area di cui avevano la disponibilità: l’attuale piazza Lucatelli.
Il nome della piazza fu posto in ricordo di un benefattore dell’ospedale: il capitano Lazzaro Lucatelli, che nel 1628 lasciò un’eredità di 3000 onze per rifare la facciata dell’ospedale, il busto in pietra del donatore è tutt’oggi visibile nell’architrave.
La medicina nel medioevo
183
Conclusioni
Per queste manifestazioni di vitalità si può dire a ragione che “il Medioevo
rappresenta il crogiolo dell’Europa e della civiltà moderna”. Secondo la mia opinione l’eredità più tangibile del Medioevo in campo medico è senza dubbio l’ospedale,
come luogo privilegiato delle attività mediche complesse. Gli ospedali medievali che possedevano una propria organizzazione autonoma reclutavano medici laici
mentre gli appartenenti alle diverse confraternite assicuravano lo svolgimento delle
attività collaterali. Le cure dirette agli ammalati erano svolte da religiosi (monache).
Accettando lasciti e donazioni si mantennero in vita, furono sostanzialmente
delle opere pie la cui missione era quella di assicurare l’assistenza sanitaria ai poveri.
Oggi concepiamo l’ospedale in modo del tutto diverso perché l’ospedale è per tutti
e perché vi si concentra la tecnologia e la capacità professionale. Oggi non tutti gli
ospedali soddisfano appieno le aspirazione dei cittadini, molti ospedali hanno perduto la cultura dell’accoglienza e le conoscenze mediche, sono diventati delle strutture
utili solo a chi amministra.
L’ospedale ideale deve essere visto oggi come una organizzazione assolutamente colta, nobile, disciplinata ed estremamente efficiente, dove deve predominare
l’etica oltre che l’intelligenza. Ciò può essere ottenuto soltanto con una severissima
selezione, sul piano etico prima ancora che professionale, di quanti operano in un
ospedale. È sbagliato pensare che tutti i medici per fatto di avere scelto una nobile
professione posseggano necessariamente l’animo nobile e alti principi morali.
Le cronache di ogni giorno ci dimostrano molto spesso il contrario.
Le notizie di pericolose distrazioni in ambito sanitario si susseguono in modo
quasi inarrestabile e sono il segno di una caduta della tensione morale prima ancora
che di quella professionale.
Vorrei concludere con una nota personale. Il mio anziano nonno, quando gli
comunicai la mia decisone di iscrivermi a medicina, ne restò inizialmente deluso,
perché aveva previsto per il mio futuro l’attività di uomo di legge: di magistrato.
Dopo avere ascoltato la mia decisione restò per qualche attimo in silenzio, poi con
gravità mi disse: «essere medico è come essere giudice. Il giudice decide il destino
di un uomo, il medico decide della vita di un uomo».
Parafrasando Benedetto Croce (in Etica e politica: frammenti di etica, XV Compassione e giustizia) che ha detto: «la giustizia vera è fatta di compassione» a
maggior ragione si può dire che “la medicina vera è fatta di compassione”. L’esercizio della medicina richiede intelligenza e compassione. Una delle eredità del Medioevo nella medicina è senza dubbio la compassione.
Abstracts, Curricula e Parole chiave
Manuela Girgenti, Filone d’Alessandria e il giudaismo rabbinico
Filone d’Alessandria è considerato il principale rappresentante del tentativo di conciliazione
tra cultura greca e teologia giudaica. Ma in particolare, la sua importanza, come si sottolinea in questo
lavoro, consiste nella differenza che egli evidenzia tra l’esegesi letterale del testo sacro della Bibbia e
quella allegorica; distinzione che permette di stabilire la funzione della filosofia nella conoscenza delle
verità religiose. Inoltre, si è messo in luce come, anche dopo la scomparsa del giudaismo alessandrino, la
filosofia ricompare in seno al giudaismo rabbinico, che in questo periodo si sviluppa nella sua pienezza.
Philo of Alexandria is considered the main representative of the attempt at conciliation
between Greek culture and Jewish theology. But in particular, his importance, as is stressed in this
paper, consists in the difference that he emphasises between literal exegesis of the sacred text of the
Bible and allegorical exegesis; a distinction making it possible to establish the function of philosophy
in knowledge of religious truths. It is also stressed that even after the disappearance of Alexandrine
Judaism, the philosophy reappears within rabbinic Judaism, which develops in its fullness in this period.
Parole chiave: Filone, ebraismo, giudaismo, esegesi, rabbinismo.
Key words: Philo, Hebraism, Judaism, exegesis, rabbinism.
Manuela Girgenti è nata a Erice (TP) nel 1984. Si è laureata con lode in Filosofia a Palermo
con una tesi dal titolo La guida dei perplessi. Maimonide tra ragione e fede. Ha conseguito un master
triennale di Counseling filosofico a Roma. Ha collaborato alla terza pagina del quotidiano La Sicilia di
Catania. Attualmente collabora per le pagine culturali alla rivista settimanale I Vespri di Catania. Ha
pubblicato: Poesia ed estetica nel pensiero di Platone in «Rassegna Siciliana (I.S.S.P.E)» 29 (2006) e
La società dell’incertezza in «Storia e Politica» 3 (2010).
E-mail: [email protected]
Antonio Bica, I vangeli Gnostici e il Cristianesimo delle origini
La scoperta dei manoscritti gnostici ci fa conoscere il pensiero della corrente gnostica del
Cristianesimo primitivo che vide il suo sviluppo dal I al IV secolo e che fu avversato dalla corrente
ortodossa allora al potere. Gli insegnamenti segreti degli gnostici gettano una nuova luce e forniscono
verità alternative sul Cristianesimo delle origini.
The discovery of the gnostic manuscripts reveals to us the thought of the gnostic current of
186
Abstracts, Curricula e Parole chiave
primitive Christianity which developed from the 1st to the 4th century and was opposed by the orthodox
current then in power. The secret teachings of the gnostics afford new light and furnish alternative truth
on early Christianity.
Parole chiave: Gesù, gnosticismo, cristianesimo delle origini, eresie, vangeli apocrifi.
Key words: Jesus, Gnosticism, early Christianity, heresies, apocryphal gospels.
Antonio Bica è medico di professione. Si è laureato in Studi Orientali e si è specializzato in
Scienze Islamiche, Lingua e Letteratura Araba presso la Facoltà di Studi Arabo-Islamici della Università
di Napoli “L’Orientale”.
E-mail: [email protected]
Giuseppina Mammana, La ricerca di sé come ricerca di Dio e dell’anima nel pensiero
di S. Agostino
Le tappe della vita inquieta di S. Agostino rispecchiano l’itinerario del suo pensiero filosofico
caratterizzato dalla ricerca di sé e di Dio. Perviene, alfine, alla consapevolezza che Dio è dentro di sé
come verità assoluta. È l’Essere, che trascende l’uomo e rimane un mistero che in questa vita non è dato
svelare, ma riconoscere e amare nella autenticità della propria dimensione interiore.
The stages in the unquiet life of St. Augustine mirror the itinerary of his philosophical thought,
characterized by the search for the self and for God. In the end he attains awareness that God is inside
the self as absolute truth. It is the Being, which transcends man and remains a mystery that in this life it
is not possible to disclose, but to recognize and to love in the authenticity of its own internal dimension.
Parole chiave: Agostino d’Ippona, Dio, essere, amore.
Key words: Augustine of Hippo, God, being, love.
Giuseppina Mammana è docente di Filosofia e Storia nelle scuole superiori, ha prestato
servizio nel Liceo Classico di Salemi e nell’Istituto Magistrale Rosina Salvo di Trapani. Ha insegnato
nei corsi di differenziazione didattica montessoriana, organizzati dall’ Opera Nazionale Montessori
e nei corsi di aggiornamento per insegnanti, indetti dal Provveditorato agli Studi di Trapani. È stata
presidente dell’ENAM (Ente Nazionale Assistenza Magistrale) di Trapani.
E-mail: [email protected]
Fabio Cusimano: Il monachesimo benedettino. Origini, tradizioni e cultura
Dalla scrittura alla musica, dalle arti del trivio e del quadrivio alla scuola, dall’architettura
all’artigianato, dalla bonifica dei terreni alle arti mediche, dalle officine alla produzione alimentare,
i monaci non solo hanno dato al mondo intero una grande lezione di saggezza e sapienza (ed ancora
oggi lo fanno!), ma lo hanno fatto con uno spirito di servizio che tutt’oggi resta come un grande lascito.
Il monachesimo si manifesta nella storia come un fatto unico e per certi versi “sovrumano”, che
aiuta l’uomo ad incontrarsi con un Mistero che entra nel tempo e collabora con esso, che si posa accanto
alla storia degli uomini accompagnandola verso destini di prosperità, di pace e di bene.
Abstracts, Curricula e Parole chiave
187
From writing to music, from the arts of the trivium and the quadrivium in schools, from
architecture to craftsmanship, from land reclaiming to medical arts, from workshops to food production,
monks not only taught a great lesson of wisdom and knowledge to the whole world (and still do today!),
but did it with a spirit of service that still today is a great legacy.
Monasticism manifests itself in history as something unique and in some respects “superhuman”,
which helps man to face up to a Mystery that enters time and collaborates with it, set alongside the
history of men accompanying them towards destinies of prosperity, peace and good.
Parole chiave: monachesimo, benedettini, San Benedetto.
Key words: monasticism, Benedictine, St. Benedict.
Fabio Cusimano (Palermo, 1980) si laurea con lode nel 2003 in Lettere Moderne presso
l’Università di Palermo. Nel 2007 consegue la Laurea Specialistica in Informatica per le Discipline
Umanistiche presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Nel 2008 consegue con lode e menzione il
Master di I Livello in “I mestieri del libro e del documento” organizzato dall’Università degli Studi
di Palermo e dall’Officina di Studi Medievali. Attualmente ha concluso le attività di ricerca per il
conseguimento del Dottorato di Ricerca in “Tradizioni e istituzioni religiose di ambiente circummediterraneo. Storia, Letteratura, Diritto” presso l’Università di Messina, dove è anche Cultore della
materia in Storia del Cristianesimo. È redattore delle riviste «Schede Medievali» e «Mediaeval Sophia»;
collabora, inoltre, con le riviste scientifiche «Benedictina», «Informatica Umanistica», «Doctor
Virtualis». Ha al suo attivo numerosi saggi e studi sulla tradizione monastica latina e su innovativi
aspetti dell’informatica umanistica.
E-mail: [email protected]
Manuela Girgenti, Il concetto di giustizia nell’età antica e medievale
Lo studio dei modi in cui la giustizia è interpretata e applicata all’interno di una società può
dare la misura del grado di evoluzione e di civiltà della comunità. Scopo di questo lavoro è quello di
mettere in luce come il problema della giustizia, così come quello del buon governo di uno stato, è
presente nel pensiero filosofico sin dall’antichità. Dai greci ai romani, all’avvento del Cristianesimo,
fino al Medioevo, considerando anche il significato che la giustizia ha per l’ebraismo, viene messo in
luce il rapporto tra esigenze morali e realtà dei fatti e le conseguenze dovute alle storture di un sistema
giuridico causa di una “giustizia ingiusta”.
The study of the ways in which justice is interpreted and applied inside a society can give a
measure of the degree of evolution and civilization of the community. The purpose of this essay is to
show how the problem of justice, like that of the good government of a state, is present in philosophical
thought starting from antiquity. From the Greeks to the Romans, to the advent of Christianity, down to
the Middle Ages, also considering the meaning that justice has for Judaism, the relationship is shown
between moral demands and reality of facts and the consequences due to the crookedness of a legal
system causing “unjust justice”.
Parole chiave: giustizia, medioevo, diritto, antichità, legge.
Key words: justice, Middle Ages, right, antiquity, law.
188
Abstracts, Curricula e Parole chiave
Giuseppe Allegro, Medioevo e teologia. Scienza e ricerca di Dio
Nel processo di costruzione della teologia medievale decisivo è il ruolo giocato da Alberto
Magno, che si pone l’obiettivo di rendere intelligibile Aristotele ai latini, polemizzando contro i detrattori
della filosofia pagana, e prima ancora da Abelardo, con il tentativo pionieristico di costruire, sui dati
della rivelazione cristiana, un sapere razionale, fondato sull’uso accorto della filosofia aristotelica; un
sapere nel quale la discussione dialettica trova tanto spazio da divenire metodo sistematico. Tuttavia in
Abelardo, come anche in Alberto, la teologia non è solo scienza di Dio, bensì anche ricerca di Dio, che
rimane ineffabile e irraggiungibile: è questa la lezione della teologia apofatica che i pensatori medievali
fanno propria.
In the process of construction of medieval theology a decisive role is played by Albertus
Magnus, who sets himself the objective of making Aristotle intelligible to the Latins, polemicizing
against the detractors of pagan philosophy, and even before by Abelard, with a pioneering attempt
to construct, on the data of Christian revelation, rational knowledge, founded upon shrewd use of
Aristotelian philosophy; knowledge in which dialectical discussion is given so much scope as to
become a systematic method. However, in Abelard, as in Albertus, theology is not only science of God,
but also a search for God, who remains ineffable and unattainable: this is the lesson of the apophatic
theology that medieval thinkers make their own.
Parole chiave: teologia, medioevo, Pietro Abelardo, Ugo di San Vittore, Bonaventura, Alberto Magno,
scienza aristotelica.
Key words: theology, Middle Ages, Peter Abelard, Hugh of Saint Victor, Bonaventura, Albertus
Magnus, Aristotelian science.
Giuseppe Allegro è laureato in Filosofia all’Università di Palermo e in Scienze Teologiche presso
la Facoltà Teologica di Palermo, dove insegna Dottrine filosofiche. È docente di Storia e Filosofia nei
Licei e Dottore di Ricerca in Filosofia. Per i tipi dell’Officina di studi Medievali ha pubblicato il volume
La teologia di Abelardo fra letture e pregiudizi (1990) e numerosi articoli su autori della tradizione
scolastica latina; con Guglielmo Russino ha curato la traduzione italiana del Commento di Alberto
Magno alla Teologia Mistica di Dionigi l’Areopagita (Palermo 2007) e recentemente ha pubblicato il
volume Teologia e metodo in Pietro Abelardo (Palermo 2010), entrambe edite dall’Officina di studi
Medievali. È vicedirettore responsabile delle riviste «Mediaeval Sophia» e «Schede Medievali».
E-mail: [email protected]
Luciana Pepi: Alcune considerazioni sulla presenza ebraica in Sicilia nel Medioevo
In questo intervento vengono proposte brevi riflessioni su alcune caratteristiche comuni alle
diverse comunità ebraiche presenti in Sicilia. Mettendo insieme alcuni importanti tasselli, si cerca di
far luce sulle condizioni di vita degli ebrei siciliani.
Vengono evidenziati due dati molto rilevanti: la durata millenaria della presenza ebraica
nell’isola, ininterrottamente dal primo secolo al quindicesimo secolo (1492) e la consistenza
demografica: nel medioevo, ad esempio, vi sono in Sicilia più ebrei che nel resto d’Italia.
In this paper brief reflections are made on some characteristics common to the different present
Jewish communities in Sicily. Putting together some important pieces, an endeavour is made to through
light on the conditions of life of Sicilian Jews.
Abstracts, Curricula e Parole chiave
189
Two very important data are stressed: the millennial duration of the Jewish presence in the
island, uninterruptedly from the first century to the fifteenth century (1492) and the demographic
importance: in the Middle Ages, for instance. in Sicily there are more Jews than in the rest of Italy.
Parole chiave: ebrei, medioevo, Sicilia, diaspora.
Key words: Jews, Middle Ages, Sicily, Diaspora.
Luciana Pepi si è laureata in Filosofia a Palermo, dove ha anche conseguito il Dottorato
di ricerca. Ha trascorso lunghi periodi di studio all’Università ebraica di Gerusalemme, dove ha
approfondito lo studio della filosofia ebraica medievale. Dal 2005 è ricercatrice presso l’università
degli Studi di Palermo ed insegna: Storia del pensiero ebraico e Lingua e Cultura Ebraica. Ha al suo
attivo numerose pubblicazioni tra cui ricordiamo: Anatoli Ja’aqov, Il pungolo dei discepoli. Il sapere
di un ebreo e Federico II, Introduzione, Traduzione e Note a cura di L. Pepi, (Machina Philosophorum)
Officina di Studi Medievali, Palermo 2004; L. Pepi. – F. Serafini, Corso di ebraico biblico. San Paolo,
Milano 2006; Lettori e Letture di Mosè Maimonide nell’Italia meridionale durante il medioevo in
Materia Giudaica vol. XI, Giuntina 2007; La dignità dell’uomo nell’ebraismo in Colloqui sulla dignità
dell’uomo, Aracne editrice, Roma 2007.
E-mail: [email protected]
Salvatore D’Agostino: La Sicilia di Federico III d’Aragona
Federico III d’Aragona, terzogenito di re Pietro il Grande d’Aragona e Costanza (figlia di re
Manfredi di Sicilia), già Luogotenente del Regnum per il fratello Giacomo II (1291), fu incoronato
nel 1296 Re di Sicilia per volontà del Parlamento. Il suo regno fu caratterizzato prevalentemente dal
continuo stato di guerra con il papato e gli Angiò di Napoli, per il riconoscimento del titolo di Re di
Sicilia. Con la pace di Caltabellotta (1302) Federico ottenne il titolo di Rex Trinacriae. Alla sua morte
(1337) il Regno sarebbe dovuto tornato in mano agli Angiò, legittimi detentori del titolo.
Frederick III of Aragona, the third-born son of King Peter the Great of Aragona and Constance
(the daughter of King Manfred of Sicily), former Lieutenant of the Regnum for his brother James II
(1291), in 1296 was crowned King of Sicily at the behest of the Parliament. His kingdom was primarily
characterized by a continual state of war with the papacy and with the Anjous in Naples, for recognition of
the title of King of Sicily. With the peace of Caltabellotta (1302) Frederick got the title of Rex Trinacriae.
On his death (1337) the Kingdom was to go back to the Anjous, the legitimate holders of the title.
Parole chiave: Sicilia, Federico III d’Aragona, angioini, Vespri siciliani, Pace di Caltabellotta.
Key words: Sicily, Frederick III of Aragona, Angevins, Sicilian Vespers, Peace of Caltabellotta.
Salvatore D’Agostino è nato a Palermo nel 1977. Si è laureato in Filosofia nel 2004 presso
l’Università degli Studi di Palermo, con una tesi dal titolo Scientia e Natura in Michele Scoto. Nel 2010
ha conseguito, presso l’Università degli Studi di Messina, Facoltà di Scienze Politiche, il Dottorato di
Ricerca Internazionale (Ph.D.) in Storia e Comparazione delle Istituzioni Giuridiche e Politiche Europee,
con una tesi dal titolo Dalla teologia alla politica. Arnau de Vilanova e Federico III d’Aragona, re di
Trinacria. Attualmente collabora con L’Officina di Studi Medievali dove prosegue i suoi studi su Arnau
de Vilanova e sulla dominazione aragonese in Sicilia; è redattore delle riviste «Mediaeval Sophia» e
«Schede Medievali». Ha al suo attivo saggi e studi.
E-mail: [email protected]
190
Abstracts, Curricula e Parole chiave
Vincenzo M. Corseri, Religione e politica in Europa nella prima metà del
quattrocento. Cusano e Piccolomini a Basilea
Lo studio intende tratteggiare alcuni aspetti del rapporto umano e intellettuale intercorso fra
Nicola Cusano ed Enea Silvio Piccolomini a partire dalle esperienze condivise durante le movimentate
fasi iniziali del Concilio ecumenico di Basilea (1431-1449). Entrambi rappresentano, seppure su piani
operativi diversi, la presa di coscienza della loro epoca, ovvero il meglio della cultura umanistica
europea intervenuta, in un perfetto connubio di vita activa e vita contemplativa, a risolvere una tra le
più complesse e drammatiche questioni politico-culturali del tempo.
The essay intends to outline some aspects of the human and intellectual relationship between
Nicola Cusano and Enea Silvio Piccolomini starting from the experiences they shared during the lively
initial phases of the ecumenical Council of Basel (1431-1449). Both represent, though on different
operational planes, achievement of awareness of their epoch, that is to say the best of European
humanistic culture that intervened, in a perfect blending of active life and contemplative life, to solve
one of the most complex and dramatic political-cultural issues of the day.
Parole-chiave: Nicola Cusano, Enea Silvio Piccolomini, Chiesa Cattolica, Concilio di Basilea,
ecumenismo, umanesimo.
Key words: Nicola Cusano, Enea Silvio Piccolomini, Catholic Church, Council of Basel, ecumenicalism,
humanism.
Vincenzo M. Corseri, nato nel 1976 a Castelvetrano (Tp), si è laureato in filosofia presso
l’Università degli Studi di Palermo. È redattore di «Schede Medievali» e «Mediaeval Sophia».
Ha collaborato con la Facoltà Teologica di Sicilia alla redazione del Dizionario Enciclopedico dei
Pensatori e Teologi di Sicilia. Secc. XIX-XX (Roma-Caltanissetta 2010). Attualmente sta svolgendo
un dottorato di ricerca in Filosofia (XXIII ciclo) presso il Dipartimento di Filosofia, storia e critica
dei saperi (FIERI-AGLAIA) dell’Università degli Studi di Palermo, con una tesi sul linguaggio della
concordantia nel pensiero politico-religioso di Nicola Cusano. Tra le sue recenti pubblicazioni, si
segnala: Vis assimilativa e soggetto conoscente nell’umanesimo di Nicola Cusano, in L. Parisoli (a
cura di), Il soggetto e la sua identità. Mente e norma, Medioevo e Modernità, Palermo, Officina di Studi
Medievali 2010, pp. 111-122.
E-mail: [email protected]
Flavia Buzzetta, Aspetti della magia in epoca tardo-medievale
La magia, considerata in una prospettiva generale, si presenta come una complessa forma di
sapere di cui gli studi critici mettono in evidenza la ricchezza e la varietà di manifestazioni. In questa
relazione la magia è considerata come una forma specifica d’interpretazione del reale e come una
peculiare tipologia di “razionalità” sottesa alla elaborazione di una strutturata visione del mondo in cui
concorrono istanze fisiche, cosmologiche, metafisiche, teologiche, etiche, antropologiche.
Magic, considered in a general perspective, appears as a complex form of knowledge whose
richness and variety of manifestations is highlighted by critical studies. In this relationship, magic is
considered as a specific form of interpretation of reality and as a peculiar typology of “rationality”
underlying the working out of a structured vision of the world to which physical, cosmological,
Abstracts, Curricula e Parole chiave
191
metaphysical, theological, ethical and anthropological drives contribute.
Parole chiave: magia medievale, Pico della Mirandola, cabala practica, magia ebraica.
Key words: medieval magic, Pico della Mirandola, practica cabal, Jewish magic.
Flavia Buzzetta si è laureata nel 2004 in Filosofia presso l’Università degli Studi di Palermo.
Nel 2006, grazie ad una borsa di perfezionamento all’estero, ha svolto ricerche sulla storia della magia
rinascimentale presso l’École Pratique des Hautes Études (EPHE) di Parigi. Attualmente sta per
concludere un Dottorato di ricerca in Filosofia presso il Dipartimento FIERI-AGLAIA dell’Università
degli Studi di Palermo e la Mention en Religion et sistèmes de pensée presso l’EPHE di Parigi con una
tesi dal titolo Aspetti della magia naturalis e della scientia cabalae nel pensiero di Giovanni Pico della
Mirandola (1486-1487). Collabora con l’Officina di Studi Medievali ed ha al suo attivo saggi e studi.
E-mail: [email protected]
Salvatore Girgenti, Le radici politiche e religiose dei templari: una ipotesi di ricerca
L’ordine monastico-militare dei templari nasce creando scandalo per quanto concerne una delle
distinzioni fondamentali della società medievale, poiché chi spargeva sangue non poteva fare parte del
clero. Solo l’autorità di San Bernardo può legittimare la nascita. Malgrado venga visto come l’esercito
del Papa, mostra di avere un piano politico, economico e sociale che, con gli interessi della Chiesa
Romana, ha ben poco a che spartire. Fra l’altro, nel loro modo di sentire religioso, i Templari presentano
non pochi punti di contatto con il pensiero ebraico.
The monastic-military order of the Templars came into being creating a scandal regarding one
of the fundamental tenets of medieval society, since anyone who shed blood could not belong to the
clergy. Only the authority of St. Bernard can legitimate its birth. Although it is seen as the Pope’s army,
it proves to have a political, economic and social plan that has very little to do with the interests of the
Roman Church. Among other things, in their religious sentiment, the Templars present more than a few
points of contact with Jewish thought.
Parole chiave: templari, Ugo di Champagne, Bernardo di Chiaravalle, ebraismo.
Key words: Templars, Hugo of Champagne, Bernard de Clairvaux, Judaism.
Salvatore Girgenti è nato a Palermo nel 1945. È direttore della sede dell’Officina di Studi
Medievali di Trapani, docente di filosofia e giornalista. Ha all’attivo numerose pubblicazioni, tra le
quali ricordiamo: La vicenda Nasi e i suoi riflessi nell’opinione pubblica, L.U.T. 1984 e La compagnia
dei Bianchi di Trapani, L.U.T. 1988.
E-mail: [email protected]
Filippo Grammauta, La pergamena di Chinon. La prova dell’assoluzione dei
dignitari templari dall’accusa di eresia
Il documento conosciuto con il nome di Pergamena di Chinon rappresenta il resoconto
dell’interrogatorio degli alti dignitari dell’Ordine dei Templari avvenuto nella fortezza di Chinon tra
il 17 ed il 20 agosto 1308. Il documento scompare subito tra gli atti della Curia pontificia, che in quel
192
Abstracts, Curricula e Parole chiave
periodo risiedeva a Poitiers. Trasportato a Roma dopo la fine della cattività avignonese, esso è stato
casualmente rinvenuto dalla ricercatrice Barbara Frale tra gli atti dell’Archivio Segreto Vaticano.
The document known by the name Parchment of Chinon is an account of the questioning of the
high dignitaries of the Order of the Templars at the Chinon fort between among 17 and 20 August 1308.
The document immediately disappears among the deeds of the pontifical Curia, which in that period
resided in Poitiers. Taken to Rome after the end of the captivity in Avignon, it was found by chance by
the researcher Barbara Frale among the deeds of the Vatican Secret Archive.
Parole chiave: templari, Chinon, pergamena, De Molay, Filippo IV il Bello.
Key words: Templars, Chinon, parchment, De Molay, Phillip IV the Handsome.
Filippo Grammauta, laureato in Ingegneria Civile con 110 e lode, vive e lavora tra Palermo e
Roma. Cultore della Storia antica e moderna, ha pubblicato diversi articoli sui Templari. È Presidente
del Centro studi Tormargana di Roma, Direttore del Dipartimento di Archivistica e Documentale
dell’Accademia Templare di Roma e Balivo della Sicilia del Gran Priorato d’Italia dell’O.S.M.T.H.
(Ordo Supremus Militaris Templi Hièrosolymitani).
E-mail: [email protected]
Salvatore D’Angelo, La medicina nel Medioevo
La medicina nel medioevo è connessa, in larga misura, al monachesimo. Al monachus
infirmarius si applicava il principio della hospitalitas. I monaci si impadronirono delle conoscenze
mediche dell’antichità classica, somministravano infusi di erbe, praticavano i salassi. Nell’XI secolo
nacquero le scuole mediche laiche: a Salerno e a Montpellier, e successivamente le Università. L’eredità
più importante é l’ospedale, luogo privilegiato delle attività mediche.
Medicine in the Middle Ages is largely connected to monasticism. To the monachus infirmarius
there was applied the principle of hospitalitas. The monks took over some medical knowledge from
classical antiquity, administered infusions of herbs and practised bloodletting. In the 11th century lay
medical schools came into being, in Salerno and Montpellier, and subsequently the universities. The
most important legacy is the hospital as a privileged place of medical activities.
Parole chiave: medicina, monaci, rimedi, università, ospedali.
Key words: medicine, monks, remedies, universities, hospitals.
Salvatore D’Angelo è nato a Palermo nel 1948. È Dottore in Medicina e Chirurgia, specialista
in Medicina del Lavoro e in Malattie del Rene, Sangue e Ricambio. È stato docente di Immunologia
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia per gli anni accademici 2003/04 e 2004/05. È un cultore di
Storia della Medicina.
E-mail: [email protected]
Giuliana Musotto (curatore)
Giuliana Musotto è nata a Cefalù (Pa) nel 1979. Si è laureata in Filosofia nel 2003 presso
Abstracts, Curricula e Parole chiave
193
l’Università degli Studi di Palermo, con una tesi dal titolo “Le quaestiones disputatae De dilectione
Dei di Nicola di Ockham”. Nel 2008 ha conseguito, presso l’Università degli Studi di Salerno, in cotutela con l’Universidad Autónoma de Barcelona (Spagna), il Dottorato di Ricerca in Filosofia, Scienze
e Cultura dell’Età Tardoantica, Medievale e Umanistica, con una tesi dal titolo “L’etica in Nicola di
Ockham: aspetti filosofici ed antropologici”. Collabora, per attività di studio e ricerca, con l’Officina di
Studi Medievali di Palermo.
E-mail: [email protected]
Indice dei nomi*
a cura di Giuliana Musotto
* I numeri in grassetto segnalano una comunicazione concernente l’autore. I nomi
degli autori, sia antichi e medievali sia moderni e contemporanei, vengono riportati così
come compaiono nel testo.
A
Abbagnano N., 39.
Abella di Castellomata, 179.
Abulafia D., 93, 94, 97, 98, 101, 102.
Adelmo, arcidiacono benedettino, 174.
Adeodato (figlio di Agostino d’Ippona), 40,
41.
Agostino d’Ippona (pseudo), 84.
Agostino d’Ippona, 9, 33-46, 67-69, 73, 84,
186.
Alberigo G., 121, 123.
Alberto Magno, 82, 83, 88, 89, 188.
Albrile E., 136.
Alcuino di York, 173.
Alessandro Magno, 3, 68.
Al-Farabi, Abu Nasr Muhammad, 175.
Alfonso Federico di Atene, 114.
Alfonso III d’Aragona, 108, 109, 116.
Alfonso X di Castiglia, 135.
Al-Kindi, Ya’qub Ibn Ishaq, 136, 175.
Allegro G., 79-90, 188.
Al-Magusi, Hali Abbas, 176.
Amari M., 106, 108.
Ambrogio (santo), 37, 40, 41.
Amedeo VIII di Savoia, 126.
Anatoli Ja’aqov, 101, 189.
Andrea di Montbard, 151, 154.
Andronico II Paleologo, 114.
Anselmo d’Aosta, 50.
Antolic P., 86.
Antonino Pierozzi, 181.
Antonio Abate (san), 54.
Apollonio di Tiro, 134.
Apollonio, 175.
Apuleio, Lucio, 36.
Archimede, 175.
Arduini M. L., 129.
Aristotele, 38, 39, 61-64, 72, 75, 81, 82, 86,
175, 188.
Arnaldez R., 4.
Arnaldo da Villanova, 101, 113, 179, 189.
Arnobio, 36.
Ashtor E., 93.
Augusto, Gaio Giulio Cesare Ottaviano, 40.
Avicenna, 101, 174-176.
B
Backman C. R., 112, 113, 115.
Baigent M., 151.
Baldovino I di Gerusalemme, 150.
Barber M., 150, 164.
Barberis G., 57.
Bartolomeo della Scala, 126.
Bartolomeo Visconti, 126.
Basilio abate, 49, 54.
Bauer M., 152, 156.
Baum W., 129.
Beatrice (Portinati), 181.
Beatrice d’Angiò, 108.
Benedetto d’Aniane, 55.
Benedetto da Norcia, 47-49, 51-55, 169, 187.
Beniamino da Tudela, 91.
Bérenger Frédol, 162-165.
Bernardo di Chartres, 81, 169.
196
Giuliana Musotto
Bernardo di Chiaravalle, 50, 53, 74, 85, 151154, 156, 158, 169, 191.
Bica A., 19-32, 185, 186.
Biffi I., 89.
Biondi A., 137.
Black A., 120.
Bobbio N., 65, 66.
Bocken I., 123.
Bonaventura da Bagnoregio, 80, 188.
Bongars J., 151.
Bonifacio (san), 52.
Bonifacio IV papa, 55, 121.
Bonifacio VIII papa, 75, 108, 110, 111, 121,
166, 179.
Bormann C., 122.
Boudet J. P., 134, 142, 146.
Boyer B. B., 84.
Brach J. P., 146.
Bréhier E., 5, 6, 8.
Bremmer J. N., 146.
Bresc H., 93, 100.
Bruno di Colonia, 53.
Bucaria N., 95.
Buytaert E. M., 86.
Buzzetta F., 131-147, 190, 191.
C
Cagiati A., 100.
Calimani R., 10.
Calvino I., 44, 181.
Cardini F., 153.
Carlo di Valois, 110.
Carlo I d’Angiò, 105, 106, 108, 175.
Carlo II d’Angiò, 108, 110.
Carlo Magno, 49, 173.
Casertano G., 59.
Cassiodoro, Flavio Magno Aurelio, 169,
170.
Celestino V papa, 55, 108.
Cerrini S., 152.
Charpentier L., 157.
Cicerone, Marco Tullio, 37, 65, 87.
Cipriano da Cartagine, 36.
Cirillo d’Alessandria, 53.
Clemente di Ochrida, 53.
Clemente V papa, 115, 161, 163, 165-167.
Clemente VI papa, 55.
Clinia di Taranto, 58.
Coggi R., 72.
Cohn L., 4.
Colli G., 61.
Colombano (san), 52, 121.
Confalonieri G., 165.
Corradi F., 132.
Corrado cardinale, 174.
Corrado di Gehlhausen, 121.
Corrado IV di Sevevia, 105, 106.
Corrado V di Svevia sive Corradino, 106,
109.
Corseri V. M., 119-129, 190.
Cosmacini G., 97.
Costantino abate, 48.
Costantino I imperatore, 23, 24.
Costantino l’Africano, 56, 175.
Costanza Calenda, 179.
Costanza d’Altavilla, 105, 109.
Costanza d’Aragona, 106, 110, 116, 189.
Crisippo di Soli, 57.
Croce B., 183.
Cusimano F., 47-56, 186, 187.
Cuttini E., 80.
D
D’Agostino S., 105-117, 189.
D’Angelo S., 169-183, 192.
D’Onofrio G., 122.
Dan J., 146.
Dante Alighieri, 105, 179, 181.
De Lubac H., 79.
De Ruggiero G., 2, 8, 9, 75.
De Stefano A., 109, 112, 114-116.
Demurger A., 149, 152.
Di Cesare D., 3.
Dionigi l’Aeropagita (pseudo), 84, 88, 188.
Dioscoride, 171.
Dogliotti A. M., 172.
Dom Pérignon P., 56.
Domenico Capranica, 122.
197
Indice dei nomi
Domenico di Guzmán, 53.
Domenico Gundisalvi, 175.
E
Ebbesen S., 86.
Edmondo di Lancaster, 105, 106.
Eimerico da Campo, 120.
Eleazar di Worms, 144.
Eleonora d’Angiò, 110, 111, 113.
Elisabetta d’Aragona, 116.
Enea Silvio Piccolomini sive Pio II papa,
119-129, 190.
Enrico di Langenstein, 121.
Enrico II d’Inghilterra, 159.
Enrico III d’Inghilterra, 105.
Enrico VI di Svevia, 109.
Enrico VII di Lussemburgo, 115, 116.
Epicuro, 27, 64, 65.
Erberto d’Orléans, 106.
Ermete Trimegisto, 134.
Erodoto, 58.
Etienne de Suisy, 162-164.
Euclide, 175.
Eugenio IV papa sive Gabriele Condulmer,
122, 126-129.
Euler W. A., 119.
Eustachio medico, 179.
F
Faivre A., 146.
Fanger C., 146.
Federici Vescovini, G., 120, 146.
Federico di Turinga, 106.
Federico I imperatore, 109.
Federico II imperatore, 95-97, 101, 105, 111,
115, 116, 135, 177, 179, 189.
Federico III d’Aragona, 105-117, 189.
Federico III d’Asburgo, 126.
Federico IV d’Aragona sive Federico III di
Sicilia, 95, 98.
Felice V antipapa, 126.
Ferdinando II d’Aragona, 91, 104.
Ferraguth di Girgenti sive Faraj ben Sālim, 175.
Ferrari F., 61.
Fidora A., 86.
Filippo di Toucy, 111.
Filippo I di Courtenay, 108.
Filippo I di Taranto, 110.
Filippo IV di Francia, 108, 110, 161-163,
165-167, 192.
Filone d’Alessandria, 1-18, 185.
Finke H., 164.
Flasch K., 119.
Flavio Belisario, 48.
Foa A., 103.
Fodale S., 110.
Folco Portinari, 181.
Fornero G., 39.
Frale B., 152, 164, 165, 192.
Francesco d’Assisi, 53.
Fumagalli S., 136.
Funkenstein A., 134.
G
Gaia P., 120, 123, 128.
Galeno, 101, 170, 171, 174-176, 179.
Garin E., 119, 122, 133.
Gentile da Foligno, 180.
Geoffroy de Charny, 161, 162, 164.
Geoffroy de Gonneville, 161, 162, 164.
Geraldo di Frachet, 82.
Gherardo da Cremona sive Gherardo da Sabioneta, 174, 175.
Ghirlanda A., 13.
Giacomo Blindano Fardella, 182.
Giacomo di Sierck, 120.
Giacomo di Vitry, 151.
Giacomo Duboys, 179.
Giacomo I d’Aragona, 106.
Giacomo II d’Aragona, 108-110, 113, 116,
164, 189.
Gianni R., 101.
Giardini G., 6.
Gill J., 122.
Gilson E., 80, 81.
Gioacchino da Fiore, 109, 113.
Giovanni Boccaccio, 180.
198
Giuliana Musotto
Giovanni da Procida, 106, 110.
Giovanni da Toledo, 179.
Giovanni di Castellomata, 177.
Giovanni di Salisbury, 81, 169.
Giovanni di San Remigio, 106.
Giovanni di Siviglia, 175.
Giovanni Gualberto, 53.
Giovanni Paolo II papa, 45.
Giovanni Pico della Mirandola, 131, 133,
136-139, 142, 144, 147, 191.
Giovanni XXII papa, 112.
Girgenti M., 1-18, 57-77, 185, 187.
Girgenti S., 149-159, 191.
Girolamo Staiti Tipa, 182.
Giuliano Cesarini, 122, 127.
Giunta F., 106.
Giustiniano imperatore, 47.
Goffredo di Buglione, 150.
Goitein S. D., 96.
Goitien A., 93.
Grammauta F., 161-167, 191, 192.
Grégoire R., 50.
Gregorio I Magno papa, 48, 49, 56, 87, 91.
Gregorio II papa, 55.
Gregorio Sinaita, 53.
Gregorio VII papa, 53, 55, 75.
Grözinger K. E., 146.
Guglielmo d’Alvernia, 136.
Guglielmo d’Aquitania, 53.
Guglielmo di Nogaret, 161, 162.
Guglielmo di Plaisians, 161-163.
Guglielmo di Saint-Thierry, 84, 85.
Guglielmo di Tiro, 150, 151.
Guglielmo Imbert, 162.
Guglielmo Raimondo Moncada alias Flavio
Mitridate, 142, 144.
Guglielmo VII di Montpellier, 173.
Guidi R. L., 119.
Guido Monaco, 56.
Guy de Montpellier, 181.
H
Hanegraaff W. J., 146.
Hay D., 126.
Hoffmann E. 122.
Hoffmann F., 172.
Hugues de Pèrraud, 161, 162, 164.
I
Ibn Al-Djassar, 176.
Idel M., 134, 146.
Iibn Haqwkal, 91.
Ildegarda di Bingen, 173.
Innocenzo II papa, 173.
Innocenzo III papa, 177, 181.
Innocenzo IV papa, 105, 179.
Ippia di Elide, 58.
Ippocrate, 101, 170-172, 175, 176.
Ireneo di Lione, 21, 24, 29.
Isabella di Castiglia, 91.
Ishaq Al-Israili, 176.
Isidoro di Siviglia, 170.
J
Jacques de Molay, 161-164, 167, 192.
Jean de Bourgogne, 164.
Jean de Gerson, 121.
Jean de Jamville, 165.
Jedin H., 121.
K
Kallen G., 120, 128.
Kieckhefer R., 132, 141, 146.
Klaassen F., 146.
Klibansky R., 122.
Koch I., 122.
Koyrè A., 58, 60.
L
Lagumina B., 94, 96, 104.
Lagumina G., 94, 96, 104.
Lancianese D., 155, 156.
Landi A., 123.
Landolfo Brancacci, 163, 164.
Landrio vescovo, 180.
199
Indice dei nomi
Lattes D., 70.
Laurenti R., 62.
Leibowitz Y., 99.
Leigh R., 151.
Lévinas E., 157.
Liccaro V., 80.
Lincoln H., 151.
Lionti F., 95.
Lowith K., 69.
Lucatelli L., 182.
Luck G., 140.
Lucrezio, Tito Caro, 27.
Ludovico il Bavaro, 115, 116.
Ludovico Pontano, 127.
Luigi IX di Francia, 105, 106.
Luigi VII di Francia, 180.
Luisa di Antiochia, 111.
Lutz Bachmann M., 86.
M
Mabillon J., 56.
Macalufo de Saya, 182.
Macrobio, 87, 88.
Maggioni B., 13.
Maglio G., 57, 61, 62, 65, 66, 69, 75, 77.
Maltese E. V., 58-60.
Mammana G., 33-46, 186.
Mancini S., 119.
Mandonnet P., 82.
Mandosio J. M., 147.
Manetti D., 66.
Manfredi di Sicilia, 101, 105, 106, 109, 114,
189.
Mani, 37.
Marcione, 24.
Marco Aurelio, Antonino Augusto, 65.
Marco Visconti, 112.
Maria d’Ungheria, 110.
Maria di Montpellier, 177.
Markale J., 149, 153.
Marsilio da Padova, 74-77.
Marsilio Ficino, 75, 77, 123, 138.
Martino II di Sicilia sive Martino I d’Aragona, 99, 182.
Martino IV di Sicilia, 108, 112.
Martino V papa, 122.
Maslama Al-Magriti (pseudo), 135.
Matteo Silvatico, 179.
Mauro Abate (san), 55, 56.
McKeon R., 84.
Mercuriade, 179.
Merlo M., 128.
Meroi F., 145, 146.
Metodio vescovo, 53.
Mews C. J., 86.
Michele da Piazza, 180.
Michele Scoto, 189.
Milano A., 93-99, 101.
Mondésert C., 4.
Mondin B., 6, 7.
Mondino de Liuzzi, 179, 180.
Monica (santa), 34, 38, 41.
Montessori M., 35.
Moricca U., 49.
Morselli M., 3.
Mosè da Salerno, 69.
Mosè Maimonide, 70-72, 100, 101, 185, 189.
Musco A., 113.
Musotto G., 192.
N
Nabucodonosor II, 1.
Nardi B., 80.
Nariot di Toucy, 111.
Narsete, 48.
Neusner J., 12, 13.
Niccolò Albergati, 126.
Niccolò Tudeschi, 127.
Nicola Cusano, 119-129, 190.
Nicola di Ockham, 193.
O
Oliveri F., 104.
Omar califfo, 174.
Omero, 170.
Onorato abate, 48.
Onorio I papa, 121.
200
Giuliana Musotto
Onorio III papa, 174.
Onorio IV papa, 179.
Ovadia da Bertinoro, 91.
P
Pacomio abate, 49, 54.
Paparelli G., 122.
Parisoli L., 190.
Partner P., 154, 156, 159.
Pascal B., 65.
Pasquale I papa, 55.
Pasquale II papa, 53, 55.
Pastore F., 146.
Patrizio (padre di Agostino d’Ippona), 34.
Patrizio d’Irlanda, 52.
Pellegrini M., 122.
Pepi L., 3, 5, 7-9, 91-104, 188, 189.
Perani M., 13.
Perotto L., 73.
Perrone Compagni V., 145, 146.
Petrucciani S., 73.
Pietro Abelardo, 56, 83-89, 188.
Pietro d’Irlanda, 72.
Pietro III d’Aragona, 106, 108, 109, 111,
112, 177, 189.
Pietro Ispano sive Giovanni XXI, 179.
Pietro IV d’Aragona, 116.
Pines S., 102.
Pio da Pietralcina, 182.
Pissavino P. C., 147.
Pitagora, 133.
Placido monaco (san), 56.
Platone, 4, 6-8, 25, 38, 39, 58-62, 83, 144,
185.
Porfirio, 101, 133.
Portolan S., 164.
Pouilloux J., 4.
Pricoco S., 49.
Protagora, 58, 59.
Pucci P., 6.
R
Radice R., 4, 5, 57.
Raimondo di Toledo, 175.
Ravasi G., 13.
Raymbaud de Caron, 161, 162, 164.
Reale G., 4, 5, 7, 58, 60, 65.
Rebecca Guarna, 179.
Reiter S., 4.
Remondino da Bologna, 179.
Renda F., 93.
Rhazes, Abu Bakr Mohammad Ibn Zakariya,
174, 175.
Riccardo di Cornovaglia, 105.
Ricoeur P., 12.
Riemen R., 169.
Roberto d’Angiò, 110, 111, 115.
Roberto il Guiscardo, 176.
Rocco B., 103.
Rodrigo Sánchez de Arévalo, 128, 129.
Romanici A. M., 101.
Romualdo (san), 53.
Rosemberg A., 11.
Rossano P., 13.
Rossi P. A., 135.
Roth C., 93.
Ruffino G., 103.
Ruggero da Flor, 114.
Ruggero di Lauria, 106, 108-110, 114.
Ruggero II di Sicilia, 97, 177.
Ruggerone di Lauria, 114.
Runciman S., 150.
S
Saadiah Gaon, 17.
Salomone re, 134.
Salomoni A., 134.
Santinello G., 120, 123.
Santo Stefano (martire), 99.
Savasorda, Abraham bar Hiyya, 175.
Scandaliato A., 96, 98, 100.
Scazzoso P., 88.
Schiffman L. H., 141.
Schiller R., 173.
Scholem G., 10, 11.
Sciacca M. F., 39.
Seneca, Lucio Anneo, 65.
201
Indice dei nomi
Senger I. G., 122.
Serafini F., 189.
Sermoneta G., 101, 103.
Shottmüller C., 165.
Sigeri di Brabante, 82.
Simon P., 88.
Simonetti M., 49.
Simonsohn S., 91-93.
Simplicio abate, 48.
Sirat C., 10, 15, 16, 101.
Smith W. K., 126.
Socrate, 38, 39, 58, 59, 83.
Solomon N., 10.
Spinnato E., 110.
Stanislao Clavica, 182.
Stefani P., 13, 101.
Stefano Harding, 53, 154.
Stefano II di Baviera, 116.
Steiner G., 169.
Stemberger G., 10-12.
Stieber J. W., 123.
Straus R., 96.
Swartz M. D., 141.
T
Taddeo Alderotti sive Alderòtto, 179.
Tamani G., 102.
Teodorico re, 47.
Teodoro Studita, 53.
Teofrasto, 171.
Tertulliano, Quinto Settimio Fiorente, 36.
Testa F., 109, 110, 115, 116.
Thorndike L., 147.
Thurner M., 123, 129.
Tolomeo, 175.
Tommaso d’Aquino, 72-74, 89, 99.
Tommaso di Cantimpré, 82.
Totaro L., 127.
Trachtenberg J., 147.
Trasimaco, 58.
Trasselli C., 93.
Trotula de’ Ruggiero, 179.
U
Ugo de Payns, 150, 151, 153, 158.
Ugo di Champagne, 154, 155, 158, 191.
Ugo di San Vittore, 80-83, 188.
Ulrich von Manderscheid, 120.
Untersteiner M., 58.
Urbano II papa, 53, 55, 149.
Urbano IV papa, 106.
V
Vagetti M., 59.
Van Den Broek R., 146.
Vansteenberghe E., 123.
Vargas Llosa M., 169.
Vasoli C., 75, 122, 147.
Veenstra J. R., 146.
Veit L. M., 122.
Villibrordo (san), 53.
Viti G., 154.
Vittore III papa, 55, 56.
W
Watanabe M., 122, 127.
Webb C., 81.
Weill Parot N., 133, 147.
Wendland P., 4.
Wirszubski C., 147.
Wolfson H. H., 5.
Z
Zagrebelsky G., 74.
Zambelli P., 147.
Zanatta M., 64.
Zenone imperatore, 47.
Zonta M., 15-17, 102.
Zuffi S., 66.
Finito di stampare in Paceco (Tp)
nel mese di Luglio 2011
Litotipografia Abate Michele
di Abate Vincenzo