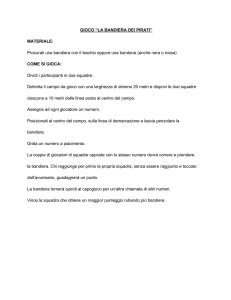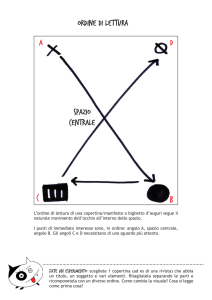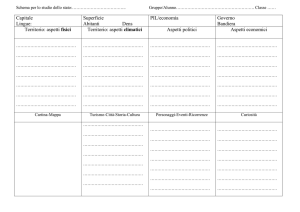Italia
L'anno che fu a cura di
Alessandro Schiavetti
1861. L’anno che fu Italia.
Gli uomini. Le battaglie. Le arti.
Dal 5 febbraio al 27 marzo 2011
Sala esposizioni, Fondazione Geiger
Corso Matteotti 47, Cecina (LI)
Mostra e catalogo a cura di Alessandro Schiavetti
In collaborazione con: Federico Gavazzi e Alessandra Scalvini
Testi in catalogo di:
Federico Gavazzi
Damiano Leonetti
Marco Andrea Piermartini
Massimo Polimeni
Alessandra Scalvini
Alessandro Schiavetti
Michela Sgarallino
Grafica Design e impaginazione: Fabrizio Pezzini
Fotografie: Valentina Ragozzino
Bandecchi & Vivaldi – Editore
ISBN
Catalogo realizzato in occasione della mostra
In copertina: Carrozza appartenuta al Generale G.Garibaldi e utilizzata durante la campagna di Bezzecca
INDICE
Introduzione
I padri della Patria
Giuseppe Mazzini
Giuseppe Garibaldi
Vittorio Emanuele II
Camillo Benso di Cavour
Pag 5
Pag 7
Pag 9
Pag 11
Pag 13
Pag 15
Le guerre per l’Indipendenza
La prima guerra per l’Indipendenza. Battaglia di Curtatone e Montanara
La seconda guerra per l’Indipendenza. Battaglia di San Martino e Solferino
La terza guerra per l’Indipendenza. Battaglia di Bezzecca
Pag 16
Pag 18
Pag 20
Pag 22
La Toscana nel Risorgimento
Eroi e personaggi Livornesi
Eroi e personaggi Cecinesi
La difesa di Livorno del 10-11 maggio 1849.
Pag 24
Pag 26
Pag 28
Pag 30
Le armi nel Risorgimento
Cenni sulle armi da fuoco individuali nel Risorgimento italiano
Pag 32
Pag 33
Le uniformi nel Risorgimento
Cenni sulle uniformi risorgimentali
Pag 37
Pag 38
Emblemi Risorgimentali: la musica
Fratelli d’Italia. Goffredo Mameli e il Canto degli Italiani
Pag 44
Pag 45
Emblemi Risorgimentali: la bandiera
La storia della bandiera italiana
Pag 50
Pag 51
Il Risorgimento delle immagini
Pag 55
Ringraziamenti e riferimenti fotografici
Pag 63
n
3
m
Cartoline collezione Piraino
n
4
m
INTRODUZIONE
E
ra il 1861, e nasceva l’Italia. Centocinquanta anni di storia. Un frammentario paese come il nostro, attraverso sanguinose battaglie e lunghi periodi di guerra, alla fine assumeva i contorni di un coeso sistema unitario. Attraverso
un periodo che rimandiamo a circa trent’anni prima dell’Unità stessa, uomini di eccelso valore politico, generali
coraggiosi e strateghi militari hanno gettato le solide fondamenta che col tempo abbiamo innalzato a Stato unitario, in una
rivoluzione non solo politica, ma anche e soprattutto territoriale, che vedeva in precedenza una suddivisione in principati
indipendenti e in conflitto tra loro.
In un paese nel quale si viveva ancora un tasso di analfabetizzazione altissimo, e dove si alloggiava ancora spesso in capanne
e case prive di ogni umana comodità, si stava radicando lentamente il sentimento popolare di rivolta, quel sentimento ricco di
pathos che mirava all’unico scopo di raggiungere l’unità nazionale, liberando il proprio territorio dagli oppressori.
Furono questi gli anni di Garibaldi, generale coraggioso ormai icona e ispirato da Spartaco il gladiatore romano, mai domo
e sempre pronto a scendere in battaglia per l’Italia e per il suo valore. Furono gli anni del nobile Cavour, il grande uomo politico piemontese, di Vittorio Emanuele II, incoronato nel 1861 come re d’Italia, e di Giuseppe Mazzini, il patriota sempre acclamato dalle folle e tessitore principe di un Italia in incubazione. Furono i momenti nei quali si partiva per lunghe spedizioni,
terminate vuoi con successo, oppure con disfatte; ma si partiva per liberare dall’oppressore le proprie terre, per dare una svolta
a quella che da tempo ormai era una penisola frammentata e priva di identità. Si partiva peraltro per fame, per gloria, per le
guerre d’Indipendenza alla difesa di un ideale di Nazione. Un ideale che spesso, rappresentato anche dai corpi degli alleati o dei
nemici lasciati esanimi sui campi di battaglia, era solo ad uno stato di gestazione e che solo molti anni dopo avrebbe assunto i
contorni tricolore che ci contraddistinguono oggigiorno. Furono anche gli anni delle rivolte popolari, del brigantaggio, di patti
ed alleanze politiche dettate dal bisogno. Ma allo stesso tempo furono gli anni dei nostri volontari, di quei giovani soldati che
lasciarono famiglie, madri in lacrime, mogli e i figli, e che lottarono a costo della loro vita giovane per una bandiera che ancora
oggi è dipinta del loro sangue.
Furono gli anni di un paese che nasceva, e che d’Italia finalmente non aveva più soltanto i contorni geografici, ma bensì
un’intensa e comune, anche se forse ancora intricata, idea di Unità. Il periodo rappresentato però non è stato soltanto caratterizzato dalle guerre per l’indipendenza e dalle battaglie che le hanno contraddistinte. Stiamo parlando anche dei singoli episodi,
quelli che hanno toccato più da vicino la nostra regione Toscana che è stata protagonista indiscussa del periodo in questione;
una Toscana che ha fatto trincea negli scontri di Curtatone e Montanara con i giovani universitari partiti da Pisa, guidati e
comandati dai loro stessi professori, o come l’episodio che ricordiamo nelle due giornate di Livorno del 10 e dell’11 maggio
1849; due date storiche in cui l’intera popolazione della città costiera si è ribellata con tutte le sue forze agli oppressori grazie
anche alla presenza di uomini come Jacopo e Andrea Sgarallino.
Furono gli anni di Goffredo Mameli e del glorioso, trionfale, Inno nazionale, della musica in tutte le sue vesti e sfaccettature, interpretata da maestri sacri come Giuseppe Verdi, che hanno saputo imprimere nelle loro composizioni, erette a pilastri
della musica, le immagini di questi anni. Furono poi gli anni in cui l’emblema nazionale assumeva a cornice un meraviglioso
tricolore verde bianco e rosso che ancora oggi sventola pieno d’orgoglio.
La Fondazione Hermann Geiger con “1861. L’anno che fu Italia” mette in scena un percorso di ricordo, riallacciandosi
ai festeggiamenti nazionali per il centocinquantenario dell’Unità d’Italia, che mira prevalentemente alla riscoperta attraverso
immagini e testi, di un periodo storicamente fondamentale per il nostro paese. Questo percorso, arricchito dalle numerose
testimonianze dell’epoca rappresentate da armi da fuoco e da armi bianche, da uniformi e divise, da documenti e manoscritti e
da cimeli appartenuti direttamente sia ai padri della patria che ai nostri volontari, mira a riportare proprio attraverso il ricordo,
ognuno di noi tra i colori e tra una musica di una storia passata, ma mai dimenticata. Il tutto attraversando l’immagine di una
bandiera dalle tonalità mai sbiadite, facendo sì che l’iniziativa abbia come motore trainante la morale collettiva. Quella morale
che contraddistingue il fiero popolo italiano, che ha portato i valorosi soldati dell’epoca, i grandi statisti, i condottieri più indomiti, ma anche i più deboli nuclei familiari a realizzare il sogno più grande di un territorio come il nostro: l’essere liberi, e
finalmente uniti.
Alessandro Schiavetti
n
5
m
Spada e copricapo appartenenti al generale Giuseppe Garibaldi
n
7
m
8
GIUSEPPE MAZZINI
G
iuseppe Mazzini nasce a Genova il 22 giugno del 1805, è figlio di Giacomo Mazzini medico e professore universitario,
e di Maria Drago; una famiglia che trasmette al giovane Giuseppe fin da subito l’amore per la cultura. A soli 15 anni
si iscrive alla facoltà di medicina per poi passare agli studi di giurisprudenza. Si interessa da subito alla politica e alla
letteratura, ed entra a far parte molto presto della Carboneria per la quale svolse compiti in Liguria e in Toscana. Nel 1829
collabora con “L’indicatore Livornese”, un giornale letterario con sfondo politico. Nel 1830 viene arrestato proprio per l’annessione alla Carboneria, ma viene rilasciato poco dopo. Sceglie la via dell’esilio prima in Svizzera poi in Francia; a Marsiglia nel
1831 fonda la Giovine Italia (Giovine per indirizzarla ai giovani e alla loro voglia di rivolta, Italia per il suo spropositato amore
per la patria), organizzazione che mirava a portare in Italia un sistema democratico con principi di libertà e di unità (nel 1859
in un comunicato a Vittorio Emanuele II re d’Italia lo stesso Mazzini scrive “Io amo più del mio partito la mia patria”).
Mazzini cerca di gettare, con la Giovine Italia, la base delle sue azioni proprio sul popolo attraverso il suo ideale: democrazia, nazione e religiosità, con questa intesa come Dio di verità e giustizia che si manifesta attraverso il popolo. Fonda nel
1834 anche la Giovine Europa, al fine di riconoscersi in un’Europa liberata e costituita da popoli uniti. Padre della coscienza
popolare, e della coscienza per la patria, raccoglie moltissime adesioni in Piemonte, Toscana e Sicilia. La repressione dell’impaurito governo sabaudo però fu pesante; ventisette condanne a morte, processi e numerosi esili. Nonostante il senso di colpa
Mazzini prova ancora a fomentare le rivolte in Italia, ma il 28 maggio del 1834 viene arrestato e poco dopo esiliato. Raggiunge
impoverito l’Inghilterra nel 1837 e si stabilisce a Londra; tenta numerose volte di rianimare i moti in Italia, ma evidentemente
la popolazione non è ancora pronta alle sue idee. A Milano fonda il quotidiano “l’ Italia del popolo”. Il 9 marzo del 1849 Goffredo Mameli gli telegrafa “Roma Repubblica, venite!”. Nominato poi triumviro, l’esperienza ha però breve durata, in quanto altri
furono gli insuccessi. Nel 1857 torna a Genova accolto in trionfo per preparare con Carlo Pisacane l’insurrezione genovese
e poco dopo viene condannato a morte in contumacia. Dopo il ritorno a Londra vorrebbe partecipare all’impresa dei Mille
di Garibaldi, dato che del generale segue ogni azione e missione. Dopo un altro arresto e un nuovo esilio, giunge nel 1872 in
incognito a Pisa, dove muore il 10 marzo.
n
9
m
10
GIUSEPPE GARIBALDI
I
l generale Giuseppe Garibaldi nasce a Nizza il 4 luglio 1807; è figlio del genovese Domenico Garibaldi che gli ispira il culto
della Libertà mentre sua madre gli trasmetterà l’ideale dell’Italia temporaneamente suddivisa in frammentari principati da
riunire. Conosce Mazzini nel 1833 a Marsiglia. Partecipa al sollevamento dei Carbonari nel 1834, ed è condannato a morte.
Riesce comunque a fuggire e poco dopo raggiunge nuovamente Marsiglia. Ripreso il mare per andare sostenere la sommossa
del Rio Grande do Sul in Brasile, diviene capo delle truppe rivoluzionarie; qui conosce Anita Riveiro che sposerà nel 1842 e che
gli darà quattro figli, Menotti, Rosita, Teresita e Ricciotti. Partecipa alla sommossa dell’Uruguay contro il dittatore argentino
Rosas e crea la Legione Garibaldina. Diviene poi comandante in capo della Marina Uruguayana vivendo in totale ben 12 anni
in Sudamerica. La vittoria di San Antonio del 1846 è salutata con entusiasmo dagli Inglesi e dai Francesi. Ancora più famoso,
la sua figura diviene un icona, un immagine, un mito.
Nel 1848 lascia Montevideo e torna in Italia. Viene impegnato nella guerra contro l’Austria, ma la sconfitta di Novara lo
costringe a ripiegare in Svizzera. Raggiunge Roma dove la Repubblica è stata proclamata l’8 febbraio 1848. Assediato dagli
Austriaci e dai Francesi, è obbligato alla ritirata attraverso l’Appennino trovando rifugio a San Marino. Anita, che lo accompagna, conoscerà una morte drammatica e romantica nella foresta di Ravenna. Esiliato in America fino al 1859, Garibaldi verrà
nominato generale dell’esercito sardo avendo concessione da parte di Cavour dell’organizzazione dell’esercito stesso. Prenderà
parte attiva alle Guerre d’Independenza. Nel 1860 conduce la famosa e storicamente emblematica Spedizione dei Mille che
libera il Regno delle due Sicilie, quindi combatte su diversi fronti austriaci; nella III guerra d’indipendenza ha il comando del
Corpo dei volontari; il suo campo d’azione è la zona tra Verona e il Tirolo.
A Custoza, Garibaldi è costretto a ritirarsi, malgrado la sua vittoria di Monte Suello e di Bezzecca. Famoso il telegramma:
“Obbedisco” inviato al comando supremo del generale La Marmora. Nel 1871, accorre all’appello di Gambetta, con un corpo
di garibaldini, e si porta a Digione a soccorrere i francesi vinti dai prussiani. Si ritira a Caprera dove morirà il 2 giugno1882.
n 11 m
Fotografia Collezione fratelli Alinari
12
VITTORIO EMANUELE II
V
ittorio Emanuele II nasce il 14 marzo 1820 da Carlo Alberto di Savoia principe di Carignano e da Maria Teresa
di Lorena. Il suo nome completo è Vittorio Emanuele Maria Alberto Eugenio Ferdinando Tommaso di Savoia.
Amante della caccia, e delle escursioni di montagna, lascia poco spazio agli studi. Eclettico e sanguigno, il giovane
Vittorio Emanuele divenuto generale, sposa sua cugina Maria Adelaide d’Asburgo nel 1842. Il padre Carlo Alberto dopo aver
dichiarato guerra all’Austria e aver perso in maniera netta la prima guerra d’Indipendenza, davanti ai suoi figli e al generale La
Marmora firmò l’abdicazione e andò in esilio in Portogallo. La prima azione da sovrano di Vittorio Emanuele fu trattare la
resa col colonnello austriaco Radetzky, resa che prevedeva numerose concessioni agli austriaci, come la roccaforte di Mantova
e zone tra il Pò e il Ticino, oltre che a 75 milioni di franchi francesi. Il 15 luglio del 1849 promulga il Proclama di Moncalieri,
nel quale si invita il popolo a scegliere per il Parlamento i rappresentanti che siano coscienti della reale situazione dello stato.
Col nuovo Parlamento, il 9 gennaio 1850 fu stipulato il trattato di pace con l’Austria. Per manifestare all’Europa il problema
dell’Italia, Cavour, divenuto Primo Ministro, spinse all’interesse verso la Guerra di Crimea del 1853, alla fine vittoriosa, che
riabilitò l’esercito sardo.
Il clima di tensione che si stava generando tra l’Austria e l’Italia aumentava e rendeva ancor più in bilico l’Europa. Dopo
l’accordo di Plombières, il 10 gennaio 1859 il re, aprì il parlamento col discorso passato alla storia come il Grido di Dolore:
Andiamo risoluti incontro alle eventualità dell’avvenire. Quest’avvenire sarà felice, riposando la nostra politica sulla giustizia, sull’amore della
“Andiamo
libertà e della patria. Il nostro paese, piccolo per territorio, acquistò credito nei consigli d’Europa perchè grande per le idee che rappresenta, per le
simpatie che esso ispira. Questa condizione non è scevra di pericoli, giacché nel mentre rispettiamo i trattati, non siamo insensibili al grido di dolore
che da tante parti d’Italia si leva verso di noi. Forti per la concordia, fidenti nel nostro buon diritto, aspettiamo prudenti e decisi i decreti della divina
provvidenza.... “. Poco dopo, al comando dell’esercito, radunò 65.000 uomini e fu guerra all’Austria. Garibaldi poi, alla volta della Sicilia e al
grido di “Italia e Vittorio Emanuele”, oppose guerra al sud. Lo stesso re poi, invase lo Stato Pontificio. A Teano il 20 ottobre del 1860 incontra il
generale Garibaldi, che ne riconosce l’autorità sul regno delle Due Sicilie. Il 17 marzo 1861 il Parlamento proclamò la nascita dell’Italia. Vittorio
Emanuele assunse il titolo ufficiale di Re d’Italia. Nel 1866 volse alla conquista dei territori mancanti. Annessa Venezia, nel 1870 fu la volta di
Roma. La caccia, amore mai trascurato, gli fu fatale. Il 5 gennaio del 1877 dopo una battuta notturna il re si ammalò ai polmoni. Il 9 gennaio il
Padre della Patria, trovò la morte.
n 13 m
Fotografia Collezione fratelli Alinari
14
CAMILLO BENSO DI CAVOUR
C
amillo Benso nobile dei marchesi di Cavour nasce a Torino il 10 agosto 1810 da Michele Benso di Cavour collaboratore
del Governatore, e da Adele de Sellon, di ricca famiglia svizzera. Il Conte di Cavour (Conte è un titolo di cortesia, alla
francese), prima è ufficiale dell’esercito, poi inizia a viaggiare in Europa apprendendo i principi della politica e dell’economia. Le sue attività bancarie lo portarono presto a diventare uno degli uomini più ricchi del Piemonte. Teorizzò da subito
la necessità di una profonda ristrutturazione politica, per garantire a tutti vantaggi economici e sociali. Nel 1850 fu nominato
ministro dell’agricoltura dal gabinetto D’Azeglio. Il 4 novembre 1852 diviene Presidente del Consiglio (il primo governo di Cavour
fu quello degli anni 1852-1855). Il suo obiettivo era quello di rendere il Piemonte uno stato costituzionale, liberista e progressivo, dedicandosi quindi ad un globale ridimensionamento dell’economia (potenziamento fabbriche, esaltazione delle linee
ferroviarie, aumento dell’importanza delle banche e dell’agricoltura). La sua fu una politica estera molto audace; inizialmente
non si volle distaccare dal vecchio programma di Carlo Alberto che voleva eliminare l’Austria dal Lombardo-Veneto, ma poi
capì che poteva allargare la propria politica a livello nazionale e aderì all’ideale mazziniano di Unità. Nel suo secondo governo
(1855-1859) grazie alla guerra di Crimea (che però lo vide scontrarsi con Mazzini, il quale non voleva l’intervento italiano nella
guerra) riuscì a portare il problema italiano in Europa nel 1856.
Incontrato Napoleone III di Francia a Plombières il 21 luglio del 1858, Cavour gettò le basi dell’alleanza antiaustriaca.
Il trattato sanciva l’aiuto della Francia a fianco del Piemonte solo se l’Austria avesse aggredito. In caso di vittoria, l’Italia
sarebbe stata formata da quattro stati confederati sotto la presidenza del Papa ma di fatto controllata dal Piemonte. Cavour
avrebbe ceduto alla Francia il Ducato di Savoia e la Contea di Nizza. La seconda guerra d’Indipendenza portò all’annessione
della Lombardia, ma nei francesi nasceva il timore per l’esercito prussiano e per uno stato italiano in preoccupante crescita;
fu per questo che firmarono un armistizio con l’Austria a Villafranca l’11 luglio 1859. Cavour, deluso, vedendo i suoi ideali
crollati dopo numerose discussioni con Napoleone III e con Vittorio Emanuele, decise di dare le dimissioni da Presidente
del Consiglio. Nel terzo governo Cavour (1860-1861) furono annesse al Piemonte, Parma, Modena e Romagna, oltre che alla
Toscana col referendum del 12 marzo 1860. Il Conte seguì preoccupato la spedizione dei Mille di Garibaldi (con il quale non
ebbe mai un buon rapporto), tentando di controllarlo il più possibile. Sventò poi altre operazioni guerrafondaie, perchè il
Conte voleva che l’Unità derivasse da tutto tranne che da azioni scellerate e da moti improvvisati. Il 29 maggio del 1861, poco
dopo la proclamazione dell’Unità, Cavour ebbe un malore, e dopo di aver chiesto di morire “da buon cristiano”, spirò il 6 di
giugno. Fu un uomo di stato, per uno stato che ancora non c’era.
n 15 m
n 16 m
FOTO A TUTTA PAGINA INSIEME ALLA PAG DOPO CON TITOLATuRA “LE GUERRE PER L’INDIPENDENZA” scritto sopra la foto che si deve vedere e non vedere, trasparente o effetto simile.
FOTO A TUTTA PAGINA INSIEME ALLA PAG PRIMA CON TITOLATuRA “LE GUERRE PER L’INDIPENDENZA” scritto sopra la foto che si deve vedere e non vedere, trasparente o effetto simile.
n 17 m
LA PRIMA GUERRA PER L’INDIPENDENZA
L
a Prima Guerra di Indipendenza italiana si inserisce nell’insieme di rivoluzioni che nel 1848 scossero l’Europa intera. I
moti hanno inizio in Sicilia ma è lo scoppio della rivoluzione a Vienna che fa precipitare gli eventi: il 17-18 marzo insorgono Venezia, dove i patrioti Manin e Tommaseo sono liberati e posti a capo del governo repubblicano, e Milano, che
dopo “cinque giornate” di combattimenti costringe il feldmaresciallo Radetsky a lasciare la città. Il 23 marzo, Carlo Alberto di
Savoia, re di Sardegna dichiara guerra all’Impero Austriaco. Il Granducato di Toscana, il Regno di Napoli e lo Stato Pontificio,
che si erano dati governi liberali, su pressione dell’opinione pubblica, sostengono l’iniziativa.
Inizialmente la guerra volge a tutto vantaggio di Carlo Alberto. Il re di Sardegna entra in una Milano già libera e prosegue
la sua avanzata verso il Mincio, che oltrepassa a Goito e Monzambano. Il nemico si rifugia nelle fortezze del Quadrilatero
(Peschiera, Mantova, Verona e Legnago) e riorganizza la difesa, in attesa dei rinforzi dall’Austria. Il 13 aprile comincia l’assedio
di Peschiera. L’esercito sabaudo prosegue verso nordest ed ottiene un’altra vittoria a Pastrengo (30 aprile), grazie alla carica dei
Carabinieri a cavallo. A questo punto la situazione politica cambia: il voltafaccia di Pio IX (29 aprile), che non voleva sostenere
una guerra contro la “cattolicissima” Austria e la preoccupazione di Ferdinando II di Borbone di fronte ad una possibile egemonia sabauda in Italia spingono i due governanti a ritirare le loro truppe. Rimangono alcune divisioni ed i volontari accorsi
da tutta Italia.
La battaglia di Curtatone e Montanara
Mentre i piemontesi continuano l’assedio di Peschiera, gli austriaci muovono dalla fortezza di Mantova e puntano verso Goito
per prendere l’esercito sabaudo alle spalle. La strada era presidiata dal Corpo di Spedizione Toscano ai comandi di Ettore De
Laugier, di stanza in località Le Grazie e composto da reparti regolari e da 450 volontari (studenti di Livorno, Pisa e Siena); a
questi si aggiungevano due battaglioni di volontari e regolari napoletani, per un totale di 6000 fanti e 11 cannoni.
Il 29 maggio 1848 gli Austriaci attaccano in forze. De Laugier divide le sue truppe tra Curtatone (2500 uomini) e Montanara (2500 uomini). Gli Austriaci puntano su Curtatone con 8500 soldati e 24 cannoni e su Montanara con 8000 soldati e
22 cannoni, mentre una brigata di altri 5000 soldati viene fatta scendere fino a San Silvestro per tentare l’accerchiamento a
Montanara. La battaglia comincia con l’assedio di Curtatone: gli austriaci della brigata Benedek tentano due assalti ma sono
respinti; i due soli cannoni italiani riescono a fermare molti pezzi d’artiglieria. La disparità delle forze in campo è enorme ma
nonostante questo si continua a combattere tutta la giornata, fino a che gli italiani sono costretti a ripiegare su Goito. A Montanara invece, riesce l’accerchiamento austriaco e molti volontari cadono prigionieri. Le perdite del corpo di spedizione toscano
sono notevoli: 168 morti, 500 feriti, 1200 tra dispersi e prigionieri.
La resistenza aveva permesso di guadagnare il tempo necessario perché l’esercito piemontese riorganizzasse la difesa su
Goito e il giorno seguente sconfiggesse Radetzky. Se in termini numerici non si può dire che quella di Curtatone e Montanara
sia stata una delle battaglie più importanti della campagna del ‘48 è vero però che questo scontro assunse un significato simbolico dal momento che pochi volontari italiani, studenti che avevano ricevuto un addestramento a dir poco approssimativo e
armi scadenti, riuscirono a tenere testa ad un esercito organizzatissimo e ben comandato.
n 18 m
Volontario toscano dei
battaglioni universitari
Granatiere piemontese
L’epilogo
Il sacrificio di Curtatone e Montanara e la successiva vittoria a Goito furono episodi inutili dal punto di vista militare,
perché non prontamente sfruttata da Carlo Alberto, che quel giorno stesso si impossessa anche di Peschiera e viene acclamato dalle sue truppe come “Re d’Italia”. Arrivano infatti altri rinforzi dal Tirolo che permettono a Radetzky di passare alla
controffensiva, di rioccupare Vicenza e di sconfiggere l’esercito piemontese a Custoza (25 luglio). Ritiratosi su Milano, Carlo
Alberto subisce qui una seconda sconfitta che lo induce a firmare l’armistizio di Salasco (dal nome del generale firmatario). A
Milano, che pochi giorni prima aveva votato con un plebiscito l’annessione al Regno di Sardegna, tornano gli Austriaci, mentre
Venezia continua a combattere. Di fronte a tensioni crescenti, il Papa decide di lasciare Roma e di rifugiarsi presso Gaeta, sotto
la protezione di Ferdinando II e dell’Austria. In Toscana, Leopoldo II fu costretto a lasciare Firenze (30 gennaio 1849), dove i
democratici diedero vita a un governo provvisorio guidato dal triumvirato Montanelli, Guerrazzi e Mazzoni. Il 9 febbraio 1849
a Roma fu proclamata la Repubblica, del cui governo faceva parte Mazzini. Il 12 marzo Carlo Alberto rompe l’armistizio con
l’Austria, ma l’immediata sconfitta di Novara (23 marzo) induce il re a chiedere un nuovo armistizio e ad abdicare a favore del
figlio Vittorio Emanuele II. Gli Austriaci entrano anche in Toscana e vinti alcuni nuclei di resistenza (come a Livorno il 10-11
maggio) riportano sul trono Leopoldo II (25 maggio). A Roma intervengono i Francesi ma incontrano la strenua resistenza
dei repubblicani comandati da Garibaldi: solo in luglio entrarono in città. Venezia cade il 22 agosto.
n 19 m
LA SECONDA GUERRA PER L’INDIPENDENZA
L’
azione diplomatica di Cavour tessuta nel corso degli anni aveva portato gli accordi segreti di Plombières del 1858,
con i quali Napoleone III si impegnava ad intervenire a fianco del Regno di Sardegna nell’eventualità di un attacco
austriaco. Per l’aiuto, nel caso di annessione al Piemonte del Lombardo-Veneto, ci sarebbe stata la cessione della
Savoia e di Nizza alla Francia.
Il Regno di Sardegna comincia una massiccia mobilitazione di truppe al confine, con reclutamento di migliaia di volontari.
L’Austria lancia l’ultimatum il 24 aprile 1859 e, per anticipare l’arrivo dei Francesi, il maresciallo Gyulai invade il Piemonte, ma
viene fermato a Montebello (20 maggio). I Piemontesi occupano Palestro mentre i Cacciatori delle Alpi, volontari agli ordini
di Giuseppe Garibaldi liberano Varese e Como. Dopo la Battaglia di Magenta (4 giugno) e l’ingresso trionfale a Milano (8 giugno) gli eserciti di Vittorio Emanuele II e di Napoleone III proseguono la loro avanzata. Convinti che gli Austriaci si stessero
organizzando dietro il Mincio, il 23 giugno, Napoleone III e Vittorio Emanuele II decidono di puntare verso est. Contemporaneamente Francesco Giuseppe, che aveva rilevato il comando dell’esercito dopo la destituzione di Gyulai, criticato perchè
attendista, decide di accelerare i tempi di una controffensiva.
La battaglia di San Martino e Solferino
Francesco Giuseppe ordina al suo esercito di riattraversare il Mincio: la II Armata ha lo scopo di tenere inchiodato il nemico, mentre la I Armata punta verso sud, su Medole, per incontrarsi con la cavalleria proveniente da Mantova. Il 24 giugno le
quattro divisioni Piemontesi agli ordini diretti di Vittorio Emanuele II, si dirigono su Pozzolengo mentre il I Corpo d’Armata
francese con la Guardia imperiale di Napoleone III, muove verso Solferino. Il II° avanza ai piedi di Solferino, il III e il IV su
Medole. Gli Italiani impegnarono 34.000 uomini con 94 cannoni, mentre gli Austriaci disponevano di 32.000 soldati e 56 pezzi.
A Solferino i Francesi schieravano circa 100.000 uomini e 250 pezzi di artiglieria, contro i 95.000 Austriaci, che disponevano
di circa 350 pezzi.
Napoleone III capisce che la collina di Solferino è la chiave di volta della difesa austriaca. Questa respinge gli attacchi,
per poco. Alle 14, San Martino viene presa. Il grosso dell’armata austriaca non poteva intervenire perché impegnato altrove
mentre a San Martino dove si continua a combattere, un migliaio di uomini della 5° divisione Cucchiari agli ordini del tenentecolonnello Cadorna provano a risalire la collina ma vengono attaccati dagli austriaci. Gli austriaci tentano l’accerchiamento,
ma il comando italiano, decide di far intervenire la riserva bloccandoli. Nel pomeriggio, il Re incita gli assalti alla collina che
procedono con scarsa coordinazione. Alle 19, l’attacco finale: 12.000 piemontesi avanzano contro i 18.000 austriaci rimasti.
L’artiglieria italiana riesce a sfondare il fianco nemico sulla sinistra sul quale si avventano i cavalleggeri del capitano Avogadro
e due brigate appena sopraggiunte. Alle 20 il colle è conquistato e gli austriaci si ritirano oltre il Mincio.
n 20 m
Capitano di fanteria
piemontese
Fante piemontese
VERONA
VILLAFRANCA
Fante francese
L’epilogo
Si contarono 7.670 morti, 19.400 feriti e 10.870 tra prigionieri e dispersi. La battaglia passò alla storia perché qui nacque la
Croce Rossa: Henry Dunant, filantropo svizzero, poi Nobel per la Pace, sconvolto dalle condizioni di caduti e feriti, decise di
fondare il Comitato ginevrino di soccorso dei militari feriti, poi Comitato Internazionale della Croce Rossa.
Intanto, Garibaldi, al comando dei Cacciatori della Alpi, aveva liberato anche Bergamo e Brescia. Le sorti della guerra
sembravano segnate a favore dei Franco-Piemontesi ma, inaspettatamente, l’11 luglio Napoleone III si accorda con Francesco
Giuseppe (armistizio di Villafranca): la successiva pace di Zurigo, riconosce l’annessione della Lombardia al Regno di Sardegna
mentre lascia il Veneto in mano austriaca. Contemporaneamente una serie di sollevazioni aveva portato alla cacciata dei governanti dai ducati di Parma, Modena, dal Granducato di Toscana e dalle Legazioni pontificie. Gli accordi di Plombières erano
saltati, ma né Francia né Austria potevano più opporsi a questo processo. Nella primavera del 1860 attraverso vari plebisciti si
riconoscono le annessioni al Regno di Sardegna e il passaggio di Nizza e Savoia alla Francia.
La situazione sembra stabilizzata, ma a questo punto i tempi sono maturi anche per una spedizione in forze nell’Italia
Meridionale che metta fine al regno dei Borboni. Il 5 maggio del 1860 Garibaldi e un migliaio di volontari partono da Quarto.
n 21 m
LA TERZA GUERRA PER L’INDIPENDENZA
A
ndata a buon fine la Spedizione dei Mille, il 17 marzo 1861 Vittorio Emanuele II è proclamato Re d’Italia. Al completamento effettivo dell’unificazione nazionale mancavano ancora Roma e il Lazio, sotto controllo del Papa, mentre
Veneto, Trento e Trieste erano ancora in mano austriaca.
L’occasione per completare l’unificazione a Nordest si presenta nel giugno del 1866 quando scoppia la guerra austroprussiana. L’Italia, grazie alla mediazione francese, si era alleata con la Prussia di Otto von Bismarck e il 23 giugno entra in
quella che per noi è stata la Terza Guerra d’Indipendenza. Il grosso dell’esercito italiano viene impiegato nel Veneto agli ordini
dei generali La Marmora e Cialdini che però agiscono in maniera indipendente e poco coordinata: le truppe agli ordini di La
Marmora e del Re, numericamente più forti, attraversano il Mincio con l’obiettivo di attaccare le fortezze del Quadrilatero;
Cialdini invece, supera il Po e muove a sud, per puntare verso Venezia e Padova.
A Giuseppe Garibaldi viene affidato il comando del Corpo Volontari Italiani, i Cacciatori delle Alpi, che avrebbero dovuto
operare lungo il confine tra la Lombardia e la Contea Principesca del Tirolo. La più agevole via d’accesso verso Trento per le
artiglierie era rappresentata dalle strade lungo il lago d’Idro e il corso del Chiese attraverso le valli Giudicarie.
La battaglia di Bezzecca
I volontari italiani avevano conquistato posizioni sul monte Suello (negli scontri Garibaldi rimase ferito ad una gamba e
da quel momento è costretto a muoversi in carrozza) ed i paesi della valle del Chiese; qui il generale austriaco Kuhn sferra
un’offensiva coordinata su Condino (dove occupano il castello, ma dove incontrano un’ottima difesa garibaldina), e nella val
di Ledro su Bezzecca, per colpire l’esercito italiano ad est il 21 luglio. Ad est gli austriaci fanno prima 600 prigionieri, poi
riescono ad occupare Bezzecca costringendo il 5° reggimento bersaglieri a ripiegare. Proprio in questo momento giunge Garibaldi, costretto in carrozza, con il 9° Reggimento comandato dal figlio Menotti e decide la pronta riconquista di Bezzecca.
Comanda al figlio di guidare il 9º Reggimento verso la destra del nemico, al colonnello Spinazzi di prenderlo alle spalle, e
dispone il 7º Reggimento e i resti del 5° e dei Bersaglieri sul centro. Ma gli austriaci avevano fortificato le posizioni e installato
svariati cannoni sulle alture retrostanti Bezzecca, riuscendo a fermare questo assalto. Il fuoco dei cannoni austriaci colpisce
anche la carrozza di Garibaldi che uscito incolume dall’esplosione, ordina di occupare le alture attorno all’abitato preparando
l’artiglieria. Questo bombardamento crea crisi nello schieramento nemico e costringe gli austriaci impegnati presso la pieve di
Santa Lucia a ripiegare.
Riordinate le truppe e di fronte ad un nemico provato, Garibaldi ordina l’attacco alla baionetta sul centro abitato, che
costringe gli austriaci alla fuga. Da parte austriaca i caduti furono 25, con 82 feriti, mentre tra gli italiani si contarono circa
100 morti, 250 feriti e più di 1100 prigionieri. Tuttavia fu una notevole vittoria per i Cacciatori delle Alpi che a questo punto
controllavano saldamente tutta la val di Ledro e la val di Chiese.
n 22 m
Bersagliere
Ufficiale del corpo
volontari italiani
L’epilogo
Nonostante i successi di Garibaldi in Trentino, la condotta delle operazioni militari in Veneto fu disastrosa: alla sconfitta di
Custoza del 20 giugno, (peraltro pesante solo sotto il profilo psicologico), non segue nessuna controffensiva degna di nota. La
clamorosa sconfitta navale a Lissa del 20 luglio, il giorno prima di Bezzecca, induce l’Italia a sospendere le operazioni militari.
Intanto però il governo Prussiano era già arrivato ad accordi di pace con l’Austria: dopo l’impressionante vittoria a Sadowa
che aveva palesato l’assoluta superiorità militare dell’esercito di Bismarck, Francesco Giuseppe acconsente a tutte le richieste
dello statista tedesco.
L’8 agosto il governo italiano ordina a Garibaldi di ritirarsi dal Trentino. Il generale, a malincuore, risponde proprio dalla
piazza di Bezzecca con il celebre telegramma: “Ho ricevuto il dispaccio n° 1.073. Obbedisco.” L’armistizio viene firmato il 12
agosto a Cormons, vicino Gorizia. L’Italia si annette il Veneto, ma restano in mano austriaca il Trentino e il Friuli Venezia Giulia.
Solo quattro anni più tardi, il 1870, Roma viene presa, ma per annettere Trento e Trieste si dovrà attendere ancora fino
alla fine della Prima Guerra Mondiale.
n 23 m
n 24 m
n 25 m
LIVORNO
di Michela Sgarallino
Andrea Sgarallino
Nasce a Livorno il 28 ottobre 1819. Si iscrive alla Giovine Italia nel 1835. Nel 1848 prende parte alla Campagna di Lombardia
con i Volontari Toscani. A Montanara salva la Bandiera del Battaglione e viene decorato con la medaglia d’argento al Valor
Militare. Nel 1849 è ai confini toscani come Capitano nel Battaglione Volontari “Giovanni delle Bande Nere”. Il 10 e 11
maggio dello stesso anno prende parte alla difesa di Livorno dall’occupazione austriaca al comando dei Bersaglieri della
Morte. Emigra poi in America dopo l’entrata degli austriaci in città per poi tornare nel 1859. Durante l’esilio nel 1853 viene
implicato nel processo Guerrazzi e condannato in contumacia a 15 anni di lavori forzati per lesa maestà. Appena rientrato
in patria nel 1859 è in Romagna con i Volontari comandati dal Generale Garibaldi. Coopera alla Spedizione dei Mille sbarcando con i suoi volontari a Talamone per ordine di Garibaldi e, dopo il combattimento delle Grotte di S. Stefano con le
truppe Pontificie, viene arrestato per ordine del Governo Provvisorio Toscano e condotto prima alla Fortezza da Basso
di Firenze e poi nel carcere dei Domenicani di Livorno da cui fugge per raggiungere Garibaldi in Sicilia. Il 2 ottobre è
gravemente ferito alla gamba destra e decorato con la Medaglia d’Argento al Valor Militare. Nel 1866, durante la Terza
Guerra d’indipendenza, assume il comando prima della Cannoniera Frassinetto, poi per un certo periodo di tutta la
flottiglia sul Lago di Garda e infine il comando della Torrione. Muore a Livorno il 6 marzo 1887.
Jacopo Sgarallino
Nasce a Livorno il 9 giugno 1823. Nel 1849 è ai confini toscani nel Battaglione Volontari Livornesi “Giovanni
delle Bande Nere”. Il 10 e 11 maggio dello stesso anno prende parte alla difesa di Livorno dall’occupazione austriaca.
Emigra a Costantinopoli dopo l’entrata degli austriaci in città, e combatte nel 1854/55 in Crimea. Rientra in Italia nel
1859 in Romagna con i volontari comandati da Garibaldi. Nel 1860 parte da Livorno con altri 37 volontari sul piroscafo Etruria. A Quarto è imbarcato sul Lombardo sotto il comando di Nino Bixio. Gli viene conferita la Medaglia
d’Argento al Valor Militare. Nel 1862 è in Aspromonte mentre nel 1864 porta le armi agli insorti in Polonia. Nel
1866 è al comando della cannoniera “Castenedolo” sul lago di Garda. Nel 1867 è prima in Grecia con i Volontari
comandati da Ricciotti Garibaldi mentre poco dopo è al comando di un gruppo di volontari (la cosiddetta “Banda
del Naufragio”) nell’Agro Romano. Combatte a Farnese, Viterbo e Mentana. Nel 1876-1877 comanda una Legione di Volontari Italiani in Erzegovina, Montenegro e Serbia. Muore a Livorno il 26 dicembre 1879.
L’epigrafe di Jacopo Sgarallino è stata scritta dallo stesso Garibaldi:
“Jacopo Sgarallino – fu Maggiore dei Mille – illustrò la nobile schiera –
su tutti i campi di battaglia – 1 gennajo 1881”
Anello appartenuto ad Andrea Sgarallino con incastonata
piccola parte dell’osso di Giuseppe Garibaldi, dopo il
ferimento in Aspromonte
n 26 m
Giacca e copricapo appartenuti al capitano
Andrea Sgarallino eroe e patriota Livornese
27
CECINA
G
Giuseppe Pesciatini
iuseppe Pesciatini nasce a Cecina il 27 giugno del 1846. Si arruola volontario non ancora ventenne, insieme a
due fratelli Alcide e Simplicio Pesciatini. Prese parte alla campagna del 1866-1867 agli ordini del colonnello
Baldini. Ha combattuto anche nell’Agro romano distinguendosi con egregio valore nei fatti di Montalto
e di Monterotondo.
Fu aggregato nel 59° reggimento e prese parte alle azioni repressive del brigantaggio in Sicilia; dopo la presa
di Roma rimase in servizio fino al 1871. Muore a Mestre nel 1937.
Gaetano Giovannoni
Nato a Cecina, fu un valoroso garibaldino dei “Cacciatori della Alpi” che seguì in prima persona il generale Garibaldi nelle sue imprese. Di lui si ha notizia che fu ferito durante il combattimento di Varese del 25
maggio del 1859, durante il quale il Generale Garibaldi tentò di fermare gli austriaci provenienti da Como.
La maggior testimonianza resta intatta nella lettera autografa che lo stesso Garibaldi scrisse l’11 Dicembre del 1883 che testualmente riporta:
Pino 11 Dicembre 1883
Certifico che Giovannoni Gaetano, che milita nei Cacciatori delle Alpi, è stato ferito sul naso nel
Combattimento di Malnate in mia presenza e che si è comportato da valoroso. G. Garibaldi
Savino Matteoni
Nato a Cecina nel 1836, fu volontario nelle truppe del Generale Garibaldi. Non si hanno notizie
certe e contestualizzate. Si sa però dalle parole dell’ex-sindaco Lelio Trafeli nato a Cecina nel 1901, che
Matteoni, in età avanzata e quasi cieco, amava trascorrere parte delle sue giornate a raccontare ai giovani,
episodi di battaglia e delle campagne alle quali aveva partecipato proprio sotto il comando del Generale
Garibaldi. Muore a Cecina nel 1921.
Enrico Papadopulo
Nato a Monterotondo Marittimo il 4 marzo 1842, a soli diciassette anni si arruolò nel corpo dei “Cacciatori delle Alpi” all’ordine del Generale Garibaldi. Fu impegnato in Lombardia e in Trentino in molte
battaglie tra le quali Montebello, Palestro, Magenta e Solferino. Fu insignito di medaglia al valore consegnata direttamente dal’imperatore francese Napoleone III e partecipò alla Spedizione dei Mille. Col grado
di tenente dei bersaglieri fu protagonista durante la presa di Porta Pia nel 1870. Muore a Monterotondo
Marittimo nel 1892, mentre i pronipoti risiedono attualmente a Cecina.
Felice Francioni
Nato a Livorno nel 1844, arruolato coi volontari del Generale Garibaldi combatté in Sicilia, nel napoletano e nella terza
guerra per l’Indipendenza. Nel 1867 fu tra quelli che combatterono nell’Agro romano. Nei Carabinieri Livornesi guidati da
Carlo Mayer, fu ferito a Mentana. Muore a Cecina nel 1890.
n 28 m
Giubba e berretto appartenuti al
garibaldino cecinese
Guiseppe Pesciatini
29
LA DIFESA DI LIVORNO DEL 10-11 MAGGIO 1849:
UNA LEZIONE MAZZINIANA
di Damiano Leonetti
L
a sconfitta di Novara del 23 Marzo 1849 subita dalle truppe piemontesi e la conseguente rinunzia alla corona sarda
da parte di Carlo Alberto avevano di fatto dato una svolta in senso reazionario al corso degli eventi neutralizzando le
ribellioni ancora attive in Italia a seguito dei moti del ’48.
Dopo gli ultimi sviluppi della guerra contro l’Austria (Prima guerra d’Indipendenza), anche in Toscana la situazione era
in evoluzione. Il 28 Marzo 1849 rassegna le dimissioni il Triumvirato a Capo del Governo Provvisorio Toscano formato da
Guerrazzi, Mazzoni e Montanelli. In aprile scoppia la reazione a Pontedera, Empoli e Cascina. Nel frattempo gli austriaci,
giunti ai valichi dell’Appennino, minacciano di entrare in Toscana. Guerrazzi da Firenze organizza truppe di volontari per
opporsi all’invasione. Da Livorno partono alcuni treni diretti nella Capitale carichi di rivoluzionari male armati ma “accesi di
ardore bellicoso”. L’11 aprile la reazione trionfa a Firenze e da qui ne seguirà l’arresto di Guerrazzi con il pretesto di proteggerne l’incolumità. Il 12 Aprile del 1849 il Granduca di Toscana Leopoldo II rientra a Firenze. Sembra la fine di ogni speranza
rivoluzionaria. Pochi giorni dopo anche Lucca e Pisa si arrenderanno al potere granducale e con loro tutta la Toscana. Unica
eccezione Livorno dove invece s’inizia a pensare alla difesa armata della città.
La città labronica si era sempre distinta tra le varie realtà toscane per il particolare attaccamento dimostrato dalla popolazione agli ideali democratici. Proprio da Livorno, l’8 ottobre 1848, Montanelli, già Professore dell’Università di Pisa, reduce di
Curtatone e Montanara dove aveva combattuto insieme ai “suoi” studenti, in qualità di nuovo Governatore della città al posto
di Guerrazzi, annunciò l’idea di proporre agli altri stati italiani la Costituente come forma politica dell’unità nazionale (Tra
la folla presente al comizio tenuto da Montanelli a Livorno c’era anche Giosuè Carducci che ricorderà così l’episodio: “Due
memorie della mia fanciullezza mi rimasero e mi rimarranno eternamente sacre nel cuore come quelle che mi appresero e mi predissero molte cose. Io
fanciullo vidi Giuseppe Montanelli co’l braccio ferito parlare parole di confidenza e d’amore al popolo di Pisa; lo vidi ancora dal balcone del palazzo
del governo di Livorno proclamare la Costituente italiana. Queste due visioni, che io riveggo ancora come presenti, ebbero grandissima parte nella
educazione dell’animo mio”). Non a caso Mazzini, di ritorno da Marsiglia, si fermò a Livorno l’8 Febbraio 1849 prima di raggiungere Roma dove l’indomani sarebbe stata proclamata la Repubblica.
La città tutta imbandierata si riempì di folla desiderosa di ascoltare l’illustre ospite. Acclamato, Mazzini parlò dal balcone
del Palazzo del Governo in Piazza d’Arme su invito del Governatore della città Carlo Pigli comunicando al popolo livornese la
fuga del Granduca da Firenze. Nello stesso giorno Mazzini dettò un proclama ai livornesi dove, tra l’altro, si diceva: “Ogni nostra
azione aggiunge un elemento alla guerra imminente; ogni nostro canto sia un inno di guerra, ogni nostro pensiero di difesa e d’offesa – Osate e sarete
forti – vogliate e sarete grandi”. Alla sera, Mazzini, facendo tappa a Firenze, riprese il suo viaggio per raggiungere Mameli a Roma
che lo aveva richiamato con il famoso telegramma: “Roma è repubblicana, venite”. Da Roma, secondo il pensiero mazziniano,
dovevano essere proclamati quei principi di libertà politica e giustizia sociale che avrebbero dovuto essere alla base della futura
Costituente italiana a conclusione dei moti nazionali. Successivamente, ormai protagonista della Repubblica Romana, Mazzini
continuò comunque a tenere stretti rapporti con i responsabili politici livornesi. Egli pensava di far leva proprio su Livorno per
realizzare quell’unione tosco-romagnola che doveva essere il fulcro di tutto il processo unitario italiano.
Con questo intento, Mazzini invia a Livorno il 17 Marzo due “suoi” uomini, Ciceruacchio e Pietro Guerrini, per preparare
l’unione con Roma. Un mese dopo, alla metà di aprile del 1849, a Firenze la reazione riesce a riportare Leopoldo II sul trono
del Granducato di Toscana. Mazzini scrive così all’amico livornese Carlo Notari: “Fratello, se non riuscite a sottomettere la reazione, in
nome di Dio, imbarcate armi quante potete, cannoni da campagna se ne avete, e venite qui con essi – Non v’è più né Toscana né altro – V’è l’Italia,
e noi la rappresenteremo qui degnamente – Dillo ai nostri”. Successivamente, il 2 maggio, mentre a Roma si combatte aspramente,
Mazzini scrive ancora a Notari: “E voi toscani fratelli, ci mancherete voi nella guerra della libertà? Sappiamo bene che i livornesi resistono,
ma caro mio, se l’insurrezione si ostina a stare sulla difensiva sarà battuta – Spero che da Roma partirà il grande impulso alla libertà ed all’unità
d’Italia…”. È il 10 maggio quando, insieme a circa millecinquecento livornesi comandati dal maggiore Giovanni Guarducci,
saranno pronti a combattere anche molti combattenti forestieri come il modenese Giuseppe Piva con i suoi bersaglieri, il
colonnello francese De Sère con alcuni suoi connazionali ed il maggiore Luigi Ghilardi di Lucca che assumerà il comando
supremo della difesa.
Nella città si scavarono trincee nei pressi del Cimitero Comunale dei Lupi dove vennero piazzati anche due grossi cannoni.
Altri furono posizionati fuori delle Porte S. Marco, S. Leopoldo detta anche Leopolda (oggi scomparsa), Maremmana (oggi
Piazza Matteotti), “a Mare” (attuale Piazza Luigi Orlando); artiglierie vennero poste alla base della torre del Marzocco e sulla
Fortezza Nuova mentre una batteria di cannoni fu posizionata all’interno di Forte S. Pietro, un bastione lungo la cinta della
n 30 m
città. Si pensò anche ad improvvisare delle barricate nelle vie cittadine utilizzando pietre, usci, banchi, mobili ed altro ancora
sull’esperienza delle Cinque Giornate milanesi. Durante la notte il corpo di spedizione austriaco che Radetzky aveva preparato
per essere inviato in Toscana, già a Pisa, si mosse con due brigate - più di dodicimila uomini, tremila cavalli e sessanta pezzi
d’artiglieria - al comando del Maresciallo Barone Costantino d’Aspre. Gli austriaci circondarono la città e poi iniziarono il
fuoco d’artiglieria. Grazie all’evidente disparità di armamento, l’esercito imperiale ebbe la battaglia vinta. Nei combattimenti si
distinsero tra i livornesi uomini come il capitano Andrea Sgarallino, i tenenti Alessandro Neri, Francesco Bargellini e Giuseppe
Aloisi e tanti altri ancora.
Per tutti si ricorda Enrico Bartelloni, detto “il Gatto”, da tutti considerato l’anima della resistenza livornese. Catturato poco
dopo la resa della città, subì il martirio in Fortezza Vecchia al grido di “Viva l’Italia” secondo i canoni del più classico romanticismo dell’epoca. Poterono soltanto assistere ai combattimenti, data lo loro giovane età, anche il pittore Giovanni Fattori
- addirittura salito sul tetto di casa in Via del Corso per assistere alle fasi più emozionanti degli scontri – e il poeta e scrittore
Renato Fucini. La giovane Diomira Cartoni, appartenente ad una famiglia benestante contraria alle idee liberali ed alla resistenza armata in atto nella città, annotò così sul suo diario la fase finale dei combattimenti: “Venerdì 11 (maggio 1849, ndr): (…) Fu
aperta una breccia tra Porta S. Marco e Porta Fiorentina (attuale Barriera Garibaldi, ndr), furono forzate tutte le porte e barriere; da ogni lato,
alle ore 10 e mezza l’armata (austriaca) entrava in città. La resistenza, fatta dalle case che avvicinavano le porte o barriere e dalle muraglie delle
ville, fece sì che i soldati austriaci, da dove veniva tale resistenza, entravano uccidendo e saccheggiando. Il danno fu forte. La mortalità, sia seguita
nella difesa, sia per quelli che, presi con l’arma alla mano erano stati fucilati, si dice ammontasse circa 800 persone, ma la maggior parte dei capi
rivoluzionari fuggirono per via di mare. Sembra che la truppa si acquietasse, che la popolazione dimostrasse agli austriaci non voler essergli tanto
avversa, tolti i peggiori soggetti, e già le truppe erano in Piazza grande abbivaccate quando a ore 12 circa dal Duomo ed altre case di piazza fu tirato
sulla truppa. Questa circostanza poteva essere fatale al nostro Livorno. Infatti cominciarono i soldati, entrando per le casa per avere i briganti che
avevano fatto fuoco, a derubarle; ma i generali e ufficiali fecero tornare tutto all’ordine: meno che arresti e fucilazioni che si eseguivano al momento
che prendevano uomini armati o indicanti che avessero preso parte alla difesa. Fra le persone più diffamate fu fucilato il Cartelloni”.
Sedata la rivolta per giorni e giorni in città ci furono centinaia di arresti. Anche a Pisa entrarono in carcere molti personaggi
sospettati di repubblicanesimo. In molti riuscirono comunque a fuggire da Livorno a partire già dalla sera dell’11 maggio trovando un imbarco su alcuni bastimenti in partenza per la Corsica.
Ridurre a semplice patriottismo l’azione di difesa di Livorno unica tra le città toscane a difendere le proprie mura e ad opporsi con le armi alla restaurazione Leopoldina, non sarebbe del tutto corretto. Erano presenti anche motivazioni legate alle
sfavorevoli condizioni di vita del popolo e dei lavoratori portuali e industriali aggravate ulteriormente dal blocco di alcune importanti opere pubbliche. Gli austriaci da sempre avevano osteggiato, ad esempio, l’allargamento della Darsena e la costruzione
del bacino di carenaggio poiché in conflitto con gli interessi delle aree portuali di Venezia e Trieste.
I democratici livornesi, lasciati soli da benpensanti, ceti abbienti e vecchia classe dirigente moderata, non vollero arrendersi
all’ondata reazionaria che aveva preso il sopravvento in Toscana a partire dalla metà di aprile del ’49. La loro decisione si pose
a difesa delle conquiste costituzionali ottenute secondo lo spirito più autentico dei principi mazziniani di libertà, indipendenza
e dedizione alla causa italiana.
10 maggio: interno di porta fiorentina
Il cannone dei Livornesi a Forte San Pietro
n 31 m
n 32 m
CENNI SULLE ARMI DA FUOCO INDIVIDUALI
NEL RISORGIMENTO ITALIANO
di Marco Andrea Piermartini
I
l Risorgimento italiano non è stato solo una fucina di progetti ed ideali, ricco di personaggi illustri, sovrani, generali, letterati e artisti, ma anche, e soprattutto, un periodo di guerre, rivoluzioni e scontri, alcuni dei quali feroci. Dalla restaurazione
post-napoleonica, dopo il congresso di Vienna, fino al 1870, anno della presa di Roma, si contarono innumerevoli episodi
rivoluzionari e terroristici, tre guerre contro l’impero d’Austria, la partecipazione piemontese alla campagna di Crimea, due
campagne contro lo stato pontificio, una garibaldina prima e piemontese poi contro il Regno delle due Sicilie ed infine una
campagna implacabile nel meridione postunitario per reprimere quell’insieme di revanscismo borbonico, ribellismo sociale e
criminalità passato alla storia sotto il nome di brigantaggio. In questo guerreggiare furono utilizzate tutte le tipologie di armi
che l’industria dell’epoca e gli artigiani potevano offrire. Anche sotto questo aspetto il Risorgimento italiano è assai interessante
e per certi versi unico agli occhi dell’oplologo e dell’appassionato in generale.
Caratteristica che rende particolare e, per certi versi, unico il panorama armiero dell’Ottocento italiano è il fenomeno del volontariato garibaldino che, libero dalle rigide prescrizioni previste per gli eserciti ufficiali, si armò in maniera variegata, con armi
spesso scadenti, ma in altri casi assai efficienti e modernissime. Ulteriore caratteristica che rende interessante il Risorgimento
agli occhi dell’appassionato d’armi è il fatto che questo ebbe luogo in un arco temporale nel quale si ebbero importantissime
innovazioni e scoperte nei campi industriale e chimico e che le armi, come accade, furono i primi oggetti ad avvalersi di tali
progressi quando non addirittura stimolo per gli stessi. Basti pensare che nell’arco di trent’anni, dal 1840 al 1870, si passò dal
fucile a pietra focaia a canna liscia e palla tonda, che armava gli eserciti da oramai 250 anni e che aveva una gittata utile di 100
metri, a quello con canna rigata a retrocarica come il Remington papalino, che sparava una cartuccia metallica il cui proiettile
arrivava a 1.200 metri. E’ chiaro che uno studio completo di tutte le armi impiegate in tale scenario riempirebbe un volume
intero e che in questo contesto può essere fatto solo un riassunto generale, incentrando l’attenzione sui tre fatti d’arme oggetto
della presente mostra, rimandando per eventuali approfondimenti alla vasta bibliografia specialistica.
Nell’Italia uscita dal congresso di Vienna, tre realtà statali apparvero subito degne di nota ed in possesso di eserciti organizzati, capaci d’influire sulla politica della penisola: il Regno di Sardegna retto dalla dinastia dei Savoia, l’Impero asburgico nel
Lombardo Veneto ed il Regno delle due Sicilie governato dai Borbone. L’impero asburgico esercitava un controllo politico e
militare anche sul resto degli staterelli italiani tra i quali spiccavano il Granducato di Toscana e lo Stato Pontificio. Dalle guerre
napoleoniche era uscita rafforzata la funzione essenziale della fanteria con l’accresciuta importanza dell’artiglieria da campagna
usata in maniera rivoluzionaria da Napoleone che, dopo avere standardizzato i calibri, la rese mobile e capace di concentrarsi in
grandi unità a supporto ravvicinato delle operazioni della fanteria sul campo di battaglia. Ridimensionata era uscita la cavalleria
che, la maggior parte delle volte ininfluente in combattimento, aveva conservate, invece, le indispensabili funzioni di forza
esplorante e di disturbo in vista dello scontro decisivo. Alla luce delle considerazioni tattiche di cui sopra le armi più importanti
e capaci di decidere una battaglia si confermarono il fucile da fanteria con relativa baionetta ed i pezzi d’artiglieria da campagna.
Dopo la sconfitta di Napoleone a Waterloo, lo scioglimento della Grande Armée ed il conseguente ridimensionamento dell’esercito inglese, si resero disponibili in Europa migliaia di armi che permisero a poco prezzo di rifornire gli arsenali dei vari stati.
Per avere un’idea della produzione d’armi in epoca napoleonica basti citare che nei dieci arsenali francesi fino al 1814 furono
prodotti 2.026.300 fucili, 226.820 moschetti e carabine e 203.137 pistole.
Quanto all’Inghilterra una relazione del 1817 alla Camera dei Comuni quantificò in 3.143.366 le armi da fuoco portatili possedute nel Regno Unito dal 1803 al 1816. Le armi più diffuse furono quindi i fucili da fanteria a pietra focaia francesi ed inglesi.
Il primo era l’ottima trasformazione del precedente fucile d’ordinanza effettuata nell’anno IX della Rivoluzione francese e
resasi necessaria per rendere più economica e standardizzata la produzione. Il secondo era anch’esso frutto di una trasformazione del fucile Brown Bess che aveva accompagnato il fante inglese, con minime varianti, nel corso degli ultimi 150 anni.
Era stato accorciato, semplificato e anch’esso standardizzato nella produzione inizialmente per permettere di rifornire i soldati
della Compagnia delle Indie e per questa ragione il modello aveva assunto il nome di India Pattern. Entrambi i fucili erano
a canna liscia, ma il calibro di quello inglese era maggiore di quello francese: 18 mm contro 17,6 ed era tristemente famoso
per le ferite devastanti che un suo colpo procurava. Il fucile francese era tuttavia decisamente superiore. Più solido e facile da
smontare, aveva la canna unita alla cassa di legno da fascette metalliche che irrobustivano l’insieme a differenza del modello
inglese che aveva la canna fissata al calcio tramite spinotti passanti. Anche la cartella, nel modello francese, era fatta meglio e,
oltre a garantire un funzionamento più regolare, aveva un cane di conformazione più massiccia rispetto al modello inglese a
forma di collo di cigno assai più fragile. La baionetta francese più slanciata e funzionale, di produzione standardizzata, veniva
n 33 m
fissata tramite una ghiera girevole che s’incastrava su di un dente saldato sotto la canna. Quella inglese di forma più arcaica e
spesso rifinita a mano per ogni arma s’innestava direttamente sul mirino ed era priva di ghiera. Quanto all’esercito austriaco era
armato del fucile a pietra mod. 1798, eccetto pochi particolari, assai simile al modello francese del quale aveva anche il calibro
di 17,6 mm. Poiché era stato costruito in quantità minori anche gli stati italiani sotto influenza austriaca si armarono di fucili
francesi ed inglesi. In mostra sono presenti un fucile napoleonico datato 1810 nella configurazione da volteggiatori, un corpo
paragonabile nelle funzioni a quello dei non ancora nati bersaglieri, ed un fucile inglese Brown Bess India Pattern costruito
dall’armaiolo Wilson di Londra intorno agli anni 1807/1808 per un corpo di volontari londinesi della Loyal Hampstead Association. È, dunque, con questa tipologia d’armi e con tutti i moschetti e fucili corti da questi derivati e destinati ad armare i
corpi specialistici e la cavalleria che furono combattuti i primi moti risorgimentali.
Con la scoperta delle sostanze fulminanti e l’abbandono dell’accensione a pietra focaia in favore di quello a percussione, si
ebbe il primo grosso perfezionamento del fucile da fanteria e delle armi di reparto. L’accensione ottenuta dalla percussione di
una piccola capsula metallica che trasmetteva tramite un canale sito nel luminello la fiammata alla carica di polvere nella canna,
rendeva le operazioni di caricamento molto più rapide e le accensioni molto più veloci e sicure anche in caso di pioggia. La
generale trasformazione delle armi da fuoco militari avvenne a partire dal 1836 in Inghilterra e dal 1840 in Francia anno nel
quale apparve il primo modello di fucile a percussione per l’esercito di nuova concezione, poi perfezionato nel modello 1842,
che per funzionalità, praticità d’uso e diffusione, nelle sue numerose varianti, rimase l’arma d’eccellenza dei reparti garibaldini
e della Guardia Nazionale.
Acquistato in grandi quantità presso gli arsenali francesi dal Regno di Sardegna, incapace di far fronte alle necessità dei vari
conflitti con l’arsenale torinese e prodotto poi anche da armaioli bresciani tra i quali Glisenti, si distingueva dai precedenti, oltre
che per il sistema d’accensione, per la cartella più slanciata e per la molla del cane alloggiata posteriormente. Questo rendeva
possibile asportare meno legno dalla cassa, con il conseguente irrobustimento della stessa. Il Regno Sabaudo adottò la percussione con un modello di transizione nel 1843 e poi nel 1844 con il modello di fucile da fanteria definitivo che accompagnò il
soldato piemontese nelle due prime guerre d’indipendenza e nella campagna di Crimea. I precedenti modelli a pietra furono
quasi totalmente modificati nel nuovo modello. L’esercito asburgico passò alla percussione nel 1840 con il sistema Augustin
alquanto originale rispetto al consueto sistema a capsula. Il Regno delle due Sicilie si apprestò a modificare i propri fucili a
pietra ed a costruire nei propri arsenali armi della tipologia francese mod. 42.
Nello scontro di Curtatone e Montanara (29 maggio 1848) mentre i volontari erano armati di fucili a pietra, i regolari toscani e napoletani avevano in dotazione fucili modello 42 o precedenti modificati a percussione. Gli austriaci vincitori, invece,
erano armati degli Augustin modello 40 e 42 e lo scontro fu deciso, più che dalla qualità delle armi, dall’enorme sproporzione
in uomini e pezzi d’artiglieria in loro favore. Nella mostra sono esposti un raro fucile Augustin mod. 42, un mod. 44 piemontese ed un mod. 42 francese con marchi piemontesi d’accettazione e timbro di Carlo Alberto sul calcio. Si tratta, quindi, di
armi originali di epoca coerente con la famosa battaglia. Sono anche presenti una daga delle Cinque giornate di Milano ed una
sciabola mod. 1833 detta “Albertina”, entrambe usate durante gli avvenimenti legati alla prima guerra d’Indipendenza.
Gli scontri di Solferino e San Martino (24 maggio 1859) furono combattuti con armi già molto più efficienti di quelle impiegate a Curtatone e Montanara. Vi era stata, nel frattempo, la campagna di Crimea (1854 – 1856) ove si era evidenziata la superiorità delle armi con la rigatura della canna che i progressi nella fabbricazione delle polveri nella metallurgia e la progressiva
industrializzazione avevano reso pratica ed economica. L’esercito piemontese entrò in campo con quantità limitate di un fucile
rigato a stelo già impiegato in Crimea, ma con la gran parte della fanteria ancora armata con il fucile mod. 44 a canna liscia.
Questo non sparava più la pallottola tonda, ma il proiettile Nessler ad espansione che grazie alla maggiore aderenza all’anima
della canna, anche se liscia, aumentava la precisione e la portata.
Il corpo dei bersaglieri era armato di carabine a canna rigata fin dal principio della sua costituzione nel 1836 ed erano già
rigati anche alcune grandi pistole in dotazione alla cavalleria. Solo nella guerra del 1866 i fanti del neonato esercito italiano ebbero in dotazione il fucile modello 1860 a canna rigata di cui si può ammirare in mostra un esemplare costruito dalla Escoffier
negli arsenali francesi di St. Etienne.
La fanteria francese era armata con il fucile mod. 1857, un mod. 1842 rigato, mentre il corpo scelto degli zuavi ebbe in
dotazione le ottime carabine mod. 53/56 con una lunga baionetta che, all’occorrenza, poteva venire usata come sciabola. Gli
austriaci scesero in campo con i fucili mod. 54: ottime armi a percussione con canna rigata e di calibro minore (13,9 mm) che
sparavano un’apposita pallottola a compressione. Le armi erano aumentate di potenza, ma le tattiche erano rimaste sostanzialmente le stesse ed il fatto si tradusse in un massacro che impressionò Napoleone III e lo convinse a cercare una via d’uscita
dal conflitto. Anche Henry Dunant, impressionato dal campo di battaglia di Solferino si adoperò per fondare l’istituzione della
Croce Rossa. In mostra sono esposti un fucile austriaco da fanteria di prima linea mod. 54 completo della sua baionetta preda
di guerra del 1859 riassegnato poi alla Guardia Nazionale di Legnago ed una carabina da zuavi mod. 53 a stelo con la sua
baionetta a sciabola protagonista della guerra di Crimea e di quella italiana poi. Solo sette anni dopo ebbe luogo lo scontro di
Bezzecca (21 luglio 1866), che fu vinto grazie alla determinazione di Garibaldi ed all’artiglieria italiana del Maggiore Dogliotti
n 34 m
aggregata al corpo garibaldino. Se da un lato gli austriaci erano sempre armati con fucili e carabine di tipologia 54, dall’altro vi
fu la consueta pittoresca varietà di armi che sempre caratterizzò i corpi garibaldini. Dei due battaglioni bersaglieri volontari, il
primo composto essenzialmente da liguri al comando di Antonio Mosto era armato con ottime carabine da cacciatori e fucili
di tipologia svizzera di piccolo calibro (10,5 mm) diretta evoluzione della carabina svizzera mod. 51, arma garibaldina d’eccellenza, che, invece, armava il secondo battaglione formato da lombardi agli ordini di Nicostrato Castellini.
La gran massa dei volontari scarsamente addestrati e armati più che altro del proprio entusiasmo giovanile ebbe in dotazione vecchi fucili a canna liscia della tipologia 40 e 42, come abbiamo visto, acquistati a suo tempo dal Regno di Sardegna. Ciò
rispondeva ad una precisa volontà politica dello Stato Maggiore italiano che diffidava delle formazioni volontarie. L’armamento scadente si fece sentire negli scontri di montagna, dove le carabine 54 dei cacciatori tirolesi impegnarono da lunga distanza
alquanto duramente le formazioni garibaldine obbligate a sanguinose cariche alla baionetta per potere annullare il vantaggio
tattico del nemico.
Quasi per beffa, solo ad operazioni concluse, giunsero alcune casse di carabine rigate. I benestanti e gli ufficiali si armarono
spesso a proprie spese e questo fece sì che in campo, anche se in numero insufficiente per influenzare l’andamento della campagna, si vedessero le armi più disparate. Frederick Stibbert, anglo-fiorentino e futuro insigne collezionista, si portò il suo ottimo Enfield 53 inglese, gli ufficiali delle Guide si armarono di revolver, molti a retrocarica a spillo della tipologia Lefaucheaux e
molti delle tipologie Colt Navy e Dragoon già sperimentati con successo nella campagna dell’Italia meridionale sei anni prima.
Fu ad esempio con una Colt Navy che durante lo scontro di Milazzo, Giuseppe Missori salvò la vita a Garibaldi uccidendo
un ufficiale borbonico a cavallo che lo stava caricando. In mostra si può ammirare una rarissima Colt Navy garibaldina a sei
colpi in calibro 36, appartenuta a Filippo Minutilli (Grumo 1812 – Genova 1863) comandante del piccolo reparto del genio
garibaldino durante l’impresa dei Mille.
Quella del 1866 fu l’ultima campagna combattuta interamente con armi ad avancarica. L’anno dopo, la sconfitta garibaldina
di Mentana, sancì la superiorità tattica e psicologica dello Chassepot e con esso delle armi a retrocarica. Nel 1870 i bersaglieri
ed i fanti italiani armati di mediocri carabine e fucili ad ago Carcano si confrontarono con gli ottimi Rolling Block degli zuavi
papalini. Solo l’ordine di Pio IX di imbastire una difesa simbolica impedì un massacro. Rimediò Menelik nel 1896 durante lo
scontro di Adua nel quale i suoi guerrieri armati degli stessi Remington papalini venduti dall’Italia causarono al corpo di spedizione italiano più morti che in tutte le guerre risorgimentali messe insieme. Una beffarda ironia accompagna quindi l’ultimo
sparo in battaglia di armi da fuoco protagoniste del nostro Risorgimento.
n 35 m
Fucile piemontese da fanteria mod. 1860,
cal. 17,5, canna rigata. Costruito su licenza da
Escoffier negli arsenali di St. Etienne nel 1863 per una
fornitura al Regno d’Italia. Arma d’ordinanza della fanteria italiana
nella terza guerra d’Indipendenza e nella campagna contro il brigantaggio
Fucile austriaco da fanteria da prima linea mod. 1854 Lorenz,
cal. 13,9 , canna rigata. Fu l’arma d’ordinanza della fanteria
austriaca durante le guerre d’Indipendenza italiane seconda e
terza. Sparava una pallottola a compressione di disegno caratteristico.
n 36 m
n 37 m
CENNI SULLE UNIFORMI RISORGIMENTALI
di Massimo Polimeni
L
e importanti riforme attuate dallo Stato Maggiore di Vittorio Emanuele II per riconvertire la vecchia Armata Sarda nel
primo Esercito Italiano, iniziarono appena conclusa la seconda Guerra di Indipendenza (1859) a seguito della necessità
di disporre di una più adeguata struttura di forze armate, in quanto il piccolo esercito regionale del Re di Sardegna non
era più sufficiente ad assolvere i complessi compiti che avrebbe dovuto affrontare il nuovo esercito a base nazionale. Governi
provvisori vennero instaurati negli ex principati dell’Italia centrale insieme ad alcuni reparti militari allo scopo di curare la fase
di transizione; queste truppe furono organizzate secondo il modello della struttura militare piemontese, poiché erano destinate
ad essere assorbite, in un prossimo futuro, nell’esercito italiano. Le operazioni di riunione, di tutte le forze militari disponibili
nel paese iniziarono negli ultimi mesi del 1859 concludendo una prima fase organizzativa nel marzo del 1861; infatti fu allora
che, con nota n. 76 del 4 maggio 1861, il Ministro Fanti “rende noto a tutte la Autorità, Corpi ed Uffici militari che d’ora in
poi il Regio Esercito dovrà prendere il nome di Esercito Italiano, rimanendo abolita l’antica denominazione d’Armata Sarda’’.
Casa Savoia, quale guida del movimento per l’indipendenza, trasferiva nelle nuove forze armate le tradizioni delle sue truppe,
un’eredità da raccogliere e preservare allo scopo di rafforzare l’identità nazionale. Gli uomini che confluirono nelle file del
nuovo esercito provenivano da:
- dai militari austriaci dell’ex provincia imperiale della Lombardia;
- dalle truppe degli stati che si erano unite al Regno di Sardegna attraverso i plebisciti, incluse le legazioni pontificie (Toscana,
Emilia Romagna, Modena, Parma e Piacenza);
- da una selezione dei volontari della spedizione dei Mille;
- dalle ultime quattro classi di coscritti dell’ex esercito borbonico.
Le trasformazioni più rilevanti dell’ordinamento militare investirono, come prevedibile, i corpi combattenti; naturalmente
esse comportarono cambiamenti nelle uniformi, nelle armi e nell’equipaggiamento; gran parte dei materiali adottati in questo
periodo assumerà la denominazione “modello 1860’’. La maggiore disponibilità di uomini che questi avvenimenti consentivano di avere, permise di creare nuove unità dei vari corpi portando cosi il totale delle divisioni da cinque a otto. Furono pertanto
inquadrate nella fanteria 6 nuove brigate: “Granatieri di Lombardia’’, “Brescia’’, “Cremona’’, “Como’’, “Bergamo’’ e “Pavia’’;
altri sei battaglioni si aggiunsero a quelli già esistenti. La cavalleria poté disporre di tre nuovi reggimenti: “Lancieri di Milano’’,
“Lancieri di Montebello’’ ed i “Cavalleggeri di Lodi’’. Per quanto concerne l’artiglieria, con le 12 batterie da campagna di nuova
costituzione, questa specialità raggiunse un totale di 32 batterie disponibili. Si compiva cosi un primo passo verso un più vasto
ampliamento delle forze. Dopo la campagna del 1859, il colonnello Raffaele Cadorna veniva inviato in Toscana dove, con il
grado di generale, ricopri la carica di Ministro della Guerra; il suo compito era di riorganizzare l’esercito granducale in modo
da riunirlo al resto dell’Armata Sarda. Di conseguenza furono sciolti i vecchi corpi e nuovamente inquadrati nelle tipiche unità
piemontesi dando cosi vita ai seguenti corpi:
- quattro brigate di fanteria: “Pisa’’, “Siena’’, “Livorno’’, “Pistoia’’;
- un reggimento “Lancieri di Firenze’’;
- un reggimento “Cavalleggeri di Lucca’’;
- un reggimento artiglieria composto da sei batterie da campagna e sei compagnie da piazza.
In Emilia si dovette procedere al reclutamento di corpi volontari e da essi scaturirono quattro brigate: “Ravenna’’, “Bologna’’, “Modena’’ e “Forlì’’. Le truppe parmensi furono trasformate nella Brigata “Parma’’; reclutando localmente altro
personale si aggiunsero altre due brigate denominate “Ferrara’’ e “Reggio’’; l’organico delle fanterie si completava poi con la
creazione di nove battaglioni bersaglieri. Ancora in Emilia la cavalleria fornì due reggimenti; il primo, costituito da dragoni e
gendarmi pontifici e volontari, fu assegnato alla specialità lancieri ed ebbe la denominazione di “Lancieri Vittorio Emanuele’’;
il secondo, di cavalleggeri, fu denominato “Ussari di Piacenza’’, era composto da dragoni parmensi e volontari ungheresi.Per
l’artiglieria furono costituite nove batterie da campagna e nove compagnie da piazza. Intanto la vecchia Brigata Savoia, per
effetto dell’annessione di quella provincia alla Francia, doveva essere completamente riorganizzata perché perdeva quasi tutti
gli uomini e gran parte dei quadri, ad essa veniva data la nuova denominazione di “Brigata Re’’. La “Brigata Alpi’’ veniva a sua
volta costituita con elementi dei disciolti “Cacciatori delle Alpi” e “Cacciatori dell’Appennino’’.
Esaminando il quadro di formazione dell’armata, che andava via via sviluppandosi, si vede chiaramente come l’Esercito
Italiano che stava nascendo non era altro che un ampliamento della vecchia Armata Sarda e la situazione politica richiese ben
presto che queste forze, appena organizzate, venissero impiegate in un ciclo di operazioni da svolgersi in concomitanza con
l’impresa garibaldina dell’Italia Meridionale, tra il 1860 ed il 1861 e che le forze piemontesi subentrassero ai volontari di Garibaldi determinando con il loro apporto la caduta delle piazze di Capua, Gaeta e Messina e con esse la fine del Regno Borbonico
n 38 m
delle Due Sicilie. Con l’annessione delle provincie meridionali nacque urgente il problema di trovare un’adeguata sistemazione
per gli eserciti che si erano battuti nel sud, i Garibaldini e i Borbonici. Riguardo all’Esercito Napoletano si decise di mantenere
in servizio solo le ultime quattro leve, cioè i giovani ritenuti più facilmente inseribili, gli anziani invece, di cui si temeva il risentimento e si nutriva scarsa stima, vennero congedati, con il risultato che questa gente sbandata finì per ingrossare le file del
brigantaggio. Le truppe garibaldine, a conclusione della loro impresa nel Regno delle Due Sicilie, assommavano a 7.000 ufficiali
e circa 50.000 uomini di truppa; il personale che le componeva era tutto estremamente eterogeneo.
Quanto alla truppa fu stabilito di risolvere il problema offrendo agli uomini l’alternativa, o il congedamento con sei mesi di
paga oppure due anni di servizio in uno speciale corpo volontario. La maggior parte scelse di congedarsi, mentre l’esiguo numero di volontari rimasti non riuscì a dar vita al nuovo corpo volontario. Gli ufficiali garibaldini vennero sottoposti ad esami, al
fine di poterli immettere nell’esercito regolare con lo stesso grado che essi ricoprivano tra i volontari; solo 1.500 di loro furono
ammessi. L’inquadramento nell’Esercito Piemontese di questi ultimi contingenti di militari portò ad un ulteriore aumento
degli organici. I reparti furono nuovamente manipolati ed il quadro di formazione dell’esercito ne risultò conseguentemente
modificato. Nei reggimenti di fanteria la forza venne ridotta da quattro a tre battaglioni; i battaglioni tolti furono raggruppati
per costituire nuove brigate: “Granatieri di Napoli’’, “Umbria’’, “Marche”, “Abruzzi’’, “Calabria’’ e “Sicilia’’.
I battaglioni bersaglieri diventati 36, furono suddivisi in 6 reggimenti. Anche per quanto riguarda le altre armi si ebbero degli aumenti negli effettivi; i reggimenti di cavalleria vennero formati da 6 squadroni, mentre in artiglieria il numero delle batterie
o compagnie per reggimento salì a 16, i battaglioni di fanteria a loro volta passarono da 4 a 6 compagnie. Le fasi del processo
di fusione di tutte le forze militari, di cui l’Italia disponeva in quel momento, fu certamente più laborioso di quanto non appaia in questa scarna esposizione. Le difficoltà maggiori scaturivano dalla grande diversità che caratterizzava quegli elementi
da amalgamare. Si trattava di comporre in un solo omogeneo organismo formazioni militari che talvolta erano addirittura in
antitesi tra loro perché ciascuno era espressione di una tradizione militare, sociale e storica completamente estranea all’altro.
Inoltre, questi corpi che ci si accingeva ad inserire nella vecchia Armata Sarda, spesso non erano più neanche organicamente
composti, si trattava di gruppi di militari senza inquadramento dove il numero degli ufficiali poteva addirittura essere maggiore
di quello della truppa, più spesso però gli ufficiali mancavano del tutto.
Gli Stati centrali furono gli unici che fornirono delle formazioni perfettamente organizzate ed inquadrate secondo la
composizione organica dei reparti piemontesi, che naturalmente fu facile inserire. Sotto il profilo tecnico poi l’eterogeneità
del personale reclutabile si presentava in forme altrettanto accentuate, si andava facilmente da un estremo all’altro; talvolta i
soldati da inserire nelle unità di nuova costituzione provenivano da solide istituzioni militari ed avevano al loro attivo una valida
esperienza di guerra, altri invece mancavano di esperienza e tradizioni, quando addirittura non avevano combattuto contro.
L’esperienza di secoli di vita vissuti profondamente divisi gli uni dagli altri, aveva disabituato gli italiani a vivere in comunità
di intenti, quindi rendeva più difficile l’operazione d’amalgama, e costituiva una valida ragione per togliere all’esercito ogni
tendenza che potesse avere carattere regionalistico.
Dar spazio ad una impostazione di questo tipo era molto pericoloso, specie in un momento in cui l’unità del Paese doveva ancora consolidarsi. La decisione di adottare l’ordinamento militare sardo anche per l’Esercito Italiano, indubbiamente
avvantaggiava gli ufficiali piemontesi che venivano favoriti nelle promozioni perché più pratici del sistema anche se talvolta
l’avanzamento non era proprio meritato. Il generale Manfredo Fanti fu l’artefice della importante riforma che proseguendo in
parte l’opera del generale Alfonso La Marmora gettò le basi per la costituzione e lo sviluppo dell’Esercito Italiano.
Fu indubbiamente un compito difficile ed arduo, specie se si tiene conto delle condizioni storiche e politiche in cui una
così delicata operazione doveva compiersi. Erano ormai secoli che in Italia non esisteva una tradizione militare comune; i
piccoli eserciti dei vari Stati della penisola, il più delle volte erano sorti quale espressione della volontà politica di un monarca
straniero, come i loro governi. Mancava del tutto un’arte della guerra ed una scuola che fossero patrimonio di tutti gli italiani.
Componendo faticosamente tutte le divergenze e le inimicizie vecchie e nuove, bisognava finalmente impostarne una.
L’organismo militare che scaturiva da una situazione così composita non poteva certo essere perfetto, nei suoi primi tre
anni di vita infatti si dimostrò ancora molto debole perché la concezione del numero prevaleva su quella qualitativa, tuttavia il
tempo e l’esperienza avrebbero provveduto a sanare gran parte dei suoi difetti.
n 39 m
LE UNIFORMI DEL REGIO ESERCITO ITALIANO
I
l nuovo Esercito, nato dalla fusione delle diverse realtà pre-unitarie, mantenne le tradizioni uniformologiche dell’Armata
Sarda, conservando in molti casi nelle insegne e nei colori la memoria delle originarie formazioni che erano in essere prima
della riforma. Le giubbe – con le dovute differenze per la truppa e per gli ufficiali – erano confezionate in panno turchino
scuro e provviste di profilature con i colori delle diverse Armi (rosse per la fanteria, giallo/arancio per l’artiglieria, cremisi per il
Genio e i Bersaglieri, etc.), i pantaloni erano in panno bigio con le medesime profilature, completati da uose e scarponcini per
la truppa e stivaletti e stivali in pelle per gli Ufficiali. Questi ultimi portavano sulle maniche elaborati gradi “a fiore” realizzati
con sottili galloni in filo d’argento, eleganti spalline metalliche a frangia e bandoliere in gallone argentato o dorato a seconda
del Corpo di appartenenza. Il copricapo era generalmente composto da un kepì rigido riportante frontalmente per la truppa
il fregio con il numero del Reggimento di appartenenza e una coccarda di lana o di seta, per gli ufficiali il trofeo dell’Arma
(Artiglieria, Genio, etc.) e il gallone di grado.
Alcune formazioni indossavano al posto del kepì un tradizionale copricapo, il cappello da Bersagliere con un folto piumetto,
la “bombetta” degli Alpini o l’elmo di Cavalleria con la vistosa cresta dorata e la croce sabauda frontale. La “Voloire” (Artiglieria a Cavallo) arricchiva il kepì di una lunga criniera equina posta sul lato destro del copricapo. Anche l’equipaggiamento
e l’armamento venne adeguato alla creazione di nuove specialità e al potenziamento dei vecchi Corpi e molte delle innova-zioni derivarono dalle esperienze acquisite nelle guerre appena concluse. Tra questi effetti l’adozione del fucile da fanteria
mod. 1860 e di un nuovo zaino (mod.1859) sul quale veniva affardellata la coperta d’ordinanza e la gavetta metallica.
Completava l’equipaggiamento tipo la borraccia in legno con tracolla in cuoio e la daga o sciabola/baionetta, nonché un
pesante pastrano in panno di lana per ripararsi dai rigori della stagione invernale.
Dal 1860 in avanti le uniformi subirono importanti modifiche dettate da ragioni di praticità, scomparvero le lunghe ed
ingombranti tuniche, le giubbe si accorciarono e molti degli ornamenti colorati vennero ridotti o del tutto eliminati.
L’uniforme militare si avviava a divenire sempre più funzionale e adatta ai nuovi schemi tattici che un moderno esercito
prevedeva. Si operò inoltre una distinzione tra le uniformi “da campagna” adatte alle marce, alle esercitazioni e al combattimento e le uniformi da cerimonia che conservavano pressoché inalterati tradizionali attributi sabaudi. Simbolo
distintivo degli Ufficiali rimase la sciarpa azzurra indossata ad armacollo dalla spalla destra al fianco sinistro mentre un
nuovo distintivo, uguale per ogni corpo e ordine di grado, veniva ufficialmente adottato il 13 Dicembre del 1871 ad
identificare in maniera univoca ogni appartenente alla forza armata del nuovo esercito: le “Stellette”.
Un cenno a parte meritano le uniformi utilizzate dalle formazioni garibaldine durante le campagne risorgimentali.
Trattandosi di corpi di volontari si registrò sempre una diffusa eterogeneità nelle tenute indossate da questi uomini,
rimanendo l’unico elemento comune il colore rosso delle giubbe e delle camicie. I garibaldini indossarono in ogni
occasione uniformi di fogge disparate, diverse nel taglio e nei tessuti, diverse per le categorie degli Ufficiali e della
truppa. I primi riprendevano sulle loro uniformi gli elementi propri dei corpi nei quali avevano militato o altri elementi a somiglianza di quelli presenti sulle uniformi dell’esercito piemontese. La truppa aveva per lo più camicie e
giubbe rosse, pantaloni bigi o chiari e ghette bianche. Anche l’armamento e la buffetteria era quanto di più eterogeneo si possa immaginare, provenendo da forniture diverse o da requisizioni effettuate sul campo o dopo le battaglie.
Il colore rosso e la versatilità di queste formazioni rappresentarono, nelle mani del Generale, un poderoso strumento
bellico che ebbe un ruolo fondamentale nel processo di unificazione nazionale.
n 40 m
Spencer Ufficiale in pannocastorino nero
utilizzato da molti eserciti europei
41
Giubba da maggiore modello 1878 con sciarpa
azzurra e spalline metalliche
Ufficiale fanteria
1859
Ufficiale fanteria
1859
Granatiere
della Guardia
1848
Volontario Battaglioni
Universitari Toscani
1848
Fante francese
1859
Fante piemontese
1859
Ufficiale garibaldino
1866
Fante austriaco
1859
n 43 m
Bersagliere
1866
n 44 m
FRATELLI D’ITALIA. GOFFREDO MAMELI E
IL CANTO DEGLI ITALIANI
di Federico Gavazzi
“Perché i nati sotto il cielo d’Italia non abbisognano dell’estraneo per redimersi, ma d’unione e d’un inno, che li colleghi! che parli all’anima dell’Italiano coll’eloquenza del fulmine, la potente parola del riscatto!” (G. Garibaldi)
I
l Canto degli Italiani, meglio conosciuto come Inno di Mameli, o Fratelli d’Italia, dalle parole del suo primo verso, rappresenta,
al pari della bandiera tricolore, l’elemento che denota e rende riconoscibile subito l’Italia agli Italiani e al resto del mondo.
Lo sentiamo suonare ad ogni cerimonia pubblica ed ad ogni manifestazione sportiva, le scuole continuano ad insegnarlo ai
bambini e comunque fa parte di fatto del bagaglio esperienziale di ogni cittadino italiano, e non solo. Sembra che ci appartenga
da sempre, almeno da quando l’Italia esiste non soltanto come “espressione geografica” ma come Stato-nazione. Invece, nonostante il grande amore che ha suscitato fin da subito nei patrioti italiani, le fortuna e il percorso che lo ha portato ad essere
l’inno ufficiale della Repubblica Italiana è molto complesso, ricchissimo di eventi e di storia.
L’autore
Il suo autore, Goffredo Mameli, nasce a Genova il 5 settembre 1827. Il padre Giorgio, di origine cagliaritana, era un ufficiale di marina del Regno Sabaudo, mentre la madre Adelaide Zoagli Lomellini apparteneva alla nobiltà cittadina illuminata,
vicina a intellettuali liberali e mazziniani. Frequenta studi classici in scuole religiose gestite dai Padri Scolopi, una congregazione moderatamente progressista e questa educazione, al contempo liberal-democratica e religiosa, affiora in tutti i suoi scritti, a
partire proprio dal Canto degli Italiani. All’Università di Genova segue i corsi di Laurea in Filosofia e Legge, ricevendo numerosi
richiami ufficiali per il suo temperamento esuberante. Nel 1846 partecipa alle riunioni della Società Entelema della quale,
l’anno successivo, diventa segretario: si trattava di un circolo culturale dove si discuteva di storia e letteratura e si faceva anche
molta politica; qui conosce Nino Bixio. A questo periodo risalgono i primi discorsi e le prime poesie: l’ode Roma, La battaglia
di Marengo, La buona novella, l’ode Ai fratelli Bandiera. Diventa presto uno degli esponenti di punta del movimento insurrezionale
di Genova, con idee che si allineano totalmente al credo mazziniano, ed organizza le manifestazioni popolari che culminano
con le celebrazioni del 101° anniversario della cacciata degli Austriaci da Genova (10 dicembre 1847). Proprio durante questi
preparativi scrisse il Canto degli Italiani.
Nel 1848 scoppia la rivoluzione a Milano e Mameli parte volontario. Mantiene stretti contatti con Mazzini e dopo la delusione dell’armistizio di Salasco è scelto per dirigere il giornale politico “Il diario del popolo”, dalle cui colonne cerca di infiammare gli Italiani alla lotta di liberazione. Ma è una breve parentesi e, quando Garibaldi riprende le operazioni militari, Mameli
lo segue in Toscana e nel Lazio, fino a Roma. Qui è uno dei promotori della Costituente ed è in prima linea tra i difensori della
Repubblica al momento dell’intervento francese. Proprio durante un attacco al casino di villa Corsini al Gianicolo, il 3 giugno,
viene ferito alla gamba sinistra. Ricoverato all’ospizio Trinità dei Pellegrini, muore a seguito di una cancrena la mattina del 6
luglio, tre giorni dopo l’ingresso dei Francesi in città. Non aveva ancora compiuto 22 anni.
Nell’immaginario comune Mameli diventa così un autentico eroe romantico, capace di unire pensiero e azione, e di consacrare tutte le suo energie ad una causa, l’Italia unita.
n 45 m
La nascita dell’Inno
Inizialmente Mameli pensò all’adattamento di musiche già esistenti, poi si rivolse a due musicisti genovesi, Magioncalda e
Nosella, che non riuscirono e soddisfarlo e infine inviò il testo a Michele Novaro, genovese di origine, che si trovava a Torino
per un impiego come secondo tenore e maestro dei cori dei teatri Regio e Carignano. Anche Novaro era un convinto liberale
repubblicano. Musicò decine di canti patriottici e organizzò spettacoli per la raccolta di fondi destinati alle imprese garibaldine.
Non ebbe un grande successo come musicista e morì relativamente povero nel 1885.
Il testo di Mameli fu consegnato al compositore la sera del 10 novembre del 1847 nella modesta abitazione torinese di
Lorenzo Valerio, uno degli esponenti più autorevoli del partito liberale piemontese. Il testo commosse il Novaro che corse a
casa e trovò in fretta la melodia giusta. Suonata a pochi amici incontrò subito un caloroso apprezzamento.
Il motivo proposto è un 4/4 in si bemolle piuttosto lineare e facile. Proprio questa “facilità” e stata ragione di critiche (anche a Mazzini la musica non piacque molto) ma anche presupposto del successo di un motivo che è facilmente memorizzabile
e la cui esecuzione può essere affidata a pochi ottoni, anche su un campo di battaglia.
L’Inno fu stampato su foglio volante a Genova dalla tipografia Casamara per essere distribuito in occasione della manifestazione del 10 dicembre, quando venne suonato dalla banda municipale di Sestri Ponente “Casimiro Corradi”, sul piazzale
del santuario della Nostra Signora di Loreto a Oregina, al termine di una processione alla quale parteciparono 30.000 cittadini
genovesi e patrioti italiani. Era l’anniversario della cacciata degli Austriaci dalla città.
L’Inno dal Risorgimento ad oggi
Fin dai primi giorni dopo la presentazione le masse popolari cominciarono a cantarlo, prima per le strade di Genova e Torino, poi a Milano nel 1848, con le brigate di volontari che giunsero a dar sostegno ai rivoltosi delle Cinque Giornate. Quando
Carlo Alberto dichiarò guerra all’Austria e invase il Lombardo-veneto, anche le bande militari lo suonarono incessantemente
ed il re fu costretto a ritirare le censure alla parte finale. Le truppe ufficiali e i volontari lo cantarono dieci anni dopo durante
la Seconda Guerra di Indipendenza, accompagnò i Mille nella liberazione dell’Italia Meridionale ed i bersaglieri nella presa di
Roma (1870). Tra tutti i canti del Risorgimento, molti dei quali in dialetto (da Addio mia bella addio, a La bella Gigogin, da L’Inno
di Garibaldi a L’inno a Oberdan), il Canto degli Italiani di fatto è stato di gran lunga il più conosciuto e il più cantato.
Giuseppe Verdi, che musicò anch’egli altri versi di Mameli nel Canto Militare e che, ironia della sorte, è stato recentemente
quasi contrapposto al patriota genovese nella querelle sull’inno d’Italia, fu il primo a riconoscere il Canto degli Italiani come identificativo dell’unità nazionale: nel 1862 infatti riprese il motivo di Novaro, al quale adattò le parole di Arrigo Boito, e lo inserì
accanto alla Marsigliese ed al Good save the Queen nell’Inno delle Nazioni, da lui composto in occasione dell’Esposizione Universale
di Londra di quell’anno.
Nell’Italia post-unitaria Fratelli d’Italia, nonostante la popolarità, è stato a lungo marginalizzato. I Savoia, continuarono a
impiegare come inno ufficiale la Marcia Reale, composta da Giuseppe Gabetti nel 1831: non potevano essere graditi certi passaggi del testo eccessivamente repubblicani e antiaustriaci, in un clima politico internazionale che stava portando l’Italia nella
Triplice Alleanza. Ma il Canto degli Italiani rimase popolare e fu cantato durante la Guerra coloniale in Libia del 1911-12, come
il più importante fra i molti canti patriottici militari e risorgimentali. La Prima Guerra Mondiale consegnò alla storia nuovi
celebri motivi, su tutti La leggenda del Piave e la Canzone del Grappa, che però non oscurarono la fama dell’Inno di Mameli.
In seguito la retorica nazionale fascista si appropriò di molti miti del Risorgimento e Mameli, figura di eroe romantico, poeta e idealista, morto giovanissimo combattendo per l’Italia, divenne così uno dei prototipi ideali della gioventù fascista. Si trattò
in effetti di una clamorosa forzatura, che omise la componente fortemente democratica presente nella sua poesia e nel suo
pensiero: spesso venne sottolineato che il poeta fu il primo ad impiegare il nome “Balilla”, venne particolarmente apprezzata
la sua volontà di conciliare Stato e Chiesa e, al momento opportuno, fu ricordata la sua morte per mano francese. Nonostante
questo l’Inno di Mameli rimase in posizione subordinata rispetto alla musica ufficiale del Regno, che continuava ad essere la
Marcia Reale, ed ai canti fascisti, in primis Giovinezza. Se nel 1932 il segretario del partito Achille Starace vietò tutti i canti che
non facevano esplicito riferimento al Duce o al Fascismo, dopo l’8 settembre 1943, la Repubblica Sociale Italiana lo recuperò,
al pari di Giovinezza, mentre il nuovo Governo Badoglio, al sud, adottava come inno La leggenda del Piave. Al contempo anche
alcuni gruppi partigiani lo intonarono insieme ai loro canti.
Finita la guerra, con la proclamazione della Repubblica, l’Inno di Mameli viene scelto come inno nazionale. Era il 12 ottobre
1946: in vista dell’imminente giuramento delle forze armate, fu adottato con decreto transitorio del Consiglio dei Ministri, su
proposta del ministro della Guerra Cipriano Facchinetti.
n 46 m
L’articolo 12 della Costituzione («La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni») riconosce la bandiera mentre l’inno nazionale rimane inspiegabilmente ignorato dalla legislazione
italiana e privo di una investitura ufficiale definitiva, che superi la transitorietà del decreto del 1946.
Il cerimoniale ufficiale prevede che l’Inno venga eseguito solo nella prima strofa e nel relativo coro, senza l’introduzione
strumentale che viene sostituita con i massimi onori tributabili (la frase musicale degli onori è ripetuta tre volte), e termina
con un “sì” deciso. Durante l’esecuzione gli ufficiali devono rimanere sull’attenti, i militari devono rimanere fermi e presentare
le armi, mentre i civili possono assumere la posizione di attenti con la mano destra sul cuore. Dal 1970, sempre nelle manifestazioni ufficiali, Fratelli d’Italia dovrebbe essere seguito dall’Inno europeo, il celebre Inno alla Gioia, adattamento strumentale
dell’ultimo movimento della Nona Sinfonia di Beethoven.
Quella di Fratelli d’Italia come inno nazionale non è stata una scelta unanimemente condivisa: già nel 1946 alcuni avrebbero
preferito confermare La leggenda del Piave, altri proposero il Va’, pensiero, mentre altri ancora pensarono ad un inno totalmente
nuovo che sottolineasse la svolta repubblicana dello Stato, scelto attraverso un concorso pubblico come avvenuto con l’emblema della Repubblica, opera di Paolo Paschetto. Se negli anni Sessanta e Settanta l’Inno non è stato particolarmente apprezzato
dalla Sinistra, che ne criticava l’eccessivo nazionalismo e la retorica della prima strofa, negli ultimi anni ha subito le contestazioni e tutti gli attacchi possibili delle forze politiche autonomiste e contro unitarie. Tuttavia per la maggioranza degli Italiani
«Fratelli d’Italia è un inno-distintivo, che sa ancora toccare il cuore dei cittadini e l’immaginario collettivo della nazione, sintetizza un patrimonio di valori nazionali ed emoziona quanto se non più della muta bandiera». Un grande lavoro nella riscoperta
dell’Inno come di tanti altri aspetti del italianità, è stato svolto da Carlo Azeglio Ciampi, durante il suo mandato presidenziale.
Così nel 2006 è stato presentato un disegno di Legge Costituzionale al Senato che ha proposto l’integrazione dell’articolo 12
con l’aggiunta di un secondo comma: «L’inno della Repubblica è “Fratelli d’Italia”».
I versi di Mameli
La prima stesura del Canto degli Italiani è conservata al Museo del Risorgimento e Istituto Mazziniano di Genova: il poeta
la scrisse di getto su un quaderno personale, pieno di altri spunti e riflessioni. La scrittura denota l’impeto con il quale Mameli
vergò i suoi versi: un primo rigo, “È sorta dal feretro”, viene abbandonato e il Canto si apre con le parole “Evviva l’Italia”.
Viene cancellata una strofa inneggiante alle donne: “Tessete o fanciulle // bandiere e coccarde // fan l’alme gagliarde //
l’invito d’amor”.
Una seconda redazione del testo è quella conservato al Museo Nazionale del Risorgimento di Torino: è la copia che Mameli
inviò a Michele Novaro perché la musicasse. Comincia con le famosissime e definitive parole “Fratelli d’Italia”.
Questa è un’importante modifica che mette subito in risalto il concetto di fratellanza. Parlare di “fratelli” significa alludere
al nesso parentale che lega tra loro i figli di una stessa madre-patria, l’Italia, comprendendo il popolo italiano tutto, dalla Val
d’Aosta alla Sicilia, senza distinzioni di classe. Sentirsi “fratelli” diventa una formula retorica che permea la produzione letteraria risorgimentale e riecheggia in tutti i discorsi patriottici.
n 47 m
n 48 m
Fratelli d’Italia
L’Italia s’è desta,
Dell’elmo di Scipio
S’è cinta la testa.
Dov’è la Vittoria?
Le porga la chioma,
Ché schiava di Roma
Iddio la creò.
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L’Italia chiamò.
Questa strofa incontrò la censura da parte del governo piemontese per l’allusione all’Austria
(l’aquila bicipite è il simbolo degli Asburgo), che fino al 23 marzo del 1848 era ancora
formalmente alleata. Di fronte al volere divino e alla determinazione degli Italiani le spade dei
mercenari austriaci si piegheranno come giunchi. Infine un riferimento al comune destino che in
quegli anni viveva la Polonia, spartita tra Russia (il “cosacco”) e Austria.
Noi siamo da secoli
Calpesti, derisi,
Perché non siam popolo,
Perché siam divisi.
Raccolgaci un’unica
Bandiera, una speme:
Di fonderci insieme
Già l’ora suonò.
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L’Italia chiamò.
Gli eventi ricordati appartengono alla storia d’Italia e sono vicende simboliche che ritornano
nell’immaginario risorgimentale e assumono il ruolo di “figure”, anticipazioni di quel riscatto
nazionale prossimo a compiersi. La battaglia di Legnano (1176) fu lo scontro principale del
conflitto tra Federico Barbarossa e i Comuni della Lega lombarda. “Ferruccio” è Francesco
Ferrucci, difensore della Repubblica di Firenze (1527-1530) contro le truppe imperiali di Carlo
V. “Balilla” era il soprannome di Giambattista Perasso, un bambino che, durante la Guerra di
Successione austriaca (1740-1748), dette il via alla rivolta che liberò la città. I Vespri Siciliani
sono i moti che il lunedì di Pasqua del 1282 videro i siciliani insorgere contro le truppe angioine.
Uniamoci, amiamoci,
l’Unione, e l’amore
Rivelano ai Popoli
Le vie del Signore;
Giuriamo far libero
Il suolo natìo:
Uniti per Dio
Chi vincer ci può?
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L’Italia chiamò.
L’appello all’unità si associa all’amara constatazione della condizione in cui ancora versava
l’Italia, mai più libera e unita dopo il VI° secolo e sempre sotto il controllo o l’influenza di
potenze straniere.
Dall’Alpi a Sicilia
Dovunque è Legnano,
Ogn’uom di Ferruccio
Ha il core, ha la mano,
I bimbi d’Italia
Si chiaman Balilla,
Il suon d’ogni squilla
I Vespri suonò.
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L’Italia chiamò.
Il credo mazziniano permea tutta la poesia e tutto il pensiero di Mameli. È l’idea di una
società di uguali, fondata moralmente sulle tre grandi aspirazioni dell’anima: la famiglia, la
patria e Dio. Se unito nel nome di Dio, il popolo italiano troverà certamente il suo riscatto.
Son giunchi che piegano
Le spade vendute:
Già l’Aquila d’Austria
Le penne ha perdute.
Il sangue d’Italia,
Il sangue Polacco,
Bevé, col cosacco,
Ma il cor le bruciò.
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L’Italia chiamò
Gli eventi ricordati appartengono alla storia d’Italia e sono vicende simboliche che ritornano
nell’immaginario risorgimentale e assumono il ruolo di “figure”, anticipazioni di quel riscatto
nazionale prossimo a compiersi. La battaglia di Legnano (1176) fu lo scontro principale del
conflitto tra Federico Barbarossa e i Comuni della Lega lombarda. “Ferruccio” è Francesco
Ferrucci, difensore della Repubblica di Firenze (1527-1530) contro le truppe imperiali di Carlo
V. “Balilla” era il soprannome di Giambattista Perasso, un bambino che, durante la Guerra di
Successione austriaca (1740-1748), dette il via alla rivolta che liberò la città. I Vespri Siciliani
sono i moti che il lunedì di Pasqua del 1282 videro i siciliani insorgere contro le truppe angioine.
50
LA STORIA DEL TRICOLORE ITALIANO
di Alessandra Scalvini
L’
articolo 12 della nostra Costituzione recita: “La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bandi
verticali di eguali dimensioni”. Per giungere a questa dichiarazione, la cui importanza è desumibile dal solo fatto di essere
stata inserita all’interno della Carta Costituzionale entrata in vigore dal 1° gennaio del 1948 , la bandiera nazionale ha
attraversato una lunga storia fatta di scontri e battaglie che parte addirittura dalla fine del Settecento. Un aspetto sicuramente
curioso è scoprire che si deve ad uno straniero l’introduzione di quello che è stato l’embrione del tricolore che abbiamo oggi:
fu infatti Napoleone Bonaparte in persona a consegnare alla prima coorte della Legione Lombarda (un corpo di volontari che
avrebbero affiancato l’esercito francese contro le offensive austriache), con una solenne cerimonia davanti al Duomo di Milano, una bandiera a strisce verticali verde (all’asta), bianco (al centro) e rosso (al battente), dove il bianco e il rosso andavano
a richiamare i colori dell’antico stemma comunale di Milano (una croce rossa su uno sfondo bianco) e il verde era, dal 1782,
il colore della Guardia Civica Milanese (ma va anche sottolineato la somiglianza che il drappo aveva con la bandiera francese,
dalla quale si distinse solo per la sostituzione del blu con il verde).
La bandiera, oltre ai tre suddetti colori, al centro era caratterizzata da una ghirlanda di foglie di quercia all’interno della quale
si trovavano su un lato un berretto frigio (simbolo di libertà fin dall’antica Roma, poiché veniva indossato dagli schiavi affrancati, fu usato anche durante la Rivoluzione Francese), un compasso e la scritta “Legione Lombarda Coorte n. 1”, con sopra la
frase “Subordinazione alle leggi militari” riportata su un finto nastro svolazzante; sull’altro lato nuovamente il berretto frigio,
il compasso, i due pugnali di Bruto e Cassio, mentre l’iscrizione sul nastro era “Eguaglianza o morte”.
Anche le altre coorti componenti la Legione Lombarda furono dotate di questo tipo di bandiera (in realtà i vessilli delle varie coorti non furono tutti uguali ma differirono per alcuni particolari). Il più antico tricolore conservato in Italia si trova al
Museo del Risorgimento a Milano: si tratta del vessillo militare dei Cacciatori a cavallo della Legione Lombarda, una bandiera
quadrata di seta ricamata con le frange dorate. In Italia, il primo tricolore verde – bianco – rosso fu introdotto pertanto sotto
l’occupazione francese e fu una bandiera militare e non nazionale. All’inizio del 1797, a Reggio Emilia, un congresso formato
dai rappresentanti di quest’ultima città e delle provincie di Modena, Bologna, Ferrara proclamò la nascita della Repubblica
Cispadana: il 7 gennaio 1797, il deputato Giuseppe Compagnoni propose di rendere “universale lo Stendardo o Bandiera Cispadana
di tre colori Verde, Bianco e Rosso e che questi tre colori si usino anche nella Coccarda Cispadana, la quale debba portarsi da tutti”, in tal modo
fu decretato per il tricolore il passaggio da un uso militare ad un significato di bandiera di Stato. Le strisce da verticali passarono ad essere orizzontali con il bianco sempre in posizione centrale, il rosso nella parte superiore e il verde in quella inferiore.
Il centro del campo bianco fu occupato dallo stemma della Repubblica Cispadana (composto da una corona di alloro al cui
interno compaiono un turcasso con 4 frecce, alla base del quale stanno un tamburo militare, delle lance, un fascio littorio, un
cannone e due bandiere rosse, bianche e verdi) ai cui lati furono inserite le lettere R C (le iniziali di Repubblica Cispadana). Il
29 giugno 1797 Napoleone annunciò la formazione della Repubblica Cisalpina che combinò insieme la Repubblica Cispadana
e quella Transpadana (corrispondente al vecchio ducato di Milano. Il nuovo stato, dichiarato da Napoleone libero ed indipendente dalla Francia, può essere definito come l’embrione della futura Italia unita. Nel maggio del 1798 il Gran Consiglio della
Repubblica Cisalpina decise che “La Bandiera della Nazione Cisalpina è formata di tre bande parallele all’Asta, la prossima all’asta, verde,
la successiva bianca, la terza rossa”.
In seguito alla conquista francese di parte dell’Italia settentrionale, nacquero anche altre repubbliche: la Repubblica Romana (dal febbraio del 1798 al settembre del 1799), adottò come bandiera un tricolore nero all’asta, bianco al centro, rosso al
battente; durata ancor più breve ebbe invece la Repubblica Partenopea che, nonostante i soli 5 mesi di vita nel 1799, si dotò
anch’essa di un proprio tricolore, blu, giallo e rosso. Nella primavera del 1799 i territori occupati dalla Francia furono invasi
dalle truppe austro-russe della II coalizione anti-francese: gli Asburgo tornarono a comandare sul suolo italiano decretando la
soppressione della Repubblica Cisalpina che Napoleone riuscì tuttavia a ricostituire nel 1800.
Due anni dopo, la Cisalpina fu trasformata in Repubblica Italiana, con Bonaparte presidente. La spinta rivoluzionaria
proveniente dalla Francia si stava ormai esaurendo e la volontà del governo in carica fu proprio quella di far dimenticare in
un certo senso da dove tutto aveva avuto inizio. L’immagine del tricolore, con le sue tre bande verticali, richiamava alla mente
troppo prepotentemente la genesi rivoluzionaria dalla quale era derivato. Fu perciò stabilito che la foggia della bandiera nazionale fosse mutata in un quadrato rosso, contenuto in un rombo bianco, inscritto a sua volta in un quadrato verde: si mantennero pertanto immutati i tre colori ma si cambiò del tutto la forma del drappo. L’aspetto della bandiera subì tuttavia una
nuova modifica nel 1805 quando Napoleone si autoproclamò sovrano del Regno d’Italia, il nuovo stato che andò a sostituire
la precedente Repubblica Italiana: l’aspetto della bandiera rimase simile a quello adottato per il drappo repubblicano, si andò
a sostituire la forma quadrata con una rettangolare ma il vero elemento di novità fu costituito dall’inserimento, all’interno del
n 51 m
campo verde centrale, dell’aquila imperiale. Alla caduta di Napoleone seguì un immediato mutamento dell’assetto territoriale
italiano: tra il 1814 e il 1815, il Congresso di Vienna, a cui parteciparono le più grandi potenze europee, si occupò di ridefinire i
nuovi confini degli stati, in base all’Ancien Régime. La Repubblica di Venezia insieme a parte della Lombardia andò a costituire
il Regno Lombardo-Veneto governato dagli Asburgo; ai Savoia spettarono Piemonte, Sardegna e Liguria; il Regno di Napoli
fu riconsegnato ai Borboni (che lo uniranno a quello di Sicilia nel 1816, formando il Regno delle Due Sicilie); fu ricostituito lo
Stato Pontificio e i Lorena tornarono al potere nel Granducato di Toscana.
Il Tricolore e il suo significato simbolico non erano mai però del tutto scomparsi, tanto che il drappo verde, bianco e
rosso tornò a sventolare fieramente tra le mani degli insurrezionalisti durante i moti risorgimentali del 1820-21 a Napoli e a
Torino. Una vera e propria concezione di unità d’Italia era da considerarsi ancora prematura, come testimoniato dal fatto che
accanto alla bandiera verde, bianca e rossa veniva issata anche la bandiera della carboneria, a tre bande orizzontali blu, rosso
e nero. Le rivolte contro i reali che governavano la penisola, divisa ancora in vari stati, erano tuttavia destinate a continuare: la
popolazione era spinta da un desiderio di democrazia a cui si stava andando a congiungersi, con il passare del tempo, anche
una sempre più profonda concezione di unità nazionale, che chiaramente mal si accordavano alla presenza di regnanti stranieri
sul territorio. L’ondata rivoluzionaria arrivò anche in Italia e nel febbraio del 1831 scoppiò una rivolta a Modena e che in pochissimo tempo si estese a Reggio Emilia, Ancona, Parma e Bologna; le truppe austriache tuttavia non tardarono ad arrivare
e la sollevazione fu soffocata velocemente. Fino a quel momento nessuna sommossa aveva avuto la partecipazione popolare
che invece avevano registrato i moti del 1831, i cui partecipanti, in qualunque città si trovassero, furono accomunati dal fatto
di stringere il tricolore verde, bianco e rosso, il quale, senza più ombra di dubbio, adesso rappresentava innegabilmente un
radicato e fortemente ambito desiderio di unità e liberazione dal principe straniero.
Il 1831 fu anche l’anno di nascita della Giovine Italia, un’associazione politica fondata a Marsiglia da Giuseppe Mazzini,
che aveva come obiettivo la trasformazione dell’Italia in un paese unito, governato da una repubblica democratica. La bandiera
scelta da Mazzini fu il tricolore verde, bianco e rosso, su un lato campeggiavano le parole “libertà”, “uguaglianza”, “umanità”,
sull’altro “unità”, “indipendenza”. Essendo l’unità di Italia il principio base della Giovine Italia, si può capire come grazie ad
essa il Tricolore divenne un simbolo che ormai non aveva più limiti campanilistici ma che richiamava invece sotto di sé tutta la
popolazione dalle Alpi fino in Sicilia, diventando lo stendardo di tutti coloro che volevano unirsi in un unico stato democratico
e libero dalla presenza straniera.
Il tricolore svolse il ruolo di bandiera nazionale durante gli avvenimenti del 1848 – 49. Nelle insurrezioni di quegli anni, il
drappo verde, bianco e rosso fu adottato in maniera spontanea da tutti i sovversivi. La prima sommossa avvenne nel gennaio
del 1848 a Palermo: la Sicilia si dichiarò stato indipendente e assunse come bandiera il tricolore ornato al centro con l’immagine della triscele. A Venezia un’insurrezione portò alla fuga degli austriaci e alla creazione della Repubblica di San Marco la
cui bandiera fu costituita dal tricolore in cui venne inserito, all’interno di un campo bianco circondato da un bordo tricolorato
posto nell’angolo in alto a sinistra, il leone veneziano. A Milano invece la popolazione si scontrò duramente con l’esercito
asburgico durante le famose “Cinque giornate di Milano”, fino a quando le truppe straniere furono costrette al ritiro. Il 23
marzo 1948 il re Carlo Alberto di Sardegna dichiarò guerra all’Austria, dando così avvio alla I Guerra di Indipendenza italiana.
Il re ordinò che le truppe militari si muovessero nell’avanzata presentando come vessillo il tricolore adornato con lo stemma
dei Savoia. Si dovette perciò decretare la foggia ufficiale della nuova bandiera di stato; Bigotti, segretario del Ministro dell’Interno, si occupò di disegnare tre possibili modelli di forma quadrata: fu scelta la soluzione con lo stemma centrale ma, poiché
l’immagine dello scudo dei Savoia non era ben delineata visto che il rosso e il bianco dello stemma si andavano a sovrapporre
agli stessi colori del tricolore, si aggiunse all’emblema una bordatura azzurra.
Di fronte allo scoppio di tale guerra, lo schierarsi (almeno iniziale) degli altri regnanti della penisola a favore do Carlo
Alberto comportò delle modifiche nella foggia delle bandiere dei vari regni: Ferdinando II dichiarò che la bandiera del Regno
delle Due Sicilie era costituita da un rettangolo verde contenente un rettangolo rosso, contenente a sua volta un rettangolo
bianco al cui centro fu collocato lo stemma dei Borboni mentre il granduca Leopoldo II inserì al centro del tricolore a bande
verticali lo stemma degli Asburgo – Lorena.
Dopo la fuga di Papa Pio IX a Gaeta, il 9 febbraio del 1849 a Roma venne costituita la Repubblica Romana, governata dal
triumvirato composto da Giuseppe Mazzini, Carlo Armellini e Aurelio Saffi. Il nuovo stato adottò come propria bandiera il
tricolore a fasce verticali, verde, bianco e rosso, sulla cui asta fu collocata l’aquila romana, ma anche un altro tipo di tricolore
fu esposto durante i giorni della Repubblica Romana: quello mazziniano con l’inconfondibile scritta “Dio e Popolo” (una
bandiera di questo tipo è conservata al Museo del Risorgimento di Milano). Nel marzo del 1849 il re Carlo Alberto decise
di abdicare in favore di Vittorio Emanuele II e i vecchi regnanti tornarono nuovamente sui loro troni, fino all’inizio della II
Guerra di Indipendenza del 1859: in giugno si dichiarò l’annessione della Lombardia al Regno di Sardegna e, grazie alla politica
di Camillo Benso conte di Cavour, nei mesi successivi al Piemonte si unirono anche la Toscana, Parma, Modena, l’Emilia e la
Romagna. A seguito dello sbarco a Marsala di Garibaldi ed i suoi 1000 uomini, il re Francesco II di Borbone tentò di ingraziarsi
il popolo adottando come bandiera il tricolore a fasce verticali, con lo stemma borbonico posizionato al centro; tuttavia questa
n 52 m
concessione nulla poté contro l’offensiva dei garibaldini. Il plebiscito del 21 ottobre 1860 decretò l’annessione del Regno delle
Due Sicilie a quello di Sardegna. Cinque giorni dopo, a Teano, Garibaldi consegnò simbolicamente i territori da lui conquistati
nelle mani di Vittorio Emanuele II.
Il 17 marzo 1861 fu proclamata la costituzione del Regno di Italia, di cui fu incoronato re Vittorio Emanuele II. A seguito
della nascita del nuovo stato sembrò naturale assumere come stendardo nazionale il tricolore con lo stemma sabaudo centrale
(adesso però raffigurato interamente nel campo bianco, senza andare a sormontare le fasce verde e rossa) anche se la mancanza
di una qualche normativa che decretasse in modo certo come si dovesse realizzare il drappo portò alcune volte alla creazione
di bandiere non esattamente uguali tra loro. In questi anni si cercò di indirizzare il popolo verso un sentimento di identità
nazionale e questo compito fu affidato prima di tutto alle scuole e all’esercito: il tricolore sabaudo era il simbolo dell’unità,
della liberazione dall’oppressore straniero e la sua presenza nelle città faceva da collegamento tra la storia del singolo paese e
quella della nazione intera.
Intanto, nel 1866 con la conclusione della III Guerra di Indipendenza, il Veneto veniva annesso al Regno d’Italia: la nazione
era finalmente unita. Va detto che l’ottenuta unità della nazione non ebbe come conseguenza una profusione di cerimonie ufficiali in onore della bandiera: solo negli anni 1896 e 1897, in occasione del centenario della bandiera della Legione Lombarda
e di quella della Repubblica Cispadana, si tennero alcune celebrazioni pubbliche.
La storia del tricolore passò attraverso la I Guerra Mondiale, durante la quale la bandiera fu un attributo indispensabile per
i soldati dell’esercito che con essa testimoniavano il mettere la loro vita a repentaglio per la patria, per arrivare al periodo fascista. Il fascismo si appropriò del tricolore esaltandolo in tutte le celebrazioni del regime in modo tale da infondere nel popolo
un culto della patria che automaticamente era possibile intendere come una legittimazione alla stessa esistenza del regime. Nel
1925 si colmò la lacuna della mancanza di una legge che decretasse in modo certo la foggia del tricolore: “La bandiera nazionale,
è formata da un drappo di forma rettangolare interzato in palo, di verde, di bianco e di rosso, col bianco coronato dallo stemma Reale bordato d’azzurro”. Dopo la fine della II Guerra Mondiale e a seguito della caduta del fascismo, il tricolore da un lato fu considerato come
un attributo del regime fascista, visto l’uso e la propaganda che ne aveva fatto tale governo; dall’altro fu visto come simbolo
di rinascita, incarnando quegli ideali di libertà che da sempre erano connessi al drappo verde, bianco e rosso ed essendo stato
utilizzato anche dai movimenti che invece si erano opposti a Mussolini: a testimonianza di questo duplice sentimento vi sono
le migliaia di bandiere tricolorate, ma dalle quali era stato tagliato lo stemma sabaudo centrale, che sventolarono nelle piazze
anche una settimana prima dell’ufficializzazione della nascita della Repubblica Italiana.
Il 19 giugno del 1946, il nuovo governo decise che la bandiera dello stato italiano era da considerarsi il tricolore rettangolare, a fasce verticali di uguali dimensioni, con il verde all’asta, il bianco al centro e il rosso al battente e senza lo stemma
sabaudo; a fine dicembre dell’anno seguente tale dichiarazione fu inserita nella Costituzione andando a costituirne il già citato
dodicesimo articolo. Il rispetto che l’Italia esige per il proprio tricolore, visto ciò che esso simboleggia per la nostra nazione, è
testimoniato anche dall’esistenza del reato di vilipendio alla bandiera per cui “Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge,
disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni”
(art. 292 del Codice Penale).
n 53 m
Tricolore della Legione
Lombarda Cacciatori a
cavallo, 1796 (Museo del
Risorgimento, Milano)
Bandiera della Repubblica Cispadana,
1797
Bandiera della Repubblica
Cisalpina, 1798 – 1802
Bandiera della Repubblica Italiana,
1802 – 1805
Bandiera del Regno Italico,
1805 – 1814
Bandiera del Regno Italico,
1805 – 1814
Bandiera del Regno di Sardegna,
1848 – 1861
Bandiera del Granducato
costituzionale di Toscana
1848 – 1849
Bandiera del
Granducato
costituzionale di
Toscana 1848 – 1849
Bandiera nazionale
italiana, dal 1946
54
n 55 m
ALCUNI PATRIOTI
Sottotenente Fossati-Renyeri
conte Carlo dei Lanceri di Montebello 1861
Colonnello Giovanni Battista Cocconi 1863,
comandante del 23° reggimento Fanteria Brigata Como
n 56 m
Gruppo di ufficiali di Artiglieria del 1863
Furiere maggiore del 40°
reggimento Fanteria 1865
Collezione Arturo Agnesina
n 57 m
Caro Sgarallino
Grazie per il gentile invio delle schiacciate e dei salami.
Un caro saluto alla famiglia dal Vostro
G. Garibaldi
Caprera 11 Aprile 1871
Lettera inviata dal generale Giuseppe Garibaldi ad Andrea Sgarallino
n 58 m
Pino, 11 Decembre 59
Certifico che Giovannoni Gaetano – che milita nei Cacciatori delle Alpi è stato ferito sul naso nel combattimento
di Malnate in mia presenza – e che si è comportato da valoroso
G. Garibaldi
Lettera inviata dal generale Giuseppe Garibaldi dove si attesta il ferimento del volontario cecinese Gaetano Giovannoni
n 59 m
Spada, fotografia con la famiglia e attestato di attribuzione di medaglia
per la partecipazione alla guerra per l’Indipendenza nella campagna del
1859 rilasciato il 7 giugno del 1863 ad Agostino Gianneschi, uzzanese
nato nel 1838 e deceduto nel 1919. Suo nipote vive attualmente a Cecina
n 60 m
Decreto con cui si istituisce il triumvirato in toscana, firmato da Mazzini, Montanelli e Guerrazzi, 1849
n 61 m
Prima pagina della Nazione, datata domenica 17 marzo 1861, giorno in cui fu fatta l’Italia
n 62 m
Si ringrazia:
AFBIS Associazione Fiorentina Battaglie in Scala, Arturo Agnesina – Miles, Archivio Storico Comunale di Cecina, Associazione Miles, Associazione Napoleonica d’Italia, Associazione Nazionale Bersaglieri, Franco Belcari, Biblioteca Nazionale
Centrale di Firenze, C.E.R.S., Circolo Filatelico – Numismatico di Cecina, Guglielmo Ciulli, Comune di Cecina, Cooperativa
il Cosmo, Coro “Amichorum, Domus Mazziniana, Pietro Finelli, Fondazione Corriere della Sera, Eri Gianneschi, Guido
Giovannoni, Umberto Giovannoni, Istituto Geografico Militare di Firenze, Istituto Mazziniano - Museo del Risorgimento di
Genova, Damiano Leonetti, Stefano Lumini, Andrea Mandroni, Ilio Nencini, Giampaolo Papadopulo, Marco Andrea Piermartini, Manuela Pizzi, Massimo Polimeni – Miles, Raffella Ponte, Enrico Ricciardi, Federico Rovini, Luciano Rustici – Miles,
Enrico Salvi, Scuola Comunale di Musica di Cecina “Sarabanda”, Michela Sgarallino.
Riferimenti fotografici:
Pag 4
Pag 6
Pag 12-14
Pag 19-21-23
Pag 26-27
Pag 29
Pag 36
Pag 41-42
Pag 43
Pag 48
Pag 56-57
Pag 58
Pag 59
Pag 60
Pag 61
Pag 62
Collezione Piraino - Domus Mazziniana
Collezione Famiglia Sgarallino
Collezione F.lli Alinari Firenze
Mappe Enrico Ricciardi
Collezione Famiglia Sgarallino
Collezione Guglielmo Ciulli
Collezione Privata
Collezione Massimo Polimeni - Miles
Miniature Enrico Ricciardi
Collezione Istituto Mazziniano-Museo del Risorgimento di Genova
Collezione Arturo Agnesina – Miles
Collezione Famiglia Sgarallino
Collezione Umberto e Guido Giovannoni
Collezione Eri Ganneschi
Collezione Domus Mazziniana
Collezione Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
n 63 m
Finito di stampare
nel mese di gennaio 2011
presso Bandecchi & Vivaldi - Editore