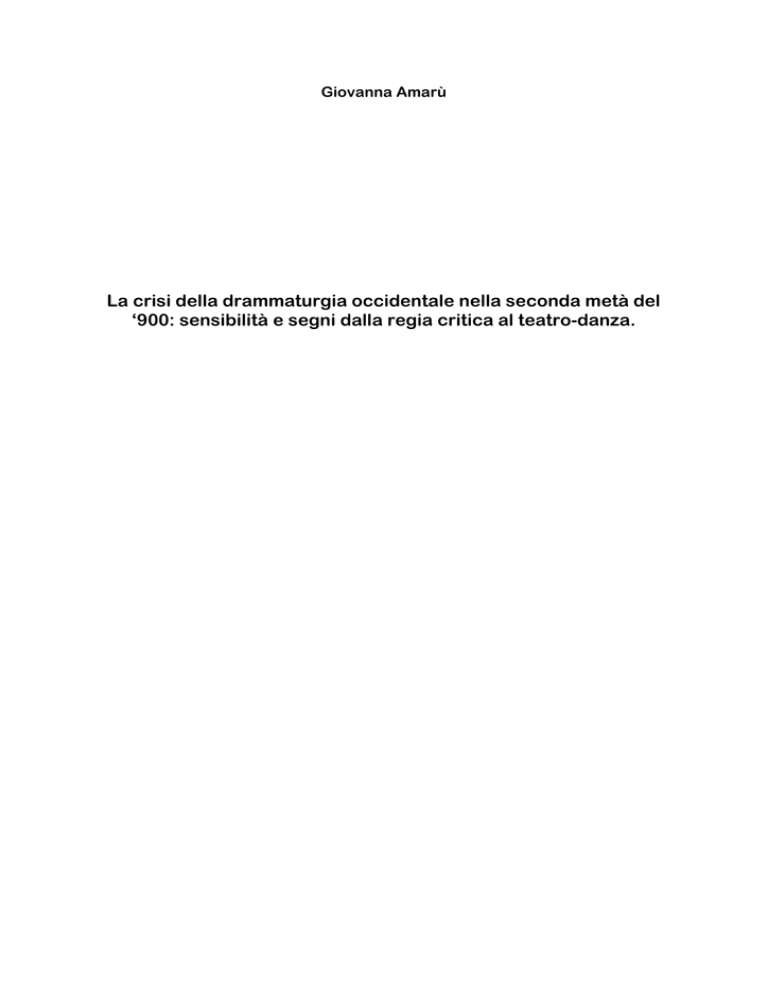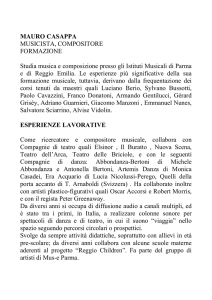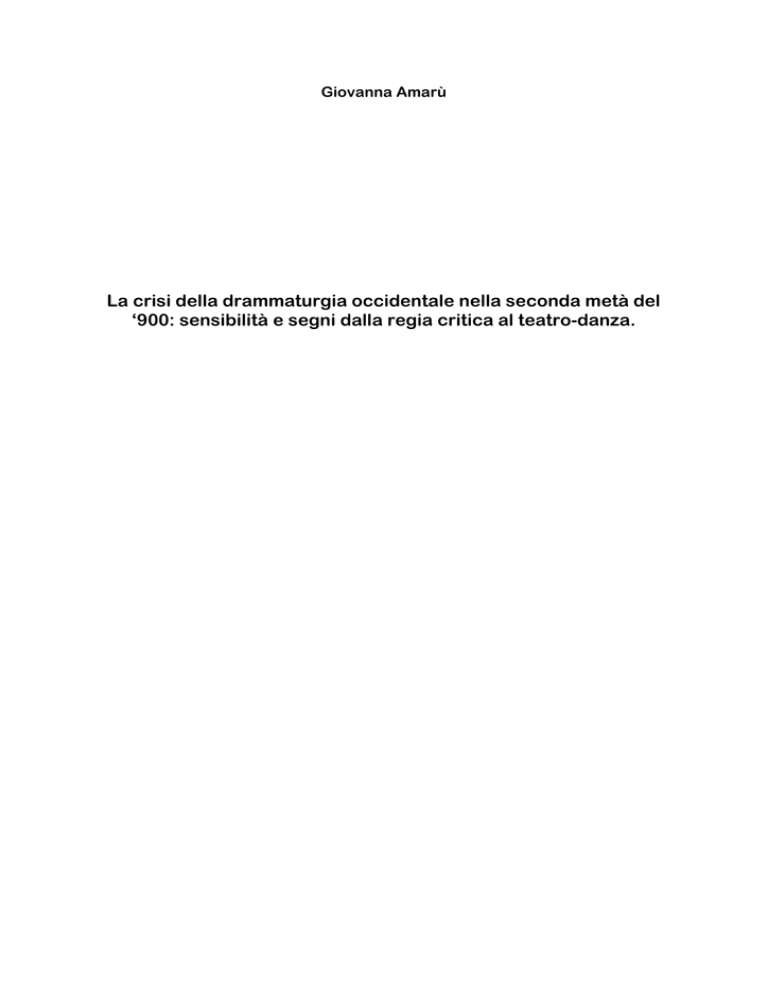
Giovanna Amarù
La crisi della drammaturgia occidentale nella seconda metà del
‘900: sensibilità e segni dalla regia critica al teatro-danza.
Indice
Nota introduttiva…………………………………………………………...... 3
Dramma e drammaturgia…………………………………………………... 6
Coreutica e coreografia.................................................................. 8
Quale “Testo”?............................................................................... 12
Quale “Spazio”?..............................................................................15
Problemi tecnici e contaminazioni.................................................. 20
La regia critica...............................................................................28
La drammaturgia del silenzio..........................................................30
Le povere cose...............................................................................37
Lo sguardo di Narciso.................................................................... 44
Teatro iconoclasta...........................................................................47
Giano bifronte................................................................................ 53
Di nero vestita................................................................................ 56
Percorsi d’avanguardia…………………………………………………….. 59
Bibliografia essenziale………………………………………………………..
61
2
Nota introduttiva.
Parlare della crisi della drammaturgia teatrale nella seconda metà del ‘900 equivale al
tentativo di dare uno sguardo d’insieme al paesaggio europeo all’indomani della seconda
guerra mondiale: la memoria delle precedenti esperienze appare in frammenti, in una realtà
policentrica dove a ciascuno incombe l’immenso compito di ricostruire la città del teatro,
sceglierne la forma e ritrovarvi un senso possibile. Le riflessioni e le esperienze condotte in
occidente nel primo trentennio del XX secolo fanno esplodere e contemporaneamente
fecondano le “forme” drammatiche, mettendo in discussione i punti cardinali del luogo teatro:
il testo, lo spazio, la regia, l’attore erano infatti divenuti l’oggetto di un ripensamento globale
nell’opera di Appia, Craig, Artaud, Copeau, Mejerchol’d, Stanislavskij. Ogni categoria
sistematica è coinvolta in un processo che la trasforma in categoria storica, ove le singole
esperienze partecipano dell’evoluzione del “significante” del teatro. In questo paesaggio
stravolto dalle istanze forti poste da alcuni maestri, i confini del teatro divengono labili ed
improntati
più che mai dall’esperienza individuale, dalla sistematicità delle domande
identitarie. Fondamentale è senza dubbio, nel processo di ricostruzione del teatro, la
ridefinizione dei modelli di produzione e diffusione sulla base delle sovvenzioni statali a
partire dagli anni ’50. Il teatro diviene un vero e proprio servizio pubblico, con modalità
leggermente diverse secondo i vari paesi europei, organizzandosi sistematicamente in
funzione della protezione del bene “repertorio” nonché di una promozione del “territorio”.
Ben diversa sarà la situazione statunitense, dove il teatro resterà per lo più fondato
sull’attività commerciale dando paradossalmente adito ad una serie di esperimenti di rottura
a cui gli artisti europei faranno costante riferimento. In questa sede, il quadro sociale
economico e politico che fa da sfondo al ripensamento del teatro verrà toccato solo
marginalmente, ma chi scrive e chi legge è ben cosciente di guardare alle problematiche
artistiche attraverso quella lente deformante che è la dialettica con il potere delle istituzioni.
Parimenti si è voluto, per quanto riguarda l’indagine sulle poetiche teatrali degli ultimi
cinquant’anni, compiere una scelta, non esaustiva né cronologicamente né geograficamente,
su alcune figure di riferimento particolarmente significative rispetto all’azione estetica e
drammaturgica, suscettibili di fornire molteplici appigli ad un discorso analitico . Tali figure
della regia “critica “, del teatro danza o semplicemente non classificabili rispetto ad una
tendenza o ad una tecnica, mi sono parse fondamentali per esplorare quelle linee e quei
territori di confine che si collocano tra drammaturgia e coreografia, tra i concetti di spazio e
di testo, in un rimando continuo con le istanze innovatrici del primo novecento e con percorsi
ed esiti radicalmente diversi. I necessari rimandi ad alcune epoche storiche non strettamente
pertinenti a questo lavoro, vogliono tendere ad evidenziare alcuni nuclei problematici inerenti
al continuo gioco di riferimento e superamento della tradizione, nonché al cambiamento di
senso delle terminologie del discorso teatrale, per rendere conto della complessità inerente
alle “sensibilità” ed ai “segni” che il teatro costantemente eredita e produce. Ma quali
strumenti di analisi si offrono a chi volesse accostarsi ai fenomeni estetici contemporanei
senza entrare in categorie psicologiche, antropologiche o ideologiche? Ed ancora, è
3
possibile una teoria omnicomprensiva delle pratiche artistiche che non stritoli nello stesso
abbraccio e la cosa e il discorso, compromettendo il senso? In “Teatro come differenza”
Antonio Attisani precisa: ”L’attuale carenza teorica attorno al teatro non è dovuta soltanto al
senso pratico dei suoi addetti, ma anche alla loro diffusa incultura, a volte subíta come
condizione di inferiorità rispetto all’ambito critico o accademico, a volte ancora scelta
opportunisticamente per evitare una presa di posizione che rischia di restringere il proprio
mercato o di sottrarre indispensabili protezioni. Tuttavia è da chi fa teatro che provengono,
magari sotto forma di narrazione delle esperienze, gli spunti teorici più interessanti, mentre
critica e università, ancora troppo prese dalle contraddizioni dei rispettivi ambiti,
intrattengono ancora con il teatro un rapporto distaccato, guardingo e/o speculativo”. Una
teoria che si fa dunque necessaria in quanto poetica e critica delle esperienze, in quanto
attenta al “macrofenomeno” teatro nel suo divenire, nella sua globalità, essendo questo
deposito di singoli segni ma soprattutto sintesi autonoma rispetto ad essi. Ma
essenzialmente, il discorso teorico scandaglia e delinea il senso dell’oggetto, lo colloca e lo
mette al mondo attraverso il linguaggio. Quest’ultimo, si trova ad essere lingua o parola posta
di fronte ai linguaggi di diversa natura adottati dal teatro, dunque metadiscorso,
essenzialmente verbale, sull’arte. Lo strumento teorico ed analitico si assottiglia quindi
inesorabilmente non appena ci si avvicina alle zone più rarefatte della musica, della danza o
dell’arte figurativa. L’importante disproporzione fra le riflessioni teoriche sulle varie
discipline artistiche si giustifica, mi pare, secondo che queste si trovino o no nella loro
“naturale” sede verbale per cui, poiché la parola scritta è “storicamente” la traccia durevole
per eccellenza e ciò che resta sembra essere la cosa più importante, bisognerà ammettere la
voracità con la quale, nonostante tutto, il teatro viene riassorbito nell’immaginario collettivo
in una zona inerente ed afferente al verbo ed, in definitiva, al logos. “È così che il visibile, e
anche l’udibile, si trova regolato dal dicibile. (…) Da una parte si potrebbe dire con altrettanta
esattezza che il dicibile si adegua al visibile: che il percepito richiama la designazione, al
limite: che la cosa richiama la parola e che la parola imita la cosa” 1 .Da cui la particolare
difficoltà d’ abbracciare in un’unica prospettiva di ricerca lavori teatrali in cui segni verbali e
non verbali abbiano un peso radicalmente diverso, opere dietro le quali sia presente o meno il
referente letterario, musicale o figurativo. Un lavoro puramente coreografico ad esempio,
conterrà, per motivi che tenteremo in seguito d’analizzare, una massa di “segni” meno
“disponibili” ad essere analizzati, in modo pertinente, dalla teoria o dalla critica rispetto ad
una rappresentazione dell’Amleto. In questa prospettiva di fondo mi è parso utile individuare
le linee della crisi drammaturgica novecentesca nella polarità fra segni e sensibilità
emergenti da alcune pratiche artistiche. I greci utilizzavano la parola sèma per indicare sia la
tomba che il segno. Segno memoria ed eredità dimorano quindi legati ed è bella inoltre
l’ambiguità etimologica con séma, la semenza, l’avvenire. Alla pietra miliare del segno
risponde il viandante con uno sguardo sensibile, suscettibile al senso ed ai sensi, per
definizione votato alla fragilità ed al mutamento. Si tratta, mi sembra, di questo:“ Il linguaggio,
1
Mikel Dufrenne, L’arte e i discorsi ,in E.Garroni , Estetica e linguistica Bologna Il Mulino, 1983,pag.9
4
se non è principio della percezione, almeno la regola. L’oggetto è riconosciuto e in qualche
modo controllato solo se dominato e predicato (…). L’uomo è al mondo solo grazie alla
mediazione del linguaggio, anche quando si convince che il linguaggio è impotente a dire
ogni cosa”. 2
2
Mikel Dufrenne L’arte e i discorsi
, op.cit.,pag.10
5
Dramma e drammaturgia.
La parola dramma, dal greco drama (azione, storia; da dran, fare), è una forma letteraria che
include parti scritte per essere interpretate da attori. Nel teatro, il dramma ha mantenuto
l'accezione in uso nell'Antica Grecia, dove indicava un qualsiasi componimento destinato alla
scena, fosse esso una tragedia od una commedia, la cui struttura interna, concepita per la
rappresentazione, equivaleva all’azione teatrale. Pur essendo oggi sinonimo di testo o opera
teatrale, il termine, dal punto di vista strettamente etimologico, mantiene in realtà una sorta
di neutralità, nella sua accezione di qualcosa che si “fa” dunque che “accade” rispetto al
verbo poieô, creare, da cui derivano i termini di poesia e poetica. Occorre dunque
distinguere in questa sede poiesi e dramma, come fra un ab initio ed un present continuous
del teatro, notando tra l’altro che nel dramma antico l’elemento scatenante, l’azione
primigenia è semplicemente nominata e nominale e che gli “attanti” vivono nel prolungamento
di un’azione conseguente e derivata da qualcosa di non rappresentato. L’azione è in questo
senso spesso riflessa dall’”esposizione” dei fatti, la parola esprime e nasconde al contempo
ciò che è accaduto. Si legano qui, indissolubilmente, al dramma la duplice presenza di
letteratura ed attore, ossatura e carne di ciò che accade in un altrove e che si fa teatro; il
dramma, sulla scia di un primigenio atto creativo, diventa presenza e voce, dinamica e suono.
La struttura del teatro greco si configura come un alternanza organica di parola drammatica
che narra l’azione e di commento, da parte del coro, che sospende il corso degli avvenimenti
attraverso un punto di domanda, che è allo stesso tempo lirico ed intellettuale. È interessante
notare che il concetto di dramma e drammaticità è legato maggiormente ad un dialogo che
non ad un monologo, come mostra l’introduzione della sticomitia 3 nel dramma antico in
quanto elemento fortemente dinamico in momenti di particolare densità emozionale. È con la
presenza di almeno un altro attore dialogante (il deuteragonista si aggiunge con Eschilo al
protagonista) che si può meglio esprimere la caratteristica principale del dramma: il
contrasto tra almeno due differenti elementi, il necessario rimando all’altro nell’ azione
comunicativa. Il binomio dramma-conflitto giustifica dunque l’uso comune dell’aggettivo
“drammatico” per descrivere eventi di portata tragica o esistenziale. Il progressivo
atrofizzarsi del coro e la scomparsa del suo ruolo interrogatorio rispetto al comportamento
dei protagonisti farà evolvere i rapporti, sia nella tragedia che nella commedia, da un conflitto
di destini ad un conflitto di caratteri, riportando, come accadrà nel dramma borghese
dell’800, il dramma ad una dimensione avulsa da un’indagine mitica e filosofica e dalla critica
politica.
Più complessa è la definizione di “drammaturgia”, poiché questa rimanda effettivamente
all’opera drammatica nel suo complesso. Vi è nel termine “drammaturgia” un aspetto
assolutamente tecnico e strutturale della concezione dell’opera, aspetto che, nel corso dei
secoli, ha subito modificazioni profonde e resta tutt’oggi non privo di ambiguità. Per quella
3
Nella tragedia greca e latina, dialogo spec. di tono intensamente drammatico, in cui ogni battuta corrisponde a un
verso.
6
legge sopraccitata che premia ciò che di un’opera resta, la definizione di drammaturgia è
venuta a coincidere in modo preponderante con quella di letteratura drammatica, dunque
con l’opera del drammaturgo. Quindi se da un lato il dramma si lega al binomio letteraturaattore,
restando,
per
così
dire,
ancorato
all’”evento”
della
rappresentazione,
la
drammaturgia sposa il binomio letteratura-autore. Ma chi è l’autore di un’opera
teatrale?Quale ruolo assume lo scrittore, l’attore, il regista, il pubblico nella creazione di un
impianto drammaturgico? La drammaturgia è forse la risultante di più atti creativi che vanno
al di là dell’evento spettacolare, la somma delle varie funzioni svolte in teatro?Si delineano
così nel XX secolo una serie di problematiche e forse di aporie concernenti le figure primarie
del teatro, con l’avvento di numerosi contributi atti a sottolineare la priorità della
“reinvenzione” di una tecnica per l’attore, ma soprattutto con l’affermazione del principio di
regìa come il solo capace di dare un’impronta poetica unitaria alla struttura drammaturgica.
La nuova estetica teatrale del ‘900 impone una autonomia dell’evento scenico, su basi
astratte e rigorosamente non-imitative. Non più dunque drammaturgia esclusivamente
afferente alla letteratura, ma complesso di relazioni significative o funzionali che si
stabiliscono tra le componenti di un’opera artistica, insieme delle relazioni formali di un
linguaggio indipendenti dal valore semantico delle singole componenti e, in definitiva,
drammaturgia come sintassi. Una sintassi che per definizione procede alla coordinazione
degli elementi verbali,spaziali, temporali ed umani fino alle estreme conseguenze della
propria autonomia estetica, fino all’esplorazione di territori che ricadono al di là ed al di qua
degli stessi confini teatrali.
7
Coreutica e coreografia.
Il termine coreutica significa arte della danza, dall'antico greco koreia, danza, da cui deriva
anche coro, poiché questo interveniva nel dramma danzando. Occorre puntualizzare, pur
dando per buona l’accezione comune del termine, che la koreia era nel teatro greco una
tecnica di sintesi tra il linguaggio della poesia, della musica e della danza di cui oggi è difficile
immaginare un equivalente nei nostri spettacoli. L’arte della danza alla quale faremo
riferimento è quella colta occidentale, vale a dire quella elaborata nel continente europeo (
Russia compresa) ed in seguito americano, su basi tecniche e di fruizione radicalmente
diverse rispetto alle danze popolari, anche se in parte quest’ultime, ad esempio nel balletto
russo, vengono a volte reintegrate nel repertorio classico con il nome di danze di carattere.
L’analisi del “linguaggio” danzato nasconde non poche insidie, soprattutto perchè a partire
da considerazioni strettamente semiologiche e cinesiche si ricade quasi sistematicamente al
di fuori dell’oggetto in questione. Non si tratta qui infatti né di un linguaggio ricalcato su un
modello verbale, come nel linguaggio dei segni appunto, né di un vocabolario mimetico, come
nella pantomima. Tuttavia è certamente possibile analizzarne le strutture e le tecniche come
fossero le sue leggi interne o “grammatiche” a patto di restare ancorati al significante e di
non confondere la produzione di significato (il famoso “messaggio” che tanto amano i
giornalisti)
con quella di senso. A questo proposito, una volta bandito il concetto di
significato, l’analisi del senso si complica ulteriormente. A rigore “semantico” infatti, ogni
segno acquisisce un senso determinato e costante solo se incluso all’interno di un contesto
semiotico comune, un codice di segni condiviso, costruito attraverso la pratica sociale. Nella
danza colta occidentale, il codice di segni in questione esiste come somma delle tecniche
“storiche”, è condiviso quasi esclusivamente dagli addetti ai lavori ed in ogni caso non ha mai
un senso determinato e costante. Diversamente, nella danza africana tradizionale si può
parlare di condivisione attraverso la pratica sociale, poiché le danze hanno una loro
specificità comunitaria e rituale. Il senso prodotto dalla danza sembra dunque essere
particolarmente “mobile” a secondo del contesto in cui ha sede il “discorso”. Situazione,
contesto e sottintesi culturali, che già nel linguaggio verbale giocano un ruolo importante,
sembrano qui essere fondamentali ad un senso esperibile. Ma cos’è la danza? Rispondendo
d’istinto ad una domanda impossibile, se la parola musica evoca un suono, la danza
immediatamente richiama a sé il corpo, in una specie di coincidenza fra la cosa e lo
strumento della cosa. Il corpo che immagino è inoltre in movimento, un movimento astratto,
non “funzionalistico” o “utile” come nell’uso quotidiano, di qualità complessa. All’alba del XX
secolo si situa un cambiamento culturale che considera l’uomo a partire da quello che egli è
innanzitutto, vale a dire corpo. In tal senso tanto Nietzsche quanto la Nuova Danza,
profetizzata da Loïe Fuller, Isadora Duncan e Ruth St. Denis, sono interessati all’incontro
dell’Essere e dell’uomo in seno al principio vitale del corpo. Il filosofo tedesco affermava di
credere in un dio capace di danzare, secondo il principio cosmico della tradizione induista
che va sotto il nome di Shiva: dea della danza simboleggiante la creazione e la distruzione di
ogni cosa, posta all’incrocio di vita e morte per riassumerle in un solo principio portante,
8
quello dell’ essere/movimento. Nella danza dunque, un corpo votato ad un movimento
astratto e complesso, a qualcosa di simile al fluire cosmico, perenne e gratuito, attinge
all’Essere. Nel dialogo socratico “L’anima e la danza” (1921), Paul Valéry afferma che la
danza è un esperire del corpo, segreto ed ineffabile, nel quale si combinano insieme gli
opposti. Un esperire che la ragione è inadeguata a cogliere nella sua essenza, poiché esso si
fonda sul senso “divino” dell’essere che in quanto tale trova senso in sé stesso, dal semplice
fatto che è. Il corpo danzante non è dunque un mezzo che trasmette un messaggio, ma è un
soggetto che incarna nella danza stessa qualcosa della verità dell’essere e dell’ esserci.
Nella riflessione del primo ‘900 è evidente la preponderanza delle correnti spiritualistiche e
dell’accostamento della dimensione estatica a quella estetica. Ma più tardi Marta Graham
tornerà ad insistere sulla centralità del movimento e della “metacinesi” cioè l'empatia
cinetica fra danzatore e spettatore grazie alla quale il corpo comunica contenuti emotivi. È
interessante notare che la dimensione del danzatore qui evolve progressivamente da quella
nobile ed elegante delle corti (dove viene codificata la danza classica accademica) a quella
magica e meravigliosa del balletto romantico fino ad una dimensione “sacerdotale” del
danzatore, il quale dedica al perfezionamento della tecnica la propria vita, per poi incarnare
un principio superiore che rimanda ad un’esperienza ineffabile. La consapevolezza della
centralità del corpo, tema privilegiato del teatro del ‘900, porterà a ricercare nuove tecniche
e pratiche che investiranno durante il secolo sia gli attori che i danzatori, arricchendo
notevolmente le possibilità espressive; al contempo il teatro porterà difficilmente il peso di
una coscienza che delinea il corpo come semplice annuncio di sé stesso, giungendo in alcune
esperienze postmoderne ad utilizzare l’oggetto-corpo come principio autosufficiente ed
autoreferente e rischiando la paralisi del senso. Il corpo rappresenta infatti un “in-sé” preverbale ed originario, la cui natura densa ed opaca rimanda difficilmente ed a prezzo di uno
“scandalo” ad un dispiegarsi fenomenologicamente in “corpo scenico” esposto allo sguardo.
Qui il segno linguistico convenzionale, la parola, è assente dunque il senso precipita in una
iniziale scelta dell’ordine simbolico a cui l’oggetto polisemico corpo deve appartenere:
secondo che le figure del corpo vengano presentate come cadavere, animale, robot o
marionetta, le strutture della realtà e le visioni del mondo conseguenti saranno radicalmente
diverse. Tocchiamo in questo senso più da vicino la problematica della “presenza scenica”,
che imporrà una riflessione metodologica sia agli interpreti che ai registi in merito alla
relazione fra formazione pedagogica o “training” e scelte di poetica.
Il termine coreografia significa letteralmente scrittura della danza. Esso appare nel XVI
secolo, contemporaneamente ai primi tentativi di notazione della danza, attraverso un
sistema di simboli grafici che rappresenta i movimenti dei ballerini ed i loro spostamenti nello
spazio. Occorre ricordare infatti che la notazione coreografica ha una storia ben più recente
della notazione musicale. Il primo sistema organico di notazione fu quello di T. Arbeau nel
suo trattato Orchésographie scritto nel 1588, in seguito M.Feuillet, successivamente alla
codificazione della danza classica accademica ad opera di Luigi XIV in Francia, fu autore di
9
un metodo completo di notazione nel 1700. Tuttavia i principali sistemi di trascrizione, tanto
dei singoli passi quanto delle loro concatenazioni negli esercizi e nelle coreografie, sono stati
elaborati soltanto nel secolo scorso da Rudolf Von Laban, Rudolph e Joan Benesh, Noa
Eshkol e Abraham Wachman, Pierre Conté, Alwin Nikolais e Valerie Sutton, sino a contare
oggi un centinaio di sistemi di notazione coreografica. L’uso della notazione, tuttora limitato
solo ad alcune compagnie per ragioni economiche ed organizzative, è stato oggi quasi
totalmente sostituito dalle riprese video, le quali a loro volta non hanno soppiantato la
tradizionale trasmissione generazionale, affidata all'oralità ed all'esempio pratico, restando il
mezzo privilegiato per garantire continuità e vitalità ad un repertorio. Già sul finire del
Settecento il termine coreografia cominciò ad essere usato con il significato attuale di
invenzione dell’insieme di passi, movimenti e figurazioni che compongono un balletto.
L’accezione creativa di coreografia ci porta di rimando a chiarire la funzione di coreografo, la
quale comporta delle radicali differenze secondo che si tratti di “invenzione” di un balletto
classico oppure di una coreografia moderna o contemporanea. Nell’ideazione del repertorio
classico infatti, il coreografo sottoponeva la sua creazione alla partizione musicale del
balletto che, nelle sue strutture ricorrenti di ouverture, adagio, variazione, coda, strutturava
il ritmo drammaturgico e adattava la combinazione dei passi, codice “storico” e “fisso” nella
danza classica, rispetto alla musicalità e non solo all’estetica. Una struttura narrativa inoltre,
faceva da contrappunto alla struttura coreografica fornendo ai danzatori il carattere di veri e
propri personaggi ed integrando delle parti più propriamente pantomimiche per coadiuvare
la comprensione della storia e dei “dialoghi”(parti oggi quasi del tutto soppresse). A questo si
aggiungeva l’obbligo di rispettare un ordine gerarchico fra i danzatori, dunque di comporre
parti per i primi ballerini(i personaggi principali), i solisti (personaggi secondari), il corpo di
ballo (costituente lo sfondo della comunità in cui si svolge la storia). La libertà compositiva
del coreografo veniva in questo senso “inquadrata” dal contesto narrativo e musicale
generale e, dall’interno, dal codice tecnico della danza adottata, di matrice storica e
suscettibile solo di essere trasformato in modo combinatorio. Con l’avvento della danza
moderna, attraverso l’opera di artisti come Martha Graham, Merce Cunningham o Alwin
Nikolais ad esempio, la figura del coreografo giunge ad avere una preponderanza assoluta
nel processo creativo, avvicinandosi paradossalmente a quella del didàskalos, il poetaregista della Grecia classica. Il coreografo assume dunque la triplice funzione di
drammaturgo, coreografo e regista. Egli è drammaturgo in quanto autore del linguaggio
utilizzato, poiché inventa un codice ed una tecnica originale che si innesta in un processo
storico di rinnovamento dei vecchi codici( ancora oggi sono studiate le tecniche Graham,
Nikolais, Limon, Cunningham etc…); egli è coreografo poiché scrive le partizioni danzate
sottoponendo la creazione musicale alle proprie esigenze; infine è regista poiché investe
della propria poetica tutti gli elementi scenici, scegliendo gli interpreti, la scenografia, i
costumi, coordinando le “tematiche” e strutturando la sintassi drammaturgica. L’elemento
narrativo inoltre scompare, lasciando il “discorso” appannaggio della danza e spogliando i
danzatori delle vesti di personaggi a favore di un contesto risolutamente astratto. Sulla scia
10
di questa importante trasformazione, anche il coreografo contemporaneo godrà di una certa
onnipotenza, dando luogo ad una frammentazione soggettiva di stili e pratiche, riguardante la
totalità dell’impianto drammaturgico, che oggi rende sempre più difficile una individuazione
di movimenti poetici o di distinzione pertinente
fra il “coreografico”, il “teatrale”, il
“performativo”. Il lettore intuisce quanto i domini di competenza dell’autore coreografico si
siano “storicamente” allargati, imponendogli la compresenza di una competenza registica,
coreutica e di scrittura originale del “testo” e favorendo, in definitiva, la rarità degli autori
all’altezza.
11
Quale “Testo”?
Testo, ci rimanda etimologicamente a ciò che è “intessuto” di molte trame e la definizione di
autore teatrale è come abbiamo visto qualcosa di simile ad un nome collettivo che comprende
lo scrittore, il traduttore eventuale, il regista, l’attore. Il testo teatrale non è dunque
anch’esso un nome collettivo che ingloba elementi letterari, verbali, scenotecnici, gestuali?
Un tessuto composto da plurime azioni sceniche, la cui natura rimanda alla globalità del
teatro?Come precedentemente accennato, nonostante che il testo drammatico sia linguaggio
plurale, quasi nessuna delle componenti di uno spettacolo sopravvive a quell’elemento fisso e
apparentemente certo che è il testo letterario. Ma qual’è lo statuto della parola a teatro?
La parola a teatro è stata per lo più posta a fondamento di una categoria cardinale della
finzione artistica: il realismo. Il teatro occidentale ha investito la parola dello status di senso
pieno escludendo quel coacervo di materiali soggiacenti al non-espressivo ma urgenti nella
loro potenzialità drammatica. Almeno fino a Cechov (1860 -1904), con il quale si assiste ad un
primo prosciugamento della comunicazione che condurrà all’ inarrestabile dissoluzione del
personaggio, la parola piena aveva infatti il compito modellare l’azione su uno stampo
direttamente verbale nel dialogo o nel monologo: l’azione si prefigurava in quanto atto
verbale di personaggi il cui statuto primario era quello di soggetti enunciatori. Gli attori, nella
congruenza
istituita
fra
i
tratti
psicologici
e
fisici
del
personaggio,
simulavano
drammaticamente la rappresentazione verbale e la rappresentazione scenica era a sua volta
simulazione di persona, altra, a cui l’ego dell’attore prestava una fisionomia . Teatralità e
verbalità, esistenza e logos, parola e atto coincidevano in un unico corpo . Così intesa la
forma drammatica era innanzi tutto un dire e, più precisamente, dire stava sempre per voler
dire. Il teatro classico usava l’espressione in quanto pratica simbolica che esprime un telos
volontario, una finalità cosciente depurata dalle scorie dei vissuti d’esperienza. Gli effetti di
tale concezione, pur storicamente superati, si misurano tutt’oggi in molte pratiche teatrali
attraverso la raffigurazione psicologica, l’ identificazione dei ruoli, la simulazione di uno
stato dell’identità attore-personaggio. Paradosso di una situazione fittizia fatta di persone ed
oggetti reali che, nella loro palese artificialità e falsa accidentalità dell’essere – esposti - in
scena, “tengono” grazie alla sospensione delle convenzioni ordinarie di comunicazione. Lo
spettacolo imita una imitazione, è mimesi scenica e sensibile di un verbo che rappresenta e
l’azione e l’identità veridica. Poiché il corpo verbale della parola assorbe la soggettività
vocale dell’attore mimetico, che simula una identità fittizia di facciata, il soggetto non può
dirsi , ma solo riprodursi nell’imitazione di persona, nella simulazione psicologica secondo
quei dettami professionali imposti dal patto teatrale: la scissione tra soggetto ed io , già
collaudata tra l’altro nel quotidiano attraverso la maschera sociale, la divisione fra corpo e
persona, soggetto e personaggio sono la convenzione in cui si riconosce il teatro del XIX
secolo. L’esigenza di esprimere l’inespresso, reintegrando il soggetto nello spettacolo e
riconducendo la rappresentazione ad essere “teatro” e non protesi del testo scritto, sarà la
nuova istanza posta dalla sensibilità degli artisti del ‘900 per rifondare l’atto scenico come
atto autonomo. Il verbo non costituisce più una illusione attendibile ed il teatro si assume una
12
responsabilità nuova: passare dalla poesia nel teatro alla poesia del teatro. La soggettività
dell’attore viene reinvestita di singolarità attraverso l’ego “istrionico”, facente capo ad una
esistenza lirica piuttosto che ad un’esistenza verbale, dando luogo a quella ricerca di nuove
tecniche e nuovi processi pedagogici capaci di esporre “in prima persona” l’attore in scena.
Sintomatico di questo avvenuto spostamento poetico è l’effetto di verbalità tonalizzata in
Cechov, l’ affievolirsi dell’intreccio e dei personaggi nella sua scrittura drammaturgica, in cui
i dialoghi sono amputati e l’azione inibita. Come nel teatro antico, i grandi fatti non sono
rappresentati e la scrittura rinuncia a delineare l’intero compimento dell’azione per meglio
misurarne le conseguenze, in uno stato indeciso e sospeso delle situazioni. Il ruolo del testo e
la sua definizione alla relativa messa in scena diventano dunque un problema fondamentale
del teatro del ‘900, che rileva la contraddizione interna e definitiva della definizione
testo/teatrale. La parola viene così degradata a supporto secondario della veicolazione del
senso “ in quanto realtà distinta, che esiste per sé stessa, che basta a sé stessa, non nel suo
spirito (…) ma semplicemente come spostamento d’aria provocato dalla sua enunciazione” 4 .
L’avanguardia storica di Craig, Appia, Tairov, Bragaglia subordina o esclude il logos rispetto
all’arte visiva ed al movimento, in un processo che arriva negli anni ’70 a definire l’azione non
verbale come primaria, includendovi anche sfumature prettamente politiche, e dando luogo
alle definizioni di “teatro-immagine”, “teatro-corpo”, teatro del “vissuto” o di “guerriglia”. Una
numerosa serie di esperienze teatrali saranno votate da questo momento in poi a promuovere
la soggettività lirica dell’attore-interprete, la risonanza estetica dei materiali di scena ed un
linguaggio sottratto al principio di simulazione. L’ attore diviene artefice e vittima dello
spettacolo, “soggetto” che si fa “travolgere” dal personaggio. La ricerca teatrale approda qui
ad un rapporto epistemologico nei confronti dei propri linguaggi, aprendosi ad altri patrimoni
culturali quali lo strutturalismo, la psicanalisi, le tecniche orientali, l’antropologia. Il rapporto
al testo drammatico
dovrà, a partire da questa consapevolezza, passare attraverso la
bipolarità di testo letterario e testo spettacolare, per cui alla fedeltà della riscrittura scenica
di un dramma si sostituirà un tradimento/traduzione della letteratura che possa adempiere
scenicamente ad una semplice potenzialità di questa. Questo processo “traduttivo” della
parola scritta renderà più agile il rinvio ad una più generale “tradizione” letteraria, cioè ad un
fitta rete di testi ed interpretazioni nella quale il gruppo teatrale si muove criticamente, dando
per scontato che il patrimonio culturale
che sottende all’evento rappresentativo è base
comune con il pubblico. Questa pratica ci rimanda ad un sistema teatrale precedente al ‘700,
quando si stabilì quella connessione inderogabile fra testo letterario drammatico e
rappresentazione che perdurò immutata per più di due secoli in Europa. Nota a questo
proposito Ferdinando Taviani: ” Storicamente, la novità (o una delle novità) della Commedia
dell’Arte consistette non nell’abbandono del testo, ma nell’uso e nello sfruttamento
drammatico tipico di una tradizione letteraria d’élite, nell’adattarlo alle esigenze di pubblici
vasti e di differenti livelli culturali. (…) Vedere la Commedia dell’Arte come “teatro che fa a
meno dei testi” è una deformazione che deriva dal vizio di trasformare in idea assoluta di
4
A. Artaud, Il teatro e il suo doppio, Torino, Einaudi 1968
13
Teatro il sistema formatosi nell’Europa del ‘700, quando nacque il Teatro come categoria
culturale autonoma, e quando il “corpo separato” costituito dalle compagnie degli attori
venne integrato nelle città, con il compito di trasformarsi - almeno in teoria - in un vivente
museo della letteratura drammatica.”. Il testo ritrova nell’elaborazione culturale del ‘900
quella dimensione di “canovaccio” intessuto di riferimenti letterari, figurativi o gestuali che fa
capo ad un atto autonomo di riscrittura da parte dell’attore quanto del regista. L’apporto
creativo dell’improvvisazione e la riflessione sulle maschere ed i tipi fissi suggeriranno nuovi
spunti alla rifondazione del nuovo teatro. L’attore sarà chiamato a lavorare, attraverso uno
studio di tipo laboratoriale, quel “sottotesto” che nell’opera scritta è assente. In definitiva,
attraverso l’improvvisazione e l’elaborazione di una precisa pedagogia, si vuole restituire
all’attore una libertà ed una precisione di intervento impensabile fino ad allora: si pensi a
questo proposito ancora una volta al lavoro di Copeau, Mejerchol’d, Stanislavskij, Grotowski.
Quest’ultimo parlava di improvvisazione “illuminata”, di impulsi vivi da cui nasce la parola;
Mejercol’d elaborò una tecnica che esaltasse la “reattività” dell’attore. È sul corpo vivo
dell’attore che si innesta il testo e l’intervento del regista, a sua volta liberato dal giogo
letterario. L’intervento drammaturgico si colloca in questo modo come “tecnica” di una
sintassi che coordina non solo le diverse componenti dell’opera teatrale ma riferimenti più
vasti che afferiscono ad un patrimonio culturale comune, di cui il testo scritto è
pretesto/metatesto. Istanze simili parteciperanno durante il
XX secolo all’evoluzione del
“testo” coreografico , ma per il momento è importante rilevare che la messa in discussione
del testo letterario partorisce il così detto teatro di ricerca, un teatro che interroga il senso
ed i propri linguaggi: "Una delle questioni che si pongono al linguaggio della ricerca è legato
all'esigenza di una discontinuità. Come parlare di tal sorta che la parola sia essenzialmente
plurale? Come parlare in modo che un rapporto d'infinità sia sempre implicato come il
movimento della significazione stessa? O ancora come scrivere in modo che la continuità del
movimento della scrittura possa lasciare intervenire fondamentalmente l'interruzione come
senso e la rottura come forma?(…) Ogni linguaggio dove si tratta d'interrogare e non di
rispondere, è un linguaggio già interrotto, meglio un linguaggio dove tutto comincia
attraverso la decisione (o la distrazione) di un vuoto iniziale." 5
5
Maurice Blanchot L'entretien infini, Gallimard Collection Blanche, Paris 1969, trad. Giovanna Amarù
14
Quale “Spazio”?
Spazio architettonico e spazio scenografico sono il duplice oggetto di riflessione contro cui
vengono a urtarsi le nuove istanze drammaturgiche del ‘900. Appare evidente che il “fare
teatro”, prescindendo da una priorità assoluta del testo scritto, significa “integrare” il corpo e
l’atto poetico ad un luogo deputato la cui natura condizionerà in modo preponderante il
significante dell’opera e la sua percezione. Lo spazio scenografico inoltre, per vocazione
mutevole, è subordinato ad uno spazio architettonico fisso che costituisce un “a priori” di
qualunque atto creativo. I difficili rapporti fra teatro ed architettura sembrano approdare,
nonostante i molteplici tentativi di riforma, ad una cristallizzazione della tipologia teatrale
moderna che si basa su un modello ideologico definito comunemente “teatro all’italiana”, a
cui l’immaginario collettivo fa riferimento istintivamente in quanto sinonimo di teatro. Questa
tipologia si è venuta a definire per tappe successive a partire dagli studi rinascimentali sulla
prospettiva, passando attraverso il Barocco e la nuova concezione del melodramma, fino alla
riforma wagneriana e all’avvento delle avanguardie storiche. Fu la cultura umanistica a
superare la coralità e la fruizione all’aperto del teatro classico e medievale, sostituendogli
l’ideologia del “chiuso” e dell’urbano. Allo spazio naturale si sostituisce lo spazio prospettico,
che aprirà la via agli architetti del ‘600 e ‘700 a quella commistione magica di trompe-l’oeil e
razionalità simmetrica che favorirà l’illusionismo perfetto della rappresentazione. Favorevole
all’ideazione di questo tipo di teatro sarà l’ingresso della speculazione finanziaria, attraverso
gli imprenditori, nell’elaborazione del processo teatrale: lo spettacolo comincia a delinearsi
nel suo status di prodotto per un pubblico pagante. Nel 1576 si costruisce in Inghilterra il
primo teatro pubblico con pubblico pagante, il The Theatre, di proprietà di James Burbage,
completamente in legno. Fu solo il primo di una serie di costruzioni quali il Curtain, il Globe
Theatre ed il Fortune. La pianta di questi edifici teatrali era quadrata, circolare, ottagonale o
ovale; le pareti laterali avevano una specie di tetto ricoperto di paglia e gallerie per posti a
sedere. Per quanto riguarda il palcoscenico, la forma più usata era quadrata, con un lato che
poteva variare dai dieci ai quindici metri e con il palcoscenico che si incuneava nella sale in
modo da essere quasi circondato dal pubblico. I teatri che fiorirono in Spagna, di struttura
paragonabile, sorsero all'incirca nello stesso periodo dei teatri elisabettiani. Nel 1579 fu
fondato a Madrid il primo teatro spagnolo importante, il Teatro de la Cruz, basato sulla
tipologia del corral de comedias. Il corral può essere definito come un cortile formato dalle
pareti di case contigue, non dissimile per la forma e la grandezza dai cortili delle locande
inglesi. Anche nelle città mercantili italiane, un pubblico di estrazione sociale diversa paga un
biglietto d’ingresso di valore proporzionale alla visibilità ed al comodità del posto da
occupare. La capienza della sala diviene un obiettivo primario e la cavea cinquecentesca,
ricalcata sul modello greco-romano, viene sostituita da ordini di palchi sviluppati in senso
verticale. Durante il periodo barocco si assisterà ad una progressiva armonizzazione delle
scene delle capitali europee grazie alle numerose edizioni librarie sul teatro e agli scambi
culturali degli intellettuali, ma soprattutto all’avvento di una nuova forma di spettacolo che
avrà un peso determinante nella nuova architettura teatrale. Poco prima del 1594, a Firenze,
15
un appassionato gruppo di intellettuali discutevano su come potevano essere state
interpretate le tragedie greche e sul problema dell'inserimento dell'elemento musicale in
quelle rappresentazioni. Dalla discussione tra il Conte Vernio, i musicisti Giulio Caccini e
Jacopo Peri e il poeta Ottavio Rinuccini, nacque il dramma “Dafne”, scritto da Rinuccini e
musicato dal Peri. Fu la prima vera opera cantata. Il melodramma ebbe una straordinaria
fortuna di pubblico e giocò un ruolo fondamentale, attraverso la sua diffusione europea,
nell’esportazione del suo “contenitore”. Le ricerche compiute in epoca barocca, in particolar
modo in Italia, in merito alla prospettiva, alla scenotecnica ed all’acustica, determinarono
quel “teatro all’italiana” con una disposizione definitivamente verticale dei palchi per il
pubblico ed un’area scenica molto sviluppata in profondità, per far posto agli effetti
prospettici e alle macchine. Già nel 1637, a Venezia, compariva il primo teatro d'opera con
pubblico pagante e contemporaneamente in Inghilterra si abbandonava la forma del teatro
elisabettiano per adottare una forma simile al teatro italiano. Un teatro così concepito sarà il
luogo ideale per la “spettacolarità” della rappresentazione, grazie alle sue possibilità
tecniche, e parimenti per la “spettacolarizzazione” del pubblico pagante: il teatro all’italiana
renderà definitivamente leggibile la stratificazione sociale, attraverso l’ordine verticale dei
palchi al cui centro troneggia il principe, consentendo contemporaneamente alla società di
mettersi in scena, di dare una visibilità ad un rituale mondano che illustra la propria nobiltà o
la propria riuscita. La critica illuministica attaccherà nella seconda metà del ‘700 questo
stato di cose, sul piano tanto architettonico che scenico e politico, volendo aggiungere
all’esigenza edonistica quella di un teatro istruttivo, ma la logica imprenditoriale e formale
consolidatasi in epoca barocca non ne verrà incrinata, diffondendosi dalla Russia al
continente americano e sopravvivendo fino ad oggi. Il teatro all’italiana integrerà
perfettamente l’esigenza borghese di una platea attenta, magicamente coinvolta nell’incanto
spettacolare, da cui prese le mosse la riforma wagneriana. Wagner, assertore convinto del
dell'opera d'arte totale (Gesamtkunstwerk) sorta dalla fusione di musica, danza e poesia,
rispose alle istanze di un teatro ipnotico e più precisamente di un melodramma di argomento
mitico, realizzando nel teatro di
Bayreuth delle riforme che (fatta eccezione per la
reintroduzione della gradinata per il pubblico) verranno applicate all’edificio di ideazione
barocca: l’oscuramento della sala e il perfezionamento dei mezzi illuminotecnici, la creazione
del golfo mistico per nascondere l’orchestra e l’uso del sipario per nascondere i cambiamenti
di scena. È interessante notare che l’uso del sipario, che anticipava l’idea della quarta parete
naturalista e annullava le capacità stranianti degli interventi tecnici “a vista”, verrà
successivamente abolito da Brecht nelle sue produzioni, tornando a quell’idea di gioco
scoperto voluta nel ‘600 dallo scenografo Giacomo Torelli (1608-1678). Anche se
limitatamente al melodramma, vengono qui individuati da Wagner i legami costitutivi del
rapporto tra spazio e drammaturgia e soprattutto uno dei principi fondamentali della regia
moderna, vale a dire il ritmo. A partire dall’opera di Wagner, lo scenografo Adolphe Appia,
pubblicando “La mise en scène du drame wagnérien” a Parigi nel 1895, definì un’estetica
autonoma del teatro attraverso una riflessione sistematica e rigorosa. Appia trova nel corpo
16
dell’attore l’elemento mediatore fra la musica e lo spazio, il mezzo essenziale per la
costruzione drammatica. Affascinato dal lavoro sulla ritmica compiuto dagli allievi danzatori
di Dalcroze, Appia intuisce che il rapporto dialettico allo spazio deve avvenire attraverso la
“contrainte” vale a dire il limite e l’opposizione reciproca che corpo e spazio si procurano. Il
corpo sarà contrastato dalla pesantezza e dalla rigidità dello spazio scenico e quest’ultimo
riceverà a sua volta dal corpo vivente la sua parte di vita. È nel contrasto e nella resistenza
fra l’elemento umano e le forme geometriche pure e lineari che Appia individua un principio
drammaturgico unitario , dunque un principio registico, che resta purtuttavia sottomesso ai
dettami del “tempo” della musica. Quest’ultima influenza il corpo dell’attore e plasma anche
lo spazio scenico, che muta in funzione musicale attraverso il sollevamento e l’abbassamento
dei praticabili. Un altro concetto introdotto da Appia è lo "spazio luce": lo scenografo
"dipinge" con la luce, sfruttandone, in modo del tutto indipendente dal ritmo dell'azione, la
funzione psicologica e aprendo la strada ai valori della luce presso i cubisti e i futuristi.
Fu Edward Gordon Craig, tenace oppositore del naturalismo ed ammiratore di Appia, a
perfezionare l’illuminotecnica ed a mettere a profitto le nuove possibilità offerte dall’energia
elettrica. Sul piano scenografico, egli inventò gli screens una serie di schemi rettangolari
mobili che avrebbero dovuto dar luogo ad un numero pressoché illimitato di combinazioni.
Contrastando l’uso delle tele dipinte, egli diede consistenza ad una visione cinetica della
scena, che prevedeva masse di luce ed ombra e forme plasticamente concepite che
annullassero ogni riferimento realistico e assumessero un valore simbolico, per fare del
teatro un tempio. Pur con le dovute differenze, assistiamo con Appia e Craig alla prima
elaborazione teorica unitaria sul problema dello spazio, della tecnica, della regia e della
fruizione del pubblico come componenti correlate indissolubilmente allo status creativo e
sociale del teatro. In particolare Appia incentrerà il problema creativo sulla natura astratta
dello spazio e la relativa fruizione dell’immagine da parte degli spettatori: “ (…) è soltanto la
nostra idea moderna della scena e del teatro che obbliga il drammaturgo a limitare la sua
concezione, a restringere la sua visione, senza reciprocità possibile da parte sua nei
confronti della messa in scena. Proclamiamolo ad alta voce: l’autore drammatico non libera
mai la sua visione se la considera sempre come fosse proiettata in uno spazio nettamente
separato dal pubblico. Questa disposizione può occasionalmente essere auspicabile, ma non
dovrà mai essere la norma. Ne risulta, è inutile dirlo, che la struttura dei nostri teatri deve
evolversi verso una concezione più libera e agile dell’arte drammatica. Prima o poi
arriveremo a quel che si chiamerà la sala, cattedrale dell’avvenire, che accoglierà le
manifestazioni più diverse della nostra vita sociale e artistica in uno spazio libero, vasto,
trasformabile, e sarà luogo per eccellenza in cui l’arte drammatica fiorirà – con o senza
spettatori.” . Craig dal canto suo sottolineerà la necessità di una figura registica libera, che
imponga un approccio “scientifico” dell’arte:”Perché tutto ciò che è accidentale è nemico
dell’artista, l’arte è in antitesi assoluta con il caos, e il caos è creato dall’accozzaglia di molti
fatti accidentali. All’arte si giunge unicamente di proposito. Quindi è chiaro che per produrre
un’opera d’arte qualsiasi, possiamo lavorare soltanto con quei materiali che possiamo
17
controllare. L’uomo non è uno di questi materiali.”. La padronanza registica invocata da
Craig, evidenzierà per la prima volta la necessità di una perfezione tecnica dell’”artificio”
teatrale, tanto per i materiali scenografici che per gli attori, i quali dovranno bandire il caos
emotivo tipico del naturalismo ed essere “fondamentalmente artificiali”: quella figura
inanimata chiamata “Supermarionetta”, lungi dal costituire un primato dell’inorganico,
indicherà in Craig l’esigenza di una figura altamente disponibile e controllata, che aprirà la
strada alla biomeccanica di Mejercol’d ed anticiperà le astrazioni delle tecniche moderne
della danza. Nonostante le scene dipinte e gli elementi figurativi trovino in Russia una
rivalutazione negli allestimenti dei balletti djaghileviani, sotto la spinta di Lev Bakst che si
rifaceva al colorismo bizantino, le concezioni e le riflessioni portate da Craig e Appia,
fecondate dai diversi
movimenti d’avanguardia come il futurismo, il cubismo ed il
costruttivismo, sfociarono in stimolanti discussioni ed esperimenti, portando in primo piano il
rinnovamento dello spazio scenico nella sua valenza artistica e sociale. Agli albori della prima
guerra mondiale, l’architetto americano Norman Bel Geddes presentò un progetto di teatro
ideato sia per scene tridimensionali che per scene con proiezioni: in esso il pubblico e gli
attori erano collocati in una grande sala rettangolare, coperta da un'ampia volta, il
palcoscenico era situato in uno degli angoli e assumeva quindi una forma triangolare. Oltre a
questo progetto Bel Geddes ne pubblicò un altro in cui gli spettatori erano disposti in due
sezioni, collocate una di fronte all'altra, fra le quali si estendeva un palcoscenico stretto e
lungo. Nel 1929 Mies Van der Rohe presenta in occasione dell’Esposizione Universale a
Barcellona un padiglione nel quale vengono sintetizzati i valori spaziali a cui aspirava
Appia:uno spazio scenico dalle linee essenziali e neutre, concepito come insieme di parti
staccate, in cui gli elementi primari si fondono senza chiudersi mai e senza precludere alcuna
possibilità, in una sorta di teatro metaforico e di “vuoto” accogliente. Nel 1927 Walter Gropius
pubblica un grande progetto per un “teatro totale”, in cui il pubblico circonda una pista
centrale ed i mezzi tecnici sono all’altezza di uno stupore e di un dinamismo continuo. Il
fondatore del Bauhaus teorizzò quella che poi divenne l’arte industriale, dando
all’architettura moderna un contributo metodologico che influenzò tanto il design che
l’urbanistica, ma fondamentalmente, nella sua associazione con Piscator, volle ridare al
teatro una dimensione “alternativa” e isolata rispetto allo spazio urbano, con un
procedimento che “fuggiva” dalla città ma contemporaneamente la “reintegrava”, come nel
Rinascimento, in quanto realtà industriale. È proprio a partire dalla duplice presa di
coscienza del funzionamento della società industriale e della necessaria autonomia registica
che il teatro moltiplicherà le ricerche di nuovi spazi d’esistenza, tanto per necessità
drammaturgiche che produttive, approdando alla coabitazione di spazi dalla valenza
totalmente diversa. Da un punto di vista strettamente scenografico, le innovazioni tecniche
ed artistiche andranno a modellarsi prevalentemente rispetto al dato “acquisito” del teatro
all’italiana. Dal punto di vista architettonico, la “reinvenzione” dello spazio sarà sinonimo di
fuoriuscita dall’edificio teatrale, di riappropriazione del “vero” spazio urbano (elemento più
ampiamente utilizzato nel cinema), con imprescindibili valenze politiche che spesso
18
approderanno alla coscienza di una impossibile sintesi fra il segno “puro” del corpo ed i segni
“corrotti” degli oggetti e della vita metropolitana (il grottesco metropolitano del cabaret
futurista o dadaista testimoniano di questo malessere). Ogni spazio teatrale, dall’ente lirico,
al teatro di varietà, alle fabbriche, alle cantine sarà sinonimo di realtà sociali e fruizioni
diverse e soprattutto rispecchierà, a partire dagli anni ’50, il ventaglio delle pratiche oscillanti
tra l’esaltazione del prodotto o del processo teatrale, tra le
esigenze conservative del
repertorio, quelle di intrattenimento, di sperimentazione o di
critica. La drammaturgia
contemporanea di ricerca aspirerà ad uno spazio reinventabile cercando di volta in volta dei
luoghi socialmente significativi, un nuovo coinvolgimento dello spettatore e una dimensione
adatta allo “spazio corpo” dell’attore. In linea generale tuttavia, lo spazio del teatro
all’italiana conserverà, oltre che il ruolo di luogo deputato dell’opera e del balletto, un ruolo
relativo all’idea di “istituzione” sovvenzionata dallo stato, che nel susseguirsi “straniante”
delle repliche assicura una qualità fissa del prodotto-tradizione-spettacolo. Lo spazio del
teatro oltre che causa formalis della drammaturgia diviene simbolo architettonico della
circuitazione dell’opera, specchio della tipologia di mercato a cui il minus media del teatro fa
riferimento: teatro istituzionale colto, genere d’intrattenimento e teatro di ricerca si dividono
iniquamente pubblico e spazi in un gioco delle parti che riassorbe la ricerca “riconosciuta”
nell’istituzione sovvenzionata e premia l’intrattenimento consegnandolo alla televisione o al
cinema.
19
Problemi tecnici e contaminazioni.
Il problema della rifondazione del teatro coincide in larga parte, nella ricerca del primo ‘900,
con quello della rifondazione della drammaturgia dell’attore e si identifica in un’accurata
indagine pedagogica sulla trasmissione della tecnica che possa meglio veicolare una nuova
creatività. La reintegrazione di una nuova coscienza corporea, atta a sostituire radicalmente
la figura dell’attore naturalista, visto grosso modo come una testa parlante poggiata su un
manichino che indossa un costume, implicherà una serie di riflessioni
che investiranno
diversamente ma parallelamente il teatro di prosa, la danza ed il mimo. Come abbiamo visto,
se le riflessioni di Appia e Craig coincisero in gran parte nella definizione di un nuovo spazio
scenico, non si può dire altrettanto del ruolo assegnato all’attore. Appia rivendicava infatti
una libertà “antropocentrica” del corpo, che benché sottoposta alla musica, era vicina allo
spiritualismo ginnico di Dalcroze o alla danza libera (di cui ci occuperemo più avanti) di Loïe
Fuller e Isadora Duncan, dunque ad un “espressionismo” che giocasse per contrasto con la
realtà inanimata della scenografia. Craig dal canto suo relegava il corpo dell’attore ad una
funzione del tutto controllabile ed è quindi nell’esigenza di una estrema precisione e
riproducibilità di movimento che la sua supermarionetta va intesa. Situandosi all’opposto del
sentimentalismo e dell’istrionismo emozionale degli attori del suo tempo, Craig si avvicina
alla precisione dell’acrobazia biomeccanica di Mejercol’d ed alle esperienze sceniche
costruttiviste della Russia post rivoluzionaria in una specie trionfo delle macchine, dove
l’uomo è “operaio” di una cinesi globale. Rispetto ad Appia dunque, Craig propone una via
risolutamente più astratta e tecnicamente precisa, che troverà eco, con esiti diversi, in
Russia e successivamente nella danza moderna degli Stati Uniti. Il termine biomeccanica
nasce nel 1922, sulla scia delle corrente rivoluzionaria sovietica, del costruttivismo e del
produttivismo. L’opera di Mejercol’d, pur prendendo le mosse da un tale terreno culturale, si
sviluppò in una pedagogia completa per l’attore, che univa il perfetto controllo di corpo e
mente, lasciando spazio alle capacità creative, emozionali e critiche dell’uomo. Un tale
risvolto umanista e prepotentemente innovativo spiega l’accusa di attività antisovietica di
Mejercol’d e la sua fucilazione nel 1939 ad opera delle truppe staliniste. Il metodo
biomeccanico prevedeva l’idea fondante di lavoro cosciente e di comprensione dell’attività
psicofisiologica dell’attore. Il movimento veniva concepito come realizzazione scenica del
pensiero, da cui scaturiva successivamente l’emozione e la parola, sulla base della reattività,
qualità primaria dello stare in scena. Contrariamente a quanto il controllo di una perfetta
meccanica del corpo potrebbe indurre a immaginare, Mejercol’d sottolineava l’importanza
della componente animale dell’attore, di cui bisognava ritrovare il ritmo e l’istinto. Egli fu il
primo a sottoporre il lavoro del testo e del corpo alla “lettura musicale del dramma”,
attraverso indicazioni di pausa, velocità, accenti e tonalità, a tal punto che in una lettura
odierna dei suoi scritti il suo metodo appare l’antesignano del lavoro dei danzatori
contemporanei. La coscienza dello spazio e la disponibilità all’improvvisazione, sulla base di
20
una reattività “animale”, confluivano in questo senso del ritmo che riprendeva in larga parte il
modo di recitazione degli attori giapponesi, i quali si muovevano come in una danza, agli
antipodi dei ritmi reali e quotidiani. Appare chiaro in questo senso la collocazione di
Mejercol’d rispetto al teatro naturalista: quando egli parla di realismo lo fa soltanto rispetto
alla natura convenzionale ed artificiale della scena ( come del resto faceva Craig). Il realismo
di Mejercol’d ( che ammirava Chaplin) è in questo senso una sincera artificialità, che
bandisce l’immedesimazione psicologica nel personaggio e rivendica un atteggiamento
cosciente della rappresentazione: l’individualità dell’attore rimane integra e mostra al
pubblico l’interpretazione del personaggio. Il denudamento del gioco dell’attore e la distanza
dal personaggio denotano una forma di critica al testo ed evocano già in Mejercol’d quella
che sarà una caratteristica peculiare della recitazione e della regia brechtiana: lo
straniamento. A sottolineare l’anti-immedesimazione dell’attore, il regista prediligeva l’uso
della maschera e immaginava che il percorso dell’attore dal camerino alla scena si facesse a
vista. L’attore biomeccanico si cimentava spesso con personaggi metaforici o grotteschi,
poiché al centro degli spettacoli mejercol’diani venivano espresse situazioni limite del
destino umano o della storia. L’esigenza di una tecnica precisa e di un’autocoscienza forte
vengono espresse negli stessi anni in Francia da Jacques Copeau, fondatore del Vieux
Colombier nel 1913. Egli sottolineava l’importanza di un’autocontrollo assoluto da parte
dell’attore, poiché questi, per donarsi, ha bisogno di possedersi. Copeau sosteneva che era il
personaggio ad avvicinarsi all’attore, a possederlo, ed in questo senso l’attore era in realtà
agito; soltanto la tecnica poteva salvaguardare e supportare la libertà dell’attore e la sua
disponibilità nei confronti del personaggio. La mise en état di Copeau non è lontana
dall’approccio sensibile mejercol’diano, dall’ascolto del “bios” che funziona come un occhio
interno: egli sosteneva infatti che “un attore in uno stato
di grande fatica, d’inferiorità
nervosa, potrà con naturalezza entrare nella parte” dunque accedere, attraverso la calma,
alla sincerità. Copeau intuì in questo senso l’importanza che la tecnica rivestiva in merito alla
presenza scenica, individuando in questa un’attitudine interiore che può e deve essere
modificata “fisiologicamente” nel corpo dell’attore secondo le situazioni drammaturgiche. Lo
studio dell’immobilità, della continuità e della coordinazione obbligheranno l’attore ad una
economia e chiarezza del movimento che renderà leggibile il senso dell’azione poiché
”essendo il dramma innanzi tutto azione e, nella sua essenza, una danza, l’operazione
primordiale dell’attore nella ricerca di una tecnica non è intellettuale ma fisica, corporea.” 6 .
Negli stessi anni, in Francia, Etienne Decroux, fondatore dell’omonima tecnica di mimo, si
preoccupò di fissare con estrema precisione un metodo capace di legare l’attore all’azione
con una logica di “bios”: egli affermava che il mimo è un attore dilatato e che il teatro era una
sorta di accidente del mimo. L’attore a teatro, sosteneva Decroux, anche quello realistico,
rappresenta un altro uomo ma non per questo è meno concreto, meno uomo. La nozione che
Decroux aveva del mimo e dell’attore è quella di “presenza che non rappresenta”, una sorta
di presenza raddoppiata che “concretizza” la rappresentazione. Prendendo le mosse dalla
6
Jacques Copeau Il luogo del teatro, La Casa Usher, Firenze 1988, pag 96
21
statuaria
classica
greca
e
dell'arte
plastica
di
Auguste
Rodin,
egli osservò che il busto era l’organo preferito dello scultore e che nell’arte figurativa petto,
collo, vertebre e bacino vivevano di una vita ed una libertà espressiva sconosciute all’attore.
Nell'attore spesso gesti e grimaces sono preponderanti per l'uso incontrollato del volto e
delle mani che Decroux definisce "strumenti della menzogna", perché legati al quotidiano
farneticare. Egli comincia ad analizzare il corpo, a scomporlo e ricomporlo, dandogli una
valenza tridimensionale e anticipando in questo senso la ricerca della danza moderna e
contemporanea, che rivendicheranno un’ autonomia delle parti centrali del corpo, troppo
spesso dimenticate a vantaggio degli arti superiori ed inferiori. È interessante notare come la
tecnica Decroux prevedesse l’occultamento del viso, proprio per non ricadere in una
sequenza di smorfie che “deresponsabilizzassero” il corpo dal compito di mimare il pensiero:
per Decroux “il corpo è un guanto di cui il pensiero sono le dita”. Parimenti a Mejercol’d, egli
osservò che la pratica degli esercizi provocava degli effetti attraverso i quali la “causa”
veniva risvegliata: a partire da una forte esigenza estetica l’azione poteva dispiegarsi nella
sua purezza. Pur non avendo creato una vera scuola o delineato una tecnica precisa, anche
Antonin Artaud risentì, nel suo teatro della crudeltà, l’esigenza di una sottomissione ad una
superiore necessità, ad una dedizione e determinazione assoluta. Affascinato dalla danza
balinese, Artaud riconobbe nell’Atelier di Charles Dullin e nel teatro di Barrault (allievo di
Decroux) i soli esempi a lui contemporanei di quel rigore e di quella coscienza indispensabili
al teatro. Nell’Atelier Dullin conduceva una ricerca pedagogica ispirata alla specializzazione
del corpo del teatro giapponese, coniugando la pratica dell’improvvisazione alla pratica
quotidiana della ginnastica e della danza. Artaud vedeva nel teatro una sorta di linguaggio a
metà strada fra gesto e pensiero, non assoggettato al testo ma all’espressione dinamica nello
spazio: da un punto di vista drammaturgico, l’attore deve obbedire ad un ritmo come una
specie di strumento organico che risponde con precisione alla messa in scena dei segni
teatrali, come l’attore giapponese. L’organismo atletico e l’organismo affettivo
devono
correre in parallelo e coordinarsi in un unico flusso cosciente:”L’attore è soltanto un empirico
grossolano, un praticone guidato da un vago istinto. Eppure, contrariamente a quanto si
potrebbe pensare, non si tratta di insegnargli a sragionare. Si tratta di farla finita con quella
selvaggia ignoranza in mezzo alla quale procede come in una certa nebbia tutto il teatro
contemporaneo, incespicando continuamente. L’attore dotato trova nel proprio istinto di che
captare e irradiare certe forze; ma si meraviglierebbe assai se gli si rivelasse che queste
forze- che percorrono una traiettoria materiale attraverso gli organi e negli organi – esistono,
in quanto non ha mai lontanamente pensato che potessero davvero esistere.(…) Sapere che
l’anima ha uno sbocco corporeo permette di raggiungere l’anima in senso inverso; e di
ritrovarne l’essenza grazie ad analogie di tipo matematico. Conoscere il segreto del ritmo
delle passioni di questa sorta di tempo musicale che ne regola il battito armonico, ecco un
aspetto del teatro cui da tempo il nostro moderno teatro psicologico ha sicuramente cessato
di pensare.” 7 È proprio l’uomo nello spazio il tema principale della drammaturgia di Oscar
7
Antonin Artaud, Il teatro ed il suo doppio , Einaudi, Torino 1968
22
Schlemmer (1888 – 1943), pittore, scultore e coreografo tedesco che operò in seno al
Bauhaus negli anni ’20. L’opera di Schlemmer occupa un posto singolare rispetto alle
tendenze teatrali e coreografiche del suo tempo, e si inscrive nella ricerca di senso che
l’uomo, incarnando la Kunstfigur (figura d’arte), compie rispetto alle tendenze di astrazione,
meccanizzazione e progresso tecnologico dell’epoca. Per Schlemmer la storia del teatro è la
storia della trasformazione della figura umana e l’uomo è al contempo un organismo di carne
e sangue e, secondo la tradizione di Leonardo da Vinci e Albrecht Dürer, un “meccanismo
fatto di numeri e misure”. Vi sono dunque due tipi di reazioni possibili nell’uomo inchiodato
alla scena: sia egli si sottomette alla legge dello spazio circostante preesistente, ai quali si
adatta attraverso dei movimenti meccanici, dettati dalla ragione, come nel balletto, oppure
costruisce il proprio spazio come i grandi attori, seguendo le proprie reazioni dettate dal
senso, determinando a proprio piacimento le leggi che lo governano. Per Schlemmer il
danzatore incarna la sintesi di queste possibilità, dunque è l’incontro perfetto tra l’uomo e lo
spazio. Egli crea nel 1922 a Stoccarda il Balletto Triadico, un balletto ove la danza è
determinata dai costumi che rappresentano delle astrazioni del corpo umano, delle forme
rigide costituite da superfici plastiche e metalliche rigide. La coreografia venne determinata
dalla specificità dei costumi che, posti accanto alle luci ed allo spazio astratto della scena,
costituiva il “palcoscenico visuale”. Attraverso l’uso del costume, Schlemmer si richiamava
al modello della Commedia dell’arte, come faceva il suo contemporaneo russo Taïrov, per il
quale i costumi moderni dovevano essere una seconda pelle. Nel confronto tra soggettività
ed astrazione, il senso è legato alla figura, nella misura in cui questa è essenzialmente
antropomorfica. La figura astratta e “costruita”, come nella pittura, lascia un posto all’uomo
ed al senso. Costruire la danza è quindi una “mise en espace”, sviluppare il ritmo degli eventi
sulla scena: la drammaturgia nasce dalla legge ritmica degli eventi, indipendentemente da
ogni tipo di sceneggiatura, in quanto articolazione del linguaggio del corpo. Schlemmer non
nega la parola ma la evoca in modo a-letterario, attraverso il ritmo e l’evento: come Klee, egli
afferma una critica dell’arte della rappresentazione e dell’estetica. La rappresentazione sulla
scena resta dunque indissolubilmente legata alle arti plastiche, la cui immobilità è in tensione
rispetto all’arte del movimento e produce un equilibrio che vede l’apparizione dell’uomo in
contesto a-temporale. Schlemmer non compie un’ analisi sistematica del movimento,
piuttosto identifica quest’ultimo con il processo di costruzione scenica. Vestire il corpo dei
danzatori con costumi che ne impedivano la mobilità era un atto rivoluzionario in un momento
in cui si affermava la danza libera, che prevedeva al contrario dei costumi atti a facilitarne
l’espressione. Paradossalmente, rispetto alle istanze “analitiche” presenti nel mondo del
teatro, la riscoperta del principio vitale del corpo darà luogo nel mondo della danza ad un
bisogno di liberazione della tecnica, ove per tecnica si intendeva l’unica vigente all’epoca,
quella della danza classica. La Nuova Danza di Loïe Fuller, Isadora Duncan e Ruth St. Denis
prevedevano l'abolizione della scarpa da punta in favore del piede scalzo e la rinuncia ai
passi codificati nel XVII secolo in favore di movimenti legati all’improvvisazione. Una nuova
esigenza estetica e spirituale si fa strada, senza approdare, da un punto di vista tecnico, ad
23
un vero e proprio metodo ma piuttosto ad una sorta di spontaneismo. Da questi presupposti si
sviluppò in Germania la corrente di Danza moderna centroeuropea o Ausdruckstanz (Danza
Espressionista) da cui ha avuto origine il teatro-danza, corrente coreografica caratterizzata
da una nuova poetica a cui, dato il suo carattere complesso, dedicheremo un’analisi
specifica. La corrente americana della Modern Dance, contrariamente ad i fenomeni
coreografici europei, approdò già negli anni ’30, attraverso la figura della danzatrice e
coreografa Martha Graham (1894-1991), ad una elaborazione sistematica di una nuova
tecnica. A partire da questo momento, mentre la danza moderna e contemporanea acquista
una tecnica che trova in sé stessa la propria coerenza, il balletto riafferma i dogmi
fondamentali della propria tradizione, evolvendo progressivamente in termini stilistici e
tecnici grazie a figure del calibro di George Balanchine( attivo negli Stati Uniti a partire dagli
anni ’30), fino all’avvento della danza neoclassica( che raggiunge vertiginosi risultati grazie a
Matz Ek, Jyri Kylian e William Forsythe).Come abbiamo precedentemente accennato, la figura
del coreografo moderno implica una autorialità della tecnica utilizzata, dunque una
fondazione di una nuova tradizione di riferimento a partire da un atto di “scrittura” poetica del
soggetto. Questo fenomeno di rifondazione culturale della danza, specialmente evidente
negli Stati Uniti, prese le mosse dall'opera di riqualificazione del ruolo femminile iniziata in
Europa dalle fautrici della Nuova danza. Al pari degli altri domini artistici, anche il balletto era
infatti esclusivo appannaggio maschile: osannate come materia e strumento della danza, le
donne erano escluse dalla dimensione intellettuale, tanto teorica quanto critica. Lavorando
autonomamente sul corpo femminile per liberarlo dai condizionamenti estetici e ideologici
maschili, Martha Graham teorizza la danza a partire dalla consapevolezza del movimento e
fonda nel 1926 una compagnia interamente formata da donne. La Graham individua nella
coppia di movimenti complementari contraction-release (contrazione-distensione), propri
della vagina, e nella spirale, movimento basilare che interessa sempre la regione pelvica
sede del baricentro, un principio fondatore di una nuova tecnica. Per la prima volta vengono
elaborati una serie di esercizi e di sequenze coerenti al pavimento, come preparazione alla
stazione eretta ed in sostituzione degli esercizi alla sbarra della tecnica classica. I movimenti
e le cadute al suolo, nelle quali il danzatore impara a trarre dal terreno stesso la spinta a
rialzarsi, congiunti ad un lavoro sulle possibilità dinamiche della spina dorsale saranno il
terreno sul quale verrà fondata la ricerca di nuove possibilità creative e interpretative della
danza moderna e contemporanea. Da un punto di vista poetico, la Graham si è appoggiata
alla mitologia e alla psicanalisi freudiana e soprattutto junghiana, entrambe nutritesi del mito
sin dalle origini. Allievo di Martha Graham, il coreografo Merce Cunningham contribuisce a
partire dagli anni '50 all’evoluzione tecnica della danza moderna, approfondendo, attraverso
lo studio delle curve della colonna vertebrale, la relazione allo spazio. Contrariamente a
Schlemmer, egli considera la musica e la scenografia indipendenti dalla danza, che è spesso
organizzata sulla base di sequenze a combinazione aleatoria. I danzatori di Cunningham
sperimentano una relazione con il tempo presente e lo spazio astratto, in un’opera avulsa da
concetti comici, drammatici o politici. Dal 1942 collabora col compositore d’avanguardia
24
John Cage col quale condivide il rifiuto dei metodi formali dell’ arte del XIX secolo, messi già
in discussione da Duchamp. Grazie al rapporto col compositore americano, Cunningham
sviluppa un approccio alla danza che vuole essere “altro” dalla musica, capace d’ imporsi
come sostanza a sé stante dal suono e dall’immagine. Fin dagli anni quaranta sia Cunningham
sia Cage utilizzano metodi di lavoro basati sulla casualità. In “Root of an Unfocus” (Radice di
un non-centro, 1944) Cunningham utilizza il metodo cinese dell’ I’ Ching per creare le proprie
coreografie che tuttavia seguono la struttura ritmica della composizione musicale scritta da
Cage. Individuiamo fin dal principio, in Cunningham, una forte dose d’ improvvisazione unita
ad un rigido formalismo. I movimenti coreografici sono basati su un linguaggio codificato ma i
danzatori sono liberi di rallentare o velocizzare i movimenti, uscire ed entrare dalla scena,
scegliere la successioni delle frasi coreografiche da eseguire. Il viso ed il corpo assumono
tuttavia un ruolo neutrale, ed in questo senso nella danza moderna americana ( ad esclusione
delle influenze legate alla tecnica jazz ed alla commedia musicale di Broadway) la
soggettività “umana” del danzatore non trova posto se non in quanto strumento della totalità
coreografica. Negli anni sessanta Cunningham sostituisce alla nozione classica di
“spettacolo”, quella di “laboratorio” e “performance”. Parallelamente in Europa, l’esigenza di
focalizzare l’attenzione più sul processo creativo che sul risultato trova un eco nel concetto
del teatro-laboratorio di Grotowsky. Le possibilità offerte dai nuovi media affascinano
incuriosiscono molto Cunningham, il quale utilizza sovente paragoni con i mezzi di
comunicazione di massa nel descrivere le proprie idee sulla danza. Nel 1968 Cunningham si
interroga sul futuro della danza in rapporto alle tecnologie ed già cosciente del fatto che
queste saranno in grado di arricchire il processo di creazione coreografica ma che la
riluttanza del mondo accademico rischierà di rallentarne di molto l’introduzione nella danza.
Il desiderio di Cunningham è quello di trovare il mezzo più ottimale per realizzare i propri
obiettivi artistici. La tecnologia elettronica ha introdotto un nuovo modo di vedere la realtà, di
negoziare, di pensare. Grazie ai nuovi media digitali è sempre più possibile “editare” un
prodotto creativo, interagendo su di esso, annullando o ripristinando modifiche che non
andranno ad influenzare il “già salvato”. Da questo presupposto, Cunningham ipotizza un
sistema di “notazione di danza elettronica immediata” che serva a mostrare i movimenti della
danza, fermali o rallentarli. Nel 1986 questa sua idea si materializza nel software Life Forms.
Un'altra figura da ricordare è quella di Alwin Nikolais (1912-1993), contemporaneo di
Cunningham, che operò a partire dal 1948 al Playhouse di New York, centro culturale che
fungeva da laboratorio teatro e scuola. Nikolais proveniva dal mondo della musica e delle
marionette ed era, come Schlemmer, appassionato dalla relazione tra l’uomo e lo spazio.
Nella sua concezione, quest’ultimo era un elemento architettonico e fluido che
accompagnava il danzatore e lo studio sulle qualità di movimento consentiva la
“visualizzazione” delle qualità dello spazio. Il gesto non doveva essere per Nikolais carico di
drammaticità o simbolico, né quotidiano né preso in prestito da altre tecniche. Il vocabolario
della sua tecnica investiva piuttosto le qualità d’energia e di spazio e tempo: il lavoro era
compiuto attraverso i termini di staccato, accentato,vibrato , pesante e leggero, duro e
25
morbido, curvo e spigoloso.
Nikolais afferma nel suo libro postumo The unique
gesture:”Nella danza, la figura dell’uomo può trascendere la sua dimensione umana e, come
nella musica, diventare qualunque cosa. Il danzatore può essere astratto o concreto. Può
essere l’essenza di un personaggio senza esserlo lui stesso. Può essere un’emozione senza
essere colui che la prova. Può essere la qualità di un tempo dato o di uno spazio dato.”
sottolineando
così il potere trascendente del danzatore attraverso la sua possibilità di
trasformazione. Questo pensiero avvicina, almeno su una linea di principio, Nikolais a
Schlemmer e alla sua Kunstfigur. Parimenti l’esuberanza dei costumi e degli oggetti di scena
e la visione astratta del movimento del coreografo americano partecipavano alla costruzione
di un teatro totale che evoca il palcoscenico visuale di Schlemmer. Nikolais si serviva di
maschere e oggetti che esaltassero il potere di trasformazione dei danzatori e ne
prolungassero il corpo nello spazio, in modo da decentralizzare l’uomo e creare un universo
multipolare. In questo senso, l’impersonalità del danzatore era utilizzata come ego
trasparente che si immergeva nel contesto spaziale d’appartenenza. Nonostante le numerose
somiglianze con Schlemmer(fatta eccezione per il vocabolario tecnico, molto più complesso),
Nikolais affermò ripetutamente che non vi era alcuna filiazione o influenza fra la sua opera e
quella del coreografo tedesco e, d’altra parte, Nikolais non fece mai riferimento nemmeno ai
suoi contemporanei, come José Limón o Merce Cunningham. Ritornando al teatro europeo
del dopoguerra, il problema della tecnica dell’attore trova un’ implicazione drammaturgica
nuova nella figura di Bertold Brecht (1898- 1956). Brecht sosteneva che la tecnica dell’attore
atta all’identificazione con il personaggio era una fonte d’impedimento alla riflessione del
pubblico e costituiva una ricaduta in un teatro sentimentale ed emotivo. Il problema della
tecnica, affrontato sotto vari aspetti, si riduceva infatti sino ad allora a quello della sincerità
dell’attore
ed
alla
sua
credibilità
nella
parte.
L’”ontologia”
dell’attore
riposava
sostanzialmente sulla mimesi e su ventiquattro secoli di teatro aristotelico fondato sul
principio della catarsi. Brecht aspirava, sul modello di Piscator, ad un teatro che innovasse la
coscienza morale e civile del popolo e proponesse un nuovo modello di teatro epico, ispirato
al vissuto e al quotidiano, in cui i registri espressivi della parola, della musica e del gesto si
fondessero in modo coerente. Il teatro di Brecht non mirava all’empatia, ma tendeva a
sviluppare il senso critico del pubblico, chiamandolo ad esercitare un giudizio rispetto alla
storia, intesa in senso non solamente particolare e soggettivo ma come corso degli eventi a
cui l’umanità è chiamata a partecipare. Questo ruolo cosciente ed “attivo” del pubblico era
ottenuto da Brecht attraverso il distanziamento dell’attore dal ruolo interpretato. Un
atteggiamento critico di questo tipo era presente già in parte negli attori mejercol’diani e fu
definito da Brecht come Verfremdungseffekt, ovvero effetto di straniamento. Il termine era
stato introdotto nella teoria e nella critica letteraria dai formalisti russi (Circolo linguistico di
Mosca, 1915) per indicare i procedimenti formali attraverso i quali l'artista produce nel lettore
una percezione 'strana', cioè inusuale, della realtà, creando un effetto di sorpresa e di
spaesamento. Lo straniamento (in russo, ostranenje) è dunque il procedimento-effetto che,
rilevando gli aspetti e le funzioni nuove del reale, rimuove qualunque sottinteso e rompe gli
26
automatismi del linguaggio. Per Viktor Šklovskij, formalista russo, lo straniamento era la
procedura artistica più importante, perché produce una nuova visione dell'oggetto attraverso
lo 'slittamento semantico'. I tropi, cioè le figure retoriche di carattere semantico proprie del
linguaggio artistico (come ad esempio la metafora e la metonimia), sono casi particolari di
questo slittamento semantico. In generale, tutte le scelte retoriche e stilistiche che
travalicano il normale orizzonte espressivo, prolungando ad esempio la durata della
percezione, concorrono all'effetto di straniamento. Il gusto barocco del meraviglioso e la
complessa architettura linguistica di Gadda, ricca di neologismi, onomatopee e termini
dialettali,
sono
un
esempio
di
linguaggio
che
fuoriesce
dagli
automatismi
della
comunicazione. Per Brecht l'attore doveva in questo modo 'storicizzare' i contenuti,
sottolinearne il carattere effimero e transitorio in un processo che mostra l'artificialità della
rappresentazione teatrale: l'attore può rivolgersi direttamente al pubblico ed esporre cartelli,
i cambiamenti di scena avvengono a vista. Per la formulazione della tecnica dello
straniamento, Brecht si ispirò all'arte drammatica e alla gestualità degli attori cinesi, del
teatro elisabettiano e del teatro classico spagnolo. L’esigenza brechtiana di un dramma
scientifico e marxista, che utilizzasse una distanza critica tra significante e significato,
impose in questo senso un’ estrema coerenza dei mezzi espressivi utilizzati ad un fine
didattico. Roland Barthes
affermava in proposito:“L’artigianato drammatico è anch’esso
coinvolto, tutte le tecniche, anche le più “naturali”, significano sempre qualcosa: vi è un’arte
rivoluzionaria o progressista dell’attore, un modo responsabile di mettere qui o lì un riflettore,
di mettere una tenda al posto di una tela dipinta. Brecht ha pensato bene a questa
responsabilità delle tecniche: anche il trucco è un atto politico, sul quale dobbiamo prendere
posizione, e che, attraverso l’infinita dialettica degli effetti e delle cause, partecipa finalmente
dello stesso combattimento rivoluzionario del testo.”. La coerenza scientifica dell’impianto
brechtiano poneva il problema della responsabilità registica della scelta dello stile, ed
andando al di là di un semplice rifiuto del teatro naturalista saldava forma e contenuto,
tecnica e poetica, attraverso un paradossale processo di lucidità storica. Brecht, come
osserva Barthes, rompe con il mito dell’attore posseduto che, partecipando del tema
ancestrale del doppio e del tema del sacrificio propiziatorio, rappresentava ed esorcizzava i
rischi ed i drammi umani immolandosi al posto del pubblico. Brecht pone il problema del
coinvolgimento del pubblico in modo nuovo, non a partire da una proposta spaziale ed
architettonica o ipnotica ed emotiva, ma restituendogli in qualche modo la funzione critica e
partecipativa del coro greco, che non si lascia inglobare nella fatalità delle vicende
rappresentate e si meraviglia e commenta costantemente. A partire dalla metà del XX secolo,
il problema della scelta della tecnica teatrale e coreografica si pone dunque come
“contaminazione delle tecniche” afferenti ai vari domini del linguaggio e come atteggiamento
cosciente rispetto alle eredità storiche. Come proferiva Nikolais, attraverso il suo “The
medium is the message”, la tecnica è definitivamente consustanziale all’atteggiamento
poetico ed è grammatica attorno alla quale si articola il fare drammaturgico.
27
La regia critica.
Abbiamo visto come il principio di regia si sviluppi parallelamente al passaggio dal
naturalismo al simbolismo in un contesto culturale che si rinnova globalmente rispetto alla
rivoluzione industriale ed ai mutati rapporti tra arte e società. La riforma wagneriana, le
teorie di Appia e Craig, le riflessioni sulla pedagogia e le tecniche sviluppatesi in Francia e
Russia partecipano ad una rifondazione del teatro che privilegia un progetto registico unico e
coerente, capace di utilizzare sapientemente tutte le componenti dello spettacolo e di aprirsi
all’assimilazione dell’”ultrateatrale” a teatro. Artaud aveva parlato di regia come linguaggio
tipico del teatro ed aspirava alla figura di un creatore unico. La tendenza privilegiata di
questo momento storico è, come notava Schlemmer, astratta ed è dunque un’arte nonimitativa, come quella preconizzata da Hegel, che fonda il principio di regia. Tuttavia, se per
molti versi il concetto di drammaturgia risultò essersi esteso e arricchito rispetto all’utilizzo
della scenografia, del corpo e del ritmo, la regia rimase per molto tempo legata all’idea di un
regista demiurgo, vale a dire tributario di un’idea poetica superiore contenuta nel testo ( o
nella musica). L’opera di Brecht, nonostante sia rimasta per lungo tempo confinata alla
riduttiva visione politica e programmatica marxista, ebbe in questo senso una notevolissima
ripercussione in tutta Europa in quanto portò in primo piano l’istanza di un arte critica,
ponendo un fondamentale problema semiologico. Sottolineando l’arbitrarietà del segno e
utilizzando poeticamente la convenzionale “menzogna” del teatro, Brecht sottopose la regia
stessa ad un movimento tellurico dei suoi domini di competenza. Come sottolinea Barthes, la
sua opera fu una scossa in quella “logosfera”, intesa come discorso dominante, che ci
avvolge totalmente e che è determinata dalla nostra epoca, classe o mestiere: che è in
definitiva un “dato” del nostro essere. L’arte critica è dunque quell’arte che apre una crisi,
diluisce il discorso dato e si costituisce come discontinuità del linguaggio. Una discontinuità
che distacca il segno dal suo effetto e discretamente indica la provenienza formale del
discorso. Il segno inquietante di Brecht è un segno straniato due volte, dallo sguardo
dell’attore e dallo sguardo dello spettatore. Da qui nasceva la possibilità di
una critica
dialettica rispetto ad un oggetto divenuto plurale, attraverso una libertà di giudizio che vede
il segno e come realtà e come gioco. Tale “smascheramento” autorizzava l’intervento
registico come atto creativo globale e libero. Una volta consolidatasi la pratica registica,
anche nel teatro commerciale, si precisarono una serie di tendenze distinte, una serie di
modi pratici del fare teatro. Intorno agli anni ’60 è possibile riconoscere in Europa, con
diverse modalità in ciascun paese, l’emergere della cosiddetta regia critica. Il termine “regia
critica” è dovuto ad uno studio di Claudio Meldolesi sulle tendenze registiche in Italia, ma è
suscettibile a mio parere, in quanto indicatore di un certo tipo di prassi creativa, di elucidare
un cambiamento profondo del teatro di regia in Europa a partire dagli anni ’50 e non solo
rispetto al testo drammatico. Lungi dall’essere un movimento unitario, la regia critica si
caratterizzò per un peculiare modo produttivo e per una spiccata posizione intellettuale dei
suoi protagonisti. L’istanza critica coincise nella maggior parte dei casi con un’autorialità che
28
comprendesse(come già in Brecht) la scrittura del testo o quantomeno una sua riscrittura. Il
regista critico sonda
l’asse passato/presente attraverso l’analisi di testi che sono già
“acquisiti” e “riconosciuti” come patrimonio culturale comune, muovendosi liberamente
attraverso il mondo dei classici letterari, teatrali o figurativi. La scrittura critica nasce poi dai
vuoti del testo, da quell’eredità contenuta a priori in un’opera artistica, ed è alla volta data da
una risultante storica e da un atto soggettivo. Il regista si pone come intellettuale e soggetto
morale insieme, si fa carico, pur attraverso una serie di innesti dall’esterno, di una presa di
posizione spesso imbarazzante rispetto alle sedi istituzionali del teatro e spesso causa di
isolamento. I contesti storici e le influenze culturali nazionali, come ad esempio il cinema
neorealista in Italia, sono preziosi indicatori di una sensibilità comune alla regia critica in
determinati momenti, ma una pratica siffatta rimanda all’analisi di personalità precise,
nonostante l’esigenza di cogliere delle direttive di fondo. Si è scelto dunque di soffermarsi
sull’opera di alcuni registi che testimoniano un tipo d’approccio autoriale originale quanto
completo nei vari aspetti della drammaturgia “dilatata”. Una riflessione importante che
accomuna autori come Samuel Beckett, Tadeusz Kantor, Carmelo Bene e Romeo Castellucci
è, mi pare, quella compiuta rispetto alla “figura”. L’opera, scrive Blanchot, “ da voce,
nell’uomo, a ciò che non parla, all’ineffabile, all’inumano, a ciò che è senza verità, senza
giustizia, senza diritto, laddove l’uomo non si riconosce.” 8 . L’inumano è qui da intendersi non
come l’espressione di ciò che è barbarico bensì come ciò che sorpassa l’uomo, ed in questo
senso la drammaturgia contemporanea vede delinearsi una figura che va oltre i contorni del
personaggio, che compie atto di figurazione e non di mimesi. Su questa figura il teatro che ha
messo in questione l’identità ed il senso ha apposto il suo segno per sfigurare, per spostare i
legami, per fendere le forme provvisorie del linguaggio. Il segno che sfigura non è assunto
qui come atto distruttivo, ma come deformazione e distinzione della figura, come rinascita di
una figura atipica. L’atto critico si contraddistingue per una passione dell’interpretazione,
per un’apertura che disfa e reinventa costantemente. Esso infrange l’illusoria riconoscenza
di Narciso del sé con il sé, indaga i riflessi, pronuncia il si se non noverit 9 che sottende allo
sguardo.
8
Maurice Blanchot, L’Espace littéraire, Folio-Essais 1955, trad. G.Amarù
“Si se non conosce se stesso” risposta di Tiresia alla madre di Narciso, che gli domandava se il figlio potesse
aspirare alla vecchiaia.
9
29
La drammaturgia del silenzio.
L’opera di Samuel Beckett (Foxrock, contea di Dublino, 1906 — Parigi, 1989) ha una portata
filosofica oltre che critica e drammaturgica. Scrittore, drammaturgo e regista singolare,
sviluppò una poetica che seppe evolvere secondo i campi di scrittura investiti, restando
tutt’oggi difficilmente classificabile dall’esterno, per la profonda coerenza e completezza di
ricerca che ne fanno un universo indipendente e compiuto. L’eredità artistica consegnataci
da Beckett è atroce e perfettamente umana al medesimo tempo, e si impone, da un punto di
vista strutturale, all’analisi di chi volesse individuare una dilatazione pertinente del concetto
di drammaturgia. Il teatro beckettiano viene d’abitudine classificato, assieme a quello di
Harold Pinter ed Eugène Ionesco, come teatro dell’assurdo, ma in effetti non ne condivide la
componente surrealista ed è, in modo singolare, la risultante di un procedere poetico
costantemente legato a contesti ultrateatrali. Di fatto l’opera beckettiana si articola rispetto
al testo ed alla dissoluzione verbale, inventa una lingua delle immagini e degli spazi che
nasce dai romanzi e dalle prose brevi, passa dal teatro e giunge alla televisione. Questo
processo, lungi dall’essere lineare e teleologico, prevede continui adattamenti e scambi fra i
diversi ambiti, si traduce in una porosità che dilata i confini di “genere” ed indaga la realtà in
modo scientifico e globale. Tale poetica si pone di fronte all’esperienza fondamentale
dell’uomo, cioè quella situata al bivio tra l’impossibilità di conoscere qualcosa dell’esistenza
e l’impossibilità di non esistere. Tornando agli elementi biografici, occorre ricordare che
Samuel Beckett
ricevette una rigida educazione religiosa dalla famiglia protestante, in
particolare dalla madre. Il ricordo delle Scritture è rintracciabile nei suoi primi testi e la figura
materna ritornerà più volte nella sua opera come una sorta di fantasma commisto ad un
senso di sacro e d’ orrendo. Da qui derivano in prima istanza il tema del peccato originale e
l’ assoluta separazione del corpo e dello spirito, un disprezzo costante per l’organico e per la
fecondità. L’amore carnale è visto da Beckett cinicamente, come un atto dalla dinamica
ridicola ed oscena. Nel 1928 si trasferisce a Parigi come lettore d’inglese alla Scuola Normale
Superiore, dove Sartre e Merleau-Ponty terminavano i loro studi. In questi anni si allontana
gradualmente dal mondo irlandese ed incontra il suo compatriota Joyce, a cui si lega di
sincera amicizia e con cui condivide molteplici affinità. Attraverso la lettura di Proust Beckett
trova una sorta di giustificazione ontologica ai suoi stati di pigrizia ed immobilità, alla sua
convinzione che nel ritiro dalla vita attiva si trovi una vita autentica. Pur disprezzando l’arte
realista, si consolida in lui il gusto per il concreto fino, contrariamente a Proust, a non
accordare una funzione salvifica alla memoria, che definiva “un gabinetto medico provvisto di
veleni e contravveleni, di eccitanti e di sedativi". In questi anni Beckett compie un’indagine
sull’Io
profondo,
di
cui
coglie
la
presenza
nel
silenzio
e
nella
solitudine,
e
contemporaneamente, si dedica ad una intensa attività saggistica e di traduzione,
specialmente delle opere joyciane. A proposito di Joyce egli scriverà, nel saggio “Dante ...
Bruno . Vico … Joyce “(1929):"Qui la forma è il contenuto, il contenuto è forma. Mi si opporrà
che 'sta roba non è scritta in inglese. Non è scritta affatto: non è fatta per essere letta, o
30
meglio, non è fatta solo per essere letta. Bisogna guardarla, ascoltarla: la scrittura di Joyce
non è un componimento su qualcosa: è quel qualcosa. [...] Quando il senso è sonno, la parola
dorme. [...] Quando il senso è danza, la parola danza". L’identificazione di forma e contenuto
compiuta da Joyce avrà una profonda ripercussione nella scrittura di Beckett. Nel 1931
rientra in Irlanda dove ottiene un lavoro d’assistente all’Università, ma sei mesi dopo lascia il
paese natale sentendosi ormai impossibilitato a viverci, per poi trascorrere cinque anni di
esistenza vagabonda che lo condurranno a trasferirsi nuovamente a Parigi nel 1937. Di
questo periodo errante e doloroso rimane traccia in “More Pricks than kicks” (1934) e in
‘Echo’s Bones” (1935). Beckett si affanna a rinnegare tutto ciò che costituiva la vita
intellettuale e religiosa del suo paese ed alterna un opaco pessimismo ad una satira religiosa
pungente, che deride le superstizioni dei compatrioti. Durante gli anni parigini coltiva delle
letture che vanno dai filosofi greci ai mistici indiani, giungendo a posizioni positiviste secondo
cui Dio è una invenzione umana per vivere meglio, per addormentarsi. A partire dal 1938,
Beckett lavorerà all’evoluzione delle tecniche d’espressione a partire da una posizione
intellettuale e spirituale ormai consolidata. Durante l’occupazione nazista scrive il romanzo
Watt, opera ricca di un umorismo tragico, che nasce da un riso puro ed aperto di fronte alla
vertigine della condizione umana. La risata è l’ultima tappa della disperazione, una collera
che si raggela come nella graffiante satira di Swift. Essa è un atto liberatorio contro l’ordine
apparente, contro la frode degli educatori, dei legislatori e dei moralisti, contro la speranza
che all’origine della vanità. Beckett ammette che nulla è più divertente del dolore,
constatando una sconfitta dell’intelligenza ferita dalla scandalosa distanza che separa ciò
che essa esige da ciò che constata. Watt è l’ultima opera in inglese di Beckett. A partire dal
1945 egli sceglierà di scrivere in francese, e di adottare la lingua materna in seconda istanza,
in quanto traduzione. Questa scelta drastica si spiega con una volontà di non sottostare ad
uno stile, per cui la lingua francese diviene una sorta di organo di lucidità e di distacco ed, in
definitiva, di libertà. La drammaturgia beckettiana
si affranca progressivamente
dall’influenza joyciana attraverso un’intuizione poetica fondamentale: un processo di
sottrazione e scarnificazione deve investire la lingua, la narrazione, il numero di personaggi,
lo spazio. La scrittura si fa monologante, rarefatta dai silenzi, le azioni vengono ridotte fino ad
una “drammatica” assenza di fatti, la personalità delle figure si assottiglia fino a raggiungere
l’impersonalità di colui che parla. La progressiva scomparsa della descrizione segna il
passaggio di Beckett al teatro. Beckett aveva già scritto dei drammi fino ad allora non
rappresentati o incompiuti, ma è con “Aspettando Godot”(1949), rappresentato con successo
a Parigi nel 1953, che viene consacrato come autore teatrale. Le intuizioni beckettiane
trovano nel teatro tutta la loro potenza espressiva: la “perdita” progressiva del testo e della
descrizione viene completata dal lavoro sull’immagine e sullo spazio. Esaurito il potere della
parola restava infatti da indagare la potenza rivelatrice del gesto, la sua capacità di
contraddire l’espressione verbale. Il gesto scavalca in Beckett la condizione afasica
dell’uomo, può proiettare all’esterno la forza drammatica dell’evento: come Charlot, Beckett
cerca una comunicazione viscerale attraverso la smorfia ed il mimo. Negli anni successivi la
31
riflessione fisico-spaziale di Beckett rivela una finezza sempre più capace di aderire al
contenuto poetico, in quella perfetta coincidenza di forma e contenuto che egli aveva
ammirato in Joyce: ce ne lasciano testimonianza “Atto senza parole” I e II (1956) e “Finale di
partita” (1957). Ritornando al contesto culturale compreso tra gli anni che precedono e
seguono la seconda guerra mondiale, ricordiamo che Heidegger aveva dato corpo ad una
visione tragica dell’esistenza attraverso una dettagliata fenomenologia dell’angoscia, della
noia e della finitezza umana. Nel1938 veniva pubblicata la nausea di Sartre e Camus comincia
a scrivere il mito di Sisifo.
Nel dopoguerra, la traduzione dell’opera di Kafka si diffuse
rapidamente, dando il segno di quel sentimento di schiacciamento dell’umanismo che si
prolungò durante lo stalinismo e la guerra fredda. È un momento in cui l’Occidente ateo,
scandalizzato dalla propria barbarie, si pone delle questioni fondamentali, come illustra il
nichilismo cinico di Cioran negli anni ‘50. Beckett, testimone e profeta al tempo stesso delle
umiliazioni della Storia, fa del dubbio cartesiano il suo strumento di ricerca. Le sue figure
sono totalmente risucchiate verso l’interno, si recludono nello spirito come per cercare una
solidità interna all’uomo. In “Aspettando Godot” ad esempio, né Vladmir né Estragon si
accorgono che “Dio” fa germogliare un albero, e,precipitati nel loro io, non partecipano a
nessuna vitalità cosmica. Il corpo distinto dall’anima degli eroi beckettiani trova un modo
goffo e maldestro di esprimersi, è tragicamente comico di fronte alla coscienza ipertrofica.
Parallelamente allo sgretolarsi della vita esterna, il Cogito comincia un discorso senza fine né
scopo, per ammazzare il tempo, per darsi una qualche consistenza. La lucidità cartesiana è
tuttavia condannata ad agire nell’assenza di Dio, dunque non ne rimane che la disperata
traccia sonora: per Beckett la sua opera “è una questione di suoni fondamentali resi il più
pienamente possibile”. Voci, mormorii e sussurri costituiscono un appiglio rispetto al caos
esterno. Il Cogito suscita l’analisi che a sua volta disintegra il pensiero, in un movimento
ebete e paradossale che avvicina l’intellettuale al volgare ignorante, come nel Nirvana che
riconcilia gli opposti. Ancor prima degli strutturalisti, Beckett aveva intuito che il linguaggio
che parliamo non ci appartiene, è il linguaggio d’altri. È con le parole altrui che ciascuno
tenta d’esistere, tenta di riempire velocemente il vuoto attraverso il flusso incoerente del
linguaggio. Lo strumento di comunicazione ha funzione ontologica, addirittura diventa una
figura a sé stante nello spettacolo “Non io” (1972) . Il ruolo di Bocca, che compie la
narrazione, è assunto da una donna di cui si vede appunto solo la bocca. Bocca parla in terza
persona di sé stessa, è soltanto un organo di comunicazione che si svuota per non smettere
d’esistere e che tuttavia non dice realmente qualcosa. Come la Penelope joyciana, da sfogo
ad un flusso indistinto di parole che sono chi le dice. In questa dimensione quantitativa del
linguaggio, Beckett orchestra la drammaturgia secondo una durata che è assieme musicale
ed esistenziale. Verbosità e silenzi hanno un equivalente spazio e valore, sono compenetrati
della stessa necessità vitale. Questa complementarità è parimenti illustrata nell’ opposizione:
la voce tormenta, il silenzio risponde, come in “Dis-Joe”(1965). In questo processo l’io
parlante si disintegra in un io collettivo, in un rumore di fondo che disgrega la soggettività. Il
discorso si fa mostruoso, le parole dell’altro contaminano ogni residuo soggettivo cosicché il
32
parlante è costretto a scegliere fra la follia ed il sonno. Da un punto di vista estetico, il
passaggio alla figurazione dei personaggi si completa intorno agli anni ’50, parallelamente
alle tendenze espresse nell’arte contemporanea. Come in Giacometti, l’essere umano è
“sfigurato”. Come nelle sculture dell’artista svizzero, le figure beckettiane annunciano la
dialettica opposizione fra immobilità e cammino. Quella che Giacometti chiama ossessione
per la testa, in Beckett è ossessione per il pensiero. In questo senso la sua drammaturgia è
atto di figurazione, in una coincidenza tra essenzialità, precisione seriale e totale apertura
della rappresentazione. Il Sisifo di Beckett porta il peso di sé stesso, s’ostina a ricominciare
eternamente il percorso: da qui il tema della ripetizione, della circolarità tragica che troviamo
in “Commedia”(1963) o “Quad”. L’isolamento delle figure beckettiane è una fonte di
protezione, un universo fatto di piccole cose, d’oggetti quotidiani e derisori d’ogni tipo, erti a
muraglia contro il vuoto: una barriera ridicola e consolatoria. L’uso della luce, contribuisce a
evocare questa specie di realtà desertica: il bianco, colore prediletto da Beckett, è la cifra
visiva di uno spazio asettico, insostenibile ed inumano, è il colore dell’assenza. Nei suoi
allestimenti sono spesso presenti delle superfici abbaglianti, sgretolate da una luce che è uno
sguardo feroce; per contrasto sono altresì presenti le atmosfere crepuscolari, le nebbie che
illustrano la presenza umana come diluita
dal dubbio, dalle ipotesi. Beckett orchestra
sapientemente le pause per creare uno spazio/tempo sospeso, come fuori dal mondo,
facendo coincidere il ritmo drammaturgico con quello di un’agonia, che procederà alla rovina
definitiva ma “autentica” della figura. Proprio questa rovina è la reale dimensione
dell’esistenza, la stessa che l’uomo ritrova la sera, dopo la vana agitazione diurna. In questo
senso si colloca l’estetica che vuole le figure beckettiane simili a quelle dei barboni, in uno
stato di decadenza fisica che attinge ad una miseria metafisica: vestiti da cappe, muniti di
bastoni e con un sacco da viandante gli uomini strascicano i loro passi. Essi sono pura
esistenza, orribilmente trasparenti nel loro essere spossessati di qualunque cosa tranne che
della loro vita assurda. Il keep on the move di Beckett illustra degli esiliati e degli espulsi in
un altrove, come in “Quad” o nel personaggio di Molloy, condannato ad ” andare solo
attraverso vie sconosciute, al calar della notte, con un bastone” in un vano tentativo di
evasione. L’attesa di qualcosa è dunque assunta a categoria fondamentale dell’esistenza
cosciente, in quanto attesa di Dio o attesa della vera vita. A detta di Beckett, se i personaggi
di Kafka hanno ancora uno scopo, i suoi si disgregano in polvere, incastrati fra il desiderio e
la paura del nuovo. Eppure sopportare l’attesa di Godot è pur sempre qualcosa, come dice
Vladmir: ” non siamo dei santi, ma siamo all’appuntamento. Quanta gente potrebbe dire
altrettanto?”. Un’ immagine cristiana fedele a questa condizione è quella del purgatorio. La
vita terrena è il purgatorio, e Beckett assumerà a modello delle sue figure l’indolente
Belacqua della Divina Commedia. Il suicidio stoico potrebbe essere una via d’uscita
all’agonia dell’attesa ma persiste il dubbio che la morte non sia la fine del dolore. L’attesa si
configura allora, come nella teologia tragica di Lutero, come un’attesa della grazia. Ma la
grazia prefigura un intervento dall’esterno, è lo strumento che asserve l’uomo ad un Dio
lontano. Dio è sconosciuto e inconoscibile, cosicché Beckett giunge spontaneamente alla
33
visione primitiva di un Dio barbaro, di un Dio crudele. La rivolta beckettiana non è
comparabile a quella di Sartre o di Genêt: egli si situa al di qua del sovversivo, non sceglie il
male ma lo subisce. E precisamente subisce la malattia dell’intelligenza, che è l’alienazione.
Negli anni ’60 il lavoro sull’immagine visiva e sonora giunge a concepire delle figure in una
situazione ambientale estrema di imprigionamento. Nella pièce “Giorni felici” (1961) Winnie,
la protagonista , è interrata fino alla vita e successivamente fino al collo ma si ostina, da
donna borghese, a dire di essere felice. Nelle opere “Quello
che è strano, via” (1964),
“Immaginazione, morta immaginate” (1965), “Bing” (1966), “Lo spopolatore” (1960)
la
sperimentazione linguistica coincide con la rappresentazione formale/scenografica. La
scrittura illustra delle istallazioni claustrofobiche, comprende disegni e misure della struttura
che ingloba l’uomo. La violenza dell’immagine pura si inserisce nel linguaggio, non si
definisce per il sublime del suo contenuto, ma per la forma, per una tensione interna che si
stacca dalla memoria e dalla ragione. Illustrata come processo alogico, essa va al di fuori del
linguaggio per collocarsi nella vastità dello spazio: uno spazio definito geometricamente ma
che accede all’indefinito, ad un “senza qui o altrove dove mai si avvicineranno o
allontaneranno da nulla tutti i passi della terra”. L’energia dell’immagine è dissipativa; il suo
destino è quello di disfarsi, di non durare. L’essere filiforme o larvale di Giacometti torna, la
sua statura è relativa secondo il punto di vista: l’uomo è ridotto a sguardo. Beckett approderà
al cinema proprio per un desiderio di controllare quello sguardo scrivendo la sceneggiatura
di “Film” (1963). L’esperienza che ne riceve è fallimentare, sia per un’avversione per gli Stati
Uniti, dove “Film” era stato girato, sia perché si rende conto che il cinema, per ragioni
produttive, non offriva affatto quel controllo assoluto sull’opera a cui egli aspirava. Sarà la
televisione a dargli la possibilità di sviluppare le potenzialità della camera: la forza dei primi
piani, l’uso della camera fissa o dello zoom gli si offrono come strumenti poetici. Le opere per
la televisione “Dis-Joe”(1965), “Quad”(1981), “Trio du Fantôme”(1977), “…Que nuages
…”(1976), “Nacht und Traüme”(1982) vengono realizzate a Stuttgart e diffuse dalla R.F.A.,
quindi, con un processo singolare, rimontate per il teatro negli anni successivi. È
interessante in questa sede prendere in esame “Quad”, per la sua struttura essenzialmente
coreografica, attraverso l’analisi proposta da Gilles Deleuze. Opera senza parole né voci,
“Quad” è un quadrato determinato solo spazialmente, da linee e diagonali equidistanti dal
centro e coincidenti con un numero preciso di passi. Di “Quad” esistono due versioni,
differenziate da poche ma significative modifiche. Le quattro figure che vi prendono parte,
asessuate e filiformi, sono coperte da cappe che nascondono il viso. In “Quad I” sono
distinguibili, poiché a ciascuna figura è attribuito un colore ed il suono di uno strumento
musicale, in “Quad II” sono totalmente equivalenti poiché vestite tutte di bianco e
accompagnate dal semplice ritmo dei loro passi. Si tratta di figure neutre in uno spazio
neutro. Il movimento è inesorabile, caratterizzato da un passo strascicato e concepito come
una serie che ha l’ordine di un canone, come un insieme di monologhi. Beckett caratterizza
la coreografia come “quattro soli possibili, tutti cosi esauriti; sei duo possibili, tutti cosi
esauriti (di cui due per due volte); quattro trio possibili due volte, tutti cosi esauriti”.
34
L’aggettivo francese utilizzato più volte da Beckett in questa descrizione è épuisé , ed il suo
senso racchiude preziose indicazioni drammaturgiche. La traduzione italiana deve a questo
proposito oscillare di volta in volta tra il triplice senso di spossato, esaurito e sfinito.
L’indicazione di Beckett concerne l’esaurimento delle possibilità, va oltre il concetto della
fatica. Il è movimento ripetuto, automatico e sofferto allo stesso tempo. L’ esaurimento delle
possibilità concerne lo spazio, come pure lo status delle figure. La potenzialità del quadrato
si trova al centro che, attraverso una sincope ritmica, i danzatori schivano. La possibilità che
qualcosa avvenga, oltre la ripetizione dei percorsi delle figure, è dunque negata. Il soggetto
si trova dinanzi all’assenza del possibile o quantomeno alla sua latenza. L’esaurimento delle
possibilità erode la potenza del soggetto, la sua capacità di realizzare qualcosa o di avere
uno scopo o quantomeno una scelta. “Quad” mostra, attraverso l’assenza della parola, come
il binomio potenza/libertà di cui la lingua si fa portavoce attraverso il semplice fatto
dell’enunciare, ceda il passo al silenzio, che è castrazione delle possibilità e dei movimenti
volontari della coscienza. L’épuisement beckettiano è in questo senso un rientrare in un
ordine ripetitivo e non teleologico, in una situazione combinatoria delle variabili che rinuncia
a qualunque forma di significato. Un significante/ vita opaco all’analisi che è esplorazione ed
impedimento contemporaneamente. Il soggetto spossato non è dunque passivo, ma si attiva
verso il nulla: Beckett utilizza il movimento ed il principio drammaturgico della trasformazione
per mettere in risalto un soggetto incapace di abolire il dato reale a cui pretende arrivare.
Tutta l’opera di Beckett è composta si serie esaustive, di processi combinatori che investono
e le figure e gli oggetti, in un impianto scientifico dell’esaurimento delle possibilità. In questo
processo drammaturgico esaustivo, la figura beckettiana si esaurisce fisiologicamente, va
verso una degenerazione che fa entrare l’io in un processo di decomposizione, in una
perfetta coincidenza tra esattezza dell’atto matematico e frantumazione della figura. Nota
Deleuze che “i dannati di Beckett sono la più sorprendente galleria di posture, posizioni e
modi di camminare dopo Dante”. La disgregazione del personaggio e della lingua corrono in
parallelo; il linguaggio nomina il possibile, ma il personaggio è oggetto senza nome, è figura.
Figura e lingua si scontrano: la drammaturgia diviene una vera operazione metalinguistica,
fatta di relazioni spaziali fra figura ed oggetti che rimpiazzano le relazioni sintattiche della
lingua e riducono quest’ultima a una funzione nominale, vocale o rumoristica. Le voci sono
utilizzate come flusso continuo e combinatorio delle particelle linguistiche, scandiscono la
durata teatrale/esistenziale. Il tema dell’altro è vissuto come serie dei mondi possibili,
monologanti e relativi, in una frantumazione pirandelliana del dire e del fare. La serie può
inoltre interrompersi in qualunque momento, ancor prima che sia esaurita, ed a nostra
insaputa: la ripetizione è di per sé esaustiva. La concordanza con la riflessione coreografica
contemporanea è profonda : abbandono della predominanza della stazione eretta,
introduzione del concetto di sforzo, sostituzione di uno spazio qualificato con uno spazio
indeterminato, sostituzione della storia con una logica derivata dal movimento e dalle
posizioni, ricerca del minimalismo, conquista delle dissonanze del gesto e delle camminate
danzate. Knowlson ricorda a proposito di “Quad”: "Quest'opera non verbale per quattro
35
ballerini era il naturale sviluppo dell'interesse di Beckett per la coreografia e della sua
radicale diffidenza verso il linguaggio. All'operatore della SDR Jim Lewis parlava infatti della
sua difficoltà a scrivere oramai una qualunque parola senza avere la profonda impressione
che si trattasse di una menzogna". La drammaturgia di Beckett ci appare dunque come una
sovrapposizione di tessuti diversi
e consunti, una struttura “aperta”, come una tela di
Fontana o Burri, a ciò che la sorpassa. A suo dire “ Dato che non possiamo eliminare il
linguaggio in una sola volta, dobbiamo quantomeno non negligere nulla di ciò che può
contribuire a screditarlo; forarlo con dei buchi, l’uno dopo l’altro, fino a quando ciò che è
nascosto dietro cominci a sgocciolare attraverso “.
36
Le povere cose.
“Rapporto: teatro-dramma
La mia realizzazione di un teatro autonomo
non è né l’esplicazione
di un testo drammatico
né la sua traduzione
In linguaggio teatrale,
ma molto più di un’interpretazione
o un’attualizzazione.
(…)Ciò che io creo
è una realtà,
un concorso di circostanze
che non hanno con il dramma
dei rapporti
né logici
né analogici
né paralleli
o inversi.
Creo un campo di tensioni
capaci
di spezzare
la superficie aneddotica
del dramma.”
Cosi scriveva nel 1963 sul suo teatro Tadeusz Kantor (1915-1990), artista polacco nato a
Wielopole da madre cattolica e padre ebreo, ricordato come uno dei più grandi drammaturghi
del ‘900. Kantor fu drammaturgo in quanto autore di una scrittura totale coniugante nel teatro
il suo mestiere di pittore, scenografo, regista e creatore di happening. Nonostante la
molteplicità delle sue definizioni e dei suoi manifesti poetici, rimase sempre centrale in lui la
rivendicazione dell’autonomia assoluta del teatro e della sua dimensione reale, esposta alla
casualità della vita. Egli svolse la sua formazione all’Accademia di Belle Arti di Cracovia dove,
attraverso gli studi di pittura e scenografia, venne notevolmente influenzato dalle
avanguardie degli anni ‘20. L’ammirazione per Tairov, Mejercol’d, Piscator e il Bauhaus lo
resero partigiano del radicalismo in arte, come indice di un sincero non compromesso. Sulla
scia di una fascinazione per il lavoro di Schlemmer, creò un teatro di marionette all’interno
dell’Accademia. Parallelamente alle arti figurative, Kantor
coltivò le letture di Kafka e
Maeterlink e dei polacchi Witkiewicz, Gombrowicz e Schulz. L’idea della necessità di uno
sviluppo continuo, di una rivoluzione artistica permanente che garantisse un progresso ed il
bisogno di autenticità rivendicati da Kantor fin dai primi anni della sua attività lo portarono
37
ben presto ad un isolamento dal teatro istituzionale. Nel ’42, nella Polonia occupata dai
nazisti, fonda con grande coraggio, nelle catacombe di Cracovia, il Teatro Clandestino. Ma è
nel ’55 che con la fondazione del Teatro Cricot 2, locuzione che in polacco suona come
“arriva il circo”, egli sottolinea la sua avversione per il mondo della cultura ufficiale. Il Cricot 2
è un gruppo di artisti che rifiutano di far parte di un meccanismo burocratico e lavorano
esclusivamente in vista del concetto di creazione. La creazione artistica è per Kantor
antitetica al concetto di produzione, la quale sottomette gli artisti alle leggi di mercato
attraverso
la separazione delle prove e degli spettacoli in serie, le stagioni teatrali, il
perseguimento di uno stile. Kantor si propone attraverso il Cricot 2 di sopprimere tutte le
linee di demarcazione fra le arti, riunendo attori professionisti, non professionisti ed artisti
provenienti da campi extrateatrali. Il superamento del limite e della gerarchia imposta da un
fare obsoleto, che aveva “dimenticato” la lezione delle Avanguardie storiche, diventa il
marchio della vera creazione teatrale che nella sua autonomia e trasformazione continua
esige dall’artista la fuoriuscita dai propri automatismi. “L’avanguardia in teatro è possibile e
ci sarà sempre”: con questa convinzione egli vuole mutare la condizione e la funzione
dell’attore, che vincitore e vittima al contempo deve abbracciare la realtà. Il tradimento delle
convenzioni è necessario per l’autonomia dell’espressione teatrale, la quale può essere
raggiunta solo allacciando stretti legami con la totalità del reale. Per Kantor solo la rinuncia a
ciò che è acquisito, artisticamente e socialmente, la ricerca continua, il disprezzo dello “stile”
sono le prerogative dell’avanguardia, intesa come perseguimento di un’utopia. In questo
senso, l’autonomia perseguita da Kantor e l’idea di teatro totale sono prossime. Tuttavia la
soppressione delle gerarchie di Appia e Craig rispetto ai vari elementi drammatici
costituiscono un approccio del tutto nuovo dell’architettura compositiva dell’opera teatrale.
Kantor riconosce, come i suoi predecessori, la necessaria unità e complessità dell’opera
d’arte ma non la sua omogeneità. Egli sottolinea infatti che l’eterogeneità degli elementi
consente a quest’ultimi di non essere limitati in alcun modo, di non essere ridotti ad illustrarsi
a vicenda. Il principio drammaturgico del collage, dell’accostamento destabilizzante fra le
superfici d’espressione di diversa natura diviene dunque la linea guida della regia di Kantor.
Una serie di tensioni regolano le relazioni fra i vari linguaggi, che si articolano attraverso la
sorpresa e lo choc, per innescare un processo che fa della realtà scenica un qualcosa di
indipendente. Il rapporto tra teatro e dramma, illustrato in apertura, si chiarifica nella netta
distinzione operata tra azione drammatica, espressa nel testo, e azione scenica. Il reale
concorso di circostanze creato dal regista, ovvero l’azione scenica, va a dialogare con la
realtà preesistente del testo come con una realtà inventata, che s’allontana e avvicina
liberamente. Già Witkiewicz, che collaborò come drammaturgo con Kantor, amava la parola
tensione riguardo al testo. Kantor va ancora più lontano introducendo il concetto di oggetto
ready-made, ovvero di realtà già pronta, estranea, proveniente dall’esterno. Il testo, al pari
degli oggetti di scena, è un ready-made da utilizzare come compagno di gioco, in virtù di
un’azione
scenica
altra da quella drammatica. Nel concetto di azione scenica,
ossessivamente ribadito da Kantor come categoria creatrice primaria, il problema della
38
tecnica dell’attore viene dissolto, poiché si assiste alla definitiva dissoluzione dell’idea
classica di “ruolo”. L’attore è interamente in una pratica, rispetto a delle situazioni imposte
dal regista. In questa pratica consiste la libertà individuale dell’attore, che, non essendo in
una situazione inferiore di imitazione, si pone naturalmente in stato di esecuzione reale
dell’azione. Tale stato è definito da Kantor come lo stato elementare delle predisposizioni
dell’attore, una condizione “profondamente umana” che lo vede come ”ritratto a nudo
dell’uomo”. La coesione del gruppo, in una sorta di rete telepatica, interviene in modo
importante nell’atto creativo, ma Kantor è lungi dal dare credibilità alla creazione collettiva,
essendo questa vera solamente se elaborata e stratificata nei secoli, come quella delle
cerimonie e dei riti. Kantor presta fede in questo senso, come i dadaisti, solo alla decisione
ed al caso: l’improvvisazione può avere luogo solamente come in un gruppo jazz. Tutta
l’opera di Kantor si impernea su un dialogo con la realtà: la manipolazione e l’utilizzazione
gratuita del reale sono le vere questioni dell’arte, che tenta letteralmente di smascherare il
linguaggio. In questa chiave vanno visti i continui spostamenti del senso operati da Kantor,
soprattutto attraverso il cambio “imprevisto” della funzione degli oggetti. Da qui deriva il suo
maniacale interesse per il grado più basso della realtà: oggetti usati, rifiuti, oggetti quotidiani
semplici e comuni. Su oggetti di questo tipo si può concentrare con particolare veemenza un
sovvertimento linguistico ed una rinnovata relazione fra arte e vita. Tutto il problema dell’arte
è un problema dell’oggetto: Kantor compie un’annessione della realtà attraverso l’idea di
ready-made e di “decontestualizzazione” alla Duchamp. In questa ottica di lettura va vista
l’operazione dell’emballage coniata da Kantor. La prima esperienza pratica di imballaggio,
nel 1956, vede la scena coperta con un sacco nero bucato da cui comparivano le teste e le
mani degli attori: Kantor vi vede la forza suggestiva delle onde dinamiche dell’imballaggio
“cancellare” una parte dell’oggetto (gli attori) per lasciare uno spazio di libera intuizione a chi
guarda. Attraverso l’imballaggio egli si concentra sulla possibilità di elevare l’oggetto più
umile al di sopra del ridicolo e del disprezzo: l’oggetto cosi protetto resta inconoscibile e
inaccessibile, come lontano ed estraneo. Di rimando l’oggetto è autonomo ed al contempo
legato al viaggio, quel viaggio senza fine che è l’arte. Per Kantor l’esplorazione del problema
“poetico” dell’ emballage consentiva d’andare oltre la pittura e le sue seduzioni pericolose e
rassicuranti. Oltre che da una poetica dell’oggetto, l’innovazione kantoriana parte da una
rifondazione dell’idea stessa di rappresentazione e di spazio scenico: molto prima di
Grotowsky e Ronconi, egli abbandona volontariamente i luoghi istituzionali . Intendendo lo
spazio come organismo unico, in cui "sia attori che spettatori si trovano nello stesso sacco",
Kantor concepisce l’idea di uno spazio performativo, di un teatro informale dove artisti e
pubblico condividono una responsabilità ed un impegno reciproco. Nel rifiuto del consumo
mercantile del teatro Kantor investe con le sue scenografie numerosi luoghi extrateatrali,
mettendo in una sorta di instabilità, mentale più che fisica, lo spettatore e rivalutando
l’importanza del rischio. Lo spazio diviene dunque anch’esso portatore d’un principio
d’autonomia, un ricettacolo di forme che devono essere contemporaneamente astratte e
concrete. Il naturalismo artificiale è per Kantor ridicolo, solo le forme puramente astratte
39
hanno un’esistenza concreta perché capaci di agire sul subconscio. In questo spazio
l’oggetto e l’uomo attirano tutta l’attenzione, ma la
scenografia, lungi dall’essere un
elemento didascalico o servile, partecipa all’azione ed agli sviluppi attraverso il “trattamento
acuto della superficie dei fenomeni”. Kantor parla a questo proposito di concretismo e di
realismo esteriore, rimandandoci a quel principio dinamico del contrasto fra l’uomo e la
forma astratta promulgato da Appia. Vi è in questa visione “esterna” qualcosa di lucidamente
cinico , un non volersi attardare su ulteriori commenti o esemplificazioni. Il dramma è realtà e
Kantor afferma che non si contempla come un quadro una pièce di teatro. Il dramma è anche
un divenire. La deformazione plastica è definita come “ipertrofia di certe parti della forma che
acquista cosi dinamica e movimento”: l’equivalente in teatro è l’ipertrofia dell’azione, intesa
in modo globalizzante. L’azione è infatti anche la semplice importanza “inusuale” data a certe
cose, l’applicazione di una logica diversa dalla realtà. La didascalia, il pathos sono visti come
un manierismo insopportabile. Per questo Kantor opera slittamenti semantici continui e
sottolinea l’importanza dello humour. Nel 1961 egli si volge alla definizione di Teatro
Informale. Un teatro che, sull’eredità dadaista, proclama la potenza del caso e una nuova
dimensione del gesto e della decisione. Kantor introduce qui il concetto di “temperatura
insolita” per cui le condizioni “biologiche” perdono qualunque legame con la vita pratica. Il
teatro informale rivendica un legame con la materia bruta, prima e primaria facendosi beffa
delle convenzioni. L’articolazione del linguaggio umano si mischia a forme sonore più remote
e selvagge, come nel circo il teatro si confronta ad una essenziale forza vitale:
“Nel circo il teatro troverà
la sua forza vitale, il suo principio
e la sua purificazione.
Il circo agisce in una maniera disinteressata
Senza compromessi,
smaschera,
sradica tutti i camuffamenti,
le dignità e i prestigi.”
“Lungo questa strada
Senza compromessi
L’attore deve offrire
Il suo ridicolo,
la sua miseria,
la sua stessa dignità,
apparire
disarmato,
senza la protezione
di maschere
fallaci.
40
La realizzazione dell’impossibile
È il fascino supremo dell’arte
E il suo segreto più profondo.”
In una guerra continua contro l’illusione, Kantor accavalla le definizioni. All’insolita
temperatura emozionale del circo egli contrappone la temperatura “fredda” del Teatro Zero:
occorre poter manipolare la noia, rappresentare in un certo senso il vuoto e l’indegnità
dell’attore di essere rappresentato. Le “zone zero” dell’esistenza vengono date in scena con
una interpretazione “in sordina”: gli attori vivono in un’economia dei gesti e dell’emozione, in
uno stato vegetativo, come avviliti. Gli stati psicologici sono gratuiti, come vuole la noninterpretazione. Accanto allo choc ed alle tensioni dinamiche create dal collage Kantor
lavora alla scoperta di una zona d’ombra, non rappresentabile, che è una situazione
angosciosa. Avviene cosi un rilassamento dei legami semantici che è riduzione a zero dei
valori di significato e contenuto, attraverso la ripetizione ed restringimento dello spazio per la
vita dell’attore. La macchina e l’oggetto operano in questa fase una espulsione dell’uomo ai
margini del reale, rinforzando il senso di precarietà della condizione umana. In quest’ottica di
rifiuto dell’illusione potremmo altresì collocare la presenza costante di Kantor sulla scena dei
suoi spettacoli: nel “ruolo” di Kantor, che gli è valso molteplici accuse di egocentrismo, egli
partecipava all’abolizione della rappresentazione convenzionale. Parallelamente all’arte
informale, che vede una crisi della forma intesa come unico criterio dell’individualità e
dell’evoluzione intesa come perfezionamento formale, Kantor comincia a sviluppare in questi
anni l’idea di immagine come traccia dell’azione e di happening come azione nella realtà.
Come pittore ed uomo di teatro, egli coglie l’importanza del cambiamento del senso
dell’esposizione, del ruolo dello spettatore e dell’ environnement inteso come contesto attivo.
Nel 1967 egli definisce l’happening come dominazione dell’oggetto, come “tentativo di
coglierlo in flagrante”. Al teatro è possibile dunque pervenire da altri luoghi e per Kantor il
luogo del teatro è correlato all’idea stessa di confine: l’immaginazione nasce dalla collisione
tra realtà materiale e sfera psichica. L’ambiguità delle frontiere semantiche esige che lo
spazio scenico divenga un luogo di transito, una zona sospesa tra la vita e la morte. Il teatro,
antropologicamente, può infatti essere inteso come "un prolungamento della vita reale, come
un luogo d’incontro con la morte. Il cambiamento della stessa scansione temporale – fra
tempo reale e tempo scenico – indica come il teatro possa ‘doppiare la vita’ (e non imitarla e
intepretarla), accompagnando metaforicamente la comunità sociale, o meglio il proprio
pubblico verso la morte" 10 . L’individuo nella sua dimensione più intima e scabrosa è al centro
dell’ultima definizione kantoriana di "Teatro della morte". La memoria, "povera stanza
dell’immaginazione" è confrontata alla nozione di riflesso e di specchio della poesia, in modo
10
G. Pedullà, Alla frontiera della vita: il teatro della morte di Tedeusz Kantor, in "La scena lo schermo", rassegna di
studi sullo spettacolo, n. 1/1992.
41
speculare al rapporto realtà-finzione. Per Kantor la perdita dell’infanzia consiste in un lento
ed inesorabile scivolamento verso il pragmatismo. In questo procedere l’immaginazione del
passato viene annientata, cosicché fatti, oggetti e volti cari vengono accantonati. Nella
“Classe morta” (1975), influenzata dal racconto “Il pensionato” di Bruno Schulz, Kantor
risveglia gli oggetti della memoria per abbracciare idealmente passato presente e futuro.
Kantor da alla sua più celebre pièce il sottotitolo di seduta drammaturgica: sulla scia delle
esperienze del teatro zero la drammaturgia si sforza di cogliere l’invisibile, in una tendenza
“verso il basso” che tenta di avvicinarci alla realtà. Questo microscopio attinge dalla realtà
degradata la nozione di morte. La “classe morta” traduce in immagini questa realtà: un
gruppo di scolari ormai vecchi siedono immobili nei loro banchi di infanzia. Una selva di mani
comincia lentamente ad apparire come se tutti volessero “ancora” dire la lezione. Il ritmo
diventa sempre più affannoso e sfocia in una serie di scherzi crudeli ed azioni inconsce o
brutali che “in vita” la classe morta aveva sognato di compiere. L’agghiacciante sogno degli
scolari defunti si conclude con il racconto frammentario delle proprie vite, ciascuno recando
sulle spalle il proprio doppio reso oggetto nella forma di un manichino, il cui viso ricorda
quello del portatore. Kantor dirige, in sordina, la sua orchestra di spettri con assoluta
imperturbabilità. La “Classe morta” racchiude una visione apocalittica di un mondo giunto
alla fine dei suoi giorni, lo stesso mondo che, terminata la seconda guerra mondiale, offriva
alla vista l’impietoso spettacolo dei campi di sterminio nazisti (in cui morì anche il padre di
Kantor). Ma oltre che aprire questa voragine storica, Kantor opera attraverso la sua seduta
drammaturgica uno sfondamento dei codici della rappresentazione che vede ogni narrazione
frantumarsi e liberarsi contemporaneamente: come se una libertà vietata ai vivi scaturisse
proprio dall’esser ritornato oggetto, ovvero cadavere-scarto. Da una poetica profondamente
oscura affiora, nell’asse oggetto-memoria, una verità commovente, violenta e viva. Nel teatro
della morte di Kantor risorge, libera e tragica, l’immagine dell’uomo. Tale immagine
dell’uomo si confonde con l’apparizione “eretica” dell’attore, definito già come “ritratto a
nudo dell’uomo”. Paradossalmente l’uomo è rivelato dalla presenza, in negativo, del suo
doppio: la marionetta. Lo scrittore Bruno Schulz, autore del “Trattato dei manichini “,
considerava questi ultimi dei veri concorrenti degli attori sulla scena, da cui il confronto
spontaneo con la teoria della Supermarionetta di Gordon Craig. Craig, influenzato da una
chiara matrice simbolista, vedeva nel panico emozionalismo dell’attore la misura della sua
piccolezza e del suo egocentrismo. L’attore nasceva per lui fondamentalmente grazie ad un
peccato d’orgoglio, ad un atto sconsiderato di protagonismo. Per l’autore polacco, al
contrario, il primo attore non nasceva da un atto di hybris bensì dalla temeraria decisione di
staccarsi, solo, dalla comunità culturale: questo atto rivoluzionario è diventato il campo
dell’arte. Da qui, per accostamento, il manichino che incarna il senso profondo della morte e
della condizione dei morti diventa un elemento che rivela, senza sostituirlo, l’attore vivo. Di
qui anche la differenza col “Teatro delle Marionette” di Heinrich von Kleist, che sognava di
eliminare definitivamente dalle marionette anche l’intervento del burattinaio. Le “povere
cose” di Kantor sono in questo senso potenti rivelatori semiologici e delicate tracce personali
42
ed autobiografiche. Dalla “Classe morte” a “Wielopole Wielopole” (1980) possono essere
considerate parte di "una confessione personale": le camicie, borse, ombrelli e valigie dei
suoi emballage ci appaiono intimamente legati al suo mondo più intimo. Nell’isolamento dei
singoli oggetti appare un atteggiamento religioso, quasi liturgico: un umile oggetto viene
sottratto alla categoria dei rifiuti e “spostato” in una diversa categoria, dove perde la sua
caratteristica essenziale, ossia la sua inutilità. Isolamento e spostamento in un contesto di
inviolabilità sono fasi tipiche della creazione dello spazio sacro, secondo la fenomenologia
delle religioni. Nel “Manifesto sull’Imballaggio” (1963) Kantor definisce l’opera d’arte come
qualcosa che, persa la sua utilità sociale, sta tra la pattumiera e l’eternità. La povertà è il
segno unificante del suo teatro. Kantor, pur nella durezza della sua opera, ritorna sempre
come un mercante della memoria, un umile trovatore di storie e d’oggetti che “salva” il
sentimento del tempo e del dolore.
43
Lo sguardo di Narciso.
Carmelo Bene appartiene a quel contesto del teatro italiano di ricerca che ha rifiutato di
mettere in scena il testo come esecuzione diretta della convenzione teatrale, promuovendo
la soggettività dell’attore interprete ed in particolare di attori – autori ed interpreti demiurghi.
Egli rappresenta un’eccezione difficilmente classificabile poiché, pur partendo dalla
soggettività dell’attore, compie un’indagine critica che scavalca la singola rappresentazione
e diventa “autocritica” dello status del teatro, giungendo paradossalmente all’ esaltazione del
non-attore. In questo senso il lavoro di Carmelo Bene illustra una fuoriuscita “metateatrale”
della ricerca drammaturgica del ‘900 che si risolve con la
dissoluzione dell’azione
drammatica in quanto atto del personaggio. L’ attore assurge con Carmelo Bene alla duplice
funzione di artefice e vittima dello spettacolo. In questa sede, una chiave di analisi
strumentale di questo nuovo senso drammaturgico ci è offerta dalla definizione di phonè
dell’attore da parte di Maurizio Grande. La phonè di Carmelo Bene è intesa non come protesi
vocale del personaggio ma come esaltazione dell’interprete: la parola esiste come corpo
sensibile e materiale ed è al contempo presenza originaria, corpo dell’essere. Bene liquida
ogni realismo ed ogni attendibilità del quotidiano (e della rappresentazione) attraverso la
parola spettacolata: il soggetto si consuma nello stare in scena, il personaggio è inattendibile
poiché tragicamente parodiato attraverso l’esaltazione stessa della “menzogna” teatrale.
Attraverso la verità scandalosa del soggetto-attore che si offre alla rappresentazione nel
teatro si dissolve la sua stessa possibilità di esistenza ed una qualunque forma di credibilità.
La ricerca teatrale di Carmelo Bene ci riconduce, ancor prima che ad una impossibilità del
teatro, ad una condizione di infanzia perenne del soggetto: la sincerità di chi non si è
compromesso con una qualunque forma di identificazione ci rinvia ad una solitudine
imbarazzante e vergognosa. La phonè utilizzata ci illustra pienamente quest’inadempienza
infantile del binomio attore-personaggio: essa non è parola piena ma farfugliamento, pura
tonalità degli andirivieni della coscienza, strumento che con la musica e l’amplificazione
“orchestra” la dissoluzione del personaggio e dell’io. La scena di Bene è un luogo di perdita,
un circo in cui il soggetto nudo compie una pletora d’atti che sono un’assenza del linguaggio.
L’opera teatrale di Bene scuote in definitiva la dissociazione tra essere e rappresentare che
postula la convenzione teatrale e più generalmente quella del linguaggio. La soggettività
dell’esistenza, a più riprese illustrata dal teatro del XX secolo, viene data come
irrappresentabile. Nella rinuncia all’io ed al mondo, il soggetto diviene al contempo eroico e
comico, il teatro si fa parodia di una onnipotenza illusoria di Narciso, che dice la sua
soggettività pur senza rappresentare. È questa una concezione-limite del teatro,
un’affermazione dell’arte come liminalità dell’esperienza che pone non pochi problemi di
collocazione del lavoro di Carmelo Bene. Il tema cardine della sua produzione artistica è lo
statuto del soggetto e si inscrive certamente nella moderna questione del soggetto; tuttavia,
egli afferma il declino dell’io senza nessuna compensazione simbolica: viene così meno il
principio di rappresentazione su cui si fonda il linguaggio stesso, quale fondamento che
44
mantiene la proiezione dell’io nel reale. L’incrinazione statutaria del linguaggio, altrettanto
forte ad esempio in Beckett, non è data per sottrazione né per significanti metafisici bensì
attraverso una terza dimensione concreta che vorrebbe far coincidere soggetto-attore e
rappresentazione-vita. L’icona bidimensionale del teatro, che comunica attraverso una
“suggerimento” della realtà si arricchisce con Bene della dimensione umana, interna al
teatro, dell’attore, sfigurando il teatro stesso e facendogli il torto di rendere la mimesi
impossibile. Quest’eccesso di zelo, attraverso cui Bene attinge alla consistenza dell’essere
nella rappresentazione, è la phonè: essa è presenza del soggetto a sé stesso, è voce
costituita in una singolarità narcisistica di un essere che non accetta nulla al di fuori di sé.
Bene dissocia radicalmente voce del quotidiano e voce fittizia. La voce del quotidiano è infatti
riconoscibile, fa parte degli enti psicologici, poiché è una protesi dell’io. La phonè dell’attore
è voce soggettiva, strumento del fittizio della scena, è presenza a sé del soggetto che non
riconosce il principio di realtà. Per questo il soggetto disunito dal mondo è irrappresentabile,
è il riflesso impossibile di Narciso che corre parallelamente verso sé stesso ed il proprio
annullamento. Tale narcisismo, come accennato, non è patologico ma sano: il soggetto, in
una infanzia non risolta dalla compromissione con il mondo, vuole esistere di per sé e non
riconosce nulla al di fuori. L’attore-infante è onnipotenza sconfitta: non è un’unità limitata ma
pura immaginazione, è un soggetto non – io. Bene incarna nei suoi spettacoli la vita di un
soggetto amplificato, mettendo in scena un ingrandimento patetico della sua singolarità. In
una prima fase di ricerca rispetto alla phonè, quando non usava la strumentazione
elettronica, egli cercava di contraddire tutto ciò che ci si può attendere da una voce:
rifiutando di prestare la sua voce al personaggio si rifiutava di legalizzare il personaggio. La
tecnica fonica consisteva in un dire tolto, in un’operazione che alternava battere e levare
allontanandosi tanto dalla chiarezza della recitazione classica che dalla naturalezza del dire
quotidiano. Accadeva tuttavia che la presenza dell’attore era raddoppiata, divenendo
insormontabile. L’uso dell’amplificazione e della strumentazione elettronica gli consentì
dunque di accrescere, fino al parossismo, questa presenza fino all’annullamento dell’oggetto
ingrandito. L’amplificazione evoca infatti il suono metafisico attraverso cui si ascolta l’essere
di un soggetto inafferrabile. Ciò che era amplificato era inoltre “estraneo” alla logica
dell’azione e non pertinente al personaggio: per eccesso la drammaturgia di Bene si
costituisce come struttura che forza il limite rappresentativo, il condivisibile. L’attore
Carmelo Bene coincide con il suo dirsi, è tautofonico; nella sua poetica assistiamo, come nel
mito, alla coincidenza tra nome e cosa: dire è essere, essere è essere Narciso. Egli stesso è
un desiderio all’eccesso, come chi pratica l’arte facendo di sé stesso arte: egli eccede il
tragico, giunge alla parodia attraverso la cui amplificazione gli spettatori possono annientarsi
esteticamente. Ritroviamo in quest’atteggiamento una posizione analoga ai filosofi medievali
che trovavano che l’essere avveniva nel linguaggio, che nel flatus vocis vi era evento di
significazione: “ La phonè è la sostanza significante che si dà alla coscienza come
intimamente unita al pensiero del concetto significato. Da questo punto di vista, la voce è la
coscienza stessa. Quando parlo non solo ho coscienza di essere presente a ciò che penso,
45
ma anche di mantenere il più aderente possibile al mio pensiero o al concetto un significante
che non cade nel mondo, che io intendo nel momento medesimo in cui lo emetto, e che
sembra dipendere dalla mia pura e libera spontaneità (…).” 11 . Lo sguardo di Narciso è tragico
ed eroico, patetico e distruttivo. L’opera di Carmelo Bene mette in questione la legalità della
pratica estetica teatrale, la sua tradizione e le sue convenzioni espressive, in una forma assai
diversa rispetto alle avanguardie occidentali. Non c’è posto né per il realismo, né per il
naturalismo, né per il teatro puramente sintattico: Bene non si iscrive nello sperimentalismo,
poiché integra e supera queste operazioni per arrivare ad un teatro dalla platea vuota, che
esaurisce l’attualità del teatro e la sua replicabilità in una critica radicale. Il paradosso
teatrale di Bene può essere illustrato nel processo di rilettura e riscrittura dell’Amleto che
egli ha compiuto per quindici anni; Amleto è il primo personaggio drammatico moderno : ha
l’angoscia del sentire moderno, l’incertezza degli orientamenti morali, etici e politici. La
paralisi dell’azione drammaturgica di Amleto è alla radice di un teatro avvertito come luogo
della distruzione organizzata e consapevole della rappresentazione, come distruzione della
logica del simulacro. Il teatro di Bene si fa negandosi: Amleto ha la lucida consapevolezza
dell’illusione, è un personaggio agito, che è giocatore e giocato. La rinuncia di Amleto ad
essere eroe lo pone fra attore e spettatore, lo rende manipolatore e manipolato, come
risposta ad un teatro impossibile. La recitazione di Bene corrode le varie identità dei
personaggi ed ingloba tutti i vari punti di vista attraverso la molteplicità reale e virtuale dei
suoi registri. Il lavoro dell’attore non riproduce semplicemente un referente, come un
modellino artificiale della realtà: è il luogo dell’alternativa al teatro, di quel teatro stabile che
equivale alla normalizzazione dell’immaginario, al dominio mortuario delle convenzioni. Vi è
in Carmelo Bene un’idea di teatro legata indissolubilmente all’esistenza teatrale, un
continuum della coscienza che ingloba tutte le fasi ed i significanti del fare teatro, di un io che
si autocancella nel teatro e per il teatro, ben aldilà dell’evento dello spettacolo. Questo
teatro, come spazio dell’idealismo assoluto della negazione, ripropone sinceramente una
confusione originaria tra reale ed immaginario, come nel sogno: la tensione verso l’assoluto
teatrale, il balletto metafisico della costrizione in un ruolo evoca per altre vie la stessa
tensione della ricerca di Schlemmer. Nel camuffamento e nell’ oppressione, nell’opposizione
tra brevità della vita e grandezza dell’arte, lo spettatore diviene co-autore dell’ illusione
messa in scena assieme agli attori. Il distanziamento nei confronti del testo scritto, il lavoro
su luci e costumi, la relazione tra corpo e voce divengono registri negativi rispetto alla vita
del personaggio, lasciano il teatro esangue nella pletora del suo artificio: Bene si spinge ai
limiti di un teatro puro che non rappresenta altro che la messa in scena problematica di sé
stesso, nella solitudine che coglie Narciso poco prima del suo annullamento.
11
J.Derrida, Posizioni, a cura di G.Sertoli, Bertani, Verona 1975
46
Teatro iconoclasta.
Da più di vent’anni la Societas Raffaello Sanzio lavora al problema della rappresentazione
teatrale facendo passare la parola teatro attraverso il retaggio bizantino della parola
iconoclastia. La questione platonica dell’orrore dell’arte è all’origine di un’elaborazione
teorica che si sforza di uscire dall’impasse nella quale il teatro, arte mimetica per eccellenza,
si trova nel suo essere il doppio di una realtà ottica di per sé ingannevole. Il “ritorno della
figura”, come iconoclastia della scena, è la base poetica su cui Romeo Castellucci opera una
rigenerazione del teatro. Cancellare l’icona, come atto genitale e negativo al contempo, è una
dichiarazione di guerra alla tradizione ma più sostanzialmente contro la pretesa
inconcepibile di rappresentare una cosa. Come sottolinea Claudia Castellucci, la parola
iconoclastia contiene una forza positiva, non è un “senza icona” ma un rompo l’icona, dunque
malgrado l’atto di rottura, l’iconoclastia è sempre figurativa. Tale rottura è la rottura con la
rappresentazione del mondo. L’ artista agisce dunque a due mani, una iconografica e l’altra
iconoclasta: è la mano di Caino che agisce per ultima, rovinando l’archetipo di Abele che vive
in essa. In questo senso, filologicamente, l’arte è legata alla colpa e precisamente alla
duplice colpa di esserci e di esserci come rovina dell’esistente. Una delle epoche più
iconoclaste fu il Barocco: l’ espansione tumorale delle figure, la pletora di forme vegetali
strozzavano e sconvolgevano qualunque equilibrio iconografico. L’opera di Raffaello Sanzio
è, per la Societas,
l’esempio di un’immagine perfetta all’esterno ma che è già minata
all’interno dalla metastasi barocca, di una tensione estetica che reca in sé il segno della
fragilità e della decomposizione. In questo senso l’opera di Romeo Castellucci subisce il
fascino della continua contaminazione, attraverso l’accostamento di elementi che per
partenogenesi o reazione chimica, ricompongono una sorta di pienezza vitale originaria,
riassorbendo in un’unità materiale ed estetica l’uomo, l’animale, il pupazzo e la macchina. Nei
primi spettacoli, fino alla metà degli anni Ottanta, la contaminazione dei linguaggi tendeva
all’abolizione di categorie culturali superate, formulando grammatiche ed universi sintattici
nuovi a partire dal principio del bricolage, già teorizzato da Claude Lévi-Strauss. L’innesto di
nuova linfa significante è portatrice di nuove possibilità di significato, per semplice
accostamento e reazione organica, senza rapporti dialettici o di subordinazione ma piuttosto,
come già aveva intuito Kantor, attraverso un principio casuale, sorprendente e di choc. In
“Kaputt Nekropolis” (1984), “Santa Sofia” (1985) e “Teatro Khmer” (1986) vengono
rispettivamente inventate tre situazioni “programmatiche” che guideranno gli sviluppi dei
lavori successivi: l’invenzione della Generalissima, una lingua perfetta e di solo quattro
parole, il rifiuto della rappresentazione e la scelta dell’iconoclastia, la nascita della nuova
Religione Columna (che vede in scena il dittatore comunista Pol Pot assieme a Leone III
Isaurico, l’imperatore iconoclasta di Bisanzio). Iconoclastia, nuova lingua e nuova religione,
se in apparenza antitetiche rispetto alla possibilità del fare teatro, vengono portate sulla
scena come istanza fondamentale della sola realtà:” l’Irreale anti-cosmico, tutto l’insieme
delle cose non pensate”. Una forma di “superrealtà” è dunque la risultante di questo
47
processo di trasformazione continua che è l’arte, di uno spostamento che consente alla
superficie ottica dei corpi e delle cose di tornare, come figure rigenerate, nel tempo del
teatro. Una riflessione sul tempo magico e rituale e sui simboli costitutivi dell’immaginario
occidentale caratterizza una seconda fase del lavoro dei Raffaello Sanzio. Con “La discesa di
Inanna” (1989), “Gilgamesh” (1990) e “Iside e Osiride” (1990) la Societas affronta le grandi
narrazioni dell’antico oriente mesopotamico, recuperando forme estetiche che si avvicinano
più alla dimensione sciamanica che a quella teatrale. Questa fase si dimostra come un’
impasse poetica ed altresì segna un momento di crisi rispetto alle istituzioni, portando
l’ingiusta esclusione della compagnia da alcuni circuiti teatrali e dalle sovvenzioni ministeriali
italiane. Negli anni compresi tra il 1990 ed il 1999, la Societas si confronta con cinque testi
della tradizione occidentale attraverso cui il lavoro di scrittura della compagnia si struttura in
una nuova coerenza. “Amleto”, “Masoch”, “Orestea”, “Giulio Cesare” e “Genesi” vengono
riscritti a partire da una nuova ricerca sulla presenza dell’attore sulla scena. Da questo
momento vengono scritturati degli attori esterni al nucleo dei soci fondatori e viene esclusa
dal lavoro qualunque prospettiva psicologica, autobiografica o lirica ( uno spazio di questo
tipo viene affidato alle numerose pubblicazioni della Societas), partendo dalla considerazione
che il nucleo della tragedia è fondamentalmente estetico e, etimologicamente, fuori
dall’etica. Romeo Castellucci, in veste di regista ed autore, approda, nonostante la guerra
dichiarata alla rappresentazione, alla sopravvivenza della figura alla furia iconoclasta.
“L’iconoclastia viene, in definitiva, per togliersi” poiché la figura dell’attore, dandosi alle
fiamme, paradossalmente sopravvive e si rigenera. Per Castellucci la struttura dell’attore
può ritrovarsi nella figura in piedi di Giacometti, un’ immagine ripetuta infinite volte che nella
sua superficie tormentata offre allo sguardo la potenza del neutro: il neutro, come la doppia
negazione nella sintassi latina, come contro la figura nella figura, si mostra incoercibile alla
tradizione. Si tratta, in termini poetici diversi, della stessa questione scabrosa affrontata da
Carmelo Bene: porre lo specchio davanti allo specchio per mettere il teatro nella patetica
condizione di fingersi, fare il verso al teatro in modo “innocente”, per potergli infliggere un
colpo mortale. La salita sul palco non comporta, per Romeo Castellucci, un atteggiamento
positivistico di chi si da all’azione. L’attore non segue in realtà nessun atto, non può ricadere
nella narratività poiché è piuttosto “inchiodato” al palco ed “agito” da esso, sospeso allo
sguardo martellante del pubblico e costretto all’assunzione dell’elemento estraneo del
linguaggio. L’attore, nella visione della Societas, riassume in sé il punto massimo della crisi
del linguaggio, la sua scepsi. Il corpo è inteso come soma, che sta e non dice, che pronuncia
se stesso, come l’animale che, non sapendo di essere perfettibile, si da per quel che è: res
extensa. Siamo, agli antipodi del Cogito assunto da Beckett, ad una risoluzione “linguistica”
attuata in termini biologici, materiali. Da qui il costante riferimento alla dicotomia uomoanimale, l’utilizzo reiterato, vicino al circo, di uno zoo che sottende all’annullamento dell’
arte: “veramente un animale può cancellare l’arte, rendere banale fino alla morte il teatro”.
Come accennato in precedenza, una tale concezione dell’attore deriva direttamente dalla
mano fratricida di Caino, dalla natura peccaminosa dell’arte che Romeo Castellucci risolve
48
nell’anagramma palco-colpa. Lo stare è la colpa. Il palco rovescia l’atto sull’attore, che
diviene un’entità passiva, un luogo negativo ed ospitale insieme. È lo sguardo degli astanti ad
agire, ad essere consustanziale all’attore, la cui verità oggettiva è il corpo e la cui umiltà lo
rende vittorioso. In questo senso Romeo Castellucci non offre appigli al testo, che rimane
così in una “dimensione bassa”. Dal “ritorno” del corpo e dall’epifania della figura promana,
negli spettacoli della Societas, un tempo incantato, un tempo di fiaba. Castellucci considera
la fiaba più forte dell’arte: la favola delle superfici ottiche è la primaria fonte di
comunicazione, la fuga drammaturgica in una “corazza” che esclude il figurativismo e la
narratività. Solamente la fiaba, nella natura misteriosa delle sue figure implose, che
incredibilmente accadono in quel tempo, costituisce un vuoto teleologico che presuppone
fortemente un creatore e acconsente alla “bestemmia” di voler creare dal nulla.
Paradossalmente la fiaba, dal tempo non narrativo e sospeso, introduce alla velocità, vale a
dire arriva immediatamente al puro comunicabile che è il corpo. La figura diviene una soglia
drammaturgica. La ricerca sullo statuto dell’attore presuppone un chiarimento su quello della
tecnica. In effetti, materialmente si sale sul palco con un corpo già perfetto, indicibile,
dunque lo statuto dell’attore si colloca “prima o sopra la tecnica”. Romeo e Claudia
Castellucci denotano che il superamento della tecnica è auspicabile per arrivare ad una
supertecnica vicina al caso e all’invisibilità. È infatti il binomio limite-alienazione a dominare
la tecnica: essa, dicendomi cosa devo fare, nega ciò che io posso fare e fa ciò che io voglio
che essa faccia per me. La tecnica presuppone infatti, attraverso un consenso cosciente, una
“figura di relazione” che è la parete di contenimento dell’attore e al contempo il garante di
quell’alienazione a cui egli si sottomette; essa mette in quella condizione di non opzione che è
vicina a quella dell’esistenza e che colloca l’attore nell’infanzia remota di chi, lasciandosi
fare, conquista una facilità a vivere. Nell’equilibrio perfetto della relazione socratica fra
attore e figura di relazione (regia) avviene un capovolgimento “anarchico” che pone la figura
di relazione in obbedienza a ciò che deve fare, vale a dire far fare all’ attore qualcosa. Si
tratta qui di escludere qualunque enfasi individualista: se l’attore è sicuro, è patetico, è
ignorante dell’aporia originale dell’inadeguatezza alla scena. La paradossale bellezza dell’
alienazione sul palco è liberatoria, si fonda sull’accettazione di una tecnica patita
consapevolmente. Entrando in scena l’attore diventa intangibile, sacro, è pura presenza che
scardina la densità storica del palco, attraverso la sua “fiaba radicale”. Castellucci sottolinea
che l’attore deve possedere un profondo riposo degli intenti, una catatonia che fa di lui il
nucleo della questione, esattamente come Amleto che, per questo motivo, non può essere
ritenuto un personaggio. La potenza passiva dell’attore consiste in questo: egli è a priori il
corpo del teatro, il suo stare, abulico e violento, può ricondurre al tradimento del poeta.
Questa condizione dell’attore trova nelle figure di Amleto e Masoch due esempi impersonati
rispettivamente da Paolo Tonti e Franco Santarelli. Nel primo caso dell’”Amleto” autistico
della Societas, come in diversi spettacoli successivi, la fisicità dell’attore è messa in primo
piano da una serie di manifestazioni corporee e secrezioni, reali o presunte, che vanno dagli
sputi, rutti e peti fino all’emissione di sangue, vomito e sperma. In “Masoch”, la passività
49
dell’attore viene illustrata nel rapporto corpo-macchina. Un’ autentica scena-macchina entra
in una comunione “masochistica” con il corpo dell’attore denudato ed appeso sopra il
palcoscenico, tra pinze e cavi elettrici. Anche la pistola, presente in “Amleto”, “Orestea” e
“Giulio Cesare”, corteggia incessantemente i protagonisti di un mancato suicidio. La
riduzione del corpo ad oggetto si compendia per Romeo Castellucci in questa forma di
“vittimismo autoricercato”, come una condizione “patetica” e di passione oltre la quale non è
possibile il teatro. L’ innocenza della vittima è in questo senso l’ elemento eucaristico
fondamentale tralasciatoci da Artaud: tutte le possibilità di ripensare il mondo, autismo e
masochismo compresi, sono precipitate in un corpo, nella carnalità della vittima. La figura ed
il teatro si salvano nella paradossale visione cristiana del sacrificio. Tale visione comprende
come accennato l’uso, in varie forme, degli animali in scena. In “Amleto” gli attori comprimari
vengono trasformati quasi tutti in animali totemici di pezza, Ofelia è una bambola parlante, la
madre/Gertrude è un canguro. Nell’Orestea compaiono un Coniglio/Corifeo (citazione di Alice
nel paese delle meraviglie di Carroll), “enormi cavalli neri”, “due asini bianchi albini”, “cinque
scimmie macaco” e pure il “cadavere di una capra scuoiata”. All’inizio del Giulio Cesare “un
lungo ariete romano da assalto che (...) ondeggia la grande testa” percuote il sipario come
per sfondarlo per poi, all’inizio del secondo tempo, percuotere il pavimento della scena. In
“Genesi” la presenza animale viene collocata in delle teche di vetro all’interno del laboratorio
di Madame Curie, in una forma imbalsamata che non gli impedisce inquietanti ed affannosi
movimenti. Il principio di trasformazione, tanto caro a Kantor, trova nella ricchezza degli
accostamenti organici della Societas un principio drammaturgico che è in effetti capace di
scavalcare l’esigenza dialettica, collocandosi in una sfera originaria, ed in qualche modo
“pretragica”. Riportare l’animale in scena è, per Romeo Castellucci, tornare ad una
tradizione rimossa dal teatro occidentale che è il teatro pretragico, legato alla materia ed a
una potenza femminile: siamo fuori dalla sfera linguistica, vicino alla dimensione matriarcale
che ci riporta al binomio nascita-sepoltura. Tale teatro è infantile e l’infante non ha,
etimologicamente, l’uso della parola. A partire dall’”Orestea”, la scomparsa del personaggio
normalmente inteso è resa evidente dalla ricerca di attori che recano in se caratteristiche e
segni fisici evidenti: più che interpretare essi incarnano, nella stranezza del corpo che
offrono allo sguardo, le figure che divengono l’ ipostasi del segno. Entriamo a questo punto
nel problema più strettamente linguistico. Con “Giulio Cesare” il teatro si confronta alla sua
parentela più prossima che è la retorica. Vi è in quest’affermazione di Castellucci l’implicita
consapevolezza operare come corruttore del senso. Il gioco serio ed infantile dell’arte
presuppone d’ alzare vertiginosamente il gioco linguistico, fino al caos. Nel “Giulio Cesare”,
spettacolo fondato sulla e contro la retorica, sul cadavere di Cassio (nel secondo tempo
interpretato da una ragazza anoressica) scende il cartello magrittiano: “Ceci n’est pas un
acteur”. Il ricorso a Magritte si spiega con il fatto che questi ha messo definitivamente in crisi
il sistema della rappresentazione imitativa. Nel suo famoso dipinto egli mostra e nega la pipa
contemporaneamente: il realismo, ben eseguito come un compitino, sferra un colpo mortale
al reale. Questa frase, usata come una lapide mortuaria nel “Giulio Cesare”, è infinitamente
50
triste: tutta l’umanità rimane sola con il suo strumentino, la parola. In questo stesso senso
Castellucci considera Duchamp un artista violento: il lavoro dell’ariete sul sipario illustra la
potenza del linguaggio retorico che nomina con nomi nuovi cose vecchie, il linguaggio, tutto il
linguaggio, assurge al ruolo di violenza e rapina. Alla maniera di Artaud, Castellucci
considera allora le parole come le molecole della chimica organica: ciò che conta è il loro
potere combinatorio, la possibilità di ricreare il senso spezzando la linearità logica e
meccanica. La “caduta” della parola, in senso fisico e metaforico, acconsente a deviazioni
immaginative, in un ritmo imprevisto. Come per Carmelo Bene, il disegno fonetico assume qui
una vitale importanza significante. Come per Artaud, il buco ( l’apoteosi retorica del discorso
di Antonio è incarnata da un autentico laringectomizzato) che spezza la parola o le parole fra
di loro è la fonte del respiro. Con “Genesi” la parola del testo pone, in quanto parola di Dio, un
problema teologico: unico a poter sorreggere il peso di questa parola è Lucifero, il primo
“attore” che ha assunto un costume di serpente. Per primo Lucifero sfrutta la
sovrabbondanza del linguaggio, la sua menzogna, dando origine all’arte. Per Castellucci
l’arte diviene necessaria una volta scacciati dal Paradiso, è nel Male che si trova l’aspetto
estremo di libertà che Dio ha concesso a tutti gli esseri. L’arte non è pura ed è, non solo
platonicamente ma anche biblicamente, corrotta. Il problema dell’inizio, per l’artista-creatore
che imita Dio, non è per Romeo Castellucci l’ horror vacui piuttosto il terrore del pieno. Dal
caos iniziale occorre capire cosa scavare, come innescare dei processi che tendono ad
autogenerarsi.
Martellare
il
testo,
ossessivamente,
come
Artaud,
apre
soglie
di
comprensione che altrimenti non si aprono; solo in un secondo momento si va alle radici
filologiche. Da qui nascono i problemi d’ordine tecnico e drammaturgico, i quali conducono al
vortice della materia: la materia è l’ultima realtà, gli elementi sono il puro comunicabile che
la casualità chimica orchestra, riportandoci al problema della bellezza. Nella poetica
iconoclasta dei Raffaello Sanzio c’è un’assoluta consapevolezza della tradizione, il che ci
rimanda di diritto ad assegnargli una regia di dimensione critica. L’intreccio di tradizione e
modernità, il rimando alla storia dell’arte occidentale globalmente intesa, la disincantata
ironia e l’attenzione storica e genealogica del segno vanno a costituire un impianto coerente
ed un sistema. Il linguaggio, inteso come corpo estraneo, è l’oggetto di un’endoscopia come
nel “Giulio Cesare”: andare a vedere l’origine pornografica della parola, simile ad un sesso
femminile, equivale a catturare la bellezza del soffio che si fa menzogna e presenza nella
carne. Questa dimensione scavalca il testo e lo ingloba nella partitura dei segni plurali.
Questa “contro-tradizione”, situata sulla linea di faglia che vorrebbe dividere significante e
significato, si da, secondo la Societas, come il solo sistema complesso di relazioni e
congiunzioni capace di eclissare per un attimo (il tempo del teatro) la realtà. Il segno
iconoclasta pare, attraverso quest’avventura poetica, coincidere con l’ineluttabile marchio
del destino sull’uomo, fin dal principio della sua caduta dal Paradiso terrestre nel linguaggio.
Lo spettacolo teatrale è vissuto dai Raffaello Sanzio come arte della ripresa, in termini
kierkegaardiani. A differenza del ricordo, la ripresa torna indietro andando avanti, ponendoci
nella condizione di operare un’inversione del destino. Il teatro, nonostante l’impossibilità
51
della rappresentazione, riscrive il destino attraverso la ripresa. Esso adempie a quello che
“Forse è il sogno umano più importante; quello assunto fin dal principio, dalle religioni della
terra
e
dal
teatro,
che
nacque
religioso
e
che
morirà
religioso”.
52
Giano bifronte.
Abbiamo già accennato alla Nuova Danza come ad un movimento antiaccademico atto a
sviluppare nuove possibilità di scrittura coreografica. Le tournées coreografiche di Loïe
Fuller, a partire dal 1892, introdussero in America e Europa un rinnovamento estetico
radicale della concezione scenografica, dando rilievo all’illuminotecnica ed ai costumi per
approdare ad una sorta di movimento globale che riempiva lo spazio attraverso lunghissimi
veli e giochi di colore. Il corpo della Fuller si muoveva liberamente in uno spazio “interattivo”
che rispecchiava una creazione interdisciplinare, come quella preconizzata de Appia e Craig.
Su un piano prettamente coreografico, un altro tentativo di rottura venne compiuto negli anni
successivi da Isadora Duncan, danzatrice americana che, rifacendosi all’iconografia classica
greca, si vestì solo di un peplo leggerissimo che velava appena il corpo e acconsentiva alla
libertà di movimenti improvvisati. Le sue danze libere furono interpretazioni emotive di grandi
musicisti, che suscitarono vivo interesse per la loro forza di rottura ma che, limitate da un
approccio dilettantistico e semplicistico, trovano piuttosto la loro importanza storica
nell’influenza che esercitarono su l’impresario Sergej Djaghilev, fondatore dei Balletti Russi.
La compagnia dei Balletti Russi nasce dalla volontà di Djaghilev di esportare in Europa il
tecnicismo dei ballerini di Mosca e San Pietroburgo e di riunire artisti del calibro di Picasso o
Debussy al servizio di nuovi spettacoli coreografici. La compagnia ebbe sede in Francia ma
acquisì una rinomanza internazionale che contribuì alla diffusione di un nuovo gusto per le
coreografie di Fokine, Massine e, più tardi, Balanchine improntate ad una sensibilità
accademica ma “moderna”. Fu tuttavia la collaborazione di Djaghilev con il danzatore Vaslav
Nijinski (1890 – 1950) a segnare una tappa fondamentale nella nascita della danza moderna in
Europa. Con la creazione de “L'Après-midi d'un faune”, su una poesia di Mallarmé e una
musica di Claude Debussy, il 29 maggio 1912 al Théâtre du Châtelet di Parigi Nijinski
scandalizza per l’anticonformismo della coreografia e l’audacia della scena finale,
eccessivamente erotica per l’epoca. Rodin, affascinato dal lavoro plastico del danzatore,
difenderà lo spettacolo senza riserve. Nijinski propone un disegno coreografico totalmente
bidimensionale, come nelle figure dei vasi greco-romani, estremamente stilizzato come in un
affresco vivente. L’uso dei piedi nudi e soprattutto dell’en dedans, posizione di chiusura delle
gambe in contrasto con la tecnica classica, e del busto curvo rompe con la concezione
accademica della grazia e dell’elevazione. La stessa violenza caratterizza le coreografie
successive, in particolare “Le Sacre du printemps” di Igor Stravinsky, del 1913, evoca un
primitivismo allora descritto come una danza selvaggia “alla maniera delle foche”. Il “caso
Nijinski”, dopo la rottura con Diaghilev nel 1917, si terminerà tristemente con la fine della
carriera dell’artista e dei lunghi anni di malattia mentale in cui si esprimerà esclusivamente
scrivendo e disegnando, ma resta in assoluto il primo tentativo “cosciente” e tecnicamente
fondato di coreografia moderna. Contemporaneamente ai Balletti Russi, la Germania vede lo
sviluppo dell’opera di Oscar Schlemmer e degli iniziatori della danza d’espressione. Occorre
puntualizzare in questa sede che le danze del Bauhaus e la danza d’espressione tedesca
53
rimasero, nonostante alcuni riferimenti comuni, totalmente distinte. Non è chiaro se questo fu
frutto di un disinteresse o di una chiusura volontaria da parte del Bauhaus ma è importante
notare come, fin dal suo sorgere, la danza moderna si caratterizza per un marcato
individualismo e per una ricerca al plurale di una nuova poetica del movimento. Al dato
emotivo della danza libera la danza d’espressione aggiunge una riflessione tecnica e teorica
più matura. Figura centrale di quest’evoluzione è Rudolf Von Laban (1879–1958) : danzatore,
coreografo e teorico egli fonda nel 1910 una scuola a Monaco, in cui studieranno Mary
Wigman (1886-1977) e Kurt Joos (1901-1979). Fuggito nel 1938 dalla Germania nazista si
rifugia in Inghilterra dove comincia un intenso lavoro teorico sui diversi piani di movimento: il
piano del tavolo (orizzontale), della porta (verticale), della ruota (sagittale). Costruisce un
icosaedro che riflette diversi punti e angoli dello spazio e che consente di precisare
geometricamente, dall’interno, le direzioni del corpo. Egli definisce questa sfera del
movimento una “cinesfera”, di cui il danzatore è il centro. Da qui concepirà molteplici sistemi
di movimento tra cui la coreutica, studio del corpo nello spazio, l’eucinetica (o effort-shape),
studio della dinamica, e la cinetografia (o Labanotation), sistema di notazione coreografica.
Laban da il primo contributo teorico sostanziale alla definizione della danza moderna
attraverso lo studio di quattro elementi essenziali e costitutivi del movimento: lo spazio, il
tempo, l’energia ed il peso. Sulla scia di tali riflessioni, negli anni ‘20 e ‘30 si delineano in
Germania nuove correnti poetiche: in particolare, quella di Von Laban e Kurt Joos parlavano
di Tanztheater mentre Mary Wigman difendeva il concetto di danza assoluta. Prima di
diventare sinonimo dello “stile” di Joos il termine Tanztheater designava semplicemente la
volontà di introdurre la nuova danza nei teatri istituzionali, dove solo la danza classica era
ammessa. Per questo Laban e Joos pensarono a introdurre nella formazione dei danzatori
moderni la tecnica accademica: il Teatro-danza si inscrive cosi nella continuità della
tradizione e per rifondare la tradizione, da cui l’interesse di Laban per una notazione
coreografica che preservasse la memoria storica. Mary Wigman, il cui nome resta legato alla
danza espressionista, non era interessata a fondare una tradizione né a confrontarsi con il
passato: solo la pura essenza della danza, spesso eseguita sul silenzio o su semplici
percussioni, la interessava. L’ Ausdruckstanz di Wigman, che si avvaleva di figure spigolose
e spesso en dedans, era una danza teatrale fondata su una tecnica non classica nella quale il
gesto sposava una condizione mentale e fisica totalmente interna al danzatore. Queste
correnti moderne, che già a partire dagli anni ‘20 avevano cominciato a trovare un certo
riconoscimento istituzionale, andranno inesorabilmente a scontrarsi con l’ascesa del potere
nazista. All’indomani della seconda guerra mondiale, nella Germania divisa tra le forze
alleate si propenderà per lo più per il rassicurante repertorio classico o per una danza
leggera e di intrattenimento. Occorrerà aspettare gli anni ’60 e ’70 affinché si ricominci a
parlare di Tanztheater. A questo proposito, Gerhard Bohner fu una delle personalità fra le più
significative della danza tedesca del dopoguerra. Sebbene poco conosciuto, egli fu all’origine
della rivoluzione estetica che condusse all’affermazione del Tanztheater. Bonher volle porsi
quale tramite di un’eredità artistica brutalmente interrotta dalla guerra. Egli considerava che
54
a partire dalle coreografie di Mary Wigman, si sarebbe potuto ritrovare un movimento
autonomo di sviluppo della danza tedesca, ripartendo da quel punto in cui si trovava negli
anni ’30 la danzatrice Palucca, che indagava il legame fra danza astratta e danza espressiva.
Parlare di “identità” tedesca era nella Germania degli anni ’60 un tema scottante che gli valse
non pochi problemi con le istituzioni. Ma l’anticonformismo della sua ricerca consistette
soprattutto nel riportare l’attenzione, al di là delle mode, su una questione poetica
fondamentale che divaricava il teatro danza fra astrazione ed espressione: cosa resta
dell’umano in un contesto totalmente astratto? O ancora come dar forma ad un impulso
emozionale senza distruggerlo? Queste domande ci riportano ad una querelle che fin dal
principio fonda la nascita del Teatro-danza, il quale, oltre che essere un “genere”, nasce in
quanto problema drammaturgico. Lo stesso Schlemmer aveva già individuato una polarità
problematica che opponeva nell’uomo leggi organiche, funzioni invisibili ed interne, e leggi
dello spazio cubico, di cui l’uomo, attraverso l’astrazione, può divenire proiezione
immaginaria. Solo se la legge organica prevale, dice Schlemmer, l’uomo può divenire il
centro del sistema. Nel binomio Teatro-danza, che tanto si è prestato a fraintendimenti e a
banalizzazioni ( penso ai molteplici accostamenti fra una danza qualunque ad oggetti
qualunque in contesti vagamente quotidiani conditi da qualche frase) si annida un Giano
bifronte che guarda contemporaneamente ad una tradizione artistica e tecnica ed all’uomo in
quanto corpo presente a sé stesso. La tradizione ed il dato presente convivono nell’unità di
corpo danzante e persona. La persona, al di là delle questioni di genere, impone a questa
drammaturgia una lente bifocale atta a individuare una struttura teatrale complessiva ed una
particolare, linguistica, rispetto alla danza. È uno sguardo in cui convivono il vicino ed il
lontano, il presente e l’eterno. La potente ambiguità del Teatro-danza deve oggi la sua
rivelazione ed il suo pieno riconoscimento all’opera di Pina Bausch. Aggiungo, per
concludere, il personale ricordo di una conferenza stampa al Teatro Argentina di Roma dove
alla domanda (probabilmente l’ennesima) se esistesse un Teatro-danza dopo o oltre la
Bausch, Pina guardò la giornalista e, degnamente, non rispose.
55
Di nero vestita.
Nel 1973 il sovrintendente Wüstenhöfer chiede alla danzatrice Pina Bausch di assumere la
direzione del dipartimento di danza dello Stadt Theater di Wuppertal. Pina Bausch, già allieva
di Kurt Joos e reduce da alcune esperienze di lavoro negli Stati Uniti, esitante accettò. Da
allora, cominciò con i venticinque danzatori del Tanztheater Wuppertal una straordinaria
avventura artistica che, nonostante il contesto assolutamente istituzionale, cambierà la storia
della danza contemporanea e del teatro divenendo sinonimo di un genere, allora poco
conosciuto, a cui il nome di Pina si legherà indissolubilmente. I primi spettacoli della Bausch,
ancora eminentemente coreografici, non tardano a scandalizzare il pubblico di Wuppertal,
abituato ad un linguaggio classico. Attraverso “Fritz” (1974), “Ifigenia in Tauride” (1974),
“Orfeo ed Euridice” (1975) e “La Sagra della Primavera” (1975) – questi ultimi già messi in
scena da Mary Wigman - Pina si appropria di temi tipici dell’espressionismo tedesco. Con i
“Sette peccati capitali” (1976) di Brecht e Weill l’omaggio all’eredità espressionista trova il
suo apogeo nell’apparizione di passerelle, travestimenti e una coreografia ispirata al mondo
della rivista musicale. A partire da questa creazione, si cristallizzano alcune componenti del
lavoro del Tanztheater Wuppertal che diverranno sinonimo dello stile Bausch ma, in
definitiva, del teatro-danza in assoluto. Oltre che le componenti stilistiche proprie al mondo
della rivista e all’espressionismo, il teatro-danza della Bausch fuoriesce da un linguaggio
prettamente coreografico per approdare ad uno statuto ambiguo dei danzatori: i “danzaattori” di Pina Bausch si riappropriano di una voce, di una soggettività “problematica” ed
infine si presentano sì per danzare ma non “a priori”. Ciò implicherà, nell’universo delle opere
più mature della Bausch, uno statuto particolare della danza, intesa come espressione ora
collettiva ora intima ma mai sconnessa dalla “persona” che danza. Un amore per il concreto
ed il vitale che caratterizzerà le pièce successive fra cui, per citare le più celebri, “Caffè
Müller” (1978), “Nelken” (1982), “Viktor” (1986), “Palermo Palermo” (1989), “Danzon” (1995).
In queste creazioni, che vedono il totale riconoscimento internazionale della compagnia, la
drammaturgia di Pina Bausch andrà a privilegiare in particolare due aspetti registici: la mise
en espace, per quanto riguarda il rapporto dei danzatori allo spazio scenografico, ed il
montaggio, per quanto riguarda la successione delle scene ed il collage musicale. A partire
dagli anni ’80 Pina instaurerà una fruttuosa collaborazione con lo scenografo Peter Pabst,
che creerà per gli spettacoli della compagnia dei veri e propri environnement che
condizioneranno la danza degli interpreti: montagne di fiori, acqua, prati o macerie daranno
la misura di quella logica “sensibile” alla quale la Bausch sottomette la coreografia. La
materia, che già nella “Sagra della primavera” sporcava con la terra la nitidezza dei
movimenti, diviene un tutt’uno con la “vita” dello spettacolo: non a riportarci ad un banale
elemento “quotidiano” piuttosto a coniugare fatto estetico e nostalgia di un’unità, bellezza e
difficoltà del caos, uomo e natura. Questo alternarsi ciclico di piccole storie individuali
confrontate ad un ordine estetico/naturale, di dimensione volutamente teatrale, assimilabile
ad un destino passeggero quanto incoercibile, ci rimanda alla struttura drammaturgica che
56
percorre tutti gli Stück della Bausch: ogni spettacolo è pièce e pezzo di una ripetizione
infinita, è una storia non narrativa, è variazione su tema di rapporti umani, luoghi, ricordi o
desideri che non cessano di ricominciare. I “danza-attori” di Pina Bausch sembrano
riportare, pur nell’aggiornamento dell’impianto drammaturgico e dei codici estetici, la
dimensione coreografica a quell’ uguaglianza dei linguaggi della koreia greca, che non
distingueva la teatralità dalla danza o dal canto. Una sorta di naturalezza poetica delle
tecniche che trova, soprattutto nei momenti corali delle scene, un compimento non fine a sé
stesso ma a servizio del senso dell’opera. Il film “Die Klage der Kaiserin”, letteralmente “Il
lamento dell’imperatrice” (1989), è una commedia drammatica la cui analisi può aiutarci a
illustrare la tecnica drammaturgica del montaggio di Pina Bausch. L’ambientazione ci riporta
alla relazione fra degli interni e degli esterni intesi e come spazi naturali e come spazi urbani.
Le figure sono prevalentemente femminili, ma sono altresì presenti degli uomini, dei bambini,
dei vecchi e degli animali domestici. In tutta la prima parte del film queste figure si
presentano come perdute rispetto al contesto o comunque incongrue per le azioni svolte o i
costumi indossati. La prima immagine ad esempio, vede una donna con un taglia erba ed una
pistola, in un bosco coperto di foglie morte, cercare affannosamente di “mettere in ordine”
una natura caotica. Un’altra donna, con orecchie da coniglio ed un corsetto nero che scopre
il seno, vaga incespicando su zolle di terra nuda, come se scappasse da lungo tempo. Le
immagini si ripetono e introducono di volta in volta altri personaggi come in una galleria di
ritratti. Una donna si sforza di trascinare una pecora, poi una capra, a seguire un’altra figura
femminile dall’abito troppo grande vaga in una foresta dai tronchi numerati . Segue un balzo
in avanti in cui una donna è seduta su una poltrona in mezzo al traffico di città, come se nulla
fosse. Lo spazio intimo contrasta con quello pubblico, non è permeabile nella sua lontananza
rispetto al sociale. Solo le figure dei vecchi nel bosco sono degne e consolatorie, ed a un
certo punto prendono con sé dei neonati apparentemente abbandonati, che strillano. Tutta
l’atmosfera iniziale ha qualcosa di solenne ed epico ma allo stesso tempo di stonato,
soprattutto grazie alla musica di fondo che pare quella di una banda di paese che celebra un
funerale o una qualche festività. Un uomo ben vestito si sforza, in mezzo ad un prato, di
portare sulla schiena un armadio, su una musica pastorale. Si delinea un ostinazione delle
figure a compiere qualcosa di smisurato o inutile, come se ciascuno portasse letteralmente
un bagaglio di futilità che è etimologicamente impedimenta. Si delinea, parallelamente al
lento evolversi delle storie, una fuga verso l’interiorità umana come rifugio nell’immaginario,
proiezione di sé o danza intima ed al contempo una fuga in avanti in vani compiti, tentativi di
comunicazione teneri o collerici, giochi di seduzione o di potere. L’ambientazione riflette
anche un contrasto geografico, un passaggio costante,visivo e musicale, tra una realtà
fredda ed invernale ed una realtà fittizia ( un uomo danza su ritmi esotici dentro una serra di
fiori, una donna guarda fuori dall’interno di una piscina) accogliente e primaverile.
L’incongruità è svelata dall’essere in luogo delle figure, che è perennemente duplice: esse
sono presenti in un luogo grigio e severo ( che è la Germania) ma sono intimamente altrove.
Vi sono numerosi elementi in questo lavoro, come la presenza dell’acqua o di un gregge di
57
capre, che potrebbero essere assunti a simbolo, per esempio del “femminile” o del “tragico”.
La giustapposizione semplice di figure umane alla materia sensibile, rende tuttavia
intelligibile l’azione in modo diretto, “epico”, in quanto restituisce attraverso una superficie
estetica ciò che è misterioso e nascosto. Il montaggio si rivela essenziale in questo tipo di
processo e, precisamente, si tratta di un montaggio che agisce tanto spazialmente che
temporalmente. In particolare, ciò che è ripetuto a breve distanza nel lavoro video è
l’equivalente della compresenza in scena, della contemporaneità di una storia appartata in un
altro luogo. Si rivela in questo senso essenziale la dialettica espressa tra i soli monologanti ed
il gruppo che ha funzione di coro. L’uso dello spazio e il montaggio delle sequenze
obbediscono di conseguenza ad un tipo di ritmo che è esistenziale ed umano, comportando
a volte delle lunghezze non prettamente teatrali, in una sorta di “serie delle situazioni” che si
autoalimenta. In questo senso le sequenze musicali hanno un’importanza preponderante e,
andando indifferentemente da scelte colte a altre più popolari, contribuiscono costantemente
a rinnovare le atmosfere e la percezione. Il tempo comico e quello tragico si alternano in
modo ludico, in una drammaturgia che fa del desiderio umano il suo motore principale: vi è
una ricerca di felicità quasi onnipresente, che diventa spesso violenta, filtrata da situazioni
quotidiane distorte, artificiali quanto è artificiale il teatro e la naturalezza dei danzatori. L’uso
degli animali testimonia in questo senso la vera dimensione naturale, essi costituiscono una
“presenza pura” rispetto al movimento caotico della coscienza e dei sentimenti umani. Il
tragico si articola quindi come movimento interno all’uomo, passaggio dell’essere in vita,
ritorno verso il sé profondo che si fa danza per necessità.
58
Percorsi d’avanguardia.
A conclusione di questo lavoro, incentrato sui percorsi di ricerca teatrale del ‘900, desidero
spendere alcune considerazioni sulla parola avanguardia e sul suo statuto. Leggo nel
dizionario che il termine ha origine militare e corrisponde a quell’unità che è posta in
posizione avanzata a scopo di protezione e difesa. Per estensione, il termine è legato a idee
rivoluzionarie, ad esempio in politica, e fa riferimento a nuove forme d’espressione che
contrastano con la tradizione o con il gusto corrente. L’avanguardia reca in sé una sorta di
vocazione missionaria, che può essere interpretata tanto come attacco di codici prestabiliti,
quanto come resistenza in difesa di valori che rischiano di annientarsi. Alla dimensione
militare dell’avanguardia di aggiunge anche una vocazione per la novità, per la provocazione
o, semplicemente, per la ricerca. Ciascuna di queste “sfumature” di significato meriterebbe
un analisi meticolosa afferente alle diverse categorie d’avanguardia: ognuna delle quali può
essere difesa strenuamente o rifiutata come non portatrice di senso. Personalmente, anche
se si potrebbe dichiarare il tempo dell’avanguardia concluso per diverse ragioni, avverto
risuonare il termine come sensato e forte( perché la forza è la sua qualità primaria) fino ai
nostri giorni solo se legato ai termini di resistenza e di ricerca. Il non compromesso e la
rinuncia alla facilità di cui parlava Kantor, rendendo giustizia alla memoria delle avanguardie
storiche, costituisce di per sé un compito degno dell’avanguardia. Ma è ineluttabile la
considerazione di come una resistenza od un’opposizione ad un sistema di società equivalga
in arte giusto esserne la ruota di scorta:“Il teatro del mercato deve avere un linguaggio
indifferenziato, più semplice di quello del gruppo o del singolo perché ne deve servire diversi.
Mentre il compito dell’approfondimento e della ricerca viene assunto da gruppi marginali, che
sono “radicati” però soltanto rispetto alle loro matrici culturali e al ristrettissimo pubblico che
aderisce alla loro ricerca. Così il gioco delle parti è perfetto: l’avanguardia vive di sacrificio
ma si nobilita rispetto alla banalità del mercato e viceversa per le compagnie di giro; diversi
pubblici vengono gratificati; l’avanguardia diventa per il teatro di giro serbatoio di
disoccupati e palestra di talenti; il mercato del teatro di giro diventa il premio per
l’avanguardia accettata. 12 ” Si spiegano probabilmente così, in un riassorbimento nel corso
“naturale” degli eventi, determinati fallimenti in termini di trasmissione di un eredità o alcuni
lenti ma inesorabili declini artistici. In questo senso il semplice ricorso “alla novità” o alla
provocazione ad ogni costo sembrano essere il fattore più debole per supplire ad un reale
bisogno d’avanzamento: occorrerà pensare che la temperie storica e culturale di un’ epoca
ha l’avanguardia che si merita. È infatti noto, a chi frequenti festival ed eventi nelle città
europee, come una pretesa avanguardia che non prende posizione alcuna abbia in qualche
modo rinunciato ad investirsi nel linguaggio, privilegiando l’estenuata percezione delle
meccaniche fisiologiche del corpo o lo “spettacolare” tecnologico svincolato dalla condizione
sostitutiva propria del segno : le “cose” appaiono come significanti vuoti di referente.
Occorre allora svincolare il termine avanguardia dal termine ricerca, perpetuamente inficiata
12
Antonio Attisani Teatro come differenza, Edizioni Essegi, Ravenna,1988,pag 24
59
da una diversità ad ogni costo o dalla produzione di “eventi”? La sperimentazione teatrale è
oggi realmente legata ad un concetto conflittuale d’avanguardia? Quest’ultima, slegata
dall’espressione del mondo e dalla stessa critica dei codici d’espressione da cui le
avanguardie storiche erano partite, pare implodere in un’autorefenzialità che è sinonimo di
debolezza. Affievolita la guardia, non può esserci avanguardia. Ma se invece l’avanguardia
fosse intesa come conservazione di una posizione degna, come difesa di quel sistema
arcaico che è il teatro o il linguaggio, in nome di un’esperienza conoscitiva autentica? “Gnosi
ovvero ricerca: ricerca della salvezza tramite la conoscenza. Per designare il lavoro di gran
parte della scena contemporanea si può parlare di gnosi. Il termine indica con buona
approssimazione anche il sentimento religioso che percorre il lavoro teatrale, l’inesausta
indagine delle sulle cause che inchiodano a questa terra, a questo destino. Il teatro come
forma dell’invisibile, come lavoro sull’apparente e sulla realtà sensibile (...). Non un
atteggiamento contemplativo, non un romantico abbandono, non una ribellione moralistica,
non un surrealistico inseguimento dell’inconscio. Un po’ di tutto questo, ma soprattutto una
meditazione svolta per mezzo della scena 13 .” A questo proposito mi pare si possa delineare
una distinzione fondamentale di atteggiamento poetico nella ricerca teatrale: esiste un teatro
d’avanguardia ed un’avanguardia del teatro, nella cui inversione dei termini consiste oggi
una reale inversione di senso. Credo che solo l’avanguardia del teatro abbia dei giorni a
venire, in quanto essa dispone dinanzi a sé, letteralmente, del teatro. Gli stessi percorsi presi
ad esempio in questo lavoro, come significativi di un’evoluzione della drammaturgia,
afferiscono a questa categoria. Rimane, accanto alla coscienza di un’eredità e del lavoro a
venire, la consapevolezza di un’insufficienza delle “vie di comunicazione”: riporto, come un
memento ed un triste fanalino di coda, un’ultima osservazione di Attisani sull’”esemplare”
situazione italiana: “Non mi sembra utile distinguere tra un teatro che cambia ed uno che
conserva. Tutto il teatro dovrebbe cambiare e non per decreto bensì per circolazione di
energie e di saperi. In Italia invece si fanno tanti spettacoli, ma i luoghi della cultura teatrale
sono davvero pochi. Non esistono “case” dove diverse generazioni della scena, gente di
diverso orientamento, professionisti affermati e giovani debuttanti possano convivere nella
differenza e mutarsi fatalmente a vicenda. La scelta assurda a cui è costretto chi comincia a
fare teatro, oggi, è tra l’inserimento in meccanismi aberranti e il rimanerne avulsi, rischiando
l’asfissia o la morte per isolamento 14 .”
13
14
Antonio Attisani Teatro come differenza, Edizioni Essegi, Ravenna,1988,pag 117
Antonio Attisani op.cit.,pag 117
60
Bibliografia essenziale:
“Il corpo scenico ovvero la tradizione tecnica dell’attore”
a cura di Giovanni Azzaroni, Nuova Alfa Editoriale, Bologna 1990
“La riscossa di Lucifero ideologie e prassi del teatro di sperimentazione in Italia”
Maurizio Grande, Bulzoni Editore, Roma1985
“Teatro come differenza”
Antonio Attisani, Edizioni Essegi, Ravenna 1988
“Guida al teatro contemporaneo”
Franco Ferrari, Gammalibri, Milano 1980
“L’attore biomeccanico”
Vsevolod Mejercol’d, Ubulibri, Milano 1993
“Epopea della polvere”
Romeo Castellucci, Chiara Guidi, Claudia Castellucci, Ubulibri, Milano 2001
“Il teatro della morte”
Tadeusz Kantor, Ubulibri, Milano 2004
“Quad” suivi de “L’épuisé”
Samuel Beckett, Gilles Deleuze, Les éditions de minuit, Paris 1992
"Les écrivains devant Dieu" collection
Jean Onimus, Desclée de Brouwer, Paris 1967
« Écrits sur le théâtre »
Roland Barthes, Éditions du Seuil, Paris 2002
« L’homme et la figure d’art »
Oscar Schlemmer, Centre National de la Danse, Paris 2001
61