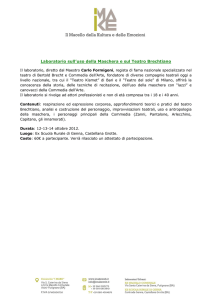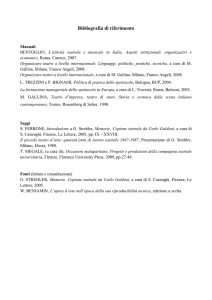La casa delle maschere
Donato Sartori
La via teatrale novecentesca. Se dovessimo ripercorrere la cronistoria della maschera teatrale dalla
fine del secondo millennio, dovremmo per prima cosa ritornare ad uno dei più rappresentativi
personaggi di teatro d’inizio secolo: il regista e scenografo inglese Edward Gordon Craig (18721966), che nel 1908 pubblicò a Firenze la rivista “Masks”, ove scrisse: «Ci fu un tempo in cui la
maschera serviva per la guerra, quando la guerra era considerata arte. Ci fu un tempo in cui la
maschera veniva usata per le cerimonie, perché si pensava che il solo volto non fosse abbastanza
forte. Venne il momento in cui la maschera fu scelta dai grandi del teatro classico: Eschilo, Sofocle,
Euripide. Venne il tempo in cui l’attore superbo non volle coprire il suo volto e gettò la maschera.
Un tempo per il gioco dei bimbi e le feste mascherate. Oggi dobbiamo creare una maschera nuova,
rifiutando di ricorrere all’archeologia del passato, che riesca a dare un volto all’anima dell’attore
per fare più grande il teatro». Vedremo l’ultimo Craig nelle vesti di docente presso l’Accademia di
Belle Arti del capoluogo toscano, dove insegnò ai giovani un teatro di puro movimento e dove, non
è escluso, esercitò una certa influenza sul giovane Amleto Sartori, allievo di scultura in quegli anni
tra le mura dello stesso istituto. Il sasso era stato ormai lanciato: la curiosità per la maschera,
straordinario strumento-oggetto che contaminò l’ambiente teatrale di tutto il secolo.
Qualche anno dopo, nel 1912, Oskar Schlemmer concretizzò in Germania una sua riflessione sulle
maschere mettendo in atto un balletto che fu rappresentato più tardi nella sede del Bauhaus di
Weimar; in Francia, quasi contemporaneamente, il giovane drammaturgo Jacques Copeau inaugurò
la piccola sala sulla rive gauche, il Teatro del Vieux Colombier. L’evento ebbe risonanza europea
dal 1913 al 1924, non solo perché presentava una vera e propria fucina di artisti di teatro, ma anche
per la realizzazione di un nuovo tipo di dispositivo scenico, e soprattutto per l’adozione della
maschera, quale mezzo teatrale di primaria importanza per la ricerca e la formazione dell’attore che
volesse vivere il mondo del teatro come fondamentale dimensione della propria vita.
Per condurre gli attori alla famigliarità con il proprio corpo Copeau li fece lavorare con la maschera.
È un interesse di lunga data quello di Copeau per le maschere dell’Improvvisa che sin dall’inizio
dell’avventura teatrale studiò e condivise con Leon Chancerel, studioso di teatro che gli propose un
vasto repertorio documentale sulle figure e sui personaggi dell’arte, tra cui l’opera di Maurice Sand
Masques et Buffons, pubblicata a Parigi nel 1860. Da questo momento il mascheramento divenne
per Copeau e per la generazione dei maestri del teatro uno strumento di straordinaria importanza.
1
Il fermento culturale di quegli anni fu inoltre stimolato da una forte spinta da parte di alcuni
ricercatori e storici di teatro che vollero ripercorrere la via a ritroso, alla ricerca delle proprie radici
perdute, prendendo le mosse proprio da quel teatro di origini popolari che dal primo Rinascimento e
per oltre due secoli, fu protagonista indiscusso sulle scene di tutto l’Occidente: la Commedia
dell’Arte. Kostantin Miklaševskij (1886-1944), detto Mic, uomo di teatro russo, pubblicò nel 1914 a
Pietroburgo un testo esemplare, intitolato La Commedia dell’arte o il Teatro dei commedianti
italiani dei secoli
XVI, XVII, XVIII.
Il testo, di indubbio valore storico e documentario, apparso nella
rivista russa L’amore delle tre melarance,1 diretta da Mejerchol’d, fornisce una testimonianza
tangibile di un’effettiva attenzione del teatro russo d’avanguardia verso tecniche, tematiche e
maschere della Commedia dell’Arte.
Fu proprio in questo contesto che Mic in uno dei suoi viaggi a Parigi, volle conoscere Copeau; dal
loro incontro nacque una solida amicizia ed una lunga collaborazione; per Copeau stesso infatti:
«l’attore in maschera ha maggior forza di quello la cui faccia è visibile al pubblico».
L’attore e regista Charles Dullin (1885-1949), dopo una lunga serie di disparati ingaggi nel mondo
teatrale, decise di accompagnare Copeau nell’avventura del Vieux Colombier fino al 1921, per poi
fondare una propria scuola che sarà frequentata tra gli altri anche da Antonin Artaud, Jean Louis
Barrault e Etienne Decroux.
Agli esordi della prima guerra mondiale, su di un treno che li avrebbe condotti a Parigi, viaggiavano
due giovani che avevano deciso di arruolarsi nel XXII reggimento dei dragoni: Pierre Louis
Duchartre e Charles Dullin. Fu questo incontro determinante che convinse Duchartre a immergersi
in quello strano mondo del teatro che non gli apparteneva per elezione ma che lo affascinava tanto
che, finita la guerra, si dedicò ad una ricerca sulle origini del teatro e sulle maschere della
Commedia dell’Arte, che gli permise di dare alle stampe nel 1925 la prima stesura di La Comedie
1
La rivista, il cui sottotitolo era La rivista del Dottor Dappertutto, diretta sotto questo pseudonimo da Mejerchol’d
stesso e della quale uscirono in tutto nove numeri, combatteva in nome della Commedia dell’arte e dell’opera di Carlo
Gozzi, il teatro cosiddetto psicologico e naturalista. Come specchio dell’attività di via Borodinskaja, pubblicò numerosi
articoli sui comici italiani insieme a diversi scenari e opere di Gozzi stesso. Cfr. C. Solvetti, L’amore delle tre
melarance, la rivista del Dottor Dappertutto in Carte segrete, 1976, n. 32, pp. 15-30.
2
Italienne, testo che costituisce uno dei riferimenti culturali più ricercati da parte di attori, registi,
studiosi e uomini di teatro.
Tra gli innumerevoli allievi della scuola, sorta accanto al teatro Vieux Colombier, uno in
particolare, Etienne Decroux, emerse nell’uso del corpo in qualità di strumento teatrale, tanto che
divenne poi uno dei principali fautori di una corrente mimica cui attinsero molti degli attori
emergenti dell’epoca tra cui J. Louis Barrault e Marcel Marceau. “Enlever le visage pour retrouver
le corp” fu l’intento che contraddistinse la metodologia pedagogica di questa scuola diretta da
Copeau e che divenne per così dire il motto di Decroux, al quale era sufficiente celare alla vista
degli spettatori le espressioni del volto dell’attore. A questo scopo, mediante l’uso di un tessuto
leggerissimo (velo) mise a punto una maschera in grado di avviluppare l’intera testa dell’attore,
consentendone la massima visione e la perfetta respirazione.
Alla scuola, vennero usate invece maschere di cartone confezionate secondo una tecnica
sperimentata dallo stesso Copeau, che consisteva in strati sovrapposti di carta di giornale, uniti tra
loro con colla d’amido, ottenuta dalla cottura della farina di grano, alla quale veniva aggiunta una
zolletta di zucchero. Quest’ultima curiosità divenne per lungo tempo uno dei misteri che avvolgeva
la maschera di fascino, dato che lo stesso maestro tenne segreta la ricetta. Le maschere, di vaga
sembianza antropomorfa, non dovevano possedere alcuna espressione, per dare così modo
all’allievo-attore di esprimere le proprie emozioni solamente con l’uso mimico del corpo. Questo
particolare strumento didattico fu chiamato le masque noble, o anche della calma, considerando
l’inespressività che la caratterizzava e che, alla fine della seconda guerra mondiale, prese il nome di
maschera neutra.
3
Jean Dastè, allievo nonché genero di Copeau, avendone sposato la figlia Marie Helene, fu colui che
trasmise l’utilizzo di tale maschera, dopo l’esperienza del Vieux Colombier, seguendo il maestro in
Borgogna nel 1925, ove organizzò un gruppo di attori che prese il nome di Copiaus. Dastè e Marie
Helene fondarono nel 1945 la propria compagnia che prese il nome di Les Comédiens de Grenoble,
per mettere in pratica le teorie, gli insegnamenti e l’uso della maschera secondo Copeau. Qui fece la
sua prima comparsa come attore-mimo professionista, il giovane Jacques Lecoq che da poco aveva
portato a termine un corso di studi d’arte drammatica tenuto dai maestri Charles Dullin e Jean
Louis Barrault.
Lavorare nel gruppo di Grenoble significava per il giovane mimo incontrare il mito di Copeau, la
tradizione pedagogica del Vieux Colombier e, soprattutto, confrontarsi con l’esperienza dei
Copiaus. Tramite Dastè, Lecoq scoprì infatti le Jeu du Masque e venne a conoscenza degli
accorgimenti tecnici sull’uso e sulla realizzazione delle maschere in cartapesta. Tornato a Parigi, nel
1945, fu assunto dalla scuola di recente fondazione E.P.J.D. (Education par le jeu dramatique);
scoprì così la sua vocazione per l’insegnamento, tralasciando la professione di attore. Più tardi, ebbe
modo di conoscere il regista Gianfranco De Bosio e la sua collaboratrice Lieta Papafava dei
Carraresi, giunti a Parigi (grazie ad una borsa di studio dell’Università di Padova) per un corso di
aggiornamento teatrale al E.P.J.D. De Bosio, assistente del poeta Diego Valeri, allora preside della
Facoltà di Lettere della città, si prodigò per mutare le sorti del teatro universitario, allora
estremamente conservatore e pervaso da correnti tradizionaliste poco consone al clima di euforia
culturale che attraversava l’Europa dell’immediato dopoguerra.
Il Teatro universitario di De Bosio a Padova. L’Università, infatti, produsse sotto la guida d’insigni
personalità accademiche e con l’apporto dei giovani che avevano fatto la Resistenza, sotto la guida
di Egidio Meneghetti, una serie di iniziative culturali, tra le quali la fondazione di un teatro
dell’università, guidato da De Bosio, che fondò anche una scuola, nella quale Lecoq fu invitato a
insegnare il movimento del corpo, Lieta Papafava recitazione e studio dei testi, Ludovico Zorzi
storia del teatro e Amleto Sartori storia dell’arte e modellazione delle maschere. Ricorda Lecoq:
«Arrivai a Padova nel dicembre del 1948, ad attendermi alla stazione erano presenti oltre a De
Bosio tutti gli attori del teatro dell’università: Agostino Contarello, Gennaro Gennari, Giuliana
Pinori, Mario Bardella, Lieta Papafava». A questi se ne aggiunsero altri come Giulio Bosetti, Carlo
Mazzone, Vanda Cardamone, o lo scenografo Misha Scandella.
4
Pochi giorni dopo, Lecoq tenne la sua prima dimostrazione agli attori della compagnia mostrando
quel che sapeva fare, in particolare riprodusse la famosa marche sur place, caratteristica camminata
mimica sul posto inventata negli anni ’30 da Decroux. Un ironico apprezzamento da parte di un
allievo, che sbottò: «bello… ma dove va?», portò Lecoq a comprendere che il mimo puro, inteso
come genere autonomo, proprio di attori che ne fecero una professione spettacolare come Decroux e
Marceau era ben lontano da quel mime dramatique, aperto al teatro e con finalità pedagogiche del
quale da tempo ne intuiva l’esistenza. Lecoq non aveva con sé maschere di sorta quando arrivò a
Padova, l’unica regalatagli dall’amico Dastè, l’aveva bêtement prestata ad un ballerino per una
dimostrazione in Germania: «Je suis arrivé a Padue avec la thecnique pour la costruction du masque
neutre dans la tête, et l’idée de travailler ce masque dans l’école».
De Bosio gli suggerì di rivolgersi allo scultore Amleto Sartori, che già aveva creato alcune
maschere per uno spettacolo di poesia negra realizzato dall’Università di Padova nei saloni di
Palazzo Papafava in via Marsala. Tra gli altri recitavano: Carlo Mazzone, Agostino Contarello che
ne curò anche la regia, il panorama artistico fu commentato dallo stesso De Bosio.
Le maschere, scolpite da Sartori in legno cavo e dipinto, montate su bastoni poggianti a terra,
avevano la funzione di coprire il viso degli attori senza essere indossate e furono le prime maschere
teatrali realizzate da Amleto, un tentativo creativo che non rimase isolato. La serata fu illustrata
dalle immagini pittoriche di artisti veneti, oltre a quelle dello stesso Sartori diedero sfoggio alle loro
opere: Guidi, Fasan, Pendini, Perissinotto (Peri), Saetti, Rosa, Schiavinato, Tosello, Travaglia,
Vedova e Tono Zancanaro.
Amleto Sartori non era solo un pittore, era soprattutto scultore e tra le sue peculiarità annoverava
una profonda conoscenza dell’anatomia umana derivatagli dalla frequentazione delle lezioni
universitarie di anatomia, allo scopo di documentare graficamente alcuni volumi di medicina
pubblicati da amici medici nonché docenti universitari. Egli aveva inoltre frequentato, per lunghi
anni, le Accademie di Belle Arti di Venezia e di Firenze istituzioni specialistiche dove si studiavano
discipline scultoree quali l’anatomia, l’osteologia e la miologia per artisti. 2
Naturalmente dotato per la ritrattistica, Amleto, incuriosito dalle richieste di Lecoq per la
realizzazione di maschere neutre da usare successivamente nella scuola di teatro, non solo fornì lo
spazio nel suo laboratorio presso la scuola d’arte Pietro Selvatico ove insegnava, ma dopo aver
osservato l’incapacità degli allievi nel modellare i volti delle maschere propose anche con
2
Amleto Sartori ebbe da sempre un rapporto con la maschera che si potrebbe definire congenito. Fin da giovanissimo,
infatti, espresse con l’intaglio una profonda predisposizione per il grottesco. Nel 1928, tredicenne, iniziò un lavoro di
scultura commissionatogli dall’antiquario Alfredo Bordin, che concluse dieci anni più tardi. Durante questo periodo,
furono scolpite nel legno di cirmolo, in bassorilievo e a tuttotondo, diverse figure grottesche, maschere e mostri a
corredo di un intero appartamento esposto ora presso il Museo Civico del Santo di Padova.
5
determinazione un suo efficace intervento. Lecoq rammenta la scelta di Amleto di fare da sé le
maschere.
3
A quelle seguirono altre maschere per spettacoli che il Teatro dell’Università mise in
scena dal 1948 al 1951 lungo le diverse produzioni: come Le cento notti, spettacolo ispirato alle
figure del teatro Nô giapponese che Lecoq portò a Padova come eco dell’esperienza di Grenoble;
Porto di mare, pantomima con maschere neutre e coreografia dello stesso Lecoq; I pettegolezzi
delle donne di Carlo Goldoni con la regia di De Bosio e le scenografie di Misha Scandella. Tra le
tante ne emerse una straordinaria: I sei personaggi in cerca d’autore, con la regia di De Bosio e
l’interpretazione di Giulio Bosetti nel ruolo del figlio. La pregnante tipologia pirandelliana, presente
nell’opera, diede modo a Sartori di indagare nel profondo della psiche umana, per produrre una
serie di maschere-personaggio in cartapesta policroma, che donò all’intero spettacolo un deciso
tratto artistico. Altre opere furono ispirate e messe in scena dai testi di Ruzante, in seguito a studi e
pubblicazioni apparsi nella prima parte del secolo ad opera del francese Alfred Mortier e del veneto
Emilio Lovarini, con cui mio padre ebbe un lungo rapporto epistolare, tuttavia anche grazie
all’apporto offerto dagli studiosi padovani Ludovico Zorzi e Paolo Sambin.
È curioso indagare il motivo che spinse De Bosio, convinto assertore delle maschere dell'Arte, a
rifiutarsi di utilizzarle per gli spettacoli di Ruzante, nonostante la colta e accorata convinzione di
Giovanni Calendoli, che vedeva Ruzante come anticipatore nel suo tempo, delle maschere della
commedia improvvisa.
Ma il dado era oramai tratto; la fama delle maschere di Amleto si diffuse così velocemente da
raggiungere consensi non solo in Italia, ma soprattutto nel pieno risveglio culturale dell’Europa
postbellica. A Parigi, infatti, Jean Louis Barrault raggiunto dalla fama delle maschere in cuoio
create dall’artista italiano, volle dapprima sperimentare quelle della Commedia dell’Arte per una
rappresentazione al Teatro Marigny; e, più tardi, ricorse a quelle dei personaggi per la Vaccaria di
Ruzante. Ciò produsse a Parigi un grande evento, e le nuove maschere avvinsero talmente regista e
pubblico che vennero premiate con una nuova produzione che Barrault mise in scena al Festival
Internazionale di Bordeau (1955) e successivamente con la complessa trilogia di Eschilo, l’Orestea
all’Odeon di Parigi, rappresentata con ben 75 maschere in cuoio scolpite da Amleto Sartori.
Questi furono gli anni dei miei primi ricordi d’infanzia, legati al teatro e alle maschere che agli
occhi di un bambino trascorsero come un gioco. Ricordo le lunge notti insonni, dovute alla presenza
di attori e gente di teatro che frequentavano la mia casa di Riviera Paleocapa, dalle cui finestre
ammiravo la maestosa imponenza della Specola. Ricordo le declamazioni frenetiche di Agostino
Contarello, singolare attore-autore padovano che veniva a “provare” qui i suoi personaggi teatrali,
prima ancora di interpretarli al Teatro dell’Università. Durante le infinite notti di veglia forzata
3
Cfr., in questo volume, La geometria al servizio dell’emozione di Jacques Lecoq.
6
(dormivo infatti nella saletta adiacente alla cucina, l’unica zona riscaldata della casa ove avvenivano
gli incontri), decine e decine di persone si davano appuntamento per discutere di teatro o,
semplicemente, per bere un bicchiere di vino con gli amici, e spesso si faceva mattina. L’amicizia
tra mio padre e Jacques (al quale, più tardi, doveva aggiungersi Marcello Moretti, straordinario
interprete dell’Arlecchino strehleriano), era tale che spesso i due scomparivano per intere giornate
alla ricerca di volti caratteristici, vere e proprie maschere umane che si potevano incontrare solo in
alcuni punti nodali della città o nel suo immediato circondario.
Il mercato “dei frutti e delle erbe” delle piazze, sotto il salone della vecchia Padova con i suoi
banchi colorati e profumati, brulicante di una pittoresca fauna popolana, era fonte inesauribile di
suggerimenti per le maschere pavane della tipologia ruzantiana. Amleto amava questi posti e veniva
spesso ad ispirarsi con Jacques che, curioso ed estasiato, scopriva l’Italia nella sua essenza vera e
popolare. L’Italia della Commedia all’Improvviso si ritrovava lì, viva, con gli autentici personaggi,
gli schiamazzi e le grida tipiche di ogni mercato rionale. Divenne presto consuetudine, da parte dei
due amici, fare lunghe scarrozzate in vespa lungo i bastioni medioevali, per raggiungere luoghi
caratteristici e spesso malfamati, abitati da una moltitudine di “tipi” degni dei più suggestivi
racconti del popolo pavano; il Foro Boario in Prato della Valle, con il suo straordinario folclore
contadino, era meta di mercanti di bestiame, avvolti dai neri tabarri che, giungendo alle prime luci
dell’alba a bordo dei loro “birroccini” trainati da cavalli rintuzzati dalle eleganti fruste a schiocco,
concludevano gli affari sputandosi sulle palme e suggellando l’accordo con una vigorosa stretta di
mano. Anche Porta Portello, emblematica zona malfamata della città, era una delle mete preferite,
serbatoio inesauribile di idee e suggerimenti per modellare maschere e personaggi per lo scultore
padovano, di posture ed atteggiamenti per il mimo francese. Altro luogo prediletto, era il quartiere
periferico di Santa Croce, area santa, popolata da pellegrini di tutto il mondo, in cerca di una grazia
o di un miracolo, richiesto a Padre Leopoldo, un minuscolo frate cappuccino.
Ricordo ancora un pomeriggio di festa, in cui venne a casa nostra Jacques, accompagnato da Lieta
Papafava; più tardi ci raggiunse Agostino Contarello. Fu quasi un incontro-spettacolo, con mio
padre che raccontava aneddoti sui personaggi della vecchia Padova, paragonando lo spirito caustico
della Gaetana a quello della Betia di ruzantiana memoria, riportando le barzellette su alcune
macchiette realmente esistite, o ancora esistenti, come Chichi Badan, famoso possessore del più
grande attributo maschile del Veneto, ipotizzando parallelismi tra Pace del Portello e storici
personaggi, quali Sier Tomao dell’Anconitana o il Ruzante stesso, quale interprete delle proprie
commedie. Jacques, ricordo, allora lungo e allampanato, interpretava scherzando e mimando le
figure che via via erano citate: il grasso e porcino Tuogno, da un’antica farsa anonima, messo a
confronto con il Fattore della Vaccaria.
7
Così arrivammo a sera; ci muovemmo all’imbrunire, invitati da qualcuno a mangiare carne di
cavallo a Legnaro, piccolo borgo situato lungo la strada per Chioggia. Stipati in una vecchia
giardinetta, ci inoltrammo per sentieri sterrati, sino a raggiungere con il buio un gruppo di casoni in
legno dal tetto di paglia, vagamente illuminati da lampade a carburo e riscaldati da allegri e
scoppiettanti fuochi, contenuti in enormi e fumosi camini. Tra un assordante cicaleccio dialettale, ci
apparve una moltitudine di strani personaggi che sembravano usciti da un film di Dreyer, questi
stavano seduti attorno a sgangherati tavoli in legno colmi di litri di vino e piatti fumanti di “carne in
tocio”, servita con polenta abbrustolita sulle braci. Il luogo, situato poco lontano da Padova, era
noto attraverso i racconti popolari che lo indicavano come covo di ladri di cavalli. Pare che le
povere bestie fossero macellate di nascosto lungo i fossi, e le carni, oggetto di lucroso
contrabbando, erano messe ad affumicare all’interno delle cappe dei camini, in ossequio ad una
probabile consuetudine locale, sviluppatasi durante la carestia provocata dalla guerra.
In questo ambiente da sabba, tra il fumo e i riflessi rossastri delle braci, prendevano forma nei
drammatici controluce, sanguigne figure; personaggi e maschere che sarebbero state disegnate e
pubblicate a corredo dei testi sul Beolco, che Ludovico Zorzi preparò per le edizioni Randi nel
1953. Riaffiorano ancora i ricordi di un giorno in cui vidi mio padre raggiante ed entusiasta, dopo
un ritiro ad Arquà Petrarca, minuscolo paesino medioevale arroccato sui Colli Euganei, noto sia per
aver dato ospitalità all’omonimo poeta, sia perché era possibile rintracciarvi uno dei dialetti tra i più
puri, meno italianizzato insomma, e più prossimo al pavano antico dei testi ruzantiani. Si trattava di
un seminario sulla lingua pavana, organizzato da De Bosio, in vista di una serie di recite a tema con
gli attori del Teatro dell’Università.
8
Come ogni bella fiaba, anche questa ebbe un termine. Le prime avvisaglie di una crisi che stava
attanagliando il Teatro universitario, fecero avvicinare Giorgio Strehler, che già da qualche anno
guidava con successo il Piccolo Teatro di Milano, assieme a Paolo Grassi. Il Teatro dell’Università
chiuse i battenti per sopraggiunte difficoltà economiche, nonostante la fama raggiunta e
l’interessamento di intellettuali e uomini di cultura: «Siamo riusciti a resistere per soli quattro anni
fino a che non ci hanno tagliato le gambe con il rifiuto dell’Università e del Comune di Padova di
continuare a sovvenzionare un teatro scomodo».4 L’esperienza terminò nell’aprile del 1950 con
l’ultima rappresentazione di Se questo è un uomo di Brecht, al Piccolo Teatro di Milano. Fu proprio
al Piccolo in cui tutti gli attori del teatro padovano confluirono, chiamati da Strehler e Grassi, ad
ingrossare le fila di un teatro che cresceva rapidamente e a dismisura. Lo stesso Lecoq fu invitato a
Milano per fondare la scuola del Piccolo Teatro.
Anche Strehler fu contagiato dalla presenza della maschera nel teatro fra le due guerre, tant’è vero
che fu coinvolto in questa avventura proprio da Etienne Decroux, invitato in quegli anni a Milano
per un ciclo di lezioni al Piccolo: «Tutto il teatro di poi è stato segnato dall’esperienza-predicazione
di Decroux».5
Il Piccolo Teatro di Strehler. Il primo incontro tra Amleto Sartori e Giorgio Strehler avvenne alla
fine del 1951 «in un giorno di sole all’ombra delle pietre» in un caffè prospiciente il Teatro
Olimpico di Vicenza, dove il Piccolo metteva in scena l’Elettra di Sofocle con la regia di Strehler e
le coreografie di Lecoq. Erano presenti, oltre a Strehler, anche Marcello Moretti e Lecoq. Il Piccolo
Teatro aveva già presentato nel 1947 il noto Servitore di due padroni di Goldoni. In quell’edizione
Pantalone, Brighella e Dottore portavano delle maschere orribili, a detta dello stesso Strehler,
mentre Arlecchino, interpretato dal geniale Moretti, utilizzava un trucco nero che, riproducendo i
tratti di una maschera, ne creava l’illusione. La scintilla era scoccata; da lì a breve ecco Giorgio
Strehler a Padova, in visita agli attori del teatro dell’Università, soprattutto per conoscere da vicino
l’artefice delle maschere di cui tanto si parlava nel mondo del teatro del dopoguerra: «so soltanto
che un certo giorno ci ritrovammo nel suo studio a Padova a parlare di teatro e della maschera a
teatro». Tra le tante, ammonticchiate sui banconi da lavoro, fu attratto e affascinato dagli studi
grafici e plastici che Amleto, aveva prodotto durante le approfondite ricerche sulla maschera neutra.
«Forse, disse Amleto, è la cosa più difficile che ho fatto; [...] questa maschera noi l’adoperammo
per anni, e proprio con questa una sera Etienne Decroux ci mostrò per la prima ed ultima volta, la
“levitazione” di un corpo umano. Veramente, per un attimo, Decroux, con la maschera neutra di
4
Da un’intervista rilasciata da Gianfranco De Bosio, Verona 30 dicembre 1997.
G. Strehler, Il mestiere della poesia, in Arte della Maschera nella Commedia dell’Arte di D. Sartori e B. Lanata, Casa
Usher, 1984, p. 171.
5
9
Sartori ed anche grazie ad una perfetta coordinazione di ogni ganglio nervoso ed ogni fascio
muscolare del suo corpo e con una concentrazione così assoluta da mettere quasi paura, restò
davanti a noi spettatori attoniti, “sospeso nello spazio” immobile. Attimo che ci sembrò eterno».6
Galeotta fu la visita di Strehler a Padova. Sartori gli propose con intraprendenza di studiare e
realizzare le maschere come erano state concepite nella tradizione della Commedia dell’Arte. Sino
ad allora Amleto non aveva mai sperimentato il cuoio ma, da artista eclettico e curioso qual era,
sotto la spinta della necessità, iniziò con il valido aiuto della moglie Miranda a consultare testi e
volumi antichi, conservati nelle principali biblioteche europe: la Marciana di Venezia, la collezione
Burcardo di Roma, gli sterminati archivi della Nationale e dell’Arsenal di Parigi. Scoprì che nel
Musée dell’Opera esistevano alcune matrici in legno per maschere in cuoio e a Venezia degli
stampi in piombo par mascare, di cui nessuno conosceva l’uso e le tecniche.
Si recò, quindi, nella Basilica di Santa Giustina a Padova, dove conobbe un priore esperto di
tecniche del restauro degli antichi volumi rilegati in cuoio e pergamena, venendo a conoscenza dei
segreti della lavorazione della pelle animale conciata. Scolpì la sua prima matrice in legno di
cirmolo,7 sulla scorta dei modelli osservati a Parigi; la ricoprì con un cuoio di capra umido e sottile.
Man mano che la superficie si asciugava Amleto, comprimeva il cuoio sul legno attraverso la
battitura di un martello di corno e lo levigava con stecchette di bosso lucido che aveva costruito da
sé. Così venne alla luce la prima maschera in cuoio.
Al Piccolo si provava in quel tempo L’Amante militare di Goldoni, il cui Arlecchino era interpretato
da Marcello Moretti; Strehler convocò Sartori per studiare le maschere per gli attori. Ero al seguito
di mio padre che si recava a Milano, sempre più frequentemente, a portare le maschere che
inventava, produceva e sperimentava in un clima di furore creativo quale non avevo visto mai
prima, durante la mia adolescenza.
Per me era un fatto di ordinaria amministrazione stare in mezzo alle maschere. Il ricordo più
pregnante riguardò la scena, tanto movimentata quanto divertente, tra mio padre e Marcello Moretti,
che provava in palcoscenico un ennesimo, pericoloso salto acrobatico. Mio padre stava in platea:
seguiva la recitazione, prendeva appunti e schizzava bozze. Marcello sentiva la concentrazione
soffocata della strettezza che la maschera lasciava agli occhi; dava continuamente in scatti per
vedere dove sarebbe finito, come poteva muoversi. Non era per nulla a suo agio. Si spazientì, senza
dir nulla levò la maschera, allargò i buchi degli occhi, usando un paio di grosse forbici ch’erano in
scena. Rimise la maschera e stava tranquillamente riprendendo le prove per il salto, se non fosse
stato per mio padre che, rimasto incredulo a seguire tutta la scena senza saper parlare, gettò un urlo
6
7
G. Strehler, In margine al diario, “Quaderni del Piccolo Teatro di Milano”, n. 4, 1962, pp. 59-61.
Cirmolo è termine dialettale veneto che identifica il Pinus Cembra, conifera usata per l’intaglio in tutte le zone alpine.
10
smisurato, dandogli del pazzo. Presero ad insultarsi con furore, a stento tenuti lontani; molto più
tardi, calmati dallo stesso Strehler, trovarono uno sbocco pacifico al loro contrasto.
Dopo questo episodio si saldò una grande amicizia tra lo scultore e l’attore, che terminò solo con la
morte di entrambi. L’artista padovano predispose alcune maschere che si adattavano potenzialmente
allo spirito dell’Arlecchino-Moretti: una tipo toro, una tipo gatto e l’ultima tipo volpe. Sartori,
infatti, accentuava certi caratteri animaleschi, rintracciabili nella maschera dello Zanni e offriva con
le sue variazioni una scelta all’attore, che in quel momento rifiutava ancora la maschera, perché gli
faceva paura.
L’arte di un padre-maestro. Era quello il tempo in cui mio padre di notte, pervaso dallo slancio
creativo, intagliava nel legno di cirmolo, resinoso e profumato, visi e caratteri ora duri e decisi, ora
torbidi e flaccidi, ispirati alle maschere giapponesi in legno cavo, viste in uno spettacolo di teatro
Nô di una famosa compagnia di Tokyo, giunta in tournée in Italia. Era rimasto talmente
impressionato dalla bellezza e dalla perfezione delle loro meravigliose maschere che si spinse anche
nello studio e nella sperimentazione delle ricette segrete della lacca giapponese, tanto da realizzarne
alcune con risultati straordinari. Frequentavo, giovanissimo, il laboratorio sotto la guida di un
padre-maestro che, a volte burbero e a volte bonario, mi rivelava, centellinandoli, i trucchi del
mestiere, ricreando ciò che in un lontano passato doveva essere il sistema di apprendimento nelle
botteghe d’arte. Apprendevo giocando, le tecniche dei lucignoli di creta nel modellare i volti e le
figure plastiche in terracotta o ceramica. Spesso accompagnavo mio padre a Venezia, presso la
vetusta fonderia del signor Bianchi nei pressi dell’Accademia, un arzillo vecchietto che viveva da
sempre tra gli artisti, prestando la sua abile e preziosa opera di fonditore di bronzo.
Ho ancora nelle narici l’odore acre della cera perduta, bruciata, negli occhi il riverbero accecante
del bronzo fuso, colato negli stampi conficcati tra la sabbia. Sento ancora la tensione dell’attesa di
quando si spaccava il negativo per scoprire, quasi fosse un reperto archeologico, la forma sepolta
che svelava gradualmente l’espressione di un volto. Maschere realizzate con altri materiali, ora
ricavate dall’intaglio del legno, ora plasmate nel cuoio, ora scavate nella pietra, si accumulavano in
tanti anni di lavoro e di esperienza. La fama delle nuove maschere in cuoio di Amleto,
meticolosamente riesumate da un passato plurisecolare, era tale che gli attori, i registi e gli uomini
di teatro europeo, prima o poi, si rivolgevano a lui per saggiare uno strumento rinato dalle antiche
tradizioni. E furono anni di febbrile ricerca e fervida creatività per cercare nuovi volti da dare ai
personaggi per le più disparate produzioni teatrali. Rammento Orazio Costa, considerato il
continuatore italiano della scuola di Copeau, che si cimentò con le maschere di Amleto per La
11
famiglia dell’antiquario di Goldoni nel 1955 e, successivamente, con le maschere policrome di
vago aspetto cubista per La favola del figlio cambiato di Pirandello.
Ebbi modo, di incontrare negli anni Costa, poco prima della sua morte; durante un colloquio venni a
conoscenza di alcuni retroscena, a proposito delle volontà e delle indicazioni di Pirandello a
proposito delle maschere per le sue opere. Ricordo le orripilanti maschere di megere, streghe e
spiriti diabolici dell’Angelo di fuoco di Prokofiev, diretto da Strehler, in occasione della Biennale di
Venezia del 1956 (che furono per me una delle fonti di ispirazione per la recente ricerca sulle
maschere medioevali nordiche del World Theatre Project in Svezia). Maschere create non solo per
testi teatrali, ma anche per opere cantate, come l’Orfeo di Monteverdi alla Scala di Milano, con la
regia di Bacchelli, o per quello di Gluck con la regia di Walmann al Teatro Massimo di Palermo,
nello stesso anno. Mio padre insegnava, fin da giovane, scultura presso la Scuola d’Arte “Pietro
Selvatico” di Padova. Lasciò il posto vacante a causa della malattia che l’avrebbe condotto a morte.
Dopo qualche anno venni nominato docente nello stesso Istituto occupando il posto che fu il suo;
aggirandomi con nostalgia negli stessi luoghi, nella stessa aula, fra gli allievi che sembravano gli
stessi di allora, mi sovvenne l’incontro di mio padre con il grande vecchio, o almeno tale mi parve
visto con gli occhi di allora, Cesco Baseggio. L’attore, con un’entrata a dir poco plateale, attorniato
dai suoi efebici discepoli, si assise su una antica poltrona da barbiere che troneggiava al centro dello
studio. Era venuto per discutere su di un personaggio da commedia che doveva interpretare a
Venezia da lì a poco (1959) e che doveva essere, se ben ricordo, il Pantalone per il Bugiardo di
Goldoni, con la regia di Carlo Ludovici. Baseggio soffriva da tempo di una noiosa asma che gli
rendeva difficile il respiro sotto la maschera; e fu in tale occasione che ebbi l’opportunità di
apprezzare la genialità di mio padre nell’affrontare con versatilità, oltre che il problema tipologicomorfologico del personaggio, anche i problemi tecnici ad esso legati.
Modellò lì per lì un volto di vecchio, arcigno e avaro, con il naso tipicamente ebraico, quale doveva
essere caratteristico dei mercanti ebrei della Serenissima, visti con gli occhi della satira sociale dei
componenti delle compagnie dell’Improvvisa. La peculiarità che la maschera andava assumendo era
quella di un volto caratterizzato da un grande naso adunco, che copriva la parte alta della faccia
dell’attore, lasciando completamente scoperte le cavità delle narici e permettendo così all’interprete
una respirazione e una dizione perfetta. Baseggio volle vedere e toccare anche le maschere di
Ruzante, che erano in lavorazione sui banchi, rammaricandosi di non averle potute usare nella sua
grande interpretazione veneziana del Parlamento del 1954. Con la tipica espressione tra il beffardo
e il faceto, vedevo che mio padre non era d’accordo; da buon conoscitore sia delle opere che della
biografia del Beolco, reputava che l’interpretazione di Ruzante ad opera di Baseggio, fosse troppo
senile, lontana dalla tipologia del personaggio-attore cinquecentesco.
12
Lo studio e l’individuazione dei tipi e caratteri popolari della campagna veneta coinvolse e trascinò
Amleto per lunghi anni plasmando, scolpendo, ma soprattutto disegnando figure a gouache e
sanguigne, chine e pastelli, oppure nella realizzazione di grandi tavole che dipingeva con diverse
tecniche pittoriche. Fu a proposito delle maschere per la commedia L’anima buona di Sezuan messa
in scena al Piccolo Teatro di Milano nel 1958, che mio padre incontrò Bertolt Brecht, ospite di
Paolo Grassi e di Giorgio Strehler. Da quel momento gli si aprì il mondo nordico del teatro tedesco
e, qualche anno più tardi, lo studio Werner Dau Produktion di Potsdam gli commissionò una serie
di maschere in cuoio per un film ispirato a personaggi ruzantiani, Italienischen Capriccio, con la
regia di Glauco Pellegrini.
La figura di Beolco era ormai talmente insita nella fantasia dello scultore, che la sua ricerca sul
ritratto e sulla figura del commediografo pavano fu premiata con la committenza di una statua in
pietra di Nanto (o pietra di Vicenza, con cui furono scolpite le statue degli insigni padovani poste
attorno alla canaletta del Prato della Valle). La statua, offerta dal Lions Club di Padova, doveva
essere posta su uno dei due basamenti a guardia del Ponte Nord del Prà, ma per alterne vicende,
prettamente “padovane”, storie di vecchi rancori e di invidie corporative, gli artisti della città
premettero presso le pubbliche istituzioni affinché il fatto non avvenisse; la statua fu eretta alla
soglia degli anni ’60 all’interno dei giardini Morgagni, nei pressi dell’Ospedale vecchio di Padova.8
Nel 1961 il male stava oramai minando, nonostante la fibra eccezionale, i polmoni di Amleto che
con enorme sforzo riuscì a progettare e a completare per il teatro del Brecht-Ensemble a Essen
disegni, maschere e costumi per il Parlamento del Beolco con la regia di Palitzsch, e per la messa in
scena teatrale di Von Bergamo bis Morgen früh di Walmann, alla Landesbühne di Hannover, con la
regia di Reinhold Rüdiger.
Il passaggio del testimone. Furono fatali mesi di sofferenza. Amleto scolpì le ultime maschere per
l’Augellin belverde di Carlo Gozzi, per la messinscena di Giovanni Poli. Venne il momento in cui
mi resi conto che dovevo togliergli dalla mano ancora vigorosa (morì a soli 46 anni) il testimone.
Per me fu un periodo drammatico per il passaggio dal ruolo di figlio-allievo a quello di
responsabile-guida, con il compito di consegnare alla storia una ricerca ed un’arte frutto della
travagliata vita di un uomo che, tra le due guerre, era riuscito a realizzare un sogno, quello di
restituire al mondo contemporaneo la maschera, simbolo di un teatro che si riteneva scomparso.
8
Molto tempo dopo, nel 1992, la scultura, lesionata dal tempo e dalla mano di balordi, fu restaurata con cura filiale da
me e dai miei collaboratori del Centro Maschere e Strutture Gestuali presso la vecchia sede, sita in un’antica villa
veneta del XVIII secolo nei pressi di Padova. La statua del Ruzante è posta ora in Piazzetta Garzeria, all’ombra
dell’orologio Dondi, a ridosso della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Padova.
13
La mansione mi travolse; in un turbinio di attività, lavoro e impegni non mi permisero alcun tempo
da dedicare a riflessioni di sorta: le pressioni da parte di Eduardo De Filippo per lo studio e la
realizzazione di una nuova maschera per Il figlio di Pulcinella, le maschere per un’opera di Gozzi
diretta da Giovanni Poli, in scena a Venezia e portata poi a New York, la necessità di concludere
una quantità di sculture non finite, dipinti murali e graffiti iniziati, e altre maschere, tra le quali
quelle per il Galileo di Brecht che, nel 1963, mi permisero all’interno del Piccolo Teatro di
collaudare con tecniche personali nuove espressioni artistiche. L’anno seguente fu la volta del
Gioco dei potenti dello stesso autore, grande avventura teatrale di Strehler.
Viaggi, ancora viaggi, soprattutto a Parigi per incontri, riflessioni e progetti con Lecoq, Jean Vilar,
Barrault. Attraverso le lezioni di Decroux, che conobbi per la prima volta, presso la sua scuola
parigina, ebbi la sensazione che si ponesse in una antitesi al discorso di Lecoq; mi sembrò
d’avvertire un’aura di puro estetismo, teso ad elevare il ruolo del corpo e del gesto verso una
dimensione mistica. Un incontro storico, che rimarrà per sempre impresso nella mia memoria, è
quello con il vecchio drammaturgo francese Leon Chancerel, che sul letto di morte non mi lesinò i
racconti, gli aneddoti e le avventure di teatro d’inizio secolo con i più grandi uomini di cultura della
nostra epoca, Copeau, Jouvet, Miklaševskij e altri ancora.
Le richieste dall’estero di mostre sulle nostre maschere si susseguirono sempre più frequenti;
dedicai, pertanto, un notevole impegno per realizzare le più importanti, come quella itinerante negli
USA, prodotta dalla New York Library, o come la successiva dell’Istituto Italiano di Cultura di
Melbourne, che si protrasse per anni nelle più importanti città australiane, e molte altre sia in Italia
che in Europa. Contemporaneamente mi riproposi di conseguire la laurea in Architettura a Venezia,
facoltà da tempo intrapresa, ma interrotta a causa della malattia di mio padre. Furono anni di
fermento studentesco e di maturazione politica sotto la guida di maestri come Bruno Zevi, architetto
e illuminato storico, che seppe trasmettere a noi discepoli la corretta coscienza politica e sociale del
tempo. Avvisaglie, fermenti, inquietudini della classe studentesca preludevano al Sessantotto che di
lì a poco avrebbe prodotto un terremoto negli ambiti della cultura e dell’arte e, successivamente,
nella società civile.
Creare le forme. Trascorrevo lunghi periodi a Parigi, dove sentivo i fermenti più intensi di quelli
familiari, che ritenevo grevi e arretrati. Furono i tempi delle maschere per i teatri francesi; conservo
una memoria vivida dell’esaltante collaborazione con la Comédie Française nel 1967, per l’Etourdi
di Molière. Frequentai anche gli studi di artisti dell’avanguardia parigina, le mostre del Palais
Royal, le lezioni di Lecoq all’Ecole Supérieure des Beaux-Arts, nell’aula adiacente a quella in cui
insegnava lo scultore Cesare Baldaccini, meglio conosciuto sotto lo pseudonimo di César.
14
Il classico colpo di fulmine, che dette nuova svolta alla mia ricerca plastica fu proprio l’incontro
con una nuova corrente, ideata e coordinata dal critico Pierre Restany, il Nouveau Realisme, che
radunò artisti che ben presto divennero personalità di spicco nel periodo del ’68: oltre allo stesso
César, ne facevano parte Christo, Arman, Tinguely, Yves Klein ed altri.
Nel mese di maggio, un clima di tensione rivoluzionaria veniva crescendo tra giovani, studenti e
operai, sulla scorta dell’analoga spinta proveniente oltreoceano, più esattamente dall’Università di
Berkeley in California. Malumori studenteschi nei confronti della guerra del Vietnam, dettero
origine a un’onda reattiva di radicale cambiamento che, coinvolgendo scibili culturali e ambiti
sociali e politici, si accinse a sbarcare in Europa, dove trovò linfa e alimento da motivazioni ed
ideologie forse differenti, ma identiche nelle istanze.
In questo periodo mi dedicai ai grandi viaggi che mi consentirono di aprire vasti orizzonti culturali;
uno tra questi, mi vide nel ruolo di disegnatore (qualora le foto non fossero permesse), componente
di una spedizione che si recava in Asia per realizzare un servizio etno-fotografico presso le
popolazioni nomadi iraniane. Furono sei mesi di spostamenti in fuoristrada dall’Italia, attraverso la
Turchia, tra piste sconnesse e desertiche, fino ai passi di montagna abitati solo da lupi e aquile, alla
ricerca delle tribù nomadi, dalle sterminate pianure del Golfo Persico agli altopiani dei massicci
centrali. Qui scoprii nuovi forme di mascherature tribali che, esulando dal mondo della festa e del
teatro, riguardavano sistemi sociali e religiosi molto al di fuori e al di là degli usuali limiti
occidentali.
Nello stesso tempo, le immagini del terribile e, insieme, esaltante maggio francese s’insinuarono e
si radicarono tanto in me da produrre una forte mutazione, una forzata maturazione d’identità, non
solo politica, ma soprattutto artistica. A Parigi partecipai a sfilate tumultuose con gli amici
dell’Ecole de Beaux Arts e mi trovai coinvolto in brutali repressioni della polizia nel quartiere
latino. Conobbi le atrocità spaventose prodotte sui corpi di giovani che erano sospinti verso gli
angoli degli edifici e sottoposti ai colpi delle famigerate lance smussate dei flics parigini, che senza
provocare lacerazioni esterne ledevano, a volte in maniera seria, gli organi interni. Vidi molti dei
ragazzi feriti, rantolanti, caricati brutalmente sui cellulari e portati chissà dove. Seppi più tardi che
alcuni di loro furono trovati a centinaia di chilometri di distanza, esanimi, nel fosso a fianco di
strade di grande viabilità, quali corpi travolti da improbabili pirati della strada.
Il turbamento fu tale che decisi di tralasciare l’orientamento artistico sin qui seguito e mi proposi di
rivedere e modificare il concetto di creare delle forme estetiche ed oggettuali fini a se stesse. Presi a
sperimentare con nuova energia forme e tecniche diverse, abbandonai la modellazione figurativa
della creta, atta alla riproduzione di calchi in gesso, fusioni in bronzo, terrecotte o altro per
proiettarmi verso la creazione diretta e definitiva delle sculture in metallo. Passai un lungo periodo
15
presso diverse officine metalmeccaniche e cercai l’aiuto di amici e tecnici che mi insegnassero tutti
i segreti della saldatura autogena e ossiacetilenica, dall’ossitaglio all’uso della forgia e del maglio
meccanico. Colmo d’entusiasmo per la scoperta di tecniche nuove, presi a realizzare piccole e
grandi forme sulla scorta dei suggerimenti parigini; uscirono dalla fiamma ossidrica quei corpi
straziati, ancora impressi nella mente, lacerati dalla violenza repressiva che sostituiva il dialogo e il
rapporto umano. Forme biomorfe di carapaci vuoti, di animali legati dai nodi di una civiltà violenta
e oppressiva. Smaglianti torsi militari che ostentavano lustre corazze metalliche lasciando trasparire
all’interno un magma marcio e purulento. Attesi alla realizzazione di grandi volumi che ricordavano
forme organiche tendenti, quasi per congiunzione osmotica, ad equiparare l’animale al vegetale e al
minerale, dall’esteriorità appariscente e splendida, ma dalle viscere orride e putride.
Questo linguaggio di reazione e di rabbia assumeva sempre più un’identità ed un significato plastico
inquietante, proprio di quell’emblematico momento storico vissuto. Per anni proseguii la ricerca sui
metalli e sulle metodologie da applicare per riuscire a domarli e plasmarli a mio piacimento, mi
dedicai alla chimica con la straordinaria collaborazione di un amico inventore di rara fantasia, Gigi
Villani, per dotare le nuove statue di suggerimenti cromatici nuovi, completando così il significato
che volevo attribuire loro. I primi anni ’70 furono dedicati a tutto questo, al modo di comunicare un
messaggio al pubblico, soprattutto ai giovani miei coetanei, che vivevano un momento sociale e
politico estremamente complesso e difficile.
Dapprima le mostre della nuova scultura si susseguirono con personali presso importanti gallerie di
tendenza, come i Volsci di Roma, la Diarcon di Milano, la Triade di Torino, il Traghetto di Venezia
e molte altre; contemporaneamente, giunsero inviti di partecipazione a prestigiose manifestazioni
internazionali quali la Triennale di Milano, il Salon de la Jeune Sculpture a Parigi, l’Arte Fiera di
Bologna, la Biennale dei metalli di Gubbio e molte altre ancora. In queste occasioni venni a contatto
con prestigiosi critici che mi aiutarono a orientare e definire meglio il mio cammino e la mia
ricerca. Le mie sculture creavano disagio, tensione, riflessione; spesso durante le esposizioni si
creavano dei momenti di intense discussioni, che sovente finivano per scivolare nel sociale o nello
scontro politico. Cercavo di colmare il vuoto che si era venuto a creare durante le mostre d’arte in
genere, presso gallerie, musei e spazi pubblici, ove il pubblico presente ed ansioso di conoscere,
dialogava spesso con l’opera, raramente con il suo creatore. La triangolazione fruitore + opera +
artista mancava, quasi sempre, del segmento che avrebbe dovuto collegare l’artista con il pubblico.
Verso la metà degli anni ’70, le tensioni in Italia si fecero più pressanti, i malumori sociali e
l’aggressività tra le diverse fazioni politiche crebbero a dismisura, fino a raggiungere talvolta stati
di guerriglia urbana. Insegnavo arte e la scuola pubblica ribolliva di fermenti e disordini, ricordo
ancora l’eccitazione nel suggerire agli allievi di esprimere le loro emozioni attraverso la creatività,
16
usando un linguaggio comunicativo non solamente verbale, ma anche attraverso l’arte, le forme, i
volumi, i colori, rifiutando la violenza.
Quasi per necessità formammo un gruppo, sorto dalla stessa scuola d’arte, che fece dello slogan
“riappropriamoci della nostra forza creativa” il manifesto di Azionecritica,
9
sodalizio
pluridisciplinare che si proponeva di fare politica attraverso le parole chiave: arte e creatività.
Ricordo momenti intensi di azioni collettive che, pur utilizzando linguaggi universali e materiali
tradizionali, segno, forma, colore, spesso sconfinavano dall’environment all’happening, dall’azione
urbana, all’installazione, al coinvolgimento del pubblico.
Un giorno del 1975 partecipammo ad un evento di quelli che all’epoca venivano definiti alternativi,
l’esposizione collettiva di opere artistiche non già all’interno di luoghi deputati all’arte e alla cultura
quali musei, gallerie bensì in una cava abbandonata dei Colli Euganei. Cavart, come titolava
l’operazione, si fregiava di grandi nomi dell’Architettura impossibile, tra i quali emergeva
Alessandro Mendini con un suo riconoscibile ziggurat di balle di paglia. Azionecritica partecipò
presentando opere di ciascun componente, nell’intento di individuare un gesto critico verso un
evento che esprimeva velleità nuove e d’avanguardia, mentre altro non era se non una collettiva
obsoleta che, al posto di una galleria civica, aveva preferito uno spazio-altro, racchiuso tra le falde
di un monte, tutto scavato all’interno. Mi arrovellavo nel pensare ad un intervento che avrebbe
dovuto amalgamare, unificare in un ambito di ovvietà stereotipata le opere disseminate e sparse
nello spazio a cielo aperto.
L’idea venne alcuni giorni dopo recandomi in treno a Parigi, per allestire una personale negli spazi
dell’American Center for Artists. Mentre osservavo assorto dal finestrino del treno, mi sovvenne
un’idea luminosa nel notare filari di vigne, lungo i lati della ferrovia, avviluppati in una sorta di
serica rete trasparente, che si stendevano per chilometri e chilometri. Al ritorno dalla Francia avevo
aggiunto al mio bagaglio alcuni sacchi di materiale acrilico, prodotto dalla Rhon-Poulenc per
proteggere le vigne dalla grandine. Fu un’apoteosi: in un batter d’occhio tutta la cava fu ricoperta da
un’avviluppante ragnatela che fluttuava al vento e avvolgeva non solo cose, persone, ambiente ma
anche umori, vista la feroce reazione degli artisti. Essi si ritenevano lesi, in quanto si
comprometteva la visuale delle loro opere attraverso l’intrigante reticolo plastico. All’epoca fui
oggetto di velenose frecciate da parte dei media locali, ma niente mi distolse dall’entusiasmo per
aver scoperto un altro straordinario materiale con cui produrre opere e azioni future. Se la
gestazione del gruppo fu breve, lo fu ancor di più la durata, dopo due anni si esaurì l’accordo,
9
Azionecritica nasce nell’inverno del 1975 ad opera di un gruppo di artisti ed intellettuali che operavano con il Liceo
Artistico di Padova. Il nucleo organizzativo di base era formato oltre che da Donato Sartori, il cui atelier costituiva il
riferimento logistico del gruppo, dall’architetto Francesco Pierobon, dal professor Emilio Vesce, dal pittore Renato
Pengo e, più tardi, da Ermanno Chasen, operatore del settore televisivo.
17
frantumato da dissidi interni e dall’allarmante situazione politica di tensione e di stragismo che ci
impedì di proseguire verso intenti comuni.
Il canto del cigno fu la grande performance che organizzammo in simbiosi con l’Odin Teatret,
allora in Italia per una collaborazione con la Biennale di Venezia. Il gruppo danese, diretto dal
regista italiano Eugenio Barba e accompagnato da critici, studiosi e intellettuali,10 fu ospite presso la
mia casa-laboratorio, situata in una ex casa colonica, nei pressi di Padova, a ridosso dei Colli
Euganei, nel comune di Abano Terme.
Le parate itineranti di teatro, danza e musica invasero le vie del centro storico padovano e, per la
prima volta nella mia città, presentai quello che da quel momento prese il nome di mascheramento
urbano attraverso la ragnatela francese e le performance teatrali dell’Odin. Avevo trovato il modo
di realizzare, finalmente, una grande scultura-maschera vivente di durata effimera, ma di grande
impatto ambientale. Il totale capovolgimento dei ruoli dell’arte e del teatro, nel decennio 19701980, aveva coinvolto anche la mia generazione; ci trovammo in molti a seguire il miraggio di
fondere le discipline artistiche che sino a quel momento avevano regolato il corso della società
industriale e post-industriale in Occidente. Lo sconvolgimento che avveniva in quegli anni nel
campo del teatro e delle arti visive, avrebbe certamente aperto la strada all’utopia della
pluridisciplinarietà o della multimedialità.
Si stava compiendo un evento epocale, le tecnologie virtuali stavano divenendo realtà anche nel
mondo dell’arte: elettronica, computer, rete satellitare per le comunicazioni, e finalmente il laser,
che proprio allora passava dal ruolo diafano della mera teoria alla concreta realtà di un utilizzo
pratico. Il ciclo di studi, la frequentazione dei circuiti artistici internazionali, l’attività professionale
ed il ruolo di docente mi avevano introdotto nell’ambito delle arti visive e, come molti, conferivo a
Marcel Duchamp il ruolo fondamentale di padre dell’arte moderna, colui che, per dirla con le parole
di Pierre Restany: «attraversando lo specchio del reale ci ha rivelato il redy-made, l’avvenimento
capitale dell’arte del XX secolo». Mai come in quel momento avvertivo l’importanza di quelle,
apparentemente semplici, operazioni che portavano ad esporre agli occhi stupefatti del pubblico
parigino del 1913 le Pissoir, oppure la Roue de Byciclette.
Con la scoperta del materiale francese avevo rintracciato uno straordinario strumento artistico per
entrare in comunicazione con il pubblico, riuscendo a infrangerne le naturali difese. Avevo notato
che durante gli allestimenti o il montaggio di installazioni nei diversi siti urbani, il pubblico
“riscopriva” l’ambiente in maniera insolita e rimaneva attonito nell’osservarne la nuova apparenza
attraverso un’ottica non consueta rispetto a quella usuale e quotidiana. Era il compimento del
10
Oltre agli attori storici dell’Odin Teatret, Iben Nagel Rasmussen, Torgheir Wethal, Nelse Marie Laukvik, Tage
Larsen e altri ancora, facevano parte del gruppo anche i docenti universitari e i critici teatrali Luciano Mariti,
Ferdinando Taviani e Nicola Savarese.
18
miracolo che Duchamp aveva creato nel lontano 1913, aprendo una strada a miriadi di artisti e
creatori, in cerca di un diverso modo di comunicare l’arte.
Qualche anno dopo Pierre Restany, apostrofò questo stile operativo come “arte sociale”, ove con il
concetto di sociale intese ripercorrere concetti antichissimi come il rito, la festa e la pulsione
collettiva, che emana una celebrazione rituale.
Forme e colori, trance e partecipazione costituiscono quella miscela che permette all’uomo di
estrinsecare la propria energia creativa in una sorta di festosa ebbrezza collettiva, le feste sono
occasioni più o meno spontanee che permettono di esternare una volontà di comunicazione
attraverso la liberazione dei sensi e nella trasgressione del quotidiano. Nel mondo occidentale se ne
è perduta ormai la motivazione, sia d’ordine religioso che propiziatorio, i miti sono stati sostituiti da
elementi più consoni alla civiltà contemporanea, più legati al consumo, al rito collettivo determinato
dalla musica, dallo sport, dai movimenti di massa. Lo stimolo a partecipare, benché modificato,
continua comunque ad esistere, è nella natura umana, insito e profondamente radicato nella
collettività.
Uso della luce e delle proiezioni, forme e colori nello spazio, oltre che gestualità, hanno
caratterizzato la ricerca dell’ultimo ventennio nell’ambito delle arti visive e del teatro
d’avanguardia. Non si poteva rimanere esenti da contaminazioni così urgenti e vivide che
pervadevano le nuove generazioni di artisti in un occidente in piena ebollizione politico culturale.
Mi orientai pertanto verso una ricerca pluridisciplinare, spaziando dall’uso delle forme (sculture di
grandi dimensioni) all’utilizzazione di mezzi e strumenti, messi a disposizione dalla moderna
tecnologia (fonti di visualizzazione laser, computer e sonorizzazione elettronica). 11 Dopo un’attenta
analisi dell’ambiente, ricorrendo ad un principio di modificazione dello spazio urbano, conosciuto
già da tempi remoti in molte civiltà, s’interveniva con un progetto di installazione urbana.
Modificazione, questa, che creava un momento non solo di effimera magia architettonica, ma
predisponeva il pubblico alla partecipazione.
“Mascherare”, dunque, una situazione urbana, una strada, un castello, una piazza, fino a stravolgere
completamente la dimensione e l’apparenza primitiva creando una sorta di collegamentoriempimento dello spazio aereo per svelarne un suggestivo fascino metafisico. L’arredo urbano così
predisposto diveniva contenitore ideale di gesti e provocazioni creative che sollecitavano un
pubblico non passivo, invitandolo all’azione ludica; una sorta di grande gioco dai ritmi suggeriti.
Suono e giochi di luce, comportamento e danza, venivano elargiti in modi e metodi, talvolta
suggeriti dall’improvvisazione, creando un’interazione tra artista e pubblico-massa così a condurlo,
11
Già negli anni 1975 con i componenti del gruppo Azionecritica avevamo iniziato sperimentazioni sonore con Teresa
Rampazzi, nota compositrice di musica concreta ed elettronica e collaboratrice di Luigi Nono. Successivamente
proseguimmo le sperimentazioni al Centro di Fonologia Computazionale dell’Università di Padova.
19
quale parte attiva, a “consumare” l’opera d’arte di storica memoria. Gesto, immagine e suono sono
gli elementi che ripropongono un uso nuovo dello spazio urbano ad un pubblico che diventa attore
in un’azione collettiva che per un momento potrà restituire il rito tribale, la danza e il gioco di cui
si è perso, per troppo tempo, il significato.
Le strutture gestuali e il mascheramento urbano. Mentre si acuiva la frattura tra i componenti del
gruppo Azionecritica, la collaborazione con l’Odin Teatret proseguì ancora, fino a quando fui
convocato dall’emergente Centro per la sperimentazione e la ricerca teatrale di Pontedera (1976),
che ebbe l’idea di avocare a sé gli impulsi stranieri che sconvolgevano il mondo culturale di quegli
anni. Fu in quella fatidica atmosfera da “carbonari dell’avanguardia teatrale” che ebbi modo di
conoscere e frequentare personaggi che reputavo, fino allora, mitici e intoccabili, scrutabili solo
attraverso le pubblicazioni o i notiziari dei media internazionali. Oltre all’Odin Teatret di Olstebro
conobbi Peter Schuman, creatore del mitico teatro americano del Bread and Puppet, con cui da
sempre ebbi divergenze di opinioni a proposito di maschere, di tecniche e orientamenti artistici, ma
che pure mi riconosceva grande professionalità. E ancora, la collaborazione con il Living Theatre
di Julian Beck e Judith Malina, che allora aveva posto radici in Italia, poiché non gradito negli USA
a causa delle proprie idee politiche; poi, Jerzy Grotowski, grande guru teatrale polacco di nascita,
ma di antiche estrazioni indiane, per quanto riguarda la ricerca sul teatro d’avanguardia; e altri che
di lì a poco avrebbero segnato con la loro presenza il “palcoscenico” del nuovo teatro occidentale.12
Ebbi modo di conoscere e divenire amico anche di importanti personalità del teatro orientale: Hideo
Kanze, ultimo rampollo della più antica famiglia d’arte giapponese del teatro Nô; Krishna
Nanboudiri, riconosciuto Bramino del Malabar, danzatore del Katakali, teatro-danza indiano; i
Made Banden, attore danzatore del Topeng, teatro in maschera balinese. Durante anni di fervida
collaborazione, trovai modo di addentrarmi maggiormente nei segreti delle maschere orientali:
questo mi permise, negli anni ottanta, di iniziare una serie di scambi culturali, con cognizione di
causa, proprio con quei luoghi (Giappone, Indonesia, India) in cui le maschere rivestivano ancora
un ruolo primario, non solo nella vita culturale, ma anche in quella rituale, religiosa e sociale.
La lunga collaborazione con il centro di Pontedera avviò altre attività che mi permisero di compiere
estenuanti tournée attorno al mondo portando con me, allo scopo di divulgarle, sia le esperienze
sulle maschere tradizionali, dalla Commedia dell’Arte al teatro del Novecento, sia quelle innovative
e pluridisciplinari della maschera totale o struttura gestuale, sia quelle del mascheramento urbano.
12
Anni addietro durante una celebre Biennale di Venezia, seguii un seminario di Grotowski realizzato in una delle isole
abbandonate della laguna e fui “testimone” delle cerimonie realizzate nel corso dei progetti pilota dell’evento.
Collaborai successivamente con Riszard Cieslak uno dei maggiori attori del Teatr Laboratorium diretto da Grotowski a
Wroclaw in Polonia ove tenevo un seminario sulle maschere teatrali.
20
Quest’ultime svolsero ben presto un ruolo di primaria importanza nell’attività artistico-culturale del
decennio successivo. Consideravo Lecoq come un fratello maggiore e avevo con lui frequenti
scambi di opinioni, non sempre tranquilli, a proposito di politica, arte e orientamento teatrale.
Qualunque fosse il risultato, tali confronti suscitavano in me ripensamenti, profonde riflessioni che
avevano il potere di modificare decisamente e di correggere la mia linea di ricerca. Nel 1977
assistevo ad una serie di lezioni all’Ecole de Beaux Arts di Parigi, che Jacques teneva sul tema
“architettura del movimento”, in cui si usavano asticelle di legno, cartoni piegati, spaghi e corde per
tracciare i confini nello spazio. Man mano che le strutture prendevano forma, diventavano il
prolungamento e completamento necessario dell’azione gestuale dell’attore per acuire una tensione
espressiva, per rendere drammatica una superficie.
Ad un tratto Jacques mi chiese, provocatoriamente, se avessi mai pensato di utilizzare le mie
sculture in metallo in quella guisa, cercando cioè di renderle vive, adoperandole in un contesto
teatrale, in funzione gestuale. Fu come se avessi ricevuta una scarica elettrica. Certo, non avrei mai
potuto manipolare nell’aria quintali di acciaio, ma avrei potuto dirottare l’attenzione verso una
scultura costituita da materiali differenti, potenzialmente usufruibile anche nello sviluppo del gesto
e del comportamento; non più scultura fissa, dunque, da mostrare in luoghi più o meno deputati
all’arte, ma scultura fruibile, tangibile anche da parte del pubblico. Il concetto di scultura-maschera
che vive all’interno di un rito, di un evento, avrebbe potuto così inserirsi anche in una scultura
oggetto.
L’occasione venne grazie ad un invito della Biennale di Venezia a partecipare ad uno dei progetti
pilota di sperimentazione teatrale, tanto in voga in quegli anni. Decentramento nel territorio fu
chiamata l’operazione e a me fu assegnata Mirano,13 una delle cittadine dell’entroterra veneziano.
L’esperimento culturale avvenne all’interno di un’antica villa veneta, in una nobile casa dogale;
attraverso stimolazioni di vario tipo si trattava d’instillare nei partecipanti la creatività, l’arte e il
teatro, con l’ausilio di un seminario che avrebbe dovuto essere semplicemente di supporto alla
maschera e che diversamente produsse ben altro e ben più che una semplice produzione di
maschere. Gli interlocutori furono scelti tra gli allievi delle scuole disseminate nel circondario,
oppure tra gli operai delle fabbriche del famigerato polo industriale di Marghera, in cui venivano
convogliati a migliaia a manipolare materiali tossici e a inalare esalazioni venefiche. La tensione
politica del momento creava malumori e malcontenti nelle classi più popolari, che si ritenevano
usate e oppresse dalle multinazionali del petrolio. Il clima di reazione era palpabile: barricate nelle
13
Nel quadro dello stesso progetto promosso dalla Biennale di Venezia del 1977, alcune cittadine dell’entroterra furono
assegnate ad noti operatori culturali, quali Giuliano Scabia che operava a Mira con la sua poetica giostra e Dario Fo,
che pur lavorando nei teatri di Venezia e Mestre, frequentemente ci raggiungeva a Mirano per collaborare con il nostro
gruppo.
21
strade, copertoni bruciati, sfilate di cortei vocianti erano all’ordine del giorno, tanto che facevamo
sempre più fatica a raggiungere nei tempi e negli orari programmati, i laboratori designati.
La reazione e la rabbia diventarono i temi creativi da svolgere. Le maschere che emersero dai
laboratori erano drammatiche, non forme teatrali di un passato romantico, ma di vita vissuta. Erano
maschere antigas, maschere di morte, erano coperture e schermi di protezione corporale, erano
toraci intubati, trapassati da canne che inalavano ossigeno vitale, erano torsi contorti dalla
sofferenza e dal dolore: furono questi gli oggetti creati con il nostro aiuto e i nostri suggerimenti,
una drammatica denuncia dello sfruttamento sociale, una presa di coscienza dell’essere esposto al
cancro, all’edema polmonare e a tanti altre malattie professionali. Le emozionanti sculture furono il
segno tangibile dell’emblematica e inquietante attenzione del folto pubblico, accorso sulla piazza
del paese per assistere ad una sorta di saggio-performance conclusivo del seminario-laboratorio.
La ragnatela acrilica, preventivamente stesa, copriva ogni dove, compreso lo spazio aereo
sovrastante la piazza; alla fine della performance la reazione del pubblico fu scatenata, tanto da
assumere l’aspetto di danza catartica collettiva in un’apoteosi di gesti liberatori e scaramantici nel
tentativo di appropriarsi di quel tenue reticolo aereo, fluttuante al vento; ed iniziò un gioco
collettivo tra grida gioiose e risate aperte fino a che, molto più tardi sull’impiantito non rimase che
qualche scampolo della materia. Il resto era stato consumato in una sorta di fruizione completa
dell’opera d’arte da parte di un pubblico vorace che aveva deciso di divenire (finalmente) attore. Le
figure anatomiche in questione erano state, in questo caso, il media-catalizzatore della
partecipazione del pubblico.
Le matrici furono realizzate attraverso calchi di varie parti anatomiche di persone prescelte tra i
molti volontari e poste in un atteggiamento plastico, cristallizzato in un gesto o una postura
preordinata. Sul negativo in gesso venivano stesi strati di cartapesta, oppure celastic (particolare
tessuto plastico simile alla cartapesta) e solo successivamente venne messa a punto una tecnica
particolare che permettesse la realizzazione di un positivo in cuoio. Era nata la prima forma
scultorea utilizzabile, una sorta di figura antropomorfa emblematica, una “novella supermarionetta”
ad uso gestuale o esposta, una sintomatica presenza di azioni e performance urbane. Venne
battezzata struttura gestuale in ricordo di Jacques Lecoq, che per primo mi trasmise le pulsioni per
la sua realizzazione.
Nell’immenso panorama che la cultura umana ci offre a proposito di maschere e mascheramento, vi
sono alcuni esempi di reperti utilizzati in maniera atipica: oggetti che non servono a coprire il
l’intero corpo o una sua parte, ma che a rappresentare una determinata identità, presentati in danze e
riti collettivi, quasi simboli di un determinato status. Presenze dotate di vita a sé, manovrate e
gestite dallo sciamano, fabbro o brujo, quasi questi fosse il servo di scena del Bunranku o del teatro
22
orientale, a disposizione dell’arnese sacro e rituale, per prestargli il movimento e per farlo vivere
attraverso le movenze del donatore. Nella civiltà occidentale solo alcuni mostri sacri dell’arte
contemporanea (Picasso, Mirò, Klee) già dagli inizi del secolo seppero cogliere il messaggio di
questi oggetti d’uso, opere nate per servire, non per assolvere una mera funzione estetica. Le
problematiche sollevate negli anni Sessanta, la messa in discussione dei valori dell’arte, il tentativo
di ridimensionare la funzione della cultura, fecero sì che il teatro e l’arte visiva, la musica e la danza
si mescolassero, grazie anche ad innovatori che crearono un’arte pluridisciplinare e multimediale.
Tale sperimentazione tendeva a rovesciare il ruolo della scultura-oggetto, esposta nelle gallerie e nei
musei, fino a modificarne la funzione, animando sculture viventi in grado di dare stimoli e messaggi
tramite azioni teatrali, gesti della danza, e addirittura della Body Art. Le strutture gestuali sono un
incontro tra la maschera e la scultura contemporanea; la forma plastica perde ogni senso meramente
estetico per assumere un’identità altra, creativa, comunicativa. Sino a quel momento agivo da solo,
coadiuvato talvolta da collaboratori che frequentavano lo studio-laboratorio, talvolta da allievi che
partecipavano ai corsi, lezioni, seminari; mi potevo permettere un’agilità di movimento che mi
conduceva, tra viaggi ed attività, in ogni angolo del mondo.
Quasi tutti gli spostamenti internazionali erano legati alla mia attività professionale. Spesso
accompagnavo e curavo personalmente gli allestimenti di complesse esposizioni sulle maschere di
teatro, create da mio padre e da me. Successivamente le mostre si arricchirono di molti elementi
inerenti la ricerca sull’ambiente, il mascheramento urbano e le nuove sculture-maschere totali o
strutture gestuali. Spesso le grandi esposizioni coincideva con i festival teatrali internazionali, e
sovente venivano completate da workshop affollati da professionisti che gravitavano attorno al
teatro di ricerca: registi, attori, scenografi, artisti delle arti visive, scultori, pittori. Si stava
realizzando concretamente un mio antico progetto, la fusione di due essenze distinte della mia
identità artistica, l’una appartenente all’ambito teatrale, l’altra alla dimensione plastica.
Ricordo che a Bergamo, all’interno dell’Atelier Internazionale del Teatro di Gruppo del 1977
diretto da Eugenio Barba, preferii cercare spazi esterni per esporre le nuove maschere totali e creare
degli ambienti collegati con l’architettura antica della città alta, realizzati con la ragnatela acrilica.
Fu una cornice strabiliante per le decine e decine di performance realizzate da gruppi provenienti da
tutto il mondo, che si esprimevano attraverso il gesto, la danza e il teatro per le vie della città.
L’anno successivo il Ministero del Turismo e Spettacolo, la Regione Toscana e il Centro di
Pontedera organizzarono una vasta tournée in America Latina che avrebbe portato per molti mesi
una grandiosa mostra all’interno di festival teatrali, università, musei e strutture culturali di
Venezuela, Cuba, Messico e Guatemala. In ogni paese furono promossi seminari-laboratorio che si
sarebbero conclusi ciascuno con un evento teatrale o un mascheramento urbano. Ebbi modo, ancor
23
più, d’incontrare straordinarie personalità del teatro internazionale, contatti che si trasformarono
successivamente in amicizie e collaborazioni. Venni a contatto con la Mama di New York Ellen
Steward, ebbi modo di scambiare opinioni sull’arte contemporanea con Tadeus Kantor, presente
all’immenso Festival del Teatro delle Nazioni di Caracas per la prima mondiale di La classe morta.
Con lui mi confrontai a proposito del reciproco lavoro sull’arte pluridisciplinare che, esulando
dall’ambito specifico del teatro, si diramava verso altre discipline creative. Peter Brook venne a
visitarmi presso l’Accademia di Belle Arti dove insegnavo, perché da sempre la maschera lo
affascinava. Laggiù incontrai anche Lecoq; assieme assistemmo al nuovo spettacolo dello
straordinario gruppo di allievi della sua scuola, i Mummenschanz, che erano giunti all’apice di una
straordinaria carriera.
A Cuba, tra un’attività e l’altra, ebbi anche occasione di vedere Arafat, invitato da Castro
all’undicesimo Festival della Gioventù, e scambiai con lui alcune opinioni sui drammatici eventi
politici che funestavano la vita civile italiana. Più tardi, grazie ad un seminario-laboratorio,
realizzato all’Università di Città del Messico, si realizzò un evento spettacolare in una delle più
antiche piazze della città, che sconvolse positivamente l'opinione pubblica per lungo tempo. Il
successo fu tale che venni invitato dall’Università a visitare e a conoscere molti dei luoghi,
all’interno del paese, sconosciuti ai più e consacrati alle maschere.
La conclusione del viaggio mi vide tra le foreste di uno straordinario paese com’è il Guatemala, uno
tra i più vitali paesi per quanto riguarda le antiche tradizioni popolari, che prevedono l’uso di
maschere secolari. La lunga tournée in America, oltre ad aver prodotto in me una serie di emozioni
profonde e di esperienze uniche, mi convinse della necessità di raccogliere sistematicamente
materiali etno-antropologici concernenti la cultura della maschera tribale, rituale e religiosa; da ogni
viaggio ritornavo ricco di straordinari reperti che sempre più si rivelavano eccezionali per il ruolo
privilegiato che andavo assumendo lungo l’attività internazionale. In quei frangenti, mi era possibile
ottenere permessi straordinari, per raggiungere luoghi e siti spesso vietati alla massa: reperti,
maschere, costumi e strumenti che accompagnavano i riti mi venivano donati, oppure ne venivo in
possesso attraverso forme di baratto, più raramente erano acquistati.
La nascita del centro maschere e strutture gestuali. Raccoglievo via via una straordinaria collezione
che ben presto avrebbe formato un ulteriore tassello da aggiungere al patrimonio della maschera. In
quegli anni, le attività erano tali e tante che sovente dovevo eludere gli impegni per mancanza di
tempo; avvertivo, inoltre, sempre più pressante la necessità di condividere la gravosa responsabilità
legata all’insegnamento, all’organizzazione, alla ricerca sistematica. L’occasione si presentò quando
conobbi dei collaboratori che accettarono con entusiasmo di condividere con me le incombenze
24
della nuova struttura emergente; si formò così il primo nucleo che dal 1979 prese il nome di Centro
Maschere e Strutture Gestuali, organismo multiplo che gravita ancora oggi attorno alla dimensione
della maschera, suddiviso in tre filoni fondamentali:
•
la maschera etno-antropologica;
•
la maschera di teatro, dall’antichità sino ai nostri giorni;
•
oltre la maschera.
Quest’ultimo settore insisteva sulle più recenti ricerche pluridisciplinari riguardo il mascheramento
urbano e le strutture gestuali. Il primo ad accettare il ruolo organizzativo e burocratico fu Roberto
Terribile, già reduce da una burrascosa esperienza con il Living Theatre, in qualità di organizzatore
delle tournée italiane del gruppo americano; Terribile presto si defilò, lasciandosi sostituire da Paolo
Trombetta, un giovane scenografo con precedenti esperienze di teatro. Paola Piizzi, un neoarchitetto
fresco di laurea della IUAV di Venezia, s’inserì successivamente nel gruppo, occupando un
importante ruolo progettuale ed organizzativo, che tuttora perdura.
Iniziò faticosamente e tra molte incertezze il lungo percorso che, attraverso peripezie e straordinarie
avventure culturali, ci vede ancora uniti dopo un sodalizio che dura da più di un quarto di secolo.
Per l’intero corso di quell’anno fu un continuo girovagare in Europa tra attività didatticolaboratoriali e allestimenti di mostre sempre più impegnative, tra la produzione di maschere per
nuovi spettacoli teatrali e la progettazione di maschere urbane e spettacoli en plain air.
Spesso i seminari venivano accompagnati dalle collaborazioni più disparate con attori, performers
e artisti visuali; tra essi si rivelò essere un vero talento nell’interpretazione di personaggi della
Commedia dell’Arte l’attore Mario Gonzales, reduce dall’esperienza presso il Théâtre du Soleil
nello spettacolo L’âge d’or, diretto da Arianne Mnouchkine; la collaborazione si protrasse lungo
una serie di attività seminariali a Bruxelles, in Belgio, a Como, un ciclo organizzato dal Piccolo
Teatro di Milano e, più avanti, in Grecia, precisamente nell’isola di Zakintos, dove avemmo la
ventura di contare, sulla partecipazione straordinaria dell’allora Ministro della Cultura, l’attrice
Melina Mercury, che si esibì in interpretazioni di maschere femminili. Dopo una massacrante
tournée nei paesi dell’Est, durante la quale toccammo Bucarest, Varsavia, Praga, Budapest e
Belgrado, l’eco di tali attività giunse in Italia, insinuandosi nei meandri burocratici dell’edizione
1980 della Biennale-Teatro di Venezia. L’allora direttore Maurizio Scaparro, le cui aspirazioni
innovative trasformarono la città in un immenso palcoscenico, mi mandò a chiamare perché
presentassi un progetto coerente con la novità dell’evento. Desiderava far rivivere l’antico carnevale
veneziano, sopito da secoli, per rivestirlo di un carattere oltre che ludico, anche teatrale e culturale.
Quale occasione migliore per sfoderare la nuova maschera per un carnevale che avrebbe aperto una
fase inedita per la città di Venezia?
25
Proposi un progetto che, tenendo conto delle istanze di Scaparro, esulasse dallo specifico teatrale in
cui mi si voleva circoscrivere. Io ed i miei assistenti procedemmo liberamente con il prendere
possesso del teatrino annesso a Palazzo Grassi, sede espositiva delle grandiose mostre veneziane; lo
liberammo delle vecchie poltroncine, aprendo un inconsueto spazio-laboratorio. Assieme allo staff
del Centro di Abano Terme, tenemmo un ciclo d’incontri presso l’Accademia di Belle Arti, con
l’intenzione di selezionare collaboratori tra docenti e allievi. Convocammo dalla Polonia uno dei
gruppi dell’avanguardia musicale l’Osmego Dnia Orkiestra, notato durante le recenti tournée
nell’est dell’Europa, coinvolgemmo un gruppo di teatro di base dell’entroterra veneziano (Teatro
Modo) ed uno di danza moderna (Charà) e cominciammo a lavorare potendo contare sulla presenza
di almeno una sessantina di addetti. L’operazione prese il nome di Ambienteazione, termine che non
lasciava dubbi sulla matrice del progetto; lavorammo giorno e notte per realizzare rilievi
architettonici di zone della città, eseguimmo indagini storiche, procedemmo alla stesura di mappali
per individuare i percorsi più congeniali alle rappresentazioni itineranti.
Il palcoscenico e lo spazio interno furono utilizzati quotidianamente per prove di teatro e danza,
oppure per studiare i metodi più validi per installare la fibra acrilica nei punti più emblematici di
Venezia. Mentre s’avvicinava la data prefissata, cresceva proporzionalmente l’inquietudine causata
dal poco tempo a disposizione per terminare ogni preparativo; negli ultimi quaranta giorni, per
evitare di perdere tempo, il teatro divenne un enorme bivacco. I giorni precedenti al martedì grasso
furono utilizzati dal gruppo per avviluppare calli, piazze, campanili, ponti ed edifici di una fibra
bianca, che assumeva l’aspetto di una ragnatela gigantesca. Lungo il percorso l’invasiva materia
acrilica creava degli spazi adatti ad azioni teatrali e performances, che avevano la funzione
d’inserire l’elemento umano nel quadro dell’opera estetica, facendola vivere attraverso il gesto o la
danza. La mattina del fatidico martedì, la giornata si presentava uggiosa e umida e Piazza San
Marco appariva ai primi frettolosi passanti completamente mutata, mascherata sotto un’enorme
tessitura di fili bianchi, che si stendevano dalla loggia del campanile sino a raggiungere le
Procuratie vecchie e nuove, coprendo il cielo con una cupola aerea, una fluttuante massa ovattata
che si gonfiava sotto la spinta della brezza marina, che ricadeva quando questa cessava, in una sorta
di etereo balletto.
La piazza prese a riempirsi di una rapida folla di curiosi, turisti, partecipanti all’evento artistico che
assistettero per tutto il giorno a intrattenimenti teatrali, artistici e danze predisposte per l’occasione.
Il miracolo avvenne tuttavia a sera, quando una straripante folla gremì la piazza in attesa dell’evento
scatenante che neppure io ed i miei collaboratori avevamo previsto. Sotto i riflettori installati dalla
RAI, al suono struggente degli strumenti musicali usati dal gruppo polacco, avvenne quello che mai
mi sarei aspettato. L’imprevedibile fascino del momento e l’effetto sonoro che si propagava sulla
26
Piazza, seguendo il ritmo che il vento imponeva all’immensa coltre aerea, provocarono tra la folla
l’esplosione di un’energia partecipativa che sino a quel momento era stata latente. Fu così che lo
sterminato pubblico di ottantacinquemila persone prese a giocare con noi, appropriandosi dei fili
che fluttuavano al vento, adoperandoli per un gioco collettivo di decine e decine di migliaia di mani
che si agitavano nell’aria nell’intento di prendere, tirare, dipanare la ragnatela. Si celebrava così il
primo carnevale senza maschere, ma coperto da un immenso unico mascheramento che dette inizio
alla successione infinita dei novelli e redivivi carnevali veneziani.
Se per Venezia, il mascheramento fu l’inizio del moderno carnevale, per il Centro Maschere, in
collaborazione con Ambienteazione, fu l’inizio di una fortunata serie di seminari, performances e
mascheramenti urbani che in alcuni anni di attività toccò altre città: Genova, Trieste, Napoli,
Padova, Milano e, più tardi, Bologna e Firenze. Gli eventi, lungi dall’essere equivalenti a spettacoli
teatrali, sempre uguali a se stessi in ogni tappa delle tournée, richiedevano particolari e specifici
progetti per ciascun sito, verifiche delle istanze sociali, culturali, architettoniche. Fu per questo che
la “spettacolazione” e il mascheramento del Maschio Angioino a Napoli fu completamente
diversificata da quella realizzata a Padova o a Milano, dentro e fuori dal Castello Sforzesco, o da
quella macchinosa realizzata in Piazza della Signoria a Firenze, dove fu necessario utilizzare dei
voluminosi palloni aerostatici, gonfiati a elio, che permisero di costruire una cupola di materiale
effimero, antitetica a quella del Brunelleschi.
Gli anni Ottanta e Novanta registrarono un numero crescente di interventi in Europa, tra esposizioni
costantemente itineranti, attività pedagogiche, installazioni e mascheramenti urbani, richiesti anche
nel resto del mondo, in America latina, negli U.S.A e nel medio ed estremo Oriente. Furono anni
intensi anche per la progettazione e l’allestimento di mostre a tema che attraverso la promozione del
Ministero degli Affari Esteri italiano, nel quadro di scambi culturali tra Italia e i paesi del mondo, ci
portarono in tournée africane (Nigeria, Tanzania, Ghana e Costa d’Avorio) e in altre capitali come
Mosca, Tokyo e Pechino (ove assistemmo alla feroce repressione dei moti studenteschi in piazza
Tien-An-Men), e poi a Houston, negli USA, e reiteratamente a Rio de Janeiro, in Brasile.
Il museo vivente. Introducendoci nel tessuto culturale dei diversi paesi visitati, approfittavamo per
raccogliere materiali, documenti e reperti che sarebbero serviti per un’idea che veniva a prendere
forma con crescente urgenza, la creazione della casa delle maschere, un luogo in cui riporre un
patrimonio di materiali creati e raccolti attorno al mondo, nel corso di tre quarti di secolo, la
maschera, cercata dentro e fuori dal teatro e nei più remoti angoli del pianeta, tra etnie e religioni
differenti. Quello che interessava maggiormente era realizzare un punto di riferimento in Italia, in
Europa, nel mondo che si riferisse in modo esclusivo alla maschera, strumento utile alla
27
comprensione della storia culturale dell’umanità. Quasi tutti i musei di etnologia o etnografia, quelli
di storia e cultura dei popoli, quelli di arti e tradizioni popolari o quelli dedicati all’antropologia
umana contengono un settore più o meno importante riferito alle maschere nei più diversi e specifici
significati, ma nessuno di questi viene dedicato solo ed esclusivamente a questo straordinario
strumento comunicativo.
Il sogno di quegli anni era quello di costituire un luogo ove poter mostrare, e far comprendere il
ruolo, la funzione ed i significati che la maschera ha avuto in ogni dove, in ogni epoca, dai primordi
della civiltà, un luogo di indagine sulla sua comparsa, dal teatro alle arti visive, dalle danze e riti
tribali alle feste popolari, per sconfinare provocatoriamente nel mondo della moda o dei
mascheramenti civili e di protezione, del lavoro o dello sport.
Cercammo e cercammo, io ed i miei collaboratori del Centro Maschere e Strutture Gestuali,
visitammo siti, zone e ambienti, case coloniche, castelli abbandonati e una miriade di ville venete
presenti a profusione nella nostra regione con l’intento di poter trasferire uomini e cose, di creare
una sorta di luogo polivalente che avesse la funzione di scuola e museo dai grandi spazi ove
mostrare, recitare, costruire, abitare e studiare, un luogo ove creare insomma.
L’occasione venne dalla “soffiata” di un amico che ci indicò uno spazio ideale: una grandiosa, villa
veneta del ’700 sita nella pianura tra Padova e Vicenza e lambita da un canale che, un tempo
navigabile, conduceva nobili e prelati a bordo dei burchielli sino alla Serenissima. Disseminati nel
vasto parco attorno alla villa padronale, barchesse e magazzini, per stivare i prodotti della
campagna, vaste stalle e fienili, persino uno squero, antico riparo per le imbarcazioni, infine, un
oratorio. Purtroppo le condizioni degli immobili erano precarie se non addirittura pericolanti, il
parco era divenuto un fitto bosco e gli impianti ed i servizi erano fuori uso. La proprietà degli
immobili spettava a un ente morale e religioso che aveva utilizzato tali spazi negli anni passati per
gestirvi un orfanotrofio; di questo utilizzo rimanevano tracce con i crocefissi ancora appesi alle
pareti, confessionali sfasciati ed inginocchiatoi zoppi. Dopo un lento e lungo processo di ripristino
avviammo i laboratori, trasferimmo gran parte dei reperti nel corpo centrale della villa ove
allestimmo un’essenziale ma rappresentativa esposizione che riguardava i tre filoni fondamentali
della nostra ricerca sistemati in altrettante aree della struttura architettonica.
Inventammo degli spazi teatrali straordinari sia all’interno dei grandi saloni che all’esterno, inseriti
nel verde rigoglioso del ritrovato parco.
Furono anche anni in cui si mise a punto una reticolare attività pedagogica denominata maschera
gesto e narrazione in cui furono inserite poliedriche attività multimediali quali performances
teatrali, artistiche e comportamentali (body-art e simili), sonore e altre inerenti il gesto (danza Buto,
acrobatica, ecc.). Tale attività fu rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, sino alle Università non
28
solo italiane. Furono migliaia gli studenti e i docenti provenienti da ogni città ospitati in villa, negli
ambienti del museo e negli annessi spazi teatrali e virtuali per trascorrere un viaggio attraverso la
maschera, un volo virtuale tra le infinite civiltà delle maschere tribali, rituali ed etniche e della
maschera teatrale presente sui palcoscenici di tutto il mondo e non solo occidentale.
Tutto ciò, comportava naturalmente una considerevole presenza di persone, specialisti, docenti e
tecnici, per non contare l’assidua collaborazione ed il prezioso aiuto da parte di tutto lo staff del
Teatro del Sole di Milano diretto da Serena Sartori, figlia minore di Amleto.
L’immane sforzo fisico ed economico avrebbe dovuto essere premiato più avanti con l’immissione
della scuola laboratorio, museo e teatro in un circuito istituzionale con finanziamenti pubblici
provenienti dalle casse, oltre che ministeriali anche da quelle locali: della Regione e Provincia del
Veneto e del Comune di Padova; tutto ciò avrebbe permesso di proseguire il nostro percorso
pedagogico, culturale e artistico, a detta dei sorridenti e disponibili politici democristiani dell’epoca.
Furono anni di stringente attività internazionale che videro, negli spazi maestosi della villa veneta,
la presenza delle più belle figure del teatro.
Nel quadro del baratto culturale era giunto il momento, dopo aver presenziato per anni ad
importanti eventi, di invitare presso la nostra sede gli ospiti di allora, cosa che fece del paesino di
Arlesega, una piccola capitale del teatro nel Veneto. In una sorta di carosello teatrale si
avvicendarono grandi personalità, come Dario Fo e Franca Rame, Ferruccio Soleri, Jacques Lecoq,
e Yves Lebreton e molti eccellenti rappresentanti del teatro Nô e del Kyogen giapponesi, il Topeng
balinese, il Kuttyattam indiano e altri provenienti dall’Africa, dall’America Latina e dagli USA.
Per quasi un decennio tenemmo duro con le sole forze provenienti dalla nostra frenetica attività
internazionale sempre dalle promesse di interventi istituzionali. Poi la catastrofe. Uno ad uno i
nostri referenti istituzionali furono travolti da squallidi scandali politici, storie di corruzione e di
miserie che crearono il vuoto tra le istituzioni pubbliche italiane. Il desolante panorama istituzionale
travolse senza speranze tutto il mondo politico ed economico, ma chi ci rimise furono soprattutto i
quanti operavano nei settori della cultura. Dopo qualche tempo i cancelli della villa sino allora
sempre aperti al giovane pubblico, rimasero chiusi per sempre.
Gli anni successivi videro il nostro tempo occupato tra la casa laboratorio di Abano Terme, ridente
cittadina termale alle porte di Padova e le lunghe permanenze all’estero, quasi un esilio forzato ove
si era, sempre e comunque, largamente riconosciuti in virtù della nostra longeva attività
professionale. Tra le varie attività emerge il caso di una richiesta da parte di un prestigioso teatro, il
Folkteatern di Gävle in Svezia, diretto da Peter Oskarson, di riesumare dalle profondità di un
lontano passato, le maschere medioevali nordiche, retaggio di una gloriosa epopea vichinga.
29
L’ambizioso progetto World Theatre Project, parte di un ben più vasto programma europeo, si
avvalse di un’entità teatrale svedese che prevede tra le altre strutture logistiche, un attrezzatissimo
studio-laboratorio Maskverkstaden che dirigo da quasi dieci anni e utilizzo con i collaboratori dello
staff nordico come punto di monitoraggio per la ricerca storica, sperimentazione e realizzazione di
sculture, maschere, strumenti ed oggetti impiegati all’interno della complessa struttura teatrale
internazionale. 14
Nello stesso ambito, la recente produzione della complessa trilogia di Eschilo, l’Orestea diretta da
Peter Oskarson, ci ha permesso di effettuare vari viaggi di studio nei siti previsti per la ricerca
storica e la messa in scena dell’opera greca: in India, in Mozambico e in Grecia per conoscere
ambienti, teatri e luoghi religiosi in essa citati. Per mettere a punto le centoquaranta maschere
realizzate con nuove tipologie e tecniche costruttive, sperimentammo approfonditamente l’acustica
prevista per i cori greci, potendo così metterle a confronto con altre, realizzate oltre cinquant’anni fa
da mio padre, con la regia di J.L. Barrault per la medesima tragedia.
Ricerca e riscoperta delle antiche maschere del grande nord Europa. La convocazione, per quanto
deferente, emanava tra le righe quel tono di elegante perentorietà che mi incuriosì non poco.
Suonava pressappoco così: “se il lavoro di ricerca attorno alla maschera teatrale della vostra
famiglia ha permesso la riesumazione o la rinnovazione della maschera della Commedia dell’Arte
vi saremmo grati se voleste affrontare il complesso tema della ben più antica maschera norrena,
scomparsa da almeno un millennio dalle lande culturali del profondo nord europeo”. Il guanto della
sfida era gettato.
Dopo breve tempo mi ritrovai in una sperduta isoletta dell’arcipelago danese a far parte di un
eterogeneo gruppo di ricerca attorno alle radici della mitologia nordica, maschere comprese.
Facevano parte di quel nucleo, registi, attori e danzatori, docenti, studiosi e storici della cultura
scandinava. Quel che più stuzzicava la mia curiosità era la presenza di un folto gruppo di attori,
musici e danzatori provenienti dalle più disparate parti del mondo. Il tema fu Il viaggio; presero
dunque consistenza antiche saghe e credenze nordiche popolate da miti, dei ed eroi in eterno
conflitto tra loro. Ci trascinarono con la fantasia nella la mitologia nordica elargita a profusione
attraverso conferenze, lezioni, proiezioni di fantastiche immagini dell’iconografia runica da parte
dei numerosi storici presenti. Iniziarono subito dopo i laboratori sul tema: quelli di teatro che
cercavano di dar corpo e gesto alle fantasmagoriche figure che oramai aleggiavano, concrete, tra di
14
Il World Theatre Project si avvale della collaborazione di gruppi internazionali: Opera di Pechino di Shangai diretta
da Ma-Ke, Cina, Natana Kairali centro per la danza Kuttyattam e Katakali diretto da Gopal Venu, Kerala, India. Teatro
Avenida, danze di guerra africane, Mozambico Folkteatern di Gävle, Svezia, diretto da Peter Oskarson e il Centro
Maschere e Strutture Gestuali di Abano Terme.
30
noi e quelli delle maschere che faticosamente presero forma nei tratti della creta sotto gli occhi degli
stessi attori che con la loro presenza cercavano di integrarsi sempre più, quasi ad osmosi, nel ruolo
del personaggio da interpretare. Il mio, di ruolo, era quello di condurre il disomogeneo gruppo di
attori, danzatori, musici e quanto altro attraverso tecniche e forme plastiche alla ricerca
fisiognomica delle figure che popolavano il maestoso cupo selvaggio mondo nordico dalle radici
senza fine, in cicli implacabili di distruzione e rinnovamento che esaltavano e travolgevano divinità
maligne e benigne, eroi, elfi, folletti, valchirie, nani, streghe, giganti e coboldi.
Ed ecco apparire l’autoritaria e terrifica immagine di Odino, capo dell’omonima Odinsjagtem, del
suo sfortunato figlio Baldr tradito e ucciso dal lupo Loki, di Thor il dio dal terribile martello. Fu la
volta degli esseri terricoli, fantastici abitatori delle lande scandinave, delle immense foreste, dei
laghi e dei fiumi, acque per la maggior parte del tempo dell’anno gelate e imbiancate da una eterna
coltre nevosa: presero forma dispettosi trolls e gnomi che custodiscono i segreti del bosco, le Vittra,
sorta di maligni spiriti femminili capaci di mutare aspetto e trasformarsi in qualsivoglia essere
vivente, la fantastica Skugs-Rå a metà tra fata e strega con le tette lunghe e i capelli corvini che
cammina a mezz’aria tra i muschi del sottobosco e che seduce gli abitatori (maschi) della foresta,
siano essi coloro che ne traggono beneficio: cacciatori, boscaioli, carbonari o siano quelli che ne
traggono rifugio: briganti, fuggitivi, eremiti e quanti altri nel poliedrico mondo arboricolo possano
esistere. Ma il contatto amoroso della Skugs-Rå produce pazzia e dalla demenza alla morte. Può
avvenire anche il contrario, la nascita di una famiglia felice ed un’esistenza boschiva, incantata,
positiva.
Tra le figure più emblematiche che trasparivano dalle saghe medioevali narrate dagli storici emerse
una presenza diabolica straordinaria, un demone gigantesco, il terrifico condottiero della Wilde Jagd
che cavalcava alla testa dell’orda composta da inferiche anime di morti narrata in una oramai
famosa Mirabilia trascritta dall’amanuense diacono anglo-normanno Orderik Vitale e ambientata
nel 1 gennaio dell’anno del Signore 1091. Familia Herlechini est mormorò l’atterrito astante, il
prete Gauchelin che, secondo la narrazione di Vitale, si trovò proprio nel bel mezzo della caccia
selvaggia, l’esercito dei morti che sfilava dinanzi al suo sguardo attonito. Erano schiere di fanti
gementi, oppressi sotto il peso di pesantissimi fardelli, sterratori che trasportavano decine di barelle
cariche di nani con la testa smisuratamente grande a forma di vaso, etiopi (demoni) neri, che
torturavano assassini morti di recente; e ancora un gran numero di donne discinte che cavalcavano
sedute su delle selle irte di chiodi roventi, monaci e preti guidati da vescovi e abati che
componevano l’esercito degli oscuri cavalieri che cavalcavano enormi destrieri vomitanti fuoco
dalle nari.
31
Era per me la scoperta di un mondo fantastico raccolto e trascritto dai racconti orali della tradizione
popolare dagli amanuensi sparsi, con l’estendersi dei territori cristianizzati, in tutto l’immenso nord
dell’Europa. Nacque infatti la prima Hure, ghigna diabolica di Hellequin, colui che sembra essere
stato il più insigne avo di quell’Arlecchino che calcò le scene rinascimentali del teatro dell’arte
italo-francese e che raggiunse notorietà internazionale in tutto il mondo conosciuto dell’epoca.
Arlecchino psicopompo in grado di trasferirsi senza danno da una parte all’altra della linea di
confine che separa la vita dalla morte, capace di compiere viaggi sciamanici dall’aldiquà all’aldilà,
prese vita attraverso decine di sculture–maschere modellate da me e mosse ed interpretate da quelli
stessi attori che ne seguivano l’invenzione e la costruzione.
Fu l’inizio di un’avventura che durò per quasi un decennio; l’esperienza danese produsse infatti un
positivo riscontro presso le alte sfere del Ministero della Cultura svedese e Peter Oskarson riuscì a
mettere in piedi quell’entità culturale che si chiamò: The World Theatre Project, i cui componenti e
partecipanti giungevano dall’Africa (Teatrodanza del Mozambico), dalla Cina con un intero staff
dell’Opera di Pechino, dall’India con la presenza di danzatori, musici ed attori del Teatro
Kuttyattam del Kerala e naturalmente un folto stuolo di attori, registi e scenografi e quanto altro
provenienti dal Folkteatern di Gävle, cittadina situata a nord della Svezia.
Per lunghi periodi ci trasferivamo in un minuscolo villaggio dell’ Helsingland, regione confinante
con la gelida Lapponia, ove si trovava una estesa struttura isolata, immersa tra i boschi di betulle e
conifere. Una vasta area urbanizzata nella quale erano inglobati: teatri, sale attrezzate per la danza,
straordinarie ed accoglienti casette in legno costruite nel tipico stile nordico che ci fornivano
l’ospitalità, ampi spazi di lavoro, l’accogliente mensa e, con mia grande soddisfazione, venne
approntato un grande atelier allestito su mio progetto costituito da un laboratorio di scultura, una
falegnameria, sale da disegno, vani e attrezzature per colorare, verniciare, dipingere e disegnare,
insomma, creare. Non potevo desiderare di più. Si lavorava su progetto; temi teatrali che
scaturivano dalla storia e dalla cultura nordica medioevale, epoca a cui si facevano risalire le
succitate figure mitologiche che prendevano forma attraverso la fissità della maschera.
I mesi scorrevano in un intenso lavoro di equipe, gli attori spesso venivano in laboratorio a
verificare lo stato di avanzamento delle maschere. Potevo contare su un nutrito staff di laboratorio
composto da artisti provenienti dalle arti visive, scenografi, perfino da attori che volevano imparare
l’arte della maschera. Perfezionammo tecniche scultoree differenti da quelle che avevo portato
dall’Italia, imparai perfino l’arte conciaria, derivata da antiche tecniche vichinghe di lavorazione del
cuoio. Potevo permettermi di consultare degli specialisti e invitarli, ospiti presso di noi per
trasferirci il loro sapere. La Svezia, paese dalle grande risorse boschive e forestali mi affascinava
per il rispetto che dimostravano i suoi abitanti nei confronti della natura; la mia considerazione
32
raggiunse l’apice osservando l’architettura abitativa disseminata in un territorio grande più
dell’Italia ed abitata solamente da meno di una decina di milioni di persone, case, cascine, nuclei
abitativi, villaggi e paesi infatti sono costruiti totalmente in legno secondo antiche regole per
permettere al calore di rimanere entro l’ambiente senza dispersione di sorta. Tronchi ancora
intagliati a mano per raggiungere la perfezione d’incastro, fibre vegetali utilizzate per il coibente
termo-acustico, architetture organiche che si inseriscono perfettamente nella natura facendone
quindi parte integrante erano, ai miei occhi di occidentale frenetico, miracolo di cui credevo non
fosse possibile l’esistenza.
Mi affascinavano soprattutto le tecniche costruttive arcaiche, eppure così moderne, che ancora
permeavano cultura ed ambiente. La tecnica di intaglio che appresi da mio padre si limitava alla
sgorbia, strumento secolare che, soprattutto nell’area alpina, era in uso presso gli scultori e
intagliatori del legno. Questo straordinario strumento, oggi da noi oramai di difficile reperimento,
nei Paesi nordici raggiunge livelli di perfezione mai visti, forme e fogge di straordinaria fantasia ed
efficienza a cui si aggiunge un oggetto ancor più straordinario, l’ascia da intaglio che per forme e
tipologie diverse diviene uno degli strumenti cui scultori, intagliatori, artigiani e molti altri
ricorrono per realizzare le loro opere creative. Asce forgiate nel più resistente degli acciai svedesi,
con tempre regolate e rinvenute per ciascuno degli svariati legni scultorei presenti nelle foreste
nordiche.
Un famoso scultore in legno, Per Nilsson Öst, oramai novantenne un giorno ci fece visita all’atelier.
Io e i miei allievi gli facemmo corona, consci di essere in procinto di assistere ad un evento
straordinario. Dopo un breve preambolo infatti egli cominciò a scolpire un blocco di legno ben
stagionato con una piccola ascia, dalla foggia strana che, a suo dire, era stata forgiata a sua misura
da un famoso fabbro del nord. Fu un evento indimenticabile vedere quel vecchio scultore, oramai
sordo e stanco nel portamento, prendere energia dal contatto con il legno, assumere una postura
oserei dire eroica mentre con colpi precisi percuoteva con la lama il tronco che prendeva forma man
mano che le scaglie di legno saltavano, volando allegre per tutta la stanza. Era una testa che
lentamente appariva, maschile a detta dei baffi che adornavano il labbro superiore, capii dal sorriso
sornione del maestro che stava realizzando il mio ritratto che di li a poco mi regalò.
Fu una lezione di alta tecnica scultorea che segnò profondamente il mio animo e dal quel momento
decisi di ridiventare ancora una volta allievo per apprendere tutti i segreti di quella che per me era
arte sublime. Notai inoltre che molti dei miei allievi portavano il coltello pendente dalla cintola;
curiosità che decisi di appagare informandomi. Scoprii che le meraviglie del profondo nord non
erano ancora finite. La straordinaria produzione di coltelli stava per essermi svelata dai racconti,
dalle testimonianze e dalle visite compiute nei villaggi di mezza Svezia. Il coltello, questo
33
sconosciuto, mi apparve in tutta la sua grandiosità attraverso l’opera di veri e propri artisti della
lama; acciai trattati e forgiati nelle più svariate forme erano lavorati nelle più disparate officine,
perlopiù casalinghe dell’entroterra svedese. Stava trasparendo un mercato del tutto nuovo ai miei
occhi, non ufficiale, solo per raffinati addetti ai lavori ed esperti, ma lungi dal credere che codesti
esperti fossero una rara realtà mi resi conto che i conoscitori ed intenditori di lame erano molti,
moltissimi, addirittura quasi tutti.
Quello che mi provocò maggior stupore fu che i coltelli, tra i più belli che avessi mai visto nei miei
numerosi viaggi attorno al mondo, non si potevano reperire nei negozi, nelle botteghe o presso i
normali mercati bensì presso i canali assolutamente privati, talvolta sotterranei di cui solo gli adepti
ne erano a conoscenza. Venni accompagnato e introdotto anche in questo straordinario ambito e
cominciai la mia ricerca. Acquistai delle meravigliose lame da intaglio, da rifinitura, da scultura
come non avrei mai potuto sognare. Imparai il loro uso ed i segreti inerenti a ciascuna delle forme
in relazione ai vari tipi di essenze lignee, presi l’abitudine, anch’io come loro, di portare al fianco
una lama, quasi a prolungamento e potenziamento degli arti superiori. Tengo a precisare che
perdetti questa consuetudine non appena rientrai in Italia dato l’assai diverso concetto nei confronti
di questo strumento che aleggia presso di noi popoli latini.
Le maschere erano sperimentate dapprima nel teatro, e in base ai risultati, modificate secondo le
istanze e le variabili sceniche. Ne nascevano personaggi che pian piano prendevano una forma
concreta; maschera e attore divenivano corpo unico. Assistei a disperati momenti di crisi da parte
soprattutto, delle attrici che non riuscivano, nonostante reiterate prove, ad integrarsi nel ruolo ( Non
va dimenticato però che nei paesi nordici non esiste una cultura di teatro in maschera). Vi erano
anche momenti commoventi: Amore folle nei confronti di questo viso di legno o di cuoio tanto che
alcuni dormivano con le proprie maschere quasi a voler confondersi corporalmente con esse. D'altra
parte potevano verificarsi rapporti di odio profondo che sovente provocavano violente crisi di
rigetto; non era raro che attori pentiti venissero in laboratorio per chiedere umilmente di riparare i
danni arrecati alla maschera durante raptus di follia. Le prove si succedevano alle prove e lo
straordinario e differente staff lentamente si amalgamava. Gli esercizi di voce e di respirazione
avvenivano di consueto all’alba, spesso all’aperto nella diaccia radura del bosco.
Altre volte erano training di mimo, danza, non di rado di arti marziali che si svolgevano nel vasto
salone delle danze; le maschere apparivano solo in teatro ed era ogni volta un evento quasi mistico.
Ogni qual volta che un attore svolgeva la maschera dal tessuto in cui veniva, religiosamente,
avvolta questa emanava una sorta di potere magnetico e spesso si assisteva alla visione di due esseri
contrapposti, l’attore e la maschera, che si fissavano per lunghissimi minuti, fermi, quasi posseduti
da uno stato di ipnosi reciproca. Poi il miracolo, la fusione di due energie che creava un essere
34
diverso: drammatico o ilare, dio o eroe, che emanava la sua identità nello spazio scenico. Sovente
mi recavo ad assistere alle prove per verificare se il mio personaggio maschera viveva veramente o
se vi era la necessità di ulteriori modifiche e cambiamenti.
Era sempre una scoperta assistere all’interpretazione di Mr. Venu, capo carismatico della
delegazione indiana, attore e danzatore alle prese con un personaggio della mitologia finnica o con
un eroe norreno. Spesso l’interlocutore (teatrale si intende) era una figura fantastica, troll, gnomo, o
folletto che sia interpretata dall’attore cinese Bai-Tao estrapolato a forza dalla sua natura di
interprete dell’opera di Pechino. Anche i suoni avevano un’identità a dir poco multietnica se si
considera che gli strani strumenti ad arco o a vibrazione erano suonati da interpreti orientali mentre
il ritmo era sostenuto da percussionisti africani proveniente dal Mozambico oppure dal Kerala
indiano. Creatività, modalità, sistemi e tecniche diverse anzi addirittura opposte tanto da divenire a
volte stridenti tra loro cominciavano ad amalgamarsi in un'unica forma teatrale. L’integrazione fra
di noi, diversi, appartenenti alle più diverse culture, avvenne progressivamente negli anni, grazie
anche ai numerosi viaggi di studio nelle rispettive aree di pertinenza.
Viaggio in India. Fu la volta della visita in India, presso una comunità religiosa del Teatro-Danza
Kutyattam del Kerala, regione tra le più ortodosse di tutta l’India. Conoscevo bene il paese per
essermi recato reiteratamente per motivi di studio (e perché no anche di svago) ma i riti e le feste
mascherate cui assistei durante quel periodo furono tra i più straordinari dell’esperienza indiana.
Eravamo ospiti a Natana Kairali, scuola di danza della dinastia Chakiyar, il guru dell’estesa
comunità quasi centenario ci elargì una delle più commoventi performance di danza Kutiattam che
mai ebbi la fortuna di assistere. Alla luce della fiamma di lampade rituali alimentate con olio di
palma egli iniziò una sorta di movenza mimata al suono dei tamburi. L’antichissima danza di
attinenza religiosa propria dei sacerdoti dei templi induisti si riferisce agli episodi narrati nei testi
sacri del Ramayana e del Mahabarata.
Dopo il battesimo iniziatico c’immergemmo, ciascuno nel settore di propria competenza, nello
studio dell’arte e della cultura indiana: maschera, danza, mimica e postura, musica e canto. Venni
accettato, in qualità di allievo ben si intende, presso l’atelier di un importante maestro conosciuto in
Kerala come il più rappresentativo maestro di maschere Kutyattam e Krishnanattam ebbi così la
rara opportunità di seguire da vicino la prassi di preparazione degli attori prima di affrontare il rito
vero e proprio dinnanzi al pubblico. Generalmente la vestizione avviene all’imbrunire dopo una
serie di preghiere e di cerimonie di devozione di fronte al fuoco della sacra lampada. Ciascuno degli
attori inizia di fronte ad un piccolo specchio il proprio trucco con lo spalmare con le dita o con
stecchette di bambù lungo le linee prefissate del volto strati di colori ottenuti polverizzando terre
35
policrome, ossidi e minerali impastandoli con olio di cocco; per il nero si utilizza il nerofumo
rimasto sul fondo delle lampade votive, per il bianco polvere di conchiglia. Terminato il maquillage
ci si affida alle cure del maestro di maschere che tenendo fra le gambe incrociate la testa dell’attore
supino appone un impasto di riso, calce e polvere di conchiglia lungo linee e tratti prestabiliti e,
attraverso una serie di cordoli, darà alla maschera un aspetto plastico a spessore.
Questo metodo di mascheramento del volto, messo a punto in secoli di teatro religioso, ha la
funzione di coprire il volto dell’attore con un materiale che si fletta e assecondi il movimento dei
muscoli mimici dando la possibilità alla maschera di accompagnare, evidenziandola, l’espressività
del danzatore. L’effetto definitivo avviene con l’inserimento di forme ritagliate dalle foglie di palma
sui suddetti cordoli in modo da creare le caratteristiche alette o Kuttiyes ai bordi delle guance degli
attori. La vestizione si concluderà con l’apporto di straordinari cappelli, spalline e pettorine
bracciali, cavigliere, sonagli e quanto altro scolpiti in legno dolce, o plasmati nella cartapesta o nel
metallo e finemente decorati. Le vesti larghissime e ornate splendidamente dai più svariati
cromatismi concludono questa operazione che richiede un tempo variante dalle tre alle sei ore prima
dell’entrata in scena tra musiche, salmodie e rullo di tamburi alla luce esclusiva di lampade a olio.
Si compie così la preparazione dell’attore che poco prima di andare in scena inserisce un minuscolo
seme (chundapu) di una pianta simile alla nostra melanzana sotto le palpebre, questo provocherà
una violenta reazione della cornea che verrà iniettata di sangue in breve tempo donando allo
sguardo bagliori sanguigni che con il riverbero del fuoco assumerà l’aspetto terrifico del Dio,
dell’eroe, o dell’essere inferico. Quando gli attori del teatro del mondo erano immersi nei training
quotidiani, in estenuanti prove di teatro , esercizi corporali e vocali , io ne approfittavo per visitare
nella regione i laboratori dei costruttori della maschere per i riti, le danze e le feste del paese.
Non di rado incontrai dei veri e propri artisti, scultori raffinati e , spesso , interpreti essi stessi delle
maschere che il più delle volte rappresentavano personaggi della mitologia orientale, descritta nei
libri sacri. Feci degli straordinari incontri; conobbi ad esempio l’ultimo discendente di una dinastia
di maestri del Tolpava-Coothu teatro d’ombre indiano. Tool significa cuoio, pava pupazzo o
marionetta e coothu rappresentazione. È un genere teatrale che utilizza marionette con i corpi piatti
quasi trasparenti in cuoio grezzo e policromo, snodati nei punti chiave dell’anatomia, (braccia,
gambe, testa, ecc.) e azionati a mano attraverso bacchette di bambù da uno o più manovratori che
contemporaneamente ne forniscono la voce e generano rumori con i piedi.
Anche questo teatro religioso si ispira alle storie narrate nei testi sacri ed è antichissimo, alcuni
studiosi lo fanno risalire al
IX
secolo e altri al
XIII
secolo Il vecchio maestro venuto a conoscenza
dell’imminente costituzione in Italia del museo della maschera intitolato all’opera dei Sartori, volle
donarmi alcune delle preziose figure in cuoio frutto di secoli di tradizione (gli lessi negli occhi quasi
36
un senso di liberazione) con il motivo che non avendo eredi in grado di raccogliere il testimone
della sua casata preferiva porre il suo patrimonio in siti ove sarebbe stato possibile trasmetterne
almeno un messaggio visivo. Provai una stretta al cuore immaginando che l’ultimo rappresentante
di un’illustre stirpe, prossimo alla fine fosse presago dell’imminente scomparsa anche di questa
tradizione secolare, parte integrante dell’immensa cultura della terra indiana.
Visioni africane. Al ritorno nella dimensione silvestre di Helsinghengarden, villaggio culturale che
paternamente tutti ci accoglieva dopo le esperienze straniere, mettemmo in essere gli insegnamenti
tratti dall’ultima immersione culturale in India. Passò il tempo tra meditazione e lavoro e presto fu
la volta di un viaggio in Africa in quel Mozambico allora afflitto da una drammatica inondazione
che pose il paese in un pietoso stato di prostrazione. La verifica delle notizie diffuse dai media
internazionali avvenne sorvolando il territorio con un piccolo aereo delle linee locali che ci
trasferiva dall’opulenta regione sudafricana a Maputo, capitale della devastata area sudafricana.
Vedemmo dall’alto interi territori sotto una coltre d’acqua limacciosa e di fango da cui emergevano
tetti di povere abitazioni in pietra, dacché le numerose capanne ed i villaggi costruiti con rami,
arbusti e fogliame erano, ovviamente, stati spazzati via dalla furia delle acque. Emergevano le
chiome degli alberi ad alto fusto ultimo rifugio, come ci informarono successivamente, della
popolazione raggiunta dalla piene e lasciata a morire di inedia, stenti e fame dalle autorità locali per
carenza di idonei mezzi di soccorso e dall’indifferenza del mondo occidentale che volgeva gli occhi
solo al suono della notizia mediatica.
Nonostante questo drammatico clima la vita continuava; fummo accolti in un isolotto al largo della
costa di fronte al Madagascar ove si notavano meno i danni della tragedia e dove la vita sembrava
proseguire con il ritmo di sempre. Anche qui ci immergemmo in una sorta di aura ove non esisteva
la dimensione del tempo: danze, riti, la presenza di prevalenti sonorità africane (percussioni,
musiche autoctone,) ci avvinsero in ritmi di lavoro che non conoscevano soste. Tralasciando le
straordinarie esperienze delle escursioni presso le tribù dell’interno dell’isola, sorvolando sulle
affascinanti integrazioni con la vita tribale del luogo che mi coinvolsero personalmente in un
incontro emblematico con i riti della magia nera, ebbi un lungo contatto , anche qui, con i maestri
della maschere Mapiko, sorta di caschi dalle fattezze antropomorfe che, calcati sui crani dei
danzatori davano l’aspetto all’attore di un grottesco fantoccio con lo sguardo rivolto al cielo; capii
poi che l’interlocutore dell’entità-maschera non era un qualsivoglia pubblico terreno bensì un
energia divina posta nell’infinito celeste.
Cercai di capire come, naturalmente senza riuscirvi, lo stregone, l’uomo della medicina, il brujo,
concepisse le entità magiche astraendosi dal quotidiano terreno, per addentrarsi in una dimensione
37
rituale sovrumana, magica, carica del mistero che le società segrete africane emanano ancora oggi
nonostante le mutazioni epocali e l’avanzata deleteria, progressiva, inevitabile della
globalizzazione. Anche per tutto questo venne la fine.
L’allestimento dell’Orestea. Al ritorno iniziò una fase di studio che a Helsinghengarden produsse
eventi teatrali densi di nuova linfa e nuovi significati. Poi, ultima, la definitiva produzione che per
due anni coinvolse totalmente le nostre, soprattutto le mie, energie: una versione tutta nuova
dell’Orestea di Eschilo messa in divenire richiamando all’ordine del giorno ogni esperienza di
comunicazione teatrale saggiate fino a quel momento. Grandi furono i preparativi, come le
premesse; il maskverkstad, il laboratorio delle maschere svedese, fu notevolmente potenziato ,
potei richiedere e richiamare i migliori collaboratori che negli anni si erano succeduti durante le
diverse, eterogenee esperienze. Era un brulichio di attori e comparse, sceneggiatori e storici, tecnici
del suono e della luce, e noi, tra gli altri, del laboratorio delle maschere. Peter Oskarson individuò
tra gli attori più o meno consacrati del panorama nordico teatrale , cinematografico e televisivo i
ruoli più idonei.
Il primo impegno fu quello di rilevare le impronte dei volti dei singoli interpreti e fu la volta di
Agamennone e Clitemestra, poi, le inferiche Erinni, che nel corso degli eventi si sarebbero
trasformate in Eumenidi pentite, e di seguito gli attori che facevano parte dei cori degli Argivi e le
attrici delle Coefore; infine, fu la volta di Oreste e dell’amico più che fraterno Pilade, che concluse
il ciclo dei calchi del viso. Il periodo successivo fu dedicato ai disegni preparatori; per questo chiesi
la collaborazione dello scenografo e delle costumiste; non solo: volli conoscere il tecnico delle luci
che stava progettando un immane apparato scenico e luminotecnico, attrezzato con oltre cinquemila
punti luce disseminati sull’intera volta del teatro. I mesi scorrevano tra prove di teatro, realizzazione
di disegni, infinite riunioni tra registi, attori e, perché no, responsabili economici che, preoccupati
dell’enorme lievitare delle cifre sborsate davano dritte e suggerivano consigli su come evitare
sprechi e spese impreviste.
Peter Oskarson desiderava dare un’impronta diversa alla tragedia di Eschilo: traendo ispirazione
dalle recenti esperienze orientali (Cina, India) e a quelle delle danze di guerra africane, senza
dimenticare le radici storiche della tragedia greca, volle donare a tutto lo spettacolo un
collegamento simbolico tra le divinità del Pantheon greco-latino e quelle dell’antica mitologia
germanica e nordica. Volle, inoltre, inferire ai vari personaggi che popolavano la trama dell’Orestea
un carattere indefinito, attinente ad un tempo universale in grado di collegare in un unicum la guerra
di Troia con i recenti conflitti del Vietnam e con quello iracheno, ancora in corso. Non so quando a
Oskarson balenò l’idea di un viaggio in Grecia alla ricerca dei siti storici citati nell’Orestea, certo
che l’e-mail che mi raggiunse in Italia mi rese attonito ma non mi sognai neppure di protestare per il
38
breve lasso di tempo concessomi per organizzare la partenza e , in breve, salii sul volo che di lì a
poco mi avrebbe portato ad Atene.
Tutto lo Staff del Folk Teatern era ad attendermi allo scalo aereo; oltre a Peter una folla di attori,
aiutoregisti, scenografi e tecnici ma anche le maestranze più lontane dal mondo creativo come
portieri, facchini, addetti alle pulizie e molti altri. Forse, con questo gesto il regista intendeva
premiare quella grande umanità di collaboratori che lo aveva, per molti anni, accompagnato nel
lungo percorso di ricerca e creazione teatrale.
Questo periodo mi rimarrà nella memoria per le numerose e straordinarie esperienze realizzate nei
più reconditi siti della Grecia antica. Tutta la troupe di attori aveva al seguito quel necessario
tecnico per sperimentare brani dell’Orestea negli stessi luoghi ove fu concepita quasi 2500 anni fa.
Nelle casse, oltre al resto, erano stipate quelle maschere realizzate nei materiali più diversi durante i
mesi precedenti sia in Italia che nel laboratorio svedese. Stavo mettendo a punto una nuova tecnica,
sperimentando altri materiali dato che, secondo le ultime decisioni di Peter, nel corso delle prove
era emerso che tutta la trilogia aveva una componente unica: l’acqua. Agamennone infatti secondo
Eschilo, venne ucciso nella vasca da bagno, così morì assassinata anche Clitemestra, le Erinni,
esseri demoniaci del Pantheon greco emergevano dal mondo sotterraneo (Oskarson lo trasformò in
un limaccioso fiume, lo Stige); insomma molte parti delle scene si svolgevano attraverso
immersioni in acqua o emersioni dall’acqua. Ovviamente le maschere dovevano essere costruite in
materiali resistenti al liquido ed estremamente leggere.
Usai infatti molte delle risorse tecnologiche apprese e sperimentate in Oriente (Cina e Giappone per
intenderci) approdai ad una sorta di resina naturale che anticamente aveva la funzione di rendere
coesi strati sovrapposti di fibre organiche , foglie, cortecce conferendo alle maschere un aspetto
rigido e duro simile al legno. Sperimentai una serie di lacche che recai con me da un recente
viaggio in Giappone e ne proposi il risultato finale a Peter Oskarson, ottenni un plauso clamoroso
per quanto riguarda i risultati estetici. Gli esperimenti realizzati secondo tale tecnica erano, in
verità, singolari ma dai costi esorbitanti; dovetti perciò rinunciare alla coerenza filologica seguita in
lunghi anni di attenti studi e indagini sulle maschere greche. Intrapresi alcune prove sulle materie
plastiche messe a disposizione dalla tecnologia produttiva contemporanea.
Nei laboratori di Helsigengarden venne messa a punto una nuova tipologia di resine che, pur
assomigliando moltissimo alle qualità tecnologiche del passato, non eccedeva più di tanto rispetto ai
costi preventivati. Vennero approntate quindi le nuove maschere-casco per l’Orestea in questa
materia che ci permise inoltre di appurare l’emblematica risorsa della vocalità dello strumentomaschera. Infatti la maschera realizzata in modo da contenere tutta la testa dell’attore sino
all’occipite, come descritto in ogni documento storico di epoca greco latina diveniva camera
39
armonica all’emissione della voce. La dizione o il canto infatti trasformavano la maschera in uno
strumento sonoro poiché le pareti rigide ( si suppone che anche nell’antichità fossero tali) entravano
in vibrazione facendo emettere delle sonorità vibrofoniche al personaggio.
Ad Atene, presso la Facoltà di Musicologia dell’Università con cui venimmo a contatto, da decenni
si svolgono studi ed esperimenti in tal senso. Questa teoria che mi tormenta ed affascina sin dalle
prime esperienze, realizzate presso i teatri della Magna Grecia, in Sicilia durante le tournée teatrali
organizzate dal centro per la ricerca teatrale di Pontedera (1976). All’epoca furono realizzati in
questi siti esperienze di recitazione con le maschere create da mio padre Amleto per l’Orestea
francese di Barrault. Con le maschere provenienti dai laboratori svedesi, alla presenza di esperti,
studiosi e storici, è stato posto un punto fermo nell’eterna querelle attorno alla bocca megafonica
che, nata presso il teatro greco, si trascinò per tutto il periodo latino.
Nei teatri archeologici più importanti della Grecia, tra cui Argos, Epidauro e il teatro di Dioniso ad
Atene, vennero realizzati esperimenti acustici di ogni sorta. Tutto lo staff del Folkteatern era
attivato. Gli attori recitavano emettendo suoni gutturali, urla, muggiti e ruggiti, regolarmente testati
da sofisticati strumenti acustici. Lo straordinario risultato fu che nei luoghi sottoposti a tali
esperimenti non vi era la minima necessità di amplificare la voce, data la perfetta acustica registrata
nelle cavee teatrali.
Si fece largo un’altra ipotesi, che quella strana forma delle labbra fatta a guisa di megafono,
presente solo in alcune delle maschere teatrali antiche, avesse la valenza di evidenziare e rendere
riconoscibili, tra gli altri, alcuni caratteri quali quelli dei sileni, dei satiri o dei servi. Maschere
tipologiche dunque piuttosto che megafoniche, in ogni caso vibrofoniche, dati gli straordinari
risultati ottenuti.
Il debutto dell’Orestea avvenne il 22 febbraio 2002, sotto una tormenta di neve ed il termometro
che segnava 20 gradi sotto lo zero, in un teatro ricavato da un manufatto di archeologia industriale
(antico deposito di gas a forma circolare), le ore recitate erano otto e la folla era immensa. Durante
il volo di ritorno ebbi la sensazione che un altro pezzo della mai vita si fosse concluso.
40
Il significato ultimo della maschera. Il nuovo millennio sembra aver portato in Italia un rinnovato
interesse nei confronti delle autoctone energie culturali, spostando la naturale inclinazione esterofila
da tempo orientata verso una globalizzazione filoamericana. In quest’ambito Abano Terme, in una
storica assemblea consigliare, decise all’unanimità di assegnare un’antica villa veneta,
convenientemente restaurata e attrezzata quale sede museale dedicata alla ricerca e all’attività dei
Sartori.
Una nuova casa delle maschere, dunque, un museo vivente, non cristallizzato, ove possano
convergere gli interessi non solo di studiosi di settore, bensì degli uomini inclini al teatro, alla
musica, alle arti espressive insomma, a tutto quel mondo che voglia conoscere le proprie fonti
culturali che conferirono alla cultura italiana un ruolo storico che la pone tra i primi posti come sito
artistico tra i più straordinari dell’intero pianeta.
Questi ultimi anni furono dedicati soprattutto a questo ambizioso progetto museale, coronamento di
una pluriennale opera collettiva da parte dei componenti del Centro, siano essi collaboratori storici
che ci accompagnano da tempo con uno straordinario spirito di abnegazione, che da quelli
temporanei che di volta in volta ci affiancano nella realizzazione dei numerosi progetti che si vanno
succedendo lungo la naturale evoluzione delle attività.
Per questo, grazie soprattutto alla preziosa opera di Paola, mia moglie, che da oltre vent’anni mi
affianca in questa straordinaria avventura, stiamo mettendo a punto un preciso piano che coinvolga,
con l’attività culturale e di scambi internazionali che oramai contraddistinguono l’identità del
Centro Maschere e Strutture Gestuali tutto il territorio, inteso come sito ospitante, l’entroterra
veneto, in particolare l’area termale situata ai piedi dei Colli Euganei, cresciuta a dismisura dal
dopoguerra ad oggi, e come tutti i giganti cresciuti troppo in fretta, priva delle infrastrutture
socioculturali a carattere internazionale che dovrebbero essere il fulcro dell’attenzione delle
pubbliche istituzioni, considerando la recente realtà dell’unificazione europea.
Da anni perseguiamo questo progetto che finalmente sembra volgere faticosamente a conclusione,
permettendoci così di accentrare in Veneto, storica sede naturale della maschera sia teatrale che
ludica, tutte le risorse ed i privilegi accumulati in quasi tre quarti di secolo.
Casa delle maschere, dunque, non solamente un ricovero museale di opere vive come le maschere,
che sarebbero condannate a morte per inedia, ma luogo vivo, aperto alle più eclettiche attività
pluridisciplinari, che riguardano il teatro e l’erigenda “Scuola della Commedia dell’Arte”, la
musica, la danza, il gesto e l’opera artistica, intesa nella più ampia accezione del termine. Qui, dopo
molti decenni di estenuanti attività attorno al mondo, dopo aver diffuso capillarmente il senso della
maschera del teatro italiano, si creerà un punto nodale su cui far confluire l’attenzione di tutti verso
uno strumento comunicativo tra i più diffusi nel mondo, in ogni epoca, da quando l’uomo esiste.
41