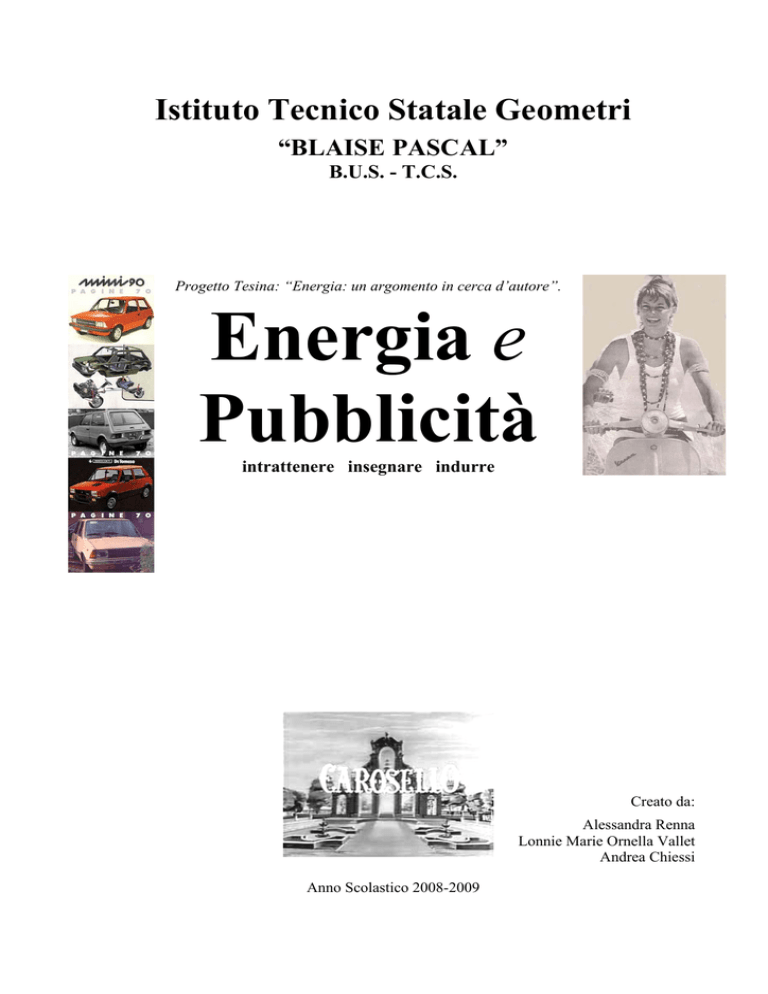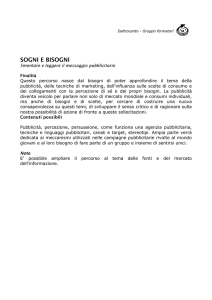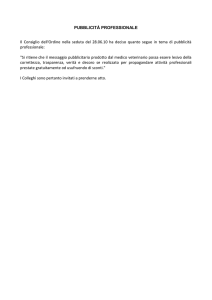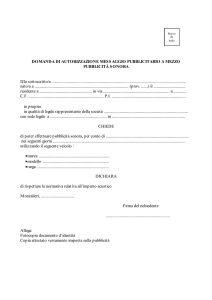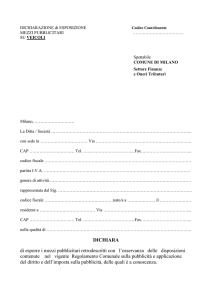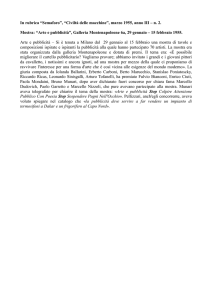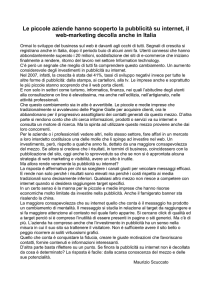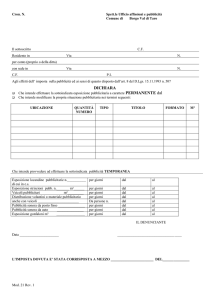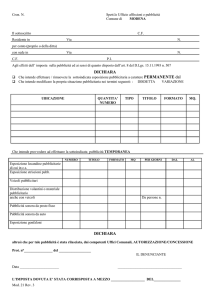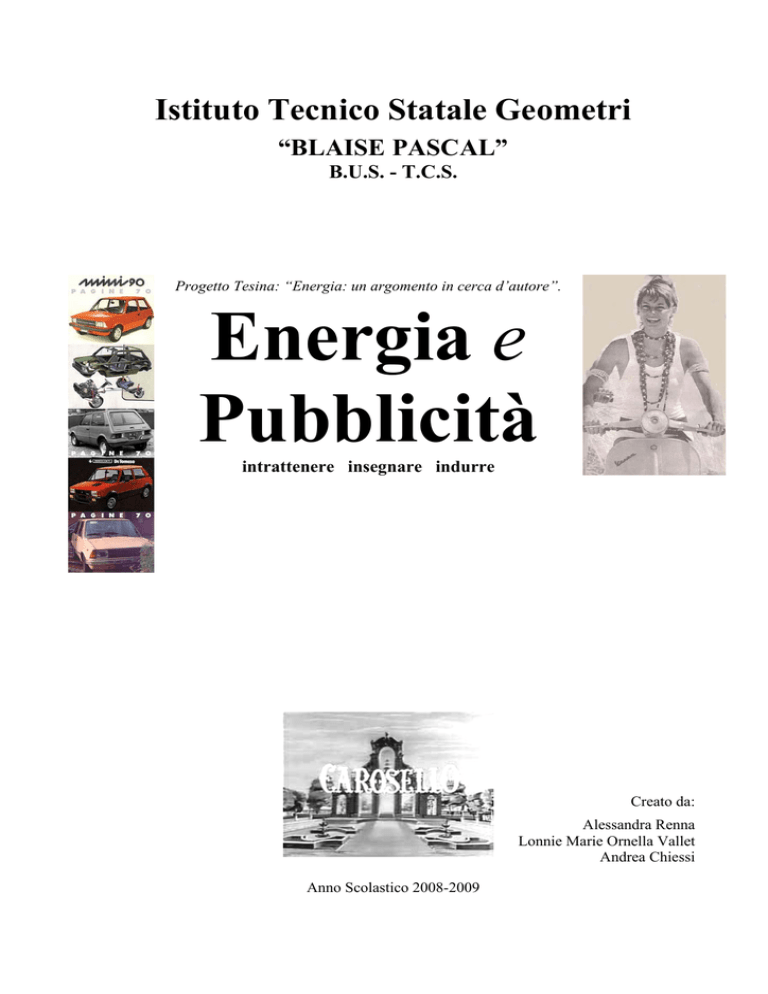
Istituto Tecnico Statale Geometri
“BLAISE PASCAL”
B.U.S. - T.C.S.
Progetto Tesina: “Energia: un argomento in cerca d’autore”.
Energia e
Pubblicità
intrattenere insegnare indurre
Creato da:
Alessandra Renna
Lonnie Marie Ornella Vallet
Andrea Chiessi
Anno Scolastico 2008-2009
INDICE
1. INTRODUZIONE
pag. 3
2. ENERGIA
pag. 5
2.1 Energia per vivere
pag. 5
2.2 Energia ieri e oggi
pag. 7
2.3 Informazioni ricavabili dal BEN
pag. 9
2.4 Consumi di energia primaria in Italia dal 1971 al 2003
pag. 10
2.4.1 Consumi di energia primaria in Italia dal 1971 al 2003 (per fonte)
pag. 10
2.4.2 Consumi di energia primaria in Italia nel 2003.
Contributo percentuale delle varie fonti.
pag. 11
2.4.3 Consumi finali di energia in Italia dal 1971 al 2003
nel settore industria (per fonte).
pag. 12
2.4.4 Consumi finali di energia in Italia dal 1971 al 2003
nel settore residenziale e terziario (per fonte).
pag. 13
2.4.5 Consumi finali di energia in Italia dal 1971 al 2003
nel settore trasporti (per fonte).
pag. 14
2.5 Produzione lorda e importazione di energia elettrica in dal 1971 al 2003
2.5.1 Produzione lorda di elettricità nel mondo, nell’UE25 e in Italia.
Contributo percentuale delle varie fonti (2002).
3. LA PUBBLICITÀ ED IL CONSUMO DELL’ENERGIA
3.1 Negli anni Sessanta
3.1.1 Carosello
pag. 15
pag. 16
pag. 17
pag. 18
pag. 25
3.2 Negli anni Settanta
pag. 26
3.3 Negli anni Ottanta
pag. 31
3.4 Negli anni Novanta
pag. 34
3.5 Nel Duemila
pag. 39
4. CONCLUSIONI
pag. 43
5. BIBLIOGRAFIA
pag. 47
Pagina | 2
1. Introduzione
Questo lavoro si propone come obiettivo una riflessione sull’utilizzo del mezzo pubblicitario
nell’ambito dell’uso e del consumo dell’energia in Italia dagli anni sessanta ad oggi, analizzando
i consumi energetici in Italia per fonte (industria trasporti, settore domestico).
La parola “consumo” dagli anni ‘60 è stata strettamente legata alla parola Pubblicità.
Approfondiremo questo legame, soffermandoci e chiedendoci che cos’è la pubblicità. Attanasio
la definisce come “ogni forma a pagamento di presentazione e di promozione di prodotti o
servizi, effettuata allo scopo di indurre il pubblico, direttamente o indirettamente interessato, a
considerarli favorevolmente e ad assumere quindi un atteggiamento positivo nei loro confronti”1.
Questa definizione, sebbene non esaustiva dal punto di vista sociologico è comunque efficace
soprattutto in riferimento all’atteggiamento dei consumatori.
Partiremo quindi proprio dal consumatore, da colui che è erroneamente definito il recettore
passivo dell’informazione pubblicitaria.
Non esisterebbe pubblicità se non ci fossero i possibili destinatari: ecco perché la pubblicità è
sempre andata di pari passo con i cambiamenti culturali e sociali delle masse. In questo modo è
facile osservare i cambiamenti del modo di fare pubblicità e del suo ruolo in rapporto ai
cambiamenti della società stessa. Sicuramente, fattori quali l’urbanizzazione e il forte sviluppo
dell’industria dei mass-media diedero una spinta decisiva che si concretizzò prepotentemente
negli anni ‘60.
Il ruolo che gioca la pubblicità in questo decennio di progresso e rinnovamento è sicuramente
importante: veicola stili di vita e prodotti della moderna società industriale, aiuta il processo di
trasformazione della società ma, d’altra parte, induce anche agli acquisti non essenziali. I
consumatori sembrano stare al gioco della pubblicità, i consumi aumentano sempre e la
pubblicità si fa forma di spettacolo quando, con la trasmissione televisiva “Carosello”, si
raggiungono i più alti indici di gradimento registrati nel palinsesto televisivo. Gli anni ‘60 sono
anni di forte consumismo. Il modello di vita s’incentra sul consumo e la fruizione di beni,
facendo nascere così i primi status-symbol.
Ovviamente, la pubblicità è complice diretta di questa fase di modernizzazione. La società
manifesta il massimo consenso nei suoi confronti e, non solo, la pubblicità favorisce l’aumento
delle vendite e di conseguenza lo sviluppo economico .
Un secondo cambiamento sconvolgerà l’Italia nel decennio successivo. Lo sgretolamento del
modello di vita da poco costituito dovuto alla crisi petrolifera manda in grave crisi la società
italiana. Il porsi dei dubbi anche sui quadri di vita emerge dai gruppi sociali con forti valori
antipubblicistici fortemente ostili al consumismo.
Facile dedurre come la pubblicità non venisse allora vista di buon occhio in questi nuovi tempi: i
consensi si riducono drasticamente, ma non solo: sembra che la pubblicità non riesca neanche
più a imporre cambiamenti nei modelli di vita della società italiana anzi, si trova decisamente
spiazzata dalla velocità stessa dei cambiamenti in atto.
Essa sembra non accorgersi dei nuovi linguaggi e dei nuovi stili di vita che si stanno imponendo
nella società: spiazzata dal repentino cambiamento sociale, la pubblicità si attacca a quei modelli
comunicativi che avevano coinciso con il suo periodo di massimo consenso, fallendo i propri
bersagli.
Negli anni ’80, il forte e progressivo aumento del consumo fa ritornare in auge di riflesso anche
la pubblicità. Dimenticate le contestazioni degli anni ‘70, il nuovo clima culturale apre le porte
ad una propensione all’acquisto senza precedenti: la presa di distanza da orientamenti collettivi
1
http://books.google.it/books?id=sKDPCTLtRDcC&pg=PA110&dq=consumi+finali+di+energia+in+italia+dal
+1960#PPA113, M1
Pagina | 3
per privilegiare invece la soggettività individuale l’erompere dell’edonismo quotidiano,
generano un nuovo stile di consumo. È soprattutto la liberalizzazione delle frequenze televisive
a livello nazionale che porterà ad un dualismo tra tv di Stato e di tv privata (con finanziamenti
derivanti dalla pubblicità) tuttora esistente, a decretare il successo dell’advertising anche a livello
economico. Così la pubblicità ritorna prepotentemente in primo piano, riacquistando non solo un
notevole riscontro presso i consumatori, ma soprattutto divenendo un importante agente di
modernizzazione per una continua ricerca e creazione di nuovi linguaggi e forme espressive.
Il consenso della pubblicità presso i fruitori della stessa rimane costante anche negli anni ‘90.
Cambiano, però, gli atteggiamenti dei consumatori che diventano più distaccati e riflessivi, più
selettivi ed esigenti, lontani, dunque, dal neoconsumismo degli anni ‘80.
Questi nuovi valori sembrano plasmare diversi modelli di consumo che appaiono nelle
manifestazioni dei soggetti culturalmente più moderni, più sobri. Anche la pubblicità cambia,
diventa più mirata, dovendosi difendere dalle pesanti accuse di falsità a lei rivolte dai critici.
La gente vorrebbe vedere una pubblicità con la quale divertirsi trascorrendo quei fastidiosi
secondi di invito all’acquisto in maniera evasiva. Una pubblicità, quindi, con più humor, con
più effetti speciali, uno spettacolo dunque dove, però, il prodotto non è più il tiranno ma una
spalla, un complice, addirittura il bersaglio dell’ironia.
Ed è solo in questi ultimi anni che anche in Italia c’è una più accurata ricerca nella creazione
delle campagne pubblicitarie, in modo da soddisfare quelle che sono le richieste del
consumatore.
Concludendo, abbiamo visto come in 50 anni è cambiato non solo il modo di fare pubblicità, ma
anche di recepirla. Questi cambiamenti hanno avuto un riflesso anche sui paradigmi teorici della
comunicazione generale e, in specifico, quella pubblicitaria.
Dal punto di vista del consumo dell’energia, si è osservato di pari passo un cambiamento
dell’atteggiamento del consumatore. Se prendiamo in considerazione il nostro campo d’indagine,
nonostante il forte consumo di energia elettrica e di benzina per autoveicoli, le famiglie e le
industrie hanno manifestato una certa attenzione ambientale, cercando di ridurre il consumo di
prodotti petroliferi .
Si può dire che anche il messaggio pubblicitario possa essere l’occasione di pensare, sia pure per
un attimo, alle implicazioni delle problematiche energetiche.
Pagina | 4
2. ENERGIA
2.1 Energia per vivere
Qualunque organismo ha bisogno di energia per vivere. L’energia è legata a tutte le attività
umane: quando pensiamo o ci muoviamo, utilizziamo energia immagazzinata nel nostro corpo e
tutti gli oggetti che ci circondano o di cui facciamo uso hanno bisogno di energia per funzionare
e ne hanno avuto bisogno per essere costruiti. L’energia illumina e riscalda le nostre case, ci
permette di spostarci, alimenta gli strumenti con i quali produciamo il cibo e così via. Tutto ciò
che produce energia è una “fonte di energia”. Il Sole è la principale fonte di energia della Terra.
In generale, tutta l’energia disponibile sul nostro pianeta deriva direttamente o indirettamente
dal Sole: l’energia idrica, l’energia eolica, l’energia chimica dei combustibili fossili (carbone,
petrolio e gas naturale) e delle biomasse (per esempio la legna), persino l’energia delle onde.
Dai campi gravitazionali del Sole, della Luna e della Terra deriva l’energia delle maree. Le
numerose fonti energetiche esistenti possono essere classificate in diversi modi.
Fig.1 La maggior parte di fonti energetiche deriva dall’ambiente
Si dicono primarie se sono utilizzabili direttamente, così come si trovano in natura. Sono fonti
primarie il carbone, il petrolio, il gas naturale, la legna, i combustibili nucleari (uranio), il sole, il
vento, le maree, i laghi montani e i fiumi (da cui è possibile ottenere energia idroelettrica) e il
calore della Terra che fornisce energia geotermica. Sono secondarie quelle che derivano dalla
trasformazione di fonti d’energia primaria: ad esempio, la benzina, che deriva dal trattamento del
petrolio grezzo, e l’energia elettrica ottenuta dalla conversione di energia meccanica (centrali
idroelettriche, eoliche) o chimica (centrali termoelettriche) o nucleare (centrali nucleari).
L’energia elettrica viene prodotta attraverso le centrali elettriche, appositi impianti in grado di
convertire energia primaria (cioè non trasformata) in energia elettrica. Alcune fonti sono
rinnovabili, cioè forniscono energia che si rigenera in continuazione mediante trasformazioni
chimiche (come le biomasse) o fisiche (come l’energia idrica, solare, eolica, ecc).
Pagina | 5
Fig.2 Schema delle fonti più conosciute derivate dal sole
Le cosiddette fonti non rinnovabili, invece, hanno tempi di rigenerazione lunghi, talmente
lunghi (milioni di anni) che una volta sfruttate si considerano esaurite. Sono quelle che si sono
formate nel corso di milioni di anni, come i combustibili fossili (petrolio, carbone, gas
naturale) o addirittura al momento della formazione del nostro pianeta, come l’uranio. La
disponibilità di queste fonti, per quanto grande, è limitata ed esse costituiscono una sorta di
magazzino energetico della Terra. Attualmente, solo il 14% dell’energia consumata nel mondo è
prodotta da fonti rinnovabili. Tutto il resto deriva da fonti non rinnovabili, perlopiù da
combustibili fossili (78%). Seppure in forme diverse, l’energia si trova dappertutto, ma quella
disponibile ad essere controllata, trasformata e utilizzata da parte dell’uomo (con le attuali
tecnologie) è solo una piccola parte, contenuta nelle fonti primarie di energia.
Fig. 3 Base petrolifera
Pagina | 6
2.2 Energia ieri e oggi
La storia dell’uomo è stata sempre caratterizzata dalla ricerca di nuove fonti d’energia:
inizialmente per garantirsi la sopravvivenza, poi per migliorare il proprio tenore di vita. Nei
primi decenni del Novecento, dopo un avvio promettente dell’energia idroelettrica, grandi
giacimenti di petrolio vennero scoperti in Medio Oriente: la corsa all’ “oro nero” era cominciata.
Negli anni ‘60, dopo mezzo secolo di dominio incontrastato del petrolio, il gas naturale si è
dimostrato una valida alternativa, soprattutto per quanto riguarda gli impieghi domestici (cottura
e riscaldamento), grazie al suo minore impatto ambientale. All’inizio degli anni ’70, in alcuni
Paesi ha cominciato a farsi avanti l’energia nucleare, principalmente nell’ambito della
produzione di elettricità. Lo sviluppo dell’energia nucleare, così come quello di altre fonti
energetiche alternative, si spiega con i forti incrementi del prezzo del greggio provocati dalle
“crisi petrolifere” verificatesi nel ‘74 e nel ‘79, e da quella del 1990, durante la Guerra del
Golfo. Il serbatoio delle fonti di energia attualmente disponibili è costituito da petrolio, gas
naturale, carbone, energia idroelettrica ed energia nucleare, in percentuali variabili da nazione a
nazione.
A queste fonti principali se ne aggiungono altre, anche se in quantità ancora poco significative,
ma dotate della caratteristica di essere rinnovabili: l’energia geotermica, l’energia solare,
l’energia eolica, l’energia da rifiuti, l’energia da biomasse. L’Agenzia Internazionale
dell’Energia (uno dei più importanti istituti di ricerca che si occupa di studi sull’energia) prevede
che da qui al 2020 il consumo mondiale di energia del mondo aumenterà di circa il 65% rispetto
ai livelli attuali.
Quali fonti forniranno tutta questa energia all’uomo? La disponibilità di combustibili fossili sarà
sempre più ridotta con il passare del tempo (a causa dell’esaurimento dei giacimenti) e per poter
soddisfare la crescente domanda di energia, sarà necessario avvalersi di nuove fonti, in
particolare di quelle rinnovabili e a minore impatto ambientale. Una delle possibili alternative al
petrolio è rappresentata dall’idrogeno. L’idrogeno è un elemento contenuto in molte sostanze
(dall’acqua al metano) ed è disponibile sulla Terra in enormi quantità. Esso si può utilizzare, per
esempio, nella cella a combustibile: un apparecchio in grado di attivare un processo
elettrochimico che trasforma l’energia contenuta nell’idrogeno in elettricità e calore evitando la
combustione, causa di numerose emissioni di inquinanti dell’aria. Le celle a combustibile
possono essere impiegate in diversi settori: dai trasporti (autobus e automobili), all’edilizia
(produzione d’acqua calda riscaldamento e condizionamento), all’elettronica (cellulari e
computer).
Attualmente però le tecnologie a disposizione per la produzione, la conservazione, il trasporto e
l’utilizzo dell’idrogeno devono essere ulteriormente testate e migliorate, prima che tale risorsa
possa essere usata su vasta scala. L’energia è ormai diventata una compagna inseparabile
dell’uomo, che la utilizza in ogni momento della sua giornata e in tutte le sue attività. Per
assicurarsi la possibilità di usufruire di questa risorsa in modo semplice, stabile e continuo,
l’uomo ha dovuto applicarsi in studi e ricerche per molto tempo e solo negli ultimi decenni del
diciannovesimo secolo è riuscito, in molte nazioni ma non in tutte, a predisporre “sistemi
energetici” che assicurano la qualità e le quantità di energia necessaria allo sviluppo.
Con il termine “sistema energetico” si è soliti indicare l’insieme dei processi di produzione,
trasformazione, trasporto e distribuzione di fonti di energia. I sistemi energetici sono
normalmente estremamente complessi e richiedono competenze in tutti i campi della scienza per
poter essere costruiti e gestiti. Infatti, tanto è semplice utilizzare l’energia che ci viene messa a
disposizione in casa (premiamo un pulsante e si accende una luce), quanto è difficile e
complesso produrre quell’energia e portarla fin dentro le nostre case. L’importanza dell’energia
nella società moderna ha portato l’uomo non solo a creare complessi “sistemi energetici”, ma
Pagina | 7
anche a porsi il problema di misurare quanta energia egli consuma ogni anno e di capire da quale
fonte la ricava e da quale Paese la importa.
A questi problemi l’uomo ha risposto utilizzando apposite unità di misura dell’energia e uno
schema di rappresentazione dei flussi di energia che entrano in un Paese e vengono utilizzati dai
diversi settori di utenza nell’arco di un anno il Bilancio energetico Nazionale. Come tutti i
bilanci, anche il bilancio energetico raccoglie informazioni sulle entrate e sulle uscite, in questo
caso di energia. Quello nazionale è il bilancio energetico più famoso e utilizzato e consiste in una
raccolta di informazioni su come viene prodotta l’energia e su come viene utilizzata in un Paese
nell’arco di un anno.
Ecco, in sintesi, come va letto il Bilancio Energetico Nazionale (BEN). Innanzitutto l’energia
messa a disposizione dalle diverse fonti viene espressa con un’unità di misura comune che
abbiamo già visto: la TEP. Questo consente di sommare tra loro e confrontare i dati relativi alle
differenti fonti. La prima informazione contenuta nel BEN è la disponibilità di energia totale e
suddivisa per fonti (chiamati anche consumi primari di energia o fonti primarie). Questi dati
indicano quanta energia è messa a disposizione di un Paese o per essere consumata direttamente
(ad esempio l’energia elettrica importata o prodotta dalle centrali idroelettriche), o per essere
trasformata in prodotti derivati da mandare successivamente al mercato del consumo finale (ad
esempio il petrolio, che va poi alle raffinerie per essere trasformato in benzina e gasolio), o,
infine, per essere trasformata in energia elettrica (il carbone, il gas e il petrolio utilizzati dalle
centrali termoelettriche per produrre elettricità).
L’energia fornita dalle fonti primarie può appartenere al Paese (produzione nazionale: ad
esempio il gas estratto nei giacimenti della Val Padana o del Mare Adriatico) oppure essere
importata (ad esempio il petrolio che l’Italia importa dal Medio Oriente o il gas che importa dalla
Libia e dalla Russia).
È importante ricordarsi che in questa fase di definizione dei consumi primari di energia la
produzione nazionale di energia elettrica include solo quella da centrali idroelettriche,
geotermiche, solari ed eoliche o da eventuali altre fonti rinnovabili, ma non include, come già
detto, quella ottenuta bruciando combustibili fossili. Questa distinzione è stata introdotta per
evitare che parte della disponibilità di energia venga conteggiata due volte, una volta come
petrolio e una volta come energia elettrica prodotta dalla combustione di quel petrolio. Dalla
somma della produzione nazionale e delle importazioni delle diverse fonti va sottratta l’energia
esportata e la variazione delle scorte. A questo punto si ottiene la disponibilità primaria di
energia (detta anche consumo primario o consumo interno lordo).Come impiega un Paese la
disponibilità annuale di fonti energetiche primarie? Ce lo dice la seconda parte del BEN, che
contiene i dati sugli impieghi (o usi) finali di energia.
Gli usi finali di energia sono rappresentati dai consumi di energia delle famiglie e delle imprese.
Fig 4 I consumi energetici vengono maggiormente consumati da imprese,
in questa immagine, un’impresa di automobili.
Pagina | 8
2.3 Informazioni ricavabili dal BEN
Il Bilancio Energetico Nazionale viene preparato ogni anno. In questo modo è possibile
confrontare i consumi di energia nei diversi anni analizzando la diversa provenienza delle fonti
(se importata o di produzione nazionale), la diversa composizione (quali fonti energetiche si
sono utilizzate) e l’andamento dei consumi nazionali (se crescono o diminuiscono).
Le informazioni che si possono trarre dal confronto dei consumi di energia nei diversi anni sono
molto importanti. Ad esempio, confrontando il consumo primario di energia con i dati sulla
produzione è possibile vedere se, nel corso degli anni, un Paese é riuscito a utilizzare meglio
l’energia che ha a disposizione, impiegandone di meno per produrre di più. Ma si può anche
verificare se le fonti energetiche rinnovabili, o quelle il cui utilizzo provoca minori emissioni di
inquinanti nell’aria, hanno progressivamente sostituito le fonti energetiche maggiormente
inquinanti.
Un’altra utile indicazione è la dipendenza di un Paese dalle importazioni di energia. In paesi
come l’Italia, ad esempio, le risorse energetiche del sottosuolo sono limitate ed è necessario
importare dall’estero più dell’80% dell’energia primaria.
Poiché dalla disponibilità di energia dipende gran parte del nostro sviluppo e benessere
quotidiano, è necessario che i paesi come il nostro, fortemente dipendenti dall’estero per
l’approvvigionamento di energia, mantengano buone e stabili relazioni con i paesi da cui la
importano.
Pagina | 9
2.4 Consumi di energia primaria in Italia dal 1971 al 2003
2.4.1 Consumi di energia primaria in Italia dal 1971 al 2003 (per fonte)
Il grafico mostra l’evoluzione dei consumi italiani di energia dal 1971 al 2003. È opportuno
precisare che la voce “idrogeno” comprende, oltre all’energia idroelettrica e a quella geotermica
o elettrica, anche l’energia nucleare (fino al 1986) nonché l’energia elettrica prodotta da altre
fonti rinnovabili, quali eolico e biomasse. Tutta l’energia elettrica primaria, di qualunque
origine, è stata valorizzata secondo il fattore di conversione 1TWh = 0, 22 Mtep (1 kWh = 2.200
kcal), il che equivale a contabilizzare l’energia dei combustibili che sarebbero necessari per
produrla in un ipotetico parco di centrali termoelettriche aventi un rendimento medio del 39%,
in accordo con la convenzione adottata nel Bilancio Energetico Nazionale.
Lo stesso fattore di conversione è stato utilizzato nella quantificazione delle importazioni nette di
elettricità. L’energia elettrica prodotta per via termoelettrica da gas, petrolio e carbone non è
invece esplicitamente mostrata dal grafico. Attualmente essa rappresenta in Italia circa il 70%
della domanda lorda I consumi di combustibili fossili indicati nel grafico comprendono la quota
parte trasformata in energia elettrica; nel 2003, ad esempio, il 17% del petrolio, il 34% del gas
e il 67% del carbone sono stati consumati per produrre elettricità (in totale circa 48 Mtep per
produrre 241 TWh).
Nel periodo esaminato, i consumi italiani di energia sono aumentati di circa il 50%, ad un tasso
nettamente inferiore a quello che ha caratterizzato, nello stesso periodo, l’incremento dei
consumi mondiali. L’andamento dei consumi italiani, nel totale, mette in evidenza i periodi di
stasi o di recessione legati alle crisi energetiche e ai rallentamenti nella crescita economica.
La disaggregazione per fonte mostra innanzitutto che il petrolio, anche se il suo peso
percentuale è gradualmente diminuito, è stato e continua ad essere la fonte prevalente del nostro
sistema energetico. In termini assoluti, i consumi di petrolio non sono cambiati di molto, in
quanto i forti aumenti registrati nel settore dei trasporti sono stati compensati da corrispondenti
riduzioni nell’impiego termoelettrico, nel settore industriale e nel settore civile.
Anche la produzione di elettricità primaria e i consumi di carbone hanno subito variazioni
limitate in valore assoluto.
Negli anni ’80 diventano consistenti le importazioni di energia elettrica;
Nello stesso decennio si accentua l’aumento dei consumi di gas, la fonte che nel periodo
esaminato ha registrato la crescita maggiore. Questo forte aumento è imputabile alla crescita dei
consumi di questo combustibile nel settore industriale, nella produzione termoelettrica e nel
settore civile (residenziale e terziario); in tutti e tre i casi il gas ha sostituito crescenti quantità di
prodotti petroliferi.
Pagina | 10
2.4.2 Consumi di energia primaria in Italia nel 2003. Contributo percentuale delle varie fonti.
Il grafico è stato elaborato adottando le stesse assunzioni già descritte nel commentare l’evoluzione
storica dei consumi italiani di energia primaria. Esso conferma il permanere del predominio del
petrolio nel soddisfacimento della domanda complessiva e il forte peso raggiunto dal gas. Nel loro
insieme, petrolio e gas rappresentano circa l’80% dei consumi nazionali di energia primaria: una
dipendenza dagli idrocarburi così alta è un chiaro indice della grande vulnerabilità della nostra
economia.
Nei prossimi anni i consumi italiani continueranno a crescere e il contributo percentuale delle varie
fonti continuerà a modificarsi.
Comunque, l’evoluzione nel medio termine del quadro energetico nazionale, almeno in termini
qualitativi, può essere così sintetizzata:
-
-
forte crescita dei consumi di gas, principalmente nella produzione termoelettrica e nel settore
civile; entro dieci anni il gas scalzerà il petrolio quale principale fonte energetica italiana;
crescita dei consumi elettrici, sia nel settore industriale che in quello civile (all’incirca in pari
misura);
modeste variazioni nei consumi complessivi di petrolio, anche se conseguenti a dinamiche
settoriali notevolmente diverse secondo i tre documenti (l’Unione Petrolifera ne prevede una
diminuzione in tutti i settori, incluso quello dei trasporti, a seguito di una progressiva
contrazione delle percorrenze medie annue delle autovetture e di una politica di
razionalizzazione del trasporto passeggeri e di quello merci);
incremento dei consumi di carbone per uso termoelettrico, accompagnato da una contrazione
della domanda delle cokerie e degli altri settori industriali;
dipendenza dall’estero e dagli idrocarburi sempre attestata su valori elevatissimi, analoghi agli
attuali.
Il ruolo relativo delle fonti energetiche primarie è previsto quindi che si modificano nel medio
termine rispetto alla situazione attuale descritta nel grafico, con un ridimensionamento del peso del
petrolio a favore del gas; i loro contributi percentuali tenderanno ad invertirsi rispetto a oggi. Il
contributo percentuale del carbone rimarrà sostanzialmente invariato, in quanto l’aumento dei suoi
consumi sarà più o meno proporzionale all’aumento della domanda energetica complessiva. Anche
il contributo percentuale delle importazioni di energia elettrica rimarrà vicino al valore attuale,
mentre quello della fonte “idrogeno”, includendo in essa tutte le forme di energia rinnovabile (e
non solo l’elettricità da fonti rinnovabili), potrà raggiungere il 10%.
Pagina | 11
2.4.3 Consumi finali di energia in Italia dal 1971 al 2003 nel settore industria (per fonte).
Il settore industriale è quello che più ha risentito delle vicende economiche e i suoi consumi sono
fortemente dipendenti dalle trasformazioni che nel tempo hanno subito i diversi comparti,
particolarmente i più energivori come il siderurgico, il meccanico, l’agroalimentare, il chimico e
petrolchimico e quello dei materiali da costruzione.
In generale le produzioni effettuate a partire da semilavorati (come ad esempio pasta di cellulosa nel
cartario o rottami nel siderurgico), invece che da materie prime vergini, hanno comportato notevoli
diminuzioni nei consumi; così pure lo spostamento della chimica primaria verso la chimica fine.
Nel periodo esaminato, l’intensità energetica del settore industriale, intesa come rapporto tra il
consumo finale di energia e il valore aggiunto del settore, è fortemente diminuita, passando da
circa 290 a circa 165 tep/Meurolire 95. In realtà questa diminuzione è avvenuta nel periodo dal
1971 al 1986, come risulta anche dall’evoluzione dei consumi, in quanto è in questo periodo che si
sono verificate le trasformazioni strutturali dei comparti più energivori.
A partire dal 1986, l’intensità energetica del settore industriale non è variata sostanzialmente, ma
ha subito solo piccole oscillazioni comprese entro la fascia 160-170 tep/Meurolire 95.
Per quanto prima accennato, questo indicatore aggregato non è significativo degli effettivi
miglioramenti di efficienza nell’uso dell’energia e non si presta, se non grossolanamente, ad
effettuare confronti con gli altri paesi. Per individuare i miglioramenti di efficienza è necessario
considerare con attenzione l’evoluzione della intensità energetica e le trasformazioni dei singoli
comparti.
Il grafico mette in evidenza il crescente peso del gas e dell’energia elettrica nel mix energetico dei
consumi industriali; mentre i consumi di petrolio, che inizialmente era la fonte prevalente, sono
drasticamente diminuiti.
Attualmente il settore industriale copre quasi la metà dei consumi di energia elettrica (alla pari del
settore residenziale e terziario), la quasi totalità dei consumi di carbone (siderurgia e produzione di
cemento) e oltre il 40% dei consumi di gas.
Pagina | 12
2.4.4 Consumi finali di energia in Italia dal 1971 al 2003 nel settore residenziale e terziario (per
fonte).
Il grafico riporta l’evoluzione dei consumi del settore civile in forma aggregata.
L’aumento dei consumi mostrato dal grafico è imputabile tanto all’espansione delle attività
terziarie, quanto alla crescita della domanda di energia del residenziale; quest’ultima è legata alla
crescente penetrazione di elettrodomestici e di apparecchiature elettroniche, alla diffusione degli
impianti di condizionamento, alla crescita della superficie abitativa pro capite e in generale al
miglioramento del reddito degli utenti.
Le fluttuazioni più marcate dei consumi sono dovute a fattori climatici. Negli anni passati era
essenzialmente il clima invernale ad influenzare i consumi (inverno freddo nel 1991, inverno
particolarmente mite nel 1994); più recentemente, a causa del diffondersi degli impianti di
condizionamento, anche il clima estivo ha cominciato ad avere effetti sensibili.
La disaggregazione per fonti mette in evidenza che i prodotti petroliferi, che all’inizio del periodo
considerato rappresentavano la fonte prevalente, sono stati gradualmente sostituiti dal gas; alla fine
degli anni ’80 il gas ha superato i prodotti petroliferi, ed oggi copre più della metà della domanda
di energia dell’intero settore. I consumi di energia elettrica sono aumentati con la crescita dei
cosiddetti usi elettrici obbligati e nel 2003 hanno rappresentato il 28% dei consumi totali.
La ripartizione dei consumi delle singole fonti tra residenziale e terziario indica che la percentuale
attribuibile al residenziale è attualmente molto più elevata di quella del terziario per gas e prodotti
petroliferi, mentre si è giunti alla parità per quanto riguarda l’energia elettrica.
Pagina | 13
2.4.5 Consumi finali di energia in Italia dal 1971 al 2003 nel settore trasporti (per fonte)
Il grafico è estremamente significativo e mette chiaramente in evidenza due circostanze:
-
-
I consumi del settore trasporti sono cresciuti, nel periodo di tempo esaminato, più di quelli
degli altri settori (sono raddoppiati negli ultimi 25 anni), hanno meno risentito delle crisi
economiche ed energetiche, e continuano a crescere, anche se con una dinamica che fa
pensare all’approssimarsi di una situazione di saturazione;
I consumi del settore trasporti sono interamente costituiti da prodotti petroliferi, con la sola
eccezione di una minima quantità di gas e dell’energia elettrica utilizzata dalle modalità su
rotaia.
Queste due considerazioni dimostrano che è su questo settore che occorre intervenire
prioritariamente con provvedimenti di drastica razionalizzazione.
La vettura media circolante in Italia consuma circa 60 grammi di carburante per ogni chilometro di
percorso misto e circa 100 grammi nei percorsi urbani. Ma alle ruote arriva meno del 15%
dell’energia sviluppata dalla combustione del carburante. Una così bassa efficienza “tank-towheels” (dal serbatoio alle ruote) è essenzialmente dovuta al basso rendimento, nelle condizioni
pratiche di impiego, dei motori a combustione interna, tanto a benzina che diesel; solo una piccola
parte dell’energia contenuta nel combustibile si trasforma in energia meccanica; la quota maggiore,
come sempre avviene nelle macchine termiche, viene riversata nell’ambiente sotto forma di calore
di scarto, principalmente attraverso il radiatore e i gas combusti che escono dal tubo di
scappamento. Per avere un’idea di quanto è questo calore di scarto, ricordiamo che la FIAT aveva
brevettato, negli anni ’70, il TOTEM, un micro cogeneratore molto efficiente che utilizzava il
motore da 903 cm3 della “127” alimentato a metano, funzionante al regime costante di 3.000
giri/minuto. Il motore azionava un alternatore, che forniva una potenza elettrica di 15 kW; e un
gruppo di scambiatori recuperava il calore di scarto, fornendo una potenza termica di oltre 38 kW,
che nel clima dell’Italia del nord è sufficiente a riscaldare tre o quattro appartamenti.
Pagina | 14
2.5 Produzione lorda e importazione di energia elettrica in Italia dal 1971 al 2003 (per fonte)
Il grafico è limitato all’arco temporale 1971- 2003. Se si andasse indietro nel tempo, si potrebbe
constatare che sino agli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale la domanda
era pari al 6 – 7 % di quella attuale ed era essenzialmente soddisfatta dalla produzione idroelettrica.
Negli anni ’50 ha iniziato a divenire significativo il contributo della produzione termoelettrica da
combustibili fossili, contributo che è gradualmente aumentato nel corso degli anni ’60, sino a
superare quello della produzione idroelettrica e della produzione geotermoelettrica messe insieme
(idrogeo); il combustibile di gran lunga prevalente nel mix termoelettrico era, alla fine degli anni
’60, l’olio combustibile.
Il grafico permette di evidenziare alcune particolarità. Innanzitutto il forte incremento della
domanda lorda (somma della produzione lorda e del saldo import export); tra il 1971 e il 2003 la
domanda lorda è passata da 127 a 345 TWh . Se si escludono alcuni anni di stasi in corrispondenza
delle cosiddette crisi petrolifere, il tasso di crescita è sempre risultato molto sostenuto, con punte
superiori al 5% annuo. Tra il 1993 e il 2003 il tasso medio annuo di crescita della domanda è stato
del 3%.
Negli anni ’70, e ancor più negli anni ’80, a fronte di una sostanziale stabilità della produzione
idrogeo (soggetta essenzialmente alle fluttuazioni legate alle variazioni annuali di idraulicità), si
registra un marcato aumento delle importazioni e un graduale spostamento del mix termoelettrico
verso il gas e il carbone; il contributo del nucleare è appena significativo solo nei pochi anni di
operatività della centrale di Caorso. Dal 1990 in poi il peso del gas nel mix termoelettrico continua
ad aumentare, fino a superare nel 2000 quello del petrolio, il quale peraltro, partendo da una
posizione iniziale di assoluto predominio nell’uso termoelettrico, continua tuttora a fornire un
contributo rilevante in termini assoluti (66 TWh nel 2003).
Pagina | 15
2.5.1 Produzione lorda di elettricità nel mondo, nell’UE25 e in Italia. Contributo percentuale
delle varie fonti (2002).
La tabella mette in evidenza le anomalie italiane nel modo di produrre l’energia elettrica. Mentre nel
mondo e nell’UE25 petrolio e gas contribuiscono solamente per circa un quarto alla produzione di
elettricità, in Italia il loro contributo supera il 60% e tende ancora ad aumentare. Per contro, in
Italia è nullo il contributo del nucleare e molto modesto quello del carbone, mentre nucleare e
carbone insieme forniscono il 55% dell’elettricità a livello mondiale e il 63% nell’UE25. La
rinuncia italiana al carbone, oltre che al nucleare, ha reso il nostro sistema elettrico pesantemente
dipendente dagli idrocarburi e quindi fortemente vulnerabile ed esposto alle perturbazioni
geopolitiche e di mercato; la sua vulnerabilità è poi aumentata dal notevole contributo fornito dalle
importazioni di elettricità (non mostrato nella tabella), che in questi ultimi anni si sono attestate
intorno al 15% della domanda.
Nei prossimi anni, secondo i programmi, il mix termoelettrico italiano dovrebbe modificarsi
notevolmente: gas e carbone dovrebbero aumentare il loro contributo, sostituendo il petrolio. Ma
sarà il gas a fornire il contributo maggiore (oltre il 50%); il sistema elettrico italiano, cioè, si
affrancherà dalla schiavitù dal petrolio ma diventerà pericolosamente dipendente dal gas, che è già
oggi il combustibile dominante nel mix.
Pagina | 16
3. LA PUBBLICITÁ ED IL CONSUMO DELL’ENERGIA
Consumare e fare la spesa ci sembrano fatti banali che riguardano solo noi, i nostri gusti, le nostre
voglie, il nostro portafoglio, il nostro diritto a non essere imbrogliati. Eppure il consumo è
tutt’altro che un fatto privato e non può essere affrontato basandosi solo sul prezzo e sulla qualità. Il
consumo è un fatto che riguarda tutta l’umanità perché dietro a questo nostro gesto quotidiano si
nascondono problemi di portata planetaria di natura sociale, politica ed ambientale.
L’immondizia deposta per strada accanto a bidoni traboccanti ci ricorda che i consumi generano
inevitabilmente rifiuti che a loro volta creano sempre problemi di inquinamento. I rifiuti finali,
tuttavia, sono solo un aspetto, e forse neanche il più grave, dell’impatto ambientale provocato dai
nostri consumi. Il danno peggiore si ha durante la fase produttiva. In agricoltura l’uso massiccio di
fertilizzanti e pesticidi sta avvelenando le falde acquifere e sta rendendo sterili vaste estensioni di
terra.
I liquami emessi dalle stalle industriali alterano fiumi e terreni. I prodotti chimici che ci vengono
venduti per tenere le nostre case così linde avvelenano le zone di produzione con sostanze tossiche
di ogni tipo. La carta, che ormai utilizziamo per tutti gli scopi, sta provocando un pauroso
impoverimento di boschi e foreste a livello planetario. Non parliamo poi dei gas prodotti dalle
centrali elettriche che producono l’energia necessaria per far funzionare l’imponente macchina
industriale della nostra società dei consumi. Ed ecco il buco dell’ozono che si allarga e l’effetto
serra che avanza.
La pubblicità è una forma di comunicazione atta a presentare e promuovere in modo impersonale
idee, beni o servizi da parte di un promotore ben identificato effettuata a titolo oneroso.
Ne deriva che è innanzitutto una forma di comunicazione e come tale si sviluppa attraverso un
processo bidirezionale che si compone dei seguenti elementi:
Emittente (o fonte emittente): chi emette il messaggio nei confronti di altri soggetti.
Codifica: il processo che riguarda la trasformazione del pensiero in forma simbolica.
Messaggio: l'insieme dei simboli che il comunicatore trasmette.
Mezzo: i canali di comunicazione attraverso i quali il messaggio passa dalla fonte al ricevente.
Decodifica: il processo mediante il quale chi riceve dà significato ai simboli trasmessi dalla fonte.
Ricevente (o destinatario): chi riceve il messaggio.
Risposta: l'insieme di reazioni che il ricevente manifesta dopo essere stato esposto al messaggio.
Retroazione (o feedback): la parte di risposta che chi riceve rimanda alla fonte.
Rumore: una distorsione non pianificata che si manifestata durante il processo di comunicazione,
per cui al ricevente arriva un messaggio diverso da quello emesso dalla fonte.
Affinché tale processo si realizzi, è necessario che emittente e destinatario condividano gli stessi
codici, cioè delle associazioni strutturate, delle convenzioni condivise da chi trasmette e chi riceve,
che permettono di decodificare i segni.
Di seguito ripercorriamo in maniera sintetica i principali momenti dell’evoluzione pubblicitaria
facendo riferimento ai prodotti attraverso cui avviene il consumo energetico.
Pagina | 17
3.1 Negli anni Sessanta
Durante gli anni ‘60, l'Italia divenne un paese prevalentemente industriale, da agricolo che era. I
settori industriali più moderni fecero registrare i progressi maggiori: l'industria automobilistica
(FIAT) e petrolifera (ENI) raggiunsero dimensioni internazionali, come pure la chimica e la
meccanica.
Nel punto culminante del boom economico, parallelo al boom demografico, l’industria soprattutto automobilistica, chimica, delle fibre sintetiche e degli elettrodomestici - diffonde nuovi
miti: la pubblicità si serve ormai di tutti i mezzi disponibili (stampa, televisione, radio) e utilizza
anche scoperte della psicanalisi, martellando il consumatore per convincerlo a comperare sempre
nuovi prodotti o a sostituire quelli che già possiede con gli ultimi modelli. Si costituiscono così,
rapidamente, nuove abitudini. La tecnologia e le comunicazioni di massa promettono un mondo
affrancato dalla fatica, veloce, dinamico, libero.
In questa favorevole circostanza la produzione industriale, tra il 1958 e il 1963, risultò più che
raddoppiata, e interessò anche il mondo domestico con una varietà di prodotti che oscillava dagli
elettrodomestici “bianchi” (cucine componibili, lavatrici, frigoriferi, macchine per cucire) a quelli
“neri” (televisori, radio, telefoni), che nel loro complesso incrementarono anche il volume delle
esportazioni. Furono tanti i significativi contributi di questo periodo, ma quelli che rivoluzionarono
le abitudini domestiche degli italiani furono soprattutto i televisori, le radio e gli stereo che, per
esempio, con le loro trasmissioni e loro linea elegante, resero esteticamente più allettanti le case,
oltre che più gradevoli le serate degli Italiani, imponendosi come rivali del cinematografo. A sua
volta, la macchina per cucire offrì alle casalinghe alcune prestazioni tipiche di macchinari di uso
industriale; anche la lavatrice, che nel giro di pochi anni diventò una macchina insostituibile,
evitando il faticoso lavoro del bucato, come pure il frigorifero, insieme a piccoli elettrodomestici,
come tostapane e frullatori, resero più semplice la vita delle donne.
Da questa attenta analisi del messaggio pubblicitario negli anni 60emerge una realtà importante del
nel nostro Paese: in questi anni si è mirato ad offrire prodotti che consumavano energia, senza
alcuna attenzione per il problema del consumo delle fonti energetiche.
L'aumento della forza produttiva comporta un ampliamento della quantità delle merci disponibili sul
mercato e una conseguente diminuzione dei costi delle stesse, dando l'avvio anche in Italia a quel
circuito produzione-consumo tipico delle società industriali avanzate.
Da questo momento sarà la velocità elettrica, applicata ai congegni per l'automazione e ai
calcolatori, a governare la produzione industriale, rendendo fluide operazioni un tempo parcellizzate
e segmentate. Le novità tecnologiche, inoltre, contribuiscono al mutamento sostanziale di tutto il
sistema sociale: grazie al grande sviluppo dell'informazione e della comunicazione di massa che
divulgano i modelli, si verifica una circolazione senza precedenti non solo di oggetti ma anche di
pensieri in grado di influenzare abitudini e stili di vita.
Per la prima volta in Italia la classe media ha una disponibilità economica che eccede quella
necessaria per fronteggiare i consumi di prima necessità e tutelarsi da eventuali accadimenti futuri,
esiste quindi una quota di denaro che può essere destinata a consumi “voluttuari”, finalizzati a
migliorare la qualità della vita.
Si ritiene che l’obiettivo fondamentale sia quello di consentire ai prodotti un ampia diffusione a
basso costo e alla pubblicità viene chiesto prevalentemente di far conoscere il prodotto.
Sono le grandi agenzie a dirigere le campagne pubblicitarie per le aziende più importanti, mentre le
strutture minori si occupano delle realtà marginali del sistema produttivo. Prima la CPV, poi la
Young & Rubicam ricopriranno il ruolo di “università della pubblicità”1.
Proprio alla Young & Rubicam ci sarà la vera nascita dell' art direction italiana, grazie a noti
fotografi, illustratori, registi – da Art Kane e Richard Avedon a Bookbinder – che collaboreranno
in comune alle campagne pubblicitarie.
1
(Ceserani 1988, p. 155)
Pagina | 18
L’Italia vive in questi anni il periodo del condizionamento dei consumi, dell’assoluta attenzione
alla materialità, alla funzionalità e della dipendenza delle scelte del consumatore indotte dalla
pubblicità.
L’industria, tramite la pubblicità, avrebbe determinato in toto gli acquisti, imposto modelli di
consumo secondo gerarchie imposte che condizionavano la libertà di scelta sul mercato:una sorta di
persuasione occulta di moderni strateghi del consenso che fornisce nuovi avalli alla concezione di
onnipotenza della pubblicità.
Questo è il momento in cui la pubblicità italiana comincia veramente a correre. In tandem col
mondo della produzione, di cui diventa la portavoce, la pubblicità contribuisce a diffondere quella
serie di valori che, in una dichiarazione del 1957, l'artista inglese Richard Hamilton aveva
attribuito alla nascente cultura di massa: “popolare, effimera, facile da buttare, di basso costo,
prodotta in massa, rivolta ai giovani, spiritosa, sexy, appariscente, grosso affare”1. La pubblicità
dei primi anni Sessanta, inoltre, taglia rapidamente i ponti col passato: il nuovo stile è in sintonia
con il rinnovamento generale dei gusti, è agile e scattante nelle sue formulazioni, prende le
distanze dai modi educativi del decennio precedente e si tuffa nella trascrizione di un mondo
trasformato dalle merci.
La pubblicità viene vista come mezzo di diffusione alternativo di un nuovo stile. “La pervasività del
linguaggio pubblicitario produce una cultura collettiva nuova, che cambia il modo di guardare alla
merce e al suo aspetto estetico”2.
Nei manifesti di questi anni, gli orpelli del linguaggio, le didascalie informative e il troppo parlato
del decennio precedente lasciano il posto all'impatto visivo del prodotto, che appare isolato,
liberato dal contesto e ingigantito a dismisura(Leader, Stice frigoriferi, 1964) o raffigurato solo in
una sua parte. Tipico del periodo è il ricorrere al dettaglio o al particolare, come una mano, un
occhio o una bocca. Esempi tipici sono di Publinter Ayer, Borotalco Manetti & Roberts, 1968; di
A. Testa, Stilla, 1966; Ata Univas, Sanagola Alemagna, 1967. Alcuni esempi rimandano ad un
tappo o un'etichetta (Leader, Acqua Ferrarelle, 1965), per evocare l'idea della totalità: attraverso
la sineddoche, una parte per il tutto, si evidenzia un aspetto peculiare capace di sintetizzare il
concetto che ne sta alla base.
Fig. 1 Agenzia Leader, Acqua Ferrarelle, 1965
1
(cit. in Grandi, Vaccari, Zannier 1992, p. 52)
(Dorfles 1998, p. 100)
2
Pagina | 19
Fig.2 R. Savignac, Olivetti Lettera 22, 1950-‘54
Fig. 3 A.Testa, Pirelli, 1954
Dal punto di vista delle soluzioni grafiche si può dire che comincia una vera e propria corsa verso
l'ottimizzazione dei marchi, che in questo periodo assumono per la maggioranza delle aziende una
veste destinata a durare fino ai giorni nostri: si pensi ad esempio ai marchi Pirelli, Esso, ecc.
Contemporaneamente si comincia a coniugare l'ambito della comunicazione verbo-visiva nello
slogan, nella frase o nella parola ad effetto in grado di entrare nel vocabolario quotidiano della
gente.
Se si considerano i contenuti della pubblicità negli anni ’60, al di là dell’apparente varietà delle
argomentazioni si nota che in modo implicito essi veicolano senza sbavature o incertezze un unico
tipo di messaggio: quello della cultura del consumo, del primato dell’avere sull’essere.
Se la TV fu il maggiore strumento di unificazione linguistica e culturale dell’Italia del miracolo, la
Lambretta, la Vespa e, ancora di più, l’automobile furono l’espressione principale di una supposta
parificazione economica e sociale, il simbolo di una nuova indipendenza e di una nuova libertà di
movimento.
Fig.4 Automobile Fiat 600
Fig.5 Negli anni ’60 sono diffuse le
automobili E vengono usate dai ceti benestanti
Pagina | 20
Fig.6 La vespa era un prodotto nuovo innovatovi per quegli anni
I prodotti abbandonano il contesto di appartenenza, diventano immagini a se stanti che
campeggiano nella loro nuova monumentalità di icone, spesso in forma di fotografia realista seppur
ritoccata, oppure spesso sono uniformate cromaticamente con lo sfondo, che invece si colora in
toni antinaturalistici, come il rosa shocking o il giallo acido, e mostra volutamente la grana del
retino tipografico (Centro, Pneumatici Velo Pirelli, 1964).
Fig.7 Agenzia Centro, Pneumatici Velo Pirelli, 1964
Fig.8 Lenzi, Agenzia Centro, Benzina Total, 1966
Pagina | 21
Se si ricorre all'illustrazione, questa è estremamente scarna e stilizzata, i contorni sono netti, ben
stagliati e riempiti da masse di colore a stesure omogenee, piatti e squillanti, come sono appunto i
colori industriali (Centro, Benzina Total, 1966) talvolta si ricorre persino al fumetto inventando
personaggi ad hoc o prendendone a prestito alcuni tra i più in voga (Mc Cann-Erickson, Esso Extra,
1963; Masius, Benzine BP, 1966).
Fig.9 Agenzia Mc Cann-Erickson, Esso Extra, 1963
Pagina | 22
Analizziamo la struttura di alcuni messaggi pubblicitari:
-
Dati del messaggio
Prodotto pubblicizzato: lavatrice CGE
Tratto da: giornale quotidiano
Anno: 1960
Emittente: CGE i riceventi sono i lettori del giornale, in prevalenza le donne
Codice: La pubblicità è interamente in lingua italiana.
- Analisi sintattica:
In alto la headline è composta da un messaggio che vuole sottolineare la funzionalità, lo
sviluppo tecnologico avvenuto negli ultimi anni, attraverso la centralità dell’avverbio.
In posizione centrale compare la marca affiancata dalla figura femminile.
In basso è presente una descrizione dettagliata del prodotto:per precisare la diverse funzioni
dell’oggetto.
I caratteri vengono scritti in modo diverso per inquadrare i diversi aspetti dell’oggetto in
questione.
- Registro visivo
Compare nella pubblicità il contrasto tra chiaro e scuro. Lo spazio della pubblicità è diviso
equamente tra immagine e parte verbale. Oltre al prodotto pubblicizzato vengono raffigurate
figure umane (una madre con dei bambini).
- Analisi semantica
Rapporto tra visivo e verbale
La headline ha un rapporto molto stretto con il prodotto pubblicizzato e con la descrizione in
fondo alla pagina.
La scritta “AUTOMATICAMENTE” sottolinea il grosso potenziale tecnologico della
lavatrice.
La scrittura più piccola sotto il titolo “ per ogni esigenza un risultato meraviglioso “
rispecchia la soddisfatta esigenza di una madre che non deve più lavare a mano i panni.
La frase “Possiede la più ricca esperienza di lavaggio” è riferita alla lavatrice che possiede
esperienza e utilità, ma anche all’esperienza della madre che deve lavare i vestiti dei figli.
Sfondo: nero. Lo sfondo mette in risalto il bianco della lavatrice e i vestiti dei due bambini
che sono bianchi, che confermano la funzionalità della lavatrice.
Il messaggio è quello di sottolineare l’aspetto funzionale del prodotto pubblicizzato.
Pagina | 23
FIDATEVI DI PHILIPS
-
Dati del messaggio
Prodotto pubblicizzato: lampadina Philips
Tratto da: giornale quotidiano
Anno: 1960
- Analisi sintattica
Il messaggio fa parte della campagna pubblicitaria della Philips, è totalmente in lingua
italiana.
Emittente: la Philips, il ricevente sono i lettori del giornale, indiscriminatamente.
- Registrazione verbale
La pubblicità ha una headline in fondo alla pubblicità, scritta con due caratteri diversi e due
grandezze di scrittura.
In fondo alla pubblicità, oltre allo slogan, c’è una frase in un altro stile.
- Registrazione visiva
L’immagine nella pubblicità raffigura una lampadina con all’interno quattro monete.
È caratterizzata da contorni ben definiti. La figura è su sfondo bianco.
- Analisi semantica
Il rapporto tra visivo e verbale è contraddistinto dall’uso di chiari e scuri tra la
lampadina e la parte scritta. Le parti bianche simboleggiano il potenziale energetico creatosi dalla
corrente e quindi la luce, mentre le parti scure e le parti più spesse rappresentano la qualità del
risparmio, la convenienza del prodotto rappresentato da quella marca.
L’immagine occupa maggiore spazio della parte scritta.
La scritta “FIDATEVI DI” scritta con un carattere grassetto, ma non pieno, fa riferimento alla
parte bianca della lampadina, cioè al suo potenziale. Questo messaggio vuole essere chiaro e
rassicurante.
La parte di testo in cui viene sottolineata l’importanza della marca è scritta con un carattere più
spesso che fa riferimento alla parte più bombata della lampadina nella quale ci sono le monete:
questa parte del testo deve garantire in fatto di risparmio economico.
La scritta sottostante alla marca serve a sottolineare l’importanza del risparmio energetico e
l’importanza della marca.
Pagina | 24
Il messaggio di questa pubblicità è quello di sottolineare la convenienza economica ed energetica
della lampadina. Trattandosi di un oggetto puramente funzionale, la pubblicità non richiama
particolari accorgimenti di stili.
3.1.1 Carosello
Un evento di grande interesse economico e sociale è costituito, in questi anni, dal successo del
Carosello.
Prima l’Italia aveva vissuto la pubblicità attraverso i manifesti, gli annunci stampa, i pochi film
pubblicitari nelle sale cinematografiche, la radio: la televisione diffonde prodotti fino ad allora
sconosciuti, impone nuove marche, nuove abitudini di consumo e di vita. Nell’Italia povera del
dopoguerra, Carosello fece apparire il mondo dei consumi come un mondo di magia, traghettando
delicatamente gli Italiani verso la modernità. Carosello fu per molti anni l’unico spazio che la
televisione italiana dedicò alla pubblicità. Tutto ebbe inizio il 3 febbraio del 1957 alle 20:50.
Carosello era strutturato in quattro episodi preceduti e seguiti da un siparietto musicale: le prime
aziende inserzioniste furono Shell, Oreal, Singer, Cynar. Andava in onda dopo il telegiornale
dell’unico canale televisivo Rai. Nel palinsesto televisivo di quegli anni, Carosello è un elemento di
rottura, una ventata di divertimento in una televisione nata per educare e acculturare gli Italiani.
L’apparecchio televisivo era ancora poco diffuso a causa degli alti costi ( circa il triplo dello
stipendio di un impiegato); la gente seguiva quindi i programmi nei locali pubblici, al bar o a casa
di un vicino facoltoso.
Fig.10 I bar diventano luogo di incontro per guardare la televisione, allora poco conosciuta
Pagina | 25
È proprio con la nascita di Carosello che la televisione passa da oggetto di consumo occasionale,
collettivo e ancora molto limitato nel tempo, ad un ascolto domestico di massa, veicolo
interessante di pubblicità.
Carosello doveva sottostare a rigide norme imposte dalla Sacis in seguito all’accordo tra Rai e
Ministero delle Poste.
Le principali regole cui doveva sottostare erano le seguenti: una netta separazione tra parte di
spettacolo, il “pezzo”, e parte pubblicitaria, il “codino”; nella parte di spettacolo non si poteva
accennare in alcun modo al prodotto reclamizzato; il nome del prodotto o della marca non potevano
essere pronunciati o scritti più di sei volte; la parte di spettacolo non poteva essere interrotta; nessun
pezzo poteva andare in onda più di una volta; non potevano comparire marche produttrici dei
medesimi beni di consumo nella stessa trasmissione.
Carosello rappresentò la via italiana alla pubblicità televisiva, nato da un compromesso tra le
esigenze pedagogiche della televisione di Stato e le esigenze di un Paese che andava rapidamente
verso la modernità.
I film di azione realizzati diedero vita a personaggi di fantasia che si sono imposti stabilmente
nell’immaginario collettivo.
L’epoca di Carosello era stata segnata dagli alti costi che le aziende inserzioniste avevano dovuto
affrontare per fare questo tipo di pubblicità televisiva, che prevedeva anche lo “spettacolo”, il
quale rappresentava una storia chiusa, senza riferimenti diretti al prodotto.
Nel 1976 il Presidente della Rai decide di sospendere il Carosello, suscitando una serie di reazioni
negative sulla stampa.
L’Associazione dei pubblicitari Italiani aveva infatti chiesto alla Rai di sopprimerlo per dare spazio
anche alle aziende che non potevano permettersi i costi elevati di quel genere di pubblicità.
Le aziende chiedevano ormai spot brevi, che si potessero ripetere, che si potessero concentrare sul
prodotto.
Nonostante questi accorgimenti gli anni del boom economico il mondo della pubblicità dovette
attraversare in tutti i paesi industrializzati una crisi che era economica, ma soprattutto culturale. I
pubblicitari, infatti, subirono numerose critiche da parte degli intellettuali e dai giovani che
condividevano ideologie anticonsumistiche.
Queste ultime rimproveravano a chi promuoveva i prodotti di creare negli individui bisogni di
consumo falsi e superflui.
3.2 Negli anni Settanta
Gli anni settanta si presentarono come un periodo particolarmente difficile per il rallentamento del
tasso di sviluppo economico, accentuato dalla crisi petrolifera del 1973. L’aumento del costo del
petrolio innesca lo sviluppo di un processo inflazionistico, che porta alla diminuzione del potere di
acquisto, in modo particolare delle classi medie, cioè dei protagonisti del cosiddetto boom
economico, che aveva sostenuto la crescita italiana del decennio precedente.
La diminuzione della domanda con un conseguente surplus di offerta genera un aumento della
pressione competitiva. Le aziende cominciano ad avere la necessità di attuare politiche commerciali
più aggressive, agendo in modo più massiccio sulla leva pubblicitaria.
In questo decennio, la pubblicità deve affrontare in tutti i paesi industrializzati gravi difficoltà, sia
economiche che culturali. La crisi petrolifera del 1973 e le crisi economiche degli anni seguenti
portarono ad un pesante rallentamento degli investimenti in pubblicità delle aziende per tutta la metà
degli anni Settanta.
Pagina | 26
L'intervento di sostegno alle imprese si caratterizza, quindi, per una forte componente
"assistenziale" di società non più a scopo di lucro, ma di pubblicità progresso. Le stime sui ritorni
economici che sarebbero entrati nelle casse dello stato dalla nazionalizzazione del settore elettrico si
rivelano utopistiche, anzi, anche l'Enel entra in una crisi finanziaria di tale gravità che impone, nel
1973, la costituzione di un fondo di dotazione. Il settore elettrico, in mano privata produceva utili
per gli azionisti, in mano pubblica debiti a carico del Paese.
A seguito della prima crisi petrolifera, tutti i maggiori paesi industrializzati avviano politiche di
diversificazione delle fonti energetiche, per ridurre la dipendenza dall'estero; l'Italia che è il Paese
con la massima dipendenza tra tutti quelli industrializzati, vara una serie di piani energetici, che
prevedono ambiziosi programmi nucleari. Ma tutto resta solo sulla carta.
Nel giugno 1979, l'Eni firma con Petromin, l'organismo pubblico che in Arabia saudita tratta le
forniture di greggio, un contratto triennale. Petromin si impegna a fornire all'Eni 91 milioni di barili
di petrolio in tre anni, al prezzo di diciotto dollari al barile.
Nonostante la crisi nel settore automobilistico degli anni ‘70 il mercato dell’automobile era un
mercato di “domanda”.
La capacità produttiva dei costruttori era inferiore alla domanda di prodotto dei consumatori . Il
cliente aspettava anche un anno la vettura da lui ordinata, non chiedeva sconti, era poco informato
e con basse aspettative sia dal prodotto che dalla rete di vendita. Le case costruttrici sfornavano
prodotti appena sufficienti e i venditori si preoccupavano solo di raccogliere ordini. I corsi sulle
tecniche di vendite erano concentrati soltanto
sulle velocità di conclusione della trattativa e
null’altro.
Fig.11 Pubblicità di una vettura commerciale degli anni ’70
Fig.12 Fotografia recente di una macchina degli anni ‘70
Nel settore industriale, invece, a seguito delle crisi energetiche degli anni Settanta, il peso del
petrolio sui consumi dell'industria cominciò ad essere ridimensionato
Ma la crisi petrolifera ebbe anche l'effetto secondario di rivolgere l'attenzione dei Paesi
industrializzati verso la ricerca di nuove fonti energetiche. Furono infatti gli anni '70 a portare alla
nascita di una nuova scienza, l'ecologia, ed alla ricerca di fonti energetiche alternative al petrolio
(ricerca che proseguì intensamente solo fino al 1985, anno in cui calò il prezzo del grezzo).
La ricerca intensa diede anche vita a quella che oggi viene chiamata 'la seconda rivoluzione
industrialè: la nascita dell'elettronica, dei computer, e, conseguentemente, anche dell'informatica.
Negli anni ‘70 il consumatore appare più cosciente, vuole riorganizzare la scala dei propri valori e
delle proprie preferenze; ci si trova dunque di fronte ad una maggiore responsabilità nelle scelte
Pagina | 27
d’acquisto con un conseguente investimento nelle grandi marche. In molti casi la qualità è preferita
alla quantità, la varietà fa premio sulla fedeltà alla marca. Non va dimenticato il fenomeno
dell’urbanizzazione e della socializzazione della nuova cultura urbana di grandi masse di persone
provenienti da una realtà di tipo rurale, dove la metropoli e le sue strade vanno a costituire un
nuovo territorio fisico e culturale insieme.
In quest’ambito la nascita della pubblicità e della modernità possono essere comprese in modo
completo anche grazie alla relazione con altri fenomeni della visibilità che si sviluppano nello stesso
periodo come ad esempio la moda.
D’altra parte, se gli anni Sessanta sono stati gli anni del boom economico e dell'apparente
accessibilità al tanto agognato benessere, con gli anni Settanta anche il consumismo viene messo in
discussione. L'azienda non è più vista, necessariamente, come fonte di benessere e via per il
progresso; ci si batte contro il consumismo sfrenato e la pubblicità è tra i nemici numero uno. Causa
di alienazione, manipolatrice di cervelli, è lei ad indurre il pubblico a spese futili ed irragionevoli.
Le campagne diventano serie, sobrie, corte. Gli annunci-stampa presentano severe fotografie di
prodotti scontornati su fondo bianco, accompagnate da lunghi testi di spiegazione.
Spesso l'immagine manca del tutto; non un disegno, non una figura, nessun fumetto e nessuna
grafica stuzzicante a catturare l'occhio del lettore, solo testi, e il più delle volte scritti con i caratteri
meno opportuni.
I visual sono in questi decenni quasi assenti. Quando l'illustrazione c'è, essa si presenta a dir poco
statica e senza prospettiva. Il visual non risulta pratico, non rende più facile la comprensione del
testo, non rappresenta il prodotto nel miglior modo possibile. Si prenda, ad esempio, una qualsiasi
pubblicità di automobili: queste raramente sono sprovviste di illustrazione. Oltre e alla mancanza di
scenografia, spesso non sono neppure
presenti persone che possano rendere più
credibile il prodotto pubblicitario. In tal
modo, ciò che viene esposto rappresenta
soltanto se stesso e non ciò che avrebbe
potuto fornire all'acquirente: comfort,
sicurezza, serenità,
È la parola la vera protagonista,
l'immagine rimane sullo sfondo. Anche
lo spazio è sacrificato, la dimensione
degli annunci è ridotta, anzi ridottissima:
si possono trovare pubblicità che non
superano i cinque centimetri di base per i
due centimetri di altezza.
Gli annunci non possono presentarsi
mastodontici e trionfalistici; i modi di
comunicare sono sommessi e sottotono.
In questo decennio ciò che conta è
presentare il prodotto nel modo più
funzionale possibile, quello che si vuole
e si richiede è l'effettiva dimostrazione
delle sue qualità.
Pagina | 28
Fig.16 La pubblicità, in questi anni, si propone a favore della ricerca per inquinare meno l’ambiente.
Il linguaggio appare informale, distaccato, rispettoso, ma anche prolisso e macchinoso. La
maggior parte degli annunci, infatti, si presenta con lunghe headline, per non parlare dei testi, che
risulta difficile riassumere in poche parole-chiave.
Conseguentemente neppure alcune figure retoriche, successivamente spesso e volentieri utilizzate,
hanno largo consenso nel mondo pubblicitario; di rado si usano metafore, similitudini, ellissi. Data
la natura dei testi degli annunci, non breve e molto descrittiva, risultano più funzionali le
ripetizioni o le enumerazioni. Come esempio di enumerazione pensiamo alla pubblicità della
Renault che aveva la bodycopy, divisa in quattro punti attestava: “1. La felicità di stare comodi in
cinque; 2. La felicità di consumare meno; 3. La felicità di sentirsi al sicuro; 4. …e di spendere
meglio i propri soldi” (“ La Repubblica ” giugno 1976). ^
Un'importante distinzione tra gli annunci degli anni Settanta e quelli più recenti sta nel non attirare
l'attenzione del lettore con alcune parole potenti, per poi lasciare alla bodycopy la funzione di
elencare e sintetizzare i pregi del prodotto, fin dal titolo, a scanso di equivoci.
Pagina | 29
Analizziamo la struttura del messaggio pubblicitario di questi anni
-
-
Dati del messaggio
Prodotto pubblicizzato: bicicletta elettrica della Piaggio
Tratto da: giornale quotidiano
Anno: 1970
Emittente: l'azienda Piaggio, un’azienda che da anni è nel settore dei prodotti per
motoveicoli.
Riceventi: i lettori delle riviste, è rivolto indiscriminatamente, ma come si può vedere
dall’immagine è anche aperto al mondo femminile.
Codice : La pubblicità è in lingua italiana.
Analisi sintattica
È posizionato in alto lo slogan: “le sardomobili mangiano l’asfalto frafole ‘chi Ciaò ”.
Tale definizione venne presa da una fortunata e martellante campagna pubblicitaria della
Piaggio che, tra i diversi slogan, recitava: "Le sardomobili hanno cieli di latta. Liberi chi
Ciao".
Il termine “Sardomobile” ha il significato metaforico con in quale, negli anni '70, veniva
definita l'automobile dagli appassionati dei veicoli a due ruote. In quegli anni, molti erano
ancora i sostenitori della supremazia del mezzo a due ruote per la mobilità autonoma urbana
ed extraurbana che, con il termine "sardomobili", intendevano sottolineare il grande senso
di libertà della moto.
Lo slogan in alto viene scritto con due caratteri diversi evidenziare il nome del prodotto.
Nel basso viene inserita la spiegazione del funzionamento del mezzo scritta in un carattere
piccolo per non disturbare l’intera pubblicità.
Pagina | 30
-
In basso viene messo il marchio con il suo slogan per associare l’immagine con il messaggio
della pubblicità. Anch’esso viene scritto con un carattere diverso dai precedenti, ma
ugualmente visibile per identificare chiaramente quale è il marchio produttore.
Relazioni spaziali. La pubblicità è divisa in due parti: la prima, minoritaria, comprende lo
slogan e un immagine di pesci colorati; la seconda, la maggioritaria, comprende l’immagine
della bicicletta elettrica con una donna in mezzo alla natura, per sottolineare che è un
prodotto ad emissioni “zero”.
Concludendo, questa pubblicità richiama fortemente l’utilizzo dello slogan, come
riconoscimento del marchio in questione ed è una delle prime pubblicità di questi anni
rivolta al benessere dell’ambiente.
Pagina | 31
3.3 Negli anni Ottanta
A partire dai primi anni ’80 si sono cominciati a sviluppare in tutta Europa studi per individuare
pratiche e strumenti utili a supportare i decisori pubblici - nazionali ma anche, e forse soprattutto,
regionali -nella pianificazione strategica delle scelte energetiche. La maggior parte di questi studi a
partire dall’analisi della domanda energetica, prevedeva l’elaborazione di scenari di previsione,
l’elaborazione di bilanci energetici, la valutazione del potenziale delle fonti energetiche rinnovabili
e le interazioni tra ambiente e produzione di energia. In pratica si sono andati sviluppando tutti
quegli aspetti conoscitivi necessari all’adozione di una vera e propria pianificazione strategica delle
politiche energetiche. Tutto ciò si colloca in un contesto storico che, inizialmente, si presentava con
una situazione economica non particolarmente positiva: l’inflazione, la crisi industriale diffusa,
l’elevato costo del denaro, l’aumento della disoccupazione.
La maggior parte dei mercati si trovano già in uno stadio di maturità, in una situazione in cui non
crescono più.
Questo genera un incremento della competività, le aziende hanno la necessità di soddisfare i bisogni
dei clienti, anche quelli marginali, in modo piu’ efficiente ed efficace della concorrenza.
La pubblicità e le promozioni divengono strumenti molto importanti all’interno del marketing delle
aziende. Le ricerche psicografiche e e sugli stili di vita, contribuiscono all’affinamento del
linguaggio pubblicitario.
Nel corso degli anni 80 lo scenario economico muta sensibilmente, si assiste alla ripresa economica,
con un conseguente aumento della domanda.
Nel mercato si manifestano alcune tendenze:
- consumatore edonista
- aumento della concorrenza
- integrazione industria- terziario
- accelerazione tecnologica
Sul piano del linguaggio, i pubblicitari, terminata la fase di crisi degli anni settanta, poterono
riattivare il coraggio di esprimersi in totale libertà e ispirati anche dalla parallela espansione del
mezzo televisivo e dei suoi vivaci programmi, cercarono spesso di attribuire alla pubblicità un
carattere altamente spettacolare.
Il pubblicitario francese Jacques Sequela, con la sua agenzia RSCG, è stato quello che piu’ ha
teorizzato, ma soprattutto praticato con diverse aziende(ad esempio Citroen), la cosiddetta
pubblicità-spettacolo.
Lo spettacolo della pubblicità determina la vita stessa delle marche.
La situazione che si viene a creare enfatizza progressivamente il ruolo della marca come punto di
riferimento delle scelte dei consumatori e delle strategie di comunicazione delle aziende.
L’immagine di marca funge contemporaneamente da garanzia della qualità dei prodotti e da
elemento di differenziazione. La pubblicità dedica sempre meno attenzione alle caratteristiche
intrinseche dei prodotti e sempre più alla creazione di un sistema di valori associabili alla marca.
Basterebbe il termine “immagine” per definire gli annunci degli anni Ottanta. Tutti sono basati su di
un visual, la parola è oramai in secondo piano. Anche se l'uso del colore è ancora molto raro, salta
subito agli occhi che la staticità del decennio precedente è sparita. Le illustrazioni suggeriscono
movimento ed è la persona il soggetto più rappresentato. Gli annunci degli anni Settanta con le sole
foto dei prodotti sono superati. Ora deve esserci un contesto, una storia, una qualsiasi relazione con
il mondo reale.
Il decennio più contraddittorio del dopoguerra è stato caratterizzato da uno sfrenato individualismo,
da un irrilevante impegno sociale e da un consumismo senza precedenti. Si assiste, di conseguenza,
ad una piena assoluzione della pubblicità.
Ciò si può evincere dalla scelta del linguaggio utilizzato. Informale, sicuro di sé, amichevole ed
ammiccante, questo è il modo di comunicare degli annunci degli anni Ottanta. Inoltre, si inizia a
tralasciare la descrizione, ma ci si inizia a concentrare sul messaggio principale. Si coniano nuovi
Pagina | 32
termini o si fa il verso a titoli di film, proverbi e modi di dire. Così, nascono Velocizzatevi, slogan
della nuova Ford Fiesta 50 (“L'Unità” ottobre 1987), “Nuova Audi 90. Il Sorpasso (“Corriere della
Sera” settembre 1987). La parola inizia il suo declino e attende inerme il suo destino da latitante del
nuovo millennio.
L’'intreccio tra pubblicità su carta stampata e televisione si fa sempre più stretto. Sui quotidiani non
vengono più presentati solamente i palinsesti della giornata, ma si reclamizzano in separata sede
programmi di intrattenimento e film. Nel 1974 la Corte Costituzionale liberalizza la trasmissione
locale via cavo, due anni più tardi dichiara legittime le televisioni e le radio via etere, purché
agiscano in ambito locale. I grandi editori cominciano ad interessarsi alla televisione: Rusconi,
Rizzoli, Berlusconi.
Le conseguenze nel mondo pubblicitario sono notevoli: il mercato si allarga. Nelle televisioni
private gli spot si moltiplicano, creando sovraffollamento. La stampa entra in crisi a causa del calo
degli investimenti pubblicitari, che passano da un 65% sul totale negli anni Settanta al 50% nei
primi anni Ottanta. Cambia anche il mestiere del pubblicitario, prima incentrato sull’impaginazione
di un annuncio stampa, ora alle prese con lo spot.
Negli anni Ottanta il rapporto tra pubblicità e televisione si fa sempre più stretto. Con la nascita
delle televisioni commerciali. I contenuti delle tv si adeguano alle necessità degli investitori. I
conduttori stessi si portano dietro in dote una serie di sponsor. Crescono gli investimenti
pubblicitari, sull’onda del falso boom economico. Le agenzie multinazionali diventano più grandi,
allargano lo spettro di servizi anche a promozioni, direct marketing . Il consumo assume un ruolo
importante poiché la marca esprime lo status sociale del consumatore, “possiedo dunque sono”.
Dopo la contestazione degli anni Settanta e la crisi degli anni di piombo si ritorna ai valori
occidentali, all’estetica personale, alle griffe, alla ricerca del benessere individuale.
Fig. 17 La pubblicità rappresenta un chiaro esempio dell’utilizzo dello slogan all’interno della pubblicità (“Razza
vincente”)
Pagina | 33
Analizziamo la pubblicità di un prodotto a consumo energetico.
Prodotto pubblicizzato: Olio lubrificante Shell
Tratto da: Campagna di affissioni e inserzioni su riviste
Anno: Autunno-Inverno 1980
Il messaggio fa parte della campagna pubblicitaria. L'emittente è l'azienda Shell, i riceventi i lettori
delle riviste, coloro che osservano i manifesti. Come sempre in pubblicità, i discorsi sono asincroni,
la struttura partecipativa è non paritaria. L'emittente è un soggetto inanimato. L'azienda Shell opera
da anni nel settore dei prodotti per l’automobile. Lo stile di discorso della Shell si è sempre distinto
per il carattere di citazione: citazione dello stile pubblicitario americano anni '50. La pubblicità è in
lingua italiana.
Il colore rosso accomuna molti elementi figurali: la cornice, il colore dell’auto, il marchio Shell.
Il nero sotto le ruote crea l’idea dell’asfalto su cui la macchina corre veloce.
Pagina | 34
3.4 Negli anni Novanta
La centralità della pianificazione strategica energetica viene sancita definitivamente agli inizi degli
anni ‘90 dalla Commissione Europea con la COM (91) 53 che ha ad oggetto proprio lo stato di fatto
e le prospettive della pianificazione energetica nella Comunità Europea. In questo documento viene,
in particolare, posto l’accento sull’importanza della pianificazione energetica a livello regionale e
locale poiché è a questa scala che si ritiene si possa agire per incidere effettivamente sul
miglioramento della gestione della domanda energetica e per avviare uno sfruttamento pieno ed
efficiente delle risorse energetiche non tradizionali disponibili. In questa Comunicazione viene,
inoltre, analizzata la complessità inerente alla pianificazione energetica. Essa deve, infatti, tenere
conto di una molteplicità di aspetti che vanno dai costi diretti degli interventi agli impatti sullo
sviluppo economico, dall’impatto ambientale all’accettabilità sociale delle misure, dalla
disponibilità di informazioni alla capacità locale di accedere alle tecnologie.
La crescita economica registrata nella seconda metà degli anni 80 si esaurisce progressivamente fino
a concludersi nei primi anni novanta.
Le famiglie italiane si trovano così a vivere una situazione di duplice disagio: da un lato la
diminuzione del potere di acquisto del reddito disponibile, e dall’altro l’incertezza sul futuro.
Tutto ciò favorisce una maggiore attenzione nei consumi ed una maggiore selettività nelle scelte che
tendono a privilegiare i prodotti che offrono un vantaggioso rapporto tra qualità offerta ed il prezzo.
La marca, assoluta protagonista degli anni Ottanta, entra in crisi ed anche gli approcci utilizzati sino
ad allora in pubblicità incominciarono ad essere meno efficaci.
Ci sono naturalmente eccezioni positive. Una di queste è rappresentata dall’azienda Pirelli e dai casi
in cui le aziende hanno saputo parlare un linguaggio internazionale fatto di originalità creativa,
ironia ed elevata qualità estetica sul piano visivo.
All'inizio degli anni Novanta grava sull'Italia una pesante recessione economica e di conseguenza
gli investimenti pubblicitari vengono drasticamente ridotti. La pubblicità entra in crisi sul finire del
1992, “il trend di espansione precedente si riduce notevolmente, soprattutto in rapporto
all'eccezionale livello di incremento che si era registrato nel periodo 1978- 1984” 1. L'inizio del
decennio è connotato da un grosso mutamento nel settore della distribuzione: i punti vendita sono
sempre più nelle mani di pochi grandi operatori e cominciano a fiorire nel nostro paese i primi harddiscount. Il prodotto di marca è in forte discesa. Solamente gli ultimi anni Novanta vedono il
risorgere del mercato pubblicitario, aiutato da nuovi settori, come quello della telefonia mobile.
Gli investimenti pubblicitari sono così caratterizzati da importanti cambiamenti. Vengono, infatti,
ridotte le spese riservate “ai settori tradizionali di largo consumo, come gli alimentari e le bevande
alcoliche, a vantaggio di settori emergenti che hanno bisogno di farsi conoscere: turismo,
informatica, nuove tecnologie di comunicazione, banche, assicurazioni. I prodotti trattati sembrano
dunque essere sempre più immateriali: puro servizio e pura immagine” 2.
A fronte della situazione in cui grava la pubblicità, anche il suo linguaggio si fa più modesto e
sottotono. Vi è una sorta di “ritorno al prodotto”, alla sua funzionalità; i toni esaltati degli anni
Ottanta non trovano più spazio.
Le headline, se negli anni Settanta puntavano sulla qualità del prodotto, ora cercano di indirizzare
l'attenzione sulla convenienza: Citroën presenta le offerte con i piedi per terra (“ La Repubblica ”
ottobre 1996), oppure, Chi va piano con i soldi va lontano con Ibiza (“Corriere della Sera” gennaio
1996). Anche il marchio Moschino paradossalmente recita: Cheap and Chic .
I visual vengono minimizzati e resi sobri..
Negli anni Novanta nascono le televisioni tematiche. La marca industriale entra in crisi con la crisi
economica dei primi anni Novanta, nascono gli hard discount. Emerge una nuova figura di
consumatore, più attento non solo alla qualità dei prodotti e al loro prezzo, ma anche alle valenze
1
2
(Zanacchi 1999, 125)
(Brigida, Baudi di Vesme, Francia 2003, 29)
Pagina | 35
etiche del consumo. Come avviene la produzione? Si rispetta la natura? Viene sfruttata
manodopera? L’azienda è attenta all’ambiente e alle risorse umane che vi operano?È in questo
periodo che si comincia a parlare di fonti di energia alternativa.
Fig.13 Pubblicità degli anni ’90 di un termosifone esaltando le sue funzioni e la sua convenienza
Anche le aziende decidono di investire nel sociale attraverso il Cause Related Marketing.
Si sviluppano forme di comunicazione commerciale diverse dalla pubblicità classica, quella
veicolata dai mass media. Ciò è reso possibile anche dallo sviluppo di nuove tecnologie Internet e
telefonia cellulare
che consente di raggiungere il consumatore con una comunicazione
personalizzata, mirata alle sue esigenze, in alcuni casi richiesta come servizio.
Anche il termine “consumatore” sembra superato dall’idea di “persona che compie scelte di
consumo”, come tutti facciamo, in modi diversi e non prevedibili nell’arco della giornata e della
vita.
La sfida tra le aziende si sposta sul terreno delle emozioni, sul reciproco scambio di valore tra
azienda produttrice e consumatori. Compito della pubblicità è coinvolgere emotivamente,
generando un vantaggio competitivo non più basato sulle differenze tangibili tra i prodotti, ormai
standardizzati per prestazioni e qualità, ma sulla relazione con il consumatore, che non può
limitarsi al momento dell’acquisto. Con in nuovi mezzi di comunicazione la pubblicità diviene “su
misura” e interattiva. Anche se gli investimenti pubblicitari in Internet sono ancora contenuti, le
aziende sono convinte che quello sarà il futuro della comunicazione con i propri clienti, per i costi
contenuti, per la possibilità di interazione, per i nuovi linguaggi che è in grado di sviluppare, per la
comunicazione ad personam. Oggi tuttavia Internet non è ancora un mezzo per raggiungere le
grandi masse come avviene ancora con la televisione.
Fig.14 È in doppia Classe A per efficienza energetica ed efficacia di lavaggio
Pagina | 36
Analisi di una pubblicità
Prodotto pubblicizzato:auto Daihatsu Sirion
Anno: 1990
Emittente: l’azienda Daihatsu.
Viene rappresentata un’auto Daihatsu Sirion di colore rosso, in primo piano, in posizione ¾, in
una piazza di città.
Caratteristiche eidetiche: Le forme sono normali.
Caratteristiche cromatiche: L’auto è rossa, e si contrappone allo sfondo che è grigio, l’auto è più
illuminata rispetto a tutto il resto.
Caratteristiche topologiche: L’auto è posta al centro dell’inquadrature in posizione ¾. In alto a
sinistra si trova un simbolo che rappresenta il centesimo anniversario della casa automobilistica. In
alto a destra compare la garanzia dell’auto. Il copy è in alto al centro. In basso a sinistra troviamo
l’offerta relativa all’acquisto dell’auto. In basso a destra il logo.
L’asse di lettura è a Z.
La messa in scena dell’auto mira a ridurre le distanze tra azienda e consumatore, in virtù del fatto
che sotto l’auto, c’è una sezione in cui vengono presentati i modelli, gli optional, i vantaggi e il
prezzo dell’auto. Inoltre l’auto viene presentata come una city car, quindi bassi consumi e risparmi.
Il messaggio che la pubblicità da è di una macchina piccola, dai bassi consumi, a un prezzo
ragionevole adatta al traffico urbano.
Pagina | 37
3.5 Nel Duemila
Nel periodo 2000 – 2005 il consumo energetico totale in Europa è aumentato del 14%, nonostante
miglioramenti nell’efficienza dell’uso dei combustibili e della produzione di elettricità.
Nel 2000 il 79% del fabbisogno energetico totale dell’UE è coperto da combustibili fossili (petrolio,
gas e carbone), il 15% dal nucleare, e il 6% da fonti rinnovabili ( 5% da centrali idroelettriche e
solo 1% da impianti solari, eolici, geotermici e da biomasse).
È assodato in questo periodo che il consumo di energia non rinnovabile porta all’impoverimento
delle risorse naturali e ha un impatto notevole sull’ambiente, in particolare sull’atmosfera.
L’emissione di CO2 è alla base di quasi tutte le fonti energetiche oggi in uso. Inoltre la
trasformazione di alcune sostanze presenti nei combustibili o nell’aria causa il rilascio di diversi
inquinanti dannosi sia per la salute degli esseri umani che per gli ecosistemi.
Dopo l’incidente di Cernobyl l’Italia aveva deciso di smantellare le sue 3 centrali nucleari,
continuando però ad importare elettricità proveniente da centrali nucleari francesi. Belgio,
Germania, Svezia e Spagna hanno deciso di non installare nuovi impianti nucleari, mentre la
Finlandia ha recentemente approvato la costruzione di un nuovo reattore.
Al di là del rischio di incidenti nei reattori, il problema principale sta nello smaltimento e deposito
delle scorie nucleari. Queste sostanze hanno un tempo di semi-disintegrazione di centinaia o
migliaia di anni ed è irresponsabile lasciarle in eredità alle future generazioni. Inoltre bisogna tener
conto dell’elevato costo di gestione delle scorie e di demolizione dei reattori alla fine del loro ciclo
vitale (circa 40 anni).
I volumi di trasporto, sia di persone che di merci, sono in continuo aumento. L’80% dei trasporti
avviene ormai su strada. È in forte aumento il traffico aereo altamente inquinante, mentre sono in
declino i due modi più sostenibili, ossia le ferrovie e la navigazione.
Quasi tutto il fabbisogno energetico del settore trasporti è coperto da derivati del petrolio.
L’aumento nell’uso di energia per i trasporti è stato del 23% negli ultimi 10 anni e continuerà a
crescere rapidamente. Nel 2000 il settore dei trasporti era responsabile del 33% del consumo totale
di energia in Europa.
Anche se negli ultimi anni sono stati applicati notevoli miglioramenti tecnologici ai motori catalitici,
i risparmi ottenuti sono stati più che pareggiati dagli aumenti nella domanda di trasporti.
In effetti gli elementi principali che caratterizzano la situazione competitiva dei primi anni del
nuovo millennio sono, tra gli altri:
•
•
•
•
•
•
Mercato globale, espansione territoriale
Ricerca da parte delle aziende di sinergie produttive
Implementazione di strategie atte a ottenere la leadership sui costi
Standardizzazione, eliminazione dei prodotti e delle marche marginali
Consumatore più maturo
Valore al rapporto prezzo qualità, miglior performance percepibile.
La pubblicità, in questo periodo, si guarda indietro e cita la sua storia passata, ma, soprattutto,
diventa “autoreferenziale” e tende ad avere come oggetto sempre meno il prodotto da pubblicizzare,
che del resto possiede di rado caratteristiche in grado di differenziarlo realmente, e sempre più se
stessa, i propri discorsi e i propri meccanismi di comunicazione. Nello svelare i segreti del proprio
funzionamento interno, il messaggio pubblicitario cerca di stabilire un rapporto di complicità con il
destinatario.
Mettendosi a nudo, si impoverisce, ma tende anche a far crollare le difese psicologiche di un
interlocutore sempre più smaliziato e sofisticato al quale non si può più semplicemente magnificare
le virtù di un prodotto. In apparenza, dunque, la pubblicità sembra vivere una situazione di
Pagina | 38
debolezza, perché cerca sempre meno di persuadere direttamente all’acquisto di un prodotto. In
realtà, utilizza modalità di persuasione più sottili, coinvolgenti ed efficaci rispetto al passato.
Il mercato pubblicitario del nuovo millennio, “dopo aver toccato il massimo storico nel 2000 con
15.626 miliardi di lire”1, subì un brusco arresto nell'anno successivo, così come l'economia in
generale.
“I quotidiani dopo la crisi del '93-'94 erano cresciuti anno dopo anno, più della televisione e ad un
ritmo molto elevato, ma furono particolarmente toccati dalla crisi, malgrado il boom pubblicitario
della free press ed il trend leggermente positivo della pubblicità locale”2. Questo favorisce gli spot
televisivi. La pubblicità in tv registra continui incrementi, anche per via di alcuni provvedimenti
compiuti in ambito legislativo. La legge Gasparri del 2003, la quale individua i principi generali
che informano l'assetto del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale, e lo adegua
all'avvento della tecnologia digitale e al processo di convergenza tra la radiotelevisione e altri settori
delle comunicazioni interpersonali e di massa, quali le telecomunicazioni, l'editoria, anche
elettronica, ed INTERNET in tutte le sue applicazioni, sollevò un grande polverone di critiche;
un'accusa forte è stata mossa dalla Federazione italiana editori giornali (Fieg), “soprattutto per il
mancato allargamento del pluralismo televisivo e il mancato riequilibrio del mercato pubblicitario.
[…]. Gli editori hanno espresso in particolare la loro contrarietà per l'esclusione delle
telepromozioni dall'indice di affollamento pubblicitario orario, delle quali è stata disattesa l'ovvia
natura pubblicitaria” 3.
Così, la pubblicità sui quotidiani appare diminuita in questi ultimi anni e ciò si può constatare
sfogliando un qualsiasi quotidiano, mentre la pubblicità in tv non è mai stata tanto invadente.
Gli annunci odierni sembrano aver boicottato l'uso della parola o, per meglio dire, l'uso della lingua
italiana. Ovunque, anche se si tratta di un termine soltanto, l'inglese compare. Soprattutto per quel
che riguarda le pubblicità di automobili: BMW Serie 1. One like no one (“La Repubblica” maggio
2005), Jeep Cherokee. The wild side of life (“Corriere della Sera” gennaio, 2005), Nissan Nuovo X
Trail: Never loose your spirit (“Corriere della Sera” marzo 2005). L'automobilista, insomma, deve
conoscere l'inglese.
Di frequente gli annunci fanno il verso, o riprendono in maniera totale, gli spot che
contemporaneamente appaiono sulle reti televisive. La pubblicità sui quotidiani tende “a stabilire
con l'universo delle comunicazioni di massa livelli sempre più elevati di citazione reciproca”4
(Codeluppi 2001, 43).
Numerose pubblicità sui quotidiani, infatti, non sono altro che meri fotogrammi estrapolati da
qualche spot del momento.
Fig.15 Pannelli fotovoltaici
1
(Brigida, Baudi di Vesme, Francia 2003, 31)
(Brigida, Baudi di Vesme, Francia 2003, 30)
3
(Zanacchi 2004, 125).
4
(Codeluppi 2001, 43)
2
Pagina | 39
L'eredità degli anni Ottanta fa sentire il suo peso. L'importanza di un buon visual è sempre più
fondamentale. L'occhio umano sembra ormai attirato solo da foto spettacolari, ironiche, esplicite.
L'uso della parola, in pubblicità e non solo, pare da tempo morto e sepolto.
Un certo uso del linguaggio o la presenza o meno di un'immagine riconducono ad un determinato
decennio di pubblicità italiana, ma anche la tipologia dei prodotti reclamizzati identifica un
particolare periodo storico. Si parla spesso di risparmio energetico, si pubblicizzano lampade ed
elettrodomestici a basso consumo.
Se negli anni Settanta imperano gli annunci di alcolici ed elettrodomestici, gli anni Ottanta lasciano
spazio alla moda ed agli alimentari, se i Novanta hanno come protagonisti i cellulari, il nuovo
millennio vede il fiorire di pubblicità sui prodotti a consumo energetico. Unica costante
l'automobile, che attraverso crisi e difficoltà, superate dall’impiego di benzina verde e attenzione
all’ambiente vede la sua continua ascesa, favorita da innumerevoli marche.
Fig.16 Philips SOFT8YSFE8E14B1 Softone Sferica: Lampadine a risparmio energetico durata 8,000 ore, Attacco E14,
Forma T45, Potenza nominale 8W - Equivalente 35W, Tensione 230V, Colorazione bianca calda
Fig.17 La nuova tecnologia ecosostenibile sostiene e sviluppa un automobile a idrogeno.
Pagina | 40
Analisi di una pubblicità
Prodotto pubblicizzato: Fiat 500
Anno: 2000
Emittente: l’azienda Fiat, che si occupa di questo settore dal 1890
Destinatario: qualsiasi persona legga il giornale, in modo indiscriminato.
La FIAT 500 è tornata, accompagnata da un imponente piano marketing&comunicazione.
Perchè punta sulla tradizione, un aspetto che nel mondo contemporaneo sembra assumere,
contrariamente a quanto si potrebbe pensare, un valore molto apprezzato dai consumatori.
Il forte legame fra FIAT 500 e storia italiana è sottolineato chiaramente dallo spot Tv.
Perchè punta sulla personalizzazione, quindi risponde alle aspettative del nuovo consumatore
postmoderno. Il piano marketing&comunicazione richiama molto quella della nuova MINI e con
questa forse potrebbe condividere un’altra peculiarità: FIAT 500 è potenzialmente un brand, sotto
cui sarebbe possibile racchiudere tutta la produzione FIAT.
Il messaggio di questa pubblicità è quello di sottolineare l’autenticità della marca.
Pagina | 41
4. CONCLUSIONI
Quando si parla di ambiente e nuove tecnologie, si pensa sempre che non esista un legame fra questi
due fenomeni: al massimo la gente può pensare che grazie ad i mezzi messi a disposizione dalla
moderna scienza si possano analizzare i cambiamenti climatici e sperare di prevenirli. In realtà
pochi pensano (o almeno in piccola parte) a quale impatto ambientale devastante hanno la
produzione di corrente elettrica tramite combustibile fossile (petrolio, carbone, metano ecc) e la
produzione di apparecchi elettronici che usano materie plastiche inquinanti e dannose per la natura.
Fortunatamente il trend sembra andare invertendosi e cresce la consapevolezza che l’uso
indiscriminato delle risorse (legname, combustibili, alimenti ecc) potrà solo portare a breve ad un
collasso della nostra cara ed amata terra. Questo grazie alla sempre più grande consapevolezza da
parte degli utenti e delle aziende che hanno deciso di approcciare diversamente alla progettazione e
costruzione di componenti e dispositivi, adottando delle politiche che per prima cosa cerchino di
diminuire ed in futuro abbassare i consumi e la produzione di rifiuti tossici o comunque inquinanti.
Fig.1 Le nuove tecnologie si specializzano per uno sviluppo ecosostenibile
Va fatto notare che la maggior parte degli studiosi che quotidianamente studiano i comportamenti
climatici e il così detto “effetto serra“ fa notare che l’aumento delle temperature è in relazione con
l’avanzamento tecnologico (consumi maggiori di risorse, produzione di dispositivi e quindi di futuri
rifiuti, rilascio di sostanze inquinanti nell’ambiente, produzione di calore ecc).
Fig.2 Grafico delle temperature e revisioni future: il primo dal 1990 al 2100, il secondo dal 1765 al 2100.
Pagina | 42
Come detto in precedenza però, la mentalità di aziende ed utenti sta mutando: grazie agli sforzi
profusi da innumerevoli fondazioni e alla ricerca da parte degli scienziati di nuovi materiali e allo
sviluppo di fonti alternative ai combustibili (sia minerali che fossili), i listini cominciano a proporre
alternative (economiche) ai canonici prodotti che generalmente abbiamo acquistato: elettrodomestici
e non solo a basso consumo energetico, anallergici e costruiti con materiali non inquinanti.
Anche l’utente si sta facendo più attento, andando ad esempio a promuovere le aziende che vanno
a produrre beni senza materie nocive, e a punire chi magari delocalizza nei paesi del terzo mondo,
dove le loro fabbriche sono fonte di inquinamento e morte per gli abitanti di quei luoghi. Non solo
quindi tecnologia eco-sostenibile, ma anche metodi di produzione e protocolli che salvaguardino
l’ambiente dall’inizio della filiera ( che tipo di energia acquista l’azienda, come vengono prodotte
le materie prime utilizzate e, non per ultimo, la situazione dei lavoratori e dell’ambiente circostante
alle fabbriche).
Fig.3 Un esempio di tecnologia ecosostenibile, ossia il ricevitore del digitale terrestre
Naturalmente tutto questo non può avvenire se i mass media e soprattutto il media odierno per
eccellenza, internet, non fanno la loro parte per sensibilizzare l’utenza (quando l’utenza cambia,
allora anche le aziende devono adeguarsi a quello che chiede il compratore). Un sito italiano
specializzato fra tutti sensibilizza, dalle sue pagine online, sia le aziende che i navigatori,
spiegando come una vita eco-solidale o comunque rispettosa dei meccanismi delicati della terra
porterà giovamento e stabilità alle popolazioni mondiali.
Fig.4 Riviste che si interessano a problematiche ambientali
Pagina | 43
La popolazione sicuramente vede di buon occhio aziende e governi impegnati contro lo SPRECO
ENERGETICO
Alcuni stati promuovono campagne per aiutare i cittadini ad acquistare componenti elettrici ed
elettronici a basso consumo energetico e spingono le aziende, con sgravi fiscali e non solo, ad
investire in materie e tecnologie a basso impatto aziendale. Non ultima è l’importanza degli utenti:
infatti ogni qual volta andremo ad acquistare un bene che rispetta l’ecosistema, le aziende si
adegueranno e punteranno la prua verso quella direzione.
Fig.5 Statistica sull’interesse del consumatore
L’interesse del consumatore ed in generale del cittadino italiano si sta spostando verso tematiche
considerate solo marginali fino a qualche anno fa: basti pensare che, dalle statistiche risulta che
problematiche come i diritti dell’uomo sono passate nel personale interesse del campione ascoltato
al 67%, la povertà al 53% ed invece l’ambiente ha subito un balzo avanti fino ad arrivare all’80%
(bisogna far notare che le tre tematiche sono comunque collegate, perché la ricerca del profitto ha
fatto impoverire intere aree del pianeta e sfruttare ed opprimere popolazioni che vivono in altri
continenti).
Questo ci porta a vedere in base a quale parametro il cittadino va a scegliere una determinata
azienda piuttosto che un’altra: al 50% stanno saldamente al comando i prodotti ed i servizi (molto
sicuramente il marchio e la pubblicità che sta attorno ad un prodotto), seguito però dalla
responsabilità sociale dell’azienda che si assesta sul 25% (che tradotto in soldi vuol dire come un
determinato marchio si pone nei confronti della comunità e cosa fa per il benessere di questa), dalle
condizioni di lavoro dei propri dipendenti (16%), e dalle strategie 14% ecc.
Da qui si capisce il dato che indica nel 92% l’attenzione nell’acquisto verso la salvaguardia
dell’ambiente, che vuol dire scegliere con cura cosa si è acquistato, analizzare il materiale con cui
è costruito, evitare prodotti con troppi imballaggi e materiali plastici che poi andranno
inesorabilmente nel ciclo dei rifiuti e, non ultimo, l’impatto ambientale di ogni prodotto (anche qui
alberi abbattuti, produzione di gas serra, sfruttamento della manodopera ecc).
Se invece le aziende, anche quelle prettamente tecnologiche o che offrono servizi o software,
dovessero disattendere le aspettative del cliente green (e sicuramente a breve del cliente in generale
sulle tematiche ambientali), allora potrebbero veder perdere velocemente valore alla propria
azienda, o ancora peggio danneggiare la reputazione del marchio, che in parole povere vuol dire
meno vendite, più problemi e quindi meno produttività (e in un periodo come questo di crisi non ci
si può permette di perdere nessun cliente).
E così si scopre come moltissime aziende, oltre che preparare piani di integrazione e
trasformazione green, vanno ad investire nel proprio o in altri eco-business Tra le tante non
possiamo non citare colossi come: Sony, Apple, Nike, Tetrapak, 3M, Dell, Ikea, Toyota, Dell,
Pagina | 44
Kodak (e ce ne sono tante altre, famose e meno famose, non citate per motivi di spazio).
Naturalmente una loro parte, come detto anche in precedenza, devono fare i media, sia cartacei
che digitali, compresi TV e radio . Devono spingere l’utente alla consapevolezza che salvaguardia
dell’ambiente non vuol dire rinunciare alla tecnologia e balzare nella preistoria ma creare senza
distruggere, trasformando le materie e salvaguardandole nella loro interezza.
Se poi si parla di media, internet è uno di quelli da prendere ad esempio, perché è una struttura
che informa, dà libertà di parola a tutti, sensibilizza per quanto riguarda i temi di vitale importanza
ma allo stesso tempo ha un impatto ambientale di minor importanza (infatti, se si escludono
particolari applicativi, per far girare un server web serve poca energia elettrica ed un computer ha
una media di vita molto alta). È uno strumento che, in proporzione produce meno, rifiuti tossici e
rilascia nell’ambiente meno gas serra e materiali inquinanti.
Fig. 6 Pubblicità di automobili ecologiche.
A differenza della TV o della radio, permette a chiunque di trovare valide alternative a qualsiasi
cosa che inquini, come ad esempio metodi (cosa che spesso gli altri mezzi di informazione non
fanno)per ricaricare le batterie usando la luce del sole, dispositivi a basso consumo energetico,
creati utilizzando materiale riciclato o comunque non inquinante o ancora potremo, per assurdo,
costruirci il nostro impianto eolico o fotovoltaico.
In definitiva, lo strumento del futuro creato ed utilizzato da persone che nel loro DNA hanno
sempre avuto un occhio di riguardo a tutto ciò che è salute e benessere proprio, dell’ambiente e
degl’altri. Un mezzo che permetterà all’uomo di informare e condividere informazioni, in modo
da abbandonare questa strada di consumismo a tutti i costi, ma di consumo senza inquinare.
Pagina | 45
5. BIBLIOGRAFIA
Documenti
Enea (2007), Rapporto Energia e Ambiente 2006, Roma 2007
International Energy Agency (2005), World Energy Outlook 2005, Parigi 2005
G. P. Beretta (2004), Prospettive Energetiche del Prossimo Futuro, Atti XXII Congresso
Nazionale sulla Trasmissione del Calore, Genova, 21-23 Giugno 2004
G. Pagliarini, E. Zanchini (1985), Lavoro massimo estraibile da un combustibile chimico, atti
del 40° Congresso Nazionale ATI, pp. 365-375, Trieste, 11-13 settembre 1985
G. Frabris (1997), La pubblicità teorie e prassi, F. Angeli, Milano, 1997
Mario Palazzetti e Maurizio Pallante (1997), L’uso razionale dell’energia, Bollati Boringhieri,
Torino, 1997
Enea (1997), Dipartimento energia – Unità piani energetici territoriali, Guida per la
pianificazione energetica comunale, 1997
Conferenza Nazionale Energia e Ambiente (1998), I consumatori, l’energia e l’ambiente.
Azioni a supporto del corretto sviluppo della domanda, Bologna, dicembre 1998
Commissione delle Comunità Europee (2000), Piano d’azione per migliorare l’efficienza
energetica nella Comunità Europea, Bruxelles, aprile 2000
M. Lucentini, E. Scatalani e F.P. Vivoli (1998), La Casa e l’Energia, Criteri e norme per una
corretta progettazione energetica degli edifici, ISES Italia, Roma, dicembre 1998
Bilancio Energetico Nazionale (2006), Ministero Sviluppo Economico, 2006
Terna, Rapporto mensile sul sistema produttivo elettrico. Consuntivo
Link utili
Direttiva 89/552/CEE relativa alla fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di
media audiovisivi).
Trattato di Amsterdam - Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri.
Sito della Commissione Europea sulla politica audiovisiva
http://www.neurolinguistic.com/pnl/scannedebooks/ipnotismoestati/page74.htm
http://books.google.it/books?id=sKDPCTLtRDcC&pg=PA110&dq=consumi+finali+di+energia+
in+italia+dal+1960#PPA113, M1
http://www.vmv.it/gli+anni+sessanta_1-2-103-0-0.aspx
http://www.atuttascuola.it/siti/laura/tema_sulla_energia.htm
Pagina | 46