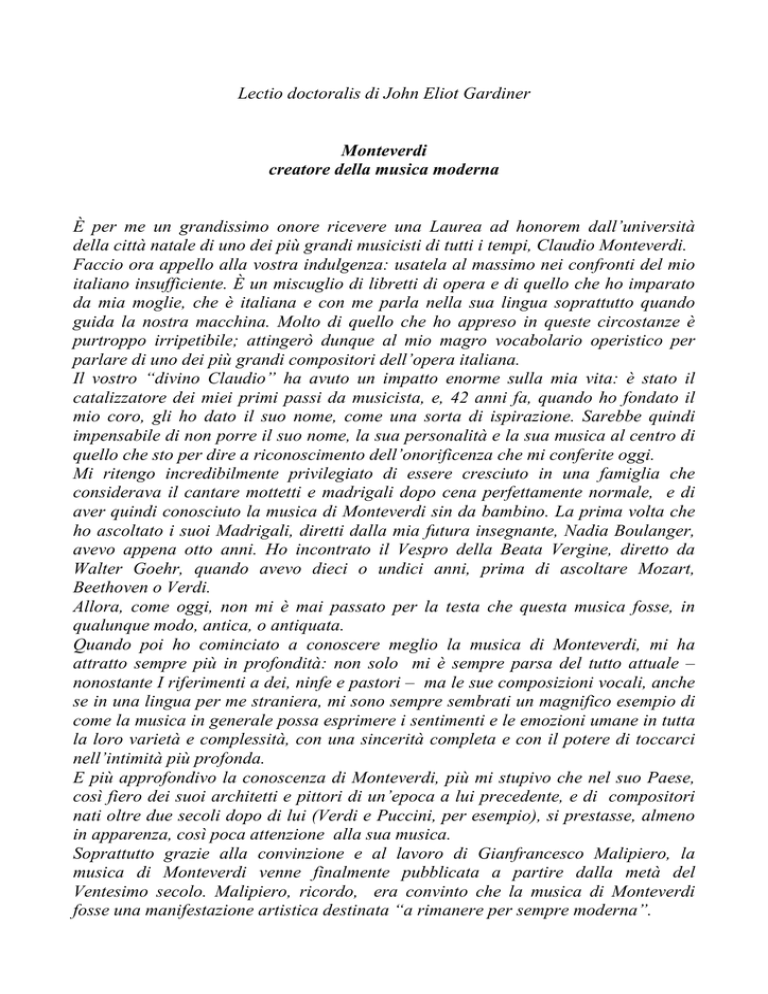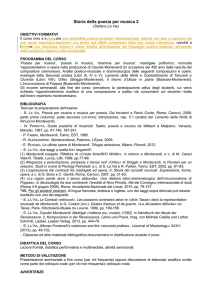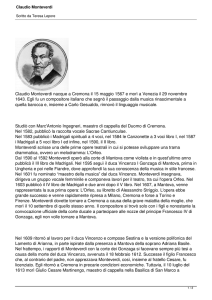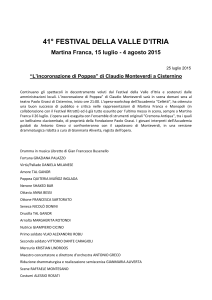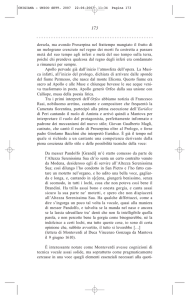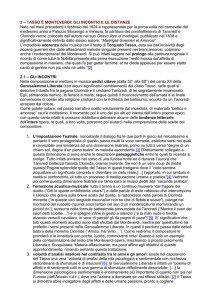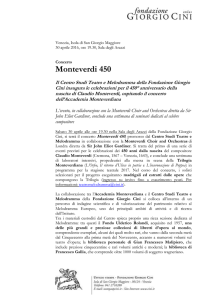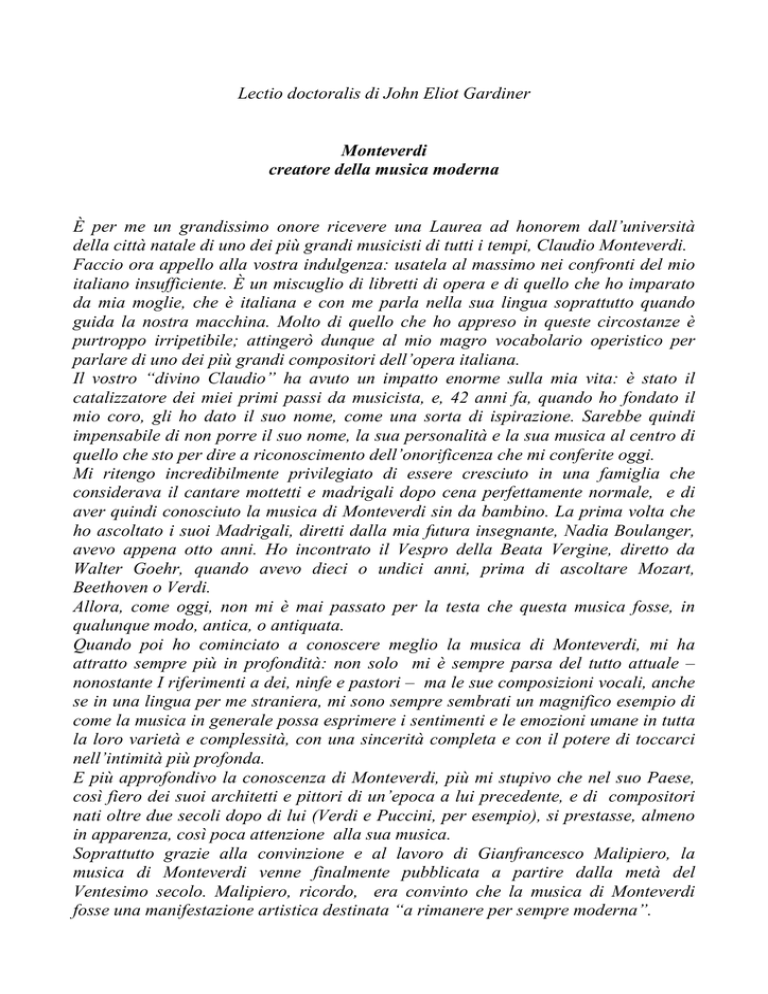
Lectio doctoralis di John Eliot Gardiner
Monteverdi
creatore della musica moderna
È per me un grandissimo onore ricevere una Laurea ad honorem dall’università
della città natale di uno dei più grandi musicisti di tutti i tempi, Claudio Monteverdi.
Faccio ora appello alla vostra indulgenza: usatela al massimo nei confronti del mio
italiano insufficiente. È un miscuglio di libretti di opera e di quello che ho imparato
da mia moglie, che è italiana e con me parla nella sua lingua soprattutto quando
guida la nostra macchina. Molto di quello che ho appreso in queste circostanze è
purtroppo irripetibile; attingerò dunque al mio magro vocabolario operistico per
parlare di uno dei più grandi compositori dell’opera italiana.
Il vostro “divino Claudio” ha avuto un impatto enorme sulla mia vita: è stato il
catalizzatore dei miei primi passi da musicista, e, 42 anni fa, quando ho fondato il
mio coro, gli ho dato il suo nome, come una sorta di ispirazione. Sarebbe quindi
impensabile di non porre il suo nome, la sua personalità e la sua musica al centro di
quello che sto per dire a riconoscimento dell’onorificenza che mi conferite oggi.
Mi ritengo incredibilmente privilegiato di essere cresciuto in una famiglia che
considerava il cantare mottetti e madrigali dopo cena perfettamente normale, e di
aver quindi conosciuto la musica di Monteverdi sin da bambino. La prima volta che
ho ascoltato i suoi Madrigali, diretti dalla mia futura insegnante, Nadia Boulanger,
avevo appena otto anni. Ho incontrato il Vespro della Beata Vergine, diretto da
Walter Goehr, quando avevo dieci o undici anni, prima di ascoltare Mozart,
Beethoven o Verdi.
Allora, come oggi, non mi è mai passato per la testa che questa musica fosse, in
qualunque modo, antica, o antiquata.
Quando poi ho cominciato a conoscere meglio la musica di Monteverdi, mi ha
attratto sempre più in profondità: non solo mi è sempre parsa del tutto attuale –
nonostante I riferimenti a dei, ninfe e pastori – ma le sue composizioni vocali, anche
se in una lingua per me straniera, mi sono sempre sembrati un magnifico esempio di
come la musica in generale possa esprimere i sentimenti e le emozioni umane in tutta
la loro varietà e complessità, con una sincerità completa e con il potere di toccarci
nell’intimità più profonda.
E più approfondivo la conoscenza di Monteverdi, più mi stupivo che nel suo Paese,
così fiero dei suoi architetti e pittori di un’epoca a lui precedente, e di compositori
nati oltre due secoli dopo di lui (Verdi e Puccini, per esempio), si prestasse, almeno
in apparenza, così poca attenzione alla sua musica.
Soprattutto grazie alla convinzione e al lavoro di Gianfrancesco Malipiero, la
musica di Monteverdi venne finalmente pubblicata a partire dalla metà del
Ventesimo secolo. Malipiero, ricordo, era convinto che la musica di Monteverdi
fosse una manifestazione artistica destinata “a rimanere per sempre moderna”.
Nello stesso anno in cui ho ascoltato per la prima volta I madrigali “Ecco mormorar
l’onde”, Zefiro torna” ed “Hor che il cielo e la terra”, veniva pubblicato un libro del
musicologo americano Leo Schrade, intitolato “Monteverdi- Creator of mondern
music”, ossia “Monteverdi, creatore della musica moderna”.
Le teorie di Schrade furono presto attaccate da altri musicologi che contestavano la
sua interpretazione di Monteverdi come un rivoluzionario: sottolineavano i suoi
legami con il passato, le sue vedute moderate, il suo fallimento come teorico di un
sistema estetico compositivo completo, e il suo uso persistente di forme tradizionali
(per esempio, il madrigale) anche se utilizzate in maniera completamente innovativa.
Ciò nonostante, l’argomento principale di Schrade rimane vero oggi come lo era nel
1950: che i principi artistici sviluppati da Monteverdi nella sua opera fossero gli
stessi della “nostra musica e della nostra comprensione della musica” , e che
avessero “molto di più in comune con la musica di Haydn, Mozart, Beethoven e
perfino Brahms, che non con quella di Palestrina, il suo immediate e meglio
conosciuto predecessore”.
Era quindi Monteverdi un genio isolato, estraneo al suo tempo e ai suoi
contemporanei? Niente affatto! Sono convinto che Monteverdi fosse assolutamente
un figlio del suo tempo, un esponente di primo livello di quella incredibile
generazione di artisti, filosofi, scienziati e scrittori i cui sforzi creativi individuali
cambiarono completamente il pensiero e la cultura medievale intorno all’anno 1600,
e che, tutti insieme, trasformarono la nostra visione del mondo e del ruolo dell’uomo
all’interno di esso.
Anche se Monteverdi non può certamente essere considerato un uomo di scienza,
sicuramente la sua espressione ed esplorazione in musica dell’intera gamma dei
sentimenti ed emozioni umane è il coronamento della sua opera. L’ invenzione dello
Stile Concitato, intercalante affetti “guerrieri” ed “amorosi”, pare quasi una
celebrazione delle emozioni umane, e al limite una rivendicazione, o come minimo
una visione positiva, dell’aggressività. E se questo appare quasi un’ anticipazione
dei temi centrali della psicologia moderna, è anche un legame con inventori e
scienziati suoi contemporanei, come Galileo.
L’interesse di Monteverdi per i sentimenti umani suggerisce inoltre un’affinità con i
pittori del suo tempo: Rubens (di cui fu parzialmente contemporaneo alla corte dei
Gonzaga a Mantova), Rembrandt (la cui reputazione fu costruita inizialmente sulla
sua abilità nel catturare le più violente emozioni sulla tela), e soprattutto il suo
compatriota, Caravaggio.
Entro le loro rispettive sfere artistiche, sia Monteverdi che Caravaggio hanno tenuto
i piedi nelle due staffe del sacro e del profano: in un certo senso, hanno umanizzato
la religiosità e santificato il quotidiano. La separazione tra le loro opere sacre e
profane è estremamente labile. Soprattutto, entrambi si vantavano della loro abilità
nell’imitare la natura in modo quasi scientifico. Un semplice commento di
Caravaggio – un pittore competente deve saper “imitare bene le cose naturali” – ha
avuto conseguenze enormi per la pittura europea. Il modo in cui Caravaggio
dipingeva i suoi modelli, in maniera realistica, non idealizzata, e con la potenza del
suo caratteristico uso del chiaroscuro, è stata la grande forza liberatrice della
pittura barocca – un esempio per gli artisti delle generazioni successive che li ha
aiutati a liberarsi dall’artificiosità del tardo manierismo.
Confrontiamo tutto questo con una lettera scritta da Monteverdi a Striggio nel 1616 ,
dove si legge la sua opinione su un libretto (le Nozze di Tetide) , che rivela alcuni
aspetti della sua arte teatrale “ Oltre di ciò ho visto li interlocutori essere Venti
.......Come, caro signore potrò io imittare il parlar de’venti se non parlano! Et come
potrò io con il mezzo loro movere li affetti! Mosse l’Arianna per esser donna, et
mosse parimenti l’Orfeo per esser hom et non vento.....”
Questo passaggio è quasi un vero e proprio manifesto per la forma dell’opera - o
dramma per musica com’era chiamata all’epoca - un proclama in favore del “parlar
cantando” invece del “cantar parlando”.
Paradossalmente, questa abilità nel commuovere gli ascoltatori tramite il canto di un
solista sulla scena fu paragonato con il potere della musica mistica dell’antichità: un
po’ come successe ad Annibale Carracci (un contemporaneo di Caravaggio) a cui fu
rinonosciuta la moderna incarnazione dell’arte dell’ antichità classica.
Partendo dalla nostra prospettiva di oggi, saremmo tentati di vedere gli sforzi di
Monteverdi per ottenere un certo realismo sulla scena come un tentativo di
sintetizzare nell’opera i drammi umani alla maniera di Shakespeare, e la
realizzazione visuale di Caravaggio, quasi un’espressione del processo scientifico
descritto da Francis Bacon nel suo sunto del metodo scientifico sperimentale
Nel Novum Organum del 1620 Bacon si esprime con parole che potrebbero quasi
essere prese per un manifesto estetico di Monteverdi o di Caravaggio. “Coloro,
quindi, che propongono non di teorizzare e indovinare, ma di discutere e di sapere.
Che sono decisi a non inventare favole e grottescherie, ma a studiare e sezionare la
natura di questo mondo reale, devono studiare unicamente gli oggetti stessi”
Questo cri de coeur di Bacon in favore di una stretta osservazione scientifica
(un’attitudine peraltro anticipata da Leonardo da Vinci un secolo prima) è parallelo
all’insistenza di Galileo sull’osservazione della realtà pura e semplice: di come i vari
fenomeni si manifestano, della relazione tra causa ed effetto – una completa rottura
insomma con l’ossessione dei suoi oppositori al perchè del manifestarsi di tali
fenomeni.
Lo sviluppo del pensiero scientifico che capovolge il concetto dell’universo e al suo
interno dell’uomo stesso, avviene esattamente nel corso di due generazioni all’inizio
del diciassettesimo secolo: inizia con Galileo e termina con I Principia di Newton.
Newton, ricordiamo, nasce nello stesso anno della morte di Galileo. Questi due geni,
con il contributo di Cartesio, Keplero e Huyghens fra gli altri, hanno espresso una
nuova concezione dell’universo.
Galileo ha fatto il primo passo concentrandosi non sul concetto del moto dei corpi
ma sui suoi cambiamenti. Newton, poi, ha fissato questo concetto nella sua prima
legge del moto: “un corpo mantiene stato di quiete o di moto rettilineo uniforme
finché una forza esterna viene a modificare tale stato”.
Questa formula demoliva un credo che aveva ostacolato il progresso della fisica per
duemila anni, postulando l’esistenza di sistemi dinamicamente isolati all’interno
dell’universo, governati da leggi pertinenti a se stessi e non contingenti al resto
dell’universo.
Sarebbe eccessivo sostenere che la rivoluzione – o forse la crisi – del pensiero e dello
sviluppo musicale della prima metà del Seicento, così legata al nome di Monteverdi,
abbia avuto uguale importanza nella storia dell’evoluzione del pensiero umano
quanto la rivoluzione scientifica a cui ho accennato. Nonostante ciò, ci sono dei
paralleli e delle coincidenze stimolanti. Galileo Galilei e Christian Huygens erano
entrambi figli di musicisti.
L’astronomo Keplero, fece riferimento alla musica moderna nel tentativo di illustrare
la struttura dell’universo: l’armonia celeste, insisteva, non è metafisica, ma reale,
anche se silenziosa.
Invece di rifiutare ciò come un’assurdità, bisogna forse ammirare l’audacia del
concetto di Keplero. Per lui l’armonia celeste era polifonica, formata
dall’interazione di consonanze e intervalli moderni (le terze e seste che la tradizione
pitagorea considerava imperfetti) geometricamente determinati e centrati e udibili
sul sole (ma non sulla terra). Per Keplero quindi, la musica polifonica moderna non
solo imitava, ma in effetti rivelava la struttura dell’universo celeste (impossibile per
la musica monodica dell’antichità) ed era quindi intrinsecamente più bella di quella
degli antichi.
Questo fermento di idee, che influì su ogni aspetto della vita europea nei primi anni
del Seicento è il contesto in cui possiamo meglio porre le esplorazioni musicali di
Monteverdi.
La Camerata Fiorentina aveva già postulato la concezione della musica come una
forma esaltata della lingua parlata. Ma una totale rivoluzione musicale che portasse
alla creazione di una nuova forma artistica chiamata opera, non poteva essere
compiuta solo in base alla teoria. Lo stile monodico di Peri e Caccini, pur con la
bellezza dei suoi passaggi più espressivi, è fondamentalmente monocromo e non
drammatico.
Le caratterizzazioni dei personaggi è debole e la loro gamma espressiva molto
limitata. Soprattutto, le loro opere mancano di una chiara e coerente struttura
musicale. Lo stesso si può dire della Dafne di Marco da Gagliano, pur con le sue
armonie più ricche e la più elaborata successione di arie, duetti e brevi interludi
strumentali scritti per interrompere lunghi passaggi di recitazione monodica.
Per passare dalla teoria a una forma artistica vitale, ma sostenuta da una forma
strutturale portante, era necessario un ingegno superiore. E fu proprio Monteverdi
che compì il passaggio: nella Favola d’Orfeo (dove per favola si intende
naturalmente “azione scenica”) ci presenta il paradigma della fusione di musica e
poesia , in cui “tutti li interlocutori parleranno musicalmente”.
Tra le numerose caratteristiche innovative dell’Orfeo, la più notevole è questa: i
momenti più salienti della narrazione – la discesa di Orfeo agli inferi, la sua
conversazione con Caronte, il suo ritorno con Euridice, e la sua perdita – non
vengono riferiti, come nella Euridice di Peri/Rinuccini, ma si compiono sulla scena,
davanti agli occhi degli spettatori.
Bisogna però diffidare delle lodi dei contemporanei di Monteverdi che hanno visto in
Orfeo il matrimonio perfetto tra poesia e musica. In realtà, attraverso tutta l’opera,
si avverte sempre nell’aria la sensazione di un imminente divorzio tra le due, dato il
contrasto fra le rispettive necessità, e cioè la solidità strutturale e l’espressione dei
sentimenti. E questa tensione tra i due elementi, presente sin dai primi esempi, è una
caratteristica intrinseca dell’opera come forma artistica. E per Monteverdi, questi
due elementi, e la tensione tra la dimensione poetica, musicale e teatrale, rimasero il
fondamento dei suoi molteplici e disparati esperimenti di tutta la sua vita di
musicista.
Per inciso, come musicista trovo altamente significativo che Orfeo, un’opera
apparentemente celebrativa del potere della musica sembri finire con il suo
fallimento – ammorbidito solo da un lieto fine che appare un po’ forzato.
Mentre molti dei suoi contemporanei sprecarono tempo ed energie teorizzando sulla
raison d’etre dell’opera, talora con polemiche accesissime, l’approccio di
Monteverdi alla composizione operistica – da Orfeo a Poppea, e includendo opere
minori in stile rappresentativo e anche la dozzina di opere perdute – fu sempre
intrinsecamente pragmatico. Le sue lettere dimostrano come Monteverdi si
preoccupasse molto più delle qualità individuali, delle pretese dei suoi interpreti e
dei problemi di messa in scena in luoghi diversi, che non di fondamenti assoluti
artistici o esistenziali.
Ciò nonostante, e anche senza conoscere le sue composizioni andate perdute (i punti
chiave mancanti nello sviluppo della sua opera come l’Arianna del 1608 – forse la
perdita più grave – e le due opere scritte in collaborazione con Giulio Strozzi , La
finta pazza Licori e Proserpina rapita), abbiamo abbastanza materiale che ci rivela i
suoi straordinari poteri di immaginazione e come Monteverdi sia riuscito a
coniugare la musica con la struttura e il significato di un testo poetico, superando I
limiti intriseci di ciascuna componente, in un’ esplorazione di come un tale
spettacolo di dramma per musica potesse toccare I sentimenti degli ascoltatori.
E proprio in questo risiede il genio di Monteverdi: nella sua capacità di comporre
musica in un’enorme varietà di generi – per rappresentazioni teatrali, da chiesa e da
camera – e con il potere di commuovere gli ascoltatori .
In un’epoca in cui la vita emotiva degli esseri umani era diventata un soggetto di
estremo fascino, in cui i filosofi cercarono di definire il ruolo delle passioni del
destino dell’umanità, e dove alcuni pittori – da Caravaggio e Rembrandt sino a
Velasquez e Poussin – aspiravano a ritrarre la vita interiore dei loro soggetti,
Monteverdi si distinse dai compositori contemporanei proprio per aver dedicato la
sua intera carriera all’esplorazione musicale degli ideali di “imitazione” e
“rappresentazione”.
Con Orfeo, Monteverdi ha creato il passaggio da un testo cantato a una
rappresentazione di un dramma per musica, con emozioni e sentimenti accentuati
dalla musica. E anche in questo possiamo metterlo a confronto con gli astronomi o
matematici suoi contemporanei, che non hanno inventato nuovi fenomeni, ma
osservato fenomeni esistenti con una prospettiva diversa dando loro un significato
diverso.
E questa simbiosi tra parole e musica in Monteverdi non avviene solo nella sua
musica profana, ma permea anche le sue composizioni sacre.
Come ho già detto, Orfeo è il suo primo proclama musicale, il risultato di una
pianificazione meticolosa di organizzazione tonale, dell’alternarsi di cori, arie e
recitativi pieni di energia drammatica grazie anche all’uso imprevedibile delle
dissonanze.
La magnifica sequenza di musiche per il Vespro della Beata Vergine è, in questo, sua
gemella. Il Vespro fu la prima pubblicazione di questo genere ad alternare salmi con
mottetti extra-liturgici e a comprendere una versione musical dell’inno mariano
corrispondente. Garantendo l’osservanza dei requisiti liturgici (il sacerdote poteva
recitare sottovoce il testo dell’antifona prescritta durante il canto del mottetto) egli
costruì una sequenza unitaria e simmetrica di musica “publica” e “privata” che
consentiva una drammatica giustapposizione di sonorità e un’impressionante varietà
di tessitura e atmosfere espressive. Nel Vespro Monteverdi dimostra ugualmente la
sua abilità nel lavorare su vasta scala, nell’organizzare il materiale musicale in
maniera strutturalmente coerente, ottenendo dei contrasti fra le dimensioni, lo stile e
la temperatura emotiva.
Sin dalla prima volta in cui ho diretto, ancora da studente, il Vespro a Cambridge,
ho avuto la sensazione che il Vespro avesse molto in comune con la vitalità di un
tableau rubensiano. Per una strana coincidenza, il mio College (il King’s) aveva
appena ricevuto una donazione della magnifica “Adorazione dei Magi”, dipinta da
Rubens a Mantova circa nello stesso periodo in cui Monteverdi componeva il Vespro
della Beata Vergine. La presenza di questo splendido dipinto è stata una fonte
d’ispirazione per i musicisti, e allora mi aveva incoraggiato a dirigere il capolavoro
di Monteverdi per la prima volta nella cappella gotica del King’s College – un luogo
che in realtà non si prestava né architettonicamente né in termini di tradizione
musicale alla calda sonorità che cercavo di ottenere dalla musica di Monteverdi.
Praticamente ogni aspetto del primo libro di musica sacra di Monteverdi ha
incuriosito i musicologi per decenni. In effetti è inusuale in ogni suo aspetto, anche
tralasciando il fatto che fosse a tutti gli effetti un insieme disparato di musiche.
Alcuni accettano l’ipotesi che fosse stato concepito, almeno in parte, come un
biglietto da visita a due facce: da un lato per ottenere un impiego a Roma (la Messa
a cappella a sei parti in “stilo antico” che dimostrava le sue impeccabili credenziali
controriformiste), dall’altro a Venezia (per il resto delle composizioni, un mosaico di
salmi per il Vespro, cantici a due, mottetti vari e la famosa Sonata sopra Sancta
Maria).
Numerosi studiosi e direttori di coro hanno dato diverse interpretazioni di quale
esattamente sia la musica che costituisce il Vespro della Beata Vergine – ossia quali
delle composizioni comprese nel volume vadano incluse, quali omesse, in quale
tonalità vadano suonate, eccetera.
Come interprete, ho invece preso la decisione di includere tutta la musica – e nella
sua esatta sequenza – pubblicata da Monteverdi nel 1610.
La mia teoria è stata messa alla prova pratica in numerose esecuzioni in chiese e
cattedrali di tutta Europa, specialmente in Italia; quella nel magnifico Duomo di
Cremona, nel dicembre del 1993, resterà negli annali della mia storia di interprete
come una delle più fredde: ogni suono usciva dalla bocca dei cantanti accompagnato
da una nuvoletta di vapore.
Questi concerti hanno rafforzato due mie convinzioni.
La prima è che Monteverdi non ha mescolato mottetti e duetti con i salmi del Vespro
a caso, o seguendo i suggerimenti del suo editore veneziano, Amadino, ma che
proprio questa alternanza di stili e forme musicali sia la chiave del successo del
Vespro: una dimostrazione della sua audacia stilistica e della solidità della sua
strutturazione del pezzo (alla pari di Orfeo), ma con il Cantus Firmus Gregoriano
come colonna portante dell’intero edificio musicale. La presenza di questo Cantus
Firmus dona al Vespro l’apparenza di una successione di anelli a catena, dove il
contrasto tra gli aspetti più opulenti (i salmi) e quelli più intimi (i mottetti solistici),
ovvero tra il “pubblico” e il “privato”, crea un effetto di chiaroscuro sonoro.
Considerati nel loro insieme e nella stessa sequenza della pubblicazione del 1610,
questi novanta minuti di musica meticolosamente calibrati formano il più
impressionante esempio di musica da chiesa mai scritta prima delle Passioni e della
Messa in Si minore di Bach. E dobbiamo ricordare che i contemporanei di
Monteverdi, e anche parecchi dei suoi successori, difficilmente componevano brani
più lunghi di un madrigale di cinque minuti, o un salmo concertato di otto.
La mia seconda osservazione è che questo lavoro – da un lato totalmente estroverso
nella sua grandiosità, dall’altro intimamente devozionale – fosse stato formulato da
Monteverdi come un paradigma di un possibile amalgama di elementi teatrali nella
musica da chiesa, e dell’utilizzo degli spazi architettonici come dimensioni musicali.
In sintesi, sono fondamentalmente convinto che proprio così lo abbia concepito
Monteverdi, anche se lui stesso aveva pianificato esecuzioni indipendenti delle varie
parti del Vespro.
In particolare, sono convinto che fosse particolarmente mirato alla struttura
architettonica e alle varie postazioni disponibili nella Basilica di San Marco a
Venezia (il doppio pulpito e, sul lato opposto, la pergola esagonale dei Musici
popolarmente chiamata il Bigonzo, le gallerie degli organi e le nicchie) e anche alla
sua acustica magica, caratterizzata da una estrema chiarezza del suono pur con dei
tempi di riverbero molto lunghi. Come la mano di Cristo sembra estendersi fuori
dalla tela nella Cena di Emmaus di Caravaggio, così nel Vespro gli invisibili solisti
echeggiano da ogni superficie della Basilica verso l’ascoltatore.
Rappresentare il Vespro della Beata Vergine in San Marco – come ho fatto in più
occasioni – significa ricreare la musica in un luogo per essa ideale, e dove ci si sente
immersi in un’opera sacra, o se vogliamo in un dramma per musica spirituale, in cui
musica e architettura entrano in simbiosi perfetta creando un banchetto visivo e
auditivo.
Sappiamo tutti come la musica del Vespro ottenne il risultato desiderato da
Monteverdi, guadagnandogli, nel 1613, l’impiego italiano più prestigioso nell’ambito
della musica da chiesa. Dopo vent’anni passati nel clima malarico di Mantova – alla
spesso solforosa corte dei Gonzaga dove si trovò il più delle volte a lavorare troppo
per un magro salario e scarso riconoscimento – Monteverdi ebbe a dire del suo
impiego a Venezia “il servizio è più dolce”. Ma non si può certo sostenere che i suoi
ultimi trent’anni di vita siano stati vissuti di rendita sul capitale musicale ammassato
durante i suoi anni cremonesi e mantovani.
Grazie a Nino Pirrotta, Lorenzo Bianconi e Paolo Fabbri tra i musicologi italiani, e
Thomas Walker, Iainn Fenlon e Tim Carter tra gli stranieri, abbiamo un panorama
più dettagliato della evoluzione personale e professionale di Monteverdi durante i
suoi anni veneziani. E abbiamo così avuto modo di valutare la sua influenza come
compositore di musica sacra anche nel portare a San Marco dei talenti quali
Grandi, Cavalli, Rovetta e Rigatti: grazie alla loro comprensione dei principi della
“prima” e “seconda Prattica” hanno aderito, e in certi casi portato avanti la ricerca
di un’espressione musicale adeguata ai testi da musicare iniziata da Monteverdi
negli anni precedenti.
È curioso osservare come nel momento in cui la musica sacra concertata di
Monteverdi tende più verso un’eufonia diatonica (almeno in confronto all’audacia e
alla forza espressiva del Vespro), quella dei suoi successori (Cavalli e Rigatti in
particolare) si muove verso una teatralità più estrema (penso, per esempio,
all’adozione di Rigatti dello stilo concitato nei suoi vespri del 1640) e una sensualità
più pronunciata, come nel Salve Regina a quattro voci di Rigatti. Qui sentiamo
veramente un passaggio di idee musicali (e non solo di musicisti) tra il teatro e la
chiesa.
La musica del famosissimo duetto “Pur ti miro, pur ti adoro” che conclude
l’Incoronazione di Poppea (che sia stato composto da Monteverdi oppure da
Cavallo, Ferrari o Sacrati poco importa) la si poteva ascoltare una sera nel teatro
Grimani a S. Giovanni e Paolo, e il giorno dopo durante la Messa in San Marco, con
le parole “Sicut erat in principio” alla fine del Dixit Dominus di Rigatti. E questo
non deve stupirci più di quanto ci stupisca che Caravaggio abbia dipinto una donna
di strada nella sua Madonna dei Pellegrini, illuminata dal retro della tela da una
luce spirituale.
È inoltre interessante vedere come i due poli creativi di Monteverdi trovino nuove
forme espressive negli anni Venti, Trenta e Quaranta del XVII secolo.
Prima di allora, i Madrigali contenuti nel suo terzo, quarto, quinto e sesto libro si
erano distinti da quelli dei suoi contemporanei (come Marenzio, Pallavicino, D’India
e Gesualdo) per la loro particolare tensione armonica e per l’uso singolare delle
dissonanze, sia nella dimensione orizzontale che verticale. Monteverdi solamente
fece uso della tensione tra un’armonia tradizionale essenzialmente “modale” e il
linguaggio armonico tonale del futuro (e tra i compositori delle generazioni seguenti
solo Bach ha utilizzato la medesima tensione – compositiva e allegorica – nei suoi
corali).
L’invenzione dello stile concitato diede un’iniezione di energia alla musica proprio
nel momento in cui l’impeto degli inizi del secolo sembrava esaurirsi: l’esempio
migliore è quello del Combattimento di Tancredi e Clorinda. Heinrich Schutz
conobbe bene questo lavoro estremamente provocatorio e polemico. Nell’ultima delle
sue Sinfoniae Sacrae del 1647, Schutz accompagna le parole “Singet den Herrn ein
neues Lied” con un tremolo dei violini ed una declamazione concitata del testo. Al
tumulto dei guerrieri del Tasso si sostituisce l’ impressionante esaltazione e il terrore
biblico del Salmo in lingua tedesca. Da qui passiamo facilmente all’uso che fa Bach
dello stilo concitato in molte delle sue cantate di argomento più guerresco, e nella
sezione centrale di “Es ist vollbracht” nella Passione secondo San Giovanni.
Monteverdi stesso usò lo stilo concitato con più sottigliezza e impatto nel suo ottavo
libro di madrigali: in modo più commovente e per esprimere il senso di appassionato
conflitto e turbolenza emotiva, nel suo meraviglioso adattamento del sonetto “Hor
che il cielo e la terra” del Petrarca.
È giusto sottolineare, anche con una certa enfasi, il fatto che il musicista Monteverdi
abbia preceduto di quasi venticinque anni il filosofo Cartesio nel tentativo di
codificare e analizzare le passioni umane nel suo trattato “Le Passioni dell’anima”
del 1649. E sarebbero dovuti trascorrere ancora cinquant’anni prima che il pittore
Charles Le Brun trasferisse il sistema cartesiano dei principi opposti (come ad
esempio Timore e Speranza) nel mondo della pittura.
In ultima analisi, però, non sono né le teorie né gli esperimenti musicali di
Monteverdi che lo rendono moderno. Ciò che lo rende contemporaneo è la sua
umanità essenziale, che traspare chiaramente dalle sue lettere. Dei pochissimi
compositori capaci di esprimere la propria personalità anche attraverso le lettere,
Monteverdi è stato il primo (Berlioz e Janacek lo hanno seguito): leggendolo, rivela
se stesso come un personaggio essenzialmente simpatico, orgoglioso, vanitoso,
vulnerabile, fallibile ma soprattutto di grande umanità.
Il suo carattere si manifesta con forza nelle sue descrizioni di come fu costretto ad
aspettare davanti alla porta del tesoriere ducale a Mantova prima di ricevere la
paga. O del suo ritorno a Cremona nel 1612 dopo il suo licenziamento improvviso
dalla corte dei Gonzaga. O di come fu derubato durante il viaggio verso il nuovo
impiego a Venezia e costretto ad arrivare nella sua nuova città senza un soldo e
vestito solo di un mantello.
E mi diverto ad immaginarlo aggirarsi nel Teatro Farnese a Parma meditando su
come disporre gli strumentisti sulla scena per una naumachia senza che venissero
anche loro sommersi, o per lo meno bagnati.
Me lo immagino anche come un “omo che li piace il ragionare largamente in
compagnia” dei suoi poeti-collaboratori come Striggio, Strozzi, Busanello e Baodaro
o con il circolo dei suoi assistenti musicali come Cavalli e Ferrari, l’ultimo dei quali
lo descrisse come un Oracolo della Musica.
E mi dispiace molto di esser nato trecento anni dopo: troppo tardi per poter essere
presente a uno di questi “ragionamenti”: tra tutti i compositori della storia, quello
che avrei più voluto incontrare è proprio, e sempre, il divino Claudio.
Grazie.