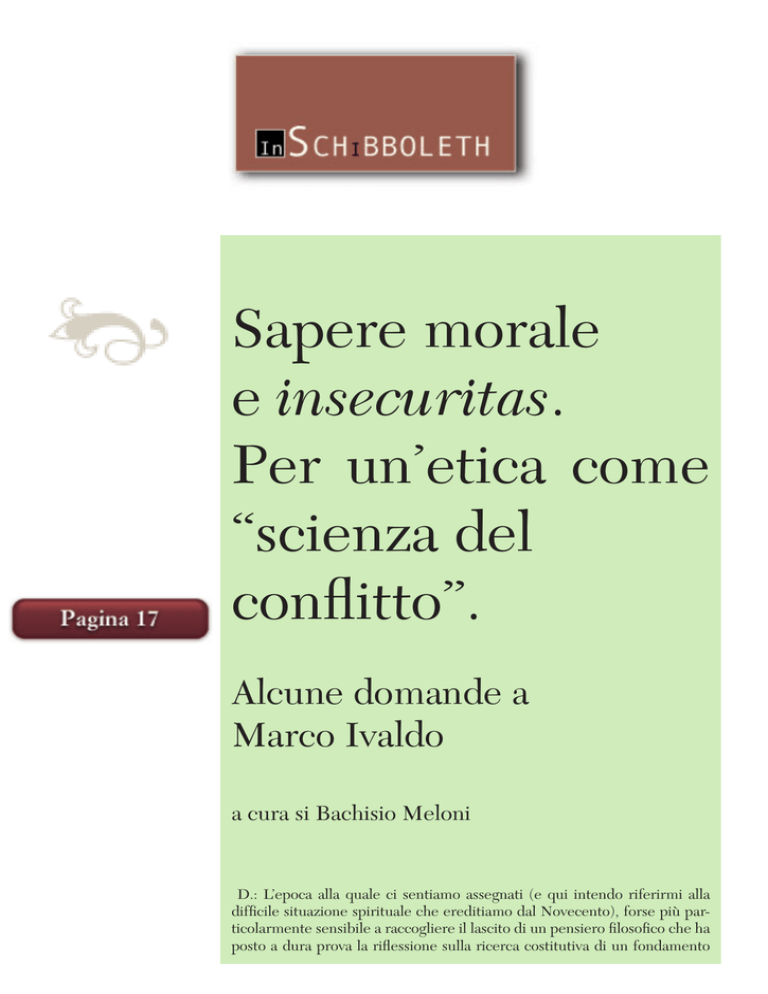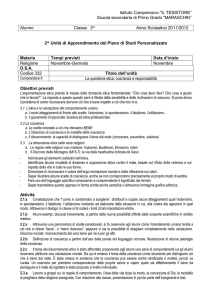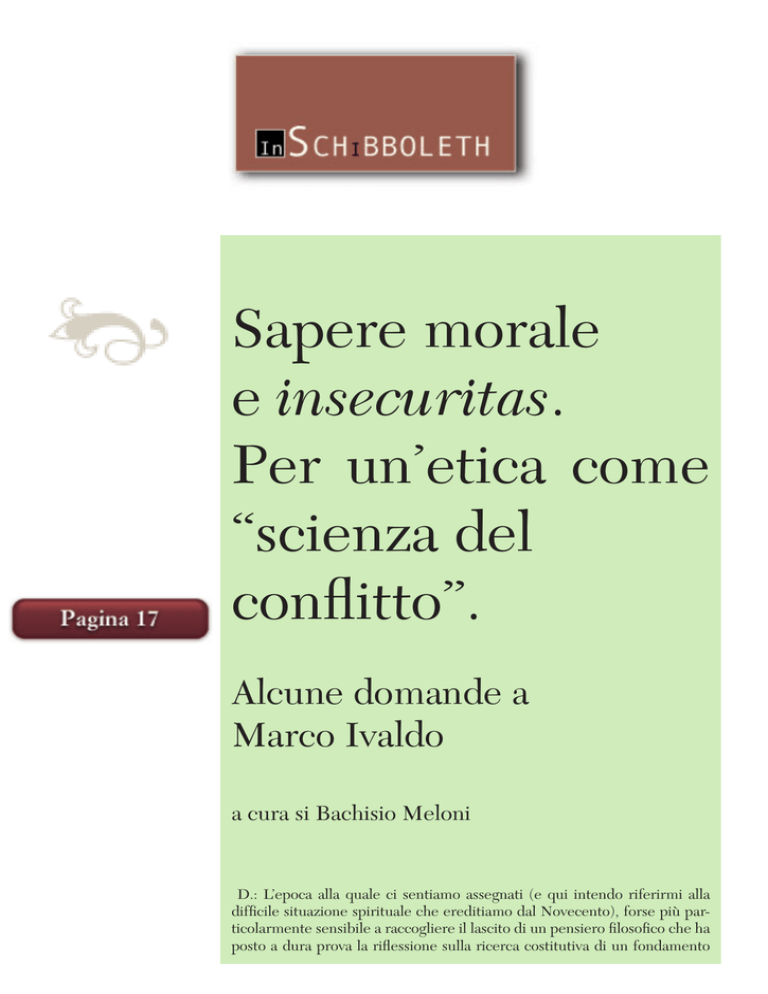
Sapere morale
e insecuritas.
Per un’etica come
“scienza del
conflitto”.
Alcune domande a
Marco Ivaldo
a cura si Bachisio Meloni
D.: L’epoca alla quale ci sentiamo assegnati (e qui intendo riferirmi alla
difficile situazione spirituale che ereditiamo dal Novecento), forse più particolarmente sensibile a raccogliere il lascito di un pensiero filosofico che ha
posto a dura prova la riflessione sulla ricerca costitutiva di un fondamento
morale – penso ai forti legami teoretici fra il pensiero di Nietzsche e quello
di Heidegger –, per quanto caratterizzata nel dopo Husserl a rimettere al
centro delle questioni il punto di vista etico, tende a persistere mantenendo
un orientamento di volta in volta pratico, individuale, legato magari all’immediatezza dei bisogni concreti, ben al di qua di un ordine complessivo generale. Emerge così il disegno di una struttura sociale livellata, aperta alle
più disparate sollecitazioni ma come vincolata ad una serie di coordinate ideali o mentali volte più in prossimità alle mire o agli “istinti di conservazione”
propri dell’“individualità precaria”. Qual è la Sua opionione in proposito?
R.: Vorrei muovere da un’osservazione che guarda anzitutto al nostro
tempo. Assistiamo oggi a un sovraccarico di attese nei confronti dell’etica.
Non soltanto nell’ambito della medicina e della biologia, ma anche nell’ambito della politica, dell’economia, del diritto, ci troviamo confrontati con
questioni e dilemmi di natura morale, rispetto ai quali i costumi e le regole
di comportamento esistenti non riescono, o non sempre riescono, a offrire
soluzioni soddisfacenti. Da qui nasce un bisogno di etica, che va oltre i confini della comunità scientifica, ma abbraccia il più vasto pubblico, e si esprime
con toni e in modi diversi sui mezzi di comunicazione sociale, oppure spinge
alla creazione dei comitati di etica o di strutture di consulenza etica nell’ambito delle istituzioni politiche, della salute, delle imprese. Questo sovraccarico di attese non resta senza ripercussioni sulla ricerca dei filosofi, già con
la sollecitazione che questi ricevono a chiarificare che cosa sia etica, quale
sia la competenza dell’etica, e perciò quali siano il suo scopo e significato,
il suo statuto epistemologico, i suoi strumenti teorici, i suoi limiti. L’etica
contemporanea si trova a questo proposito in una situazione paradossale: la
cosiddetta “epoca della scienza e della tecnica” ha accresciuto enormemente il potere dispositivo sulla vita e perciò la responsabilità dell’uomo, e ha
così fatto emergere un bisogno di etica in forme nuove; tuttavia all’accrescimento del potere non si è accompagnato un corrispondente e proporzionato
accrescimento nella competenza morale, e questo anche perché i filosofi
morali stessi – che dovrebbero lavorare al dispiegamento di un’etica consistente – hanno talora rinunciato al loro compito, in quanto si sono ripiegati
sulla sola ricerca storico-filologica (che è soltanto una parte del loro compito) oppure si dimostrano scettici sulla possibilità di elaborare un’etica capace
di sostenersi di fronte alla ragione e perciò in grado di offrire un contributo
ragionevole alla chiarificazione dei problemi e dei dilemmi morali.
D.: Pertanto, se di etica si può ancora parlare, la intenderemmo al pari
di un’insonne ricerca, o come un risveglio di inesauribili tentativi di aperture
e ricerche tramite la significazione ed il dialogo, in vista di un orientamento
comune, o per dirla con Apel, di una “bussola”, o di una norma etica generale, per l’intera umanità. Ciò a dimostrazione del fatto che l’etica è concepibile non diversamente che come la pratica di un movimento di indagine
volto alla rimessa in questione di un “fondamento nascosto”, di un principio
universale assoluto rintracciabile attraverso una profonda, e non mai determinabile, ricostruzione “genealogica dell’umano”. Siamo in prossimità di ciò
che articola e glorifica la possibilità autentica del senso.
R.: L’etica si trova in una condizione di ricerca anche perché deve apprendere a considerarsi come “scienza del conflitto”, come un sapere filosofico cioè che, in vista della possibilità effettuale del bene, o della “buona
vita”, contribuisce alla soluzione dei conflitti che emergono quando la “nor-
malità dei costumi” non costituisce più una realtà a-problematica, un sostrato ‘naturale’ del vivere collettivo, o non sembra più in grado di orientare
adeguatamente il giudizio morale di fronte alle nuove sfide. In particolare
si possono mettere a fuoco tre tipi di conflitto: 1) il “conflitto morale”, che
nasce quando in una situazione determinata vale più di una sola regola o
obbligazione, ma può esserne seguita una soltanto, ad esempio per la scarsità di mezzi a disposizione; 2) il “dissenso morale”, che compare allorché
la comprensione dei fattori morali e la modalità di interpretazione e applicazione dei principi morali in una situazione determinata sono diverse fra
differenti gruppi di una società (o fra diverse società) a causa delle diverse
visioni del mondo e della vita che sono proprie degli agenti; 3) “l’eccesso
di richiesta normativa”, che si presenta allorché una persona non riesce a
soddisfare tutte e allo stesso tempo le obbligazioni che risultano dai diversi
ruoli (familiari, sociali, professionali) in cui ella è contemporaneamente impegnata. Certamente la competenza dell’etica come “scienza del conflitto”
deve ammettere una limitazione: l’etica non può abolire immediatamente
i mali ampiamente diffusi nella realtà del mondo, ma può cooperare ad arginarli, a impedirli, o a eliminarli, in quanto essa cerca di chiarire il modo
in cui il bene, nella figura della buona vita comune, è possibile. Se risponde
a questo compito l’etica può offrire all’agire umano un orientamento che
serve allo scopo di migliorare le condizioni di vita e di rendere possibile ciò
che non soltanto astrattamente, ma in concreto, può venir chiamato ‘buona
vita’. Ogni etica è poi in certo modo un’etica “situativa”, dato che essa contiene aspetti ed elementi che caratterizzano il contesto individuale e collettivo dell’agente. Ogni situazione richiede l’esercizio di una specifica virtù:
l’esercizio della fortezza, ad esempio, presuppone una situazione in cui è
richiesto coraggio, e qualcosa di analogo vale per le altre virtù. Tuttavia, e
insieme, l’etica è situativa e universalistica; tra i due aspetti non c’è opposizione, se si tiene fermo che esiste un complesso di regole e di imperativi
che vengono via via applicati a situazione mutevoli. Di tali regole alcune
sono invariabili (analogamente a quanto avviene per le regole del calcolo);
altre variano in corrispondenza del mutare delle situazioni (come ad es. le
regole stradali), senza però che necessariamente vari il loro significato o la
loro pretesa di validità (ad es.: le regole del traffico possono mutare, ma non
cambia il carattere normativo della regola del traffico via via stabilita).
D.: A proposito di tale dualismo fra etica situativa e universalistica vorrei
esplicitare con Lei la possibilità di sfatare una fin troppo evidente, tal volta sgradevole, genericità e retoricità di fondo riscontrabile nell’insistente
appello ad un fondamento assoluto. L’impressione è che il vivere secondo
un orientamento fisso e categorico tenda ad esulare dai bisogni pratici, di
volta in volta relativi, immediati, mutevoli, per l’appunto, dando vita così al
dispiegarsi dell’idea di un “mondo dietro al mondo”, di un “fuori” impraticabile proprio in quanto disposizione indeterminata al di là dello spazio e
del tempo comune (è Kant stesso ad offrire l’esempio di un presupposto, se
non di un contrappunto ineludibile: quell’idea di resistenza che l’aria produce quale condizione essenziale al volo della colomba). Uno scenario assoluto che cela l’invito al disconoscimento della “problematicità” della realtà
e l’incapacità di situarsi empiricamente nella turbolenta “irrequietudine”
della Storia. Non è da sottovalutare quanto il vivere all’insegna di un ideale etico assoluto sia di per sé ansia di “follia”, contrapposizione peraltro a
quel principio ideale di ricerca, sclerosi o esaurimento cioè di quella spinta
inestinguibile ed infinita verso il fondamento stesso. Movimento di ricerca
che è piuttosto protrarsi infinito, seppur in grado di svilupparsi proprio in
quanto legato ad una temporalità determinata, pur sempre delimitata nella
sua “insecuritas”, relativa nella sua finitezza.
R.: Vorrei affrontare la domanda a partire dalla relazione fra l’etica e il
costume. L’etica non può non riferirsi al “costume”, alle forme della eticità
vissuta, che stanno abitualmente alla base così dei giudizi morali sul giusto
e sull’ingiusto come della prassi di vita degli uomini in una determinata cultura e società. Tuttavia, il costume non è affatto al di sopra di ogni dubbio,
non tutti i costumi hanno un influsso positivo sul comportamento. Inoltre,
il sentimento morale e il costume non sono affatto esenti dalla possibilità
di divenire insicuri. Ciò che è abituale e ‘naturale’, posto di fronte a nuove
questioni, può cessare di essere tale. Può avvenire – e avviene – che riguardo a domande sulla vita, sul nascere, il morire, o sui limiti della responsabilità individuale e sociale, il costume abituale non metta più a disposizione
degli uomini risposte convincenti riguardo a ciò che è bene o male, giusto o
ingiusto. Ora, l’etica inizia propriamente nel punto, o nel momento, in cui
il sentimento morale smarrisce la sua sicurezza e la distinzione fra buono e
cattivo, mediata dal costume, non risulta più evidente. L’etica è il sapere morale nella condizione dell’insicurezza. In questo senso l’etica è la ricerca dei
“fondamenti” per giustificare (criticamente e auto-criticamente) la distinzione di ciò che, secondo il sentimento morale, è buono o cattivo. L’etica ha
a che fare perciò con il momento della “fondazione” o della “giustificazione”
del dover-essere, e possiamo pensare questo lavoro come un processo sempre aperto della riflessione e della argomentazione. Occorre distinguere fra
“validità” e “giustificazione”. Avere validità significa “essere in vigore”, “essere in atto”, oppure “venir riconosciuto”. Giustificare significa invece “ben
fondare”, o anche conferire legittimità. Ad esempio: “valgono” disposizioni,
decisioni, pratiche di vita, norme o regole di procedura, in quanto esse vengono riconosciute e abitualmente seguite entro determinati contesti o ordinamenti. Al fatto che tali pratiche valgano, ovvero vengano riconosciute e
seguite, non è necessaria la circostanza che i loro fondamenti siano saputi in
maniera riflessa dagli agenti, ovvero che tali pratiche siano poste in atto con
l’esplicita consapevolezza dalla loro giustificazione (o giustificazioni) in coloro che le seguono. Tra validità e giustificazioni esiste perciò una relazione
asimmetrica: le validità (cioè le forme di vita o le norme riconosciute) sono
precedenti alle giustificazioni che se ne possono dare e sono indipendenti
da esse. Invece, le giustificazioni sono tali in quanto si riferiscono a validità,
ne ricercano cioè i fondamenti, e perciò le presuppongono. Le validità sono
(normalmente) irriflesse, le giustificazioni riflesse. Tuttavia è vero che le validità – le norme riconosciute come valide – sono, almeno potenzialmente,
sempre sotto “pressione di giustificazione”. Le validità richiedono infatti riconoscimento, e il riconoscimento è una prima forma di giustificazione, che
però non è immune da errore. Nella richiesta di riconoscimento si annuncia
perciò un bisogno di giustificazione effettiva e consistente; se la soddisfazione di questo bisogno viene in linea di principio esclusa, la validità, ad es. di
una norma, perde di legittimità.
D.: Viene naturale a questo punto del nostro dialogo affermare che l’etica, nella sua condizione di insicurezza, non possa far a meno della volontà
privata, di matrice “utilitarista”, che essa cioè non sia possibile se non a partire da un egoismo di fondo, pratico ed essenziale – eppure critico ed auto-
critico, come Lei osserva – il quale, sia ben chiaro, dovrà pur sempre essere
distinguibile non tanto come fine a se stesso, quanto come punto iniziale da
cui poter ripartire. Parliamo di un Io disposto quindi a perdere la propria
“ipseità”, il cui egoismo – in grado di affermarsi in qualità di riconoscimento
del proprio infinito valore personale – non possa essere praticato se non alla
stessa stregua di un circuito esiziale suscettibile però al contempo di evocare
l’invito ad essere spezzato e scongiurato; ambito dell’autonomia personale
che è pur sempre rifiuto dell’indistinzione dell’en masse (così tanto denunciata da Kierkegaard), rifiuto della totalità compiuta e della pianificazione
sociale, manto di dominio costrittivo da cui poter liberamente prendere le
distanze; insomma, siamo dell’avviso che l’alterità dell’universale non possa
fare a meno del per sé dell’esistenza individuale.
R.: Vorrei riferirmi qui a Rousseau. Questi mette in luce che energie
fondamentali dell’uomo sono l’amore di sé (amour de soi) e la compassione
(commisération) per la sofferenza dei propri simili. Nel passare dallo stato
di natura alla società, nella quale regna la lotta degli uni con gli altri, l’amore
naturale di sé diviene l’amor proprio (amour propre). Il rimedio a questa
degenerazione è una superiore evoluzione in virtù della componente spirituale dell’uomo, cioè lo sviluppo dell’amore di sé in un amore dell’ordine
totale della realtà (amour de l’ordre), sicché l’amore di sé si estende agli
altri uomini, nei quali il singolo si ritrova e si riconosce. Questa evoluzione
spirituale resta ancora sempre il nostro compito etico. La moralità non è
soltanto osservanza della regola indispensabile che rende possibile un rapporto tra liberi ed eguali, tanto da dover dire che la libertà a questo livello è
riconoscere una regola. La moralità è anche azione creativa, incarnazione di
idee o valori che promuovano la vita dell’uomo e degli uomini, una ricerca
nella quale gioca un ruolo essenziale la fantasia creativa. Bergson con la sua
distinzione fra la morale della pressione sociale e l’etica dell’ispirazione ha
messo a fuoco questa essenziale articolazione dell’ordine morale: non abbiamo soltanto l’imperativo del non-devi, ma anche quelli del “devi”, o anche
del “Sii”! In questo senso l’io trova se stesso – la propria ipseità, da non
confondersi con una statica medesimezza – (ri)trovandosi con l’altro, già con
quell’altro che egli ospita in se stesso (l’estraneità interiore, della quale parla
Armando Rigobello).
D.: Che l’etica permanga fondamentalmente in qualità o modalità di ricerca di questo principio costitutivo dell’umano (come trascendimento della
singolarità chiusa ed apertura nel segno della relazione), che l’atteggiamento
etico sia per sua essenza tensione dialettica e movimento spirituale verso ciò
che costituisce e determina tale movimento stesso: di ciò stiamo discutendo;
di ciò che, in termini hegeliani, determina il generativo del senso. Ossia, ma
è convinzione o sfumatura del tutto personale, del riconoscimento dell’impossibilità di ottenere una norma e finanche una modalità di trascendenza
comune, fine o impossibilità del dialogo – che è impossibilità dell’etica stessa
in termini assoluti, della sua negazione. O quantomeno: ispirazione o tentativo di risalita al fondamento dell’etica, a patto di vivere però tale senso
genealogico di ricerca non altrimenti che come movimento inarrestabile,
infinito, di volta in volta principio da recuperare e da riaffermare nella sua
essenza assoluta, e perciò stesso inattingibile. Etica e metafisica, Le chiedo,
si incontrano, peraltro dicendosi e dis-dicendosi in questa comune e forse
disarmante, perché in fondo per sempre tragica, tensione?
R.: Penso che l’‘etico’ sia una struttura originaria della coscienza umana,
che si impone a partire da se stesso nella presentazione della legge morale,
in ciò che Kant ha designato come il fatto della ragione pratica. La legge
morale dal canto suo non dipende dall’uomo, ma lo sovrasta, ed esige assoluta obbedienza, anche se in questa richiesta è implicata la possibilità della
trasgressione, ossia è implicata la libertà umana come capacità di bene e di
male. Se l’esperienza morale non fosse accompagnata dall’esperienza di trascendenza, e di alterità, della legge morale, scomparirebbe, come ha messo
in luce Kant, qualsiasi distinzione fra bene e male, che sono gli oggetti della
ragione pratica dischiusi dalla coscienza del dovere-essere, che potremmo
anche esprimere come la coscienza, o l’appello, della persona che devo/voglio essere (coscienza che si manifesta, ad esempio, in quelle che Taylor
chiama le “valutazioni forti”). In questo senso l’etica è autonoma rispetto alla
metafisica. Al tempo stesso tra metafisica e morale esiste un nesso di inseparabile articolazione, variamente declinato nella tradizione della filosofia:
se la legge morale comanda incondizionatamente, questa incondizionatezza
non può avere nell’uomo la sua origine, ma ha a che fare con la dimensione originaria dell’essere. Certamente, di questa dimensione dell’originario
possiamo dare soltanto predicazioni indirette, e avanzare affermazioni simboliche, o asserzioni “al limite”, dato che ogni nostro sapere e parlare si relaziona in via diretta alla sfera dell’apparire. Si tratta di un dire che insieme
deve concomitantemente dis-dire se stesso, come Fichte ha mostrato nella
sua filosofia trascendentale.
D.: Un’ultima domanda, Professor Ivaldo, spero in grado di condurre il
nostro discorso a riflettere degnamente sul caso specifico della situazione
politica attuale (non solo italiana e non solo europea). Penso però, in
parallelo al nostro discorso, più che alla ricerca di un fondamento assoluto
(semmai realizzabile in una società in grado di riconoscersi nei termini di
una comunità civile), alla compossibilità di uno scardinamento (avveduto,
sensato) dell’orientamento comune, chiedendomi se la ricerca di nuove
prospettive di pensiero, per quanto forse più attinente a quell’ibrida
assunzione del “politeismo dei valori” (di cui paventiamo tuttavia esiti
puramente emotivi, se non persino irrazionalistici, dove l’“altro” si rivela
l’assolutamente “superfluo”), possa giungere a determinare in modo più
proficuo il rovesciamento della tradizionale genealogia dei riferimenti ideali,
dei modelli teorici di ispirazione. Mi riferisco in tal caso – ma non saprei
dire quanto pertinente sia il mio richiamo – alla presente predisposizione
di un vero e proprio nuovo firmamento culturale e intellettuale, specie in
seno alla componente militante della nuova destra (per cui Hannah Arendt
succede al posto di Jünger o Schmitt, Aron e Berlin subentrano a Popper
e von Hayek ecc.), dove la spasmodica ricerca di nuove coordinate, specie
se autenticamente vissuta, sembra contraddistinguere la riflessione postideologica dell’epoca attuale.
R.: La domanda mi sollecita a considerare alcune, serie modificazioni del
costume: in questi anni, non solo in Italia, ma in Italia con caratteri abbastanza
decisi, si viene imponendo e diffondendo – certo con diverse gradualità, ma
in modo piuttosto diffuso – una certa immagine di uomo, un forma mentis
che plasma le scale di priorità e i piani di vista personali. È l’emergenza di
un individuo che si vuole come auto-referenziale, coltiva i propri desideri
interpretandoli in maniera semplicemente empirica ed egoista, eleva
immediatamente questi desideri, così angustamente interpretati, a misura
del proprio rapporto con la realtà. Questo individualismo onni-desiderante,
propagandato come comportamento quasi “naturale” da una parte assai
cospicua dei media – che intende il sacrificio di se stessi come massima
insensatezza e non eleva altro criterio di giudizio che l’auto-soddisfazione
empirica e il successo immediato – rappresenta a mio giudizio la manifestazione
contemporanea più inquietante del nichilismo. Inoltre l’Italia ha conosciuto
negli ultimi anni un processo già da tempo in atto in altre società europee: le
ondate migratorie hanno popolato le nostre città non solo di nuovi colori, ma
anche di culture, costumi, religioni diverse. Orbene, il governo di fenomeni
complessi come l’accoglienza dei diversi, dello “straniero”, e la realizzazione
di una convivenza solidale e regolata fra differenti culture e religioni in uno
stesso spazio territoriale, politico e giuridico, richiederebbero una sapiente
mediazione politica e una consistente cultura della complessità, e non sembra
possano venire ragionevolmente affrontate esorcizzandole con scorciatoie
identitarie, chiusure fondamentalistiche, introversioni localistiche. Un altro
aspetto del quadro è – come già accennavo – l’enorme crescita del potere
tecnologico sostenuto dalle conquiste scientifiche. Come ha accentuato fra
gli altri Hans Jonas la vita non è più oggi un presupposto indiscusso. Le
bio-tecnologie aprono nuove possibilità di intervenire sulla vita, ma questo
potere scientifico-tecnico moltiplica i dilemmi morali – cioè i dilemmi che si
riferiscono non al poter fare, di per sé aperto al bene e al male, ma al dover
essere –, in particolare quando di tratta della vita umana. I codici deontologici
fino ad ora condivisi, e le legislazioni, faticano a padroneggiare le nuove
questioni. Ci troviamo ad esempio confrontati con il potere che le tecnologie
mediche, o le tecnologie che richiedono competenze mediche e sanitarie
per essere applicate, hanno o potranno avere nel determinare i processi che
riguardano sia l’iniziare che il terminare della vita sensibile. Fino a che punto,
cioè entro quale limite etico, relativo al dover essere, l’applicazione di queste
tecnologie alla vita sensibile è compatibile con la natura morale dell’uomo,
natura morale della quale fa parte necessariamente anche la libertà di
determinare con un giudizio se stessi? Su questi punti si contrappongono
abbastanza vivacemente visioni morali e concezioni antropologiche diverse;
la politica si trova messa così a confronto con problemi sui quali sembra
arduo pervenire a soluzioni condivise, dati la differenza delle antropologie
di partenza e il pluralismo conflittuale di visioni morali che non sempre
manifestano reale disponibilità a realizzare quello che Jürgen Habermas
chiama un “apprendimento complementare”. In questo senso si evidenzia
il ruolo costruttivo della ricerca etica come “scienza del conflitto” della
quale parlavo all’inizio, per tentare di padroneggiare secondo la comune
ragionevolezza, esercitata in vista dell’intesa, le questioni maggiori di questa
nostra età complicata.