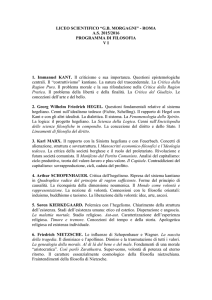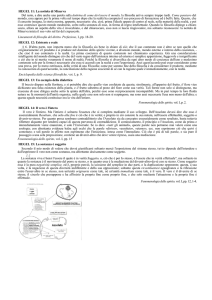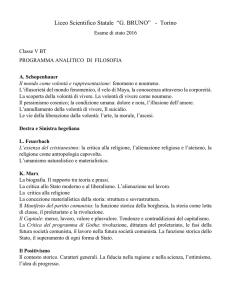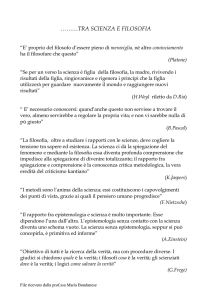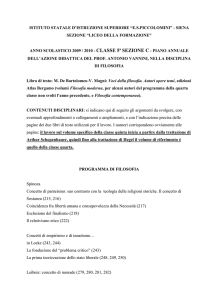INDICE
Che cos’è la filosofia?
I.
L’ULTIMO SISTEMA (Hegel)
L’IDEALISMO HEGELIANO: CERTEZZA E VERITÀ. HEGEL. La vita e le opere. La risoluzione del
finito nell’infinito. Il sistema hegeliano. Il metodo dialettico. Dalla coscienza infelice al sapere
assoluto. La logica. La filosofia della natura. La filosofia dello spirito. Conclusioni.
II.
L’ARCANO DELLA RELIGIONE E DELLA METAFISICA (Feuerbach)
DESTRA E SINISTRA HEGELIANA. FEUERBACH. La vita e le opere. Il capovolgimento del rapporto
soggetto/predicato. La demistificazione della religione. L’alienazione religiosa. La critica alla
metafisica. La filosofia dell’avvenire. Conclusioni.
III.
DALLA METAFISICA AL MATERIALISMO STORICO-DIALETTICO (Marx)
KARL MARX. La vita e le opere. LA CRITICA DELLA FILOSOFIA. Il rovesciamento di Hegel. I
conti con Feuerbach. La dialettica. Una comparazione del concetto di alienazione. La concezione
materialistico-dialettica della storia. LA CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA. Il metodo. Il
Capitale. LA CRITICA DEL SOCIALISMO UTOPISTICO. Dall’utopia alla scienza. Le classi sociali.
Lo Stato. La dittatura del proletariato. Abolizione della proprietà dei mezzi di produzione.
Socialismo e comunismo. Conclusioni.
IV.
LA MORTE DI DIO E L’OSPITE INQUIETANTE (Schopenhauer, Nietzsche)
SCHOPENHAUER. La vita e le opere. L’eclettismo schopenhaueriano. Il “velo di Maya”. Il mondo
come volontà. La vita oscilla tra il dolore e la noia. Il significato dell’amore. Filosofia e
religione. Il rifiuto dell’ottimismo o la critica all’Occidente. La liberazione dal dolore.
Conclusioni.
NIETZSCHE. La vita e le opere. Interpretazioni del pensiero nietzschiano. Pensiero e modus
operandi. Apollineo e dionisiaco. Storia e vita. La filosofia illuminista e genealogica. La morte
di Dio e della metafisica. L’avvento del Superuomo. Zarathustra. L’eterno ritorno. Genealogia
della morale. La volontà di potenza. L’ospite inquietante. Prospettivismo. Conclusioni.
V.
DALL’ESSERCI COME POSSIBILITA’ ALL’EPOCA DELLA TECNICA (Heidegger,
Galimberti)
L’ESISTENZIALISMO. HEIDEGGER. La vita e le opere. Il primo Heidegger: l’analisi dell’esistenza.
Essere e Tempo. L’Essere-nel-mondo. L’esistenza inautentica. La cura. L’esistenza autentica. La
voce della coscienza. Il tempo e la storia. La Kehre. La metafisica e il nichilismo. Essere, uomo,
evento. La centralità dell’essere. Arte, linguaggio, poesia. La tecnica. La fine della filosofia e il
compito del pensiero. Conclusioni.
GALIMBERTI. La vita e le opere. Psiche e techne. L’uomo e la tecnica. La tecnica è il nostro
mondo. La tecnica è l’essenza dell’uomo. La genesi ‘strumentale’ della tecnica. La
trasformazione della tecnica da ‘mezzo’ in ‘fine’. La revisione degli scenari storici. La
soppressione di tutti i fini nell’universo dei mezzi. La fine della dialettica servo-padrone. La
revisione delle categorie umanistiche. La tecnica e il nichilismo. L’inadeguatezza della
comprensione umana. Il nichilismo e i giovani. Conclusioni.
2
VI.
LA RIDEFINIZIONE DELL’IO: LA RIVOLUZIONE PSICANALITICA (Freud)
FREUD. La vita e le opere. La nascita della psicanalisi. L’inconscio e le vie per accedervi. La
topica della psiche: Es, Io, Super-Io. La teoria della sessualità. Il disagio della civiltà.
Conclusioni.
VII. LA
CRISI DEI FONDAMENTI SCIENTIFICI E LA FILOSOFIA DELLA SCIENZA
(Comte, Popper, Khun, Lakatos, Feyerabend)
LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA. IL POSITIVISMO DI COMTE. La legge dei tre stadi. LA CRISI DEI
FONDAMENTI. IL FALSIFICAZIONISMO DI POPPER. Il falsificazionismo. L’induttivismo. Scienza e
verità. Il realismo dell’ultimo Popper. IL POST-POSITIVISMO DI KHUN, LAKATOS E FEYERABEND.
Khun: La struttura delle rivoluzioni scientifiche. Lakatos: La metodologia dei programmi di
ricerca. Feyerabend: Contro il metodo. Conclusioni.
ANTOLOGIA
L’ultimo sistema:
Hegel, Lezioni di storia della filosofia. Concezione volgare della filosofia.
Hegel, Scienza della Logica. Essere. Nulla, Divenire.
Hegel, Fenomenologia dello spirito. Signoria e servitù.
L’arcano della religione e della metafisica:
Feuerbach, Tesi e Principi.
Engels, Ludovico Feuerbach e il punto di approdo della filosofia classica tedesca.
Dalla metafisica al materialismo storico-dialettico:
Marx-Engels, Manifesto del partito comunista.
Marx, Tesi su Feuerbach.
La morte di Dio e l’ospite inquietante:
Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione.
Schopenhauer, O si pensa o si crede.
Nietzsche, La gaia scienza.
Nietzsche, Così parlò Zarathustra. Introduzione.
Dall’Esserci come possibilità all’epoca della tecnica:
Heidegger, Essere e Tempo. L’esser-per-la-morte.
Heidegger, La questione della tecnica.
Galimberti, Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica.
3
L’umiliazione dell’Io: la rivoluzione psicanalitica:
Freud, Il piccolo Hans
La crisi dei fondamenti scientifici e la filosofia della scienza:
Comte, Corso di filosofia positiva
Popper, Logica della ricerca e società aperta. Sull’induzione
4
CHE COS’E’ LA FILOSOFIA?
La filosofia è la ricerca della verità!
Che cos’è la verità?
La verità è, ad un tempo, alétheia cioè ciò che ‘sta in luce’, ed epistéme cioè ciò che ‘sta sopra’.
La verità è, dunque, un sapere cristallino, palmare e, perciò stesso, incontrovertibile, innegabile,
assoluto, eterno, immutabile, perfetto che né uomo, né dio può mettere in discussione: non è
soggetta alla corrosione del tempo, né ai costumi, ecc.
Il senso greco della verità è una dimensione forte e inaudita - proprio nel senso di mai udita prima.
Come cogliere questa “ben rotonda verità” (Parmenide)?
Qual è il modo per guardare il volto della realtà così com’è, nella sua verità?
“Bisogna seguire il comune. Pur essendo comune il Lógos, i molti vivono come se avessero una
saggezza privata” (Eraclito)!
Il Lógos va tradotto in maniera energica: ragione, logica! Ciò che è comune a tutti gli uomini è,
appunto, il Lógos. La ragione è il mezzo attraverso il quale si lascino le cose parlare venire alla luce
affinché si mostrino nella loro assoluta evidenza e, dunque, innegabilità. Comune non è l’opinione
dei dormienti che è semplice rappresentazione soggettiva del reale; non è la produzione poetica del
mito, ecc.
Comune agli uomini è il Lógos e tutti possono ritrovarsi in esso.
La verità non è nell’opinione (dóxa) che per sua stessa natura è un sapere soggettivo, individuale
che si fonda sui sensi, sulla tradizione o su qualsiasi rivelazione. La verità non è nel racconto
mitico-religioso che si basa sul senso estetico o sulla fede. O si crede o si pensa!
La filosofia pensa! La filosofia fin dall’inizio si distanzia dal sapere soggettivo, relativo che non
può essere dimostrato oggettivamente. La filosofia sceglie risolutamente ciò che è comune a tutti
gli uomini e in cui tutti possono riconoscersi: il Lógos.
La filosofia è la ricerca della verità attraverso il Lógos!
Dalla pòlis greca sbuca questo senso inaudito del sapere come dalla testa di Zeus saltò fuori Athena
di tutto punto vestita per la pugna e lancia e scudo. La filosofia nasce guerriera contro un sapere
fallace, contro il buio che intorpidisce: non c’è autorità del tempo che tenga sotto il suo maglio; non
c’è sapere reale nei sensi che abbagliano; non c’è possibilità di fondazione nell’atto di fede perché
esso è inscritto nella stessa dimensione della dóxa. Solo il Lógos, comune a tutti gli uomini, ci
rivela il volto della realtà nella sua oggettività: mostra le cose nella luce, nella loro evidenza tale che
non è possibile contraddirle.
5
Con questo senso inaudito della verità la filosofia subitaneamente, come un crepitio di fuoco, crea
cieli mai visti, schiude orizzonti, radure inusitate.
Alétheia, Epistéme, Lógos questi i remi con cui una nave di temerari fece “ali al folle volo”, oltre le
colonne d’Ercole, oltre i mari e i cieli conosciuti.
Una verità assoluta da cogliere con la ragione! Temerarietà e arroganza! Un progetto titanico; una
cosa inaudita – proprio nel senso, ora, di folle e, diremo, arrogante! La filosofia, per la prima volta,
distingue il mondo fino allora guardato attraverso la produzione soggettiva, da un mondo di cui
possiamo conoscere la verità come sapere oggettivo e assoluto. La filosofia si pretende epistéme,
cioè scienza, sapere oggettivo, appunto!
Non è cosa da poco! E’ precisamente in questo progetto titanico, folle e arrogante, cioè nel senso
greco della verità, la radice fondante e ultima dell’intera cultura Occidentale cioè di quella parte
del mondo che si crede mondo e che, effettivamente, ha finito con il produrre un mondo a sua
immagine e somiglianza.
Un tratto caratteristico del volto della filosofia greca è lo sguardo rivolto al Tutto. Il greco fin
dall’inizio capisce che gli elementi possono essere conosciuti solo all’interno della totalità, solo
all’interno della connessione parte-Tutto: un braccio staccato dal corpo non è che un “braccio
dipinto” (Aristotele) inutile per capirne la funzione ecc. In effetti, il concetto stesso di verità,
determinato come sapere assoluto, non è concepibile se non all’interno della totalità. La verità non
può essere la verità di una parte, perché sarebbe solo una parte della verità lasciandosi contaminare,
con ciò, dal falso.
Il Tutto è quella dimensione nella quale tutto è compreso; in cui tutte le cose stanno e al di fuori
della quale non è possibile che vi sia alcunché. Il Tutto è la dimensione della verità. La verità è la
verità del Tutto. Lo sguardo del filosofo greco è rivolto al Tutto come unica possibile dimensione
della verità! Tratto, quest’ultimo, messo in discussione dalla filosofia della natura ovvero da ciò che
oggi chiamiamo scienza.
Solo guardando in faccia la filosofia greca, che è l’inizio e il fondamento della filosofia, possiamo
riconoscere, poi, le differenze, le cicatrici e ciò che ci rimane della idea di verità e di Lógos.
Ovvio, allora, che lo studio della storia della filosofia è indispensabile ed è fare filosofia!
Bisogna, altresì, evitarne lo studio come se fosse una galleria di quadri dove ognuno sceglie a
partire da ciò che è più vicino alla sua ‘natura’, meglio, ‘incontra’ la sua sensibilità e il suo gusto.
Questa concezione volgare della storia della filosofia deve fare spazio alla considerazione che i
diversi e contrastanti sistemi filosofici non sono fantasie private, ma il lungo faticoso cammino del
pensiero per determinare la verità.
Ricorda il buon vecchio Hegel, riprendendo tenacemente il senso greco della verità e della storia
della filosofia, che essa non è una “filastrocca di opinioni” per il semplice motivo che in filosofia
non ci sono opinioni! “La filosofia è scienza oggettiva della verità, scienza della necessità della
verità, conoscenza concettuale, e non già opinare e filza di opinioni” (Lezioni sulla storia della
filosofia).
Ad uno studio attento le ‘diverse’ filosofie hanno un legame profondo, un fondo comune e
registrano, man mano, progressi effettivi della scienza filosofica. Progressi lenti, difficili, che
impegnano in dure battaglie concettuali. E’ un processo laborioso della ragione che tenta di districar
nodi: nodi concettuali, problemi che il pensiero, nel suo incedere trova inevitabilmente. I diversi
filosofi, nel momento in cui cercano, trovano, risolvono aporie e confutano, non fanno altro che
districare nodi, con ciò facendo avanzare il pensiero verso la scienza, la verità.
Gli idioti fanno sempre lo stesso errore, i filosofi, magari, ne fanno sempre di nuovi e così
conquistano alla luce nuovi territori!
6
Se da una parte Hegel ci sprona a guardare alla storia della filosofia come ad una scienza che
registra progressi, dobbiamo tener pure ferma l’indicazione di Marx che ci avverte che la filosofia,
in quanto sovrastruttura, non ha una propria autonomia: “Non è la coscienza degli uomini che
determina il loro essere, ma è, al contrario, il loro essere sociale che determina la loro coscienza”
(Per la critica dell’economia politica).
Lo studio della storia della filosofia bisogna che tenga dietro alle confutazioni e agli avanzamenti
della scienza così come all’incurvarsi alla necessità storica!
Con queste semplici ipotesi di lavoro ci siamo messi in acqua per imparare a nuotare, pardon, a
filosofare!
prof. Alfredo Carrella
7
I. L’ULTIMO SISTEMA
(Hegel)
~ L’IDEALISMO HEGELIANO
~ HEGEL
~
~
~
~
~
~
~
~
La vita e le opere
La risoluzione del finito nell’infinito
Il sistema hegeliano
Il metodo dialettico
Dalla coscienza infelice al sapere assoluto
La Logica
La filosofia della natura
La filosofia dello spirito
~ CONCLUSIONI
8
L’IDEALISMO HEGELIANO: CERTEZZA E VERITA’
Georg Wilhelm Friedrich Hegel siede accanto a giganti come Platone, Aristotele e Kant. E’ indubbio pure
che Hegel rappresenti il culmine, lo zenit della filosofia o, quantomeno, di un modo di fare filosofia, come
rappresenta anche il punto oltre il quale si schiudono altre strade, orizzonti, radure. Insomma, Hegel è uno
spartiacque! Con Hegel il volto della filosofia avrà tratti assai precisi, così come dopo di lui il cambiamento
sarà radicale: una totale rivoluzione!
Con Hegel ci si trova di fronte al compito titanico di ultimare quel percorso filosofico iniziato nel 600 a. C.
con Talete e contemporaneamente di comprendere l’ultimo tassello di una dura conquista filosofica.
Hegel è il più greco dei tedeschi: l’ultimo filosofo a riproporre il concetto greco di verità assoluta; l’ultimo
filosofo a proporre un sistema filosofico.
Ma iniziamo dall’inizio! Per Hegel la filosofia non è una semplice “galleria di opinioni” in cui l’uomo può
scegliere il ‘quadro’ che più lo affascina o lo colpisce. A questa diffusa e melensa concezione egli risponde
ricordando che se davvero così fosse la filosofia “sarebbe in ogni caso una scienza del tutto superflua e
noiosa, per quanto profitto si possa trarre dall'esercizio del pensiero e dall'erudizione”. La filosofia per Hegel
coincide con il senso forte che i greci avevano dato a questa disciplina: epistéme! Magnificamente, nelle
Lezioni sulla storia della filosofia, ricapitola che “la filosofia è scienza oggettiva della verità, è la scienza
della sua necessità, è conoscenza concettuale, non un opinare o tessere opinioni.”
La storia della filosofia per Hegel è un organismo autonomo in cui i vari sistemi di pensiero, pur nella loro
diversità, sono la stessa filosofia in diversi gradi di svolgimento. I diversi sistemi filosofici non hanno
nulla di accidentale o inessenziale ma sono, al contrario, momenti necessari di uno stesso organismo,
appunto, che evolve verso la comprensione dello Spirito Assoluto e di cui la filosofia hegeliana è, dunque,
anche l’ultima figura.
Per Hegel la filosofia antica e medievale è stata solamente comprensione dell’idea, quella moderna, da
Cartesio in poi, invece, è stata comprensione dello spirito. Con ciò Hegel vuole intendere che il tratto
caratteristico – non privo di notevoli eccezioni – della filosofia greca è quello di concentrarsi sulla realtà,
dimenticando che tale riflessione è pur sempre frutto del pensiero. L’essenziale, nel pensiero greco, è la
realtà, mentre il pensiero umano è generalmente considerato accidentale, cosa tra le cose. Comprensione
dello spirito significa, invece, riconoscere alla filosofia moderna il merito di porre il pensiero stesso a
contenuto della propria riflessione e, pian piano, riconoscere che il pensiero stesso è la realtà. Questo salire,
dall’idea allo spirito, nella storia della filosofia si esplica nel rapporto tra certezza e verità che si sviluppa,
secondo Hegel, lungo una dialettica triadica:
1) Identità immediata di certezza e verità (filosofia antica e medievale);
2) Opposizione di certezza e verità (filosofia moderna, da Cartesio a Kant);
3) Identità mediata di certezza e verità – o superamento mediato dell’opposizione tra certezza e verità
(filosofia hegeliana).
In prima approssimazione si può definire certezza il pensiero e verità l’essere. La certezza è il lato soggettivo
della verità, intesa come realtà esterna. L’identità di certezza e verità significa che il pensiero si appropria
della realtà e la mostra esattamente com’è. Il pensiero umano è, in questo caso, in grado di cogliere
esattamente la realtà come è in se stessa.
L’identità di certezza e verità indica quella fase in cui l’uomo pensa che il mondo, pur esistendo
indipendentemente da sé ed esterno alla coscienza, sia, tuttavia, penetrabile attraverso il pensiero. La
filosofia greca, in particolare, pensa che la verità sia il pensiero epistemico-filosofico.
Il primo momento del percorso filosofico inizia quindi con l’uomo greco, convinto che il suo pensiero
corrisponda a verità. Meglio, la realtà appariva all’uomo greco evidente ed incontrovertibile, grazie a quel
Lógos – la ragione, la logica – che scandagliava la realtà e la rendeva comprensibile a tutti, essendo metodo
e linguaggio comune a tutti gli esseri razionali. Le cose, insomma, dovevano essere semplicemente tirate
9
fuori dal buio in cui si trovavano e portate alla luce attraverso il Lógos, appunto. Le cose, illuminate dal
pensiero, si presentavano nella loro chiara e lampante evidenza come vere!
Il greco non pensava quindi che potesse esserci un residuo di verità tra pensiero e realtà. Il pensiero, nella
forma del Lógos, è lo strumento capace di portare le cose alla verità. In questo senso il greco rifletteva così:
a) Le cose sono fuori di noi ed indipendentemente da noi;
b) Il pensiero dell’uomo, pur nella sua particolarità, è cosa tra le cose e, per questa sua contiguità, ha la
possibilità di cogliere la verità delle cose sottoponendole al Lógos;
c) Il pensiero, nella fattispecie il pensiero epistemico-filosofico, coglie, senza residui di verità, la realtà
profonda delle cose.
Il greco, nel suo sguardo rivolto al Tutto, non aveva mai posto, quindi, l’interrogativo circa la
corrispondenza tra pensiero e reale, tra razionale e realtà, ma la postulava implicitamente. Si postula,
insomma, che il contenuto immediato del pensiero evidente sia la realtà.
Il secondo movimento del rapporto tra certezza e verità è contrassegnato, al contrario, dalla opposizione che
pian piano viene a configurarsi, tra pensiero e realtà.
Per Hegel la filosofia moderna si rende conto del carattere soggettivo e del tutto mentale del mondo. E’
Cartesio – che Hegel individua come padre della filosofia moderna - a portare alla luce il problema: fa
emergere l’opposizione tra certezza e verità. A rompere la sicurezza greca della corrispondenza tra pensiero e
realtà è la riflessione che la realtà è ‘pensato’. La realtà, le cose, il mondo sono pensate, dunque,
rappresentazione.
Ecco il problema! Il pensato è pur sempre un pensato, una cosa che rimanda a qualcosa fuori di noi. La realtà
che noi cogliamo è solo contenuto di pensiero o idee. Non solo, le rappresentazioni, pure se evidenti,
possono ingannarci. Il dubbio cartesiano è, in fondo, esattamente l’espressione plastica della opposizione di
certezza e verità: Dubito del sole, dubito del cielo, della matematica... e se Dio stesso ci ingannasse? Si tratta
allora di capire se tutto il nostro sapere ha un carattere ipotetico o è definibile come incontrovertibile.
L’asse della riflessione si è ora radicalmente spostato verso lo strumento che coglie la realtà: il pensiero. La
filosofia moderna mostra che le cose sono pensate, dunque rappresentazioni, e che per questo il contenuto
immediato del pensiero, che è unica certezza, non può essere verità. Infatti, chi può assicurare che le
rappresentazioni corrispondano alla realtà?
In Cartesio l’opposizione di certezza e verità è ancora problematica, in Kant essa diventa radicale e
definitiva. La realtà, in quanto pensato, non è la realtà in sé stessa, ma mero contenuto di pensiero o idea. La
realtà è sempre una rappresentazione, ciò che appare: il contenuto del pensiero è il fenomeno. Dunque, le
cose in sé stesse non possono essere conosciute, sono inconoscibili!
In Kant è la realtà che si adatta alla natura della nostra conoscenza, alla struttura del nostro pensiero! Fin da
Cartesio sapevamo che il mondo è rappresentazione, ma Kant mostra che il mondo è prodotto dall’uomo; le
leggi che regolano il mondo sono prodotte dall’uomo. Il mondo, per quanto ‘roccioso’ e ‘duro’ possa
apparire diventa ‘liquido’ e si adatta alla coppa della conoscenza umana. Infine, Kant mostra che voler
legittimare teoreticamente la conoscenza con l’esistenza di un Dio – magari buono come in Cartesio – è pura
follia: metafisica!
Per Kant non si può uscire dalla rappresentazione, per quanto si possa approfondire la sua comprensione essa
rimane semplice conoscenza dell’apparenza e mai della cosa in sé. La cosa in sé è ciò che è indipendente
dalla struttura della soggettività umana ed è, perciò, inconoscibile. Impossibile proporre la metafisica come
conoscenza delle cose in sé. Impossibile la metafisica come scienza!
Il terzo movimento nel rapporto tra certezza e verità è rappresentato dalla stessa filosofia hegeliana: identità
mediata di certezza e verità. L’idealismo hegeliano rappresenta il tentativo di riportare la riflessione
filosofica nello spazio metafisico del Tutto.
10
Innanzitutto, la critica che l’idealismo muove alla cosa in sé è che essa non è affatto chiusa in sé e al
conoscere ma, in quanto concepita, essa è aperta al conoscere. Questa contraddittorietà fa sì che tutto sia
riportato all’interno del pensiero e niente esista indipendentemente da esso.
In effetti, Kant aveva distinto tra conoscibile e pensabile, ma per l’idealismo non è possibile mettere limiti al
pensiero. Hegel rimprovererà a Kant di voler fare come “quel tale Scolastico, d’imparare a nuotare prima di
arrischiarsi nell’acqua” (Enciclopedia, par. 10) a voler significare che non è possibile conoscere prima di
immergersi nella realtà.
Non solo! L’idealismo va oltre! Se non si presuppone, come nella filosofia greca e finanche in quella
moderna fino al criticismo kantiano, che la realtà esiste esternamente e indipendentemente dal pensiero non
si può assolutamente chiamare il contenuto del pensiero rappresentazione.
Chiamo rappresentazione ciò che è il riflesso, il prodotto di qualcosa d’altro cioè della realtà esterna e
indipendente dal pensiero. Se rinuncio, invece, all’idea che la realtà esiste indipendentemente dal pensiero,
necessariamente non potrò chiamare il contenuto del mio pensiero rappresentazione. Se, insomma, tolgo la
cosa in sé, il fenomeno non ha più ragion di esistere, ma esso è, semplicemente, la realtà, ossia la verità,
come si presenta nel mio pensiero.
Per Hegel, dunque, la realtà si presenta senza veli alla conoscenza. Ciò che appare nel pensiero è la realtà!
Presupporre un qualcosa al di là del pensiero è comunque un modo di pensarla, concepirla e dunque, oggetto
di conoscenza. Con la impossibilità della cosa in sé viene meno anche la sua inconoscibilità.
Ora, con il realismo greco, l’idealismo tedesco ha in comune l’identità di certezza e verità, ma, se nel primo
essa era immediata, nel secondo è mediata. La nuova posizione rompe con il realismo in quanto si afferma
che al di là del pensiero non v’è nulla: si nega ogni realtà che sia fuori dal pensiero.
L’idealismo, nella forma hegeliana, nebulizza il mondo esterno, il mondo duro e roccioso si sublima
annichilendosi. Come un mago fa scomparire il coniglio dal cilindro così l’idealismo fa scomparire,
nientemeno, che il mondo! Il pensiero è l’inizio e la fine! Il pensiero è il Tutto e Tutto è nel pensiero!
Siamo di nuovo alla ripresa di un tratto fondamentale della filosofia greca: il Tutto!
Siamo di nuovo alla metafisica!
Quella hegeliana non è però una riproposizione della metafisica greca – metafisica dell’essere come mondo
esterno – ma una metafisica del pensiero, giacché Tutto è pensiero.
Si ricorderà che in Spinoza il pensiero è solo una parte della Sostanza intesa come la cosa in sé esterna al
pensiero, e non come il pensiero stesso. In Spinoza Deus sive natura! Dio e natura coincidono!
Hegel rimprovera a Spinoza di non aver detto a chiare lettere che la Sostanza è Soggetto: nell’idealismo
hegeliano la Sostanza, infatti, non è che il pensiero, Soggetto.
In Hegel l’attività del pensiero è autoproduzione dell’essere in modo che solo al suo interno sia possibile la
Storia dell’essere. In Spinoza, invece, l’Assoluto è una sostanza statica che coincide con la natura, mentre
nell’idealismo hegeliano è un soggetto spirituale in movimento che si sviluppa ed evolve: un processo.
Riassumendo: il pensiero, pensando l’essere, lo produce; l’Assoluto è un processo di auto-produzione, è
Storia, e proprio perché fuori non c’è nulla la sua non può che essere autocoscienza: la coscienza che pone a
contenuto della propria coscienza sé stessa.
Fine della storia del mondo è dunque che lo spirito giunga al sapere di ciò che esso è veramente, e
oggettivi questo sapere, lo realizzi facendone un mondo esistente, manifesti oggettivamente se stesso.
L'essenziale è il fatto che questo fine è un prodotto. Lo spirito non è un essere di natura, come
l'animale; il quale è come è, immediatamente. […] In questo processo sono dunque essenzialmente
contenuti dei gradi, e la storia del mondo è la rappresentazione del processo divino, del corso graduale
in cui lo spirito conosce se stesso e la sua verità e la realizza. (Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia)
Il pensiero umano è il Pensiero e, in quanto tale, Assoluto. In questo senso Uomo e Dio coincidono e perciò
il dogma cristiano dell’Incarnazione del Verbo rappresenta, per Hegel, una profonda verità filosofica.
11
Per il realismo, il criticismo ed il materialismo, che ipotizzano una realtà esterna ed autonoma, il pensiero è
lo strumento che ci permette di comprendere il mondo. Per l’idealismo il pensiero è il mondo! In questo
senso l’idealismo è immanentismo, cioè ciò che produce la realtà è l’essenza stessa del mondo.
HEGEL
La vita e le opere
G. W. F. Hegel nacque a Stoccarda il 27 agosto 1770. Dopo aver conseguito la maturità nel 1788, si iscrisse
alle Facoltà di Filosofia e Teologia all'Università di Tubinga, dove conobbe Friedrich Schelling.
Nel 1801 entrò come docente all’Università di Jena. La Fenomenologia dello Spirito (1807) segnò il distacco
definitivo da Schelling. Notevolissime sono la pubblicazione de La Scienza della logica (1812-16),
l’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (1817).
Nel 1818 Hegel è chiamato dal ministro della pubblica istruzione, che vede nella filosofia hegeliana un
puntello autorevole alla politica reazionaria del governo prussiano, ad insegnare all’Università di Berlino.
Ultimo capolavoro, La filosofia del diritto (1821).
Hegel morì, improvvisamente, nella capitale il 14 Novembre 1831, forse colpito dal colera.
Postume, raccolte dagli studenti, le Lezioni su: storia, arte, religione e storia della filosofia.
La risoluzione del finito nell’infinito
Il sistema filosofico hegeliano si basa sostanzialmente su un’ipotesi fondamentale: la risoluzione del finito
nell’infinito.
Hegel non considera la realtà come un insieme di elementi autonomi, ma piuttosto come un tutt'uno del quale
ogni singolo elemento rappresenta una manifestazione particolare.
Questo organismo unitario, non avendo nulla al di fuori di sé, rappresenta l'Assoluto e l'Infinito, mentre ogni
suo fenomeno particolare s’identifica con il finito. Finito che quindi non esiste, in quanto semplice
espressione parziale dell'infinito. D’altra parte l’infinito trova, necessariamente, nel finito il modo di
manifestarsi. Insomma il finito è, in pari tempo, manifestazione e momento necessario dell’infinito o, se si
vuole, dell’Assoluto, di Dio, dello Spirito.
Da ciò, logicamente, scaturisce che il reale, in quanto manifestazione e parte dell’infinito, non può essere
manifestazione casuale ed accidentale, ma necessaria e, dunque, razionale.
Ciò che è razionale è reale; e ciò che è reale è razionale. (Lineamenti di Filosofia del Diritto, Prefazione)
Quello che è, senza dubbio, il più famoso aforisma dell’hegelismo spiega come per Hegel vi sia una perfetta
identità tra il pensiero, ovvero la ragione, e la natura, ovvero la realtà.
La prima parte di questa espressione sta a significare che la razionalità non è qualcosa di puramente ideale o
di astratto, ma la forma stessa di tutto ciò che esiste, in quanto è la razionalità stessa a costituire e governare
la natura.
La seconda parte, invece, indica come tutto ciò che è reale sia non qualcosa di accidentale, ma il dispiegarsi
di una struttura del tutto razionale, che si manifesta inconsciamente nella natura e consciamente nell’uomo.
Tutto ciò vuol dire, anche, che vi è una totale coincidenza tra ciò che è e ciò che razionalmente deve essere.
La realtà stessa costituisce, dunque, una totalità processuale necessaria. Ne discende che il compito della
filosofia consiste nel constatare la realtà e comprenderla nelle sue strutture razionali.
12
Comprendere ciò che è, è il compito della filosofia, poiché ciò che è, è la ragione. ( Lineamenti di Filosofia
del Diritto, Prefazione)
Semmai, il filosofo può quindi dimostrarne la razionalità stessa tramite le proprie riflessioni. Siccome queste
non possono prescindere dal substrato storico-ideologico dal quale si originano (“ciascuno è senz’altro figlio
del suo tempo”), anche la filosofia non può non essere che “il proprio tempo appreso col pensiero”.
Secondo Hegel, tuttavia, i pensatori giungono quando la natura si è già completata “ed è bell'e fatta”, come la
Nottola di Minerva, simbolo della filosofia stessa, “che inizia il suo volo sul far del crepuscolo”.
Con ciò la filosofia finisce per avere un ruolo sostanzialmente giustificatorio del reale che semplicemente
registra quanto è già accaduto. Si capisce a partire da ciò perché la posizione hegeliana è anti-illuminista. Gli
illuministi, per Hegel, vogliono, individualmente, con le loro esigenze e aspirazioni, dare lezioni alla storia e
al mondo. Gli illuministi non accettano l’identificazione tra ciò che è e ciò che è razionale, ma pretendono
con la loro ragione finita, limitata, di stabilire ciò che deve essere, mentre la realtà è sempre e
necessariamente ciò che è.
La separazione della realtà dall’idea è specialmente cara all’intelletto, che tiene i sogni delle sue
astrazioni per alcunché di verace ed è tutto gonfio del suo dover essere, che anche nel campo politico
va predicando assai volentieri: quasi che il mondo avesse aspettato quei dettami per apprendere come
dev’essere e non è; che, se poi fosse come dev’essere, dove se ne andrebbe la saccenteria di quel dover
essere? (Enciclopedia, par. 6)
Il sistema hegeliano
Il sistema filosofico hegeliano ha la bellezza di una cattedrale gotica che lievita verso il cielo e la possanza
razionale di un tempio greco. E’ un organismo in sé ricco, compiuto, armonico, in cui le singole parti sono
necessarie e in relazione tra loro. Non si può che rimanerne affascinati!
Hegel, nell’Enciclopedia, disegna il farsi dell’Assoluto attraverso una grande triade dialettica: l'idea in sé e
per sé (tesi), l'idea fuori di sé (antitesi) e l'idea che ritorna in sé (sintesi).
- L'idea in sé e per sé (an sich und für sich) è l'idea pura, a prescindere da ogni sua concreta
realizzazione. E' quindi lo scheletro razionale della realtà, corrispondente a Dio “prima della creazione
della natura e di uno spirito finito”;
- L'idea fuori di sé non è altro che la natura, ovvero l'estrinsecazione o alienazione dell'idea stessa nella
realtà propria del mondo;
- L'idea che torna in sé (bei sich) è invece lo spirito che assume coscienza di sé nell’uomo dopo essersi
fatta natura.
13
Questo movimento triadico Hegel non lo concepisce come un susseguirsi cronologico delle varie fasi, ma
piuttosto come una coesistenza eterna dei momenti della tesi e dell'antitesi, fusi nella loro sintesi.
Ad ognuno dei tre momenti Hegel associa una sezione della propria filosofia:
- All'idea in sé corrisponde la logica, che per l’appunto è “scienza dell’idea in sé e per sé” nella sua forma
pura, cioè senza che essa si concreti nella natura e nello spirito;
- All'idea fuori di sé corrisponde la filosofia della natura, che è “scienza dell’idea nel suo alienarsi da sé”,
nel suo diventare mondo;
- All'idea che ritorna in sé corrisponde la filosofia dello spirito, cioè “la scienza dell’idea, che dal suo
alienamento ritorna in sé” cosciente di tutto il percorso svolto.
Il metodo dialettico
Pensiero e realtà sono la stessa cosa. Non esiste nulla al di fuori del pensiero, dunque la scienza del pensiero
è anche scienza del reale. La logica è logica del discorso umano ed anche della realtà. Essa è, nello stesso
tempo, legge ontologica e logica in quanto il reale è razionale.
Dunque, la dialettica è legge dello sviluppo dell’essere e anche legge logica della sua comprensione.
La dialettica è la legge del divenire dell’Assoluto.
Di conseguenza, la logica che esprime questo farsi dell’Assoluto è la logica dialettica. Essa esprime
l’inquietudine del finito nel farsi infinito. La dialettica è completamente diversa dalla logica formale di
tipo aristotelica, che rappresenta ancora una forma primitiva di cogliere il reale con cui l’intelletto astratto
misura le cose isolatamente e che, perciò, si mostra inefficace.
Principi astratti della logica formale sono il principio di identità e di non contraddizione. La dialettica, al
contrario, si basa sul principio di contraddizione.
Il principio di identità afferma che A = A.
Hegel nota subito che A è A solo se è inserito in un contesto più ampio: bisogna cioè riconoscere che A non
è non-A, e che quindi non-A limita A, dettandone quasi il perimetro. Verificare che A non è autonomo ed
indipendente ma che la sua identità è delimitata da ciò che non è, significa riconoscere che A è inscritto in
una dimensione in cui A può essere A ma sempre e comunque per esistenza del non-A.
14
Straordinario, massimamente bello, è l’incipit della Logica che inizia con un bell’esempio di processo
dialettico: tesi, antitesi, sintesi: essere, non essere, divenire.
Il punto di arrivo è un’unità di opposti che conserva e poi oltrepassa i due momenti precedenti. La
mediazione dialettica è il modo di far uscire i concetti dal loro isolamento, trattarli come fossero non cose
morte, ma organismi viventi la cui essenza è “l’assoluta inquietudine di non essere quello che sono”. Essi
sono movimento, divenire: dialettica.
Estremamente esplicativa, per capire il metodo dialettico in Hegel, è la trattazione, nell’Enciclopedia par. 79,
del modo in cui procede il pensiero nel processo conoscitivo, nell’afferrare la realtà. Esso passa attraverso tre
momenti:
- Astratto o intellettuale;
- Dialettico o negativo-razionale;
- Speculativo o positivo-razionale.
Nella fase astratta il pensiero, in quanto intelletto, si figura la realtà del mondo come un insieme di cose
fisse e separate le une dalle altre. Ogni cosa vive in una fissità e separazione: un seme è un seme ed è diverso
da una pianta. Il pensiero, in altri termini, osserva il mondo nelle sue differenze e lo analizza attraverso il
principio di identità e di non contraddizione.
Nella fase dialettica il pensiero, in quanto ragione, approfondisce la comprensione della realtà togliendo la
fissità e la separazione – unilateralità – con cui aveva interpretato il mondo. Le cose non vivono chiuse in sé
stesse ma in relazione con i propri opposti, con cui sono connessi: la vita possiamo concepirla mostrandone
l’opposizione con la morte.
Infine, nella fase speculativa, la ragione coglie la sostanziale unità degli opposti. Ad un grado più elevato
di comprensione della realtà il pensiero realizza che le cose finite non vivono nella separazione e nella
differenza e nemmeno nella relazione con l’opposto, ma sono in una superiore unità che le ri-comprende e
sintetizza. Insomma, si scopre che la realtà non è l’unità fissa e separata, né la molteplicità data dalla
relazione con l’opposto, ma unità di opposti che vive attraverso la molteplicità.
Complessivamente la dialettica hegeliana si caratterizza per un incedere triadico di tesi, antitesi, sintesi:
affermazione, negazione, unione e superamento (Aufhebung). Sintesi non come semplice ri-affermazione
della tesi iniziale, ma come affermazione ex-novo di una unità di opposti che pure ingloba tesi e antitesi.
La ragione speculativa, diversamente dall’intelletto astratto, si eleva sino alla comprensione della totalità
come processo. Ogni esistenza determinata, finita, è tale in quanto negazione di altre esistenze finite, da cui
riceve la propria delimitazione. Ma tutte sono costrette ad “andare oltre se stesse” per trovare la propria
verità solo nella totalità dei rapporti in cui sono implicate come manifestazioni dell’Assoluto.
Soltanto questa è la vera natura del finito, che esso è infinito e nel suo essere si toglie. Il determinato
come tale non ha altra essenza che questa assoluta inquietudine, di non essere ciò che è. (Logica)
E’ evidente che dalla dialettica ci si aspetta che deduca a priori tutta la realtà, che tutta la realtà trovi
adeguata sistemazione nel sistema dedotto, dato che è un metodo conoscitivo che caratterizza lo sviluppo
stesso dell’Essere. Proprio questa identificazione, tra pensiero ed essere, farà si che tutto il sistema hegeliano
si presenti come un edificio fondato forzatamente sul numero tre. Tutto il sistema sembra dipanarsi
attraverso un coattivo procedere dialettico che, paradossalmente, però, irrigidisce l’intero sistema e ne fa, per
altro verso, il lato più affascinante.
In questo irrigidimento della forma dialettica si scorge un modo di pacificare la lotta tra gli opposti:
l’architettura ha la meglio sulla vita! La battaglia e i lividi sono scongiurati dall’ordine che regnerà sovrano.
La stessa iconografia, che è possibile ricavare dall’intero sistema filosofico, propende verso la forma perfetta
del cerchio.
Hegel opta per una dialettica a sintesi finale chiusa, perfetta cioè per una dialettica che ha un ben preciso e
pacificato punto di arrivo.
15
Mentre nei gradi intermedi della dialettica prevale la rappresentazione della spirale, nella visione
complessiva e finale del sistema prevale la rappresentazione del circolo chiuso, che soffoca la vita dello
spirito, dando al suo progresso un termine, al di là del quale ogni attività creatrice si annulla, perché,
avendo lo spirito realizzato pienamente sé stesso, non gli resta che ripercorrere il cammino già fatto.
L’impetuosa corrente sfocia in uno stagnante mare, e nell’immobile specchio trema la vena delle acque
che vi affluiscono. (G. de Ruggiero, Storia della filosofia, Hegel)
Visto dall'alto, quindi, il tragitto dell’Assoluto, dunque del sistema, non è altro che una circonferenza, statica
e chiusa in sé stessa.
Il sistema hegeliano ci si presenta come un lavoro titanico, articolatissimo e intricato dove il sistema fagocita
tutta la realtà, ma che restituisce, a contemplarlo, la sensazione di cui parla J. L. Borges in Nove saggi
danteschi per la Divina Commedia: “tranquillo labirinto”, labirinto inestricabile dove c’è tutto, dalla vita al
conflitto, eppure tranquillo, univoco. E’ il luogo del viaggiatore, mai del viandante! La meta è nota fin dal
suo inizio!
Tuttavia va anche sottolineato che l’istanza metodologica che si ricava dalla dialettica, comunque, è
travolgente, come sarà più tardi messo in evidenza dalla Sinistra hegeliana e, in particolare, dal Marxismo.
E’ chiaro che il metodo conoscitivo che Hegel propone è dirompente e rivoluzionario giacché non si ferma
davanti al principio di identità o di non contraddizione, ma lo supera con quella logica che fu di Eraclito per
cui una cosa è e non è. La contraddizione è la molla del divenire e il finito è auto-contraddizione che sempre
spinge verso una risoluzione nell’infinito.
Il metodo hegeliano è rivoluzionario perché rompe assolutamente con ciò che è unilaterale, semplice, rigido,
ossificato, pacificato e da vita, movimento, lotta alle cose e ai concetti! La dialettica è la vita che scorre come
un fiume in piena e rompe gli argini angusti di un pensiero secco e vetusto!
Ovunque la dialettica scopre “un intreccio multilaterale e polisenso” (Fenomenologia).
Dalla coscienza infelice al sapere assoluto
Hegel pensa all’evoluzione dello spirito come ad un succedersi di figure astratte, che rappresentano i diversi
stadi dello svolgersi della coscienza, fino al raggiungimento del sapere assoluto, dove la coscienza si rende
conto di essere essa stessa l’intera realtà. La fenomenologia – scienza di ciò che appare – consiste, dunque,
nell’apparire dello spirito a se stesso.
La Fenomenologia dello Spirito ha una funzione didattico-pedagogica, in quanto il singolo individuo può
scorgervi i diversi gradi che la coscienza ha dovuto superare, nella storia della civiltà, attraverso varie
traversie, per potersi riconoscere come coscienza infinita e universale, come “la certezza di essere ogni
realtà”, come Tutto.
Il singolo individuo agevolmente riconosce le tappe, le figure, dello spirito universale, che sono, ad un
tempo, entità ideali e storiche, metafore della crescita della coscienza e della storia dello sviluppo culturale.
E’ un viaggio di una coscienza infelice che non sa di essere tutta la realtà: essa è coscienza scissa che ritrova
il sé e si riconosce come Tutto attraverso un processo di auto-coscienza. E’ la storia romanzata della
coscienza!
La Fenomenologia si divide in due parti: la prima parte comprende i tre momenti della coscienza (tesi),
dell’autocoscienza (antitesi) e della ragione (sintesi); la seconda include le tre sezioni dello spirito, della
religione e del sapere assoluto.
A. La coscienza è ciò che si rapporta con l’esterno, che Hegel definisce “oggetto”. In questa relazione la
coscienza attraversa tre stati conoscitivi, cioè la certezza sensibile, la percezione e l’intelletto.
La certezza sensibile è la consapevolezza dell’esistenza dell’oggetto nel momento in cui lo percepiamo con i
nostri sensi e non ci dà alcun tipo di conoscenza. La percezione si ha quando l’oggetto viene interiorizzato,
per cui diventa effettivamente qualcosa attraverso un’unificazione delle sue numerose qualità. L’intelletto è
16
la capacità di richiamare l’oggetto alla mente senza aver bisogno di avvertirlo attraverso i sensi, ovvero
significa possedere il concetto di una determinata cosa.
B. Con l’autocoscienza Hegel si occupa di definire il soggetto e le relazioni che esso ha con gli altri
individui.
L’autocoscienza non si riconosce come identità se non nella sua duplicazione poiché una coscienza, per poter
veramente definirsi tale, ha bisogno di relazionarsi con un’altra coscienza. All’inizio esse si muovono in
sincronia, come fossero allo specchio. L’autocoscienza fuori di sé cerca dunque di riconoscere l’altro, ma
non riesce nel suo intento perché non trova che la sua stessa essenza. La successiva lotta per la vita è
l’elemento decisivo, in cui una delle due coscienze prevale sull’altra, ed entrambe trovano la propria identità
in un elemento di diversificazione dall’altra. E’ a questo punto che si ha la formazione di due figure,
attraverso le quali il pensiero può procedere dando vita a nuove figure fino al raggiungimento della coscienza
dell’Universale.
Le figure del servo e del padrone sono sicuramente le più note della Fenomenologia dello Spirito. Esse
hanno dato adito, infatti, a numerose questioni filosofiche per la notevole ricchezza tematica.
La coscienza ha un’altra coscienza di fronte a sé. Entrambe, come in un balletto, si muovono
simmetricamente. Al movimento dell’una corrisponde, come in uno specchio, il movimento dell’altra finché,
in un processo di differenziazione, le due coscienze ingaggiano una lotta per la vita o la morte. Quella che
ha paura della morte, che “ha tremato nel profondo di sé”, che si priva della propria libertà per aver salva la
vita, si trova in posizione subordinata rispetto all’altra: essa è il servo. La coscienza che mostra di non aver
paura di morire è il padrone.
Tuttavia, questa posizione di supremazia, ad una analisi più approfondita, diventa dialetticamente l’opposto:
il padrone è servo del servo e il servo è padrone del padrone! Il processo con cui si crea l’indipendenza del
servo consta delle fasi della paura della morte, del servizio e del lavoro.
La paura della morte fa comprendere al servo la distinzione tra se stesso e il resto delle cose, chiarendo
come la sua essenza sia completamente diversa dalla realtà che lo circonda.
Durante il servizio la coscienza si auto-disciplina ed impara a vincere i propri impulsi naturali.
Il lavoro è l’attività umano-sensibile con cui si stabilisce il rapporto servo-natura. La natura diventa nuovo
elemento di confronto perché, una volta antropomorfizzata attraverso il lavoro, essa ritorna al servo come
immagine di se stesso come quando un artista imprime nell’argilla la propria sensibilità e in tal modo si
riconosce nell’oggetto creato. La natura antropomorfizzata è uno specchio!
Il servo a questo punto non ha più bisogno del padrone perché ha trovato l’alterità (oltre che se stesso) nella
natura. Il padrone, al contrario, ha bisogno della mediazione del servo, che diventa necessario affinché la
coscienza si riconosca e possa interagire con la natura; il padrone si ritrova, così, ad essere servo del servo.
I marxisti riconosceranno ad Hegel il merito di aver intuito l’importanza del lavoro come elemento
fondamentale dello sviluppo umano. La figura del servo, inoltre, anticipa alcuni temi dell’esistenzialismo
heideggeriano come la consapevolezza dell’esistenza di sé tramite l’angoscia della morte.
Il signore è uno stoico in quanto, non avendo paura della morte, crede di potersi rendere completamente
indipendente dalle cose materiali, raggiungendo quindi una libertà assoluta. La libertà dello stoico è però
solo un prodotto del puro pensiero, perché egli è costretto infine a costatare che i condizionamenti della
realtà esterna permangono.
La diffidenza nei confronti di ciò che è reale si tramuta, poi, nello scetticismo: visione filosofica in cui la
verità assume il connotato della relatività. Hegel critica gli scettici perché essi si auto-contraddicono nel
momento in cui, affermando che ogni conoscenza è relativa, impongono una verità che, di per sé, è assoluta.
Inoltre cercano di imporre un’etica scettica dopo aver reso nullo il ruolo dell’etica stessa. Infine, non si
accorgono che, per parlare delle cose del mondo, essi devono prima averle percepite attraverso quegli stessi
sensi che dichiarano essere fallaci.
17
Profferisce l’assoluto dileguare; ma il profferire è; […] profferisce la nullità del vedere, dell’udire ecc. ed
è proprio lei che vede, ode ecc.; profferisce la nullità delle essenze etiche, e ne fa le potenze del suo
agire. Il suo operare e le sue parole si contraddicono sempre. (Fenomenologia)
La coscienza scettica trapassa nella figura della coscienza infelice – altra figura notissima della
Fenomenologia - che si caratterizza per una separazione radicale tra uomo e Dio. Questa figura cerca
costantemente un raccordo tra sé e la verità, ma non vi riesce, per cui si trova in continuo movimento senza
mai giungere ad un approdo.
L’opposizione tra uomo e Dio si ritrova già nella religione ebraica, dove Dio è un padrone lontano che
impone la sua autorità dall’alto della sua completezza. Anche la religione cristiana fallisce nel suo tentativo
di ricongiungimento all’Assoluto, pur avendo prodotto un Dio-uomo: Gesù Cristo. Simbolo di questo
fallimento sono le Crociate, che si concludono con un sepolcro vuoto.
La coscienza resta dunque infelice e la sua condizione si manifesta nella devozione, nel fare e nella
mortificazione.
La devozione è il frutto di un’inquietudine irrazionale, che cerca un punto di riferimento che, però, non
esiste. Si ciba dunque di una lontana rappresentazione di Dio, che non è capace in alcun modo di soddisfare
la coscienza infelice.
Il fare si esprime con il concupire e l’appetire le cose del mondo e non quelle di Dio; il desiderio trova una
sua realizzazione nel lavoro. Hegel, probabilmente, fa riferimento all’ora et labora benedettino.
La mortificazione di sé, l’ascetismo, l’umiliazione della carne, è il punto più basso toccato dalla coscienza
infelice, che in questo modo nega completamente se stessa per cercare di elevarsi a Dio.
La coscienza, a questo punto, si renderà conto di essere lei stessa Dio e potrà quindi cominciare il suo
percorso verso l’Assoluto. Hegel posiziona questo evento nel parallelo storico del Rinascimento.
C. La Ragione è quindi la coscienza che diventa consapevole di se stessa. Questa consapevolezza è, in
ultima analisi, lo stesso idealismo, cioè l'affermazione filosofica che la vera realtà è l'Idea, cioè il Pensiero.
Essa si realizza, a sua volta, nei diversi momenti della ragione osservatrice della natura, dell'attività pratica
individuale, fino a culminare nell'eticità, cioè nel momento in cui l'individuo supera se stesso e si realizza nel
concreto di un popolo, di uno Stato e delle sue istituzioni.
A questo punto, però, la Ragione diventa Spirito e il suo sviluppo non è più quello della coscienza
individuale, bensì quello della storia dell'umanità.
La Logica
Alla logica Hegel dedica un’opera monumentale quanto granitica: La scienza della logica, poi sintetizzata
nell’Enciclopedia.
La logica è "scienza dell'idea pura, cioè dell'idea nell'elemento astratto del pensiero" che si snoda attraverso
una serie di concetti: “struttura completamente astratta” e struttura programmatica razionale del mondo.
La logica è perciò da intendere come il sistema della ragion pura, come il regno del puro pensiero.
Questo regno è la verità, com’essa è in sé e per sé senza velo. Ci si può quindi esprimer così, che questo
contenuto è la esposizione di Dio, com’egli è nella sua eterna essenza prima della creazione della natura
e di uno spirito finito. (Scienza della logica, Introduzione)
Per capire la portata filosofica della Logica hegeliana bisogna riprendere in considerazione l’eguaglianza
puramente idealistica di pensiero ed essere. L’oggetto della logica è il puro pensiero e il suo modo di
manifestarsi in concetti puri, che sono enucleazioni di esperienze storico-fenomenologiche.
In che senso la logica è scienza della realtà?
Innanzitutto, l’idealismo hegeliano volatilizza la realtà nel pensiero. Non esiste una realtà al di là del
pensiero. Il pensiero è la realtà! La logica, dunque, trattando del pensiero puro e del modo in cui si manifesta
18
nei concetti non è altro che scienza della realtà, la realtà nella sua essenza, realtà sic et simpliciter! D’altra
parte i concetti sono puri eppure enucleati da concrete esperienze storico-fenomenologiche, senza che ciò sia
contraddittorio giacché la storia è il modo in cui la realtà viene ad essere compresa: il concetto di essere, ad
esempio, è legato all’eleatismo, quello di causa alla rivoluzione scientifica. E’ ovvio allora che
Fenomenologia e Logica trattano lo stesso contenuto ma ad un livello di astrazione diverso.
Infine, essendo il pensiero l’unica realtà possibile senza nulla fuori di sé, lo studio del pensiero è studio
dell’essere: logica e metafisica coincidono!
La logica si divide triadicamente in logica dell’essere, logica dell’essenza e logica del concetto. Queste
hanno, a loro volta, ulteriori triadiche determinazioni.
1. La logica dell’essere studia la qualità (la prima categoria attraverso cui cogliamo le cose), la quantità
(il superamento della qualità attraverso la numerazione delle cose) e la misura (la compiuta sintesi di
qualità e quantità). A sua volta, la logica della qualità si divide in essere indeterminato, essere determinato
ed essere per sé. Il concetto di essere indeterminato rappresenta ciò che è vuoto e astratto, privo di ogni
possibile contenuto. Questo, a ben vedere, fa coincidere l’essere col nulla e il nulla, a sua volta, coincide
con l’essere, in quanto per essere definito come “nulla” esso si fa parte del pensiero e quindi dell’essere.
L’unità tra i due opposti è il processo dialettico del divenire, che rappresenta il vero e proprio inizio del
pensiero.
La verità dell’essere e del nulla è pertanto questo movimento consistente nell’immediato sparire
dell’uno di essi nell’altro: il divenire; movimento in cui l’essere e il nulla son differenti, ma di una
differenza, che si è in pari tempo immediatamente risoluta . (Scienza della logica)
L’essere determinato è invece la cristallizzazione dell’essere, del pensiero, che quindi passa da possibilità
a concretezza. Esso nasce dalla definizione del pensiero come indeterminato. Con un processo dialettico
simile alla triade essere-nulla-divenire, infatti, il pensiero, proprio determinandosi come indefinito,
diventa determinato e finito in sé stesso.
Ma Hegel ribadisce che il finito risolve nell’infinito, anche per quanto riguarda il pensiero. Infatti, la
finitezza del pensiero determinato lo spinge a diventare da ciò che è a qualcosa che non è, finendo col
perdere la propria consistenza, così come il vuoto essere indeterminato. Non è quindi possibile analizzare
il finito nella filosofia e ciò rappresenta per Hegel il fondamento stesso del pensiero idealista.
L’essere per sé è la compiuta sintesi di determinato e indeterminato. L’uomo tenta di coglierlo attraverso
le categorie della quantità e della qualità, ma queste da sole non bastano per comprenderne l’essenza. Per
questo motivo l’analisi può essere effettuata solo attraverso la misura, superamento delle categorie
precedenti.
Siccome non esiste una scienza che definisca univocamente la misura delle cose, e dato che l’essere non
può venir determinato attraverso le proprietà oggettive, non resta che riflettere sull’essere, per coglierne
l’essenza;
2. La logica dell’essenza studia i modi in cui l’oggetto si presenta come fenomeno, manifestazione non
pura della verità che si basa, però, comunque, su una “ragione” che ne giustifica l’esistenza stessa;
nonostante sia sostanzialmente sdoppiata, distinta da essa;
3. La logica del concetto, infine, è l’unità dialettica tra essere ed essenza, lo “spirito vivente della realtà”
del quale l’essere e l’essenza sono momenti coesistenti.
Il pensiero diventa, quindi, vero e proprio oggetto, in quanto l’oggetto si risolve nella riflessione su di
esso, che non può essere che pensiero.
Il concetto è, innanzitutto, concetto oggettivo, formale; poi concetto soggettivo, per come si manifesta
nella natura; infine idea, che è ragione autocosciente.
Il concetto soggettivo si esprime nelle categorie di individuale, particolare e universale; si articola poi nel
giudizio, per poi sfociare nel sillogismo, che è alla base della razionalità del tutto;
Il concetto oggettivo comprende le categorie fondamentali della natura, meccanicismo, chimismo e
teleologia.
L’idea è la ragione stessa, “l’unità dell’ideale e del reale, del finito e dell’infinito, dell’anima e del
corpo”. Nella sua forma immediata è la vita stessa, l’anima unita al corpo; nella sua forma mediata è il
19
conoscere, poiché oggetto e soggetto sono distinti tra loro. Al di là di tutto vi è l’idea assoluta, che ha
superato il finito e non è altro che la logica nelle sue determinazioni.
La filosofia della natura
Alla filosofia della natura Hegel dedica la seconda parte della sua Enciclopedia.
Per Hegel la natura è “l’idea nella forma dell’esser altro”, ossia “Dio che ha compiuto la creazione”. Essa è,
quindi, esteriorità che vive una propria inadeguatezza: idea precipitata nelle coordinate spazio-temporali.
Il passaggio dall’Idea alla natura è, per molti versi, un vero e proprio arcano. In termini più edulcorati
diremmo rompicapo. Lo stesso Hegel non dà una chiave univoca: da un lato dice che la natura è pura
esteriorità, una contraddizione insoluta; dall’altro che è pur sempre un’inevitabile, necessario modo in cui si
manifesta l’idea che si arricchisce nella forma dell’antitesi. In effetti, il problema è estremamente serio dato
che è, esattamente, la domanda del come e perché Dio decide di farsi mondo.
Infine, La natura assolve, nel sistema hegeliano, anche la funzione di trovare posto a tutto ciò che vi è di
accidentale, così da fungere da “pattumiera” del sistema.
Nonostante ciò, Hegel considera la natura necessaria, e divide la filosofia della natura triadicamente in
meccanica, fisica e fisica organica che, a loro volta, si determinano in altrettante triadi:
1. La meccanica considera l’esteriorità, ovvero l’essenza propria della natura, nelle forme di spazio e
tempo, analizzandone materia e movimento. Affronta quindi l’astrazione, l’isolamento e la meccanica
assoluta della natura;
2. La fisica studia gli elementi della materia e le sue proprietà fondamentali. Si divide in fisica
dell’individualità totale, dell’individualità particolare e dell’individualità universale;
3. La fisica organica studia la natura geologica, la natura vegetale e l’organismo animale.
20
La filosofia dello spirito
La filosofia dello spirito, alla quale sono dedicate la Fenomenologia dello Spirito e la terza parte
dell’Enciclopedia, studia l’idea che ritorna in sé dopo essersi estraniata come natura: “Dio, il quale dopo la
creazione prende coscienza di se stesso”.
Hegel divide la filosofia dello spirito in tre parti, corrispondenti ai tre gradi evolutivi di sviluppo dello
spirito:
1. Lo spirito soggettivo;
2. Lo spirito oggettivo;
3. Lo spirito assoluto.
1) Lo spirito soggettivo è lo spirito individuale che emerge, seppur lentamente, dalla natura. Lo studio di
tale spirito è affidato a tre scienze: l’antropologia, la fenomenologia e la psicologia.
L’antropologia studia lo spirito come anima, ovvero le varie disposizioni psicofisiche dell’uomo
derivanti dall’età della vita e dalle sue connotazioni, che si manifestano come carattere. In particolare, per
quanto riguarda le età della vita, Hegel distingue un movimento dialettico: l’infanzia (tesi) è un periodo di
armonia con il mondo circostante; la giovinezza (antitesi) è il momento in cui l’uomo entra in contrasto
con il proprio ambiente a causa del proprio temperamento; la maturità (sintesi), infine, rappresenta la
riconciliazione con il mondo, che sfocia però nell’abitudine, nell’inattività, durante la vecchiaia.
La fenomenologia, a cui Hegel dedica la già citata opera a sé stante, studia lo spirito come coscienza,
autocoscienza e ragione.
La psicologia studia lo spirito vero e proprio, che si manifesta nelle forme del conoscere, dell’attività
pratica e del volere libero.
21
2) Lo spirito oggettivo è la manifestazione concreta del volere libero, che si trasfigura nelle istituzioni
sociali, che per Hegel vanno a costituire il “diritto” tema trattato, in particolare, nei famosissimi Lineamenti
di Filosofia del Diritto.
I momenti o gradi dello spirito oggettivo sono tre: diritto astratto, moralità, eticità.
Il diritto astratto è il volere del singolo individuo, considerato come persona con capacità giuridiche
ma non caratterizzato.
La persona trova il suo primo compimento nella proprietà delle cose esterne. Per stabilirne i limiti, quindi,
le persone si accordano tramite un contratto. Il contratto è sì alla base del diritto, ma è, evidentemente,
anche l’origine del suo contrario: il delitto, a causa del libero arbitrio insito nell’uomo. Al delitto il diritto
contrappone la pena. La pena dev’essere non punitiva, ma riformativa; dev’essere interiorizzata dal
colpevole. Questo richiama la sfera della moralità.
La moralità è la sfera della volontà soggettiva: essa sgorga da un proponimento, che in un essere
pensante prende la forma dell’intenzione. L’intenzione, diventando universale, diventa il bene in sé e per
sé.
La coscienza morale come soggettività formale è puramente e semplicemente questo, esser sul punto
di rovesciarsi nel male, nella coscienza di sé stessi […] hanno entrambi, la moralità e il male, la loro
comune radice. (Lineamenti di Filosofia del Diritto, par. 139)
Ma questo causa una separazione tra il soggetto che deve realizzare il bene e l’oggetto che è il bene
stesso. Questa separazione si trasforma in una contraddizione tra essere e dover essere, che in Kant resta
insoluta, mentre per Hegel va colmata asserendo che il dover essere non va raggiunto nella sua totalità,
poiché lo sforzo infinito è parte stessa della moralità.
Hegel critica inoltre di Kant l’astrazione eccessiva, che può spingere all’immoralità, in quanto
l’imperativo categorico descrive solo la forma dell’azione e non il bene che in essa dev’essere contenuto.
Questo si riversa in un estremo soggettivismo, che per Hegel si manifesta anche nel suo tempo, sotto tre
diversi aspetti:
- La morale del cuore, che riconduce il bene alle inclinazioni proprie di ogni singolo soggetto;
- L’ironia romantica, che è lo scarto tra l’io presuntuoso e la realtà effettiva delle cose e si manifesta
con una trasfigurazione del soggetto in un “signore del bene e del male”;
- L’anima bella, che è tronfia della propria bellezza ed è incapace di agire per paura di “sporcarsi le
mani”, di intaccare la propria fittizia realizzazione.
22
L’eticità risolve concretamente il divario tra essere e dover essere. Il termine “eticità” (Sittlichkei)
deriva dalla parola éthos che in greco significa “costume”.
Il bene, che qui è il fine universale, non deve restare semplicemente nel mio interno, ma deve, anche
realizzarsi. La volontà soggettiva cioè esige che il suo interno, il fine, consegua esistenza esterna, e che
quindi il bene debba essere compiuto nell’esistenza esteriore. La moralità e il momento precedente del
diritto formale sono due astrazioni, la cui verità è solamente l’eticità. (Lineamenti di Filosofia del Diritto,
par. 33)
Se la moralità è la volontà soggettiva del bene, l’eticità è la moralità sociale che si realizza nelle forme
istituzionali di famiglia, società e Stato.
- La famiglia, primo momento dell’eticità, è l’incontro di due individui secondo il rapporto naturale tra
i due sessi che porta all’unità spirituale e, appunto, alla famiglia. Essa si articola nel matrimonio, nel
patrimonio e nell’educazione dei figli. La singola famiglia rappresenta, però, solamente un punto del
“sistema atomistico” nel quale si viene a trovare e sarà, quindi, costretta a lottare per difendere i propri
interessi, dando così origine alla società civile;
- La società civile è l’incontro di interessi particolari e indipendenti, che devono necessariamente
coesistere tra loro. Essa si articola in tre momenti: il sistema dei bisogni, che, basandosi su una
ripartizione del lavoro e dei beni in base alle singole esigenze, porta alle classi sociali;
l’amministrazione della giustizia, che è sostanzialmente il diritto pubblico; infine, la polizia e le
corporazioni, che si occupano concretamente della sicurezza della società, fungendo dialetticamente
da tramite tra la società civile e lo Stato.
- Lo Stato è il momento culminante dell’eticità, che coincide con l’entrata di Dio nella vita terrena:
“Dio fatto carne e sangue”.
Lo Stato è volontà divina, come spirito presenziale, come spirito esplicantesi e reale figura e organizzazione
di un mondo. (Lineamenti di Filosofia del Diritto, par. 270)
La sostanza vivente ritorna in sé proprio nello Stato, dopo che i contrasti sociali delle classi hanno
messo in dubbio l’unità della famiglia. E per Hegel lo Stato è proprio una famiglia in grande, che si
occupa del bene comune.
Lo Stato è la sostanza etica consapevole di sé, la riunione del principio della famiglia e della società
civile, la medesima unità, che è nella famiglia come sentimento dell’amore, è l’essenza dello Stato.
(Enciclopedia delle Scienze Filosofiche in Compendio, par. 535)
Questo può avvenire anche con la totale soppressione di alcune parti della società. Ciò non è
immorale, in quanto lo Stato non ha altra giustificazione che in sé stesso, poiché la sua totalità viene
prima delle particolarità della famiglia e della società civile.
Se lo Stato viene confuso con la società civile e la destinazione di esso viene posta nella sicurezza e
nella protezione della proprietà e della libertà personale, allora l’interesse degli individui come tali è
il fine estremo per il quale essi sono uniti. (Lineamenti di Filosofia del Diritto, par. 258)
Nello Stato Hegel identifica tre poteri sovrani, distinti, ma non separati tra loro: il potere legislativo, il
quale concerne le leggi in quanto tali, che sono universali, e quindi non ancora applicabili ai singoli casi
particolari; questo compito è infatti assegnato al potere esecutivo o governativo, che è rappresentato dai
funzionari dello Stato; vi è infine il potere del principe, che rappresenta l’incarnazione dell’unità statale,
un’individualità reale che decide definitivamente circa gli affari della comunità.
In genere la concezione dello Stato hegeliano viene definita “Stato etico” in quanto Hegel concepisce,
appunto, lo Stato come incarnazione suprema della moralità sociale e garante del bene comune. Inoltre la
sua concezione dello Stato è assolutamente anti-individualistica. Essa si distanzia sia da una concezione
23
liberale che da una democratica. La sua è una concezione organica dello Stato che tende a concepire lo
Stato come unione e non come associazione, come organismo vivente e non prodotto storico, totalità e
non aggregato (N. Bobbio). Da qui una sostanziale concezione dello Stato, “Dio reale”, da venerare e a
cui sacrificarsi.
Hegel - diversamente da Kant - pur definendo lo Stato come comunità globale, non auspica un’unità
interstatale, sia essa a livello europeo o globale; ma egli ritiene anzi che ogni Stato debba essere
autonomo, in linea con i principi di identità nazionale.
Da ciò consegue pure che Hegel è contrario all’esistenza di un diritto internazionale. I conflitti tra gli
Stati, quindi, non possono essere mediati da un giudice, ma solo dall’arbitro universale che è la storia:
dalla guerra.
Hegel – sempre diversamente da Kant - ritiene che:
La guerra ha il superiore significato che grazie ad essa […] la salute etica dei popoli viene mantenuta
[…] come il movimento dei venti preserva il mare dalla putredine, nella quale sarebbe ridotto da
una quiete durevole, come i popoli da una pace durevole o addirittura perpetua . (Lineamenti di
filosofia del diritto)
La guerra ha, dunque, un alto valore morale!
La concezione dello Stato pone la filosofia hegeliana, di fatto, come garante del movimento reazionario
dell’Europa uscita dal Congresso di Vienna e diviene, in effetti, la filosofia ufficiale dello Stato prussiano
nonostante Hegel saluti la Rivoluzione francese come “un superbo levar del sole”. L’impianto reazionario
e conservatore si deve, tra l’altro, al fatto che per Hegel ogni Stato particolare, concreto, storico, partecipa
pur sempre del carattere divino dello Stato perfetto e che i caratteri dello Stato perfetto sono ricavati
surrettiziamente dalla monarchia prussiana. Non a caso, per Hegel, esso sarà il migliore degli Stati storici.
3) Lo spirito assoluto è il momento in cui l’idea giunge alla consapevolezza di se stessa e della propria
infinità attraverso il consueto andamento dialettico che ora vede tre gradi: arte, religione e filosofia.
L’arte comprende l’Assoluto nella forma di intuizione sensibile, ovvero attraverso le forme delle arti
figurative, della musica e della poesia. Nell’arte si coglie in maniera intuitiva lo spirito poiché di fronte al
24
bello in senso artistico quest’ultimo viene recepito come fuso nella natura, in quanto la forma non è altro
che espressione della spiritualità.
Hegel riconduce anche l’arte ad un processo dialettico, sintetizzandone la storia in tre momenti:
- L’arte simbolica, nella quale vi è uno squilibrio tra contenuto e forma, poiché lo spirito non trova,
nella sua povertà, forme adeguate a rappresentarlo. La forma artistica tipica di questo periodo è
l’architettura, nella quale la materia è predominante;
- L’arte classica, nella quale contenuto e forma trovano il loro equilibrio nella figura umana. Si
privilegia quindi la scultura, che rappresenta un passo avanti nella rarefazione della materia verso lo
spirito;
- L’arte romantica, caratterizzata da un nuovo squilibrio tra contenuto e forma, poiché lo spirito
questa volta è troppo ricco per essere rappresentato e quindi trabocca dalla forma. Gli artisti del
periodo si affidano quindi alla pittura, alla poesia e soprattutto alla musica per liberarsi dall’elemento
materiale, che ostacola la libera manifestazione dello spirito. Per Hegel quindi si configura una vera e
propria morte dell’arte, da intendere come la sua inadeguatezza ad esprimere la spiritualità moderna,
poiché gli uomini non riconoscono più l’arte come manifestazione dell’idea, ma preferiscono
analizzarla e collocarla storicamente.
La religione è lo spirito che acquista coscienza di sé, ma solo nella forma della rappresentazione e
ciò la rende certamente una conoscenza vera ma ancora imprecisa rispetto del sapere filosofico. La
rappresentazione è caratterizzata da due limiti rispetto al concetto: prima di tutto “le rappresentazioni in
genere possono essere considerate come metafore dei pensieri e concetti” (Enciclopedia, par. 3) avvolti
ancora nell’elemento sensibile; inoltre, il concetto procede in modo a-dialettico, cioè attraverso una
narratologia di eventi che seguono un ordine in cui sono semplicemente giustapposti, e non un procedere
dialettico capace di cogliere l’unità degli opposti in termini logici e atemporali. Inoltre, la religione
rappresenta l’Assoluto nella forma storica della rivelazione. La filosofia procede, invece, mostrando la
necessità del suo oggetto.
Tuttavia, alla religione va riconosciuto lo sviluppo dell’idea di Dio, che può avere diverse ‘forme’.
- Nelle religioni naturali Dio è parte della natura, vi è “sepolto”. Queste si dividono poi in religioni
animistiche e panteistiche;
- Nelle religioni della libertà Dio è uno spirito libero, ma inserito ancora in un orizzonte naturalistico;
- Le religioni dell’individualità spirituale vedono Dio come un’entità spirituale o personificata;
- La religione assoluta, quella cristiana, risolve per prima Dio nella dialettica di Padre-Figlio-Spirito
Santo, la Sacra Trinità, ovvero idea-natura-spirito.
La filosofia è l’ultimo momento dello spirito assoluto, nella quale l’idea giunge finalmente a sé nella
forma più alta: il concetto.
Come la religione, la filosofia è il pensiero di Dio. Religione e Filosofia hanno lo stesso contenuto, ma la
filosofia ne costituisce, allo stesso tempo, il superamento e “l’inveramento”.
Diversamente dalla religione, la filosofia “manifesta l’esigenza di mostrare la necessità del suo
contenuto” e di “provare i caratteri dei suoi oggetti” (Enciclopedia). Infine, anche la filosofia ha un
andamento storico, ma solo fino a quando non si è conclusa nell’idealismo. Tutte le varie filosofie
precedenti, quindi, costituiscono un momento necessario per raggiungere la verità, che è racchiusa in
un’ultima espressione completa:
La filosofia, che è ultima nel tempo, è insieme il risultato di tutte le precedenti e deve contenere i principi di
tutte: essa è perciò - beninteso, se è davvero una filosofia - la più sviluppata, ricca e concreta. (Enciclopedia, par.
13)
La filosofia hegeliana è davvero la più sviluppata, ricca e concreta! Hegel afferma che il completamento
ideale della filosofia dopo un enorme cammino è, appunto, il proprio pensiero.
25
L’attuale punto di vista della filosofia è che l’idea sia conosciuta nella sua necessità […]. A questo punto
è pervenuto lo spirito universale, e ogni stadio ha, nel vero sistema della filosofia, la sua forma
specifica. Niente si perde, tutti i principi si conservano; la filosofia ultima è difatti la totalità delle forme.
Quest’idea concreta è la conclusione dei conati dello spirito, in quasi due millenni e mezzo di lavoro
serissimo, per diventare oggettivo a sé stesso, per conoscersi. (Lezioni sulla Storia della Filosofia)
La filosofia come grado più alto dello spirito assoluto è il momento in cui, in maniera concettuale e chiara, la
coscienza arriva alla consapevolezza che tutto è spirito e non vi è nulla al di fuori di esso.
La filosofia hegeliana è la scienza suprema in cui l’Assoluto giunge ad auto-conoscersi. La filosofia
hegeliana costituisce l’apice, e, dunque, la fine, di tutto questo durissimo lavoro.
Molti giovani hegeliani rimprovereranno al maestro di non aver pensato al futuro!
La filosofia della storia
Nelle famose “Lezioni sulla filosofia della storia”, pubblicate nel 1840, Hegel mette a punto la sua
concezione della storia, della sua evoluzione verso la libertà e della funzione della personalità nel processo
storico.
Hegel, declinando storicamente il principio che ciò che è razionale è reale e ciò che è reale è razionale,
afferma che la storia non è una congerie di eventi irrazionali, casuali, insignificanti: un “banco di un
macellaio” o un “mattatoio inutile”. Al contrario, il “contenuto della storia è razionale e dev’essere razionale:
una volontà divina domina poderosa nel mondo”. La ragione governa il mondo! La storia è ciò che è e non
poteva essere altro da ciò che è stato! Tutto ciò che è accaduto trova una sua ragione. Tutto “ciò che è
accaduto o accade, era giusto che accadesse, è giusto che accada: ciò che è stato, doveva essere”. La
necessità domina il mondo! Le idee, i progetti, i tentativi che non si sono realizzati non dovevano, non
potevano realizzarsi: non erano adeguati alla razionalità storica. La storia, in pratica è già come dovrebbe
essere, e non potrebbe essere altrimenti.
Ma pure quando consideriamo la storia come un simile mattatoio, in cui sono state condotte al sacrificio
la fortuna dei popoli, la sapienza degli stati e la virtù degli individui, il pensiero giunge di necessità anche
a chiedersi in vantaggio di chi, e di quale finalità ultima, siano stati compiuti così enormi sacrifici. (Lezioni
di filosofia della storia)
La fede religiosa con il concetto di provvidenza registra, anche se in maniera ancora generica, la presa di
coscienza che la storia, anche a prima imperscrutabile, è portatrice di un fine. “La storia è il dispiegarsi della
natura di Dio”. In questo senso la Logica si occupa dell’essenza di Dio, la Filosofia della storia del modo con
cui egli si è manifestato. Alla filosofia spetta il compito di rendere palese questa razionalità e di chiarirne il
fine, i mezzi e i modi.
26
La filosofia “nella certezza che è la ragione a governare, sarà convinta che l’accaduto si combinerà con il
concetto”. La filosofia cioè deve interpretare i fatti storici accaduti, coglierne il senso e riportare senso,
ordine in una massa di eventi apparentemente casuali.
Il fine della storia è "che lo spirito giunga al sapere di ciò che esso realmente è (...) manifesti oggettivamente
sè stesso", ossia è la piena automanifestazione dello spirito in una realtà storico-oggettiva.
Fine della storia del mondo è che lo spirito giunga al sapere assoluto e che esso si incarni in uno storico
spirito del mondo (Weltgeist) interpretato dal succedersi dello spirito dei popoli che, di volta in volta,
prendono il comando della storia. Fine ultimo è la realizzazione della libertà dello spirito che si realizza nello
Stato. Da questa prospettiva la storia del mondo è l’avvicendarsi di tre forme statali: mondo orientale (solo il
monarca è libero); mondo greco (libertà di alcuni e schiavitù di altri); mondo germanico (libertà di tutti).
All’interno del dispiegarsi dello Spirito, la funzione della personalità è assai ridimensionata nonostante essa
agisca nel pieno delle proprie passioni.
Gli individui sono all’interno del loro tempo e prodotti del loro tempo!
1) Ogni individuo si muove all’interno, compresso nel suo tempo: non può prescindere dal
momento storico-sociale, politico e culturale nel quale viene a trovarsi. Guai a mettersi contro
il proprio destino! “Ogni individuo è figlio del suo popolo, in un momento determinato dello
sviluppo di questo popolo. Nessuno può saltare oltre lo spirito del suo popolo più di quanto
possa saltare via dalla terra”;
2) I grandi uomini, gli ‘eroi’, Cesare, Napoleone, non sono altro che individui che incarnano, più di
altri, lo spirito del tempo. Pare che Hegel vedendo Napoleone abbia detto: “Ho visto lo spirito del
mondo, seduto a cavallo che lo domina e lo sormonta” ma Napoleone, pur seguendo la sua indole, le
sue passioni, non è altro che un’astuzia della ragione (List der Vernuft) che si serve degli uomini per i
propri fini: raggiungere lo spirito assoluto. I fini che i singoli si propongono sono dettati dalla loro
limitatezza, eppure attraverso ciò si compie il compito della ragione. “L’idea paga il tributo
dell’esistenza e della caducità non di sua tasca, ma con le passioni degli individui. Cesare doveva
compiere quello che era necessario per rovesciare la decrepita libertà; la sua persona perì nella lotta ma
quello che era necessario restò”. Cesare o Napoleone non valgono come individui, ma interpretano
semplicemente lo spirito del loro tempo: non agiscono … sono agiti!
3) I grandi uomini sono prodotti dal loro tempo. Rispetto alla Riforma protestante, scandalo delle
indulgenze, ecc. Hegel dice: “Ma dal punto di vista complessivo l’occasione è indifferente: quando la
cosa in sé e per sé è necessaria, e lo spirito è in sé pronto, essa può manifestarsi tanto in un modo
quanto nell’altro. Tale evento non è neppure connesso ad un individuo, come qui, ad es. a Lutero: i
grandi uomini sono produzioni del tempo stesso”;
4) Infine, “Nella storia universale viene alla luce, mediante le azioni degli uomini, qualche cosa di
diverso da ciò che essi si propongono ed ottengono, da ciò che essi sanno e vogliono
immediatamente”. La somma delle singole azioni determina qualcosa di diverso dalle volontà di
ciascuno!
CONCLUSIONI
In molti sensi la filosofia hegeliana rappresenta una fine!
27
Innanzitutto, Hegel stesso pensa alla sua filosofia come ad una fine o, se si vuole, all’inizio di un sapere
assoluto che ha solo il compito di rimirarsi, di riconoscersi in perenne circolo. La sua filosofia è fine della
storia e della filosofia come ricerca della verità.
Hegel era in errore! Il superbo sistema hegeliano, con il suo incedere triadico che tutto sembrava fagocitare,
la cattedrale gotica e il tempio greco in breve tempo saranno fatti a pezzi che, tuttavia, saranno ripresi qua e
là per tutto l’Ottocento e il Novecento dando prova di estrema fecondità.
Il sistema.
Il sistema nella filosofia hegeliana non è un semplice accessorio, una forma, ma lo scheletro essenziale della
verità. Il sistema non è qualcosa di esteriore ma essenziale: è esso stesso la verità! E’ il modo in cui si
presenta l’Assoluto attraverso il suo incedere dialettico. La verità del fondamento filosofico, dell’identità di
finito e infinito – o, meglio, della sua risoluzione nell’infinito – deve essere provato attraverso il sistema.
L’ipotesi idealistica della identità di certezza e verità può essere provata solo se si riesce a narrare la storia
dell’Assoluto attraverso un incedere necessario sicché nel sistema viene riportata la realtà nelle sue
determinazioni finite. Insomma, l’ipotesi idealistica di Hegel può essere provata solo se il suo sistema è
articolato in maniera tale che il mondo vi sia collocato senza residui; solo se il sistema ha cassetti per tutto. Il
sistema e le sue articolazioni sono una prova della bontà dell’ipotesi idealistica.
Secondo il mio modo di vedere, che dovrà giustificarsi soltanto mercé l’esposizione del sistema stesso,
tutto dipende dall’intendere e dall’esprimere il vero non come sostanza, ma altrettanto decisamente
come soggetto. (Enciclopedia)
Quello di Hegel è un panteismo logico-dialettico, dove il sistema è la realtà stessa. Sarà proprio il sistema,
con le sue articolazioni, che cederà irrimediabilmente per primo. Le deduzioni dialettiche franeranno dinanzi
all’irrompere delle ricerche specifiche e scientifiche. Titanico è lo sforzo di racchiudere il Tutto nella triade
dialettica e non mancano intuizioni geniali, ma complessivamente va rilevato che più spesso si assiste a mere
artificiose similitudini, associazione arbitrarie o imprecise, analogie fantasiose.
Il metodo dialettico e le sue deduzioni rimangono metodologicamente un gioiello se, tuttavia, si recepiscono
non come schemi coatti da imporre e in cui inchiodare la realtà, ma come istanze di apertura che evitano
l’isolamento dei concetti e delle cose di un mondo anacoreta. Altrimenti i danni sono assai notevoli.
La filosofia della natura.
E’ proprio qui che fin dall’inizio si sono concentrate ambiguità e difficoltà. L’ipotesi idealistica è che la
sostanza assoluta sia una sostanza spirituale: essa si presenta come idea assoluta, preesistente alla materia.
Solo in un secondo tempo essa si esteriorizza come natura inscritta nel tempo e nello spazio, per poi ritornare
in sé.
Va sottolineato che la filosofia spinoziana, con l’identificazione di Dio e natura, evita di dover riproporre un
dualismo che hegelianamente si esprime in idea in sé e idea alienata, estraniata, fuori di sé. Spinoza, evitando
di concepire la Sostanza come soggetto spirituale, evita perfino una concezione finalistica, che
dell’inquietudine del finito verso l’infinito fa il suo araldo. Il problema è che Spinoza arriva, di fatto, ad una
concezione materialistica e atea che per Hegel è inaccettabile.
Hegel cerca di provare la razionalità della natura e, nel contempo, che essa si muove verso un suo
superamento nella forma della spirito abbandonandosi frequentemente a complicatissime e artificiose
deduzione dialettiche.
Hegel mostra un sostanziale rifiuto e sprezzo dei dati sperimentali e in generale della scienza a partire da
Galileo.
28
La più grande illusione in cui Hegel è caduto nella sua, pur mirabile costruzione, è stata quella di
ritenere che la razionalità della natura potesse venir provata solo col dedurre a priori lo sviluppo da
principi generali, e non – come volevano i fisici – col fare appello all’esperimento, rivelatore dei processi
concreti in cui si articola tale razionalità. (L. Geymonat, Storia del pensiero filosofico, v. 3, p. 62)
L’idea di poter dedurre a priori la natura ricavandola dalla dialettica segna una distanza siderale con il
metodo scientifico. Distanza che ha portato i filosofi della natura di allora - gli scienziati - a staccarsi sempre
più dalla filosofia.
La filosofia hegeliana ebbe una influenza assai negativa nel rapporto tra scienza e filosofia.
Un brano dello scienziato E. Helmholtz tratteggia in maniera eloquente il rapporto di ignoranza, diffidenza e,
addirittura, irrisione tra scienza e filosofia.
A me sembra che questa opposizione abbia avuto origine essenzialmente per influenza della filosofia
hegeliana […] quando la filosofia kantiana regnava suprema, un tale scisma non sarebbe stato
proclamato, che anzi la filosofia di Kant si fondava proprio sul terreno delle scienze fisiche. […] La
‘filosofia dell’identità’ [di Hegel] è assai presuntuosa. Essa parte dall’ipotesi che non solo i fenomeni
spirituali, ma anche il mondo reale, la natura cioè l’uomo, sono il risultato di un atto del pensiero da
parte di una mente creativa, simile come Hegel suppone, alla mente umana. Partendo da questa ipotesi
sembrava possibile che la mente umana […] potesse ripensare i pensieri del Creatore e riscoprirli
attraverso la sua attività interna. E’ secondo questo concetto che la ‘filosofia dell’identità’ si pose
all’opera per costruire a priori i risultati delle altre scienze. […Ma] questo non può in alcun modo
dimostrare la validità dell’ipotesi della identità da cui egli partì. […] Il suo sistema della natura sembra,
almeno ai filosofi naturali, assolutamente assurdo. (E. Helmoholtz in Geymonat, Storia del pensiero filosofico,
v.3, p. 71)
Certo, il panlogismo hegeliano è positivo in quanto asserisce l’idea di una natura che si srotola in maniera
razionale e che, dunque, può essere compresa dalla ragione, ma l’idea di poterla dedurre da principi generali
e l’idea che essa sia finalisticamente mossa verso lo spirito assoluto è a dir poco pericolosa.
La scissione che la filosofia hegeliana doveva arrecare nel rapporto con le scienze in generale è comunque
più profondo che il semplice disprezzo del materiale sperimentale e dell’esperimento. La frattura che la
filosofia hegeliana crea con la scienza ha radici più profonde.
Hegel riprende in maniera ferma quel tratto della filosofia greca: lo sguardo rivolto al Tutto. Comprensione
del Tutto è comprensione delle sue determinazioni. La conoscenza in Hegel è conoscenza della totalità.
Hegel è il culmine della filosofia classica tedesca, ma è profondamente greco. Greco è il senso che egli
ripropone della verità (alétheia).
La rivoluzione scientifica – che riprenderemo nel capitolo 7 – è una doppia riduzione dello sguardo
filosofico: dal Tutto al particolare e, ancora, dal particolare alla sola quantità - come voleva il buon vecchio
Democrito. Ancora, è la riproposizione di un doppio tribunale: il Lógos e l’esperimento.
La distanza tra la filosofia e la scienza come ricerca della verità non può che essere incommensurabile: un
vero cambio di paradigma.
Hegel rigetta sia la riduzione dello sguardo galileiano, sia la nascente soggettività cartesiana che si avviluppa
nella opposizione tra certezza e verità. Ripropone, al contrario, sia la totalità dello sguardo, sia la ritrovata
identità di certezza e verità. E’ possibile afferrare la verità solo se si considera che essa è come un UnoTutto, di eraclitea memoria, che scaturisce dalla guerra tra i molteplici: “Pólemos [la guerra] è di tutte le cose
padre, di tutte re”. Il pensiero umano è capace di penetrare la realtà che non è che pensiero.
Se Kant con la Critica aveva dimostrato che la metafisica e Dio non era epistéme, scienza, Hegel ci assicura
che “Un popolo senza metafisica è un tempio senza altare”. Sarà l’ultima metafisica!
Al di là di tutte le critiche possibili che un sistema filosofico così imponente come quello hegeliano si è
portato dietro, la filosofia di Hegel rappresenta una tappa decisiva ed impareggiabile per la storia della
filosofia successiva. Del resto, come sosterrà nel ‘900 il filosofo tedesco Adorno, rappresentante della Scuola
29
di Francoforte, “anche quando sbaglia, un maestro è sempre ricco di insegnamenti”: ed Hegel è stato, piaccia
o no, un maestro di prima grandezza nel cammino del pensiero.
BIBLIOGRAFIA
Opere di Hegel
Hegel, Fenomenologia dello spirito, Nuova Italia, 2008
Hegel, Scienza della logica, Laterza, 2004
Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche, Laterza, 2009
Hegel, Lezioni di storia della filosofia, Laterza, 2009
Opere su Hegel
V. Verra, Introduzione a Hegel, Laterza, 2005
J. Hippolyte, Genesi e struttura della ‘Fenomenologia dello spirito’ di Hegel, Bompiani, 2005
SITI WEB:
http://www.emsf.rai.it/gadamer/
II. L’ARCANO DELLA RELIGIONE E DELLA METAFISICA
(Feuerbach)
30
~ DESTRA E SINISTRA HEGELIANA
~ FEUERBACH
~
~
~
~
~
~
La vita e le opere
Il capovolgimento del rapporto soggetto/predicato
La demistificazione della religione
L’alienazione religiosa
La critica alla metafisica
La filosofia dell’avvenire
~ CONCLUSIONI
DESTRA E SINISTRA HEGELIANA
La filosofia hegeliana aveva proposto come stadi finali dello Spirito assoluto l’arte, la religione e la filosofia.
Religione e filosofia avevano lo stesso contenuto, la stessa verità ma espressa in modo diverso: l’una in
forma di rappresentazione, l’altra nella forma più elevata del concetto.
Da tale impostazione si potevano legittimamente dedurre due diverse posizioni:
1. religione e filosofia sono solo due modi di espressione dello stesso identico contenuto di verità;
2. la religione è una forma elementare, semplicistica e, infine, inadeguata, di espressione della verità.
La prima posizione accettava la religione come forma di verità; l’altra, invece, intendeva la filosofia come
forma superiore di conoscenza e relegava la religione ad una sorta di filosofia o metafisica ‘per poveri’. La
prima posizione animò quella che sarà ricordata come la Destra hegeliana, affannata a mostrare come si
potessero giustificare razionalmente le credenze religiose.
La Sinistra hegeliana, invece, brandì l’idea di una critica razionale della religione capace di relegarla ad
istituzione ormai sorpassata della storia. Destra e Sinistra hegeliana si fronteggiarono non solo
specificatamente sulla religione, ma sul lascito generale della filosofia hegeliana.
Coloro che davano importanza soprattutto al sistema di Hegel, potevano in entrambi questi campi
essere conservatori; coloro per cui l’essenziale era il metodo dialettico, potevano appartenere, tanto in
religione che in politica, all’opposizione estrema. (F. Engels, Feuerbach e il punto di approdo della filosofia
classica tedesca)
31
La Destra, filosoficamente e
politicamente conservatrice, dette
infatti ampio spazio al sistema
hegeliano, la Sinistra, invece, al
metodo dialettico del grande
maestro.
La Destra caldeggiava il principio
hegeliano che “Tutto ciò che è reale
è razionale, e tutto ciò che è
razionale è reale”. Essa proponeva
una visione conservatrice e
giustificatrice, sempre e comunque,
di ogni aspetto del reale,
dell’esistente: dal dispotismo, allo
Stato poliziesco, alla censura.
Conseguentemente assumeva come
punto di riferimento uno degli
aspetti fondamentali della filosofia
hegeliana:
la
sua
funzione
giustificatrice.
La Sinistra hegeliana sviluppava,
viceversa, sulla scorta della stessa
impostazione
hegeliana
del
divenire, l’idea – secondo F. Engels
- che “Tutto ciò che esiste è degno
di morire”. Insomma, si concepiva
la
filosofia
come
critica
rivoluzionaria dello status quo.
Della Sinistra hegeliana faceva
parte Ludwig Feuerbach.
FEUERBACH
La vita e le opere
Ludwig Feuerbach nacque il 28 luglio 1804 a Landshut in Baviera e morì a Rechenberg il 13 settembre 1872.
Scolaro di Hegel a Berlino, libero docente ad Erlangen, vide la propria carriera universitaria troncata
dall'ostilità incontrata dalle sue idee sulla religione riassunte nella sua prima grande opera: Pensieri sulla
morte e l'immortalità (1830).
Fu hegeliano fervente, ammaliato dalla grandiosità del sistema del maestro. Si staccò in seguito
dall'hegelismo con lo scritto Per la critica della filosofia hegeliana (1839).
Del 1841 fu la sua opera più importante: L’essenza del cristianesimo. Seguirono le Tesi provvisorie per la
riforma della filosofia (1843) e Princìpi della filosofia dell'avvenire (1844). Altro lavoro notevole fu
L’essenza della religione (1845).
Si ritirò, infine, nella solitudine della campagna, nello studio e visse quasi sempre a Bruckberg. Nell'inverno
1848-1849, invitato da una parte degli studenti di Heidelberg, tenne le Lezioni sull'essenza della religione.
L'invito era stato reso possibile dagli avvenimenti del '48 e fu soltanto una parentesi nella vita di Feuerbach
che passò i suoi ultimi anni in miseria, a Rechenberg.
Il capovolgimento del rapporto soggetto/predicato
32
In Per la critica della filosofia hegeliana Feuerbach attacca il modo in cui, senza alcuna giustificazione,
Hegel fa iniziare il suo sistema: l’Idea, il Pensiero.
Sia la Logica, sia la Fenomenologia, iniziano con il pensiero, il che contraddice “l’intuizione sensibile e
l’avvocato di questa, l’intelletto” (Per la critica della filosofia hegeliana). Per Hegel il pensiero è il prius, il
grund, il fondamento, il soggetto originario e creatore; mentre l’essere, la realtà effettiva, non è che un
semplice predicato del soggetto. Il sistema hegeliano, infatti, inizia con l’Idea che solo fuori di sé diventa
natura.
Feuerbach denuncia l’impostazione hegeliana come una completa inversione, un capovolgimento dell’esatto
rapporto tra pensiero ed essere.
Il vero rapporto tra pensiero ed essere non può che essere che questo: l’essere è il soggetto, il pensiero
è il predicato. Il pensiero dunque deriva dall’essere, ma non l’essere dal pensiero. (Tesi provvisorie, in
Principi della filosofia dell’avvenire, Einaudi, Torino 1948, p. 63)
Il difetto fondamentale del sistema hegeliano è quindi quello di porre come originario ciò che è derivato. Col
materialismo di Feuerbach, il giusto rapporto è esattamente l’opposto di quello idealista hegeliano: il
soggetto, il fondamento è il concreto e il pensiero è un attributo. La natura non è un predicato o attributo
dello Spirito, ma lo Spirito un attributo della natura. L’inizio non può che essere l’essere sensibile nella sua
finitezza.
L’inizio della filosofia non è Dio, non è l’Assoluto, non è l’essere come predicato dell’assoluto o
dell’idea: l’inizio della filosofia è il finito, il determinato, il reale. (Tesi provvisorie, cit. p. 67)
Nella storia della filosofia, in genere, i filosofi si sono sempre divisi in questi due grandi campi,
(materialismo e idealismo) ma il livello storico raggiunto permette a Feuerbach di riproporre il
materialismo con una chiarezza estrema, inusitata.
Gli idealisti – ricordiamo sinteticamente – sostengono la priorità dello Spirito rispetto alla natura, del
pensiero rispetto all’essere e, generalmente, si trovano poi a dover ammettere, in ultima istanza, una
creazione ad opera di un Dio/Demiurgo personale esterno alla natura.
I filosofi che affermano la priorità della natura appartengono, al contrario, al campo materialistico e
intendono con ciò affermare che il concreto esiste indipendentemente da noi e prima di noi. Il pensiero, lo
spirito, la coscienza non sono altro che il prodotto più alto della stessa materia: predicato, dunque, e non
soggetto.
Mettendo al centro il rapporto tra pensiero ed essere Feuerbach attacca non soltanto Hegel, ma le fondamenta
stesse della sua filosofia: l’idealismo.
La rottura con il vecchio maestro idealista è totale! L’Idea assoluta, la preesistenza delle categorie della
Logica di Hegel, reperibili chissà dove prima del mondo, non sono altro, per Feuerbach, che
l’imbellettamento filosofico della credenza in un Dio creatore, esterno.
Allora bisogna assolutamente rovesciare i termini della predicazione per mettere le cose nel loro giusto verso.
Bisogna fare del predicato il soggetto e del soggetto il predicato!
L’errore logico che Feuerbach denuncia, il rovesciamento dei rapporti di predicazione, è un grimaldello
metodologico molto semplice ed efficace allo stesso tempo, capace di far implodere il gigantesco sistema
hegeliano, di far schiantare al suolo questo ‘gigante dai piedi d’argilla’. Ed è con questo grimaldello che
Feuerbach s’appresta alla critica razionale della religione.
In Hegel religione e filosofia condividono lo stesso contenuto, ma Feuerbach s’accorge di qualcosa di più
profondo: la filosofia idealistica in generale e la religione soffrono dello stesso vizio originario, poiché
operano entrambe il capovolgimento dei rapporti di predicazione, entrambe fanno del pensiero il soggetto e
della causa l’effetto.
Insomma, la religione finisce per identificarsi come una forma di idealismo che distorce i rapporti reali.
33
La demistificazione della religione
Cos’è il divino?
Per Feuerbach, null’altro che una proiezione di alcune qualità umane elevate all’ennesima potenza: nella
fattispecie la ragione, la volontà, il cuore… Attributi propriamente umani, isolati, portati fuori di noi e che ci
si presentano, ora, come altro da noi.
La religione è l’insieme dei rapporti dell’uomo con se stesso, o meglio con il proprio essere, riguardato
però come un altro essere […] Tutte le qualificazioni dell’essere divino sono perciò qualificazioni
dell’essere umano […] Tu credi che l’amore sia un attributo di Dio perché tu stesso ami, credi che Dio
sia un essere sapiente e buono perché consideri bontà e intelligenza le migliori qualità. (L’essenza del
cristianesimo)
L’arcano della teologia è nell’antropologia. La religione è antropologia ‘capovolta’.
La religione è l’infanzia dell’umanità. (L’essenza del cristianesimo)
Quindi, qual è l’origine dell’idea di Dio? In che consiste?
a) Dio è l’ente che risolve il sentimento di dipendenza dell’uomo di fronte ad una natura matrigna.
Il fondamento della religione è il sentimento di dipendenza dalla natura, ma il fine di essa è il superamento di
questa dipendenza, è la libertà dalla natura. (Essenza del cristianesimo)
Dio è quindi il tentativo di lenire il terrore di fronte alla natura, di addomesticarla con strumenti
soprannaturali: il culto e la preghiera;
b) Dio è personificazione delle qualità della specie umana.
La coscienza che l’uomo ha, non della limitazione, ma dell’infinità del proprio essere. (L’essenza del cristianesimo)
Dio, dunque, è il superamento dei limiti che l’uomo stesso s’impone e si riconosce; l’ente che
dissolve il contrasto tra il suo volere illimitato e il suo limitato potere, realizzando ogni desiderio.
L’alienazione religiosa
La religione è alienazione: una forma patologica di scissione del sé giacché Dio altro non è che la proiezione
del proprio sé fuori di sé, oggettivato e autonomizzato; ciò che era in me, ora è fuori di me, in un Altro che
inizia a prender vita propria.
All’autonomia di questa figura subentra uno stato di dipendenza da essa come da una potenza estranea.
L’Altro ora mi si para contro come soggetto estraneo, indipendente, con una propria potenza e volontà. L’Io
fuori di me si atteggia a Creatore e ne sono succube, dominato.
L’uomo proietta il proprio essere fuori di sé e poi si fa oggetto di questo essere metamorfosato in
soggetto, in persona. (L’essenza del cristianesimo)
Quanto più mettiamo in Dio tanto meno ritroviamo in noi e questo dà luogo a due processi complementari:
1. un processo di estraneazione della propria essenza umana che si manifesta come impoverimento del
sé;
2. un processo di inversione: Dio è essere infinito, l’uomo è essere limitato; Dio è santo, l’uomo è
peccatore; Dio è tutto, l’uomo è nulla.
34
A tale alienazione non si può che rispondere che con un processo di demistificazione che ripristini i reali
rapporti tra soggetto e predicato: non è Dio che ha creato l’uomo a sua immagine e somiglianza, ma l’uomo
che ha creato Dio a sua immagine e somiglianza!
L’ateismo si configura, quindi, come una forma di riappropriazione della propria essenza alienata, della
propria sanità e integrità intellettuale. E, soprattutto, l’ateismo diventa vero e proprio dovere morale: l’uomo
deve recuperare quanto di positivo ha proiettato fuori di sé.
In questo senso, la filosofia e l’ateismo sono mezzi terapeutici, strumenti di liberazione dalla fede e dalla
superstizione.
Ma verrà il tempo nel quale […] la fede di un Dio in genere […] verrà considerata superstizione.
(L’Essenza della religione)
Superstizione. Feuerbach si ricongiunge in ciò a quell’’anomalia’ che era stato il grande Baruch Spinoza che,
con il Deus sive natura, aveva finito con l’evaporare Dio nell’ordine causale del mondo e definito la religione
e i suoi sacri testi ‘immaginazione superstiziosa’.
Per Feuerbach ormai si ridisegna il compito generale della filosofia: porre l’infinito – Dio come
personificazione dei predicati umani – nel finito! “Non il finito nell’infinito, ma l’infinito nel finito”.
E’ giunto il momento di porre al centro l’uomo!
La critica alla metafisica
Per Feuerbach la filosofia hegeliana non è altro che una forma di teologia. O meglio:
La filosofia hegeliana è l’ultimo rifugio, l’ultimo puntello razionale della teologia. (Tesi provvisorie, p. 192)
Così come la religione è antropologia capovolta, la filosofia speculativa hegeliana e, in generale, l’idealismo,
sono teologia ‘mascherata’ giacché entrambe condividono l’errore fatale di capovolgere i reali rapporti
predicativi.
La dottrina hegeliana, secondo cui la natura, o la realtà, è posta dall’idea, non è altro che l’espressione
in termini razionali della dottrina teologica, secondo cui la natura è creata da Dio, o l’essere materiale è
creato da un essere immateriale, cioè astratto. […] La filosofia speculativa si è resa colpevole dello
stesso errore che ha commesso la teologia: l’errore di aver ridotto a determinazioni, a predicati
dell’infinito, le determinazioni della realtà o del finito. (Tesi provvisorie)
Feuerbach critica Hegel anche nel suo trasformare l’astrazione, che pure è un normale meccanismo
conoscitivo, in astrazione negativa, dato che volatilizza il reale e non vi fa più ritorno, vivendo solo nelle
regioni nebulose del pensiero.
In Hegel l’astrazione diventa alienazione, arriva ad un livello tale per cui – come nell’alienazione religiosa –
“l’essenza della natura è posta fuori della natura, l’essenza dell’uomo fuori dell’uomo, l’essenza del pensiero
fuori dell’atto del pensiero”. L’astrazione, in Hegel, prende autonomia e, in questo delirio di onnipotenza del
pensiero, essa diventa creatrice, dominatrice. Proprio come la colomba di Kant che, ebbra di volo, pensa di
poter far a meno dell’attrito dell’aria e s’invola in regioni ‘iperuraniche’ che perdono qualsiasi contatto con la
realtà.
L’essere della Logica di Hegel è il pensiero trascendente, il pensiero dell’uomo posto al di fuori
dell’uomo. […] Hegel ha estraniato l’uomo da se stesso, avendo fatto appoggiare tutto il sistema su
questi atti di astrazione. (Tesi provvisorie)
Ecco, dunque, come il grande affresco hegeliano - l’impresa titanica di rimettere in piedi la metafisica
idealistica, dopo che la Critica della ragion pura di Kant ne aveva mostrato l’insensatezza - viene
irrimediabilmente smascherato nella sua più intima ed elementare natura.
35
Se la pars destruens della filosofia feuerbachiana è la critica allo hegelismo e, in pari tempo, la critica alla
metafisica in generale, la pars costruens è l’avvio di una filosofia materialistica incentrata sull’uomo.
La filosofia dell’avvenire
Finalmente l’uomo! Un uomo che diventa il soggetto e la preoccupazione principale della filosofia, scopo e
fine della speculazione filosofica. Un uomo che, trascinato fuori da una concezione astratta e idealistica, è
inscritto in una dimensione reale e fondamentale: la natura!
La nuova filosofia fa dell’uomo l’oggetto unico, universale e supremo della filosofia, includendovi la
natura considerata come il fondamento dell’uomo. La nuova filosofia fa dell’antropologia, con
inclusione della fisiologia, la scienza universale. (Principi della filosofia dell’avvenire)
Un uomo, dunque, che sfugge alle secche di una concezione idealistica che lo concepisce come un ente
astrattamente spirituale o, come nella concezione hegeliana, una mera modalità corporea di presentarsi dello
Spirito.
L’uomo di Feuerbach è un uomo fatto di “carne e di sangue”: nasce, si evolve, si emoziona, ama, odia,
patisce, gioisce, muore. Un uomo collocato in una dimensione materialistica, dunque, che risulta legato e
condizionato dal reale, dal corpo, dal sensibile.
Soltanto un essere sensibile è un essere reale. (Principi della filosofia dell’avvenire)
Un essere sensibile ha fame, ha sete, ha bisogni primari da cui è determinato. In questo contesto Feuerbach
dice: “Se volete far migliorare il popolo, in luogo di declamazioni contro il peccato, dategli un’alimentazione
migliore”. Da qui la famosa, e spesso fraintesa, frase “l’uomo è ciò che mangia” (Mann ist was isst) a
significare la necessità di pensare l’uomo come unità psicofisica determinata innanzitutto dai bisogni primari
prima che possa evolversi a coscienza libera e autodeterminantesi.
Infine, come l’ateismo era un dovere morale in quanto disalienazione, la filosofia si configura come uno
strumento capace di:
36
trasformare gli uomini da teologi in antropologi, da teofili in filantropi, da candidati dell’aldilà in
studenti dell’aldiquà, da camerieri religiosi e politici della monarchia e aristocrazia celeste e terrestre in
autocoscienti cittadini della terra. (Lezioni sull’essenza della religione)
La distanza con la filosofia hegeliana, che offriva il fianco ad una funzione giustificatrice di tutto il reale, non
poteva essere registrata meglio che con questo intento programmatico: la filosofia al servizio dell’uomo!
CONCLUSIONI
L’impressione che fece l’apparizione della filosofia di Feuerbach, che d’un colpo rimetteva al centro il
materialismo, fu grande, ‘esaltante’ – come dirà F. Engels.
L’incanto era rotto; il «sistema» [hegeliano] era spezzato e gettato in un canto […] Bisogna aver provato
direttamente l’azione liberatrice di questo libro, per farsi un’idea di essa. L’entusiasmo fu generale: in
un momento diventammo tutti feuerbachiani. (F. Engels, Ludwig Feuerbach)
Feuerbach rappresenta il punto archimedeo di un duplice rovesciamento a partire dal capovolgimento dei
rapporti di predicazione.
Da una parte, Feuerbach mostra come il grande tentativo hegeliano di riproporre la metafisica - dopo che Kant
l’aveva demolita - naufraga nell’incapacità di fondare l’inizio del suo sistema con il Pensiero, l’Idea. Questo
sistema, che trova nel puro pensiero l’inizio, procede in un mero movimento con se stesso, in un solipsismo
idealistico in cui la materia non è che mera incarnazione del pensiero stesso, elemento formale di un processo
spirituale.
Hegel proprio partendo dall’Idea non può che capovolgere, inevitabilmente, i reali rapporti di predicazione.
Nella realtà, invece, l’essere è il soggetto, il pensiero è il predicato. E questa inversione assicura che i processi
di astrazione, anziché bloccarsi nell’iperuranio, si sviluppino piuttosto in un circolo virtuoso di empiria,
pensiero astratto, empiria. Siamo, dunque, alla riproposizione del materialismo.
D’altra parte, Feuerbach smaschera l’errore logico di fondo della religione che si costruisce sullo stesso vizio
della metafisica di invertire soggetto e predicato: non è Dio che crea l’uomo a sua immagine e somiglianza
ma esattamente il contrario attraverso un processo di estraneazione.
Se Newton aveva infranto le perfette, eterne e cristalline orbite sublunari di Aristotele, e aveva unificato la
legge del cielo e della terra, Feuerbach strappa il velo alla religione e tira giù le corti celesti, al completo di
cherubini, angeli e arcangeli, mostrandone l’essenza umana.
La sfida è rimettere l’infinito nel finito. Svuotare finalmente il cielo!
Si badi, la proposta materialistica di Feuerbach non è più, semplicemente, un’ipotesi di lavoro, come poteva
essere per Democrito, ma una proposta sostenuta dallo sviluppo delle scienze e delle forze produttive che,
proprio nel connubio capitale-scienza vedono il nuovo potente strumento di lavoro, di trasformazione della
natura per la soddisfazione dei bisogni umani.
Il materialismo non è più una mera ipotesi di ricerca filosofica, ma un habitat storico. In un certo senso,
Feuerbach è Davide contro Golia, ma un Davide che ora ha dalla sua parte la produzione capitalistica.
Va sottolineato, infine, come con Feuerbach la filosofia svuota il cielo, si riconcentra sull’uomo in carne ed
ossa, rifonda il suo spazio in una prospettiva illuministica, antropologica, umanistica, fortemente materialista,
mandando in soffitta lo Spirito Assoluto di hegeliana memoria.
37
BIBLIOGRAFIA
Opere di Feuerbach
L. Feuerbach, Essenza del cristianesimo, Feltrinelli, 2008
L. Feuerbach, (a cura di Ascheri, Cesa), Essenza della religione, Feltrinelli, 2006
Opere su Feuerbach
C. Cesa, Introduzione a Feuerbach, Laterza, 2005
F. Engels, Ludwig Feuerbach e il punto di approdo della filosofia classica tedesca, La Città del Sole, 2009
SITI WEB:
http://www.filosofico.net/feuerbach.htm
38
III. DALLA METAFISICA AL MATERIALISMO STORICO-DIALETTICO
(Marx)
E’ questo un capitolo che tiene dietro ad un tratto fondamentale del volto della filosofia, che disegna il
passaggio dalla metafisica al materialismo storico-dialettico, che è possibile leggere anche nei termini del
passaggio dalla ubbia contemplativa al racconto reale del mondo, dalla filosofia speculativa alla prassi. Dalla
mera solipsistica interpretazione del mondo alla sua trasformazione! Ebbene questo tratto si compie tutto in
Marx.
Karl Marx ha cambiato la storia e la geografia del mondo!
Il marxismo è teoria e programma del movimento operaio internazionale!
E’ impossibile ‘tenere’ Marx nel manuale di filosofia: ad ogni piè sospinto salta dalle pagine e riemerge nelle
piazze antagoniste.
E’ impossibile ridurre Marx alla mera dimensione filosofica, così come è impossibile cacciarlo in una
dimensione economica o costringerlo nella sfera politica. Marx rappresenta il punto in cui convergono tre
grandi gioielli della cultura occidentale del secolo XIX e, ad un tempo, il suo superamento in una concezione
coerente e organica. In Marx si mantiene insieme e si oltrepassa:
1) la filosofia classica tedesca;
2) l’economia politica inglese;
3) il socialismo francese.
Il marxismo non si lascia collocare in nessuna di queste scienze borghesi perché ne rappresenta, appunto, il
positivo superamento: è la teoria e il programma del movimento operaio internazionale!
Marx è uno scienziato e un rivoluzionario!
Il marxismo è una rivoluzione della scienza è una scienza della rivoluzione.
La rivoluzione della scienza è la critica alla filosofia, all’economia politica, al socialismo utopistico; la
scienza della rivoluzione è la pars costruens, la formulazione positiva del metodo, della concezione
materialistica, della teoria del valore-lavoro, della teoria del plusvalore, della caduta tendenziale del saggio
del profitto, della teoria della lotta di classe e delle articolazioni delle tattiche e delle strategie che vedranno il
proletariato internazionale portare “l’assalto al cielo”.
KARL MARX
~ La vita e le opere
~ LA CRITICA DELLA FILOSOFIA
~
~
~
~
~
Il rovesciamento di Hegel
I conti con Feuerbach
La dialettica
Una comparazione del concetto di alienazione
La concezione materialistica-dialettica della storia
~ LA CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA
~ Il metodo
~ Il Capitale
39
~ LA CRITICA DEL SOCIALISMO
Dall’utopia alla scienza
Le classi sociali
Lo Stato
La dittatura del proletariato
Abolizione della proprietà privata dei mezzi di produzione
~ Socialismo e comunismo
~
~
~
~
~
~ CONCLUSIONI
La vita e le opere
Marx nasce a Treviri nel 1818 da una famiglia borghese di origine ebraica. Studia a Bonn e poi a Berlino
laureandosi in filosofia con una tesi su Differenza tra la filosofia della natura di Democrito e quella di
Epicuro.
Frequenta l’ambiente della ‘sinistra hegeliana’ di cui è fervente sostenitore. Nel 1844 conosce F. Engels
(Barmen 1820- Londra 1895) con il quale stringe subito una sincera e profonda amicizia e un sodalizio
intellettuale che durerà tutta la vita. Espulso da Parigi, ripara nel Belgio, dove scrive il famoso Manifesto del
partito comunista nel 1848. Ritorna in Francia, ma è costretto di nuovo ad emigrare e si stabilisce a Londra.
Gli anni di dura miseria sono in parte alleviati dall’amico Engels che lo sostiene economicamente.
Alle opere e alla ricerca scientifica, Marx, alterna l’opera politica di organizzazione del movimento operaio:
è prima di tutto un rivoluzionario e fonda nel 1864 l’Internazionale dei lavoratori, cioè la Prima
Internazionale. Muore a Londra nel 1883.
Le opere principali sono: Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico (1843); Manoscritti
economico-filosofici (1844); Tesi su Feuerbach (1845); Ideologia tedesca (1846); Miseria della filosofia
(1847); Per la critica dell’economia politica (1859), Il Capitale (1867).
Engels scrive tra l’altro l’Antidühring (1878) e la Dialettica della natura (1883).
LA CRITICA DELLA FILOSOFIA
Il rovesciamento di Hegel
Marx conosce a menadito la storia della filosofia e, nello specifico, lo sviluppo del pensiero materialistico a
partire da Democrito. Non a caso la sua tesi di dottorato in filosofia è, appunto, Differenza tra le filosofie
della natura di Democrito e di Epicuro.
Marx si libera piuttosto presto di ciò che gli appare complessivamente come “una grottesca melodia
rocciosa”: la filosofia hegeliana. Tuttavia Hegel è sicuramente il culmine della filosofia occidentale e i conti
rispetto a questa sirena ammaliatrice devono essere fatti in maniera articolata e precisa.
La filosofia di Feuerbach è salutata da Marx con vero entusiasmo e con piena adesione alla ferma
riproposizione materialistica, contro l’impostazione idealistica di Hegel che riconosceva, come inizio e fine
della sua filosofia, una sostanza spirituale che si aliena e ritorna in sé. Detto in altri termini: Tutta la realtà è
pensiero! Feuerbach ha il merito di aver riproposto il materialismo in maniera chiara quanto ferma,
mostrando l’inversione di soggetto e predicato in Hegel.
Il primo scritto che fa i conti con il maestro è la Critica della filosofia del diritto di Hegel (1843). Già in
questo scritto Marx rileva come Hegel, surrettiziamente, trasformi la realtà storica-empirica in
manifestazione necessarie dello spirito. Hegel, riprendendo le istituzioni delle esperienze storiche reali, ne fa
delle pure astrazioni che poi inserisce all’interno del processo del pensiero puro. Per Hegel la storia ha quindi
40
senso solo se letta nel complessivo movimento dell’assoluto e quindi le istituzioni reali non sono altro che
allegorie di una realtà spirituale. Hegel fa del concreto la mera manifestazione dell’astratto, dello Spirito.
Bisogna allora riconoscere, così come fa Feuerbach, l’inversione di soggetto e predicato operato da Hegel.
Così come bisogna svelare l’operazione conservatrice che giustifica tutte le istituzioni reali come
manifestazioni razionali e necessarie della vita dello Spirito assoluto. Bisogna demistificare la filosofia
hegeliana innanzitutto nel suo “misticismo logico”.
Nella Sacra famiglia (1845), Marx ed Engels ridicolizzano il metodo hegeliano partendo dal gustoso
esempio della Frutta. Nel processo speculativo hegeliano si capovolge il reale rapporto tra le cose: concetto
universale (Frutta) e concreti enti individuale (mele, pere, ecc.). Il concetto universale di Frutto in Hegel
sembra soggetto reale mentre le mele, le pere, le mandorle concrete sono solo manifestazione secondarie. Le
sue caratteristiche, apparentemente, vengono dedotte attraverso un puro procedimento speculativo, mentre in
verità sono derivate dall’esperienza empirica-sensoriale. Il filosofo speculativo pretende, poi, di passare dal
Frutto alle pere e mele, cioè dalla sostanza ai predicati, dall’unità alla molteplicità con il richiamo al
movimento necessario della sostanza, che necessariamente si oggettiva nella molteplicità concreta.
Questa operazione si chiama, con espressione speculativa: concepire la sostanza come soggetto, come
processo interno, come persona assoluta, e questo concepire forma il carattere essenziale del metodo
hegeliano. (Marx-Engels, Sacra famiglia)
Feuerbach è il tassello indispensabile, che permette la demistificazione dell’intero impianto hegeliano e della
stessa metafisica “intesa nel senso di speculazione ubriaca in opposizione alla filosofia sobria” (Sacra
famiglia). In pari tempo il processo di demistificazione della filosofia hegeliana mette in luce il materialismo
come unica strada percorribile.
Il conto con Hegel sull’impostazione di fondo del sistema filosofico è, dunque, netto e chiaro e senza indugi
fin da subito. Marx si schiera con il materialismo!
Per Hegel il processo del pensiero, che egli, sotto il nome di Idea, trasforma addirittura in soggetto
indipendente, è il demiurgo del reale, mentre il reale non è che il fenomeno esterno del processo del
pensiero. Per me, viceversa, l’elemento ideale non è altro che l’elemento materiale trasferito e
tradotto nel cervello degli uomini. (Poscritto II edizione del Capitale)
Engels gli fa eco:
Hegel era un idealista, cioè per lui i pensieri della sua testa non erano le immagini riflesse, più o meno
astratte, delle cose e dei fenomeni reali, ma invece le cose e il loro sviluppo erano immagini riflesse
realizzate dell’”idea”, esistente già prima del mondo in qualche luogo. Conseguentemente tutto veniva
poggiato sulla testa, e il nesso reale del mondo veniva completamente rovesciato. (F. Engels, Antidühring,
p. 23)
Il prius è la materia!
Come già detto, Engels, nel Ludwig Feuerbach, ribadisce che nella storia della filosofia ci si è sempre divisi
in due campi: idealismo e materialismo.
L’idealismo pensa che lo spirito, il pensiero, sia la sostanza, inizio e fondamento della realtà. E’ sempre
legato, in qualche modo, all'ipotesi di Dio perchè, a partire dall'idea di una sostanza spirituale, resta pur
sempre da spiegare come si giunga ad una sostanza Altra come la materia e la natura, se per creazione o
emanazione.
Ora se per Hegel la sostanza è spirito, per il materialismo di Marx e di Engels l'elemento primordiale è la
materia. L'unitá del mondo è la sua materialitá. La materia è increata e contiene in sé il movimento – cosa
che esclude l'ipotesi di un dio personale che metta in moto tutto o governi a piacere qualsiasi cosa –.
Il movimento è il solo modo di esistere della materia. Mai e in nessun luogo c’è stata o può esserci
materia senza movimento. […] Materia senza movimento è altrettanto impensabile quanto movimento
41
senza materia. Il movimento è perciò altrettanto increabile ed indistruttibile quanto lo è la materia
stessa. (F. Engels, Antidühring, v. 25, p. 57)
Il pensiero non è altro che il prodotto più alto, complesso, elaborato di un lunghissimo processo evolutivo
della natura.
Ma se ci si chiede ulteriormente che cosa siano allora pensiero e coscienza, e da dove essi traggano
origine, si trova che essi sono prodotti del cervello umano, e che l’uomo stesso è un prodotto della
natura che si è sviluppato col e nel suo ambiente; da ciò si intende allora senz’altro che i prodotti del
cervello umano, i quali in ultima istanza sono anch’essi prodotti naturali, non contraddicono il restante
nesso della natura, ma invece vi corrispondono. (F. Engels, Antidühring, v. 25, p. 35)
Proprio questa appartenenza alla stessa sostanza, alla materia, pur nella modificazione natura-pensiero,
garantisce che vi sia una corrispondenza. Insomma, pensiero ed essere (natura-realtà) coincidono. Le leggi
della natura e del pensiero sono congrue, coincidono. Il pensiero è in grado di riflettere e cogliere la verità
della natura perchè esso stesso è natura.
L’idealismo è una concezione infantile, giacchè pensa di poter dominare la realtà solo ponendola come
contenuto dei suoi pensieri. Addirittura, il pensiero pensa di ‘creare’ la realtà esterna.
Il marxismo, invece, sostiene l’esistenza della realtà esterna come indipendente dal pensiero e dall’uomo, che
deve però continuamente sottoporsi al maglio di questa stessa realtà per provare la sua ‘potenza’, la sua
‘produttività’.
Per sfuggire alle secche della metafisica, alla colomba di Kant che pensa di poter volare meglio senza
l’attrito dell’aria, il marxismo ‘rinchiude’ il pensiero nel circolo essere-pensiero-essere che si declina in
concreto-astratto-concreto; un circolo che parte, come nella struttura del metodo scientifico, osservazioneipotesi-esperimento. Il circolo idealistico, all’opposto, è pensiero-essere-pensiero!
I conti con Feuerbach
Con le Tesi su Feuerbach (1845) e poi con l’Ideologia tedesca (1846), il rapporto di Marx con Feuerbach
viene precisato e superato. Le Tesi su Feuerbach sono uno scritto di notevole fascino e di straordinaria
densità concettuale che, in maniera rapidissima e concisa – quasi fosse una stenografia intellettuale – precisa
l’elaborazione teorica di Marx e segna un vero punto di approdo dell’elaborazione materialistica marxista
distinguendola nettamente dal vecchio materialismo, compreso quello di Feuerbach. Si tratta quindi di un
testo fondamentale per conoscere l’impostazione critico-gnoseologico marxista.
Il “vecchio materialismo” o “materialismo volgare”:
1)
2)
3)
4)
è meccanico;
è astorico e adialettico;
considera l' “essenza dell’uomo” in modo astratto, non inserita in rapporti sociali determinati;
non comprende l' “attività rivoluzionaria pratica”.
Le critiche che Marx muove al gnoseologismo materialista, secondo cui il pensiero dell’uomo riflette semplicemente l’oggetto come obietto (Objekt), definiscono questo gnoseologismo stesso come qualcosa di oggettivo e di statico, che rimane staccato dal pensiero. L’attività intellettuale del soggetto si limiterebbe a tradurre meccanicamente, semplicemente a riflettere, come in uno specchio, la realtà fuori di noi. Il soggetto
viene cioè inteso come mero contemplante e non come agente implicato in un rapporto. Dunque, l’uomo
procederebbe ad un’oggettiva e passiva registrazione dell’oggetto esterno, indipendente dall’attività umana:
mera morta datità. L’obietto è dunque cosalità, reificazione. Fondando l’atto conoscitivo sull’intuizione
sensibile, questo materialismo meccanico vuole fondare un’oggettività che non coglie però il reale rapporto
conoscitivo, che è quello soggetto/oggetto.
A questa impostazione, meccanica quanto rozza, Marx oppone una “teoria del riflesso” in cui l’Objekt perde
la sua ferma datità e diventa Gegestandt, cioè “rapporto tra oggetto e soggetto”. L’oggetto intonso diventa
quindi rapporto. Il soggetto, da contemplante qual era, si ritrova in una relazione vivente con l’oggetto.
42
Il difetto principale d'ogni materialismo fino ad oggi (compreso quello di Feuerbach) è che l'oggetto
[Gegenstand], la realtà, la sensibilità, vengono concepiti solo sotto la forma dell'obietto [Objekt] o
dell'intuizione; ma non come attività sensibile umana, prassi; non soggettivamente. (Tesi su Feuerbach,1)
Marx fornisce così anche una critica ante litteram al positivismo, in quanto inserisce l’oggetto in una fitta
relazione con il soggetto, creando un rapporto con la sua attività umana ed evitando un’impostazione che lo
ponga come contemplante un’esterna verità oggettiva. Nell’inquadratura marxista, l’oggetto è nella prassi
umana e la prassi umana crea questo oggetto; il positivismo, invece, smarrisce il senso della attività umano
sensibile – cioè del rapporto reale soggetto/oggetto –.
Conseguentemente, il lato soggettivo del rapporto finisce per influenzare quello oggettivo, dando adito ad
uno sviluppo di elaborazioni anti-materialistiche. L’idealismo che ne deriva “non riconosce la reale
sensibilità in quanto tale” e si configura come male opposto al materialismo rozzo aprendosi in un ventaglio
di posizioni che annullano l’oggetto esterno e lo assorbono nel puro pensiero o lo annientano in una pura
interpretazione soggettivistica e relativistica.
Feuerbach “vuole oggetti sensibili realmente distinti dagli oggetti del pensiero”, cioè rivendica
l’indipendenza dell’oggetto dal pensiero che pretende di essere demiurgo; tuttavia, egli non riesce a
concepire l’attività umana come attività rivoluzionaria, pratico-critica e oggettiva, cioè non riesce a
considerare l’oggetto – inserito in un contesto storicamente determinato – come impegnato in una relazione
attiva col soggetto.
Feuerbach non comprende che l’unico oggetto possibile è l’oggetto per noi realizzato attraverso l’attività
“rivoluzionaria”, “pratico-critica”.
Si tratta di “vivere l’oggetto” all’interno della storia ed è proprio per questo che le dispute puramente
teoretiche e impostate in termini metafisici, riguardo alla controversia sull’oggettività della verità, sono
banalmente ‘scolastiche’, inutili.
La seconda Tesi su Feuerbach pone in maniera netta la questione se al pensiero spetti o meno una verità
oggettiva. Si tratta, secondo Marx, di un problema irrisolvibile se il pensiero, nella sua astratta soggettività,
pone il problema teoreticamente. E’ possibile dare diverse risposte, arbitrarie quanto intercambiabili: Marx
rifiuta sia la soluzione data dalla metafisica, di stampo ontologico, sia la conoscenza che privilegia il
soggetto come forma conoscitiva.
Insomma, il problema gnoseologico rimanda necessariamente alla prassi. E’ proprio nella prassi, nell’attività
umano-sensibile, che l’uomo deve trovare la verità, cioè la realtà del suo pensiero, provando la capacità di
agire sul mondo e di trasformarlo.
La questione se al pensiero umano spetti una verità oggettiva, non è questione teoretica bensì una
questione pratica. Nella prassi l'uomo deve provare la verità cioè la realtà e il potere, il carattere
immanente del suo pensiero. La disputa sulla realtà o non-realtà del pensiero - isolato dalla prassi - è
una questione meramente scolastica. (Tesi su Feuerbach, 2)
La terza Tesi mette in evidenza che le circostanze, se modificano l’uomo, sono a loro volta modificate
dall’uomo. Insomma, lo stesso educatore deve essere educato. Ciò significa che non vi può essere un
materialismo meccanico, ma un materialismo dialettico che consideri l’attività come prassi rivoluzionaria.
Come l’oggetto non va pensato come Objekt, così il soggetto non va pensato come semplice prodotto
meccanico delle circostanze, giacché è il soggetto stesso a cambiarle. In altri termini significa che la storia
siamo noi, che la storia è creazione umana!
La dottrina materialistica della modificazione delle circostanze e dell’educazione dimentica che le
circostanze sono modificate dagli uomini e che l’educatore stesso deve essere educato. (Tesi su
Feuerbach, 3)
In questa Tesi Marx chiarisce, dunque, che il materialismo rozzo è destinato a rimanere unilaterale – a
vedere, cioè, solo il lato passivo del soggetto determinato dalle circostanze – mentre quello dialettico, al
contrario, ne presenta anche il lato creativo – cioè capace di produrre cambiamento –.
43
La critica è rivolta, poi, anche a quell’illuminismo che pensa di poter essere ‘progresso’ semplicemente
svelando la realtà delle cose a livello intellettuale, come se la chiarificazione di un problema fosse la sua
soluzione. Non basta quindi la comprensione teoretica, bisogna che si ponga mano alla trasformazione reale!
L’arma della critica non può di certo sostituire la critica delle armi. (Per la critica della filosofia di Hegel)
La quarta Tesi chiarisce come Feuerbach abbia affrontato con atteggiamento illuminista l’alienazione
religiosa nel suo fondamento umano, demistificandola e ponendola come illusorietà: egli pensa quindi di
esser riuscito a risolvere positivamente tale scissione patologica, ma la sua non è una soluzione. Feuerbach
avrebbe dovuto chiedersi per quale ragione materiale l’uomo è portato all’auto-dissociazione. La religione
non è semplicemente un errore logico e psicologico ma ha, per Marx, radici che affondano in una reazione
umana a una sofferenza reale originata all’interno della dimensione storica. La religione, dirà Marx, è
l’“oppio dei popoli” (Opium des Volks).
La miseria religiosa è, da un lato, l’espressione della miseria effettiva e, dall’altro, la protesta contro
questa miseria effettiva. La religione è il gemito della creatura oppressa. (Introduzione a Per la critica della
filosofia di Hegel)
Dunque, la disalienazione religiosa non passa tanto attraverso una presa di coscienza del fenomeno illusorio
e consolatorio quanto per una ricerca delle basi materiali e sociali che hanno portato a questa scissione
patologica che è, appunto, la religione. La religione, come l’ideologia in generale, non è un errore che la
critica può denunciare a livello teorico e sperare che si risolva.
Una volta un valentuomo si immaginò che gli uomini annegassero nell’acqua soltanto perché
ossessionati dal pensiero della gravità. […] Per tutta la vita costui combatté l’illusione della gravità.
(Ideologia tedesca)
La quinta Tesi ribadisce i meriti di Feuerbach e della proposta squisitamente materialista versus l’idealismo
hegeliano. Ma la critica a Hegel è rimasta parziale in quanto il modo di intendere la concretezza sensibile in
Feuerbach è sempre passiva ed egli non arriva alla critica del reale perché non arriva a capire che l’essenza
umana è prodotta dai rapporti sociali. Feuerbach è costretto, dunque, ad astrarre dal corso della storia il
sentimento religioso e a presupporre un individuo umano astratto ed isolato.
L'essenza umana può essere concepita solo come genere, come universalità interna, muta, che leghi
molti individui naturalmente. (Tesi su Feuerbach, 6)
Feuerbach non s’accorge – settima Tesi – che il sentimento religioso è esso stesso un prodotto sociale e che
l’uomo non è mai un uomo astratto ma sempre storicamente determinato; che appartiene ad una determinata
forma sociale. Come dice l’ottava Tesi “la vita sociale è essenzialmente pratica. Tutti i misteri che
trascinano la teoria verso il misticismo trovano la loro soluzione razionale nella prassi umana e nella
comprensione di questa prassi”. Risolvendo la scissione religiosa nella struttura economica e non
semplicemente in una ipotetica astorica natura umana, Marx riprenderà raramente il tema religioso: egli dice,
infatti, che la critica alla religione è stata sostanzialmente portata a termine da Feuerbach.
Ora che è stata chiarità la centralità del concetto di prassi, Marx non può far altro che invitarci a
“trasformare” il mondo, abbandonando l’atteggiamento puramente teoretico dei filosofi.
La famosa undicesima Tesi recita:
I filosofi hanno soltanto diversamente interpretato il mondo, ma si tratta di trasformarlo. (Tesi su
Feuerbach, 11)
Ciò significa che lo stesso processo conoscitivo deve radicalmente cambiare nel senso qualitativo. La
conoscenza non è un puro contemplare radicato in quella separazione tra teoria e prassi. Una conoscenza
siffatta implica una separazione tra soggetto e oggetto che porta ad una conoscenza astratta, unilaterale,
44
rigida. La conoscenza che Marx propone è quella che vive nella dialettica, unità di teoria e prassi; la
conoscenza come capacità orientativa della prassi e della trasformazione che deve ritornare a riannodarsi alle
proprie radici concrete, da cui trae origine e nutrimento, per potersi proficuamente librare in una conoscenza
sempre mediata storicamente e socialmente. Di un mito, di una scienza ‘scientificamente pura’ così come di
verità assolute Marx non sa cosa farsene!
Infine le Tesi, nella loro lineare stenografia, sono ante litteram la critica allo stesso marxismo di stampo
stalinista che si cristallizza nel materialismo dialettico sovietico (Diamat) all'agnosticismo, al criticismo,
all’empirismo, al positivismo, all’utilitarismo, al falsificazionismo di Popper.
Marx corregge Hegel con Feuerbach e Feuerbach con Hegel: rovescia l’idealismo hegeliano nel materialismo
feuerbachiano e rovescia il materialismo di Feuerbach nel materialismo dialettico riprendendo Hegel.
A Feuerbach rimane il grande merito di aver riproposto il materialismo dopo l’idea hegeliana, ma Marx
individua una serie di limiti della speculazione feuerbachiana: la natura in Feuerbach è qualcosa di dato e
fermo, un tempo mitico sospeso, un equilibrio originario e quieto. Per Marx la natura non esiste, esiste la
storia!
Il filosofo che ha detronizzato Dio, pulito il cielo resituendolo a semplici passeri, senza accorgersene finisce
con una nuova religione: un naturalismo astratto, pietrificato, eterno.
A Feuerbach sfugge che la sensibilità umana si inscrive all’interno di una dimensione in cui essa è “prodotto
dell’industria e delle condizioni sociali”. Per Feuerbach natura e storia sono due entità distinte. Qui Marx
evidenzia la fragilità del pensiero feuerbachiano e se ne distanzia.
La dialettica
La dialettica è, per Marx come per Engels, la più grande conquista della filosofia di Hegel.
Marx – come già detto – rimprovera Feuerbach di non essere stato capace di cogliere il lato rivoluzionario
della filosofia hegeliana, cioè la dialettica, che è strumento per capire razionalmente lo sviluppo storico.
Feuerbach concepisce, dunque, la negazione della negazione solo come contraddizione della filosofia
con se stessa. (Manoscritti economico-filosofici, p. 345)
Non solo la negazione della negazione, ma anche la compenetrazione degli opposti, la mediazione dialettica
che offre la possibilità di cogliere i rapporti tra cose opposte, di modo che la sua analisi diventi sempre
unilaterale e non riesca a tener dietro ad una visione olistica.
La dialettica, per Marx come per Engels, è “la scienza delle leggi generali del movimento, così del mondo
esterno come del pensiero”. Engels, soprattutto, nella Dialettica della natura (pubblicata postuma nel 1925)
cercherà di mostrare come tali leggi di movimento siano riscontrabili nella natura e come rivelino una
miriade di esempi tratti dall’evoluzione delle scienze naturali.
Mentre in Germania i discepoli trattano Hegel come un ‘cane morto’, Marx non può che elogiare, all’altezza
del 1873, il grande pensatore e ricordare nel Capitale, sul valore di scambio, di ‘civettare’ qua e là con la
terminologia a lui cara:
Per il suo fondamento, il mio metodo dialettico, non solo è differente da quello hegeliano, ma ne è
anche l’opposto […] La mistificazione alla quale soggiace la dialettica nelle mani di Hegel non toglie in
nessun modo che egli sia stato il primo ad esporre ampiamente e consapevolmente le forme generali
del movimento della dialettica stessa. In lui essa è capovolta. Bisogna rovesciarla per scoprire il nocciolo
razionale entro il guscio mistico. […] Nella sua forma mistificata, la dialettica divenne una moda
tedesca, perché sembrava trasfigurare lo stato di cose esistente. Nella sua forma razionale, la dialettica
è scandalo e orrore per la borghesia e pei suoi corifei dottrinari, perché nella comprensione positiva
dello stato di cose esistente include simultaneamente anche la sua comprensione della negazione di
esso, la comprensione del suo necessario tramonto, perché concepisce ogni forma divenuta nel fluire
del movimento, quindi anche dal suo lato transeunte, perché nulla la può intimidire ed essa è critica e
rivoluzionaria per essenza. (Poscritto alla II edizione del Capitale)
45
La dialettica in Marx non è certo l’insieme delle rigide tripartizioni di tesi-antitesi-sintesi con cui Hegel fa
forzatamente incedere l’Idea fino al rientro a Spirito assoluto, ma è l’osservazione che la realtà è un processo
e che la contraddizione è un suo carattere vitale.
In Marx domina imperiosa la necessità di seguire la logica specifica dell’oggetto specifico fin dalla Critica
della filosofia hegeliana del diritto pubblico del 1843, di contro all’impostazione hegeliana che costringe la
realtà in una macchinosa rigidità processuale del concetto puro:
nel non riconoscere ovunque le determinazioni del concetto puro (logischen Begriffs) bensì […]
concepire la logica specifica dell’oggetto specifico. (Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico, p. 103)
La logica specifica dell’oggetto è l’unica impostazione che pone le scienze particolari nella possibilità di fare
ricerca libera. Così gli schemi che possono ricavarsi dalla dialettica hegeliana, riportati da Engels a partire
dalle scoperte scientifiche delle scienze della natura, non possono essere leggi applicate alla natura o alla
storia, ma utili allo scienziato semplicemente come vademecum – dal latino vieni con me, con il significato
figurativo ti do una mano, ti guido – per non sorprendersi davanti a ‘bizzarrie’ della natura o a ‘stranezze’
sociali.
Con ciò si vuole affermare che non è possibile imporre alla realtà degli schemi apriori, ma al contrario è la
realtà stessa a presentarsi in schemi e processi. Deve prevalere sempre il principio anti-metafisico della
logica specifica dell’oggetto specifico onde evitare quell’insulso procedere hegeliano, che pretendeva di far
muovere la realtà all’interno del suo balletto triadico.
Ciò che Marx coglie della dialettica hegeliana è la conversione della quantità in qualità, la compenetrazione
degli opposti, la negazione della negazione che però non nega una battaglia e lividi, la mediazione tra opposti
in unità, l’esigenza di comprendere nella realtà le contraddizioni, i salti catastrofici, lo sviluppo a spirale,
l’interdipendenza, la interconnessione sistemica dei dati, l’analisi multilaterale, il processo che rompe la
stasi, l’inquietudine del concreto.
La dialettica è rivoluzionaria, par exellence, dato che per essa tutto ciò che esiste “è degno di morire”; nulla è
definitivo, nulla assoluto, nulla sacro. Tutto è transeunte! Tutto è un continuo eracliteo fluire, senza fine,
incessante.
La grande idea fondamentale che il mondo non deve essere concepito come un complesso di cose
compiute, ma come un complesso di processi, in cui le cose in apparenza stabili, non meno dei loro
riflessi intellettuali nella nostra testa, i concetti, attraverso un ininterrotto processo di origine e
decadenza [...] questa grande idea fondamentale è entrata così largamente, specie dopo Hegel, nella
coscienza comune, che in questa sua forma generale non trova quasi più contraddittori. Ma
riconoscerla a parole, e applicarla concretamente nella realtà, in ogni campo che è oggetto di indagine,
sono due cose diverse. (F. Engels, Ludovico Feuerbach)
Marx lascerà la speculazione filosofica come speculazione metafisica, ma anche come mero sapere
contemplante che vive quella separatezza tra teoria e prassi.
Bisogna ‘mettere in disparte la filosofia’ (Wigand, P. 187, cfr. Hess, ‘Die letzeten Philosophen’, p. 8),
bisogna balzarne fuori e mettersi, come uomo comune, a studiare la realtà, e per far questo esiste un
immenso materiale, anche letterario, naturalmente sconosciuto ai filosofi; e se poi un bel giorno ci si
ritrova dinanzi gente come Krummacher o ‘Stirner’, ci si accorge di averli lasciati da lungo tempo
‘dietro’ e sotto di se. La filosofia e lo studio del mondo reale sono tra loro in rapporto come l’onanismo
e l’amore sessuale”. (Ideologia Tedesca, p. 232)
Della filosofia, dirà più tardi Engels, non rimane che la “dottrina del pensiero e delle sue leggi, cioè la logica
formale e la dialettica”. Una filosofia non più regina delle scienze particolari, ma che si scioglie nelle scienze
particolari e si fa sapere positivo.
46
Insomma il sistema hegeliano fu il culmine di un ampio processo storico. Con essa naufrago tutta la
filosofia. Rimane la dialettica e la concezione che il mondo naturale, la storia, le forme intellettuali sono
in un continuo e perenne fluire. Le scienze particolari dovevano indagare tali leggi di movimento. E per
quanto alcuni nessi singoli venissero concepiti da Hegel in modo giusto e geniale, pure per le ragioni
addotte, molto, anche nei dettagli, doveva riuscire rabberciato, artificioso, architettato di sana pianta,
in breve sovvertito. Il sistema di Hegel fu come tale un colossale aborto, ma fu anche l’ultimo nel suo
genere. […] il materialismo moderno è essenzialmente dialettico e non ha più bisogno di una filosofia
che stia al di sopra delle altre scienze. […] Ciò che quindi resta ancora in piedi, autonomamente, di tutta
quanta la filosofia che si è avuta sino ad ora è la dottrina del pensiero e delle leggi, cioè la logica
formale e la dialettica. Tutto il resto si risolve nella scienza positiva della natura e della storia. (F. Engels,
Anti-Dühring, v. 25, p. 23-25)
La filosofia si dilegua, dunque, nella varie scienze particolari e positive.
Una comparazione del concetto di alienazione
Se nella filosofia hegeliana il termine “alienazione” stava ad indicare, in senso ambiguamente positivo e
negativo al contempo, il farsi altro dello Spirito che ritorna poi nuovamente in sé, in quella feuerbachiana
esso assume valore decisamente negativo, configurandosi come una condizione patologica di scissione,
dipendenza e autoestraniazione.
Marx, per “alienazione”, vuole proprio intendere lo stato patologico individuato da Feuerbach, ma
interpretandolo in un’ottica estremamente materialistica. In Feuerbach, infatti, lo stato di scissione e autoestraniazione è un processo puramente coscienziale, mentre per Marx tale processo oltre che mentale è
concreto e reale. L’alienazione è difatti riflesso e conseguenza di una condizione reale quale quella
lavorativa nell’ambito del capitalismo. È infatti il lavoro salariato causa principale dell’alienazione. Se il
lavoro resta l’attività umano-sensibile atta alla trasformazione della natura per soddisfacimento di un
bisogno, quello salariato, che si distingue necessariamente per l’impossibilità del lavoratore di possedere i
mezzi di produzione si caratterizza, per questo, in modo totalmente diverso.
La differenza tra un artigiano e un operaio sta quindi nella proprietà del primo dei mezzi di produzione, del
prodotto finito e soprattutto della conoscenza dello stesso processo produttivo.
Nei Manoscritti economico-filosofici del 1844 l’alienazione dell’operaio è descritta da Marx sotto quattro
aspetti strettamente connessi tra loro:
1) il lavoratore è alienato rispetto al prodotto della sua attività. Egli contribuisce, in virtù della forzalavoro che costituisce, alla produzione di un prodotto di cui non conosce né lo scopo né l’intero
processo produttivo, che non gli appartiene, che non è specchio della propria immagine e che gli si
ritorce contro nel momento in cui è costretto a comprarlo;
2) il lavoratore è alienato rispetto alla sua stessa attività. Quest’ultima prende la forma di un “lavoro
forzato”, in cui l’uomo è strumento di profitto per il capitalista; il lavoratore si sente, per questo,
“bestia” proprio nello svolgimento di quell’attività che dovrebbe condurlo all’affermazione della
propria umanità, al riconoscimento delle proprie facoltà creative e razionali e si sente, viceversa,
“uomo” quando si comporta da animale, dedicandosi al soddisfacimento dei bisogni primari
(cibandosi, bevendo, procreando) come se questi fossero l’unico scopo della vita;
3) il lavoratore è alienato rispetto al proprio Wesen, cioè alla propria “essenza”, al proprio “genere”,
perché privato del suo aspetto più umano, quello che lo rende diverso dall’animale: il lavoro libero,
creativo e universale. Nella società capitalistica, infatti, l’uomo è costretto al lavoro forzato,
ripetitivo e unilaterale;
4) il lavoratore è alienato rispetto al prossimo, che si identifica con il capitalista, con lo sfruttatore che
lo espropria del frutto della sua fatica. Ciò comporta che il rapporto del lavoratore nei confronti del
capitalista e, di conseguenza, dell’umanità, sia necessariamente conflittuale.
47
La causa del meccanismo di alienazione è quindi nella scissione della proprietà privata dei mezzi di
produzione dal lavoro che vede, dunque, su fronti opposti capitale e forza-lavoro, capitalista e operaio.
Questo meccanismo verrà descritto più tardi da Marx in termini di “sfruttamento” e “logica del profitto” nel
Capitale.
La dis-alienazione è possibile con il superamento del regime della proprietà privata e, quindi, con l’avvento
del comunismo, in quanto nella stessa struttura economica socializzata non sussiste più scissione tra
produttore e prodotto.
La concezione materialistico-dialettica della storia
Marx estende il principio materialistico del primato della materia sulla coscienza alla storia umana: dà vita
così ad una concezione materialistica della storia. Elemento fondamentale non è certo lo Spirito assoluto
hegeliano, né la coscienza, ma le condizioni materiali di vita degli uomini.
Producendo i loro mezzi di sussistenza, gli uomini producono indirettamente la loro stessa vita
materiale […] Questo modo di produzione […] è già un modo determinato dell’attività di questi uomini,
un modo determinato di estrinsecare la loro vita, un modo di vita determinato. Come gli individui
esternano la loro vita, così essi sono. Ciò che essi sono coincide dunque con la loro produzione, tanto
con ciò che producono quanto come lo producono. Ciò che gli individui sono dipende dunque dalle
condizioni materiali della loro produzione […] Anche le immagini nebulose che si formano nel cervello
dell’uomo sono necessarie sublimazioni del processo materiale della loro vita, empiricamente
constatabile e legato a presupposti materiali. Di conseguenza la morale, la religione, la metafisica e
ogni altra forma ideologica, e le forme di coscienza che ad esse corrispondono, non conservano oltre la
parvenza dell’autonomia. Esse non hanno storia, non hanno sviluppo, ma gli uomini che sviluppano la
loro produzione materiale e le loro relazioni materiali trasformano, insieme con questa loro realtà,
anche il loro pensiero e i prodotti del loro pensiero. Non è la coscienza che determina la vita, ma la vita
che determina la loro coscienza. (Ideologia tedesca, v. 5, 17-22)
Più oltre, in Per la critica (1957), scriverà:
Nella produzione sociale della loro esistenza, gli uomini entrano in rapporti determinati, necessari,
indipendenti dalla loro volontà, in rapporti di produzione che corrispondono a un determinato grado di
sviluppo delle forze produttive materiali. L’insieme di questi rapporti di produzione costituisce la
struttura economica della società, ossia la base reale sulla quale si eleva una sovrastruttura giuridica e
politica e alla quale corrispondono forme determinate della coscienza sociale. Il modo di produzione
della vita materiale condiziona, in generale, il processo sociale, politico e spirituale della vita. Non è la
coscienza degli uomini che determina il loro essere, ma è al contrario, il loro essere sociale che
determina la loro coscienza. (Per la critica dell’economia politica)
Il fondamento interpretativo della concezione materialistica è la divisione tra struttura e sovrastruttura.
Questo elemento viene superbamente colto da Lenin quando scrive:
Il materialismo ha dato un criterio completamente oggettivo, separando ‘i rapporti di produzione’
come struttura della società e dando la possibilità di applicare a questi rapporti quel criterio scientifico
generale della reiterabilità. […] Soltanto riconducendo i rapporti sociale ai rapporti di produzione, e
questi al livello delle forze produttive, si è ottenuta una base salda per presentare l’evoluzione delle
formazioni sociali come un processo storico naturale.” (Lenin, Che cosa sono gli amici del popolo, Opere, v.1,
p. 134-135)
Da qui in poi si evitano le pastoie di una storiografia idealistica – “la notte in cui tutte le vacche sono nere”
direbbe Hegel –, dove tutto è determinante e determinato, condizionante e condizionato, dove si raccolgono
bagattelle insulse. Il materialismo storico di Marx, per la prima volta, separando la struttura dalla
48
sovrastruttura, indica il metodo per chiarire i nessi essenziali di formazioni sociali, la loro evoluzione e la
loro metamorfosi.
La struttura economica è costituita dal modo di produzione, un grande accorpamento economico che
comprende le forze produttive e i rapporti di produzione.
Le forze produttive comprendono ciò che è necessario affinché la produzione sia possibile; in particolare
abbiamo:
1) uomini che producono (forza-lavoro);
2) i mezzi di produzione (terra, macchinari, ecc.);
3) le conoscenze tecniche e scientifiche.
I rapporti di produzione sono quelli che si creano tra gli uomini nel corso della produzione stessa, che
ineriscono alla forma del possesso e all’impiego dei mezzi di lavoro, così come alla ripartizione dei prodotti.
Insomma, i rapporti di produzione si rispecchiano nella forma giuridica dei rapporti di proprietà, sancendo a
chi spetta la proprietà dei mezzi di produzione e del prodotto.
Sulla base della struttura economica, scheletro della società, si eleva una sovrastruttura giuridico-politicoculturale. Le dottrine morali, artistiche, religiose e filosofiche non sono che espressioni della struttura
economica.
L’elemento determinante e fondamentale di una determinata epoca è dunque ciò che gli uomini producono e
il modo con cui lo producono. Tutti gli elementi della sovrastruttura, come il diritto, la morale o la filosofia,
non hanno vita propria, ma sono un riflesso di un determinato modo di produzione. Con questo concetto di
sovrastruttura, Marx toglie l’illusione di autonomia a quelle scienze, come la filosofia, che pretendevano di
essere creatrici di culture e in realtà erano soltanto riflesso inevitabile della struttura economica in cui erano
state prodotte.
Non sono le idee a governare i processi materiali, ma, al contrario, si può dire che le idee sono una sorta di
estraniazione delle cose materiali. Una concezione materialistica di questo tipo comporta non più
l’assunzione di una logica finalistica, ma di una logica specifica dell’oggetto specifico, cioè quella già
proposta nelle Tesi su Feuerbach. Una concezione di tipo finalistico può sopravvivere solo in quei sistemi
che adottano un Dio personale esterno o, comunque, in un materialismo rozzo che veda nel processo storico
un movimento unidirezionale.
In conclusione è opportuno specificare, attraverso Engels, che:
secondo la concezione materialistica della storia il fattore che in ultima istanza è determinante nella
storia è la produzione e la riproduzione della vita reale. Di più non fu mai affermato né da Marx, né da
me. Se ora qualcuno travisa le cose, affermando che il fattore economico sarebbe l’unico fattore
determinante, egli trasforma quella proposizione in una frase vuota, astratta, assurda. (Lettera di Engels
a J. Bloch)
Il materialismo storico non è un materialismo meccanico che individua nel fattore economico l’unico
elemento determinante del processo storico. Infatti:
a) la storia è prodotto umano;
b) gli stessi fattori economici non sono cose ma rapporti fra uomini, rapporti sociali.
Per ora si può affermare che l’anatomia della società civile è nell’economia, di modo che non si possa che
rivolgere ad essa l’attenzione per cercare di capire la nascita, lo sviluppo e l’estinzione di questo organismo
vivente che chiamiamo capitalismo.
49
LA CRITICA DELL’ECONOMICA POLITICA
Il metodo
Il metodo dialettico applicato alla disamina dei fatti economici, imprime un incalzante meccanismo
distruttivo di tutti i concetti rigidi, astratti, dell’economia politica inglese. Concetti superati, venerati ‘per
l’antico pelo’, che si frantumano sotto il maglio della dialettica e riprendono nuovo ‘forma’; concetti che
invocano lo stato di natura, vengono portati davanti al tribunale della storia e diventano flessibili.
Già Adam Smith e David Ricardo avevano cercato sinceramente di scoprire le leggi del sistema capitalistico
prima che arrivassero veri e propri ‘pugili a pagamento’, ‘cani da guardia’ del capitalismo, espressione di
una borghesia non più rivoluzionaria.
La critica di Marx all’economia borghese prende forma, innanzitutto, nella constatazione che essa è adialettica; ad esempio, essa assume surrettiziamente concetti storici, che ipostatizza e che assume come
valori eterni ed immutabili.
Lo stesso sistema capitalistico e le sue leggi, i rapporti di produzione e i rapporti giuridici che su di essi si
elevano, vengono analizzati come immutabili, eterni.
Ad esempio, il concetto di proprietà privata è considerato naturale ed immodificabile, fondamento e
postulato metastorico del capitalismo. In Marx si tratta, al contrario, di studiare la genesi, l’evoluzione, le
forme di tale concetto nel tempo, per cui non è difficile constatare che tale concetto è tutt’altro che naturale:
nella tribù esiste infatti una forma di proprietà comunistica primitiva.
La proprietà privata inizia la sua carriera con il regime delle società stanziali che praticano l’agricoltura.
Nello stesso sistema capitalistico la proprietà privata si configura come proprietà dei mezzi di produzione,
cioè negazione per la maggioranza della popolazione di proprietà privata. Marx mostrerà pure che la
proprietà dei mezzi di produzione non è che plusvalore estorto ai proletari.
Per Marx non esistono leggi economiche universali, poiché ogni formazione sociale ha caratteri peculiari e
leggi specifiche. Non rimane che studiare la logica specifica dell’oggetto specifico tenendo conto che una
formazione economico sociale rappresenta una totalità organica in cui i singoli elementi sono strettamente
correlati fra loro.
La dialettica non è solo storicizzazione dei concetti ossificati dell’economia borghese, ma anche capacità di
vedere all’interno del sistema la conflittualità, l’opposizione reale, la mediazione dialettica nella sintesi,
nell’oltrepassamento. La dialettica è capacità di vedere nella totalità organica. E’, poi, inforcando gli occhiali
del metodo dialettico, che Marx è in grado sciogliere l’arcano della forma merce. In effetti, le merci si
scambiano non per le loro proprietà naturali ma in quanto prodotti sociali, rapporto sociale fra persone. Il
valore di scambio della merce è un valore sociale ma appare mistificato, cioè come una sua proprietà
50
naturale. “Quel che qui assume per gli uomini la forma fantasmagorica di un rapporto fra cose, è soltanto il
rapporto sociale determinato che esiste fra gli uomini.” Questo è ciò che Marx chiama feticismo delle merci.
Il Capitale
Il Capitale ha il compito di spiegare “le leggi specifiche che regolano nascita, esistenza e morte di un
organismo sociale dato”. (Capitale, Poscritto II edizione, p. 17)
La merce è unità di opposti: valore d’uso e valore di scambio.
Il valore d’uso è l’utilità di una merce atta a soddisfare un bisogno, che provenga dallo stomaco o dalla
fantasia. Come valori d’uso le merci sono soprattutto di qualità differenti. Come è possibile che esse si
scambino?
Affinché possano essere comparate, devono possedere una qualità comune. Esse sono prodotte di lavoro
umano. E’ possibile misurarne la grandezza misurandone la quantità, cioè il tempo di lavoro oggettivato
nella merce. Un lavoro, comunque, astratto, cioè medio, né particolare né specializzato.
Il valore di scambio è il tempo di lavoro socialmente necessario per produrre la merce. ‘Socialmente
necessario’ significa il tempo impiegato mediamente, che varia da un’epoca all’altra.
Il valore d’uso diventa la forma fenomenica del valore di scambio. Certo, il valore d’uso deve dar buona
prova di sé sul mercato affinché ci sia lo scambio, ma nemmeno un atomo di valore d’uso entra nella
formazione del valore di scambio.
Il valore di scambio, che per facilità si può far coincidere con il prezzo, non può essere determinato da
oscillazioni della domanda e dell’offerta. Come si determinerebbe il prezzo in presenza di equilibrio tra
domanda e offerta? Attraverso le oscillazioni, pur reali, di domanda e offerta, trionfa il tempo di lavoro
socialmente necessario coagulato nel valore d’uso.
La formula della circolazione semplice delle merci è: M (merce) – D (denaro) – M (merce) cioè vendita di
una merce per l’acquisto di un’altra. La formula generale del capitale è D (denaro) – M (merce) – D (più
denaro) cioè compera per la vendita con profitto. Marx chiama plusvalore questo accrescimento di D'.
Ora, come è possibile che D diventi D’, cioè si accresca, generi profitto, se gli scambi devono presupporsi
equivalenti? Marx non spiega l'aumento del denaro totale con un aumento dei prezzi, poiché i guadagni in
più che ricaverebbe A sarebbero tolti a B, e quindi il denaro totale rimarrebbe costante e non si otterrebbe
nulla. Piuttosto, bisogna spiegare l’accrescimento facendo in modo che tutte le transazioni vengano effettuate
rispettando il principio di equivalenza, per cui le cose vengono vendute e acquistate al loro prezzo.
L’unico modo possibile è che il possessore di denaro trovi sul mercato una merce che generi più valore: una
gallina dalle uova d’oro! Ebbene, questa merce esiste ed è il prodotto di un lungo processo storico che ha
preparato uomini che si accalcano sulle città. E’ la storia fangosa della separazione dei mezzi di produzione
dai produttori. E’ la storia dell’accumulazione originaria che è il processo storico di separazione del
produttore dai mezzi di produzione che sprizza “bava e sangue da ogni poro”.
All’inizio di questo processo si trovano l’espropriazione dei produttori rurali, l’espulsione dei contadini dalle
terre che nelle enclosures trova il suo paradigma. Il sistema capitalistico trova pronta sul mercato una merce,
l’operaio, che non ha altra proprietà che la semplice capacità di lavoro. Un processo che lo ha denudato della
proprietà individuale e gettato sul mercato al miglior offerente pronto per essere portato nella fabbrica.
Il capitalista va sul mercato e trova l’operaio pronto per la concia. Il capitalista compra questa merce, cioè la
forza-lavoro al suo valore. Qual è il valore della forza-lavoro? Come qualsiasi altra merce, dipende dal
tempo di lavoro socialmente necessario per produrla, cioè dal valore dei mezzi che sono necessari al
sostentamento dell’operaio e che sono storicamente determinati. Tutto avviene senza inganno e senza
imbroglio! E’ solo seguendo capitalista e operaio nella fabbrica che l’arcano verrà svelato. Il capitalista, si
badi, ha comprato al giusto prezzo la merce forza-lavoro, cioè la capacità di lavoro semplice, ma è un suo
diritto consumarla come crede.
Ora l’operaio viene utilizzato presso una macchina e alla quinta ora ha ripagato il proprio salario, cioè il
tempo per il proprio mantenimento. Ma ecco che il capitalista non accenna a scioglierlo dal lavoro ma lo fa
51
proseguire per altre cinque ore. Sono ore eccedenti la ricostruzione del proprio salario: sono ore in cui il
capitalista si appropria di un plus-valore non pagato. Ecco, finalmente, svelato il mistero della merce che
figlia denaro!
Il capitalista paga al giusto prezzo la forza-lavoro cioè la capacità di lavorare, ma cosa diversa è il tempo di
impiego effettivo che lega l’operaio alla macchina. Non nella circolazione, ma nella sfera della produzione,
tra i vapori dei macchinari e il sudore, ha origine il plusvalore come coatto prolungamento della giornata
lavorativa oltre la reintegrazione del salario. Ecco la trasformazione di D in D’. “L’arcano
dell’autovalorizzazione del capitale si risolve nel suo potere di disporre di una determinata quantità di lavoro
altrui non retribuito”. (Il Capitale, L. I, p. 653)
Schematizzando il processo lavorativo complessivo si ha all’inizio:
a) Capitale costante (c), cioè mezzi di produzione, macchinari, materie prime che non cambiano la
propria grandezza di valore ma che la trasferiscono alla merce finale;
b) Capitale variabile (v), cioè la forza-lavoro impiegata che cambia di grandezza in quanto viene fatta
lavorare oltre la reintegrazione del salario;
c) Plusvalore (pv), cioè quella quota parte che l’operaio ha oggettivato nella merce oltre la
reintegrazione del salario.
C + V + PV
Il saggio del plusvalore è il rapporto tra il plusvalore e il capitale variabile ed indica in maniera chiara il
grado di sfruttamento della forza-lavoro da parte del capitale:
pv’ (saggio del plusvalore) = pv (plusvalore) / v (capitale variabile).
Il saggio del profitto rappresenta, invece, il rapporto tra plusvalore e totalità del capitale investito dal
capitalista per la produzione di una determinata merce:
p’ (saggio del profitto) = pv (plusvalore) / v (capitale variabile) + c (capitale costante)
Si noti che, per gli apologeti della proprietà privata dei mezzi di produzione, dopo un certo numero di anni il
capitale iniziale che il capitalista ha impiegato (c + v) viene completamente reintegrato dal plusvalore
prodotto dall’operaio – cioè da lavoro non pagato –. (Il Capitale, L. I, p. 700)
Il capitalismo nel suo processo di valorizzazione produce e riproduce costantemente il capitalista come
capitalista e l’operaio come operaio, nel senso che le forme di appropriazione capitalistica fanno sì che il
prodotto del processo produttivo spetti al capitalista mentre l’operaio viene alienato, espropriato del prodotto
del suo lavoro.
Il capitale non può esistere senza che si valorizzi continuamente, senza cioè che si rinnovi, che aumenti
costantemente la produttività nel tentativo di aumentare il saggio di profitto. Aumenta, con lo sviluppo
capitalistico, quello che Marx chiama composizione organica del capitale; ovvero il rapporto tra l’impiego di
capitale costante e capitale variabile: W (composizione organica) = c / v.
L’aumento della composizione organica restituisce, significativamente, ciò che comunemente chiamiamo
progresso. Indica cioè il rapporto tra mezzi di produzione e numero di operai. Con il progresso tecnologico
servono sempre meno operai relativamente all’impiego di capitale costante. Dunque, il progresso è
contrassegnato da un aumento di W e da una relativa diminuzione di v: ci vogliono meno operai per produrre
la stessa cosa!
Ora, se si calcola un aumento di c – continuando a considerare un certo saggio del plusvalore, ad esempio
100% – il saggio del profitto cala.
52
Si noti che il saggio del profitto diminuisce in ragione del progressivo sviluppo della produttività sociale del
lavoro.
La diminuzione del saggio di plusvalore è una tendenza reale, ma si verifica con un aumento della massa del
profitto in termini assoluti. Insomma, il saggio cala anche se la massa assoluta del profitto aumenta: ciò
perché la massa va confrontata con l’ammontare anticipato (c + v).
La caduta del saggio di profitto è una tendenza a cui si oppongono ‘influenze antagoniste’, tra cui:
1)
2)
3)
4)
un aumento del grado di sfruttamento del lavoro;
una riduzione del salario;
una diminuzione del valore del capitale costante;
sviluppo del commercio estero.
Tutte queste forze, tuttavia, rendono il processo più lento, meno meccanico, ma non lo annullano. Ad
esempio, un aumento del grado di sfruttamento – cioè un aumento del saggio di plusvalore – ha dei limiti
fisici:
a) nella durata della giornata di lavoro: non si può far lavorare un uomo più di 24 ore;
b) nella intensità del lavoro: non si può farlo lavorare più veloce di Charlot in Tempi moderni.
La caduta tendenziale del saggio del profitto è la teoria del crollo del capitalismo. Di caduta del saggio aveva
parlato anche il grande Ricardo ma – dirà Marx -"dall'economia, egli si rifugia nella chimica organica"
(Opere, v. 30, p. 141) attribuendola alla natura, alla crescente infertilità dei terreni. E’ solo nella teoria del
plusvalore scoperta da Marx che è possibile leggere questa tendenza nel suo tratto distruttivo per il sistema
capitalistico. Tale legge si pone nel cuore del capitalismo stesso, nella stessa dinamica della crescita delle
forze produttive sociali.
Lo stesso sviluppo delle forze produttive diventa motivo di crollo del sistema!
Un modello teorico del crollo rende più semplice la comprensione della contraddizione interna al
capitalismo. Un modello di sviluppo economico semplificato da H. Grossmann in Il crollo del capitalismo da
immediatamente la dinamica che si evolve all’interno del sistema capitalistico.
Il modello teorico dà vita ad una simulazione del processo di accumulazione capitalistica che prevede ogni
anno un incremento del 10% del capitale costante e del 5% del capitale variabile ad un saggio del plusvalore
costante del 100%.
Ebbene, il sistema registra:
a) un aumento di W (composizione organica);
b) una caduta di p’ (saggio del profitto) contemporaneamente ad una crescita della massa assoluta del
profitto;
c) una massa del plusvalore (pv) sempre crescente.
PV
1200
1000
800
600
400
200
53
49
46
43
40
37
34
31
28
25
22
19
16
13
7
10
4
1
0
Il sistema entra in crisi e crolla perché la massa del plusvalore prodotta, anche se aumenta in assoluto, non
è più in grado di sostenere il processo di accumulazione capitalistico.
K
300
250
200
150
100
50
49
46
43
40
37
34
31
28
25
22
19
16
13
7
10
4
1
0
-50
Il grafico ‘k’ mette in evidenza che, una volta tolto dalla massa del plusvalore quanto serve per una ulteriore
accumulazione sul capitale costante e variabile, ad un certo punto, non è più possibile andare avanti con il
processo di accumulazione e di valorizzazione del capitale. La caduta del saggio del profitto non è che la
forma fenomenica attraverso la quale il sistema si mostra incapace di svilupparsi giacché è incapace di
produrre una massa del plusvalore necessaria al suo ‘sostentamento’. E’ il crollo del sistema capitalistico!
La teoria del crollo è, in pari tempo, una teoria delle crisi cicliche – nel senso che questa tendenza opera su
scala storica – e una teoria che vive all’interno di serie economiche più ridotte. Nella realtà capitalistica,
tuttavia, le crisi di caduta del saggio sono o sono accompagnate da crisi dovute a vari fattori: anarchia del
mercato, sproporzione, sovrapproduzione, autonomia del capitale finanziario... Va sottolineato, comunque,
che Marx, nel Capitale, supera completamente la teoria della crisi di sovrapproduzione di tipo sismondiana
che attribuisce le crisi alla mancanza di domanda solvibile.
In ogni caso, rimane ferma la convinzione che ogni crisi viene superata dalla borghesia preparandone una più
estesa ed intensa e ciò dimostra che essa non è più in grado di gestire, in qualità di classe egemone, lo
sviluppo storico dell’umanità.
Con Il Capitale Marx dimostra che il socialismo è passato dall’utopia alla scienza proprio mentre dimostra
che il capitalismo è, come altri organismi economico-sociali, storico e transeunte e che le stigmate non sono
divine ma vere crepe del sistema.
Con Il Capitale si ha la prova scientifica dell'impossibilità economica dell'organismo capitalistico a
svilupparsi all'infinito, che ad un certo grado dello sviluppo delle forze produttive esso entra in un conflitto
insormontabile con il suo ulteriore sviluppo
Il vero limite del capitale è il capitale stesso! Marx è però cosciente che con la caduta viene dimostrato in
termini puramente economici, che il sistema capitalistico non è né assoluto, né eterno, ma limitato e relativo
(Capitale, L. III, p. 363). Ora, però, uomini in carne ed ossa dovranno abbattere questo sistema!
Le forze produttive sociali entrano in contrasto con i rapporti di produzione che fino allora ne avevano
agevolato lo sviluppo. I rapporti di produzione si trasformano in catene! Subentra un’epoca di conflitti
sociali. Alla produzione sempre più sociale dovrà corrispondere, ora, un’appropriazione sociale del
prodotto! Suona l’ora della proprietà privata capitalistica!
LA CRITICA DEL SOCIALISMO UTOPISTICO
Dall’utopia alla scienza
54
Il passaggio dall’utopia alla scienza si deve sostanzialmente all’elaborazione del materialismo storicodialettico e alla scoperta del plusvalore. Questi due elementi fanno sì che il comunismo abbandoni
definitivamente la dimensione utopica e il suo radicamento etico. Nel Manifesto Marx porta a fondo la critica
al socialismo precedente, individuandone la radice di classe e la fallacia tattico-strategica in un processo
rivoluzionario che vuole essere vittorioso. Il perimetro di tali socialismi rivela, contemporaneamente,
l’orizzonte strategico-organizzativo del movimento operaio rivoluzionario e lumeggia, a grandi linee, delle
tendenze e dei tratti che il proletariato vittorioso dovrà affrontare.
L’attacco e la demolizione è portata al socialismo reazionario; conservatore, o borghese, fino al socialismo
utopistico di Sain-Simon, Fourier e Owen che si perdono nella costruzione di società utopistico-ideali.
Il comunismo non è un ideale da realizzare quanto una risposta ineluttabile di cui lo stesso sviluppo delle
forze produttive, ormai entrato in conflitto con i rapporti di produzione, necessita.
Il comunismo per noi non è uno stato di cose che debba essere instaurato, un ideale al quale la realtà
dovrà conformarsi. Chiamiamo comunismo il movimento reale che abolisce lo stato di cose presente.
(Ideologia tedesca)
Il socialismo scientifico marxista, invece, risulta determinato dalla stessa legge economica che regola il
movimento della società capitalista. Lo sviluppo delle forze produttive e la socializzazione del lavoro
costituiscono la base materiale della possibilità del comunismo. Protagonisti del cambiamento sulla scena
della storia sono gli uomini che concretamente porteranno a termine questo passaggio: i moderni proletari.
Le classi sociali
L’incipit del Manifesto, con grande e lapidaria sintesi materialistica, dice: “La storia finora scritta è storia di
lotta di classe”. La moderna società borghese non ha eliminato, ma grandemente semplificato i contrasti di
classe: la società si va sempre più scindendo in due grandi campi, l’un contro l’altro armati: borghesia e
proletariato! Lo sviluppo della grande industria produce i moderni operai: gli uomini che le daranno la morte.
Fra tutte le classi che oggi stanno di contro alla borghesia, il proletariato soltanto è una classe
realmente rivoluzionaria. Le altre classi decadono e tramontano con la grande industria; il proletariato
è il suo prodotto più specifico.
Gli ordini medi, il piccolo industriale, il piccolo commerciante, l’artigiano, il contadino, combattono tutti
la borghesia, per premunire dalla scomparsa la propria esistenza come ordini medi. Quindi non sono
rivoluzionari ma conservatori. Anzi, sono reazionari, poiché cercano di far girare all'indietro la ruota
della storia. (Manifesto)
Come l’aristocrazia, la nobiltà si mostrò incapace di garantire lo sviluppo delle forze produttive entro i
rapporti di produzione medievali che gli corrispondevano, così la borghesia, oggi, mostra di non essere più in
grado di mantenere la leadership storica che ha conquistato contro il vecchio regime. La borghesia, da classe
rivoluzionaria contro l’aristocrazia e la nobiltà terriera, ora diventa reazionaria, arroccata nella difesa dei suoi
interessi contro il proletariato. La borghesia mostra continuamente di non essere più in grado di incarnare
l’ulteriore sviluppo economico e sociale in quanto è incapace di gestire il suo stesso schiavo, di assicurargli
un lavoro e un’esistenza dignitosa, e sempre lo ricaccia nella incertezza della sua stessa esistenza come
operaio.
Le cicliche crisi economiche, la tendenza generale alla caduta tendenziale del saggio di profitto, la continua
incertezza sociale sono i segni che mostrano che la borghesia non è più il soggetto storico che incarna un
ulteriore sviluppo storico.
La borghesia non è in grado di rimanere ancora più a lungo la classe dominante della società e di
imporre alla società le condizioni di vita della propria classe come legge regolatrice. Non è capace di
dominare, perché non è capace di garantire l'esistenza al proprio schiavo neppure entro la sua
schiavitù, perché è costretta a lasciarlo sprofondare in una situazione nella quale, invece di esser da lui
55
nutrita, essa è costretta a nutrirlo. La società non può più vivere sotto la classe borghese, vale a dire la
esistenza della classe borghese non è più compatibile con la società. (Manifesto)
La lotta è da principio innanzitutto nazionale e il proletariato dovrà vedersela con la propria borghesia;
tuttavia la lotta per il comunismo non può essere una lotta nazionale, ma si inscrive in una dimensione
internazionale. Il socialismo in un solo paese non è previsto da Marx: la vittoria del proletariato o sarà
internazionale o non sarà affatto!
Lo stesso sviluppo dell’industria, del quale la borghesia è l’agente involontario, fa sì che il proletariato come
classe si educhi attraverso la stessa disciplina del lavoro in fabbrica e poi, pian piano, attraverso i primi
timidi tentativi di lotta, sporadici e isolati, e i successivi, più coraggiosi e corali. Dalla lotta economica il
proletariato si spinge inevitabilmente alla lotta politica.
La lotta di classe del proletariato trova nel partito comunista la sua risoluta avanguardia in quanto forma
organizzativa che corrisponde alla volontà di dar vita ad un assalto al cielo, nel processo rivoluzionario che
mira a prendere il potere politico.
I comunisti si distinguono dalle altre formazioni operaie per il fatto che, da una parte, essi fanno sempre
valere gli interessi comuni del movimento operaio nel suo complesso, e dall’altra “essi hanno il vantaggio
sulla restante massa del proletariato, di comprendere le condizioni, l'andamento e i risultati generali del
movimento proletario”.
I comunisti sdegnano di nascondere le loro opinioni e le loro intenzioni. Dichiarano apertamente che i
loro fini possono esser raggiunti soltanto col rovesciamento violento di tutto l'ordinamento sociale
finora esistente. Le classi dominanti tremino al pensiero d’una rivoluzione comunista. I proletari non
hanno da perdervi che le loro catene. Hanno un mondo da guadagnare.
Lo Stato
Il proletariato vittorioso, nella figura del partito comunista, procede risolutamente a spezzare la macchina
dello Stato borghese.
Lo Stato quale “comitato degli affari pubblici della borghesia” (Manifesto) è anche organizzazione della
violenza.
Come lo Stato antico fu anzitutto lo Stato di possessori di schiavi al fine di mantener sottomessi gli
schiavi, così lo Stato feudale fu l’organo della nobiltà per mantenere sottomessi i contadini, servi o
vincolati, e lo Stato rappresentativo moderno è lo strumento per lo sfruttamento del lavoro salariato da
parte del capitale. (Engels, L’origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato)
L’esperienza storica suggerisce che il proletariato, preso il potere politico e organizzatosi come classe
dominante, non può operare con la macchina burocratico-organizzativa borghese, ma deve fin da subito
spezzarla. Il proletariato non può semplicemente impadronirsi dello Stato borghese ma deve procedere a
smantellarlo nelle sue forme istituzionali, al fine di garantirsi una maggiore capacità di democrazia
sostanziale e di penetrazione nel rivolgimento eonomico-sociale che la rivoluzione comunista comporta.
La dittatura del proletariato
Il proletariato attraverso il partito comunista instaura la dittatura del proletariato.
Il proletariato vittorioso si impadronisce del potere politico, dello Stato e dà avvio alla trasformazione
economico-sociale della società borghese, mai dimenticando che la vittoria ottenuta all’interno di un tessuto
sociale in cui fin al giorno prima si esplicava il dominio della borghesia e che la classe egemone detiene di
fatto tutte le leve del comando. Ciò perché lo Stato non è che la materializzazione degli interessi della
borghesia come classe che esercita il suo dominio sul corpo sociale. Lo stato come macchina istituzionale
non è affatto una macchina neutra, ma risponde a determinate necessità specificatamente di classe. Il
56
proletariato non potrà che spezzarla sin da subito e dar vita ad una propria macchina, che gli consenta di
procedere ai propri fini. Il proletariato può rimanere saldo al comando della macchina dello Stato solo
attraverso una decisa, coattiva opera di smantellamento dell’apparato di dominio borghese in tutte le sue
forme.
La dittatura del proletariato non è un principio da realizzare, ma una misura storica transitoria, una
strumentazione politica da adoperare per raggiungere due fini:
a) spezzare la controrivoluzione, la resistenza della borghesia armata in tutte le sue forme,
ideologicamente e materialmente;
b) procedere alla rottura dei rapporti di proprietà borghesi accentrando nelle mani dello Stato i gangli
vitali dell’economia.
Spezzare la controrivoluzione significa colpire la vecchia classe borghese nelle sue forme di organizzazione.
Significa, innanzitutto, procedere in maniera da potersi garantire la vittoria, cioè il proprio dominio. La
classe borghese non smette di essere classe dominante da un momento all’altro, ma mantiene una miriade di
centri di potere, economico, militare, mediatico e così via, che le danno la possibilità di ribaltare le sorti della
rivoluzione. Al fine di spezzare le reni di questa vecchia classe, il proletariato, con interventi certamente
dispotici nell’ambito del diritto e delle libertà individuali, realizza meccanismi che impediscono alla classe
borghese di poter riprendere il potere politico e che la relegano in uno stato in cui non possa nuocere.
Abolizione della proprietà privata dei mezzi di produzione
Contemporaneamente, il proletariato procede a scompaginare la società borghese portando la sua opera al
cuore del meccanismo economico: l’abolizione della proprietà privata capitalistica.
Come la borghesia ha abolito la proprietà feudale così il proletariato procede all’abolizione della
proprietà privata dei mezzi di produzione. Abolizione della proprietà privata borghese. (Manifesto)
Non si tratta di abolire la proprietà personale, frutto del proprio lavoro - già distrutta dalla stessa proprietà
capitalistica – quanto quella dei mezzi di produzione che sfrutta il lavoro salariato. Abolire la proprietà
privata capitalistica significa adeguare la produzione sociale alla forma che meglio la corrisponde: sociale!
Abolire la proprietà privata capitalistica significa abolire la proprietà privata dei mezzi di produzione e,
dunque, l’appropriazione privata che poggia sugli antagonismi di classe, sullo sfruttamento dell’altrui lavoro.
Il comunismo non toglie a nessuno il potere di appropriarsi prodotti della società, toglie soltanto il
potere di assoggettarsi il lavoro altrui mediante tale appropriazione. (Manifesto)
Tutto ciò non è ottenibile - come insegna lo studio della storia (Rivoluzione francese, Comune di Parigi, ecc)
– se non con “interventi dispotici nel diritto di proprietà e nei rapporti borghesi di produzione” (Manifesto)
La minoranza della società viene espropriata del ‘diritto’ alla proprietà privata capitalistica, in nome e per
conto della maggioranza della società. Insomma, il proletariato procede alla socializzazione dei mezzi di
produzione e di scambio. L’abolizione della proprietà privata è contestualmente accentramento di tutti gli
strumenti di produzione nelle mani dello Stato.
Il proletariato adoprerà il suo dominio politico per strappare a poco a poco alla borghesia tutto il
capitale, per accentrare tutti gli strumenti di produzione nelle mani dello stato, cioè del proletariato
organizzato come classe dominante, e per moltiplicare al più presto possibile la massa delle forze
produttive. (Manifesto)
Solo questo accentramento nelle mani del proletariato può essere la leva con cui procedere ulteriormente
nella organizzazione di una economia socialista.
57
Tra la società capitalistica e la società comunista vi è il periodo della trasformazione rivoluzionaria
dell’una nell’altra. Ad esso corrisponde anche un periodo politico di transizione, il cui Stato non può che
essere altro che la dittatura rivoluzionaria del proletariato. (Critica del programma di Gotha)
La dittatura del proletariato è una misura storica transitoria che mira alla propria estinzione. A differenza
delle altri classi che si sono susseguite nella storia, il proletariato, proprio abolendo il modo di
appropriazione capitalista, abolisce se stesso e lo stesso sorgere delle classi sociali in generale; pone, cioè, le
basi per una società senza classi. Lo Stato, ancorché proletario, come forma di dominio, non ha più ragione
di esistere, ma si dilegua nella semplice amministrazione. Il proletariato, come classe dominante, abolendo
gli antichi rapporti di produzione borghesi, abolisce perciò se stesso e le condizioni della esistenza della
divisione e dell’antagonismo di una società divisa in classi sociali. In termini generali, l’adeguamento della
forma di produzione sociale alla forma di appropriazione sociale consente non solo il pieno dispiegarsi dello
sviluppo delle forze produttive, ma disgrega alla radice la formazione di classi sociali.
Quando le differenze di classe saranno scomparse nel corso dell'evoluzione, e tutta la produzione sarà
concentrata in mano agli individui associati, il pubblico potere perderà il suo carattere politico. […] Alla
vecchia società borghese con le sue classi e i suoi antagonismi fra le classi subentra una associazione in
cui il libero sviluppo di ciascuno è condizione del libero sviluppo di tutti. (Manifesto)
Socialismo e comunismo
Evitando giochi di prestidigitazione, o da filosofi della storia di hegeliana memoria, Marx tratteggia a grandi
linee due fasi storiche che seguiranno alla rivoluzione proletaria. Si può schematicamente riassumere il
pensiero di Marx al riguardo distinguendo due grandi fasi storiche: socialismo e comunismo.
Nella fase socialista il proletariato instaura la sua dittatura e procede alla socializzazione dei mezzi di
produzione nelle mani dello Stato. In questa fase ognuno riceve quanto produce: principio ancora borghese
di distribuzione del prodotto.
La società comunista, invece, è quella in cui lo Stato si è dileguato in un semplice apparato amministrativo,
non esistono più le classi sociali, lo sviluppo delle forze produttive consentono di oltrepassare la divisione
lavoro intellettuale-manuale, il tempo di lavoro necessario per la società è limitato e semplificato in maniera
tale che ognuno possa essere pescatore, artista, nella stessa giornata, e con ciò si pongono le basi per uno
sviluppo onnilaterale dell’individuo. E’ la fase in cui è possibile che sia
ognuno secondo le sue capacità; a ognuno secondo i suoi bisogni (Critica del programma di Gotha)
Marx non ha favoleggiato ciò che si cela alla vista dello scienziato, magari sulla scia di un atteggiamento
meramente egualitario o guardando nella solita palla di vetro che gli incantatori di tutti i tempi sfoderano
all’occasione. I dettagli di una futura società comunista non possono essere determinati se non a grandi linee,
in quanto opera di uomini futuri e della loro attività creativa, del loro modo di risolvere concretamente i
problemi che man mano si porranno.
Proletari di tutti i paesi, unitevi!
CONCLUSIONI
Il marxismo con tutta evidenza è molto più che una filosofia, molto più di una Weltanschauung.
Dal punto di vista filosofico, Marx rappresenta il punto di arrivo, ad oggi insuperato, di una coerente, coesa
impostazione materialistica che sfugge alle secche del materialismo rozzo, compreso quello di Feuerbach. Se
a Feuerbach dobbiamo la scoperta del meccanismo di quel travisamento del reale operata da Hegel attraverso
58
i rapporti di predicazione e la schietta riproposizione della impostazione materialistica, a Marx dobbiamo
l’elaborazione di un materialismo dialettico che finalmente è capace di riconquistare l’intero processo
conoscitivo. Marx, soprattutto nella stenografia delle Tesi su Feuerbach, mostra come il processo conoscitivo
in generale sia essenzialmente rapporto. Se l’idealismo sbaglia a ritenere che il pensiero sia la realtà, crea la
realtà, il materialismo rozzo sbaglia a ritenere che il soggetto sia semplice specchio di una realtà oggettiva.
Ebbene, Marx ricongiunge dialetticamente soggetto e oggetto all’interno di una dimensione che è la prassi
umana, la storia. Il processo conoscitivo è il rapporto storicamente determinato di soggetto-oggetto.
Marx ci libera dalla natura trasformandola in storia. Egli chiude la verità all’interno di quel circolo di
concreto-astratto-concreto che, si badi, non è la riproposizione empiristica o pragmatica di una verità utile.
Per Marx, tuttavia, rimane il concetto di verità utile.
Infine, l’atteggiamento antimetafisico e anti-aprioristico, che privilegia la logica specifica dell’oggetto
specifico, apre risolutamente alla scienza particolare e positiva, la quale relega ciò che resta della filosofia in
una dimensione puramente contemplativa, teorica, a puro sollazzo onanistico.
Questa impostazione materialistica dialettica fornisce alla scienza una base filosofica sicura su cui poter
poggiare le scoperte scientifiche, senza irrigidire i risultati in dogmi assoluti. Il materialismo dialettico è in
perfetta consonanza con lo sviluppo scientifico, proprio perché la sua impostazione dialettica attribuisce alla
materia una dinamicità interna che è inconciliabile con i tentativi di irrigidire la natura e i suoi principi.
Inoltre, il marxismo non intende sostituire l’analisi specifica dell’oggetto specifico con la proposizione
aprioristica degli schemi dialettici, anche se questi ultimi sono continuamente avvalorati dalla stessa scienza
della natura. Proprio questo atteggiamento, che evita apriorismi di tutti i generi, garantisce una base salda alla
scienza, alla sua metodologia, evitando, dunque, di cadere in forme di assolutismo metafisico, che non fanno
che ostacolare lo sviluppo scientifico.
La concezione materialistica e dialettica della storia è, ancora, un’acquisizione ormai accettata
universalmente nelle discipline storiche in generale, anche se con diverse sfumature. Con Marx usciamo
dalla concezione della storia come una semplice narrazione che mette insieme alla rinfusa una congerie di
fatti tutti determinanti. Con Marx la storia riceve un criterio di lettura oggettivo separando i rapporti di
produzione dalla sovrastruttura politica, giuridica, etica… A partire da questa separazione, e individuando nei
primi gli elementi che, in ultima istanza, sono determinanti, fondanti, causali, Marx elabora una serie di
strumenti concettuali (forze produttive, rapporti di produzione, sovrastruttura, ideologia, ecc), diventati
indispensabili per la comprensione storica.
Per quanto riguarda l’economia, va rimarcato come Marx ci abbia liberato anche in questa scienza dagli
eterni e abbia visto l’economia come scienza dei rapporti sociali mediati da cose, ché l’attuale formazione
economico sociale è un organismo affatto eterno, ma storico, e non è possibile interpretarlo con categorie
ossificate e valide per tutte le epoche.
Da un punto di vista teoretico, sia la teoria del valore-lavoro che la conseguente teoria del crollo non hanno
trovato affatto una confutazione teorica e sistematica. Ad esempio la teoria economica borghese di stampo
marginalista o neoclassica non riesce a spiegare il sistema economico nel suo complesso, né riesce a
trasformarsi in una teoria dello sviluppo capitalistico. Le teorie che riguardano, poi, specificamente lo
sviluppo capitalistico indulgono su elementi descrittivi, ma non riescono a cogliere i meccanismi
fondamentali, né a trovare schemi sufficientemente articolati per le crisi o tantomeno a prevederle. Insomma,
l’economia borghese ha proposto modelli alternativi alla critica economica marxista, ma non è riuscita a
confutarla. Nonostante le teorie economiche borghesi siano diventate estremamente ricche ed eleganti nella
loro formulazione matematica nell’ambito della micro-economia, la spiegazione macro-economica e le teorie
dello sviluppo risultano ancora deficitarie e incapaci di prevedere, o tantomeno risolvere, le crisi
internazionali: l’economia borghese, infatti, guarda alle stesse crisi internazionali come a vere e proprie
iatture che riesce a ‘spiegare’ solo post festum.
Rimane, tuttavia, la critica al fatto che il marxismo non riesce a dare, ad esempio, al suo modello teorico un
tempo certo, a prevedere il crollo del capitalismo. Secondo i critici del marxismo, è troppo facile formulare
un modello che non preveda una falsificabilità (Popper) attraverso la determinazione di una data certa.
A questa impostazione sulla scientificità del marxismo, in verità si può facilmente obiettare:
59
a) Non è possibile determinare temporalmente il crollo perché l’economia è scienza sociale mediata
dalle cose. Ad esempio, il valore del salario dipende anche dalla capacità contrattuale del movimento
operaio in quel momento;
b) In ogni caso, la determinazione puramente economica non significa automaticamente il crollo sociale
se il proletariato non aggancia soggettivamente il treno della rivoluzione;
c) Si dimentica che pur avendo trattato la formazione economico-sociale come processo di storia
naturale (Capitale, L. I, p. 937 e 6), distinguendo il determinante dal determinato, la storia umana
non è storia naturale: “società non è mineralogia”;
d) Infine, nessuna teoria economica borghese è capace di prevedere una crisi.
Il marxismo non è capace di prevedere un fatto storico proprio perché la storia è fatta dagli uomini di modo
che la sua scientificità sta nell’aver mostrato le tendenze, cioè le reali prospettive storiche, che uomini in
carne ed ossa dovranno realizzare fermo restando che le stesse classi in lotta potrebbero perire nella lotta
(Manifesto). La scienza sociale non è un libro di profezie!
Se si potesse prevedere in tempi certi il crollo del capitalismo, si potrebbe anche suggerire ai disperati della
terra, agli umiliati e agli offesi di rimanere buoni perché ciò che dovrà accadere accadrà. Sappiamo, invece,
che nessuna classe dominante lascerà il suo posto volentieri.
Più che una serie di profezie sbagliate, come vogliono intenderla i critici, la dottrina economica marxiana
sembra, al contrario, confermata da una serie di indicatori macroeconomici e dinamiche internazionali
previste da Marx e corroborate dallo stesso Lenin in Imperialismo, fase suprema del capitalismo (1916).
Innanzitutto, va ricordato come la teoria del crollo, in particolare, sembri trovare una convalida statistica
nell’analisi fatta dalla Sinistra comunista italiana (bordighista), in un lavoro economico, continuamente
aggiornato, Il corso del capitalismo mondiale nella esperienza storica e nella dottrina di Marx. In tale
trattato si tiene conto delle serie storiche delle produzioni industriali del paesi occidentali. La curva storica
della produzione industriale dei paesi europei a vecchio capitalismo, dal 1860, segna con evidenza uno
sviluppo sempre più lento, un decremento tendenziale del sistema capitalistico, che è possibile leggere come
imminente vecchiaia di tale organismo, soprattutto se lo si mette a confronto con i ‘giovani’ capitalismi
asiatici che si sviluppano ad un ritmo impressionante. Proprio questa tendenza storica di uno sviluppo ad un
ritmo tendenzialmente bradipico è forse l’empirica constatazione – anche se solo sul terreno economico –
della realizzazione della caduta del saggio di profitto e la rivelazione di un organismo economico ormai
senile, che ha perso le energie di un tempo e che si appresta a lasciare il posto ad organizzazioni più evolute.
Secondariamente, la teoria economica viene confermata da una serie di indicatori concretamente rilevabili:
a) processo di globalizzazione economica;
b) crisi cicliche sempre più intense ed estese in cui si distruggono forze produttive;
c) sviluppo ineguale: nord-sud del mondo;
d) accentramento e concentrazione del capitale: trusts, multinazionali, ecc.;
e) spartizione del mondo tra complessi capitalistici;
f) esportazione dei capitali verso Paesi meno sviluppati;
g) esercito proletario di riserva sempre più esteso a livello mondiale;
h) aumento della forbice ricchi-poveri tanto nei paesi avanzati quanto tra le diverse aree del mondo;
i) utilizzo indiscriminato delle risorse del pianeta piegate al solo scopo del profitto.
Infine, per ciò che concerne la prospettiva di Marx di una vittoriosa rivoluzione internazionale proletaria sul
continente europeo, essa si è rivelata completamente sbagliata. Tutti i tentativi di una rivoluzione proletaria
in Europa sono andati falliti dal 1848 ad oggi.
La rivoluzione proletaria si è presentata, paradossalmente, nel paese meno sviluppato d’Europa, la Russia
zarista. Mancò, però, alla rivoluzione bolscevica l’aggancio con la rivoluzione europea e Lenin dovette
andare a scuola dal capitalismo tedesco e inventarsi la Nep. La rivoluzione era persa!
Mancando l’ossigeno di una rivoluzione europea, nel 1926 la rivoluzione aveva definitivamente ripiegato su
se stessa, su una rivoluzione borghese. A Stalin toccò l’edificazione del capitalismo di Stato e la buffonata
60
del socialismo in un solo paese. Allo stalinismo va riportata la responsabilità storica di aver mistificato al
movimento operaio internazionale lo stato reale delle cose. I fondamenti del sistema economico borghese
rimasero in piedi: denaro, forza-lavoro, plusvalore!
I tentativi rivoluzionari in Europa furono fatti, ma portarono ovunque, per diversi motivi, alla vittoria della
borghesia nel suo complesso, specificatamente nella veste del fascismo e nazismo. La fine della seconda
guerra mondiale segnò la logica di spartizione nei blocchi di potere USA-URSS e nella falsa logica
capitalismo-socialismo. Il marxismo, intanto, raccoglieva in diversi modi sotto la sua bandiera i processi di
liberazione nazionali, i processi di decolonizzazione dei paesi sottosviluppati.
In Europa, dalla fine della seconda guerra mondiale fino agli anni settanta, il ciclo economico capitalistico
sembrava trionfale di modo che la lotta di classe vedeva ridimensionati i suoi presupposti; essa fu compressa
e incanalata nel welfare-state.
La caduta del muro di Berlino, la fine dell’URSS, l’identificazione del socialismo reale con il marxismo
hanno fatto sì che innanzitutto Marx fosse obliterato dall’immaginario collettivo e successivamente che le
organizzazioni politiche, le quali si richiamavano in vario modo al marxismo, si sciogliessero come neve al
sole. La classe operaia, almeno per quanto riguarda il capitalismo occidentale, oggi sembra essere stata
risucchiata nelle viscere della terra.
Eppure, paradossalmente, la caduta del socialismo reale ha, per molti versi, liberato Marx dai limiti angusti
in cui l’identificazione con il socialismo reale lo aveva imprigionato.
Rimane al marxismo uno studio ragguardevole su tutta una serie di problemi non risolti, perimetri non ancora
rilevati: lo studio della straordinaria vitalità delle forze capitalistiche, il ciclo storico economico attuale, la
‘fine del lavoro manuale’, lavoro dipendente-lavoro autonomo, postfordismo, forme ideologiche di
consenso…
Attualmente non vi sono, né si intravedono all’orizzonte, teorie diverse dal marxismo, che spieghino
l’andamento di questa formazione economico-sociale, ormai mondializzata e come gestirla senza andare
incontro alla catastrofe, alla precarizzazione del lavoro e della stessa vita. Questo fa di Marx un gigante del
XIX così come del XXI secolo! Il grande storico E. Hobsbawm, autore tra l’altro de Il secolo breve, ha
recentemente scritto:
E’ ora di prendere di nuovo Marx sul serio. (Come cambiare il mondo, Rizzoli, p. 416-417)
Per quelle masse mondiali che vogliono il pane, ma anche le rose, il marxismo è ancora quella teoria e quel
programma capace di saldarsi con le speranze del mondo.
61
BIBLIOGRAFIA
Opere di Marx-Engels
Marx, Manoscritti economico-filosofici del ’44, Einaudi, 2004
Marx-Engels, Manifesto del partito comunista, Einaudi, 2005
Opere su Marx
G. Bedeschi, Introduzione a Marx, Laterza, 2005
V. Lenin, Karl Marx, in Lenin, Opere, Riuniti, v. 21
SITI WEB:
http://www.marxist.org/italiano/marx-engels/index.htm
62
IV. LA MORTE DI DIO E L’OSPITE INQUIETANTE
(Schopenhauer, Nietzsche)
Questo capitolo propone un tratto del volto della filosofia post-hegeliana attraverso la lettura di due grandi
filosofi: Schopenhauer e Nietzsche. I due filosofi hanno, ovviamente, notevoli punti di divergenza e
personale originalità, ma ciò che qui interessa è come entrambi si muovano nel disegno di una riflessione
filosofica che si qualifica, schematicamente, attorno ad alcuni punti notevolissimi:
il Lógos, che la tradizione filosofica ci ha consegnato come strumentazione capace di cogliere la verità
delle cose, è incapace di cogliere la verità dell’essere, la verità del mondo;
il reale, il mondo ha una struttura essenzialmente irrazionale, caotica, insensata e perciò stesso non ha
nessun fine e non c’è spazio alcuno per le "magnifiche sorti e progressive” (Leopardi);
lo stesso concetto di verità (alétheia) non è altro che una menzogna il cui unico scopo è di porci al
riparo dal caos del mondo; dalla paura del nulla che ci annichilisce;
la metafisica, come la religione si sono rivelati peggiore del male cui intendevano essere rimedio;
Dio è morto! Dio è definitivamente morto e nel mondo si presenta il più inquietante fra gli ospiti: il
nichilismo!
Se il marxismo rimaneva all’interno della tradizione razionale occidentale, con l’elaborazione filosofica di
Schopenhauer e poi di Nietzsche si inaugura una riflessione potentemente irrazionale tesa a ‘distruggere’ il
Lógos: antitetica pur essendone il frutto più intimo!
Questo tratto del volto della filosofia è caratterizzato, inoltre, dall’idea - già feuerbachiana e marxiana - di
una riflessione che si curvi risolutamente verso l’uomo concreto, versus le ubbie oltremondane della
speculazione hegeliana. Al mondo, al mondo! Bisogna essere fedeli alla terra!
Infine è il caso di dire che il nichilismo – come sarà formulato da Nietzsche - ci porta a respirare la nostra
aria: è l’ambiente culturale in cui viviamo, lo sfondo in cui prende figura l’era della tecnica.
63
~ SCHOPENHAUER
~
~
~
~
~
~
~
~
~
La vita e le opere
L’eclettismo schopenhaueriano
Il “Velo di maya”
Il mondo come volontà
La vita oscilla tra il dolore e la noia
Il significato dell’amore
Filosofia e religione
Il rifiuto dell’ottimismo o la critica all’Occidente
La liberazione dal dolore
~ CONCLUSIONI
SCHOPENHAUER
La riflessione filosofica di Schopenhauer è completamente estranea e critica nei confronti dell’idealismo e
del panlogismo hegeliano. Basti pensare che Schopenhauer contrappone all’Idea hegeliana, al suo Lógos che
si muoveva con quell’incedere rigido e persuasivo nelle triade dialettiche, la Volontà che, al contrario, si
muove senza ragione e senza scopo. La storia, che in Hegel era un continuo progresso nella misura in cui era
un continuo conoscersi fino allo Spirito assoluto, diventa eterna ripetizione di un identico dramma del dolore.
64
La vita e le opere
Arthur Schopenhauer nacque il 22 febbraio 1788 a Danzica. Nel 1793, in seguito all’annessione di Danzica
all’impero Prussiano, si trasferì ad Amburgo per sfuggire ad un ambiente divenuto antiliberale.
Si laureò a Jena nel 1813 discutendo una tesi intitolata Sulla quadruplice radice del principio di ragion
sufficiente, dopo aver seguito anche, a partire dal 1811, le lezioni dell’idealista Fichte a Berlino.
Tra il 1814 e il 1818 visse a Dresda, dove si dedicò alla stesura dello scritto Sulla vista e i colori, ispirato dal
pensiero scientifico di Wolfgang Goethe, conosciuto a Weimar, e di quella che è considerata la sua opera
principale: Il mondo come volontà e rappresentazione.
A Berlino ottenne, nel 1820, l’abilitazione alla libera docenza in quell’Università dove Hegel
spadroneggiava. Il contrasto con Hegel lo portò a fissare le sue lezioni nelle stesse ore di quelle di Hegel: il
risultato fu la sospensione dei corsi per mancanza di studenti.
Nel 1836 Schopenhauer pubblicò il suo Sulla volontà nella natura, mentre nel 1841 I due problemi
fondamentali dell’etica. Le sue opere ebbero sostanzialmente uno scarso successo fino al 1848, anno nel
quale si diffuse la corrente pessimista in Europa, che era in linea con il suo pensiero tenebroso e antiidealistico.
Nel 1851 pubblicò la sua ultima opera, Parerga e Paralipomena, scritta con un linguaggio brillante e
leggero, quasi vicino alla narrativa, che contribuirà in maniera fondamentale alla diffusione della sua
filosofia.
Schopenhauer morì il 21 settembre 1860.
L’eclettismo schopenhaueriano
Schopenhauer si mostra decisamente eclettico nel prendere spunto da ideologie precedenti per elaborare il
proprio sistema filosofico. Il suo pensiero, infatti, è influenzato parimenti dai grandi filosofi occidentali (in
primo luogo Platone e Kant) e dalla spiritualità indiana; non mancano poi riferimenti importanti al
Romanticismo, così come all’Illuminismo e all’Idealismo.
Egli è affascinato dalla teoria platonica delle idee, che sono da lui considerate delle entità astratte ed eterne,
“fortunate” in quanto esentate dal dolore che domina il mondo.
L’impostazione soggettivistica della gnoseologia schopenhaueriana, deriva, senza dubbio, dall’influenza di
Kant, che considera grande maestro.
Dalla sapienza orientale, invece, Schopenhauer riprende una serie di immagini suggestive come il “velo di
Maya”. E’ proprio questo forte interesse per la cultura indiana che lo distingue dagli altri pensatori del suo
tempo: se infatti fino ad ora i filosofi occidentali l’hanno accantonata perché “la cultura orientale non crea
Savi, ma Santi”, adesso essa dimora all’interno della riflessione schopenhaueriana, base di un pensiero
moderno, filosofico nel senso proprio del termine. Si ricordi che Hegel aveva tra l’altro trattato della
conoscenza Orientale, specificatamente cinese e indiana, “soltanto per rendere ragione del fatto che non ce
ne occuperemo […] Ciò che chiamiamo filosofia orientale è piuttosto la rappresentazione religiosa che gli
Orientali si fanno della realtà, la loro intuizione generale del mondo, ch’è facile scambiare per filosofia”
(Lezioni sulla storia della filosofia, p. 133).
L’influenza romantica si fa sentire per quanto riguarda la propensione all’irrazionalismo e al tema
dell’infinito, idea per la quale Schopenhauer viene comunemente collegato alla figura di Giacomo Leopardi,
con cui ha in comune anche la forte vena pessimistica; dalla corrente ottocentesca deriva poi la grande
importanza attribuita alla musica e alle arti visive.
Ma lo spunto principale è sicuramente il tema del dolore, che pervade la visione schopenhaueriana del
mondo.
Dall’Illuminismo derivano la tendenza demistificatrice nei confronti delle credenze passate e la
considerazione della psiche come pura manifestazione del sistema nervoso umano.
65
L’Idealismo, infine, è “paradossalmente” fondamentale in quanto Schopenhauer lo affronta per prenderne
apertamente le distanze: Hegel viene da lui definito un “sicario della verità”, accusato di irrigidire e
cristallizzare la filosofia con la divinizzazione delle istituzioni e della storia, considerate mere manifestazioni
dello Spirito. Il pensiero hegeliano è una “buffonata filosofica”!
Il “Velo di maya”
Schopenhauer pone come punto di partenza della propria filosofia la distinzione tra la realtà fenomenica e
quella noumenica già operata da Kant nella Critica della Ragion Pura, ma curva al massimo grado il
significato del fenomeno traducendolo come illusorietà: fenomenico = illusorio!
Se per l’illuminista il fenomeno, la cosa come ci appare, è reale, per Schopenhauer esso è pura illusione,
sogno, ovvero ciò che, appunto, nella sapienza indiana veniva definito “Velo di Maya” dietro il quale si
nasconde il noumeno, che va appunto svelato dal filosofo con la sua ricerca.
E’ Maya, il velo ingannatore, che avvolge gli occhi dei mortali e fa loro vedere un mondo del quale non
può dirsi né che esista, né che non esista; perché ella rassomiglia al sogno, rassomiglia al riflesso del
sole sulla sabbia, che il pellegrino da lontano scambia per acqua; o anche rassomiglia alla corda gettata
a terra che egli prende per un serpente. (Il mondo come volontà e rappresentazione, par. 3)
Per Schopenhauer, inoltre, il fenomeno è solamente interno alla coscienza ed è pura rappresentazione
soggettiva: “Il mondo è la mia rappresentazione”.
La rappresentazione consta di due parti, che sono come due inscindibili facce della stessa medaglia: il
soggetto e l’oggetto. Ai materialisti precedenti, quindi, Schopenhauer rimprovera l’aver preso in
considerazione solo quest’ultimo, sminuendo o negando del tutto il soggetto, mentre agli idealisti rimprovera
il procedimento opposto.
Schopenhauer crede che la mente dell’uomo sia corredata da forme a priori e che il merito di questa scoperta
tocchi al grande Kant. La rappresentazione si origina, dunque, dalle forme a priori della mente umana, ma le
dodici categorie kantiane possono essere ridotte alle forme di spazio, tempo e causalità.
Quest’ultima, come affermato nel trattato Sulla quadruplice radice del principio di ragion sufficiente, si
snoda attraverso quattro diverse forme:
1. “Principium rationis sufficientis fiendi”, il principio di ragion sufficiente del divenire, che regola i
rapporti tra gli oggetti naturali;
2. “Principium rationis sufficientis cognoscendi”, il principio di ragion sufficiente del conoscere, che
regola i rapporti tra le premesse e le conseguenze;
3. “Principium rationis sufficientis essendi”, il principio di ragion sufficiente dell’essere, che regola i
rapporti tra aritmetica e geometria così come tra lo spazio e il tempo;
4. “Principium rationis sufficientis agendi”, il principio di ragion sufficiente dell’agire, che regola i
rapporti tra un’azione e i suoi motivi.
Le forme a priori sono considerate delle lenti sfaccettate, la realtà viene deformata inevitabilmente
diventando ingannevole. I Veda, Platone, Pindaro, Sofocle, Shakespeare e Calderón de la Barca sono solo
alcuni predecessori che hanno intuito questa grande verità. La realtà è pura esperienza onirica: “La vita è
sogno”!
In Schopenhauer, dunque, il fenomeno kantiano diventa una pura rappresentazione ingannevole, soggettiva,
cosicché la vita stessa non diventa altro che una rappresentazione, una sorta d’incantesimo, un sogno.
Viene ripresa quindi, dal filosofo tedesco, tutta quella tradizione letteraria e poetica da Shakespeare a
Calderòn che aveva identificato la vita umana con un lungo e articolato sogno, lo portarono ad affermare la
celebre frase: “la vita e i sogni son pagine dello stesso libro”.
66
L’atteggiamento di Schopenhauer è duplice: rigore filosofico e dimensione poetico-letteraria. La
dimostrazione della illusorietà del mondo è un percorso razionale, poiché la vita è immersa in cose solamente
“rappresentate”, ma anche risultato di un’intuizione estetico-poetica.
Il mondo come volontà
Schopenhauer si presenta, oltre che come una sorta di continuatore kantiano, anche come un riparatore
kantiano: egli pensa, infatti, di aver individuato la via d’accesso al noumeno kantiano che nella Critica della
ragion pura rimaneva inconoscibile e inaccessibile.
La domanda fondamentale è: se il mondo è rappresentazione, cioè illusione, come si fa a rompere questo
‘velo di Maya’ per inoltrarsi nella regione della verità, della conoscenza della cosa in sé, dell’assoluto?
La cosa in sé, la sostanza unica del mondo – se così ci si può esprimere – per Schopenhauer è la “volontà”.
Come si fa a rendersene conto?
Attraverso una riflessione su noi stessi: quando ci pensiamo corpo e coscienza, possiamo fare a meno dei
primordiali principi a priori e, in una sorta d’intuizione, ci rendiamo conto che ciò che ci accomuna e
percorre tutto l’universo è questa “volontà di vivere” (Wille zum Leben), indistinta, che penetra tutte le cose.
Schopenhauer afferma, dunque, che il fenomeno è illusione che vela la realtà delle cose nella loro essenza
autenticamente originaria, essenza che è conoscibile come volontà. Tramite il corpo, che ognuno sente come
“brama” di vivere e di autoconservazione, si riesce a comprendere che si vive immersi come parte integrante
di un’unica volontà, di un “cieco ed irresistibile impeto” che si identifica con il nostro esistere e agire.
Già Hobbes aveva utilizzato il termine “brama”, ma in tutt’altra accezione: quando pensava allo stadio di
natura, egli riconosceva la “bramosia” che rendeva l’uomo “egoista”.
In Schopenhauer, invece, la “brama” di vivere è un’energia, un impulso indistinto che ci fa muovere e che è
al di là di tutto, spazio e tempo compresi.
La volontà di vivere va intesa quindi non solo poeticamente: sembra, infatti, assumere i connotati dell’
“istinto” che Darwin metterà in ordine nella sua costruzione di tipo evoluzionistica.
Per esprimere il concetto di questa lotta tra corpo e coscienza, tra volontà e razionalità, Schopenhauer si
serve di immagini eloquenti. Il rapporto tra volontà e intelletto è simile a quello tra il padrone e il servo, tra il
fabbro e il martello, tra il cavaliere e il cavallo. Secondo questa prospettiva, che verrà ripresa da Nietzsche,
chi padroneggia le azioni umane non è l’elemento razionale, ma questa “voglia di vivere” inconscia che
muove l’uomo. La voglia di vivere sembra essere una forza interna, quasi di stampo freudiano, che
segretamente ci agita e ci guida.
Solo questa autoriflessione, questo piegarci su noi stessi, ci permette di squarciare il ‘velo di Maya’ – il velo
del fenomeno – e di intuire che la cosa in sé del nostro essere è la brama di vivere. Noi, più che intelletto,
siamo volontà di vivere. Il nostro corpo è la manifestazione, l’oggettivazione, la rappresentazione delle
nostre brame; l’apparato sessuale è la forma fenomenica dei nostri appetiti sessuali. Il mondo intero è il
modo in cui si manifesta la nostra volontà nello spazio e nel tempo.
La volontà di vivere non è però solo la verità dell’uomo nel suo aspetto noumenico, ma anche l’essenza di
tutte le cose dell’universo. Non è soltanto l’uomo che si muove grazie alla volontà di vivere, ma tutto
l’universo: dall’inorganico all’organico, dai minerali alle piante, dai pesci all’uomo. La volontà informa la
stessa costruzione cosmica!
La prima caratteristica della volontà primordiale è quella di essere inconscia. La volontà è un’energia, un
impulso, inconscio che muove il cosmo.
La volontà è poi unica ed esiste al di fuori dello spazio e del tempo.
Ma proprio perché è al di fuori del tempo essa è anche eterna e indistruttibile: un principio senza inizio né
fine.
Ma se la volontà è superiore allo stesso principio di causa, essa è una forza libera e cieca, un’energia
incausata, senza un perché e senza uno scopo. Non c’è, dunque, nessuna struttura finalistica nel cosmo!
67
La volontà non ha “telos”, non ha alcuna meta oltre se stessa. E’ possibile scorgere in questa interpretazione
anti-finalistica ciò che accomuna Schopenhauer, Leopardi e Nietzsche, all’orizzonte del “nichilismo”, in cui,
non c’è più uno scopo, non c’è un fine e i valori si svalorizzano. Hegel ne morirebbe!
Tutti gli esseri, quindi, vivono per vivere e per continuare a vivere. La crudele verità del mondo che
Schopenhauer scopre è proprio questa: gli uomini, attraverso la creazione di un Dio, non hanno fatto che
“mascherare” questa verità, cercando di trovare un significato alle loro azioni e alla loro stessa vita. Ma per
Schopenhauer Dio non esiste. L’unica cosa assoluta è la volontà stessa, le cui caratteristiche non a caso sono
le stesse che invece una lunga tradizione aveva attribuito a Dio.
Schopenhauer pensa che la volontà di vivere si manifesti attraverso due fasi: la prima, in cui la volontà si
oggettiva in un sistema di forme immutabili, archetipi del mondo; la seconda, in cui la volontà si oggettiva
nelle realtà naturali, dalle forze generali della natura all’uomo.
Schopenhauer crede inoltre in una struttura gerarchica in cui si articola il mondo delle realtà naturali: più si
sale nella scala gerarchica più si raggiunge un “grado” di maggiore “coscienza”. Dalle forze generali della
natura si passa quindi alle piante, agli animali e, infine, “la piramide” culmina nella figura umana, in cui la
volontà è pienamente consapevole.
Da questo punto di vista l’uomo è il vertice della piramide, il massimo grado raggiunto dalla coscienza; ma
ciò si risolve, paradossalmente nel suo più grande difetto: quanto più acquista in coscienza, tanto più perde in
sicurezza. La ragione è meno efficace dell’istinto come guida per la vita: l’uomo non è altro che un “animale
malaticcio”.
L’uomo ha una capacità intellettuale, razionale e coscienziale che lo porta ad essere superiore a qualsiasi
altro animale, come ad un cane, ma proprio questo oltrepassamento del corredo istintuale lo sguarnisce
completamente come organismo animale rispetto al caos del mondo.
Con Schopenhauer si ha una prima risposta, precisa, a un interrogativo che già Kant aveva proposto nella
Critica. La risposta di Schopenhauer è secca: è esattamente la dimensione razionale dell’uomo che,
sganciandosi dal mondo animale, ci rende vulnerabili. Questa non è la nostra forza, ma il nostro ‘tallone
d’Achille’. Contro il caos esistenziale, contro il buio dell’esistenza, noi ripariamo creandoci dei miti, delle
religioni, delle ideologie, che ci possono far sopportare la nostra vita perché a tutta una serie di elementi noi
non abbiamo risposta. Un cane non ha tentennamenti, risponde attraverso il suo corredo istintuale. Ciò che ci
ha reso propriamente umani ci ha reso anche deboli rispetto agli altri animali. La creazione di religioni,
ideologie, credenze, superstizioni è dettata proprio da questa mancanza istintuale. Se fossimo tutto istinto,
non avremmo bisogno della religione! La riflessione di Schopenhauer sull’”animale malaticcio” sarà
estremamente feconda con Nietzsche, che parlerà dell’uomo come di “animale non stabilizzato” (Al di là del
bene e del male, § 62).
La vita oscilla tra il dolore e la noia
La vita è un pendolo che oscilla tra il dolore e la noia (Il mondo … par. 57)
Ecco, in una delle frasi celebri, il cosiddetto il pessimismo schopenhaueriano.
Il termine ‘pessimismo’ è, per molti versi, riduttivo e, per certi, fuorviante: quella di Schopenhauer può
essere considerata semplicemente un’analisi profonda della realtà che lo porta a vedere il mondo in maniera
‘iper-realistica’. Il cosiddetto pessimismo non è una semplice inclinazione caratteriale, ma una struttura
ideologica profondissima che si erge contro una concezione razionalistica e positivistica in cui l’elemento
concettuale dominante sono le “umane sorti e progressive” (Leopardi).
Quando si parla di Schopenhauer, così come di Leopardi, la predisposizione ideologica “pessimistica” non è
il frutto di un’inclinazione caratteriale personale, ma è una profonda critica all’Occidente che si sta
industrializzando e che vede nella modalità dell’organizzazione industriale la sua potenza e nella scienza il
suo strumento. Il ‘pessimismo’ di Schopenhauer è una critica feroce di “disvelamento” e di
“demistificazione” dei concetti positivi che fanno da guardia pretoriana alle umani sorti progressive!
Innanzitutto, è davvero incredibile come la vita individuale sia priva di significato:
68
Gli uomini somigliano a orologi, che vengono caricati e camminano, senza sapere il perché; ed ogni
volta, che un uomo viene generato e partorito, è l’orologio della vita umana di nuovo caricato, per
ancora una volta ripetere, frase per frase, battuta per battuta, con variazioni insignificanti, la stessa
musica già infinite volte suonata. […] La vita d’ogni singolo, se la si guarda nel suo complesso,
rilevandone solo i tratti significanti, è sempre invero una tragedia; ma esaminata nei particolari, ha il
carattere della commedia (Il mondo… par.58)
La vita ha tutti i mali della tragedia ma siamo, piuttosto, goffi tipi da commedia!
Secondo Schopenhauer il principio universale è il dolore; il piacere non è altro che un momento transeunte
che qualifica l’assenza del dolore, che è invece la sostanza, l’essenza della natura cosmica. L’uomo soffre,
perennemente tormentato dai suoi desideri che non riesce mai a soddisfare in modo definitivo.
La felicità è impossibile come elemento stabile, essa è solo passeggera e altro non fa che segnare l’assenza
del dolore.
Se non c’è il dolore, che è direttamente legato alla volontà di godere le cose, c’è allora un ristagno dei
desideri: la noia. La vita è o dolore, brama di volere, tensione spasmodica verso determinati obiettivi, o noia,
flessione del desiderio, ristagno. La noia è esperienza dolorosissima e insopportabile perché ci catapulta in
una dimensione di involontario disinteresse per tutto: “nel vuoto spaventoso”. In questa oscillazione il
piacere e la felicità non rappresentano che un momento fugace.
Solo la sofferenza è universale e colpisce e affligge tutto, indistintamente: dal fiore che appassisce
all’animale ferito, al bimbo inerme e all’uomo malvagio.
La sofferenza cresce anche al crescere dell’intelletto: “più intelligenza avrai, più soffrirai”, “chi aumenta il
sapere moltiplica il dolore” dice più volte Schopenhauer riprendendo l’Ecclesiaste. Il sapere non è un
‘sapere-sapore’ che addolcisce l’esistenza ma, in quanto coscienza dell’esserci nel mondo, è un’esperienza
dolorosa perché ci porta sul ciglio rovinoso dell’insensatezza.
Il dolore si avverte anche nella lotta crudele di tutte le cose:
dietro le celebrate meraviglie del creato si cela un’arena di esseri tormentati e angosciati, i quali
esistono solo a patto di divorarsi l’un l’altro, dove perciò ogni animale carnivoro è il sepolcro vitale di
mille altri e la propria autoconservazione è una catena di morti strazianti. (Il mondo… )
L’espressione, molto forte e decisa, taglia un’eccessiva antropomorfizzazione della natura, non c’è più
anima, ma una legge spietata per cui “ogni carnivoro è il sepolcro di mille altri”.
Ogni visione edulcorata ed edulcorante della natura non trova quindi assolutamente spazio nella visione
schopenhaueriana, a vantaggio di una visione rigidamente iper-realistica.
Eccellente in tal senso è l’esempio della formica gigante che dimostra, appunto, l’autolacerazione dell’unica
volontà in una molteplicità di parti e di individui reciprocamente ostili:
quando la si taglia, comincia una lotta fra la parte del corpo e quella della coda; quella ghermisce
questa col morso, questa si difende validamente col pungere quella. La battaglia dura di solito una
mezz’ora, finché le due parti muoiono, o vengono trascinate via da altre formiche. (Il mondo … par. 27)
Il significato dell’amore
Schopenhauer rifugge completamente una visione romantica dell’amore:
dietro le lusinghe di Cupido e il suo incanto sta in realtà il freddo Genio della Specie che mira alla
perpetuazione della vita. (Il mondo … Supplementi)
69
Per Schopenhauer, l’innamoramento e tutte le “smancerie” ad esso legate si riducono in ultima analisi a
“puro desiderio sessuale”, accoppiamento a strumento di organizzazione della specie. La prospettiva
schopenhaueriana anticipa, per certi versi, l’evoluzionismo darwiniano. Infatti, una massa di tiepidi, melensi
concetti sull’innamoramento vengono ricondotti al loro nesso reale: la mera continuazione della specie.
Per lo stesso motivo, l’innamorato diventa “zimbello” della natura. L’uomo, proprio mentre crede di essere
se stesso, nell’innamoramento, è mosso da altro! La natura illude l’individuo facendogli credere di
perseguire scopi personalissimi, quando in realtà lavora per la specie; per la natura l’individuo è nulla: essa è
solo per la conservazione della specie. Schopenhauer descrive questo fatale inganno: “Perciò dunque ogni
innamorato si ritrova, dopo il compimento finale della grande opera, infinocchiato: perché è svanita
l’illusione per la quale l’individuo era lo zimbello della specie.” (Supplementi). L’amore non è che un’astuzia
della specie!
Anche in questa occasione la visione schopenhaueriana non è semplicemente pessimistica: è uno scavare
all’interno di concetti elaborati, sofisticati, romantici, per riportarli ad una realtà completamente diversa da
quella raccontata dalla narrativa e dalla letteratura, che pure ha la sua giustificazione nel fatto che attraverso
di essa passa l’istinto sessuale.
“l’istinto sessuale si conferma essere la risoluta, la più forte affermazione della vita. […] In
conseguenza di tutto ciò i genitali sono il vero e proprio fuoco della volontà […] e in tal qualità furon
dai Greci venerati nel Phallus, dagli Indiani nel Limgam”. (Il mondo…., par. 60)
Schopenhauer non nega che possa esserci un atteggiamento di tipo sentimentale, ma esso è solo una
“guaina”, una “protezione”, un “velo” che cela il puro desiderio:
Ogni innamoramento, per quanto etereo voglia apparire, affonda le sue radici nell’istinto sessuale; se la
passione del Petrarca fosse stata appagata, il suo canto sarebbe ammutolito. (Supplementi)
Questa impostazione penetrante, pre-freudiana, pre-psicanalitica, si manifesta anche nel celebre aforisma:
l’amore è nient’altro che due infelicità che si incontrano, due infelicità che si scambiano e una terza
infelicità che si prepara. (Il mondo …)
La stessa procreazione si riduce a pura creazione di ulteriore dolore, venendo quindi inconsapevolmente
etichettata come “peccato” o “vergogna”.
L’unico amore da lodare non è, quindi, quello dell’eros, ma quel sentimento disinteressato della pietas.
Filosofia e religione
La riflessione di Schopenhauer sul rapporto tra filosofia e religione è estremamente interessante non solo
nella demistificazione di una menzogna quanto nella miriade di spunti che innervano le sue argomentazioni e
che avranno feconde ricadute sugli sviluppi successivi del fare filosofico e in primo luogo su Nietzsche.
Innanzitutto Schopenhauer distingue nettamente l’origine della filosofia dall’origine della religione.
L’origine della religione è la paura, il terrore. Terrore esistenziale e di una natura soverchiante e sconosciuta
nei suoi nessi causali. L’origine della religione è “nella angoscia” degli uomini di fronte ad una natura che
non riescono a dominare. La filosofia, al contrario, sgorga dalla pura sete di conoscenza dell’uomo: è,
aristotelicamente, il sapere per il sapere. Anche in un mondo felice gli uomini arriverebbero alla riflessione
filosofica.
Non solo religione e filosofia hanno radici diverse, ma sono l’una contro l’altra armata. La religione è un
credere. La filosofia, al contrario, un pensare!
Nessuno che sia veramente filosofo è religioso: cammina senza dande, pericolosamente ma libero. (O si crede o
si pensa)
70
Chi crede non è filosofo!
O si crede o si pensa!
La filosofia è scienza e non doxa, opinare, credere; “il suo oggetto è ciò che si può sapere”. La filosofia non
ha assolutamente niente a che vedere con la religione; sono cose diversissime ed è bene che stiano separate.
Pensare significa dimostrare incontrovertibilmente.
La filosofia, diversamente dalla religione, è una scienza e, come tale, non ha nessun articolo di fede; in essa,
quindi, non si deve assumere come esistente se non ciò che è o chiaramente accertato come dato empirico o
dimostrato per via di deduzioni incontrovertibili.
Con ogni evidenza il mondo basta a se stesso! Il mondo è materia. La materia ha in sé forza per il movimento
– come direbbero Democrito, Epicuro, Lucrezio, ecc. L’ipotesi di un Dio personale ed esterno al mondo è
un’ipotesi superflua e “non dimostrabile in alcun modo”.
Il teismo si deve riconoscere in una di queste tre accezioni:
1) Dio ha fatto il mondo dal nulla: questo fa a pugni con l’assoluta certezza che dal nulla non si crea
nulla.
2) Egli ha creato il mondo da se stesso: allora o c’è rimasto dentro anche lui stesso (panteismo), o la
parte di se stesso, che è diventata mondo, si è staccata da lui (emanazione).
3) Egli ha formato la materia che ha trovata: allora questa è eterna come lui ed egli è soltanto un
demiurgo.
La religione per 1800 anni “ha messo la museruola alla filosofia”! Dopo una lunga stagione che ha visto la
filosofia portata a forza nei monasteri e ridotta ad ancilla theologiae, a vergognosa valletta delle Sacre
scritture sotto la patristica e la scolastica, eccola, pian piano, uscire dal buio del Medioevo e prorompere con
la ricerca in mille rivoli e scoperte: l’astronomia, le scienze naturali... La filosofia può riprendere la parola.
La libera ricerca si allontana dai conventi. La filosofia rialza la testa!
Le religioni sono come le lucciole: per brillare hanno bisogno dell’oscurità. Ciò che occorre a tutte le
religioni è un certo grado di diffusa ignoranza; quello che è il solo elemento in cui possano vivere. Non
appena, invece, è consentito all’astronomia, alle scienze naturali, alla storia, alla geografia, all’etnologia,
di diffondere ovunque la loro luce, e può finalmente prendere la parola anche la filosofia, ogni religione
fondata sui miracoli e sulla rivelazione è destinata a tramontare; e allora è la filosofia a prendere il suo
posto. Verso la fine del quindicesimo secolo, spuntò, in Europa, il giorno della conoscenza e della
scienza; quel sole continuò a salire, sempre più in alto, nel 1500 e nel 1600, due secoli così fecondi, e
dissipò le nebbie del Medioevo. Parallelamente si ebbe, a poco a poco, il declino della Chiesa e della
religione, tanto che, nel 18° secolo, alcuni filosofi inglesi e francesi potevano già insorgere, contro l’una
e l’altra, direttamente, finché, sotto Federico il Grande, venne Kant, che sottrasse alla fede religiosa il
sostegno della filosofia di cui aveva goduto fino ad allora, e, affrontando la questione con scrupolosità e
pacatezza tutta tedesca, emancipò l’ancilla theologiae. (O si crede o si pensa)
Con la Critica della ragion pura Kant assesta, dal punto di vista teoretico, il colpo mortale alla religione:
come con un rosario, sgrana, ad una ad una, le prove dell’esistenza di Dio e le confuta, ad una ad una! Non
rimane che la doxa, la fede! Kant sottrae alla religione il sostegno della filosofia e giunge, definitivamente,
ad espungere la religione dal consesso scientifico: la teologia è definitivamente ridotta ad un articolo di fede.
Il meglio della secolare elaborazione mistico-metafisica, la prova ontologica, la prova cosmologica, la prova
fisico-teologica cadono sotto il peso della ragione. Tutte le dimostrazioni della teologia speculativa sono
insostenibili! La Critica impietosa ricaccia la religione fuori dal consesso scientifico!
Kant – sostiene Schopenhauer -, al pari di Hume, deve però cercare di mitigare gli effetti delle sue
conclusioni, sconvolgenti e dirompenti per i suoi tempi, e così si piega alla ragion pratica. Viene fondata
una fede senza conoscenza giusto perché la gente abbia in mano qualcosa di concreto. Kant dà così vita “a
71
una creatura mostruosa quale una dottrina teologica valida soltanto praticamente”. Insomma, Kant riporta
l’esistenza di Dio nella sola sfera morale, senza fondamenta teoretiche.
Per attenuare quanto poteva esservi di scandaloso nella sua critica di tutta la teologia speculativa, Kant
vi aggiunse un’affermazione: anche se l’esistenza di Dio avesse dovuto restare indimostrata, era
altrettanto impossibile dimostrare la sua inesistenza. Con ciò, molti si tranquillizzarono, senza
accorgersi che Kant, con finta ingenuità, aveva ignorato che affermanti incumbit probatio, e, inoltre, che
il numero delle cose di cui non è possibile dimostrare l’inesistenza è infinito. (O si crede o si pensa)
Ecco allora grandi professori e stimati professorini tentare le ultime difese: Kant non ha inteso negare Dio,
ma piuttosto mettere in discussione la dimostrabilità razionale della sua esistenza. Kant riterrebbe che la
ragione umana non possa dimostrare né l’esistenza di Dio, né la sua non-esistenza. Non s’accorgono che il
più, ormai, è fatto. L’onore della prova spetta a chi afferma! La religione è relegata alla fede e questo basta a
renderla soggetta ai capricci della doxa! Non solo, sarà difficile senza l’aiuto di una qualche ragione
distinguere il grano dalla pula; senza un filtro sarà difficile che non passi qualsiasi cosa!
Certamente la religione, come abbiamo detto, sorge da una esigenza reale. Se vi fosse un uomo senza
bisogno alcuno non vi sarebbe neanche la necessità di un Dio. In questo senso le religioni non sono affatto
un prodotto naturale ma artificiale.
Il cuore, cioè la volontà, ha bisogno di sperare nell’assistenza di qualcosa di onnipotente e quindi di
soprannaturale, e di invocarla: si ipostatizza un dio perché è necessario pregare, non viceversa [cioè
perché vi si creda a priori].
Ancora, ogni teismo è antropomorfismo nel senso che Dio è immagine dell’uomo: ha sentimenti umani, ha
una volontà fornita di intelletto che fa da guida. Questi tratti sono indispensabili nell’elaborazione del
concetto di Dio in quanto un dio che prescinda da queste caratteristiche non sarebbe un dio esterno e
personale, capace, cioè, di poter intervenire nel tessuto del mondo e modificarlo attraverso il nostro
sacrificio, la supplica, la preghiera. Un Dio che non fosse ‘personale’ sarebbe banalmente una legge di
natura!
D’altra parte, sarcasticamente, un dio personale sarebbe davvero un bel ‘tipo’. Sprezzante, Schopenhauer
dice:
Dovrebbe, veramente, essere un dio sconsiderato quello che, per divertirsi, non sapesse trovare niente
di meglio che trasformarsi in un mondo come questo. (O si crede o si pensa)
Un mondo imperfetto, pieno di dolore e sofferenza.
Se un dio ha fatto questo mondo, io non vorrei essere quel dio, perché il dolore mi strazierebbe il cuore.
A tratti, in consonanza con Feuerbach, Schopenhauer parla di un processo di ipostatizzazione di Dio. Il
concetto di Dio pone all’esterno quanto è all’interno: “dio’ è essenzialmente un oggetto e non il soggetto:
non appena si pone un dio, quindi io non sono niente”.
La religione, secondo Schopenhauer, mina poi le basi per un vero principio etico e con grande acume mette
in evidenza il conflitto tra teismo e morale. Il teismo abolisce la libertà morale e l’imputabilità giacchè con
“un essere che esiste ed è quello che è in quanto opera di un altro, non si può pensare né a colpe né a
meriti”. Insomma, l’imputabilità presuppone in se stessa la causa e il principio del proprio essere: l’aseità!
Certo, la religione risponde ad un bisogno metafisico dell’uomo – “la religione è la metafisica del popolo” –,
ma essa è un semplice, limitato, primitivo stadio di risposta a questo bisogno umano, schematismo adattato ai
bisogni e alle facoltà intellettuali della massa. La religione è, quindi, una stampella per la patologica
debolezza della maggior parte degli uomini.
Ora, lo stesso bisogno metafisico nella religioni viene bloccato, delimitato, paralizzato, irrigidito nei suoi
dogmi e non vi trova soddisfazione che il popolo incolto, ad un bassissimo livello di conoscenze.
72
«Teologia e filosofia» disse, «sono come i due piatti della bilancia. Quanto più si abbassa l’uno, tanto
più si alza l’altra. Quanto più nel nostro tempo cresce la miscredenza, tanto più diventa grande il
bisogno di filosofia, di metafisica; e allora devono venire da me.» (O si crede o si pensa)
La religione è quella conoscenza adatta all’infanzia dell’umanità. Le religioni sono necessarie per il popolo
ma quando pretendono di conoscere la verità bisogna assolutamente fermarle in questo loro delirio.
Le conoscenze che, in ogni campo, aumentano di giorno in giorno e si estendono sempre più in tutte le
direzioni, allargano l’orizzonte di ogni individuo nell’ambito dei suoi particolari interessi, e lo allargano a
tal punto che, fatalmente, esso finirà per raggiungere un’ampiezza tale che al suo contatto i miti che
costituiscono l’ossatura del cristianesimo rinsecchiranno, e non offriranno più appiglio alla fede. La
religione è come il vestito di un bambino quando il bambino è cresciuto: non gli va più bene, e non c’è
niente da fare: il vestito si squarcia. Fede e conoscenza rinchiuse nella medesima testa non vanno
d’accordo; ci stanno come un lupo e una pecora chiusi nella medesima gabbia: e la conoscenza è il lupo
che minaccia di divorare la vicina. (O si crede o si pensa)
Ma, ancora oggi, sedicenti filosofi e professori che non conoscono l’ABC della filosofia e del metodo
filosofico, la riducono costantemente a insulsa teologia, a spaccio della mitologia ebraico-cristiana, e si
attardano ancora su Dio e i suoi attributi e su come abbia ‘concepito’ tutta questa ‘valle di lacrime’.
Continuano la litania che l’argomento della filosofia è l’Assoluto. Ebbene, essi non sono che asini! Il mondo
è il problema della filosofia!
I filosofi da strapazzo non conoscono neppure il problema della filosofia. Pensano che esso sia Dio. Da
lui partono, come se fosse un dato certo, con lui hanno sempre a che fare: se egli sia nel mondo o fuori
del mondo, se abbia una coscienza propria o se si debba servire di quella degli uomini, e simili buffonate
a non finire.
Asini, il mondo, il mondo è il problema della filosofia, il mondo e nient’altro! (O si crede o si pensa)
Il rifiuto dell’ottimismo o la critica all’Occidente
Schopenhauer si pone sulla stessa lunghezza d’onda dei cosiddetti ‘maestri del sospetto’ – Marx, Nietzsche e
Freud – che cercano di portare a fondo, attraverso la tecnica dello smascheramento, le impostazioni
ideologiche ingannevoli che proprio il filosofo ha il dovere di rivelare in modo da renderne evidenti le basi.
La critica dell’ottimismo è una critica all’Occidente che, schematicamente, si dipana attraverso il rifiuto
dell’ottimismo cosmico, sociale e storico.
1) Il rifiuto dell’ottimismo cosmico.
La cosa in sé è la Volontà irrazionale e senza scopo. La vita è forza irrazionale, il cosmo teatro della alogicità.
Se si conducesse il più ostinato ottimista attraverso gli ospedali, i lazzaretti, le camere di martirio
chirurgiche, attraverso le prigioni, le stanze di tortura, i recinti degli schiavi, per campi di battaglia e i
tribunali, aprendogli poi tutti i sinistri covi della miseria […] certamente finirebbe anch’egli con
l’intendere di qual sorte sia questo meilleur des mondes possibile. […] A me l’ottimismo, quando non sia
per avventura vuoto ciaciar […] sembra non pure un pensare assurdo, ma anche iniquo, un amaro
scherno dei mali senza nome patiti dall’umanità. (Il mondo … par. 59)
Il sistema hegeliano, come la religione in generale, non è che un tentativo consolatorio, e perciò falso, di
lenire il dolore. Il tentativo hegeliano di riproporre un cosmo razionale e un’armonia che si faccia valere
attraverso le mediazioni dialettiche è una menzogna che si inserisce in un puro tentativo consolatorio.
Dimensione puramente consolatoria è in definitiva la religione, che non è che “metafisica per il popolo.
Schopenhauer si pone, dunque, contro qualsiasi ottimismo cosmico basato sull’idea di un mondo perfetto
regolato da un essere superiore.
73
Si gettano, così, le basi per un pensiero fortemente ateo. D’altra parte, come sarebbe possibile che un Dio
perfetto abbia creato un mondo imperfetto, a tal punto colmo di irrazionalità e dolore?
Se un Dio ha creato questo mondo, io non vorrei essere Dio; l’estrema miseria del mondo mi
strazierebbe il cuore. (Il mio oriente)
2) Il rifiuto dell’ottimismo sociale.
Schopenhauer è convinto che l’uomo sia per sua natura conflittuale, nonostante egli abbia cercato di
nascondere questa sua inclinazione col progredire della civiltà.
Per questo motivo Schopenhauer è contro quella che egli chiama la menzogna della bontà connaturata
all’uomo. Gli uomini sono mossi dal desiderio di sopraffarsi reciprocamente, e si ritrovano a vivere
insieme non tanto per predisposizione caratteriale quanto per puro bisogno: insomma, si tratta dell’homo
homini lupus e della necessità del contratto delineato da Thomas Hobbes.
E lo Stato, icona hegeliana dell’eticità e della razionalità umana, si riduce a pura barriera contro gli istinti
dei singoli, sempre pronti ad aggredirsi l’un l’altro.
Vi è dunque, nel cuore di ogni uomo, una belva che attende solo il momento propizio per scatenarsi e
infuriare contro gli altri. […] Come l’uomo si comporti con l’uomo è mostrato, ad es., dalla schiavitù dei
neri […] Ma non v’è bisogno di andare così lontani: entrare nelle filande o in altre fabbriche all’età di
cinque anni, e d’allora in poi sedervi prima per dieci, poi per dodici, infine per quattordici ore al giorno,
ed eseguire lo stesso lavoro meccanico, significa pagar caro il piacere di respirare. (Parerga e
paralipomena, II)
3) Il rifiuto dell’ottimismo storico.
Schopenhauer è fortemente polemico nei confronti di qualsiasi tipo di storicismo. Egli è “disertore
d’Europa e della sua fede nella storia” (M. Scheler). E’ l’unico, tra i suoi contemporanei, a non
condividere la fiducia, per certi versi smodata, nel progresso e, appunto, nella storia. Schopenhauer è in
ciò avvisaglia di una crisi che porterà fino al nichilismo: è l’anima critica della cultura occidentale.
La storia non è una vera scienza, ma piuttosto una mera catalogazione dell’individuale, poiché essa non
può poggiarsi su leggi generali o concetti che fungano da “assiomi”. Infine, da qualsiasi punto di vista,
essa si rivela, in ultima analisi, poco utile. Se, infatti, si dà per assodato che l’uomo sia mutevole nel
tempo (concetto al quale Schopenhauer è avverso), allora non vi è alcuna possibilità di ottenere qualche
insegnamento dalle sue azioni passate, poiché il suo modo di pensare e i motivi che lo animano saranno
destinati a un continuo cambiamento. Se invece si riescono a cogliere i legami di fondo tra le varie fasi
della storia, se si riesce cioè a comprendere che l’animo dell’uomo è in qualche modo caratterizzato da
tratti immutabili, essa non diventa altro che una continua conferma della propria ripetitività, per cui è
insensato continuare a tenerla in conto come scienza.
Per Schopenhauer, quindi, la storia può essere considerata mutevole solo in superficie ed essa è, per il
resto, nient’altro che una “monotona sonata”. Oltre le apparenze “non vi è nulla di nuovo sotto il sole”
(Ecclesiaste, 1, 10); la storia dell’uomo nei suoi tratti salienti presenta sempre la stessa riproposizione di
tratti eterni.
Mentre la storia ci insegna che in ogni tempo avviene qualcosa di diverso, la filosofia si sforza di
innalzarci alla concezione che in ogni tempo fu, è sarà sempre la stessa cosa. (Il mondo … Supplementi,
cap. 38)
In questo senso, allora, è sufficiente leggere solo Erodoto per addottorarsi in storia!
Bisogna quindi passare dalla storia alla filosofia della storia, il cui compito è offrire all’uomo la
coscienza di sé e del proprio destino.
“La vita è dolore e la storia è cieco caso. Il progresso è un’illusione”: la storia non è, come pretende
Hegel, razionalità e progresso; ogni finalismo e qualsiasi ottimismo sono ingiustificati.
74
La liberazione dal dolore
Poiché per Schopenhauer la vita è sostanzialmente dolore, egli afferma che la volontà di vivere, la brama,
viene poco a poco rifuggita dall’uomo stesso.
Nella vita umana, come in ogni cattiva mercanzia, il lato esterno è mascherato con falso splendore:
sempre si cela ciò che soffre; mentre ciascuno quanto più interna contentezza gli manca tanto più
desidera nell’opinione altrui passare per felice. (Il mondo … par. 59)
Come si può evincere da tale passo, Schopenhauer riprende tutta la tradizione orientale (“Esistere è soffrire”)
e platonica (“È meglio non essere nati piuttosto che vivere”).
Il suicidio può essere un mezzo per sfuggire al dolore?
Una plastica rappresentazione di questa impostazione possiamo scorgerla, da una parte, nella visione
religiosa, dall’altra, ad es. nello stoico Seneca. Per la religione la vita è un dono di Dio e, dunque, a Lui
spetta toglierla. La posizione senecana è cristallina quanto ‘tagliente’: “Dire ciò significa non accorgersi che
si chiude la via alla libertà […] Ti piace la vita? Vivi. Non Ti piace? Puoi tornare donde sei venuto”. (Lettere
a Lucilio, n. 70)
Schopenhauer bypassa entrambe queste impostazioni ritenendo che il suicidio non è percorribile per due
motivi: a) “il suicidio, lungi dall'essere negazione della volontà, è invece un atto di forte affermazione della
volontà stessa” in quanto il suicida “vuole la vita ed è solo malcontento delle condizioni che gli sono
toccate” (Il mondo… par. 69); b) la morte di un singolo uomo è semplicemente l’eliminazione di una
manifestazione fenomenica della volontà di vivere, mentre la volontà in sé continuerà a rinascere nell’animo
di mille altri uomini, nella specie.
Non ci si sottrae al dolore ma lo si accetta “affinchè esso possa contribuire a spegnere la volontà di vivere”.
(par. 69) L’uomo ha come unica via d’uscita la liberazione dalla stessa volontà di vivere, che deve farsi
noluntas (non-volontà). Quando l’uomo, inabissandosi nel proprio intimo, arriva a capire che la realtà è
volontà e che egli stesso è volontà, allora è pronto per la sua redenzione, e questa si potrà ottenere “solo col
cessare di volere”. La volontà può sopprimere se stessa non con la violenza fisica ma con la noluntas!
Ci si può liberare dal dolore e dalla noia, sottrarsi alla catena infinita dei bisogni, attraverso l’arte, la pietà e
l’ascesi.
1) L’arte
L’arte, secondo Schopenhauer, è il primo passo del percorso salvifico dell’uomo, in quanto conoscenza
libera e disinteressata, ed è quindi un gradino sopra la scienza, irrigidita nei limiti delle forme di spazio e
tempo.
Nell’esperienza estetica, infatti, l’individuo si stacca dalle catene della volontà, si allontana dai suoi desideri,
annulla i suoi bisogni: non guarda gli oggetti per la loro utilità nel quotidiano. L’uomo, nell’esperienza
estetica, si annienta come volontà e si trasforma in puro occhio del mondo, si immerge nell’oggetto e
dimentica se stesso e il suo dolore.
Le arti si occupano, più che delle cose contingenti, delle idee eterne, cogliendo gli aspetti immutabili della
realtà in una visione in chiave quasi platonica. La purificazione dell’uomo avviene proprio a partire dalla
contemplazione di tali idee: l’uomo, contemplando la vita dall’esterno piuttosto che vivendola, viene
esonerato dal dolore, dal tempo e dallo spazio, dalla sua stessa volontà, diventando non più singolo, ma
figura dell’intera umanità, occhio del mondo.
Nell’intuizione estetica, l’intelletto infrange la sua servitù alla volontà, non è più lo strumento che ne procura
i mezzi per soddisfarla, ma puro occhio contemplante.
La forma più bassa di arte è l’architettura, che è manifestazione della volontà attraverso la materia
inorganica. Vengono poi la scultura, la pittura e la poesia, manifestazioni attraverso idee appartenenti al
mondo animale, vegetale e umano. Ai vertici abbiamo la tragedia, che è un’autorappresentazione del
75
dramma della vita, e la musica, considerata vera e propria “metafisica dei suoni”, in quanto strumento capace
di metterci in contatto, al di là della ragione, con le radici dell’essere.
Bisogna notare come Schopenhauer consideri l’arte come uno strumento che può estraniare l’uomo
dall’elemento propriamente naturale: egli vede nell’arte una materializzazione della cultura umana che può
sganciarci dal dolore del mondo; una costruzione puramente umana con cui noi possiamo fare a meno degli
elementi pratici. L’arte è la dimensione in cui possiamo tentare di essere noi stessi, in cui l’uomo tenta di
riappropriarsi della propria umanità.
Diversamente da quella brama di vivere, che è istintiva, c’è l’arte con cui l’uomo riesce ad essere
effettivamente animale culturale perché si sgancia in maniera disinteressata dai bisogni quotidiani per
inserirsi in una situazione culturale completamente diversa in cui si cerca l’oscuramento di una coscienza
dolorosa. L’arte, dunque, è liberatrice.
Questi momenti felici della contemplazione estetica in cui ci sentiamo liberati dalla tirannia furiosa della
volontà, però, sono istanti brevi e rapidi. L’arte dunque non è una via duratura per la liberazione, ma
temporanea, un breve incantesimo: essa è allora semplicemente conforto.
2) L’etica della pietà
L’etica è superiore all’arte in quanto implica un impegno a favore del prossimo. Il suo punto di forza sta
nella vittoria sull’egoismo che è insito nell’uomo. Essa nasce da un sentimento di ‘com-passione’, ovvero di
empatia verso le sofferenze altrui, che vengono sentite, quindi, come proprie.
Questa ‘compenetrazione’ dell’altro permette di sperimentare l’unità metafisica di tutti gli esseri andando a
costituire, di fatto, la base della coscienza umana. E’ un’unità totale in quanto tormentati e tormentatori sono
in realtà congiunti, poiché anche i malvagi soffrono attraverso il rimorso e l’angoscia per i loro misfatti.
La morale si divide in due fasi distinte, le virtù cardinali di giustizia e carità.
La prima ha carattere negativo di fondo, in quanto non è altro che astensione dal male e riconoscimento
dell’uguaglianza degli altri con noi stessi. La giustizia, infatti, dà, sì, un colpo all’egoismo, ma fa considerare
gli altri come distinti da sé e per questo non abbatte quel principium individuationis che fonda l’egoismo
dell’uomo e lo contrappone agli altri. Bisogna oltrepassare la giustizia e avere il coraggio di eliminare ogni
distinzione tra la nostra individualità e quella degli altri, aprendo gli occhi sul fatto che tutti siamo impastati
della medesima sventura.
Solo la seconda fase, quindi, ha effettivamente valore positivo, in quanto rappresenta la volontà attiva di
compiere il bene, ed è quindi amore autentico verso l’altro; il suo grado più alto consiste nell’assumere su di
sé l’intero dolore cosmico, facendosi carico delle sofferenze di ogni essere. Bontà che è, dunque,
compassione, un sentire l’altrui dolore attraverso la comprensione del nostro: “ogni amore (agape, charitas)
è compassione”. E’ perciò superiore ad ogni forma di eros che è mosso da un principio egoistico.
Ed è proprio la compassione che Schopenhauer pone a fondamento dell’etica. In ogni caso, però, anche la
pietas, cioè il compatire, è pur tuttavia un patire. E la via per sradicare in modo decisivo la volontà di vivere,
e quindi il dolore, è la via dell’ascesi, quell’ascesi che fa sentire Schopenhauer vicino ai saggi indiani.
3) L’ascesi
L’ascesi, il grado più alto di liberazione raggiungibile dall’uomo, si presenta migliore dell’etica, poiché
quest’ultima, pur rappresentando una vittoria sull’egoismo dell’uomo, è ancora legata alla vita terrena.
L’ascesi nasce dall’orrore dell’uomo per il mondo colmo di dolore e per la sua stessa volontà di vivere. Egli,
infatti, cerca in ogni modo di estirpare quest’ultima da sé stesso tramite “l’astensione del piacevole e la
ricerca del piacevole, l’espiazione e la macerazione spontaneamente scelta”.
L’ascesi, quindi, è caratterizzata da una serie di tappe: castità, povertà, rinuncia ai piaceri, digiuno, sacrificio,
umiltà... Insomma, da qualunque cosa possa liberare l’uomo dalla sua prorompente voglia di vivere. Con
l’atto ascetico, infatti, l’uomo costringe la sua coscienza, la sua natura, a comprimersi affinché si sganci
dall’elemento naturale, che agisce a sua insaputa, per cercare di “redimersi”. Schopenhauer crede che il
primo gradino per arrivare a questa macerazione della coscienza sia proprio la castità perfetta, poiché è ,
secondo una lunga tradizione, uno degli strumenti con cui si fustiga la coscienza e si cerca di padroneggiarla.
76
La soppressione della volontà di vivere, di cui l’ascesi è lo strumento, è l’unico atto di libertà possibile per
l’uomo, in quanto egli altrimenti non sarebbe altro che un semplice anello della catena della causalità. Se
invece questi riesce a separare la volontà di vivere da sé stesso, egli può sottrarsi dalla causalità stessa.
L’unico momento in cui l’uomo è libero è quello in cui rinnega la sua essenza naturale perché afferma in
massima parte la sua potenza soggettiva di essere contro e di essere oltre la natura che lo gestisce.
Il punto più alto dell’ascesi è rappresentato, coerentemente con la visione atea di Schopenhauer, non
dall’unione con un Dio, ma piuttosto dal raggiungimento del nulla, del nirvana di stampo buddhista. Non
trova spazio l’insistere sul rapporto con la filosofia indiana che viene, in genere, sopravvalutata. In effetti lo
stesso Schopenhauer ha, e a più riprese, smentito un rapporto stretto e ancor più genetico con la filosofia
indiana. Il suo è un rapporto che, indubbiamente, insiste sulle somiglianza, ma l’origine, l’elaborazione della
filosofia di Schopenhauer è tutta interna al pensiero Occidentale (I. Vecchiotti). Non è un caso che lo stesso
principio buddistico del Nirvana viene descritto anche nei termini dell’estasi di Plotino, di Scoto Euriugena,
di Meister Eckhart.
Il rimedio contro il dolore non può essere che la negazione della volontà di vivere, cioè la cosciente, libera
autonegazione della volontà; la sua totale assenza.
Come per il fenomeno kantiano Schopenhauer aveva ripreso il “velo di Maya”, così per l’autonegazione
della volontà di vivere si rifà al Nirvana, al distaccarsi dal ciclo della vita, al “non bruciar più” nel fuoco
della Volontà, dal Samsàra delle Upanishad. Non basta uscire dalla propria individualità attraverso l’amore
per gli altri e soffrire del dolore altrui, ma bisogna che nell’uomo sorga l’orrore per l’intimo essere del Tutto,
cioè la Volontà da cui sorge il dolore. Bisogna ritirarsi dal Tutto in modo che davanti a noi resti il nulla –
non nel senso del nulla in assoluto (nihil negativum), ma del nulla relativamente a qualcosa (nihil privativum
cioè “niente come privazione”). E’ l’ascesi che ci porta davanti al nulla (relativo).
Il nulla, dunque, non è da considerarsi come un’assenza materiale del mondo, un niente, ma piuttosto una
negazione del mondo stesso e della volontà che lo anima, ovvero la completa dissoluzione delle illusioni che
compongono la vita dell’uomo, tra le quali vi è l’identità dell’uomo stesso come singolo, come soggetto,
come io:
Quel che rimane dopo la soppressione completa della volontà è certamente il nulla per tutti coloro che
sono ancora pieni della volontà. Ma per gli altri, in cui la volontà si è distolta da se stessa e rinnegata,
questo nostro universo tanto reale, con tutti i suoi soli e le sue vie lattee è, esso, il nulla. (Il mondo …par.
71)
CONCLUSIONI
77
Schopenhauer, come una melagrana ricca di semi, ha influenzato una miriade di pensatori e tratti rilevanti
del pensiero filosofico da Darwin a Freud a Nietzsche. Diventa faticoso ricapitolare complessivamente la sua
posizione nella cultura contemporanea. La critica ha letto Schopenhauer in vari modi, finanche in chiave
religiosa.
Una lettura idealistica ne ha messo in rilievo soprattutto la concezione gnoseologica della rappresentazione e
dunque ha argomentato soprattutto sul lato puramente soggettivistico della filosofia di Schopenhauer.
La lettura realista, invece, ha insistito sul concetto di volontà per mettere in rilievo la curvatura
‘materialistica’ della filosofia del filosofo di Danzica ed è, anche, quella che sembra meglio coglierne
l’intero edificio filosofico e i fecondi sviluppi.
Il concetto di volontà è certamente dominante, il vero centro propulsore della sua filosofia. Si badi, la
volontà è, per Schopenhauer, il divenire delle cose prodotte senza alcuna legge. La Volontà è fuori del
dominio del principio di ragione ed è quindi assolutamente senza ragione. La Volontà è fuori dalla ragione!
Ecco il punto! Ecco il ciglio dell’abisso!
Lungo il tratto, amplissimo, che dai greci porta ad Hegel, noi abbiamo sempre concepito il divenire delle
cose come il modo in cui la ragione si manifesta, si oggettiva secondo un ordine. Ora, Schopenhauer, al
contrario, ci mostra che non esiste un ordine! La stessa ragione e verità sono all’interno di un processo senza
leggi e, dunque, all’interno di uno sviluppo senza direzione né senso. Ogni legge, e dunque ogni ragione e
verità, si da all’interno di una dimensione fenomenica in cui si oggettiva la Volontà.
Insomma, la ragione non può essere neanche il rimedio contro il dolore di un mondo che si muove verso il
nulla. La Volontà non può avere alcun fine. La Volontà è impulso cieco, irrazionale, non ha un’origine, né
una direzione, né uno scopo.
Schopenhauer ci mostra con ciò la verità che non riusciamo a sopportare: l’idea di un divenire che tutto
fagocita, ingoia e riporta nel nulla insensato! Da questo punto di vista, Schopenhauer, anticipando il
nichilismo nietzschiano, apre lo spazio entro cui oggi ci muoviamo. Da Schopenhauer parte in maniera
potente ciò che chiamiamo ‘il tramonto della ragione’ come rimedio contro il dolore che il divenire procura
continuamente fluendo nel nulla insensato.
Non possiamo però non riportare la lettura che di Schopenhauer fa il filosofo G. Lukács, con l’immagine
indelebile dell’Hotel Abisso che inquadra le filosofie irrazionaliste, pessimiste, nulliste fluire in una
estetizzante passività reazionaria:
il nulla come prospettiva, il pessimismo come orizzonte di vita, secondo l’etica di Schopenhauer […] non
può affatto impedire, e nemmeno rendere difficile all’individuo una condotta di vita piacevole e
contemplativa. Anzi l’abisso del nulla, il tetro sfondo dell’assurdità dell’esistenza, non fanno che
aggiungere un fascino piccante a questo godimento della vita. Questo fascino viene ulteriormente
accresciuto dal fatto che lo spiccato aristocraticismo della filosofia schopenhaueriana innalza i suoi
seguaci, nella loro immaginazione, di gran lunga al di sopra di quella plebe miserabile che è così ottusa
da lottare e soffrire per un miglioramento delle condizioni sociali. Così il sistema di Schopenhauer,
costruito, dal punto di vista architettonico formale, con molto impegno e senso della composizione, si
erge come un elegante e moderno hôtel fornito di ogni comodità, sull’orlo dell’abisso, fra piacevoli
festini e produzioni artistiche, non può che accrescere il gusto di questo comfort raffinato (La distruzione
della ragione, cap. II, 4).
Il pericolo è reale e, forse, Leopardi maggiormente si sottrae a questo destino con un più intenso interesse
‘civico’ come testimonia C. Luporini in Leopardi progressivo.
Dentro e dietro i fumi delle promesse della grande industria, di sorti progressive dell’Occidente,
Schopenhauer taglia le menzogne ideologiche e mostra che i fasti, così affascinanti, nascondono miserie,
infelicità, orrore. In ciò, Schopenhauer procede ad una vera e propria demistificazione di concetto-menzogna.
In questa prospettiva il pessimismo schopenhaueriano non è altro che l’aver descritto la vita com’è,
realisticamente, anche quando la sua penna affonda e fa male:
Noi siamo soltanto concime per futuri meloni.
78
La stessa storia, come narrazione dotata di senso, si ritrova svuotata.
Infine, è piacevole ricordare uno Schopenhauer sarcastico e affilatissimo: distruttore di dei!
Asini, il mondo, il mondo è il problema della filosofia, il mondo e nient’altro!
BIBLIOGRAFIA
Opere di Schopenhauer
Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, Laterza, 2009
Schopenhauer, O si pensa o si crede. Scritti sulla religione, Rizzoli, 2011
Opere su Schopenhauer
79
I. Vecchiotti, Introduzione a Schopenhauer, Laterza, 2005
SITI WEB:
http://www.emsf.rai.it/gadamer/interviste/24_schopen/schopenhauer.htm
~ NIETZSCHE
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
La vita e le opere
Interpretazioni del pensiero nietzschiano
Pensiero e modus operandi
Apollineo e dionisiaco
Storia e vita
La filosofia illuministica e genealogica
La morte di Dio e della metafisica
L’avvento del Superuomo
Zarathustra
L’eterno ritorno
Genealogia della morale
La volontà di potenza
L’ospite inquietante
Prospettivismo
~ CONCLUSIONI
80
NIETZSCHE
Il pensiero di Nietzsche getta le basi e permette l’affermarsi della concezione nichilistica della realtà,
demolendo vecchi concetti, attaccando anche convinzioni considerate fino ad allora veri e propri dogmi del
pensiero filosofico, arrivando, perfino, a dubitare del valore conoscitivo del Lógos.
La sua dottrina sancisce, però, al contempo la piena fiducia nelle capacità umane che, se ben incanalate,
potranno portare all’avvento di un qualcosa che è aldilà dell’uomo: un superuomo!
La filosofia di Nietzsche si scaglia contro l’idea della storia come progresso; del positivismo culturale e
scientifico dell’epoca fiducioso in uno sviluppo progressivo.
Nietzsche anticipa e poi affianca quella che viene definita la crisi dei fondamenti che caratterizza la seconda
metà dell’Ottocento e la prima metà del Novecento, che si esprime sinteticamente nella nascita delle
geometrie non-euclidee che aprivano scenari del tutto nuovi alla scienza, fino ad allora considerata perfetta.
Il filosofo ci porta con il nichilismo a vivere il nostro habitat, dove prende vita l’era della tecnica.
La vita e le opere
Friedrich Wilhelm Nietzsche nasce il 15 ottobre del 1844 a Rocken presso Lipsia.
Nietzsche comincia a scrivere poesie a dodici anni. Nel 1864 inizia gli studi di teologia, ma successivamente,
nel 1865, si trasferisce a Lipsia per seguire lezioni di filologia classica. E’ questo il periodo in cui legge Il
mondo come volontà e rappresentazione di Schopenhauer, restandone profondamente colpito: “qui vedevo la
malattia e la guarigione”.
A 24 anni ottiene la cattedra di Lingua e Letteratura greca all’università di Basilea. Qui conoscerà Franz
Overbeck e Richard Wagner, ed entrambi avranno un ruolo particolarmente importante per quanto concerne
la formulazione del suo pensiero filosofico.
Dal 1876 in poi, a causa di continui malesseri, Nietzsche è costretto a lasciare la cattedra e a vagare per
l’Europa in cerca di un clima migliore per la sua salute. A Torino dà i primi segni di squilibrio mentale. Le
sue precarie condizioni psico-fisiche si aggravano, portandolo alla pazzia proprio quando inizia a riscuotere
fama. Muore il 25 agosto del 1900 a Weimar.
Scritti importanti: La nascita della tragedia (1872), incontra subito l’astio dei filologi del tempo poiché mina
fortemente il concetto di classicità; Umano, troppo umano. Un libro per spiriti liberi (1878) segna il distacco
sia dal musicista che da Schopenhauer; La gaia scienza (1882); Così parlò Zarathustra (1883) pubblicata a
spese dell’autore; Al di là del bene e del male (1886); Genealogia della morale (1887).
La volontà di potenza (1901, I edizione) – raccolta di aforismi – viene pubblicato postumo dalla sorella
Elisabeth e Peter Gast.
Interpretazioni del pensiero nietzschiano
Diverse sono le critiche mosse alla filosofia di Nietzsche. Le due più screditanti sono indubbiamente la
correlazione tra il suo filosofare e la sua pazzia, che caratterizzò gli ultimi anni della sua vita e il rapporto
con il nazismo.
La prima critica parte dall’idea che o la filosofia nietzschiana sia il prodotto della sua malattia o, ancor
peggio, che la malattia sia stata il risultato della sua filosofia. Tale interpretazione di tipo positivistico è stata
81
successivamente rimpiazzata da quella avanguardista che al contrario vede nel malessere di Nietzsche lo
sprono che gli ha permesso di raggiungere tali vette del pensiero. Oggi tuttavia ogni tipo di critica mossa al
lavoro del filosofo considera del tutto futili e irrilevanti tali considerazioni: ciò che veramente conta è il
concetto, non come sia nato!
Per quanto riguarda la correlazione tra Nietzsche e il nazismo, la questione è più spinosa. Da un punto di
vista puramente cronologico, è impossibile un’adesione del filosofo al nazismo perché Nietzsche è morto
prima dell’ascesa al potere di Hitler. È indubbio che molte delle considerazioni nietzschiane erano in accordo
con l’ideologia del regime, tuttavia esse furono elaborate in maniera del tutto indipendente.
Molti critici hanno evidenziato il ruolo di Elisabeth, sua sorella, nella “nazificazione” di Nietzsche, tenendo
conto la sua adesione al nazismo, ricordando un incontro con Hitler proprio presso l’archivio, ma soprattutto
mostrando una serie di errori-falsificazioni nella prima edizione de La volontà di potenza. Malgrado delle
sue responsabilità in realtà, non tutto è attribuibile alla sorella: molti passi e concetti di Nietzsche si prestano
ad essere inglobati in una visione nazista, antiegualitaria, antidemocratica. Dunque la sua filosofia si presta
ad essere una filosofia reazionaria.
È nel secondo dopoguerra che viene attuata un’opera di denazificazione di Nietzsche. In alcuni casi tale
tendenza è addirittura sfociata in una visione di Nietzsche progressista. È superfluo affermare che, come
spesso accade, la verità risiede nel mezzo. Nietzsche non era il filosofo del nazismo, né tantomeno, però, le
sue idee possono essere accostate a quelle di K. Marx o F. Engels attraverso l’idea che il superuomo
prospetti metaforicamente una liberazione della moltitudine.
L’edizione più importante delle opere di Nietzsche che ha contribuito non poco a rispolverare il suo pensiero
è quella critica di Giorgio Colli e Mazzino Montinari (fine anni ’50) che hanno organizzato gli scritti nel
loro ordine cronologico definitivo restituendo molti aspetti inediti e modificando diverse interpretazioni
preesistenti.
Pensiero e modus operandi
Nietzsche distrugge i dogmi della filosofia fino ad allora vigenti. Il suo pensiero si pone come una frattura
insanabile con il passato e apre le porte per il mondo moderno. La vera grandezza del filosofo non sta infatti
nel semplice rinnego della tradizione. A cosa varrebbe eliminare la base su cui poggiamo senza trovarne
una nuova? Ogni critica, per quanto giusta, deve essere necessariamente costruttiva se non vuole essere
inghiottita dall’indifferenza e dall’oblio. Così, al vecchio dominio della divinità e di enti astratti, Nietzsche
sostituisce quello della vita e dell’uomo.
Un uomo che deve spingersi oltre i suoi limiti per divenire un superuomo o oltreuomo.
Da Umano, troppo umano in poi l’aforisma diviene la prassi per la comunicazione del pensiero filosofico
asistematico. Nietzsche paragona l’aforisma alle figure in rilievo: è possibile cogliere le cose narrate, ma sta
allo spettatore andare dietro di esse e in parte costruire l’impronta data. Per questo gli aforismi si prestano a
differenti interpretazioni e non è sufficiente la loro lettura per comprenderli fino in fondo. La forma breve
dell’aforisma, diversamente dall’incedere sistematico, tecnico austero del linguaggio filosofico (si veda
quello hegeliano) punta sull’illuminazione istantanea che precede quel “ruminare”, quel riflettere
conoscitivo.
In Così parlo Zarathustra lo stile si fa invece simile a quello della poesia prosaica o a quello adottato nei
Vangeli. Esposizione autobiografica e invettiva polemica prevalgono nelle ultime opere.
I vari stili evidenziano la compartecipazione del filosofo ai suoi scritti: “In tutte le opere che ho scritto, io ho
messo dentro anima e corpo: non so che cosa siano problemi puramente intellettuali”.
Altra caratteristica dello stile di Nietzsche è la sua asistematicità. Egli rifiuta un modo di filosofare
sistematico, in particolare quello proposto da Hegel, e in verità come aveva già firtemente denunciato
Feuerbach.
Il desiderio di inquadrare la realtà in un sistema è associato, secondo Nietzsche, alla volontà di potenza che
regola il mondo. Il volersi impadronire del Tutto diviene così qualcosa di assolutamente illusorio e destinato
al fallimento, perché risulta impossibile interpretare il mondo dominato dal caos con un sistema ordinato.
Nietzsche è un asistematico “scriba del caos” (F. Masini).
82
Apollineo e dionisiaco
La nascita della tragedia è un trattato filosofico in cui il giovane Nietzsche getta le basi per la formulazione
del suo pensiero.
Il tema portante dell’opera è la distinzione tra “apollineo e “dionisiaco”, due elementi tra loro contrastanti,
ma rappresentanti in pieno la cultura greca.
L’apollineo descrive il tentativo di mettere ordine al caos del mondo, cioè, di dare forma a ciò che è informe
attraverso l’armonia della scultura e della poesia epica. Apollineo è ciò che rifugge dal divenire delle cose.
Il dionisiaco è invece il disordine, ossia, la partecipazione completa al dramma della vita che si esprime
massimamente nella esaltazione creatrice della musica e nella poesia lirica. Dionisiaco è ciò che abbraccia e
si fonde con il divenire magmatico delle cose.
L’apollineo sta al dionisiaco come la forma al caos; la ragione all’istinto!
Ora, per Nietzsche - diversamente dal giudizio della filologia dominante che vedono nell’Ellade la culla
dell’apollineo, dell’equilibrio - il dionisiaco (asiatico) è il fondamento, della sensibilità greca. L’apollineo,
anzi, nasce per arginare, sublimare il caos dionisiaco. Il dionisiaco è portato a vedere il dramma terribile
della morte e gli aspetti raccapriccianti dell’essere. L’apollineo s’elabora come strumentazione contro il
dolore e l’atrocità della vita.
In un primo momento, i due impulsi convissero separati; poi nella tragedia attica (Sofocle, Eschilo) si
armonizzarono, si accoppiarono. L’arte successiva ha, invece, rotto quest’armonia, dando maggiore
importanza alla parte più razionale, cioè all’apollineo. Questa “crisi” si manifesta pienamente in Euripide,
che elimina dalla tragedia il mito e vi inserisce l’uomo comune. La decadenza della tragedia è direttamente
collegata all’apparire sulla scena filosofica di Socrate che, con il suo atteggiamento razionalistico, uccide la
vita fondata, al contrario, sull’istinto.
Socrate diventa il simbolo della filosofia, intesa come tentativo di mettere ordine nel mondo con il Lógos
attraverso la ricerca di una verità assoluta. Per Nietzsche ciò costituisce una pura violenza nei confronti
della vita, la quale è una forza straordinaria e indomabile che non segue nessuna regola e che non è possibile
incasellare in un ordine precostituito. In questo senso, Nietzsche riprende l’irrazionalità della volontà di vita
di Schopenhauer che non ha scopo e fine, ma muove tutto il mondo. Ne Il mondo come volontà e
rappresentazione Schopenhauer aveva rivelato che alzando il ‘velo di Maya’ delle apparenze scopriamo un
mondo vulcanico, caotico, irrazionale e senza scopo che corrisponde esattamente al principio dionisiaco di
cui parla Nietzsche.
Contro la decadenza dell’Occidente il dionisiaco ci salverà! Dioniso, dio dell’ebbrezza e della gioia, incarna
in Nietzsche l’accettazione totale del flusso della vita.
La critica a Socrate è, quindi, una critica alla filosofia: non esistono verità assolute e il Lógos, sebbene
sembri aver prodotto il meglio della cultura occidentale, non è uno strumento adatto alla conoscenza, anzi si
rivela nefasto nel momento in cui ci allontana dal caos della vita.
La consapevolezza dell’insensatezza della vita comporta il carattere doloroso della vita stessa, individuato
già da Schopenhauer e a cui, però, i due filosofi rispondono in maniera praticamente opposta. Se, infatti,
Schopenhauer fugge la vita attraverso l’ascesi che si configura come rinuncia alla stessa volontà di vita,
Nietzsche giunge alla consapevolezza che è necessario accettare la vita così com’è.
Dioniso diventa un modello del flusso della vita, vissuta senza freni e inibizioni, dove il caos regna
incontrastato e ogni atteggiamento è ambiguo: può significare una cosa come l’esatto contrario. Il dio è
quindi l’affermazione più completa della vita e del mondo.
Compreso ormai che il Lógos non ha alcun valore gnoseologico, Nietzsche arriva a dire che solo l’arte, in
particolare la musica, ci dà la possibilità di conoscere le verità della vita, e individua nella musica di Wagner
l’incarnazione dell’ideale tragico.
83
Il fenomeno dell’arte viene posto al centro; con esso e a partire da esso viene spiegato il mondo.” (E.
Fink, La filosofia di Nietzsche).
Storia e vita
Nel saggio Sull’utilità e il danno della storia per la vita, contenuto nelle Considerazioni inattuali (1874),
Nietzsche si mostra contrario a qualsiasi tipologia di storia. Per comprendere la posizione del filosofo
nichilista, è opportuno ricordare come fosse cambiata la storiografia con l’avvento del marxismo.
La storiografia tradizionale era un “minestrone” i cui ingredienti, gli avvenimenti, erano mescolati tutti
insieme, semplicemente impilati l’uno dietro l’altro non trovavano alcun fondamento e spiegazione, per cui
avevano tutti la stessa importanza ed erano parimenti determinanti e determinati.
Con la concezione materialistica di Marx per la prima volta viene fornito un metodo per “fare storia”: i fatti
sono ricondotti alla loro matrice economica attraverso la divisione di struttura e sovrastruttura. E’ così che è
possibile separare il grano dalla pula, la causa dall’effetto e dare un ordine alla storia.
La critica di Nietzsche è radicale e coinvolge anche l’impostazione marxista. La storia - come del resto aveva
affermato Schopenhauer - non è una scienza e il suo sviluppo non è affatto inquadrabile in nessun ordine. I
fatti stessi non esistono: ciò che gli storici ci forniscono sono solo interpretazioni, cioè visioni soggettive di
quanto è accaduto. Di conseguenza, la storia non può essere ascritta in un ambito scientifico, e non produce
nessuna conoscenza proficua.
Secondo Nietzsche esistono tre tipi di storia:
1) la storia monumentale dell’individuo che cerca la grandezza del passato per poterla riprodurre nel
presente;
2) la storia antiquaria di chi “guarda indietro con fedeltà e amore, verso il luogo onde proviene, dove
è divenuto”;
3) la storia critica di chi è capace di “infrangere e dissolvere un passato per poter vivere”.
Il tipo di storia a cui Nietzsche si sente più vicino è ovviamente l’ultimo, dal momento che la storia è
solamente un peso, una catena da cui liberarsi per poter vivere più intensamente il presente.
La storia, infatti, non può far altro che danneggiare l’uomo e comprimere le energie vitali.
La filosofia illuministica e genealogica
L’opera Umano, troppo umano dedicata a Voltaire, segna il passaggio dall’età giovanile al periodo che
viene definito “illuministico”, caratterizzato da una ritrovata fiducia nella ragione: la scienza rappresenta un
faro che illumina con il suo procedere razionale le tenebre della superstizione e della menzogna. La ricerca
scientifica si concretizza in un’aspra critica a tutta la cultura occidentale, condotta attraverso il metodo
genealogico, il cui scopo è liberare l’uomo dagli “errori” passati.
La svolta razionalistica comporta un allontanamento sia da Schopenhauer - che aveva cercato di liberarsi
dalla volontà di vita, attraverso la pratica ascetica e, più in generale, aveva visto una struttura irrazionale del
mondo -, sia da Wagner, la cui arte non sembra più fornire verità valide per l’uomo.
La filosofia del martello è la critica con cui vengono polverizzati i concetti e le categorie della cultura
occidentale che si credeva fossero eterni e immutabili, ed essa si esplica con il metodo genealogico, cioè un
metodo critico di tipo storico-genealogico.
Il metodo consta di due parti:
1) l’analisi storico-concettuale, con cui i concetti astratti sono riportati in una dimensione umana, cioè
nel loro ambito storico-culturale;
2) la critica demistificante, che mostra le motivazioni umane per cui i concetti hanno assunto una
determinata forma in una determinata epoca storica.
84
Questa istanza critica della filosofia – come abbiamo visto – trova un suo antecedente nell’analisi
antropologica di Feuerbach, ma ancor più esplicito e articolato lo si ritrova in Marx.
La critica demistificante, dunque, avvicina Nietzsche agli altri ‘filosofi del sospetto’, tra cui Schopenhauer,
Marx e Freud, i quali si impegnano in un'opera di smantellamento delle certezze legate al pensiero
occidentale. All’interno dei concetti e delle idee-valori, infatti, esistono delle motivazioni umane, “ahi troppo
umane”.
Il “troppo” indica che, a un’analisi più approfondita del concetto, esso stesso non è più da considerarsi
eterno, né tantomeno, “sovrumano” ma, anzi, risponde a esigenze concrete degli uomini. Tutti i concetti e
delle idee-valori sono, dunque, prodotti storici che rispondono a bisogni e interessi. Bisogna che si analizzino
le idee, i valori, i sentimenti come “una chimica delle idee e dei sentimenti” che metta capo da una parte alla
demistificazione, cioè mostrando come da idee semplici e bisogni si elaborino concetti ‘nobili’; dall’altra
bisogna mostrare il loro carattere “dialettico”, o meglio il ruolo dinamico che ha avuto il negativo nella
elaborazione di quel concetto.
La filosofia illuministica e genealogica di Nietzsche si rappresenta con le figure dello spirito libero e della
filosofia del mattino.
Lo spirito libero si raffigura con la figura del viandante che, grazie ad una gaia scienza, alla libera ricerca,
riesce a liberarsi ed emanciparsi dal passato e dalle certezza assolute, tra cui in particolare la morale e la
metafisica. Tale processo porta a quella che Nietzsche chiama filosofia del mattino in cui l’uomo vive la
vita come transitorietà e libero esperimento: che si traduce come semplice possibilità.
Chi anche solo in una certa misura è giunto alla libertà della ragione non può poi sentirsi sulla terra
nient’altro che un viandante. (Umano, troppo umano)
Mentre Nietzsche si occupa della morale negli ultimi scritti, affronta la questione della metafisica con
l’annuncio della morte di Dio nella Gaia Scienza che è la critica più completa di questo errore.
La morte di Dio e della metafisica
La metafisica è un errore dell’umanità.
Quando Nietzsche discute della morte di Dio non bisogna pensare che sia solo una metafora della metafisica
ma anche della reale impossibilità di credere ancora in un Dio, la cui esistenza è ormai superflua nella nostra
epoca.
Se, infatti, del Medioevo non si poteva scrivere la storia senza tenere conto delle implicazioni dell’intervento
divino, oggi parlare di Dio è un ostacolo alla corretta comprensione della realtà.
Davanti a un cosmo disordinato che si mostra informe e senza regole, Dio rappresenta la ricerca disperata di
ordine, il tentativo inutile di contrastare la durezza dell’esistenza:
C’è un solo mondo ed è falso, crudele, contraddittorio, corruttore, senza senso. […] Noi abbiamo
bisogno della menzogna per vincere questa realtà, questa ‘verità’, cioè per vivere. (Frammenti postumi)
La paura del caos rappresenta, in ultima analisi, la paura della morte che, a sua volta, nasce dall’idea che il
nostro essere possa essere fagocitato e distrutto dal nulla.
Di fronte al caos, l’uomo rimane, dunque, pietrificato dal dolore e crea l’immagine di Dio che, in un primo
momento, lenisce le sofferenze, ma risulta poi funesta poiché ci allontana dalla vera essenza della vita e del
mondo. Come la filosofia, infatti, anche la religione rappresenta una forzatura, una violenza nei confronti
della vita, perché acquieta la forza straordinaria della vita stessa arrivando addirittura alla sua uccisione.
85
L’idea di Dio risulta essere, quindi, “la nostra più lunga menzogna” per poter controllare il caos del
mondo. L’uomo pietrificato davanti alla forza del caos ha escogitato l’idea di Dio per potersi quietare, per
trovare senso davanti al vuoto incombente.
Per Nietzsche non è più necessario dimostrare la non-esistenza di Dio attraverso una prova teorico-filosofica
perché è ormai rivelato l’inganno, sia attraverso la sua riduzione ad antropologia - come aveva già fatto
Feuerbach - ma anche, semplicemente, davanti alla insensatezza caotica del mondo - come aveva mostrato
Schopenhauer. Non si può che essere atei!
Un tempo si cercava di dimostrare che Dio non esiste, oggi si mostra come ha potuto avere origine la
fede nell’esistenza di Dio, e per quale tramite questa fede ha avuto il suo peso e la sua importanza: in
tal modo una controdimostrazione della non esistenza di Dio diventa superflua. (Nietzsche, Aurora)
Nella Gaia scienza il messaggio “Gott ist tot!” (“Dio è morto!”) è annunciato con toni fortemente
drammatici dall’uomo folle:
Il folle uomo balzò in mezzo a loro e li trapassò con i suoi sguardi: “Dove se n’è andato Dio? – gridò – ve
lo voglio dire! Siamo stati noi ad ucciderlo: voi e io! Siamo noi tutti gli assassini! Ma come abbiamo fatto
questo? Come potemmo vuotare il mare bevendolo fino all’ultima goccia? Chi ci dette la spugna per
strusciar via l’intero orizzonte? Che mai facemmo, a sciogliere questa terra dalla catena del suo sole?
Dov’è che si muove ora? Dov’è che ci muoviamo noi? Via da tutti i soli? Non è il nostro un eterno
precipitare? E all’indietro, di fianco, in avanti, da tutti i lati? Esiste ancora un alto un basso? Non stiamo
forse vagando come attraverso un infinito nulla? Non alita su di noi lo spazio vuoto? Non si è fatto più
freddo? Non seguita a venire notte, sempre più notte? Non dobbiamo accendere lanterne la mattina?
Dello strepito che fanno i becchini mentre seppelliscono Dio, non udiamo dunque nulla? Non Fiutiamo
ancora il lezzo della divina putrefazione? Anche gli dei si decompongono? Dio è morto! Dio resta morto!
E noi lo abbiamo ucciso! Come ci consoleremo noi, assassini di tutti gli assassini? Quanto di più sacro e
di possente il mondo possedeva fino ad oggi, si è dissanguato sotto i nostri coltelli; chi detergerà da noi
questo sangue? […] Vengo troppo presto – proseguì – non è ancora il mio tempo. Questo enorme
avvenimento è ancora per strada e sta facendo il suo cammino: non è ancora arrivato fino alle orecchie
degli uomini. Fulmine e tuono vogliono tempo, il lume delle costellazioni vuole tempo, le azioni
vogliono tempo, anche dopo essere state compiute, perché siano vedute e ascoltate. […] Che altro sono
queste chiese, se non le fosse e i sepolcri di Dio?” (La Gaia scienza, 125)
“Che altro sono queste chiese, se non le fosse e i sepolcri di Dio?”. “Dio è morto. Dio resta morto!” La
chiesa, in quanto istituzione, non è altro che la testimonianza di un passato ormai superato, che non ha più
ragione di esistere. Eppure l’uomo sembra non riuscire ad accettare tale verità e a superare la vertigine del
nulla, cioè la mancanza dei valori e di un senso dell’esistenza: “Vengo troppo presto […] non è ancora il
mio tempo”. La morte di Dio è il processo di secolarizzazione che si compie lentamente sotto i nostri occhi,
per cui la storia si spoglia degli orpelli religiosi e diventa sempre più laica. Questo fenomeno, tuttavia,
incontra la resistenza delle masse, cosicchè occorrono secoli affinché questa idea possa essere
definitivamente accettata: i popoli poveri di filosofia credono e crederanno ancora a lungo nell’esistenza di
Dio, perché ne hanno bisogno. Le religioni sopravvivranno ancora a lungo nonostante si mostrino come
sciocchezze, bagatelle finanche al semplice buon senso.
Quando una mattina di domenica sentiamo rimbombare le vecchie campane, ci chiediamo: ma è mai
possibile! Ciò si fa per un ebreo crocifisso duemila anni fa, che diceva di essere il figlio di Dio. (Umano,
troppo umano).
Eppure, queste menzogne continuano ad esistere:
Nella vecchia Europa, mi sembra che anche oggi sia pur sempre la maggioranza ad avere necessità del
cristianesimo, perciò esso continua sempre a trovare chi gli presta fede. Così infatti è l’uomo: anche se un
86
articolo di fede potesse essere mille volte confutato – posto che egli lo sentisse necessario -, continuerebbe
sempre a tenerlo per ‘vero’. (La gaia scienza)
La morte di Dio, intanto, ha cassato via l’intero orizzonte! Non esiste più una destra, una sinistra, un alto, un
basso! Insomma, il cielo, ripulito dalla grande menzogna, ha annichilito le costellazioni che ci indicavano il
cammino!
L’avvento del Superuomo
Dio è morto e tutta la configurazione concettuale della realtà è crollata insieme alla metafisica. Davanti a noi
ritorna un cosmo tutt’altro che ordinato e benefico, bensì - come aveva già rilevato Schopenhauer - senza un
senso e una direzione.
La religione, la metafisica sono stati rimedi che si son rivelati peggiori del male!
Questa consapevolezza non comporta però la perdita di senso delle azioni umane ma, anzi, apre davanti
all’uomo infinite possibilità.
La morte di Dio è l’atto di nascita del superuomo! La morte di Dio è la condizione del superuomo! E’ in
questa assenza, in questa voragine che compare sulla scena il superuomo. In questa assenza di costellazioni
che ci indicano il cammino è possibile avanzare ‘per l’alto mare aperto’. Dio è morto, tutto è possibile!
Noi filosofi e “spiriti liberi”, alla notizia che il vecchio Dio è morto, ci sentiamo come illuminati dai raggi di
una nuova aurora; il nostro cuore ne straripa di riconoscenza, di meraviglia, di presentimento, d’attesa –
finalmente l’orizzonte torna ad apparirci libero, anche ammettendo che non è sereno – finalmente
possiamo di nuovo scioglier le vele alle nostre navi, muovere incontro a ogni pericolo; ogni rischio
dell’uomo della conoscenza è di nuovo permesso; il mare, il nostro mare, ci sta ancora aperto dinanzi,
forse non vi è ancora mai stato un mare così “aperto”. (La gaia scienza)
Nel viaggio di cui parla Nietzsche tutto è possibile, poiché l’annichilimento della cultura occidentale
permette la scoperta di nuovi orizzonti culturali, di nuove dimensioni culturali in cui progettare
l’esistenza al di fuori di una struttura metafisica.
Morti sono tutti gli dei: ora vogliamo che il superuomo viva. (Nietzsche, Così parlò Zarathustra)
Per scongiurare il ritorno a qualsiasi tipo di metafisica, Nietzsche non vuole semplicemente la morte di Dio,
ma anche di ogni suo ipotetico surrogato, e con quest’ultimo si può intendere qualsiasi tipo di certezza.
Surrogati di Dio sono lo Stato, la morale, la verità, la scienza, il socialismo, ecc. cioè tutte quelle altre ideedivinità a cui gli uomini orfani si prostrano, che devono essere assassinati senza riverenza alcuna per poter
fare conoscenza veramente con il flusso della vita, il caos dionisiaco.
L’intento di Nietzsche è arrivare a una ‘maggiorazione’ della vita attraverso un pieno adeguamento alla vita
stessa, eliminando tutto ciò che è estraneo alla vita reale e che sfocia quindi nella metafisica. Scopo
dell’uomo è raggiungere dunque l’ateismo assoluto:
l’ateismo assoluto, onesto è […] una vittoria finale e faticosamente conquistata dalla coscienza europea,
in quanto è l’atto più ricco di conseguenze di una bimillenaria educazione alla verità, che nel suo
momento conclusivo si proibisce la menzogna della fede in Dio. (Aurora)
La morte di Dio coincide con la morte della metafisica e il definitivo tramonto del platonismo: metafisica
par exellence! Il platonismo rappresenta per Nietzsche l’origine della metafisica, perché ha il demerito di
aver separato il mondo reale dalle idee, sublimando concetti storici in concetti imperituri ed eterni
87
nell’iperuranio. A partire da Platone i filosofi hanno dovuto fare i conti con una prospettiva dualistica del
mondo che solo il superuomo sarà, secondo Nietzsche, capace di schiantare!
Zarathustra
Così parlò Zarathustra è l’opera che contraddistingue il periodo della filosofia del meriggio, terza e
penultima fase della speculazione nietzschiana. I temi portanti sono il mito del superuomo, l’eterno ritorno
dell’uguale e la volontà di potenza, ovvero, il nucleo principale della asistematica riflessione del filosofo,
spirito libero che si sgancia dall’“oltremondo” per approdare verso orizzonti nuovi, non precostituiti, e
perdersi nel mare aperto delle possibilità, dopo aver “ucciso” Dio.
Zarathustra è stato, per Nietzsche, il primo a rendere la morale in termini metafisici cosicchè a lui spetta
ravvedersene per prima:
Zarathustra ha creato questo errore fatale, la morale, di conseguenza egli deve essere anche il primo a
riconoscere quell’errore. (Zarathustra).
Zarathustra è l’alter-ego di Nietzsche! Zarathustra è il profeta del superuomo: lo annuncia!
Il superuomo (Übermensch) rappresenta la compiuta realizzazione del pensiero di Nietzsche, il concetto
filosofico dominante che proprio a partire dalla morte di Dio, si prefigura come possibile “salvezza” per
l’uomo occidentale che, denudato dalle sue fallaci e illusorie certezze, deve ora reinventarsi e costruirsi da
sé. Il superuomo di cui si parla è, perciò, un uomo che si inchina alla vita, accettandone la tragicità ed
emancipandosi dalla sfera morale e dalla dimensione religiosa, e che fa propria la prospettiva dell’eterno
ritorno (ciclicità degli eventi).
“L’uomo è una corda tesa tra la bestia e il superuomo”. Il superuomo è colui che è capace, al di là di tutto,
senza nessuna guida, di dire sì al flusso della vita alla dimensione dionisiaca dell’esistenza, senza accettare
sovrastrutture di tipo ideologico. Chi si adegua al flusso degli eventi e al fatto che Dio è morto. Il superuomo
è chi adegua le pulsioni vitali con la vita stessa, senza ricercare esempi altrove, ma si muove solo nella sua
dimensione.
Nietzsche tiene molto a sottolineare il rapporto superuomo-terra, basato su una fedeltà che il superuomo deve
alla terra e a nessun’altra “sovraterrena speranza”.
Vi scongiuro, fratelli, rimanete fedeli alla terra e non credete a quelli che vi parlano di sovra terrene
speranze! Lo sappiano o no: costoro esercitano il veneficio. (Prefazione, Zarathustra)
In questo modo il filosofo sta mettendo praticamente a tacere ogni supposizione inspiegabile che presume
l’esistenza di un’anima che viva nell’ultraterreno.
L’uomo è corpo, null’altro! Pertanto, egli non è alla ricerca più di alcuna dimora che si trovi nell’aldilà, ma
la sua esistenza trova senso nell’espressione della sua libertà terrena. Zarathustra in uno dei suoi primi
discorsi racconta proprio di come il superuomo per divenire tale subisce tre metamorfosi:
“Lo spirito diventa cammello, e il cammello leone, e infine il leone fanciullo” (Delle tre metamorfosi):
Il cammello è l’uomo ancora legato alle tradizioni e al culto di certezze oltremondane;
Il leone rappresenta l’uomo che si libera della sfera metafisica, rigettandola. Il suo rapporto con la
libertà non è però ancora completamente definito. Si tratta di una volontà negativa.
Il fanciullo costituisce, invece, la creatura dionisiaca che si sente realizzata nella sua accettazione
della vita. E’ il superuomo, spirito libero, che si muove alla stregua della sua libertà, verso orizzonti
“involati”.
88
Il superuomo è stato diversamente interpretato. Una interpretazione che possiamo definire di destra lo
“legge” come uomo eccezionale, super-uomo anche in senso biologico, élite; un’interpretazione di ‘sinistra’
traduce Übermensch con oltre-uomo (Vattimo) per poi in certi casi arrivare addirittura ad affiancare
Nietzsche e Marx: superuomo = umanità liberata.
In realtà in Nietzsche, al di là delle metafore, delle parabole, ecc., il superuomo ha effettivamente notevoli
tratti che lo configurano come élite, “razza dominatrice” che esprime il suo elitarismo con la schiavitù della
massa inferiore. E’ evidente come in questa figura si condensi un atteggiamento antiegualitario e
antidemocratico che successivamente doveva essere sfruttato dalla propaganda nazista.
L’eterno ritorno
Folgorato durante una passeggiata a Sils Maria, in Engadina, nel 1881 Nietzsche arriva alla intuizione
dell’eterno ritorno dell’uguale: “il più abissale dei miei pensieri”.
Nell’aforisma 341 della Gaia scienza si pone il dilemma di cosa accadrebbe se un demone ponesse ad un
uomo una “eterna sanzione”:
L’eterna clessidra dell’esistenza viene sempre di nuovo capovolta e tu con essa, granello della polvere?
(Gaia scienza, 341)
L’uomo sarebbe terrorizzato da una vita che si ripeterebbe uguale in “ogni dolore e ogni piacere” e stritolato
da questo peso per le future scelte. Al contrario, una gioia pervaderebbe il superuomo che ama la vita,
accetta totalmente la vita. Come nella Fenomenologia di Hegel il signore diventa tale perché non ha paura
della morte, così in Nietzsche chi accetta la vita nella sua totalità con il suo aspetto dionisiaco diventa
superuomo.
Un’altra suggestiva formulazione si trova in Così parlò Zarathustra. Un serpente nero entra nella bocca di
un pastore, forse mentre sta dormendo, e il giovane rischia di essere soffocato. Allora Zarathustra gli grida
di mordergli la testa, di staccargliela.
Lontano da sé sputò la testa del serpente e balzò in piedi. – Non più pastore, non più uomo – un
trasformato, un circonfuso di luce, che rideva! Mai prima al mondo aveva riso un uomo, come lui rise!
(Così parlò Zarathustra)
Con tutta evidenza il serpente rappresenta il circolo, il tempo che ritorna, l’eterno ritorno dell’uguale. Il
giovane pastore è l’uomo che diventa superuomo: il ridente circonfuso di luce. Il passaggio è reso possibile
proprio perché il giovane pastore vince la ripugnanza dell’eterno ritorno, staccando la testa al serpente a
significare l’accettazione totale della vita.
Come si può vedere Nietzsche ritorna ad una concezione greca, presocratica, e comune alle antichissime
culture indiane: al tempo ciclico! “Ricurvo – dice Zarathustra – è il sentiero dell’eternità”.
I Greci non mettono mano ad una filosofia della storia dato che sono impegnati nella ricerca delle forme che
permangono. Il divenire della natura, dell’uomo stesso sembra loro qualcosa di accidentale, esteriore. Il
divenire delle cose si inserisce in uno schema circolare dove tutto si ripete all’infinito.
Con il cristianesimo si apre una nuova concezione del tempo e della storia. Il cristianesimo avversa qualsiasi
impostazione pagana e atea della ripetizione infinita dei cicli. Alla visione ciclica viene opposta una visione
lineare del tempo. La storia viene vista non più come una serie di avvenimenti insensati, ma dotati di senso,
cioè come una totalità dotata di senso e di scopo! Questo senso del tempo e della storia hanno, per la prima
volta, una prima ampia formulazione e applicazione in Agostino con l’opera La città di Dio in cui istituisce
un parallelo tra le sei epoche della storia dell’umanità e i sei giorni della creazione. La storia ha un
significato: gli avvenimenti non s’impilano uno dietro l’altro in maniera casuale, ma secondo un ordine, un
disegno, in una direzione, dunque, secondo uno scopo. In Agostino questo tempo lineare, rappresentato come
una freccia scagliata verso un obiettivo, si muove secondo lo schema Eden – caduta – redenzione.
89
La storia, complessivamente, si configura come storia della salvezza dove, ovviamente, gli eventi si ripetono
una sola volta. Cosa ne sarebbe della figura di Cristo in croce – polemizza Agostino versus i pagani – nel
tempo circolare? Cristo sarebbe ridotto a mero attore che prova all’infinito il sacrificio della croce!
Ora è facile vedere in questo incedere triadico, lo schema escatologico (“fine ultimo”) che informerà la
riflessione filosofica hegeliana anche se i termini propriamente teologici si affievoliscono in quelli
“secolarizzati” di Ragione, Spirito.
La dottrina dell’eterno ritorno è stata diversamente interpretata giacchè lo stesso Nietzsche ne ha dato diverse
prospettive. A tratti sembra che l’eterno ritorno poggi su una spiegazione scientifica che vede la energiamateria finita muoversi in un tempo infinito cosicchè le combinazioni della energia-materia devono
necessariamente ripetersi.
Un’altra interpretazione parte, invece, dall’impatto che l’eterno ritorno ha sulla dimensione etico-esistenziale
dell’uomo: un selettore di scelte che prescrive di amare la vita e di agire, appunto, come se tutto dovesse
ritornare.
Ancora, l’eterno ritorno e la circolarità del tempo è la critica, di fatto, all’idea positivistica (comtiana) di uno
sviluppo lineare dove sviluppo viene inteso sostanzialmente come progresso.
Nonostante le difficoltà interpretative risulta tuttavia chiaro, netto il rifiuto del tempo lineare cristiano. Vi è il
rifiuto di pensare che ogni attimo sia in funzione del successivo sicchè mai ad es. è possibile la felicità
perché sempre si sposta in un senso futuro. Il tempo lineare è un tempo d’angoscia giacchè il senso è sempre
spostato sull’asse del futuro. Al contrario per Nietzsche ogni attimo è in se stesso sferico, pieno!
L’eterno ritorno, in ogni caso, con il suo tempo ciclico riporta alla fedeltà alla terra contro qualsiasi
aspirazione oltremondana. Il senso dell’essere è tutto nell’essere, non c’è nessun fuori, oltre: nessun
iperuranio è in agguato! Il tempo è solo l’incedere “innocente” e “dionisiaco” delle cose.
Infine, l’eterno ritorno, invita e, ad un tempo, mostra la coincidenza di essere e senso. Ogni attimo come tutto
pieno è anche il senso e ciò è la sola possibilità di poter realizzare “la felicità del circolo”.
Genealogia della morale
Nell’ultimo Nietzsche la filosofia del martello manda in frantumi le credenze dominanti, le menzogne.
Innanzitutto bisogna partire dalla morale, dalla morale come problema.
Abbiamo bisogno di una critica dei valori morali, di cominciare a porre una buona volta in questione il
valore stesso di questi valori. (Genealogia della morale)
Nietzsche mette in discussione la morale attraverso un’indagine genealogica, che evidenzia gli elementi
storici, culturali e psicologici che hanno dato vita alla morale stessa e ne hanno determinato la sua funzione
all’interno della società umana.
I concetti etici non sono eterni, ma storici, e in quanto tali nascondono al loro interno interessi sordidamente
umani, “cose umane, ahi troppo umane”. La pretesa naturale ed astorica di una “voce della coscienza”, di una
“voce di Dio in petto” è assolutamente falsa: essa non è altro - anticipando Freud - che la forma
dell’educazione inculcata dalle autorità sociali.
In particolare Nietzsche individua nella morale una delle espressioni con cui si presenta la volontà di
potenza, anche nel senso della sua forma più bieca, cioè come volontà di sopraffazione, di dominio umano.
In ultima analisi l’etica si dimostra infatti utile per il mantenimento e il rafforzamento delle forme di
dominio umano.
La trascendenza della morale è soltanto un’illusione, perché essa in realtà non è altro che una creazione
dell’uomo divinizzata e presentata come eterna. Le verità che essa ci propina non sono che menzogne al pari
dell’esistenza di Dio.
90
E’ necessaria quindi una trasvalutazione dei valori:
la mia verità è tremenda: perché fino a oggi si chiamava verità la menzogna. Trasvalutazione di tutti i
valori: questa è la formula per l’atto con cui l’umanità prende la decisione suprema su se stessa, un
atto che in me è diventato carne e genio. (Ecce homo)
Nella sua analisi storica, Nietzsche distingue due forme diverse di morale: quella dei signori, che
apparteneva la mondo greco, e quella degli schiavi, propria del cristianesimo.
La morale dei signori rappresenta in pieno tutte le energie vitali dell’uomo, e quindi la forza, la salute fisica
e psichica, la gioia, la fierezza, e predica l’abbandono totale al flusso della vita, la piena accettazione del
caos del mondo. Una morale di questo tipo predilige l’espressione del corpo su quella dello spirito.
L’avvento del cristianesimo ha però spinto la morale in tutt’altra direzione, improntandola a valori
antivitali, quali il sacrificio di sé, l’abnegazione o il disinteresse. Ciò si spiega con l’instaurazione, ad opera
dei sacerdoti, di una sorta di dittatura del pensiero, che impone la superiorità dello spirito sul corpo non
potendo certo competere con i guerrieri sul piano della forza. La dualità corpo-spirito, di derivazione
platonica, viene decisamente marcata e rafforzata in una concezione che fa della materia e del corpo, un
elemento transeunte e inessenziale, e dello spirito una sostanza immutabile, eterna, necessaria.
Il cristianesimo rappresenta la massima espressione della morale degli schiavi, cioè di coloro che
sopprimono la volontà di potenza con un’imposizione del pensiero, allo scopo di contrastare la morale
dell’elite dei guerrieri. Con il cristianesimo la vita si è posta contro la vita! Il cristianesimo ha celebrato
valori antivitali. Ciò è cominciato con il popolo ebraico che in maniera sistematica ha rovesciato i valori
guerrieri nella apologia del debole e del deforme:
i miserabili soltanto sono i buoni; solo i poveri, gli impotenti, gli umili sono i buoni; i sofferenti, gli
indigenti, gli infermi, i deformi sono anche gli unici devoti. (Genealogia della morale)
A questo punto Nietzsche si occupa di stabilire quali siano state le conseguenze a livello psicologico della
soppressione degli impulsi istintuali e vitali. Innanzitutto si rende conto che la concezione del peccato ha
creato un uomo malato, preso continuamente dai sensi di colpa. Il cristiano è infatti costretto in una camicia
di forza, la morale degli schiavi, che naturalmente non gli appartiene. La limitazione delle sue energie vitali
causa un autotormento, che si concretizza non solo nella macerazione del proprio essere, ma anche nel senso
del rimorso e poi del risentimento, causa, quest’ultimo, dell’aggressività e di veri comportamenti violenti
come le guerre religiose testimoniano.
Per Nietzsche la simpatica figura di Gesù – “santo anarchico” anche se un po’ “idiota” – si sarebbe rivoltato
contro qualsiasi istituzione:
La Chiesa è esattamente ciò contro cui Gesù ha predicato e contro cui egli ha insegnato ai suoi discepoli
a combattere. (Ecce homo)
Non rimane al filosofo che essere legislatore di una nuova morale che insegni i valori vitali. I veri filosofi
sono dominatori e legislatori! A partire dagli operai scientifici della filosofia, tra cui nientemeno, Kant ed
Hegel, i veri filosofi dicono: “così deve essere!” (Al di la del bene e del male!)
La volontà di potenza
La volontà di potenza è uno degli elementi più controversi della filosofia nietzschiana, al punto tale che ha
permesso una lettura del filosofo in entrambi gli schieramenti politici, la destra e la sinistra, sebbene, in
91
realtà, il suo pensiero non sia catalogabile entro tali angusti schemi. Indubbi, in ogni caso, elementi che si
caratterizzano come antiegualitari, reazionari, che inneggiano al dominio sugli schiavi, ecc.
La volontà di potenza è per Nietzsche l’”intima essenza dell’essere”. La vita è autoaffermazione! Da un
punto di vista individuale, la volontà di potenza è quell’elaborazione o processo attraverso cui si esprime la
propria identità. L’affermazione di se stessi, il riconoscimento della propria identità è – prendendo a
prestito la terminologia hegeliana – un uscire fuori di sé e un ritornare in sé trovando nell’altro lo specchio
della propria identità. Detto in altri termini il processo identitario si manifesta attraverso la mediazione con
un altro essere, che in Nietzsche si risolve con la autoaffermazione-sopraffazione dell’altro.
Trattenerci reciprocamente dall’offesa, dalla violenza, dallo sfruttamento, stabilire un’eguaglianza tra la
propria volontà e quella dell’altro: tutto questo può diventare una buona costumanza tra gli individui
[…]. Ma appena questo principio volesse prendere ulteriormente terreno, addirittura, se possibile,
come principio basilare della società, si mostrerebbe immediatamente per quello che è: una volontà di
negazione della vita, un principio di dissoluzione e di decadenza. (Al di là del bene e del male)
E’ chiaro che questa visione implica una visione elitaria in cui c’è “bisogno della schiavitù” e una
differenziazione gerarchica affinchè vi sia un progresso della società verso il superuomo. Ogni progresso è
stato, secondo Nietzsche, “opera di una società aristocratica” come di una società che crede nella
“differenziazione tra uomo e donna” (in Così parlò Zarathustra, aveva detto: “Vai da una donna? Non
dimenticare la frusta!).
Ogni lotta per uguaglianza dei diritti è già un sintomo di malattia. (Ecce homo)
E’ possibile comunque interpretare il processo identitario del superuomo come libera progettazione: ognuno
è creatore della propria vita e ha una libertà di produzione che non rispetta nessun ordine prestabilito. Anche
per questo Nietzsche individua nell’arte un elemento fondamentale. L’arte, come trasvalutazione del reale,
ci avvicina a ciò che vogliamo, sia nella rappresentazione dell’individuo che nei nostri desideri, ed è sempre
un elemento che ci porta al di là delle conoscenze certe. L’artista può essere considerato quindi la “prima
visibile figura dell’oltreuomo”. (Vattimo)
Infine, è possibile interpretare il concetto di volontà di potenza, dal punto di vista dell’intera specie umana,
come la manifestazione della volontà dell’uomo di creare una rete di concetti tale da ‘pescare’ il mondo e di
tenerlo ‘irretito’ in un ordine razionale. Le leggi che l’uomo crea in realtà non rappresentano che il vano
tentativo di spiegare il mondo, dominato dal caos, attraverso il Lógos.
Per Nietzsche non esiste nessun tipo di certezza, e dunque tutto è relativo; l’unica cosa di cui possiamo
essere certi è che:
Questo mondo è volontà di potenza – e nient’altro! E anche voi stessi siete questa volontà di potenza –
e nient’altro! (Frammenti postumi)
L’ospite inquietante
Nietzsche stesso si definisce il primo nichilista d’Europa! Ma che cosa è precisamente il nichilismo? Che
volto ha questo ospite che ormai si siede alle nostre tavole, respira la nostra aria? Che volto ha “il più
inquietante fra tutti gli ospiti” (Frammenti postumi 1885-1887, fr. 2 (127))?
In maniera chiara e sintetica:
Nichilismo: manca il fine; manca la risposta al ‘perché’; che cosa significa nichilismo? – che i valori
supremi perdono ogni valore.” (Frammenti postumi 1887-1888, fr. 35)
Manca il fine, lo scopo e i valori si svalorizzano!
92
Siamo al “crepuscolo degli idoli”, “il senso dei valori non è all’altezza dei tempi”!
La più semplice forma di nichilismo consiste nella “volontà del nulla”, ovvero il rifiuto e la fuga dalla realtà
concreta; la nascita di tale modo di percepire il mondo è attribuita al platonismo e al cristianesimo.
Nietzsche spiega il nichilismo anche come la condizione dell’uomo moderno che, caduta ogni convinzione
su una realtà organizzata e retta da perfette entità metafisiche, razionali ed eterne, ai valori supremi di Dio,
della verità assoluta, di bene, capisce che Dio è morto e si lascia andare al più profondo sgomento. La nascita
di questo modo di rapportarsi con la realtà è da imputare alla delusione dell’umanità nel constatare che i
valori e i fini assoluti, derivati dalle metafisiche, non sono altro che una menzogna priva di riscontro nella
realtà.
Il concetto di “uno”, “vero”, “buono” non esistono! È inutile ricercare un senso alle cose, perché un senso
non c’è. Così, quanto più l’uomo si è lasciato andare alle farneticazioni, tanto più paga lo scotto della vera
essenza delle cose.
L’organizzazione che abbiamo dato ai fenomeni, al mondo non è affatto organizzata su base oggettiva,
universalmente e univocamente data. L’organizzazione del mondo nella rete di concetti e di senso è stabilita
semplicemente dalla volontà di potenza che impone il proprio fine!
Nietzsche supera il concetto stesso di nichilismo, facendo diventare la condizione di sconforto solo una tappa
intermedia e passeggera tra l’iniziale illusione e l’effettiva comprensione. Probabilmente proprio per questa
ragione Nietzsche distingue tra nichilismo incompleto e completo.
Il nichilismo incompleto è quello che si palesa per primo, e consiste nella crisi degli ideali e nello sconforto.
Per superare questo stato d’animo si ha la creazione di surrogati, di nuovi idoli che svolgono una funzione
analoga a quelli iniziali. In pratica l’uomo ha ancora bisogno di un’entità che gli detti la giusta condotta: ha
ancora bisogno di verità! Tale stato può portare al massimo ad una serie ininterrotta di cicli di creazione di
nuove entità e rispettive distruzioni. Esempi di questo tipo di nichilismo sono molteplici: lo Stato, il
nazionalismo, il socialismo, l’anarchismo, il positivismo, il naturalismo, ecc.
Il nichilismo completo permette finalmente all’uomo di liberarsi dagli idoli da egli stesso creati e di rendersi
libero. Esso è caratterizzato negativamente se si prende solamente atto dell’insussistenza dei valori
crogiolandosi nel nulla (nichilismo passivo); viceversa è positivo se la sempre maggior potenza dello spirito
è utilizzata come forza di distruzione (nichilismo attivo). Il nichilismo diventa “estremo” se annienta ogni
rimanente credenza metafisica per proporre un sano relativismo: “non esiste affatto un mondo vero”
(Frammenti, 1887-1888).
La distruzione di tutti i ponti con l’inconsistente passato, apre nuove prospettive per il futuro, per questo si
parla anche di “nichilismo estatico”. Infine, il nichilismo diviene “classico” quando permette il superamento
del nichilismo stesso e permette di capire che il senso deve essere umanamente inventato. Quindi la
distruzione delle certezze assolute rappresenta un obiettivo fondamentale per permettere all’umanità di farsi
definitivamente carico delle proprie decisioni e responsabilità, uscendo dal precedente stato di minorità!
L’uomo è fonte di valori e di significati.
Prospettivismo
Nella fase terminale dell’attività filosofica Nietzsche estremizza sempre di più la sua concezione che egli
stesso chiama “prospettivismo”. I fatti non esistono, esistono interpretazioni! Chi sostiene il contrario, come i
positivisti, ha torto, esistono interpretazioni relativamente a diversi angoli prospettici.
Il mondo non può essere quindi compreso in senso univoco, ma ci sono innumerevoli sensi. Non esiste un
mondo vero ma infiniti mondi!
La posizione di Nietzsche vuole essere anche un superamento dell’idealismo che mette al centro l’Io.
Nietzsche non concorda neanche con l’interpretazione secondo cui tutto è soggettivo. Anche questa
posizione è una posizione, una interpretazione.
L’idea di caos ordinato mediante schemi umani avvicina Nietzsche a Kant, tuttavia per quest’ultimo vi è una
sola verità indiscutibile, necessaria. Infatti, se per Kant il mondo è indagato mediante le forme a priori, esse
sono uguali per tutti e ciò garantisce la universalità della verità. In Nietzsche le nostre deduzioni sono frutto
93
della volontà di potenza: “Sono i nostri bisogni che interpretano il mondo” (Frammenti, 1885-87). Dunque,
ci sono innumerevoli punti di vista sul mondo. Conoscenze empiriche e logica, un po’ come affermava
Hume, sono fallaci. Il rapporto causa-effetto non è un principio concreto, ma la sciocca volontà di astrarre un
modello da dati reali che solo casualmente si sono manifestati seguendo un certo ordine.
La conoscenza razionale con tutta la sua strumentazione di verità assolute, concetti, categorie non sono che
invenzioni o, al meglio, convenzioni. Lo stesso linguaggio, come grimaldello della conoscenza, non è che
“un esercito di metafore”, similitudini assai lontano dalla comprensione “in sé” della natura.
È quindi minata alla base l’essenza stessa della scienza di ciò che i greci avevano chiamato epistéme, cioè ciò
che ‘sta sopra’ e che si propone come incontrovertibile. La scienza è nata per offrire rifugio all’instabilità
tipica dell’essere umano, e per questo è assimilabile a una semplice illusione di verità. L’uomo, non capace
di comprendere le cose nella loro immediatezza, è costretto a trasporle in un una realtà astratta, immutabile a
parallela, nel tentativo di fare chiarezza nel caos del mondo. Per la venerazione che l’uomo riversa nella
scienza, essa risulta la miglior alleata dell’ideale ascetico.
Nietzsche esprime una visione antipositivistica. I fatti che i positivisti pretendono studiare sono spiegabili
solo all’interno di determinate teorie che ‘creano’ gli oggetti, cioè configurazioni che esse stesse danno
senso, significato ai fatti.
Nietzsche critica in particolare la scienza moderna; le sue invettive sono rivolte a vari capisaldi dell’indagine
scientifica come il meccanicismo, la sempre maggiore specializzazione e la visione atomica del mondo, il
determinismo.
La scienza moderna impone una visione unilaterale e perciò violenta della realtà. Le interpretazioni non
possono essere che plurali, da varie angolazioni. Ciò significa pure che la scienza, imponendo la sua
concezione meccanicistica, matematizzante, della realtà, travisa la realtà stessa che è polimorfismo e totalità.
Affermando che le discipline scientifiche non permettono di penetrare la natura ma solo di modificarla,
Nietzsche anticipa le correnti pragmatistiche ed ermeneutiche del Novecento.
Infine, il prospettivismo di Nietzsche non afferma che tutte le interpretazioni date di un certo fenomeno sono
equivalenti. Il criterio di scelta tra interpretazioni confliggenti sarà dato dalla sua corrispondenza al criterio
della salute e della forza cioè della vita: volontà di potenza. Tutti questi concetti (vita, salute, ecc.) in
Nietzsche non hanno un semplice valore fisiologico, ma riguardano la capacità dell’individuo di accettare,
mediante la sua parte dionisiaca, la tragicità della vita e di sfruttarla a proprio vantaggio. In definitiva, per
salute, forza si intende il modo di essere del superuomo, e in particolare della sua capacità di prosperare
anche senza certezze assolute.
CONCLUSIONI
Nietzsche in Ecce homo si augura che non venga preso “per un altro”, ebbene, il linguaggio aforismatico,
parabolico, ecc. se, da una parte, rende estremamente fecondo il filosofo per la molteplicità interpretativa a
cui da luogo, dall’altra è facile che ci sfugga il ‘vero’ Nietzsche.
Le interpretazioni della filosofia di Nietzsche oscillano ampiamente da interpretazioni naziste a letture in
chiave esistenzialista, come teorico cioè della coscienza europea, come propone K. Jasper, o Löwith,
accostandolo a Kierkegaard. Altri come Lukács hanno visto il pensatore dell’irrazionalismo borghese del
periodo imperialista che si rifugia nella decadenza della propria classe. Addirittura i teologi hanno insistito
sull’anticristo nietzscheano come un nuovo cristiano.
Il linguaggio poetico e profetico, a prima vista più adatto ad un moralista che ad un filosofo, in ogni caso
segnala - già con Schopenhauer - non solo una propensione personale quanto, ormai, una più profonda
rottura con la filosofia sistematica che si affida ad un linguaggio tecnico a voler sottolineare il tentativo
razionale di ordinare il mondo. L’aforisma, l’intuizione linguistica meglio si adatta a scandagliare il
dionisiaco caos della vita.
Dal punto di vista individuale Nietzsche per certi versi ha un parallelo in Van Gogh, e non solo per la
malattia mentale che segnerà l’epilogo dei due quanto per la sincera ricerca senza risparmio: entrambe non
94
conoscono il lavoro ‘teorico’, ‘intellettuale’ nel senso che nel loro lavoro essi mettono anima e corpo,
sistema nervoso, senza distinzione, fino allo schianto!
Nietzsche è sicuramente filosofo anticipatore di quella crisi dei fondamenti che investe il sapere nei primi
decenni del XX secolo, ma le cui propaggini si estendono fino all’oggi: epoca della tecnica.
In sede conclusiva vanno sottolineati almeno quattro temi che fanno di Nietzsche un pensatore estremamente
fecondo nella riflessione filosofica attuale: l’irrazionalismo, la demistificazione, la morte di Dio e il
nichilismo.
Per ciò che afferisce all’irrazionalismo Nietzsche prosegue e a suo moto supera l’irrazionalismo di
Schopenhauer. Irrazionale è il mondo! Non c’è nessun ordito o trama razionale che si dipana in una
direzione, verso uno scopo, un fine. Il tentativo hegeliano di dare ordine al caos è pura follia esso si inquadra
in quei tentativi che cercano ancora di imbrigliare il mondo in una necessità, in una Ragione che
sostanzialmente serve per acquietare, lenire il terrificante volto del dionisiaco, del caos. Non solo il mondo
non può essere tagliato e messo in comodi cassetti orinati, ma lo strumento che doveva essere in grado di
penetrare il mondo e farci conoscere la più recondita verità è esso stesso inservibile, inefficace: il Lógos. Il
Lógos non è più in grado di cogliere la verità del mondo. Nietzsche porta a fondo la critica che già è presente
in Schopenhauer, al Lógos come strumento che si rivela parziale nella comprensione della molteplicità, della
poliformità della vita. Il Lógos è una struttura incapace di cogliere il flusso della vita. Il Lógos è menzogna
che ci aiuta a credere nella vita a sopportarla. D’altra parte il Lógos, lungi dall’essere quella regione
autonoma e necessaria, è al servizio della volontà di potenza. L’uomo ha, infatti, costruito una filiera di
concetti e valori che servono solo alla sua volontà di potenza.
Ecco il secondo punto che Nietzsche sviluppa. La filosofia del martello gli permette di frantumare tutte
quelle credenze assolute in cui l’uomo, come animale instabile, si rifugia e crede di trovare riparo
dall’intemperie del caos. La filosofia del martello fa perno su un metodo genealogico-critico scava i concetti,
ne fa - per così dire - l’archeologia e ne svela l’origine umana, troppo umana, e la corrispondenza al bisogno
umano. Non c’è, dunque, filiazione ontologica, né divina, ma meramente, ‘sordidamente’ umana. La vita è
tutto quello che abbiamo! La vita vuole solo se stessa, un mondo dionisiaco al di là del bene e del male, è la
volontà di potenza e nient’altro. Né finalità né morale ma il dispiegarsi di una potenza. Non c’è un Dio che
impone tavole della legge o che ci apra il petto e vi innesti sacri valori!
La demistificazione dei concetti e valori supremi e assoluti ci porta dritti alla morte di Dio che è
contestualmente morte del Dio cristiano, ma anche la morte della metafisica, e del Lógos, della verità
assoluta, ecc. Dio è morto. Dio resta morto! E noi abbiamo ucciso Dio scoprendo l’inganno, la grande
menzogna. Menzogna che alla fine si è rivolta contro di noi giacchè se doveva lenire il dolore davanti al buio
del nulla, di finire nell’indistinto, nel nulla, ecco che tale rimedio ha completamente obliato la vita, la forza
vitale, compresso ciò che di dionisiaco è in noi. Il rimedio è stato peggiore del male! In verità Nietzsche non
annuncia la morte di Dio, ma - se così possiamo esprimerci - la certifica, la testimonia dopo una lunga
elaborazione teoretica che parte da Spinoza e che, in Hume, Kant, Schopenhauer, Feuerbach trova i suoi
araldi. Se questo è vero è però completamente nietzschiano il modo di intendere la morte di Dio e di porre
subitaneamente la presenza dell’ospite più inquietante: il nichilismo. In Marx la morte di Dio aveva
significato, invece, la possibilità di realizzare quel processo demistificatorio antimetafisico e di tutto
l’apparato concettuale borghese: eterizzante, ossificato.
La morte di Dio ci porta alla presenza del più inquietante fra gli ospiti: il nichilismo! Profetico quanto
Nietzsche scrive: “Ciò che racconto è la storia dei prossimi due secoli. Io descrivo ciò che viene, ciò che non
può più venire in altro modo: l’insorgere del nichilismo” (La volontà di potenza). Tale ospite – anticipiamo –
si aggira nell’attuale orizzonte culturale dominato dalla tecnica!
Non c’è più la destra, la sinistra, l’alto e il basso. Non c’è più il fine. Non c’è più il perché. I valori si
svalorizzano prima che possano attecchire. Il nichilismo è l’ospite che minaccia qualsiasi costruzione
culturale, qualsiasi progetto, ancorché politico, qualsiasi tentativo di senso. Ma solo guardandolo in faccia,
conoscendolo è, forse, possibile andare oltre. La formulazione del superuomo è esattamente questa
possibilità di andare oltre: un oltre-uomo che, lasciate oltremondane speranze, decide di rimanere fedele alla
terra; decide di accettare la totalità della vita. Al di là di un nichilismo passivo e stancamente decadente,
Nietzsche afferma un nichilismo attivo - espressione della volontà di potenza - grazie al quale l’uomo possa
riappropriarsi – similmente in ciò al programma feuerbachiano – della terra, della vita.
95
Non è possibile parlare di Nietzsche senza far riferimento alla lettura che ne da Heidegger. La metafisica
secondo Heidegger è stata un progressivo oblio dell’essere giacchè l’essere è stato sempre trattato come ente.
Ora la filosofia nietzschiana non è affatto antimetafisica ma si inserisce in perfetta continuità con quella
storia metafisica che, partendo da Platone (riduzione dell’essere a idea), attraverso Cartesio (verità come
certezza soggettiva), arriva fino alla formulazione della volontà di potenza pensata come l’intima essenza
dell’essere. Nietzsche in questa prospettiva, è l’ultima metafisica: il suo estremo compimento! La volontà di
potenza è la necessaria, coerente conclusione della storia dell’Occidente. Nietzsche non avrebbe fatto altro
che portare a termine l’oblio dell’essere, cioè a fare dell’uomo la misura delle cose. La volontà non vuole che
se stessa e nient’altro e che nella sanzione dell’eterno ritorno si glorifica soggettivisticamente: la volontà di
potenza non è altro che il trionfo del soggettivismo. E’ questo che rende Nietzsche contemporaneo: filosofo
del nichilismo e profeta della tecnica. In questo senso la filosofia nietzschiana non è – suo malgrado - né
antimetafisica né inattuale, ma metafisica e contemporanea.
L’oggi […] è la determinatezza metafisica dell’umanità storica nell’epoca della metafisica di Nietzsche.
(Heidegger, Nietzsche)
96
BIBLIOGRAFIA
Opere di Nietzsche
Nietzsche, Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno, Adelphi, 1976
Nietzsche, La stella danzante. Le più belle pagine del grande filosofo, Rizzoli, 2000
Opere su Nietzsche
G. Vattimo, Introduzione a Nietzsche, Laterza, 2012
E. Fink, La filosofia di Nietzsche, Mondadori, 1977
SITI WEB:
http://www.filosofico.net/nietzsche.htm
V. DALL’ESSERCI COME POSSIBILITA’ ALL’EPOCA DELLA
TECNICA (Heidegger – Galimberti)
97
Questo tratto del volto della filosofia prende avvio dalla la riflessione filosofica del primo e del
secondo Heidegger e si conclude con U. Galimberti che sintetizza ed articola, in maniera ampia e
dettagliata, le problematiche attorno al nichilismo e alla tecnica.
Questo tratto della filosofia contemporanea mette in evidenza innanzitutto la curvatura avvenuta da
una concezione che vede l’uomo come soggetto al suo annichilimento come ingranaggio.
Il passaggio dal primo al secondo Heidegger mette bene in evidenza come l’impostazione
esistenziale non regga all’urto della riflessione sulla tecnica; passaggio che significa passare dalla
possibilità del progetto e della scelta dell’Esserci all’accettazione destinale nella figura della tecnica
che ridimensiona grandemente l’azione del soggetto. L’uomo esiste all’interno di una “radura”
(Lichtung), un orizzonte storico-culturale che precede la sua progettualità senza esserne il soggetto,
quanto, piuttosto, vi si trova come progetto-gettato che riceve ed è consegnato in questa
dimensione.
L’uomo non ha alcun potere sulla tecnica che sfugge a qualsiasi progettualità. Il superamento della
nostra epoca non è opera dell’uomo: “Come e quando sia destino che accada nessuno lo sa”
(Heidegger).
Galimberti offre una riflessione dispiegata sull’epoca della tecnica che da ‘strumento’ è ormai
diventata ‘ambiente’. Soprattutto il ragionamento si concentra sul gap che esiste tra la
strumentazione concettuale che usiamo e l’età della tecnica: ci attardiamo ancora in un orizzonte
umanistico, pretecnologico. Ritardo che conviene colmare, ma, si badi, ancora lontano dalla
soluzione dei pericoli dell’età della tecnica dove la prossima domanda potrebbe essere ormai: Che
cosa la tecnica può fare di noi?
~ L’ESISTENZIALISMO
~ HEIDEGGER
98
~ Vita e opere
~ Il primo Heidegger: l’analisi dell’esistenza
~ Essere e tempo
~ L’essere nel mondo
~ L’esistenza inautentica
~ La cura
~ L’esistenza autentica
~ La voce della coscienza
~ Il tempo e la storia
~ La Kehre
~ La metafisica e il nichilismo
~ Essere, uomo, evento
~ La centralità dell’essere
~ Arte, linguaggio, poesia
~ La tecnica
~ La fine della filosofia e il compito del pensiero
~ CONCLUSIONI
L’ESISTENZIALISMO
L’esistenzialismo, fenomeno che ha radici profonde che vanno cercate nella crisi generale del vecchio
continente europeo, che prende avvio dalla fine della prima guerra mondiale aggravatosi nel periodo postseconda guerra mondiale, pervade le manifestazioni culturali tout court. I contributi sono i più svariati, dalla
letteratura all’arte, alla poesia, ad es. in questo contesto si collocano grandi scrittori e poeti, da Saba a
Ungaretti, fino a Montale, che condividevano il vero significato della ricerca esistenzialista, il senso della
vita all’interno della dimensione di una società moderna.
In un contesto post-guerra ci si interroga, insomma, su alcuni temi di fondo: il richiamo alla finitudine
umana e la possibilità della scelta; l’angoscia, la morte.
Dal punto di vista più specificatamente filosofico l’esistenzialismo si articola, anche se in diverso modo nei
diversi autori, attorno al concetto di esistenza. Esistenza (ex-sistere) indica nella sua radice latina il costituirsi
e mantenersi (sistere) venendo da altro (ex). Dunque, esistenza indica già nella sua radice il divenire.
L’esistenza è il divenire specificatamente dell’uomo! In questo senso l’uomo non è un “già dato”, ma come
dice Heidegger, “ha sempre da essere il suo essere”, a significare che l’uomo è decisione, scelta di essere.
In questo senso la filosofia dell’esistenza o esistenzialismo è contraria a quel filone filosofico che da Platone,
Aristotele fino ad Hegel, ha sempre pensato l’esistenza umana come realizzazione dell’essenza dell’uomo
come se si potesse parlare aprioristicamente di una essenza prima della esistenza. La filosofia esistenzialista
mentre afferma che l’uomo è esistenza afferma contemporaneamente che l’uomo è produzione della propria
essenza. L’esistenza è fondamento della essenza!
L’uomo è scelta, decisione, libertà, possibilità di essere. La scelta è ovviamente possibilità. La scelta implica
pure, necessariamente, che gli esistenzialisti pensano l’uomo come singolo: individuato e irripetibile. In
questo senso l’esistenza è anche l’espressione pure della impossibilità di previsione, di far rientrare
l’individuo singolo in un sistema scientifico giacchè la scelta e la libertà sfuggono, per loro natura a qualsiasi
universalità e necessità scientifica. Stirner, Kierkegaard, ma anche Nietzsche, avevano potentemente rilevato
che l’esistenza dell’uomo è esistenza del singolo. Il singolo, in quanto tale è l’espressione del massimo grado
di imprevedibilità. Ovvio che l’esistenzialismo si richiami esplicitamente a Kierkegaard e Nietzsche e versus
99
la metafisica hegeliana che tutto assorbiva nel suo fagocitante sistema che stritolava ogni singolarità rispetto
all’Assoluto.
HEIDEGGER
La vita e le opere
Nasce a Messkirch, nel Baden, nel 1889. Muore a Freiburg nel 1976.
Insegna all’Università di Marburgo (1923) e succede poi a Husserl – di cui era stato scolaro e assistente alla
cattedra di Friburgo con la prolusione Che cosa è la metafisica? che fece molto scalpore.
Il 21 aprile del 1933 viene eletto rettore dell’Università di Friburgo il che segna il suo coinvolgimento con il
nazismo. Si iscrive al partito il 1 maggio e il 27 assume ufficialmente il rettorato, pronunciando il celebre
discorso L’autoaffermazione dell’università tedesca in cui delinea i compiti degli studenti: lavoro, difesa,
sapere.
Alla fine della guerra è messo sotto accusa per il suo rapporto con il nazismo e interdetto dall’insegnamento.
In seguito, egli cerca di minimizzare il proprio errore storico e politico, ricordando come anche altri
personaggi di spicco, quali Hegel o Hölderlin, avessero appoggiato figure “discutibili”, come quella di
Napoleone, considerato da loro “lo spirito del mondo.”
Tuttavia, l’avversione di grandi filosofi, come J. Habermas, ecc, è giustificata dal fatto che Heidegger non si
dichiarò mai esplicitamente ostile agli orrori del nazismo stesso, mantenendo un atteggiamento piuttosto
ambiguo.
Il capolavoro di Heidegger è sicuramente Essere e tempo (1927) dedicato a Husserl. Altre opere importanti
sono: Che cos’è la metafisica? (1939), La dottrina platonica della verità (1929), L’essenza della verità
(1943), Lettera sull’umanismo (1947), Tempo e essere (1962).
Il primo Heidegger: L’analisi dell’esistenza
Si suole distinguere la filosofia di Heidegger in due grandi fasi: quella esistenzialista e quella propriamente
ontologica, che viene fortemente riproposta proprio dalla riflessione sulla tecnica. Diciamo subito che alcuni
studiosi sottolineano, in verità, gli elementi di continuità tra una fase e l’altra e chi, invece, ne sottolinea lo
rottura, la svolta (Kehre).
Il “primo” Heidegger pur partendo dal problema dell’Essere declina questa ricerca con tematiche
esistenzialiste, il secondo, invece, ripropone la riflessione su un livello specificatamente ontologico.
Per entrambi i periodi il grande filosofo tedesco darà vita a una miriade di spunti filosofici estremamente
profondi e alimenterà il dibattito internazionale.
In realtà bisogna sottolineare come Heidegger abbia da sempre rifiutato l’etichetta di filosofo
“esistenzialista”, tuttavia lo è stato, suo malgrado, nella misura in cui il suo testo più famoso e
rappresentativo Essere e tempo (Sein und Zeit) è considerato un vero caposaldo della filosofia esistenzialista,
e lo pose, insieme a Sartre, tra i più grandi esponenti di tale corrente.
Essere e Tempo
Dopo Hegel, la riflessione filosofica ha risposto con una forte flessione e riflessione sull’uomo concreto,
declinato, certo, all’interno di diverse sensibilità: l’ente generico di Feuerbach; l’uomo storicamente
determinato di Marx; l’uomo come animale malaticcio di Schopenhauer, il superuomo di Nietzsche.
100
Heidegger non si sottrae a questa riflessione filosofica coeva, ma ritorna, in Essere e tempo, alla domanda
cruciale: Che cos’è l’essere?
Heidegger ritorna, dunque, a porre la domanda fondamentale della filosofia; ritorna alla vertigine della
filosofia in grande stile.
Essere e tempo, il suo capolavoro, già nel titolo porta scritto due concetti che nella storia della filosofia
hanno una grandiosa perdurante permanenza. Due parole magiche che saranno declinate con le inquietudini
della crisi dei fondamenti, degli assoluti, di un nuovo senso e l’atteggiamento disincantato e che perciò
cattureranno la riflessione filosofica del Novecento. Il problema dell’essere viene posto a partire da una
prospettiva completamente nuova: l’analisi dell’esistenza. Essere e tempo può essere visto come un trattato
di filosofia pratica che orienti nella vita, un po’ come era nell’intenzione dell’Etica nicomachea di Aristotele
(F. Volpi). In questo senso trovano diversa lettura i concetti di vita autentica e in autentica. D’altra parte il
tentativo heideggeriano può essere letto anche all’interno di un capitolo di storia della filosofia della
religione nel senso che il soggetto è visto all’interno di un racconto in cui può perdersi ma anche salvarsi,
riscattarsi. Essere e tempo può configurarsi anche come un romanzo agnostico attraversato com’è dalla
caducità, dalla finitudine in cui siamo gettati. Insomma, le suggestioni di Essere e tempo sono molteplici e in
ciò sta non un limite ma un pregio dell’opera.
Heidegger pone, dicevamo, la domanda: Che cos’è l’essere?
Con tutta evidenza il cercato, cioè l’essere, e il suo senso può trovare una risposta solo in un ente che possa
essere interrogato: l’uomo, che Heidegger chiama, l’Esserci (Dasein). Non rimane, dunque, che interrogare
l’Esserci, cercare l’essere e carpirne il senso. Ma il modo d’essere dell’Esserci è l’esistenza dunque non
possiamo che partire dall’analisi dell’esistenza: comprenderne le caratteristiche, perimetrarne i confini.
Partendo da una domanda squisitamente ontologica, dunque, Heidegger s’incunea in una prospettiva
esistenzialistica alla quale fornisce un immenso apparato di validi strumenti analitici, tematiche ed una vasta
terminologia.
La prima caratteristica dell’esistenza è la fondamentale capacità di comprensione dell’essere, ovvero la
possibilità di avere un rapporto con l’essere stesso;
La seconda caratteristica è che “L’Esserci è sempre la sua possibilità” cioè, mentre le cose sono ciò che sono
e non possono esser altro, l’uomo ha la possibilità di essere ciò che sceglie o progetta di essere. L’esistenza è
la possibilità di essere, per cui l’uomo, l’Esserci, appare come un ente il cui essere risulta eternamente in
gioco, a differenza delle cose, le quali sono sempre ciò che sono, ovvero semplici presenze.
Si noti che nonostante in Essere e tempo Heidegger prospetti un Esserci come possibilità non arriva mai a
parlare di libero arbitrio o di libertà dell’uomo - come farà ad es. Sartre - ma usa sempre termini alternativi.
L’uomo per Heidegger è sì capace di progettarsi di farsi carico del poter essere, ma sempre all’interno di una
dimensione dell’essere, di un destino che l’essere gli ha destinato. L’uomo può compiere piccoli passi,
piccoli furti all’interno della coessenzialità, coappartenenza di essere e uomo che egli deve accettare.
L’uomo quindi è “ciò che ha da essere”, e la sua esistenza si snoda tra le alternative, la prima delle quali è la
scelta tra l’autenticità e l’inautenticità. Se l’uomo decide di non scegliere, esce sconfitto: “Scegliersi oppure
perdersi”.
L’essere-nel-mondo
L’uomo nel suo concreto e quotidiano esistere per Heidegger è, innanzitutto, “essere-nel-mondo” (in-derWelt-sein), ossia un prendersi cura delle cose che gli sono necessarie. (Questo concetto è quindi un
esistenziale: determinazione strutturale dell’Esserci). Per questo motivo l’essere delle cose coincide con il
loro poter essere usate. Le cose figurano come strumenti che può utilizzare: la casa per abitare, la stella per
orientarsi, ecc.
Poiché l’uomo è essere-nel-mondo, il suo compito è quello di avere cura delle cose, dando al termine cura il
significato di “rapporto tra le cose mediate attraverso il loro uso, utilizzo”. Le cose non sono indipendenti,
ma l’uomo ne stabilisce un rapporto di puro “uso”. L’Esserci è nel mondo in modo tale da progettare il
101
mondo stesso, secondo un piano globale di utilizzabilità, in modo da subordinare le cose ai propri fini e
bisogni.
L’Esserci si trova quindi nel mondo non secondo la modalità della conoscenza, ma secondo la modalità della
manipolazione degli altri enti, detta “commercio”.
In altri termini Heidegger sta affermando che l’uomo non è un mero contemplante ma opera con le cose,
con gli enti. Il nostro rapporto con le cose è di “commercio” nel senso semplicemente di concreta
“funzionalità” e “utilità”.
In questo senso Heiddeger si pone - in un certo senso - sulla stessa lunghezza d’onda di Marx, per cui la
conoscenza non è teoretica, ma una conoscenza umano-sensibile, “pratica” che interviene tra il soggetto e
l’oggetto e che lascia le dispute teoretiche alla filosofia scolastica.
Il commercio non è un’attività “cieca”, poiché vi è comunque un punto di vista dal quale si opera la
manipolazione, che Heidegger chiama “visione ambientale preveggente”, ovvero la visione del complesso
dei collegamenti e dei rimandi tra gli utilizzabili: “Prima del singolo mezzo, è già scoperta una totalità di
mezzi”. Il mondo è un insieme di significati che si collegano l’un l’altro e che fanno capo all’uomo.
L’uomo è quindi capace di dare un significato alle cose così come al mondo stesso, rendendoli “utili”: se il
mondo viene prima delle singole cose, allora l’uomo viene anche prima del mondo, in quanto si identifica
con l’ente, grazie al quale è possibile dare dei significati, che sono l’essenza del mondo.
L’esistenza inautentica
Un altro esistenziale, cioè struttura fondamentale dell’esistenza dell’uomo, è l’“esser-tra-gli-altri” (Mitsein), poiché l’esistenza umana è costitutivamente apertura verso il mondo e gli altri.
L’uomo non solo è nel mondo e fa “commercio”, ma è anche fra gli altri: è un animale che porta scritto le
stimmate dell’”animale sociale”. L’uomo si costituisce direttamente con un’apertura sia verso il mondo (le
cose), sia verso gli altri; non c’è alcun residuo dell’uomo egoarca hobbesiano o indipendente e isolato come
una monade leibniziana.
L’esistenza è inoltre comprensione esistenziale. L’uomo per comprendersi può servirsi di sé stesso, ma anche
degli altri e del mondo, appunto, come punto di partenza per la comprensione stessa:
Se egli parte da sé stesso, si ha una comprensione esistenziale autentica;
Se egli decide di partire invece dagli altri e dal mondo, si ha piuttosto una comprensione
esistenziale inautentica, che è alla base della “esistenza anonima”.
L’esistenza anonima è l’esistenza “di tutti e di nessuno”, è l’esistenza del “si”, nella quale il “si dice” e il “si
fa” la fanno da padrone. Sono coloro che quindi nella folla si sentono protetti perché non hanno punti deboli
perché il numero della folla li acquieta perché li maschera. L’esistenza anonima e contrassegnata da un
linguaggio ch’è pura chiacchiera inconsistente; da una curiosità per l’apparenza che finisce per essere
mero equivoco.
Tuttavia, Heidegger non intende condannare l’esistenza inautentica come una sorta di peccato, ma piuttosto
analizzarla, poiché riconosce che anche la forma anonima è parte dell’esistenza umana come “poter essere”:
parte essenziale dell’Esserci.
Alla base dell’esistenza inautentica c’è ciò che Heidegger chiama “deiezione”, la quale è la caduta
dell’uomo al livello delle cose del mondo. La deiezione è una sorta di “reificazione”, di “cosificazione”:
l’Esserci diventa come le altre cose del mondo: cosa tra le cose!
Essa è piuttosto un processo interno per cui l’essere dell’uomo scende al livello dei fatti. La “fattualità”
dell’Esserci, quindi, è il suo “essere-gettato” nel mondo in mezzo agli altri esistenti, al loro stesso livello. Lo
stesso “essere-gettato” sottointende però un processo di “nullificazione”, di insensatezza: l’uomo si sente
emotivamente abbandonato.
Heidegger riconduce buona parte dell’esistenza umana all’anonimato, in quanto anche l’intero ambito della
normatività e dei valori appartiene all’esistenza anonima, poiché non è comprensibile al di fuori del
rapporto dell’uomo con il mondo.
102
La cura
Per Heidegger la “Cura” (Sorge) è la totalità delle determinazioni dell’essere, ovvero la struttura
fondamentale dell’esistenza sia autentica che inautentiche.
Riprendendo il poeta latino Igino, infatti, il filosofo afferma: “Poiché infatti fu la Cura che per prima diede
forma all’uomo, la Cura lo possieda finché esso viva”.
La Cura esprime la condizione dell’uomo - che si prende appunto cura delle cose e si cura degli altri - il
quale, gettato nel mondo, progetta le sue possibilità, ma ritorna sempre nella situazione originaria.
Per questo la Cura è una struttura circolare che descrive l’essere dell’uomo.
L’esistenza autentica
Dell’Esserci, considerato nella sua autenticità e totalità, fa parte anche la fine stessa dell’Esserci, cioè la
morte. La morte è la
possibilità dell’Esserci più propria, incondizionata, certa e, come tale, indeterminata e insuperabile.
(Essere e tempo)
Soltanto riconoscendo tale possibilità l’uomo ritrova il proprio essere autentico e comprende veramente sé
stesso. La morte diventa la possibilità per eccellenza dell’Esserci per il semplice fatto di essere la fine
dell’Esserci: il fatto che abbiamo una fine, la consapevolezza di questo fine fa sì che la morte diventi un
modo che pone sempre l’uomo davanti alla scelta, a scelte coscienziali.
L’esistenza inautentica, è una “fuga” davanti alla morte: l’individuo cerca semplicemente di non pensarci e
di obliarla nelle cure del quotidiano.
L’esistenza autentica è, invece, l’“essere-per-la-morte”: soltanto comprendendo la possibilità della morte
come impossibilità dell’esistenza, soltanto assumendo questa possibilità con una decisione anticipatrice,
l’uomo ritrova il suo essere autentico.
A questa comprensione, però, si accompagna un sentimento costante, quello dell’angoscia.
Angoscia che è ben distinta dalla paura, in quanto quest’ultima è sempre volta verso un oggetto determinato
e reale, ed è quindi inautentica. L’angoscia, invece, quello stato in cui l’uomo è davanti alla possibilità di
morire e ricadere nel nulla. L’angoscia si manifesta come “nientificazione”, come immediata rivelazione del
nulla. L’angoscia colloca l’uomo dinanzi al nulla, rendendo l’esistenza qualcosa di estremamente fragile,
ma, allo stesso tempo, essa rivela il significato autentico della presenza dell’uomo nel mondo, ovvero il
“tenersi fermi nell’interno del nulla”.
L’idea della morte, come con Nietzsche, dà il senso dell’insensatezza del tutto che arriva a fluire nel “nulla”.
Esistere autenticamente implica il coraggio di guardare in faccia alla possibilità del proprio non-essere,
morire. L’esistenza autentica, dunque, significa l’accettazione della propria finitezza.
L’esistenza autentica progetta la “decisione anticipatrice” di esser-per-la-morte, non nel senso che anticipa
la morte con il suicidio, ma nel senso invece, che accetta di convivere con la possibilità della morte, accetta
l’angoscia, e sceglie di liberarsi da una vita anonima.
Ciò che caratterizza l’essere-per-la-morte autenticamente progettato sul piano esistenziale può essere
riassunto così: [… l’Esserci è] innanzi alla possibilità di essere se stesso, in una libertà appassionata,
affrancata dalle illusioni del Si, effettiva, certa di se e piena d’angoscia: la libertà per la morte. (Essere e
tempo, par. 53)
La voce della coscienza
103
Appurata la superiorità dell’esistenza autentica, sorge quindi il problema di mostrare cosa richiami
perpetuamente l’Esserci ad un’esistenza di questo tipo, in modo da non considerarla come una semplice
possibilità tra le altre.
Secondo Heidegger è la “voce della coscienza”, la quale non è altro che il richiamo dell’esistenza a sé
stessa, che riporta costantemente l’uomo alla sua esistenza autentica.
Abbiamo visto che l’esistenza umana è possibilità, progetto. L’uomo è in ciò fondamento di se stesso nel
senso che sceglie tra diverse opzioni. Tuttavia l’uomo dice Heidegger è un progetto-gettato cioè non è affatto
il fondamento del proprio fondamento.
L’Esserci è doppiamente attraversato dalla negatività, poiché:
Nella sua condizione di progetto-gettato, esso non risulta il fondamento di sé stesso. Da ciò deriva
la sua “nullità”: “L’esser-fondamento significa non essere mai signore dell’essere più propri.
L’Esserci, essendo fondamento, è una nullità di sé stesso”.
Anche nella sua realtà di progetto concreto, esso incontra il nulla, in quanto la scelta stessa preclude
tutte le altre possibilità dunque è qualcosa e non altro.
Per questo motivo, “l’Esserci è colpevole”.
Poiché la ‘voce della coscienza’ richiama l’Esserci ad una esistenza autentica in effetti è, dunque, un
richiamo al nulla. Il nulla fa sì che l’Esserci prenda una “decisione” maturata proprio all’interno di questa
situazione d’angoscia del nulla. Questa decisione per il nulla coincide secondo Heidegger con la decisione
dell’anticipazione della morte.
Un’esistenza autentica, pertanto, è quella che comprende appieno, e realizza emotivamente (tramite
l’angoscia), la radicale nullità dell’esistenza. In questo modo l’Esserci entra in possesso della propria
finitudine, comprende il proprio destino e riesce a mantenersi fermo nel nulla.
Noi concepiamo esistenzialmente la morte come la possibilità già chiarita dell’impossibilità
dell’esistenza, cioè come la pura e semplice nullità dell’Esserci. (Essere e tempo)
La morte ha quindi il compito di mostrare la negatività strutturale dell’esistenza. In Essere e Tempo, domina
dunque una certa negatività espressa dalle equazioni: “Cura = Nulla” e “Esserci = Nullo fondamento di
una nullità”.
Il tempo e la storia
Nel discorso di Heidegger si inserisce a questo punto la temporalità, in quanto le stesse strutture
fondamentali dell’Esserci rimandano ad altrettante dimensioni del tempo:
Il progetto proietta l’Esserci verso il futuro;
L’esser-gettato inchioda l’uomo al passato;
La deiezione radica l’Esserci nel presente inautentico della cura delle cose, mentre la decisione
anticipatrice della morte conduce al presente autentico dell’attimo.
L’Esserci è quindi “tempo”.
L’assunzione dell’eredità del passato va a costituire la “storicità”. Essa è possibile in quanto l’esistenza
autentica, pur progettandosi come nullità, non elimina il mondo, ma, anzi, lo presuppone.
Il nulla, insomma, non ci impedisce di vivere ma anzi ci rende liberi di accettare l’esistenza così come essa è.
Ora, dice Heidegger, dato che l’esistenza è vivere con gli altri, tessere una ragnatela di rapporti, l’uomo ha la
possibilità di rimanere fedeli al destino della comunità o del popolo a cui appartiene. Il destino è l’atto con
cui “si tramanda in una possibilità ereditata e tuttavia scelta“ (Essere e tempo).
L’uomo non utilizza gli altri “esclusivamente” come cose, ma “anche” come cose; l’esistenza autentica
impone all’uomo di considerare gli altri come co-partecipi di un destino e di una comunità. La sua socialità
104
era inscritta nella sua dimensione di essere, nella sua dimensione ontologica. Il destino della comunità, del
popolo, della nazione diventa un concetto di co-partecipazione alle usanze e ai suoi destini, ma non è
quell’”accettazione del si” alla massa: è una cosciente partecipazione al destino della nazione.
Al dualismo dell’esistenza autentica e della partecipazione alla comunità, si affianca il dualismo di un
destino dettato da esperienze pregresse, ma anche liberamente scelto. Il destino è si tramandato, ma anche
scelto, in un rapporto di co-partecipazione.
La Kehre
Essere e Tempo, è un’opera incompiuta: manca proprio la sezione relativa al problema del senso dell’essere
in generale. Appena pubblicato, l’autore ripensa l’intera impostazione e intuisce che il percorso intrapreso
sulla esistenza non lo riporta al problema che aveva posto con tanta fortissima chiarezza: Che cos’è l’essere?
Qui i critici vogliono vedere quella che chiamano la svolta, la Kehre! Heidegger si rende conto che per quella
via non è possibile arrivare all’essere e che l’analisi dell’esistenza conduce invece, inevitabilmente, ad una
genuflessione dell’Essere all’ente (Esserci). Bisogna, allora, ritornare ad una dimensione più strettamente
ontologica; porsi direttamente nell’ottica dell’essere!
La svolta, la Kehre, non è una completa frattura, ma a ben guardare un ritorno, un mutamento di prospettiva:
non è possibile più metterci dal punto di vista dell’Esserci, ma bisogna ritornare all’Essere, al punto di
domanda che pure era presente proprio all’inizio di Essere e tempo. Il problema dell’essere è sempre
presente in Heidegger e in ciò è possibile ravvisare una continuità nel suo pensiero, tuttavia è pur vero che si
presenta una frattura nel suo pensiero a partire dal modo con cui arrivare alla risposta sull’essere, ed è
precisamente questo che va inteso quando si parla di Kehre.
La Kehre diventa chiara con la Lettera sull’umanismo!
Riprendendo il quesito fondamentale, Che cos’è l’essere e il senso dell’essere, ma cambiando prospettiva,
ovvero partendo dall’Essere stesso e non dall’Esserci, sembra che Heidegger si riavvolga in una ragione
superiore che è appunto l’Essere e che valuti l’uomo non più come soggetto, indipendente, autonomo,
capace di libero arbitrio. In questo senso sembra riprendere quella visione hegeliana secondo cui l’uomo non
è altro che manifestazione dell’Essere; come in Hegel, l’uomo perde quell’elemento di arbitrio: l’uomo non è
più “chi progetta” liberamente, ma è “a sua volta progettato” perché è una manifestazione dell’Essere,
inserito in una ragione che gli è superiore.
La metafisica e il nichilismo
Dopo che in Essere e Tempo Heidegger aveva definito l’Esserci come temporalità, la quale rappresentava
l’unico orizzonte per la comprensione dell’Essere, ora egli si concentra su una critica rivolta alla
metafisica e alla storia della metafisica
In un primo momento, nella riflessione heideggeriana, la metafisica non assume ancora un significato
negativo, poiché viene connaturata con l’Esserci:
La metafisica fa parte della natura dell’uomo. […] La metafisica è l’accadimento fondamentale
dell’Esserci.” (Che cos’è la metafisica)
Tuttavia, ben presto l’analisi mostra che la metafisica ha perso il senso stesso di quello che doveva essere.
Heidegger la riprende come bisogno oltremondano, come una disposizione dell’uomo a voler pensare
qualcosa che è altro da sé e che abbia un senso allo stesso tempo. È un po’ la stessa motivazione presente in
Kant e, per certi versi studiata e spiegata dallo stesso Schopenhauer. In Kant la metafisica era un bisogno
insopprimibile dell’uomo anche se doveva essere esclusa dalla scienza: era un semplice bisogno da
sopperire. In Schopenhauer la metafisica è il modo con cui l’uomo, come animale malaticcio cerca di
sopperire al deficit del suo corredo istintuale rispetto alle temperie del caos. Per Heidegger la metafisica è
accadimento fondamentale dell’Esserci volontà: di conoscere oltre e di dare senso.
105
L’Esserci, per Heidegger, può essere quindi visto come fondamento (Grund) solo come assenza di
fondamento (Abgrund), in quanto egli è libertà che tutto fonda, ma che a sua volta non si fonda da sola, per
la sua natura di progetto gettato.
L’uomo quindi è fondamento di sé stesso, ma capisce anche che il suo fondamento è un “nulla”, un caos
indistinto: l’uomo è un fondamento senza fondamento.
Dunque l’Esserci, che è ente, non va confuso con l’Essere in quanto tale. Esiste per Heidegger, una
differenza ontologica: la verità ontica è la conoscenza dell’ente; la verità ontologica è la verità dell’Essere.
L’Essere non è l’Esserci. L’essere è la luce, l’orizzonte all’interno del quale si dà la comprensione dell’ente.
Solo la preliminare conoscenza dell’Essere rende il quadro all’interno del quale è possibile comprendere
l’ente e l’Esserci.
Se in Essere e tempo la verità era una proprietà o un modo di essere dell’Esserci, che coincideva con
l’illuminazione del mondo ad opera dell’Essere, dopo la Kehre, la verità s’identifica con l’accadere
dell’Essere, che come radura (Lichtung) rende visibile l’ente. Ne consegue, per Heidegger, una critica serrata
con quelle dottrine che riducono la verità a proprietà dell’uomo (Aristotele, Tommaso, Cartesio, e
Nietzsche).
In termini chiari, a partire dalla Introduzione alla metafisica del 1935, Heidegger avverte che la metafisica,
pur ponendosi il problema dell’essere, “non pensa l’essere nella sua verità”: essa ha perso il senso
dell’Essere perché ogni volta che parla dell’Essere non vede più l’”Essere in quanto Essere” ma in un
particolare “ente”, riducendo la metafisica a scienza del particolare limitandosi a mera indagine attorno
all’ente.
La metafisica è oblio dell’Essere!
La metafisica quindi, secondo Heidegger, non è stata altro che ontologia, o al più teologia, quando essa si è
concentrata sull’ente supremo, Dio. Essa ha poi assunto le connotazioni della logica, in particolare con
Hegel, quando il pensiero è diventato essere e soggetto. Ed il filosofo la definisce appunto onto-teo-logia,
proprio in funzione del suo “ingannevole” campo di analisi.
Il cammino della metafisica è un errare dovuto a tre errori:
Ha visto l’Essere in senso ontologico, ma attribuendogli delle caratteristiche dell’ente e non dell’Essere;
Ha sempre visto l’Essere nel suo “Essere supremo”, diventando teologica;
Ha errato finanche quando, accanto a queste due discipline, ontologia e teologia, ha pensato l’Essere
come logica, ragione; in questo modo ha pensato l’essere come pensiero attribuendogli caratteristiche
che non gli appartengono. L’essere non è strutturalmente razionale. Siamo ben lontani, con Heidegger,
da quel pensiero hegeliano per cui “tutto ciò che è razionale è reale e tutto ciò che è reale è razionale”.
La metafisica, per Heidegger, non è un semplice scomparto della filosofia, ma una prospettiva globale. E il
suo fraintendimento di fondo tra essere ed ente ha condizionato in maniera indelebile la storia
dell’Occidente: “La metafisica non è un accadimento della storia, ma l’accadere stesso della storia.”
Heidegger pensa che la metafisica non sia uno studio settoriale della filosofia, ma è ciò che informa tutta
quanta la dimensione culturale di un’epoca e in cui si articolano i concetti chiave di una determinata epoca:
dalla filosofia all’arte, all’etica, alla politica. L’orizzonte culturale è, difatti totalmente plasmato dalla
metafisica. Quando la metafisica pensa l’Essere non è una semplice questione “da filosofo”: è una categoria
che dà sviluppo e dà alimento a tutti i concetti di una determinata epoca. Se la metafisica non è quindi un
elemento particolare, allora lo sviluppo della metafisica non è un fatto della storia, ma la storia stessa.
La completa realizzazione della metafisica come oblio dell’Essere si manifesta nel pensiero di Nietzsche, che
ha estremizzato, con il nichilismo, la tendenza a fare dell’uomo la misura delle cose, continuando il percorso
iniziato da Platone e Cartesio. Per questo il pensiero heideggeriano sarà inevitabilmente contro ed oltre
Nietzsche.
106
Il passaggio è fondamentale: Heidegger pensa che la filosofia di Nietzsche non è qualcosa di estraneo al
corpo vivo della metafisica occidentale. Nietzsche apparentemente sembra essere versus tutto:
antimetafisico, inattuale. In verità il suo “esser contro” altro non è che il frutto ultimo dell’impostazione
filosofica e metafisica greca. Egli è, dunque, metafisico e attuale! Nietzsche porta alle estreme conseguenze
tutto lo sviluppo della riflessione filosofica iniziata in Grecia. Nietzsche nonostante appaia come il grande
dissacratore, demistificatore della cultura occidentale, ne è, bellamente, il suo rappresentante più genuino.
Quell’uomo misura di tutte le cose, che pure Protagora, aveva pensato, ora assume la figurazione della
volontà di potenza, trionfo del soggettivismo che si concretizza nella tecnica che permette il dominio
incondizionato sul mondo.
Nietzsche dunque porta all’estremo l’oblio dell’Essere! Non rimane, per Heidegger, che colmare la
differenza ontologica tra Essere e ente con un superamento della normale concezione della metafisica
ponendo una domanda post-metafisica sull’Essere.
Essere, uomo, evento
Secondo Heidegger lo stesso termine Essere è ormai fuorviante dato che la metafisica lo ha logorato nel suo
errare verso l’ente. D’altra parte pure la nozione di differenza ontologica sembra rimanere impigliato in una
dimensione ancora metafisica così Heidegger prova a definire il concetto di Essere attraverso il poeticoevocativo, un modo allusivo, e perciò anche ambiguo, di concetti-metafore: Lichtung, Ereignis.
Innanzitutto, l’Essere non è ne Dio - delle religioni o dei filosofi - ne il fondamento del mondo. L’Essere non
crea il mondo nel senso biblico, né lo plasma come vorrebbe Platone.
L’Essere non è un ente, ma ciò che entifica l’ente, cioè ciò che lo rende visibile: Heidegger lo definisce con
il termine “radura” (Lichtung). L’uomo non può capire né le cose né se stesso se non all’interno della
comprensione dell’essere: solo attraverso la comprensione del tutto è possibile una qualche comprensione
della parte.
L'Essere - dice Heidegger - è simile a una foresta buia e intricata, dentro la quale si è costretti a vagare lungo
i suoi sentieri senza poterla cogliere in maniera oggettiva e distaccata. A tratti, comunque, si arriva a un
diradamento, una “radura” (Lichtung) che consente di averne una visuale più ampia pur dal suo interno.
L’Essere si esprime attraverso il linguaggio ed è un evento (Ereignis) che si dà attraverso il destino, di volta
in volta differente attraverso parole chiavi:
C’è essere ogni volta soltanto in questa o quella impronta destinale: Phýsis [Natura], Lógos
[Ragione], Ėn [Uno], Idéa, Enérgheia [Atto], sostanzialità, oggettività, soggettività, volontà di
potenza, volontà di volontà. (Identità e differenza, in Aut-aut)
Da ciò nasce la connessione tra essere e tempo. L’Essere è tempo!
L’essere, in quanto evento, rivela e nasconde sé stesso, in quanto si mostra in maniera tangibile, ma allo
stesso tempo esclude tutte le sue altre possibili manifestazioni.
L’evento apre e istituisce le epoche, mondi, culture.
Infine, uomo ed essere sono correlati in maniera inscindibile, anzi sono coessenziali. L’uomo appartiene
all’essere ma l’essere non si da senza l’uomo: “L’essere ha bisogno dell’uomo per la sua rivelazione,
custodia e configurazione.” (Ormai solo un Dio ci può salvare). Questa coappartenenza Heidegger la chiama
Evento (Ereignis). L’essere è, dunque, Ereignis!
La centralità dell’essere
Questo riposizionamento heideggeriano sull’Essere mette in evidenza sia il senso del suo antiumanismo che
l’antiesistenzialismo proprio comprimendo il controllo dell’uomo come progetto libero e autonomo. Con la
107
Kehre si assiste ad un passaggio dall’antropocentrismo di Essere e tempo ad un’analisi imperniata
sull’Essere. Per Sartre l’esistenza concreta precede l’essenza e la determina. Si delinea una distanza siderale
con l’esistenzialismo di Sartre, il quale agiva entro “un piano dove vi sono soltanto gli uomini” (Lettera
sull’umanesimo).
Heidegger arriva a definire l’uomo non come “padrone dell’ente”, ma piuttosto come “pastore dell’essere”,
che non ha più alcuna indipendenza.
L’uomo non è più padrone dell’ente né decide o controlla l’Essere:
l’uomo è piuttosto gettato dall’essere stesso nella verità dell’essere, in modo che, così esistendo,
custodisca la verità dell’essere, affinchè nella luce dell’essere l’ente appaia come quell’ente che è. Se e
come esso appaia […] non è l’uomo a deciderlo. L’avvento dell’ente riposa nel destino dell’essere.
(Lettera sull’umanismo)
Da ciò deriva che anche il progetto dell’uomo non è più espressione dell’attività umana, ma piuttosto una
manifestazione dell’Essere, così come la storia, la quale si trasfigura in storia dell’essere diventa destino
(Geschick).
Le manifestazioni particolari dell’uomo, come ad esempio l’arte, o lo stesso linguaggio, diventano un
risultato dell’Essere: la prima è messa in opera della verità, la quale agisce, in effetti, indipendentemente
dalla volontà dell’artista, mentre il secondo non è più uno strumento dell’uomo, ma è piuttosto esso stesso ad
esprimersi: “Chi parla, nel linguaggio, non è l’uomo, ma il linguaggio stesso”.
E’ la decentralizzazione del ruolo umano ancora più evidente quando Heidegger afferma che l’uomo, sì,
esiste, ma in orizzonti storico-culturali che precedono la sua progettualità cosciente.
In base a questa posizione sull’essere, l’esistenzialismo viene quindi accusato di essere una filosofia
antropologica, umanistica, “dimentica del fatto che quello che conta è l’Essere, non l’uomo” (Lettera
sull’umanismo).
Tuttavia, secondo Heidegger, ciò non significa sminuire l’uomo, ma anzi ritrovare il suo vero valore: la sua
dignità di fondo non è più nel suo supposto dominio tecnico che, al contrario lo caratterizza in quanto ente,
ma piuttosto nel suo ruolo di ontologica custodia dell’essere e della sua verità: pastore!
L’uomo è governato dunque, dal destino. Tuttavia egli non è un servo passivo ma un ascoltante che si pone
in ascolto dell’essere e ne coglie il suo disvelamento, le opportunità del suo darsi.
L’uomo diventa libero solo nella misura in cui appartiene all’ambito del destino e così diventa un
ascoltante, non però servo. (La questione della tecnica, in Saggi e discorsi)
Arte, linguaggio, poesia
- Arte. In questa riflessione sull’essere, l’arte si configura come il “porsi-in-opera-della-verità”, ovvero la
verità dell’ente, che mostra il significato autentico delle cose.
Celebre è l’esempio con il quale il filosofo espone questa tesi: riferendosi al famoso “Paio di scarpe” di Van
Gogh, Heidegger ne fa un’analisi, definendolo come l’“aprimento”, il disvelamento di ciò che un mezzo
della vita quotidiana è nella sua verità più profonda. L’arte non riproduce, ma istituisce la verità stessa,
diventando in ultima analisi automanifestazione dell’essere.
- Linguaggio. Per Heidegger il linguaggio non è una cosa tra le altre ma ha un ruolo fondamentale fino a
definire l’uomo come tale “in quanto parla”, poiché “Noi parliamo nella veglia e nel sonno. Parliamo
sempre, anche quando non proferiamo parola.”
D’altronde, non esiste nessuna possibilità di aprire mondi, di darsi Lichtung senza che vi sia anche un evento
linguistico, nel senso che solo attraverso il linguaggio si può manifestare una interazione tra gli enti:
108
Là dove non ha luogo linguaggio di sorta, come nell’essere della pietra, della pianta e dell’animale, non
ha neppure luogo alcun aprimento dell’ente. (Sentieri interrotti)
Per questo il linguaggio diventa la “casa dell’essere”, poiché delinea l’ambito entro cui le cose acquistano
significato e vengono all’essere. Il linguaggio è la dimora dell’essere, in esso abita l’uomo!
- Poesia. L’espressione più alta del linguaggio che ne rivela nel contempo l’impossibilità di ridurlo a mero
strumento, è la poesia.
La poesia è la vera automanifestazione dell’essere: “Il destino del mondo si annuncia nella poesia”. La
poesia è quel luogo privilegiato in cui l’essere, che sempre nella storia si ritrae, nasconde, si mostra in
maniera imperfetta, oscura, si mostra a tratti nella luce, traluce.
Per questo i poeti assumono un’importanza fondamentale, in quanto forniscono a un popolo la sua identità, i
suoi costumi e le sue usanze.
“La poesia è il linguaggio originario di un popolo, è il fondamento che regge la storia” (Hölderlin e
l’essenza della poesia): ciò significa, in altre parole, che Heidegger rifiuta un modello storicistico, in quanto
è l’arte, e quindi la poesia, a plasmare un’epoca storica, e non viceversa.
Inoltre, solo attraverso la poesia l’uomo può concretamente avvicinarsi all’essere, poiché “i pensatori e i
poeti sono i custodi della dimora dell’essere.”
Perciò la poesia si identifica col pensiero, il pensare diventa poetare, ed il poetare pensare: “Pensiero e
poesia si coappartengono.”
Nella sua ricerca della verità dell’essere attraverso la voce dei poeti, Heidegger ritrova la figura del poeta
tedesco Hölderlin, che viene considerato come il vero interprete della modernità.
Se Nietzsche ha svelato l’arcano del nichilismo rimanendone tuttavia all’interno, Hölderlin, secondo
Heidegger, va oltre il nichilismo, anticipando una età nuova:
la destinazione storica della filosofia culmina nella conoscenza della necessità di procurare udienza alla
parola di Hölderlin. (Perché i poeti?)
Ora, dato che il linguaggio è la “casa dell’essere”, il quadro all’interno del quale le cose vengono all’essere e
acquistano significato, l’ontologia diventa ermeneutica (interpretazione di parole, discorsi) e l’etimologia
diventa un modo di comprendere la storia dell’essere.
Se le cose sono nel linguaggio e come linguaggio bisogna ascoltare il linguaggio.
La tecnica
In una serie di conferenze del 1949 Heidegger si occupa in maniera specifica della tecnica, poi edite con il
titolo La questione della tecnica. La tecnica è per Heidegger la completa realizzazione della metafisica, la
quale si manifesta a livello globale. La tecnica è il fenomeno che definisce la civiltà contemporanea!
La riflessione heideggeriana non è tesa alla tecnica in quanto manifestazione tecnica, quanto sull’essenza
della tecnica, dunque la sua è una impostazione non tecnica dell’essenza non tecnica della tecnica.
La tecnica non si identifica con l’essenza della tecnica […] l’essenza della tecnica non è affatto qualcosa di
tecnico. (La questione della tecnica)
Porre il problema dell’essenza significa porre la domanda: Che cos’è la tecnica?
109
Comunemente la definizione strumentale della tecnica è che è un’attività umana, un mezzo in vista di fini.
Insomma, la tecnica è un puro mezzo. Questa definizione, dice Heidegger, è esatta, ma non necessariamente
vera!
La definizione della tecnica come semplice mezzo fa si che l’uomo sia il soggetto di questo rapporto, che la
tecnica sia pensata come a disposizione e controllata dall’uomo. Ma se così non fosse? Cosa ne sarà della
volontà di dominare la tecnica?
L’elaborazione heideggeriana a questo punto riflettendo sui concetti di mezzo e fine ne mette in evidenza il
rapporto di causalità tra essi analizzando i quattro tipi di causa che la storia della metafisica ha sviscerato a
partire da Aristotele. Le quattro cause interrelate tra loro fanno avvenire nella presenza ciò che non è ancora
presente. Insomma portano ciò che è presenza all’apparire. Platone nel Simposio diceva: “Ogni far avvenire
di ciò che – qualunque cosa sia – dalla non presenza passa e si avanza nella presenza è produzione”. Bene!
Le quattro cause sono unite da un portare, da un far uscire le cose allo scoperto, da un disvelare: dal buio alla
luce. La produzione è allora quella modalità che porta il nascosto nella disvelatezza ovvero proprio al senso
greco del termine alétheia.
La tecnica, dunque, è un “modo del disvelamento”, ovvero un processo che rende manifeste cose che prima
non erano tali: che porta alla luce, alla verità, ciò che prima era nel buio. Ciò che contraddistingue la tecnica
moderna è che il disvelamento è una pro-vocazione (Herausforden) nel senso che si pretende “alla natura che
essa fornisca energia che possa come tale essere estratta e accumulata” (La questione della tecnica) mentre la
tecnica antica non era in grado di accumulare alcunché.
Per Heidegger la techne greca è ciò che l’artigiano, l’artista produce, il sapere incarnato in questo fare. La
techne greca è dunque poiesis! La techne greca è un portare alla luce ciò che non si produce da sé ciò che
non viene alla luce dalla physei da natura. La tecnica moderna non è un produrre come poiesis, ma un
provocare un trarre dalla natura energia che possa essere accumulata. In ciò la natura viene disvelata come
fondo.
Se la tecnica stessa, infatti, veniva intesa dai greci come una “pro-duzione”, ossia un processo che favoriva
l’opera della natura senza stravolgerla, adesso la pro-vocazione moderna non fa altro che accumulare
l’energia nascosta della natura, metterla allo scoperto, trasformarla e porla a disposizione dell’uomo
seguendo il principio della massima utilizzazione ed il minimo costo.
Il disvelamento che governa la tecnica moderna […] non si dispiega in un pro-durre nel senso della
poiesis. Il disvelamento che vige nella tecnica moderna è una pro-vocazione la quale pretende dalla
natura che essa fornisca energia che possa come tale essere estratta e accumulata. Ma questo non vale
anche per l’antico mulino a vento? No. Le sue ali girano sì spinte dal vento, e rimangono dipendenti dal
suo soffio. Ma il mulino a vento non ci mette a disposizione le energie delle correnti aeree perché le
accumuliamo.
All’opposto, una determinata regione viene pro-vocata a fornire all’attività estrattiva carbone e
minerali. La terra si disvela ora come bacino carbonifero, il suolo come riserva di minerali. In modo
diverso appare il terreno che un contadino coltivava, quando coltivare voleva ancora dire accudire e
curare. […] L’agricoltura è diventata industria meccanizzata dell’alimentazione . (La questione della tecnica)
L’energia prende la forma di un fondo (Bestand) in cui tutte le cose trovano la loro precisa collocazione,
trasmutando da semplici oggetti in riserve di energia: così come l’aria non è più vento ma fonte di ossigeno,
il suolo non è più fertilità ma agricoltura programmata, e così via. La natura è un fondo a disposizione! E’
chiaro che tutte le cose del fondo ci sono ormai di fronte non più come ‘oggetti’, ma come fondo, appunto,
per essere impiegato, pronto per l’impiego.
L’essenza della tecnica moderna viene indicata da Heidegger con il termine “Gestell”, dal tedesco
“Ge”,“tutto”, e dal verbo “Stellen”, “porre”. Perciò, il Gestell rappresenta, in altre parole, la totalità del
porre tecnico. (Gestell è tradotto da F. Volpi con “impianto” e da Vattimo con “im-posizione”)
Chi compie il richiedere provocante? L’uomo? No! Il Gestell, l’impianto, l’intelaiatura che non è nulla di
tecnico, ma è il modo in cui si disvela il mondo come fondo. Ciò avviene non senza l’uomo ma non ad opera
sua. Esso è destino, Geschick!
110
Questa totalità assume le sembianze di un gigantesco strumento al servizio della volontà di potenza, la
quale domina l’uomo nella misura in cui egli non si accontenta di manipolare le cose, ma anzi da questa
stessa manipolazione trae sollecitazione a nuove prestazioni, in un circolo senza fine.
Per questo motivo, la tecnica non dipende dall’uomo, ma piuttosto dall’essere e dal suo destino.
Da questo rifiuto di una visione antropologica della tecnica nasce la considerazione che l’uomo pro-voca la
realtà, riducendola a fondo, poiché è esso stesso pro-vocato, in quanto si trova a vivere nello specifico e
storico modo del disvelamento che è proprio il Gestell.
E’ l’uomo che pro-voca la natura ma…
Ma sulla disvelatezza entro la quale di volta in volta il reale si mostra o si sottrae, l’uomo non ha potere.
(La questione della tecnica)
Dunque, dove si annida il pericolo? Dove il precipizio?
Nella perdita dell’essenza dell’uomo. La modalità della tecnica dissolve il mondo come ‘oggetti’ per riporlo
nel fondo. Ciò fa si che l’uomo si trovi senza mondo, senza ‘oggetti’, cioè solo come impiegante, funzionario
che amministra un fondo.
Questo pone l’uomo in una situazione di pericolo, poiché il dominio incontrollato della tecnica può portare
allo smarrimento della sua essenza; pericolo di cui quasi non si rende conto, in quanto fortemente convinto
del suo primato sulla tecnica:
quando è sotto questa minaccia, l’uomo si veste orgogliosamente della figura di signore della terra.
Così si viene diffondendo l’apparenza che tutto ciò che si incontra sussista solo in quanto è un prodotto
dell’uomo. Questa apparenza fa maturare un’ulteriore ingannevole illusione per la quale sembra che
l’uomo, dovunque, non incontri più altri che sé stesso. In realtà tuttavia, proprio sé stesso l’uomo di
oggi non incontra più in alcun luogo; non incontra più, cioè, la propria essenza. (La questione della tecnica)
Ecco dove si annida il precipizio: nella perdita della essenza della verità! La tecnica è solo un modo destinale
del disvelamento. L’uomo non comprende che il Gestell è solo una modalità del disvelamento dell’essere,
ovvero la sua modalità nichilistica. Anzi, la tecnica non è altro che l’essere disvelato in un ambito totalmente
nichilistico.
In altre parole, la tecnica coincide metafisicamente con il nichilismo compiuto, l’estremo oblio dell’essere
che è caratterizzato da un totale dominio della volontà di potenza. Tale modalità si è configurata come
prevalente sin da Platone, in un processo con il quale, secondo il filosofo Franco Volpi, “si è arrivati alla
realizzazione essenziale del padroneggiamento conoscitivo ed operativo dell’ente da parte dell’uomo
pensato come soggetto-padrone, e quindi alla piena dimenticanza dell’essere.”
Tuttavia, la tecnica, in quanto pericolo supremo, contiene in sé stessa anche una suprema possibilità di
salvezza. Essa è quindi, secondo Heidegger, un “Giano bifronte”, poiché se da un lato è dimensione
nichilista, dall’altro contiene la possibilità di un disvelamento più originario dell’essere, in grado di far
spazio alla verità: nella tecnica, a tratti, attraverso fugacissime intuizioni si può scorgere “un primo
incalzante lampeggiare dell’Evento”, ossia i segni dell’essenza post-metafisica dell’essere. Il Gestell è
quindi “il negativo fotografico dell’evento.”
In effetti per Heidegger la tecnica ha un duplice carattere: a) annulla la differenza tra essere e ente al
massimo grado. Potenziando al massimo grado lo sfruttamento indiscriminato dell’ente conclude la storia
della metafisica; b) libera, perciò stesso, la possibilità che la differenza ontologica tra essere e ente sia
pensata nella sua autenticità. Svela, così, l’oblio dell’essere e prepara la strada a un pensiero post-metafisico.
Nella notte buia e senza stelle, senza dèi e senza valori, proprio la tecnica prepara un’altra aurora.
Tuttavia, nonostante l’uomo possa approfondire filosoficamente la tecnica, egli non ha alcun potere su di
essa. Infatti, poiché fa capo all’essere, essa sfugge alla progettualità dell’uomo.
La tecnica si manifesta, secondo Heidegger, nelle principali dottrine politiche del Novecento, ovvero il
comunismo, il nazismo, il fascismo e democrazia “mondiale”: queste non sono altro che manifestazioni
111
apparentemente opposte dell’organizzazione tecnica del mondo che manipola le cose e sfrutta la terra,
all’insegna del consumismo sfrenato.
La fine della filosofia e il compito del pensiero
La fine della metafisica che ha obliato l’essere coincide, secondo Heidegger, con la fine della filosofia stessa:
Il pensiero a venire non è più filosofia, perché esso pensa in modo più originario della metafisica,
termine che indica la stessa identica cosa. (Lettera sull’umanesimo)
La filosofia non ha più niente da dire; non può più dire niente: perdiamo tempo. La filosofia è finita! E’ finita
perché ha assolto al suo compito; ha realizzato il suo progetto cioè la metafisica. Cosa pronuncia fin
dall’inizio? Chiama l’Essere ma chiede l’ente. Il filosofo è il competente in enti e a lui si affida ad es. il
governo della polis, ecc. Fin dall’inizio la filosofia chiede l’essere dell’ente, cioè il principio e la causa
dell’ente. Chiede la causa che produce l’ente nella sua rappresentabilità.
La filosofia interrogando l’essere come ente ha finito per dileguarsi nelle varie scienze particolari.
La filosofia si dissolve in scienze autonome: la logistica, la semantica, la psicologia, la sociologia,
l’antropologia culturale, la politologia, la poetologia, la tecnologia. […] La nuova scienza che unifica […]
tutte le varie scienze si chiama cibernetica. (La questione della determinazione della ‘cosa’ del pensiero)
La filosofia diventa scienza. Cos’è la scienza se non la scienza dell’ente. “La scienza non pensa” dirà
Heidegger, non pensa l’essere, ma l’ente. La scienza moderna è impegnata a calcolare la natura per renderla
fondo. La scienza è impegnata altresì nelle scienze umane a rendere l’uomo calcolabile. La scienza frequenta
la stessa domanda della metafisica. Meglio, è l’ultima parola della metafisica. La scienza diventa cibernetica
scienza dell’informazione. Anche il domandante (l’uomo) è ridotto a ente: informazione cibernetica, ridotto
ad algoritmico. La filosofia scompare nelle scienze umane:
psicologia, neurologia, ecc. Lo scienziato, in effetti non si
occupa più dell’essere, deve far uscire dalla porta tutte le
questioni dei fondamenti e deve far entrare tutte le
questioni di metodo. La scienza è protesa a fare dell’ente
una quantità calcolabile di informazioni. La scienza non
parla di essere ma di metodo.
E’ stato un lungo cammino quello della storia
dell’Occidente che è storia della metafisica occidentale. Un
cammino che è partito dalla Grecia e si è articolato nelle
varie figure o epoche: idea platonica, sostanza aristotelica,
cogito cartesiano, spirito assoluto hegeliano, volontà di
potenza nietzschiana, tecnica.
Siamo arrivati fin qui perché fin dall’inizio la filosofia,
forse, non era così pura come andava sbandierando: l’uomo
non è mai stato un occhio puro sul mondo! Fin dall’inizio la
filosofia andava predicando il sapore del sapere ma
nascondeva – anche a se stessa – le mire sull’ente. Fin
dall’inizio l’amore per il sapere disinteressato nascondeva
ben altri fini. Come posso impadronirmi dell’ente? Era fin
dall’inizio volontà di potenza. Per intenderci: la voglia di
verità si presenta fin dall’inizio come la voglia di fare, di
produrre l’ente. Per spingere un po’ oltre la metafora
potremmo dire che la filosofia progetta di produrre l’ente al
posto di Dio. Oggi la filosofia ha assolto il suo compito
nella scienza che è produzione dell’ente senza Dio.
112
Cosa abbiamo perso, dove ci siamo smarriti?
Eppure i greci dissero la parola: alétheia! Ma non la intesero, non la videro, la dislocarono sull’ente. Già con
Platone alétheia veniva tradotta con ‘adeguamento’, ‘corrispondenza’ tra realtà e intelletto e Agostino
definitivamente la sancisce come adaequatio rei et intellectus. Heidegger pensa, in un primo tempo, che
forse il più antico Omero… poi ci ripensa… nemmeno Omero poteva intenderla perché usa alétheia già
come ‘esattezza’ del discorso. Fatto è che alétheia nemmeno è l’originario! Alétheia è già la preoccupazione
dell’uomo nel mondo che è volontà di dominazione dell’ente nella sua semplice presenza del suo essere:
riduzione dell’essere a fondamento empirico della cosa che ho davanti, l’ente.
Non è certo demerito dei greci non averla intesa. Non siamo arrivati fin qui per un errore teoretico di qualche
filosofo come se la storia dell’essere potesse incrinarsi o prendere una strada per una formulazione filosofica
inesatta, sbagliata.
La storia della metafisica non è un errore logico e tuttavia è un errore e un errare! Un errore giacchè
abbiamo confuso l’essere con l’ente, un errare perché ci siamo imbattuti nelle varie epoche della metafisica
per addivenire alla conclusione che la strada ancorchè necessaria, non è quella giusta. La metafisica, quindi,
non è un “errore” dell’uomo, sempre abbacinato dall’ente: la “rovina” dell’essere è parte dell’essenza stessa
dell’essere; semmai, il cammino metafisico è un errore necessario. L’errare, il perdersi era ed è necessario!
La filosofia d’ora in avanti può essere solo una filosofia epigonale che si esaurisce nel mero studio del
passato.
La fine della filosofia prelude ad un tempo in cui non più il pensiero sull’ente, ma sull’essere prende il
sopravvento; un pensiero che ponga il problema dell’essere come essere, mai come ente. Dobbiamo lasciarci
alle spalle il modo di procedere della filosofia e tutto il suo apparato concettuale. Questo pensiero postfilosofico, post-metafisico è diametralmente opposto anche al pensiero scientifico come pensiero calcolante
il cui scopo è l’ente.
E’ possibile riconsiderare l’essere a partire da un salto che abbandoni il Lógos così come è stato pensato fino
ad oggi, che abbandoni la concettualità logica e si abbandoni al pensare e poetare: pensare-poetare e poetarepensare i cui paradigmi possono essere i greci antichi o Hölderlin per la modernità.
Quando supereremo la configurazione tecnica dell’essere?
Come e quando sia destino che accada, nessuno lo sa. (La svolta)
Come possiamo superare l’epoca della tecnica e del nichilismo?
Superare il pensiero metafisico, accedere al pensiero post-metafisico non è opera dell’uomo, non è un suo
progetto, qualcosa che accade a partire dall’uomo ma dall’essere stesso.
Superare e voler superare il nichilismo […] significherebbe che l’uomo va da sé contro l’essere stesso
nel suo rimanere assente. Ma chi, o che cosa, sarebbe mai abbastanza potente da andare contro
l’essere stesso […] e da portarlo a sottomettersi all’uomo? (Nietzsche)
Cosa rimane da fare all’uomo?
L’uomo ridotto a fondo non è mai solo fondo, egli è tramite attivo dello svolgersi dell’essere ma non
padrone.
All’uomo non rimane che attendere, condurre un’attesa nutrita di pensiero, poiché nella stessa essenza di
uomo vi è la sua condizione di “attendente, che attende l’essere in modo pensante”, mantenere vivo il
problema dell’essere! Metterci all’ascolto!
Non ha più senso pensare che l’uomo sia capace di auto salvarsi, che abbia nelle sue mani la possibilità di
salvarsi o di perdersi. C’è qualcosa che sfugge, che si sottrae, a cui l’uomo può solo adeguarsi cioè l’Essere.
Cosa possiamo fare?
Il problema umano non ha una soluzione umana! L’antropocentrismo è solo un capitolo nella storia della
terra.
113
Ormai solo un solo un Dio può salvarci!
E ciò a significare, non una conversione religiosa, o un affidarsi alla volontà di un Dio, quanto il
riconoscere l’angusto spazio di manovra dell’uomo all’interno dell’Essere; la coscienza della finitudine e
dei limiti umani.
CONCLUSIONI
La figura di Heidegger è notevole nel panorama filosofico del Novecento e ha diversamente animato la
riflessione filosofica sia sull’esistenzialismo che sulla essenza della tecnica.
Lo stile mistico-mitologico, manieristico, l’allusività poetica hanno fatto pensare ad Heidegger come ad un
parolaio, un pifferaio magico anche a studiosi avvezzi ad aspre asperità linguistiche.
In ogni caso Heidegger fornisce con la sua ricerca filosofica un intero tratto del volto della filosofia che
partendo dalla impostazione esistenziale e dalla scelta ne registra l’inefficacia rivelando un capovolgimento
dei mezzi in fini della storia dell’Occidente.
Al di là delle discussioni, pur fruttuose, sul primo e sul secondo Heidegger ci sembra interessante soprattutto
questo cammino che dall’individuo come progetto approda alla scelta che non da spazio più ad alcuna
soluzione umana ma al destino.
- Ambiguità di fondo
Vero è che rimane una ambiguità di fondo nel pensiero heideggeriano a proposito del superamento della
metafisica e specificatamente dell’epoca della tecnica.
Da una parte si sostiene che l’essere non è mai afferrabile giacché essere è tempo; dall’altro si ipotizza una
nuova epoca, post-metafisica, che, saltando l’oblio dell’essere, ci porta all’essere come originarietà: un
ritorno all’essere dopo esserci persi.
Da una parte sembra che possiamo afferrare l’essere attraverso un linguaggio poetico-evocativo, dall’altra si
suggerisce che l’unica possibilità che abbiamo, ormai, è ‘rammemorante’ e non possiamo uscire, come
uomini, da questa epoca della tecnica.
Questa oscillazione ha dato vita ad una interpretazione di ‘destra’ che vede in Heidegger l’alfiere di un
superamento del nichilismo per la riproposizione di un essere forte.
L’interpretazione di sinistra di Heidegger, invece, è una interpretazione che insiste sulla impossibilità di un
essere “presenziale” che si da una volta per tutte: un essere pensato nei termini della metafisica tradizionale.
Insomma, si pone l’accento sulla equazione heideggeriana di essere è tempo nel senso della storicità
dell’essere.
In effetti per Heidegger l’essere, da Parmenide a Hegel e fino a Nietzsche compreso, è pensato come
“presenzialità”, cioè come dato oggettivo, fisso e dunque determinabile una volta per tutte e non come
esistenza.
Per Platone c’è conoscenza solo se ciò che è conosciuto non diviene, ma è.
Concepito in tal modo l’essere (cioè come presenza oggettiva), la metafisica finisce col cancellare il divenire
storico.
- Filosofia irrazionalista
La filosofia di Heidegger, comunque la si voglia interpretare, è una filosofia sostanzialmente irrazionalista e
in ciò segue quella linea che dopo Hegel viene avanzando con Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche.
Questa impostazione irrazionalista è presente in Heidegger, diversamente declinata, sia in Essere e tempo
che negli ultimi scritti.
114
Il pensiero irrazionalista si presenta come un pensiero che non trova più nel Lógos, nella ragione,
nell’apparato logico concettuale una strumentazione adeguata a cogliere la realtà del mondo. Il cardine di
tale impostazione si fortifica attorno alla svalutazione della ragione, all’accettazione acritica della intuizione
che diventa la lente attraverso la quale ‘vedere’ ciò a cui la ragione è cieca.
La filosofia heideggeriana si qualifica chiaramente come un’abdicazione della ragione occidentale in linea,
dicevamo, con il pensiero irrazionalista. La ragione, il pensiero sono chiaramente da Heidegger dichiarati
inidonei, inefficienti, incapaci di comprendere la realtà del mondo: l’essere.
L’Essere, d’altra parte, non è determinabile se non attraverso una fugacissima intuizione. L’Essere si
nasconde e si dà, ma non è possibile determinare l’Essere con la forza del pensiero.
Bisogna trasformare il pensiero: lasciar cadere il pensiero. Lasciar cadere il pensiero logico-razionale a
favore di un sentire che è originarietà che è prima o oltre la razionalità.
E’ evidente che questa impostazione anti-razionalista si esponga ad infiltrazioni religiose, mistiche, ecc.
nonostante Heidegger non arrivi affatto ad una mistica e si ponga sostanzialmente fuori dal problema
religioso (A. Masullo).
La filosofia di Heidegger ha trovato una sua conclusione in una pesante metafisica di stampo neo-platonico.
L’essere in Heidegger è assolutamente trascendente.
L’essere si mostra, traluce nell’arte, nella poesia. Non ci rimane che un pensiero poetante e un poetare
pensieroso!
In questo senso Heidegger pensa alla riflessione filosofica di Marx come alla vecchia metafisica ancora
invischiato in quella lunga tradizione che vede nel Lógos, razionale, illuminista, lo strumento per la
comprensione del sociale e del cambiamento. In questo senso Heidegger pensa a Marx come figlio di
Platone!
La logica tradizionale non ci porta da nessuna parte, non ci porta a nessun disvelamento.
Bene! Quale sarà allora il nuovo strumento?
Una nuova logica individuata nel linguaggio mistico-poetico. Con questo nuovo strumento possiamo
approssimare la verità dell’essere.
Il neo-positivista R. Carnap in un celebre saggio del 1931 (Superamento della metafisica mediante l’analisi
logica del linguaggio), sottoporrà a dura critica il testo di Heidegger Che cosa è la metafisica? e i suoi
“pseudo enunciati senza senso” del procedere metafisico. Secondo Carnap, in ultima istanza, è vero che la
metafisica risulta incompatibile con la logica, ma da ciò non si deduce l’insufficienza della logica quanto
l’irrimediabile inconsistenza della metafisica.
- Pensiero idealistico
P. Chiodi, in L’ultimo Heidegger, ha acutamente rintracciato in Heidegger una forma di hegelismo
rovesciato: allo sviluppo della autocoscienza hegeliana si sostituisce il nascondimento dell’essere; il finito,
come nel sistema hegeliano, trova giustificazione e fondamento solo sotto l’ordine necessario dell’essere.
L’arguto parallelo di Chiodi ci spinge a mettere a nudo il procedimento idealistico di Heidegger. Se è vero
che la metafisica classica pensa all’essere come presenzialità, rigido, stabile e fondamento assoluto, in
Heidegger l’essere è pura temporalità che apre alle diverse epoche della storia.
Tuttavia, l’essere heideggeriano è idealistico.
La storia umana ritorna idealisticamente ad essere scandita, nientemeno, che dalla storia della metafisica e
dai suoi concetti-chiave: l’idea platonica, la sostanza aristotelica, il cogito cartesiano, ecc.
Con Heidegger, come con Hegel, è possibile leggere la storia reale dell’Occidente, ma come sulla retina
dell’occhio dove l’immagine si presenta capovolta. Abbiamo già visto Feuerbach e Marx smascherare questo
incedere tipico che inverte i normali rapporti di predicazione dove la sovrastruttura culturale diventa
fondamento!
Idealisticamente la storia dell’Occidente viene vista come oblio dell’essere, e dunque, erramento
metafisico in cui gli uomini sono agiti piuttosto che attori. Questo erramento - ci informa Heidegger - era il
115
destino dell’Occidente: il volere dell’essere, in ultima analisi! L’essere si auto-produce in figure epocali e
l’oblio dell’essere, l’erramento, la storia dell’Occidente altro non è che sentiero destinale dell’essere: non
all’uomo è data la possibilità di perdersi o salvarsi, ma allo sviluppo destinale dell’essere, appunto.
In ciò la distanza con il materialismo è abissale e si ritorna, volendo forzare un po’ la metafora, alle figure
della Fenomenologia di hegeliana memoria. Se la storia reale informava, surrettiziamente, le figure della
coscienza, con l’epoca della “tecnica”, scopertamente, la figura metafisica prende i contorni ‘tecnicamente’
storici.
Se Marx aveva riportato la storia sui piedi, ai fondamenti materiali, ecco che Heidegger ci riporta di nuovo
alle ‘figure’ dell’essere.
Il problema della tecnica, ad es. ci riporta di nuovo alle ‘figure’ dell’essere, che Heidegger imposta in termini
squisitamente idealistici: l’essenza della tecnica che ovviamente non è una questione tecnica!
Indubbiamente gli va riconosciuto il merito di aver visto in questa figura il nuovo ambiente in cui si muove
l’uomo, e le felici intuizioni sono innumerevoli, ma il tratto, quando si fa concreto, è distante dalla profondità
ad es. dell’analisi marxiana del Capitale o dei Grundisse.
Heidegger registra in forma idealistica ciò che già Marx aveva registrato, e con ben altra profondità e
coerenza, in forma materialistica: a) la presenza storica di un capovolgimento dei mezzi in fine; b) la
compressione della scelta dell’uomo pensata come pura libertà.
- Filosofia reazionaria
L’essere, la realtà non si apre al Lógos!
La rinuncia al linguaggio logico-discorsivo fa tutt’uno con il sostenere l’inafferrabilità concettuale del
mondo e ciò fa pendant con l’idea, in Heidegger, della irriformabilità dello status quo.
L’essere nelle sue figure, nelle sue epoche storiche vengono completamente canonizzate, sacralmente
accettate e giustificate.
Quando dalla tecnica passeremo ad una epoca post-metafisica, non ci è dato sapere ne come, ne quando. In
ciò è possibile scorgere il lato conservatore, reazionario della sua filosofia che infine, attende, è pensiero
rammemorante!
Come l’irrazionalismo si traduca in filosofia conservatrice e reazionaria sarà Lukàcs con La distruzione della
ragione e poi Adorno con La dialettica del negativo a metterlo ben in evidenza.
116
BIBLIOGRAFIA
Opere di Heidegger
Heidegger, Essere e tempo, Longanesi, 2011
Heidegger, Saggi e discorsi, Mursia, 1976
Opere su Heidegger
G. Vattimo, Introduzione a Heidegger, Laterza, 2010
U. Galimberti, Invito al pensiero di Heidegger, Mursia, 1986
~ GALIMBERTI
~ La vita e le opere
~ Psiche e techne
117
~ L’uomo e la tecnica
~ La tecnica è il nostro mondo
~ La tecnica è l’essenza dell’uomo
~ La genesi ‘strumentale della tecnica
~ La trasformazione della tecnica da ‘mezzo’ in ‘fine’
~ La revisione degli scenari storici
~ La soppressione di tutti i fini nell’universo dei mezzi
~ La fine della dialettica servo-padrone
~ La revisione delle categorie umanistiche
~ La tecnica e il nichilismo
~ L’inadeguatezza della comprensione umana
~ Il nichilismo e i giovani
~ CONCLUSIONI
GALIMBERTI
La vita e le opere
Nato a Monza nel 1942, Umberto Galimberti conosce e frequenta regolarmente K. Jasper. Allievo di E.
Severino è stato dal 1976 professore incaricato di Antropologia Culturale e dal 1983 professore associato di
Filosofia della Storia. Dal 1999 è professore ordinario all’università Ca’ Foscari di Venezia, titolare della
cattedra di Filosofia della Storia e Psicologia dinamica.
Membro ordinario dell’International Association Analytical Psychology è, inoltre, vicepresidente
dell’Associazione Italiana per la Consulenza Filosofica “Phronesis”. Editorialista di Repubblica.
Opere importanti: Heidegger, Jaspers e il tramonto dell'Occidente (1975), Psichiatria e Fenomenologia
(1979), Il corpo (1983), La terra senza il male. Jung dall'inconscio al simbolo (1984), e Psiche e techne.
(1999), La casa di psiche. Dalla psicoanalisi alla pratica filosofica, (2005); L’ospite inquietante. Il
nichilismo e i giovani (2007).
Psiche e techne
U. Galimberti è uno dei più autorevoli filosofi italiani che ha ampiamente studiato l’epoca della tecnica e i
cambiamenti epocali che la connotano mappandola a partire da varie angolazioni e sfaccettature.
Psiche e techne. L’uomo nella età della tecnica, del 1999, è un ampio saggio che descrive la tecnica in tutti i
suoi aspetti: partendo da una definizione chiara ed esaustiva della tecnica, spiega, poi, come essa sia
cambiata, dalla grecità fino ai giorni nostri, e ridefinisce tutta quella costellazione concettuale umanista che
ancora ci attardiamo ad usare - uomo, individuo, politica, verità, bellezza - alla luce di questo nuovo
ambiente che è la tecnica.
118
L’uomo e la tecnica
Già Heidegger aveva notato come la tecnica nasconda in se stessa il pericolo che l’uomo perda i suoi
connotati umani e divenga sempre più un ente tra gli enti, una cosa tra le cose, in un processo che spesso non
è percepito dall’uomo stesso. Nonostante Heidegger veda nell’Esserci qualcosa di diverso da una semplice
presenza, anzi, una posizione privilegiata dell’uomo rispetto all’ente, nel senso in cui egli è ascoltante e
pastore dell’essere e unico capace di profferire la domanda: Che cos’è l’essere? L’uomo non può scavalcare
l’essere. Come un uomo non è capace di saltare la sua ombra così l’Esserci non è capace di saltare l’epoca
tecnica che si configura, dunque, come un dominio completo dell’essere, vale a dire della tecnica,
sull’uomo, privato della sua possibilità di progettarsi nella libertà.
Galimberti, con Heidegger, afferma che l’uomo non è ancora in grado di comprendere l’ambiente tecnico in
cui vive tant’è che ancora malamente fa uso di categorie ormai vetuste, rinsecchite che più non riescono a
cogliere sensatamente alcunché. L’uomo in questa impreparazione complessiva, a cogliere l’ambiente in cui
viviamo - difetto di pensiero meditante come direbbe Heidegger - si attarda ancora in figurazioni concettuali
classiche e classicheggianti, frutto di lunghissime radici storiche, e non s’accorge di camminare con morti:
morte figurazioni concettuali umanistiche.
Portiamo ancora in noi i tratti dell'uomo pre-tecnologico che agiva in vista di scopi iscritti in un orizzonte
di senso, con un bagaglio di idee proprie e un corredo di sentimenti in cui si riconosceva. L'età della
tecnica ha abolito questo scenario "umanistico", e le domande di senso che sorgono restano inevase,
non perché la tecnica non è ancora abbastanza perfezionata, ma perché non rientra nel suo programma
trovar risposte a simili domande.
Già… le domande di senso rimangono inevase. L’orizzonte di senso è cancellato.
“Chi ci dette la spugna per strusciar via l’intero orizzonte?” diceva Nietzsche nella Gaia scienza. La tecnica
è la spugna che ha cassato l’orizzonte umanistico! L’ambiente è cambiato! Il “bagaglio” culturale di tipo
umanistico e pre-tecnologico, non è più capace di dare risposte e neanche di capire dove ci troviamo. Le
domande di senso sono poste all’indirizzo sbagliato. La tecnica non è iscritta in nessuna dimensione di senso:
la tecnica, semplicemente, funziona, e ciò è il suo fine.
La tecnica non ha uno scopo, non tende ad un fine, non è freccia verso nessun centro. La tecnica non si
muove verso nessuna dimensione soteriologica, salvifica. Essa, semplicemente, funziona e deve essere
efficiente.
La tecnica è il nostro mondo
Siamo portati solitamente a pensare che la tecnica sia un elemento neutrale, che possa essere impiegato
dall’uomo nel bene o nel male; ad esempio, una pistola, nell’immaginario comune, possa essere impiegata al
fine di garantire la giustizia, o mezzo per realizzare i più efferati crimini a seconda di chi la utilizza.
Secondo Galimberti invece la tecnica non è neutrale, ma impone direttamente un ambiente. L’idea che la
tecnica sia neutrale è un’idea ingenua che intende la tecnica ancora come semplice mezzo. La tecnica, ormai,
è il nostro ambiente nel senso che crea un mondo con certe caratteristiche che dettano il nostro modo di stare
al mondo. Non siamo occhi puri sul mondo! Essendo la tecnica il nostro ambiente è la condizione del nostro
vivere e operare: la condizione della nostra esistenza e la modalità all’interno della quale noi possiamo
vivere. Abitiamo la tecnica! Irrimediabilmente e senza scelta. Tale abitare non è mai neutrale giacchè
l’abitare è una modalità esperienziale. La televisione, ad esempio, non è semplicemente un mezzo neutro,
ma, come aveva intuito P. Pasolini, ci fornisce una modalità comunicativa a-dialettica, unidirezionale, excathedra che è alla base dei processi di omologazione della società di massa.
Non siamo infatti esseri immacolati ed estranei, gente che talvolta si serve della tecnica e talvolta ne
prescinde. Per il fatto che abitiamo un mondo in ogni sua parte tecnicamente organizzato, la tecnica
non è più oggetto di una nostra scelta, ma è il nostro ambiente, dove fini e mezzi, scopi e ideazioni,
119
condotte, azioni e passioni, persino sogni e desideri sono tecnicamente articolati e hanno bisogno della
tecnica per esprimersi.
L’uomo non è un ente generico ma storicamente determinato che trova il mondo che le generazioni
precedenti gli hanno lasciato con materiali, tradizioni culturali con cui continua a produrre e riprodurre le
condizioni della sua esistenza. (Marx).
La tecnica è l’essenza dell’uomo
La definizione, sintetica e precisa, che ci dà Galimberti del concetto di “tecnica”, offre numerosi spunti di
riflessione:
Con il termine "tecnica" intendiamo sia l'universo dei mezzi (le tecnologie) che nel loro insieme
compongono l'apparato tecnico, sia la razionalità che presiede il loro impiego in termini di funzionalità
ed efficienza. Con questi caratteri la tecnica è nata non come espressione dello "spirito" umano, ma
come "rimedio" alla sua insufficienza biologica.
Quando parliamo di tecnica, dunque, bisogna tener ben presente il duplice carattere, le tecnologie e la
razionalità tecnica.
La tecnica è espressione non tanto dello spirito umano, ma della insufficienza biologica. L’istinto ha
abbandonato l’uomo e lo ha lasciato solo, innanzi ad una natura che si erge maestosamente contro. E’
proprio questa latitanza dell’istinto, questa debolezza dell’apparato istintuale la forza dell’uomo. Tutta la
nostra cultura che poi si concentra nella tecnica è un’elaborazione che parte da un’insufficienza biologica;
dal momento che non siamo come un qualsiasi altro animale, rispondiamo agli stimoli esterni con azioni più
complesse e modi più articolati, che mai possono essere definiti istintuali. L’uomo ha dovuto rispondere alla
complessità della natura e al terrore che incute con una sua organizzazione razionale, e proprio grazie alla
deficienza dei suoi istinti, è riuscito ad adattarsi ai vari ambienti, superando, da un punto di vista evolutivo,
gli altri animali.
Giuste le tesi di Schopenhauer sull’”animale malaticcio” e di Nietzsche sull’”animale non stabilizzato”,
questa insufficienza è stato il punto archimedeo che ha dato all’uomo la tecnica.
In questo senso è possibile dire che la tecnica è l'essenza dell'uomo, non solo perché, a motivo della sua
insufficiente dotazione istintuale, l'uomo, senza la tecnica, non sarebbe sopravvissuto, ma anche perché,
sfruttando quella plasticità di adattamento che gli deriva dalla genericità e non rigidità dei suoi istinti, ha
potuto, attraverso le procedure tecniche di selezione e stabilizzazione, raggiungere "culturalmente" quella
selettività e stabilità che l'animale possiede "per natura".
La genesi ‘strumentale’ della tecnica
Se la tecnica è l’essenza dell’uomo, allora definire la tecnica uno strumento è un errore.
Se condividiamo la tesi che la tecnica è l'essenza dell'uomo, allora il primo criterio di leggibilità che va
modificato nell'età della tecnica è quello tradizionale che prevede l'uomo come soggetto e la tecnica
come strumento a sua disposizione. Questo poteva essere vero per il mondo antico, dove la tecnica si
esercitava entro le mura della città, che era un'enclave all'interno della natura, la cui legge incontrastata
regolava per intero la vita dell'uomo. Per questo Prometeo, l'inventore delle tecniche, poteva dire: "la
tecnica è di gran lunga più debole della necessità".
Dunque, se nel mondo antico era valido il principio per il quale era l’uomo ad essere soggetto e la tecnica un
mero strumento, ciò non è più valido per quanto riguarda il mondo moderno. Se, infatti, nel mondo greco la
tecnica era “di gran lunga più debole della necessità” ora non è più così.
120
Allora la tecnica, da strumento nelle mani dell'uomo per dominare la natura, diventa l'ambiente dell'uomo, ciò che
lo circonda e lo costituisce secondo le regole di quella razionalità che, misurandosi sui criteri della funzionalità e
dell'efficienza, non esita a subordinare alle esigenze dell'apparato tecnico le stesse esigenze dell'uomo.
Rispetto al mondo antico la tecnica ha preso il sopravvento sull’uomo e da semplice suo strumento è
divenuta il suo ambiente, ciò con cui egli deve misurarsi, rapportarsi, in cui deve vivere e respirare.
Si è già detto che la tecnica va intesa in duplice senso, sia come l’insieme vero e proprio dei mezzi materiali,
sia come razionalità tecnica, cioè come ragione e criterio tecnico per il quale è necessario raggiungere il
massimo dei risultati con il minimo dispendio di energie e sforzi (efficienza). La razionalità tecnica si
configura e si declina concretamente come procedura tecnica. Giacché la tecnica è l’ambiente dell’uomo e,
al contempo, si misura secondo i criteri di funzionalità ed efficienza, essa non esita a subordinare quelle che
sono le esigenze umane alle necessità tecniche della procedura.
La tecnica infatti è iscritta per intero nella costellazione del dominio, da cui è nata e al cui interno ha
potuto svilupparsi solo attraverso rigorose procedure di controllo che, per esser davvero tale, non può
evitare di essere planetario. Questa rapida sequenza era già chiaramente intravista e annunciata dalla
scienza moderna al suo primo sorgere quando, senza indugio e con chiara preveggenza, F. Bacone toglie
ogni equivoco e proclama: "scientia est potentia".
Già Bacone, quando diceva “la scienza è potenza”, rendeva evidente la differenza quantitativa-qualitativa
che era avvenuta in campo tecnico-filosofico: la filosofia, che ai suoi albori aveva predicato una scienza che
fosse “sapere-sapore”, priva di altri scopi all’infuori del sapere intellettuale, curiosità che deriva dalla
meraviglia (Aristotele) giunge alla consapevolezza che il sapere tecnico si traduce in potenza capace di
trasformare la natura e di metterla in produzione.
La trasformazione della tecnica da ‘mezzo’ in ‘fine’
Tuttavia ai tempi di Bacone “i mezzi tecnici erano ancora insufficienti” e, dunque, il margine di autonomia
che la tecnica lasciava all'uomo era ancora abbastanza ampio tale che l’uomo “poteva ancora rivendicare la
sua soggettività e il suo dominio sulla strumentazione tecnica”. Ma, come il buon vecchio Hegel insegnava
con la sua dialettica formula della trasformazione della quantità in qualità, la quantità tecnica si è trasformata
in qualità tecnica: il mero aumento tecnico in ambiente. Oggi il dominio della tecnica è così ampio e vasto,
così estensivo ed intensivo, che l’uomo non ha più la possibilità di sottrarsene vivendone all’interno.
Finché la strumentazione tecnica disponibile era appena sufficiente per raggiungere quei fini in cui si
esprimeva la soddisfazione degli umani bisogni, la tecnica era un semplice mezzo il cui significato era
interamente assorbito dal fine, ma quando la tecnica aumenta quantitativamente al punto da rendersi
disponibile per la realizzazione di qualsiasi fine, allora muta qualitativamente lo scenario, perché non è
più il fine a condizionare la rappresentazione, la ricerca, l'acquisizione dei mezzi tecnici, ma sarà la
cresciuta disponibilità dei mezzi tecnici a dispiegare il ventaglio di qualsivoglia fine che per loro tramite
può essere raggiunto. Così la tecnica da mezzo diventa fine, non perché la tecnica si proponga qualcosa,
ma perché tutti gli scopi e i fini che gli uomini si propongono non si lasciano raggiungere se non
attraverso la mediazione tecnica.
In un’economia di sussistenza, ove ciò che si produce è fine al soddisfacimento dei propri bisogni, ogni
strumento ha una funzione esplicita, chiara e cristallina, con uno scopo ben definito. Quando però la quantità
della tecnica aumenta a dismisura, subentra una trasformazione qualitativa, così che, la tecnica diventa essa
stessa un fine.
È necessario disporre della tecnica in generale perché solo con essa è possibile raggiungere qualsiasi fine ci
si prefigge.
Tutti i nostri scopi hanno una mediazione tecnica, ma la tecnica ha, a sua volta, un fine?
121
Se per noi la tecnica è divenuta uno scopo, non è altrettanto vero che essa si muova secondo una direzione
verso un obiettivo. La tecnica vuole solo se stessa, si auto-perpetra e non ha altro scopo se non quello di
perfezionarsi indipendentemente da ogni altra cosa: è essa un’auto-produzione.
Già Marx aveva descritto questa trasformazione dei mezzi in fini a proposito del denaro che, se come
mezzo, serve a produrre beni e a soddisfare bisogni, quando beni e bisogni sono mediati per intero dal
denaro, allora il conseguimento del denaro diventa il fine, per raggiungere il quale, se necessario, si
sacrifica anche la produzione dei beni e la soddisfazione dei bisogni.
La tecnica assume le caratteristiche già descritte da Marx e attribuite al denaro, che, da mezzo di scambio,
diviene fine dell’uomo nel momento in cui rappresenta equivalente generale che può comprare tutto e che
può soddisfare ogni bisogno. La tecnica diventa equivalente generale!
E. Severino osserva che se il mezzo tecnico è la condizione necessaria per realizzare qualsiasi fine che non
può esser raggiunto prescindendo dal mezzo tecnico, il conseguimento del mezzo diventa il vero fine che
tutto subordina a sé.
Come non citare il Marx dei Manoscritti economico-filosofici del 1844 che su questo punto schizza il
concetto di denaro in modo memorabile:
Il denaro, perché possiede la qualità di comprar tutto, la qualità di appropriarsi tutti gli oggetti, è così
l’oggetto in senso eminente. L’universalità della sua qualità è l’onnipotenza del suo essere; esso vale
quindi come essere onnipotente (Manoscritti economici filosofici)
Poi riprende il grande Shakespeare con il Timone d’Atene:
Tanto di questo [oro] fa il nero bianco, il brutto bello, il cattivo buono, il vecchio giovane, il vile
valoroso, l’ignobile nobile. […] Maledetto metallo, comune bagascia del genere umano che smuove la
marmaglia dei popoli.
La revisione degli scenari storici
Se l’ambiente dell’uomo è ormai la tecnica e l’uomo si esprime inevitabilmente attraverso il suo ambiente,
che a sua volta non è neutrale nei confronti dell’uomo che non esiste come individuo indipendente, ma
sempre in relazione alla storia, al modo di produzione con cui l’uomo produce e riproduce la sua esistenza,
allora l’uomo si esprime attraverso la tecnica, così che anche le sue modalità esperienziali sono mediate da
essa.
Soggetto della storia non è più l’uomo, ma la tecnica.
Se la tecnica diventa quell'orizzonte ultimo a partire dal quale si dischiudono tutti i campi d'esperienza,
se non è più l'esperienza che, reiterata, mette capo alla procedura tecnica, ma è la tecnica a porsi come
condizione che decide il modo di fare esperienza, allora assistiamo a quel capovolgimento per cui
soggetto della storia non è più l'uomo, ma la tecnica che, emancipatasi dalla condizione di mero
"strumento", dispone della natura come suo fondo e dell'uomo come suo funzionario.
La tecnica, liberatasi dalla condizione di semplice strumento, si pone come soggetto della storia, facendo
della natura il suo fondo e dell’uomo un suo funzionario, portando, conseguentemente, ad un mutamento
“dei tradizionali modi di intendere la ragione, la verità, l'ideologia, la politica, l'etica, la natura, la religione e
la stessa storia”.
- La ragione.
122
La ragione non è più l'ordine immutabile del cosmo in cui prima la mitologia, poi la filosofia e infine la
scienza si erano riflesse creando le rispettive cosmo-logie, ma diventa procedura strumentale che garantisce
il calcolo più economico tra i mezzi a disposizione e gli obiettivi che si intendono raggiungere.
La ragione, diremmo il Lógos, nell’epoca della tecnica, va declinata in ragione strumentale, meglio,
procedura strumentale che assicura l’efficienza, ossia il procedimento più economico per ottenere, dai
mezzi disponibili, il massimo risultato. Il Lógos si declina ora in con tecno-logia.
- La verità.
La verità non è più conformità all'ordine del cosmo o di Dio perché, se non si dà più orizzonte capace di
garantire il quadro eterno dell'ordine immutabile, se l'ordine del mondo non dimora più nel suo essere,
ma dipende dal "fare tecnico", l'efficacia diventa esplicitamente l'unico criterio di verità.
Del vecchio concetto di alétheia, intesa come verità eterna ed immutabile, non resta più nulla.
La luce scintillante di alétheia che disvela e porta in chiaro ciò che era nel buio ora piega risolutamente
sull’efficace. La ben rotonda e piena verità assoluta, che faceva tremare il cuore ancora ad Hegel, svanisce,
evapora. Verità è, semplicemente, ciò che è efficace nella procedura tecnica!
- Le ideologie.
Le ideologie, la cui forza riposava sull'immutabilità del loro corpo dottrinale, nell'età della tecnica non
reggono alla dura riduzione di tutte le idee a semplici ipotesi di lavoro.
Nell’epoca della tecnica tutto viene relativizzato, nulla è più fondato. Le ideologie sono per loro stessa natura
Weltaschaung troppo rigide, ampie, che poco si adattano ai continui cambiamenti e alla necessità continua di
corrispondere alle procedure tecniche. Esse si riducono, così, a mere ipotesi di lavoro, che hanno da
dimostrare la loro efficacia nell’ambito della procedura tecnica.
- La politica.
La politica, che Platone aveva definito "tecnica regia" perché assegnava a tutte le tecniche le rispettive
finalità, oggi può decidere solo in subordine all'apparato economico, a sua volta subordinato alle
disponibilità garantite dall'apparato tecnico.
In campo filosofico la politica ha da sempre ricoperto un ruolo di massima importanza, dal momento che uno
dei fini della filosofia è quello di rendere migliori le condizioni della comunità; ogni filosofo ha delineato
una politica capace di essere veicolo ed espressione del proprio sistema filosofico. Nessuna filosofia può
dirsi esente da implicazioni politiche.
La politica come amministrazione della polis a misura d’uomo e avente l’uomo come fine muta di segno. La
tecnica ha piegato le esigenze umane alle proprie necessità, così che la politica è diventata semplice scienza
dell’amministrazione tecnica.
Destra e sinistra sono divenute, politicamente, categorie superflue nell’epoca della tecnica perché l’uomo è
ormai ridotto a funzionario, non più padrone dell’apparato tecnico
In questo modo la politica si trova in quella situazione di adattamento passivo, condizionata com'è dallo
sviluppo tecnico che essa non può controllare e tantomeno indirizzare, ma solo garantire. Riducendosi
sempre di più a pura amministrazione tecnica, la politica mantiene un ruolo attivo e quindi decisionale
solo là dove la tecnica non è ancora egemone, o dove nella sua egemonia presenta ancora delle lacune o
delle insufficienze in ordine al vincolo della sua razionalità strumentale.
123
- L’etica.
L’etica, come forma dell'agire in vista di fini, celebra la sua impotenza nel mondo della tecnica regolato
dal fare come pura produzione di risultati, dove gli effetti si addizionano in modo tale che gli esiti finali
non sono più riconducibili alle intenzioni degli agenti iniziali. Ciò significa che non è più l'etica a scegliere i
fini e a incaricare la tecnica a reperire i mezzi, ma è la tecnica che, assumendo come fini i risultati delle
sue procedure, condiziona l'etica obbligandola a prender posizione su una realtà, non più naturale ma
artificiale, che la tecnica non cessa di costruire e render possibile, qualunque sia la posizione assunta
dall'etica.
Non è più l’etica a scegliere i fini e a incaricare la tecnica a reperire i mezzi per realizzarli. Essa non è più un
elemento che pone un obiettivo da realizzare con la tecnica, ma il procedere tecnico si è completamente reso
indipendente dall’etica. Il suo fine è iscritto nelle sue procedure ovvero, se le cose tecnicamente devono
giungere ad un risultato, inevitabilmente sarà quello l’obiettivo. L’etica diventa serva della tecnica e la segue
a distanza adeguandosi alla sua agenda. L’agenda degli argomenti tecnici non la detta più il soggetto, ma la
tecnica e l’etica arranca dietro a questa lepre che sempre sfugge. Etica, bioetica, ecc. a rincorrere la tecnica
che non solo detta l’agenda dei ‘lavori’ ma anche i tempi e i modi di risoluzione.
[...] una volta che l'"agire" è subordinato al "fare", come si può impedire a chi può fare di non fare ciò
che può? Non con la morale dell'intenzione inaugurata dal cristianesimo e riproposta nei termini della
"pura ragione" da Kant, perché questa, fondandosi sul principio soggettivo dell'autodeterminazione e
non su quello della responsabilità oggettiva, non prende in considerazione le conseguenze oggettive
delle azioni e, proprio perché si limita a salvaguardare la "buona intenzione", non può essere all'altezza
del fare tecnico. Ma all'altezza non è neppure l'etica della responsabilità.
L’etica delle intenzioni - di cristiana memoria - non è più all’altezza dei tempi; con Max Weber si affermava
che l’etica doveva essere tale da prevedere l’esito di un’azione. L’etica della responsabilità fa si che
l’azione sia inquadrata in un sistema di riferimento non solo soggettivo-intenzionale, ma più ampio, capace,
cioè, di cogliere di quella azione la sua interazione con il mondo. L’etica della responsabilità, dunque,
significa rispondere delle conseguenze (prevedibili) delle proprie azioni. Ovvero, nel caso dell’elemosina,
mentre l’etica delle intenzioni si limita al gesto caritatevole, l’etica della responsabilità si preoccupa di capire
anche come viene “utilizzato” il gesto di carità, se per fini etici o meno.
Il problema però, è che nell’ambito della tecnica, non si conosce il fine della tecnica. Dunque, nemmeno
l’etica della responsabilità, così come quella dell’intenzione, è all’altezza della situazione storica poiché la
procedura tecnica porta a scenari storici non prevedibili. La nostra capacità di previsione è notevolmente
ridotta e non perché vi è un minimo di conoscenza riguardo al massimo di capacità.
Come faremo a non fare ciò che possiamo fare? Come non utilizzeremo ciò che possiamo utilizzare? Come
faremo a sottrarci a questi criteri della tecnica? Come faremo a sottrarci ad un’etica in cui a dettare i principi
non sono più gli uomini ma le cose?
- La natura.
Il rapporto uomo-natura è stato regolato per noi occidentali da due visioni del mondo: quella greca che
concepisce la natura come dimora di uomini e dèi e quella giudaico-cristiana, poi ripresa dalla scienza
moderna, che la concepisce come campo di dominio dell'uomo.
La concezione di tipo greco inquadra la natura in un tempo di tipo circolare; la natura è la dimensione
all’interno del quale l’uomo greco vive. La concezione invece giudaico-cristiana, poi di tipo scientifica,
concepisce la natura come oggetto del consumo, come oggetto di dominio. L’uomo è al vertice di una
piramide gerarchica della natura, e da tale posizione esercita il suo dominio sulla natura.
Per differenti che siano, queste due concezioni convengono nell'escludere che la natura rientri nella sfera di
competenza dell'etica, il cui ambito è stato finora limitato alla regolazione dei rapporti fra gli uomini, senza
alcuna estensione agli enti di natura.
124
Ciò accade per un duplice motivo: sia la concezione di tipo greco, sia quella giudaico-cristiana, fino alla
rivoluzione industriale, non si pongono il problema della natura e del rapporto tra natura e uomo perché la
natura è ‘sovrabbondante’. Non è proprio nell’orizzonte umano un rapporto ‘etico’ con la natura.
Quest’ultima è lì come presenza che l’uomo può dominare. E’ con la rivoluzione industriale che si porrà il
rapporto con la natura in maniera problematica. La capacità di antropomorfizzare la natura e di lacerarla ad
opera dell’uomo pone il problema del limite e del rispetto cioè dell’equilibrio.
Ma oggi, che la natura mostra tutta la sua vulnerabilità per effetto della tecnica, si apre uno scenario di fronte al
quale le etiche tradizionali si fanno mute, perché non hanno strumenti per accogliere la natura nell'ambito della
responsabilità umana.
Le etiche si fanno mute e la natura fino ad oggi non è stata mai pensata nell’ambito della responsabilità
umana. Basti pensare che le riflessioni etiche riguardanti l’economia sostenibile, che tra l’altro stentano a
decollare, sono relative agli ultimi quarant’anni.
- La religione.
[…] ha come suo presupposto quella dimensione del tempo dove alla fine (éschaton) si realizza ciò che
all'inizio era stato annunciato. Solo in questa dimensione "escatologica", che iscrive il tempo in un
disegno, tutto ciò che accade nel tempo acquista il suo senso. Ma la tecnica, sostituendo alla dimensione
escatologica del tempo quella progettuale contenuta, come scrive S. Natoli, tra il recente passato in cui
reperire i mezzi disponibili e l'immediato futuro in cui questi mezzi trovano il loro impiego, sottrae alla
religione, per effetto di questa contrazione del tempo, la possibilità di leggere nel tempo un disegno, un
senso, un fine ultimo a cui poter far riferimento per pronunciare parole di salvezza e verità.
L’uomo, nel tempo circolare greco, era inserito nella natura e in questo tempo delle stagioni perenni trovava
un senso, una culla in cui tutto aveva un posto ordinario e ordinato. Il tempo lineare di tipo cristiano era una
freccia scagliata verso un obiettivo e perciò stesso dotato di senso: tutto s’impilava in una sequenza che
aveva una precisa direzione di senso e le singole parti erano fotogrammi il cui senso era iscritto nel fine. Con
la tecnica la religione non è più dimensione salvifica in quanto perde possibilità di essere guida, direzione e
fine. La tecnica sostituisce il tempo escatologico con quello progettuale dove il tempo è contratto
nell’oscillazione tra il reperimento dei mezzi e il loro subitaneo impiego.
- La storia.
Si costituisce nell'atto della sua narrazione che ordina l'accadere degli eventi in una trama di senso. Il
reperimento di un senso traduce il tempo in storia, così come il suo smarrimento dissolve la storia nel
fluire insignificante del tempo. Il carattere afinalistico della tecnica, che non si muove in vista di fini ma
solo di risultati che scaturiscono dalle sue procedure, abolisce qualsiasi orizzonte di senso,
determinando così la fine della storia come tempo fornito di senso.
Se l’uomo non si muove verso un obiettivo, la storia, gli eventi non hanno più senso ma sono solo ciò che
accade: La storia è solo un grande minestrone di fatti, un puro accadere insensato e caotico che non ha più
senso e le azioni delle grandi Nazioni non trovano più un posto in un ‘disegno’. La Città di Dio di
sant’Agostino aveva messo insieme, in un tempo lineare, storia ed escatologia cristiana; la tecnica, non
avendo nessun orizzonte, fa della narrazione storica una mera sequela di fatti privi di senso immersi nel puro
accadere accidentale.
Rispetto alla memoria storica, la memoria della tecnica, essendo solo procedurale, traduce il passato
nell'insignificanza del "superato" e accorda al futuro il semplice significato di "perfezionamento" delle
procedure.
125
Il passato storico non è altro per la tecnica che un sistema di procedure e il futuro semplicemente un arco per
perfezionare le procedure precedenti.
L'uomo, a questo punto, nella sua totale dipendenza dall'apparato tecnico, diventa astorico, perché non
dispone di altra memoria se non quella mediata dalla tecnica, che consiste nella rapida cancellazione del
presente e del passato per un futuro pensato solo in vista del proprio autopotenziamento.
La storia precedente viene contratta dalla tecnica in quanto il suo sguardo è esclusivamente rivolto
all’immediato futuro, ma non perché il futuro abbia un senso, un fine, ma solo per perfezionare le
procedure tecniche.
La fine della storia non è da intendersi, dunque, come impossibilità del succedersi dei fatti, quanto piuttosto
come la perdita di un orizzonte di senso, cioè di una visione complessiva attraverso cui poter valutare e
ordinare gli accadimenti storici.
La soppressione di tutti i fini nell’universo dei mezzi
Nella mitologia, il primo mezzo tecnico che Prometeo fornisce all’uomo ha ancora le caratteristiche di uno
strumento, non di una macchina, e serve, dunque, a raggiungere semplicemente un fine. Anche la promessa
biblica dice che l’uomo è destinato a un continuo e costante progresso attraverso l’uso della tecnica e il
dominio sulla natura.
Insomma, la direzione è verso una libertà che significa esser sciolti da qualsiasi condizionamento.
Ora è la tecnica ad essere l’assoluto privo di qualsiasi legame!
Nell’ambiente tecnico, invece, l’uomo è assoggettato dalla tecnica ed è inconsapevole di questa sua
condizione.
Per effetto di questa inconsapevolezza, chi aziona l'apparato tecnico o chi vi è semplicemente inserito,
senza poter più distinguere se è attivo o è a sua volta azionato, più non si pongono la domanda se lo
scopo per cui l'apparato tecnico è messo in azione sia giustificabile o abbia semplicemente un senso,
perché questo significherebbe dubitare della tecnica, senza di cui nessun senso e nessuno scopo
sarebbero raggiungibili, e allora la "responsabilità" viene affidata al "responso" tecnico, dove è sotteso
l'imperativo che si "deve" fare tutto ciò che si "può" fare.
Il negativo è circoscritto all’errore tecnico, al guasto, al difetto. La tecnica si presenta come un intero
universo di mezzi che non ha nessun fine, meglio, i suoi effetti si traducono nei suoi fini che dunque significa
incremento infinito della tecnica in quanto tecnica.
Se nell’età pre-tecnologica i fini e gli scopi umani avevano ancora qualche senso per orientare l’azione ora
non ha senso porsi tale problema giacchè è positivo ciò che si inscrive nell’esercizio tecnico.
Lo stesso bisogno disperato e affannoso di senso che ora si vive nell’ambito della tecnica e a cui religione e
psicanalisi cercano di dar risposte testimoniano che lo stesso senso, il voler a tutti i costi un senso è diventato
puro mezzo in un universo di mezzi. Pertanto anche le dimensioni salvifiche della religione e della
psicanalisi risultano ridotti a puri mezzi tecnici che ci permettono di trovare un contatto con il proprio io e
acquietare l’inquietudine. La fede a tutti i costi venduta porta a porta, i corsi serali sulla salute psichica sono
le note evidenti di un ‘senso’ della vita diventato mezzo per vivere.
La fine della dialettica servo-padrone
Là dove il mondo della vita è per intero generato e reso possibile dall'apparato tecnico, l'uomo diventa
un funzionario di detto apparato e la sua identità viene per intero risolta nella sua funzionalità, per cui è
126
possibile dire che nell'età della tecnica l'uomo è presso-di-sé solo in quanto è funzionale a quell'altroda-sé che è la tecnica.
Nello stesso modo in cui Marx diceva che l’uomo si sente umano nelle sue funzioni bestiali e animale nelle
sue funzioni umane (Manoscritti eonomico-filosofici), Galimberti avverte che l’uomo nell’età della tecnica si
sente presso-di-sé quando è altro-da-sé, cioè si sente umano quando è appendice dell’apparato tecnico,
mentre si ritrova spaesato nel momento in cui deve esplicare le sue funzioni più propriamente umane.
L’apparato tecnico per grandezza e autonomia si erge ora maestoso di contro all’uomo che viene ridotto a
funzionario dell’apparato tecnico.
L’alienazione tecnologica, secondo Galimberti, è sostanzialmente diversa dall’alienazione che Marx
raccontava a proposito dell’alienazione del lavoro.
Quando Marx parla dell’alienazione configura questo esser altrove, questa estraneazione in una dimensione
che prevede ancora uno scenario in cui l’uomo è soggetto, protagonista, insomma, un orizzonte umanistico.
L’uomo è ancora soggetto e la tecnica ancora pensata, vissuta come strumento. Lo scenario umanistico è
ancora presente nella stessa elaborazione della dialettica storica, del materialismo storico dialettico, appunto,
dove la storia è si influenzata, in ultima istanza, dalla struttura economica, ma sono gli uomini, ancora, a fare
la storia. La rivoluzione ad es. non è semplicemente il prodotto di cause economiche ma la concomitanza di
più fattori dove la soggettività della classe è elemento fondamentale. Lo stesso comunismo è un movimento
reale, ma anche ciò che risolve positivamente l’alienazione giacchè risolve la contraddizione della
produzione sociale e della appropriazione privata. Insomma, Marx si attarda ancora in un alveo umanistico
che si riferisce ad un uomo pre-tecnologico. Nell’epoca della tecnica il capovolgimento avvenuto fa si che
l’uomo è predicato della tecnica.
Dunque, il concetto di alienazione marxiano è ormai insufficiente a perimetrare la complessità dell’epoca
nostra. La stessa analisi della ‘civiltà delle macchine’ cioè lo scenario della tecnica che Marx per primo
profetizzò non è più idoneo a comprendere la contemporaneità.
Marx si muove ancora in un orizzonte umanistico, con riferimento all’uomo pre-tecnologico, dove,
come vuole la lezione di Hegel, il servo ha nel signore il suo antagonista, e il signore nel servo, mentre,
nell’età della tecnica, non ci sono più né servi né signori, ma solo le esigenze di quella rigida razionalità
a cui devono subordinarsi sia i servi sia i signori.
La fiducia nell’uomo e nella ragione ascrive Marx a una visione filosofica che ormai è considerata vetusta è
superata dall’epoca tecnica. Per Galimberti, “l’uomo non è in grado di percepirsi più come ‘alienato’”. La
dialettica servo-padrone, più specificatamente, quella capitalista-operaio marxista è stata assorbita nella
figura totalizzante della tecnica.
L’alienazione, infatti, può sussistere solo nel momento in cui un uomo, l’operaio, viene effettivamente
espropriato di qualcosa da qualcun altro, il capitalista; in un’epoca, invece, in cui tutti sono dominati dalla
tecnica, non si ha la percezione, nel sentire comune, di ciò che si sta perdendo, dunque è impossibile parlare
della stessa alienazione. L’alienazione, insomma, ha bisogno di una figura che sente la scissione da sé mentre
nell’epoca della tecnica si ha piuttosto un processo di identificazione con l’apparato tecnico che come
apparato non concede nelle sue procedure altro da sé.
Si può anzi dire che la tecnica diventa l’unico ambiente possibile per l’uomo, che quindi è costretto a un
processo di identificazione tecnologica.
La revisione delle categorie umanistiche
Tutte le categorie umanistiche devono essere completamente, radicalmente rifondate alla luce dell’ambiente
tecnico in cui viviamo.
127
- L’individuo. Il concetto di individuo, faticosamente elaborato, forgiato in secoli di storia, nell’era della
tecnica è destinato a dissolversi. Muore l’individuo come libertà, autonomia, consapevolezza di singolarità.
Dell’individuo non rimane più nulla, solo, ancora la sua inconsistenza umbratile.
- L’identità. Il concetto di identità la cui storia si sagoma anch’essa faticosamente con l’uscire dalla
appartenenza e dalla indistinzione dal gruppo, pian piano dilegua. Il riconoscimento della identità era
indissolubilmente legato all’azione dell’individuo che fungeva da cartina di tornasole della essenza del
singolo, ora non può essere più letta come tale. L’azione dell’individuo è completamente inserita nelle
procedure tecniche sicchè essa risponde solo alla forma dell’esecuzione. Le azioni di un individuo non
rivelano più la sua anima, bensì l’adeguamento dello stesso individuo all’apparato tecnico. Così è
impossibile trovare un’identità dell’individuo prescindendo dalla funzione che quest’ultimo svolge
all’interno della procedura tecnica; ne consegue, quindi, che identità = funzionalità.
Mentre nell'età pre-tecnologica era possibile riconoscere l'identità di un individuo dalle sue azioni,
perché queste erano lette come manifestazioni della sua anima, intesa come soggetto decisionale, oggi
le azioni dell'individuo non sono più leggibili come espressioni della sua identità […]. Eseguendole, il
soggetto non rivela la sua identità, ma quella dell'apparato, all'interno del quale l'identità personale si
risolve in pura e semplice funzionalità.
- La libertà. Nell’epoca della tecnica assume un rilievo particolare la libertà come competenza che viene
esercitata all’interno dei rapporti professionali e che come tali sono impersonali. La funzione che l’individuo
svolge all’interno dell’apparato entra in conflitto con le aspirazioni personali dello stesso individuo. Ciò non
è altro che la manifestazione di una condizione patologica di schizofrenia, dovuta alla separazione sempre
più profonda tra la sfera pubblica e quella privata. Si ha quindi che
gli individui reagiscono al senso di impotenza che sperimentano ripiegandosi su se stessi e,
nell'impossibilità di riconoscersi comunitariamente, finiscono con il considerare la società stessa
in termini puramente strumentali.
- La cultura di massa. La cultura di massa implica direttamente la massificazione ossia quel processo per
cui non siamo più in presenza di una semplice concentrazione di molti quanto la produzione di una massa
che consuma le stesse cose ma in maniera solipsistica. Prodotti di massa, consumi di massa, informazione di
massa fanno si che rifocillino in massa singoli individui che sanno tuttavia di avere un consumo privato,
personale, originale dei prodotti. Il singolo ha la sensazione di esperire una vita individuale pur consumando
prodotti di massa, creati in serie ma che apparentemente rispondono ai bisogni di ognuno. Si slabbra allora
quel diaframma tra il pubblico e il privato giacchè ciascuno è stato rifornito in privato di ciò che poi incontra
in pubblico. Da ciò si articolano processi di de-individuazione che portano a società omologate e
conformiste.
- I mezzi di comunicazione di massa. La comunicazione è ormai una rete di mezzi che ci esonera
dall’obbligo della esperienzialità. McLuhan, in Strumenti del comunicare (1867), è stato uno dei primi a
mettere in evidenza i mutamenti antropologici prodotti dal media nell’uomo. Forse in questo più che in altri
casi si può constatare come il mezzo tecnico non è affatto neutrale ma ‘impone’ una modalità comunicativa,
intervenendo sulle stesse modalità comunicative e facilita i processi di omologazione.
Non abbiamo più bisogno dell’esperienza diretta. I mezzi di comunicazione hanno sostanzialmente e
radicalmente modificato il nostro modo di fare esperienza abolendo le classiche modalità esperienziali del
tempo, dello spazio. I media propongono presente il passato, vicino ciò che è lontano, ma anche assente ciò
che è stato individualmente ‘visto’.
La realtà della informazione è ad un tempo tutt’altro che neutra giacchè gli eventi vengono ‘allestiti’,
codificati in termini che sono già pronti per essere digeriti. L’evento diventa bolo alimentare pronto per il
passaggio successivo a chimo, ecc.
128
La comunicazione diventa un monologo collettivo in cui il cardine dell’esperienza comunicativa vissuta
individualmente frana completamente in ascoltanti ex-cathedra come aveva già intuito P. Pasolini.
- La psiche. Nell’epoca pre-tecnologica l’individuo era quel fascio di esperienze individuali che esperiva.
Oggi, invece, l’individuo, allevato nell’oblio dell’esperienza singolare si ritrova senza alcun diaframma tra
interiorità ed esteriorità: ciò che mi rappresento coincide con la rappresentazione comune; tra superficie e
profondità in quanto la profondità finisce per essere semplice accettazione delle regole sociali; tra attività e
passività in quanto l’unica attività possibile è l’adattamento alle procedure tecniche. Infine, è propria
dell’età della tecnica una cultura che tende al potenziamento delle facoltà intellettive su quelle emotive assai
poco controllabili.
La tecnica e il nichilismo.
Fin dall’inizio il nulla si è fatto presente, si è affacciato nella riflessione filosofica delle origini, ma solo con
l’età della tecnica essa mostra il suo volto severo e disincantato; solo con l’età della tecnica il nichilismo
diventa l’aria che respiriamo, il paesaggio che vediamo, il labirinto che percorriamo.
Sulle orme della definizione di Nietzsche di nichilismo attivo e passivo, Galimberti dice che la forma attiva
è propriamente la forma che assume la tecnica che è uscita da qualsiasi orizzonte di senso. L’abolizione dei
fini fa si che non vi sia alcun senso da cogliere. Si genera da questa mancanza di senso la ricerca affannosa di
senso per l’uomo occidentale; si genera, allora, quel nichilismo passivo per cui sembra che i fini sono
inadeguati e bisogna rintracciarne altri all’altezza storica che ristorano, acquietano, stordiscano.
Eppure, dice Galimberti, il nichilismo filosofico profetizzato da Nietzsche è ben pallida cosa rispetto al
nichilismo della tecnica perché vien messo in gioco non solo il senso dell’essere, ma l’essere stesso
dell’uomo e del mondo. Nietzsche ha solo profetizzato ciò che la tecnica sta realizzando come potere reale:
la nientificazione!
Il nichilismo culturale, da Schopenhauer a Nietzsche ad Heidegger rimane a livello culturale, mentre il
nichilismo tecnico ha, ormai, il potere concreto di annientare il mondo e l’uomo ed è uscito “dal cerchio
ristretto delle tendenze culturali per divenire coscienza comune e mentalità di massa”.
L’inadeguatezza della comprensione umana
Che cosa è e cosa diventa l’uomo nell’età della tecnica? La natura umana non è nulla di stabile, originario,
archetipico data una volta per tutte. Essa è storia, è tempo! E’ produzione, lavoro! L’uomo è dunque, il suo
fare che determina anche l’orizzonte della sua comprensione. Non esiste la natura umana al di fuori di una
modalità del darsi tecnico. La questione che si pone, tuttavia, è che se l’uomo si è sempre rapportato in un
mondo poco trasformabile, oggi la tecnica si presenta come la possibilità estrema e illimitata della
manipolabilità del mondo.
Quanto più l’apparato tecnico si erge maestoso e fittamente intrecciato tanto più cala la nostra capacità di
immaginazione o di previsione e di percezione del dove stiamo andando rispetto ai fini. Ciò comporta che
il nostro sentimento diventa incapace di agire.
A paralizzare la nostra immaginazione non è solo questo impianto gigantesco ma la parcellizzazione dei
processi lavorativi che non ci permette più di seguire la trama dell’intero processo anche se conchiuso
cosicchè lo stesso nostro fare ci appare senza senso. Non riusciamo più, non solo a prevedere, ma
semplicemente a intravedere gli effetti, gli esiti, gli scopi e il senso. E’, dunque, possibile che l’addetto al
campo di sterminio possa dire che ha soltanto “lavorato”. Questo gap fa si che si insinui quel nichilismo
passivo di cui parla Nietzsche che il troppo grande ci lascia troppo freddi. Come analfabeti emotivi
assistiamo passivi alla proliferazione nucleare, alla distruzione dell’ambiente, alla morte per fame di un
bambino ogni 5 secondi. C’è insomma un’inadeguatezza del nostro sentire. E’ proprio questa inadeguatezza
a rendere possibile, infine, lo sterminio di sei milioni di ebrei. Possibile e ripetibile! Si inceppa, tra l’altro, il
sentimento della responsabilità.
129
Il nazismo è, da questo punto di vista l’irrazionalità che scaturisce dalla perfetta razionalità organizzativa. La
Shoah è simbolo della perfetta organizzazione del ‘lavoro’ cioè dello sterminare, in una perfetta razionalità
della macchina organizzativa. Il nazismo è la figura che meglio di altre segna “l’atto di nascita dell’età della
tecnica”.
Senza la tecnica l’uomo non sarebbe sopravvissuto con la sua carenza biologica e, d’altra parte, proprio la
sua carenza gli conferisce una plasticità comportamentale inusitata alle altre specie.
Prometeo (“colui che pensa in anticipo”), regalando il fuoco agli uomini, simbolo della tecnica, si è
trasformato in colui che non è capace di prevedere le ‘fiamme’.
Oggi la nostra capacità previsionale, di anticipazione è fortemente compromessa e in ciò risiede il nostro
massimo pericolo. Rimane una flebile speranza. Una maggiore capacità di comprensione, “ben lungi
dall’esser sufficiente per dominare la tecnica, evita almeno all’uomo che la tecnica accada a sua insaputa”.
Occorre evitare che la nostra prossima domanda sia: Che cosa la tecnica può fare di noi?
Il nichilismo e i giovani
I giovani stanno male, ma non sempre lo sanno!
Stanno male non tanto per le normali crisi esistenziali-adolescenziali quanto perché vivono un ambiente dove
si aggira un ospite inquietante. L’ospite inquietante di cui parlava Nietzsche è tra noi e fagocita tutto: invade
e distrugge tutti i valori che la cultura occidentale aveva lentamente conquistato. E’ l’ospite inquietante che
cancella gli orizzonti! E’ Nietzsche ad annunciare che:
L’uomo moderno crede sperimentalmente ora a questo ora a quel valore, per poi lasciarlo cadere. Il
circolo dei valori superati e lasciati cadere è sempre più vasto. Si avverte sempre più il vuoto e la povertà
di valore. Il movimento è inarrestabile, sebbene si sia tentato in grande stile di rallentarlo. Alla fine l’uomo
osa una critica dei valori in generale; ne riconosce l’origine, conosce abbastanza per non credere più in
nessun valore; ecco il pathos, il nuovo brivido. Quella che racconto è la storia dei prossimi due secoli .
(Nietzsche, Frammenti postumi 1887-1888)
E’ diventato ormai impossibile prescindere dalla tecnica, che ha annullato qualsiasi orizzonte di senso e ha
imposto il suo modo di ragionare in termini di massima funzionalità ed efficienza, spostando su un piano
completamente subalterno il proprio Io e quindi la logica dei sentimenti, delle emozioni e della razionalità ad
esso collegata.
Heidegger giustamente di quest’ospite diceva che vuole lo “spaesamento come tale. […] Ciò che occorre è
accorgersi di quest’ospite e guardarlo bene in faccia”. (La questione dell’essere)
Con L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani del 2007, Galimberti cerca di rintracciare le ragioni e,
forse, i rimedi per il malessere giovanile all’interno dell’età della tecnica e del nichilismo.
Se il nichilismo è tra noi e noi ne viviamo l’ambiente, ne respiriamo l’aria, non è più possibile leggere il
disagio giovanile come semplice crisi adolescenziale-esistenziale. Non sarà nemmeno possibile, allora,
trovare qualche panacea che rimanga in una dimensione individuale, soggettivistica, psicologica. Il problema
è epocale, d’orizzonte culturale!
La scuola è, gioco forza, la principale colpevole dell’isolamento dei ragazzi all’interno della società: infatti
in un’età come quella adolescenziale in cui si fanno sempre più aspri, pungenti i rapporti familiari, la scuola
dovrebbe fornire quell’educazione all’emotività che permette all’individuo di autodisciplinarsi; invece si
limita a valutare con strumenti matematici, obiettivi, rigorosi lo studente in base alla sua efficienza, senza
curarsi minimamente di suscitare un interesse che lo coinvolga anche a livello emotivo.
Ora, questo eccesso di emozionalità, che non riesce ad incanalarsi in modo costruttivo, trova secondo
Galimberti, tre possibili sbocchi:
130
1) lo stordimento dell’apparato emotivo attraverso quelle pratiche rituali che sono le notti in discoteca o i
percorsi della droga; 2) il disinteresse per tutto, messo in atto per assopire le emozioni attraverso i
percorsi dell’ignavia e della non partecipazione che portano all’atteggiamento opaco dell’indifferenza; 3) il
gesto violento, quando non omicida, per scaricare le emozioni e per ottenere un’overdose che superi il
livello di assuefazione come nella droga. (Galimberti, L’ospite inquietante)
La seduzione della droga.
L’uso sempre più diffuso delle droghe, così come anche degli psicofarmaci, è un fenomeno culturale che
trova le sue radici: a) nell’impossibilità di soddisfare il proprio piacere; b) nella rinuncia alla ricerca di
un qualsiasi senso, anche precario, nella propria vita.
Droghe che rispondono alla prima delle due necessità sono l’ecstasy, che allontana la paura e permette di
vivere più intensamente i rapporti interpersonali, e la cocaina, che spinge chi la assume a vivere oltre i limiti
concessi dal proprio corpo per rispondere a quel “senso di insufficienza” per quanto riguarda le proprie
capacità fisiche e mentali.
L’eroina ha, invece, un effetto anestetizzante, per cui uccide i sensi sottraendo l’individuo dalla noia della
routine quotidiana e dall’insensatezza della propria vita.
Non bisogna dunque avere paura di affrontare questo problema e di capirne realmente le cause, uscendo
anche fuori dagli schemi della cultura tradizionale e scavando a fondo nell’interiorità dei tossicomani, per
riuscire ad “accettare il male per quello che ha di costruttivo e non solo di distruttivo”.
Fondamentale è instaurare una cultura della droga, che, come quella del tabacco o dell’alcool, possa
veramente informare i giovani:
Per questo è necessario che a scuola, e in quel suo sostituto mediatico che è la televisione, si parli di
droga in modo analitico, determinato, scientifico e persino filosofico, in modo che i giovani sappiano che
cosa assumono, che effetto fa, che danni procura, che piaceri promette e da che visione del mondo
scaturisce. L’ignoranza non ha mai salvato nessuno e l’ignoranza dei giovani a proposito della droga è pari
alla sua diffusione. (L’ospite inquietante)
Il gesto estremo.
L’omicida che compie il suo crimine “senza movente” non esiste; è la mancata educazione delle emozioni
che spinge un qualsiasi individuo ad un gesto di tale violenza.
I professori entrano in classe. Ma li vedono in faccia questi ragazzi? […] Sanno che le generazioni di giovani
con cui oggi hanno a che fare, non per colpa dei professori ma a causa delle rapidissime trasformazioni
economiche, sociali e tecnologiche che li coinvolgono, sono di una fragilità emotiva impressionante?
Sanno che l’emozione, se non trova il veicolo della parola, ricorre al gesto? Gesto truculento d’amore o
gesto truculento di violenza? (L’ospite inquietante)
Il suicidio è il gesto di chi non trova più alcun senso alla propria vita, sentendosi circondato da maschere
prive di valore che non fanno altro che interpretare dei ruoli già stabiliti, dove non c’è più alcun rapporto
autentico. E’ la disperazione di chi si accorge che non c’è alcun fine e che il “progresso” è solo un’illusione
consolatoria. Anche qui la possibile soluzione, riprendendo le parole di Freud, è questa:
La scuola deve fare qualche cosa di più che evitare di spingere i giovani al suicidio. Essa deve creare in
loro il piacere di vivere e offrire appoggio e sostegno in un periodo della loro esistenza in cui sono
necessitati dalle condizioni del proprio sviluppo ad allentare i legami con la casa paterna e la famiglia.
(Freud, Contributi a una discussione sul suicidio)
131
Le generazioni nichiliste.
I giovani nell’era nichilista della tecnica si agitano in maschere strette:
1) La generazione del pugno chiuso è in aperto contrasto con la società, tanto da non accettare più la
contrattazione che essa offre perché si pone, invece, sul piano della sfida e dello scambio terroristico, il
quale si fonda su una richiesta che non può essere soddisfatta; due sole diventano quindi le possibili
soluzioni della sfida: la morte del sistema o la propria morte;
2) La “generazione X” degli indifferenti vive nell’apatia, nell’impossibilità di trasformare il gesto in stile
di vita e di sentire l’emozione nel profondo; il tratto fondamentale che li caratterizza è la non-partecipazione,
per cui, anche se risultano omologati dal consumismo, o forse proprio per questo, perdono la propria identità
e si sentono dunque soli;
3) La “generazione Q” dal basso quoziente intellettivo ed emotivo comprende i giovani che vengono
definiti sociopatici o psicopatici per la loro incapacità di sentirsi parte di una società e di avvertire il peso
delle proprie azioni; coloro che ne fanno parte sono mossi dal desiderio di rompere la monotonia delle regole
determinate dalla tecnica attraverso gesti eclatanti in grado di risvegliarli, almeno momentaneamente, dalla
noia;
4) Gli squatter sono, invece, rassegnati all’impossibilità del cambiamento, e rispondono con il silenzio a
quel silenzio che viene dalle istituzioni, che, a loro volta, non hanno potere decisionale per il semplice fatto
che il loro agire è completamente determinato dalla tecnica;
5) I ragazzi dello stadio usano la pura violenza nichilista per liberare le proprie energie vitali che non sanno
come impiegare, scegliendo di agire in massa perché
la responsabilità individuale è difficile da identificare e l’impunità generale diventa un salvacondotto
per gesti più esecrati e senza motivazione, perché la violenza nichilista è autosufficiente. (L’ospite
inquietante)
Oltre il nichilismo.
Come ci salveremo dalla voragine, dal niente che tutto ingoia? Come ci salveremo dalla notte se i valori e le
azioni perdono di senso e il futuro non sembra riservare alcuna promessa? Dove i rimedi?
I rimedi tradizionali non sono più all’altezza della domanda. Il rimedio religioso quanto quello razionalista
non reggono la domanda di senso in questa epoca storica.
La religione e la sua dimensione salvifica è inefficace perché il cielo è un cielo vuoto: Dio è veramente
morto e resta morto; le chiese sono davvero sepolcri!
La ragione si è dimostrata inefficace nel cogliere la totalità della vita: la ragione non regola affatto i rapporti
tra gli uomini.
Siamo dunque immersi in una ragione strumentale che cancella tutti gli orizzonti giacchè cancella il pensiero
e la dimensione emotiva.
Per uscire dall’imbuto nichilistico in cui siamo finiti, Galimberti propone “l’etica del viandante”, già
presente in Nietzsche quando parla del “piacere di navigante”:
Se in me è quella voglia di cercare che spinge le vele verso terre non ancora scoperte, se nel mio piacere
è un piacere di navigante: se mai gridai giubilante: “la costa scomparve – ecco anche la mia ultima
catena è caduta – il senza-fine mugghia intorno a me, laggiù lontano splende per me lo spazio e il
tempo, orsù! coraggio! vecchio cuore”. (Nietzsche, Così parlò Zarathustra)
La salvezza non è più nelle escatologie tranquillizzanti. La salvezza è nel viaggio senza fine, senza meta in
cui non è necessario trovare un orizzonte, un senso, uno scopo. Il giovane viandante rifugge dalla dimensione
delle illusioni che proteggono e coscientemente diserta le acque tranquille del lago limaccioso per dire sì al
mondo.
132
In un tale scenario, il proprio comportamento sarà dettato da un’etica “che non si appella al diritto ma
all’esperienza e all’azione”, la quale poi non è altro che quella ricerca della iusta mensura greca che
permette all’individuo di svilupparsi riconoscendo quelle che sono le proprie capacità ed inclinazioni.
L’’arte del vivere’, come dicevano i Greci!
E’ così che si potrà passare da una visione del mondo – giudaico-cristiano - basata sull’attesa, tutta
incentrata sul raggiungimento di un preciso momento futuro, a una nuova concezione fondata sulla
speranza, che apre invece ad infinite possibilità e non limita in alcun modo l’azione dell’uomo.
In questo senso diciamo che l’attesa è passiva, perché vive il tempo come qualcosa che viene verso di
noi, la speranza invece è attiva perché ci spinge verso il tempo, come verso quella dimensione che ci è
assegnata per la nostra realizzazione. I giovani sono attivi quando con la speranza vanno verso il tempo
e non quando con l’attesa aspettano che il tempo venga verso di loro. (L’ospite inquietante)
Ora, se i giovani, affrancati dall’illusione di una meta da raggiungere, da un senso ultimo, si abbandoneranno
al flusso della vita, alla sua energia ‘vitale’ cercando se stessi, libereranno il mondo nelle sue infinite
possibilità, forse, il nichilismo non sarà passato invano!
CONCLUSIONI
Il linguaggio chiaro, piano, seducente di Galimberti offre una certa maggiore distensione rispetto ad
Heidegger, ma soprattutto il cammino ci sembra libero da una spessa metafisica. Insomma, pur muovendosi
sulla linea heideggeriana, Galimberti ci sembra scevro da quella pesante imbragatura metafisica.
Il merito di Galimberti è di aver chiaramente posto il problema della tecnica all’interno di una spiegazione
assai convincente che parte da quel meccanismo hegeliano del passaggio della quantità a qualità che lo stesso
F. Engels della Dialettica della natura aveva ripreso come uno dei meccanismi della dialettica hegeliana. Ad
un certo grado quantitativo la tecnica non è solo un aumento tecnologico ma essa si trasforma in ambiente. Il
passaggio da strumento neutro ad ambiente posto in maniera così chiara fa si che il cambiamento si avverta
in maniera inusitata e il pericolo di una completa subordinazione dell’uomo si erge in tutta la sua plastica
evidenza.
Ancora, è merito di Galimberti sottolineare come la strumentazione concettuale con cui ci attardiamo a voler
leggere gli avvenimenti è ormai antidiluviana: umanistica e pre-tecnologica. La pars destruens della
strumentazione concettuale come in un negativo disegna la pars costruens degli spazi che ad es. la politica,
l’etica viene ad avere in un’età della tecnologia e del ruolo che assegnano all’uomo ossia di vera e propria
subalternità all’apparato tecnologico.
Heidegger e Galimberti concludono entrambi la loro riflessione filosofica con una certo indulgere
all’abbandono ascoltante ai sentieri destinali, il primo, ad una maggior consapevolezza anche se impotente, il
secondo. Questo atteggiamento è la conseguenza coerente di uno scenario che si apre davanti a loro, di un
destino che si compie al di sopra, dietro, oltre l’uomo ormai funzionario di un apparato, di un impianto, di un
Gestell di cui non è più possibile recuperare il controllo. Entrambi concordano che non resta molto da fare!
Alla filosofia, del resto, spetta solo la registrazione puntuale, precisa, chiara dello stato dell’arte, o se si
vuole, dell’imbuto in cui ci siamo cacciati: una filosofia dell’abbandono!
Lo scenario
Lo scenario delineato da entrambi è che la tecnica non può essere intesa più come strumento ma essa è ora il
Moloch che fagocita tutto ciò che è altro da sé al solo fine della autoespansione, dell’autoaccrescimento
insensato e senza scopo che si misura solo con i criteri della efficienza e funzionalità. La tecnica è un
gigantesco apparato che si para innanzi, nientemeno, che al genere umano, all’umanità tutta. La fase storica
133
che viviamo, dunque, prevede un oblio dell’uomo e un protagonismo della tecnica. Una volta che la tecnica
ha fatto dell’uomo un semplice funzionario la storia si traduce in puro e semplice sviluppo della tecnica. In
ciò il destino, Geschick! Non abbiamo alcun potere sulla tecnica, sull’impianto, imposizione, in generale,
cosicchè siamo abbandonati al nostro destino che ha sviluppi imperscrutabili.
Dialettica Soggetto/Oggetto-Mondo
Innanzitutto va notato come questa posizione sia più materialista del materialismo marxiano nel senso che
disegna l’uomo come completamente determinato, legato, prodotto, condizionato dalla modalità della
produzione e riproduzione della vita. Si tratta in questo caso dell’abbraccio mortale con quello che Marx
definiva materialismo deterministico e da cui prendeva le distanze come materialismo rozzo giacchè non
intendeva il reale come prassi. Marx criticando aspramente questa forma ingenua di materialismo vi
opponeva il suo materialismo storico-dialettico che mantiene in vita la dialettica Soggetto/Oggetto-Mondo;
mantiene in vita, prepotentemente, la categoria della prassi.
La riflessione filosofica di Heidegger e di Galimberti sulla tecnica fa si che venga completamente schiacciata
qualsiasi dialettica Soggetto/Oggetto-Mondo proprio mentre ribadiscono che l’uomo è dentro al destino del
Gestell che in termini marxiani, per intenderci, possiamo tradurre con modo di produzione. Da questo punto
di vista Marx rimane sulla linea che da Cartesio con il suo cogito propone in maniera forte la soggettività.
In verità in Heidegger e poi in Galimberti la dialettica non rimane propriamente schiacciata, non è
propriamente dialettica ma monologo della tecnica. Il rapporto uomo/tecnica viene declinato assolutamente
come incedere tecnico. L’uomo viene fagocitato, accorpato nell’impianto tecnico, semplicemente. Dunque,
da qui in poi possiamo solo parlare propriamente della storia della tecnica.
Questa posizione finisce con il ricordare molto quella posizione di sedicenti marxisti che aspettavano,
trasognati e immobili, il comunismo giacchè era scritto nel destino e descritto nel Capitale!
Dialettica servo-padrone
Non solo… un altro passaggio fondamentale travestito da metafore filosofiche è l’annichilimento della
dialettica servo-padrone di hegeliana memoria. Fuor di metafora ciò significa che la tecnica non può essere
usata ma usa indifferente il genere umano. E’ indifferente la figura del servo o del padrone, anzi superata. E’
qui un nodo problematico estremamente complesso, ma cruciale, per poter dipanare i fili del nostro …
destino.
Questa liquidazione della dialettica servo-padrone evapora d’incanto nientemeno che la società divisa in
classi, la divisione tra capitale e forza-lavoro, una particolare, specifica storica, proprietà dei mezzi di
produzione, ecc.
E’ proprio indifferente la forma di proprietà che abita la tecnica?
E’ indifferente all’analisi che la tecnica respiri nella forma della proprietà privata capitalistica?
Poiché le macchine, considerate in sé, - scrive Marx - abbreviano il tempo del lavoro, mentre, adoperate
capitalisticamente, prolungano la giornata lavorativa, poiché le macchine in sé alleviano il lavoro e
adoperate capitalisticamente ne aumentano l'intensità, poiché in sé sono vittoria dell'uomo sulla forza
della natura e adoperate capitalisticamente soggiogano l'uomo mediante la forza della natura, poiché in
sé aumentano la ricchezza del produttore e usate capitalisticamente lo pauperizzano, ecc., l'economista
borghese dichiara semplicemente che la considerazione delle macchine in sé dimostra con la massima
precisione che tutte quelle tangibili contraddizioni sono una pura e semplice parvenza della ordinaria
realtà, ma che in sé, e quindi nella teoria, non ci sono affatto. Così risparmia di doversi ulteriormente
stillare il cervello, e per giunta addossa al suo avversario la sciocchezza di combattere non l'uso
capitalistico delle macchine, ma le macchine stesse. (Il Capitale, L. I)
La citazione sulle macchine ci fornisce un bell’esempio di come un elemento cambia segno qualora si trovi
in un sistema piuttosto che in un altro.
134
La valutazione marxiana è che la tecnica (componente del capitale fisso) si dispiega chiaramente e
totalmente nel socialismo ovvero in una società in cui viene risolta la contraddizione tra produzione sociale e
appropriazione privata e che l’ha fatta finita con la tecnica nella figurazione della proprietà privata o forma
capitalistica. La tecnica è non più alienante e alienata in processi tecnici chiari, perché liberati dal loro uso
capitalistico e al servizio della socialità, non è più forma di dominio sociale. Dunque “dispiegamento
disalienato e totale della tecnica.
Il destino.
Chi compie il richiedere provocante secondo Heidegger? L’uomo? No! Il Gestell, intelaiatura che non è nulla
di tecnico, ma è il modo in cui si disvela il mondo come fondo. Ciò avviene con l’uomo ma non per opera
sua. Esso è destino, Geschick! Per Heidegger la tecnica non accade fuori dall’uomo, ma non per opera sua.
Cos’è il Gestell per Marx?
Il Gestell in termini marxiani è la struttura, meglio, modo di produzione.
L’uomo non è mai occhio puro sul mondo ma è all’interno di rapporti di produzione storicamente
determinati, all’interno di rapporti sociali, ecc. Nessuno può seriamente pensare alla neutralità degli
strumenti: l’uomo in quanto essere al mondo non può prescindere dal relazionarsi con gli enti utilizzandoli e
trasformandoli attraverso la tecnica, ma con ciò egli stesso ne viene continuamente trasformato. L’uomo ha il
suo ambiente nel modo di produzione di volta in volta storicamente determinato e non può sfuggirvi come
non può sgattaiolare dal suo corpo.
Marx, primo fra tutti ha compreso in profondità, il capovolgimento dei mezzi in fini del sistema capitalistico:
un sistema che solo secondariamente soddisfa i bisogni umani avendo come legge suprema quella del
profitto! Ha capito perfettamente che il denaro da strumento di scambio diventa equivalente generale e,
dunque, fine. Ha compreso perfettamente che questo organismo economico si sviluppa e sfugge al controllo
dei singoli. E tuttavia l’uomo in questo sistema non figura semplicemente come cosa tra le cose. Gli stessi
cambiamenti ‘necessari’ devono essere opera dell’uomo. Così come il socialismo non è l’opera segreta di un
destino inevitabile, ma il movimento reale di masse che si muovono sulla scena della storia.
L’uomo è un uomo determinato storicamente e pure vincolato dalla storia e finanche si pone problemi che
storicamente può risolvere. Tuttavia, in Marx non viene mai pensato come mero funzionario anche quando
nel Capitale le classi sociali sembrano svolgere il ruolo di “impersonificazioni” delle categorie economiche:
capitale/lavoro.
Ha un destino il modo di produzione? Sí e no!
Cos’è il Geschick per Marx?
Il modo di produzione capitalistico è nato dall’incontro tra il capitale e il lavoro, tra denaro e forza-lavoro
senza proprietà alcuna. Ebbene questo incontro più volte si è dato nella storia ma non ha fatto presa non è
durato e non si è trasformato in un nuovo modo di produzione. I singoli elementi, fuori da qualsiasi visione
teleologica, fluttuano prima della loro combinazione per poi incontrarsi e durare. Il caso e la necessità! Nulla
è preordinato al di fuori della prassi umana e della dialettica del Soggetto. Nemmeno ha senso porsi, tuttavia,
in una prospettiva in cui la storia umana ha l’uomo come protagonista che sceglie il suo cammino. L’uomo
non sceglie liberamente il suo destino ma lo fa nella situazione che trova e con gli elementi che trova!
Metà della sua vita Marx l’ha dedicata alla comprensione teorica del modo di produzione capitalistico, l’altra
metà ad abbatterlo! Metà della sua vita è stata impegnata nella organizzazione politica del proletariato, nella
organizzazione della Prima Internazionale, ecc. conscio che il capitalismo non sarebbe caduto da solo e che
la lotta stessa è incertezza del risultato. La comprensione della caduta del saggio del profitto, dal punto di
vista semplicemente economico, è proprio la limitatezza della comprensione borghese del fenomeno storico.
Risultano da quanto siamo andati dicendo due concezioni della nostra epoca che, pur avendo dei tratti in
comune, si differenziano notevolmente e in più punti. Le singole scienze potranno apportare nuovi contributi
a meglio articolare la discussione. Ne va, come ognuno può comprendere, del nostro … destino!
135
BIBLIOGRAFIA
Opere di Galimberti
Galimberti, Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica, Feltrinelli, 1999
Galimberti, L’ospite inquietante, Il nichilismo e i giovani, Feltrinelli, 2007
Galimberti-Alloni, Il viandante della filosofia, Aliberti, 2011
Galimberti, Cristianesimo. La religione dal cielo vuoto, Feltrinelli, 2012
SITI WEB:
http://www.umbertogalimberti.it/
VI. LA RIDEFINIZIONE DELL’IO:
136
LA RIVOLUZIONE PSICANALITICA (Freud)
Tutta la cultura occidentale ha fruito e subito la rivoluzione psicanalitica operata da Sigmund Freud. Tale
rivoluzione, pur non inquadrandosi immediatamente nella riflessione filosofica, nasce, infatti, dalla cura di
certe malattie e disturbi mentali, per la portata dirompente che ha il concetto di inconscio, apporta elementi
fondamentali al fare filosofia.
Questo capitolo restituisce la nascita e l’elaborazione della teoria psicanalitica che con la scoperta
dell’inconscio ha avuto una importanza eccezionale nella riflessione filosofica facendo franare, innanzitutto,
il concetto di Io che in Occidente già con Socrate, ma soprattutto con Cartesio viene a delinearsi.
Dopo la rivoluzione psicanalitica di Freud la riflessione filosofica non potrà fare a meno di ripensare,
praticamente, tutti gli ambiti in cui l’Io è operativo dovendo riperimetrare la sua capacità, chiarezza,
motivazione, potenza, ecc.
~ FREUD
~
~
~
~
~
~
La vita e le opere
La nascita della psicanalisi
L’inconscio e le vie per accedervi
La topica della psiche: Es, Io, Super-Io
La teoria della sessualità
Il disagio della civiltà
~ CONCLUSIONI
FREUD
Vita e opera
Sigmund Freud nasce a Freiberg, in Moravia, nel 1856 e già nel 1860 è a Vienna.
Si laurea in medicina e inizia, nel laboratorio di Brücke, studi di anatomia del sistema nervoso.
Lavora con Breuer sull’isteria e perviene alla scoperta dell’inconscio e alla teoria psicanalitica.
Nel 1910 nasce a Norimberga, La Società internazionale di psicoanalisi, di cui Jung, suo allievo, è
presidente.
Nel 1933 i nazisti bruciano le sue opere.
Nel 1938 lascia Vienna per Londra dove morirà, aiutato dal suo medico che gli inietta morfina, nel 1939.
Opere importanti: L’interpretazione dei sogni (1900); Totem e tabù (1913); Introduzione alla psicanalisi
(1915-32); Psicologia delle masse e analisi dell’Io (1921); Il disagio della civiltà (1929).
La nascita della psicoanalisi
137
La medicina dell’epoca si muoveva in un orizzonte teorico e in un genere culturale squisitamente
positivistico-materialistico. I disturbi della personalità erano risolti in chiave meramente somatica cosicchè
stati psiconevrotici come le isterie non erano prese in seria considerazioni dato che non vi corrispondeva
nessuna lesione organica. Ora proprio l’isteria aveva catalizzato l’attenzione di un gruppo di studiosi tra i
quali Charcot e Breuer che usavano l’ipnosi. Breuer in particolare aveva usato l’ipnosi, non tanto come
strumento per inibire e tenere sotto controllo lo stato isterico e i suoi sintomi, quanto come mezzo, leva per
poter accedere alla memoria affinchè riportasse alla luce avvenimenti spiacevoli, angosciosi, penosi, dolorosi
obliati.
Il caso di Anna O. curata da Breuer e dal suo collaboratore Freud, si inquadra nel caso di una isterica grave
affetta da turbe della vista e dell’udito, anoressia, paralisi motorie, ecc. e da una forte paura dell’acqua
(idrofobia). Proprio attraverso l’ipnosi Breuer era riuscito a risalire all’evento che aveva fortemente turbato
Anna: bambina, aveva visto bere il cane della governante in un bicchiere, provandone un forte disgusto. I
sintomi idrofobici scomparvero quando Breuer chiarì l’episodio che Anna aveva rammentato sotto ipnosi. A
partire da questi studi Breuer e Freud elaborarono un ‘metodo catartico’, che provocava una scarica emotiva
in grado di liberare il malato.
In autonomia da Breuer, Freud arrivò a scoprire che causa dei disturbi psiconevrotici fosse un conflitto tra
forze psichiche inconsce. Ora la conclusione a cui Freud perviene è dirompente: in quanto si sostiene che la
causa di quei sintomi patologici, ad es. temporanee paralisi, ecc. erano da iscriversi in una dimensione
psicogena e non fisiologica: i disturbi non erano organici, ma dovuti alle traversie della psiche.
La scoperta dell’inconscio segnava la nascita della psicanalisi!
L’inconscio e le vie per accedervi
La psicanalisi è psicologia dell’”abissale”, del “profondo”. Prima di Freud la psiche era comunemente
equiparata alla coscienza. Al contrario, Freud afferma che la maggior parte della nostra vita psichica è oltre,
fuori della portata della coscienza; l’inconscio è la parte abissale e primaria di cui la parte cosciente è solo la
punta. Insomma, la nostra psiche è come un iceberg la cui punta, la coscienza, è solo una piccola parte di una
massa enorme, che si cela ai nostri occhi, la parte inconscia.
L’inconscio si divide propriamente in:
a) preconscio ovvero quella zona che cela ricordi che ancora possono, con sforzo, tornare alla nostra
attenzione;
b) rimosso cioè quei ricordi che, stabilmente, sono obliati alla nostra coscienza per virtù di una
avvenuta censura e “rimozione” e che solo determinate tecniche possono riportare alla nostra
coscienza.
Quali le tecniche, il grimaldello per poter forzare la zona dell’inconscio? In un primo tempo Freud pensa –
come abbiamo visto – all’ipnosi, poi, piuttosto che forzare il paziente usa una tecnica più ‘rilassante’: le
associazioni libere. Il paziente, rilassato sul divano, è indotto al libero corso dei propri pensieri e si cerca di
invogliarlo a creare tra le parole da lui espresse una catena associativa che gravita attorno al materiale
rimosso e che si vuole portare a galla.
La tecnica terapeutica dovrà adoperare, magistralmente anche quel fenomeno che Freud chiama transfert o
traslazione, cioè il trasferimento sullo psicanalista di una serie di stati d’animo ambivalenti di cui il paziente
fa oggetto il medico: sentimenti d’amore e di odio che il paziente destinava ad una figura importante della
sua infanzia. Affinché vi sia una guarigione è necessario che psicanalista e paziente collaborino e si sforzino
sinergicamente per uscire dalla malattia. Tuttavia, il transfert positivo, cioè quella sorta di attaccamento
amoroso verso lo psicanalista che si instaura nel rapporto medico-paziente, deve essere sfruttata per il
successo della malattia ed è una leva potentissima perché agisce surrettiziamente, di nascosto rispetto allo
stesso paziente.
138
[Il transfert positivo o traslazione] modifica tutta la situazione analitica, lasciando in disparte l’intento
razionale di guarire e liberarsi dalle sofferenze. In suo luogo subentra l’intenzione di piacere all’analista,
di guadagnare la sua approvazione, il suo affetto. Essa diventa la vera molla della collaborazione del
paziente; l’Io indebolito diventa forte, sotto l’influenza della traslazione riesce a far cose che altrimenti
gli sarebbero impossibili, fa cessare i suoi sentimenti, apparentemente diventa sano, ma solo per amore
dell’analista.
Ma l’analisi di questo iceberg celato dalle acque non avviene solo attraverso le associazioni libere, ma anche
attraverso dei sogni, degli atti mancati e dei sintomi nevrotici che il paziente mostra.
L’interpretazione dei sogni (1900) è stato spesso paragonato a ciò che L’origine della specie è stato in
biologia. Freud intuisce che il sogno è la “via regia che porta alla conoscenza dell’inconscio nella vita
psichica”. Il sogno non è altro che “l’appagamento (camuffato) di un desiderio (rimosso)”. Il sogno è una
narrazione all’interno della quale abbiamo un contenuto manifesto, palese e un contenuto latente cioè un
contenuto così forte che esita a mostrarsi chiaramente e che viene censurato. Il contenuto manifesto è,
dunque, un contenuto che non corrisponde ai desideri se non in forma “travestita”. Insomma il contenuto
manifesto deve essere interpretato e riportato al contenuto latente e reale da parte dello psicanalista.
Altri elementi che qua e là fanno erompere l’inconscio sono i lapsus, gli errori, le dimenticanze. Ebbene,
questi elementi, che a prima vista sembrano casuali e banali, rivelano per Freud un modo con cui le istanze
dell’inconscio si presentano in superficie.
La topica della psiche: Es, Io, Super-Io
La psiche non ha affatto una struttura unitaria, omogenea, ma è una unità complessa formata da luoghi o
istanze: L’Es, l’Io, il Super-Io.
- L’Es è la regione più antica, inconscia, caotica, magmatica della nostra struttura psichica: matrice
originaria. L’Es è “la parte oscura e inaccessibile della nostra personalità”. Il suo contenuto riguarda la
“natura” dell’individuo e, per tanto, contiene quelle che Freud chiama “pulsioni” primitive.
Il termine “pulsione” non va però confuso con “istinto”. Gli istinti, diversamente dalle pulsioni, sono risposte
rigide ad uno stimolo e sono propriamente degli animali, che hanno un apparato istintuale organizzato
rigidamente. Nell’uomo queste risposte rigide non esistono: l’apparato istintuale è estremamente lacunoso
proprio in virtù del suo apparato psichico così complesso. Le pulsioni, invece, sono istanze con cui la specie
si fa valere nell’individuo: il modo con cui la specie influenza la vita del singolo. Gli uomini non hanno
istinti, ma pulsioni cioè spinte generiche a meta indeterminata.
Essendo l’interesse della specie la riproduzione, la natura fornisce all’individuo due tipi di pulsioni: quella
sessuale per l’accoppiamento e la procreazione e quella aggressiva per la difesa della prole.
L’Es è la sede delle pulsioni: la sede dell’inconscio pulsionale.
E’ un “caos, un calderone d’impulsi ribollenti”. L’Es non conosce dimensione etica e neanche logica. L’Es
non conosce l’etica, nel senso che si muove al di là di qualsiasi principio morale: al di là del bene e del male.
Non conosce altresì la logica, nel senso che nessun principio logico viene tenuto in considerazione o la
governa: ignora il principio di non-contraddizione; ignora il principio di causalità; non funziona la categoria
di spazio né quella di tempo. L’Es obbedisce, unicamente, all’”inesorabile principio del piacere”. L’Es
tende sempre all’immediato soddisfacimento dei suoi desideri, che non essendo minimamente strutturati
possono tranquillamente essere contradditori l’uno con l’altro.
- Il Super-Io è ciò che chiamiamo “coscienza morale”: quell’insieme di proibizioni che il bambino introietta,
interiorizza attraverso l’educazione genitoriale e imposti dalla società. In altre parole esso funge da giudice
censore dell’Es, in modo tale da poter permettere la vita comunitaria dell’individuo, che non sarebbe
139
possibile se questi si abbandonasse completamente alle pulsioni naturali. Il Super-Io è, pertanto, definito
come inconscio sociale (inconscio, giacché, una volta interiorizzato un divieto, non è necessario riflettere sul
comportamento da adottare al riguardo).
Freud parla di morale eteronoma e autonoma.
Quando viene imposto da un genitore ad un bambino un divieto, questi lo rispetta, perché consapevole che il
genitore rappresenta la condizione della sua sopravvivenza (perché lo ciba, perché se ne prende cura, ecc.) e
che la perdita del suo amore e del suo sostegno, della sua “alleanza” comporterebbe un pericolo per la sua
vita. In questo modo anche l’amore e l’affetto che il figlio prova nei confronti dei genitori si configura come
un meccanismo che la natura mette in atto per la difesa dell’individuo, un rapporto di egoismo che si istaura
per un proprio vantaggio. Il ‘sacro’ amore per la mamma è lo strumento che la specie adotta per garantirci la
sopravvivenza!
Il bambino è quindi spinto ad ubbidire per paura di perdere l’amore dei genitori. Insomma,
l’interiorizzazione avviene, quindi, con modalità sostanzialmente egoistiche. L’introiezione non è altro che
un baratto! Questo tipo di interiorizzazione, comporta che l’individuo rispetti il divieto solo in presenza di un
“controllore” (nel caso del bambino, in presenza di un genitore). Una morale del genere prende il nome di
morale eteronoma.
Quando, invece, il divieto è rispettato indipendentemente dalla presenza o meno di un controllore, si è
arrivati ad un’interiorizzazione più profonda del divieto stesso e pertanto ad una morale autonoma.
Quando si è pervenuti ad una morale autonoma si è arrivati alla formazione piena del Super-Io che funge da
“controllore interno”: un garante del rispetto delle istanze sociali.
- L’Io è quella parte della nostra psiche, razionale e intellettuale, che è obbligata a fare i conti con istanze
confliggenti che vengono dall’Es e dall’Super-Io e, ancora, dal mondo esterno. L’Io è così sempre dilaniato,
trascinato a dover mediare e trovare un equilibrio, una armonia tra questi tre “padroni severi”! L’Io patisce,
subisce le istanze pulsionali dell’Es, che diventano sue “passioni”; ma deve pure rispondere alle esigenze del
Super-Io, dell’inconscio sociale che chiede il rispetto dei divieti sociali, il contenimento delle pulsioni
dell’Es.
Definiamo Io normale quell’individuo che riesce a trovare un certo equilibrio tra istanze così disparate e
contrastanti. Se l’Es è troppo forte o se il Super-Io è troppo debole avremo dei comportamenti devianti o
perversi. Se Il Super-Io è troppo forte, invece, abbiamo l’attivazione di meccanismi di rimozioni troppo ampi
tali da creare sintomi nevrotici. La nevrosi non è altro che il conflitto, appunto, tra l’inconscio pulsionale
(Es) e inconscio sociale (Super-Io). In questo senso l’Io è sempre un Io nevrotico, impegnato com’è ad
armonizzare i due nemici. La follia, invece, indica quello stato in cui l’Io soccombe e i due belligeranti
vengono a contatto: l’io viene soppresso e il mondo pulsionale e quello dell’inconscio sociale prendono il
sopravvento.
L’intenzione degli sforzi terapeutici della psicoanalisi è in definitiva di rafforzare l’Io, di renderlo più
indipendente dal Super-io, di ampliare il suo campo percettivo e perfezionare la sua organizzazione, così
che possa annettersi nuove zone dell’Es. Dove era l’Es, deve subentrare l’Io. È questa l’opera della
civiltà, come per esempio il prosciugamento dello Zuiderzee. (Freud, Introduzione alla psicoanalisi)
Si noti, infine, che la topica che Freud aveva inizialmente elaborato, dell’inconscio, preconscio e conscio,
non coincide con quella dell’Es, Io e Super-Io in quanto zone dell’Io e del Super-Io sono normalmente
inconsce o preconsce, nel senso che i loro contenuti non ci sono immediatamente coscienti.
L’interrelazione tra la prima e la seconda topica è ben illustrata dallo stesso Freud in L’Io e l’Es con una
struttura che mostra come i diversi luoghi e istanze non debbano essere concepite come comparti stagno, ma
aperti, dialoganti. Inoltre, lo schema mostra bene come pure il Super-Io e l’Io affondino in parte
nell’inconscio e nel preconscio e come solo una piccola parte sia cosciente.
140
La teoria della sessualità
La teoria della sessualità di Freud è stata la pietra dello scandalo che ha ‘generato’ maggiori diffidenze sia
dagli ambienti culturali in genere, che dalle chiese in genere sessuofobe.
Prima di Freud, e ancora oggi per le diverse chiese, la sessualità era confinata alla procreazione. Ecco,
invece, Freud ampliare la sessualità fino alla libido.
Ma iniziamo dall’inizio! Se la sessualità, pensa Freud, dovesse essere finalizzata alla procreazione perché
mai essa pure esiste nei bambini: sessualità infantile?
Dovrebbe mancare nell’infanzia, subentrare intorno all’epoca e in connessione con il suo processo di
maturazione, esprimersi in fenomeni di attrazione irresistibile esercitata da un senso sull’altro; la sua
meta dovrebbe essere l’unione sessuale.
Non solo resterebbero inspiegati una serie di atteggiamenti sessuali infantili, ma altresì anche quei fenomeni
che Freud chiama di sublimazioni, ovvero di trasferimento della carica sessuale ad ambiti come l’arte, la
scienza, la filosofia e le perversioni cioè a quegli atteggiamenti sessuali che non perseguono un fine
riproduttivo, ma di piacere.
La sessualità per Freud non è affatto limitata alla genitalità, è, piuttosto, una energia che può dirigersi verso
mete diverse da quella propriamente riproduttiva e investire gli oggetti più disparati.
La libido migra, di volta in volta, localizzandosi su parti del specifiche del corpo del bambino.
La dottrina della sessualità infantile di Freud ci perimetra finalmente un bambino non più “angioletto
asessuato”, ma “un essere perverso e polimorfo” che ha una sessualità completamente sganciata dalla
riproduzione. Lo sviluppo del bambino viene segnato da tre fasi legate alla localizzazione di una zona
erogena:
1) fase orale (primi mesi e fino a un anno e mezzo). La libido si localizza attorno alla bocca. La bocca
come zona erogena fa si che il soggetto provi piacere nell’atto del poppare, che altrimenti sarebbe
solo fatica.
2) fase anale (un anno e mezzo a tre). La zona erogena ora è l’ano ed è collegata alla funzione
escrementizia. Il bambino incomincia a prendere il controllo del proprio corpo, che per lui equivale
ad un primo controllo sul mondo. Se nella fase orale il bambino sviluppa la concezione dell’avere in
141
quella anale, attraverso l’esercizio del controllo degli sfinteri, sviluppa il primo controllo sul mondo
che è esercizio di potere. Dipende dal bambino rilasciare o trattenere le feci. Dalla soddisfazione o
dall’insoddisfazione che si trae da questa fase si sviluppano, in seguito, tratti della personalità come
ad es. quella dei leader o dei gregari. I leader, a differenza dei gregari, non possono rinunciare al
controllo del mondo esterno. Nei casi estremi, questo bisogno di controllo del mondo può condurre a
forme patologiche come la paranoia e alla mania di persecuzione.
3) fase genitale (terzo anno fino alla pubertà). La fase genitale si suddivide a sua volta in a) fase
fallica. Sia i maschi che le femmine scoprono il pene ed entrambi accusano un complesso di
castrazione vissuto, tuttavia, in maniera diversa: i maschi temono l’evirazione; le femmine si sentono
evirate e provano “l’invidia del pene”. Inoltre, la fase fallica è contrassegnata dal fatto che il pene è
l’organo di eccitamento maschile, mentre quello femminile è la clitoride; b) fase genitale in senso
stretto e caratterizzata dalla genialità come localizzazione delle pulsioni sessuali.
Sempre a proposito dell’”angioletto asessuato” Freud elabora la dottrina del “complesso di Edipo” ricordando la tragedia di Sofocle - che interessa, nello specifico, i maschietti dai fra i tre e i cinque anni (fase
fallica) e che gioca un ruolo importantissimo nello sviluppo della personalità. Il complesso edipico rileva
l’attaccamento libidico verso la madre da parte dei maschietti e un parallelo atteggiamento ambivalente
(positivo e negativo) verso il proprio padre. Detto altrimenti: il complesso edipico maschile si manifesta con
l’amore per la madre e l’intenzione di prendere il posto del padre per avere la madre solo per sé.
Si vede facilmente che il maschietto vuole avere la madre soltanto per sé, avverte come incomoda la
presenza del padre, si adira se questi si permette segni di tenerezza verso la madre e manifesta la sua
contentezza quando il padre parte per un viaggio o è assente. Spesso da diretta espressione verbale ai
suoi sentimenti, promette alla madre che la sposerà. […] Quando il piccolo mostra la più scoperta
curiosità sessuale per la madre, quando pretende di dormirle accanto la notte, insiste per essere
presente alla sua toeletta o intraprende addirittura tentativi di seduzione – come spesso la madre può
constatare e riferire ridendo – la natura erotica del legame con la madre è garantita contro ogni dubbio
(Freud, Introduzione alla psicoanalisi)
Attraverso il complesso edipico il bambino sviluppa due concetti: identità e relazione. Identità sessuale e
relazione con l’altro sesso.
Per sedurre la madre il bambino imita il padre e con ciò crea la propria identità maschile. Nel momento in
cui, però, il bambino interiorizza la dimensione dell’identità, prende consapevolezza del fatto di non poter
realizzare il suo desiderio e viene assalito da uno stato di frustrazione al quale può reagire in due modi
diversi, che inevitabilmente, caratterizzeranno il modo di relazionarsi con l’altro sesso acquisendo quindi la
dimensione della relazione.
I due comportamenti con il quale il bambino può superare lo stato di frustrazione sono quello di risolutezza,
per cui si instaura una sorta di stimolo a migliorare nei rapporti con l’altro sesso, oppure, viceversa, un
comportamento di tipo depressivo.
Durante lo stadio edipico il bambino costruisce la propria identità attraverso l’imitazione del padre e impara
il rapporto con il sesso opposto attraverso l’amore per la madre. Uccidere il padre per acquisire la propria
identità; amare la madre per imparare ad amare le donne!
Il complesso edipico si tramuta in complesso di Elettra per quanto riguarda le femmine. In effetti, il
complesso di Elettra non ha una equivalenza completa con quello maschile e ciò perché il corpo femminile è
sostanzialmente due: femmina e figlio; Io e l’Altro.
In generale, infatti, la donna è contraddistinta da una sostanziale duplicità del suo essere. Ella è, infatti,
donna, ma allo stesso tempo, più dell’uomo, è strumento della natura, funzionario della specie. Questa sua
funzionalità è evidenziata dall’apparato biologico del suo corpo, che è “progettato” per ospitare un Altro da
sé, cosa che le viene ricordata ogni mese dal ciclo mestruale. La donna è un Io ma anche un funzionario della
specie. È evidente, quindi, come la psiche della donna sia più complicata di quella dell’uomo, che risente di
meno del suo ruolo di padre e funzionario della natura.
142
La ragazza, proprio a partire da questo doppio – Io e funzionario della specie – vuole e non vuole essere
funzionario della specie. La bambina si innamora del padre, ma non mai completamente convinta di voler
prendere il posto della madre, vi è indecisione e insicurezza: il complesso di Elettra non ha tratti chiaramente
definiti così come quello maschile.
Infine, la soddisfazione o l’insoddisfazione che si trae da una determinata fase dello sviluppo sessuale, può
comportare l’insorgere di condizioni psichiche “squilibrate”. Per esempio conseguenza di un’eccessiva
soddisfazione in una fase è lo sviluppo di una fissazione o di una regressione. Nel caso della fissazione vi è
un’incapacità dell’individuo di passare alla fase successiva, nel caso della regressione vi è un ritorno alla
fase in questione, nel momento in cui la successiva non è stata soddisfacente. Ad es. relativamente alla fase
orale una fissazione o regressione a tale fase possiamo avere disturbi più o meno gravi dell’alimentazione;
relativamente alla fase anale possiamo avere l’insorgere – come abbiamo accennato – di paranoia.
Il disagio della civiltà
Ben presto Freud capisce che le sue scoperte in ambito psicanalitico sono destinate a travalicare i limiti della
mera medicina e nell’ultima parte della sua vita si dedica ad una serie di argomenti più generali che
investono ad es. il rapporto con la religione, con le istituzioni della società civile e accenna al rapporto tra
masse e potere che in seguito sarà assai fecondo nella cosiddetta Scuola di Francoforte.
In L’avvenire di un’illusione (1927) Freud precisa il suo pensiero intorno alla religione e alle sue
rappresentazioni. Le rappresentazioni religiose non sono che “illusioni, appagamenti dei desideri più antichi,
più forti, più pressanti dell’umanità”. Desideri, si badi, infantili. Desideri di protezione contro le temperie
della vita. La religione non è altro che il bisogno dell’essere umano di affidarsi ad una illusione;
un naturale bisogno psicologico, inconscio, che ognuno di noi ha di persuadersi, di illudersi, che la vita
abbia un senso più profondo di quello che ci mostra il ciclo della natura. Il segreto della forza delle
rappresentazione religiose? “il segreto della loro forza - dice Freud - è la forza di questi desideri”.
Dio non è che il Padre celeste, amato e odiato ovvero la proiezione psichica dei rapporti ambivalenti verso il
padre terreno. Il Padre celeste è il padre nostro!
In Il disagio della civiltà (1929) Freud si sofferma sul rapporto tra civiltà e libido. Se per civiltà si intende
quelle realizzazioni e ordinamenti che l’uomo ha elaborato a difesa dell’umanità contro la natura e a regolare
le relazioni degli uomini, ebbene, la civiltà rivela essere infelicità, disagio.
La civiltà non è che piacere deviato verso mete sociali, prestazioni sociali e lavoro sociale. In questa
deviazione dal piacere la civiltà si configura come negativa, come costrizione, compressione. La civiltà dà
origine ad un Super-Io collettivo che, al pari di quello individuale, ha regole severe che se non vengono
assecondate generano nell’individuo “angoscia morale”. Il conflitto tra il principio del piacere orientato al
soddisfacimento individuale entra in conflitto con il principio di realtà che impone la rinuncia alle pulsioni
egoistiche.
Tuttavia, la civiltà è il male minore!
L’uomo ha barattato la felicità per un po’ di sicurezza!
Se la civiltà impone sacrifici tanto grandi non solo alla sessualità, ma anche all’aggressività dell’uomo,
allora intendiamo meglio perché stenti a trovare in essa la sua felicità. Di fatto l’uomo primordiale stava
meglio, poiché ignorava qualsiasi restrizione pulsionale. In compenso la sua sicurezza di godere a lungo
di tale felicità era molto esigua. L’uomo civile ha barattato una parte della sua possibilità di felicità per
un po’ di sicurezza. […] Quando giustamente protestiamo contro lo stato attuale della nostra civiltà,
accusandola di appagare troppo poco le nostre esigenze di un assetto vitale che ci renda felici, di lasciar
sussistere molto dolore che probabilmente potrebbe essere evitato, quando con critica spietata ci
sforziamo di mettere a nudo le radici della sua imperfezione, sicuramente esercitiamo un nostro giusto
diritto e non ci mostriamo nemici della civiltà. Possiamo aspettarci di ottenere cambiamenti nella nostra
civiltà con l’andare del tempo, tali che soddisfino meglio i nostri bisogni e sfuggano a questa critica. (Il
disagio della civiltà)
143
La concezione di Freud, al pari di quella di Schopenhauer - è realistica e pessimistica: il dolore, la sofferenza
è componente strutturale dell’uomo. L’uomo è animale che ha in sè una massiccia dose di aggressività e il
suo destino è la finitudine: la morte. Una società senza vincoli, senza impedimenti, senza regole morali, ecc.
sarebbe la dimensione all’interno della quale l’aggressività umana non farebbe che infliggersi ancor più
tormenti. Allora, il problema è una organizzazione sociale e istituzioni sociali che, nei limiti del possibile,
cerchino di limitare la compressione dell’Es contenendo gli spazi di repressione e di sofferenza. Insomma, se
la civiltà è un male inevitabile, che sia il minor male possibile!
CONCLUSIONI
Perché il ‘padre’ della psicanalisi si trova bellamente schierato in un manuale di filosofia?
Il rapporto tra filosofia e psicoanalisi può essere dipanato, schematicamente, considerando almeno due piani:
a) il rapporto di Freud con la filosofia, ovvero le influenze sulla sua personale formazione; b) il rilievo
filosofico della sua scoperta, ovvero il rapporto tra psicoanalisi e filosofia.
- Freud e la filosofia
Per quanto concerne il rapporto personale che Freud intesse con la filosofia esso è piuttosto negativo. Da una
parte vi è un rigetto della filosofia tout court, dall’altra la consapevolezza, soprattutto nel Freud maturo, che
le sue scoperte avranno un ruolo decisivo anche nella riflessione filosofica.
Freud non ha maestri filosofici in senso stretto. La sua è, di fatto, una preparazione medico-neurologico:
fisiologia, anatomia, biologia. E’ stato sicuramente influenzato da psicologi come Hebart, Brentano e da
scienziati come Darwin, Lamarck. Certamente vive e respira la cultura viennese e la cultura tedesca della sua
epoca: Conosce Schopenhauer, ma certo non Hegel.
A Schopenhauer attribuisce il grande merito di aver, con la sua filosofia, anticipato temi della psicanalisi:
l’inconscio nella vita psichica e l’importanza della sessualità.
non è stata la psicanalisi la prima ad aver compiuto il primo passo. Tra i precursori si possono citare
famosi filosofi, e, sopra tutti, il grande Schopenhauer, la cui ‘Volontà’ inconscia equivale agli istinti
psichici della psicoanalisi. Inoltre fu questo stesso pensatore ad ammonire l’umanità, con parole di
indimenticabile incisività, sull’importanza, tuttora grandemente sottovalutata, delle sue brame sessuali.
(Una difficoltà della psicoanalisi)
A questo elogio al grande filosofo segue, ad onor del vero, repentinamente una distinzione assai importante
tra le due discipline. La filosofia, ancorchè schopenhaueriana, è “astratta”; la psicanalisi, invece è concreta e
verificabile il che significa che si presenta come scienza.
Freud avversa complessivamente la filosofia del suo tempo su due punti strategici: a) l’astrattezza; b) il
coscienzialismo.
a) Freud respinge in blocco la filosofia in quanto la identifica a Weltanschauung, ossia visione del
mondo globale e totalizzante: più vicina alla religione che non alla scienza.
La Weltanschauung filosofica "partendo da una determinata ipotesi generale, - scrive Freud - risolve
in modo unitario tutti i problemi della nostra vita". In ciò la filosofia si rende colpevole di una
astrazione che tutto risolve nel puro pensiero e che in nulla tiene conto della diversità e complessità
della vita. Sinteticamente: la filosofia è identificata con l’incedere metafisico e questo con il peccato
di astrazione. La filosofia è, dunque, priva di valore conoscitivo;
144
b) In particolare Freud è avverso all’impostazione filosofica “coscienzialista” cioè a
quell’atteggiamento che afferma il primato della coscienza e che, di fatto, impedisce di accedere alla
comprensione dell'inconscio. Freud è, dunque, contrario a tutto quell’atteggiamento, di derivazione
cartesiana, che mette la coscienza a fondamento della conoscenza. La rivoluzione freudiana porta,
invece, a decentrare la coscienza: la coscienza non gode affatto di una posizione privilegiata. Infine,
anche quando i filosofi parlano di inconscio, lo pensano, semplicemente, come il negativo del
conscio, "sembra definire semplicemente l'opposto del conscio"; mentre per Freud "è lo psichico
reale nel vero senso della parola" (Interpretazione dei sogni). Non solo, l’inconscio risponde a
meccanismi che sono assolutamente diversi dal conscio e dall’Io. Ancora, se è sbagliata la posizione
coscienzionalista è sbagliata anche la posizione che non dà alcun rilievo alla coscienza. La filosofia,
per Freud, non fa che invilupparsi in posizioni astrattamente opposte.
In genere si tende a tracciare una linea di continuità tematica tra Schopenhauer, Nietzsche e Freud. Va
ricordato che tale continuum, tuttavia, è assai superficiale. Certamente vi sono temi in comune con
Schopenhauer che influenzerà Freud attraverso il concetto di doppia soggettività: Io, natura. La natura è la
dimensione dimenticata dall’uomo. L’interesse della specie fornisce due elementi per la propria
sopravvivenza: la pulsione sessuale e quella aggressiva. Queste due pulsioni, che servono all’economia della
natura, dominano l’inconscio. L’Io è costretto a illudersi, a giocare un vuoto progettarsi, ma è la specie a
dettare legge e a comprimere l’Io tra la nascita e la morte.
Per Schopenhauer l'inconscio è la causa vera del comportamento, mentre le motivazioni coscienti sono
ridotte ad un ruolo subordinato, sono razionalizzazioni che mascherano le reali cause dell'agire. L'amore
sdolcinato e romantico è una maschera, dietro la quale opera il freddo genio della specie. "Ogni
innamoramento, per quanto etereo voglia apparire, affonda sempre le sue radici nell'istinto sessuale".
La distinzione tra un piano cosciente e uno inconscio nelle motivazioni del comportamento umano verrà
ripresa anche da Nietzsche a partire da Aurora dove addirittura si anticipa che il sogno è considerare come il
soddisfacimento allucinatorio di un istinto rimasto insaziato. Anche nella Gaia scienza, si attacca l’elemento
cosciente come quello privilegiato o in Al di là del bene e del male è approfondita la critica dell’Io cartesiano
(n° 17).
Sia Nietzsche che Freud scardinano alcune certezze fondamentali e, da questo punto di vista, ha ragione P.
Ricoeur a unirli come “maestri del sospetto” insieme a Marx. Ma la distanza è siderale. Come per
Schopenhauer Freud sente una distanza che è, ad un tempo, lontananza epistemologica avrebbe sentito assai
lontano è distante il linguaggio aforismatico-poetico di Nietzsche.
Distanza siderale se si considera anche che sia Schopenhauer, che Nietzsche propongono un pensiero
irrazionale da veri paladini del pensiero irrazionalista. Freud si ostina a voler trattare razionalmente quel
caos, indistinto e magmatico che è l’inconscio.
- Psicanalisi e filosofia
Fin dall’inizio la filosofia ha segnalato in diverso modo l’inconscio. Tutta la filosofia potrebbe addirittura
essere pensata come il tentativo di arginare questa “divina follia” di cui parlava Platone. La filosofia cioè
come tentativo di porre ordine al caos; tentativo di organizzare coscientemente una risposta al caos che ci
abita prorompente e distruttivo. La filosofia, in questo senso, sarebbe il rimedio contro il terrore
dell’imprevedibile. Filosofia come risposta all’irrazionale che ci schianta!
Fin dall’inizio la filosofia ha segnato sulla mappa questo luogo oscuro, ma non lo ha mai compreso.
E’ Freud che teorizza in modo esplicito del tutto nuovo e con inusitata chiarezza un'istanza psichica al di là
della coscienza, in forza della quale l'uomo è agito da pulsioni, da forze che gli sfuggono. E’ su questa base
che Freud elabora una armatura teorica che sconvolgerà tutta la filosofia del XX secolo.
La teorizzazione dell’inconscio rimodella il concetto di Io. La rivoluzione psicanalitica irrompe nella cultura
occidentale sgretolando la classica concezione che avevamo dell’Uomo. Frana, innanzitutto, l’immagine
dell’Uomo che si era costruito intorno al cogito cartesiano.
Il dubbio cartesiano ci aveva insegnato che le cose possono non essere come appaiono, ma Cartesio non
dubita che la coscienza non sia come appaia a se stessa. Per Cartesio il mondo esiste ed esiste perché l’Io ne
145
ha una percezione chiara e distinta. Il cogito ergo sum presuppone a sua volta un Io unitario e fondante.
Dopo Marx, Nietzsche, Freud non possiamo non dubitare della nostra stessa coscienza. Pensavamo che l’Io
fosse presso di sé. Ora con Freud scopriamo che quando pensiamo di essere a casa nostra siamo altrove.
Pensiamo di agire e, invece, siamo agiti da forze che surrettiziamente gonfiano le nostre passioni. Siamo,
dice Freud, come quel sovrano che pensa di poter governare solo attenendosi alle informazioni del suo primo
ministro (l’Io) senza rapporto alcuno con il popolo.
Freud afferma che certo l’Io esiste ma è una realtà molto più marginale di quanto non si sia affermato lungo
tutta la tradizione occidentale.
La stessa cultura classica si configura, attraverso la strumentazione psicanalitica, come una roccaforte, una
muraglia cinese contro il terrore del nulla, la paura della morte che ci perseguita dall’inizio dei tempi.
L’uomo al centro del mondo e il mondo a misura umana sono entrambi elementi, da una parte consolatori,
dall’altra autogratificanti in funzione di volontà di dominio. Tutto ciò di cui eravamo certi e fieri ora si
disgrega davanti agli occhi. Le certezze crollano. Le teorie roboanti che ci ponevano al centro di tutto si
mostrano false e, semplicemente consolatorie. La conoscenza scientifica ha fugato quelle narrazioni
consolatorie e narcisistiche. Tre le ferite narcisiste che Freud vede nitidamente sul corpo della cultura
occidentale. Tre crisi: crisi della concezione dell’universo; crisi della concezione dell’uomo; crisi della
concezione della ragione. Tre gli autori: Copernico, Darwin e lo stesso Freud. Pensavamo di essere al centro
del mondo e Copernico ha dimostrato il contrario. Pensavamo di essere scintille divine e Darwin ci ha
riportato tra gli animali. Pensavamo di essere signori, almeno, di noi stessi e Freud ci mostra che non siamo
padroni neppure in casa nostra.
In Una difficoltà della psicanalisi (1917) Freud descrive magnificamente questa triplice umiliazione, questa
triplice ferita al narcisismo umano:
Mi propongo di dimostrare come l’universale narcisismo degli uomini, l’amore che essi portano a sé
stessi, abbia finora subito tre gravi colpi per opera della ricerca scientifica.
a) Nelle prime fasi della sua ricerca l’uomo credeva inizialmente che la sua dimora, la terra, fosse il
centro immobile dell’universo, intorno al quale roteavano il sole, la luna e i pianeti. [… con Copernico]
l’egoismo umano subì il primo colpo, quello cosmologico.
b) Nel corso dello sviluppo della civiltà, l’uomo acquistò una posizione di predominio sulle creature
compagne, del regno animale, ma, non contentandosi di tale supremazia, prese a scavare un abisso tra
la sua natura e quella degli animali. Negò loro il possesso della ragione e attribuì a se stesso un’anima
immortale ed avanzò delle pretese circa la propria origine divina, ciò che gli consentì di rompere il
legame di comunanza tra se e il regno animale. […] Darwin e dei suoi collaboratori e precursori, posero
fine a questa presunzione umana. […] Questo è stato il secondo colpo apportato al narcisismo, il colpo
biologico.
c) Il terzo colpo, di natura psicologica, è forse il più tremendo. […] L’Io, infatti, è certo sia della
completezza e veridicità delle informazioni che riceve, sia della pervietà dei canali tramite i quali
trasmette i suoi comandi. [… L’Io si] comporta come un monarca assoluto, che si accontenta delle
notizie fornitegli dai suoi più alti funzionari, senza mai scendere in mezzo al popolo per ascoltarne la
voce. […] Ma queste due scoperte [di Freud] – che la vita dei nostri istinti sessuali non può essere
dominata integralmente e che i processi psichici sono, di per se stessi, inconsci e pervengono all’Io,
ponendosi sotto il suo controllo, soltanto mediante percezioni incomplete e inattendibili – ci
permettono di affermare che l’Io non è padrone in casa sua. Insieme, esse sferrano il terzo colpo
all’egoismo umano, quello che io sono solito chiamare psicologico. (Una difficoltà della psicanalisi)
In questo senso P. Ricoeur può annoverare Freud tra i “maestri del sospetto” insieme a Marx e Nietzsche
perché, al di là delle differenze, considerano, complessivamente, “La coscienza come falsa coscienza”.
Tuttavia va rimarcata la differenza! La psicanalisi è per Freud scienza particolare; strumentazione
scientifico-razionale. Freud è un razionalista. Il periplo dell’inconscio è, ancora, affidato alla ragione.
L’inconscio pulsionale, caotico, tellurico che non riconosce alcuna ragione, né alcun principio di ragione
viene perimetrato con la ragione illuminista senza la quale non possiamo che essere prescientifici.
146
Diversamente da Nietzsche Freud non involve verso un irrazionalismo. Freud è, in questo, più vicino a Marx
che ancora si adopra alla lettura razionale del mondo anche per scoprirne i lati irrazionali.
Merito della psicanalisi è certo quello di aver spostato l’attenzione dal conscio all’inconscio e di aver
mostrato come il conscio non è affatto così sicuro, evidente, trasparente come pensava di essere.
Merito della psicanalisi è aver testimoniato e tentato di leggere un mondo irrazionale che ci abita e ci
governa. Eppure lo sforzo di Freud è stato quello di circumnavigare questo mare irrazionale e ribollente con
l’unica navicella possibile: la ragione. Freud ebbe il coraggio scientifico di inoltrarsi per l’alto mare aperto
dell’irrazionale ben sapendo che l’unico modo per capirlo era di nuovo il suo setaccio razionale. Capire le
interferenze, le relazioni, le distorsioni che l’Io subisce ad opera di processi inconsci è opera scientifica di
disvelamento. In questo senso Freud scoprendo l’inconscio non annulla affatto il valore della coscienza ma
della falsa coscienza. “Con tutto ciò – scrive Freud – non è detto che la qualità della coscienza abbia per noi
perduto il suo significato. Resta la sola luce che splende nell’oscurità della vita psichica e ci guida”. Fuori le
tenebre! Freud si inserisce a pieno titolo nel solco illuminista che alla ragione affida il futuro della
conoscenza e della ‘cura’. Della conoscenza perché “il sonno della ragione genera mostri”. Della
‘cura’perchè la psicanalisi si adopra affinchè “Dove era l’Es, deve subentrare l’Io”.
BIBLIOGRAFIA
Opere di Freud
Freud, Psicopatologia della vita quotidiana, Boringhieri, 2012
Freud, Compendio di psicanalisi, Boringhieri, 1980
Freud, Leonardo da Vinci. Boringhieri, 2012
Opere su Freud
Cappelletti, Introduzione a Freud, Laterza, 2010
SITI WEB:
http://www.psicoanalisi-freudiana.com
147
VII. LA CRISI DEI FONDAMENTI SCIENTIFICI
E LA FILOSOFIA DELLA SCIENZA
(Comte, Popper, Khun, Lakatos, Feyerabend)
Questo tratto della filosofia, nello specifico, della filosofia della scienza parte dalla rivoluzione
scientifica e ci porta con il post-positivismo fino alla contemporaneità. Il percorso tratteggiato
privilegia sostanzialmente il rapporto tra scienza e verità: la parabola che il concetto di verità
evidenzia.
~ LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA
~ IL POSITIVISMO DI COMTE
~ La dottrina della scienza
~ La legge dei tre stadi
~ LA CRISI DEI FONDAMENTI
~ IL FALSIFICAZIONISMO DI POPPER
~
~
~
~
Il falsificazionismo
L’induttivismo
Scienza e verità
Il realismo dell’ultimo Popper
~ IL POST-POSITIVISMO DI KHUN, LAKATOS E FEYERABEND
~ Khun: La struttura delle rivoluzioni scientifiche
~ Lakatos: La metodologia dei programmi di ricerca
~ Feyerabend: Contro il metodo
~ CONCLUSIONI
148
LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA
E’ qui il caso di accennare, per sommi capi, la definizione che abbiamo dato di filosofia e di avvertire della
profonda differenza che si produce con la rivoluzione scientifica operata dai filosofi della natura, nome con
cui venivano chiamati gli scienziati fino al XIV secolo.
La verità è, ad un tempo, alétheia cioè ciò che ‘sta in luce’, ed epistéme cioè ciò che ‘sta sopra’. La verità
così caratterizzata è sapere assoluto, incontrovertibile, eterno, immutabile che né uomo né Dio possono
mettere in discussione. Il mezzo che la filosofia sceglie per giungere a questo sapere è il Lógos, la ragione, la
logica. Ancora, fin dall’inizio la verità viene concepita all’interno del Tutto. Il Tutto è la dimensione della
verità. Il Tutto è ciò di cui non è possibile pensare altro e oltre. Ogni cosa è parte del Tutto e solo la
comprensione del Tutto può portare alla luce e ‘fermare’ ogni singola cosa. Aristotele dirà che un braccio
staccato dal corpo è un “braccio dipinto” ad intendere che un elemento, staccato dalla relazione con la
totalità, non può essere inteso veramente; perché è un elemento a cui mancano, appunto, le relazioni con il
Tutto. Un braccio staccato dal corpo, per intenderci, non può restituirci più la funzione all’interno del sistema
corpo, la relazione con il cervello, ecc. al massimo è, sotto la lama, non più braccio, ma pezzo di carne
sanguinolenta di nervi senza relazione, muscoli senza comandi, ecc. carne morta ,“dipinta”. Detto in altri
termini un elemento in un sistema è altro che lo stesso elemento fuori da un sistema.
Lo sguardo della filosofia al suo nascere è uno sguardo che guarda al Tutto. L’albero, la nuvola, l’unghia non
ha una sua verità se non all’interno del Tutto. Lo sguardo della filosofia è a 360°, mai si sofferma su ciò che
è il particolare. Non è certo un caso che Talete, con cui si vuole far iniziare questo viaggio di folli, pone in
maniera ‘cristallina’ la domanda sull’identità dei diversi.
Altro tratto caratteristico del fare filosofico è il Lógos come mezzo per arrivare alla verità. Il greco pensa che
la evidenza razionale, logica è essa stessa prova della verità. Il Lógos, portando le cose dal buio indistinto
alla luce, le recupera all’epistéme. La verità è la evidenza con cui le cose si presentano al Lógos. Per il greco
basta che attraverso il Lógos si mostri, in maniera chiara e distinta, una cosa perché essa sia vera.
Proprio come aveva detto Hegel, questa identità di certezza e verità viene meno in quel movimento del
pensiero che da Cartesio arriva a Kant: non siamo sicuri che al Lógos, al pensiero spetti una verità assoluta.
149
Ora, proprio all’inizio di questo movimento, avviene ciò che chiamiamo rivoluzione scientifica attraverso
l’opera di Galileo, Bacone, Newton, Cartesio, ecc.
Dal punto di vista squisitamente filosofico, questa rivoluzione complessivamente produce una rottura
epistemologica col fare filosofico precedente.
L’inizio, come in ogni rivoluzione, fu flebile: si voleva solo aggiustare qualche canna dell’organo di
Aristotele. Si finì con il mandarlo in soffitta!
I filosofi della natura operano innanzitutto una riduzione dello sguardo. L’occhio ora si concentra sui
particolari: albero, nuvola, unghia. Se Aristotele ammoniva contro il “braccio dipinto” Bacone farà
l’apologia della scienza come “dissezione della natura”. Dunque, riduzione o isolamento! La rivoluzione
scientifica opera, dunque, una prima riduzione: dal Tutto al particolare.
Non basta! L’albero, la nuvola, l’unghia è unione di aspetti qualitativi e quantitativi. In fondo lo stesso
grande Democrito, ora certo più attuale di Aristotele, aveva insegnato questa duplicità. Democrito aveva
distinto gli aspetti quantitativi o qualità primarie, che potevano essere oggetto di verità perché comuni, dagli
aspetti qualitativi o qualità secondarie, che avevano carattere soggettivo. La conoscenza vera era la
conoscenza degli aspetti quantitativi, oggettivamente sperimentabili da chiunque.
La rivoluzione scientifica guarda al materialismo di Democrito nel tentativo di scrollarsi dal groppone la
“sillogistica aristotelica”. In ciò la rivoluzione scientifica opera la seconda riduzione: dal particolare alla sola
quantità.
Dunque, la rivoluzione scientifica opera una doppia riduzione:
1) dal Tutto al particolare;
2) dal particolare alla sola quantità.
Con quale strumento possiamo cogliere, al di là dell’aspetto sensibile-percettivo, la struttura quantitativa
delle cose? Quantità, dunque, misura, ergo, matematica! La matematica è il passepartout del libro
dell’universo. Ecco che Galileo può dire senza indugio che “Egli [l’universo] è scritto in lingua
matematica...". (Il Saggiatore)
Non basta, la scienza opera sostanzialmente attraverso l’induzione: lo strumento per scoprire le cause prime.
La scienza si muove nella convinzione che, partendo dall’osservazione, sia possibile formulare leggi e
ipotesi predittive.
La filosofia della natura parte dalla convinzione che bisogna rovesciare l’impostazione metafisica
precedente: dal Tutto al particolare. Bisogna partire dal particolare per poi assemblare, sommare i pezzi e
ricostruire la Totalità. Dal particolare al Tutto. Per la scienza bisogna partire dal “braccio dipinto”, per poi
legarlo al torace, e scoprirne le funzioni, nella relazione ‘viva’ con il corpo.
L’incedere filosofico è messo sottosopra!
Parallelamente alla doppia riduzione, la scienza avanza una doppia strumentazione per giungere alla verità
che è, ad un tempo, anche doppio controllo o verificazione, fare scientifico.
Il Lógos, la ragione rimane lo strumento indispensabile che governa e tiene unito il procedimento
conoscitivo-scientifico, dalla ipotesi all’esperimento, ma ora la dimostrazione meramente logica non può più
essere considerata la ‘dimostrazione’, ma solo una sua parte.
La verità dell’ipotesi scientifica è imbrigliata o saldata in una serie di operazioni pratiche che, isolando le
parti, le osserva per confermare o meno la previsione dell’ipotesi. L’ipotesi è, dunque, resa vera o falsa
attraverso l’esperimento, il “cimento” (Galileo). Alla evidenza razionale ora si affianca l’esperimento. Il
Lógos raddoppia con l’esperimento!
Dunque, la rivoluzione scientifica trova il modo per accedere e dimostrare la verità attraverso un raddoppio
dello strumento del controllo:
1) Lógos;
2) esperimento.
150
Un circolo che propone teoria e prassi e tale da legare l’uno all’altra in maniera che il Lógos non possa
involarsi nelle regioni della metafisica.
La rivoluzione scientifica infine, si situa all’interno della filosofia e con la filosofia condivide il problema
della verità. La scienza è verità seppur limitata ad elementi particolari, ma che si ampliano sempre più. La
scienza inscrive la sua attività nella dimensione della verità, seppur decurtata. Ciò che essa afferma
corrisponde alla verità fuori di noi: rispecchia la verità della natura.
151
IL POSITIVISMO DI COMTE
Auguste Comte (Montepellier, 1798 – Parigi, 1857) è il positivismo, o buona parte di esso!
Comte è l’espressione filosofica della grande industria, della borghesia in ascesa di metà Ottocento e dei
suoi interessi rivoluzionari; rivoluzionari in quanto, pur essendo decisamente di classe, finiscono per
diventare storicamente generali, globali: coincidenti con gli interessi generali di un processo storico gravido
di portentosi sviluppi.
La borghesia e il positivismo, che in Comte ha una plastica raffigurazione, ripone nella scienza l’unica
chance di salvezza dalle catene della metafisica, della religione e della tradizione.
La scienza è, ancora, l’unico strumento capace di porre uno sviluppo senza limiti, nel mentre spiana la strada
verso un controllo sempre maggiore della natura. Il positivismo identifica senz’altro lo sviluppo con il
progresso. La scienza è il metodo scientifico, è l’unica modalità che ci permette uno sviluppo costante in
campo culturale e materiale, dunque, davanti a noi si erge sicuro un progresso storico senza pari: sorti
progressive!
I testi più importanti di Comte sono: Corso di filosofia positiva (1830) e Discorso sullo spirito positivo
(1844). Il “bisogno fondamentale”, la molla che ha spinto la riflessione di Comte è la costruzione di una
filosofia della storia, l’individuazione di una legge di sviluppo dell’umanità. Tuttavia la parte della sua
riflessione che ebbe più risonanza è sicuramente quella che concerne la dottrina della scienza.
Per Comte la scienza è “garante del consorzio umano”, poiché essa è l’unica fonte di sapere libero e
soprattutto condivisibile, universale, che sfugge alle secche della dóxa e, ancor più, della metafisica e del suo
involversi in pure e semplici, astruse e insensate fantasticherie.
Il positivismo è caratterizzato da una fiducia assoluta, incondizionata nella ragione e nel sapere come mezzi
principali per il progresso, versus qualsiasi ingerenza irrazionale o dimensione religiosa o che si appelli alla
autorità della tradizione. Per certi versi, quindi, essa è simile all’Illuminismo settecentesco, ma se ne distacca,
tuttavia, per la minore carica polemica e per l’intento più rilevante di assolutizzazione e riordinamento del
quadro scientifico e delle modalità del procedere scientifico.
152
La dottrina della scienza
La scienza è l’arma attraverso cui l’uomo potrà esercitare il proprio predominio.
Comte si inserisce in quella lunga linea di pensiero che da Bacone a Cartesio aveva presagito il dominio
dell’uomo sulla natura attraverso la scienza. Rammentiamo che, in maniera chiara e cristallina, in Bacone il
sapere, nella fattispecie la scienza, aveva perso il candore di un sapere disinteressato, un sapere per il mero
sapere ed era ora potenza: capacità di penetrare la natura per porla al servizio dei propri bisogni.
La scienza per Comte ha carattere essenzialmente speculativo-teoretico, da non confondere con la scienza
tecnico-pratica. La scienza ha una base razionale e teorica che permette di prevedere i fenomeni per poter,
solo successivamente, modificarli a proprio piacimento e vantaggio. Il suo scopo è quindi formulare delle
leggi attraverso l’attenta osservazione dei fatti, in modo da comprenderli ed esplicarli completamente.
Dunque, la scienza è formulazione di leggi che permettono la previsione e questa, a sua volta, permette
l’azione:
scienza, donde previsione; previsione, donde azione.
Osservazione dei fatti e formulazioni di leggi. Formulazione di leggi al fine della previsione che garantisce la
possibilità di potersi servire dei fatti per la soddisfazione dei propri bisogni.
Da ciò è evidente l’impostazione empiristica del pensiero di Comte, che infatti fa proprio il principio che da
Tommaso a Locke recita che Nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu (Nell’intelletto non vi è
niente che non sia già stato nei sensi). Tuttavia, in contrasto col pensiero del filosofo inglese, egli è
fermamente convinto che al di sotto del fenomeno, l’oggetto di indagine dell’esperienza, non vi sia affatto un
noumeno, una realtà nascosta e più stabile.
Tuttavia si possono notare anche alcuni spunti razionalistici condivisi da Comte, come l’adozione del
principio di regolarità nell’analisi della realtà: non si ha conoscenza senza una previa concettualizzazione
del mondo, senza che ogni singolo evento venga ricondotto attraverso la scienza ad una teoria generale ed
astratta. Inoltre, le teorie stesse devono essere il più concise e universali possibili, in quanto se vi fosse una
legge specifica per ogni accadimento della realtà, questa finirebbe col diventare un duplicato della realtà
stessa, che vanificherebbe l’utilità della scienza: tale obiettivo viene definito da Comte come “principio di
economia”.
Infine, la scienza per Comte è avalutativa, in quanto non crea valori e non ne fa uso. Ciò non significa però
che la morale non necessiti della scienza, in quanto senza quest’ultima essa risulterebbe illogica e
ingiustificabile.
Partendo dalle suddette influenze, Comte si preoccupa di distinguere ciò che è pura scienza dal ciarpame
pseudo-scientifico, creando una enciclopedia generale di tutte le conoscenze scientifiche.
La legge dei tre stadi
La legge dei tre stadi: sulla base di considerazioni storiche e antropologiche Comte afferma che ogni ambito
del sapere umano si articola attraverso tre fasi teoricamente, ma anche socialmente, differenti: lo stadio
teologico, lo stadio metafisico e lo stadio positivo.
Nello stadio teologico, che è il necessario punto di partenza dell’intelligenza umana, l’uomo, ricercando
le cause prime e la natura delle cose, finisce per attribuire ai fenomeni un’origine sovrannaturale, il cui
intervento spiega tutte le anomalie dell’universo. A questa forma di pensiero corrisponde la monarchia
teocratica del Medioevo;
Nello stadio metafisico, che non funge nient’altro che da tramite verso il sapere positivo, l’elemento
sovrannaturale viene sostituito da forze astratte, come le essenze, capaci anche stavolta di giustificare da
153
sole l’andamento della natura. Lo stadio metafisico è tipico del mondo moderno, governato dalla
sovranità popolare, che si trova in una fase di crisi e transizione;
Nello stadio positivo, infine, l’uomo rinuncia ad indagare l’origine dell’universo; per scoprirne piuttosto
le leggi che lo governano, ovvero le relazioni di successione e somiglianza. Com’è ovvio, il positivismo
si addice all’organizzazione scientifica che assume la società industriale e borghese.
Il problema principale della conoscenza umana è ora, secondo Comte, l’assenza di un sapere positivo in
alcuni campi fondamentali, ed in particolare nelle scienze sociali:
Infatti, mentre esistono allo stadio positivo una fisica celeste, che studia gli astri e i loro moti, una fisica
terrestre, che si occupa della meccanica e della chimica e finanche una fisica organica, che tratta
scientificamente gli esseri viventi, non vi è alcuna fisica sociale e tale mancanza provoca una condizione di
anarchia intellettuale, a cui consegue la crisi politica e morale che affligge la società contemporanea.
La fisica sociale è tuttavia, almeno per ora, irrealizzabile, in quanto in essa coesistono i tre stadi del sapere,
e ciò non permette di ottenere un ordine prestabilito che porti al superamento della crisi.
Proprio per questo Comte, riprendendo il percorso già cominciato da Cartesio, Galileo e Bacone, tenta di
tratteggiare i principi generali ed universali della filosofia positiva, delineando i tratti della già citata
enciclopedia.
In essa Comte racchiude non le scienze pratiche, le arti o la tecnica, ma piuttosto le scienze speculative; egli
si limita, inoltre, ad affrontare solo quelle generali ed astratte, rifuggendo dalle analisi più specifiche,
concrete e particolari.
Il criterio con le quali le suddette scienze vengono classificate è l’ordine decrescente di semplicità, in modo
che la loro disposizione coincida con la successione con cui esse sono entrate nella loro fase positiva.
Secondo questo parametro, in primo luogo si possono distinguere i fenomeni che interessano gli enti più
semplici, cioè i corpi inorganici, che sono appunto oggetto di studio da parte della fisica inorganica; vi è poi
l’analisi dei fenomeni che interessano i corpi più complessi, organizzati, gli esseri viventi, attraverso la fisica
organica.
A sua volta la prima può essere divisa, nuovamente, in base alla complessità della materia trattata, nello
studio dei corpi celesti, l’astronomia, o fisica celeste, e nella fisica terrestre, che si occupa delle interazioni
tra i corpi (nella fisica propriamente detta) e della loro composizione (nella chimica).
La seconda, invece, viene suddivisa anch’essa in due parti, in quanto essa ha, sì, un campo di analisi
individuale, ma anche uno collettivo, relativo all’intera specie: si parla quindi, nel primo caso, di biologia,
ovvero una fisica organica fisiologica, e di sociologia, ovvero di fisica organica sociale, nel secondo.
Le cinque scienze fondamentali, che vanno a costituire l’enciclopedia, sono: l’astronomia, la fisica, la
chimica, la biologia e la sociologia.
Comte esclude quindi dall’enciclopedia discipline quali la matematica, la logica e la psicologia.
Per quanto riguarda la matematica, essa viene esclusa non perché Comte non la consideri una scienza vera e
propria, ma piuttosto poiché essa è ritenuta la base di tutte le altre scienze, un fondo sul quale poggiano tutte
le scienze.
La logica, invece, viene considerata come concreta e particolare, in quanto essa non è un sapere generale,
ma un metodo con cui ogni branca del sapere stesso sussiste e prende forma.
Infine, la psicologia viene esclusa poiché non è una vera e propria scienza, in quanto il suo campo d’analisi,
similmente a come dirà più tardi Popper, non è tangibile, poiché la ragione non può essere in alcun modo
osservata dall’esterno mentre agisce.
La sociologia, invece, rappresenta il fine ultimo di tutte le scienze positive, in quanto da essa dipendono i
concetti, fondamentali per l’uomo, di ordine e progresso.
Questi due concetti fanno capo a due compartimenti della sociologia, complementari l’uno con l’altro.
L’ordine viene analizzato dalla statica sociale, che mette in luce le relazioni necessarie tra le varie parti della
società, mentre il progresso e lo sviluppo sono prerogativa della dinamica sociale. Quest’ultima spiega
154
anche la presenza degli “uomini di genio”, che vengono hegelianamente interpretati come uno strumento,
un’espressione della volontà di affinamento del genere umano attraverso, appunto, il progresso.
Per questo Comte auspica l’avvento di quella che egli chiama “sociocrazia”, ovvero di un regime pressoché
perfetto, fondato proprio sulle scienze sociali: culla ideale di un’umanità volta sempre più verso il
perfezionamento di sé stessa.
Infine, va rilevato come l’esaltazione della scienza positiva diventa in Comte, alla fine, una sorta di apologia
quasi religiosa della scienza che ben trova nell’idea di un “calendario positivista” la sua figura più esplicita
ed esaltata.
155
LA CRISI DEI FONDAMENTI
Alla fine dell’Ottocento quelle che si pensavano fossero le solide basi della scienza tremano, meglio, franano
e con esse le verità che la scienza ci aveva abituato a considerare ferme: epistéme. E’ la crisi dei fondamenti!
Le categorie fondamentali della scienza, spazio, tempo, causa, si ritrovano al centro di una vera tempesta in
cui non sembra esservi nulla di solido e stabile ma tutto è fluttuante e relativo. Le basi della matematica e
della fisica si ritrovano ricacciate nell’incertezza e tutto sembra essere costruito non sulla solida roccia, ma
su fango molle, cedevole.
- Matematica
La matematica era stata considerata a partire da Euclide e fino a Kant la scienza per eccellenza: un sapere
perfetto. Non è certo un caso che Kant nella Critica aveva ammesso al consesso scientifico la matematica e
la fisica e aveva risolutamente escluso qualsiasi volo della ‘colomba metafisica’ denunciandone l’astrazione
come fabula.
Ora la matematica, che aveva nella geometria la sua radice più profonda, vacilla perché è lo stesso grattacielo
della geometria euclidea a vacillare a flettere al vento di altre geometrie. La geometria di Euclide (323-285 a.
C.) dopo duemila anni sembrano vacillare con l’irrompere delle geometrie non euclidee.
Gauss e Lobacevskkij (inizio 1800) misurano la crosta terrestre, prendendo in considerazione il triangolo
avente per vertici Terra, Sole, Sirio e rilevano che la somma degli angoli è meno di 180°. Lobacevskij e
Bolyai, indipendentemente, costruiscono una geometria iperbolica a somma angoli minore di 180° e, dato
una retta r e un punto P esterno a essa, esistono almeno due rette (e non una come voleva Euclide) passanti
per P e parallele a r.
Riemann costruisce una geometria ellittica, dove la somma degli angoli di un triangolo è maggiore di 180° e
dove, in generale, non esistono rette tra loro parallele.
La geometria euclidea - che aveva costituito la base sicura della matematica - non è la sola possibile, dunque,
da qui si cercherà, attraverso vari tentativi, una rifondazione epistemologia della matematica:
a) sull’aritmetica (Peano);
b) sulla logica (Frege, Russell);
c) sull’intuizione (Brouwer).
Un’altra importante spallata alla certezza matematica viene da un giovanotto di appena venticinque anni:
Kurt Gödel. Gödel con il suo teorema di completezza (1930) dimostra che la logica è un sistema coerente e
completo: da assiomi, attraverso regole, si possono derivare tutte e sole verità logiche.
Lo stesso Gödel, l’anno successivo, con il teorema di incompletezza (1931) dimostra, invece, l’impossibilità
di fondare la matematica come sistema coerente: se non vogliamo avere antinomie dobbiamo avere
incompletezza; se vogliamo completezza dobbiamo convivere con le antinomie riprendendo, dunque, quanto
Kant aveva affermato in sede gnoseologica nella sua Critica della ragion pura.
- Fisica
A partire dall’inizio del Novecento anche la fisica mostra vari spazi critici che, tuttavia, possiamo
sintetizzare in due punti che danno il senso di veri e propri cambi di paradigma. cioè di cambio del modello
scientifico-culturale:
1. Einstein: teoria della relatività: la meccanica newtoniana non da risultati corretti se applicata a
oggetti molto grandi che si muovono a grande velocità;
2. Plank: meccanica quantistica: la teoria newtoniana non è corretta se si applica ad oggetti molto
piccoli, particelle subatomiche.
156
Il FALSIFICAZIONISMO DI POPPER
Il falsificazionismo
Karl Popper (Vienna, 1902 – Londra, 1994) è il filosofo del falsificazionismo!
Falsificazionismo che Popper elabora a partire dalla influenza che su di lui avrà il grande Albert Einstein e le
sue teorie scientifiche. Popper fin dall’inizio rimase colpito dal fatto che Einstein avesse formulato le proprie
teorie non tanto in vista di facili verifiche, quanto di rischiose previsioni e, dunque di possibili smentite (o
falsificazioni). Insomma, le teorie di Einstein potevano essere falsificate a differenza ad es. del marxismo o
della psicanalisi. La psicanalisi poteva spiegare un evento o la mancanza di un evento con una facilità
estrema senza mai contraddirsi. Ugualmente, la teoria della storia di Marx faceva si che si giustificasse e
spiegasse con eguale eleganza sia che una cosa accadesse che non accadesse. Insomma nulla a che fare con
l’impostazione della teoria di Einstein, che faceva previsioni molto definite e precise: i raggi luminosi
provenienti da stelle lontane sarebbero stati deviati dal campo gravitazionale del sole: cosa che venne
confermata dalle osservazioni.
Inoltre, come Einstein, Popper elabora la propria rivoluzione epistemologica a partire dalla convinzione che
le teorie scientifiche non sono verità assolute ma semplici ipotesi, congetture destinate ad essere superate.
Se la teoria di Newton, che era stata controllata nel modo più rigoroso era stata confermata meglio di
quanto uno scienziato si sarebbe mai potuto sognare, era poi stata smascherata come ipotesi malsicura
e superabile, allora era cosa disperata l’aspettarsi che una qualsiasi altra teoria fisica potesse
raggiungere qualcosa di più che lo stato di ipotesi. (I due problemi fondamentali della conoscenza)
Il falsificazionismo è, dunque, il metodo attraverso cui è possibile distinguere il grano dalla pula, la scienza
dal semplice racconto. Tale problema viene definito demarcazione, e Popper vi trova una soluzione appunto
nel principio di falsificabilità: a differenza del verificazionismo, che intendeva elevare a scienza tutto ciò
157
che fosse stato, appunto, verificato dall’esperienza, egli introduce il criterio della validità di una teoria in
virtù della sua possibilità di essere smentita dalla stessa esperienza.
Per questo motivo risultano, quasi paradossalmente, scientifiche solo quelle teorie che possono essere
falsificate, o quantomeno quelle che presentano potenzialmente un elemento falsificatore in loro stesse.
Perciò la metafisica, secondo Popper, sicuramente non è una scienza, ma egli non la ritiene come un
qualcosa privo di senso, in quanto riconosce la sua funzione propulsiva nei confronti della scienza. Infatti, le
idee “dogmatiche” al suo fondamento rappresentano la fonte “da cui rampollano le teorie delle scienze
empiriche”.
Da quanto detto sopra risulta che non sarà mai possibile definire come certa e assolutamente vera anche una
singola teoria, poiché servirebbero infinite conferme ad essa, mentre basta una semplice asserzione contraria
per smontare un impianto apparentemente scientifico. Questo principio esprime l’assoluta superiorità
epistemologica del falsificazionismo sul verificazionismo, che tuttavia lascia la scienza senza un
fondamento assoluto, ma piuttosto con delle convenzioni. La scienza risulta cioè costruita non sulla solida
roccia, ma su “fragili palafitte”, decise dagli scienziati stessi che ne fanno uso in un determinato periodo
storico per i loro scopi:
La base empirica delle scienze oggettive non ha in sé nulla di assoluto. La scienza non posa su un solido
strato di roccia. L’ardita struttura delle sue teorie si eleva, per così dire, sopra una palude. E’ come un
edificio costruito su palafitte. Le palafitte vengono conficcate dall’alto, giù nella palude: ma non in una
base naturale o data; e il fatto che desistiamo dai nostri tentativi di conficcare più a fondo le palafitte
non significa che abbiamo trovato un terreno solido. Semplicemente, ci fermiamo quando siamo
soddisfatti e riteniamo che almeno per il momento i sostegni siano abbastanza stabili da sorreggere la
struttura. (La logica della scoperta scientifica)
La superiorità epistemologica della falsificabilità, secondo Popper, sta anche nella evidente asimmetria
logica tra verificabilità e falsificabilità. Basta un solo fatto negativo per confutare una teoria rispetto a
miliardi di conferme.
La scienza è, quindi, non il mondo delle verità ma l’universo delle ipotesi.
Tuttavia, alcune teorie sono ritenute più affidabili di altre. Popper spiega questo meccanismo con il concetto
di corroborazione.
Una teoria si dice infatti corroborata quando essa ha superato il confronto con un’esperienza che si riteneva
potenzialmente falsificante.
Vi è quindi un criterio di preferenza verso la verità, che, in certi casi, risulta più forte persino della
falsificabilità stessa: in primo luogo, anche le esperienze falsificanti devono essere ritenute valide, e quindi
sottoposte allo stesso criterio di cui sono strumenti, il quale potrebbe smentirle a loro volta, ridando validità
scientifica alla teoria attaccata; inoltre, qualora una teoria venisse falsificata definitivamente (anche se a
questo punto di falsificazione definitiva non si può più parlare), essa non potrebbe essere sostituita fino alla
costruzione di una teoria migliore.
Per questo, Popper elabora un modello flessibile, diremmo pluriteorico, nel quale vi è un confronto non solo
tra teoria ed esperienza, ma anche tra teorie rivali.
Tale modello si basa su una procedura specifica alla base della scienza, che egli definisce procedimento per
congetture e confutazioni, il quale consiste nel rispondere ai problemi attraverso delle ipotesi sottoposte alla
critica dell’esperienza. In questo senso Einstein e una semplice ameba adottano lo stesso metodo per
sopravvivere in un ambiente: la differenza sta nel fatto che il signor Einstein ha la capacità di imparare dai
suoi errori!
Vi è quindi un trittico “problemi-teorie-critica” alla base del tutto, il quale finisce con lo stabilire
l’importanza, paradossalmente, dell’errore, all’interno della scienza, che è perciò non più epistéme, sapere
immutabile, ma disciplina che si costruisce e si corrobora man mano, imparando dai propri sbagli, che sono
un passaggio necessario verso il miglioramento.
158
L’induttivismo
La deduzione o inferenza deduttiva è una modalità del nostro ragionamento che si esplica ad es. nel modo
seguente: Tutti gli italiani amano il vino rosso. Antonio è un italiano. Antonio ama il vino rosso.
I primi due enunciati sono premessa della inferenza deduttiva. Se le premesse sono vere la conclusione deve
essere vera.
Nella inferenza induttiva, invece, possiamo partire da premesse vere e arrivare a conclusioni false. Ci
muoviamo da premesse su oggetti che abbiamo esaminato a conclusioni su oggetti che non conosciamo
affatto: dal particolare al generale. Nonostante ciò il ragionamento induttivo è indispensabile nella vita di
tutti i giorni.
Il grande Hume poneva il problema: se il sole è sorto fino ad oggi ciò non significa che sorgerà domani! Per
Hume il principio induttivo non può essere affatto dimostrato razionalmente. Esso è semplicemente una
abitudine animale, una fede cieca.
Noi presupponiamo la uniformità della natura, ma non possiamo dimostrarla. Per dimostrare che la natura è
uniforme dovremmo fare degli esempi che concluderebbero con il ribadire che fino ad oggi si sono
comportati così e finiremmo, con ciò, con il creare un circolo. Il sole, domani, potrebbe non sorgere!
L’idea di fondo dell’induttivismo è che la scienza parta da osservazioni, fa delle generalizzazione e predice
gli avvenimenti.
Uno scienziato osserva attentamente una quantità enorme di uccelli e inferisce che:
1) Tutti i corvi sono neri;
2) Tutti i cigni sono bianchi.
Le preposizioni sono, entrambe, il frutto di un attento e duro lavoro, ma solo la prima é vera! La seconda è
stata vera in Europa solo fino al diciottesimo secolo, quando, i primi esploratori dell’Australia, osservarono
cigni neri. Il prossimo corvo osservato potrebbe essere rosso?
Si capisce che le inferenze scientifiche non producono mai verità ma, magari, solo alti gradi di probabilità.
E’ quanto sostiene anche B. Russell dopo le riflessioni sul tacchino induttivista: “la probabilità è tutto ciò che
dobbiamo cercare”. Per quanto riluttanti, per Russell bisogna credere nel principio di induzione come in una
cieca fede.
Popper si scaglia contro l’induzione, ovvero quella linea di pensiero che da Bacone in poi sosteneva di poter
derivare dall’esperienze particolari delle teorie generali ed universalmente valide.
La tradizione induttivista, come aveva già rilevato Hume, non ha alcun valore poiché anche numerose prove
a favore di una teoria non bastano a renderla vera immutabilmente. Non sappiamo se domani il sole sorgerà o
non sorgerà! (Hume)
A tal proposito, in tono brioso quanto arguto, Bertrand Russell spiegava l’impotenza dell’induttivismo con il
racconto del ‘tacchino induttivista’:
Fin dal primo giorno questo tacchino osservò che, nell’allevamento dove era stato portato, gli veniva
servito il cibo alle 9 del mattino. E da buon induttivista non fu precipitoso nel trarre conclusioni dalle
sue osservazioni e eseguì altre in una vasta gamma di circostanze: di mercoledì e di giovedì, nei giorni
caldi e nei giorni freddi, sia che piovesse che splendesse il sole. Così, arricchiva ogni giorno il suo elenco
di una proposizione osservativa in condizioni più disparate. Finché la sua coscienza induttivista fu
soddisfatta ed elaborò un’inferenza induttiva come questa: ‘Mi danno il cibo alle 9 del mattino’.
Purtroppo, però, questa conclusione si rivelò incontestabilmente falsa alla vigilia di Natale, quando,
invece di venir nutrito, fu sgozzato. (in A. F. Chalmers, Che cos’è questa scienza?)
159
Scienza e verità
Il rifiuto dell’induttivismo porta Popper anche al rifiuto dell’osservazionismo cioè di quella concezione che
vuole lo scienziato come un neutrale e asettico osservatore di fatti. Per Popper lo scienziato non è affatto un
osservatore neutro. La nostra mente non è una tabula rasa o contenitore vuoto ma, al contrario, un “faro” che
illumina cioè un fascio di ipotesi, consce o inconsce, con cui vediamo il mondo. Insomma, come aveva detto
anche se in altro contesto Heidegger, “l’uomo non è un occhio puro sul mondo” o se si vuole, Nietzsche:
“non esistono fatti ma interpretazioni”!
Quando ci accingiamo ai fatti essi sono già “impregnati” di teoria. L’osservazione è “carica di teoria” (theoyi
laden)!
La metafora del “faro” che illumina si presta ad un parallelo con Kant e la sua rivoluzione copernicana che
sposta il problema della conoscenza dai fatti al soggetto. Concordemente con Kant Popper ritiene che la
nostra mente impone delle leggi alla natura ma diversamente da Kant che afferma la validità oggettiva,
necessaria e universale di tali leggi, Popper ritiene che le leggi non sono affatto necessariamente valide ma
che, al contrario la natura si mostra assai refrattaria ad accoglierle e più spesso le rigetta. (Congetture e
confutazioni)
Dunque, per Popper la scienza non è epistéme, ma dóxa, opinione, semplice ipotesi di lavoro, congettura.
Le teorie scientifiche sono solo corroborate il che significa momentaneamente non-falsificate. Quelle che
chiamiamo verità scientifiche non hanno nessun fondamento su cui poggiare in maniera stabile e sicura. Al
contrario, il sapere scientifico è strutturalmente problematico e incerto e a nulla vale la domanda se possiamo
giustificare o meno il nostro sapere: essa è priva di senso. All’uomo compete la ricerca non la verità!
Dunque, dal punto di vista filosofico Socrate aveva ragione! Dal punto di vista epistemologico Popper
riprende dunque Socrate.
Il fallibilismo [falsificazionismo] non è altro che il non-sapere socratico. In breve abbiamo: 1) Socrate: io
so di non sapere nulla (e nessuno sa più di questo); 2) Kant: la teoria di Newton è scienza che può
essere giustificata, e perciò sapere certo. (Dunque Socrate vien contraddetto dal fatto dell’esistenza del
sapere scientifico.) […] 3) Einstein: il sapere scientifico riguardante la realtà è incerto. […] Dunque il
fallibilismo di Socrate continua ad esser dalla parte della ragione. (I due problemi fondamentali della teoria
della conoscenza)
Per Popper lo scopo della scienza non è la verità, come sapere assoluto, immutabile, ecc, quanto il
raggiungimento di teorie sempre più verosimili, cioè che “appare più vicina alla realtà”. Se non possiamo
dimostrare che una teoria è definitiva possiamo, tuttavia, dimostrare che una teoria è da preferire ad un’altra,
cioè che rappresenti un progresso verso la verità.
Innanzitutto, tra una teoria scientifica e una non-scientifica è sicuramente da preferire quella scientifica
perchè può essere falsificata, cioè sottoposta al controllo empirico.
Tra teorie entrambe scientifiche è da preferire quella in cui il contenuto di verità, cioè la corrispondenza ai
fatti, è superiore all’altra e il contenuto di falsità è minore.
In effetti lo stesso Popper ammise repentinamente che la rappresentazione della verosimiglianza era errata.
Tuttavia il criterio di scelta tra teorie rimane, per Popper, inscritto nell’ambito di una analisi razionale e,
ovviamente, di una comparabilità delle teorie.
Lo sviluppo della nostra conoscenza è il risultato di un processo strettamente rassomigliante a quello
chiamato da Darwin “selezione naturale”; cioè la selezione naturale delle ipotesi.
160
Il realismo dell’ultimo Popper
L’ultimo Popper prende posizione – in sintonia con Galileo - contro lo strumentalismo ovvero quella
concezione secondo cui le teorie scientifiche non sarebbero che utili strumenti di previsione. Per Popper le
teorie sono anche enunciati descrittivi e non solo strumenti di previsione e di calcolo. In questo senso è
possibile parlare di una ripresa del realismo nella riflessione filosofica di Popper che stronca una possibile
deriva relativistica che pure era immaginabile non avendo fatti ma interpretazioni, non avendo verità ma
ipotesi, congetture.
L’ultimo Popper muove verso l’ipotesi realistica semplicemente perché è l’unica posizione che può
“rammentarci che le nostre idee possono essere errate”. Proprio l’errore ci permette di distinguere nettamente
tra la realtà e la teoria e coglierne la corrispondenza o meno. Ciò significa pure sottolineare una realtà esterna
alla teoria.
Chiamiamo “vera” una asserzione se coincide con i fatti, se corrisponde ai fatti, o se le cose sono tali
quali l’asserzione le presenta. E’ questo il concetto cosiddetto assoluto o obiettivo di verità.
Anche se il realismo nei suoi fondamenti teorici è “non dimostrabile, nè confutabile”, in definitiva nessuno è
stato ancora capace di opporre una teoria migliore. Perché una teoria venga messa da parte occorre che se ne
abbia a disposizione una migliore!
161
Il POST-POSITIVISMO DI KHUN, LAKATOS E FEYERABEND
Il post-positivismo ha tre figure ormai classiche a cui far riferimento e che ben rappresentano la critica al neo
positivismo sia nella versione del Circolo di Vienna sia nella versione del falsificazionismo popperiano.
La critica dei tre filosofi, pur nella loro differenza, si concentra a) nella assoluta convinzione che i fatti non
esistono come realtà obiettiva ma solo nel loro essere all’interno di un sistema, di un quadro teorico; b) non è
possibile alcuna verificazione di una teoria o falsificabilità proprio perché non esistono fatti obiettivi; c) il
sapere scientifico è un sapere che si muove all’interno di una configurazione storico-concreta; d) nella
elaborazione scientifica confluiscono elementi assolutamente extra-scientifici ; e) il Lògos, la Ragione è
ormai solo un mito che va rifiutato come strumento che ci porta alla verità; f) le teorie non hanno nulla a che
vedere con la verità quanto, piuttosto, con il consenso.
Khun: La struttura delle rivoluzioni scientifiche
Secondo Thomas Samuel Kuhn (1922-96) lo sviluppo storico della scienza si snoda attraverso un ‘alternarsi
di periodi “scienza normale” e periodi di “rotture rivoluzionarie”.
Il periodo di scienza normale è caratterizzato da determinati paradigmi, ovvero insiemi complessi e
organizzati di teorie, modelli di ricerca e di sperimentazioni.
Il quadro complessivo di un periodo è caratterizzato non solo da questioni scientifiche in senso specifico, ma
da un complesso di elementi culturali: religiosi, etici, estetici, politici, ecc. che incidono pesantemente su una
determinata teoria favorendola o screditandola.
Lo stesso Kuhn cercherà di chiarire cosa si debba intendere per paradigma nella sua opera più importante, La
struttura delle rivoluzioni scientifiche (1962):
162
Con tale termine voglio indicare conquiste scientifiche universalmente riconosciute, le quali, per un
certo periodo, forniscono un modello di problemi e soluzioni accettabili a coloro che praticano un certo
campo di ricerche. (La struttura delle rivoluzioni scientifiche)
Un paradigma è una conquista scientifica (come la grande teoria geocentrica di Tolomeo o il
copernicanismo, la meccanica di Newton o la teoria evolutiva di Darwin...) che per un certo periodo
costituisce la base della ulteriore ricerca. Ricerca ulteriore consistente in quella che Kuhn chiama “scienza
normale”. La scienza normale è cumulativa; lo scienziato normale non cerca la novità; egli è un risolutore di
“rompicapi”, cioè di problemi emergenti dal paradigma e risolvibili con i mezzi del paradigma stesso.
La scienza normale entra in crisi per effetto di un sommarsi di anomalie che rompono il paradigma esistente
fino a quel momento così si opera una vera rottura rivoluzionaria.
Aumentando il contenuto informativo della teoria, lo scienziato “normale” espone il paradigma alle
“anomalie”, a problemi che resistono agli assalti dei sostenitori del paradigma. I dogmi vengono messi in
dubbio; gli scienziati perdono la fiducia nella teoria finora abbracciata: siamo in piena crisi del paradigma. E’
un periodo, di solito breve, di “ricerca sgangherata”; è la “scienza straordinaria”, dalla quale poi emerge un
nuovo paradigma attorno al quale si articolerà di nuovo la scienza normale, e così all’infinito. Gli scienziati,
che fino ad allora si erano mossi nella conservazione del paradigma che garantiva stabilità, ora si
avventurano per sentieri inesplorati e vedono cose nuove guardando le stesse cose di prima. Il noto diventa
ignoto!
Cambiano completamente i quadri o sistemi concettuali. Cambiano i paradigmi!
Per Khun, d’accordo con Popper, i fatti sono “carichi di teoria”. I fatti non esistono se non all’interno di una
teoria che, dunque, li determina come fatti. Diversamente da Popper, però, Khun è più radicale nella
conseguenza che ciò comporta cioè che non è possibile confrontare, paragonare due diverse teorie. Per
Popper due teorie per quanto diverse, l’astronomia di Tolomeo e quella di Aristotele, sono commensurabili.
Per Khun, invece, esiste una vera e propria incommensurabilità tra teorie perché esiste una
incommensurabilità tra paradigmi.
Su che basi dunque si può accettare un nuovo paradigma?
I singoli scienziati abbracciano un nuovo paradigma per ogni genere di ragione, e di solito per parecchie
ragioni allo stesso tempo. Alcune di queste ragioni […] si trovano completamente al di fuori della sfera
della scienza. Altre possono dipendere da idiosincrasie autobiografiche e personali. Persino la nazionalità
o la precedente reputazione dell’innovatore e dei suoi maestri. (La struttura delle rivoluzioni scientifiche)
La risposta è davvero spiazzante e ci riporta ad una dimensione tutt’altro che razionale. La scelta del
paradigma non è affatto, secondo Khun, una scelta logica e/o sperimentale ma inscritta in una dimensione
storico-sociologico-personale. Giustamente Lakatos dirà che per Khun “la rivoluzione scientifica è
irrazionale, è una questione di psicologia di massa”. Insomma, al di fuori di ciò che siamo abituati a pensare
come scienza.
È per questo che quindi Khun vede il passaggio a un nuovo paradigma non come un avvicinamento
progressivo alla verità, ma una semplice “conversione delle comunità scientifiche”. Insomma conversioni
religiose! E’ chiaro che se i paradigmi non sono commensurabili non è neanche pensabile un progresso della
scienza. Infatti, Khun pensa che la scienza si muova non tanto verso un progressivo avvicinamento alla verità
quanto, semplicemente, ci allontaniamo da stadi primitivi di ricerca nel senso che siamo sempre più bravi
nell’articolare i problemi.
Lakatos: la metodologia dei programmi di ricerca
Imre Lakatos (1922-1974) offre un fitto contronto con Khun e Popper di cui è un ammiratore considerandolo
come l’esponente più importante della filosofia del ventesimo secolo che regge il confronto con Hume e
Kant.
163
Le opere più importanti sono: La falsificazione e la metodologia dei programmi di ricerca scientifici (1970)
e La storia della scienza e le sue ricostruzioni razionali (1971).
Innanzitutto Lakatos, in polemica con Khun, contesta che si possa passare da un paradigma ad un altro come
con una conversione religiosa: un “irrazionale cambiamento di fede”. In questo modo Lakatos mantiene la
sua riflessione in un alveo sicuramente più razionale o razionalista di Khun.
Lakatos spiega il passaggio da un paradigma ad un altro non tanto per il presentarsi di “esperimenti cruciali”
che contraddicono o confutano una teoria quanto per la presenza di una teoria rivale. Con ciò Lakatos è
distante sia da Khun che intende lo sviluppo della scienza come continue ‘conversioni’, sia da Popper
secondo cui si procede per congetture ed errori.
Lakatos ritiene che si proceda attraverso una serie di programmi di ricerca in razionale confronto tra loro.
La storia della scienza confuta sia Popper, sia Khun: a un esame accurato, sia gli esperimenti cruciali di
Popper, sia le rivoluzioni di Khun risultano essere dei miti: ciò che di solito accade è che un programma
di ricerca progressivo ne rimpiazza un altro.
Nello specifico Lakatos definisce un programma di ricerche come un insieme di teorie scientifiche coerenti
tra loro e che obbediscono ad alcune regole metodologiche.
In un programma di ricerca è possibile scorgere un “nucleo” ovvero asserzioni inconfutabili “in virtù di una
decisione metodologica dei suoi sostenitori”, e una “cintura protettiva” ovvero una serie di ipotesi ausiliarie
che hanno la funzione di proteggere il nucleo.
Un programma di ricerca è “progressivo” se continua a “predire fatti nuovi”, altrimenti è “regressivo”
ovvero si limita a dare spiegazioni post hoc.
Dunque, i programmi di ricerca si susseguono non in base a strane conversioni o in base a confutazioni
quanto a decisioni razionali che sostituiscono programmi ormai regressivi.
Feyerabend: Contro il metodo
Contro il metodo (1980) di Paul Feyerabend è il testo ormai classico di una “epistemologia anarchica“ o
“dadaista”, non a caso il sottotitolo recita: Per una conoscenza anarchica del sapere.
l’anarchismo, pur non essendo forse la politica più attraente, è senza dubbio una eccellente medicina
per l’epistemologia e per la filosofia della scienza. (Contro il metodo)
Feyerabend è estremamente radicale nella sua impostazione epistemologica: non esiste la verità, non esiste
un “metodo scientifico” non esiste una “regola”, non esiste un “criterio di eccellenza”.
Gli uomini intelligenti non si lasciano limitare da norme, regole, metodi, neppure da metodi “razionali”,
ma sono degli opportunisti, ossia utilizzano quei mezzi mentali e materiali che, all’interno di una
determinata situazione, si rivelano i più idonei al raggiungimento del proprio fine . (La scienza in una
società libera)
En passant, notiamo, come questa ‘tirata’, faccia pendant con quella vena anarchica individualistica di
Nietzsche. Opportunismo e scienza, ovvero volontà di potenza e mancanza di regole. Insomma, “tutto può
andar bene” (anything goes)!
Secondo Feyerabend, occorre abbandonare la chimera stando alla quale le regole “ingenue e semplicistiche”
proposte dagli epistemologici possano render conto di quel “labirinto di interazioni” offerto dalla storia reale:
164
la storia in generale, la storia delle rivoluzioni in particolare, è sempre più ricca di contenuto, più varia,
più multilaterale, più viva, più astuta, di quanto possano immaginare anche il miglior storico e il miglior
metodologo.
Ne deriva che
l’idea di un metodo che contenga principi fermi, immutabili e assolutamente vincolanti come guida
nell’attività scientifica si imbatte in difficoltà considerevoli quando viene messa a confronto con i
risultati della ricerca storica. (Contro il metodo)
E questo, secondo Feyerabend, appare con tutta chiarezza quando questi principi (per esempio quelli
formulati da Popper) vengono messi a confronto con l’effettiva storia della scienza.
Progressi significativi si sono avuti solo perché le norme metodologiche furono violate consapevolmente o
inconsapevolmente:
Troviamo infatti che non c’è una singola norma, per quanto plausibile e per quanto saldamente radicata
nell’epistemologia, che non sia stata violata in qualche circostanza. Diviene evidente anche che tali
violazioni non sono eventi accidentali, che non sono il risultato di un sapere insufficiente o di
disattenzioni che avrebbero potuto essere evitate. Al contrario, vediamo che tali violazioni sono
necessarie per il progresso scientifico. In effetti, uno fra i caratteri che più colpiscono delle recenti
discussioni sulla storia e la filosofia della scienza è la presa di coscienza del fatto che eventi e sviluppi
come l’invenzione dell’atomismo nell’antichità, la rivoluzione copernicana, l’avvento della teoria
atomica moderna, il graduale emergere della teoria ondulatoria della luce si verificarono solo perché
alcuni pensatori o decisero di non lasciarsi vincolare da certe norme metodologiche ovvie o perché
involontariamente le violarono. (Contro il metodo)
La lotta contro il metodo vuole essere, dunque, una lotta per la libertà di metodo: l’anarchismo metodologico
è la libertà di non aver metodi e di avere una idea e di poterla sconfessare subito dopo per una contingenza
qualsiasi.
Sbaglia, Lakatos a pretendere che delle teorie o dei programmi di ricerca possano essere confrontati: non ci
sono criteri per giudicare una teoria se non pure quelli psicologici, sociologici e culturali.
Per Khun i fatti, come aveva già registrato Popper, non esistono al di fuori della teoria ovvero di un sistema
di “quadri mentali”. Tuttavia in Feyerabend tale assunzione viene portata alle estreme conseguenze
relativistiche e irrazionalistiche diversamente dall’ultimo Popper.
Recuperando Khun contro Popper, Feyerabend ritiene che, non solo le teorie possono essere comparate, ma
neanche i termini più semplici come ad es. il termine massa in Newton e in Einstein.
Se la verità non esiste, se la scienza non ha un criterio in base al quale scegliere una teoria piuttosto che
un’altra in quanto incommensurabili, allora non rimane che un criterio di tipo pragmatico cioè di efficienza
o se si vuole di capacità di persuasione, di momentaneo potere, ecc.
Ora questo criterio impone che quando si valuta le teorie dal punto di vista storico bisogna farlo assumendo
un metro di valutazione interno alla teoria stessa. Ad es., non è possibile smontare la fisica di Aristotele con
la fisica degli ultimi due secoli giacchè si dovrebbe dimostrare che la scienza moderna è migliore di quella
aristotelica.
Feyerabend cerca conferme della sua concezione nel caso Galileo ribaltando l’ormai acclarato giudizio
storico sull’errore della Chiesa.
165
La chiesa all’epoca di Galileo si attenne alla ragione più che lo stesso Galileo, e prese in considerazione
anche le conseguenze etiche e sociali delle dottrina galileiana. La sua sentenza contro Galileo fu
razionale e giusta. (in Corriere della Sera, 25/01/2008)
Una lettura simile era stata avanzata negli anni Trenta da Husserl nella Crisi delle scienza europee tuttavia
Feyerabend autonomamente sostiene, appunto, che la condanna delle dottrine galileiane fu emessa sulla base
non tanto di ragioni teologiche, quanto delle conoscenze diffuse nel contesto scientifico dell’epoca.
Insomma, la Chiesa applicò al caso Galileo una ‘razionalità’ più ampia di quella galileana. Anzi, deve essere
dimostrato che gli standard scientifici sono più sicuri, e soprattutto più utili di quelli religiosi!
Le conclusioni, paradossali, sono perfettamente in linea con la metodologia storiografica di Feyerabend: la
plausibilità di una teoria scientifica dev’essere valutata in relazione all’epoca.
CONCLUSIONI
Il percorso che si è dipanato in questo capitolo, dalla rivoluzione scientifica al post-positivismo, sembra
consegnarci, attraverso la riflessione in atto nella filosofia della scienza, la perdita, l’oblio di qualsiasi
relazione tra scienza e alétheia ovvero con quel concetto, inaudito, da cui tutto era partito e aveva, d’incanto,
aperto nuovi orizzonti e fondato, nientemeno, l’Occidente.
Sicuramente a partire, all’ingrosso, dall’inizio del Novecento la filosofia della scienza, sia sotto la pressione
della crisi dei fondamenti, che con l’avanzare dell’irrazionalismo e del nichilismo ha fatto registrare una vera
parabola del concetto di verità fino ad annichilirlo completamente. La verità decurtata, che la rivoluzione
scientifica aveva di fatto elaborata, finisce per essere anch’essa vaporizzata, sublimata, addirittura, in
probabilità, in consenso. Del concetto di alétheia non rimane più niente!
Ma iniziamo dall’inizio!
La rivoluzione scientifica segna una differenza all’interno del fare filosofico. La filosofia della natura, (la
scienza) si distingue sempre più e prepotentemente dal fare metafisico per imboccare una strada che cerca
ancora la verità assoluta ma con una modalità tutta nuova.
La rivoluzione scientifica è la filosofia che decisamente riperimetra il concetto di verità e lo riduce
doppiamente dal Tutto al particolare e, ancora, il particolare lo riconduce a solo ciò che può essere comune a
tutti: alla quantità. E’ chiaro che questa doppia riduzione ridefinisce il concetto stesso di verità che non ha
più i contorni della pienezza, non ha più le forme parmenidee della perfetta rotondità, ma, pur limitata al solo
aspetto parziale e quantitativo, essa ha comunque le caratteristiche della necessità e universalità.
La Totalità, il Tutto è al di là da venire nell’infinita sommatoria di verità singole e parziali.
La modalità per arrivare a questa verità decurtata è ancora il Lògos ora diversamente modulato con il
cimento, con l’esperimento.
Dal punto di vista propriamente filosofico la rivoluzione scientifica si presenta, dunque, come doppia
riduzione della natura e raddoppio del controllo. Il raddoppio del controllo permetterà di evitare di
involarsi nelle asfittiche aree iperuraniche della metafisica - come più tardi ci suggerirà la colomba di Kant.
Il positivismo non è altro che la rivoluzione scientifica che, ormai matura, è brandita dalla borghesia
storicamente ancora rivoluzionaria che ha, nella grande industria e nella sua capacità egemonica, la sua
immensa forza motrice. La grande industria, che fagocita il globo, nello stridore dei macchinari e nei
pennacchi di fumo onnipresenti, crea il suo inno alla scienza. Questo incedere tumultuoso non può che far
scrivere sulla bandiera: Keine Metaphisik mehr! (Niente più metafisica!).
Il positivismo e il neopositivismo - anche se in maniera più articolata e disincantata, soprattutto con il
Circolo di Vienna e il Circolo di Berlino - rimangono nella scia dell’illuminismo, del razionalismo
166
antimetafisico e, infine, della corrispondenza delle teorie ai fatti: la conoscenza come corrispondenza
adaequatio.
Viceversa il falsificazionismo di Popper e il post-positivismo incarnano in ambito epistemologico
l’irrazionalismo che avanza diremmo da Schopenhauer e che, in Nietzsche trova la sua più larga e cosciente
formulazione con il nichilismo.
La crisi dei fondamenti scientifici che, sostanzialmente, apre il Novecento apre altresì, materialmente, il
problema della verità in ambito filosofico riproponendo criticamente il problema della corrispondenza tra
teoria e fatti: il rapporto tra scienza e verità.
Popper legge la scienza come la dimensione che esclude la verità assoluta; la scienza è costruzione precaria
eretta su palafitte. Le asserzioni-base di una teoria scientifica per Popper sono nient’altro che decisioni dei
ricercatori in un determinato periodo storico. Esplicitamente Popper legge la scienza non come alétheia ma
come dóxa.
Il falsificazionismo di Popper, ma soprattutto il post-positivismo di Khun e Feyerabend arrivano ad una vera
e propria concezione relativistica che fa pendant con il nichilismo nietzschiano ovvero con quella
espressione della borghesia, ormai decadente, che riduce qualsiasi certezza a semplice ipotesi di lavoro.
Khun, ad es., con più vigore irrazionalista legge l’intera vicenda scientifica come un movimento mosso da
semplici conversioni da parte della comunità scientifica.
Feyerabend, poi, porta alle estreme conseguenze una impostazione irrazionalista e sfocia risolutamente in
una posizione relativistica in cui ‘tutto va bene’: siamo alla notte in cui tutte le vacche sono nere!
Feyerabend è, forse, l’esempio classico che dimostra come la filosofia della scienza si nutra di nichilismo. La
sua conoscenza anarchica sembra essere la versione, in ambito epistemologico, della filosofia nichilista di
Nietzsche letto assieme allo Stirner de L’Unico e la sua proprietà.
Insomma, tutta la riflessione da Popper al post-positivismo rileva come, nell’ambito della filosofia della
scienza, vengano ripresi molti argomenti e suggestioni nichilistiche e irrazionali: esistono interpretazioni e
non fatti; la scienza è volontà di potenza; non c’è alcuna verità, ecc.
L’esito del dibattito, soprattutto in ambito post-positivistico, ci porta alla chiara esplicitazione di una visione
irrazionale della scienza dove tutto e provvisorio e, soprattutto, dove tutto è ammesso e non c’è modo di
marcare, definire metodi e risultati più veritieri di altri. Insomma, siamo al relativismo puro e semplice.
In effetti, come abbiamo visto, l’ultimo Popper aveva curvato la sua riflessione filosofica verso il realismo,
ovvero quell’atteggiamento filosofico per cui esiste una realtà fuori di noi e le nostre teorie colgono
effettivamente la realtà. Le teorie per l’ultimo Popper sono descrittive e non semplici convenzioni o
strumenti pragmatici.
Popper fa valere, sostanzialmente, la posizione realista o materialista su due argomenti:
a) è l’unica posizione che può “rammentarci che le nostre idee possono essere errate” proprio perché
“cozzano” contro la realtà. Dunque, proprio quando una teoria è errata io posso dedurre che è
respinta da una realtà esterna alla mia formulazione;
b) pur se non dimostrabile nei suoi fondamenti teorici non esiste una teoria migliore con cui sostituirla.
Dunque, convenzionalismo, strumentalismo, ecc. vengono sconfessati con la riproposizione della ‘vecchia’
adaequatio rei et intellectus che fu già di Aristotele, Tommaso, ecc.
Tralasciando Popper ci compete dire che a favore del realismo c’è ben altro!
Innanzitutto, in sede di filosofia della scienza propriamente, il progresso scientifico, tanto criticato dai postpositivisti a noi sembra indubitabile per tre ordini di ragioni:
1. la storia ci consegna un continuo accrescimento e successo del patrimonio tecnico-sperimentale;
2. la storia confuta singole teorie, ma dall’altro, ci offre teorie sempre più ampie capaci di includere le
precedenti. Apparenti antinomie vengono riassorbite in teorie più ampie e includenti. Dunque,
abbiamo un accrescimento del sapere teorico della scienza;
167
3. la storia ci insegna un continuo consolidamento reciproco che ogni ramo della scienza offre agli altri.
Abbiamo teorie sempre più estese, ampie, includenti, capaci di assorbire le precedenti e ciò conferma nella
verifica i principi. Le tre geometrie (euclidea, iperbolica, ellittica), che sembravano portare sicuramente ad
antinomie, sono state riprese nella più ampia geometria proiettiva. Assistiamo continuamente alla
convergenza di molte discipline su alcuni risultati particolari. Ad es. la teoria della evoluzione viene
confermata autonomamente dalla zoologia, paleontologia, genetica, geologia, ecc. Nella fisica delle
particelle constatiamo una convergenza dei vari metodi di rilevamento utilizzati (emulsioni fotografiche,
camera a bolle, acceleratori, ecc..).
Infine non possiamo sottostimare i successi nelle applicazioni tecnologiche delle scoperte scientifiche.
Questo aumento del patrimonio tecnico-sperimentale e teorico non è cosa da poco rispetto alla presa di
posizione realista. Esso conferma, non tanto che singole teorie non sono rivedibili, ma testimonia una presa
graduale e sicura sulla realtà prima inusitata. Pur prendendo in considerazioni quadri concettuali rivedibili,
correggibili e integrabili, la direzione di marcia sembra essere chiara. Risulta evidente che il procedere
scientifico non è il risultato di una operazione del ricercatore, solipsistico, onanistico, irriducibile al soggetto,
quanto, piuttosto, di un rapporto storico-dialettico tra soggetto e oggetto leggibile, – a nostro avviso - alla
luce di quanto Marx diceva in quella stenografia intellettuale che erano le Tesi su Feuerbach, sicuro
capolavoro di materialismo non metafisico. Basterebbe rileggere il richiamo antimetafisico, appunto, della
tesi n° 1:
Il difetto principale d'ogni materialismo fino ad oggi (compreso quello di Feuerbach) è che l'oggetto
[Gegenstand], la realtà, la sensibilità, vengono concepiti solo sotto la forma dell'obietto [Objekt] o
dell'intuizione; ma non come attività sensibile umana, prassi; non soggettivamente.
Rileggere il quadro generale entro cui va posto il problema della verità (tesi n° 2):
La questione se al pensiero umano spetti una verità oggettiva, non è questione teoretica bensì una
questione pratica. Nella prassi l'uomo deve provare la verità cioè la realtà e il potere, il carattere
immanente del suo pensiero. La disputa sulla realtà o non-realtà del pensiero - isolato dalla prassi - è
una questione meramente scolastica.
BIBLIOGRAFIA
Opere:
Geymonat, Galileo Galilei, Einaudi, 1981
Popper, La logica della scoperta scientifica, Einaudi, 2010
Feyerabend, Contro il metodo, Feltrinelli 2002
Okasha, Il primo libro di filosofia della scienza, Einaudi, 2006
168
ANTOLOGIA
G. W. Friedrich Hegel
LEZIONI SULLA STORIA DELLA FILOSOFIA
Concezioni volgari della storia della filosofia
Occorre anzitutto menzionare e correggere le idee volgari che sogliono correre sulla storia della filosofia.
Intorno a queste vedute molto diffuse, che sono senza dubbio note, miei Signori, anche a voi (giacché in
realtà esse rappresentano le riflessioni immediate, che possono correre alla mente al primo semplice pensare
ad una storia della filosofia), voglio dire brevemente soltanto ciò ch'è strettamente necessario; in seguito
l'esame delle differenze esistenti tra le varie filosofie ci porrà in grado di approfondire il problema.
La storia della filosofia come filastrocca d'opinioni
A prima vista sembra che la storia debba raccontare gli avvenimenti casuali relativi ad età, a popoli, a
individui; casuali, in parte secondo l'ordine cronologico, in parte secondo il contenuto. Della casualità
relativa alla successione cronologica si parlerà in seguito; ora intendiamo occuparci anzitutto della casualità
relativa al contenuto, vale a dire del concetto delle azioni casuali. Sennonché il contenuto della filosofia non
è costituito da azioni esteriori o da eventi dolorosi o lieti, sebbene da pensieri. Orbene, i pensieri casuali non
sono altro che opinioni; e dire opinioni filosofiche vuoi dire opinioni intorno al contenuto preciso e
all'oggetto specifico della filosofia, vale a dire intorno a Dio, alla natura, allo spirito.
C'imbattiamo quindi subito nella veduta assai comune intorno alla storia della filosofia, secondo cui essa non
dovrebbe far altro che ritessere la narrazione delle opinioni filosofiche quali esse si sono presentate e sono,
state esposte nel corso dei tempi. Quando si parla con urbanità, a questo materiale si dà il nome di opinioni;
quelli invece che credono di poter dare un giudizio più profondo, chiamano questa storia addirittura galleria
delle pazzie, o almeno dei traviamenti dell'uomo che si inabissa nel pensiero e nei puri concetti. Tale veduta
la si può udir manifestare non soltanto da coloro che confessano la loro ignoranza in fatto di filosofia (ed essi
la confessano, perché secondo l'opinione comune l'ignoranza non può far loro ostacolo a sentenziare su ciò
che sia filosofia, anzi ognuno è sicuro di poter giudicare del valore e dell'essenza della filosofia senza capirne
un'acca), ma anche da persone che hanno scritto e scrivono storie della filosofia. Una storia, concepita in tal
modo come una filastrocca di opinioni diverse, diventa curiosità oziosa, o, se si vuole, interesse di semplice
erudizione. Infatti l'erudizione consiste principalmente nel sapere una quantità di cose inutili, che non hanno
in sé alcun contenuto e alcun interesse all’infuori di quello costituito appunto dal semplice fatto d'averne
conoscenza.
Tuttavia si crede ugualmente di trarre profitto dalla conoscenza delle varie opinioni e dei vari pensieri degli
altri: si crede ch'essa metta in moto la facoltà del pensare, che susciti anche qualche buona idea, vale a dire
porga l'occasione di formulare opinioni nuove; la Scienza consisterebbe così nel continuare a filare opinioni
su opinioni.
Se la storia della filosofia fosse soltanto una galleria d'opinioni - sia pure relative a Dio e all'essenza delle
cose naturali e spirituali – essa sarebbe una scienza superfluissima e noiosissima, per quante utilità si
169
potessero mai addurre che si ricaverebbero da siffatto movimento di pensieri e d'erudizione. Che vi può esser
di più inutile che l'imparare una serie di semplici opinioni? Che cosa di più indifferente? Basta dare
un'occhiata alle opere che espongono la storia della filosofia come semplice serie di opinioni, per veder
subito quanto siano aride e senza, interesse.
Un'opinione è una rappresentazione soggettiva, un pensiero casuale, un'immaginazione, che io mi formo in
questa o quella maniera, e altri può avere in modo diverso: l'opinione è un pensiero mio, non già un pensiero
in sé universale, che sia in sé e per sé. Ma la filosofia non contiene opinioni, giacché non si danno opinioni
filosofiche. Chi parla di opinioni filosofiche, anche se ha scritto storie della filosofia, rivela subito la
mancanza dei primi fondamenti. La filosofia è scienza oggettiva della verità, scienza della necessità della
verità, conoscenza concettuale, e non già opinare e filza di opinioni.
L'ulteriore significato proprio di cotesto modo di vedere è che abbiamo conoscenza soltanto di opinioni: e si
insiste sul fatto che si tratta solo di opinioni. Ora ciò che si contrappone all'opinione, è la verità; e di fronte
alla verità, l'opinione deve cedere. Sennonché è appunto la parola verità quella da cui distoglie lo sguardo chi
nella storia della filosofia cerca soltanto, o crede si possano trovare soltanto opinioni. In questo caso la
filosofia deve combattere con un duplice avversario. Da un lato, è noto, la pietà religiosa ha proclamato non
esser la ragione o il pensiero in grado di conoscere il vero, la ragione condurre soltanto all'abisso del dubbio,
doversi rinunziare al pensare autonomo e, per giungere alla verità, costituirsi prigionieri della cieca fede
nell'autorità. Parleremo in seguito del rapporto che la religione ha con la filosofia e con la storia di essa.
D'altra parte è altrettanto noto che la cosiddetta ragione si è fatta valere, ha respinto la fede nell'autorità, e ha
voluto rendere razionale il Cristianesimo, sicché in sostanza soltanto il mio intuito, la mia convinzione
personale mi obbligherebbero a riconoscere qualche cosa. Ma è meraviglioso come questa tesi sul diritto
della ragione sia stata poi capovolta e in modo da risultarne che la ragione stessa non possa riconoscere nulla
di vero. Questa cosiddetta ragione da un lato combatté la fede religiosa in nome e con la forza del pensiero
razionale, e contemporaneamente si volse contro la ragione e diventò nemica della vera ragione. Contro
quest'ultima essa afferma l'ispirazione interna, il sentimento; e così pone come norma del valore l'elemento
soggettivo, vale a dire la propria convinzione, come ciascuno se la forma in se stesso e nella propria
soggettività. Senonchè siffatta convinzione non è altro per l'appunto che l'opinione, la quale così è diventata
ultima ratio dell'uomo.
Volendo prender le mosse dai modi di vedere che si presentano più spontanei e immediati, non possiamo far
a meno, nella storia della filosofia, di ricordare in primo luogo quello testé accennato. Esso è infatti un
risultato, che ha compenetrato la cultura generale, e costituisce per dir così la tesi pregiudiziale, il vero
contrassegno dell'età nostra, il principio in cui ci s'intende e ci si riconosce reciprocamente, la premessa che
si considera pacifica, e che si mette a fondamento d'ogni attività scientifica. Così, per esempio, in teologia
non si ritiene come dottrina del Cristianesimo la professione di fede della Chiesa, sebbene ciascuno si foggia
più o meno una speciale dottrina cristiana secondo la propria convinzione. Oppure vediamo spesso la
teologia indirizzata in senso storico, e assegnato alla scienza teologica il compito di imparare a conoscere le
varie opinioni. Uno dei primi frutti di tale informazione dovrebbe esser l'ossequio verso tutte le opinioni, da
considerarsi come cosa che ciascuno deve regolare da sé. In tal modo si rinunzia allo scopo di conoscere la
verità. È vero che la propria convinzione costituisce il fondamento ultimo e assolutamente essenziale, che
stimola alla conoscenza la ragione e la sua filosofia, dal punto di vista soggettivo; ma vi è differenza fra la
convinzione che s'appoggia su sentimenti, presentimenti, intuizioni ecc., vale a dire su moventi soggettivi, in
genere sulla peculiarità del soggetto, e quella che si basa sul pensiero, che la trae dall'approfondimento del
concetto e della natura delle cose. La prima forma di convinzione non è altro che opinione.
Questa antitesi tra opinione e verità, oggi così acuta e manifesta, la ritroviamo già nella cultura dell'età
socratico-platonica, vale a dire in un'età di corruzione della vita greca, sotto forma della contrapposizione
platonica di opinione (dóxa) a scienza (epistéme). È lo stesso contrasto che scorgiamo nel declinare della vita
pubblica e politica di Roma sotto Augusto e successori, quando l'epicureismo e l'indifferentismo si fecero
strada contro la filosofia. Proprio in questo senso Pilato, allorché Cristo disse “io sono venuto al mondo per
annunziare la verità”, gli replicò “che cosa è verità?”. È una risposta eloquente, che significa su per giù
questo: “Il concetto di verità è una cosa morta, con cui noi l'abbiamo fatta finita; noi siamo andati avanti, e
sappiamo che non si può dire di conoscer la verità; abbiamo superato questa ingenuità”. Chi parla così, è
realmente al di sopra e al di fuori della verità. Se nella storia della filosofia si prendono le mosse da questo
modo di vedere, tutta l'importanza di questa disciplina si riduce a far conoscere soltanto le opinioni
particolari, di cui ciascuno ha la sua, diversa da quella degli altri. Queste peculiarità individuali sono dunque
170
per me qualche cosa d'estraneo, nelle quali la mia ragione pensante non è libera, non è presente,
rappresentano unicamente per me una materia esteriore, morta, storica, una massa in se stessa priva di
contenuto; e appagarsi così di cose vane è vanità soggettiva.
Per l'uomo libero da preconcetti la verità resterà sempre una grande parola, che gli farà sempre battere il
cuore. Quanto all'affermazione, secondo cui la verità non potrebbe conoscersi, essa si presenta esplicitamente
nella storia della filosofia, e la esamineremo più dappresso a suo tempo. Qui osserveremo soltanto che se si
dà valore a siffatto presupposto, come fa per esempio il Tennemann, non si capisce più a che approdi
l'occuparsi di filosofia, giacché in tal caso ogni opinione sarebbe nel falso, quando, crede di possedere la
verità. Provvisoriamente io mi richiamo all'antica convinzione secondo cui nel sapere risiede bensì la verità,
ma la si può conoscere soltanto in quanto si mediti, e non già in quanto si cammini e si stia fermi; la verità
non si riconosce già nella percezione e nell'intuizione immediata, sia esteriore e sensibile, sia intellettuale
(giacché ogni intuizione come tale è sensibile), sebbene soltanto mediante il travaglio del pensiero.
Dimostrazione dell'inanità della conoscenza filosofica tratta dalla storia stessa
della filosofia
Con la predetta concezione della storia della filosofia si collega un'altra conseguenza, che si può considerare
a piacere come un bene o come un male. Infatti davanti a tante e così svariate opinioni, a tanti e così svariati
sistemi filosofici, si perde la bussola e non si sa più a quale ci si debba attenere. Si constata che a proposito
degli oggetti più importanti, verso i quali l'uomo si sente attratto, e che la filosofia dovrebbe far conoscere, i
più grandi genii hanno errato, posto che sono stati confutati da altri. “E se questo è capitato a genii così
grandi, come posso ego homuncio pretendere di decidere?”. Si ritiene che siffatta conseguenza tratta dalla
varietà dei sistemi filosofici, sia bensì un male per ciò che riguarda l'oggetto stesso, ma anche un bene
soggettivamente parlando. Infatti questa diversità di sistemi è il solito pretesto che tutti coloro, i quali con
aria di competenti vogliono dare ad intendere d'interessarsi di filosofia, accampano per potere, pur
affermando la loro buona volontà, anzi magari la necessità d'affaticarsi intorno, a questa scienza, in realtà
lavarsene le mani. Senonchè questa diversità dei sistemi filosofici non serve soltanto, come si è detto, di
pretesto; essa viene anzi fatta passare come argomento poderoso e verace contro la serietà delle
investigazioni filosofiche, come giustificazione del nessun interesse per la filosofia, come istanza irrefutabile
contro la vanità del tentativo di voler raggiungere la conoscenza filosofica della verità. E se anche si ammette
che la filosofia sia una scienza reale, e che tra le filosofie ve ne debba pur essere una vera, sorge la domanda:
ma quale è? e come riconoscerla? Ognuna assicura d'esser la vera; ognuna offre i suoi particolari segni e
criteri da cui riconoscere la verità; e quindi il pensiero cauto e giudizioso deve avere ritegno a pronunziarsi.
Questo per alcuni è il più importante risultato che si possa ricavare dalla storia della filosofia. In questo senso
Cicerone (De natura Deorum I, 8 sgg.) ha compilato una storia molto zoppicante del pensiero filosofico su
Dio. Egli la mette bensì in bocca ad un Epicureo, ma non sa dire nient'altro di meglio su quest'argomento:
dunque questo è il suo modo di vedere. L'Epicureo dice che non si è riusciti a formulare alcun concetto
preciso; e immediatamente dal quadro generale e superficiale della storia della filosofia trae la prova che gli
sforzi di quest'ultima sono vani: infatti il processo di questa storia appare come un continuo sorgere dei più
svariati pensieri filosofici, che si contrappongono, si contraddicono e si confutano I'un l'altro. Questo fatto,
d'altronde innegabile, sembra autorizzarci, anzi obbligarci ad applicare anche alle filosofie le parole di
Cristo: “Lascia che i morti seppelliscano i loro morti e seguimi”. Sicché la storia della filosofia nel suo
complesso sarebbe un campo di battaglia coperto soltanto dall'ossame dei cadaveri, un regno non soltanto
d'individui defunti, corporalmente trapassati, ma anche di sistemi confutati, idealmente defunti, ciascuno dei
quali ha ucciso e sepolto l'altro. E’ vero tuttavia che in questo senso, anziché “seguimi” dovrebbe dirsi
piuttosto “segui te stesso”; vale a dire, attieniti alla tua propria convinzione, fermati alla tua opinione. Perché
mai infatti seguire gli altri?
Accade certamente che una nuova filosofia al suo apparire sostenga che le altre non hanno alcun valore; anzi
ogni filosofia pretende non solo di confutare tutte le precedenti, ma anche di colmare le loro lacune e d'aver
trovato finalmente la giusta soluzione. Senonchè l'esperienza del passato dimostra che a siffatte filosofie
possono applicarsi altre parole dei Vangelo, vale a dire quelle dette dall'apostolo Pietro ad Anania: “Ecco
171
all'uscio i piedi di coloro che ti porteranno via”. Vedi, la filosofia che confuterà ed eliminerà la tua, non
tarderà a sopravvenire, come non ha mancato di sopraggiungere alle altre.
Schiarimenti sulla diversità delle filosofie
Senza dubbio è un fatto abbastanza provato che vi sono state e vi sono diverse filosofie; ma l'istinto della
ragione ha l'invincibile sentimento, o la fede, che la verità è una sola. “Vi deve essere dunque una sola
filosofia vera, e poiché le filosofie sono così diverse, tutte le altre – si conclude – debbono essere erronee;
senonchè ognuna di esse assicura, prova, dimostra esser essa la vera”. Questo è il ragionamento usuale, ed è
un giudizio apparentemente esatto del pensiero così detto sobrio, del buon senso. Orbene, quanto a questa
sobrietà del pensiero, sappiamo dall'esperienza quotidiana che la sobrietà è accompagnata o immediatamente
seguita dalla fame: invece quel tale pensiero sobrio ha il talento e l'arte di condurre, non alla fame e alla
brama, sebbene ad essere e a rimaner sazio in se stesso. In tal modo questo pensiero si smaschera, rivelandosi
soltanto morto intelletto; giacché soltanto ciò ch'è morto può a un tempo essere e rimanere digiuno e sazio.
Invece la vitalità spirituale, al pari della vitalità fisica, non resta soddisfatta della sobrietà, ma sente lo
stimolo di procedere attraverso la fame e la sete verso la verità, verso la conoscenza della verità, anela al
soddisfacimento di questo stimolo, e non si lascia pascere né satollare da riflessioni analoghe a quella
accennata.
Alla riflessione suddetta si può subito obiettare che, per quanto diverse siano le filosofie, tuttavia esse hanno
questo di comune, d'essere appunto filosofie. E quindi chi ha studiato e conosciuto una filosofia qualsiasi,
sebbene questa sia soltanto una filosofia, possiede la filosofia. E quel pretesto, quel ragionamento che
s'aggrappa alla pura diversità, e per disgusto od esitazione di fronte al particolare, in cui è contenuto
realmente l'universale, rifiuta di capire o riconoscere questa universalità, è stato paragonato da me altrove ad
un ammalato, cui il medico abbia consigliato di mangiar frutta, e che vedendosi presentate ciliege o prugne o
uva, per pedanteria dell'intelletto non ne assaggia, non essendo esse “frutta”, ma ciliege, prugne o uva.
È necessario farsi un concetto più profondo di che cosa sia veramente questa famosa diversità dei sistemi
filosofici. Quando si riconosca filosoficamente che cosa è la verità e la filosofia, siffatta diversità come tale
appare di significato ben diverso da quello implicito nell'opposizione astratta di verità ed errore. I chiarimenti
che darò a questo riguardo ci schiuderanno il significato dell'intera storia della filosofia. Mi propongo infatti
di dimostrare come la varietà delle molte filosofie non soltanto non rechi alcun pregiudizio alla filosofia
medesima, alla possibilità della filosofia, ma anzi sia e sia stata assolutamente necessaria perché possa
esistere la scienza della filosofia; essa le è essenziale.
Certamente in quest'investigazione noi presupponiamo che la filosofia abbia lo scopo, pensando la verità,
d’intenderla concettualmente, e non già di riconoscere che non v'è niente da conoscere, o almeno che non si
può riconoscere la verità vera, sebbene soltanto una verità temporanea, finita (cioè una verità, che nel tempo
stesso è anche una non verità); presupponiamo, inoltre, che nella storia della filosofia abbiamo che fare con
la filosofia. I fatti che ricorrono nella storia della filosofia non sono avventure, allo stesso modo che la storia
universale non è un romanzo; essi non sono una collezione d'eventi accidentali, non sono peregrinazioni di
cavalieri erranti, che vadano attorno per proprio conto, affaticandosi senza scopo, e scomparendo poi senza
lasciare alcuna traccia della loro azione. Né è vero che in questo campo uno si sia ad arbitrio immaginato una
cosa, un altro un'altra; ché anzi nel movimento dello spirito pensante vi è continuità essenziale, e si procede
razionalmente. Con questa fede nello spirito del mondo dobbiamo accostarci alla storia e particolarmente alla
storia della filosofia.
172
G. W. Friedrich Hegel
SCIENZA DELLA LOGICA
DETERMINATEZZA
L'essere è l'Immediato indeterminato. Esso è scevro della determinatezza rispetto all'essenza, com'è ancora
scevro da ogni altra determinatezza che possa conseguire dentro se stesso. Questo essere irriflesso è l'essere
com'è immediatamente soltanto in lui stesso.
Essendo indeterminato, è un essere privo di qualità; ma in sé il carattere dell'indeterminatezza non gli compete che per contrapposto al determinato, ossia al qualitativo. Ora all'esser in generale viene a contrapporsi
l'essere determinato come tale, ma con questo è la sua indeterminatezza stessa, quella che costituisce la sua
qualità. Si mostrerà quindi che il primo essere è un essere in sé determinato, e che per ciò in secondo luogo,
passa nell'esser determinato, è esser determinato; ma che questo, come essere finito, si toglie, e nell'infinito
riferirsi dell'essere a se stesso, passa, in terzo luogo, nell'esser per sé.
A. ESSERE
Essere, puro essere, – senza nessun'altra determinazione. Nella sua indeterminata immediatezza esso è simile
soltanto a se stesso, ed anche non dissimile di fronte ad altro; non ha alcuna diversità né dentro di sé, né
all'esterno. Con qualche determinazione o contenuto, che fosse diverso in lui, o per cui esso fosse posto come
diverso da un altro, l'essere non sarebbe fissato nella sua purezza. Esso è la pura indeterminatezza e il puro
vuoto. – Nell'essere non v'è nulla da intuire, se qui si può parlar d'intuire, ovvero esso è questo puro, vuoto
intuire stesso. Così non vi è nemmeno qualcosa da pensare, ovvero l'essere non è, anche qui, che questo
vuoto pensare. L'essere, l'indeterminato Immediato, nel fatto è nulla, né più né meno che nulla.
B. NULLA
Nulla, il puro nulla. È semplice somiglianza con sé, completa vuotezza, assenza di determinazione e di
contenuto; indistinzione in se stesso. – Per quanto si può qui parlare di un intuire o di un pensare, si
considera come differente, che s'intuisca o si pensi qualcosa oppur nulla. Intuire o pensar nulla, ha dunque un
significato. I due si distinguono; dunque il nulla è (esiste) nel nostro intuire o pensare, o piuttosto è lo stesso
vuoto intuire e pensare, quel medesimo vuoto intuire e pensare ch'era il puro essere. Il nulla è così la stessa
determinazione o meglio assenza di determinazione, epperò in generale lo stesso, che il puro essere.
C. DIVENIRE
Unità di essere e nulla
Il puro essere e il puro nulla sono dunque lo stesso. Il vero non è né l'essere né il nulla, ma che l'essere, –
non passa, – ma è passato, nel nulla, e il nulla nell'essere. In pari tempo però il vero non è la loro
indifferenza, la loro indistinzione, ma è anzi ch'essi non sono lo stesso, ch'essi sono assolutamente diversi,
ma insieme anche inseparati e inseparabili, e che immediatamente ciascuno di essi sparisce nel suo opposto.
La verità dell'essere e del nulla è pertanto questo movimento consistente nell'immediato sparire dell'uno di
essi nell'altro: il divenire; movimento in cui l'essere e il nulla sono differenti, ma di una differenza, che si è in
pari tempo immediatamente risoluta.
173
Nota
Il nulla si suole contrapporre al qualcosa. Ma qualcosa è già un ente determinato, che si distingue da un altro
qualcosa, e così anche il nulla contrapposto al qualcosa è il nulla di un certo qualcosa, un nulla determinato.
Qui però il nulla è da intendere nella sua indeterminata semplicità. – Quando si volesse riguardar come più
esatto di contrapporre all'essere il non essere, invece che il nulla, non vi sarebbe niente da dire in contrario,
quanto al risultato, poiché nel non essere è contenuto il riferimento all'essere; il non essere è tutti e due,
l'essere e la sua negazione, espressi in uno, il nulla, com'è nel divenire. Ma da principio non si tratta della
forma dell'opposizione, cioè in pari tempo del riferimento; si tratta soltanto della negazione astratta,
immediata, del nulla preso puramente per sé, della negazione irrelativa, – ciò che, volendo, si potrebbe anche
esprimere per mezzo del semplice: Non.
Furono gli Eleati i primi ad enunciare il semplice pensiero del puro essere, soprattutto Parmenide, che lo
enunciò come l'Assoluto e come l'unica verità, e ciò, nei frammenti di lui rimastici, col puro entusiasmo del
pensiero, che per la prima volta si afferra nella sua assoluta astrazione: soltanto l'essere è, e il nulla non è
punto. –Nei sistemi orientali, essenzialmente nel Buddismo, il principio assoluto è, com'è noto, il nulla, il
vuoto. – Contro cotesta semplice ed unilaterale astrazione il profondo Eraclito mise in rilievo il più alto
concetto totale del divenire, e disse: L'essere è tanto poco, quanto il nulla, o anche: Tutto scorre, cioè tutto è
divenire. –Le sentenze popolari, specialmente orientali, che tutto quel che è abbia nella sua nascita stessa il
germe del suo perire, e che viceversa la morte sia l'ingresso in una nuova vita, esprimono in sostanza cotesta
medesima unione dell'essere col nulla. Ma queste espressioni hanno un substrato, in cui avviene il passaggio;
l'essere e il nulla vengono tenuti separati uno dall'altro nel tempo, vengono immaginati come avvicendantisi
in esso, non già pensati nella loro astrazione, epperciò nemmeno pensati come tali che siano in sé e per sé lo
stesso.
Ex nihilo nihil fit – è una delle proposizioni a cui in metafisica venne attribuita una grande importanza. Ma o
in questa proposizione non v'è da veder altro che la vana tautologia che nulla è nulla, oppure, se il divenire vi
deve avere un significato reale, non vi è anzi in essa alcun effettivo divenire, giacché in quanto per quella
proposizione da nulla viene soltanto nulla, il nulla vi rimane nulla. Il divenire importa che il nulla non resti
nulla, ma passi nel suo altro, nell'essere. – Quando la metafisica posteriore, soprattutto la cristiana, rigettò la
proposizione che dal nulla venisse nulla, essa affermò un passaggio dal nulla nell'essere. Per quanto, ora,
questa proposizione fosse da lei presa sinteticamente o in guisa semplicemente rappresentativa, pur
nondimeno anche nella più imperfetta unione è contenuto un punto in cui l'essere e il nulla coincidono, e la
differenza loro sparisce. – La vera e propria importanza della proposizione: Dal nulla non viene nulla, il nulla
è appunto nulla, sta nell'opposizione sua contro il divenire in generale e con ciò anche contro la creazione del
mondo dal nulla. Coloro, che vanno fino a riscaldarsi per affermar la proposizione che il nulla è appunto
nulla, non si accorgono che con ciò aderiscono all'astratto panteismo degli Eleati, e, sostanzialmente, anche a
quello spinozistico. La veduta filosofica, per cui vale come un principio che l'essere è soltanto essere e il
nulla soltanto nulla, merita il nome di sistema dell'identità. Questa identità astratta è l'essenza del panteismo.
Se questo resultato, che l'essere e il nulla sono lo stesso, riesce di per sé sorprendente o sembra un paradosso,
non v'è da farne gran caso. Vi sarebbe piuttosto da meravigliarsi di quella meraviglia, che si mostra così
nuova nella filosofia, dimenticando che in questa scienza si presentano determinazioni affatto diverse che
non nella coscienza ordinaria e nel cosiddetto senso comune, il quale non è precisamente il buon senso, ma
anche l'intelletto rivolto alle astrazioni e alla fede (o meglio, alla superstizione) verso di esse. Non sarebbe
difficile di mostrar questa unità dell'essere col nulla in ogni esempio, in ogni realtà o pensiero. Dell'essere e
del nulla è il caso di dir lo stesso che dianzi fu detto dell'immediatezza e della mediazione (la quale ultima
importa il riferirsi di uno a un altro, epperò una negazione), che cioè in nessun luogo, né in cielo né in terra
v'è qualcosa che non contenga in sé tanto l'essere quanto il nulla. Senza dubbio, in quanto qui si parla di un
certo qualcosa e di un certo reale, quelle determinazioni non si trovan più nella lor completa non verità, in
cui stanno come essere e come nulla, ma vi si trovano in una determinazione ulteriore, e intese p. es. come
positivo e negativo, diventano, quello, il posto, riflesso essere, questo il posto, riflesso nulla; ma il positivo e
il negativo contengono, il primo l'essere, il secondo il nulla, come loro base astratta. – Così perfino in Dio la
qualità, cioè l'attività, la creazione, la potenza etc., contiene essenzialmente la determinazione del negativo;
coteste qualità consistono nella produzione di un altro. Ma una spiegazione empirica di quell'affermazione,
174
per mezzo di esempi, sarebbe qui intieramente superflua. Poiché questa unità di essere e nulla sta ormai una
volta per sempre per base qual verità prima, costituendo l'elemento di tutto quel che segue, tutte le ulteriori
determinazioni logiche (senza contare il divenire stesso), l'esser determinato, la qualità, e in generale tutti i
concetti della filosofia, sono esempi di essa unità. -- È invece il sedicente senso comune o buon senso, quello
che, giacché rigetta l'inseparabilità dell'essere e del nulla, potrebb'essere invitato a scoprire un esempio in cui
si trovino separati (separato p. es. qualcosa dal suo termine o limite, oppure l'infinito, Dio – come dianzi fu
detto – dall'attività). Soltanto quei vuoti « enti di ragione » stessi, l'essere e il nulla, sono questi separati, e
sono appunto essi, che quel senso comune o buon senso preferisce alla verità, all'inseparabilità loro, che per
ogni dove ci è innanzi.
Non si può avere in mente di ovviar da ogni parte alle confusioni, in cui s'imbatte la coscienza ordinaria a
proposito di cotesta proposizione logica. Sono infatti inesauribili. Se ne posson solo menzionare alcune. Una
delle ragioni di tal confusione, fra le altre, è che la coscienza porta seco, nella considerazione di
cotest'astratta proposizione logica, le rappresentazioni (li un qualcosa concreto, dimenticando che non si
parla di un tal qualcosa, ma unicamente delle pure astrazioni dell'essere e del nulla, e che queste sole bisogna
fissare.
Essere e non essere sono lo stesso; dunque è lo stesso che io sia o non sia, che questa casa sia e non sia, che
questi cento talleri siano, o non siano, nel mio patrimonio. Questa conclusione o applicazione di quella
proposizione ne cambia completamente il senso. La proposizione contiene le pure astrazioni dell'essere e del
nulla; l'applicazione invece ne fa un determinato essere e un determinato nulla. Ma, come si è detto, qui non
si parla di un essere determinato. Un essere determinato, finito, è un essere che si riferisce ad altro; è un
contenuto che sta in un rapporto di necessità con un altro contenuto, col mondo intiero. Riguardo alla
reciproca dipendenza dell'insieme la metafisica poté giungere alla affermazione (sostanzialmente
tautologica) che se venisse distrutto un granello di polvere, rovinerebbe l'intiero universo. Se nelle istanze,
che vengono fatte contro la proposizione in questione, qualcosa non si mostra indifferente, quanto al suo
essere o non essere, ciò non è già a cagione dell'essere o non essere, ma a cagione del contenuto di cotesto
qualcosa, per cui viene a connettersi con un altro qualcosa. Quando si presuppone un contenuto determinato,
un qualche determinato esistere, questo esistere, essendo determinato, sta in una molteplice relazione verso
un altro contenuto. Per quell'esistere non è allora indifferente che un certo altro contenuto, con cui sta in
relazione, sia o non sia, perocché solo per via di tal relazione esso è essenzialmente quello che è. Lo stesso
accade nel rappresentarsi (in quanto prendiamo il non essere nel senso più determinato del rappresentarsi
come opposto della realtà). Nel contesto delle rappresentazioni, l'essere o l'assenza di un contenuto, che
viene immaginato come tale che stia in una determinata relazione verso altro, non è indifferente.
Questa considerazione contiene quello stesso, che è un momento capitale nella critica kantiana della prova
ontologica dell'esistenza di Dio, critica a cui però qui non si guarda se non per ciò che si riferisce alla differenza, che vi si presenta, fra l'essere e il nulla in generale, e l'essere o il non essere determinati. E noto che in
quella cosiddetta prova si presupponeva il concetto di un'essenza cui convenissero tutte le realtà, epperò
anche l'esistenza, che veniva parimenti ammessa come una delle realtà. La critica kantiana si attaccava
principalmente a questo, che l'esistenza o l'essere (che qui si prendono per equivalenti) non sia affatto una
proprietà o un predicato reale, non sia cioè un concetto di qualcosa, che possa aggiungersi al concetto di una
cosa. Con questo Kant vuol dire che l'essere non è una determinazione di contenuto. Dunque il reale,
continua Kant, non contiene più che il possibile; cento talleri reali non contengono nulla più che cento
possibili; vale a dire che quelli non hanno nessuna determinazione di contenuto in più di questi. Per un simile
contenuto considerato isolatamente è infatti indifferente di essere o non essere. In esso non sta alcuna
differenza dell'essere o del non essere; questa differenza non tocca punto, in generale, quel contenuto. I cento
talleri non diventano meno, quando non siano, e non diventano più, quando siano. La differenza non può
venire che da un'altra parte. «All'incontro, rammenta Kant, nel mio patrimonio v'è più con cento talleri reali,
che col loro semplice concetto, o colla loro possibilità. Perocché, trattandosi della realtà, l'oggetto non è
soltanto contenuto analiticamente nel mio concetto, ma si aggiunge sinteticamente al mio concetto (che è una
determinazione del mio stato), senza che per questo essere fuor del mio concetto, questi stessi cento talleri
pensati si trovino minimamente aumentati.»
Si presuppongono qui due sorta di stati (per non scostarci dalle espressioni kantiane, che non sono senza una
certa imbrogliata goffaggine); l'uno, quello che Kant chiama il concetto, per cui è da intendere la rappresentazione, e l'altro, lo stato patrimoniale. Per l'uno come per l'altro, per il patrimonio come per la rappresentazione, cento talleri sono una determinazione di contenuto, ossia, come si esprime Kant, « vi si aggiungono
175
sinteticamente ». Io come possessore di cento talleri, o come non possessore di essi, oppure anche io in
quanto mi rappresento cento talleri, o in quanto non me li rappresento, sono senza dubbio un contenuto
diverso. Prendendo la cosa più generalmente: le astrazioni dell'essere e del nulla cessano tutte e due di essere
astrazioni, in quanto acquistano un contenuto determinato; l'essere è allora realtà, il determinato essere di
cento talleri, e il nulla è negazione, il determinato non essere di cotesti talleri. Questa determinazione di
contenuto stessa, i cento talleri, presa astrattamente per sé, è invariatamente nell'uno quel medesimo che è
nell'altro. Ma in quanto l'essere si prende poi come uno stato patrimoniale, i cento talleri vengono a trovarsi
in relazione con uno stato, e per questo stato una determinatezza tale, qual essi sono, non è indifferente. Il
loro essere o non essere non è che mutamento; essi sono stati trasportati nella sfera dell'esser determinato.
Quando pertanto contro l'unità dell'essere e del nulla si adduce che non è pur nondimeno indifferente, che
questo o quello (i cento talleri) sia o non sia, è un'illusione che questa differenza, che io abbia i cento talleri o
non li abbia, noi la rimandiamo sèmplicemente all'essere e non essere – una illusione, la quale, come si è
mostrato, è basata sulla unilaterale astrazione che tralascia il determinato esserci, presente in tali esempi, e si
attiene semplicemente all'essere e non essere, come viceversa cambia quell'astratto essere e nulla, che si
tratta d'intendere, in un essere e nulla determinato, ossia in un esserci. Soltanto l'esserci contiene la
differenza reale dell'essere e del non essere, vale a dire un qualcosa e un altro. È questa differenza reale che
sta dinanzi alla rappresentazione, e non già l'astratto essere e il puro nulla, colla loro differenza
semplicemente presunta.
Come Kant si esprime, « per mezzo dell'esistenza » entra « qualcosa nel contesto dell'intiera esperienza », «
la nostra percezione acquista con ciò un oggetto di più, ma il nostro concetto dell'oggetto non è con ciò
accresciuto ». Ciò vuol dire, come risulta dalle spiegazioni date, che per mezzo dell'esistenza, essenzialmente
per ciò che qualcosa è una esistenza determinata, esso si trova connesso con altro, e fra l'altro anche con un
percipiente. – Il concetto dei cento talleri, dice Kant, non viene accresciuto per il fatto che siano percepiti.
Concetto significa qui i già accennati cento talleri quali oggetto di rappresentazione isolata. Ora isolati a
questo modo, i cento talleri son certo un contenuto empirico, ma tagliato fuori, senza connessione e senza
determinatezza contro altro; la forma dell'identità con sé toglie loro la relazione ad altro, e li rende
indifferenti ad esser percepiti, o no. Se non che questo cosiddetto concetto dei cento talleri è un falso
concetto. La forma della semplice relazione a sé non appartiene essa stessa a un tal contenuto limitato, finito,
ma è una forma di cui esso è rivestito e che gli viene prestata dall'intelletto soggettivo. Cento talleri non sono
nulla che si riferisca a sé, ma sono un mutevole e un transitorio.
Il pensiero o la rappresentazione, cui non sta innanzi altro che un essere determinato, l'esserci o l'esistere, è
da rimandare al già menzionato cominciamento della scienza, compiuto da Parmenide, il quale chiarificò ed
elevò il suo rappresentarsi (epperò anche il rappresentarsi di tutti i tempi che vennero poi) fino al puro
pensiero, all'essere come tale, col che creò l'elemento della scienza. Quello che è il primo nella scienza, si
dovette mostrare storicamente come il primo. E come primo del sapere del pensiero dobbiamo noi riguardare
l'uno o l'essere eleatici. L'acqua ed altri simili principii materiali debbono bensì esser l'universale, ma,
essendo materia, non sono puri pensieri. I numeri non sono né il primo semplice pensiero, né il pensiero che
resta presso di sé, ma anzi il pensiero che è affatto esterno a se stesso.
Il rinvio dall'essere particolare finito all'essere come tale nella sua universalità affatto astratta è da riguardare
non solo come la prima esigenza teoretica, ma anche come la prima esigenza pratica. Quando cioè si tolga, a
proposito dei cento talleri, che faccia una differenza nel mio patrimonio di averli o non averli, anzi perfino
che io sia o non sia, che qualcos'altro sia o no, allora (senza contare che vi saranno patrimonii, per cui un tal
possesso di cento talleri sarà indifferente) si può rammentare, che l'uomo si deve innalzare nell'animo suo a
quest'astratta universalità, nella quale non solo gli sia di fatto indifferente che i cento talleri (qualunque
rapporto quantitativo abbiano essi rispetto al suo patrimonio) siano o non siano, ma gli sia anche indifferente
ch'egli sia o no, sia cioè o non sia nella vita finita (poiché s'intende uno stato, un essere determinato) etc.
Anche si fractus illabatur orbis, impavidum ferient ruinae, disse un Romano. Ed il cristiano ancora di più si
deve trovare in questa indifferenza.
È ancora da notare il legame immediato in cui sta l'elevamento al di sopra dei cento talleri e delle cose finite
in generale, colla prova ontologica e con l'addotta critica kantiana di essa. Questa critica si è resa generalmente plausibile a cagione del suo esempio popolare. Chi non sa che cento talleri reali sono diversi da cento
talleri semplicemente possibili? ch'essi costituiscono una differenza nel mio patrimonio? Poiché questa
diversità si mostra così facilmente nei cento talleri, il concetto (cioè la determinatezza del contenuto come
vuota possibilità) e l'essere sono diversi uno dall'altro. Dunque anche il concetto di Dio è diverso dal suo
176
essere, e come dalla possibilità dei cento talleri io non posso produrre la loro realtà, così dal concetto di Dio
non posso « scernere e cavar fuori » la sua esistenza, mentre in questo scernere e cavar fuori l'esistenza di
Dio dal suo concetto ha da consistere la prova ontologica. Ora se è ad ogni modo esatto che il concetto è
diverso dall'essere, Dio è però ancora più diverso dai cento talleri e dalle altre cose finite. È la definizione
delle cose finite, che in esse concetto ed essere siano diversi, che concetto e realtà, anima e corpo, siano
separabili, e che perciò coteste cose siano transitorie e mortali. L'astratta definizione di Dio, all'incontro, sta
appunto in questo, che il suo concetto e il suo essere sono inseparati e inseparabili. La vera critica delle
categorie e della ragione è appunto questa, d'istruire il conoscere intorno a questa differenza, e d'impedirgli
di applicare a Dio le determinazioni e i rapporti del finito.
Hegel, Scienza della logica, vol 1, lib 1, sez 1, cap 1
177
G. W. Friedrich Hegel
FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO
Indipendenza e dipendenza dell’autocoscienza: signoria e servitù
L’autocoscienza è in e per sé in quanto e perché essa è in e per sé per un'altra; ossia essa è
soltanto come un qualcosa di riconosciuto. Il concetto di questa sua unità nella sua duplicazione,
ossia il concetto dell’infinità realizzantesi nell'autocoscienza, è un intrec cio multilaterale e polisenso; e
così i momenti di siffatto intreccio debbono in parte venir tenuti rigorosamente gli uni fuori degli
altri, in parte, in questa distinzione, venire in pari tempo anche presi e conosciuti come non
distinti, ossia debbon venir presi sempre e riconosciuti nel loro significato opposto. Il doppiosenso
del distinto sta nell'essenza dell'autocoscienza, essenza per cui l'autocoscienza è infinitamente e
immediatamente il contrario della determinatezza nella quale è posta. L'estrinsecazione del
concetto di questa unità spirituale nella sua duplicazione ci presenta il movimento del riconoscer.
[L’autocoscienza duplicata]. – Per l’autocoscienza c’è un’altra autocoscienza; essa è uscita fuori di sé.
Ciò ha un duplice significato: in primo luogo l’autocoscienza ha smarrito se stessa perché ritrova
se stessa come una essenza diversa; in secondo luogo essa così ha superato l’altro, perché non vede
anche l’altro come essenza, ma nell’altro vede se stessa.
Essa deve togliere questo suo esser-altro; ciò è il togliere del primo doppiosenso, ed è perciò di nuovo
un secondo doppiosenso; in primo luogo la coscienza deve procedere a togliere l’altra essenza indipendente
e, mediante ciò, a divenir certa di se stessa come essenza; in secondo luogo provvede con ciò a
toglier se stessa, perché questo altro è lei stessa.
Questo togliere in doppio senso questo esser -altro in doppio senso, è altrettanto un ritorno in doppio
senso in se stessa; ché, in primo luogo, essa, mediante il togliere, riottiene se stessa, perché diviene
ancora eguale a se stessa mediante il togliere del suo esser-altro; ma, in secondo luogo, restituisce di
nuovo a lei stessa anche l’altra autocoscienza, perché era a se stessa nell’altro; nell’altro toglie questo
suo essere, e quindi rende di nuovo libero l’altro.
Ma in questa guisa tale movimento dell'autocoscienza nel rapporto con un'altra autocoscienza è
stato presentato come l'operare dell'una; ma anche questo operare dell'una ha il duplice
significato di essere il suo operare non meno dell'operare dell'altra; l'altra è infatti altrettanto
indipendente e conchiusa in se stessa; nulla è in lei che non sia mediante lei stessa. La prima
autocoscienza non ha l'oggetto di fronte a sé, c om'esso sul principio è solo per l'appetito; anzi
ora l'oggetto è un oggetto capace di essere per sé e indipende nte; né l'autocoscienza è in grado
di disporre per sé di esso, se esso stesso non opera in se stesso ciò ch'essa opera in lui. Il
movimento è dunque senz'altro il movimento duplice di entrambe le autocoscienze. Ciascuna
vede l'altra fare proprio ciò ch'essa stessa fa; ciascuna fa da sé ciò che esige dall'altra; e
quindi fa ciò che fa, soltanto in quanto anche l'altra fa lo stesso; l'operare unilaterale sarebbe vano,
giacché ciò che deve accadere può venire attuato solo per opera di entrambe.
L'operare non ha dunque un duplice senso solo in quanto esso è un operare sia rispetto a sé, sia rispetto
all’Altro; ma lo è anche perché è inseparatamente l’operare tanto dell’Uno quanto dell’Altro.
178
In questo movimento noi vediamo ripetersi quel processo che si presentò come gioco delle forze, ma
nella coscienza. Ciò che in esso era per noi, ora è proprio per gli estremi stessi. Il medio è
l'autocoscienza che si scompone negli estremi, e ciascun estremo è questa permutazione della sua
determinatezza, ed è assoluto passaggio nell'estremo opposto. Ma come coscienza, ciascun estremo esce
bensì fuori di sé; non di meno nel suo esser fuori di sé è in pari tempo trattenuto in se stesso, è per sé, e
il suo fuori-di-sé è per esso. E per esso di essere o di non essere immediatamente altra coscienza; ed
è altrettanto per esso che quest'altra coscienza sia sol per sé, giacché essa togliesi come qual cosa
che è per sé, ed è per sé solo nell'esser-per-sé dell'altra. Ciascun estremo rispetto all'altro è il medio,
per cui ciascun estremo si media e conchiude con se stesso; e ciascuno è rispetto a sé e all'altro
un'immediata essenza che è per sé, la quale in pari tempo è per sé solo attraverso questa mediazione.
Essi si riconoscono come reciprocamente riconoscentisi. È ora da considerare questo puro concetto del riconoscere, della duplicazione dell'autocoscienza nella sua unità; è da considerare, cioè, come il suo
processo appaia per l'autocoscienza. Esso presenterà da prima il lato dell'ineguaglianza di
ambedue le autocoscienze; o presenterà l'insinuarsi del medio negli estremi, il quale medio, in
quanto estremi, è opposto a sé: l'un estremo è solo ciò che è riconosciuto, mentre l'altro è solo ciò
che riconosce.
[La contesa delle autocoscienze opposte]. – Dapprima l’autocoscienza è semplice esser-per-sé, è eguale a se
stessa, perché esclude da sé ogni alterità; a lei sua essenza e suo assoluto oggetto è l’Io; ed essa in questa
immediatezza o in questo essere del suo esser-per-sé è qualcosa di singolo. Ciò che per lei è un altro, lo è
come oggetto inessenziale, segnato col carattere del negativo. Ma l’altro è anch’esso un’autocoscienza; un
individuo sorge di fronte a un individuo. In questa posizione immediata gli individui sono l’un per l’altro a
guisa di oggetti qualunque; sono formazioni indipendenti e, - dacché l’oggetto essente si è qui determinato
come vita, - sono coscienze calate nell’essere della vita, le quali non hanno ancora compiuto l’una per l’altra
il movimento dell’assoluta astrazione, consistente nel sopprimere ogni immediato, e nell’essere soltanto
l’essere puramente negativo della coscienza eguale a se stessa; ossia son coscienze le quali non si sono
ancora presentate reciprocamente come puro esser-per-sé, vale a dire come autocoscienze. Ciascuna è bensì
certa di se stessa, non però dell’altra; e quindi la sua propria certezza di sé non ha ancora verità alcuna,
perchè di una sua verità si potrebbe parlare qualora il suo proprio esser-per-sé le si fosse presentato come
oggetto indipendente, o, - ciò che è lo stesso, - l’oggetto si fosse presentato come pura certezza di se stesso.
Ma, secondo il concetto del riconoscere, ciò non è possibile se non in quanto, come l'altro
oggetto per il primo, così il primo per l'altro compia in se stesso questa pura astrazione dell'esser per-sé mediante l'operare proprio, e, di nuovo, mediante l'operare dell'altro.
Ma la presentazione di sé come pura astrazione dell’autocoscienza consiste nel mostrare sé come
pura negazione della sua guisa oggettiva, o nel mostrare di non essere attaccato né a un qualche
preciso esserci, né all'universale singolarità dell'esserci in generale, e neppure alla vita. Tale
presentazione è l'operare duplicato: l'operare dell'altro e l'operare mediante se stesso. Fin ché si
tratta dell'operare dell'altro, ognuno mira alla morte dell'altro. Ma così è già presente anche il
secondo operare, l'operare mediante se stesso; quell'operare dell'altro, infatti, implica il rischiare in sé
la propria vita. La relazione di ambedue le autocoscienze è dunque così costituita ch'esse danno
prova reciproca di se stesse attraverso la lotta per la vita e per la morte. – Esse debbono
affrontare questa lotta, perché debbono, nell'altro e in se stesse, elevare a ver ità la certezza
loro di esser per sé. E soltanto mettendo in gioco la vita si conserva la libertà, si dà la prova che
all'autocoscienza essenza non è l'essere, non il modo immediato nel quale l’autoscienza sorge, non
l'esser calato di essa nell'espansione della vita: – si prova anzi che nell’autocoscienza niente è per
lei presente, che non sia un momento dileguante, e ch'essa è soltanto puro esser-per-sé. L'individuo
che non ha messo a repentaglio la, vita, può ben venir riconosciuto come persona; ma non ha raggiunto
la verità di questo riconoscimento come riconoscimento di autocoscienza indipendente. Simil mente
ogni individuo deve aver di mira la morte del l'Altro, quando arrischia la propria vita, perché per
lui l'Altro non vale più come lui stesso; la sua essenza gli si presenta come un Altro; esso è fuori
di sé, e deve togliere il suo esser-fuori-di-sé; l'Altro è una coscienza in verio modo impigliata che
vive nell'elemento dell'essere; ed esso deve intuire il suo esser-altro come puro esser-per-sé o come
assoluta negazione.
179
Ma questa prova attraverso la morte toglie e la verità che ne doveva scaturire, e, insieme, anche la certezza di
se stesso in generale; infatti, come la vita è la posizione naturale della coscienza, l’indipendenza senza
l’assoluta negatività, così la morte è la negazione naturale della coscienza medesima, la negazione senza
l’indipendenza, negazione che dunque rimane priva del richiesto significato del riconoscere. Mediante la
morte si è bensì formata la certezza che ambedue, mettendo a repentaglio la loro vita, la tenevano in non cale
in loro e nell’altro; ma tale certezza non si è formata per quelli che sostennero questa lotta. Essi superano la
coscienza loro posta in quell’essenza estranea che è l’esserci naturale; ovvero superano se stessi e vengono
superati come gli estremi che vogliono essere per sé. Ma così dal gioco dello scambio dilegua
il momento essenziale: quello di scomporsi in estremi con determi natezze opposte. E il medio
coincide con una unità morta, scomposta in morti estremi, i quali sono estremi meramente essenti, e non
già opposti; e ambedue non sanno né abbandonarsi né riceversi reciprocamente e vicendevolmente
mediante la coscienza; ma si conce dono a vicenda una libertà fatta soltanto d'indiffe renza,
quasi fossero delle cose. L'opera loro è la negazione astratta; non la negazione della c oscienza
che supera in modo da conservare e tenere il superato, e con ciò sopravvivere al suo venir-superato.
In questa esperienza si fa [chiaro] all'autoscienza che a lei la vita è così essenziale, come lo è
l'autocoscienza pura. Nell'autocoscienza immediata l'Io semplice è l'oggetto assoluto, che peraltro
per noi o in sé è l'assoluta mediazione, e ha per momento essenziale l'indipendenza sussistente.
Resultato della prima esperienza è la risoluzione di quell'unità semplice; mediante quell'espe rienza son poste un'autocoscienza pura e una cos cienza la quale non è pura per se stessa, ma
per un altro: vale a dire che è come coscienza nell'elemento dell'essere o nella figura della cosalità.
Entrambi i momenti sono essenziali; poiché da prima essi sono ineguali ed opposti, e la loro riflessione
nell'unità non è ancora risultata, essi sono come due opposte figure della coscienza: l'una è la
coscienza indipendente alla quale è essenza l'esser-per-sé; l'altra è la coscienza dipendente alla
quale è essenza la vita o l'essere per un altro; l'uno è il signore, l'altro il servo.
[Il signore e il servo.- La signoria]. – Il signore è la coscienza che è per sé; ma non più soltanto
il concetto della coscienza per sé, anzi coscienza che è per sé, la quale è mediata con sé da
un'altra coscienza, cioè da una coscienza tale, alla cui essenza appartiene di essere
sintetizzata con un essere indipendente o con la cosalità in genere. Il signore si rapporta a questi
due momenti: a una cosa come tale, all'oggetto, cioè, dell'appetito; e alla coscienza cui
l'essenziale è la cosalità; e mentre egli a) come concetto dell'autocoscienza è immediato
rapporto dell'esser-per-sé, pur essendo in pari tempo b) come mediazione o come un esser per-sé che è per sé soltanto mediante un altro, si rapporta a) immediatamente ad ambedue, e b)
mediatamente a ciascheduno mediante l'altro. Il signore si rapporta al servo in guisa mediata
attraverso l'indipendente essere, ché proprio a questo è legato il servo; questa è la sua ca tena, dalla
quale egli non poteva astrarre nella lotta; e perciò si mostrò dipendente, avendo egli la sua
indipendenza nella cosalità. Ma il signore è la potenza che sovrasta a questo essere; giacché
egli nella lotta mo stra infatti che questo essere gli valeva soltanto come un negativo; siccome
il signore è la potenza che domina l'essere, mentre questo essere è la potenza che pesa sul l'altro
individuo, così, in questa disposizione sillogistica, il signore ha sotto di sé questo altro
individuo. Parimente, il signore si ra pporta alla cosa in guisa mediata, attraverso il servo; anche
il servo, in quanto autocoscienza in genere, si riferisce negativamente alla cosa e la toglie; ma per
lui la cosa è in pari tempo indipendente; epperò, col suo negarla, non potrà mai distruggerla
completamente; ossia il servo col suo lavoro non fa che trasformarla. Invece, per tale mediazione, il rapporto immediato diviene al signore la pura negazione della cosa stessa: ossia il
godimento; ciò che non riuscì all'appetito, riesce a quest'atto del godere: esaurire la cosa e
acquetarsi nel godimento. Non poté riuscire all'appetito per l'indipendenza della cosa; ma il
signore che ha introdotto il servo tra la cosa e se stesso, si conchiude così soltanto con la
dipendenza della cosa, e puramente la gode; peraltro il lato dell'indipendenza della cosa egli lo
abbandona al servo che la elabora.
In questi due moment i per il signore si viene at tuando il suo esser-riconosciuto da un'altra
coscienza; questa infatti si pone in essi momenti come qualcosa di inessenziale; si pone una volta
nell'elaborazione della cosa, e l'altra volta nella dipendenza da un determi nato esserci; in
entrambi i momenti quella coscienza non può padroneggiare l'essere e arrivare alla nega zione
180
assoluta. Qui è dunque presente il momento del riconoscere per cui l'altra coscienza, togliendosi
come esser-per-sé, fa ciò stesso che la prima fa verso di lei; ed è similmente presente l'altro
momento, che l'operare della seconda coscienza è l'operare proprio della prima; perché ciò che
fa il servo è propriamente il fare del padrone; a quest'ultimo è soltanto l'esser-per-sé, è soltanto
l'essenza; egli è la pura potenza negativa cui la c osa non è niente; ed è dunque il puro, essenziale operare in questa relazione; il servo peraltro non è un operare puro, sì bene un operare
inessenziale. Ma al vero e proprio riconoscere manca il momento per quale ciò che il signore fa
verso l’altro individuo lo fa anche verso se stesso, e pel quale ciò che il servo fa verso di sé lo fa
verso l’altro. Col che si è prodotto un riconoscere unilateral e e ineguale.
La coscienza inessenziale è quindi per il signore l’oggetto costituente la verità della certezza di se stesso. E’
chiaro però che tale oggetto non corrisponde al suo concetto; è anzi chiaro che proprio là dove il signore ha
trovato il suo compimento, gli è divenuta tutt’altra cosa che una coscienza indipendente; indipendente; non
una tale coscienza è per lui, ma piuttosto una coscienza dipendente; egli non è dunque certo
dell'esser-per-sé come verità, anzi la sua verità è piuttosto la coscien za inessenziale e
l'inessenziale operare di essa medesima.
La verità della coscienza indipendente è, di conseguenza, la coscienza servile. Questa da
prima appare bensì fuori di sé e non come la verità dell'autocoscienza. Ma come la signoria
mostrava che la propria essenza è l'inverso di ciò che la signoria stessa vuol essere, così la
servitù nel proprio compimento diventerà piuttosto il contrario di ciò ch'essa è immediatamente;
essa andrà in se stessa come coscienza riconcentrata in sé, e si volgerà nell'indipendenza vera.
[La paura]. – Noi abbiamo veduto soltanto ciò che la servitù è nel comportamento della
signoria. Ma poiché la servitù è autocoscienza, devesi all ora considerare ciò ch'essa è in sé e per
sé. Da prima per la servitù l'essenza è il signore; e quindi la verità le è la coscienza indipendente che è
per sé, verità tuttavia che per essa servitù non è ancora in lei medesima. Solo, essa in effetto
ha in lei stessa questa verità della pura negati vità e dell'esser-per-sé, avendo in sé
sperimentato una tale essenza. Vale a dire, tale c oscienza non è stata in ansia per questa o
quella cosa e neppure durante questo o quell'istante, bensì per l'intiera sua essenza; essa ha
infatti sentito paura della morte, signora assoluta. E’ stata, così, intimamente dissolta, ha
tremato nel profondo di sé, e ciò che in essa v’era di fisso ha vacillato. Ma tale puro e
universale movimento, tale assoluto fluidificarsi di ogni momento sussistente, è l’essenza
semplice dell’autocoscienza, è l’assoluta negatività, il puro esser-per-sé che, dunque, è in
[an] quella coscienza. Tale momento del puro esser -per-sé è anche per essa, che che signore
tale momento è l’oggetto di questa coscienza. La quale inoltre non è l’oggetto di questa
coscienza. La quale inoltre non è soltanto questa universale risoluzione in generale, ché, nel
servire, essa la compie affettivamente; quivi essa toglie in tutti i singoli momenti la sua
adesione all’esserci naturale e, col lavoro, lo trasvaluta ed elimina.
[Il f ormare o colt ivare] . – Ma il senti mento della potenza assoluta in generale e, in particolare,
quello del servizio è soltanto la risoluzione in sé; e sebbene la paura del signore sia l'inizio della
sapienza, pure la coscienza è quivi per lei stessa, ma non è l'esser-per-sé; ma, mediante il
lavoro, essa giunge a se stessa. Nel momento corrispondente all'appetito nella coscienza del
signore, sembrava bensì che alla coscienza servile toc casse il lato del rapporto inessenziale
verso la cosa, poiché quivi la cosa mantiene la sua indipendenza. L'appetito si è riservata la
pura negazione dell'oggetto, e quindi l'intatto sentimento di se stesso. Ma tale appagamento è
esso stesso soltanto un dileguare, perché gli manca il lato oggettivo o il sussistere. Il
lavoro,invece, è appetito tenuto a freno, è un dileguare trattenuto; ovvero: il lavoro forma.
Il rapporto negativo verso l'oggetto diventa forma dell'oggetto stesso, diventa qualcosa
che permane; e ciò perché proprio a chi la vora l'oggetto ha indipendenza. Tale medio negativo o
l ' operare f or mat i vo c ost i t ui scono i n pari t empo la singolarità o il puro esser-per-sé della
coscienza che ora, nel lavoro, esce fuori di sé nell'elemento del permanere; così, quindi, la
coscienza che lavora giunge all'intuizione dell'essere indipendente come di se stessa.
Tuttavia il formare non ha soltanto questo signific ato positivo, che cioè in esso la coscienza servile
181
come puro esser-per-sé diventi a sé l'essente; ma ha anche il significato di contro al suo primo
momento, la paura. Infatti, nel formare la cosa, la negati vità propria di quella coscienza, il suo
esser-per-sé, le diventa un oggetto, sol perché essa toglie l'essente forma opposta. Ma tale
negativo oggettivo è appunto l'essenza estranea, di n an zi al l a q ual e l a c osci e n za s er vi l e ha
t r e ma t o . Ora peraltro essa distrugge questo negativo che le è estraneo; pone sé, come un tale
negativo, nell'elemento del permanere e diviene così per se stessa un qualcosa che è per sé.
Alla coscienza servile l'esser-per-sé che sta nel signore è un esser-per-sé diverso, ossia è solo per lei;
nella paura l'esser-per-sé è in lei stessa; nel formare l'esser-per-sé diviene il suo proprio
per lei, ed essa giunge alla consapevolezza di essere essa stessa in sé e per sé. Per il fatto di venire
esteriorizzata, la forma alla coscienza servile non si fa un Altro da lei; ché proprio la forma è il suo
puro esser-per-sé che quivi alla coscienza servile si fa verità. Così, proprio nel lavoro, dove sem brava
ch'essa fosse un senso estraneo, la coscienza, mediante questo ritrovamento di se stessa
attraverso se stessa, diviene senso proprio. – Per tale riflessione son necessari entrambi questi
momenti: sia la paura e il servizio in generale, sia il formare; e necessari tutti e due in guisa
universale. Senza la disciplina del servizio e dell'obbedienza la paura resta al lato formale e non si
riversa sulla consaputa effettualità dell'esistenza. Senza il formare la paura resta interiore e
muta, e la coscienza non diviene coscienza per lei stessa. Se la coscienza forma senza quella prima paura
assoluta, essa è soltanto un vano senso proprio; infatti la sua forma o negatività non è la negatività in s
é; e quindi il suo formare non può fornirle la consapevolezza di sé come essenza. Se la
coscienza non si è temprata alla paura assoluta, ma soltanto alla sua particolare ansietà, allora
l'essenza negativa le è restata solo qualcosa di esteriore, e la sua sostanza non è intimamente
penetrata di tale essenza negativa. Siccome non ogni elemento ond’è riempita la sua
coscienza naturale ha cominciato a vacillare, quella coscienza appartiene, in sé, ancora
all'elemento dell'essere determinato: il senso proprio è pervicacia, libertà ancora irretita entro la
servitù. Quanto meno a siffatto senso proprio la pura forma può diven tare l'essenza, tanto meno
questa stessa pura forma, considerata come un espandersi oltre il si ngolo, può essere
universale formare o coltivare, concetto assoluto; è invece soltanto un'abilità che ha potere
sopra un singolo alcunché, ma non sopra l'universale potenza né sopra l'intera essenza oggettiva.
182
Ludwig Feuerbach
TESI PROVVISORIE PER UNA RIFORMA DELLA FILOSOFIA
Il segreto della teologia è antropologia, ma la teologia è il segreto della filosofia speculativa, e s’intende la
teologia speculativa, vale a dire quella che si distingue dalla teologia comune per il fatto che colloca nell’al
di qua, rendendolo presente e determinato e attuale, quell’essere divino che appunto la teologia comune ha
per paura e per incomprensione relegato, lontano, nell’al di là. […]
La filosofia hegeliana è il superamento del contrasto tra pensiero ed essere, quale fu espresso in particolare
da Kant; ma, si badi, è il superamento del contrasto nell’interno del contrasto stesso, cioè nell’interno d’uno
dei due elementi, ossia del pensiero. In Hegel il pensiero è l’essere, o meglio, il pensiero è il soggetto,
l’essere il predicato. […] chi non rinuncia alla filosofia di Hegel, non rinunzia neppure alla teologia. La
dottrina hegeliana, secondo cui la natura, o la realtà, è posta dall’idea, non è altro che l’espressione in termini
razionali della dottrina teologica, secondo cui la natura è creata da Dio, o l’essere materiale è creato da un
essere immateriale, cioè astratto. Alla fine della Logica l’idea assoluta giunge ad una nebulosa “risoluzione”,
quasi per documentare con le proprie mani che ha origine dal cielo teologico. La filosofia di Hegel è l’ultimo
rifugio, l’ultimo sostegno razionale alla teologia. Come una volta i teologi cattolici diventarono de facto
aristotelici per poter combattere il protestantesimo, così ora i teologi protestanti devono diventare de iure
hegeliani per poter combattere l’ateismo.
Il vero rapporto tra pensiero ed essere non può essere che questo: l’essere è il soggetto, il pensiero è il
predicato. Il pensiero dunque deriva dall’essere, ma non l’essere dal pensiero. L’essere è da se stesso e per
opera di se stesso, l’essere viene dato soltanto per opera dell’essere, l’essere ha il suo fondamento in se
stesso, perché soltanto l’essere è senso, ragione, necessità, verità, in breve è tutto in tutto. L’essere è, perché
il non-essere cioè il nulla, è assurdo.
Tesi provvisorie per una riforma della filosofia, in Principi
della filosofia dell’avvenire, Einaudi, 1979, pp. 49; 62-3.
PRINCIPI DELLA FILOSOFIA DELL’AVVENIRE
La nuova filosofia è la risoluzione completa, assoluta, coerente della teologia nella antropologia, perché è la
risoluzione della teologia non soltanto nella ragione, come aveva fatto la vecchia filosofia, ma anche nel
cuore, in breve nell’essere reale o totale dell’uomo. Ma anche sotto questo rapporto il risultato necessario
della vecchia filosofia, perché ciò che viene risolto una volta nell’intelletto, deve risolversi alla fine anche
nella vita, nel cuore, nel sangue dell’uomo; ed è anche nello stesso tempo l’inveramento della vecchia
filosofia, proprio in quanto essa è una verità nuova ed autonoma: solo la verità diventata carne e sangue è
verità. La vecchia filosofia ricadeva necessariamente nella teologia: ciò che è superato soltanto
nell’intelletto, cioè in abstratio, trova ancora un’opposizione nel cuore. La nuova filosofia, invece, non può
più ritornare indietro: ciò che è morto nel corpo e nell’anima non può più ricomparire neppure come
fantasma.
L’uomo non si distingue affatto dalle bestie soltanto per il pensiero. La sua differenza dalle bestie è data
piuttosto dalla sue essenza considerata nella sua totalità. Certamente chi non pensa, non è un uomo; ma non
183
perché il pensiero sia la causa dell’essere umano, ma soltanto perché è una conseguenza e una proprietà
necessaria. […] la nuova filosofia fa dell’uomo l’oggetto unico, universale e supremo della filosofia,
includendovi la natura considerata come fondamento dell’uomo. La nuova filosofia fa dell’antropologia, con
inclusione della fisiologia, la scienza universale. […]
La filosofia dell’identità assoluta ha completamente spostato il punto di vista della verità. Il punto di vista
naturale per l’uomo, il punto di vista della differenza tra l’io e il tu, tra il soggetto e l’oggetto, è il punto di
vista assoluto, e di conseguenza anche il punto di vista della filosofia. […] La verità non esiste nel pensiero,
non esiste nel sapere considerato in se stesso. La verità non è altro che la totalità della vita e dell’essere
umano. L’uomo singolo, considerato in se stesso, non racchiude l’essenza dell’uomo in sé, né in quanto
essere morale, né in quanto essere pensante. L’essenza dell’uomo è contenuta soltanto nella comunione,
nell’unità dell’uomo con l’uomo: ed è tale unità che si appoggia sulla realtà della differenza tra l’io e il tu. La
solitudine è finitezza e limitatezza; la comunione è la libertà e infinitudine. L’uomo considerato per se stesso
è uomo nel senso abituale della parole; l’uomo con l’uomo, ossia l’unità dell’io e del tu, è Dio. […] La vera
dialettica non è monologo del pensatore solitario con se stesso, ma un dialogo tra l’io e il tu. […]
La vecchia filosofia ha una doppia verità: la verità considerata per se stessa, che non si cura dell’uomo, cioè
la filosofia, e la verità per l’uomo, cioè la ragione. La nuova filosofia, invece in quanto filosofia dell’uomo, è
essenzialmente anche una filosofia per l’uomo. Senza pregiudizio della dignità e della autonomia della
teoria, anzi in profondo accordo con essa, la nuova filosofia ha essenzialmente una tendenza pratica nel più
alto senso della parola: essa subentra al posto della religione, implica in se stessa l’essenza della religione, è
essa stessa veramente religione.
Principi della filosofia dell’avvenire, op. cit. pp. 136-41
184
Friedrich Engels
LUDOVICO FEUERBACH
E IL PUNTO DI APPRODO DELLA FILSOSOFIA CLASSICA TEDESCA
Prefezione 1888
Su Feuerbach, che pure forma sotto molti aspetti un anello intermedio tra la filosofia hegeliana e la nostra
concezione, non siamo mai più ritornati.
In queste circostanze m’è parso che si rendesse sempre più necessaria una esposizione breve, sistematica, dei
nostri rapporti con la filosofia hegeliana, della nostra origine e del nostro distacco da essa. E allo stesso
modo, un riconoscimento pieno ed intero dell’influenza esercitata sopra di noi, nel periodo del nostro Sturm
und Drang, da Feuerbach più che da tutti gli altri filosofi successivi a Hegel, m’è apparso come un debito
d’onore non ancora assolto.
Invece ho ritrovato in un vecchio quaderno di Marx le undici tesi su Feuerbach che riproduco in appendice3.
Sono appunti per un lavoro ulteriore, buttati giù in fretta, non destinati in nessun modo alla pubblicazione,
ma d’un valore inestimabile come il primo documento in cui è deposto il germe geniale della nuova
concezione del mondo.
Capitolo I
la tesi famosa di Hegel: «Tutto ciò che è reale è razionale, e tutto ciò che è razionale è reale». Questa era
manifestamente, infatti, l’approvazione di tutto ciò che esiste, la consacrazione filosofica del dispotismo,
dello Stato poliziesco, della giustizia di gabinetto, della censura.
E così nel corso della evoluzione tutto ciò che prima era reale diventa irreale, perde la propria necessità, il
proprio diritto all’esistenza,
La tesi della razionalità di tutto il reale si risolve quindi secondo tutte le regole del ragionamento
hegeliano nell’altra: tutto ciò che esiste è degno di perire.
la verità risiedeva ormai nel processo della conoscenza stessa, nella lunga evoluzione storica della scienza,
che si eleva dai gradi inferiori della conoscenza a gradi sempre più alti, senza però giungere mai, attraverso
la scoperta di una cosiddetta verità assoluta, al punto in cui non può più avanzare
Ogni tappa è necessaria, e quindi giustificata per il tempo e per le circostanze a cui deve la propria origine,
ma diventa caduca e ingiustificata rispetto alle nuove condizioni, più elevate, che si sviluppano a poco a poco
nel suo proprio seno;
Il carattere conservatore di questa concezione è relativo, il suo carattere rivoluzionario è assoluto:il solo
assoluto ch’essa ammetta.
185
Ma con ciò si dichiara verità assoluta tutto il contenuto dogmatico del sistema hegeliano, in contraddizione
col suo metodo dialettico, che dissolve ogni elemento dogmatico; in questo modo il lato rivoluzionario viene
soffocato da una ipertrofia del lato conservatore.
la filosofia intera, nel senso che finora si è dato a questa parola è finita. Si lascia correre la «verità
assoluta», che per questa via e da ogni singolo isolatamente non può essere raggiunta, e si dà la caccia,
invece, alle verità relative accessibili per la via delle scienze positive e della sintesi dei loro risultati a mezzo
del pensiero dialettico. Con Hegel ha fine, in modo generale, la filosofia; da una parte perché egli nel suo
sistema ne riassume tutta la evoluzione nella maniera più grandiosa, d’altra parte perché egli, sia pure
inconsapevolmente, ci mostra la via che da questo labirinto dei sistemi ci porta alla vera conoscenza positiva
del mondo.
Il complesso della dottrina di Hegel lasciava, come abbia mo visto, uno spazio considerevole per le più
differenti concezioni pratiche di partito; e pratiche, nella Germania teoretica di quel tempo, erano soprattutto
due cose: la religione e la politica. Coloro che davano importanza soprattutto al sistema di Hegel, potevano
in entrambi questi campi essere conservatori; coloro per cui l’essenziale era il metodo dialettico, potevano
appartenere, tanto in religione
che in politica, all’opposizione estrema.
Allora apparve l’Essenza del cristianesimo di Feuerbach. D’un colpo essa ridusse in polvere la
contraddizione, rimettendo sul trono senza preamboli il materialismo. La natura esiste indipendentemente da
ogni filosofia; essa è la base sulla quale siamo cresciuti noi uomini, che siamo pure prodotti della natura;
oltre alla natura e agli uomini, non esiste nulla, e gli esseri più elevati che ha creato la nostra fantasia
religiosa sono soltanto il riflesso fantastico del nostro proprio essere. L’incanto era rotto; il «sistema» era
spezzato e gettato in un canto; la contraddizione era rimossa, in quanto esistente soltanto
nell’immaginazione. Bisogna aver provato direttamente l’azione liberatrice di questo libro, per farsi un’idea
di essa. L’entusiasmo fu generale: in un momento diventammo tutti feuerbachiani. Con quale entusiasmo
Marx salutasse la nuova concezione e quanto ne fosse influenzato, - malgrado tutte le riserve
critiche, - lo si può vedere leggendo La sacra famiglia.
Capitolo II
Il grande problema fondamentale di tutta la filosofia, e specialmente della filosofia moderna, è quello del
rapporto del pensiero coll’essere
I filosofi si sono divisi in due grandi campi secondo il modo come rispondevano a tale quesito. I filosofi che
affermavano la priorità dello spirito rispetto alla natura, e quindi ammettevano in ultima istanza una
creazione del mondo di un genere qualsiasi, - questa creazione è spesso nei filosofi, per esempio in Hegel,
ancora più complicata e assurda che nel cristianesimo , - formavano il campo dell’idealismo. Quelli che
affermavano la priorità della natura appartenevano alle diverse scuole del materialismo.
È in grado il nostro pensiero di conoscere il mondo reale; possiamo noi nelle nostre rappresentazioni e nei
nostri concetti del mondo reale avere una immagine fedele della realtà? Questa questione si chiama, nel
linguaggio filosofico, questione dell’identità dell’essere e del pensiero, e l’immensa maggioranza dei filosofi
risponde ad essa in modo affermativo. Per Hegel, per esempio, questa risposta affermativa si comprende da
sé, perché ciò che noi conosciamo del mondo reale è precisamente il suo contenuto ideale, ciò che fa del
mondo una realizzazione progressiva dell’idea assoluta, la quale idea assoluta è esistita in qualche parte
dall’eternità, prima del mondo e indipendentemente da esso. È senz’altro evidente che il pensiero può
conoscere un contenuto il quale è già, preventivamente, un contenuto ideale. È altrettanto evidente che ciò
che si deve provare è già contenuto qui, tacitamente, nelle premesse.
Tra i moderni, appartengono a questa schiera Hume e Kant, che hanno avuto una parte molto importante
nello svolgimento della filosofia. L’essenziale per la confutazione di questa concezione è già stato detto da
Hegel, nella misura in cui si poteva farlo da un punto di vista idealistico. Ciò che Feuerbach ha aggiunto da
un punto di vista materialistico è più ingegnoso che profondo. La confutazione più decisiva di questa ubbìa
filosofica, come del resto di tutte le altre, è data dalla pratica, particolarmente dall’esperimento e
186
dall’industria. Se possiamo dimostrare che la nostra comprensione di un dato fenomeno naturale è giusta,
creandolo noi stessi, producendolo dalle sue condizioni e, quel che più conta, facendolo servire ai nostri fini,
l’inafferrabile «cosa in sé» di Kant è finita. Le sostanze chimiche che si formano negli organismi animali e
vegetali restarono «cose in sé» fino a che la chimica organica non si mise a prepararle l’una dopo l’altra;
quando ciò avvenne, la «cosa in sé» si trasformò
in una cosa per noi
In questo lungo periodo, che va da Descartes a Hegel e da Hobbes a Feuerbach, i filosofi non furono però
spinti unicamente, come essi credevano, dalla forza del pensiero puro. Al contrario. Ciò che in realtà li
spingeva era soprattutto il potente e sempre più rapido e impetuoso progresso delle scienze naturali e
dell’industria. Nei materialisti ciò appariva già alla superficie, ma anche i sistemi idealistici si riempivano
sempre più di contenuto materialistico e cercavano di rimuovere il contrasto tra lo spirito e la materia in
modo panteistico, cosicché il sistema di Hegel alla fine rappresenta soltanto, pel suo metodo e pel suo
contenuto, un materialismo posto idealisticamente con la testa all’ingiú.
La evoluzione di Feuerbach è quella di un hegeliano, - a dire il vero non del tutto ortodosso, - verso il
materialismo; evoluzione che porta, a un punto determinato, a una rottura totale col sistema idealistico del
suo predecessore. Alla fine gli si impone con forza irresistibile l’idea che l’esistenza premondana dell’«idea
assoluta» secondo Hegel, la «preesistenza delle categorie logiche » prima della apparizione del mondo, non è
altro che un residuo fantastico della fede in un creatore ultraterreno; l’idea che il mondo materiale,
percepibile dai sensi, e a cui noi stessi apparteniamo, è il solo mondo reale, e che la coscienza e il pensiero,
per quanto appaiano soprasensibili, sono il prodotto di un organo materiale, corporeo: il cervello. La materia
non è un prodotto dello spirito, ma lo spirito stesso non è altro che il più alto prodotto della materia. Questo,
naturalmente, è materialismo puro. Arrivato a questo punto,
Feuerbach s’arresta.
Peggio ancora, egli lo confonde con la forma piatta, volgare, in cui il materialismo del secolo XVIII continua
a esistere nella testa dei naturalisti e dei medici, e in cui venne predicato tra il 1850 e il 1860 da Bucbner,
Vogt e Moleschott.
La seconda ristrettezza specifica di questo materialismo consisteva nella sua incapacità di concepire il
mondo come un processo, come una sostanza soggetta a una evoluzione storica.
Certamente, Feuerbach era ancora vivo al tempo delle tre scoperte decisive: quella della cellula, quella della
trasformazione dell’energia e quella della teoria dell’evoluzione che porta il nome di Darwin. Ma come
poteva il filosofo, che viveva isolato nella campagna, seguire la scienza in modo da apprezzare pienamente le
scoperte che i naturalisti stessi allora, in parte contestavano ancora, in parte non sapevano convenientemente
sfruttare?
Capitolo III
La sola religione che Feuerbach indaga seriamente è il cristianesimo, la religione mondiale dell’Occidente,
che è fondata sul monoteismo. Egli dimostra che il dio cristiano non è che il riflesso fantastico, l’immagine
riflessa dell’uomo. Ma questo stesso dio è il prodotto di un lungo processo di astrazione, è la quintessenza
concentrata di una moltitudine di precedenti dèi di tribù e nazionali. E conforme a ciò anche l’uomo, di cui
quel dio è l’immagine, non è un uomo reale, ma è a sua volta la quintessenza di molti uomini reali, è l’uomo
astratto, quindi è esso pure una immagine ideale.
Nella forma egli è realistico, egli parte dall’uomo; ma non dice assolutamente nulla del mondo in cui
quest’uomo vive, e perciò l’uomo rimane sempre lo stesso uomo astratto che era il protagonista della
filosofia della religione.
La storia è per lui, in generale, un terreno in cui egli sta a disagio e si sente un estraneo.
In una parola, succede alla dottrina morale di Feuerbach lo stesso che a tutte quelle che l’hanno preceduta.
Essa è adatta a tutti i tempi, a tutti i popoli, a tutte le circostanze, e appunto per questo non è applicabile in
187
nessun tempo e in nessun luogo, ed è, rispetto al mondo reale, altrettanto impotente quanto l’imperativo
categorico di Kant.
Ma come fu possibile che il potente impulso dato da Feuerbach rimanesse per lui stesso così sterile? Pel
semplice motivo che Feuerbach non è in grado di trovare la strada che porta dal regno delle astrazioni, da lui
stesso odiato a morte, alla natura vivente. Egli si aggrappa con tutte le forze alla natura e all’uomo, ma la
natura e l’uomo rimangono per lui soltanto delle parole. Né della natura reale, né dell’uomo reale egli non ci
sa dire nulla di determinato. Ma dall’uomo astratto di Feuerbach si arriva agli uomini viventi e reali soltanto
quando si considerano gli uomini operanti nella storia. Feuerbach si rifiutava di farlo, e perciò l’anno 1848,
che egli non comprese, segnò per lui la rottura definitiva col mondo reale, il ritiro nella solitudine.
Capitolo IV
Egli rimase a mezza strada anche come filosofo: dalla metà in giù materialista, dalla metà in su idealista.
Non si liberò di Hegel criticandolo, ma lo gettò in disparte come inservibile, mentre egli stesso, di fronte alla
ricchezza enciclopedica del sistema di Hegel, non realizzava niente di positivo fuorché un’ampollosa
religione dell’amore e una morale magra, impotente. Dalla dissoluzione della scuola hegeliana uscì però
anche un’altra corrente, la sola che ha veramente dato dei frutti, e questa corrente si lega essenzialmente al
nome di Marx
La rottura colla filosofia hegeliana si produsse anche qui attraverso il ritorno alla
concezione materialistica. Ciò vuol dire che ci si decise a concepire il mondo reale, - natura e storia, - nel
modo come esso si presenta a chiunque vi si accosti senza ubbie idealistiche preconcette; ci si decise a
sacrificare senza pietà ogni ubbia idealistica che non si potesse conciliare con i fatti concepiti nel loro
proprio nesso e non in un nesso fantastico. E il materialismo non vuol dire niente altro che questo. Soltanto
che per la prima volta la concezione materialistica del mondo veniva presa qui veramente sul serio, veniva
applicata in modo conseguente, almeno nelle sue grandi linee, a tutti i campi del sapere che si dovevano
prendere in considerazione. Non ci si accontentò di mettere Hegel semplicemente in disparte; al contrario ci
si ricollegò a quel suo lato rivoluzionario che abbiamo indicato sopra, al metodo dialettico. Ma nella forma
che Hegel gli aveva dato, questo metodo era inservibile. Per Hegel la dialettica è l’autoevoluzione del
concetto. Il concetto assoluto non esiste soltanto, - non si sa dove, - sin dall’eternità, esso è anche la vera e
propria anima vivente di tutto il mondo esistente. Esso si sviluppa su se stesso attraverso tutti i gradi
preliminari che vengono trattati nel modo più ampio nella Logica e che sono tutti racchiusi in lui; infine, esso
si «estrinseca» trasformandosi in natura, dove, senza aver coscienza di se stesso, travestito da necessità
naturale, compie una nuova evoluzione e giunge infine nuovamente ad aver coscienza di se stesso nell’uomo
Noi concepimmo di nuovo i concetti del nostro cervello in modo materialistico, come riflessi delle cose reali,
invece di concepire le cose reali come riflessi di questo o quel grado del concetto assoluto. La dialettica si
riduceva in questo modo alla scienza delle leggi generali del movimento, tanto del mondo esterno, quanto del
pensiero umano: a due serie di leggi, identiche nella sostanza, differenti però nell’espressione, in quanto il
pensiero umano le può applicare in modo consapevole, mentre nella natura e sinora per la maggior parte
anche nella storia umana esse giungono a farsi valere in modo incosciente, nella forma di necessità esteriore,
in mezzo a una serie infinita di apparenti casualità. Ma in questo modo la dialettica del concetto stesso non
era più altro che il riflesso cosciente del movimento dialettico del mondo reale, e così la dialettica hegeliana
veniva raddrizzata, o, per dirla più esattamente, mentre prima si reggeva sulla testa, veniva rimessa a reggersi
sui piedi.
Con ciò il lato rivoluzionario della filosofia hegeliana veniva ripreso e in pari tempo liberato dalle pastoie
idealistiche, che avevano impedito a Hegel di applicarlo in modo conseguente. La grande idea fondamentale,
che il mondo non deve essere concepito come un complesso di cose compiute, ma come un complesso di
processi, in cui le cose in apparenza stabili, non meno dei loro riflessi intellettuali nella nostra testa, i
concetti, attraversano un ininterrotto processo di origine e di decadenza, attraverso al quale, malgrado tutte le
apparenti casualità e malgrado ogni regresso momentaneo, si realizza, alla fine, un progresso continuo
La vecchia metafisica, che considerava le cose come compiute in se stesse, sorse da una scienza naturale che
indagava le cose vive e le morte come cose compiute in se stesse. Ma quando questa indagine fu andata tanto
lontano che fu possibile il progresso decisivo, il passaggio all’indagine sistematica delle modificazioni che
188
queste cose subiscono nella natura stessa, allora suonò anche nel campo filosofico l’ultima ora della vecchia
metafisica.
La storia della evoluzione della società si rivela però in un punto come essenzialmente differente da quella
della natura. Nella natura, - sino a che non prendiamo in considerazione la reazione degli uomini sopra di
essa, - agiscono gli uni sugli altri dei fattori assolutamente ciechi e incoscienti e la legge generale si realizza
nella loro azione reciproca. Nulla di ciò che accade, - né degli innumerevoli fatti apparentemente accidentali
che appaiono alla superficie, né dei risultati definitivi, che in mezzo a questi fatti accidentali affermano la
conformità ad una legge, - si pro duce come fine consapevole, voluto. Invece nella storia della società gli
elementi attivi sono esclusivamente degli uomini, dotati di coscienza, di capacità di riflessione e di passioni,
e che perseguono scopi determinati. Nulla accade, in questo campo, senza intenzione cosciente, senza uno
scopo voluto. Ma questa differenza, pur essendo così importante per l’indagine storica, specialmente di
epoche e di avvenimenti determinati, non può cambiare nulla al fatto che il corso della storia è retto da
determinate leggi interiori. Perché anche qui, malgrado gli scopi coscientemente voluti dai singoli, regna alla
superficie, in apparenza e all’ingrosso, il caso. Solo di rado ciò che si vuole riesce. Nella maggior parte dei
casi i molti fini voluti si incrociano e si contraddicono, oppure sono essi stessi anticipatamente irrealizzabili,
oppure i mezzi per la loro realizzazione sono insufficienti. Gli scontri tra le innumerevoli volontà e attività
singole creano sul terreno storico una situazione che è assolutamente analoga a quella che regna nella natura
incosciente. Gli scopi delle azioni sono voluti, ma i risultati che succedono effettivamente alle azioni non
sono voluti oppure, se anche sembrano a tutta prima corrispondere allo scopo voluto, in conclusione hanno
delle conseguenze del tutto diverse da quelle volute. Gli avvenimenti storici sembrano dunque, nel loro
complesso, dominati essi pure dal caso. Ma laddove alla superficie regna il caso, ivi il caso stesso è retto
sempre da intime leggi nascoste, e non si tratta che di scoprire queste leggi. In qualsiasi modo si svolga la
storia degli uomini, sono gli uomini che la fanno,
D’altra parte si domanda ancora quali forze motrici si celano a loro volta dietro questi motivi determinanti,
quali sono le cause storiche che nei cervelli degli uomini che agiscono si trasformano in questi motivi.
Dopo l’affermarsi della grande industria, cioè per lo meno a partire dai trattati di pace del 1815, non era più
un segreto per nessuno in Inghilterra che tutta la lotta politica in questo paese si aggirava attorno alle pretese
di predominio di due classi, l’aristocrazia fondiaria (landed aristocracy) e la borghesia (middle class).
E dal 1830 la classe operaia, il proletariato, è stato riconosciuto come terzo pretendente al potere in questi
due paesi.
L’origine e lo sviluppo di due grandi classi si basava qui in modo chiaro e tangibile su cause puramente
economiche.
Ma questa concezione mette fine alla filosofia nel campo della storia, così come la concezione dialettica
della natura rende altrettanto inutile quanto impossibile ogni filosofia della natura. Da ogni parte ormai non
si tratta più di escogitare dei nessi nel pensiero, ma di scoprirli nei fatti. Alla filosofia, cacciata dalla natura e
dalla storia, rimane soltanto il regno del pensiero puro, nella misura in cui esso continua a sussistere: la
dottrina delle leggi del processo del pensiero, la logica e la dialettica.
Il nuovo indirizzo, che ha ravvisato nella storia della evoluzione del lavoro la chiave per comprendere tutta la
storia della società, si è rivolto sin dal primo momento alla classe operaia e ha trovato in essa l’accoglienza
che non cercava né attendeva dalla scienza ufficiale. Il movimento operaio tedesco è l’erede della filosofia
classica tedesca.
189
Marx-Engels
IL MANIFESTO DEL PARTITO COMUNISTA (1848)
Uno spettro s’aggira per l'Europa - lo spettro del comunismo. Tutte le potenze della vecchia Europa si sono
alleate in una santa battuta di caccia contro questo spettro: papa e zar, Metternich e Guizot, radicali francesi e
poliziotti tedeschi.
Quale partito d'opposizione non è stato tacciato di comunismo dai suoi avversari governativi; qual partito
d'opposizione non ha rilanciato l'infamante accusa di comunismo tanto sugli uomini più progrediti
dell'opposizione stessa, quanto sui propri avversari reazionari?
Da questo fatto scaturiscono due specie di conclusioni. Il comunismo è di già riconosciuto come potenza da
tutte le potenze europee.
E’ ormai tempo che i comunisti espongano apertamente in faccia a tutto il mondo il loro modo di vedere, i
loro fini, le loro tendenze, e che contrappongano alla favola dello spettro del comunismo un manifesto del
partito stesso.
A questo scopo si sono riuniti a Londra comunisti delle nazionalità più diverse e hanno redatto il seguente
manifesto che viene pubblicato in inglese, francese, tedesco, italiano, fiammingo e danese.
Capitolo I: Borghesi e proletari
La storia di ogni società esistita fino a questo momento, è storia di lotte di classi.
Liberi e schiavi, patrizi e plebei, baroni e servi della gleba, membri delle corporazioni e garzoni, in breve,
oppressori e oppressi, furono continuamente in reciproco contrasto, e condussero una lotta ininterrotta, ora
latente ora aperta; lotta che ogni volta è finita o con una trasformazione rivoluzionaria di tutta la società o
con la comune rovina delle classi in lotta.
Nelle epoche anteriori della storia. troviamo quasi dappertutto una completa articolazione della società in
differenti ordini, una molteplice graduazione delle posizioni sociali. In Roma antica abbiamo patrizi, cavalieri, plebei, schiavi; nel medioevo signori feudali, vassalli, membri delle corporazioni, garzoni, servi della
gleba, e, per di più, anche particolari graduazioni in quasi ognuna di queste classi.
La società borghese moderna, sorta dal tramonto della società feudale, non ha eliminato gli antagonismi fra
le classi. Essa ha soltanto sostituito alle antiche, nuove classi, nuove condizioni di oppressione, nuove forme
di lotta.
190
La nostra epoca, l'epoca della borghesia, si distingue però dalle altre per aver semplificato gli antagonismi di
classe. L'intera società si va scindendo sempre più in due grandi campi nemici, in due grandi classi
direttamente contrapposte l'una all'altra: borghesia e proletariato.
Dai servi della gleba del medioevo sorse il popolo minuto delle prime città; da questo popolo minuto si
svilupparono i primi elementi della borghesia.
La scoperta dell'America, la circumnavigazione dell’Africa crearono alla sorgente borghesia un nuovo
terreno. Il mercato delle Indie orientali e della Cina, la colonizzazione dell’America, gli scambi con le colonie, l'aumento dei mezzi di scambio e delle merci in genere diedero al commercio, alla navigazione,
all’industria uno slancio fino allora mai conosciuto, e con ciò impressero un rapido sviluppo all'elemento
rivoluzionario entro la società feudale in disgregazione.
L'esercizio dell'industria, feudale o corporativo, in uso fino allora non bastava più al fabbisogno che aumentava con i nuovi mercati. Al suo posto subentrò la manifattura. Il medio ceto industriale soppiantò i
maestri artigiani; la divisione del lavoro fra le diverse corporazioni scomparve davanti alla divisione del
lavoro nella singola officina stessa.
Ma i mercati crescevano sempre, il fabbisogno saliva sempre. Neppure la manifattura era più sufficiente.
Allora il vapore e le macchine rivoluzionarono la produzione industriale. All'industria manifatturiera subentrò la grande industria moderna; al medio ceto industriale subentrarono i milionari dell'industria, i capi di
interi eserciti industriali, i borghesi moderni.
La grande industria ha creato quel mercato mondiale, che era stato preparato dalla scoperta dell'America. Il
mercato mondiale ha dato uno sviluppo immenso al commercio, alla navigazione, alle comunicazioni per via
di terra. Questo sviluppo ha reagito a sua volta sull'espansione dell'industria, e, nella stessa misura in cui si
estendevano industria, commercio, navigazione, ferrovie, si è sviluppata la borghesia, ha accresciuto i suoi
capitali e ha respinto nel retroscena tutte le classi tramandate dal medioevo.
Vediamo dunque come la borghesia moderna è essa stessa il prodotto d'un lungo processo di sviluppo, d'una
serie di rivolgimenti nei modi di produzione e di traffico.
Ognuno di questi stadi di sviluppo della borghesia era accompagnato da un corrispondente progresso politico.
Ceto oppresso sotto il dominio dei signori feudali, insieme di associazioni armate ed autonome nel comune,
talvolta sotto forma di repubblica municipale indipendente, talvolta di terzo stato tributario della monarchia,
poi all'epoca dell'industria manifatturiera, nella monarchia controllata dagli stati come in quella assoluta,
contrappeso alla nobiltà, e fondamento principale delle grandi monarchie in genere, la borghesia, infine, dopo
la creazione della grande industria e del mercato mondiale, si è conquistata il dominio politico esclusivo
nello stato rappresentativo moderno. Il potere statale moderno non è che un comitato che amministra gli
affari comuni di tutta la classe borghese.
La borghesia ha avuto nella storia una parte sommamente rivoluzionaria.
Dove ha raggiunto il dominio, la borghesia ha distrutto tutte le condizioni di vita feudali, patriarcali, idilliche.
Ha lacerato spietatamente tutti i variopinti vincoli feudali che legavano l'uomo al suo superiore naturale, e
non ha lasciato fra uomo e uomo altro vincolo che il nudo interesse, il freddo «pagamento in contanti». Ha
affogato nell'acqua gelida del calcolo egoistico i sacri brividi dell'esaltazione devota, dell'entusiasmo
cavalleresco, della malinconia filistea. Ha disciolto la dignità personale nel valore di scambio e al posto delle
innumerevoli libertà patentate e onestamente conquistate, ha messo, unica, la libertà di commercio priva di
scrupoli. In una parola: ha messo lo sfruttamento aperto, spudorato, diretto e arido al posto dello sfruttamento
mascherato d'illusioni religiose e politiche.
La borghesia ha spogliato della loro aureola tutte le attività che fino allora erano venerate e considerate con
pio timore. Ha tramutato il medico, il giurista, il prete, il poeta, l'uomo della scienza, in salariati ai suoi
stipendi.
La borghesia ha strappato il commovente velo sentimentale al rapporto familiare e lo ha ricondotto a un puro
rapporto di denaro.
La borghesia ha svelato come la brutale manifestazione di forza che la reazione ammira tanto nel medioevo,
avesse la sua appropriata integrazione nella più pigra infingardaggine. Solo la borghesia ha dimostrato che
cosa possa compiere l'attività dell'uomo. Essa ha compiuto ben altre meraviglie che piramidi egiziane,
191
acquedotti romani e cattedrali gotiche, ha portato a termine ben altre spedizioni che le migrazioni dei popoli
e le crociate.
La borghesia non può esistere senza rivoluzionare continuamente gli strumenti di produzione, i rapporti di
produzione, dunque tutti i rapporti sociali. Prima condizione di esistenza di tutte le classi industriali
precedenti era invece l'immutato mantenimento del vecchio sistema di produzione. Il continuo rivoluzionamento della produzione, l'ininterrotto scuotimento di tutte le situazioni sociali, l'incertezza e il movimento
eterni contraddistinguono l'epoca dei borghesi fra tutte le epoche precedenti. Si dissolvono tutti i rapporti
stabili e irrigiditi, con il loro seguito di idee e di concetti antichi e venerandi, e tutte le idee e i concetti nuovi
invecchiano prima di potersi fissare. Si volatilizza tutto ciò che vi era di corporativo e di stabile, è profanata
ogni cosa sacra, e gli uomini sono finalmente costretti a guardare con occhio disincantato la propria
posizione e i propri reciproci rapporti.
Il bisogno di uno smercio sempre più esteso per i suoi prodotti sospinge la borghesia a percorrere tutto il
globo terrestre. Dappertutto deve annidarsi, dappertutto deve costruire le sue basi, dappertutto deve creare
relazioni.
Con lo sfruttamento del mercato mondiale la borghesia ha dato un'impronta cosmopolitica alla produzione e al
consumo di tutti i paesi. Ha tolto di sotto i piedi all'industria il suo terreno nazionale, con gran rammarico dei
reazionari. Le antichissime industrie nazionali sono state distrutte, e ancora adesso vengono distrutte ogni
giorno. Vengono soppiantate da industrie nuove, la cui introduzione diventa questione di vita o di morte per
tutte le nazioni civili, da industrie che non lavorano più soltanto materie prime del luogo, ma delle zone più
remote, e i cui prodotti non vengono consumati solo nel paese stesso ma anche in tutte le parti del mondo. Ai
vecchi bisogni, soddisfatti con i prodotti del paese, subentrano bisogni nuovi, che per essere soddisfatti
esigono i prodotti dei paesi e dei climi più lontani. All'antica autosufficienza e all’antico isolamento locali e
nazionali subentra uno scambio universale, una interdipendenza universale fra le nazioni. E come per la
produzione materiale, cosi per quella intellettuale. I prodotti intellettuali delle singole nazioni divengono
bene comune. L'unilateralità e la ristrettezza nazionali diventano sempre più impossibili, e dalle molte
letterature nazionali e locali si forma una letteratura mondiale.
Con il rapido miglioramento di tutti gli strumenti di produzione, con le comunicazioni infinitamente
agevolate, la borghesia trascina nella civiltà tutte le nazioni, anche le più barbare. I bassi prezzi delle sue
merci sono l'artiglieria pesante con la quale essa spiana tutte le muraglie cinesi, con la quale costringe alla
capitolazione la più tenace xenofobia dei barbari. Costringe tutte le nazioni ad adottare il sistema di produzione della borghesia, se non vogliono andare in rovina, le costringe ad introdurre in casa loro la cosiddetta
civiltà, cioè a diventare borghesi. In una parola: essa si crea un mondo a propria immagine e somiglianza.
La borghesia ha assoggettato la campagna al dominio della città. Ha creato città enormi, ha accresciuto su
grande scala la cifra della popolazione urbana in confronto di quella rurale, strappando in tal modo una parte
notevole della popolazione all'idiotismo della vita rurale. Come ha reso la campagna dipendente dalla città, la
borghesia ha reso i paesi barbari e semibarbari dipendenti da quelli inciviliti, i popoli di contadini da quelli di
borghesi, l'Oriente dall'Occidente.
La borghesia elimina sempre più la dispersione dei mezzi di produzione, della proprietà e della popolazione.
Ha agglomerato la popolazione, ha centralizzato i mezzi di produzione, e ha concentrato in poche mani la
proprietà. Ne è stata conseguenza necessaria la centralizzazione politica. Province indipendenti, legate quasi
solo da vincoli federali, con interessi, leggi, governi e dazi differenti, vennero strette in una sola nazione,
sotto un solo governo, una sola legge, un solo interesse nazionale di classe, entro una sola barriera doganale.
Durante il suo dominio di classe appena secolare la borghesia ha creato forze produttive in massa molto
maggiore e più colossali che non avessero mai fatto tutte insieme le altre generazioni del passato. Il soggiogamento delle forze naturali, le macchine, l'applicazione della chimica all'industria e all'agricoltura, la
navigazione a vapore, le ferrovie, i telegrafi elettrici, il dissodamento d'interi continenti, la navigabilità dei
fiumi, popolazioni intere sorte quasi per incanto dal suolo - quale dei secoli antecedenti immaginava che nel
grembo del lavoro sociale stessero sopite tali forze produttive?
Ma abbiamo visto che i mezzi di produzione e di scambio sulla cui base si era venuta costituendo la
borghesia erano stati prodotti entro la società feudale. A un certo grado dello sviluppo di quei mezzi di
produzione e di scambio, le condizioni nelle quali la società feudale produceva e scambiava, l'organizzazione
feudale dell'agricoltura e della manifattura, in una parola i rapporti feudali della proprietà, non corrisposero
192
più alle forze produttive ormai sviluppate. Essi inceppavano la produzione invece di promuoverla. Si
trasformarono in altrettante catene. Dovevano essere spezzate e furono spezzate.
Ad esse subentrò la libera concorrenza con la confacente costituzione sociale e politica, con il dominio
economico e politico della classe dei borghesi.
Sotto i nostri occhi si svolge un moto analogo. I rapporti borghesi di produzione e di scambio, i rapporti
borghesi di proprietà, la società borghese moderna che ha creato per incanto mezzi di produzione e di
scambio così potenti, rassomiglia al mago che non riesce più a dominare le potenze degli inferi da lui
evocate. Sono decenni ormai che la storia dell'industria e del commercio è soltanto storia della rivolta delle
forze produttive moderne contro i rapporti moderni della produzione, cioè contro i rapporti di proprietà che
costituiscono le condizioni di esistenza della borghesia e del suo dominio. Basti ricordare le crisi commerciali
che col loro periodico ritorno mettono in forse sempre più minacciosamente l'esistenza di tutta la società
borghese. Nelle crisi commerciali viene regolarmente distrutta non solo una gran parte dei prodotti ottenuti,
ma addirittura gran parte delle forze produttive già create. Nelle crisi scoppia una epidemia sociale che in
tutte le epoche anteriori sarebbe apparsa un assurdo: l'epidemia della sovrapproduzione. La società si trova
all'improvviso ricondotta a uno stato di momentanea barbarie; sembra che una carestia, una guerra generale
di sterminio le abbiano tagliato tutti i mezzi di sussistenza; l'industria, il commercio sembrano distrutti. E
perché? Perché la società possiede troppa civiltà, troppi mezzi di sussistenza, troppa industria, troppo
commercio. Le forze produttive che sono a sua disposizione non servono più a promuovere la civiltà
borghese e i rapporti borghesi di proprietà; anzi, sono divenute troppo potenti per quei rapporti e ne vengono
ostacolate, e appena superano questo ostacolo mettono in disordine tutta la società borghese, mettono in
pericolo l'esistenza della proprietà borghese. I rapporti borghesi sono divenuti troppo angusti per poter
contenere la ricchezza da essi stessi prodotta. - Con quale mezzo la borghesia supera le crisi? Da un lato, con
la distruzione coatta di una massa di forze produttive; dall'altro, con la conquista di nuovi mercati e con lo
sfruttamento più intenso dei vecchi. Dunque, con quali mezzi? Mediante la preparazione di crisi più generali
e più violente e la diminuzione dei mezzi per prevenire le crisi stesse.
A questo momento le armi che son servite alla borghesia per atterrare il feudalesimo si rivolgono contro la
borghesia stessa.
Ma la borghesia non ha soltanto fabbricato le armi che le porteranno la morte; ha anche generato gli uomini
che impugneranno quelle armi: gli operai moderni, i proletari.
Nella stessa proporzione in cui si sviluppa la borghesia, cioè il capitale, si sviluppa il proletariato, la classe
degli operai moderni, che vivono solo fintantoché trovano lavoro, e che trovano lavoro solo fintantoché il
loro lavoro aumenta il capitale. Questi operai che sono costretti a vendersi al minuto, sono una merce come
ogni altro articolo commerciale, e sono quindi esposti, come le altre merci, a tutte le alterne vicende della
concorrenza, a tutte le oscillazioni del mercato.
Con l'estendersi dell'uso delle macchine e con la divisione del lavoro, il lavoro dei proletari ha perduto ogni
carattere indipendente e con ciò ogni attrattiva per l'operaio. Egli diviene un semplice accessorio della
macchina, al quale si richiede una operazione manuale semplicissima, estremamente monotona e facilissima
ad imparare. Quindi le spese che causa l'operaio si limitano quasi esclusivamente ai mezzi di sussistenza dei
quali egli ha bisogno per il proprio mantenimento e per la riproduzione della sua specie. Ma il prezzo di una
merce, quindi anche quello del lavoro, è uguale ai suoi costi di produzione. Quindi il salario decresce nella
stessa proporzione in cui aumenta il tedio del lavoro. Anzi, nella stessa proporzione dell'aumento dell'uso
delle macchine e della divisione del lavoro, aumenta anche la massa del lavoro, sia attraverso l'aumento delle
ore di lavoro, sia attraverso l'aumento del lavoro che si esige in una data unità di tempo, attraverso
l'accresciuta celerità delle macchine e così via.
L'industria moderna ha trasformato la piccola officina del maestro artigiano patriarcale nella grande fabbrica
del capitalista industriale. Masse di operai addensate nelle fabbriche vengono organizzate militarmente. E
vengono poste, come soldati semplici dell'industria, sotto la sorveglianza di una completa gerarchia di
sottufficiali e ufficiali. Gli operai non sono soltanto servi della classe dei borghesi, dello stato dei borghesi ma
vengono asserviti giorno per giorno, ora per ora dalla macchina, dal sorvegliante, e soprattutto dal singolo
borghese fabbricante in persona. Questo dispotismo è tanto più meschino, odioso ed esasperante, quanto più
apertamente esso proclama come proprio fine ultimo il guadagno.
Quanto meno il lavoro manuale esige abilità ed esplicazione di forza, cioè quanto più si sviluppa l'industria
193
moderna, tanto più il lavoro degli uomini, viene soppiantato da quello delle donne [e dei fanciulli]. Per la
classe operaia non han più valore sociale le differenze di sesso e di età. Ormai ci sono soltanto strumenti di
lavoro che costano più o meno a seconda dell'età e del sesso.
Quando lo sfruttamento dell'operaio da parte del padrone di fabbrica è terminato in quanto all'operaio, viene
pagato il suo salario in contanti, si gettano su di lui le altre parti della borghesia, il padron di casa, il bottegaio,
il prestatore su pegno e cosi via.
Quelli che fino a questo momento erano i piccoli ordini medi, cioè i piccoli industriali, i piccoli commercianti e coloro che vivevano di piccole rendite, gli artigiani e i contadini, tutte queste classi precipitano
nel proletariato, in parte per il fatto che il loro piccolo capitale non è sufficiente per l'esercizio della grande
industria, e soccombe nella concorrenza con i capitalisti più forti, in parte per il fatto che la loro abilità viene
svalutata da nuovi sistemi di produzione. Così il proletariato si recluta in tutte le classi della popolazione.
Il proletariato passa attraverso diversi gradi di sviluppo. La sua lotta contro la borghesia comincia con la sua
esistenza.
Da principio singoli operai, poi gli operai di una fabbrica, poi gli operai di una branca di lavoro in un dato
luogo lottano contro il singolo borghese che li sfrutta direttamente.
Essi non dirigono i loro attacchi soltanto contro i rapporti borghesi di produzione, ma contro gli stessi
strumenti di produzione; distruggono le merci straniere che fan loro concorrenza, fracassano le macchione,
danno fuoco alle fabbriche, cercano di riconquistarsi la tramontata posizione del lavoratore medievale.
In questo stadio gli operai costituiscono una massa disseminata per tutto il paese e dispersa a causa della
concorrenza. La solidarietà di maggiori masse operaie non è ancora il risultato della loro propria unione, ma
della unione della borghesia, la quale, per il raggiungimento dei propri fini politici, deve mettere in
movimento tutto il proletariato, e per il momento può ancora farlo. Dunque, in questo stadio i proletari
combattono non i propri nemici, ma i nemici dei propri nemici, gli avanzi della monarchia assoluta, i proprietari fondiari, i borghesi non industriali, i piccoli borghesi. Così tutto il movimento della storia è concentrato nelle mani della borghesia; ogni vittoria raggiunta in questo modo è una vittoria della borghesia.
Ma il proletariato, con lo sviluppo dell'industria, non solo si moltiplica; viene addensato in masse più grandi,
la sua forza cresce, ed esso la sente di più. Gli interessi, le condizioni di esistenza all'interno del proletariato
si vanno sempre più agguagliando man mano che le macchine cancellano le differenze del lavoro e fanno
discendere quasi dappertutto il salario a un livello ugualmente basso. La crescente concorrenza dei borghesi
fra di loro e le crisi commerciali che ne derivano rendono sempre più oscillante il salario degli operai;
l'incessante e sempre più rapido sviluppo del perfezionamento delle macchine rende sempre più incerto il
complesso della loro esistenza; le collisioni fra il singolo operaio e il singolo borghese assumono sempre più
il carattere di collisioni di due classi. Gli operai cominciano col formare coalizioni contro i borghesi, e si
riuniscono per difendere il loro salario. Fondano perfino associazioni permanenti per approvvigionarsi in
vista di quegli eventuali sollevamenti. Qua e là la lotta prorompe in sommosse.
Ogni tanto vincono gli operai; ma solo transitoriamente. Il vero e proprio risultato delle loro lotte non è il
successo immediato ma il fatto che l'unione degli operai si estende sempre più. Essa è favorita dall'aumento
dei mezzi di comunicazione, prodotti dalla grande industria, che mettono in collegamento gli operai delle
differenti località. E basta questo collegamento per centralizzare in una lotta nazionale, in una lotta di classe,
le molte lotte locali che hanno dappertutto uguale carattere. Ma ogni lotta di classi è lotta politica. E quella
unione per la quale i cittadini del medioevo con le loro strade vicinali ebbero bisogno di secoli, i proletari
moderni con le ferrovie la attuano in pochi anni.
Questa organizzazione dei proletari in classe e quindi in partito politico torna ad essere spezzata ogni
momento dalla concorrenza fra gli operai stessi. Ma risorge sempre di nuovo, più forte, più salda, più
potente. Essa impone il riconoscimento in forma di legge di singoli interessi degli operai, approfittando delle
scissioni all'interno della borghesia. Così fu per la legge delle dieci ore di lavoro in Inghilterra.
In genere, i conflitti insiti nella vecchia società promuovono in molte maniere il processo evolutivo del
proletariato. La borghesia è sempre in lotta; da principio contro l'aristocrazia, più tardi contro le parti della
stessa borghesia i cui interessi vengono a contrasto col progresso dell'industria, e sempre contro la borghesia
di tutti i paesi stranieri. In tutte queste lotte essa si vede costretta a fare appello al proletariato, a valersi del
suo aiuto, e a trascinarlo così entro il movimento politico. Essa stessa dunque reca al proletariato i propri
194
elementi di educazione, cioè armi contro se stessa.
Inoltre, come abbiamo veduto, il progresso dell'industria precipita nel proletariato intere sezioni della classe
dominante, o per lo meno ne minaccia le condizioni di esistenza. Anch'esse arrecano al proletariato una
massa di elementi d'educazione.
Infine, in tempi nei quali la lotta delle classi si avvicina al momento decisivo, il processo di disgregazione
all'interno della classe dominante, di tutta la vecchia società, assume un carattere così violento, così aspro,
che una piccola parte della classe dominante si distacca da essa e si unisce alla classe rivoluzionaria, alla
classe che tiene in mano l'avvenire. Quindi, come prima una parte della nobiltà era passata alla borghesia, così
ora una parte della borghesia passa al proletariato; e specialmente una parte degli ideologi borghesi, che sono
riusciti a giungere alla intelligenza teorica del movimento storico nel suo insieme.
Fra tutte le classi che oggi stanno di contro alla borghesia, il proletariato soltanto è una classe realmente
rivoluzionaria. Le altre classi decadono e tramontano con la grande industria; il proletariato è il suo prodotto
più specifico.
Gli ordini medi, il piccolo industriale, il piccolo commerciante, l’artigiano, il contadino, combattono tutti la
borghesia, per premunire dalla scomparsa la propria esistenza come ordini medi. Quindi non sono
rivoluzionari ma conservatori. Anzi, sono reazionari, poiché cercano di far girare all'indietro la ruota della
storia. Quando sono rivoluzionari, sono tali in vista del loro imminente passaggio al proletariato, non difendono i loro interessi presenti, ma i loro interessi futuri, e abbandonano il proprio punto di vista, per
mettersi da quello del proletariato.
Il sottoproletariato, questa putrefazione passiva degli infimi strati della società, che in seguito a una
rivoluzione proletaria viene scagliato qua e là nel movimento, sarà più disposto, date tutte le sue condizioni
di vita, a lasciarsi comprare per mene reazionarie.
Le condizioni di esistenza della vecchia società sono già annullate nelle condizioni di esistenza del proletariato. Il proletario è senza proprietà; il suo rapporto con la moglie e figli non ha più nulla di comune con il
rapporto familiare borghese; il lavoro industriale moderno, il soggiogamento moderno al capitale, identico in
Inghilterra e in Francia, in America e in Germania, lo ha spogliato di ogni carattere nazionale. Leggi, morale,
religione sono per lui altrettanti pregiudizi borghesi, dietro i quali si nascondono altrettanti interessi borghesi.
Tutte le classi che si sono finora conquistato il potere hanno cercato di garantire la posizione di vita già
acquisita, assoggettando l'intera società alle condizioni della loro acquisizione. I proletari possono
conquistarsi le forze produttive della società soltanto abolendo il loro proprio sistema di appropriazione
avuto sino a questo momento, e per ciò stesso l'intero sistema di appropriazione che c'è stato finora. I proletari non hanno da salvaguardare nulla di proprio, hanno da distruggere tutta la sicurezza privata e tutte le
assicurazioni private che ci sono state fin qui.
Tutti i movimenti precedenti sono stati movimenti di minoranze, o avvenuti nell'interesse di minoranze. Il
movimento proletario è il movimento indipendente della immensa maggioranza nell'interesse della immensa
maggioranza. Il proletariato, lo strato più basso della società odierna, non può sollevarsi, non può drizzarsi,
senza che salti per aria l'intera soprastruttura degli strati che formano la società ufficiale.
La lotta del proletariato contro la borghesia è in un primo tempo lotta nazionale, anche se non sostanzialmente, certo formalmente. E’ naturale che il proletariato di ciascun paese debba anzitutto sbrigarsela con
la propria borghesia.
Delineando le fasi più generali dello sviluppo del proletariato, abbiamo seguito la guerra civile più o meno
latente all'interno della società attuale, fino al momento nel quale quella guerra erompe in aperta rivoluzione
e nel quale il proletariato fonda il suo dominio attraverso il violento abbattimento della borghesia.
Ogni società si è basata finora, come abbiam visto, sul contrasto fra classi di oppressori e classi di oppressi.
Ma, per poter opprimere una classe, le debbono essere assicurate condizioni entro le quali essa possa per lo
meno stentare la sua vita di schiava. Il servo della gleba, lavorando nel suo stato di servo della gleba, ha
potuto elevarsi a membro del comune, come il cittadino minuto, lavorando sotto il giogo dell’assolutismo
feudale, ha potuto elevarsi a borghese. Ma l'operaio moderno, invece di elevarsi man mano che l'industria
progredisce, scende sempre più al disotto delle condizioni della sua propria classe. L'operaio diventa povero,
e il pauperismo si sviluppa anche più rapidamente che la popolazione e la ricchezza. Da tutto ciò appare
manifesto che la borghesia non è in grado di rimanere ancora più a lungo la classe dominante della società e
195
di imporre alla società le condizioni di vita della propria classe come legge regolatrice. Non è capace di
dominare, perché non è capace di garantire l'esistenza al proprio schiavo neppure entro la sua schiavitù,
perché è costretta a lasciarlo sprofondare in una situazione nella quale, invece di esser da lui nutrita, essa è
costretta a nutrirlo. La società non può più vivere sotto la classe borghese, vale a dire la esistenza della classe
borghese non è più compatibile con la società.
La condizione più importante per l'esistenza e per il dominio della classe borghese è l'accumularsi della
ricchezza nelle mani di privati, la formazione e la moltiplicazione del capitale; condizione del capitale è il
lavoro salariato. Il lavoro salariato poggia esclusivamente sulla concorrenza degli operai tra di loro. Il
progresso dell'industria, del quale la borghesia è veicolo involontario e passivo, fa subentrare all'isolamento
degli operai risultante dalla concorrenza, la loro unione rivoluzionaria, risultante dall'associazione. Con lo
sviluppo della grande industria, dunque, vien tolto di sotto ai piedi della borghesia il terreno stesso sul quale
essa produce e si appropria i prodotti. Essa produce anzitutto i suoi seppellitori. Il suo tramonto e la vittoria
del proletariato sono del pari inevitabili.
Capitolo II: Proletari e comunisti
In che rapporto sono i comunisti con i proletari in genere?
I comunisti non sono un partito particolare di fronte agli altri partiti operai.
I comunisti non hanno interessi distinti dagli interessi di tutto il proletariato.
I comunisti non pongono principi speciali sui quali vogliano modellare il movimento proletario.
I comunisti si distinguono dagli altri partiti proletari solo per il fatto che da una parte essi mettono in rilievo e
fanno valere gli interessi comuni, indipendenti dalla nazionalità, dell'intero proletariato, nelle varie lotte
nazionali dei proletari; e dall'altra per il fatto che sostengono costantemente l'interesse del movimento
complessivo, attraverso i vari stadi di sviluppo percorsi dalla lotta fra proletariato e borghesia.
Quindi in pratica i comunisti sono la parte progressiva più risoluta dei partiti operai di tutti i paesi, e quanto
alla teoria essi hanno il vantaggio sulla restante massa del proletariato, di comprendere le condizioni,
l'andamento e i risultati generali del movimento proletario.
Lo scopo immediato dei comunisti è lo stesso di tutti gli altri partiti proletari: formazione del proletariato in
classe, abbattimento del dominio della borghesia, conquista del potere politico da parte del proletariato.
Le proposizioni teoriche dei comunisti non poggiano affatto su idee, su principi inventati o scoperti da questo
o quel riformatore del mondo.
Esse sono semplicemente espressioni generali di rapporti di fatto di una esistente lotta di classi, cioè di un
movimento storico che si svolge sotto i nostri occhi. L’abolizione di rapporti di proprietà esistiti fino a un
dato momento non è qualcosa di distintivo peculiare del comunismo.
Tutti i rapporti di proprietà sono stati soggetti a continui cambiamenti storici, a una continua alterazione
storica.
Per esempio, la rivoluzione francese abolì la proprietà feudale in favore di quella borghese.
Quel che contraddistingue il comunismo non è l'abolizione della proprietà in generale, bensì l’abolizione
della proprietà borghese.
Ma la proprietà privata borghese moderna è l'ultima e più perfetta espressione della produzione
dell’appropriazione dei prodotti che poggia su antagonismi di classe, sullo sfruttamento degli uni da parte
degli altri.
In questo senso i comunisti possono riassumere la loro teoria nella frase: abolizione della proprietà privata.
Ci si è rinfacciato, a noi comunisti, che vogliamo abolire la proprietà acquistata personalmente, frutto del
lavoro diretto e personale; la proprietà che costituirebbe il fondamento di ogni libertà, attività e autonomia
personale.
196
Proprietà frutto del proprio lavoro, acquistata, guadagnata con le proprie forze! Parlate della proprietà del
minuto cittadino, del piccolo contadino che ha preceduto la proprietà borghese? Non c'è bisogno che
l'aboliamo noi, l'ha abolita e la va abolendo di giorno in giorno lo sviluppo dell'industria.
O parlate della moderna proprietà privata borghese?
Ma il lavoro salariato, il lavoro del proletario, crea proprietà a questo proletario? Affatto. Il lavoro del
proletariato crea il capitale, cioè quella proprietà che sfrutta il lavoro salariato, che può moltiplicarsi solo a
condizione di generare nuovo lavoro salariato, per sfruttarlo di nuovo. La proprietà nella sua forma attuale si
muove entro l’antagonismo fra capitale e lavoro salariato. Esaminiamo i due termini di questo antagonismo.
Essere capitalista significa occupare nella produzione non soltanto una pura posizione personale ma una
posizione sociale.
Il capitale è un prodotto collettivo e può essere messo in moto solo mediante una attività comune di molti
membri, anzi in ultima istanza solo mediante l'attività comune di tutti i membri della società.
Dunque, il capitale non è una potenza personale; è una potenza sociale.
Dunque, se il capitale viene trasformato in proprietà collettiva, appartenente a tutti i membri della società,
non c’è trasformazione di proprietà personale in proprietà sociale. Si trasforma soltanto il carattere sociale
della proprietà. La proprietà perde il suo carattere di classe.
Veniamo al lavoro salariato.
Il prezzo medio del lavoro salariato è il minimo del salario del lavoro, cioè è la somma dei mezzi di
sussistenza che sono necessari per mantenere in vita l’operaio in quanto operaio. Dunque, quello che
l'operaio salariato s’appropria mediante la sua attività è sufficiente soltanto per riprodurre la sua nuda
esistenza. Noi non vogliamo affatto abolire questa appropriazione personale dei prodotti del lavoro per la
riproduzione della esistenza immediata, appropriazione che non lascia alcun residuo di profitto netto tale da
poter conferire potere sul lavoro altrui. Vogliamo eliminare soltanto il carattere miserabile di questa
appropriazione, nella quale l'operaio vive solo allo scopo di accrescere il capitale, e vive solo quel tanto che
esige l'interesse della classe dominante.
Nella società borghese il lavoro vivo è soltanto un mezzo per moltiplicare il lavoro accumulato. Nella società
comunista il lavoro accumulato è soltanto un mezzo per ampliare, per arricchire, per far progredire il ritmo
d'esistenza degli operai.
Dunque, nella società borghese il passato domina sul presente, nella società comunista il presente domina sul
passato. Nella società borghese il capitale è indipendente e personale, mentre l'individuo operante è
dipendente e impersonale.
E la borghesia chiama abolizione della personalità e della libertà l'abolizione di questo rapporto! E a ragione:
infatti, si tratta dell'abolizione della personalità, della indipendenza e della libertà del borghese.
Entro gli attuali rapporti di produzione borghesi per libertà s'intende il libero commercio, la libera
compravendita.
Ma scomparso il traffico, scompare anche il libero traffico. Le frasi sul libero traffico, come tutte le altre
bravate sulla libertà della nostra borghesia, hanno senso, in genere, soltanto rispetto al traffico vincolato,
rispetto al cittadino asservito del medioevo; ma non hanno senso rispetto alla abolizione comunista del
traffico, dei rapporti borghesi di produzione e della stessa borghesia.
Voi inorridite perché vogliamo abolire la proprietà privata. Ma nella vostra società attuale la proprietà
privata è abolita per i nove decimi dei suoi membri: la proprietà privata esiste proprio per il fatto che per i
nove decimi non esiste. Dunque voi ci rimproverate di voler abolire una proprietà che presuppone come
condizione necessaria la privazione della proprietà dell’enorme maggioranza della società.
In una parola, voi ci rimproverate di volere abolire la vostra proprietà. Certo, questo vogliamo.
Appena il lavoro non può più essere trasformato in capitale, in denaro, in rendita fondiaria, insomma in una
potenza sociale monopolizzabile, cioè, appena la proprietà personale non può più convertirsi in proprietà
borghese, voi dichiarate che è abolita la persona.
Dunque confessate che per persona non intendete nient’altro che il borghese, il proprietario borghese. Certo
197
questa persona deve essere abolita.
Il comunismo non toglie a nessuno il potere di appropriarsi prodotti della società, toglie soltanto il potere di
assoggettarsi il lavoro altrui mediante tale appropriazione.
Si è obiettato che con l’abolizione della proprietà privata cesserebbe ogni attività e prenderebbe piede una
pigrizia generale.
Da questo punto di vista, già da molto tempo la società borghese dovrebbe essere andata in rovina per
pigrizia, poiché in essa coloro che lavorano, non guadagnano, e quelli che guadagnano, non lavorano. Tutto
lo scrupolo sbocca nella tautologia che appena non c’è più capitale non c’è più lavoro salariato.
Tutte le obiezioni che vengono mosse al sistema comunista di appropriazione e di produzione dei prodotti
materiali, sono state anche estese alla appropriazione e alla produzione dei prodotti intellettuali: come il
cessare della proprietà di classe è per il borghese il cessare della produzione stessa, cosi il cessare della cultura
di classe è per lui identico alla fine della cultura in genere.
Quella cultura la cui perdita egli rimpiange, è per la enorme maggioranza la preparazione a diventar
macchine.
Ma non discutete con noi misurando l’abolizione della proprietà borghese sul modello delle vostre idee
borghesi di libertà, cultura, diritto e così via. Le vostre idee stesse sono prodotti dei rapporti borghesi di
produzione e di proprietà, come il vostro diritto è soltanto la volontà della vostra classe elevata a legge,
volontà il cui contenuto è dato nelle condizioni, materiali di esistenza della vostra classe.
Voi condividete con tutte le classi dominanti tramontate quell’idea interessata mediante la quale trasformate
in eterne leggi della natura e della ragione, da rapporti storici quali sono, transeunti nel corso della
produzione, i vostri rapporti di produzione e di proprietà. Non vi è più permesso di comprendere per la
proprietà borghese quel che comprendete per la proprietà antica e per la proprietà feudale.
Abolizione della famiglia! Anche i più estremisti si riscaldano parlando di questa ignominiosa intenzione dei
comunisti.
Su che cosa si basa la famiglia attuale, la famiglia borghese? Sul capitale, sul guadagno privato. Una
famiglia completamente sviluppata esiste soltanto per la borghesia: ma essa ha il suo complemento nella
coatta mancanza di famiglia del proletario e nella prostituzione pubblica.
La famiglia del borghese cade naturalmente col cadere di questo suo complemento ed entrambi scompaiono
con la scomparsa del capitale.
Ci rimproverate di voler abolire lo sfruttamento dei figli da parte dei genitori? Confessiamo questo delitto.
Ma voi dite che sostituendo l'educazione sociale a quella familiare noi aboliamo i rapporti più cari.
E anche la vostra educazione, non è determinata dalla società? Non è determinata dai rapporti sociali entro i
quali voi educate, dalla interferenza più o meno diretta o indiretta della società mediante la scuola e così via?
I comunisti non inventano l’influenza della società sull'educazione, si limitano a cambiare il carattere di tale
influenza, e strappano l'educazione all’influenza della classe dominante.
La fraseologia borghese sulla famiglia e sull’educazione, sull’affettuoso rapporto fra genitori e figli diventa
tanto più nauseante, quanto più, per effetto della grande industria, si lacerano per il proletariato tutti i vincoli
familiari, e i figli sono trasformati in semplici articoli di commercio e strumenti di lavoro.
Tutta la borghesia ci grida contro in coro: ma voi comunisti volete introdurre la comunanza delle donne.
Il borghese vede nella moglie un semplice strumento di produzione. Sente dire che gli strumenti di
produzione debbono essere sfruttati in comune e non può naturalmente farsi venire in mente se non che la
sorte della comunanza colpirà anche le donne.
Non sospetta neppure che si tratta proprio di abolire la posizione delle donne come semplici strumenti di
produzione.
Del resto non c'è nulla di più ridicolo del moralissimo orrore che i nostri borghesi provano per la pretesa
comunanza ufficiale delle donne fra i comunisti. I comunisti non hanno bisogno d'introdurre la comunanza
delle donne; essa è esistita quasi sempre.
198
I nostri borghesi, non paghi d'avere a disposizione le mogli e le figlie dei loro proletari, per non parlare
neppure della prostituzione ufficiale, trovano uno dei loro divertimenti principali nel sedursi reciprocamente
le loro mogli.
In realtà, il matrimonio borghese è la comunanza delle mogli. Tutt’al più ai comunisti si potrebbe rimproverare di voler introdurre una comunanza delle donne ufficiale e franca al posto di una comunanza delle
donne ipocritamente dissimulata. Del resto è ovvio che, con l'abolizione dei rapporti attuali di produzione,
scompare anche quella comunanza delle donne che ne deriva, cioè la prostituzione ufficiale e non ufficiale.
Inoltre, si è rimproverato ai comunisti ch'essi vorrebbero abolire la patria, la nazionalità .
Gli operai non hanno patria. Non si può togliere loro quello che non hanno. Poiché la prima cosa che il
proletariato deve fare è di conquistarsi il dominio politico, di elevarsi a classe nazionale, di costituire se
stesso in nazione, è anch'esso ancora nazionale, seppure non certo nel senso della borghesia.
Le separazioni e gli antagonismi nazionali dei popoli vanno scomparendo sempre più già con lo sviluppo
della borghesia, con la libertà di commercio, col mercato mondiale, con l'uniformità della produzione
industriale e delle corrispondenti condizioni d'esistenza.
Il dominio del proletariato li farà scomparire ancor di più. Una delle prime condizioni della sua
emancipazione è l'azione unita, per lo meno dei paesi civili.
Lo sfruttamento di una nazione da parte di un’altra viene abolito nella stessa misura che viene abolito lo
sfruttamento di un individuo da parte di un altro.
Con l'antagonismo delle classi all'interno delle nazioni scompare la posizione di reciproca ostilità delle
nazioni.
Non meritano d'essere discusse in particolare le accuse che si fanno al comunismo da punti di vista religiosi,
filosofici e ideologici in genere.
C'è bisogno di profonda comprensione per capire che anche le idee, le opinioni e i concetti, insomma, anche
la coscienza degli uomini cambia col cambiare delle loro condizioni di vita, delle loro relazioni sociali, della
loro esistenza sociale?
Cos'altro dimostra la storia delle idee, se non che la produzione intellettuale si trasforma assieme a quella
materiale? Le idee dominanti di un'epoca sono sempre state soltanto le idee della classe dominante.
Si parla di idee che rivoluzionano un'intera società; con queste parole si esprime semplicemente il fatto che
entro la vecchia società si sono formati gli elementi di una nuova, e che la dissoluzione delle vecchie idee
procede di pari passo con la dissoluzione dei vecchi rapporti d'esistenza.
Quando il mondo antico fu al tramonto, le antiche religioni furono vinte dalla religione cristiana. Quando nel
secolo XVIII le idee cristiane soggiacquero alle idee dell'illuminismo, la società feudale dovette combattere
la sua ultima lotta con la borghesia allora rivoluzionaria. Le idee della libertà di coscienza e della libertà di
religione furono soltanto l'espressione del dominio della libera concorrenza nel campo della coscienza.
Ma, si dirà, certo che nel corso dello svolgimento storico le idee religiose, morali, filosofiche, politiche,
giuridiche si sono modificate. Però in questi cambiamenti la religione, la morale, la filosofia, la politica, il
diritto si sono sempre conservati.
Inoltre vi sono verità eterne, come la libertà, la giustizia e cosi via, che sono comuni a tutti gli stati i della
società. Ma il comunismo abolisce le verità eterne, abolisce la religione, la morale, invece di trasformarle;
quindi il comunismo si mette in contraddizione con tutti gli svolgimenti storici avuti sinora.
A che cosa si riduce quest’accusa? La storia di tutta quanta la società che c'è stata fino ad oggi s’è mossa in
contrasti di classe che hanno avuto un aspetto differente a seconda delle differenti epoche.
Lo sfruttamento d'una parte della società per opera dell'altra parte è dato di fatto comune a tutti i secoli
passati, qualunque sia la forma ch'esso abbia assunto. Quindi, non c'è da meravigliarsi che la coscienza
sociale di tutti i secoli si muova, nonostante ogni molteplicità e differenza, in certe forme comuni: forme di
coscienza, che si dissolvono completamente soltanto con la completa scomparsa dell'antagonismo delle
classi.
La rivoluzione comunista è la più radicale rottura con i rapporti tradizionali di proprietà; nessuna meraviglia
199
che nel corso del suo sviluppo si rompa con le idee tradizionali nella maniera più radicale.
Ma lasciamo stare le obiezioni della borghesia contro il comunismo.
Abbiamo già visto sopra che il primo passo sulla strada della rivoluzione operaia consiste nel fatto che il
proletariato s’eleva a classe dominante, cioè nella conquista della democrazia.
Il proletariato adoprerà il suo dominio politico per strappare a poco a poco alla borghesia tutto il capitale, per
accentrare tutti gli strumenti di produzione nelle mani dello stato, cioè del proletariato organizzato come
classe dominante, e per moltiplicare al più presto possibile la massa delle forze produttive.
Naturalmente, ciò può avvenire, in un primo momento, solo mediante interventi dispotici nel diritto di
proprietà e nei rapporti borghesi di produzione e cioè per mezzo di misure che appaiono insufficienti e poco
consistenti dal punto di vista dell'economia: ma che nel corso del movimento si spingono al di là dei propri
limiti e sono inevitabili come mezzi per il rivolgimento dell'intero sistema di produzione.
Queste misure saranno naturalmente differenti a seconda dei differenti paesi.
Tuttavia, nei paesi più progrediti potranno essere applicati quasi generalmente i provvedimenti seguenti:
1. Espropriazione della proprietà fondiaria ed impiego della rendita fondiaria per le spese dello stato.
2. Imposta fortemente progressiva.
3. Abolizione del diritto di successione.
4. Confisca della proprietà di tutti gli emigranti e ribelli.
5. Accentramento del credito in mano delle stato mediante una banca nazionale con capitale dello stato e
monopolio esclusivo.
6. Accentramento di tutti i mezzi di trasporto in mano allo stato.
7. Moltiplicazione delle fabbriche nazionali, degli strumenti di produzione, dissodamento e miglioramento
dei terreni secondo un piano collettivo.
8. Eguale obbligo di lavoro per tutti, costituzione di eserciti industriali, specialmente per l'agricoltura.
9. Unificazione dell'esercizio dell'agricoltura e della industria, misure atte ad eliminare gradualmente
l'antagonismo fra città e campagna.
10. Istruzione pubblica e gratuita di tutti i fanciulli. Eliminazione del lavoro dei fanciulli nelle fabbriche nella
sua forma attuale. Combinazione dell'istruzione con la produzione materiale e cosi via.
Quando le differenze di classe saranno scomparse nel corso dell'evoluzione, e tutta la produzione sarà
concentrata in mano agli individui associati, il pubblico potere perderà il suo carattere politico. In senso
proprio, il potere politico è il potere di una classe organizzato per opprimerne un’altra. Il proletariato,
unendosi di necessità in classe nella lotta contro la borghesia, facendosi classe dominante attraverso una
rivoluzione, ed abolendo con la forza, come classe dominante, gli antichi rapporti di produzione, abolisce
insieme a quei rapporti di produzione le condizioni di esistenza dell'antagonismo di classe, cioè abolisce le
condizioni d'esistenza delle classi in genere, e cosi anche il suo proprio dominio in quanto classe.
Alla vecchia società borghese con le sue classi e i suoi antagonismi fra le classi subentra una associazione in
cui il libero sviluppo di ciascuno è condizione del libero sviluppo di tutti.
[ … si salta il Capitolo III: Letteratura socialista e comunista …]
Capitolo IV: Posizione dei comunisti di fronte ai diversi partiti di opposizione
Da quanto s'è detto nel secondo capitolo appare ovvio quale sia il rapporto dei comunisti coi partiti operai già
costituiti, cioè il loro rapporto coi cartisti in Inghilterra e coi riformatori agrari nell'America del Nord.
200
I comunisti lottano per raggiungere i fini e gli interessi immediati della classe operaia, ma nel movimento
presente rappresentano in pari tempo l'avvenire del movimento. In Francia i comunisti si alleano al partito
socialista-democratico contro la borghesia conservatrice e radicale, senza per questo rinunciare al diritto d'un
contegno critico verso le frasi e le illusioni provenienti dalla tradizione rivoluzionaria.
In Isvizzera essi appoggiano i radicali, senza disconoscere che questo partito è costituito da elementi
contraddittori, in parte da socialisti democratici in senso francese, in parte da borghesi radicali.
Fra i Polacchi, i comunisti appoggiano il partito che fa d'una rivoluzione agraria la condizione della
liberazione nazionale. Lo stesso partito che promosse l'insurrezione di Cracovia del 1846.
In Germania il partito comunista combatte insieme alla borghesia contro la monarchia assoluta, contro la
proprietà fondiaria feudale e il piccolo borghesume, appena la borghesia prende una posizione rivoluzionaria.
Però il partito comunista non cessa nemmeno un istante di preparare e sviluppare fra gli operai una coscienza
quanto più chiara è possibile dell'antagonismo ostile fra borghesia e proletariato, affinché i lavoratori
tedeschi possano subito rivolgere, come altrettante armi contro la borghesia, le condizioni sociali e politiche
che la borghesia deve creare con il suo dominio, affinché subito dopo la caduta delle classi reazionarie in
Germania, cominci la lotta contro la borghesia stessa.
I comunisti rivolgono la loro attenzione soprattutto alla Germania, perché la Germania è alla vigilia d'una
rivoluzione borghese, e perché essa compie questo rivolgimento in condizioni di civiltà generale europea più
progredite, e con un proletariato molto più evoluto che non l’Inghilterra nel decimosettimo e la Francia nel
decimottavo secolo; perché dunque la rivoluzione borghese tedesca può essere soltanto l'immediato preludio
d'una rivoluzione proletaria.
In una parola: i comunisti appoggiano dappertutto ogni movimento rivoluzionario diretto contro le situazioni
sociali e politiche attuali.
Entro tutti questi movimenti essi mettono in rilievo, come problema fondamentale del movimento, il
problema della proprietà, qualsiasi forma, più o meno sviluppata, esso possa avere assunto.
Infine, i comunisti lavorano dappertutto al collegamento e all'intesa dei partiti democratici di tutti i paesi.
I comunisti sdegnano di nascondere le loro opinioni e le loro intenzioni. Dichiarano apertamente che i loro
fini possono esser raggiunti soltanto col rovesciamento violento di tutto l'ordinamento sociale finora
esistente. Le classi dominanti tremino al pensiero d’una rivoluzione comunista. I proletari non hanno da
perdervi che le loro catene. Hanno un mondo da guadagnare.
PROLETARI DI TUTTI I PAESI, UNITEVI!
201
Karl Marx
TESI SU FEUERBACH
1
Il difetto principale d'ogni materialismo fino ad oggi (compreso quello di Feuerbach) è che l'oggetto
[Gegenstand], la realtà, la sensibilità, vengono concepiti solo sotto la forma dell'obietto [Objekt] o
dell'intuizione; ma non come attività sensibile umana, prassi; non soggettivamente. Di conseguenza il lato
attivo fu sviluppato astrattamente, in opposizione al materialismo, dall'idealismo, che naturalmente non
conosce l'attività reale, sensibile in quanto tale. Feuerbach vuole oggetti sensibili, realmente distinti dagli
oggetti del pensiero; ma egli non concepisce l'attività umana stessa come attività oggettiva. Egli, perciò,
nell'«Essenza del cristianesimo», considera come veramente umano soltanto l'atteggiamento teoretico,
mentre la prassi è concepita e fissata solo nel suo modo di apparire sordidamente giudaico. Egli non
comprende, perciò, il significato dell'attività « rivoluzionaria », « pratico-critica ».
2
La questione se al pensiero umano spetti una verità oggettiva, non è questione teoretica bensì una questione
pratica. Nella prassi l'uomo deve provare la verità cioè la realtà e il potere, il carattere immanente del suo
pensiero. La disputa sulla realtà o non-realtà del pensiero - isolato dalla prassi - è una questione meramente
scolastica.
3
La dottrina materialistica della modificazione delle circostanze e dell'educazione dimentica che le
circostanze sono modificate dagli uomini e che l'educatore stesso deve essere educato. Essa è costretta quindi
a separare la società in due parti, delle quali l'una è sollevata al di sopra della società.
La coincidenza del variare delle circostanze dell'attività umana, o auto-trasformazione, può essere concepita
o compresa razionalmente solo come prassi rivoluzionaria.
4
Feuerbach prende le mosse dal fatto dell'auto-estraniazione religiosa, della duplicazione del mondo in un
mondo religioso e in uno mondano. Il suo lavoro consiste nel risolvere il mondo religioso nel suo
202
fondamento mondano. Ma il fatto che il fondamento mondano si distacchi da se stesso e si costruisca nelle
nuvole come un regno fisso ed indipendente, è da spiegarsi soltanto con l'auto-dissociazione e con l'autocontraddittorietà di questo fondamento mondano. Questo fondamento deve essere perciò in se stesso tanto
compreso nella sua contraddizione, quanto rivoluzionato praticamente. Pertanto, dopo che, per esempio, la
famiglia terrena è stata scoperta come il segreto della sacra famiglia, è proprio la prima a dover essere
dissolta teoricamente e praticamente.
5
Feuerbach, non soddisfatto del pensiero astratto, vuole l'intuizione; ma egli non concepisce la sensibilità
come attività pratica umana-sensibile.
6
Feuerbach risolve l'essenza religiosa nell'essenza umana. Ma l'essenza umana non è qualcosa di astratto che
sia immanente all'individuo singolo. Nella sua realtà essa è l'insieme dei rapporti sociali.
Feuerbach, che non penetra nella critica di questa essenza reale, è perciò costretto:
1. ad astrarre dal corso della storia, a fissare il sentimento religioso per sé, ed a presupporre un individuo
umano astratto - isolato.
2. L'essenza può dunque esser concepita soltanto come « genere », cioè come universalità interna, muta,
che leghi molti individui naturalmente.
7
Feuerbach non vede dunque che il « sentimento religioso » è esso stesso un prodotto sociale e che l'individuo
astratto, che egli analizza, appartiene ad una forma sociale determinata.
8
Tutta la vita sociale è essenzialmente pratica. Tutti i misteri che trascinano la teoria verso il misticismo
trovano la loro soluzione razionale nella prassi umana e nella comprensione di questa prassi.
9
Il punto più alto cui giunge il materialismo intuitivo, cioè il materialismo che non intende la sensibilità come
attività pratica, è l'intuizione degli individui singoli e della società borghese.
10
Il punto di vista del vecchio materialismo è la società borghese, il punto di vista del materialismo nuovo è la
società umana o l'umanità sociale.
11
I filosofi hanno soltanto diversamente interpretato il mondo; si tratta di trasformarlo.
Karl Marx, Tesi su Feuerbach, Riuniti
203
Arthur Schopenhauer
IL MONDO COME VOLONTA’ E RAPPRESENTAZIONE
«Il mondo è mia rappresentazione»: - questa è una verità che vale in rapporto a ciascun essere vivente e
conoscente, sebbene l'uomo soltanto sia capace d'accoglierla nella riflessa, astratta coscienza: e s'egli
veramente fa questo, con ciò è penetrata in lui la meditazione filosofica. Per lui diventa allora chiaro e ben
certo, ch'egli non conosce né il sole né la terra, ma appena un occhio, il quale vede un sole, una mano, la
quale sente una terra: che il mondo da cui è circondato non esiste se non come rappresentazione, vale a dire
sempre e dappertutto in rapporto ad un altro, a colui che rappresenta, il quale è lui stesso. Se mai una verità
può venire enunciata a priori è appunto questa: essendo l'espressione di quella forma d'ogni possibile e
immaginabile esperienza, la quale è più universale che tutte le altre forme, più che tempo, spazio e causalità;
poi che tutte queste presuppongono appunto quella. [ ... ] Nessuna verità è adunque più certa, più
indipendente da ogni altra, nessuna ha minor bisogno d'essere provata, di questa: che tutto ciò che esiste per
conoscenza, - adunque questo mondo intero, - è solamente oggetto in rapporto al soggetto, intuizione di chi
intuisce: in una parola, rappresentazione. [ ... ] Tutto quanto è compreso e può esser compreso nel mondo,
deve inevitabilmente aver per condizione il soggetto, ed esiste solo per il soggetto. Il mondo è
rappresentazione. [ ... ]
Che nondimeno questa considerazione, malgrado la sua verità, sia unilaterale, e quindi ottenuta mediante
un'astrazione arbitraria, è fatto palese a ciascuno dall'intima riluttanza ch’ei prova a concepire il mondo
soltanto come sua pura rappresentazione; al quale concetto d'altra parte non può mai e poi mai sottrarsi. Ma
l'unilateralità di questa considerazione verrà integrata [ ... ] con un'altra verità, la quale [ ... ] deve apparire
molto grave e per ognuno, se non proprio paurosa, almeno meritevole di riflessione: ossia questa, che egli
appunto può dire e deve dire: «il mondo è la mia volontà». [ ... ]
Quello che tutto conosce, e da nessuno è conosciuto, è soggetto. Esso è dunque che porta in sé il mondo; è
l'universale, ognora presupposta condizione d'ogni fenomeno di ogni oggetto: perché ciò che esiste, non
esiste se non per il soggetto. Questo soggetto ciascuno trova in sé stesso; ma tuttavia solo in quanto conosce,
non in quanto è egli medesimo oggetto di conoscenza. Oggetto è già invece il suo corpo: ed anch'esso perciò,
secondo questo modo di vedere, chiamiamo rappresentazione. Invero il corpo è oggetto fra oggetti, e
sottoposto alle leggi degli oggetti, sebbene sia oggetto immediato. [ ... ]
Il mondo come rappresentazione, adunque - e noi non consideriamo qui se non sotto questo aspetto - ha due
metà essenziali, necessarie e inseparabili. L'una è l'oggetto, di cui sono forma spazio e tempo, mediante i
quali si ha la pluralità. Ma l’altra metà, il soggetto, non sta nello spazio e nel tempo: perché essa è intera e
indivisa in ogni essere rappresentante; perciò anche un solo di questi esseri, con l'oggetto, integra il mondo
come rappresentazione, si appieno quanto i milioni d'esseri esistenti. Ma, se anche solo quell’unico svanisse,
cesserebbe d'esistere pure il mondo come rappresentazione. Queste metà sono perciò inseparabili, anche per
204
il pensiero; perché ciascuna di esse consegue solo mediante e per l'altra significazione ed esistenza, ciascuna
esiste con l'altra e con lei dilegua. Esse si limitano a vicenda direttamente: dove l'oggetto comincia, finisce il
soggetto. [ ... ]
In verità, il senso tanto cercato di questo mondo, che mi sta davanti come mia rappresentazione - oppure il
passaggio da esso, in quanto pura rappresentazione del soggetto conoscente, a quel che ancora può essere
oltre di ciò - non si potrebbe assolutamente mai raggiungere, se l'indagatore medesimo non fosse nient'altro
che il puro soggetto conoscente (alata testa d'angelo senza corpo). Ma egli ha in quel mondo le proprie radici,
vi si trova come individuo: ossia il suo conoscere, che è condizione dell'esistenza del mondo intero in quanto
rappresentazione, avviene in tutto e per tutto mediante un corpo; le cui affezioni [ ... ] sono per l’intelletto il
punto di partenza dell’intuizione di quel mondo. Codesto corpo è per il puro soggetto conoscente, in quanto
tale, una rappresentazione come tutte le altre, un oggetto fra oggetti: i suoi movimenti, le sue azioni non sono
da lui, sotto questo rispetto, conosciute altrimenti che le modificazioni di tutti gli altri oggetti intuitivi; e gli
sarebbero egualmente estranee ed incomprensibili, se il loro senso non gli fosse per avventura svelato in
qualche modo affatto diverso. In caso contrario, vedrebbe la propria condotta regolarsi con la costanza d'una
legge naturale sui motivi che le si offrono, proprio come le modificazioni degli altri oggetti sono regolate da
cause, stimoli, motivi. [ ... ]
Ma le cose non stanno così: al soggetto conoscente, che appare come individuo, è data la parola dell'enigma;
e questa parola è volontà. Questa, e questa sola, gli dà la chiave per spiegare il suo proprio fenomeno, gli
manifesta il senso, gli mostra l’intimo congegno del suo essere, del suo agire, dei suoi movimenti. Al
soggetto della conoscenza, il quale per la sua identità col proprio corpo ci si presenta come individuo, questo
corpo è dato in due modi affatto diversi: è dato come rappresentazione nell'intuizione dell'intelletto, come
oggetto fra oggetti, e sottomesso alle leggi di questi; ma è dato contemporaneamente e che in tutt'altro modo,
ossia come quell'alcunché direttamente conosciuto da ciascuno, che la parola volontà esprime. Ogni vero atto
della sua volontà è immediatamente e ineluttabilmente anche un moto del suo corpo: egli non può voler
davvero senz'accorgersi insieme ch'esso appare come movimento del corpo. L'atto volitivo e l'azione del
corpo non sono due - stati conosciuti oggettivamente, che il vincolo della causalità collega; non stanno fra
loro nella relazione di causa ed effetto: bensì sono un tutto unico, soltanto dati in due modi affatto diversi,
nell'uno direttamente, e nell'altro mediante l'intuizione per l'intelletto. L'azione del corpo non è altro, che
l'atto del volere oggettivato, ossia penetrato nell'intuizione. [ ... ]
Attraverso tutte queste considerazioni, chi può aver giunto anche in abstracto - quindi con chiarezza e
certezza - la conoscenza che ciascuno ha direttamente in concreto come sentimento: che cioè l'essenza in sé
del nostro proprio fenomeno (il quale come rappresentazione ci si offre sia nelle nostre azioni, sia nel
permanente loro substrato: il nostro corpo) è la nostra volontà; e che questa costituisce l'elemento immediato
della nostra coscienza. [ ... ] chi, io dico, è arrivato con me a desta persuasione, troverà che questa è per lui
come la - per conoscere l'intima essenza della natura intera; applicandola anche a quei fenomeni che non gli
son dati, come i suoi propri, in conoscenza immediata oltre che mediata, ma quest'ultima, quindi solo
unilateralmente, come semplice presentazione. Non soltanto in quei fenomeni che sono affatto simili al suo
proprio - negli uomini e negli animali - egli dovrà riconoscere, come più intima essenza, quella medesima
volontà; ma la riflessione prolungata lo condurrà a conoscer che la forza che ferve e vegeta nella pianta, e
quella per forma il cristallo, e quella che volge la bussola al polo, e quella che scocca nel contatto di due
metalli eterogenei, e quella rivela nelle affinità elettive della materia, come ripulsione ed attrazione,
separazione e combinazione; e da ultimo perfino la gravità, che in ogni materia sì potentemente agisce e
attrae la pietra alla terra, come la terra verso il sole - tutte queste in apparenza diverse conoscerà nell'intima
essenza come unica forza, come quella forza a lui più profondamente e meglio nota d'ogni altra cosa, che là,
dove più chiaramente si produce, prende nome di volontà. Solo quest'impiego della riflessione non ci fa più
arrestare al fenomeno, bensì ci conduce fino alla cosa in sé. Fenomeno è rappresentazione, e non più: ogni
rappresentazione, di qualsivoglia specie, ogni oggetto è fenomeno. Cosa in sé invece è solamente la volontà:
ella, come tale, non è punto rappresentazione, bensì qualcosa toto genere differente da questa: ogni
rappresentazione, ogni oggetto, è fenomeno, estrinsecazione visibile, obiettità di lei. Ella è l'intimo essere, il
nocciolo di ogni singolo, ed egualmente del Tutto: ella si manifesta in ogni cieca forza naturale; ella anche si
manifesta nella meditata condotta dell'uomo. La gran differenza, che separa la forza cieca dalla meditata
condotta, tocca il grado della manifestazione, non l'essenza della volontà che si manifesta. [ ... ]
205
La volontà come cosa in sé [ ... ] sta fuor del dominio del principio di ragione in tutte le sue forme, ed è
quindi assolutamente senza ragione, sebbene ogni sua manifestazione sia in tutto sottomessa al principio di
ragione; sta fuori inoltre di ogni pluralità, sebbene le sue manifestazioni nel tempo e nello spazio siano
innumerevoli. Ella è una, ma non com'è uno un oggetto, la cui unità può esser conosciuta solo in contrasto
con la possibile pluralità; e nemmeno com'è uno un concetto, che è sorto dalla pluralità mediante astrazione:
bensì è una in quanto sta fuori del tempo e dello spazio, fuori del principium individuationis, ossia della
possibile pluralità. [ ... ]
Un ultimo passo ci rimane da fare: l'estensione del nostro sistema anche a quelle forze, che agiscono nella
natura secondo leggi generali ed immutabili, conformemente alle quali si producono i movimenti di tutti quei
corpi che, affatto privi di organi, non sono sensibili allo stimolo e non possono conoscere motivi. La chiave
per l'intendimento delle cose nella loro sostanza in sé - chiave che sola poteva darci l'immediata cognizione
della nostra propria essenza - dobbiamo ora applicarla anche a questi fenomeni del mondo inorganico, che
sono i più remoti da noi stessi. Ora, se noi li osserviamo con occhio indagatore; se vediamo il veemente,
incessante impeto, con cui le acque precipitano verso il profondo; la costanza, con cui il magnete torna
sempre a volgersi al polo; lo slancio, con cui il ferro corre alla calamita; la vivacità, con cui i poli elettrici
tendono a congiungersi, vivacità che viene aumentata dagli ostacoli, proprio come accade ai desideri umani;
se vediamo il cristallo formarsi quasi istantaneamente, con tanta regolarità di conformazione, la quale
evidentemente è solo una risoluta e precisa tendenza verso differenti direzioni, irrigidita e fissata d'un tratto;
se osserviamo la scelta, con cui i corpi sottratti ai vincoli della solidità, e fatti liberi dallo stato liquido, si
cercano, si sfuggono, si congiungono, si separano; se infine sentiamo direttamente che un peso, la cui
tendenza verso terra sia trattenuta dal nostro corpo, grava e preme incessantemente su di questo seguendo la
propria unica tendenza; - non ci costerà un grande sforzo di fantasia il riconoscere, anche a sì gran distanza.
la nostra medesima essenza: quella stessa, che in noi opera seco suoi fini alla luce della conoscenza, mentre
qui, nei più deboli de' suoi fenomeni, opera in modo cieco, sordo, unilaterale ed invariabile. Ella è sempre
una e sempre la stessa in così diverse manifestazioni, e perciò [ ... ] in queste ed in quelle deve prendere il
nome di volontà: il quale contrassegna ciò che è essenza di ciascuna cosa nel mondo, ed unica sostanza di
ogni meno. [ ... ]
In primo luogo desidero, che si richiami qui la considerazione con cui abbiamo chiuso il secondo libro,
indottivi dalla manda colà formulata, intorno alla meta e allo scopo della volontà. Invece di trovar risposta, ci
risultò evidente che la volontà, in tutti i gradi del suo fenomeno, dai più bassi a i più manca affatto d'un fine
ultimo e d'uno scopo; continuamente aspira, perché aspirare è la sua unica essenza, a cui non termine alcun
fine raggiunto; non è quindi capace d'alcun pagamento finale, e solo per una costrizione può esser trattenuta,
ma in sé si estende nell'infinito. [ ... ]
Da tempo conoscemmo quest'aspirazione, costituente r di ogni cosa, come identica e tutt'una con ciò che in
noi, dosa si manifesta con la maggior chiarezza, alla luce della più piena coscienza, si chiama volontà. La sua
compressione m te un ostacolo, che si mette fra lei e una sua mira, chiamiamo quindi dolore; viceversa il suo
conseguir la mira chiamiamo pagamento, benessere, felicità. Cotali denominazioni possiamo pur riferire ai
fenomeni del mondo privo di conoscenza, più boli di grado, ma nell'essenza identici. Questi vedremo presi
da perenne soffrire, senza durabile felicità. Perché aspirare proviene da mancanza, da insoddisfazione del
proprio stato: è quindi dolore, finché non sia appagato; ma nessun appagamento è durevole, anzi non è che il
principio di una nuova aspirazione. L'aspirazione vediamo ovunque in più forme compressa, diuturnamente
pugnando; quindi sempre come dolore. Non ha termine l'aspirare, non ha dunque misura e termine il soffrire.
Ma quel che così sol con più acuta attenzione ed a fatica scopriamo nella natura priva di conoscenza, limpido
ci appare nella conoscente, nella vita animale; il cui perenne soffrire è facile a dimostrarsi. E, senza indugiare
in codesto grado intermedio, ci volgeremo là, dove, dalla più luminosa conoscenza rischiarato, tutto nel
modo più chiaro si disvela: nella vita dell’uomo. Imperocché come il fenomeno della volontà diventa più
compiuto, così diventa anche più e più palese il dolore. Nella pianta non è ancora sensibilità, e quindi punto
dolore: un grado certamente tenue di sofferenza è insito negli animali infimi, infusori e radiolari; perfino
negl'insetti è la capacità di sentire e di soffrire ancor limitata: solo col perfetto sistema nervoso dei vertebra ti
la si presenta in alto grado, e sempre più al. quanto più l'intelligenza si sviluppa. Nella stessa misura dunque,
onde la conoscenza perviene alla chiarezza, e la coscienza si eleva, cresce anche il tormento, che raggiunge
perciò suo massimo grado nell'uomo; e anche qui tanto più, quanto più l'uomo distintamente conosce ed è
più, intelligente. Quegli, in cui vive il genio, soffre più di tutti. [ ... ]
206
Già vedemmo la natura priva di conoscenza avere per suo rimo essere un continuo aspirare, senza meta e
senza posa; più evidente ci apparisce quest'aspirazione considerando l’animale e l'uomo. Volere e aspirare è
tutta l'essenza loro, affatto simile a inestinguibile sete. Ma la base d'ogni volere è bio, mancanza, ossia
dolore, a cui l'uomo è vincolato dall'oe, per natura. Venendogli invece a mancare oggetti del desiderio,
quando questo è tolto via da un troppo facile appagato, tremendo vuoto e noia l'opprimono: cioè la sua natura
suo essere medesimo gli diventano intollerabile peso. La sua vita oscilla quindi come un pendolo, di qua e di
là, tra il dolore e la noia, che sono in realtà i suoi veri elementi costitutivi. [ ... ] Ciò ch'è universalmente
ammesso come positivo, che noi - amiamo l'ente, e la cui negazione è espressa dal concetto del a nel suo
significato più universale, è appunto il mondo della rappresentazione, che io ho indicato come oggettità,
specchio della volontà. E questa volontà e questo mondo sono poi anche noi stessi, e al mondo appartiene la
rappresentazione in genere, come una delle sue facce: forma di tale rappresentazione sono spazio e tempo,
quindi ogni cosa, che sotto questo riguardo esista, dev'esser posta in qualche luogo e in qualche tempo.
Negazione, soppressione, rivolgimento della volontà è anche soppressione e dileguamento del mondo, ch'è
specchio di quella. Se non vediamo più la volontà in codesto specchio, invano ci domanderemo dove si sia
rivolta; e lamentiamo allora ch'ella non abbia più né dove né quando, e sia svanita ne nulla.
Un punto di vista invertito, qualora fosse possibile per noi. scambierebbe i segni, mostrando come il nulla ciò
che per noi è l'ente, e quel nulla come l'ente. Ma, finché noi medesimi siamo la volontà di vivere, il nulla può
esser conosciuto da noi solo negativamente, perché l'antico principio d'Empedocle, potere il simile esser
conosciuto soltanto dal simile, ci toglie qui ogni possibilità di conoscenza. [ ... ]
Quando si volesse tuttavia insistere nel pretendere in qualche modo una cognizione positiva di ciò, che la
filosofia può esprimere solo negativamente, come negazione della volontà. non potremmo far altro che
richiamarci allo stato di cui fecero esperienza tutti coloro, i quali pervennero alla completa negazione della
volontà; stato al quale si san dati i nomi di estasi, rapimento, illuminazione, unione con Dio, e cosÌ via. Ma
tale stato non può chiamarsi cognizione vera e propria, perché non ha più la forma del soggetto e
dell'oggetto, e inoltre è accessibile solo all'esperienza diretta, né può essere comunicato altrui. [ ... ]
Davanti a noi non resta invero che il nulla. Ma quel che si ribella contro codesto dissolvimento nel nulla, la
nostra natura. è anch'essa nient'altro che la volontà di vivere. Volontà di vivere siamo noi stessi, volontà di
vivere è il nostro mondo. L'aver noi tanto orrore del nulla, non è se non un'altra manifestazione del come
avidamente vogliamo la vita, e niente siamo se non questa volontà, e niente conosciamo se non lei. Ma
rivolgiamo lo sguardo dalla nostra personale miseria e dal chiuso orizzonte verso coloro, che superarono il
mondo; coloro, in cui la volontà, giunta alla piena conoscenza di sé, se medesima ritrovò in tutte le cose e
quindi liberamente si rinnegò; coloro, che attendono di vedere svanire ancor solamente l'ultima traccia della
volontà col corpo, cui ella dà vita. Allora, in luogo dell'incessante, agitato impulso; in luogo del perenne
passar dal desiderio al timore e dalla gioia al dolore; in luogo della speranza mai appagata e mai spenta,
ond'è formato il sogno di vita d'ogni uomo ancor volente: ci appare quella pace che sta più in alto di tutta la
ragione, quell'assoluta quiete dell'animo pari alla calma del mare, quel profondo riposo, incrollabile fiducia e
letizia, il cui semplice riflesso nel volto, come l'hanno rappresentato Raffaello e Correggio, è un completo e
certo Vangelo. La conoscenza sola è rimasta, la volontà è svanita. E noi guardiamo con profonda e dolorosa
nostalgia a quello stato, vicino al quale apparisce in piena luce, per contrasto, la miseria e la perdizione del
nostro. Eppur quella vista è la sola, che ci possa durevolmente consolare, quando noi da un lato abbiam
riconosciuto essere insanabile dolore ed infinito affanno inerenti al fenomeno della volontà, al mondo; e
dall'altro vediamo con la soppressione della volontà dissolversi il mondo, e soltanto il vacuo nulla rimanere
innanzi a noi. In tal guisa dunque, considerando la vita e la condotta dei santi, che raramente ci è concesso
invero d'incontrar nella nostra personale esperienza, ma che dalle loro biografie e, col suggello dell'interna
verità, dall'arte ci son posti sotto gli occhi, dobbiamo discacciare la sinistra impressione di quel nulla, che
ondeggia come ultimo termine in fondo a ogni virtù e santità e di cui noi abbiamo paura, come della tenebra i
bambini. Discacciarla, quell'impressione, invece d'ammantare il nulla, come fanno gl'Indiani, in miti e in
parole prive di senso, come sarebbero l'assorbimento in Brahma o il Nirvana dei Buddhisti. Noi vogliamo
piuttosto liberamente dichiarare: quel che rimane dopo la soppressione completa della volontà è invero, per
tutti coloro che della volontà ancora son pieni, il nulla. Ma viceversa per gli altri, in cui la volontà si è rivolta
da se stessa è rinnegata, questo nostro universo tanto reale, con tutti i suoi soli e le sue vie lattee, è - il nulla.
207
Da: Laterza, 1986, pp. 29-32, 152-4, 165-6, 169-70, 175-6, 408-12, 533-6.
Arthur Schopenhauer
O SI PENSA O SI CREDE
Il mito della metempsicosi è, fra tutti i miti che siano stati creati, il più ricco di contenuto, il più significativo,
il più vicino alla verità filosofica, tanto che io lo ritengo il non plus ultra della rappresentazione mitica. Per
questo anche Pitagora e Platone lo ammirarono e lo adottarono; e il popolo presso il quale esso domina
universalmente come fede popolare e ha un influsso decisivo sulla vita è da considerarsi, proprio per questo,
il più maturo, così come è anche il più antico.
Nessuno che sia veramente filosofo è religioso: cammina senza dande, pericolosamente ma libero.
Noi siamo soltanto concime per futuri meloni.
Se un dio ha fatto questo mondo, io non vorrei essere quel dio, perché il dolore del mondo mi strazierebbe il
cuore.
Ogni religione positiva non è che una stampella per la patologica debolezza di spirito della maggior parte
degli uomini.
Chiese e templi in tutti i paesi, in tutte le epoche, con sfarzo e grandezza, testimoniano il bisogno metafisico
dell’uomo.
La religione cattolica è una guida per elemosinare il Cielo: guadagnarselo sarebbe troppo scomodo. I preti
sono i sensali di quell’accattonaggio.
Non esiste alcuna religione naturale: le religioni, tutte, sono prodotti artificiali.
Ogni animale rapace è una tomba vivente di migliaia e migliaia di altri esseri viventi. Per lui nutrirsi e
uccidere è una cosa sola. La sua conservazione consiste nel martoriare altri esseri, perché ce meilleur des
mondes possibile esiste a condizione che l’uno divori l’altro.
L’inizio della teologia è la paura: se dunque gli uomini fossero felici, non sorgerebbe mai una teologia. Ma
l’inizio della filosofia è completamente diverso: una pura riflessione senza uno scopo, alla quale una testa
geniale perverrebbe anche in un mondo senza sofferenze e senza la morte.
Ci si immagini un demone creatore: si avrebbe il diritto di gridargli, indicando la sua creazione: «Come hai
osato rompere la sacra pace del nulla per creare una simile massa di dolori e di miserie?».
Fate che egli [l’uomo] sia senza bisogni, mettiamo un essere puramente teoretico: non gli occorre alcun dio,
e non ne fabbrica alcuno. Il cuore, cioè la volontà, ha bisogno di sperare nell’assistenza di qualcosa di
208
onnipotente e quindi di soprannaturale, e di invocarla: si ipostatizza un dio perché è necessario pregare, non
viceversa [cioè perché vi si creda a priori].
Già solo il presentarsi come verità rivelata è il marchio dell’inganno, e costituisce, per uno che pensi, una
sollecitazione all’ostilità.
Una cretinata tutta particolare dei filosofastri di oggi è che essi danno per certo che gli animali non hanno un
Io, mentre Loro, evidentemente, ne avrebbero uno.
La parola «dio» mi ripugna tanto perché, in ogni caso, pone all’esterno quello che è all’interno. In base a ciò
si potrebbe dire che la differenza tra teismo e ateismo sia spaziale. Ma le cose stanno piuttosto così: «dio» è
essenzialmente un oggetto e non il soggetto: non appena si pone un dio, quindi, io non sono niente. Se si
sostiene l’identità del soggettivo e dell’oggettivo, si può anche sostenere l’identità del teismo e dell’ateismo.
Vorrei che, prima di prorompere nella lode dell’infinitamente Buono, si guardassero un po’ intorno e
vedessero che aspetto ha e coma va questo mondo. Dopo di che chiederei loro se un tale mondo sia più
simile all’opera dell’infinita Saggezza, dell’infinita Bontà e dell’infinita Potenza, oppure a quella della
volontà di vivere.
Solo quando il mondo sarà diventato abbastanza onesto da non impartire lezioni di religione ai ragazzi prima
del quindicesimo anno di età ci si potrà aspettare qualche cosa da lui.
Mediante il precoce indottrinamento, in Europa si è arrivati al punto che la credenza in un dio personale è
letteralmente diventata, in quasi tutti, un’idea fissa.
Panteismo? Un dio che, incorporato, non raffigurasse niente di meglio che questo mondo inquieto,
sanguinante e mortale, le cui creature esistono solo a condizione che l’una divori l’altra, sarebbe un bel tipo
davvero.
Le religioni si sono impadronite della disposizione metafisica dell’uomo, in parte delimitandola e
paralizzandola tempestivamente con i loro dogmi, in parte mettendo un assoluto divieto su tutte le sue liberi
e naturali espressioni. Così, all’uomo la libera ricerca sulle questioni più importanti e interessanti, anzi sulla
sua stessa esistenza, viene in parte proibita direttamente, in parte ostacolata indirettamente, in parte resa
soggettivamente impossibile mediante quella paralisi; e dunque la più elevata delle sue disposizioni giace in
catene.
Il teismo si deve riconoscere in una di queste tre accezioni:
1. Dio ha fatto il mondo dal nulla: questo fa a pugni con l’assoluta certezza che dal nulla non si crea
nulla.
2. Egli ha creato il mondo da se stesso: allora o c’è rimasto dentro anche lui stesso, panteismo, o la
parte di se stesso, che è diventata mondo, si è staccata da lui, emanazione.
3. Egli ha formato la materia che ha trovata: allora questa è eterna come lui ed egli è soltanto un
demiurgo.
Verrà il tempo in cui l’idea di un dio creatore sarà considerata, nella metafisica, come ora si considera quella
degli epicicli nell’astronomia.
Chi crede non è filosofo.
I filosofi da strapazzo non conoscono neppure il problema della filosofia. Pensano che esso sia Dio. Da lui
partono, come se fosse un dato certo, con lui hanno sempre a che fare: se egli sia nel mondo o fuori del
mondo, se abbia una coscienza propria o se si debba servire di quella degli uomini, e simili buffonate a non
finire. Asini, il mondo, il mondo è il problema della filosofia, il mondo e nient’altro!
209
Un essere personale avrebbe fatto il mondo: ciò si può certo credere, come ha insegnato l’esperienza, ma non
pensare.
Quando uno comincia a parlare di Dio, io non lo so di che cosa parli.
Per 1800 anni la religione ha messo la museruola alla filosofia. Il compito dei professori di filosofia consiste
nello spacciare per filosofia la mitologia ebraica.
Animali – esseri coscienti che dividono con noi questa esistenza misteriosa.
Il bisogno metafisico dell’uomo [...] viene subito dopo il bisogno fisico.
Esistono in tutti i popoli i monopolizzatori e gli appaltatori del bisogno metafisico: i preti. [...] [La prima
infanzia] è il momento in cui qualsiasi dogma ben impresso, per quanto insensato possa essere, si fisserà per
sempre. Se i preti dovessero aspettare la maturità di giudizio, i loro privilegi non potrebbero esistere.
Una seconda classe, sebbene non numerosa, di persone che traggono il loro sostentamento dal bisogno
metafisico degli uomini è formata da quelli che vivono della filosofia: presso i greci si chiamavano sofisti,
ora si chiamano professori di filosofia.
Le religioni sono necessarie al popolo e sono per lui un beneficio inestimabile. Ma se esse vogliono opporsi
al progresso dell’umanità nella conoscenza della verità, allora, pur con tutta la delicatezza possibile, devono
essere messe da parte. E pretendere che perfino un grande spirito – uno Shakespeare, un Goethe – si
convinca e accetti implicite, bona fide et sensu proprio i dogmi di qualche religione è come pretendere che
un gigante calzi le scarpe di un nano.
Se prendessi come misura della verità i risultati della mia filosofia, dovrei accordare al buddhismo la
superiorità su tutte le altre religioni.
La filosofia è essenzialmente sapienza del mondo: il suo problema è il mondo: solo con il mondo essa ha da
fare, lasciando in pace gli dèi; ma in compenso si aspetta che gli dèi lasciano in pace lei.
La filosofia, diversamente dalla religione, è una scienza, e, come tale, non ha nessun articolo di fede; in essa,
quindi, non si deve assumere come esistente se non ciò che è o chiaramente accertato come dato empirico o
dimostrato per via di deduzioni incontrovertibili; e si pensava di esservi giunti da molto tempo, quando Kant
tolse al mondo quella illusione, e fornì, anzi, prove così evidenti dell’impossibilità di tali dimostrazioni che,
da allora, non ci fu, in Germania, alcun filosofo che si provasse a ricorrervi.
A guardare le cose in modo del tutto realistico e obiettivo, è chiaro come il sole che il mondo si conserva da
sé; gli esseri organici esistono e si propagandano grazie alla loro propria, specifica, forza vitale interiore: i
corpi organici hanno in sé forze che la fisica e la chimica si limitano a descrivere, e il corso dei pianeti è
determinato da forze intrinseche grazie alla loro inerzia e alla gravitazione. Il mondo, dunque, non ha
bisogno di altri che di se stesso [...]. Ora, dire che, un tempo, questo mondo, con tutte le forze che contiene,
non esisteva, ma fu tirato fuori dal nulla a opera di una forza estranea che si trovava al suo esterno – dire ciò
significa formulare un’ipotesi del tutto gratuita, non dimostrabile in alcun modo; tanto più che le forze del
mondo sono legate alla materia; né è pensabile che la materia sia qualcosa che può nascere o morire.
Quella concezione del mondo sfocia nello spinozismo. E’ del tutto naturale che gli uomini, nella loro
angoscia, abbiano sempre immaginato, per poterli invocare, degli esseri che avrebbero dominato le forze
della natura e il loro operare; ma i greci e i romani si contentavano di entità che dominavano, ciascuna, in un
suo ambito particolare, né veniva loro in mente di affermare che una di quelle avesse fatto il mondo e le
forze della natura.
Dopo aver inferto, con la sua critica della medesima, un colpo mortale alla teologia speculativa, Kant dovette
cercare di mitigarne gli effetti sul pubblico stendendo, su quella critica, un lenitivo di funzione analgesica; un
comportamento molto simile a quello di Hume, che, nell’ultimo dei suoi Dialogues on natural religion, così
pregevoli e così impietosi, ci rivela che è stato tutto uno scherzo, un semplice exercitium logicum. Così Kant,
come surrogato delle prove dell’esistenza di Dio, ci ha dato il suo postulato della ragion pratica e la teologia
morale che ne deriva, la quale, senza alcuna pretesa di validità soggettiva per la conoscenza o per la ragione
210
teoretica, avrebbe dovuto essere pienamente valida per quanto riguardava l’agire, o per la ragion pratica; con
ciò veniva fondata una fede senza conoscenza – tanto perché la gente avesse ancora in mano qualcosa di
concreto. Il discorso di Kant, inteso come si deve, non vuol dire altro che questo: l’ipotesi di un dio giusto
che remuneri l’uomo dopo la morte è uno schema regolativo utile e soddisfacente a cui può informarsi la
definizione di ciò che sentiamo come significato serio, etico, del nostro agire, e , anche, quello stesso agire.
Si tratta, in certo qual modo, di un’allegoria della verità: sicché, sotto questo aspetto, che è, poi, il solo che
conti, quell’ipotesi potrebbe prendere il posto della verità – se non fosse necessario giustificarla anche
teoreticamente, od oggettivamente. Uno schema analogo, di eguale orientamento, ma dotato di una assai
maggiore, intrinseca verità e assai più plausibile (e quindi, in sé, più valido) è il dogma del brahmanesimo,
quello della metempsicosi e della sua funzione riparatrice: noi dovremo, un giorno, rinascere sotto l’aspetto
di ognuno degli esseri a cui abbiamo fatto del male, per subire la medesima offesa. La teologia morale
kantiana sarà, dunque, da intendersi al modo di cui si è detto, e ciò, anche, con riguardo al fatto che a Kant
non era consentito di ricorrere, su tali argomenti, a un linguaggio esplicito e aperto come quello del presente
discorso, mentre, nel dar vita a una creatura mostruosa quale una dottrina teologica valida soltanto
praticamente, egli contava sul granus salis delle persone più intelligenti. In questa nostra epoca, che si è
lasciata alle spalle la filosofia kantiana, gli scrittori di teologia e di filosofia hanno cercato, per lo più, di far
passare la teologia morale di Kant per un vero e proprio teismo dogmatico: per una nuova dimostrazione
dell’esistenza di Dio. Si tratta, invece, di una cosa completamente diversa: quella teologia è valida
esclusivamente nell’ambito della morale, guarda soltanto alla morale, e non si spinge oltre neppure di un
millimetro.
Non si mantennero a un lungo tranquilli neppure i professori di filosofia; benché si sentissero messi in grave
difficoltà dalla critica kantiana della teologia speculativa. Da tempo immemorabile, infatti, essi avevano
considerato loro specifica missione quella di discorrere dell’esistenza e delle qualità di Dio e di fare, del
medesimo, l’oggetto principale del loro filosofare: perciò, se la Scrittura dice che Dio nutre i corvi sul
campo, io debbo aggiungere: e i professori di filosofia sulle loro cattedre. Questi, infatti, hanno ancor oggi la
faccia tosta di affermare che il vero argomento della filosofia è l’Assoluto (che, come si sa, è il termine di
moda per dire «il buon Dio») e il suo rapporto col mondo, e sono tutti indaffarati – come sempre – a
precisare quel concetto, a ricamarci sopra, a fantasticarci attorno. E poi, i governi, che elargiscono denaro per
un’attività filosofica di quel genere, vorrebbero, in cambio, veder venir fuori dalle aule universitarie dei
buoni cristiani e degli assidui frequentatori delle chiese. Che cosa avranno provato quei signori della filosofia
lucrativa quando dovettero constatare che, dimostrando che tutte le dimostrazioni della teologia speculativa
sono insostenibili, e che è assolutamente inaccessibile ogni conoscenza riguardante il loro tema prediletto,
Kant aveva rotto tutte le uova del loro paniere?
Insomma: a dispetto della Critica della Ragione e delle sue dimostrazioni, ai professori di filosofia non sono
mai venute a mancare notizie autentiche sull’esistenza di Dio e sui suoi rapporti col mondo, mentre, secondo
loro, l’attività filosofica deve consistere esclusivamente nel fornire dettagliate informazioni in proposito.
Non è evidente di per sé neppure una natura naturans (quella natura naturans in cui il loro dio minaccia,
spesso, di trasformarsi): Leucippo, Democrito, Epicuro e Lucrezio, infatti, costruirono il mondo senza di
essa; e quegli uomini, con tutti i loro errori, valevano molto di più di una legione di banderuole la cui
filosofia venale gira a seconda del vento.
Una caratteristica assolutamente essenziale del teismo è l’antropomorfismo; e questo non consiste soltanto
nella figura umana attribuita alla divinità, e neppure soltanto nel suo partecipare dei sentimenti e delle
passioni umane, ma è proprio del fenomeno fondamentale in sé: una volontà fornita di un intelletto che le fa
da guida.
Comunque, si potrebbe dire, con Kant, che il teismo è, in certo qual modo, un postulato di natura pratica; ciò,
però, in un senso affatto diverso da quello da lui inteso. Il teismo, infatti, non è, in realtà, un prodotto della
coscienza; è un prodotto della volontà. Se avesse un’origine teoretica, come potrebbero, tutte le
dimostrazioni su cui si basa, essere così insostenibili? Ecco, invece, in che modo esso nasce dalla volontà. La
costante, affannosa inquietudine che ora opprime angosciosamente il cuore (la volontà) dell’uomo, ora
accende in lui emozioni e passioni, e lo mantiene in uno stato perenne di timore e speranza – mentre le
circostanze che lo fanno sperare e temere non sono in suo potere, e, anzi, non gli è dato di conoscere che un
breve tratto della concatenazione dei relativi nessi casuali – quell’inquietudine, quel perenne temere e
211
sperare, lo induce a creare l’ipostasi di entità personali da cui fa dipendere tutto. Di tali entità personali si
può supporre che, al pari di altre persone, saranno sensibili a preghiere e lusinghe, servizi e doni; che, cioè, si
dimostreranno più arrendevoli della rigida necessità, delle spietate, insensibili forze delle forze della nature, e
delle oscure potenze che reggono il corso del mondo. Ora, se in un primo tempo, com’è naturale e come, con
grande senso pratico, avevano voluto gli antichi, quelle divinità – in corrispondenza con la diversità delle
circostanze – sono numerose, in seguito, per l’esigenza di conferire a quella nozione coerenza, ordine e unità,
esse vengono assoggettate, tutte, alla sovranità di una, o, addirittura, ridotte a una soltanto: a un dio che,
come una volta mi fece osservare Goethe, non è per niente utilizzabile per un’opera teatrale: che cosa si può
fare con un personaggio solo? A ogni modo, ciò che qui importa è l’impulso che spinge l’uomo, spaventato e
inquieto, a prosternarsi e a supplicare per avere soccorso nelle sue assidue, miserevoli pene, e, anche, in ciò
che riguarda la sua felicità eterna. L’uomo preferisce affidarsi all’altrui grazia piuttosto che ai propri meriti;
quello è uno dei pilastri che sorreggono il teismo. Perché il cuore (la volontà) abbia il sollievo della preghiera
e il conforto della speranza l’intelletto dell’uomo deve inventargli un dio: non avviene l’inverso: non prega,
l’uomo, perché il suo intelletto abbia dedotto, attraverso un corretto ragionamento logico, l’esistenza di un
dio. Fate che egli sia senza pene, senza desideri, senza bisogni, un essere fatto soltanto di intelletto, privo di
volontà: quell’essere non ha bisogno di alcun dio, e non ne crea alcuno. Nella sua gravosa angoscia, il cuore
– cioè la volontà – sente il bisogno di invocare il soccorso di un’entità onnipotente, e, quindi, soprannaturale;
e appunto perché si deve pregare si ipostatizza una divinità. Perciò, se il lato teoretico della teologia è, di
popolo in popolo, molto diverso per quanto concerne il numero e la natura delle divinità, queste hanno, tutte,
una cosa in comune: se gli uomini li servono e li pregano, possono aiutarli e lo fanno: perché è questo ciò
che conta; e questo è, allo stesso tempo, il marchio, il segno distintivo da cui si riconosce l’origine di ogni
teologia; si comprende, cioè, che ogni teologia nasce dalla volontà, dal cuore, e non già, come si vuol far
credere, dalla testa, ossia dalla conoscenza.
Strettamente connesso con la vera origine [...] di ogni forma di teismo, e derivante, come quello, dalla natura
dell’uomo, è il suo sentirsi stimolato a offrire sacrifici ai suoi dei, o per comprare il loro favore, o, se glielo
hanno già dimostrato, perché continuino a farlo, o perché lo liberino da un male. Tale è il senso di ogni
sacrificio; da ciò ha origine e su ciò si regge l’esistenza di tutti gli dèi, tanto che si può veramente dire che gli
dèi vissero dei sacrifici. Se l’uomo si crea degli dèi è perché in lui è naturale – anche se è un prodotto della
sua miseria e della sua limitatezza intellettuale – il desiderio di invocare e di comprare l’assistenza di entità
soprannaturali, e, con esso, il bisogno di soddisfarlo.
Per attenuare quanto poteva esservi di scandaloso nella sua critica di tutta la teologia speculativa, Kant vi
aggiunse [...] un’affermazione: anche se l’esistenza di Dio avesse dovuto restare indimostrata, era altrettanto
impossibile dimostrare la sua inesistenza. Con ciò, molti si tranquillizzarono, senza accorgersi che Kant, con
finta ingenuità, aveva ignorato che affermanti incumbit probatio, e, inoltre, che il numero delle cose di cui
non è possibile dimostrare l’inesistenza è infinito.
Si deve ammettere che il teismo fornisce un appoggio alla morale; ma si tratta di un appoggio della specie
più grossolana, tale anzi da annullare, in sostanza, la vera, pura moralità dell’agire: qualunque azione
disinteressata, una volta che viene retribuita con una cambiale a lunghissima scadenza, ma sicura, che si
ottiene in pagamento, si muta istantaneamente in un’azione egoistica; e quello che, in principio, era il dio
creatore, diventa, alla fine, il dio della vendetta e della rimunerazione.
Il teismo è, poi, in contrasto con la morale anche a parte ante; e ciò perché abolisce la libertà e
l’imputabilità. In relazione, infatti, con un essere che esiste ed è quello che è in quanto è opera di un altro,
non si può pensare né a colpe né a meriti. [...] Se esso agisce male, ciò accade perché è malvagio; e, quindi,
la colpa non è sua, ma di colui che lo ha fatto. [...] Sant’Agostino, Hume e Kant si sono perfettamente resi
conto della validità di questa argomentazione maliziosamente e codardamente ignorata dagli altri [...].
Appunto per eludere quella tremenda, esiziale difficoltà, è stata inventata la libertà del volere, il liberum
arbitrium indifferentiae, una finzione assolutamente mostruosa, e perciò costantemente contestata, e respinta
ormai da molto tempo da tutte le menti pensanti, ma mai, forse, confutata sistematicamente e a fondo.
Dire che l’uomo è stato creato libero è affermare una cosa impossibile: affermare, cioè, che il creatore gli ha
dato un’existentia senza essentia; gli ha dato, quindi, l’esistenza soltanto in abstracto, lasciando a lui di
decidere «che cosa» voglia essere.
212
La libertà morale e la responsabilità, ossia l’imputabilità, presuppongono, inevitabilmente, l’aseità. Le azioni
scaturiranno sempre, necessariamente, per effetto dei motivi e in relazione a essi, dal carattere di un essere,
vale a dire dalla natura che gli è peculiare, ed è quindi immutabile. Perciò, per essere responsabile,
quell’essere deve esistere come entità primigenia e in virtù di un autonomo potere assoluto: deve, cioè, per
quanto concerne la sua existentia e la sua essentia, essersi fatto da sé, essere autore di se stesso – se vuole
essere il vero autore delle proprie azione. Ovvero: [...] la libertà non può trovar posto nell’operari, e, quindi,
deve trovarsi nell’esse; perché che esista è sicuro.
Non ha alcuna ragione di temere la morte uno che vede in sé l’essere primogenio ed eterno, l’origine di tutto
ciò che é, e sa che nulla esiste al di fuori di lui.
Contro il panteismo io muovo una sola, importante obiezione: non dice nulla. Chiamare dio il mondo non
vuol dire spiegarlo; significa soltanto arricchire la lingua di un inutile sinonimo della parola «mondo». Dire
«il mondo è dio» è come dire «il mondo è il mondo».
Dovrebbe, veramente, essere un dio sconsiderato quello che, per divertirsi, non sapesse trovare niente di
meglio che trasformarsi in un mondo come questo, un mondo così affamato, per sopportare in esso dolori,
miseria e morte che non conoscono limiti né hanno un fine, sotto le specie di milioni innumerevoli di esseri
viventi, ma viventi nell’angoscia e nei tormenti, che restano in vita, tutti quanti, per qualche tempo, soltanto
divorandosi l’un l’altro – per esempio, sotto la specie di sei milioni di schiavi negri, che ricevono, in media,
ogni giorno, sessanta milioni di frustate sul corpo nudo; o di tre milioni di tessitori europei che vegetano
stentatamente nella fame e nell’affanno di umide stanze o in squallide fabbriche, e così via. Che bel
passatempo, per un dio che, in quanto tale, dovrebbe essere abituato a ben altro!
Io vorrei contrapporre alla formulazione kantiana del principio morale la norma seguente: quando si entra in
contatto con una persona non ci si metta a giudicarla, con criteri oggettivi, secondo il suo valore e la sua
dignità: non si prendano, cioè, in considerazione né la malvagità della sua volontà né la limitatezza del suo
intelletto e la stoltezza delle sue idee; perché quella malvagità potrebbe ingenerare antipatia nei suoi riguardi,
e la stoltezza del disprezzo; ma si guardi soltanto alle sue sofferenze, alla sua miseria, alla sua angoscia, ai
suoi dolori. Allora ci si sentirà, sempre, simili a lui, si proverà simpatia per lui, e, in luogo di avversione o di
disprezzo, si proverà per lui quella compassione che, sola, è quella ἀγάπη [amore] a cui ci esorta il Vangelo.
E non è certo con un’indagine sulla sua presunta «dignità» che si può evitare che nasca, nei suoi confronti,
avversione o disprezzo: l’unica posizione da assumere a quel fine è, al contrario, quella della compassione.
Data la maggiore profondità delle loro concezioni etiche e metafisiche, i buddhisti non prendono le mosse da
virtù cardinali, ma da vizi cardinali.
Così ci tocca sentire che il suicidio è la più grande viltà, che è possibile soltanto in caso di pazzia, e altre
insulsaggini del genere, o anche la frase, del tutto insensata, «uno non ha il diritto di suicidarsi»; mentre è
evidente che su nulla al mondo uno ha diritti più incontestabili di quelli che riguardano la sua persona e la
sua vita.
Non pensiamo che si debba desiderare tanto la vita da voler vivere comunque, qualunque esistenza si
conduca. Chiunque tu sia, dovrai morire ugualmente, che tu sia vissuto bene o viziosamente e in modo
nefando. Perciò ognuno, come rimedio per la sua anima, pensi soprattutto a questo: fra tutti i beni che la
natura ha elargiti all’uomo nessuno è migliore di una morte che giunga quando è bene che giunga; e ciò che
la morte ha di meglio è il fatto che ognuno se la può procurare da sé.
La religione è la metafisica del popolo; bisogna assolutamente lasciargliela, e, quindi, mostrare,
esteriormente, rispetto per essa, perché screditarla vorrebbe dire portargliela via.
Ora, le varie religioni non sono altro che semplificazioni schematiche diverse, nelle quali il popolo coglie e si
prospetta una verità che, in sé, gli è inattingibile, mentre, con quelle, si fa tutt’uno con essa,
indissolubilmente. Perciò, mio caro, non avertene a male, ma schernire le religioni è, a un tempo, una
meschinità e un’ingiustizia.
213
Ma non è, forse, altrettanto meschino e ingiusto pretendere che non vi debba essere alcun’altra metafisica
all’infuori di quella, confezionata su misura per adattarsi ai bisogni e alle facoltà intellettuali della massa?
All’incirca, come una gamba di legno sostituisce una gamba naturale: ne prende il posto, adempie alla meno
peggio le sue funzioni pretendendo di essere considerata una gamba vera, è costruita ora più ora meno
abilmente, e così via. C’è, però, una differenza: di solito, prima della gamba di legno, ce n’era una vera,
mentre la religione ha preso, dappertutto, il sopravvento sulla filosofia.
Ma per chi non ha una gamba naturale, una gamba di legno ha un grande valore. Devi tener presente che il
bisogno metafisico dell’uomo vuole, assolutamente, essere soddisfatto: l’orizzonte dei suoi pensieri
dev’essere chiuso, non può restare sconfinato.
Comunque, ammesso che la religione sia uno strumento eccellente per addomesticare e ammaestrare questa
razza di bipedi dissennata, ottusa e malvagia, agli occhi di chi è amico della verità ogni fraus, per quanto pia
possa essere, è riprovevole. La menzogna e l’inganno sarebbero strumenti davvero singolari per affermare le
virtù. La bandiera a cui ho giurato fedeltà è la verità; le rimarrò fedele in tutto, e, senza curarmi del risultato,
combatterò per la luce e per la verità.
Le religioni sono come le lucciole: per brillare hanno bisogno dell’oscurità. Ciò che occorre a tutte le
religioni è un certo grado di diffusa ignoranza; quello che è il solo elemento in cui possano vivere. Non
appena, invece, è consentito all’astronomia, alle scienze naturali, alla storia, alla geografia, all’etnologia, di
diffondere ovunque la loro luce, e può finalmente prendere la parola anche la filosofia, ogni religione fondata
sui miracoli e sulla rivelazione è destinata a tramontare; e allora è la filosofia a prendere il suo posto. Verso
la fine del quindicesimo secolo, con l’arrivo di alcuni dotti greci, spuntò, in Europa, il giorno della
conoscenza e della scienza; quel sole continuò a salire, sempre più in alto, nel 1500 e nel 1600, due secoli
così fecondi, e dissipò le nebbie del Medioevo. Parallelamente si ebbe, a poco a poco, il declino della Chiesa
e della religione, tanto che, nel 18° secolo, alcuni filosofi inglesi e francesi potevano già insorgere, contro
l’una e l’altra, direttamente, finché, sotto Federico il Grande, venne Kant, che sottrasse alla fede religiosa il
sostegno della filosofia di cui aveva goduto fino ad allora, e, affrontando la questione con scrupolosità e
pacatezza tutta tedesca, emancipò l’ancilla theologiae; con ciò essa assunse un aspetto meno frivolo, e tanto
più serio. Di conseguenza, vediamo, nel 19° secolo, un cristianesimo molto indebolito, abbandonato quasi
del tutto dai credenti più seri, un cristianesimo che lotta, ormai, per la sua stessa esistenza, mentre i sovrani,
premurosi, cercano di mantenerlo in piedi con sostanze stimolanti, così come fa il medico che sostiene col
muschio il moribondo.
Può anche darsi che sia addirittura imminente il momento, tanto profetizzato, in cui la religione si dipartirà
dalle popolazioni dell’Europa, come la nutrice da un bambino troppo cresciuto per restare affidato alle sue
cure e ormai pronto a ricevere gli insegnamenti di un precettore. E’, infatti, fuori di dubbio che pure e
semplici dottrine religiose basate sull’autorità, sui miracoli e sulla rivelazione non sono adatte che
all’infanzia dell’umanità.
Veramente è, questo, il lato peggiore di tutte le religioni: i seguaci di ciascuna ritengono che tutto sia loro
permesso contro i seguaci di tutte le altre, coi quali, perciò, si comportano in modo estremamente malvagio e
spietato. Così fanno i maomettani coi cristiani e con gli indù, e così fanno i cristiani con gli indù, coi
maomettani, con le popolazioni americane, coi negri, gli ebrei, gli eretici e così via. Ma forse, quando dico
«tutte», vado troppo lontano; e, in omaggio alla verità, debbo aggiungere che veramente, a quanto sappiamo,
il fanatismo e gli orrori nati da motivi religiosi non appartengono che ai seguaci delle religioni
monoteistiche, sono tipici, cioè, dell’ebraismo e delle sue due ramificazioni, il cristianesimo e l’Islam. [...] In
pratica, l’intolleranza è un fenomeno proprio soltanto del monoteismo: un dio unico è, per sua natura, un dio
geloso, e non ne lascia vivere altri. Al contrario, gli dei delle religioni politeistiche sono, per loro natura,
tolleranti, vivono e lasciano vivere, e, soprattutto, sono benevoli verso i loro colleghi, gli dei della medesima
religione; e poi la loro tolleranza si estende anche agli dei stranieri, che, quindi, vengono accolti
ospitalmente, e talvolta, in seguito, ottengono il diritto di cittadinanza, ciò che è dimostrato soprattutto
dall’esempio dei romani, che accoglievano di buon grado e onoravano divinità frigie, egizie e altre ancora.
Nella sua qualità di scienza, la filosofia non ha assolutamente nulla a che vedere con ciò che si deve credere
né con ciò che è lecito credere; il suo oggetto è soltanto ciò che si può sapere.
214
A ogni modo, si tratta di due cose fondamentalmente diverse [fede e filosofia], che, per il bene di entrambe,
debbono restare rigorosamente separate, così che vadano ciascuna per la sua strada ignorandosi
reciprocamente.
C’è un altro difetto fondamentale del cristianesimo del quale si deve far parola; [...] ha distaccato l’uomo dal
mondo degli animali, a cui egli, in sostanza, appartiene e, dando importanza a lui soltanto, li tiene addirittura
in conto di cose. [...] Ora, il difetto fondamentale di cui ho detto è una conseguenza della creazione dal nulla,
dopo la quale il creatore (capp. 1 e 9 della Genesi), consegna all’uomo tutti gli animali, proprio come se
fossero cose, e senza nemmeno raccomandargli di trattarli bene, come fa, per lo più, uno che vende cani nel
separarsi dal cane che ha allevato; e glieli consegna perché imperi su di loro, cioè ne faccia quello che vuole,
dopo di che, nel secondo capitolo, gli conferisce, per di più, il titolo di primo professore di zoologia, in
quanto lo incarica di dar loro i nomi che dovranno portare di lì in avanti; il che, poi, non è che un simbolo
della loro totale indipendenza dall’uomo, vale a dire della loro condizione di essere privi di diritti. Santa
Ganga! Madre della nostra specie! Racconti di quel tipo mi fanno l’effetto del bitume e del foetor judaicus.
Tutto dipende dalla visione ebraica, nella quale l’animale è un manufatto costruito a uso e consumo
dell’uomo.
«Il giusto ha pietà del suo bestiame.» «Ha pietà»! Che razza di espressione! Si ha pietà di un peccatore, di un
malfattore; non di un innocente, fedele animale, che spesso dà da vivere al proprio padrone e non ottiene, in
cambio, altro che un po’ di cibo. «Ha pietà!» Non pietà, ma giustizia, è ciò che è dovuto agli animali; ma per
lo più tale giudizio manca in Europa, perché il vostro continente è impregnato di foetor judaicus a un punto
tale che la semplice, ovvia verità «l’animale è, in sostanza, la stessa cosa che l’uomo» è considerata uno
scandaloso paradosso.
Non ci sono dubbi: è ormai tempo che, in Europa, si ponga fine, almeno per quanto riguarda gli animali, alla
concezione ebraica della natura, e che si riconosca, si rispetti e si tuteli l’essenza eterna che vive, come in
noi, così anche in tutti gli animali. Sappiatelo e tenetelo presente! Si tratta di una cosa seria, e non si può
cambiare, nemmeno se coprite di sinagoghe tutta quanta l’Europa. Bisogna essere privi di ogni sensibilità e
completamente cloroformizzati dal foetor judaicus per non riconoscere che gli animali sono, nella loro
essenza e in ciò che più conta, assolutamente uguali a noi, e che la differenza sta unicamente nell’accidente,
nell’intelletto, non nella sostanza, che è la volontà.
E’ vero, purtroppo, che l’uomo, spintosi a nord è perciò divenuto bianco, ha bisogno della carne degli
animali (anche se, in Inghilterra, vi sono dei vegetarians); ma, a quegli animali, si deve dare una morte del
tutto indolore usando il cloroformio e raggiungendo rapidamente l’organo vitale; e ciò non già, come si legge
nell’Antico Testamento, per «compassione», ma per un maledetto obbligo nei confronti dell’essenza eterna
che vive, come in noi, così in ogni animale.
Quelli che si immaginano che le scienze possano progredire e diffondersi sempre di più senza che ciò
impedisca alla religione di continuare a sopravvivere e a prosperare sono vittime di grande errore. La fisica e
la metafisica sono nemiche naturali della religione, e quindi questa è, a sua volta, nemica loro e fa, da
sempre, tutto ciò che può per soffocarle, allo stesso modo che quelle si studiano di scalzare le sue
fondamenta.
Le conoscenze che, in ogni campo, aumentano di giorno in giorno e si estendono sempre più in tutte le
direzioni, allargano l’orizzonte di ogni individuo nell’ambito dei suoi particolari interessi, e lo allargano a tal
punto che, fatalmente, esso finirà per raggiungere un’ampiezza tale che al suo contatto i miti che
costituiscono l’ossatura del cristianesimo rinsecchiranno, e non offriranno più appiglio alla fede. La religione
è come il vestito di un bambino quando il bambino è cresciuto: non gli va più bene, e non c’è niente da fare:
il vestito si squarcia. Fede e conoscenza rinchiuse nella medesima testa non vanno d’accordo; ci stanno come
un lupo e una pecora chiusi nella medesima gabbia: e la conoscenza è il lupo che minaccia di divorare la
vicina. Vediamo come, quando si sente in pericolo di morte, la religione si aggrappi alla morale, quella
morale di cui vorrebbe farsi credere madre; ma non le è madre per nulla.
215
Se la civiltà ha raggiunto il suo culmine fra i popoli cristiani, ciò non dipende da un’influenza positiva del
cristianesimo, ma dal fatto che il cristianesimo è morto e ha, ormai, ben poca influenza: e infatti, finché ne
ebbe molta, e cioè nel Medioevo, la civiltà era molto arretrata. Per contro l’islamismo, il brahmanesimo e il
buddhismo esercitano ancora, sulla vita, un’influenza decisiva: ma in Cina assai di meno e per questo la sua
civiltà è abbastanza vicina a quella europea. Ogni religione è agonistica rispetto alla civiltà.
«Se si studia il buddhismo nelle sue fonti», disse Schopenhauer, «ci si rischiara la mente: qui non ci sono le
stupide chiacchiere sul mondo creato dal nulla e su un tizio personale che lo avrebbe fatto. Al diavolo tutta
questa robaccia.»
«Teologia e filosofia» disse, «sono come i due piatti della bilancia. Quanto più si abbassa l’uno, tanto più si
alza l’altra. Quanto più nel nostro tempo cresce la miscredenza, tanto più diventa grande il bisogno di
filosofia, di metafisica; e allora devono venire da me.»
A. Schopenhauer, O si pensa o si crede, Rizzoli, 2011
Friedrich Nietzsche
LA GAIA SCIENZA
125. L’uomo folle. Avete sentito di quel folle uomo che accese una lanterna alla chiara luce del mattino,
corse al mercato e si mise a gridare incessantemente: “Cerco Dio! Cerco Dio!”. E poiché proprio là si
trovavano raccolti molti di quelli che non credevano in Dio, suscitò grandi risa. “È forse perduto?” disse uno.
“Si è perduto come un bambino?” fece un altro. “Oppure sta ben nascosto? Ha paura di noi? Si è imbarcato?
È emigrato?” – gridavano e ridevano in una gran confusione. Il folle uomo balzò in mezzo a loro e li trapassò
con i suoi sguardi: “Dove se n’è andato Dio? – gridò – ve lo voglio dire! Siamo stati noi ad ucciderlo: voi e
io! Siamo noi tutti i suoi assassini! Ma come abbiamo fatto questo? Come potemmo vuotare il mare
bevendolo fino all’ultima goccia? Chi ci dette la spugna per strusciar via l’intero orizzonte? Che mai
facemmo, a sciogliere questa terra dalla catena del suo sole? Dov’è che si muove ora? Dov’è che ci
muoviamo noi? Via da tutti i soli? Non è il nostro un eterno precipitare? E all’indietro, di fianco, in avanti,
da tutti i lati? Esiste ancora un alto e un basso? Non stiamo forse vagando come attraverso un infinito nulla?
Non alita su di noi lo spazio vuoto? Non si è fatto più freddo? Non seguita a venire notte, sempre più notte?
Non dobbiamo accendere lanterne la mattina? Dello strepito che fanno i becchini mentre seppelliscono Dio,
non udiamo dunque nulla? Non fiutiamo ancora il lezzo della divina putrefazione? Anche gli dèi si
decompongono! Dio è morto! E noi lo abbiamo ucciso! Come ci consoleremo noi, gli assassini di tutti gli
assassini? Quanto di più sacro e più possente il mondo possedeva fino ad oggi, si è dissanguato sotto i nostri
coltelli; chi detergerà da noi questo sangue? Con quale acqua potremmo noi lavarci? Quali riti espiatori,
quali giuochi sacri dovremo noi inventare? Non è troppo grande, per noi, la grandezza di questa azione? Non
dobbiamo noi stessi diventare dèi, per apparire almeno degni di essa? Non ci fu mai un’azione più grande:
tutti coloro che verranno dopo di noi apparterranno, in virtù di questa azione, ad una storia più alta di quanto
mai siano state tutte le storie fino ad oggi!”. A questo punto il folle uomo tacque, e rivolse di nuovo lo
sguardo sui suoi ascoltatori: anch’essi tacevano e lo guardavano stupiti. Finalmente gettò a terra la sua
lanterna che andò in frantumi e si spense. “Vengo troppo presto – proseguì – non è ancora il mio tempo.
Questo enorme avvenire è ancora per strada e sta facendo il suo cammino: non è ancora arrivato fino alle
orecchie degli uomini. Fulmine e tuono vogliono tempo, il lume delle costellazione vuole tempo, le azioni
vogliono tempo, anche dopo essere state compiute, perché siano vedute e ascoltate. Quest’azione è ancor
sempre più lontana da loro delle più lontane costellazioni: eppure son loro che l’hanno compiuta!”. Si
racconta ancora che l’uomo folle abbia fatto irruzione, quello stesso giorno, in diverse chiese e quivi abbia
intonato il suo Requiem aeternam Deo. Cacciatone fuori e interrogato, si dice che si fosse limitato a
rispondere invariabilmente in questo modo: “Che altro sono ancora queste chiese, se non le fosse e i sepolcri
di Dio?”.
216
341. Il peso più grande. Che accadrebbe se, un giorno o una notte, un demone strusciasse furtivo nella più
solitaria delle tue solitudini e ti dicesse: “Questa vita, come tu ora la vivi e l’hai vissuta, dovrai viverla
ancora una volta e ancora innumerevoli volte, e non ci sarà in essa mai niente di nuovo, ma ogni dolore e
ogni piacere e ogni pensiero e sospiro, e ogni indicibilmente piccola e grande cosa della tua vita dovrà fare
ritorno a te, e tutte nella stessa sequenza e successione – e così pure questo ragno e questo lume di luna tra i
rami e così pure questo attimo e io stesso. L’eterna clessidra dell’esistenza viene sempre di nuovo capovolta
e tu con essa, granello della polvere!”. Non ti rovesceresti a terra, digrignando i denti e maledicendo il
demone che così ha parlato? Oppure hai forse vissuto una volta un attimo immenso, in cui questa sarebbe
stata la tua risposta: “Tu sei un dio e mai intesi cosa più divina?”. Se quel pensiero ti prendesse in suo potere,
a te, quale sei ora, farebbe subire una metamorfosi, e forse ti stritolerebbe; la domanda per qualsiasi cosa:
“Vuoi tu questo ancora una volta e ancora innumerevoli volte?” graverebbe sul tuo agire come il peso più
grande! Oppure, quanto dovresti amare te stesso e la vita, per non desiderare più alcun’altra cosa che questa
ultima eterna sanzione, questo suggello?
Friedrich Nietzsche
COSI’ PARLO’ ZARATHUSTRA.
Introduzione
1.
Allorchè Zarathustra ebbe raggiunto il trentesimo anno, abbandonò il paese nativo ed il nativo lago e andò
sulle montagne. Ivi godè del suo spirito e della sua solitudine e non se ne stancò per dieci anni. Ma alla fine
il suo cuore si cangiò – e un mattino, levatosi con l'aurora si mise di fronte al sole e gli disse:
O grande astro! Che sarebbe della tua beatitudine, se tu non avessi coloro ai quali risplendi?
Da dieci anni vieni quassù nella mia caverna; ti saresti tediato della tua luce e di questo cammino, se non
fosse per me, per l'aquila mia e pel mio serpente.
Ma noi ti attendevamo ogni mattina, prendevamo il tuo superfluo, benedicendoti in cambio. Guarda, mi è
venuta in disgusto la mia sapienza; come l'ape che ha raccolto troppo miele, ho bisogno di mani che si
tendano a me.
Vorrei donare e distribuire fin che i savi tra gli uomini fossero ridivenuti lieti della loro follia e i poveri della
loro ricchezza.
Perciò debbo discendere nel profondo: come tu fai la sera quando scomparisci dietro il mare e dispensi la
luce tua anche al mondo degli inferi, tu astro fulgentissimo!
Al pari di te, io debbo tramontare, come dicono gli uomini, tra i quali voglio discendere.
Benedicimi dunque, occhio tranquillo, che puoi contemplare senza invidia anche una felicità troppo grande!
Benedici il calice che sta per traboccare, affinchè l'acqua ne esca dorata e porti da per tutto il riflesso della
tua gioia!
Vedi! Questo calice vuol essere vuotato un'altra volta e Zarathustra vuol ridivenire uomo. Così cominciò la
discesa di Zarathustra.
2.
Zarathustra discese solo, dalla montagna, e non si incontrò con alcuno. Ma quando giunse nei boschi subito
gli si levò dinanzi un vecchio che aveva abbandonato la sua sacra capanna per cercare radici nella selva. E
così parlò il vecchio a Zarathustra:
217
«Non mi è straniero questo viaggiatore; molti anni or sono egli passò di qui. Si chiamava Zarathustra; ma ora
è mutato.
Portavi allora la tua cenere al monte; – vuoi tu oggi portare il fuoco nelle valli? Non temi il castigo degli
incendiari?
Sì, io riconosco Zarathustra. L'occhio suo è puro e sulle labbra non nasconde segno di disgusto. Non s'avanza
egli simile a un danzatore?
Zarathustra si è trasformato; è ridivenuto un bambino; Zarathustra è un ridesto; che vuoi tu ora fra i
dormienti?
Tu vivevi nella solitudine come in un mare, e il mare ti cullava. Ahimè, vuoi tu approdare? Ahimè, vuoi
novellamente trascinare da te stesso il tuo corpo?».
Zarathustra rispose: «Io amo gli uomini».
«Perchè – disse il santo – mi rifugiai nella selva e nel deserto? Non forse perchè amai troppo gli uomini?
Ora amo Dio e non amo gli uomini. L'uomo è per me una cosa troppa imperfetta. L'amore per gli uomini mi
ucciderebbe».
Zarathustra rispose: «Non parlai d'amore! Io reco agli uomini un dono».
«Non dare loro nulla – disse il santo. – Togli loro piuttosto qualche cosa o aiutali a portarla – codesto gioverà
loro più di tutto: purchè giovi anche a te! E se vuoi donar loro qualcosa, non dare più di una elemosina e
lascia che essi te la chiedino!»
«No, rispose Zarathustra, io non dispenso elemosine. Non sono abbastanza povero per far ciò».
Il santo rise di Zarathustra e parlò così: «Allora, vedi un po' se essi accettano i tuoi tesori! Essi diffidano dei
solitari e non credono che noi veniamo per donare. I nostri passi risuonano troppo solitari traverso le loro
strade. E come quando di notte, dai loro letti, odono camminare un uomo, molto prima del levar del sole, si
chiedono: dove va codesto ladro?
Non andare tra gli uomini e rimani nella selva! Va piuttosto tra gli animali! Perchè non vuoi tu essere come
me – un orso tra gli orsi, un uccello tra gli uccelli?»
«E che cosa fa il santo nella selva?» domandò Zarathustra.
Rispose il santo: «Io compongo canzoni e le canto; e quando le compongo, rido, piango e mormoro: così
lodo Iddio.
Col cantare, col piangere, col ridere e col mormorare, io lodo Iddio che è il mio nume. Ma che cosa ci porti
tu in dono?».
Quando Zarathustra ebbe udito queste parole, salutò il santo e disse: «Che cosa avrei io da darvi? Ma
lasciatemi partir presto, perchè non vi tolga nulla!». E così si separarono, l'un dall'altro, il vecchio e l'uomo,
ridendo come ridono due fanciulli.
Ma quando Zarathustra fu solo, parlò così al suo cuore: «Sarebbe dunque possibile! Questo vecchio santo
non ha ancora sentito dire, nella sua foresta, che Dio è morto!».
3.
Quando Zarathustra giunse alla vicina città che è presso le foreste, trovò gran popolo raccolto sul mercato:
poichè era corsa voce che vi si sarebbe veduto un funambolo. E Zarathustra così parlò al popolo:
«Io insegno a voi il Superuomo. L'uomo è cosa che deve essere superata. Che avete fatto voi per superarlo?
Tutti gli esseri crearono finora qualche cosa oltre sé stessi: e voi volete essere il riflusso di questa grande
marea, e tornare piuttosto al bruto anzichè superare l'uomo?
Che cosa è la scimmia per l'uomo? Una derisione o una dolorosa vergogna. E questo appunto dev'essere
l'uomo per il Superuomo: una derisione o una dolorosa vergogna.
Voi avete tracciata la via dal verme all'uomo, ma molto c'è ancora in voi del verme. Una volta eravate
scimmie, e ancor adesso l'uomo è più scimmia di tutte le scimmie. Ma anche il più saggio, fra di voi, non è
che una cosa sconnessa, un essere ibrido tra pianta e fantasma.
E nondimeno vi consiglio io forse di divenir piante o fantasmi?
Ecco, io vi insegno il superuomo!
Il superuomo è il senso della terra. Dica la vostra volontà: il superuomo sia il senso della terra!
Vi scongiuro, fratelli miei, restate fedeli alla terra, e non credete a coloro che vi parlano di speranze
soprannaturali.
Sono avvelenatori, lo sappiano o no. Sono spregiatori della vita, moribondi, avvelenatori di sè medesimi; la
terra ne è stanca: se ne vadano dunque!
218
L'oltraggio a Dio era una volta il maggior delitto: ma Dio è morto e morirono con lui anche questi
bestemmiatori.
Oltraggiar la terra è quanto vi sia di più terribile, e stimare le viscere dell'imperscrutabile più che il senso
della terra è una colpa spaventosa. Una volta l'anima guardava con disprezzo il corpo: e quel disprezzo era
una volta il più alto ideale – lo voleva magro, odioso, affamato. Pensava, in tal modo, di sfuggire a lui e alla
terra.
Oh, quest'anima era anch'essa magra, odiosa, affamata: e la crudeltà sua gioia suprema.
Ma voi pure, fratelli miei, ditemi: che cosa vi rivela il vostro corpo intorno all'anima vostra? Essa non è forse
miseria e sozzura, e compassionevole contentezza di sé medesima?
In verità l'uomo è fangosa corrente. Bisogna addirittura essere un mare per poter ricevere in sè un torbido
fiume senza divenire impuro.
Ecco, io vi insegno il superuomo: egli è questo mare, e in esso può inabissarsi il vostro grande disprezzo.
Che di più sublime potete voi sperimentare? Ecco l'ora del maggior disprezzo, l'ora nella quale vi verrà a
noia non solo la vostra felicità, ma anche la vostra ragione e la vostra virtù.
L'ora in cui dite: «Che importa la mia felicità? Essa è povertà e sozzura e miserabile contentezza. Ma la mia
felicità dovrebbe giustificare la vostra stessa vita!».
L'ora in cui dite: «Che importa della mia ragione? Brama essa la scienza come il leone il nutrimento? Essa è
povertà e sozzura e una miserabile contentezza!».
L'ora in cui dite: «Che importa della mia virtù? Non mi ha ancor reso furibondo. Come sono stanco del mio
bene e del mio male! Tutto ciò è miseria e sozzura e miserabile contentezza!».
L'ora in cui dite: «Che importa della mia giustizia? Non vedo che io sia fiamma e carbone. Ma il giusto è
fiamma e carbone!».
L'ora in cui dite: «Che importa della mia pietà? La pietà non è forse la croce su cui inchiodano colui che ama
gli uomini? Ma la mia pietà non è crocifissione».
Avete già parlato così? Avete già gridato così? Ah se vi avessi già udito gridare così!
Non il vostro peccato – la vostra moderazione grida contro il cielo, la vostra avarizia nello stesso peccato!
Dov'è il fulmine che vi lambisca con la lingua?
Dov'è la follia con la quale potete esaltarvi?
Ecco, io v'insegno il superuomo: egli è questo fulmine, egli è questa follia!».
Allorchè Zarathustra ebbe parlato così, uno del popolo gridò: «Abbiamo ora udito abbastanza del funambolo;
fate che adesso lo vediamo!». E tutto il popolo rise di Zarathustra. Ma il funambolo che credette la parola
rivolta a lui, si accinse all'opera sua.
4.
Ma Zarathustra guardava il popolo e si meravigliava. Poi disse:
«L'uomo è una corda tesa tra l’animale e il superuomo – una corda sopra l'abisso.
Pericoloso l'andare alla parte opposta, pericoloso il restare a mezza via, pericoloso il guardare indietro,
pericoloso il tremare e l'arrestarsi.
Ciò ch'è grande nell'uomo è l'essere un ponte e non una meta: ciò che si può amare nell'uomo è l'essere una
transizione e una distruzione.
Amo quelli che sanno vivere soltanto per sparire, poichè son coloro appunto che vanno oltre.
Io amo i grandi spregiatori perchè sono i grandi adoratori, frecce del desiderio verso l'opposta riva.
Amo coloro che non cercano, oltre le stelle, una ragione per offrirsi in sacrificio o perire; amo coloro che si
sacrificano alla terra, perchè la terra appartenga un giorno al superuomo.
Amo colui che vive per conoscere, e che vuol conoscere affinchè, un giorno, viva il superuomo. E in tal
modo egli vuol la propria distruzione.
Amo colui che lavora e inventa, per edificare una casa al superuomo e preparare a lui la terra, gli animali e le
piante: giacchè vuole così la sua distruzione.
Amo colui che non ritiene per sè una sola goccia del suo spirito, ma che vuol essere interamente lo spirito
della sua virtù: così egli varca, quale spirito, il ponte.
Amo colui che della sua virtù fa la propria inclinazione e il proprio destino: così vuole per amore della
propria virtù vivere ancora o non più vivere.
Amo colui che della sua virtù fa la propria inclinazione e il proprio destino: così vuole per amore della
propria virtù vivere ancora o non più vivere.
219
Amo colui che non vuole avere troppe virtù. Una virtù vale più di due, perchè essa è un nodo più saldo al
quale s'aggrappa il destino.
Amo colui l'anima del quale si prodiga,che non vuole ringraziamento e non restituisce: giacchè egli dona
sempre e non vuol conservare nulla di sè.
Amo colui che si vergogna se il dado cade in suo favore e si domanda: sono io dunque un pazzo giocatore?
poichè egli vuole perire.
Amo colui che getta parole d'oro dinanzi alle sue azioni e mantiene sempre di più di quanto ha promesso
poichè egli vuole la propria distruzione.
Amo colui che giustifica i venturi e redime i passati: poichè egli vuole perire in causa dei presenti.
Amo colui che castiga il suo Dio perchè lo ama: giacchè egli deve perire per la collera del suo Dio.
Amo colui la cui anima è profonda anche nella ferita, e che può perire per un piccolo avvenimento: così egli
passa volentieri sul ponte.
Amo colui l'anima del quale è traboccante, così ch'egli dimentica sè stesso e tutte le cose che sono in lui: così
tutte le cose cooperano alla sua distruzione.
Amo colui che è libero spirito e libero cuore: così la sua testa non è che un viscere del suo cuore, ma il cuore
lo spinge alla rovina.
Amo tutti coloro che sono come gocce pesanti, cadenti una per una dalla fosca nube sospesa su gli uomini:
esse annunziano che viene il fulmine, e periscono quali messaggeri.
Guardate, io sono un nunzio del fulmine e una pesante goccia della nube: ma questo fulmine si chiama
superuomo».
5.
Quando Zarathustra ebbe pronunciate queste parole, guardò di nuovo gli uomini e tacque. «Eccoli – disse al
suo cuore – essi ridono: essi non mi comprendono, io non sono bocca per queste orecchie. Bisogna dunque
prima spezzar loro le orecchie affinchè essi imparino a intender con gli occhi?
Bisogna fardello strepito come cembali e predicatori della penitenza? Oppure essi non credono che a colui
che balbetta?
Essi hanno qualcosa della quale vanno superbi. Come chiamano però, ciò che li fa superbi? La chiamano
cultura: essa li distingue dai pastori di capre.
Perciò odono malvolentieri per loro la parola «disprezzo».
Voglio dunque parlare al loro orgoglio. Voglio dunque parlar loro di ciò che è più spregevole: cioè
dell'ultimo uomo». E così parlò Zarathustra al popolo:
«È tempo che l'uomo fissi a sè medesimo uno scopo. È tempo che l'uomo pianti il seme della sua più alta
speranza.
Il suo terreno è ancora abbastanza ricco per questo. Ma questo terreno diverrà un giorno povero e sterile e
nessun altro albero potrà crescervi.
Ahimè! Viene il tempo nel quale l'uomo non getterà più al di sopra degli uomini il dardo del suo desiderio, e
la corda del suo arco più non saprà vibrare!
Vi dico: bisogna ancora portare in sè un caos, per poter generare una stella danzante. Vi dico: avete ancora
del caos in voi. Ahimè! Viene il tempo in cui l'uomo non potrà più generare alcuna stella. Ahimè! giunge il
tempo del più spregevole tra gli uomini che non sa più disprezzare sé stesso.
Guardate! Io vi mostro l'ultimo uomo.
«Che cosa è amore? Che cosa è creazione? Che cosa è nostalgia? Che cosa è astro?» – così chiede l'ultimo
uomo ammiccando.
La terra sarà divenuta allora piccina e su di lei saltellerà l'ultimo uomo che impicciolisce ogni cosa.
La sua razza è indistruttibile come quella della pulce; l'ultimo uomo vive più a lungo di tutti.
«Noi abbiamo inventato la felicità» – dicono gli ultimi uomini e ammiccano.
Essi hanno abbandonate le regioni dove duro era vivere: giacchè si ha bisogno di calore. Si ama ancora il
vicino e ci si stropiccia a lui: giacchè si ha bisogno di calore.
Ammalarsi e diffidare equivale per essi a peccato: avanziamo guardinghi. Folle chi incespica ancora nei sassi
o negli uomini!
Un po' di veleno di qui e di là: ciò produce sogni gradevoli. E molto veleno infine, per una gradevole morte.
Si lavora ancora poichè il lavoro è uno svago. Ma si ha cura che lo svago non ecciti troppo.
Non si diviene più poveri e ricchi: entrambe queste cose sono troppo opprimenti. Chi vuole ancora regnare?
Chi ancora obbedire? Entrambe queste cose sono troppo opprimenti.
220
Nessun pastore e un solo gregge. Ognuno vuol la stessa cosa, ognuno è simile: chi sente altrimenti, va
volentieri al manicomio.
«Una volta tutto il mondo era pazzo» dicevano i più astuti ammiccando.
Si è prudenti e si sa tutto ciò che accade: così non si hanno limiti nel deridere. Ci si bisticcia ancora, ma
subito ci si riconcilia – altrimenti ci si rovina lo stomaco.
Abbiamo i nostri svaghi per il giorno e i nostri svaghi per la notte: ma pregiamo la salute.
«Noi abbiamo inventato la felicità» dicono, ammiccando gli ultimi uomini».
E qui Zarathustra terminò il primo discorso che si chiama anche «l'introduzione»: giacchè in quel punto
l'interruppe il clamore e la gioia della folla. «Dacci questo ultimo uomo, o Zarathustra – essi gridavano –
rendici simili a quest'ultimo uomo». E tutto il popolo giubilava e faceva schioccare la lingua. Ma Zarathustra
divenne triste e disse al suo cuore:
«Essi non mi comprendono: io non sono bocca per queste orecchie.
Troppo a lungo, certo, vissi nella montagna, troppo ascoltai i ruscelli e gli alberi: ora parlo a loro come a
pastori di capre.
L'anima mia è serena e luminosa quale montagna al mattino. Ma essi pensano che io sia freddo e un buffone
dalle burle atroci.
Ed ecco che mi guardano e ridono: e mentre ridono essi mi odiano ancora. Vi è del ghiaccio nel loro riso».
6.
Ma allora accadde qualcosa, che fece ammutolire ogni bocca, irrigidire ogni sguardo. Nel frattempo il
saltimbanco aveva infatti cominciato il suo lavoro: era uscito da una porticina e camminava su la corda tesa
fra le due torri, così che rimaneva sospeso sopra il mercato e la folla. Quando fu appunto a metà del suo
cammino, la piccola porta si aperse ancora una volta, e saltò fuori un garzone screziato, somigliante a un
pagliaccio, che seguì con passi rapidi il primo. «Avanti, zoppo, gridò la sua terribile voce, avanti poltrone,
paltoniere, faccia smunta! Bada ch'io non ti carezzi con le mie calcagna! Che fai tu qui fra le torri?
Bisognerebbe appunto chiuderti nella torre; tu sbarri la via a uno migliore di te». E ad ogni parola gli si
avvicinava sempre più: ma quando egli fu soltanto a un passo da lui, allora avvenne questa cosa terribile che
fece ammutolire ogni bocca ed irrigidì ogni sguardo – egli gettò un grido indemoniato e saltò oltre colui che
gli impediva il cammino. Ma questi, allorchè vide vincer così il proprio rivale, perdette la testa e la fune;
gettò via la pertica e più svelto di questa, come un turbine di braccia e di gambe, precipitò nell'abisso. Il
mercato e il popolo somigliavano al mare quando si solleva la tempesta: tutti fuggivano l'un dall'altro e l'uno
sopra l'altro, e principalmente in quel punto ove doveva precipitare il corpo.
Zarathustra però non si mosse, e proprio accanto a lui cadde il corpo straziato, sfracellato, ma non morto
ancora. Dopo un poco quell'infranto rinvenne e vide Zarathustra inginocchiato presso di lui. «Che fai tu qui?,
disse infine; sapevo da gran tempo che il diavolo m'avrebbe giocato di sgambetto. Ora mi trascina all'inferno:
vuoi tu impedirglielo?».
«Sul mio onore, o amico, rispose Zarathustra, non esiste affatto quanto tu dici: non vi è nessun diavolo e
nessun inferno. L'anima tua morirà prima ancora del tuo corpo. Non temere più nulla».
L'uomo guardò su, diffidente. «Se tu dici la verità, diss'egli poi, allora io non perdo nulla perdendo la vita. Io
non sono molto più di una bestia alla quale insegnarono a ballare a furia di busse e di scarso alimento».
«Non è punto così, disse Zarathustra; tu hai fatto del pericolo il tuo mestiere; in ciò nulla vi è di spregevole.
Ora tu perisci pel tuo mestiere: voglio quindi seppellirti con le mie mani».
Quando Zarathustra ebbe detto questo, il moribondo non rispose più, ma scosse la mano, come se cercasse la
mano di Zarathustra per ringraziarlo.
7.
Giunse frattanto la sera ed il mercato si avvolse di tenebre: allora il popolo si disperse, poi che anche la
curiosità e lo spavento si stancano. Ma Zarathustra sedette presso il morto, sulla terra, e s'immerse nei
pensieri: così dimenticava il tempo. E giunse alla fine la notte, e soffiò un vento freddo sul solitario. Allora
Zarathustra si alzò e disse al suo cuore:
«Davvero una bella pesca ha fatto oggi Zarathustra! Non trovo alcun uomo, bensì un cadavere.
Inquietante è l'esistenza umana e, di più, sempre priva di senso: un buffone può divenirle fatale.
Io voglio insegnare agli uomini il senso della loro vita: chi è il superuomo, il lampo di quella oscura nube che
è l'uomo.
221
Ma sono ancor lungi da essi e il senso mio non parla ai loro sensi. Per gli uomini io sono ancora un punto
centrale tra pazzo e cadavere.
Buia è la notte, buie sono le vie di Zarathustra. Vieni, rigido e freddo compagno. Ti conduco al luogo ove ti
seppellirò con le mie mani».
8.
Allorchè Zarathustra ebbe detto questo al suo cuore, si caricò il cadavere sulle spalle e si pose in cammino. E
non aveva ancora fatto cento passi, quando un uomo gli si avvicinò e gli sussurrò nell'orecchio – e vedi!
Colui che parlava era il buffone della torre.
«Vattene via da questa città, o Zarathustra, diss'egli; qui troppi ti odiano. I buoni e i giusti ti odiano e ti
chiamano loro nemico e spregiatore; ti odiano i credenti della vera fede e ti chiamano il pericolo della folla.
Fu tua fortuna che si ridesse di te: e veramente tu parlavi a guisa di un buffone. Fu tua fortuna che tu ti
accompagnassi al cane morto; abbassandoti così ti sei salvato per oggi. Ma vattene via da questa città;
altrimenti domani io salterò sopra di te, un vivente sopra un cadavere». E quan-do ebbe detto ciò, disparve,
l'uomo; ma Zarathustra continuò il cammino attraverso le vie tenebrose. Alle porte della città s'incontrò coi
becchini: essi alzarono le fiaccole per vederlo in viso, riconobbero Zarathustra e si burlarono molto di lui.
«Zarathustra porta con sè il cane morto: bravo, Zarathustra divenne becchino! Giacchè le nostre mani sono
troppo pulite per questa vivanda. Vuol forse Zarathustra rubare la preda al diavolo? Ebbene! Buon appetito
pel desinare! Purchè il diavolo non sia miglior ladro di Zarathustra! – Egli ruba entrambi, entrambi divora!».
Ed essi ridevano fra di loro e bisbigliavano.
Zarathustra non disse parola e proseguì la sua via. Come ebbe camminato due ore lungo boschi e paludi,
l'aver troppo a lungo udito l'urlo dei lupi destò anche in lui la fame. Si fermò quindi a una casa isolata, dove
ardeva una luce. «La fame mi assale come un brigante, disse Zarathustra.
La fame mi assale tra i boschi e le paludi, nella notte profonda.
Meravigliosi capricci ha la mia fame. Sovente essa non mi viene che dopo il pasto, ed oggi non mi è venuta
in tutto il giorno: dove s'è dunque indugiata?».
E Zarathustra picchiò alla porta della casa. Apparve un vecchio che portava il lume e chiese: «Chi viene a me
e al mio cattivo sonno?»
«Un vivente ed un morto, disse Zarathustra. Datemi da mangiare e da bere, me ne dimenticai durante il
giorno. Chi dà da mangiare agli affamati ristora la propria anima: così parla la sapienza».
Il vecchio si allontanò, ma tornò tosto indietro ed offerse a Zarathustra pane e vino. «È una cattiva contrada
per gli affamati, diss'egli; per questo abito qui. Bestie e uomini vengono a me, solitario. Ma invita anche il
tuo compagno a mangiare e a bere, egli è più stanco di te». Zarathustra rispose: «Morto è il mio compagno, e
ve lo deciderei difficilmente». «Questo non mi riguarda, disse il vecchio arcigno; chi bussa alla mia porta
deve prendere anche ciò che gli offro. Mangiate e state bene!».
Zarathustra camminò poi nuovamente per due ore, affidandosi alla via ed al chiaror delle stelle: giacchè egli
era solito andar di notte, e amava guardare in faccia tutto ciò che dorme. Ma quando cominciò a spuntare il
giorno, Zarathustra si trovò in un profondo bosco e non vide più alcun sentiero. Allora depose il morto nella
cavità di un albero, all'altezza della sua testa – poichè voleva proteggerlo dai lupi – e si sdraiò per terra sul
musco. E subito s'addormentò, stanco il corpo, ma con l'anima imperturbata.
9.
A lungo dormì Zarathustra, e non l'aurora soltanto, ma anche il mattino gli passò sul volto. Gli si apersero gli
occhi alla fine: meravigliato guardò Zarathustra nella foresta e nel silenzio, meravigliato guardò entro di sè.
Poi s'alzò svelto, come il marinaio che vede improvvisamente la terra, e mandò un grido di giubilo poichè
egli vedeva una nuova verità.
E così parlò quindi al suo cuore:
«Una luce è sorta in me: ho bisogno di compagni e di compagni viventi – non compagni morti e cadaveri,
che porto con me dove voglio.
Ho bisogno di compagni viventi, i quali mi seguano, perchè vogliono seguire sè stessi – e là dove io voglio.
Una luce è sorta in me: Zarathustra non parli al popolo ma ai compagni! Zarathustra non deve essere il
pastore e il cane di una mandria!
A distogliere molti dalla mandria – a questo io venni. Il popolo e la mandria devono irritarsi con me: il
pastore mi chiamerà ladro.
222
Io dico pastori, ma essi si dicono i buoni e i giusti. Io dico pastori: ma essi si dicono i credenti della vera
fede.
Guarda i buoni e i giusti! Chi odiano essi di più? Colui che spezza le loro tavole dei valori, il distruttore, il
corruttore: – ma questi è colui che crea.
Compagni cerca colui che crea e non cadaveri e neppur mandrie e credenti. Creatori come lui cerca il
creatore, i quali scrivano nuovi valori su nuove tavole.
Compagni cerca il creatore, e mietitori che mietano con lui: giacchè in lui tutto è maturo per la messe. Ma a
lui mancano le cento frasi: sì che egli strappa irato le spighe.
Compagni cerca il creatore, e tali che sappiano affilare le proprie falci. Saranno chiamati distruttori e
spregiatori del bene e del male. Ma essi sono i mietitori e i festeggiatori.
Zarathustra cerca compagni che con lui creino, mietano e facciano festa: che cos'ha egli di comune con le
mandrie, i pastori e i cadaveri?
E tu, mio primo compagno, riposa in pace! Ti seppellii bene nella cavità dell'albero, e bene ti nascosi ai lupi.
Ma io mi separo da te. Il tempo passa. Fra aurora e aurora mi giunse una nuova verità.
Non pastore debbo essere, non becchino. Non voglio parlare nuovamente al popolo: per l'ultima volta parlai
a un morto.
Voglio accompagnarmi a chi crea, a chi miete, a chi festeggia: voglio mostrar loro l'arcobaleno e tutte le
scale del superuomo.
Canterò la mia canzone ai solitari e a quelli che sono due nella solitudine; a chi ha ancora orecchie per
l'inaudito, a questi voglio opprimere il cuore con la mia felicità.
Io tendo alla mia mèta, seguo la mia strada; salterò oltre gli esitanti e i lenti. Sia così mio il cammino la loro
distruzione!».
10.
Zarathustra aveva detto questo al suo cuore, quando il sole era a mezzogiorno: allora egli guardò in alto
interrogando – poichè udiva sopra di sè l'acuto grido di un uccello. Ed ecco! Un'aquila volava a larghi cerchi
per l'aria, e da essa pendeva un serpente, non come una preda ma come un amico: giacchè essa lo teneva
avvolto intorno al collo.
«Ecco i miei animali!» disse Zarathustra, e si rallegrò di cuore.
«Il più superbo animale sotto il sole, e l'animale più astuto – sono andati ad esplorare.
Essi vogliono accertarsi se Zarathustra viva ancora. In verità vivo io ancora?
Trovai maggiori pericoli fra gli uomini che fra gli animali; per vie pericolose va Zarathustra. Possano
guidarmi i miei animali!».
Allorchè Zarathustra ebbe detto ciò, ricordò le parole del santo nel bosco, e sospirando disse al suo cuore:
«Potessi essere più accorto! Potessi essere accorto, nel profondo, come il mio serpente!
Ma io chiedo l'impossibile; pregherò il mio orgoglio di accompagnarsi sempre alla mia saggezza! E se mi
abbandonasse un giorno la mia saggezza – ah, purtroppo essa ama volarsene via! – possa allora il mio
orgoglio volarsene insieme con la mia follia!».
Così cominciò la discesa di Zarathustra.
Traduzione di Domenico Ciampoli, Edizioni Monanni, Milano, 1927. da Liberliber.it
223
Martin Heidegger
ESSERE E TEMPO
§ 50 Schizzo della struttura ontologica-esistenziale della morte
La morte sovrasta l'esserci. La morte non è affatto una semplice presenza non ancora attuatasi, non è un
mancare ultimo ridotto ad minimum, ma è, prima di tutto, un'imminenza che sovrasta.
Ma all'esserci, come essere-nel-mondo, sovrastano molte cose. Il carattere d'imminenza sovrastante non è
esclusivo della morte. Un'interpretazione del genere potrebbe far credere che la morte sia un evento che
s'incontra nel mondo, minaccioso nella sua imminenza. Un temporale può sovrastare come imminente; la
riparazione d'una casa, l'arrivo d'un amico, possono essere imminenti; tutte cose, queste, che sono semplicipresenze o utilizzabili o compresenze. Il sovrastare della morte non ha un essere di questo genere. […]
La morte è una possibilità di essere che l'esserci stesso deve sempre assumersi da sé. Nella morte l'esserci
sovrasta se stesso nel suo poter-essere più proprio. In questa possibilità ne va per l'esserci puramente e
semplicemente del suo essere-nel-mondo. La morte è per l'esserci la possibilità di non-poter-più-esserci.
Poiché in questa possibilità l'esserci sovrasta se stesso, esso viene completamente rimandato al proprio poteressere più proprio. In questo sovrastare dell'esserci a se stesso, dileguano tutti i rapporti con gli altri esserci.
Questa possibilità assolutamente propria e incondizionata è, nel contempo, l'estrema. Nella sua qualità di
poter-essere, l'esserci non può superare la possibilità della morte. La morte è la possibilità della pura e
semplice impossibilità dell'esserci. Così la morte si rivela come la possibilità più propria, incondizionata e
insuperabile. Come tale è un'imminenza sovrastante specifica. [...]
Questa possibilità più propria, incondizionata e insuperabile, l'esserci non se la crea accessoriamente e
occasionalmente nel corso del suo essere. Se l'esserci esiste, è anche già gettato in questa possibilità. [...].
L'esser-gettato nella morte gli si rivela nel modo più originario e penetrante nella situazione emotiva
dell'angoscia. Un'angoscia davanti alla morte è angoscia davanti al poter-essere più proprio, incondizionato e
insuperabile. [...] L'angoscia non dev'essere confusa con la paura davanti al decesso. Essa non è affatto una
tonalità emotiva di 'depressione', contingente, casuale, alla mercé dell'individuo; in quanto situazione
emotiva fondamentale dell'esserci, essa costituisce l'apertura dell'esserci al suo esistere come esser-gettato
per la propria fine. Si fa così chiaro il concetto esistenziale dei morire come esser-gettato nel poter-essere più
proprio, incondizionato e insuperabile, e si approfondisce la differenza rispetto al semplice scomparire, al
puro cessare di vivere e all'esperienza vissuta dei decesso. […]
224
§ 51 L’essere-per-la-morte e la quotidianità dell’Esserci
Un'interpretazione pubblica dell'esserci dice: "Si muore"; ma poiché si allude sempre a ognuno degli Altri e a
noi nella forma dei Si anonimo, si sottintende: di volta in volta non sono io. Infatti il Si è il nessuno. [...] Il
morire, che è mio in modo assolutamente insostituibile, è confuso con un fatto di comune accadimento che
capita al Si. Questo tipico discorso parla della morte come di un "caso" che ha luogo continuamente. Esso fa
passare la morte come qualcosa che è sempre già "accaduto", coprendone il carattere di possibilità e quindi le
caratteristiche di incondizionatezza e di insuperabilità. Con quest'equivoco l'esserci si pone nella condizione
di perdersi nel Si proprio rispetto al poter-essere che più di ogni altro costituisce il suo se-Stesso più proprio.
Il Si fonda e approfondisce la tentazione di coprire a se stesso l'essere-per-la-morte più proprio.
Questo movimento di diversione dalla morte coprendola domina a tal punto la quotidianità che, nell'essereassieme, "i parenti più prossimi" vanno sovente ripetendo al "morente" che egli sfuggirà certamente alla
morte e potrà far ritorno alla tranquilla quotidianità del mondo di cui si prendeva cura. Questo "aver cura"
vuol così "consolare il morente". Ci si preoccupa di riportarlo nell'esserci, aiutandolo a nascondersi la
possibilità del suo essere più propria, incondizionata e insuperabile. Il Si si prende cura di una costante
tranquillizzazione nei confronti della morte. In realtà ciò non vale solo per il "morente" ma altrettanto per i
consolanti. [...] Il Si non ha il coraggio dell'angoscia davanti alla morte. [...] Nell'angoscia davanti alla
morte, l'esserci è condotto davanti a se stesso in quanto rimesso alla sua possibilità insuperabile. Il Si si
prende cura di trasformare quest'angoscia in paura di fronte a un evento che sopravverrà. Un'angoscia,
banalizzata equivocamente in paura, è presentata come una debolezza che un esserci sicuro di sé non deve
conoscere. […]
Un essere-per-la-morte è l'anticipazione di un poter-essere di quell'ente il cui modo dì essere è l'anticiparsi
stesso. Nella scoperta anticipante di questo poter-essere, l'esserci si apre a se stesso nei confronti della sua
possibilità estrema. Ma progettarsi sul poter essere più proprio significa poter comprendere se stesso entro
l'essere dell'ente così svelato: l'anticipazione dischiude all'esistenza, come sua estrema possibilità, la rinuncia
a se stessa, dissolvendo in tal modo ogni solidificazione su posizioni esistenziali raggiunte.
Martin Heidegger, Essere e tempo, UTET
225
Martin Heidegger
LA QUESTIONE DELLA TECNICA
Tutti conoscono le due risposte che si danno alla nostra domanda. La prima dice: la tecnica è un mezzo in
vista dei fini. L'altra dice: la tecnica è un'attività dell'uomo. Queste due definizioni della tecnica sono
connesse. Proporsi degli scopi e apprestare e usare i mezzi in vista di essi, infatti, è un'attività dell'uomo.
All'essenza della tecnica appartiene l'apprestare e usare mezzi, apparecchi e macchine, e vi appartengono
anche questi apparati e strumenti stessi, come pure i bisogni e i fini a cui essi servono. La totalità di questi
dispositivi è la tecnica. Essa stessa è un dispositivo, o in latino, un instrumentum.
La rappresentazione comune della tecnica, per cui essa è un mezzo e un'attività dell'uomo, può perciò
denominarsi la definizione strumentale e antropologica della tecnica.
Chi vorrà negare che sia esatta? Essa si conforma chiaramente a ciò che si ha davanti gli occhi quando si
parla di tecnica. La definizione strumentale di tecnica è così straordinariamente esatta che vale anche per la
tecnica moderna, la quale peraltro viene generalmente considerata, e con una certa ragione, qualcosa di
completamente diverso dalla tecnica artigianale del passato. Anche una centrale elettrica, con le sue turbine
ed i suoi generatori, è un mezzo apprestato dall'uomo per uno scopo posto dall'uomo. […]
Ma nell'ipotesi che la tecnica non sia un puro mezzo che ne sarà della volontà di dominarla? […] Fino a che
non ci dedicheremo a questi problemi, la causalità, e con essa la strumentalità, e insieme con questa la
definizione corrente della tecnica, resteranno qualcosa di oscuro e non-fondato.
[Le cause. ] L'argento è ciò di cui il calice è fatto. In quanto materia di esso, è corresponsabile del calice.
Questo deve all'argento ciò in cui consiste. Ma l'oggetto sacrificale non rimane debitore solo dell'argento. In
quanto calice, ciò che è debitore dell'argento appare nell'aspetto di calice e non di fibbia o di anello.
L'oggetto sacrificale è quindi anche debitore dell'aspetto di calice. L'argento, in cui l'aspetto di calice è fatto
entrare, e l'aspetto in cui l'argento appare, sono entrambi corresponsabili dell'oggetto sacrificale.
Responsabile di esso rimane però, anzitutto un terzo. Questo è ciò che preliminarmente racchiude il calice
nel dominio della consacrazione dell'offerta. Da questo esso è circoscritto come oggetto sacrificale. Ciò che
circoscrive de-finisce la cosa. Ma con tale fine la cosa non cessa, anzi a partire da essa comincia ad essere
ciò che sarà dopo la produzione. Ciò che de-finisce e compie, in questo senso, si chiama in greco telos,
termine che troppo spesso si traduce con "fine" o "scopo" travisandone il senso. Il telos risponde di ciò che,
come materia e come aspetto, è corresponsabile dell'oggetto sacrificale.
226
C'è infine un quarto corresponsabile della presenza e dell'esser disponibile dell'oggetto sacrificale compiuto:
è l'orafo, ma non in quanto egli operando, causi il calice compiuto come effetto di un fare, cioè non in
quanto causa efficiens.
La dottrina di Aristotele non conosce né la causa che si indica con un tal nome, né usa un termine greco
corrispondente.
L'orafo considera e raccoglie i tre modi menzionati dell'esser-responsabile. Riflettere, considerare, in greco si
dice legein, lògos. Questo si fonda sull'hypokeìmenon, il far apparire. L'orafo è corresponsabile come ciò da
cui la produzione e il sussistere del calice sacrificale ricevono la loro prima emergenza e la conservano. I tre
modi dell'esser-responsabile menzionati prima devono alla considerazione dell'orafo il fatto ed il modo del
loro apparire ed entrare in gioco nella produzione del calice sacrificale.
Nell'oggetto sacrificale presente e disponibile si dispiegano quindi quattro modi dell'esser responsabile. Sono
distinti fra loro e tuttavia connessi. Che cos'è che li tiene preliminarmante uniti? A che livello si costituisce la
connessione dei quattro modi dell'essere responsabile? Donde proviene l'unità delle quattro cause? Che cosa
significa, insomma, pensato in modo greco, questo esser responsabile?
Noi moderni siamo troppo facilmente inclini a intendere l'esser responsabile in senso morale, come una
mancanza, oppure a interpretarlo come un operare. In entrambi i casi ci precludiamo la via a capire il senso
originario di ciò che più tardi è stato chiamato causalità. Finché questa via non è aperta, neppure potremo
scorgere che cosa sia propriamente la strumentalità che si fonda sulla causalità.
Per difenderci da tali fraintendimenti dell'esser-responsabile, cerchiamo di chiarire i suoi quattro modi a
partire da ciò di cui essi rispondono. Nel nostro esempio, essi rispondono dell'esser dinanzi a noi e
disponibile del calice d'argento come oggetto sacrificale. L'esser dinnanzi a noi e l'esser disponibile
caratterizzano la presenza di una cosa-presente. I quattro modi dell'esser-responsabile portano qualcosa
all'apparire. Fanno sì che questo qualcosa si avanzi nella presenza. Essi lo liberano per questo suo avanzare,
cioè per il suo compiuto avvento. L'esser responsabile ha il carattere fondamentale di questo lasciar-avanzare
nell'avvento. Nel senso di questo lasciar avanzare l'esser-responsabile è il far avvenire. Sulla base del senso
che i greci annettevano all'esser-responsabile, alla aitia, noi diamo ora all'espressione far-avvenire un
significato più ampio, in modo che esso indichi l'essenza della causalità nel senso greco. Il significato
comune e ristretto del termine "cagionare" esprime invece solo qualcosa come una spinta od un impulso
iniziale, e indica una specie secondaria di causa nell'insieme di causalità.
In che ambito si dispiega la connessione dei quattro modi del far-avvenire? Essi fanno avvenire nella
presenza ciò che non è ancora presente. Essi sono dunque tutti egualmente dominati da un portare, quello che
porta ciò che è presente all'apparire. Che cosa sia questo portare, ce lo dice Platone in un passo del Simposio:
"Ogni far-avvenire di ciò che - qualunque cosa sia - dalla non presenza passa e si avanza nella presenza è
pro-duzione.
[Disvelatezza.] Pro-duzione si da solo in quanto un nascosto viene nella disvelatezza […] Ma dove siamo
andati a perderci? Il nostro problema è quello della tecnica, e ora siamo arrivati all' aletheia, al disvelamento.
Che ha da fare l'essenza della tecnica con il disvelamento? Rispondiamo: tutto […] Se poniamo con ordine il
problema di che cosa sia veramente la tecnica concepita come mezzo, arriviamo passo a passo al
disvelamento. In esso si fonda la possibilità di ogni azione producente.
La tecnica, dunque, non è semplicemente un mezzo. La tecnica è un modo del disvelamento Se facciamo
attenzione a questo fatto, ci si apre davanti un ambito completamente diverso per l’essenza della tecnica. E’
l’ambito del disvelamento, cioè la verità. […]
Che cos'è la tecnica moderna? Anch'essa è disvelamento. Solo quando fermiamo il nostro sguardo su questo
tratto fondamentale ci si manifesta quel che vi è di nuovo nella tecnica moderna.
Il disvelamento che governa la tecnica moderna, tuttavia, non si dispiega in un pro-durre nel senso
della poiesis. Il disvelamento che vige nella tecnica moderna è una pro-vocazione la quale pretende dalla
natura che essa fornisca energia che possa come tale essere estratta e accumulata. Ma questo non vale anche
per l’antico mulino a vento? No. Le sue ali girano sì spinte dal vento, e rimangono dipendenti da suo soffio.
Ma il mulino a vento non ci mette a disposizione le energie delle sue correnti aree perché le accumuliamo.
[…]
227
All’opposto, una determinata regione viene pro-vocata a fornire all’attività estrattiva carbone e
minerali. La terra si disvela ora come bacino carbonifero, il suolo come riserva di minerali. In modo
diverso appare il terreno che un contadino coltivava, quando coltivare voleva ancora dire accudire e
curare. […] L’agricoltura è diventata industria meccanizzata dell’alimentazione.
La centrale idroelettrica non è costruita nel Reno come l’antico ponte di legno che da secoli unisce una riva
all’altra. Qui è il fiume, invece, che è incorporato nella costruzione della centrale. Esso è ciò che ora, come
fiume, è, cioè produttore di forza idrica, in base all’essere della centrale. […]
Il disvelamento che governa la tecnica moderna ha il carattere dello Stellen, del ‘richiedere’ nel senso della
pro-vocazione. […La provocazione è un ] promuove in quanto apre e mette fuori. Questo promuovere,
tuttavia, rimane fin da principio orientato a promuovere, cioè a spingere avanti, qualcosa d'altro verso la
massima utilizzazione ed il minimo costo. Il carbone estratto nel bacino carbonifero non è richiesto solo
affinché sia in generale e da qualche parte disponibile. Esso è immagazzinato, cioè "messo a posto" in vista
dell'impiego del calore solare in esso accumulato. Quest'ultimo viene provocato a riscaldare, e il
riscaldamento prodotto è impiegato per fornire vapore la cui pressione muove il meccanismo mediante il
quale una fabbrica resta in attività. […]
[Il fondo.] La parola "fondo" prende qui il significato di un termine-chiave. Esso caratterizza nientemeno
che il modo in cui è presente tutto ciò che ha rapporto al disvelamento pro-vocante. Ciò che sta nel senso del
"fondo", non ci sta più di fronte come oggetto.
Eppure un aereo da trasporto che sta sulla sua pista di decollo è ben un oggetto. Sicuro. Possiamo
rappresentarci la macchina in questi termini. Ma in tal caso essa si nasconde nel che cosa e nel come del suo
essere. Si disvela, sulla sua pista, solo in quanto "fondo", nella misura in cui è impiegata per assicurare la
possibilità del trasporto. In vista di ciò bisogna che essa, in tutta la sua struttura, in ognuna delle sue parti
costitutive, sia pronta all'impiego, cioè pronta a partire. (Qui sarebbe il luogo di discutere la definizione
hegeliana della macchina come strumento indipendente.) Confrontata con lo strumento del lavoro artigianale,
questa caratterizzazione è giusta. Solo che, appunto, la macchina viene in tal modo pensata in base
all'essenza della tecnica, alla quale invece appartiene. Vista dal punto di vista del "fondo", la macchina è il
puro e semplice contrario dell'indipendenza; essa ha infatti la sua posizione solo in base all'impiego
dell'impiegabile.
Il fatto che, in questo nostro sforzo di mostrare la tecnica moderna come disvelamento pro-vocante, si
facciano avanti termini come "richiedere", "impiegare", "fondo", e si accumulino in un modo scarno,
uniforme e perciò anche noioso - tutto questo ha la sua ragion d'essere in ciò che qui viene in questione.
Chi compie il richiedere provocante mediante il quale ciò che si chiama il reale viene disvelato come
"fondo"? Evidentemente l'uomo. In che misura egli è capace di un tale disvelamento? L'uomo può bensì
rappresentarsi questa o quella cosa in un modo o in un altro, e così pure in vari modi foggiarla e operare con
essa. Ma nella disvelatezza entro la quale di volta in volta il reale si mostra o si sottrae, l'uomo non ha alcun
potere. Il fatto che a partire da Platone il reale si mostri alla luce di idee non è qualcosa che sia stato prodotto
da Platone. Il pensatore ha solo risposto a ciò che gli ha parlato.
Solo nella misura in cui l'uomo è già, da parte sua, pro-vocato a mettere allo scoperto le energie della natura,
questo disvelamento impiegante può verificarsi. Se però l'uomo è in tal modo pro-vocato e impiegato, non
farà parte anche lui, in modo ancora più originario che la natura, del "fondo"? Il parlare comune di "materiale
umano", di "contingente di malati" di una clinica, lo fa pensare. La guardia forestale che nel bosco misura il
legname degli alberi abbattuti e che apparentemente segue nello stesso modo di suo nonno gli stessi sentieri è
oggi impiegata dall'industria del legname, che lo sappia o no. […]
[L’uomo] non diventa mai puro ‘fondo.’ […]
Nell'imposizione accade la disvelatezza conformemente alla quale il lavoro della tecnica moderna disvela il
reale come "fondo". Essa non è dunque soltanto un'attività dell'uomo, né un puro e semplice mezzo
all'interno di tale attività. La concezione puramente strumentale, puramente antropologica, della tecnica,
diventa caduca nel suo principio; né si può completarla mediante la semplice aggiunta di una spiegazione
religiosa o metafisica.
228
Resta vero, comunque che l'uomo dell'età della tecnica è pro-vocato al disvelamento in un modo
particolarmente rilevante. Tale disvelamento concerne anzitutto la natura come principale deposito di riserve
di energia. […]
Il destino del disvelamento è in sé stesso non un pericolo qualunque, ma il pericolo. […] L'uomo cammina
sull’orlo estremo del precipizio, cioè là dove egli stesso può essere preso solo più come un 'fondo'. E tuttavia
proprio quando è sotto questa minaccia l'uomo si veste orgogliosamente della figura di signore della terra.
Così si viene diffondendo l'apparenza che tutto ciò che si incontra sussista solo in quanto è un prodotto
dell'uomo. Questa apparenza fa maturare un'ultima ingannevole illusione. E' l'illusione per la quale sembra
che l'uomo, dovunque, non incontri più altri che sé stesso. […]
Ma dove c’è il pericolo, cresce
Anche ciò che salva (Hölderlin)
[…] Così - contrariamente a ogni nostra aspettativa - ciò che costituisce l'essere della tecnica alberga in sé il
possibile sorgere di ciò che salva.
Per questo, ciò che importa è che noi meditiamo su questo sorgere e lo custodiamo rimemorandolo. In che
modo? Anzitutto, bisogna che cogliamo nella tecnica ciò che ne costituisce l'essere, invece di restare
affascinati semplicemente dalle cose tecniche. Fino a che pensiamo la tecnica come strumento, restiamo
anche legati alla volontà di dominarla. E in tal caso, passiamo semplicemente accanto all'essenza della
tecnica.
Se però ci domandiamo come ciò che è strumentale dispiega il suo essere in quanto specie particolare della
causalità, allora potremo cogliere questo essere come il destino di un disvelamento.
Se infine consideriamo che ciò che costituisce l'essere dell'essenza accade in ciò che concede, il quale
adopera e salvaguarda l'uomo per farlo partecipare al disvelamento, vediamo che:
L'essenza della tecnica è in alto grado ambigua. Tale ambiguità richiama all'arcano di ogni disvelamento,
cioè della verità.
Da un lato, l'imposizione pro-voca a impegnarsi nel furioso movimento dell'impiegare, che impedisce ogni
visione dell'evento del disvelare e in tal modo minaccia nel suo fondamento stesso il rapporto con l'essenza
della verità.
D'altro lato, l'im-posizione accade da parte sua in quel concedere il quale fa sì che l'uomo - finora senza
rendersene conto, ma forse in modo più consapevole in futuro - duri nel suo essere l'adoperatosalavaguardato per la custodia dell'essenza della verità. Così appare l'aurora di ciò che salva. […]
[L’arte.] Poiché l'essenza della tecnica non è nulla di tecnico, bisogna che la meditazione essenziale sulla
tecnica e il confronto decisivo con essa avvenga in un ambito che da un lato è affine all'essenza della tecnica
e, dall'altro, né è tuttavia fondamentalmente distinto.
Tale ambito è l'arte. S'intende solo quando la meditazione dell'artista, dal canto suo, non si chiude davanti
alla costellazione della verità riguardo alla quale noi poniamo l nostra domanda.
M. Heidegger - La questione della tecnica in Saggi e discorsi - Mursia
229
Umberto Galimberti
PSICHE E TECNE. L’UOMO NELL’ETA’ DELLA TECNICA
Ciò che è veramente inquietante non è che il mondo si trasformi in un completo dominio della tecnica. Di
gran lunga più inquietante è che l'uomo non è affatto preparato a questo radicale mutamento del mondo. Di
gran lunga più inquietante è che non siamo ancora capaci di raggiungere, attraverso un pensiero meditante,
un confronto adeguato con ciò che sta realmente emergendo nella nostra epoca. M. HEIDEGGER,
Gelassenheit (1959), tr. it. L'abbandono, 1983, p. 36.
1. L'uomo e la tecnica. Siamo tutti persuasi di abitare l'età della tecnica di cui godiamo i benefici in termini
di beni e spazi di libertà. Siamo più liberi degli uomini primitivi perché abbiamo più campi di gioco in cui
inserirci. Ogni rimpianto, ogni disaffezione dal nostro tempo ha del patetico. Ma nell'assuefazione con cui
utilizziamo strumenti e servizi che accorciano lo spazio, velocizzano il tempo, leniscono il dolore, vanificano
le norme su cui sono state scalpellate tutte le morali, rischiamo di non chiederci se il nostro modo di essere
uomini non è troppo antico per abitare l'età della tecnica che non noi, ma l'astrazione della nostra mente ha
creato, obbligandoci, con un'obbligazione più forte di quella sancita da tutte le morali che nella storia sono
state scritte, a entrare e a prendervi parte.
In questo inserimento rapido e ineluttabile portiamo ancora in noi i tratti dell'uomo pre-tecnologico che agiva
in vista di scopi iscritti in un orizzonte di senso, con un bagaglio di idee proprie e un corredo di sentimenti in
cui si riconosceva. L'età della tecnica ha abolito questo scenario "umanistico", e le domande di senso che
sorgono restano inevase, non perché la tecnica non è ancora abbastanza perfezionata, ma perché non rientra
nel suo programma trovar risposte a simili domande.
230
La tecnica infatti non tende a uno scopo, non promuove un senso, non apre scenari di salvezza, non redime,
non svela la verità, la tecnica funziona, e siccome il suo funzionamento diventa planetario, questo intervento
si propone di rivedere i concetti di individuo, identità, libertà, salvezza, verità, senso, scopo, ma anche quelli
di natura, etica, politica, religione, storia, di cui si nutriva l'età pre-tecnologica e che ora, nell'età della
tecnica, dovranno essere riconsiderati, dismessi, o rifondati dalle radici.
2. La tecnica è il nostro mondo. Sono questi alcuni temi che nascono dal pensare la configurazione che
l'uomo va assumendo nell'età della tecnica. Le riflessioni qui svolte sono solo un avvio. Resta ancora molto
da pensare. Ma prima di tutto resta da pensare se le categorie che abbiamo ereditato dall'età pre-tecnologica e
che tuttora impieghiamo per descrivere l'uomo sono ancora idonee per questo evento assolutamente nuovo in
cui l'umanità, come storicamente l'abbiamo conosciuta, fa esperienza del suo oltrepassamento.
Per orientarci occorre innanzitutto farla finita con le false innocenze, con la favola della tecnica neutrale che
offre solo i mezzi che poi gli uomini decidono di impiegare nel bene o nel male. La tecnica non è neutra,
perché crea un mondo con determinate caratteristiche che non possiamo evitare di abitare e, abitando,
contrarre abitudini che ci trasformano ineluttabilmente. Non siamo infatti esseri immacolati ed estranei,
gente che talvolta si serve della tecnica e talvolta ne prescinde. Per il fatto che abitiamo un mondo in ogni
sua parte tecnicamente organizzato, la tecnica non è più oggetto di una nostra scelta, ma è il nostro ambiente,
dove fini e mezzi, scopi e ideazioni, condotte, azioni e passioni, persino sogni e desideri sono tecnicamente
articolati e hanno bisogno della tecnica per esprimersi.
Per questo abitiamo la tecnica irrimediabilmente e senza scelta. Questo è il nostro destino di occidentali
avanzati, e coloro che, pur abitandolo, pensano ancora di rintracciare un'essenza dell'uomo al di là del
condizionamento tecnico, come capita di sentire, sono semplicemente degli inconsapevoli che vivono la
mitologia dell'uomo libero per tutte le scelte, che non esiste se non nei deliri di onnipotenza di quanti
continuano a vedere l'uomo al di là delle condizioni reali e concrete della sua esistenza.
3. La tecnica è l'essenza dell'uomo. Con il termine "tecnica" intendiamo sia l'universo dei mezzi (le
tecnologie) che nel loro insieme compongono l'apparato tecnico, sia la razionalità che presiede il loro
impiego in termini di funzionalità ed efficienza. Con questi caratteri la tecnica è nata non come espressione
dello "spirito" umano, ma come "rimedio" alla sua insufficienza biologica.
Infatti, a differenza dell'animale che vive nel mondo stabilizzato dall'istinto, l'uomo, per la carenza della sua
dotazione istintuale, può vivere solo grazie alla sua azione, che da subito approda a quelle procedure tecniche
che ritagliano, nell'enigma del mondo, un mondo per l'uomo. L'anticipazione, l'ideazione, la progettazione, la
libertà di movimento e d'azione, in una parola, la storia come successione di autocreazioni hanno nella
carenza biologica la loro radice e nell'agire tecnico la loro espressione.
In questo senso è possibile dire che la tecnica è l'essenza dell'uomo, non solo perché, a motivo della sua
insufficiente dotazione istintuale, l'uomo, senza la tecnica, non sarebbe sopravvissuto, ma anche perché,
sfruttando quella plasticità di adattamento che gli deriva dalla genericità e non rigidità dei suoi istinti, ha
potuto, attraverso le procedure tecniche di selezione e stabilizzazione, raggiungere "culturalmente" quella
selettività e stabilità che l'animale possiede "per natura". Questa tesi, che A. Gehlen ha ampiamente
documentato nel nostro tempo, era stata anticipata da Platone, Tommaso d'Aquino, Kant, Herder,
Schopenhauer, Nietzsche, Bergson, dunque da grandi esponenti del pensiero occidentale, indipendentemente
dalla direzione del loro orientamento filosofico.
4. La tecnica e la rifondazione radicale della psicologia. Se si accolgono queste premesse, la psicologia
deve fare con se stessa dei conti radicali e incominciare a pensare le varie figure, oggetto del suo sapere, a
partire dalla tecnica, che è poi quel patto originario tra uomo e mondo che è rimasto "impensato" sia dalla
psicologia a indirizzo scientifico-naturalistico che tenta di "spiegare" l'uomo a partire dall'esperimento
animale, sia dalla psicologia a indirizzo fenomenologico-ermeneutico che, in tutte le sue varianti:
psicodinamiche, comportamentiste, cognitiviste, sistemiche, sociologiche, tenta di "comprendere" l'uomo a
partire dai condizionamenti tipici della cultura occidentale che parla di "corpo", "anima" o "coscienza".
231
Senza un'adeguata riflessione sulla tecnica, pensata come essenza dell'uomo, la psicologia scientificonaturalistica non può che approdare all'etologia, mentre la psicologia fenomenologico-ermeneutica non può
che arrestarsi all'ingenuità del soggettivismo, in quanto all'una sfugge che l'uomo è abissalmente distante
dall'animale perché privo di quel connotato animale che è l'istinto, all'altra che l'"anima" o "coscienza" sono
il residuato dell'azione e del suo prolungamento tecnico, quindi ciò che resta dopo che l'azione ha già
consentito all'uomo di essere al mondo e, in esso, di ritagliare il suo mondo.
A questo punto occorre fondare una psicologia dell'azione per evitare sia uno sguardo riduttivo sull'uomo,
come accade alla psicologia scientifico-naturalistica che pensa l'uomo a partire dall'animale, sia uno sguardo
reattivo sull'uomo, come accade alla psicologia fenomenologico-ermeneutica che non accosta l'uomo a
partire dalla sua esperienza immediata della realtà attraverso l'azione, ma dalla sua esperienza seconda, e
quindi re-attiva, che è la riflessione sull'azione.
Si scoprirà allora che, a partire dalla carenza istintuale compensata dalla plasticità dell'azione, sarà possibile
spiegare la motricità, la percezione, la memoria, l'immaginazione, la coscienza, il linguaggio, il pensiero,
nella loro genesi e nel loro sviluppo, seguendo un percorso assolutamente lineare che, per giustificare il suo
tracciato, non ha bisogno di ricorrere a quel dualismo anima e corpo che ogni psicologia dichiara di voler
superare senza sapere come.
Non c'è scienza infatti che, nata da un falso presupposto, possa rimuoverlo senza negare se stessa. E questo è
proprio il caso della psicologia che, anche se non lo sa, è la più "platonica" delle scienze, perché ancora non
si è emancipata dal dualismo antropologico che, inaugurato da Platone e rigorizzato da Cartesio, impedisce
alla psicologia di approdare al suo oggetto, se prima questa scienza non si disloca dal presupposto dualistico
da cui è nata. Si tratta di una dislocazione che può avvenire solo attraverso una rifondazione radicale della
psicologia che deve assumere come suo punto di partenza non il "soggetto psicologico" e tanto meno l'
"oggetto psichico", ma l'azione.
5. La genesi "strumentale" della tecnica. Se condividiamo la tesi che la tecnica è l'essenza dell'uomo,
allora il primo criterio di leggibilità che va modificato nell'età della tecnica è quello tradizionale che prevede
l'uomo come soggetto e la tecnica come strumento a sua disposizione. Questo poteva essere vero per il
mondo antico, dove la tecnica si esercitava entro le mura della città, che era un'enclave all'interno della
natura, la cui legge incontrastata regolava per intero la vita dell'uomo. Per questo Prometeo, l'inventore delle
tecniche, poteva dire: "la tecnica è di gran lunga più debole della necessità".
Ma oggi è la città ad essersi estesa ai confini della terra, e la natura è ridotta a sua enclave, a ritaglio recintato
entro le mura della città. Allora la tecnica, da strumento nelle mani dell'uomo per dominare la natura, diventa
l'ambiente dell'uomo, ciò che lo circonda e lo costituisce secondo le regole di quella razionalità che,
misurandosi sui criteri della funzionalità e dell'efficienza, non esita a subordinare alle esigenze dell'apparato
tecnico le stesse esigenze dell'uomo.
La tecnica infatti è iscritta per intero nella costellazione del dominio, da cui è nata e al cui interno ha potuto
svilupparsi solo attraverso rigorose procedure di controllo che, per esser davvero tale, non può evitare di
essere planetario. Questa rapida sequenza era già chiaramente intravista e annunciata dalla scienza moderna
al suo primo sorgere quando, senza indugio e con chiara preveggenza, F. Bacone toglie ogni equivoco e
proclama: "scientia est potentia".
6. La trasformazione della tecnica da "mezzo" in "fine". Ma all'epoca di Bacone i mezzi tecnici erano
ancora insufficienti e l'uomo poteva ancora rivendicare la sua soggettività e il suo dominio sulla
strumentazione tecnica. Oggi invece il "mezzo" tecnico si è così ingigantito in termini di potenza ed
estensione da determinare quel capovolgimento della quantità in qualità che Hegel descrive nella Logica e
che, applicato al nostro tema, fa la differenza tra la tecnica antica e lo stato attuale della tecnica.
Infatti, finché la strumentazione tecnica disponibile era appena sufficiente per raggiungere quei fini in cui si
esprimeva la soddisfazione degli umani bisogni, la tecnica era un semplice mezzo il cui significato era
interamente assorbito dal fine, ma quando la tecnica aumenta quantitativamente al punto da rendersi
disponibile per la realizzazione di qualsiasi fine, allora muta qualitativamente lo scenario, perché non è più il
fine a condizionare la rappresentazione, la ricerca, l'acquisizione dei mezzi tecnici, ma sarà la cresciuta
232
disponibilità dei mezzi tecnici a dispiegare il ventaglio di qualsivoglia fine che per loro tramite può essere
raggiunto. Così la tecnica da mezzo diventa fine, non perché la tecnica si proponga qualcosa, ma perché tutti
gli scopi e i fini che gli uomini si propongono non si lasciano raggiungere se non attraverso la mediazione
tecnica.
Già Marx aveva descritto questa trasformazione dei mezzi in fini a proposito del denaro che, se come mezzo,
serve a produrre beni e a soddisfare bisogni, quando beni e bisogni sono mediati per intero dal denaro, allora
il conseguimento del denaro diventa il fine, per raggiungere il quale, se necessario, si sacrifica anche la
produzione dei beni e la soddisfazione dei bisogni. In altra prospettiva e sullo sfondo di un altro scenario, E.
Severino osserva che se il mezzo tecnico è la condizione necessaria per realizzare qualsiasi fine che non può
esser raggiunto prescindendo dal mezzo tecnico, il conseguimento del mezzo diventa il vero fine che tutto
subordina a sé. Ciò comporta il crollo di numerosi impianti categoriali con cui l'uomo aveva finora definito
se stesso e la sua collocazione nel mondo.
7. La tecnica e la revisione degli scenari storici. Se la tecnica diventa quell'orizzonte ultimo a partire dal
quale si dischiudono tutti i campi d'esperienza, se non è più l'esperienza che, reiterata, mette capo alla
procedura tecnica, ma è la tecnica a porsi come condizione che decide il modo di fare esperienza, allora
assistiamo a quel capovolgimento per cui soggetto della storia non è più l'uomo, ma la tecnica che,
emancipatasi dalla condizione di mero "strumento", dispone della natura come suo fondo e dell'uomo come
suo funzionario. Ciò comporta una radicale revisione dei tradizionali modi di intendere la ragione, la verità,
l'ideologia, la politica, l'etica, la natura, la religione e la stessa storia.
LA RAGIONE non è più l'ordine immutabile del cosmo in cui prima la mitologia, poi la filosofia e infine la
scienza si erano riflesse creando le rispettive cosmo-logie, ma diventa procedura strumentale che garantisce
il calcolo più economico tra i mezzi a disposizione e gli obbiettivi che si intendono raggiungere.
LA VERITÀ' non è più conformità all'ordine del cosmo o di Dio perché, se non si dà più orizzonte capace di
garantire il quadro eterno dell'ordine immutabile, se l'ordine del mondo non dimora più nel suo essere, ma
dipende dal "fare tecnico", l'efficacia diventa esplicitamente l'unico criterio di verità.
LE IDEOLOGIE, la cui forza riposava sull'immutabilità del loro corpo dottrinale, nell'età della tecnica non
reggono alla dura riduzione di tutte le idee a semplici ipotesi di lavoro. La tecnica infatti, a differenza
dell'ideologia che muore nel momento in cui il suo nucleo teorico non "fa più mondo" e tantomeno lo
"spiega", pensa le proprie ipotesi come "per principio" superabili, e perciò non si estingue quando un suo
nucleo teorico si rivela inefficace perché, non avendo legato la sua verità a quel nucleo, può mutare e
correggersi senza smentirsi. I suoi errori non la fanno crollare, ma si convertono immediatamente in
occasioni di autocorrezione.
LA POLITICA, che Platone aveva definito "tecnica regia" perché assegnava a tutte le tecniche le rispettive
finalità, oggi può decidere solo in subordine all'apparato economico, a sua volta subordinato alle
disponibilità garantite dall'apparato tecnico. In questo modo la politica si trova in quella situazione di
adattamento passivo, condizionata com'è dallo sviluppo tecnico che essa non può controllare e tantomeno
indirizzare, ma solo garantire. Riducendosi sempre di più a pura amministrazione tecnica, la politica
mantiene un ruolo attivo e quindi decisionale solo là dove la tecnica non è ancora egemone, o dove nella sua
egemonia presenta ancora delle lacune o delle insufficienze in ordine al vincolo della sua razionalità
strumentale.
L'ETICA, come forma dell'agire in vista di fini, celebra la sua impotenza nel mondo della tecnica regolato
dal fare come pura produzione di risultati, dove gli effetti si addizionano in modo tale che gli esiti finali non
sono più riconducibili alle intenzioni degli agenti iniziali. Ciò significa che non è più l'etica a scegliere i fini
e a incaricare la tecnica a reperire i mezzi, ma è la tecnica che, assumendo come fini i risultati delle sue
procedure, condiziona l'etica obbligandola a prender posizione su una realtà, non più naturale ma artificiale,
che la tecnica non cessa di costruire e render possibile, qualunque sia la posizione assunta dall'etica. Infatti,
una volta che l'"agire" è subordinato al "fare", come si può impedire a chi può fare di non fare ciò che può?
Non con la morale dell'intenzione inaugurata dal cristianesimo e riproposta nei termini della "pura ragione"
da Kant, perché questa, fondandosi sul principio soggettivo dell'autodeterminazione e non su quello della
responsabilità oggettiva, non prende in considerazione le conseguenze oggettive delle azioni e, proprio
perché si limita a salvaguardare la "buona intenzione", non può essere all'altezza del fare tecnico. Ma
233
all'altezza non è neppure l'etica della responsabilità che Max Weber ha introdotto e H. Jonas riproposto
perché, se l'etica della responsabilità si limita ad esigere, come scrive Weber, che "si risponda delle
conseguenze prevedibili delle proprie azioni", ebbene è proprio della tecnica dischiudere lo scenario
dell'imprevedibilità, imputabile, non come quella antica a un difetto di conoscenza, ma a un eccesso del
nostro potere di fare enormemente maggiore del nostro potere di prevedere.
LA NATURA. Il rapporto uomo-natura è stato regolato per noi occidentali da due visioni del mondo: quella
greca che concepisce la natura come dimora di uomini e dèi e quella giudaico-cristiana, poi ripresa dalla
scienza moderna, che la concepisce come campo di dominio dell'uomo. Per differenti che siano, queste due
concezioni convengono nell'escludere che la natura rientri nella sfera di competenza dell'etica, il cui ambito è
stato finora limitato alla regolazione dei rapporti fra gli uomini, senza alcuna estensione agli enti di natura.
Ma oggi, che la natura mostra tutta la sua vulnerabilità per effetto della tecnica, si apre uno scenario di fronte
al quale le etiche tradizioni si fanno mute, perché non hanno strumenti per accogliere la natura nell'ambito
della responsabilità umana.
LA RELIGIONE ha come suo presupposto quella dimensione del tempo dove alla fine (éschaton) si realizza
ciò che all'inizio era stato annunciato. Solo in questa dimensione "escatologica", che iscrive il tempo in un
disegno, tutto ciò che accade nel tempo acquista il suo senso. Ma la tecnica, sostituendo alla dimensione
escatologica del tempo quella progettuale contenuta, come scrive S. Natoli, tra il recente passato in cui
reperire i mezzi disponibili e l'immediato futuro in cui questi mezzi trovano il loro impiego, sottrae alla
religione, per effetto di questa contrazione del tempo, la possibilità di leggere nel tempo un disegno, un
senso, un fine ultimo a cui poter far riferimento per pronunciare parole di salvezza e verità.
LA STORIA si costituisce nell'atto della sua narrazione che ordina l'accadere degli eventi in una trama di
senso. Il reperimento di un senso traduce il tempo in storia, così come il suo smarrimento dissolve la storia
nel fluire insignificante del tempo. Il carattere afinalistico della tecnica, che non si muove in vista di fini ma
solo di risultati che scaturiscono dalle sue procedure, abolisce qualsiasi orizzonte di senso, determinando
così la fine della storia come tempo fornito di senso. Rispetto alla memoria storica, la memoria della tecnica,
essendo solo procedurale, traduce il passato nell'insignificanza del "superato" e accorda al futuro il semplice
significato di "perfezionamento" delle procedure. L'uomo, a questo punto, nella sua totale dipendenza
dall'apparato tecnico, diventa astorico, perché non dispone di altra memoria se non quella mediata dalla
tecnica, che consiste nella rapida cancellazione del presente e del passato per un futuro pensato solo in vista
del proprio autopotenziamento.
8. La tecnica e la soppressione di tutti i fini nell'universo dei mezzi. Tra le categorie che siamo soliti
impiegare per orientarci nel mondo, l'unica che ci pone all'altezza dello scenario dischiuso dalla tecnica è la
categoria di assoluto. "Assoluto" significa sciolto da ogni legame (solutus ab), quindi da ogni orizzonte di
fini, da ogni produzione di senso, da ogni limite e condizionamento. Questa prerogativa, che l'uomo ha
attribuito prima alla natura e poi a Dio, ora si trova a riferirla non a se stesso, come lasciavano presagire la
promessa prometeica e la promessa biblica quando alludevano al progressivo dominio dell'uomo sulla natura,
ma al mondo delle sue macchine, rispetto alla cui potenza, per giunta iscritta nell'automatismo del loro
potenziamento, l'uomo, come scrive G. Anders, risulta decisamente inferiore e inconsapevole della sua
inferiorità.
Per effetto di questa inconsapevolezza, chi aziona l'apparato tecnico o chi vi è semplicemente inserito, senza
poter più distinguere se è attivo o è a sua volta azionato, più non si pongono la domanda se lo scopo per cui
l'apparato tecnico è messo in azione sia giustificabile o abbia semplicemente un senso, perché questo
significherebbe dubitare della tecnica, senza di cui nessun senso e nessuno scopo sarebbero raggiungibili, e
allora la "responsabilità" viene affidata al "responso" tecnico, dove è sotteso l'imperativo che si "deve" fare
tutto ciò che si "può" fare.
Ma quando il positivo è per intero iscritto nell'esercizio della potenza tecnica e il negativo è circoscritto
all'errore tecnico, al guasto tecnicamente riparabile, la tecnica guadagna quel livello di autoreferenzialità che,
sottraendola ad ogni condizionamento, la pone come assoluto. Un assoluto che si presenta come un universo
di mezzi, il quale, siccome non ha in vista veri fini ma solo effetti, traduce i presunti fini in ulteriori mezzi per
l'incremento infinito della sua funzionalità e della sua efficienza. In questa "cattiva infinità", come la
chiamerebbe Hegel, qualcosa ha valore solo se è "buono per qualcos'altro", per cui proprio gli obbiettivi
234
finali, gli scopi, che nell'età pre-tecnologica regolavano le azioni degli uomini e ad esse conferivano "senso",
nell'età della tecnica appaiono assolutamente "insensati".
A questo proposito non ci si deve far ingannare dal bisogno di senso, dalla sua ricerca affannosa, dalla sua
domanda incessante a cui cercano di dar risposta le religioni con le loro promozioni di fede e le pratiche
terapeutiche con le loro promozioni di salute, perché tutto ciò rivela solo che la figura del "senso" non si è
salvata dall'universo dei mezzi. Se infatti il reperimento di senso favorisce l'esistenza, se, come scrive
Nietzsche, rappresenta per la condizione umana un vantaggio biologico, là dove il senso non si trova occorre
inventarlo, e allora anche il "senso" si giustifica perché, come mezzo per vivere, è in grado di assurgere a sua
volta al rango di "mezzo" .
9. Dall'alienazione tecnologica all'identificazione tecnologica. Che ne è dell'uomo in un universo di mezzi
che non ha in vista altro se non il perfezionamento e il potenziamento della propria strumentazione? Là dove
il mondo della vita è per intero generato e reso possibile dall'apparato tecnico, l'uomo diventa un funzionario
di detto apparato e la sua identità viene per intero risolta nella sua funzionalità, per cui è possibile dire che
nell'età della tecnica l'uomo è presso-di-sé solo in quanto è funzionale a quell'altro-da-sé che è la tecnica.
La tecnica infatti non è l'uomo. Nata come condizione dell'esistenza umana e quindi come espressione della
sua essenza, oggi, per le dimensioni raggiunte e per l'autonomia guadagnata, la tecnica esprime l'astrazione e
la combinazione delle ideazioni e delle azioni umane ad un livello di artificialità tale che nessun uomo e
nessun gruppo umano, per quanto specializzato, e forse proprio per effetto della sua specializzazione, è in
grado di controllare nella sua totalità. In un simile contesto, essere ridotto a funzionario della tecnica
significa allora per l'uomo essere "altrove" rispetto alla dimora che ha storicamente conosciuto, significa
essere lontano da sé.
Marx ha chiamato questa condizione "alienazione" e, coerentemente alle condizioni del suo tempo, ha
circoscritto l'alienazione al modo di produzione capitalistico. Ma sia il capitalismo (causa dell'alienazione)
sia il comunismo (che Marx progettava come rimedio all'alienazione) sono ancora figure iscritte
nell'umanismo, ossia ancora in quell'orizzonte di senso, tipico dell'età pre-tecnologica, dove l'uomo è
previsto come soggetto e la tecnica come strumento. Ma, nell'età della tecnica, che prende avvio quando
l'universo dei mezzi non ha in vista alcuna finalità (neppure il profitto), il rapporto si capovolge, nel senso
che l'uomo non è più un soggetto che la produzione capitalistica aliena e reifica, ma è un prodotto
dell'alienazione tecnologica che instaura sé come soggetto e l'uomo come suo predicato.
Ne consegue che la strumentazione teorica messa a disposizione da Marx, che pure fu tra i primi a prevedere
gli scenari dell'età della tecnica da lui chiamata "civiltà delle macchine", non è più del tutto idonea per
leggere il tempo della tecnica, non perché storicamente il capitalismo si è rivelato vincente sul comunismo,
ma perché Marx si muove ancora in un orizzonte umanistico, con riferimento all'uomo pre-tecnologico, dove,
come vuole la lezione di Hegel, il servo ha nel signore il suo antagonista, e il signore nel servo, mentre,
nell'età della tecnica, non ci sono più né servi né signori, ma solo le esigenze di quella rigida razionalità a cui
devono subordinarsi sia i servi sia i signori.
A questo punto anche il concetto marxiano di "alienazione" appare insufficiente, perché di alienazione si può
parlare solo quando, in uno scenario umanistico, c'è un'antropologia che vuol recuperarsi dalla sua
estraneazione nella produzione, in un contesto caratterizzato dal conflitto di due volontà, di due soggetti che
ancora si considerano titolari delle loro azioni, non quando c'è un unico soggetto, l'apparato tecnico, rispetto
al quale i singoli soggetti sono semplicemente suoi predicati.
Esistendo esclusivamente come predicato dell'apparato tecnico che pone se stesso come assoluto, l'uomo non
è più in grado di percepirsi come "alienato", perché l'alienazione prevede, almeno in prospettiva, uno
scenario alternativo che l'assoluto tecnico non concede, e perciò, come in altro contesto scrive R. Madera,
l'uomo traduce la sua alienazione nell'apparato in identificazione con l'apparato. Per effetto di questa
identificazione, il soggetto individuale non reperisce in sé altra identità al di fuori di quella conferitagli
dall'apparato e, quando si compie l'identificazione degli individui con la funzione assegnata dall'apparato, la
funzionalità, divenuta autonoma, riassorbe in sé ogni senso residuo di identità .
235
10. La tecnica e la revisione delle categorie umanistiche. Siccome, come funzionario dell'apparato tecnico,
l'uomo non è più leggibile con gli impianti categoriali elaborati e maturati nell'età pre-tecnologica, occorre
una radicale revisione delle categorie umanistiche a partire dalla nozione di individuo, identità, libertà,
comunicazione, fino al concetto di anima, la cui arretratezza psichica ancora non consente all'uomo d'oggi
un'adeguata comprensione dell'età della tecnica.
L'INDIVIDUO. Questa nozione tipicamente occidentale, che ha avuto nella nozione platonica di "anima",
rivisitata dal cristianesimo, il suo atto di nascita, ha nell'età della tecnica il suo prevedibile atto di morte.
Certo non muore quell'entità indivisibile (dal latino: in-dividuum) che a livello naturale fa parte della specie e
a livello culturale di una società di cui ripete, per le sue caratteristiche, il tipo generale, ma muore quel
soggetto che, a partire dalla consapevolezza della propria individualità, si pensa autonomo, indipendente,
libero fino ai confini della libertà altrui e, per effetto di questo riconoscimento, uguale agli altri. In altri
termini non muore l'individuo empirico, l'atomo sociale, ma il sistema di valori che, a partire da questa
singolarità, hanno deciso la nostra storia.
L'IDENTITÀ. Questa nozione che, come quella di individuo, nasce all'interno dell'antropologia occidentale
perché, prima dell'Occidente e a fianco dell'Occidente, l'individuo non riconosce la sua identità ma solo
l'appartenenza al gruppo con cui si identifica, dipende, come ci ricorda Hegel, dal riconoscimento. Solo che,
mentre nell'età pre-tecnologica era possibile riconoscere l'identità di un individuo dalle sue azioni, perché
queste erano lette come manifestazioni della sua anima, intesa come soggetto decisionale, oggi le azioni
dell'individuo non sono più leggibili come espressioni della sua identità, ma come possibilità calcolate
dall'apparato tecnico, che non solo le prevede, ma addirittura le prescrive nella forma della loro esecuzione.
Eseguendole, il soggetto non rivela la sua identità, ma quella dell'apparato, all'interno del quale l'identità
personale si risolve in pura e semplice funzionalità.
LA LIBERTÀ. Se con questa parola intendiamo l'esercizio della libera scelta a partire dalle condizioni
esistenti, dobbiamo dire che la società tecnologicamente avanzata offre uno spazio di libertà decisamente
superiore a quello concesso nelle società poco differenziate, dove la qualità personale e non oggettiva dei
legami, nonché l'omogeneità sociale riducono il margine di libertà a quello elementare dell'obbidienza o
della disobbidienza. La tecnica, avendo come suo imperativo la promozione di tutto ciò che si può
promuovere, crea un sistema aperto che di continuo genera un ventaglio sempre più allargato di opzioni, che
diventano via via praticabili in base ai livelli di competenza che i singoli individui sono in grado di acquisire.
Ma la libertà come competenza, avendo come spazio espressivo quello impersonale dei rapporti
professionali, crea quella scissione radicale tra "pubblico" e "privato" che, anche se da molti è acclamata
come cardine della libertà, comporta quella conduzione schizofrenica della vita individuale (schizofrenia
funzionale), che si manifesta ogni volta che la funzione, che all'individuo spetta come membro impersonale
dell'organizzazione tecnica, entra in collisione con quello che l'individuo aspira ad essere come soggetto
globale. Si determina infatti per la prima volta nella storia la possibilità per l'individuo di entrare in rapporto
con gli altri individui, e quindi di "fare società", senza che ciò comporti un qualsiasi legame di natura
personale. E allora, privati di una comune esperienza d'azione, che è sempre più prerogativa esclusiva della
tecnica, gli individui reagiscono al senso di impotenza che sperimentano ripiegandosi su se stessi e,
nell'impossibilità di riconoscersi comunitariamente, finiscono con il considerare la società stessa in termini
puramente strumentali.
LA CULTURA DI MASSA. La disarticolazione tra "pubblico" e "privato", tra "sociale" e "individuale"
operata dalla razionalità tecnica, modifica anche il concetto tradizionale di "massa", introducendo quella
variante che è la sua atomizzazione e disarticolazione in singolarità individuali che, foggiate da prodotti di
massa, consumi di massa, informazioni di massa, rendono obsoleto il concetto di massa come concentrazione
di molti, e attuale quello di massificazione come qualità di milioni di singoli, ciascuno dei quali produce,
consuma, riceve le stesse cose di tutti, ma in modo solistico. Viene così consegnata a ciascuno la propria
massificazione, ma con l'illusione della privatezza e l'apparente riconoscimento della propria individualità, in
modo che nessuno sia più in grado di percepire un "esterno" rispetto a un "interno", perché ciò che ciascuno
incontra in pubblico è esattamente ciò di cui è stato rifornito in privato. Nascano da qui quei processi di
deindividuazione e deprivatizzazione che sono alla base delle condotte di massa tipiche delle società
omologate e conformiste.
I MEZZI DI COMUNICAZIONE. All'omologazione sociale contribuiscono in modo esponenziale i mezzi di
comunicazione che la tecnica ha potenziato modificando il nostro modo di fare esperienza: non più in
contatto con il mondo, ma con la rappresentazione mediale del mondo che rende vicino il lontano, presente
236
l'assente, disponibile quello che altrimenti sarebbe indisponibile. Esonerandoci dall'esperienza diretta e
mettendoci in rapporto non con gli eventi, ma con il loro allestimento, i mezzi di comunicazione non hanno
alcun bisogno di falsificare o di oscurare la realtà, perché proprio ciò che informa codifica, e l'effetto di
codice diventa non solo criterio interpretativo della realtà, ma anche modello induttore dei nostri giudizi, che
a loro volta generano comportamenti nel mondo reale conformi a quanto appreso del modello induttore. In
questa comunicazione tautologica, dove chi ascolta sente le stesse cose che egli stesso potrebbe
tranquillamente dire, e chi parla dice le stesse cose che potrebbe ascoltare da chiunque, in questo monologo
collettivo l'esperienza della comunicazione crolla, perché è abolita la differenza specifica tra le esperienze
personali del mondo che sono alla base di ogni bisogno comunicativo. Con il loro rincorrersi, infatti, le mille
voci e le mille immagini che riempiono l'etere aboliscono progressivamente le differenze che ancora esistono
fra gli uomini e, perfezionando la loro omologazione, rendono superfluo se non impossibile parlare "in prima
persona". A questo punto i mezzi di comunicazione non appaiono più come semplici "mezzi" a disposizione
dell'uomo perché, se intervengono sulla modalità di fare esperienza, modificano l'uomo indipendentemente
dall'uso che questi ne fa e dagli scopi che si propone quando li impiega.
LA PSICHE. Quando nell'epoca pre-tecnologica il mondo non era disponibile nella sua totalità, ogni anima
costruiva se stessa come risonanza del mondo di cui faceva esperienza. Questa risonanza era per ogni uomo
la sua interiorità. Oggi, esonerata dall'esperienza personale del mondo, l'anima di ciascuno diventa
coestensiva al mondo. In questo modo viene soppressa: la differenza tra interiorità ed esteriorità, perché il
contenuto della vita psichica di ciascuno finisce con il coincidere con la comune rappresentazione del
mondo, o per lo meno con ciò che i mezzi di comunicazione le destinano come "mondo"; la differenza tra
profondità e superficie perché, con buona pace della psicologia del profondo, la profondità finisce con
l'essere null'altro che il riflesso individuale delle regole del gioco a tutti comune dispiegato in superficie; la
differenza tra attività e passività perché, se la tendenza della società tecnologica è quella di funzionare ad un
regime di massima razionalità, quindi leibnizianamente come un sistema armonico prestabilito, non si dà
alcuna "attività" che non sia per ciò stesso "adattamento" alle procedure tecniche che, sole, la rendono
possibile. In questo modo l'anima viene progressivamente depsicologizzata e resa incapace di comprendere
che cosa veramente significa vivere nell'età della tecnica, dove ciò che si chiede è un potenziamento delle
facoltà intellettuali su quelle emotive, per poter essere all'altezza della cultura oggettivata nelle cose che la
tecnica esige a scapito e a spese di quella soggettiva degli individui .
11. L'età della tecnica e l'inadeguatezza della comprensione umana. La depsicologizzazione dell'anima
trattiene le discussioni sull'età della tecnica a quel livello inessenziale che è l'esaltazione incondizionata o la
demonizzazione acritica. Questo libro vorrebbe promuovere quel passo ulteriore che è l'apertura
dell'orizzonte della comprensione, persuasi come siamo che oggi orizzonte della comprensione non è più la
natura nella sua stabilità e inviolabilità, e neppure la storia che abbiamo vissuto e narrato come progressivo
dominio dell'uomo sulla natura, ma la tecnica che dischiude uno spazio interpretativo che si è
definitivamente congedato sia dall'orizzonte della natura che da quello della storia.
Questo è il passaggio epocale in cui ci troviamo, dove l'epocalità è data dal fatto che la storia che abbiamo
vissuto ha conosciuto la tecnica come quel fare manipolativo che, non essendo in grado di incidere sui grandi
cicli della natura e della specie, era circoscritto in un orizzonte che rimaneva stabile e inviolabile. Oggi anche
questo orizzonte rientra nelle possibilità della manipolazione tecnica, il cui potere di sperimentazione è senza
limite perché, a differenza di quanto accadeva agli albori dell'età moderna, dove la sperimentazione
scientifica avveniva in "laboratorio", quindi in un mondo artificiale distinto da quello naturale, oggi il
laboratorio è divenuto coestensivo al mondo, ed è difficile continuare a chiamare "sperimentazione" ciò che
modifica in modo irreversibile la nostra realtà geografica e quindi storica.
Quando le condizioni poste "per ipotesi" lasciano effetti irreversibili, non è più possibile continuare a
iscrivere la tecnica nel giudizio ipotetico-congetturale che ha come sue caratteristiche la problematicità, la
revisionabilità, la provvisorietà, la perfettibilità, la falsificabilità, ma occorre iscriverla nel giudizio storicoepocale che, tra i giudizi, è il più severo, perché ciò che accade una volta è accaduto per sempre in modo
irrevocabile.
A questo punto la domanda: se l'uomo non esiste a prescindere da ciò che fa, che cosa diventa l'uomo
nell'orizzonte della sperimentazione illimitata e della manipolazione infinita dischiusa dalla tecnica? Per
rispondere è necessario superare la persuasione ingenua secondo cui la natura umana è un che di stabile che
237
resta incontaminata e intatta qualunque cosa l'uomo faccia. Se infatti l'uomo, come vuole l'espressione di
Nietzsche, è quell' "animale non ancora stabilizzato" che fin dalle origini non può vivere se non operando
tecnicamente, la sua natura si modifica in base alle modalità di questo "fare", che perciò diventa l'orizzonte
della sua autocomprensione. Non dunque l'uomo che può usare la tecnica come qualcosa di neutrale rispetto
alla sua natura, ma l'uomo la cui natura si modifica in base alle modalità con cui si declina tecnicamente.
Oggi la tecnica dispone l'uomo di fronte a un mondo che si presenta come illimitata manipolabilità, e perciò
la natura umana non può essere pensata come la stessa che si relazionava a un mondo, che è poi il mondo che
la storia ci ha finora descritto, ai suoi limiti inviolabile e fondamentalmente immodificabile.
Eppure ancor oggi l'umanità non è all'altezza dell'evento tecnico da essa stessa prodotto e, forse per la prima
volta nella storia, la sua sensazione, la sua percezione, la sua immaginazione, il suo sentimento si rivelano
inadeguati a quanto sta accadendo. Infatti la capacità di produzione che è illimitata ha superato la capacità di
immaginazione che è limitata e comunque tale da non consentirci più di comprendere, e al limite di
considerare "nostri", gli effetti che l'irreversibile sviluppo tecnico è in grado di produrre.
Quanto più si complica l'apparato tecnico, quanto più fitto si fa l'intreccio dei sottoapparati, quanto più si
ingigantiscono i suoi effetti, tanto più si riduce la nostra capacità di percezione in ordine ai processi, ai
risultati, agli esiti, per non dire degli scopi di cui siamo parti e condizioni. E siccome di fronte a ciò che non
si riesce né a percepire né a immaginare il nostro sentimento diventa incapace di reagire, al "nichilismo
attivo" della tecnica iscritto nel suo "fare senza scopo" si affianca il "nichilismo passivo", denunciato da
Nietzsche, che ci lascia "freddi", perché il nostro sentimento di reazione si arresta alla soglia di una certa
grandezza. E così da "analfabeti emotivi" assistiamo all'irrazionalità che scaturisce dalla perfetta razionalità
(strumentale) dell'organizzazione tecnica che cresce su se stessa al di fuori di qualsiasi orizzonte di senso.
L'esperimento nazista, non per la sua crudeltà, ma proprio per l'irrazionalità che scaturisce dalla perfetta
razionalità di un'organizzazione, per la quale "sterminare" aveva il semplice significato di "lavorare", può
essere assunto come quell'evento che segna l'atto di nascita dell'età della tecnica. Non si trattò allora, come
oggi potrebbe apparire, di un evento erratico o atipico per la nostra epoca e per il nostro modo di sentire, ma
di un evento paradigmatico, in grado ancora oggi di segnalare che se non saremo in grado di portarci
all'altezza dell'operare tecnico generalizzato a dimensione globale e senza lacune, ciascuno di noi resterà
irretito in quella irresponsabilità individuale che consentirà al totalitarismo della tecnica di procedere
indisturbato, senza neppure più il bisogno di appoggiarsi a tramontate ideologie. A differenza, infatti, del
nichilismo descritto dalla filosofia che si interroga sul senso dell'essere e del non essere, il nichilismo della
tecnica non mette in gioco solo il senso dell'essere e quindi dell'uomo, ma l'essere stesso dell'uomo e del
mondo nella sua totalità. E se il nichilismo descritto dalla filosofia era anticipatore, profetico, ma impotente,
perché non era in grado di determinare il nichilismo che prefigurava, il nichilismo sotteso al carattere
afinalistico della tecnica non solo ha in suo potere la nientificazione, ma, stante la qualità degli imperativi
tecnici e la morale degli strumenti che ne deriva, è nella possibilità di esercitare questo potere. Il fatto che la
filosofia, e con lei la letteratura e l'arte, ancora si trattengono sul problema del senso dell'essere e quindi
dell'uomo, senza sporgere sul problema della possibilità che hanno l'uomo e il mondo di continuare ad
essere, contribuisce a quel "nichilismo passivo" che Nietzsche denunciava come nichilismo della
rassegnazione. Nata sotto il segno dell'anticipazione, di cui Prometeo, "Colui che pensa in anticipo", ne è il
simbolo, la tecnica finisce in questo modo col sottrarre all'uomo ogni possibilità anticipatrice, e con essa
quella responsabilità e padronanza che deriva dalla capacità di prevedere. In questa incapacità, divenuta
ormai inadeguatezza psichica, si nasconde per l'uomo il massimo pericolo, così come nell'ampliamento della
sua capacità di comprensione la sua flebile speranza. Questo ampliamento psichico, alla cui promozione
questo libro affida il suo senso, se da un lato non è sufficiente a dominare la tecnica, evita almeno all'uomo
che la tecnica accada a sua insaputa e, da condizione essenziale all'esistenza umana, si traduca in causa
dell'insignificanza del suo stesso esistere.
U. Galimberti, Psiche e techne, Feltrinelli, 1999
238
Sigmund Freud
ANALISI DELLA FOBIA DI UN BAMBINO DI CINQUE ANNI. IL PICCOLO HANS
Quel pomeriggio padre e figlio erano venuti a consultarmi nel mio studio. Conoscevo già il bricconcello,
tutto sicuro di sé ma tanto simpatico che mi faceva sempre piacere vederlo. Non so se si ricordasse di me, ad
ogni modo si comportò in modo impeccabile, come un ragionevolissimo membro del consorzio umano. La
visita fu breve. Il padre cominciò col dire che, nonostante tutte le spiegazioni, la paura dei cavalli non era
diminuita. Dovemmo anche convenire che tra i cavalli, di cui aveva paura, e i moti palesi di tenerezza verso
la madre, non c’erano molte relazioni. Ciò che sapevamo non era certo in grado di spiegare i particolari che
appresi soltanto allora: che lo infastidiva soprattutto ciò che i cavalli hanno davanti agli occhi e il nero
intorno alla loro bocca. Ma mentre guardavo i due seduti davanti a me e ascoltavo la descrizione dei cavalli
che incutevano paura, mi venne improvvisamente in mente un altro pezzo della soluzione, tale, come capii,
da sfuggire proprio al padre. Chiesi a Hans in tono scherzoso se i suoi cavalli portassero gli occhiali, e il
piccino disse di no; poi se il suo papà portasse gli occhiali, e anche questa volta egli negò, nonostante fosse
evidente il contrario; gli chiesi ancora se con il nero intorno alla “bocca” non intendesse dire i baffi, e infine
gli rivelai che egli aveva paura del suo papà, e proprio perché lui, Hans, voleva tanto bene alla mamma.
Credeva che perciò il babbo fosse arrabbiato con lui, ma non era vero, il babbo gli voleva bene lo stesso e lui
gli poteva confessare tutto senza paura. Già tanto tempo prima che lui venisse al mondo, io già sapevo che
sarebbe nato un piccolo Hans che avrebbe voluto così bene alla sua mamma da aver paura, per questo, del
babbo, e tutto questo l’avevo raccontato al suo papà. – Come puoi credere che io sia arrabbiato con te? –
m’interruppe il padre, – t’ho mai sgridato o picchiato? – Oh sì – lo corresse Hans, – mi hai picchiato. – Non è
vero; ma quando? – Questa mattina – rispose il bambino, e il padre si ricordò che al mattino Hans gli si era
239
gettato all’improvviso con la testa contro la pancia e che, quasi automaticamente, egli aveva risposto con uno
scappellotto. Fatto singolare, il padre non aveva messo in riferimento questo particolare col contesto della
nevrosi; ora però si rese conto ch’esso costituiva un’espressione della disposizione ostile del piccino verso di
lui e fors’anche del bisogno di ricevere una punizione per questo.
Ritornando a casa Hans chiese al padre: – Com’è che il professore sapeva già tutto prima? Forse parla col
buon Dio? – Sarei straordinariamente fiero di questo riconoscimento per bocca di un bambino, se non
l’avessi provocato io stesso con la mia scherzosa vanteria. Dopo quella visita ricevetti quasi ogni giorno
ragguagli sulle variazioni dello stato del piccolo paziente. Non ci si poteva aspettare che, grazie alla mia
spiegazione, egli si liberasse di colpo delle sue angosce; si vide però che ora gli era offerta la possibilità di
portare avanti le sue produzioni inconsce e dipanare la sua fobia. Da quel momento in poi Hans attuò un
programma che potei preannunciare al genitore.
“Il 2 aprile si nota il primo reale miglioramento. Finora non era mai stato possibile convincerlo a trattenersi
per un po’ di tempo fuori del portone, e quando si avvicinava un cavallo rientrava a precipizio in casa,
spaventatissimo; oggi invece è rimasto davanti al portone un’ora, anche quando passava qualche carrozza, il
che avviene piuttosto spesso davanti a casa nostra. Qualche volta, vedendo da lontano una carrozza, faceva
per correr dentro, ma poi tornava indietro subito, come se ci avesse ripensato. Ad ogni modo, l’angoscia
sembra ridotta a un residuo e i progressi avvenuti dopo la spiegazione sono innegabili.
“La sera dice: – Adesso che arriviamo fino davanti al portone, possiamo anche andare al Parco municipale.
“La mattina del 3 aprile viene a letto da me, mentre negli ultimi giorni non era mai venuto e anzi sembrava
fiero di questa sua riservatezza. Gli chiedo: – Perché oggi sei venuto?
“Hans: – Quando non ho più paura non vengo più.
“Io: – Allora tu vieni da me perché hai paura?
“Hans: – Quando non sto con te, ho paura; quando non sto a letto con te, ho paura, ecco. Quando non avrò
più paura, non vengo più.
“Io: – Allora tu mi vuoi bene, e la mattina presto a letto hai paura, e perciò vieni da me?
“Hans: – Sí. Perché mi hai detto che io voglio bene alla mamma e che è per questo che ho paura, mentre
invece io voglio bene a te?”
Il piccolo è qui straordinariamente esplicito. Egli fa capire che in lui l’amore per il padre è in conflitto con
l’ostilità verso il padre, rivale nei confronti della madre, al quale egli fa il rimprovero di non avergli fatto
rilevare questo giuoco di forze opposte che doveva trovar sfogo nell’angoscia. Il padre non comprende
ancora completamente suo figlio perché, durante questo colloquio, non fa che convincersi della sua ostilità
verso di lui, quell’ostilità ch’io gli avevo fatto rilevare nell’ultima visita. Ciò che segue serve in realtà a
dimostrare più i progressi del padre che quelli del figlio; tuttavia lo riferirò senza cambiare nulla.
“Purtroppo non comprendo subito il senso di questa obiezione. Poiché Hans ama la mamma, vuole
evidentemente che io non ci sia più, in modo da mettersi al posto del padre. Questo desiderio ostile represso
si tramuta in angoscia per la sorte del padre, sicché egli viene la mattina da me per vedere se ci sono ancora.
Questa spiegazione non mi viene purtroppo in mente lì per lì, e gli dico:
“– Quando tu sei solo, è che hai paura per me e allora mi vieni a trovare.
“Hans: – Quando tu sei via, io ho paura che non torni più a casa.
“Io: – Forse ti ho minacciato qualche volta di non tornare più?
“Hans: – Tu no, ma mamma sí. La mamma mi ha detto che non ritornava più a casa – (probabilmente aveva
fatto i capricci e la mamma l’aveva minacciato di andarsene).
“Io: – Questo l’ha detto perché tu eri cattivo.
“Hans: – Sí.
240
“Io: – Tu perciò hai paura che io me ne vada via perché sei stato cattivo, e allora vieni da me.
“Appena fatta colazione mi alzo da tavola e Hans dice: – Papà, perché trotti subito via? – Noto che ha detto
‘trotti’ invece di ‘corri’ e gli rispondo: – Ah, ecco! tu hai paura che il cavallo trotti via – Hans ride.”
Sappiamo che questa parte dell’angoscia di Hans ha due componenti: paura del padre e paura per il padre. La
prima proviene dall’ostilità verso il padre, la seconda dal conflitto tra tenerezza, che qui è esagerata per
reazione, e ostilità.
Il padre continua: “Questo è senza dubbio l’inizio di una fase importante. Il fatto che il piccolo si azzardi al
massimo a uscire dal portone, senza allontanarsi dalla casa, che a metà strada, al primo accesso d’angoscia,
ritorni sui suoi passi, è dunque motivato dalla paura di non trovare più a casa i genitori perché sono andati
via. Egli è inchiodato alla casa dal suo amore per la madre, e teme ch’io me ne vada a causa dei desideri
ostili (allora, sarebbe lui il padre) che nutre nei miei riguardi.
“La scorsa estate ero solito partire spesso da Gmunden alla volta di Vienna, per motivi di lavoro, e allora era
lui il padre. Ricorderò a questo proposito che la paura dei cavalli è legata all’episodio di Gmunden quando
un cavallo doveva portare i bagagli di Lizzi alla stazione [p. 499]. Il desiderio rimosso di vedermi andare in
carrozza alla stazione, per restare solo con la mamma (il desiderio che ‘il cavallo s’avvii’), si era poi
tramutato nell’angoscia di vedere i cavalli avviarsi; e in effetto nulla lo agita di più che il vedere un carro
avviarsi dal cortile del Dazio centrale, sito dirimpetto al nostro appartamento, e i cavalli mettersi in moto.
“Tutta questa parte nuova (malanimo nei confronti del padre) è potuta venire in luce soltanto dopo che il
bambino ha appreso che io non ero adirato con lui per il fatto ch’egli vuole tanto bene alla mamma.
“Nel pomeriggio esco nuovamente con lui fuori del portone; va di nuovo davanti alla casa e vi resta anche
quando passano le carrozze, ha paura soltanto di certe carrozze e corre dentro al portone. – Non tutti i cavalli
bianchi mordono – mi spiega; ciò significa che, in virtù dell’analisi, alcuni cavalli bianchi sono già stati
riconosciuti come il ‘babbo’ e quindi non mordono più, però ce ne sono altri che mordono ancora.
“Ecco ciò che si vede dal portone della nostra casa (fig. 2): dirimpetto c’è il deposito dell’ufficio delle
imposte di consumo, con una piattaforma di carico davanti a cui passano continuamente i carri che vengono
a caricare casse di merci e simili. Il cortile è recinto da una cancellata che corre lungo la strada. Proprio di
fronte al nostro appartamento vi è il cancello d’ingresso al cortile. Ho osservato da alcuni giorni che Hans
s’impaurisce in modo particolare quando i XXXXXX
civile inevitabilmente incontra nello sforzo di superare le sue componenti pulsionali innate, dall’altra fece
accorrere il padre in suo aiuto. Forse Hans ha ora il vantaggio rispetto agli altri bambini di non recare più in
sé quel germe di complessi rimossi che ha sempre importanza per la vita futura, causando una più o meno
grande deformazione del carattere, se non addirittura la disposizione a una successiva nevrosi. Questo è il
parere cui sono incline, ma non so quanti altri condivideranno tale giudizio e non so neppure se l’esperienza
mi darà ragione.
Domandiamoci ora: qual danno ha procurato a Hans il portare alla luce in lui complessi solitamente rimossi
dai figli e temuti dai genitori? Forse che perciò egli ha seriamente tentato di tradurre in atto le sue pretese
verso la madre, o forse che alle cattive intenzioni contro il padre sono subentrati i fatti? Certo, è quello che
avranno temuto i molti che, misconoscendo la natura della psicoanalisi, credono che render coscienti le
cattive pulsioni significhi renderle più forti. Queste sagge persone agiscono con coerenza quando ci
supplicano per l’amor del cielo di non occuparci delle brutture che si nascondono dietro le nevrosi. Ma, così
facendo, essi dimenticano di esser medici e vengono fatalmente a rassomigliare al Sanguinello
shakespeariano in Molto rumore per nulla, che consiglia alla ronda di tenersi lontana da ogni contatto con i
ladri che incontrasse per via. “Con gente di quella specie, meno che ci vi immischiate o avete a che fare,
meglio è per la vostra onestà.”
Al contrario, le uniche conseguenze dell’analisi sono che Hans guarisce, che non ha più paura dei cavalli e
che assume una specie di tono cameratesco con il padre, come questi ci riferisce divertito. Ma quel che il
padre perde in rispetto lo riacquista in fiducia: “Credevo che tu sapessi tutto, perché hai saputo la cosa del
cavallo.” L’analisi non annulla l’effetto della rimozione; le pulsioni precedentemente represse restano
represse; ma essa ottiene lo stesso effetto per altra via, sostituendo al processo della rimozione, che è
automatico ed eccessivo, il graduale dominio temperato e adeguato conseguito con l’aiuto delle massime
istanze psichiche, in una parola: sostituendo alla rimozione la condanna. Ciò sembra darci la prova, da
241
tempo cercata, del fatto che la coscienza – l’essere coscienti – ha una funzione biologica, e che il suo avvento
implica un importante vantaggio. [Nota aggiunta nel 1923: La parola “coscienza” è qui usata in un senso in
cui l’ho poi evitata, ossia nel senso del nostro normale concepir pensieri ammissibili alla coscienza. Noi
sappiamo che tali processi di pensiero possono anche svolgersi preconsciamente, e faremo bene a
considerare il loro “essere coscienti” da un punto di vista puramente fenomenico. Ciò non vuol dire,
naturalmente, che anche il divenir cosciente in tal senso fenomenico non adempia una funzione biologica].
Se la cosa fosse dipesa soltanto da me avrei osato dare al bambino anche una spiegazione che i genitori
ritennero di ricusargli. Avrei confermato i suoi presentimenti istintivi rivelandogli l’esistenza della vagina e
del coito, e in tal modo avrei ulteriormente ridotto i suoi residui insoluti e messo fine al suo torrente di
domande. Sono convinto che non ne avrebbero sofferto né il suo amore per la mamma né la sua natura di
bimbo e che avrebbe compreso egli stesso che, per occuparsi di queste importanti, anzi imponenti questioni,
avrebbe dovuto attendere in pace che si fosse adempiuto il suo desiderio di diventare grande. Ma
l’esperimento pedagogico non fu condotto così a fondo.
Che non sia possibile tracciare un netto confine tra “nervosi” e “normali”, sia bambini che adulti; che la
“malattia” sia soltanto un concetto meramente pratico di sommazione; che la predisposizione e i casi della
vita debbano combinarsi per varcar la soglia di questa sommazione; che pertanto numerosi individui passino
continuamente dalla categoria dei sani a quella dei malati di nervi, mentre un numero assai minore compie il
tragitto inverso, sono tutte cose che sono state dette tante volte e hanno trovato tanta eco, che non son io
certo il solo a sostenerle. Ora, è perlomeno molto verosimile che l’educazione del bambino possa esercitare
un profondo influsso a favore o a sfavore di quella predisposizione alla malattia che abbiamo menzionato
come fattore della sommazione. Ma a che, deve mirare l’educazione? dove deve intervenire? È ancora
difficile rispondere con sicurezza. Finora, essa si è posta per compito soltanto il dominio, o meglio la
repressione delle pulsioni. I risultati sono stati tutt’altro che soddisfacenti e dove si è avuto qualche successo,
questo ha riguardato soltanto un esiguo numero di privilegiati sfuggiti alla pretesa della repressione
pulsionale. D’altra parte nessuno si è domandato per quali vie e in virtù di quali sacrifici si raggiunga la
repressione delle pulsioni imbarazzanti. Se per contro noi sostituiamo a questo compito un altro, quello di
rendere l’individuo atto alla civiltà e utile membro del consorzio umano, senza chiedergli di sacrificare la
propria attività più di quanto non sia strettamente necessario, ecco che allora i chiarimenti datici dalla
psicoanalisi sull’origine dei complessi patogeni e sul nucleo di ciascheduna nevrosi meriteranno giustamente
di essere considerati dall’educatore una guida di inestimabile valore per la condotta da tenere nei confronti
del bambino. Quali conclusioni pratiche se ne possano trarre, fino a che punto l’esperienza possa giustificare
l’applicazione di tali conclusioni nel nostro sistema sociale, lascio ad altri di decidere e di giudicare.
Non posso prender congedo dalla fobia del nostro piccolo paziente senza esprimere un’idea che conferisce
per me un valore particolare all’analisi che permise la guarigione. Quest’analisi non m’ha rivelato, in senso
stretto, nulla di nuovo, nulla che non avessi già appreso (spesso in modo meno chiaro e meno immediato)
durante la cura di altri pazienti in età matura. Ma, poiché le nevrosi di questi altri malati potevano sempre
esser ricondotte a quegli stessi complessi infantili che abbiamo scoperto dietro la fobia di Hans, sono tentato
di annettere a questa nevrosi infantile l’importanza di un modello e di un tipo, opinando che la molteplicità
dei fenomeni nevrotici di rimozione e l’abbondanza del materiale patogeno non impediscano la loro
derivazione da pochissimi processi riguardanti gli stessi complessi rappresentativi.
poscritto del 1922
Qualche mese fa – primavera del 1922 – mi si presentò un giovanotto dichiarando di essere il “piccolo
Hans”, sulla cui fobia infantile avevo pubblicato un rapporto nel 1909. Fui molto lieto di rivederlo, poiché
circa due anni dopo la conclusione dell’analisi l’avevo perso di vista e per oltre un decennio non avevo
saputo più nulla di lui. La pubblicazione di quella prima analisi di un bambino aveva suscitato molto rumore
e ancor maggiore indignazione; tutte le sventure erano state profetate al povero ragazzo, violato nella sua
innocenza e vittima di una psicoanalisi in sì tenera età.
Ma nessuna di queste profezie si era verificata. Hans adesso era un prestante giovane di diciannove anni. Mi
disse che stava perfettamente bene e che non soffriva di disturbi o inibizioni di alcun genere. Non soltanto
aveva attraversato indenne la pubertà, ma aveva sopportato senza conseguenze una delle più dure prove della
242
sua vita emotiva: i genitori avevano divorziato passando ambedue a nuove nozze. Perciò egli viveva solo,
pur mantenendo buone relazioni con tutt’e due i genitori: gli rincresceva soltanto che, scioltasi la famiglia
fosse rimasto separato dalla giovane sorella che gli era molto cara.
Particolarmente notevole mi apparve una delle cose che mi disse il piccolo Hans, e di cui non tenterò
neppure di dare una spiegazione. Dichiarò che, quando aveva letto il suo caso clinico, tutto gli era parso
estraneo, non si riconosceva, non si ricordava di nulla, solo leggendo del viaggio a Gmunden gli era balenata
l’idea, quasi un barlume di ricordo, di poter essere stato lui. L’analisi dunque, lungi dall’aver preservato gli
avvenimenti dall’amnesia, vi era essa stessa soggiaciuta. Succede talvolta in modo simile nel sonno a chi ha
familiarità con la psicoanalisi: costui è destato da un sogno, decide di analizzarlo senza indugio, si
riaddormenta soddisfatto del risultato, e il giorno dopo sogno e analisi sono dimenticati.
(S. Freud, Opere, Boringhieri, Torino, 1989, vol. V, pagg. 508-511, 587-589)
Auguste Comte
CORSO DI FILOSOFIA POSITIVA
[I caratteri della filosofia positiva]
Vediamo, da ciò che precede, che il carattere fondamentale della filosofia positiva è da considerare tutti i
fenomeni come sottostanti a leggi naturali invariabili, la cui scoperta precisa e la cui riduzione al minor
numero possibile sono il fine di tutti i nostri sforzi, considerando come assolutamente inaccessibile e privo di
senso per noi la ricerca di ciò che viene chiamato la causa, sia prima, che finale. […] Così, per citare
l’esempio più ammirevole, noi diciamo che i fenomeni generali dell’universo sono spiegati, per quanto è
possibile, dalla legge newtoniana della gravitazione, perché, da un lato, questa bella teoria ci mostra tutta
l’immensa varietà dei fatti astronomici come fossero un solo e medesimo fatto, considerato sotto diversi
punti di vista, ci mostra la tendenza costante di tutte le molecole, le une verso le altre, in ragione diretta delle
loro masse ed in ragione inversa dei quadrati delle loro distanze; mentre, d’altra parte, questo fatto generale è
presentato come la semplice estensione di un fenomeno che ci è estremamente familiare e che, per ciò
soltanto, noi consideriamo perfettamente conosciuto: la pesantezza dei corpi e la superficie della terra. Il
determinare che cosa siano in se stesse attrazione e pesantezza, quali ne siano le cause, sono questi i
problemi, a cui guardiamo come insolubili, che non appartengono al dominio della filosofia positiva e che
noi abbandoniamo con ragione all’immaginazione dei teologi o alle sottigliezze dei metafisici. La prova
manifesta della impossibilità di raggiungere soluzioni di questo genere è che tutte le volte che si è cercato di
dire a questo riguardo qualcosa di veramente razionale i maggiori spiriti non hanno potuto far altro che
definire questi due principi l’uno per mezzo dell’altro dicendo, per quanto riguarda l’attrazione, che essa
altro non è che un peso universale e poi, per il peso, che esso consiste semplicemente nell’attrazione
243
terrestre. Spiegazioni di questo genere, che fanno sorridere quando si pretende di conoscere la natura intima
delle cose ed il modo in cui vengono generati i fenomeni, sono tuttavia tutto ciò che noi possiamo ottenere di
più soddisfacente, in quanto ci mostrano come identici due ordini di fenomeni che sono stati così a lungo
considerati come non aventi alcun rapporto tra loro. Nessuno spirito sano cerca oggi di andare più a fondo.
[Il compito della filosofia positiva]
Ma, pur riconoscendo i prodigiosi risultati di questa divisione e pur vedendo in essa la base fondamentale
dell’organizzazione del mondo del sapere, è impossibile, d’altra parte, non imbattersi negli inconvenienti che
essa genera allo stato attuale, per l’eccessiva limitazione dei campi di indagine. Una maniera valida per
arrestare l’influenza deleteria, da cui l’avvenire sembra minacciato in seguito ad una esagerata
specializzazione della ricerca individuale, non sarà certamente quella di ritornare all’antica confusione dei
lavori, la quale farebbe soltanto regredire lo spirito umano e che al giorno d’oggi sarebbe impossibile. Essa
consiste al contrario nella perfezione della divisione del lavoro. Basta, in effetti, fare dello studio delle
generalità scientifiche una grande specialità in più. Che una nuova classe di sapienti, preparati da una
educazione adeguata, non legati alla cultura specialistica della filosofia naturale, si occupi unicamente,
considerando le diverse scienze positive allo stato attuale, a determinare esattamente lo spirito di ciascuna di
esse, a scoprirne le relazioni ed i nessi, a ricondurre, se è possibile, tutti i principi propri in un minor numero
di principi comuni, conformandosi continuamente ai fondamenti del metodo positivo.
[La legge dei tre stadi]
Per spiegare convenientemente la vera natura ed il carattere proprio della filosofia positiva è necessario
gettare uno sguardo d’insieme sulla marcia progressiva dello spirito umano, perché qualsiasi dottrina può
essere meglio conosciuta quando se ne conosce la storia.
Studiando così lo sviluppo dell’intelligenza umana nelle sue diverse sfere di attività, dalle prime
manifestazioni fino ai nostri giorni, credo di aver scoperto una grande legge fondamentale, alla quale esso è
soggetto con ferrea necessità e che può essere definita in modo preciso sia con prove razionali ricavate dalla
conoscenza della nostra organizzazione, sia con la verifica storica risultante da un attento esame del passato.
Questa legge consiste nel fatto che ogni nostra concezione fondamentale, ciascun settore delle nostre
conoscenze, passa successivamente attraverso tre stadi diversi: lo stadio teologico o fittizio; lo stadio
metafisico o astratto; lo stadio scientifico o positivo. In altre parole lo spirito umano, per sua natura, adopera
successivamente, in tutte le sue ricerche, tre metodi di filosofare, il cui carattere è essenzialmente differente e
persino opposto: all’inizio il metodo teologico, quindi quello metafisico, infine il metodo positivo. Da lì
hanno origine tre tipi di filosofia, o di concezioni generali sull’insieme dei fenomeni, che si escludono
reciprocamente; il primo è il punto di partenza necessario dell’intelligenza umana, il terzo la sua
sistemazione definitiva e fissa, il secondo vale soltanto come momento di passaggio.
Nello stadio teologico lo spirito umano indirizza essenzialmente le sue ricerche verso la natura intima delle
cose, le cause prime e le cause ultime di tutti gli effetti che lo colpiscono, in una parola, verso le conoscenze
assolute e si rappresenta i fenomeni come prodotti dall’azione diretta e continua di agenti sovrannaturali più
o meno numerosi, il cui arbitrario intervento dà ragione di tutte le contraddizioni apparenti dell’universo.
Nello stato metafisico, che non è in fondo se non una semplice modificazione generale del precedente, gli
agenti sovrannaturali sono sostituiti da forze astratte, vere entità inerenti ai diversi esseri del mondo e
concepite come capaci di produrre esse stesse tutti i fenomeni osservati, la cui spiegazione consiste dunque
nell’assegnare a ciascuno l’entità corrispondente. Infine nello stato positivo lo spirito umano riconoscendo
l’impossibilità di raggiungere delle nozioni assolute rinuncia a cercare l’origine ed il destino dell’universo ed
a conoscere le cause intime dei fenomeni, per dedicarsi unicamente a scoprire, con l’uso opportunamente
combinato del ragionamento e dell’osservazione, le loro leggi effettive, cioè le loro relazioni invariabili di
successione e di somiglianza. La spiegazione dei fatti, ridotta dunque nei suoi termini reali, non è altro ormai
che il legame posto tra i diversi fenomeni particolari ed alcuni fatti generali; di qui derivano i progressi della
scienza che tende sempre più a diminuire il numero delle leggi [...]
Ordunque, se la filosofia positiva è il vero e proprio stato definitivo dell’intelligenza umana, quello stato
verso cui essa è stata sempre più intensamente protesa, nondimeno essa ha dovuto necessariamente
244
impiegare all’inizio e durante una lunga successione di secoli sia come metodo, sia come dottrina
provvisoria, la filosofia teologica; filosofia il cui carattere è d’essere spontanea, e perciò la sola possibile
all’origine, la sola anche che possa offrire al nostro spirito nascente un interesse sufficiente. È ora molto
facile accorgersi che per passare da questa filosofia provvisoria alla filosofia definitiva, lo spirito umano ha
dovuto naturalmente adottare, come filosofia transitoria, i metodi e le dottrine metafisiche. Quest’ultima
considerazione è indispensabile per completare il breve ragguaglio generale sulla grande legge che ho
prospettato.
F. Tonon, Auguste Comte e il problema storico-politico nel pensiero contemporaneo,
G. D’Anna, Messina-Firenze, 1975, pagg. 129-136
Karl Raimund Popper
LOGICA DELLA RICERCA E SOCIETA’ APERTA. SULL’INDUZIONE
Desidero perciò dire che io non credo che esista nulla di simile al metodo induttivo, o a un procedimento
induttivo, [...].
Non faccio mai questioni di parole, e naturalmente non ho nessuna seria obiezione contro chi voglia
chiamare col nome “induzione” il metodo di discussione critica. Ma in questo caso è necessario rendersi
conto che si tratta di qualcosa di molto diverso da tutto ciò che in passato è stato chiamato “induzione”.
Infatti, si è sempre pensato che l'induzione debba fondare una teoria, o una generalizzazione, mentre il
metodo della discussione critica non fonda un bel niente. Il suo verdetto è sempre e invariabilmente “non
provato”. La miglior cosa che possa fare – e raramente la fa – è quella di venir fuori con il verdetto che una
certa teoria sembra la migliore disponibile, cioè la migliore che finora sia stata sottoposta alla discussione,
quella che sembra risolvere una gran parte del problema che era destinata a risolvere, e che è sopravvissuta ai
controlli più severi che siamo stati finora in grado di escogitare. Ma naturalmente ciò non fonda la verità
della teoria; cioè non stabilisce che la teoria corrisponde ai fatti, o è una descrizione adeguata della realtà;
tuttavia possiamo dire che un verdetto positivo di questo genere equivale al dire che, alla luce della
discussione critica, la teoria appare come la migliore approssimazione alla verità che si sia finora raggiunta.
245
In realtà, l'idea di “migliore approssimazione alla verità” è, allo stesso tempo, il principale modello della
nostra discussione critica e lo scopo che speriamo di raggiungere, come risultato della discussione. Tra i
nostri altri modelli ci sono il potere esplicativo dl una teoria e la sua semplicità.
Nel passato il termine “induzione” è stato usato soprattutto in due sensi. La prima è l'induzione ripetitiva (o
induzione per enumerazione), che consiste di osservazioni spesso ripetute, osservazioni che dovrebbero
fondare qualche generalizzazione della teoria. La mancanza di validità di questo genere di ragionamento è
ovvia: nessun numero di osservazioni di cigni bianchi riesce a stabilire che tutti i cigni sono bianchi (o che la
probabilità di trovare un cigno che non sia bianco è piccola). Allo stesso modo, per quanti spettri di atomi
d'idrogeno osserviamo non potremo mai stabilire che tutti gli atomi d'idrogeno emettono spettri dello stesso
genere. Tuttavia considerazioni di ordine teorico possono suggerirci quest'ultima generalizzazione, e
considerazioni teoriche ulteriori possono suggerirci di modificarla introducendo spostamenti Doppler e
spostamenti verso il rosso propri della gravitazione einsteiniana.
Dunque l'induzione per enumerazione è fuori causa: non può fondare nulla.
Il secondo senso principale in cui il termine “induzione” è stato usato in passato è l'induzione eliminatoria:
l'induzione fondata sul metodo dell'eliminazione o confutazione delle teorie false. A prima vista questo tipo
di induzione può sembrare molto simile al metodo della discussione critica che io sostengo, ma in realtà è
molto diverso. Infatti Bacone e Mill, e gli altri diffusori di questo metodo dell'induzione per eliminazione
credevano che, eliminando tutte le teorie false, si possa far valere la teoria vera. In altre parole, non si
rendevano conto che il numero delle teorie rivali è sempre infinito, anche se, di regola, in ogni momento
particolare possiamo prendere in considerazione soltanto un numero finito di teorie. Dico “di regola”, perché
qualche volta ci troviamo di fronte a un numero infinito di tali teorie: ad esempio, qualcuno suggerì di
modificare la legge newtoniana dell'attrazione secondo l'inverso dei quadrati, sostituendo al quadrato una
potenza che differisca solo di poco al numero 2. Questa proposta equivale al suggerimento che si dovrebbe
considerare un numero infinito di correzioni, di poco differenti tra loro, della legge di Newton.
Il fatto che per ogni problema esiste sempre un'infinità di soluzioni logicamente possibili, è uno dei fatti
decisivi di tutta la scienza; è una delle cose che fanno della scienza un'avventura così eccitante. Esso infatti
rende inefficaci tutti i metodi basati sulla mera routine. Significa che, nella scienza, dobbiamo usare
l'immaginazione e idee ardite, anche se l'una e le altre devono sempre essere temperate dalla critica e dai
controlli piú severi.
Tra l'altro, mette anche in evidenza l'errore di coloro i quali pensano che lo scopo della scienza sia,
puramente e semplicemente, quello di stabilire correlazioni tra gli eventi osservati, o le osservazioni (o,
peggio ancora, fra i “dati sensibili”). In scienza, tendiamo a molto di più. Tendiamo a scoprire nuovi mondi
dietro il mondo dell'esperienza ordinaria, mondi come, ad esempio, un mondo microscopico o
submicroscopico; come, ad esempio, un mondo non-euclideo, un mondo popolato di forze invisibili: forze
gravitazionali, chimiche, elettriche e nucleari, alcune delle quali, forse, sono riducibili ad altre, mentre altre
non lo sono. Proprio la scoperta di questi nuovi mondi, di queste possibilità che nessuno si era mai sognato,
accresce di tanto il potere liberatore della scienza. I coefficienti di correlazione sono interessanti, non perché
mettono le nostre osservazioni in relazione fra loro ma perché, e solo quando, ci aiutano a imparare qualcosa
di più intorno a questi mondi.
K. R. Popper, Logica della ricerca e società aperta, Antologia a cura di D. Antiseri,
La Scuola, Brescia, 1989, pagg. 33-35
246