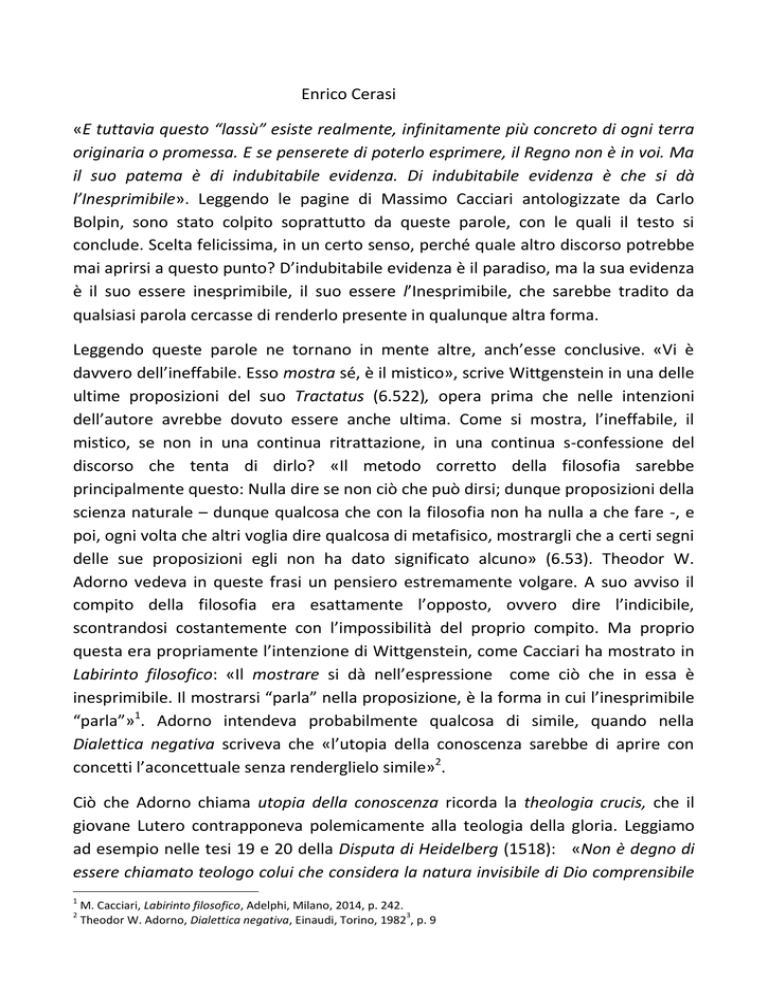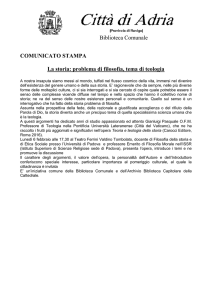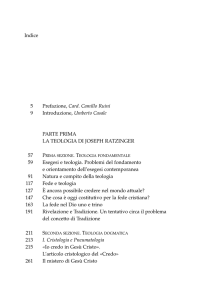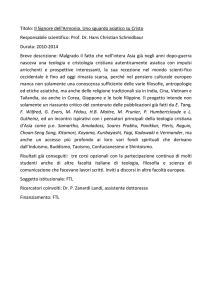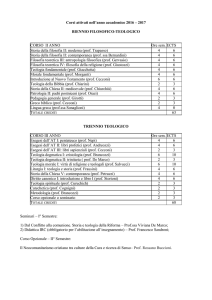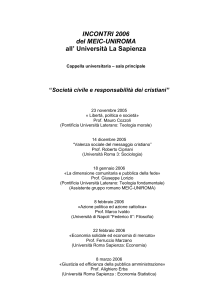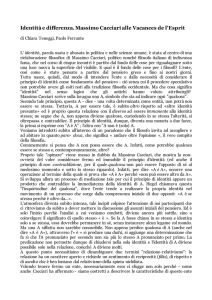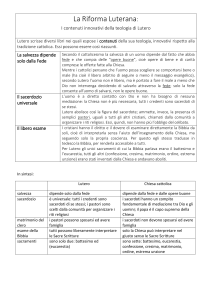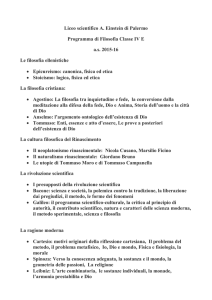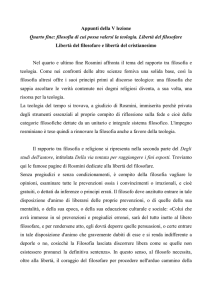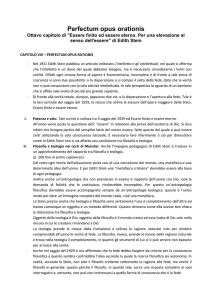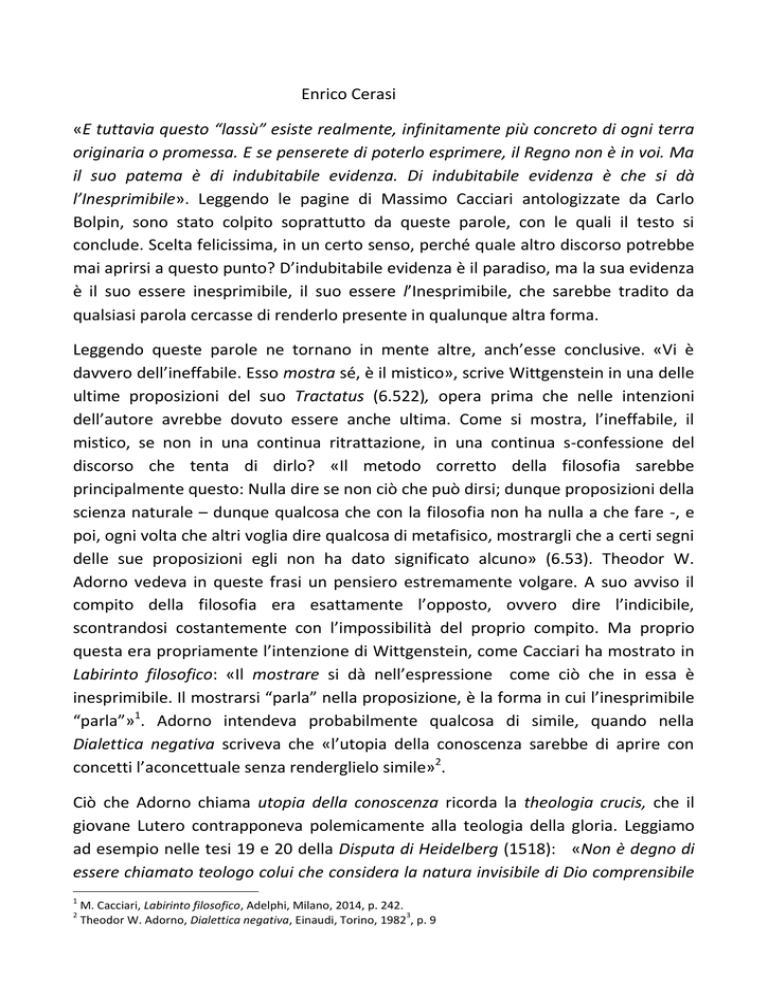
Enrico Cerasi
«E tuttavia questo “lassù” esiste realmente, infinitamente più concreto di ogni terra
originaria o promessa. E se penserete di poterlo esprimere, il Regno non è in voi. Ma
il suo patema è di indubitabile evidenza. Di indubitabile evidenza è che si dà
l’Inesprimibile». Leggendo le pagine di Massimo Cacciari antologizzate da Carlo
Bolpin, sono stato colpito soprattutto da queste parole, con le quali il testo si
conclude. Scelta felicissima, in un certo senso, perché quale altro discorso potrebbe
mai aprirsi a questo punto? D’indubitabile evidenza è il paradiso, ma la sua evidenza
è il suo essere inesprimibile, il suo essere l’Inesprimibile, che sarebbe tradito da
qualsiasi parola cercasse di renderlo presente in qualunque altra forma.
Leggendo queste parole ne tornano in mente altre, anch’esse conclusive. «Vi è
davvero dell’ineffabile. Esso mostra sé, è il mistico», scrive Wittgenstein in una delle
ultime proposizioni del suo Tractatus (6.522), opera prima che nelle intenzioni
dell’autore avrebbe dovuto essere anche ultima. Come si mostra, l’ineffabile, il
mistico, se non in una continua ritrattazione, in una continua s-confessione del
discorso che tenta di dirlo? «Il metodo corretto della filosofia sarebbe
principalmente questo: Nulla dire se non ciò che può dirsi; dunque proposizioni della
scienza naturale – dunque qualcosa che con la filosofia non ha nulla a che fare -, e
poi, ogni volta che altri voglia dire qualcosa di metafisico, mostrargli che a certi segni
delle sue proposizioni egli non ha dato significato alcuno» (6.53). Theodor W.
Adorno vedeva in queste frasi un pensiero estremamente volgare. A suo avviso il
compito della filosofia era esattamente l’opposto, ovvero dire l’indicibile,
scontrandosi costantemente con l’impossibilità del proprio compito. Ma proprio
questa era propriamente l’intenzione di Wittgenstein, come Cacciari ha mostrato in
Labirinto filosofico: «Il mostrare si dà nell’espressione come ciò che in essa è
inesprimibile. Il mostrarsi “parla” nella proposizione, è la forma in cui l’inesprimibile
“parla”»1. Adorno intendeva probabilmente qualcosa di simile, quando nella
Dialettica negativa scriveva che «l’utopia della conoscenza sarebbe di aprire con
concetti l’aconcettuale senza renderglielo simile»2.
Ciò che Adorno chiama utopia della conoscenza ricorda la theologia crucis, che il
giovane Lutero contrapponeva polemicamente alla teologia della gloria. Leggiamo
ad esempio nelle tesi 19 e 20 della Disputa di Heidelberg (1518): «Non è degno di
essere chiamato teologo colui che considera la natura invisibile di Dio comprensibile
1
2
M. Cacciari, Labirinto filosofico, Adelphi, Milano, 2014, p. 242.
3
Theodor W. Adorno, Dialettica negativa, Einaudi, Torino, 1982 , p. 9
per mezzo delle sue opere» «Ma colui che comprende la natura di Dio, visibile e volta
verso il mondo, per mezzo della passione e della croce»3. La gloria dell’Altissimo nella
più abietta umiliazione, l’onnipotenza dell’Eterno nella passione temporale e nella
croce: Dio, insomma, sub contraria specie, nelle apparenze contrarie. Scrisse
Giovanni Miegge: «Così la nostra vita è nascosta sotto la morte, l’amore di Dio per
noi sotto l’odio contro di noi […]. E in generale, ogni nostro sì nei riguardi di ogni
bene, sotto il no, affinché la fede abbia spazio in Dio»4.
… Affinché la fede abbia spazio in Dio. Dunque è affinché si dia fede e non pagana
sapienza che Dio si rivela nella croce? Risuonano qui le note parole dell’Apostolo:
«Poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza, è piaciuto a
Dio, nella sua sapienza, di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. I Giudei
infatti chiedono miracoli e i Greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo
crocefisso, che per i Giudei è scandalo e per gli stranieri pazzia» (I Corinzi 1, 21-23).
La rivelazione di Dio nella croce di Cristo richiede la fede, siamo d’accordo, ma ciò
poiché la sapienza degli uomini si è rivelata inconcludente, o peggio asservita
all’orgoglio umano e quindi al peccato? È il fallimento storico della sapienza a
rendere necessaria la pura fede nella croce? O forse la sapienza umana era sin
dall’origine esclusa dal piano salvifico di Dio, secondo il mito gnostico valentiniano?
Demitizzata, era probabilmente questa la posizione di Lutero, che spesso si lasciava
andare a pensati invettive contro la meretrice ragione. Oppure la sapienza umana
deve accordarsi, sia pure in modo paradossale, alla stessa fede per corrispondere al
mistero della rivelazione? Almeno dalle Confessioni di Agostino la storia della
teologia occidentale ha riproposto in diverse forme il rapporto complesso,
paradossale, agonico, tra pensiero e rivelazione. Diversi sarebbero in nomi da citare
in proposito; il pensiero di Cacciari, che nella sua opera maggiore parla di crux
philosophorum5, ci obbliga ad andare fino in fondo in questa direzione, molto più di
quanto la teologia sarebbe disposta a pensare. Proprio rispondendo a Lutero, il
quale parlava del credente quale simul iustus et peccator, contemporaneamente
giusto e peccatore, Cacciari nota che la fede (e la permanenza in essa) è sì opera
divina, come nella teologia agostiniana e luterana, ma ciò non dà alcuna sicurezza:
«La fede è opera divina, ma dura soltanto perché in ogni istante sostenuta da Dio, e
perciò in ogni istante il pistós è anche àpistos. L’agón, il certamen, la lotta tra pístis e
3
M. Lutero, Scritti religiosi, a cura di V. Vinay, Utet, Torino, 1967, p. 196
G. Miegge, Lutero giovane, Claudiana, Torino, 1946, ora ristampato col titolo Lutero. L’uomo e il pensiero fino alla
dieta di Worms (1483-1521), Claudiana, Torino, 2003, p. 154.
5
2
Cf. M. Cacciari, Dell’Inizio, Adelphi, Milano, 2001 , pp. 61-165.
4
apistía si rinnova, costantemente, e sta al fondamento di quella preghiera che il
credente, che non è mai “buono”, esprime come sua propria: “credo; adiuva
incredulitatem meam”»6. Credo, aiuta la mia incredulità. Si noti che già per Lutero, il
quale per altro si era sporto parecchio innanzi, molto più di quanto la Chiesa romana
ritenesse lecito, il credente non è davvero simul giusto e peccatore: ma è giusto solo
agli occhi di Dio, il quale per grazia non gli imputa alcun peccato, mentre è sempre
peccatore ai suoi propri occhi. Per Cacciari, se capisco bene, questa “aristotelica”
divisione degli ambiti non può darsi. La fede è anche incredulità, o almeno è in
costante lotta con essa; il Dio rivelato è al tempo stesso nascosto; l’Indicibile, il
mistico, il senso della vita, nell’Età del Figlio, si dà solo come ciò che la forma logica
del linguaggio esclude e al tempo stesso mostra.
È questo il pensiero impossibile per ogni teologia? È questo il suo limite? Solo la
filosofia è capace di quella necessaria sconfessione, che non diventi sospensione del
giudizio, al modo degli scettici, ma lotta costante contro Dio, o il suo angelo, come
nell’esperienza di Giacobbe? Che tutto ciò sia già nelle Confessioni di Agostino,
padre della teologia occidentale, farebbe propendere per una risposta negativa. Del
resto andrebbe ricordato che proprio il vescovo d’Ippona non usa mai la parola
“teologia” se non per qualificare il pensiero dei pagani, mentre altrimenti parla di
filosofia cristiana. Teologia e filosofia, insomma, non nominano due discipline
distinte o addirittura incommensurabili, due facoltà in conflitto, ma due attitudini
diverse del pensiero nei confronti della rivelazione.
Con ciò abbiamo smentito le sensazioni iniziali, com’era inevitabile. Le parole di
Cacciari erano tutt’altro che conclusive. Piuttosto che chiudere il sistema, esse
parlano dell’insecuritas che la teologia non dovrebbe mai sopire, ma che la filosofia
sbaglierebbe a trasformare in un appagato scetticismo o in fideismo irrazionalista. E
inquieto è il cuore mio finché non trova pace in Te, confessava Agostino. Ma questa
pace è concepibile solo escatologicamente, perché nel tempo la presenza di Dio si
dà solo nell’inquietudine, nell’insonne confessione e della grazia e nella
sconfessione di ogni umano tentativo di impadronirsene.
6
Ibid. p. 577.