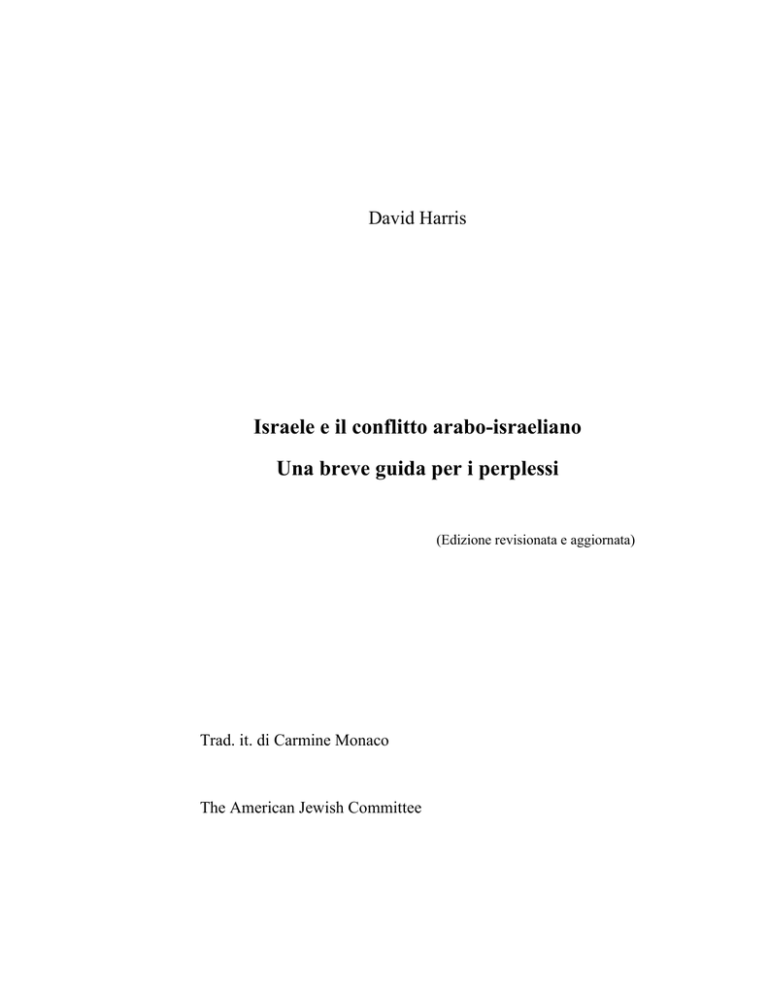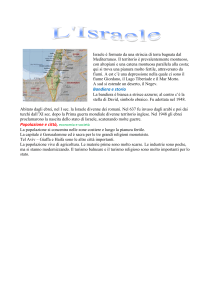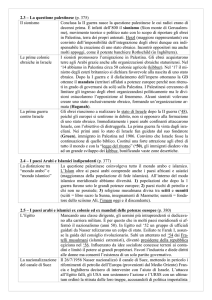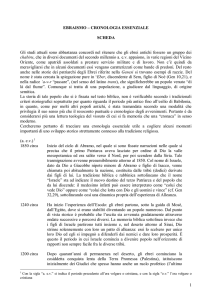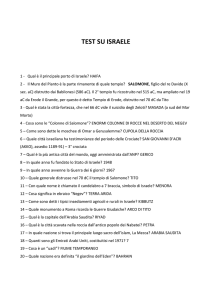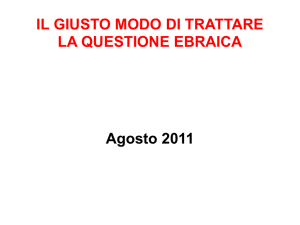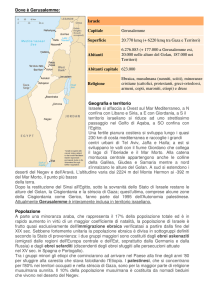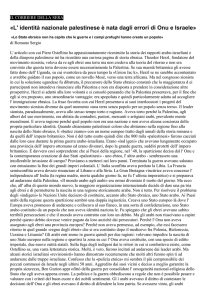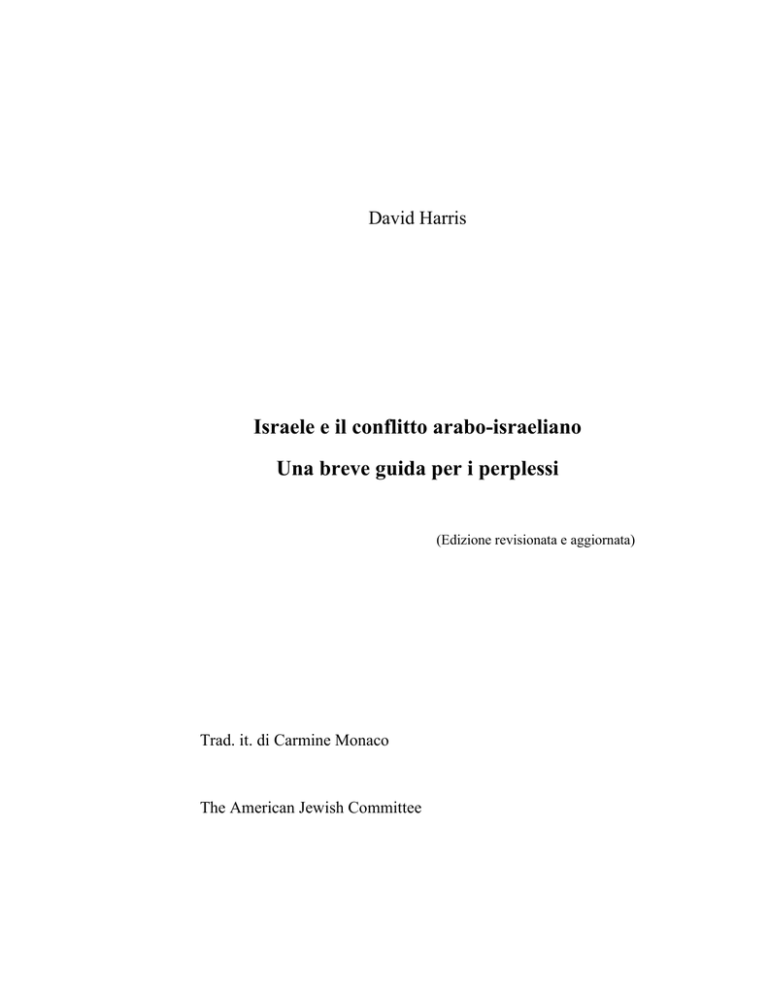
David Harris
Israele e il conflitto arabo-israeliano
Una breve guida per i perplessi
(Edizione revisionata e aggiornata)
Trad. it. di Carmine Monaco
The American Jewish Committee
L’American Jewish Committee protegge i diritti e le libertà
degli ebrei in tutto il mondo; combatte il fanatismo e
l’antisemitismo e promuove i diritti umani per tutti; lavora per la
sicurezza di Israele e per una maggiore comprensione tra
Americani e Israeliani; sostiene una posizione politica fondata
sui valori democratici americani nella prospettiva del retaggio
culturale ebraico, e sostiene la creativa vitalità del popolo
ebraico. Fondata nel 1906, è stata un’agenzia pionieristica nel
campo delle relazioni umane negli Stati Uniti.
David Harris
Israele e il conflitto arabo-israeliano
Una breve guida per i perplessi
(Edizione revisionata e aggiornata)
Trad. it. di Carmine Monaco
The American Jewish Committee
David A. Harris è direttore esecutivo dell’American Jewish
Committee dal 1990. Ha conseguito la laurea presso l’Università
di Pennsylvania, si è laureato in relazioni internazionali presso la
London School of Economics, ed ha effettuato studi post-laurea
presso l’Università di Oxford. È autore di The Jewish World,
Entering a New Culture, In the Trenches, Vol. I, II, III, e coautore di The Jokes of Oppression.
La storia di Israele è la mirabile realizzazione di un legame
tra una terra, una fede, una lingua, un popolo e una visione, che
dura da oltre 3.500 anni.
È una storia esemplare di tenacità e determinazione, di
coraggio e rinnovamento. È la prova del predominio della
speranza sulla disperazione.
David A. Harris, da In the Trenches (2000).
Titolo originale: Israel and the Arab-Israel Conflict: a Brief
Guide for the Perplexed
Copyright © 2005 American Jewish Committee
All Rights Reserved.
Data di pubblicazione: Agosto 2005
Israele e il conflitto arabo-israeliano:
una breve guida per i perplessi
Il Medio Oriente pare essere sempre presente nei notiziari. È
difficile che un giorno trascorra senza una storia su qualcosa
accaduto
in
Israele
o
sul
conflitto
arabo-israeliano.
Sfortunatamente, data la natura rapida e martellante di molti
notiziari dei giorni nostri, l’informazione spesso è carente in
quanto a contesto storico. Questa pubblicazione fornisce alcune
prospettive e punti di discussione, sia storici che contemporanei,
ma senza l’intento di una disamina esaustiva della situazione.
Le ragioni a sostegno della causa di Israele sono forti
oggi come ieri.
Di fronte ai fatti concreti, le persone di buona volontà
dovrebbero comprendere:
a) la richiesta di pace e sicurezza avanzata da Israele per
cinquantasette anni;
b) il reale pericolo affrontato da Israele, un paese non più
esteso del New Jersey o del Galles, pari a due terzi del Belgio e a
solo l’1% del territorio dell’Arabia Saudita, circondato da vicini
tumultuosi e pesantemente armati;
c) l’incrollabile impegno di Israele ad essere una
democrazia, caratterizzata da libere elezioni, pacifici passaggi di
potere, controllo dei civili sui militari, libertà di parola, stampa,
religione e riunione, ed una magistratura indipendente – un caso
unico in tutta la regione;
d) il filo comune delle minacce dell’estremismo e del
terrorismo affrontate da Israele, Stati Uniti, Europa, India,
Australia, Russia, paesi islamici moderati e altri ancora;
e) l’impressionante e pionieristico contributo di Israele alla
civiltà mondiale in campi come scienza, medicina, tecnologia,
agricoltura e cultura; contributo ancora più rimarchevole,
considerando la relativa giovinezza del paese e il pesante
impegno difensivo dei propri confini, ma che purtroppo viene
spesso dimenticato nella preoccupazione di trattare il conflitto e
la violenza.
Nessun paese può vantare una storia perfetta, e Israele, come
altre nazioni democratiche, ha commesso la sua quota di errori.
Ma riconoscere la propria fallibilità è una forza nazionale, non
una debolezza. E la storia israeliana può essere favorevolmente
comparata a quella di qualsiasi altro paese della regione, e anche
ben oltre la regione, in forza della sua dedizione ai valori
democratici.
Israele può essere orgoglioso della sua storia, e i suoi amici
non dovrebbero esitare a gridarlo dai tetti. Una storia iniziata
molto prima della rifondazione del moderno stato nel 1948.
Il legame del popolo ebraico con la terra d’Israele è
incontrovertibile e ininterrotto.
Un legame che illumina un arco di storia di quattromila anni.
La prova “A” di questo legame è la Bibbia ebraica. Il Libro
del Genesi, il primo dei cinque libri della Bibbia, racconta la
storia di Abramo, l’alleanza col Dio unico, e la partenza da Ur
(nell’attuale Iraq) verso Canaan, la regione corrispondente grosso
modo a Israele. Il Libro dei Numeri, il quarto libro della Bibbia,
contiene le seguenti parole: «Il Signore parlò a Mosè, e gli disse:
“Manda degli uomini ad esplorare la terra di Canaan, che sto per
dare al popolo d’Israele”». Cosa che si realizzò al termine di
quarant’anni di spostamenti degli israeliti, in cerca non solo di un
rifugio dagli egiziani, ma della Terra Promessa – quella terra che
oggi è Israele.
La prova “B” è costituita da qualsiasi libro di preghiere
ebraiche in uso lungo l’arco dei secoli ovunque nel mondo. I
riferimenti nella liturgia a Sion, la terra di Israele, sono infiniti.
E questi argomenti sono solo due tra i molti riferimenti a
questa terra e alla sua centralità per la storia ebraica e la sua
identità nazionale.
Lo stesso forte legame unisce il popolo ebraico a
Gerusalemme.
Questo legame risale ai tempi di Re Davide, il quale visse
approssimativamente tremila anni fa, stabilendo a Gerusalemme
la capitale di Israele. Da quel momento, Gerusalemme ha
rappresentato non soltanto il centro geografico del popolo
ebraico, ma anche il cuore metafisico e spirituale della sua fede e
della sua identità. Non importa dove gli ebrei preghino: essi si
rivolgeranno sempre in direzione di Gerusalemme. Davvero, la
relazione tra Gerusalemme e il popolo ebraico è un caso unico
negli annali della storia.
Gerusalemme è stata il sito dei due Templi – il primo
costruito da Re Salomone durante il decimo secolo a.e.v., e
distrutto nel 586 a.e.v. durante la conquista babilonese, e il
secondo fu costruito meno di un secolo dopo, successivamente
ampliato da Re Erode e infine distrutto dall’esercito romano nel
70 e.v..
Scrive il salmista: «Se ti dimentico, Gerusalemme, mi si
secchi la mano destra; la mia lingua si incolli al palato se smetto
di pensarti, se non dovessi ricordare Gerusalemme anche nell’ora
più felice».
In un commentario alle Scritture ebraiche si legge: «Anche
tu trovi che ci sia una Gerusalemme superiore, corrispondente
alla Gerusalemme inferiore. Per puro amore della Gerusalemme
terrestre, Dio si fece Uno sopra».
E per tremila anni al Seder di Pasqua (cena pasquale, n.d.t.)
gli ebrei hanno ripetuto le parole: «L’anno prossimo a
Gerusalemme».
Sebbene forzatamente dispersi per quasi diciannove
secoli, gli ebrei non hanno mai spento il loro ardente
desiderio per Sion e Gerusalemme.
È scritto nel libro di Isaia: «Per la causa di Sion non rimarrò
in silenzio, per la causa di Gerusalemme non resterò immobile...»
Oltre ad esprimere questa aspirazione mediante le preghiere,
gli ebrei hanno sempre vissuto in terra di Israele, e specialmente
a Gerusalemme, sovente malgrado i pericoli per la loro
incolumità.
Fin dall’Ottocento, gli ebrei hanno costituito la maggioranza
della popolazione in queste terre. Ad esempio, secondo il
Political Dictionary of the State of Israel, gli ebrei costituivano il
61,9 per cento della popolazione di Gerusalemme già nel 1892.
Il legame storico e religioso con Gerusalemme è di speciale
importanza perché alcuni arabi cercano di riscrivere la storia e
asseriscono che gli ebrei sono «occupanti stranieri» o
«colonialisti» senza reali legami con questa terra. Questi tentativi
di negare la legittimità dello Stato di Israele sono falsi in maniera
evidente e vanno mostrati per quello che sono: bugie. Peraltro
essi ignorano il fatto “sconveniente” che quando Gerusalemme fu
sotto dominio islamico (ad esempio, degli Ottomani e, più tardi,
dei giordani), fu sempre ridotta ad una palude. Non fu mai un
centro politico, religioso o economico. Ad esempio, quando
Gerusalemme fu in mani giordane dal 1948 al 1967, praticamente
nessun leader arabo la visitò, e nessuno della casa regnante dei
Saud venne dall’Arabia Saudita a pregare alla Moschea di AlAqsa in Gerusalemme Est.
Il Sionismo è la richiesta di autodeterminazione
nazionale del popolo ebraico.
Sebbene l’aspirazione alla terra della nazione ebraica risalga
a migliaia di anni addietro, come testimoniano i testi classici
ebraici, essa affonda le sue radici anche in una realtà più recente.
Teodoro Herzl, considerato il padre del moderno Sionismo,
fu un ebreo laico, un giornalista viennese che rimase sbigottito
dal chiassoso antisemitismo che corroborava l’infame “Affaire
Dreyfus” in Francia, il primo paese europeo ad estendere pieni
diritti agli ebrei, così come nel suo nativo impero austroungarico. Egli giunse alla conclusione che gli ebrei non
avrebbero mai potuto godere di piena eguaglianza come
minoranza nelle società europee, poiché la triste eredità di secoli
di antisemitismo vi era troppo profondamente radicata. Perciò,
egli chiese la creazione di uno stato ebraico, da lui stesso
descritto nella sua opera più importante Der Judenstaat (trad. it.
Lo stato ebraico, Genova 1992), pubblicato nel 1896.
La visione di Herzl fu fatta propria dal ministro degli esteri
britannico Lord Balfour, il quale, il 2 novembre del 1917, emanò
una dichiarazione:
Il governo di Sua Maestà vede con favore lo stabilirsi in Palestina di
una casa nazionale per il popolo ebraico, e compirà i suoi migliori
sforzi per facilitare il raggiungimento di questo obiettivo, essendo
chiaramente compreso che nulla sarà fatto che possa pregiudicare i
diritti civili e religiosi delle esistenti comunità non ebraiche in
Palestina, così come i diritti e lo status politico goduto dagli ebrei in
qualsiasi altro paese.
Nel 1922, la Lega delle Nazioni, incaricando la Gran
Bretagna di un mandato per la Palestina, riconobbe «il legame
storico del popolo ebraico con la Palestina».
L’ascesa di Adolf Hitler e la “Soluzione Finale” nazista,
guidata dalla Germania e dai suoi alleati – e facilitata dalla
diffusa complicità o dalla semplice indifferenza al destino degli
ebrei della gran parte del mondo – rivelò in tutta la sua tragica
dimensione il disperato bisogno di uno stato ebraico. (Al
riguardo, ricordiamo che il muftì di Gerusalemme Haj Amin elHusseini fu tra i più entusiastici sostenitori del genocidio nazista
del popolo ebraico.)
Solo in un tale stato, credeva il movimento sionista – e i suoi
sostenitori non ebrei – gli ebrei non avrebbero dovuto affidarsi
alla “buona volontà” degli altri per determinare il proprio
destino. Tutti gli ebrei sarebbero stati benvenuti in Israele, che
avrebbe dato loro un rifugio dalle persecuzioni o compimento al
loro “ardente desiderio di Sion”. Fu proprio quest’ultimo aspetto
che infiammò l’immaginazione di molti ebrei che, a cavallo tra
l’800 e il ‘900, si insediarono in quella che era allora una
Palestina desolata e, al riparo dalle condanne ideologiche,
guidarono la fondazione del moderno stato di Israele.
Parlando di desolazione, l’autore e umorista americano Mark
Twain visitò l’area nel 1867. Egli la descrisse così:
… [Un] paese desolato il cui suolo è ricco abbastanza, ma è quasi
per intero dato alle erbacce – un silenzio luttuoso vi si espande... Vi
è qui una desolazione a cui nessuna immaginazione può fare la
grazia di pomparvi la vita e l’azione... Non abbiamo mai visto un
essere umano lungo l’intero percorso... C’era a stento un albero o un
arbusto in tutto. Persino l’ulivo e il cactus, questi amici fedeli dei
suoli senza valore, avevano pressoché disertato il paese.
Basta un solo momento a chiunque visiti oggi Israele per
vedere le miracolose trasformazioni della terra, le foreste
amorevolmente piantate, il suolo irrigato e coltivato, e le città e i
villaggi costruiti.
Gli attuali avversari di Israele alterano maliziosamente il
significato di Sionismo – il movimento per l’autodeterminazione
del popolo ebraico – nel tentativo di presentarlo come una forza
demoniaca. Inoltre, essi cercano di descrivere l’area come un
posto ben sviluppato dagli arabi residenti, successivamente
estromessi dagli ebrei che vi erano sopraggiunti. Il loro obiettivo
principale è quello di minare la raison d’être di Israele ed isolare
lo stato dalla comunità delle nazioni.
Questo accadde, ad esempio, nel 1975, quando l’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite, superando le strenue obiezioni dei
paesi democratici, adottò una risoluzione che etichettava il
Sionismo come “razzismo”. La risoluzione fu finalmente
abrogata nel 1991, ma l’infame menzogna riemerse nel 2001, alla
Conferenza mondiale contro il razzismo, svoltasi a Durban, nel
Sud Africa. Il blocco arabo, comunque, fallì il suo tentativo di
ottenere la condanna del Sionismo nel documento della
conferenza. In quella circostanza, molte nazioni compresero che
il conflitto tra Israele e i palestinesi è, come è sempre stato,
politico, non razziale.
Tra l’altro, questo ricorrente tentativo di marchiare il
Sionismo come razzismo è un lampante esempio di asino che dà
del somaro al bue. Le nazioni arabe formalmente definiscono se
stesse in base alla loro etnia, cioè quella araba, il che esclude
automaticamente gli altri gruppi etnici non-arabi, come i berberi
e i curdi. Lo stesso vale per la religione. L’Islam è la religione
ufficiale in tutti i paesi arabi tranne uno (il Libano), il che
determina una emarginazione forzata delle fedi non islamiche, in
particolare delle minoranze cristiane.
In quest’ambito, vale la pena di ricordare il commento
sull’antisionismo del reverendo Martin Luther King Jr.:
Che cos’è l’antisionismo? È il rifiuto opposto al popolo ebraico di
quel fondamentale diritto che noi giustamente reclamiamo per il
popolo d’Africa e per tutte le nazioni della Terra. È una
discriminazione contro gli ebrei, amici miei, perché essi sono ebrei.
In breve, questo è antisemitismo... Lasciate che queste mie parole
riecheggino nel profondo della vostra anima: quando la gente critica
il Sionismo, intende gli ebrei – non c’è da sbagliarsi al riguardo.
È importante anche sottolineare che i non ebrei non sono
stati esclusi dalla costruzione dello stato di Israele. Al contrario.
Oggi un quinto dei cittadini israeliani sono non ebrei, compreso
oltre un milione di arabi, e l’arabo è una delle lingue ufficiali
della nazione.
Inoltre, la popolazione ebraica di Israele è sempre stata
portatrice di enormi diversità nazionali, etniche, culturali e
linguistiche, che si accentuarono ancora di più a cavallo del
1980, quando Israele salvò decine di migliaia di ebrei neri
residenti in una Etiopia duramente colpita dalla siccità, e che
chiedevano di essere portati in Israele. Riporto qui l’eloquente
commento di Julius Chambers, allora direttore generale del
“N.A.A.C.P. [National Association for the Advancement of
Coloured People, n.d.t.] Fondo di difesa legale ed educazione”:
Se le vittime della carestia in Etiopia fossero state bianche,
innumerevoli nazioni avrebbero forse offerto loro un rifugio. Ma la
gente che muore ogni giorno di fame in Etiopia e in Sudan sono neri,
e in un mondo dove il razzismo è ufficialmente deplorato
virtualmente da ogni governo organizzato, solo una nazione non
Africana ha aperto le sue porte e le sue braccia. La silenziosa azione
umanitaria dello Stato di Israele, azione intrapresa senza alcun
riguardo al colore della pelle di coloro che sono stati salvati, si eleva
come una condanna del razzismo molto più concreta di tanti
semplici discorsi o risoluzioni.
Il conflitto arabo-Israeliano poteva essere evitato.
Poco dopo la sua fondazione nel 1945, le Nazioni Unite
presero ad interessarsi del futuro della Palestina mandataria,
allora sotto protettorato britannico. Una commissione dell’ONU
(UNSCOP, United Nations Special Committee on Palestine)
raccomandò all’Assemblea Generale una partizione della terra tra
ebrei e arabi. Nessuna delle parti avrebbe ottenuto tutto ciò che
desiderava, ma una divisione avrebbe riconosciuto che vi erano
due popolazioni – una ebraica, l’altra araba – su una terra, e che
ciascuna meritava il suo stato.
Il 29 novembre 1947, l’Assemblea Generale dell’ONU, con
un voto di 33 a favore, 13 contrari e 10 astenuti, adottarono la
Risoluzione n. 181, nota come Piano di Partizione.
L’accettazione del Piano di Partizione avrebbe significato lo
stabilirsi di due stati, ma i confinanti stati arabi e le popolazioni
arabe locali rifiutarono la proposta con veemenza. Essi
rifiutarono di riconoscere un diritto degli ebrei a qualsiasi parte
della terra e scelsero la guerra per ricacciarli fuori. Questo rifiuto
è sempre stato il nocciolo e il cuore del conflitto – allora come
oggi.
Molti paesi arabi e l’Iran, per non menzionare le
organizzazioni terroristiche palestinesi, ancora non riconoscono il
reale diritto all’esistenza di Israele, qualsiasi siano i suoi confini,
anche dopo cinquantasette anni dalla sua fondazione.
Il 14 maggio 1948 lo Stato di Israele fu fondato. Winston
Churchill comprese il suo significato:
La realizzazione di uno stato ebraico... è un evento nella storia del
mondo che non va visto nella prospettiva di una generazione o di un
secolo, ma nella prospettiva di mille, duemila o addirittura tremila
anni.
Anni dopo, il presidente John F. Kennedy offrì la sua
interpretazione del significato della rinascita di Israele quasi
1900 anni dopo la sua ultima espressione di sovranità nazionale:
Israele non è stato creato per scomparire: Israele durerà e fiorirà.
Israele è il figlio della speranza e la casa dei coraggiosi. Esso non
può essere distrutto dall’avversità né demoralizzato dal successo.
Esso porta lo scudo della democrazia e onora la spada della libertà.
Sull’argomento
della
pace,
la
Dichiarazione
della
Costituzione dello Stato di Israele include queste parole:
Noi tendiamo la nostra mano a tutti gli stati vicini e ai loro popoli in
una offerta di pace e buon vicinato, e facciamo loro appello affinché
stabiliscano legami di cooperazione e aiuto reciproco con il popolo
ebraico sovranamente insediato sulla propria terra per il bene
comune di tutti.
Tragicamente,
questa
offerta,
come
molte
altre
precedentemente fatte da leader ebrei nei mesi precedenti la
creazione dello stato, fu ignorata.
Il 15 maggio 1948 gli eserciti di Egitto, Iraq,
Giordania, Libano e Siria attaccarono il nascente
stato ebraico, allo scopo di distruggerlo.
Nel corso di questa guerra, dichiarata dalle nazioni arabe, le
popolazioni civili soffrirono, come accade in tutte le guerre. È
tuttora oggetto di controversie quanti arabi locali lasciarono
Israele perché i leader arabi glielo ordinarono fino a minacciarli
in caso di un loro rifiuto, quanti partirono per timore dei
combattimenti, e quanti furono costretti a partire dalle forze
israeliane. Ciò che rileva è che centinaia di migliaia di arabi
rimasero in Israele e divennero cittadini di questo stato.
Ma il punto centrale non va perso di vista, ovvero i paesi
arabi scatenarono questa guerra allo scopo di annientare i
650.000 ebrei del nuovo Stato di Israele, e così facendo queste
nazioni hanno sfidato il piano delle Nazioni Unite mirato a creare
i due stati: quello ebraico e quello arabo.
Il
conflitto
arabo-israeliano
ha
creato
due
popolazioni di rifugiati, non una sola.
Mentre l’attenzione del mondo è stata focalizzata sui
profughi palestinesi, il problema delle centinaia di migliaia di
ebrei costretti a lasciare i paesi arabi, divenendo rifugiati a loro
volta, è stato largamente ignorato. Molti esperti, infatti,
sostengono che l’entità delle due popolazioni interessate è molto
simile. Ma c’è stata una profonda differenza: Israele ha assorbito
immediatamente gli ebrei rifugiati, mentre i profughi palestinesi
sono stati confinati in campi e deliberatamente tenuti qui
generazione dopo generazione a causa di un calcolo politico degli
arabi e con la complicità dell’ONU.
Non esiste oggi al mondo alcun esempio comparabile
di una popolazione rifugiata trattata in maniera così
cinica.
Finora, tra tutti i paesi arabi, solo la Giordania ha esteso la
cittadinanza ai profughi palestinesi. Gli altri ventuno stati arabi,
che si estendono su vasti territori e condividono la lingua, la
religione e le radici etniche dei palestinesi, hanno rifiutato di
farlo.
Perché? Tristemente, essi sembrano aver ben poco interesse
ad alleviare le sofferenze dei rifugiati che continuano a vivere in
campi profughi spesso davvero squallidi. Piuttosto, essi vogliono
nutrire l’odio nei confronti di Israele, e così usano i rifugiati
come un’arma chiave nella loro incessante guerra contro Israele.
Tra l’altro – solo per dare una percezione di come i
palestinesi sono trattati nel mondo arabo – il Kuwait espulse
sommariamente oltre 300.000 palestinesi che lavoravano da anni
nel paese (ma a cui non venne mai dato il passaporto kuwaitiano)
quando Yasser Arafat sostenne l’invasione di Saddam Hussein
che scatenò la Guerra del Golfo 1990-91. I palestinesi furono
tutti visti come una potenziale quinta colonna. Si elevò a stento
qualche lieve protesta da parte degli altri paesi arabi per quella
che fu l’espulsione di una intera comunità di palestinesi. E potrà
sembrare difficile a credersi, ma il Libano, che per decenni è
stato casa di diverse centinaia di migliaia di palestinesi, ha
impedito loro con apposite leggi di operare in numerosi settori
professionali.
La storia dei rifugiati ebrei provenienti dai paesi
arabi per sfortuna non è stata raccontata a dovere.
Quando è sorta la questione dei rifugiati ebrei, i portavoce
arabi hanno spesso finto di ignorarla, oppure hanno strenuamente
sostenuto che gli ebrei vivevano bene sotto il dominio islamico,
contrariamente a quanto accadeva nell’Europa cristiana. In
qualche circostanza hanno argomentato, con falsa ingenuità, che
gli arabi, per definizione, non possono essere antisemiti perché,
come gli ebrei, sono semiti.
È vero che non vi è mai stato l’equivalente dell’Olocausto
nell’esperienza ebraica in terra islamica, ed è anche vero che vi
sono stati periodi di cooperazione ed armonia, ma occorre
raccontare tutta la storia. Gli ebrei non hanno mai goduto di
uguali diritti dei mussulmani in paesi sotto dominio islamico; ci
sono sempre state precise norme di comportamento per gli ebrei
(come per i cristiani) da cittadini di seconda classe. Le violenze
contro gli ebrei non erano sconosciute nel mondo islamico.
Per citare solo un esempio del destino degli ebrei nei paesi
arabi, gli ebrei vissero ininterrottamente in Libia sin dai tempi dei
Fenici, ovvero da molto tempo prima che gli arabi arrivassero
dalla penisola arabica, portando l’Islam nel nord Africa e
insediandosi – occupando? – terre già abitate tra l’altro dalle
popolazioni indigene dei Berberi.
La gran parte dei 40.000 ebrei libici dovette partire tra il
1948 e il 1951, in seguito ai pogroms verificatisi il 1945 e il
1948. Nel 1951 la Libia divenne un paese indipendente.
Nonostante le garanzie costituzionali, agli ebrei rimasti nel paese
fu negato il diritto di voto, di ricoprire uffici pubblici, di ottenere
un passaporto libico, di supervisionare i loro affari comunitari o
acquistare nuove proprietà. Dopo il terzo pogrom del 1967, ai
residui 4.000 ebrei libici fu concesso di partire con solo una
valigia e l’equivalente di 50 dollari. Nel 1970 il governo libico
promulgò una serie di leggi relative alla confisca dei beni degli
ebrei esiliati e emanò delle obbligazioni a risarcimento, pagabili
entro quindici anni. Ma il 1985 giunse e trascorse, e non fu
pagato alcun risarcimento. Il governo fece invece distruggere i
cimiteri ebraici, usando le pietre tombali per pavimentare nuove
strade, in base ad una calcolata strategia mirata a cancellare le
vestigia della storica presenza ebraica nel paese.
Si stima una presenza di circa 750.000 ebrei nei paesi arabi
nel 1948, l’anno della fondazione di Israele; oggi ne sono rimasti
appena 6.000, la gran parte dei quali residente in Marocco e
Tunisia.
Dov’era la simpatia araba per il popolo palestinese
tra il 1948 e il 1967?
Con gli accordi inerenti l’armistizio che pose fine alla
Guerra d’Indipendenza di Israele, la Striscia di Gaza passò nelle
mani
dell’Egitto.
Piuttosto
che
conferire
sovranità
alle
popolazioni arabe locali e ai palestinesi che vi si erano rifugiati,
le autorità egiziane imposero un regime militare. Nel frattempo,
la West Bank e Gerusalemme Est furono governate dalla
Giordania. Anche in questo caso nulla fu fatto al fine della
creazione di uno stato indipendente palestinese; al contrario, la
Giordania si annetté il territorio con un’azione riconosciuta solo
da due nazioni nel mondo, ovvero Gran Bretagna e Pakistan.
Fu durante questo periodo, e precisamente nel 1964, che fu
fondata l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina
(OLP). Il suo scopo non era la creazione di uno stato sulle terre
sotto l’autorità egiziana e giordana, ma piuttosto l’eliminazione
di Israele e la fondazione di uno stato arabo palestinese
sull’intera area.
L’articolo 15 della Carta dell’OLP definisce chiaramente il
suo scopo:
La liberazione della Palestina, dal punto di vista arabo, è un dovere
nazionale per respingere il Sionismo, l’invasione imperialista della
grande madrepatria araba e per purgare la presenza Sionista dalla
Palestina.
Negli anni seguenti, il terrorismo targato OLP raggiunse
l’apice della sua mortale violenza, focalizzata su obiettivi
israeliani, americani, europei ed ebraici. Furono bersaglio dei
terroristi: scolari, atleti olimpionici, diplomatici, passeggeri di
aeroplani, e persino un turista in crociera costretto su una sedia a
rotelle.
Come giunse Israele in possesso di West Bank,
Golan, Striscia di Gaza, Penisola del Sinai e di
Gerusalemme Est, inclusa la Città Vecchia?
Tutt’oggi molte persone si riferiscono istintivamente ai
“territori occupati” senza neppure chiedersi come queste aree
siano pervenute nelle mani di Israele nel 1967.
Anche in questo caso c’è nel mondo arabo chi tenta di
riscrivere la storia e imputa ad Israele un preteso espansionismo,
ma i fatti sono chiari. Ecco una rapida cronologia dei principali
eventi che portarono alla Guerra dei Sei Giorni:
Il 16 maggio 1967 Radio Cairo annunciò: «L’esistenza di
Israele è durata troppo a lungo. È giunta l’ora della battaglia in
cui noi distruggeremo Israele». Lo stesso giorno l’Egitto chiese il
ritiro delle truppe dell’ONU di stanza in Gaza e Sharm el-Sheikh
fin dal 1957. Tre giorni dopo l’ONU, a sua eterna vergogna,
annunciò che avrebbe esaudito la richiesta egiziana.
Il 19 maggio Radio Cairo affermò: «Questa è la nostra
occasione, arabi, per infliggere a Israele un colpo mortale di
annientamento...»
Il 23 maggio il Presidente egiziano Gamal Abdel Nasser
dichiarò la sua intenzione di bloccare lo stretto di Tiro alle navi
israeliane, per colpire i commerci vitali di Israele verso l’Asia e
l’Africa dell’Est. Israele replicò che, per le leggi internazionali,
ciò costituiva un casus belli, un atto di guerra.
Il 27 maggio Nasser disse: «il nostro obiettivo principale è la
distruzione di Israele».
Il 30 maggio il re di Giordania Hussein collocò le forze
giordane sotto il controllo egiziano. Truppe egiziane, irachene e
saudite furono inviate in Giordania.
Il 1 giugno il leader iracheno espresse il suo pensiero: «Noi
siamo risoluti, determinati e uniti per raggiungere il nostro chiaro
scopo di cancellare Israele dalla mappa».
Il 3 giugno Radio Cairo salutò l’imminente guerra santa
islamica.
Il 5 giugno Israele, circondato da forze arabe notevolmente
più numerose e pesantemente armate, pronte ad attaccare in
qualsiasi momento, lanciò un attacco preventivo.
In sei giorni Israele sconfisse i suoi nemici e conquistò
nuove terre lungo i fronti egiziano, giordano e siriano.
Israele fece strenui – e documentati – sforzi, attraverso i
canali dell’ONU, al fine di persuadere re Hussein a restare fuori
dalla guerra. Diversamente da Egitto e Siria, la cui ostilità verso
Israele era irremovibile, la Giordania aveva tranquillamente
cooperato con Israele, di cui condivideva la preoccupazione per
l’ostilità dei disegni palestinesi. Anni dopo, re Hussein riconobbe
pubblicamente che la sua decisione di entrare nella guerra del
1967, in seguito alla quale perse il controllo della West Bank e di
Gerusalemme Est, fu uno dei più grossi errori da lui commessi.
Un’altra occasione di pace perduta.
Poco dopo la Guerra dei Sei Giorni, Israele manifestò il suo
desiderio di dare terra in cambio di pace con i suoi vicini arabi.
Mentre Israele non era preparato a cedere la parte Est di
Gerusalemme – che conteneva i luoghi più sacri di Israele e che,
in lampante violazione dei termini dell’accordo di armistizio
israelo-giordano, erano stati interamente off limits per Israele per
quasi diciannove anni (mentre la Giordania dissacrava 58
sinagoghe nel Quartiere Ebraico della Città Vecchia e il mondo
rimaneva in silenzio) – era però pronto a cedere i territori
conquistati nel quadro di un accordo generale. Ma l’apertura di
Israele fu rifiutata seccamente. Una inequivocabile risposta
giunse da Karthoum, la capitale del Sudan, dove i leader arabi
riuniti in conferenza annunciarono la loro risoluzione il 1
settembre 1967, contenente tre no: «No alla pace, no al
riconoscimento e no al negoziato con Israele».
Nel novembre del 1967 il Consiglio di Sicurezza
dell’ONU adottò la risoluzione n. 242
Questa risoluzione, spesso citata nelle discussioni inerenti il
conflitto arabo-israeliano come base per la sua soluzione, non
viene sempre riportata con precisione. La risoluzione sottolinea
«l’inammissibilità dell’acquisizione di territorio mediante la
guerra e il bisogno di lavorare per una giusta e durevole pace in
cui ciascuno [il corsivo è nostro, n.d.r.] Stato dell’area possa
vivere in sicurezza».
Più avanti essa chiede il «ritiro delle forze armate israeliane
da territori occupati nel recente conflitto», ma deliberatamente
omette l’uso dell’articolo “i” prima della parola “territori”.
L’allora ambasciatore degli Stati Uniti presso l’ONU, Arthur
Goldberg, notò che questa fu una omissione intenzionale,
affinché la sistemazione finale potesse permettere, sulla base di
non specificati confini, quegli aggiustamenti necessari alla
sicurezza di Israele. Ad esempio, prima della Guerra dei Sei
Giorni del 1969, il punto più stretto dello Stato di Israele –
appena a nord di Tel Aviv, la sua città più grande – si estendeva
per appena nove miglia.
La risoluzione includeva anche un appello a porre termine
«ad ogni richiesta e stato di belligeranza e al rispetto e al
riconoscimento della sovranità, dell’integrità territoriale e
dell’indipendenza politica di ogni Stato nell’area e al loro diritto
di vivere in pace dentro confini sicuri e riconosciuti, liberi da
minacce o atti di forza».
E, non ultimo, essa «afferma inoltre la necessità (a) di
garantire la libertà di navigazione lungo le rotte internazionali
dell’area; (b) di dare una giusta soluzione al problema dei
profughi [Notare come l’assenza di specificità dell’espressione
“problema dei profughi”, permette più di una interpretazione su
quante siano le popolazioni rifugiate. N.d.r.]; e (c) garantire
l’inviolabilità e l’indipendenza politica di ogni Stato nell’area,
attraverso
misure
comprendenti
la
creazione
di
zone
demilitarizzate».
Il 22 ottobre 1973 – durante una nuova guerra dichiarata
dagli arabi, che divenne nota come Guerra di Yom Kippur poiché
ebbe inizio nel corso del giorno più sacro all’ebraismo – il
Consiglio di Sicurezza dell’ONU adottò la Risoluzione n. 338.
La misura chiedeva il cessate il fuoco, l’applicazione della
Risoluzione n. 242 nella sua interezza, e l’avvio di un dialogo tra
le parti coinvolte. Le Risoluzioni nn. 242 e 338 sono
normalmente citate insieme riguardo qualsiasi colloquio di pace
arabo-israeliano.
Gli
insediamenti
diventano
argomento
di
contestazione
Ciò è fuor di dubbio, però anche questo aspetto, come
qualunque altro del conflitto arabo-israeliano, ha alle spalle
molto di più.
Dopo la vittoria di Israele nella guerra del 1967, e una volta
divenuto chiaro che i paesi arabi non erano interessati a
negoziare la pace, Israele, guidato da una coalizione laburista,
comincia a incoraggiare la costruzione di insediamenti, o nuove
comunità, sulle terre conquistate. Questa pratica fu accelerata
durante il governo guidato dal Likud, dopo il 1977.
Qualsiasi opinione si possa avere sugli insediamenti, è
importante comprendere i motivi che hanno spinto Israele a
perseguire questa politica:
(a) Israele sostiene che la terra era oggetto di disputa – sia
gli arabi che gli ebrei la reclamavano – e poiché non esisteva
alcuna autorità sovrana, gli israeliani avevano lo stesso diritto ad
insediarvisi dei palestinesi (i quali non avevano mai avuto un
proprio stato su questi territori);
(b) sono esistite comunità ebraiche nella West Bank molto
prima del 1948, ad esempio in Hebron e in Gush Etzion, dove
nell’arco del 1900 gli arabi hanno compiuto numerosi massacri,
uccidendo un gran numero di ebrei;
(c) la West Bank, secondo la Bibbia ebraica rappresenta la
culla della civiltà ebraica, e alcuni ebrei, guidati dalla fede e dalla
storia, erano ansiosi di riallacciare tali legami;
(d) il governo israeliano riteneva che alcuni insediamenti
potevano essere utili ai fini della sicurezza, data la loro
importanza geografica e soprattutto topografica in quest’area
piuttosto ristretta;
(e) molti ufficiali israeliani ritenevano che la costruzione
degli insediamenti, determinando uno stato di fatto, avrebbe
potuto avvicinare il giorno in cui i palestinesi, comprendendo che
il tempo non era necessariamente dalla loro parte, avrebbero
parlato di pace.
Allo stesso tempo, i sondaggi hanno frequentemente rilevato
che la maggioranza degli israeliani concorda sul fatto che
qualsiasi accordo di pace con i palestinesi comporterà
necessariamente lo smantellamento di molti degli insediamenti,
sebbene non tutti. Quegli insediamenti che oggi sono
sostanzialmente delle città e che sono più vicine a Gerusalemme
e altre aree adiacenti ai confini del 1967, saranno verosimilmente
tenuti da Israele in qualsiasi accordo di pace.
È importante sapere che la linea del 1967 non è mai stata un
vero e proprio confine riconosciuto internazionalmente, ma
piuttosto una linea di armistizio che marcava le posizioni sul
campo alla fine della Guerra di Indipendenza di Israele del 1949.
Gli Stati Uniti hanno di recente riconosciuto questo fatto di
importanza critica quando il Presidente George W. Bush scrisse
al Primo Ministro Ariel Sharon, il 14 aprile del 2004, che «è
irrealistico aspettarsi che lo status finale derivante dai negoziati
sarà il pieno e completo ritorno alle linee dell’armistizio del
1949».
Le possibilità di pace
Nel 1977 per la prima volta un esponente del Likud,
Menachem Begin, divenne primo ministro. Fatto che non impedì
al presidente egiziano Anwar Sadat di compiere quello stesso
anno il suo storico viaggio in Israele e di tenere un discorso alla
Knesset, il parlamento israeliano. Si realizzò uno straordinario
percorso di pace, tra gli alti e bassi inevitabili in una così difficile
negoziazione.
Nel settembre 1978 furono formulati gli Accordi di Camp
David, i quali fornivano una solida struttura per una pace
complessiva, compresa una proposta relativa ad un autogoverno
limitato per i palestinesi (proposta che fu rifiutata dai
palestinesi). Sei mesi più tardi fu firmato l’accordo di pace che
pose termine a trentuno anni di stato di guerra tra Israele ed
Egitto.
Fu un notevole momento della storia. Sadat (che per gran
parte della sua vita aveva manifestato la sua virulenza antisemita
e anti-israeliana, oltre ad essere stato l’ispiratore dell’attacco a
sorpresa egiziano – condotto insieme alla Siria – contro Israele,
che diede luogo alla Guerra di Yom Kippur del 1973) si accordò
con Begin, il capo di una coalizione israeliana di destra, per
aprire un nuovo capitolo delle relazioni arabo-israeliane. Era la
prova che con la volontà, il coraggio e la lungimiranza tutto era
possibile.
Ma tutti gli altri paesi arabi, ad eccezione del Sudan (guidato
allora da una leadership molto più moderata di quella attuale) e
dell’Oman, interruppero le relazioni diplomatiche con l’Egitto in
segno di protesta contro la pace. Finché nel 1981 il leader
egiziano fu assassinato da membri della Jihad islamica egiziana,
che più tardi sarebbero diventati “fratelli in arme” di Osama bin
Laden e della sua rete terroristica Al-Qaeda.
Da parte sua, Israele restituì all’Egitto la vasta distesa del
Sinai (approssimativamente 23.000 miglia quadrate, più del
doppio dell’intera superficie di Israele), la quale avrebbe fornito
una zona cuscinetto tra Egitto e Israele di fondamentale
importanza strategica. Israele restituì anche i notevoli campi
petroliferi che aveva scoperto nel Sinai, un grande sacrificio per
un paese privo in pratica di risorse naturali. Israele chiuse
importanti basi che aveva costruito per la sua aviazione e,
nonostante il forte sostegno di Begin agli insediamenti, smantellò
queste enclavi nel Sinai.
Così facendo, Israele dimostrò la sua inestinguibile sete di
pace, la sua volontà di correre rischi concreti e di compiere serie
rinunce, e la sua scrupolosa determinazione nel rispettare i
termini degli accordi. Nella storia moderna, quale altro paese
dopo aver vinto una guerra per la propria stretta sopravvivenza,
avrebbe rinunciato alla terra conquistata e ad altri fondamentali
assetti strategici per raggiungere la pace?
Israele e la Giordania strinsero uno storico accordo
di pace nel 1994.
Questi furono negoziati molto più semplici rispetto a quelli
con l’Egitto, poiché Israele e Giordania godevano già di buoni,
seppur taciti, legami basati sulla sovrapposizione del reciproco
interesse nazionale a fronteggiare i palestinesi. (I giordani
temevano le ambizioni territoriali dei palestinesi allo stesso modo
degli israeliani.)
Israele dimostrò ancora una volta la sua profonda
aspirazione alla pace e la sua disponibilità a compiere i passi
necessari a raggiungerla, compreso l’aggiustamento dei confini e
la condivisione delle risorse idriche reclamata da Amman.
Il 26 ottobre 1994, il primo ministro israeliano Yitzhak
Rabin e re Hussein di Giordania firmarono un formale trattato di
pace a Wadi Araba sul confine israelo-giordano. Rabin lo definì
«la pace dei soldati e la pace degli amici».
Spinti dagli esempi dell’Egitto prima e della Giordania poi,
altri paesi arabi cominciarono ad instaurare relazioni con Israele.
Il più disponibile tra questi fu la Mauritania, che divenne il terzo
stato arabo a stabilire relazioni diplomatiche formali con Israele.
Altri ancora, come Marocco, Oman, Qatar e Tunisia, pur non
offrendo pieno riconoscimento, avviarono aperte relazioni
politiche ed economiche. E anche altri paesi arabi hanno
sviluppato punti di contatto con Israele che hanno portato ad una
varietà di risultati, pur scegliendo i canali della non ufficialità
finché, sostengono, non sarà raggiunto un più generale e
complessivo accordo di pace tra Israele e i suoi vicini.
Ancora
un’opportunità
di
pace
rifiutata
dai
palestinesi nel 2000-2001.
Quando Ehud Barak divenne primo ministro nel 1999,
annunciò un’ambiziosa agenda. Il leader del centrosinistra
israeliano affermò che avrebbe tentato di arrivare alla storica fine
del conflitto con i palestinesi nell’arco di tredici mesi, ripartendo
da dove erano giunti i suoi predecessori, sulla base di quanto
stabilito dalla Conferenza di Madrid del 1991, i primi colloqui di
pace dopo gli accordi di Camp David, e dagli Accordi di Oslo del
1993, i quali produssero una Dichiarazione di Principi congiunta
tra Israele e i palestinesi. Così formulata, l’agenda di Barak
andava oltre ciò che in Israele chiunque avrebbe pensato
possibile
concedere
nella
volontà
di
raggiungere
un
compromesso nell’interesse della pace.
Con il sostegno attivo dell’amministrazione Clinton, Barak
spinse il processo di pace più lontano e più veloce che poteva e,
per raggiungere l’accordo, egli fece nuove e importanti
concessioni anche su una questione infinitamente sensibile come
quella di Gerusalemme. Ma ugualmente, Barak e Clinton
fallirono. Arafat non era pronto ad avviare il processo di pace e di
farlo funzionare.
Piuttosto che spingere avanti quei colloqui che avrebbero
portato alla creazione del primo stato palestinese, con la sua
capitale in Gerusalemme Est, Arafat andò via dopo aver
assurdamente provato a convincere il presidente Clinton che non
vi erano legami storici tra Gerusalemme e gli ebrei, ed aver
lanciato la richiesta-bomba del riconoscimento di un cosiddetto
“diritto al ritorno” dei rifugiati palestinesi e di generazioni di loro
discendenti. Arafat sapeva sicuramente che ciò rappresentava la
rottura immediata delle trattative, poiché nessun governo
israeliano avrebbe mai potuto concedere a milioni di palestinesi
di insediarsi in Israele e, in tal modo, cancellare completamente il
carattere ebraico dello stato.
Tragicamente, Arafat rivelò la sua incapacità, la sua
mancanza di volontà, o entrambe, a raggiungere la
pace al tavolo dei negoziati. Egli preferì invece
tornare ad un modello a lui più familiare: parlare di
pace all’occasione, e allo stesso tempo incoraggiare
in maniera sistematica il terrorismo.
Arafat comprese che l’immagine mediatica di un Israele
pesantemente armato che affronta in strada i palestinesi, inclusi
quei bambini da questi cinicamente spediti in prima fila, avrebbe
lavorato a suo vantaggio. Israele sarebbe stato spinto nel ruolo
dell’aggressore e dell’oppressore, i palestinesi in quello delle
vittime calpestate.
Non sarebbe passato molto tempo, secondo i suoi calcoli,
prima che il mondo arabo denunciasse rabbiosamente Israele, che
i paesi non allineati rispondessero con lo stesso seme, che gli
europei richiedessero ulteriori urgenti concessioni da Israele per
placare i palestinesi, che i gruppi internazionali per i diritti umani
accusassero Israele di usare una forza eccessiva, e che il mondo,
afflitto come sempre dalla memoria corta, dimenticasse che il
leader palestinese aveva appena rifiutato un’occasione senza
precedenti per stringere un accordo di pace.
Arafat non si sbagliava del tutto. Molti media, molti governi
europei e la maggioranza delle organizzazioni umanitarie
interpretarono il ruolo che lui aveva ritagliato per loro. Fu solo
dopo la sua morte, avvenuta nel 2004, che alcuni tra questi (e
solo alcuni) finalmente compresero quanto e in che modo erano
stati ingannati dall’astuto e corrotto leader di cui essi avevano
inesplicabilmente scelto di fidarsi, e persino di rendere
romantico.
È probabile inoltre che i calcoli di Arafat confidassero
nell’adozione di una linea più dura nei confronti di Israele sia da
parte di Washington, come conseguenza delle pressioni di Egitto
e Arabia Saudita, due paesi arabi di grande peso nella visione del
mondo dei politici americani, sia da parte dell’Unione Europea. E
c’era la possibilità, a lungo andare, che Israele, un paese giovane,
cominciasse a stancarsi della lotta e del pedaggio quotidiano di
vittime civili e militari, dell’impatto negativo sul morale e sulla
psiche della nazione – per non parlare della sua economia – e del
potenziale crescente isolamento internazionale.
Ma Arafat sbagliò grossolanamente i suoi calcoli. Israele
non si stancò: resse la corsa. E gli Stati Uniti, vicini ad Israele,
riconoscendo e smascherando Arafat per quello che era,
rifiutarono di avere ulteriori colloqui con lui.
Cosa ci si aspetta esattamente che Israele faccia per
garantire la sicurezza dei suoi cittadini? Cosa
farebbero gli altri stati in una situazione simile?
Forse i recenti attentati in Gran Bretagna, Egitto, Indonesia,
Marocco, Russia, Spagna, Tunisia, Turchia, Stati Uniti e così via,
hanno aiutato il mondo a comprendere la vera natura della
minaccia terroristica che Israele ha dovuto affrontare e la base
razionale dell’inflessibile risposta israeliana.
Inflessibile, sì, ma anche misurata. La verità è che Israele,
data la sua forza militare, avrebbe potuto infliggere un colpo
molto più devastante ai palestinesi, ma ha scelto di non farlo per
molteplici
umanitarie.
ragioni
diplomatiche,
politiche,
strategiche
e
Jenin è un esempio perfetto. Sebbene i portavoce palestinesi
si affrettarono a condannare l’operazione militare israeliana del
2002 in questa città della West Bank, definendola come un
“massacro”, in realtà Israele scelse il metodo molto più rischioso
di entrare in città in cerca dei covi dei terroristi proprio allo
scopo di evitare vittime civili tra i palestinesi. Come risultato,
Israele subì la perdita di ventitre giovani soldati e dall’altra parte
morirono una cinquantina di palestinesi armati. L’alternativa di
Israele poteva essere quella di attaccare Jenin via aria, allo stesso
modo in cui gli aerei da combattimento della NATO
bombardarono Belgrado nel 1990, ma ciò avrebbe causato delle
uccisioni indiscriminate, cosa che Israele tenta disperatamente di
evitare.
È interessante che molti tra coloro che in Occidente criticano
Israele per la sua tattica nel trattare il terrorismo, stanno ora
adottando quegli stessi metodi, compreso il rafforzamento
dell’intelligence, la sorveglianza, l’infiltrazione e la prevenzione.
A giudicare dall’analisi delle pubblicazioni antiterrorismo
diffusesi
globalmente,
non
sembra
che
“contenimento”,
“dialogo”, “compromesso” e “comprensione” facciano parte del
vocabolario corrente adoperato nei confronti di chi ci attacca; né
dovrebbero esserlo, ma queste erano alcune delle molte parole
offerte non tanto tempo fa come consiglio a Israele dalla
comunità internazionale per trattare la minaccia terroristica.
In ultima analisi, sebbene Israele goda di una superiorità
militare, Gerusalemme comprende che questo non è un conflitto
che può essere vinto esclusivamente sul campo di battaglia. Più
semplicemente, nessuna delle due parti si appresta a sparire.
Questo conflitto può essere risolto solo al tavolo della pace, se e
quando i palestinesi comprenderanno alla fine che hanno
dissipato oltre mezzo secolo di storia e numerose opportunità per
costruire uno stato accanto ad Israele, non al suo posto.
L’aspetto forse più controverso della politica
israeliana è la barriera difensiva – o di sicurezza –
attualmente in costruzione, definita falsamente dai
suoi oppositori “muro”.
Sono tre le cose che, in particolare, dovrebbero essere
ricordate.
Primo,
la
barriera
ha
dimostrato
di
ridurre
drasticamente la capacità dei terroristi palestinesi di entrare nei
centri abitati israeliani e causarvi devastazioni e stragi. Secondo,
la barriera fu costruita in conseguenza di una reiterata attività
terroristica: sono stati rilevati oltre 25.000 tentati attacchi contro
Israele da parte di gruppi o di singoli palestinesi solo negli ultimi
cinque anni. Terzo, la barriera può essere spostata in qualsiasi
direzione, o anche smantellata, ma le vite delle vittime innocenti
del terrore non potranno mai più essere restituite.
Gaza è un test delle reali intenzioni palestinesi
Il disimpegno di Israele da Gaza, frutto della mente del
primo ministro Sharon, non soltanto fornisce un potenziale nuovo
punto di partenza del processo di pace, ma dà anche ai
palestinesi, sotto la leadership del presidente dell’Autorità
Palestinese Mahmoud Abbas, una storica opportunità per darsi un
autogoverno. Cominceranno i palestinesi a costruire una società
civile e pacifica priva dell’endemica corruzione, violenza e
anarchia così diffuse in passato o Gaza finirà per diventare una
zona franca per i terroristi e i loro amici? Aspireranno a costruire
uno stato modello che possa vivere pacificamente accanto ad
Israele oppure useranno Gaza come una nuova piattaforma per
lanciare missili e organizzare attacchi terroristici contro i vicini
israeliani?
Un test chiave per la leadership del presidente Abbas è la
sfida posta dai gruppi terroristici operanti all’interno della società
palestinese. La nuova leadership palestinese ha condannato a
volte gli attacchi portati da questi gruppi, ma solo raramente li ha
affrontati in maniera diretta, e non ha mai tentato di disarmarli.
Senza agire su questo fronte, le possibilità di andare avanti con
successo
lungo
il
cammino
della
pace
diminuiscono
drammaticamente. Inoltre, l’Autorità Palestinese non potrà mai
stabilire la sua autorità se gruppi armati si permettono il lusso di
operare sia come fazioni politiche sia come milizie armate.
In particolare, Hamas e Jihad islamica, due gruppi radicali
sulla lista delle organizzazioni terroristiche stilata da Stati Uniti
ed Unione Europea, hanno operato con relativa impunità nelle
aree sotto il controllo palestinese. Lo stesso vale per Hezbollah.
Ciascuno di questi tre gruppi ha legami operativi e finanziari con
l’Iran e la Siria.
Vi è un altro punto importante. Se, dopo gli Accordi di Oslo
del 1993, l’Autorità Palestinese avesse iniziato a introdurre i
valori della tolleranza e della coesistenza negli studi scolastici,
forse la generazione di giovani attentatori suicidi a cui abbiamo
assistito in anni recenti avrebbe potuto agire diversamente.
Invece costoro sono stati nutriti con una ferrea dieta a base di
incitamento, odio, diffamazione e demonizzazione degli ebrei,
dell’ebraismo, di Israele e del Sionismo. Sono stati spinti a
credere che non può esserci più alta chiamata per gli arabi e per i
mussulmani
di
quel
cosiddetto
“martirio”
finalizzato
all’uccisione del maggior numero possibile di quegli odiati ebrei
“figli di scimmie e maiali”, come sono regolarmente definiti da
alcuni portavoce.
E questi insegnamenti sono stati rinforzati dalla grancassa
dell’odio suonata nelle moschee duranti i sermoni del venerdì,
dalla popolarità di libri notoriamente antisemiti come il Mein
Kampf e i Protocolli dei Savi di Sion, e dall’impiego dei media
palestinesi come megafoni per l’incitamento all’odio. Quando le
scuole, i media e le moschee palestinesi fermeranno questa
inondazione
di
antisemitismo
e
antisionismo,
allora
aumenteranno le possibilità di gettare le basi di una vera pace.
Nonostante le dichiarazioni della propaganda palestinese,
non esiste nulla di comparabile da parte israeliana. Quando
solitarie voci israeliane adottano un linguaggio estremista (o
azioni) la società israeliana le condanna velocemente, non le
idolatra.
Israele è una democrazia che pensa e si comporta
come una democrazia
Non è sempre facile però essere democratici e gestire le
difficili situazioni che Israele si trova ad affrontare. Ma mentre
Israele riceve la sua quota di critiche per i suoi presunti metodi
pesanti, i palestinesi, a dispetto della loro stridente retorica,
comprendono meglio di chiunque altro che sono proprio i valori
democratici e il ruolo delle leggi di Israele a costituire il
probabile tallone di Achille della nazione. I palestinesi sanno,
anche se non lo ammettono pubblicamente, che il sistema
democratico pone ostacoli e limiti alle opzioni politiche di
Israele.
Essi sanno che Israele è basato su un sistema politico
multipartitico e che questi partiti necessitano di differenziarsi
l’uno dall’altro per avere una possibilità di successo elettorale.
Infatti, i partiti includono qualsiasi punto di vista, dall’estrema
sinistra all’estrema destra, dai laici ai religiosi, dagli ebrei russi
agli arabi. Al riguardo, gli arabi israeliani attualmente detengono
circa il dieci percento dei seggi alla Knesset e alcuni di questi
parlamentari si sono apertamente schierati in questo conflitto con
i nemici di Israele.
Essi sanno che l’opinione pubblica in Israele ha la sua
importanza e i suoi effetti politici.
Essi sanno che Israele gode di una stampa libera e
indagatrice.
Essi
sanno
che
Israele
possiede
una
magistratura
indipendente che occupa un posto di rispetto nella vita della
nazione, e che non ha esitato ad annullare le decisioni del
governo, anche militari, quando sono sembrate incoerenti con lo
spirito o la lettera delle leggi israeliane.
Essi sanno che Israele ha una prospera società civile e
numerosi gruppi per i diritti umani che operano in maniera
obiettiva e imparziale.
Essi sanno che Israele protegge la libertà di culto di tutte le
comunità religiose, fino al punto di impedire agli ebrei di pregare
al Monte del Tempio, il luogo più sacro all’ebraismo, allo scopo
di evitare tensioni con i fedeli islamici delle due moschee
costruite su quel luogo molto più tardi. Infatti, a partire dalla
Guerra dei Sei Giorni del 1967, Israele ha ceduto l’autorità
sull’area al Waqf, l’autorità religiosa islamica. Possiamo fare il
confronto con quello che è successo ai luoghi santi ebraici una
volta in mani arabe?
Essi sanno che Israele, basato sui principi che stanno al
cuore delle tradizioni ebraiche, attribuisce grande importanza alle
norme etiche e morali di comportamento, anche quando, a volte,
non riesce ad essere all’altezza di esse.
E infine essi sanno che esistono restrizioni auto-imposte al
comportamento di Israele proprio perché Israele è uno stato
democratico, e perché, in ultima analisi, il suo governo è
espressione della volontà del popolo.
Se solo il Medio Oriente rassomigliasse all’Europa!
Chi non auspicherebbe una soluzione pacifica del conflitto e
l’instaurazione di una cooperazione regionale? Quando è stata
l’ultima volta che una nazione democratica ha lanciato un attacco
militare contro un’altra democrazia? Per sfortuna, la democrazia
è un lusso molto raro in Medio Oriente.
I palestinesi sanno che l’ultimo presidente siriano Hafez elAssad trattò con i fondamentalisti islamici uccidendone un
numero stimato tra 10.000 e 20.000 in Hama, e spianando la città
per dare un inequivocabile messaggio agli altri fondamentalisti
del paese.
Essi sanno come l’ex presidente Saddam Hussein gestì la
questione dei curdi usando gas venefici per ucciderne decine di
migliaia, e distruggendo centinaia di villaggi curdi.
Essi sanno come l’Arabia Saudita reagì al sostegno dato a
Saddam Hussein dallo Yemen durante la Guerra del Golfo del
1990-91. Nel giro di una notte il governo espulse dal paese
600.000 yemeniti.
Ed essi sanno come l’Egitto ha trattato i suoi radicali
islamici, al riparo dai radar dei media, senza fanfare. Migliaia di
questi estremisti sono stati uccisi o detenuti in prigione senza
neppure il dovuto processo.
I palestinesi contano sul fatto che Israele non seguirà alcuno
di questi esempi. Il che è la forza di Israele come democrazia,
anche se ciò comporta un prezzo. I palestinesi cercano di trarre
vantaggio da ciò. Ma essi hanno commesso un errore
fondamentale: hanno sottovalutato la volontà di Israele di
sopravvivere.
Gli israeliani vogliono la pace disperatamente.
Allo stesso tempo però, la pace a qualunque costo
non è pace.
Gli israeliani vogliono smettere di preoccuparsi delle bombe
sugli autobus e nei mercati. Essi vogliono mettere fine alle
sepolture dei loro figli, vittime del terrore o di scontri militari. In
breve, essi vogliono condurre vite normali, ed hanno dimostrato
più volte la loro disponibilità ad arrivare a lungimiranti, e persino
potenzialmente rischiosi, compromessi alla ricerca della pace.
Gli israeliani, comunque, hanno imparato la dolorosa lezione
della storia.
La pace senza confini sicuri e difendibili può significare il
suicidio nazionale. E chi può sapere meglio dei cittadini di
Israele, gran parte dei quali sopravvissuti all’Olocausto e rifugiati
dalle terre comuniste e dall’estremismo arabo, quanto pericoloso
può essere abbassare la guardia troppo rapidamente, troppo
facilmente?
Possono gli israeliani semplicemente ignorare gli appelli
dell’Iran all’annientamento di Israele e la sua domanda di
acquisizione di armi di distruzione di massa, l’ospitalità data
dalla Siria ai gruppi terroristici decisi a distruggere Israele, gli
arsenali di Hezbollah pieni di migliaia di missili a corto raggio
dislocati nel Libano meridionale e capaci di raggiungere la parte
settentrionale di Israele, e gli orripilanti appelli a compiere
attacchi suicidi contro Israele lanciati in Gaza e nella West Bank?
Il nostro mondo non è stato affatto gentile con gli ingenui, i
creduloni e gli illusi. A dispetto dei dubbiosi del tempo, Adolf
Hitler intendeva esattamente quello che diceva quando scrisse il
Mein Kampf, Saddam Hussein intendeva esattamente quello che
diceva quando insisteva che il Kuwait era una provincia
dell’Iraq, e Osama bin Laden intendeva esattamente quello che
diceva quando, nel 1998, faceva appello all’uccisione del
maggior numero possibile di americani.
Israele vive in un quartiere particolarmente rozzo. Per
sopravvivere, deve essere coraggioso sul campo di battaglia e al
tavolo della pace: esso ha superato entrambi i test con ottimi voti.
Israele è molto più che conflitto e soluzione del
conflitto.
Mentre il dibattito pubblico tende a focalizzarsi sulle
questioni legate a guerra, violenza e terrorismo nella regione,
esiste un altro lato di Israele che viene visto solo di rado, se si
escludono quei fortunati che hanno visitato Israele e che hanno
visto con i propri occhi.
Israele è un paese di inimmaginabili vibrazioni e dinamismo.
È un paese antico e all’avanguardia al tempo stesso. È un paese
di vincitori di premi Nobel in letteratura e chimica, di medaglie
olimpiche, di concertisti e di stelle del rap. Ci sono più scienziati
e ingegneri pro capite in Israele che in qualsiasi altra parte del
mondo. È ai vertici delle classifiche mondiali per numero di
giornali, di lettori e di libri pubblicati.
Il numero di società di start-up nell’high-tech e di brevetti
rilasciati è impressionante per un paese di appena sei milioni di
abitanti. Dei suoi progressi medici, delle rivoluzioni nei campi
della tecnologia e delle comunicazioni, così come delle
innovazioni in agricoltura, non ha beneficiato solo Israele, ma
anche miliardi di persone in tutto il mondo.
La prossima volta che entri in una chat room, che usi un
telefono cellulare, che gestisci un’immagine a colori o che ricevi
un messaggio vocale, che adoperi un microprocessore Pentium, o
che hai bisogno di una TAC o di una risonanza magnetica, o che
vedi prosperare una fattoria in un deserto grazie all’irrigazione
goccia a goccia, ci sono ottime probabilità che Israele ti stia
dando una buona mano.
Israele. Più lo conosci, più lo comprendi.
(Edizione revisionata e aggiornata)
The American Jewish Committee
The Jacob Blaustein Building
David A. Harris
165 East 56 Street
New York, NY 10022
L’American Jewish Committee opera nelle seguenti aree:
Odio razziale e antisemitismo – Pluralismo – Israele –
Ebraismo americano – Ebraismo internazionale – Diritti
umani
Agosto 2005-09-22
www.ajc.org
The American Jewish Committee