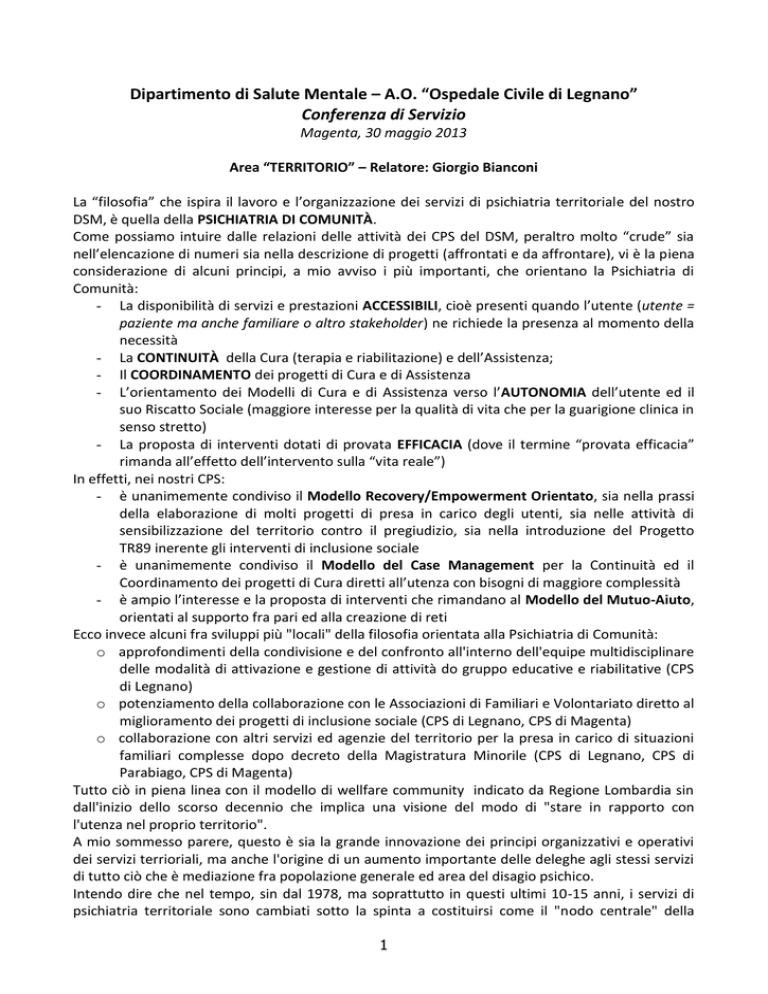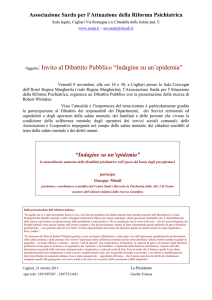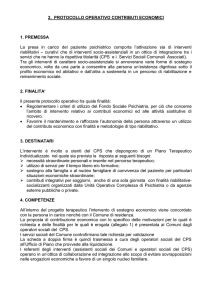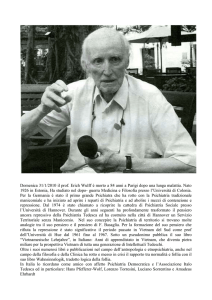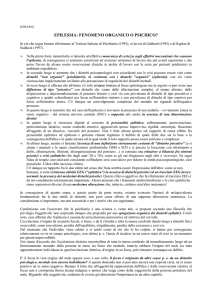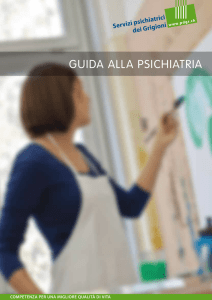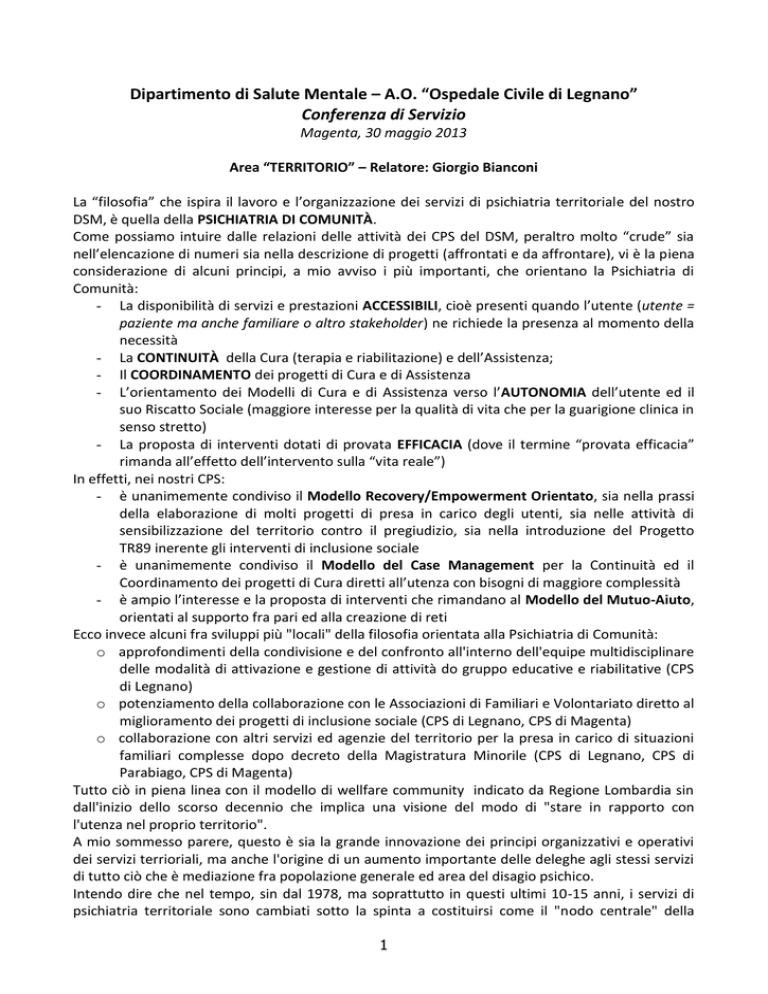
Dipartimento di Salute Mentale – A.O. “Ospedale Civile di Legnano”
Conferenza di Servizio
Magenta, 30 maggio 2013
Area “TERRITORIO” – Relatore: Giorgio Bianconi
La “filosofia” che ispira il lavoro e l’organizzazione dei servizi di psichiatria territoriale del nostro
DSM, è quella della PSICHIATRIA DI COMUNITÀ.
Come possiamo intuire dalle relazioni delle attività dei CPS del DSM, peraltro molto “crude” sia
nell’elencazione di numeri sia nella descrizione di progetti (affrontati e da affrontare), vi è la piena
considerazione di alcuni principi, a mio avviso i più importanti, che orientano la Psichiatria di
Comunità:
- La disponibilità di servizi e prestazioni ACCESSIBILI, cioè presenti quando l’utente (utente =
paziente ma anche familiare o altro stakeholder) ne richiede la presenza al momento della
necessità
- La CONTINUITÀ della Cura (terapia e riabilitazione) e dell’Assistenza;
- Il COORDINAMENTO dei progetti di Cura e di Assistenza
- L’orientamento dei Modelli di Cura e di Assistenza verso l’AUTONOMIA dell’utente ed il
suo Riscatto Sociale (maggiore interesse per la qualità di vita che per la guarigione clinica in
senso stretto)
- La proposta di interventi dotati di provata EFFICACIA (dove il termine “provata efficacia”
rimanda all’effetto dell’intervento sulla “vita reale”)
In effetti, nei nostri CPS:
- è unanimemente condiviso il Modello Recovery/Empowerment Orientato, sia nella prassi
della elaborazione di molti progetti di presa in carico degli utenti, sia nelle attività di
sensibilizzazione del territorio contro il pregiudizio, sia nella introduzione del Progetto
TR89 inerente gli interventi di inclusione sociale
- è unanimemente condiviso il Modello del Case Management per la Continuità ed il
Coordinamento dei progetti di Cura diretti all’utenza con bisogni di maggiore complessità
- è ampio l’interesse e la proposta di interventi che rimandano al Modello del Mutuo-Aiuto,
orientati al supporto fra pari ed alla creazione di reti
Ecco invece alcuni fra sviluppi più "locali" della filosofia orientata alla Psichiatria di Comunità:
o approfondimenti della condivisione e del confronto all'interno dell'equipe multidisciplinare
delle modalità di attivazione e gestione di attività do gruppo educative e riabilitative (CPS
di Legnano)
o potenziamento della collaborazione con le Associazioni di Familiari e Volontariato diretto al
miglioramento dei progetti di inclusione sociale (CPS di Legnano, CPS di Magenta)
o collaborazione con altri servizi ed agenzie del territorio per la presa in carico di situazioni
familiari complesse dopo decreto della Magistratura Minorile (CPS di Legnano, CPS di
Parabiago, CPS di Magenta)
Tutto ciò in piena linea con il modello di wellfare community indicato da Regione Lombardia sin
dall'inizio dello scorso decennio che implica una visione del modo di "stare in rapporto con
l'utenza nel proprio territorio".
A mio sommesso parere, questo è sia la grande innovazione dei principi organizzativi e operativi
dei servizi terrioriali, ma anche l'origine di un aumento importante delle deleghe agli stessi servizi
di tutto ciò che è mediazione fra popolazione generale ed area del disagio psichico.
Intendo dire che nel tempo, sin dal 1978, ma soprattutto in questi ultimi 10-15 anni, i servizi di
psichiatria territoriale sono cambiati sotto la spinta a costituirsi come il "nodo centrale" della
1
domanda inerente la salute mentale - organizzandosi sulla base di bisogni sempre più ampi e
diversificati - uscendo dalla canonica ed originaria connotazione di "servizi per la malattia
mentale" per diventire, per l'appunto, "servizi per la salute mentale". Si tratta di servizi che non
solo curano, ma tendono anche a dotarsi di strumenti per leggere bisogni, costruire consenso,
reperire risorse, gestire percorsi di cura/assistenza direttamente nel territorio.
Questa spinta ri-organizzativa ha trasformato (o meglio sta trasformando) i servizi di psichiatria
territoriale da strutture "forti" e "chiuse" a luoghi "aperti" al lavoro di rete, interconnessi con il
territorio, ove è possibile valorizzare anche legami "deboli" con agenzie non istituzionali.
Organizzazione "a rete" dei servizi quindi come risposta fondamentale al mandato che gli stessi
servizi hanno ricevuto e continuano a ricevere: organizzazione "a rete" che riguarda sia la
definizione di servizio di psichiatria territoriale come "nodo" nella rete del territorio, sia
l'organizzazione interna dello stesso servizio, da tempo naturalmente costituito da una "rete di
professioni".
Proprio questi due aspetti, vale a dire
1. il servizio psichiatrico territoriale come rete di professioni
2. il servizio psichiatrico territoriale nella rete del territorio
rappresentano per gli stessi servizi importanti momenti sia di qualità sia di criticità.
1. IL SERVIZIO PSICHIATRICO TERRITORIALE COME RETE DI PROFESSIONI. Come è noto,
MULTIPROFESSIONALITA' è il termine che identifica l'organizzazione delle risorse interne al
servizio psichiatrico territoriale. Brevemente, la multiprofessionalità è la più naturale risposta alla
complessità insita sia nel mandato dei servizi psichiatrici territoriali stessi, sia nei bisogni espressi
dell’utenza dei servizi. E' tempo che le cinque professionalità convivono nei servizi territoriali e si
avvicendano nella costruzione di processi e percorsi di cura. Prova ne è la realizzazione di
piani/processi di cura attravverso il Modello del Case Management, che implica il lavoro di (in)
microequipe, per l'appunto multiprofessionali, che operano secondo obiettivi condivisi articolati a
partire dalla complessità dei bisogni dell'utente.
Se tutti condividiamo questo modello di riferimento, particolarmente efficace nell'organizzazione
del lavoro con l'utenza a più elevata complessità, siamo davvero così certi che la convivenza delle
professionalità sia oggi espressione di una reale integrazione fra aree di competenza?
E' opinione mia e di molti che la multiprofessionalità si configura ancora come tensione verso
l'integrazione (per il momento ideale), mentre ciò che si realizza è, almeno il più delle volte, "una
catena di montaggio" di pezzi di intervento realizzati in sequenza. Recentemente, dopo un ricco
scambio con i colleghi reponsabili di CPS, siamo arrivati alla conclusione che ancora non siamo
riusciti a completare il passaggio da "organizzazioni di monoprofessioni contigue che operano in
sequenza" a "organizzazioni multiprofessionali" connotate da reale condivisione di responsabilità e
di risorse, nel pieno rispetto del pincipio della continuità fra singole professioni, dotate di
chiarezza nel mandato ed autonomia operativa, capaci di esprimersi per processi paralleli e
sinergici.
Non è facile cambiare, e molte sono le difficoltà che rallentano l'evoluzione verso la integrazione
delle professionalità, fra cui mi sovvengono:
a) la difficoltà a identificare, con la dovuta precisione, la dimensione dell'ASSISTENZA
nell'ambito del lavoro psichiatrico, con conseguente rischio di crisi di identità per la
professionalità infermieristica
b) la difficoltà a riconoscere la soluzione di continuità fra psichiatria clinica e psichiatria
sociale, ovvero fra la terapia come obiettivo e la qualità di vita come tensione, con
conseguente rischio di crisi di identità per la professionalità medica
2
E' peraltro doveroso ricordare che alcune professioni dell'ambito psichiatrico territoriale, come
quella dell'educatore (ma anche quella dell'assistente sociale) hanno una professionalità
connotata da più chiare identità/ruolo/funzione. Personalmente, ritengo che ciò sia frutto
dell'orientamento della stessa psichiatria di comunità verso la dimensione riabilitativa e di riscatto
sociale, per cui le professioni di questo ambito hanno già vissuto la loro fase di empowerment,
laddove per empowerment intendo il prodotto di processi di capacitazione, maturazione ed
emancipazione.
Presumibilmente, il costrutto di empowerment deve essere riferimento non solo per orientare
buona parte del lavoro clinico-riabilitativo con l'utenza che presenta bisogni di più elevata
complessità, ma può rappresentare uno strumento utile a risolvere alcuni nodi delle
professionalità "in crisi" verso la realizzazione della vera multiprofessionalità. Pensiamo quale
vantaggio otterrebbero le identità professionali dall'approccio orientato all'empowerment, "... che
esplora e facilita sistematicamente le possibilità di autodeterminazione della persona (per noi
dell'identità professionale) e ne valorizza la dimensione psicologica ..." (Straticò 2009, p. 70).
Non mi dilungo oltre, ed intendo lasciare aperta la questione dell'acquisizione di empowerment
nelle professionalità in rete nei servizi teritoriali, perché è mio profondo desiderio che parte della
discussione verta proprio su questo; magari verso la progettazione di percorsi di "formazione
insieme" diretti alla valorizzazione delle responsabilità, alla padronanza dell'organizzazione,
all'accettazione dell'errore, verso un comune processo di attenzione condivisa alla salute
organizzativa del servizio e della sua missione.
2.
IL SERVIZIO PSICHIATRICO TERRITORIALE NELLA RETE DEL TERRITORIO. L’adesione dei
servizi di psichiatria territoriale alla filosofia della Psichiatria di Comunità ha implicitamente
indotto la definizione degli stessi servizi come nodo nella rete del territorio: non più quindi area
“chiusa” relegata all’interno delle mura dell’Ospedale Psichiatrico, ma inserita nel territorio ed in
diretta e naturale continuità con le altre agenzie di cura e di supporto alla fragilità.
Non è un caso che la popolazione oggetto di cura ed assistenza è sensibilmente aumentata nel
tempo, e che oggi i servizi di salute mentale non si occupano più solo della grave malattia mentale,
ma spaziano in tutto ciò che è racchiuso dagli ampi confini del disagio psichico e della fragilità. Ciò
ha trasformato i servizi per la cura della malattia mentale in servizi per la salute mentale: si tratta
di servizi che non solo curano, ma colgono bisogni, costruiscono consensi, reperiscono risorse e
quant’altro, in (quanto meno formale) sinergia con altre agenzie del territorio.
La delega ai servizi territoriali di salute mentale è quindi molto vasta; questa vastità si correla da
una parte all’aumentata capacità dei servizi stessi di offrire risposte più articolate e complesse ai
bisogni dell’utenza “ortodossa” (Disturbi Gravi). Ciò ha permesso di orientare buona parte del Case
Management all’esterno dei servizi secondo i principi e le logiche della recovery e
dell’empowerment: il lavoro clinico sui sintomi, la prevenzione riabilitativa della cronicità che
favorisce l’acquisizione di competenze, gli interventi assistenziali sui bisogni di base, si sono
articolati ai nuovi progetti diretti al raggiungimento di autonomie utili a una più radicata ed
efficace inclusione sociale (di cui sono parte i progetti di inserimento socio-lavorativo e la
trasformazione di utenti in facilitatori sociali).
Questo nuovo stile di organizzare ha visto un immediato ed intenso coinvolgimento delle
Associazioni dei Familiari, che si sono trasformate ad hoc, a loro volta, in aiutanti e facilitatori,
oltre che a promuovere l’importanza dei processi di inclusione sociale nei Tavoli Politici accanto
agli stessi operatori dei servizi.
Questo (per noi) relativamente nuovo stile di organizzare progetti di cura, presenta peraltro ad
oggi alcune lacune che riguardano particolarmente la collaborazione attiva di altre agenzie del
territorio (Comuni, ASL), necessarie al reperimento di risorse (ad esempio l'housing) ed al
3
compimento di fasi dei percorsi di inclusione (ad esempio l'inserimento lavorativo). Appare
sempre più interessante la possibilità di concretizzare l’idea dell’inter-agentività, ovvero la
creazione di reti effettivamente orientate alla continuità ed all'ampliamento della presa in carico
con Case Manager che, in alcune fasi del progetto, non debbano forzatamente essere “del servizio
psichiatrico”. Un’innovazione che rimanda alla reale disponibilità di partnership e alla possibilità di
spostamenti della leadership nel Case Management in relazione all’emergenza di bisogni che
talora sono affrontabili non tanto dal servizio psichiatrico, ma da altre agenzie e nodi della rete.
L'altro aspetto della delega ai CPS nella rete è rappresentato dalla sempre più importante (sino a
divenire gravosa) richiesta di interventi (per di più in momento connotato dalla generale
contrazione delle risorse a disposizione). Faccio qui riferimento alla presenza dei servizi psichiatrici
territoriali nell'intervento su utenza con doppie (e talora triple) diagnosi, con emergenze di tipo
assistenziali, con fragile multiculturalità; per non parlare di una significativa tendenza della delega
agli stessi servizi psichiatrici anche per le aree più "leggere" della sofferenza psichica, correlata
all'eccessivo carico della medicina di base (o talora alle più o meno esplicitate difficoltà nel
dedicarsi al paziente psichiatrico da parte del medico di medicina generale).
Tutto ciò rappresenta, almeno in parte, un effetto negativo della delega ai servizi di psichiatria
territoriale in materia di salute mentale; ciò riguarda anche il coinvolgimento dei servizio di
psichiatria territoriale nel trattamento del comportamento ambnorme, come dimostra la
crescente richiesta di interventi "difficili" a ponte fra il trattamento dell’utenza in uscita dagli
Ospedali Psichiatrici Giudiziari e le richieste "garanzia sociale" dirette ad individui con evidente
antisocialità (e talora nessun altra patologia mentale).
Per ovviare a queste difficoltà e rendere la delega funzionale e costruttiva è necesario potenziare il
lavoro di rete, la cooperazione e la negoziazione con le altre agenzie del territorio, ovvero i
Comuni, le ASL con la Medicina di Base, i Consultori ed i Servizi per le Dipendenze, le forze
dell'ordine. La risposta possibile sta nell'avviare processi di focusing che necessitano la continuità
di tavoli programmatici e tecnici in grado di riconoscere le diverse competenze, di negoziare i ruoli
nell'ambito del coordinamento e di favorire la piena cooperazione fra gli stakeholders.
Intervento del Dr. Roberto Bezzi
Di seguito riporto un testo da un articolo di Dario De Martis, pubblicato nel 1986 sulla Rivista
Sperimentale di Freniatria (CX, 1986, 4, 697 - 705) col titolo “Il reparto di diagnosi e cura in
un'ottica relazionale”, inserito successivamente nel volume Fare e pensare in psichiatria, di De
Martis, Petrella, Ambrosi, Raffaello Cortina, 1996.
Rileggendolo dopo anni mi sono reso conto che l’esperienza di lavoro accumulata sin qui mi faceva
comprendere ancor meglio la ricchezza e la lungimiranza dell’autore. Il reparto di psichiatria
presenta aspetti critici legati alla eterogeneità dell’utenza, alle differenti e contrastanti richieste
del terzo sociale, ma anche se non soprattutto alle caratteristiche umane e professionali degli
operatori. Questi sono chiamati ad un incessante lavoro di rivisitazione del proprio operare, delle
emozioni che nascono nell’incontro con le varie forme di sofferenza psichica e con colleghi e
collaboratori di tutto l’ospedale, delle reazioni ‘controtransferali’ che quasi sempre ci appaiono
come ‘le uniche possibili’, mentre sovente coprono movimenti di rifiuto o di onnipotente
manipolazione. La percezione di essere sempre in ritardo, di dover correre affannosamente da una
consulenza ad un ricovero ad una dimissione, di essere vittime assediate e non comprese dal
territorio, come pure le dimenticanze, i mancati passaggi di informazioni, le richieste di
appuntamenti all’ultimo istante della degenza, a mio avviso non riposano solo e sempre su dati di
4
realtà, ma dal confronto quotidiano con situazioni di per sé ambivalenti in assenza di adeguati
spazi da riservare alla rielaborazione emotiva, possibilmente in équipe. In questo la lezione di De
Martis mi è parsa davvero attuale. Eccola.
“La legge 180 ha inteso limitare i posti letto nei SPDC per contrastare la psichiatrizzazione abusiva,
che abbracciava indiscriminatamente malati mentali, alcolisti, tossicomani, anziani, persona
sprovviste di autonomia.
C’era una dimensione utopica in questi provvedimenti legislativi, quasi che modificando le misure
di intervento si potessero risolvere i problemi più drammatici inerenti la malattia mentale.
Il SPDC finisce per rappresentare un concentrato di problemi irrisolti e in buona misura irresolubili.
Quanto meglio funzionano i servizi sul territorio, quanto più corrette sono le indicazioni al
ricovero, tanto maggiore risulta la gravità dei soggetti ricoverati, fino a rappresentare la cartina di
tornasole dei fallimenti sul piano esistenziale, delle situazioni di convivenza familiare e sociale
insostenibili e dei fallimenti terapeutici.
Il servizio di diagnosi e cura può essere così visto all'insegna del ritorno del rimosso, dell'inutilità
delle operazioni di negazione, come una sorta di deposito della teratologia psicopatologica e
sociale.
Osservando la popolazione ricoverata, si trovano utenti occasionali per crisi acute, sovente con le
caratteristiche della reazione psicogena. Queste persone vivono in maniera drammatica e
perturbante l’improvviso confronto con il clima 'folle' che connota il reparto.
La loro motivazione predominante è quella della dimissione, con scarsissima disponibilità a
mettere in discussione il significato della crisi che ha determinato il ricovero.
Ci sono poi le persone affette da psicosi acuta, per le quali appare pienamente giustificata la
dizione di Diagnosi e Cura. Per loro sarebbe indicata una degenza prolungata in un clima più
stabile e accogliente, anche dal punto di vista residenziale.
Non sempre è possibile, per l’indisponibilità di letti post acuzie, e i curanti possono trovarsi
costretti a una dimissione precoce, una volta raggiunta una ricomposizione formale, perché malati
e familiari non tollerano di permanere in un ambiente psichiatrico per acuti.
Ci sono poi i rientri della vecchia e della nuova cronicità. Per questi il ricovero costituisce una
tappa di una dolorosa ma consuetudinaria routine. Molti di loro, conoscendo la trafila
istituzionale, fanno per così dire irruzione in reparto, eludendo i servizi ambulatoriali e passando
direttamente dal pronto soccorso.
Infine vi sono le persone la cui attribuzione psichiatrica risulta impropria. Queste persone
rifluiscono nel reparto come rifugio provvisorio a causa di un’intolleranza, di un'espulsione sociale.
Se consideriamo nel suo assieme un agglomerato umano così eterogeneo, non avremo difficoltà a
renderci conto che le motivazioni che sottostanno ai loro comportamenti divergono
profondamente. Se guardiamo con gli occhi della fenomenologia, in rapporto al parametro
spaziale si può scorgere un'antinomia fra chi vive il contesto della degenza come soffocante e
minaccioso e chi sente la restrizione in moto protettivo e rassicurante. Anche per quanto riguarda
il tempo emerge la medesima ambivalenza. Da un lato un tempo interminabile dominato
dall'attesa struggente dell'uscita, dall'altro un tempo privo di parametri di riferimento, un tempo
invertebrato, un lungo fluire con caratteristiche a volte paraoniriche, ove passato e futuro non
sono distinti da un'effettiva scansione (il tempo manicomiale, per intenderci). La dimensione
sonnolenta, potenziata dai farmaci, è rotta a volte da improvvisi scoppi di agitazione e di
clamorosità.
Il referente corporeo sembra l'elemento unificante. Il riferimento topografico all'ospedale, dove ci
si occupa del somatico, valorizza questa dimensione, collegata alla ritualità delle indagini di
laboratorio, alla sottolineatura delle concomitanti patologie organiche.
5
In questo quadro emerge, ulteriore complicazione, la contraddittorietà del compito affidato ai
curanti. Da un lato si richiede loro uno sforzo volto a creare un clima accogliente nel tentativo di
attenuare le ansie e i movimenti di frammentazione, costituendo una barriera protettiva volta a
rassicurare e a sedare. D'altro canto questi stessi fattori possono costituire uno stimolo
regressivante e passivizzante per i pazienti che tendono abusivamente a stabilire col reparto una
relazione di dipendenza simbiotica. Ai curanti compete pertanto un arduo impegno: essere
disponibili e accoglienti nella maggior parte delle situazioni, ma anche in grado di assumere
atteggiamenti di fermezza nei casi in cui il ricovero si riveli abusivo e controproducente. Questa
doppia funzione richiede una costante autodisciplina onde mantenere l'elasticità dello stile di
rapporto, evitando la sclerosi di un tipo di relazioni stereotipate con i dirigenti e con i loro
familiari.
In una situazione di questo tipo il terapeuta è costantemente coinvolto in azioni e scoraggiato dal
cercare di comprendere o addirittura di interpretare, in mancanza di un assetto che assomigli in
qualche modo a un setting. In un ambiente dominato dall'intensità delle identificazioni proiettive,
mancano al curante lo spazio, il tempo e anche la disponibilità a effettuare una sorta di lavoro di
Sisifo ai fini di ricollegare in un insieme coerente le trame aggrovigliate dei rapporti plurimi.
Pertanto le nostre azioni sono sovente ispirate a contro identificazioni massicce, che possono
sfuggire al controllo autocritico, inducendo talora atteggiamenti di insofferenza, di rifiuto o di
derisione verso il malato. Sulle sottili e complicate interazioni predomina l'urgenza, il peso
schiacciante della realtà (o per lo meno quella che appare come istanza realistica) con il pericolo
persistente di indurre uno stile di lavoro automatico e routinario, cui si aggiunge troppo sovente
l'indifferenza, per usare un termine pietoso, delle autorità politico amministrative.
Chi non intende trincerarsi in una difesa cinica ha la possibilità di utilizzare in modo costruttivo gli
effetti depressivi suscitati dalla coppia sofferenza impotenza, con la mobilitazione di un
atteggiamento di fondo di tipo riparativo. Questa posizione fondamentalmente auto terapeutica
rimanda alle motivazioni di base che hanno costituito il fondamento della nostra scelta
professionale. Proprio perché narcisisticamente remuneranti, esse appaiono al riparo da ogni
inautentica retorica. Esse si rafforzano nel corso di una lunga militanza psichiatrica, mediante una
conferma dell’irriducibilità dell'uomo, della sua capacità di fronteggiare le catastrofi interne ed
esteriori. Non si tratta di una scelta velleitaria, ma di quanto scaturisce da un'attenta lettura delle
vicissitudini dei nostri pazienti. Questi, rivisti a distanza di anni, dimostrano sovente una
straordinaria capacità di sopportazione e di risposta, un viscerale attaccamento alla vita, anche nei
casi che, reiteratamente, hanno attentato alla loro sopravvivenza. Da essi promana una carica di
simpatia e di umanità che la sofferenza ha depurato facendole risaltare. Il nostro compito può
allora essere pensato come accomunamento solidale suscettibile di un approccio comprensivo,
non supponente, ma discreto e tollerante che, nelle situazioni di crisi, si trasforma in una sfida al
dolore mentale. Questo tipo di risposta da parte dei curanti viene in molti casi raccolto e
gelosamente conservato nell'intimità dei nostri pazienti. Per queste ragioni di ordine strutturale, la
convergenza dei fattori negativi prima elencati non è preclusiva per mantenere un assetto di
fondo di tipo terapeutico. E questo assetto è sia una condizione mentale dell'operatore, sia uno
stile di vita. Esso richiede, per poter sopravvivere alle frustrazioni, alcune condizioni che sono
fondamentali. Prima di tutto la rinunzia a quella che Freud definisce ambizione terapeutica, intesa
come derivato da inconfessate aspirazioni alla manipolazione e all'onnipotenza infantile. In
secondo luogo mi pare necessaria un'attenzione particolare a quelli insieme di emozioni profonde
che possono essere riassunte con il termine di controtransfert. In particolare i sentimenti di paura,
rabbia, disgusto, eccitamento seduttivo, che soggetti sofferenti inducono in noi, ma che rischiamo
di mascherare sotto atteggiamenti ipercompensati di gentilezza e di eccessiva disponibilità.
6
Nel rapporto con tutti gli operatori del reparto è necessario usare il linguaggio dell'ostensibilità. Il
riferimento va fatto a situazioni obiettivabili, richiamando costantemente, nella discussione
collettiva sui casi, il ruolo dei fattori esterni, della famiglia e dell'ambiente. In questo modo è
possibile consentire a tutti di intravedere nel soggetto degente non solo la dimensione folle che ha
richiesto il ricovero, ma anche la persona in situazioni della sua storia, nella vita reale, coinvolta in
problemi che riguardano anche ciascuno di noi.
Questo rudimentale canovaccio, teso alla risignificazione, non può essere pensato come attività a
sé stante, ma come momento iniziale, soprattutto nei casi nuovi, di un processo di presa in carico
che, abbozzatosi in reparto, potrà prolungarsi nei servizi territoriali per periodi più o meno lunghi.
Ma il tempo della degenza può assumere un suo specifico valore: mirare alla ricostruzione di un
minimo equilibrio egoico e rappresentare una variante mutativa di valore non trascurabile.
Il reparto svolge una funzione di rianimazione, sia come ruolo materno, sia come forma particolare
di ritualizzazione del lutto, la cui finalità sociale è di ricostituire una presenza minacciata di
annientamento. Se la crisi psicotica si connota in una caduta in uno spazio senza nome di
atemporalità angosciosa, l'apporto terapeutico relazionale e farmacologico, realizzato anche
attraverso le pratiche di accudimento fisico, può contribuire a ricostituire una coscienza chiara,
che si oppone all'agonia psichica e al vuoto del pensiero. Ci sono anche una funzione di
contenimento, di holding, e una funzione di sblocco, necessaria per assicurare nel soggetto in crisi
un reinvestimento adeguato del proprio sé corporeo e della realtà esterna. Si tratta di un
programma minimale, che il più delle volte si verifica o spontaneamente nel paziente, con il solo
allontanamento da una situazione patogena, o in funzione degli interventi terapeutici, al di fuori
della consapevolezza dei curanti. Ma una crescita culturale scaturirà anche dalla presa di coscienza
critica e riflessiva di quanto facciamo automaticamente”.
7