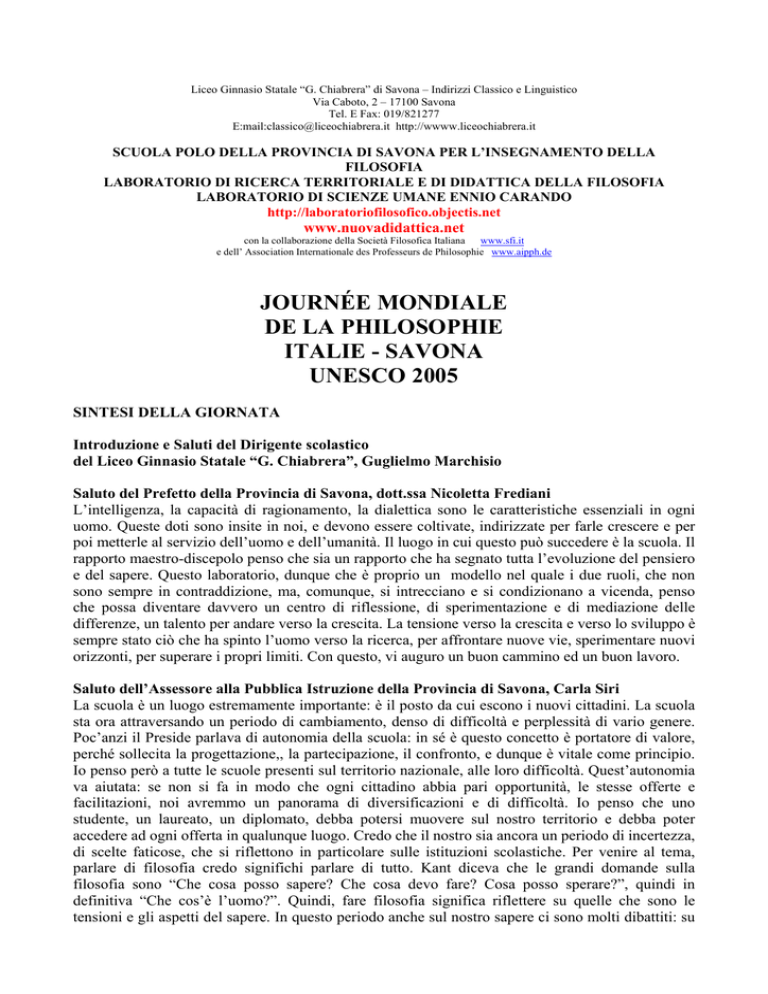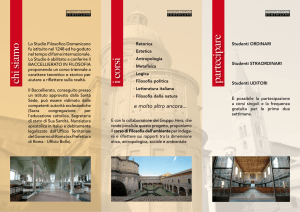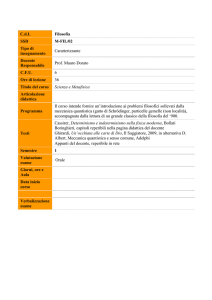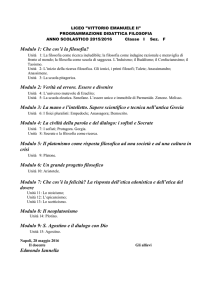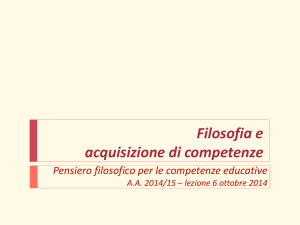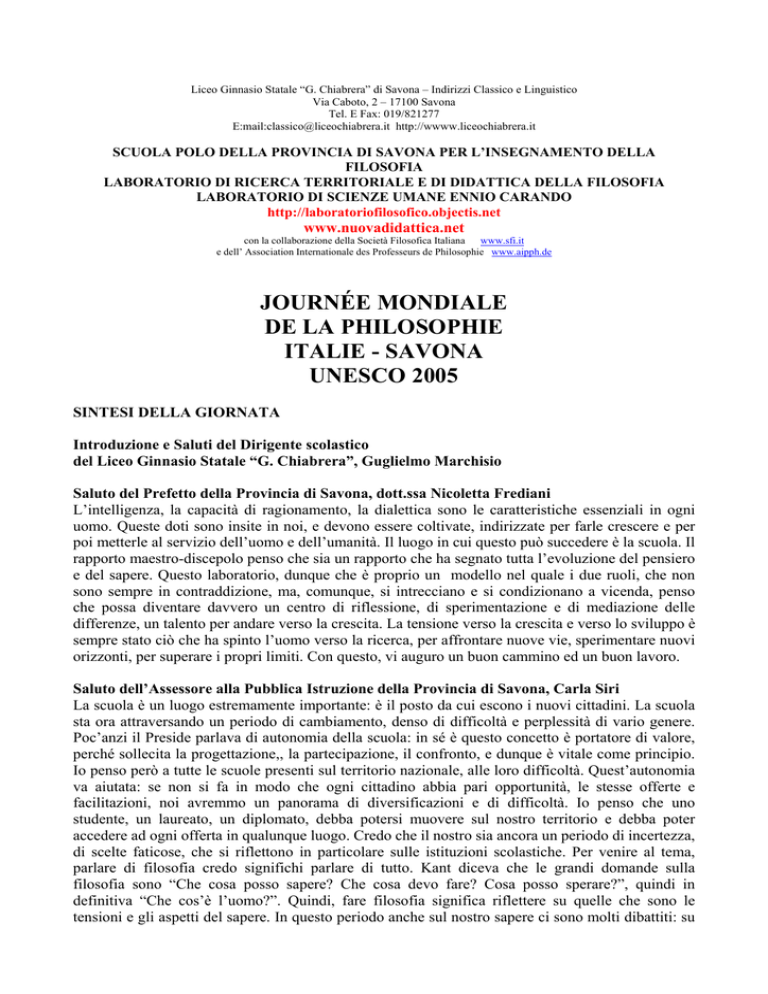
Liceo Ginnasio Statale “G. Chiabrera” di Savona – Indirizzi Classico e Linguistico
Via Caboto, 2 – 17100 Savona
Tel. E Fax: 019/821277
E:mail:[email protected] http://wwww.liceochiabrera.it
SCUOLA POLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER L’INSEGNAMENTO DELLA
FILOSOFIA
LABORATORIO DI RICERCA TERRITORIALE E DI DIDATTICA DELLA FILOSOFIA
LABORATORIO DI SCIENZE UMANE ENNIO CARANDO
http://laboratoriofilosofico.objectis.net
www.nuovadidattica.net
con la collaborazione della Società Filosofica Italiana
www.sfi.it
e dell’ Association Internationale des Professeurs de Philosophie www.aipph.de
JOURNÉE MONDIALE
DE LA PHILOSOPHIE
ITALIE - SAVONA
UNESCO 2005
SINTESI DELLA GIORNATA
Introduzione e Saluti del Dirigente scolastico
del Liceo Ginnasio Statale “G. Chiabrera”, Guglielmo Marchisio
Saluto del Prefetto della Provincia di Savona, dott.ssa Nicoletta Frediani
L’intelligenza, la capacità di ragionamento, la dialettica sono le caratteristiche essenziali in ogni
uomo. Queste doti sono insite in noi, e devono essere coltivate, indirizzate per farle crescere e per
poi metterle al servizio dell’uomo e dell’umanità. Il luogo in cui questo può succedere è la scuola. Il
rapporto maestro-discepolo penso che sia un rapporto che ha segnato tutta l’evoluzione del pensiero
e del sapere. Questo laboratorio, dunque che è proprio un modello nel quale i due ruoli, che non
sono sempre in contraddizione, ma, comunque, si intrecciano e si condizionano a vicenda, penso
che possa diventare davvero un centro di riflessione, di sperimentazione e di mediazione delle
differenze, un talento per andare verso la crescita. La tensione verso la crescita e verso lo sviluppo è
sempre stato ciò che ha spinto l’uomo verso la ricerca, per affrontare nuove vie, sperimentare nuovi
orizzonti, per superare i propri limiti. Con questo, vi auguro un buon cammino ed un buon lavoro.
Saluto dell’Assessore alla Pubblica Istruzione della Provincia di Savona, Carla Siri
La scuola è un luogo estremamente importante: è il posto da cui escono i nuovi cittadini. La scuola
sta ora attraversando un periodo di cambiamento, denso di difficoltà e perplessità di vario genere.
Poc’anzi il Preside parlava di autonomia della scuola: in sé è questo concetto è portatore di valore,
perché sollecita la progettazione,, la partecipazione, il confronto, e dunque è vitale come principio.
Io penso però a tutte le scuole presenti sul territorio nazionale, alle loro difficoltà. Quest’autonomia
va aiutata: se non si fa in modo che ogni cittadino abbia pari opportunità, le stesse offerte e
facilitazioni, noi avremmo un panorama di diversificazioni e di difficoltà. Io penso che uno
studente, un laureato, un diplomato, debba potersi muovere sul nostro territorio e debba poter
accedere ad ogni offerta in qualunque luogo. Credo che il nostro sia ancora un periodo di incertezza,
di scelte faticose, che si riflettono in particolare sulle istituzioni scolastiche. Per venire al tema,
parlare di filosofia credo significhi parlare di tutto. Kant diceva che le grandi domande sulla
filosofia sono “Che cosa posso sapere? Che cosa devo fare? Cosa posso sperare?”, quindi in
definitiva “Che cos’è l’uomo?”. Quindi, fare filosofia significa riflettere su quelle che sono le
tensioni e gli aspetti del sapere. In questo periodo anche sul nostro sapere ci sono molti dibattiti: su
questioni religiose, etiche, sulla giustizia, sul concetto di stato e di amministrazione dello stato.
Credo che questo vostro sia un contributo importante, ma soprattutto un contributo che parte da un
lavoro in comune, che parte da un rapporto con altre scuole ed istituzioni, dalla continuità e dalla
consequenzialità di questo rapporto; sono tutti valori estremamente importanti, che spero possano
contribuire a creare persone in rado di abbordare ogni argomento in modo critico, aperto, libero e
senza pregiudizi, per potersi porre come soggetti importanti all’interno tanto della nostra società,
quanto delle altre società che ci circondano. Penso soprattutto alla società europea, che è il mondo
dentro al quale noi ci muoviamo oggi. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro.”
Intervento del prof. Riccardo Sirello, Docente e Coordinatore scientifico del Centro
Territoriale Didattica della Filosofia della provincia di Savona
Ringrazio tutti i partecipanti e le autorità, che danno ufficialità a questo nostro incontro di frutti
eterogenei, perché qui sono presentate diverse scuole, e soprattutto un progetto importante
nazionale e internazionale: quello di avere iniziato un lavoro in comunità e in condivisione,
Studiando scenari e linguaggi e producendo nuovi progetti. In questa occasione così importante
metterei in rilievo proprio la riflessione che mira a dare senso e significato alle cose, ecco perché il
gruppo è multidisciplinare e coinvolge le scienze, la matematica e i saperi in generale.
L’UNESCO si è sempre impegnata in questa attività, mettendo in luce l’uomo “dialogico”. Porto i
saluti di M.me Moufida Goucha, Chef de la Section de Philosophie et Sciences Humaines de
l’Unesco, che ci ha comunicato gli auguri e il sostegno a tutte le iniziative che si stanno realizzando
sul territorio in tutti gli stati di tutto il mondo, tutti coinvolti in un processo di riflessione. Mio
compito è anche quello di fornire una descrizione della Journée al nostro Centro didattico della
Filosofia: il sito UNESCO diffonderà la selezione di questi modelli didattici, esaltando soprattutto
questa funzione che secondo me è più importante di tutto, la funzione paritetica tra docenti e
studenti. Oggi bisogna cambiare molte strategie didattiche nelle nostre scuole superiori e
all’Università, per fare degli studenti soggetti attivi e farli diventare protagonisti. I Laboratori che
vedremo oggi pomeriggio sono risultati degli studenti, in concertazione certo coi professori, i quali
non perdono chiaramente la loro centralità, ma diventano anche agevolatori ed esperti. Il gruppo di
progettazione si farà carico in questa giornata di presentare una relazione e un documento finale
sottoscritto dai presenti. Mi è gradito anche comunicare che il bollettino che ho qui dell’AIPPh, con
sede a Bruxelles, riporta il nostro precedente documento del 2004 e poi un altro bollettino che
riguarda l’Insegnamento della Filosofia ed Etica nei diversi Stati Europei, per la precisazione
ventotto paesi (dal Belgio alla Rep.Ceca alla Russia) in cui si fa il punto della situazione didattica
dell’insegnamento della filosofia, il merito va alla capacità della responsabile di Redazione Frau
Luise Dreyer che ha saputo raccogliere e diffondere i materiali dei diversi corrispondenti .Infine, il
presidente dell’AIPPh, membro permanente belga, dell’Università di Ostenda, Hermann
Lodewyckx, in occasione della Journée ha inviato un documento in lingua francese, lingua
veicolare dell’UNESCO. Mi premurerò di leggere il documento in lingua francese con il desiderio
che tutti i nostri i giovani possano nella scuola coltivare tutte le lingue europee.
LETTURA DELLA LETTERA DEL PRESIDENTE dell’AIPPh
E con questo vorrei chiudere il mio intervento: il fatto che noi ci ritroviamo, che comunichiamo,
che abbiamo momenti dedicati alla formazione a distanza ci fanno un Gruppo solido ed pieno di
entusiasmo.L’anno scorso ci siamo dedicati intensamente a questa esperienza ed attraverso un
portale abbiamo costruito veramente una comunità. I laboratori attivati hanno prodotto dei materiali
interessanti, dei veri pacchetti formativi (l’ispettrice ne parlerà poi più dettagliatamente) sui quali la
rete nazionale ha dimostrato interesse. Questo ci onora e ci rinforza nel perseguire un obiettivo di
un lavoro che non deve mai essere individuale o legato a personalismi, ma frutto della condivisione
di tutta una comunità che dialoga e crede in questo valore degli uomini.
Ispettrice MIUR Anna Sgherri, Direttore Responsabile del Centro Territoriale di Didattica
della Filosofia della Provincia di Savona
Non è questa la prima giornata di questo tipo: abbiamo iniziato da più di un anno quest’attività. Già
ora cominciamo a raccogliere qualche frutto. Il mio compito è quello di ricordare un po’ in che
situazione siamo, cioè da dove siamo partiti e qual è effettivamente il contesto in cui ci muoviamo,
perché è preoccupazione di questo gruppo e di tutti i gruppi che ho avuto occasione di coordinare
quella di tenere conto della specificità, della particolarità del contesto in cui operiamo, ma nello
stesso tempo dobbiamo collocarci all’interno di esso, in progetti più ampi, perché quando si lavora
nella scuola si lavora in una società, in una comunità, per quanto la scuola sia un microcosmo di
società. Abbiamo dunque due livelli: quello della particolarità dell’istituzione, della comunità, del
progetto; quello dell’orizzonte nazionale e internazionale in cui ci muoviamo. Questi due livelli
vanno sempre tenuti presente, perché essi danno senso, spessore e direzione alla nostra attività. In
questo progetto abbiamo tenuto conto dei due aspetti. Infatti, dalle indicazioni dell’UNESCO, ma
anche della Società Filosofica Italiana e dell’Associazione Filosofica Ligure, abbiamo colto certe
linee essenziali, cioè abbiamo raccolto il messaggio della riflessione filosofica nella formazione di
base del cittadino. Al centro del discorso sta l’idea di una diffusione della filosofia, non solo dello
studio filosofico specifico, ma appunto la diffusione nel senso filosofico del confronto, del dialogo,
dell’approccio filosofico ai problemi. Ciò implica la necessità per tutti i cittadini di avere uno spazio
intellettuale per riflettere sul senso delle cose che si fanno, sul senso della vita e della società, il che
è un privilegio proprio dell’uomo: avere uno spazio intellettuale proprio in cui operare come
riflessione libera, perché riteniamo sia una condizione essenziale affinché l’uomo possa dare il
meglio di sé nei rapporti sociali, nella costruzione di una comunità, nel contenuto proprio della
formazione di valori condivisi, che devono essere ricostruiti, riscoperti. Il senso del messaggio
dell’UNESCO è proprio in questa direzione, non tanto sul piano metodologico-didattico, quanto sul
piano del significato filosofico dell’esistenza che deve permeare un po’ tutta la nostra vita. Su
questo ci siamo impegnati nel passato, ma io e molti insegnanti ancora continuano a farlo pr
avvicinare la riflessione e la ricerca filosofica anche agli istituti e alle comunità scolastiche che non
hanno la filosofia fra i loro corsi. Noi qui siamo all’interno di un contesto che al proposito è
sicuramente facilitato dalla struttura curriculare. Per questo riteniamo che, se effettivamente la
filosofia è un privilegio, una conquista e un diritto dell’uomo, allora questo deve esserlo per tutti.
Allora, uno degli obiettivi è proprio quello di un coinvolgimento maggiore, atipico se volete, anche
informale, anche molto libero, anche creativo e un po’ eccentrico, di quelle comunità scolastiche in
cui non è previsto uno spazio per la filosofia. Quando noi abbiamo iniziato questo progetto
l’abbiamo iniziato con un obiettivo molto preciso: coinvolgere i docenti di discipline interessate al
tema dei modelli di razionalità, ma con la specificità di avviare una formazione e un coinvolgimento
basato sulla ricerca. Non un aggiornamento di tipo nozionistico o comunque metodologico-didattico
“calato dall’alto”, anche se condiviso, ma una formazione basata sulla ricerca, perché la più alta
dimensione professionale di un docente è quella di fare ricerca. La scuola è un progetto di ricerca,
ha senso come laboratorio di ricerca, non solo come trasmissione di contenuti. I contenuti sono i
mattoni su cui si costruisce la casa, ma bisogna avere idee per costruirla. Il progetto, dunque, e la
ricerca sono essenziali, per avere una comunità scolastica e degli insegnanti: non si può infatti
insegnare a ricercare se non si è a propria volta ricercatori. Questo era il nostro obiettivo, ama
questo progetto, come tutti i progetti fondati sulla ricerca, è diventato autonomo, è diventato un
progetto di ricerca in cui la presenza degli studenti è molto forte nella stessa linea di ricerca. Non
una ricerca subalterna, non un’applicazione di ricerca, ma un coinvolgimento sullo stesso progetto
di ricerca: ogni soggetto ha un suo ruolo legato alle competenze che ha – non è una simulazione
giovanilistica – ma c’è una condivisione sulla linea di percorso della ricerca. Su questa base si ridà
senso all’essere scuola e non solo all’essere filosofia. L’altro aspetto che qui voglio ricordare è
quello della scelta del tema, dell’oggetto di questo progetto. Noi abbiamo scelto questo scenario sui
modelli di razionalità, ma all’interno dei modelli di razionalità abbiamo fatto una scelta, che è
quella del rapporto fra i saperi e specificatamente fra i saperi filosofico e scientifico. C’è una
ragione anche storica, perché noi abbiamo decenni, un secolo, da recuperare in questa linea, perché
la filosofia è stata sempre relegata, da Gentile in avanti, e forse anche prima, in un’area che non era
quella scientifica, per cui la formazione di molti insegnanti di filosofia è una formazione letterariafilosofica piuttosto che filosofico-scientifica. È solo negli ultimi decenni (e qui c’è la diretta
testimonianza del prof. Palladino, che insegna matematica a filosofia) che si è verificato un
cambiamento di segno, che tuttavia resta non generalizzabile, “utopico”. Abbiamo quindi anche un
passato da recuperare. Ma la ragione vera è che la filosofia è nata all’interno del sapere scientifico,
non sono saperi separati che si sono incontrati o che s’incontrano casualmente, o che si vogliono
incontrare: se noi pensiamo a dov’è nata la domanda filosofica, essa è nata e si è strutturata
all’interno del sapere scientifico, sul suo perché e sui suoi fondamenti. La filosofia ha aggiunto alla
ricerca scientifica il senso, la dimensione di problematicità, di apertura, ma non le si è mai
contrapposta. Allora, qui si tratta non solo di riscoprire un’origine comune, ma di continuare a
costruirla insieme, e i campi di sapere sono campi che si sono separati solo storicamente o
convenzionalmente, ma sui nodi essenziali c’è una grande integrazione. Io ritengo che questo non
sia solo un programma scientifico di lavoro, ma che anche dal punto di vista operativo della scuola
la organizzazione della scuola nel futuro non dovrà essere quella di una moltiplicazione dei campi
di ricerca, o di un insieme di saperi. Noi dovremo operare sempre più verso una semplificazione ed
un’aggregazione dei nuclei essenziali di sapere, perché questo potrà rendere efficace l’azione della
scuola e della formazione. Noi operiamo allora in una direzione che è anche quella che sotto il
profilo organizzativo a mio avviso, nel futuro noi ci troveremo ad affrontare. L’altro aspetto è
quello della costituzione di una comunità. Qui sono presenti più scuole: il progetto raccoglie più
scuole e più insegnanti di discipline diverse. Questo è secondo me un modello di collaborazione e
condivisione che costituisce anche un modello di interazione sciale; è quello che chiamo
“l’apprendistato di comportamento”, cioè se noi operiamo così tra scuole, i nostri ragazzi questo
vivono. Il modello che si presenta loro è un modello di collaborazione, solidarietà, condivisione, di
interazione, senza confusioni superficiali. Dunque, offriamo anche un modello di comunità e
condivisione che non viene semplicemente raccontato o esortato, ma vissuto.
Questo secondo me è un aspetto che non può essere considerato marginale, è un aspetto che fa parte
essenziale dell’impegno educativo.
Intervento del prof. Antonio Zanghì – Università di Genova, Dipartimento di Fisica e CNR
Per quanto riguarda i “saperi forti”, le mie competenze non sono elevate, nel senso che mi occupo
da una vita i fondamenti della fisica, e in particolare della fisica quantistica e della meccanica
statistica. Questo mi porta ad occuparmi di questioni che sono davvero molto vicine a questioni
filosofiche, a pormi domande che non sono facilmente decidibili secondo i canoni tipici che il fisico
applica, che sono la formulazione di teorie e la loro verifica sperimentale. Mi porta ad affrontare la
questione da un punto di vista leggermente diverso. In questa mezz’ora mi sarà molto difficile
comunicarvi tutte le diverse sfaccettature presenti nel fare della fisica e nell’occuparsi di
fondamenti. Cercherò di raccontare in pochissimo tempo un argomento specifico, che concerne i
rapporti tra Einstein e la meccanica quantistica. Ora, queste cose non si dovrebbero raccontare in un
liceo, nessuno di voi ha studiato la meccanica quantistica, quindi come farò a comunicarvi
quest’aspetto? È una sfida, ci voglio provare, perché quest’anno 2005 è stato un anno di
festeggiamenti per la fisica e per Einstein in particolare, perché ricorre il centenario di quei tre
lavori che segnalano in senso forte la fisica del XX secolo.
Spesso, in molti problemi che ho affrontato, la sottolineatura della critica di Einstein allo sviluppo
della meccanica quantistica è, non dico assente, ma per lo meno messa in secondo piano. Spesso
trovate nella letteratura scientifica divulgativa (o anche non divulgativa), trovate l’immagine di un
Einstein che è stato incapace di adeguarsi alle nuove idee che sono cresciute nel corso del
Novecento. In sostanza, si spiega che la critica fatta da Einstein allo sviluppo della fisica è in
qualche modo collegata al suo essere in qualche modo “vecchio”, incapace di stare dietro agli
sviluppi della scienza. Ora, io ritengo che questo non sia affatto vero, e vorrei provare a chiarirvi
perché le cose stanno così. Spero che, in questo, riesca a farvi capire perché c’è un forte legame tra
riflessione scientifica e riflessione filosofica.
Il nocciolo del problema che Einstein aveva era una questione, da un lato, filosofica e, dall’altro,
fisica. Innanzitutto, Einstein riteneva la meccanica quantistica incompleta. Per spiegarvi cosa
intendesse, posso raccontarvelo facendovi capire quale non era il senso di incompletezza che
Einstein aveva in mente, cioè che cosa non dobbiamo intendere per incompletezza.
Quando si parla di fisica, fin dai tempi di Galileo Galilei, nel momento in cui cerchiamo di capire
cosa succede nel mondo, dobbiamo “difalcare gl’impedimenti della materia”. Vuol dire che non
possiamo tener conto di tutti i dettagli, ma dobbiamo focalizzarci su quelli che sono i dettagli
rilevanti per il fenomeno che stiamo studiando. Immaginate di lanciare in aria qualcosa: Galileo ci
dà una descrizione di questo fenomeno, ci fa capire le leggi che governano questo fenomeno
defalcandone appunto gli impedimenti. Con occhi moderni, il moto che avviene è un moto
parabolico, ed è tipico dei gravi nel campo gravitazionale terrestre.
Per capire da cosa è governato il fenomeno noi dobbiamo elaborare una buona rappresentazione
matematica di quanto sta accadendo. Nel far questo, nel ricostruire il fenomeno secondo il modello
matematico, ci dimentichiamo di altre cose, quindi in qualche modo i nostri modelli sono
incompleti. Le leggi fisiche sono quasi sempre incomplete: se pensiamo ad esempio al moto dei
pianeti intorno al sole, nella descrizione “classica” di Newton nei termini della legge di gravitazione
universale, la primissima approssimazione del loro moto è di tipo ellittico, poi, se si tengono in
considerazione le interazioni reciproche tra i pianeti, il moto cambia, e, ancora, se tenessimo conto
di quanto accade su larghissima scala temporale, dovremmo tenere conto degli effetti di attrito.
Quando noi diciamo che il moto dei pianeti è governato dalle leggi di Newton stiamo dando una
descrizione incompleta; quando noi descriviamo dell’acqua, e diciamo che è una sostanza pura,
secondo le leggi della termodinamica, cioè che per descriverla basta dire quanta ce n’è, a che
pressione si trova, e che temperatura ha, diamo anche in questo caso una descrizione incompleta:
per essere più precisi dovremmo ragionare in termini di molecole, etc.. I modelli usati dalla fisica
trasformano i dati rilevati, occupandosi soltanto dei dati utili alla descrizione di un particolare
fenomeno: quello che ci aspettiamo è che ci sia una perfetta compatibilità e coerenza tra modelli
diversi, ad es. fra la descrizione termodinamica e la descrizione atomica soggiacente, e che questa
sia a sua volta compatibile con la descrizione di ciò che accade all’interno degli atomi, e così via.
Se sono riuscito a comunicarvi l’idea di questo tipo di incompletezza, posso ora dirvi che questo
non è ciò che intendeva Einstein quando diceva che la meccanica quantistica è incompleta.
Ora provo a raccontarvi con una metafora cosa possiamo intendere per descrizione incompleta nel
senso di Einstein. Immaginiamoci qualcosa che non c’entra niente con la fisica: un mondo che non
è il nostro, in cui vivono individui più o meno simili a noi, in cui però lo sviluppo della medicina è
diverso dal nostro. In quel mondo, per qualche strana ragione, non si conosce esattamente quello
che c’è nei nostri corpi, non si ha una conoscenza anatomica e fisiologica come abbiamo noi,
perché, che so, quando la gente muore, i corpi immediatamente si dissolvono, oppure perché,
quando si cerca di tagliare qualche parte del corpo, questo si dissangua completamente. Inoltre, non
si è ancora arrivati ad uno studio tecnologico in grado di fare dei raggi X o delle tomografie. Allora,
immaginiamoci una possibile medicina in quel mondo. Lo scienziato medico innanzitutto si fida
poco di quel che raccontano i malati, ed ogni volta che deve capire cosa sta succedendo nel corpo
della persona, fa degli esperimenti; prende una persona, la mette fuori quando piove e fa freddo, e
poi considera che, se la persona viene tenuta fuori per due/tre giorni al freddo e al gelo, la
temperatura corporea si alza. La sua scienza consiste in questo: fare alcune operazioni su una
persona sottoponendola ad agenti e condizioni esterni, guardando cosa succede. Pone dunque delle
relazioni chiare fra manipolazioni operate su un corpo e conseguenze che ne derivano e ne scrive
una lista molto lunga su un quaderno. Dunque immagina tante possibili situazioni e tante possibili
reazioni. Essendo un bravo matematico, riesce ad immaginare modelli chiari che mi diano in
qualche modo una relazione chiara tra segnali in uscita e segnali in ingresso, cioè tra risposte
corporee e condizioni imposte al corpo stesso. A queste valutazioni qualitative, in quel mondo
ipotetico, si riesce a dare una razionalizzazione precisa in termini matematici, ottenendo un catalogo
molto chiaro di quello che succede quando, date certe azioni, si osservano certi fenomeni.
In quel mondo, inoltre, si sostiene che la buona medicina dev’essere di quel tipo lì. Mi spiego: se in
quel mondo si presentasse una persona a dire: “Ok, tutto quello che fate è buono, però perché
succede questo? Perché al corpo, se fornito di molto sale, si alza la pressione? Perché, se sottoposto
a condizioni particolari di stress e di basse temperature, dopo un po’ gli viene il raffreddore?”.
Quella persona, che è un “eretico” in quel mondo, pensa che sia importante avere una descrizione di
quello che accade dentro i corpi, cioè quella persona vorrebbe ragionare come ragioniamo noi, che
siamo portati a concludere che il raffreddore si prende perché ci sono i germi, i virus, perché
abbiamo rappresentazioni chiare di meccanismi interni ai nostri corpi, tali da rendere la nostra
scienza capace di dirci, se pur non in maniera completa, date le nostre limitate capacità conoscitive,
quello che avviene, tramite descrizioni chiare e precise.
Se sono riuscito a chiarire il contrasto fra questo ipotetico mondo e il nostro, allora posso sciogliere
la metafora. Il nostro modo di trattare la medicina, nella fisica, grosso modo, corrisponde a quello
che si è fatto fino agli anni ‘20 del XX secolo. Si riteneva infatti che, per quanto non fosse
accessibile alla diretta osservazione sperimentale lo stato microscopico della materia, ciononostante,
fosse compito della fisica fornire immagini accurate di ciò che accadeva in ciò che non si vedeva, e
dedurre conseguenze da questi modelli ipotetici, sostrati di cose reali (un po’ come la medicina che
attraverso la teoria dei virus e dei germi è in grado di capire perché le persone prendono il
raffreddore). Che cosa divise Einstein dai suoi detrattori? Il fatto che lui ritenesse che questa idea
non fosse da scartare, ma fosse una idea “perenne” della fisica. I suoi oppositori ritenevano invece
che gli sviluppi della fisica del Novecento avevano mostrato che bisognava comportarsi come i
medici di quell’ipotetico, mondo, cioè che, in conseguenza delle nostre limitate capacità cognitive,
non potessimo, in linea di principio, fornirci un’immagine chiara di ciò che succede nel mondo
aldilà dei nostri occhi. Questa fu la vera e profonda differenza tra l’immagine della scienza di
Einstein e l’immagine di coloro che crearono la meccanica quantistica. Devo aggiungere che
Einstein stesso andrebbe incluso fra i padri fondatori della meccanica quantistica, che volutamente
ho esagerato. Basti dire che la meccanica quantistica è spesso ricondotta ad un’unica equazione,
l’equazione di Schrödinger, scoperta da un fisico austriaco che aveva le medesime idee di Einstein
in merito ai due “mondi” di cui parlavamo prima.
Questo è un esempio di come ciò che si sosteneva in quegli anni, cioè che una descrizione nel senso
di Einstein era impossibile, era dettato non dai fatti della fisica, non dai fatti sperimentali, ma dalle
convinzioni filosofiche di un gruppo di fisici che allora aveva la supremazia sul piano scientifico
ma anche sul piano sociologico nello sviluppo della meccanica quantistica, tra cui Niels Bohr,
Heisenberg, Pauling, etc.. Dico questo con estrema sicurezza, perché oggi sappiamo che esistono
possibilità di descrivere la meccanica quantistica che non sono sotto forma di “catalogo” di ingressi
ed uscite, ma descrizioni in cui è possibile parlare di stati di cose nello stesso modo in cui se ne
parlava nella medicina del nostro mondo e della fisica prima degli anni ’20. Tra coloro che
contribuirono a convincerci che questo fosse possibile, va ricordato il nome di John Bell, morto
prematuramente una decina di anni fa.
Vi ho raccontato questa storia per darvi un’idea di come il rapporto fra filosofia e fisica spesso non
sia soltanto un rapporto positivo, di quanto sia importante capire che, nelle nostre azioni, le visioni
del mondo che abbiamo possono spostare la ricerca in un senso piuttosto che nell’altro, senza
alcuna oggettiva necessità. È sempre bene tenere presente i rapporti esistenti, sempre in doppia
direzione, tra scienza e filosofia e scienza e società in generale, per comprendere l’evoluzione dei
saperi.
Intervento del prof. Dario Palladino – Università di Genova, Dipartimento di Filosofia
Io sono un matematico che insegna logica al dipartimento di filosofia. La logica è una disciplina
della quale io difendo l’autonomia sia dalla filosofia sia dalla matematica, la quale però si trova
dentro la matematica, che lo si voglia o no, e che è uno dei settori tradizionali della filosofia.
Dei discorsi introduttivi che abbiamo sentito, mi ha colpito la parola: “Modello di razionalità”. Che
cosa si intenda in questi discorsi, più che altro burocratici, non mi è dato sapere, tuttavia posso dire
che la logica studia dei modelli di razionalità. Cosa si intenda però occorre specificarlo, anche per
andare nel concreto in modo didatticamente utile ed indagabile anche in ambito laboratoriale.
Bisogna prima di tutto intendere che la logica si occupa del ragionamento. Ragionamento che però
non va inteso come il modo in cui ragioniamo, cosa abbiamo nella testa, ma come il ragionamento
dopo che esso è stato esplicitato nel linguaggio. Dunque, il logico analizza delle proposizioni del
linguaggio naturale. Le quali vengono usate per molti scopi, di cui uno soltanto è il ragionamento.
Proprio per questa ragione il linguaggio è complicato, perché contiene tante sfumature. Quando si
vuole analizzare il linguaggio ai fini del ragionamento, anche qui, come nella fisica, occorre operare
delle semplificazioni. Certi tipi di ragionamento sono stati codificati e studiati e quello che è stato
maggiormente capito nel secolo scorso è ciò che sono i canoni del ragionamento matematico, i quali
non sono però limitati alla matematica. Il ragionamento logico che si fa all’interno della
matematica, infatti, aspira ad avere una valenza di tipo universale, ad essere il linguaggio in cui si
codificano i ragionamenti di tutte le scienze. Questo nucleo “forte” è stato analizzato, studiato e
capito, ed è l’oggetto del corso che io tengo agli studenti di filosofia dell’Università di Genova. Mi
ci vuole un corso, dunque circa 60 ire, per esplicare questo nucleo di conoscenze-base di logica.
Nelle mie lezioni non uso quasi mai la parola “ragionamento”, perché essa, nel linguaggio comune,
ha una valenza molto superiore a quel tipo di ragionamento che ha trovato il suo sviluppo, la sua
collocazione più naturale nell’ambito della matematica. Allora, ecco che, quando noi ragioniamo,
usiamo tutta una serie di regole, di strategie, che dipendono dal contesto in cui stiamo ragionando.
C’è poi un nucleo “più ristretto” che, invece, vale in qualunque contesto. Esso è molto limitato, che
può essere oggetto di attenzione didattica anche a livello di scuola secondaria. La tendenza dei
nuovi programmi è proprio quella di inserire questo nucleo anche all’interno dei curricula didattici,
anche se poi di fatto questi non hanno ancora raggiunto la “base”. Il mio intervento può essere un
incoraggiamento a che i docenti, sia di matematica, sia di filosofia, sia di lingua, possano occuparsi
delle regole-base con cui si ragiona correttamente. Quando si analizzano le regole del ragionare
corretto (le “inferenze”), noi analizziamo il linguaggio, operando su di esso delle semplificazioni,
per essere precisi, per chiarire, ed eliminare le ambiguità del linguaggio naturale. Per far ciò, i logici
hanno introdotto dei simboli, diversi dalle lettere e dalle parole comuni.
La prima semplificazione essenziale che si fa in logica è quella in base alla quale le proposizioni
sono soltanto o vere o false, ossia si prescinde da tutti i “gradi” di verità con cui noi sosteniamo le
nostre proposizioni. È proprio per questo che si dice che la logica è matematica, perché in
matematica una proposizione o è vera o è falsa: non si può dire che probabilmente 2 è pari; è vero e
basta. Nei ragionamenti intervengono delle proposizioni; nelle proposizioni intervengono dei
termini. Il logico analizza il comportamento di questi termini per trarre delle conclusioni dalle
premesse che ha assunto. Le semplificazioni del linguaggio vengono tradotte con quelli che si
chiamano “connettivi”, il cui funzionamento si esplica nelle tabelle di verità.
Tra questi:
- la negazione (“non”): se una proposizione è vera, la sua negazione è falsa e viceversa;
- la congiunzione (“et”)di due proposizioni: è vera quando sono entrambe vere;
- il “vel”
- l’“aut”
- il condizionale, il connettivo più importante, indicato dal simbolo “→”, che corrisponde a
dire che “non è il caso che siano vere A e la negazione di B”, che noi nel linguaggio ad es.
esprimiamo con frasi del tipo “se A allora B”. Esso è il connettivo più importante perché lo
usiamo quando deduciamo. Questo è il “se allora” come si usa nelle dimostrazioni
matematiche, ovvero corrispondentemente alla tavola seguente:
A
B
A→B
V
V
V
V
F
F
F
V
V
F
F
V
Dal fatto che il condizionale ha questa tavola, seguono alcune conseguenze; facciamo un paio di
esempi: Socrate dice “se sono colpevole, devo essere punito; ma io non sono colpevole, dunque non
devo essere punito”. Chiunque mi direbbe che ciò è convincente, eppure, dal punto di vista
strettamente logico, non è un ragionamento corretto: da A→B non segue nonA→nonB. Ciò si può
vedere da analoghi esempi: “Se una figura è un quadrato, ha quattro lati; ma non è un quadrato,
quindi non ha quattro lati”. Il fatto che io possa dire che il ragionamento di Socrate non è corretto,
segue da quelle tavole, che sono le “tabelline” del nucleo più “forte” di quelle che sono le
argomentazioni.
Ora, perché il primo ragionamento sembra convincente? Perché noi tutti abbiamo in mente che, se
uno è colpevole, dev’essere punito, e dev’essere punito solo se è colpevole. Quindi, noi
esprimiamo, col “se…allora…”, ciò che invece nella nostra testa è un “…se solo se…”: spesso
usiamo il linguaggio in modo da non rendere trasparente ciò che effettivamente vogliamo dire.
Questo test fa vedere come, quando le persone comuni usano il “se…allora…”, non abbiano in
mente quella tavola, perché la cosa importante è che, mentre sulle prime due righe della tavola si
riesce ad ottenere consenso, sulle ultime due “non va bene”. La tavola del condizionale ricorda
infatti quella che si fa nel ragionamento logico, e però presuppone che, quando l’antecedente è
falso, il condizionale sia vero.
Esempi del tipo: “Se il sole ruota attorno alla terra, allora il sole è una stella”, siccome il
condizionale antecedente è falso, da un punto di vista logico, devono essere considerati veri; ma
chiunque direbbe che ciò è falso. C’è allora una discrepanza tra la logica del common sense, usata
normalmente dalle persone, e questo nucleo di logica “forte” che ha la sua tradizione nelle
dimostrazioni matematiche.
Ecco un altro esempio recentissimo: una delle domande a quiz per prendere la patente dice così:
“Le strade extraurbane principali, se a carreggiata unica, devono avere almeno due corsie per ogni
senso di marcia”. La risposta che si deve dare per prendere la patente è “Falso”, perché le strade
extraurbane principali, per definizione, sono “strade a carreggiata indipendente”, quindi non
possono essere a carreggiata unica. Io avrei risposto, come logico, che era vero, perché un
condizionale con antecedente falso, nella logica che insegno ai filosofi, è vero. Il ministero dei
trasporti vuole che uno dica “Falso”.
La morale non è che sbaglia il Ministero, ma che non c’è una sola logica. Ci sono varie logiche, vari
“modelli” di razionalità. Quando si affronta un quiz, ci sono spesso test di “Logica”, la maggior
parte dei quali non ha a che fare con la logica come disciplina. Si tratta di test di abilità linguistica,
per lo più, ma ci sono anche quelli di logica propriamente detta. Quando uno li affronta, deve
documentarsi per capire quale sia la logica da impiegare per rispondere correttamente. Quindi, per
prendere la patente, non bisogna seguire il corso che io faccio a Genova.
Un altro argomento molto interessante è quello delle fallacie, ragionamenti che sembrano logici
(come potrebbe essere quello di Socrate di prima), ma che in realtà non lo sono propriamente, e
possono dare origine a fraintendimenti. Un tipo di fallacia è il seguente:
A→B
B
A
Questa ultima si chiama “fallacia dell’affermazione conseguente”. Esempio: “Se non ho benzina, la
macchina non parte; la macchina non parte, dunque non ho benzina”. Questa è una fallacia, perché
la macchina può anche non partire per altre ragioni: magari la benzina c’è, ma ha qualche altro
guasto. Da un punto di vista logico, dunque, questa regola di ragionamento è sbagliato.
Quel tipo di fallacia logica si chiama anche ragionamento abduttivo. Quando io ho un fenomeno B,
ad es. una malattia, il medico dice: “Se tu hai questo, hai la febbre”, e dunque, quando fa una
diagnosi, assume A come causa della mia malattia, pur sapendo che non è un ragionamento logico.
La morale è che uno schema, pur logicamente scorretto, si chiama ragionamento. Ecco perché
occorre distinguere i termini. Allora, secondo me, quando si vuole studiare la “razionalità”, bisogna
prima di tutto che gli studenti acquisiscano queste nozioni di logica classica, che non sono difficili
né lunghe, le quali costituiscono il nucleo forte di regole attraverso cui si ragiona logicamente.
Esse diventano a quel punto il paradigma non al quale sempre attenersi per ragionare, poiché il
ragionamento ha un ambito molto più vasto, ma con il quale tutte le altre forme di ragionamento
devono confrontarsi. Questo a dire che la logica non è innata, ma si apprende e si coltiva, e per
acquisirla deve essere fatta oggetto diretto di studio, apprendendo tavole e ragionamenti
formalmente definiti.
Intervento della prof.ssa Maria LuisaMontecucco – Università di Genova, Dipartimento di
Filosofia
In riferimento alla lettera del Presidente dell’UNESCO, che accennava allo stupore, al domandare
proprio dell’età infantile, che dovrebbe caratterizzare l’atteggiamento filosofico tanto che ciascun
uomo è filosofo, quest’attitudine meravigliosa è l’enorme rischio della filosofia. È un rischio,
perché, come abbiamo sentito dai precedenti relatori, entrambi hanno fatto forti riferimenti a teorie
che sono il risultato della ricerca in ambito scientifico dell’ultimo secolo e degli ultimi decenni.
Si tratta di teorie ampiamente condivise, per cui il matematico o il fisico possono appoggiarvisi
quand’anche vogliano discuterne da un punto di vista storico o concettuale con riferimento al loro
progresso e alle problematiche da cui sono interessate. Senza contare altri ambiti della scienza oltre
ai già detti, che hanno forti cadute applicative a livello tecnologico, per cui possono anche vantare
riferimenti alle tecniche. Non solo: ci sono riviste che convogliano questo sapere, e alle quali deve
fare di necessità riferimento il ricercatore nei casi specifici.
Cosa ha il filosofo? Niente di tutto questo: né teorie ampiamente condivise, né applicazioni
pratiche, né pubblicazioni che devono essere conosciute, alle quali con sicurezza occorra fare
riferimento. Al filosofo rimane questo atteggiamento di stupore, questo atteggiamento di chiedersi il
perché, di cercare di dare un senso, ma questo dovrebbe essere l’atteggiamento di ogni persona
curiosa ed interessata alla realtà. Allora, la filosofia non avrebbe un suo specifico. In effetti, questa
è un’immagine della filosofia che a volte viene convogliata e che potrebbe essere difficile
contrastare. Ammettendo di assegnare alla filosofia la qualifica di “sapere”, quale possibile rapporto
tra il sapere scientifico e il sapere filosofico si può trarre ad es. da una conoscenza anche
superficiale della storia del pensiero occidentale. Non entro nel merito di che cosa caratterizzi
l’ottica filosofica, ma cerco di ricavare qualche indicazione sui possibili rapporti fra sapere
scientifico e sapere filosofico. Se guardiamo alla storia della filosofia occidentale, a partire
dall’ambito culturale fertilissimo del mondo greco, ci rendiamo conto che, da quel contesto
culturale, col passare dei secoli, si sono poi staccati degli ambiti disciplinari specifici che,
inizialmente erano uniti. Pensate alle scuole di Aristotele e di Platone, in cui confluivano persone
con competenze di tipo diverso, non solo generalmente filosofico, ma anche matematico, botanico,
zoologico, storico. Tuttavia era la prospettiva filosofica il collante generale, anche se già Aristotele
operava distinzioni specifiche tra i diversi tipi di scienza e quel sapere fondante che chiamava
Filosofia Prima, e che poi s’è chiamato Metafisica. In seguito è successo che, da questo alveo
filosofico in cui confluivano problematiche relative al mondo della natura e dell’uomo, si sono poi
pian piano separati ambiti disciplinari che hanno, via via, specificato il loro universo di oggetti.
Una disciplina di tipo scientifico si specifica appunto quando dice di che cosa si occupa, da che
punto di vista, e con quali metodi. Sembrerebbe che la filosofia, da questo punto di vista, abbia
costituito qualcosa di simile ad un sapere pre-scientifico, dal quale, col passare del tempo e lo
specializzarsi della ricerca, si sono distaccate le diverse teorie scientifiche, a partire dalla
matematica, la geometria, la fisica, la chimica, fino ad arrivare alle scienze che più di recente hanno
cercato di dimostrare la loro scientificità, come la psicologia, la sociologia. Se è così, se la filosofia
costituisce questo tipo di sapere pre-scientifico, è meglio che non vi iscriviate a filosofia: la filosofia
sarebbe un tipo di sapere che va esaurendo le sue domande. Potrebbe esserci un’immediata reazione
a questo atteggiamento, ma se qualcuno di voi è interessato ad es. alla “filosofia della mente”, che è
una delle discipline che io insegno, può rendersi conto che su tale settore aleggia uno spirito di
questo genere, che tende a risolvere i grandi quesiti da lei posti attraverso altre discipline: per certi
versi da un tipo di psicologia adeguato (cognitiva, del pensiero, etc.), per altri versi da discipline
scientifiche più di base, come la neurofisiologia, per poi arrivare a discipline ancora più fondanti,
per arrivare sicuramente alla fisica. Questo atteggiamento di intendere la filosofia come sapere prescientifico è tutt’altro che abbandonato.
Un altro atteggiamento è quello che considera la filosofia in relazione alla scienza come sapere antiscientifico. La filosofia, in questa interpretazione, è vista come “qualcosa d’altro” rispetto alla
scienza. Essa ha a che fare con interpretazioni di testi, con problemi esistenziali degli esseri umani
calati nel mondo di senso comune, etc.. Non ci sarebbe dunque in questa prospettiva alcuna
cooperazione nella ricerca e nella conquista del sapere, ma una opposizione tra due strade
divergenti.
Sempre guardando alla storia del pensiero occidentale, possiamo poi vedere un altro tipo di
soluzione a questo difficile rapporto, ed è quello che potrebbe essere esemplificato dal neopositivismo logico dei primi decenni del secolo scorso, quello del Circolo di Vienna. Nel primo
momento entusiasta e giovanile del pensiero filosofico, la filosofia si è ancora proposta come
riflessione sulla conoscenza, e su quel tipo di conoscenza che ne rappresenta il paradigma, ed è la
conoscenza scientifica. Abbandoniamo quindi le ricerche di tipo metafisico e prendiamo in
considerazione l’effettivo procedere della conoscenza verso la verità, che è esemplificato dalle
diverse scienze. Allora, la filosofia diventa un sapere meta-scientifico, che riflette sul sapere della
scienza, e ovviamente riflette su di esso da un punto di vista particolare. Non rifletterà sugli oggetti
di indagine della scienza, dato che questo è l’obiettivo delle diverse scienze, ma sugli strumenti e
sul linguaggio con cui le diverse scienze studiano i propri rispettivi ambiti di oggetti. In questa
visione è stata rappresentata in parte una travolgente utopia in quel momento filosofico; ha poi
subito diverse sconfitte e, in ogni caso, adesso sembra una visione un po’ limitante della filosofia,
che sarebbe così un “commento”, una “metodologia” del linguaggio delle scienze.
A queste tre possibili visioni, io vorrei proporvi invece la visione di una filosofia come un vero e
propri ambito di sapere per sua natura diverso dal sapere delle scienze e con il quale tuttavia
intrattiene fruttuosi rapporti. Se la proposta di interpretare il rapporto tra sapere scientifico e
filosofico è di questo tipo, se è fondato proporre questa interpretazione, allora non ci aspettiamo di
vedere un progressivo diminuire e indebolirsi della ricerca filosofica, ma, al contrario, essa aumenta
i suoi problemi, raffina i suoi metodi, anche perché è in rapporto con il ricco ambito della ricerca
scientifica.
Questa è la mia possibile interpretazione nei diversi rapporti e la proposta di considerare la filosofia
come un vero tipo di sapere. In ogni caso, anche accettata sulla base di alcune evidenze storicoculturali questa quarta proposta, ci rimane il problema: ma quale tipo di sapere?
Non è scienza. Perché? Quando il prof. Zanghì ha specificato quale senso di incompletezza non
avesse in mente Einstein, ha parlato della incompletezza delle descrizioni scientifiche del mondo.
Questo vuol dire che ciascuna teoria scientifica problematizza, studia e cerca di spiegare il mondo –
inteso nel modo più generico possibile – da un particolare punto di vista, isolando certi aspetti dei
fenomeni, trascurandone completamente alcuni per concentrarsi su altri. Il successo della scienza è
dovuto anche proprio a questa opera di delimitazione dell’ottica, di precisazione di quali tipi di
oggetti sono quelli di cui si occupa una certa disciplina scientifica, di quali sono i predicati che
hanno valore dentro quella disciplina, di quali sono i metodi. Il sapere scientifico, dunque, si
autodelimita. Le teorie scientifiche sono saperi delimitati, incompleti da questo punto di vista. Il
loro successo, la loro profondità, deriva proprio dall’aver accettato l’incompletezza.
Ora, se ogni teoria scientifica è un sapere delimitato e rappresenta un punto di vista scientifico sulla
realtà, sorge un altro problema: un sapere delimitato da che cosa è delimitato, cosa sta sul suo
confine? Nulla? Pensate alla struttura della geometria euclidea, a come sono costruiti gli Elementi
di Euclide. Euclide - o chi ha sistematizzato la conoscenza geometrica dell’epoca - parte
dichiarando alcune proposizioni fondamentali (postulati) che devono essere accettate come vere di
per sé, autoevidenti, dando poi alcune definizioni che precisano gli oggetti di cui si occupa quella
teoria, aggiungendo infine delle “nozioni comuni”, tentativo di precisare che cosa è presupposto da
quella teoria. In epoca contemporanea, la geometria euclidea è stata rivista anche per cercare di
rendere esplicito tutto quanto in essa era rimasto ancora implicito. Quindi, una teoria scientifica
deve esplicitare i suoi punti di partenza, ma quando ha fatto ciò, rimane ancora qualcosa sulla quale
i suoi punti di partenza si fondano. Rimane qualcosa che sta al di fuori della teoria scientifica così
come è delimitata. Questo “al di fuori” può essere un insieme ad es. di presupposti pregiudiziali che
influenzano negativamente la stessa teoria scientifica: il prof. Zanghì ha fatto l’esempio della
meccanica quantistica e dei pregiudizi di tipo filosofico che hanno influenzato grandissimi
ricercatori tra cui Bohr, Heisenberg, etc.. Dunque, quando anche noi riusciamo a costituire un
ambito di sapere estremamente controllato come si fa in matematica e in fisica - le scienze che per
prime hanno guadagnato lo statuto di scientificità - qualcosa rimane al di fuori. Su quel qualcosa, su
quei pregiudizi o su quei presupposti di tipo concettuale l’occhio del filosofo dovrebbe intervenire.
Certo, il filosofo non è il “tuttologo”: questo è l’altro rischio, il rischio cioè di avere un entusiasmo
di tipo non critico per la ricerca, il rischio di andare a mettere il naso su contesti specialistici che
non padroneggia. È un rischio enorme, per cui anche il filosofo deve restringere la sua ottica, per
quanto l’attitudine filosofica sia radicata nell’uomo comune e prenda in esame qualunque problema
di natura conoscitiva o di natura pratica. L’altro problema è infatti che non esiste un ambito di
problemi specificamente filosofici, delimitati, mentre esiste un ambito di problemi, sia pure in
crescita, di tipo fisico, matematico, o chimico, specificatamente delimitati. I problemi filosofici
nascono in qualunque contesto, sia in quello della vita quotidiana, sia in contesti conoscitivi, legati
alle diverse scienze, sia in contesti applicativi, che spesso sono la “vita adulta” dell’avanzamento
della conoscenza scientifica. Il filosofo non ha niente di preciso, non ha specifici problemi, ma è
collegato a qualunque contesto, e tuttavia deve specificare e precisare la sua ottica. La precisa
utilizzando quella che è comune a tutti gli esseri umani, la sua capacità razionale, possibilmente
raffinandola al massimo livello, quella capacità razionale che la logica coglie in parte, di cui la
logica dice molto ma certamente non tutto.
Vorrei farvi un esempio al proposito di quanto ha detto prima il prof. Palladino: s’è parlato di
“ragionamento”. Di questo, la logica dice qualcosa di molto importante, ma non dice tutto. La
logica chiarisce determinati schemi formali che hanno la caratteristica di preservare la verità se le
premesse da cui si partono vengono interpretate in modo da essere vere. Quindi, la logica, seppure
nata in ambito filosofico, si è costituita come disciplina di tipo scientifico, perché prende in
considerazione un oggetto che appartiene al nostro mondo di senso comune, ragionamenti espressi
in un linguaggio. Su questi, egli punta un occhio che seleziona alcuni aspetti, così come, nel
riferimento a Galileo, alcuni aspetti vengono selezionati, altri trascurati. Quello che viene
selezionato dalla logica a proposito del ragionamento è la presenza di strutture formali in grado di
preservare la verità. Ma il ragionamento di senso comune è un oggetto composito, che richiede, per
essere compreso, più ottiche disciplinari. Giustamente qualcuno ha chiesto come avrebbe dovuto
ragionare Socrate per essere logico; la sua affermazione sembrava del tutto condivisibile: “Se sono
colpevole, devo essere punito”. A dir la verità Socrate non diceva proprio così: se pensate
all’Apologia, egli diceva qualcosa di molto rivoluzionario: “Io sono colpevole, è vero. Io ho
insegnato ai giovani questa cosa fondamentale: che la vita senza ricerca non è degna di essere
vissuta.”. Socrate si riconosceva colpevole di avere messo questo seme di dubbio contro qualunque
pregiudizio nella mente dei giovani. La punizione e la morte sono state accettate da Socrate come
conseguenza di questa sua “corruzione” del conformismo dei giovani.
Ma tornando all’esempio del prof. Palladino, la logica dice che questa inferenza è scorretta. Dal
punto di vista appunto strettamente logico, è sicuramente scorretta, perché viola le regole che
vincolano l’uso del “se…allora…” così come definito dalla tavola di verità del condizionale
materiale. Questo è un aspetto dello studio del ragionamento, che, nel caso specifico, fallisce nel
cogliere l’adeguatezza pragmatica di quella frase, che tutti comprendiamo e anche condividiamo.
Questo è un esempio di come oggetti che appartengono al nostro mondo di senso comune (qui, il
ragionamento) richiedono diverse ottiche disciplinari per essere studiate scientificamente, ma
richiedono un’ottica di senso comune, con la quale la filosofia ha diverse parentele, per essere
compresi nella loro complessità, per comprendere che quella frase è adeguata pragmaticamente ad
un determinato scambio dialogico, e che in quel caso l’ottica logica, che pur giustamente nota la
violazione della tavola di verità, è un’ottica parziale. Questo è dunque un esempio di come l’ottica
scientifica può essere incompleta e parziale, mentre l’ottica filosofica si proponga invece come
un’ottica di maggiore apertura, che in qualche modo faccia riferimento anche al mondo di senso
comune, al ragionamento di senso comune in cui gli esseri umani sono immersi. Questo vuol dire
anche un’altra cosa, che la filosofia di permette anche di problematizzare non solo ciò che è
estremamente sofisticato, come ad es. i possibili presupposti di una teoria come la meccanica
quantistica. La filosofia si permette anche di problematizzare ciò che è ovvio e scontato a livello di
senso comune, ciò che sta davanti a tutti e che non viene detto, che nel momento in cui viene detto
sorprende, perché è ovvio. Per quanto riguarda ad es. l’ambito logico, giustamente il prof.Palladino
ha detto che la logica e i suoi contenuti non devono essere considerati innati; la logica si apprende.
È vero: la logica si apprende e mai ne ho avuto conferma come quando ho fatto una piccola
sperimentazione didattica, proponendo agli studenti la risposta ad un insieme di quesiti di tipo
logico, riguardo ad un test di autovalutazione della facoltà di ingegneria. I miei studenti hanno
risposto rapidissimamente a domande di tipo più o meno logico fintanto che esse non hanno toccato
problemi di natura proposizionale, legata cioè ai connettivi del linguaggio logico. Improvvisamente,
quasi tutti hanno alzato la testa e mi hanno detto: “Ma dobbiamo rispondere come se non avessimo
seguito il corso del prof. Palladino o come se l’avessimo seguito?”. È una domanda veramente
sorprendente, perché c’è proprio una biforcazione: da un lato il rispondere in base a regole apprese,
dall’altro in base al senso comune.
Tuttavia, l’ottica filosofica, anche nell’ambito della logica intesa come disciplina appresa, si rende
conto che ci sono alcuni principi fondamentali della logica che sembrano stare alla base della stessa
elaborazione logica. Aristotele aveva già fatto questo, anche se oggi la cosa viene messa in
discussione. Ad es., il principio di non contraddizione voi sapete che è stato ritenuto da Aristotele il
primo di tutti i principi, fondante qualunque discorso, tale che lo stagirita non lo dimostra, né
potrebbe perché è un principio e non un teorema, ma lo sostiene per confutazione, attraverso una
dimostrazione per “elenchos”. Dice: “Tu che vuoi confutarlo, di’ qualcosa. Nel mentre che tu
esprimi qualunque proposizione, vedrai, lo stai presupponendo.”. A proposito della logica, la
filosofia esamina quali tipi di grandi principi, se ci sono, sono tali da essere presupposti dalla stessa
teoria logica. Questo è un altro esempio di un intervento di tipo filosofico a proposito di una
disciplina che io ritegno di natura scientifica.
Un altro modo per capire come si qualifica il sapere filosofico in relazione al sapere scientifico è
vederne il rapporto con le rispettive storie. Voi sapete che la filosofia è stata insegnata, soprattutto
in Italia, nella sua forma storica. Desso si cerca di sperimentare una forma diversa di insegnamento
della filosofia, e non è assolutamente facile. I riferimenti di tipo storico sono inevitabili e spesso
necessari, perché mostrano il trasformarsi di un concetto (ad es. l’infinito) nel corso del tempo.
La scienza sembra avere invece un rapporto molto diverso con la propria storia, anche se il prof.
Zanghì ha sottolineato l’importanza, per comprendere i problemi di Einstein, del riferimento al
contesto immediatamente precedente o compresente la sua disciplina. In generale, comunque,è
sufficiente aprire un manuale di matematica, fisica o chimica: non si parte dalla considerazione
dello sviluppo storico della disciplina, anche se riferimenti di questo tipo sono di grandissimo aiuto.
Per contro, aprire un ipotetico manuale di qualunque ambito della filosofia senza riferimenti storici
è impossibile, credo non ne esistano di tal fatta, e non so nemmeno bene come potrebbero essere
costruiti. Pertanto, anche il diverso rapporto di scienza e filosofia con la propria storia è un altro
aspetto che potrebbe essere considerato nel cercare di capire qual è l’ottica filosofica, come si regge
e come può resistere a tentativi riduzionismi estremamente potenti nell’ambito, ad esempio, della
filosofia della mente.
SALUTO del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, dott. Attilio Massara
Discussione col pubblico.
POMERIGGIO: Incontro del Gruppo dei docenti e degli studenti afferenti al Polo di Filosofia
Introduzione della prof.ssa Giosiana Carrara – docente e Segretaria alle relazioni del Centro
Territoriale di Didattica di Filosofia della Provincia di Savona
Presentazione del gruppo dell’Istituto Superiore Secondario “Alberti - Da Vinci” di Savona.
Ci siamo proposti di realizzare un lavoro che metta in relazione la matematica e l’architettura
attraverso la filosofia, anche se questa non è una nostra materia di studio. Durante lo svolgimento di
questo lavoro, abbiamo preso in considerazione Leon Battista Alberti, leggendo alcuni passi del
“De pictura” e del “De re aedificatoria”, che qui presentiamo. Abbiamo consultato anche un testo di
storia dell’arte ed un testo critico di B.Zevi. Nell’affrontare questo lavoro ci siamo posti alcune
domande:
- che rapporto c’è fra il sapere tecnico e gli altri saperi?
- esiste una vera diversificazione?
Per trovare una risposta abbiamo scelto appunto Alberti, considerato il primo artista in senso
moderno. Affermava infatti: “…piacemi il pittore sia dotto, in quanto e’ possa in tutte le arti
liberali, ma in prima desidero sappi geometria…”, ovvero occorre indagare sulle origini delle arti
per trovare i principi che le regolano. Per questo è necessario che l’architetto abbia una formazione
completa teorico-pratica, che conosca le arti liberali, che sia stato educato ad esse, e soprattutto che
conosca la geometria, cioè la scienza dello spazio.
Alberti, inoltre, rivalutò il lavoro dell’architetto, inquadrandolo in una prospettiva più vasta, cioè
indagare il mondo. A questo proposito sosteneva di “indagare sulle origini delle arti, sui principi
onde furono tratte, sui mezzi coi quali si accrebbero”. Questo è il compito dell’architetto. Infatti, a
differenza dei capimastri medievali, formatisi per tirocinio diretto, Alberti presenta una concezione
nuova dell’architettura derivata in parte da Vitruvio. L’architettura è per Alberti una scienza nella
quale si fondono la conoscenza teorica, ovvero la componente ideale, e quella pratica, derivata
dall’esperienza. Per questo la progettazione è un processo che implica la conoscenza dell’uomo e
del rapporto che lo lega alla natura. Infatti afferma: “dagli oggetti nei quali la natura ha dato di sé
cospicue prove ricaveremo le leggi della delimitazione”. L’architetto opera nello spazio, che deve
essere organizzato attraverso la conoscenza e la progettazione. Questa concezione di spazio non si
ha solo all’interno dell’edificio, poiché questo è visto non più solo come singola struttura, ma
comincia ad essere considerato nel contesto particolare in cui verrà inserito. L’esempio più calzante
è quello della piazza di Pienza. La sua particolarità sta nella disposizione degli edifici, disposti in
modo da poter avere una visione completa di tute le facciate.
Nel disegno l’uomo esplica la sua attività di soggetto conoscente, e, di conseguenza, il pittore come
l’architetto non possono ignorare come l’uomo conosce. Per Alberti, infatti, l’occhio è il vertice
della piramide visiva che si forma tra oggetto e soggetto, e il disegno non è altro che il piano di
intersezione tra la superficie rappresentata e questa piramide. Di conseguenza la rappresentazione
dev’essere prospettica e la prospettiva è centrale. Abbiamo scelto di analizzare “La flagellazione di
Cristo” di Piero della Francesca perché qui si vede molto bene la prospettiva inserita nel quadro.
Vediamo che il quadro viene studiato in pianta. La scena centrale è la flagellazione che si trova n el
punto di fuga, mentre in primo piano si trovano i tre committenti del quadro. Vediamo ancora
inseriti gli elementi architettonici che fino ad allora non erano presenti nelle opere.
In questo periodo viene anche studiata lo sviluppo delle città ideali, basate su di un numero
prefissato di abitanti e di funzioni, cioè città senza storia dove l’elemento temporale è assente. Sono
città prive di sviluppo, per certi aspetti sacre, “ieratiche”.
A questo punto è necessario dire che l’ideale è sicuramente ciò che l’Alberti si prefigge come
finalità, come altri artisti del Cinquecento. Questa ricerca della dimensione estetica è molto
importante. Le opere architettoniche vengono viste differentemente da prima: iniziano ad essere
progettate a misura dell’uomo.
Per quanto riguarda il rapporto tra architettura e matematica, è necessario citare la chiesa di
Sant’Andrea in Mantova, dove si può notare grande alternanza di volumi nella pianta, con
composizione modulare (Argan) secondo il modulo del quadrato. Tutta la struttura in effetti è
impostata sull’antitesi tra quadrati, pieni e vuoti. Anche nella facciata si riprendono le figure
geometriche principali: cerchio, triangolo, quadrato. Le nicchie conferiscono un senso di
leggerezza, senza nulla togliere alla maestà della struttura.
Progettato da Alberti abbiamo ancora il Palazzo Rucellai a Firenze. Si può notare sulla facciata una
certa ritmicità: dal basso verso l’alto, abbiamo un bugnato molto grezzo, e, man mano che si sale, la
decorazione si raffina per alleggerire la struttura. Inoltre, è da notare anche la suddivisione della
verticalità: le finestre mantengono sempre lo stesso ritmo.
Ancora è da sottolineare come per Alberti la venustas, la bellezza, sia da ricercare soltanto nella
natura. La bellezza è intesa come “armonia tra forma e struttura”, ed è qui che entra in gioco
l’architettura vera e propria. La chiesa di San Sebastiano è a croce greca inserita in un quadrato, al
fine del “coordinamento dei volumi e dei vuoti” (Argan).
Altro esempio è Santa Maria Novella in Firenze, dove l’Alberti elabora il tema romanico secondo i
principi dedotti da Vitruvio della composizione modulare, assumendo come modulo compositivo il
quadrato, perché, come spiegato nel trattato, “le forme geometriche, con la loro verità, sollecitano a
meditare sulla verità della fede”.
A questo punto, bisogna ritornare alla matematica, perché l’architettura lì affonda le proprie radici.
L’artista, infatti, aspira alla perfezione e quindi deve conoscere le leggi del reale. Da un punto di
vista matematico, la perfezione divina può essere intesa come perfezione geometrica, e in questo
senso c’è un recupero della struttura antica della Chiesa. Al proposito, Alberti sostiene: “piglieremo
da matematici quelle cose che alla nostra materia appartengono…perché vogliamo le cose essere
poste da vedere”, non quindi per astrarre dal reale i concetti. La matematica è “irrelata alla natura,
quasi per miracoloso collegamento”: ricordiamo la serie matematica di Fibonacci, che ora non viene
più intesa come gioco logico, ma costituisce un modello di interpretazione della natura. In questo
periodo vengono infatti scoperte piante la crescita delle cui foglie segue la serie di Fibonacci.
Un’altra dimostrazione del collegamento tra matematica e natura è la conchiglia del Nautilus che si
sviluppa a spirale, seguendo proprio la serie suddetta.
Tornando sui passi di prima, abbiamo in questa figura rappresentato il tempio malatestiano di
Rimini: vi si trova sempre il rispetto delle proporzioni, la leggerezza dell’edificio, pur incompleto,
permangono il triangolo, il cerchio e il quadrato. Qui, Alberti interpreta la facciata come organismo
plastico articolato, non accontentandosi di proiettare semplicemente lo spazio, ma sentendolo come
realtà fisica di luce, penombra, atmosfera e colore. Tuttavia, l’edificio rimane pur sempre un
oggetto, anche se è oggetto ideale ed assoluto, che esprime una concezione del mondo come natura
e come storia.
Natura e architettura per Alberti devono essere messe in relazione senza danno per la natura, la
quale in futuro, prima o poi, riuscirà a recuperare lo spazio sottrattole.
Presentazione del gruppo del Liceo Scientifico “O.Grassi” di Savona:
“Evoluzionismo e fissismo, due paradigmi a confronto” – un percorso di protagonisti
Anassimandro può essere considerato il primo “evoluzionista” ante litteram: pochi sanno infatti di
come la sua opera non s’incentrasse unicamente sulla cosmologia, ma, come sappiamo da un
frammento riportato da Simplicio (l’unico autentico) e da altri riferiti ad Anassimandro, ma
d’incerta collocazione, si interessava anche di altri aspetti relativi alla nascita dell’uomo e degli
organismi in generale sul nostro pianeta. È importante ricordare l’espressione che troviamo nel
frammento di Simplicio “secondo necessità”. Da un punto di vista scientifico, essa può essere
interpretata come un accenno al concetto di legge naturale.
Significativo per il nostro discorso è la testimonianza di Censorino (IV, 7):
“Anassimandro di Mileto pensa che dall’acqua e dalla terra, sotto l’azione del calore, siano nati
pesci o animali molto simili ai pesci, nel cui interno sarebbero cresciuti gli uomini, rimanendovi
rinchiusi come dei feti fino all’epoca della pubertà; allora, rotto l’involucro, ne sarebbero usciti
uomini e donne già capaci di nutrirsi.”
È importante perché abbiamo un riferimento all’acqua, dove si dimostra l’influenza del suo
maestro, Talete, ma soprattutto perché c’è un accenno all’idea di evoluzione, cioè l’idea di animali
diversi dall’uomo al cui interno sarebbero nati e cresciuti gli uomini.
Altra testimonianza significativa è quella di Ippolito (Confutazione delle eresie, I, 6, 3):
“Gli animali hanno avuto origine dall’umidità che il sole fa evaporare. L’uomo deriva da un
animale diverso da lui e cioè da un pesce o da qualcosa che agli inizi gli assomigliava.”
Anche qui abbiamo il riferimento al fatto che gli animali siano derivati da altri organismi che un
tempo vivevano in acqua.
Cuvier elabora una nuova teoria, la teoria del catastrofismo o teoria dei cataclismi (1815), messa a
punto per spiegare i cambiamenti verificatisi nella fauna e nella flora della terra nel corso della sua
storia naturale, senza far ricorso a teorie evoluzionistiche. Cuvier infatti, pur essendo gran
conoscitore dei fossili, non accetterà mai le teorie evolutive, ma si ricollegherà ad un atradizione
fissista, come quella di Linneo. Elaborò la teoria in base alla quale Dio avrebbe creato un numero di
specie superiore a quelle viventi, che si sarebbero ridotte in seguito a catastrofi naturali quali
inondazioni, terremoti ed eruzioni vulcaniche. Queste avrebbero distrutto gli esseri viventi di una
regione che sarebbe poi stata ripopolata in seguito dalle specie provenienti dalle aree geografiche
circostanti. Fra le grandi catastrofi, riteneva che l’ultima fosse il diluvio universale, il cui ricordo
ancora si conservava. La sua teoria nasce dall’osservazione di strati geologici francesi dove notò un
massiccio avanzamento del mare, convincendosi di poter generalizzare questo fenomeno.
Combatté aspramente il lamarckismo.
Darwin e il neo-darwinismo si pongono a cavallo tra necessità e contingenza, nel considerare
l’interazione tra l’ambiente che seleziona negativamente i caratteri svantaggiosi e l’individuo con i
suoi tratti ereditari. È significativa una citazione dall’“Origine della specie” del 1859:
“Non vi è certamente cosa che si possa ammettere più difficilmente di quella che gli organismi e gli
istinti più complessi non siano stati perfezionati con mezzi che sono superiori alla ragione
dell’uomo, sebbene analoghi alla medesima, ma invece mediante l’accumulazione di piccole
variazioni, ciascuna delle quali sia proficua all’individuo che la possiede.”
Bisogna assolutamente porre l’attenzione su due termini importanti:
- il modo in cui Darwin tratta di Dio, ovvero “mezzi che sono superiori alla ragione
dell’uomo”: elemento laico molto accentuato;
-
l’evoluzione realizzata attraverso “l’accumulazione di piccole mutazioni casuali ciascuna
delle quali sia proficua all’individuo stesso”, dove la proficuità è decretata proprio
dall’ambiente.
Con l’avvento della genetica, ovvero di quella branca della biologia che studia la generazione degli
organismi e la trasmissione dei caratteri ereditari, la prospettiva darwiniana cambia. Da ricordare la
figura di Mendel, che dimostra come il carattere ereditario sia trasmesso come unità distinta dalle
altre, da lui chiamata “elementum”. Le intuizioni geniali di Darwin, prive di alcuni elementi
basilari, furono colmate in molta parte da Mendel. Egli non era in grado infatti di dimostrare né
l’origine delle variazioni né il modo in cui esse venivano trasmesse alle generazioni successive.
L’unione della teoria darwiniana della selezione naturale e dei principi, delle leggi, di Mendel,
diedero origine alla nuova teoria del neo-darwinismo. Questo parla di una evoluzione continua e
graduale, ovvero di mutazioni repentine delle frequenze alleliche che però si manifestano in modo
graduale con l’affermazione di nuove specie.
Per finire, vogliamo citare alcuni scienziati che hanno contribuito alla diffusione del neodarwinismo, R. Fisher e S. Wright, e così il fondamentale apporto di J.B.S. Haldane, che nel 1918
dimostrò matematicamente come i caratteri genetici contribuivano regolando l’evoluzione secondo
l’andamento della curva di Gauss.
L’esito ultimo delle teorie evoluzioniste hanno portato allo sviluppo dell’embrionologia.
Presentazione dei gruppi del Liceo Classico “G.Chiabrera” di Savona.
“Questa misura mi appartiene”
Il titolo del progetto si ispira alla frase del delegato della Repubblica ligure Antonio Musedo alla
conferenza dei Pesi e delle Misure di Parigi del 1792, e consiste in un’analisi dei piani della
razionalità nell’ambito della dialettica metrologica, ovvero del modo in cui l’uomo, nel corso della
sua storia, dall’età della mezzaluna fertile fino all’800, ha utilizzato e manipolato il concetto di
misura, che fossero pesi, prodotti della terra oppure semplicemente di misure.
Gli aspetti analizzati sono stati differenti: l’aspetto storico, didattico, antropico, razionale.
Ci siamo basati su diversi testi, tra cui Vitolsk Kula, “Le misure di uomini dall’antichità ad oggi”, e
lo studio dei testi ci ha portato alla lettura dei più disparati documenti storici: dai “Cahiers de
doléances” alle leggi Siccardi degli anni ’50 del XIX secolo.
Le attività che abbiamo svolto, da un punto di vista didattico, hanno preso le mosse da una serie di
lezioni che ci hanno fornito le conoscenze di base sull’argomento, cercando di evidenziare in
seguito l’aspetto filosofico del discorso sulla metrologia. S’è fatto inoltre largo uso del portale
telematico che voi tutti potete visitare all’indirizzo http:// laboratoriofilosofico.objectis.net che
accoglie tutti i nostri lavori, aggiornati settimanalmente.
I totalitarismi come forma di linguaggio estremo
Il progetto ha coinvolto la filosofia, la matematica ma anche le lingue classiche, a partire dai testi
aristotelici, per individuare linguisticamente le diverse problematiche inerenti il linguaggio e la
manifestazione del totalitarismo. Quest’ultimo ne è uscito fuori soprattutto come manifestazione
della violenza della Ragione, dell’uso della Ratio forte. Per far questo, ci siamo avvalsi della lettura
dei saggi di Adorno e Lyotard. L’asse portante è stato quello della filosofia analitica e dell’indagare
sulla cesura di un processo che da un lato mira ad una libertà vissuta dal singolo (esistenzialismo),
e, dall’altro, si configura invece come omologazione e standardizzazione. La nostra attenzione è
stata in particolar modo quella di riflettere sull’uso dello scenario espressivo che si dà attraverso il
mezzo di espressione, e la crisi che ne consegue quando il mezzo si “inceppa”. L’oggetto di studio
con principale riscontro nel presente è stata infine l’incapacità della tecnologia di fornire
un’effettiva libertà, e la ricerca di una sua diversa codificazione.