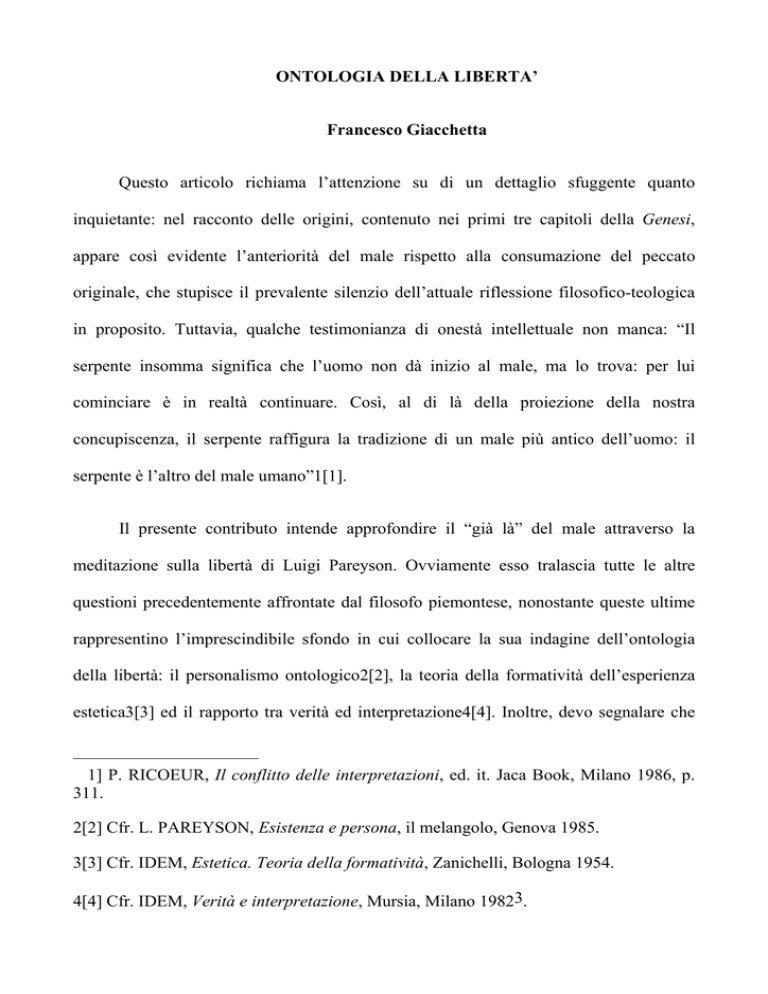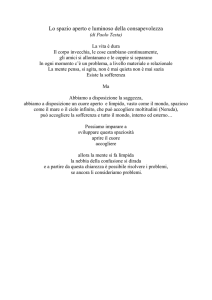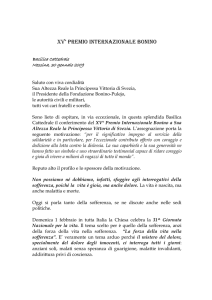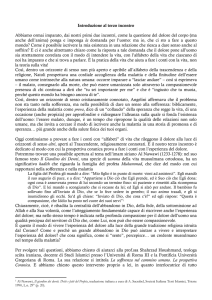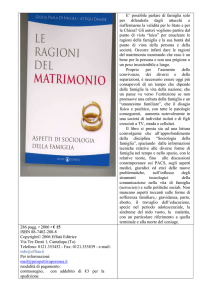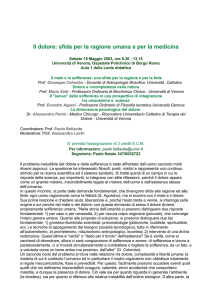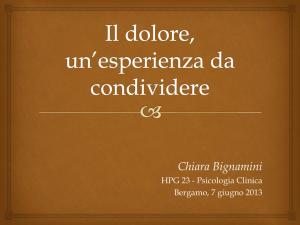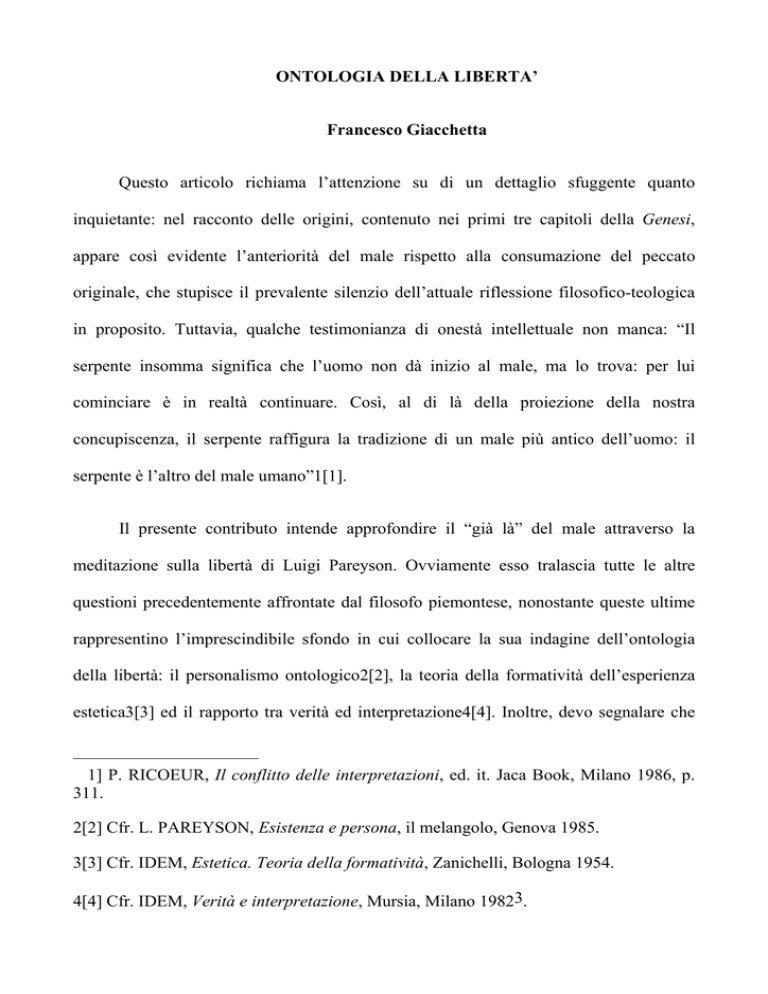
ONTOLOGIA DELLA LIBERTA’
Francesco Giacchetta
Questo articolo richiama l’attenzione su di un dettaglio sfuggente quanto
inquietante: nel racconto delle origini, contenuto nei primi tre capitoli della Genesi,
appare così evidente l’anteriorità del male rispetto alla consumazione del peccato
originale, che stupisce il prevalente silenzio dell’attuale riflessione filosofico-teologica
in proposito. Tuttavia, qualche testimonianza di onestà intellettuale non manca: “Il
serpente insomma significa che l’uomo non dà inizio al male, ma lo trova: per lui
cominciare è in realtà continuare. Così, al di là della proiezione della nostra
concupiscenza, il serpente raffigura la tradizione di un male più antico dell’uomo: il
serpente è l’altro del male umano”1[1].
Il presente contributo intende approfondire il “già là” del male attraverso la
meditazione sulla libertà di Luigi Pareyson. Ovviamente esso tralascia tutte le altre
questioni precedentemente affrontate dal filosofo piemontese, nonostante queste ultime
rappresentino l’imprescindibile sfondo in cui collocare la sua indagine dell’ontologia
della libertà: il personalismo ontologico2[2], la teoria della formatività dell’esperienza
estetica3[3] ed il rapporto tra verità ed interpretazione4[4]. Inoltre, devo segnalare che
1[1] P. RICOEUR, Il conflitto delle interpretazioni, ed. it. Jaca Book, Milano 1986, p.
311.
2[2] Cfr. L. PAREYSON, Esistenza e persona, il melangolo, Genova 1985.
3[3] Cfr. IDEM, Estetica. Teoria della formatività, Zanichelli, Bologna 1954.
4[4] Cfr. IDEM, Verità e interpretazione, Mursia, Milano 19823.
qui non si accennerà neppure alla proposta pareysoniana di una filosofia della religione
intesa come ermeneutica filosofica dell’esperienza religiosa che, pure, darebbe un
importante riferimento di cornice5[5].
In definitiva, questa indagine, dopo aver brevemente accostato la difficile
questione interpretativa del rapporto tra essere e libertà in Pareyson nel corso
dell’evoluzione del suo pensiero, intende presentare, in modo critico, le linee portanti di
quel “discorso temerario” che è il “male in Dio” e che si affaccia inevitabilmente,
seppure modulato in forme differenti, ogni qualvolta si tenti di pensare, in maniera
radicale, la libertà.
1.
Il “già là” del male
Siamo abituati a parlare del male nei termini di mysterium iniquitatis. Tuttavia
non può sfuggire che spesso il male è, piuttosto che mistero, ripetitivo meccanismo,
carenza di riflessione o di umanità, banalità6[6]. La storia del male è monotona,
5[5] Cfr. IDEM, “Filosofia ed esperienza religiosa”, Annuario filosofico, 1 (1985), pp. 7
– 52, ora in IDEM, Ontologia della libertà. Il male e la sofferenza, Einaudi, Torino
1995, pp. 85 – 149. Per un’analisi complessiva di questo tema cfr. G. FERRETTI (a cura
di), Filosofia ed esperienza religiosa: a partire da Luigi Pareyson, Università degli studi
di Macerata, Macerata 1995. Invece, per un’estesa nota bibliografica rinvio a F.
TOMATIS, Bibliografia pareysoniana, Trauben Edizioni – Centro Studi Filosoficoreligiosi Luigi Pareyson, Torino 1988.
6[6] Cfr. H. ARENDT, La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme, ed. it.
Feltrinelli, Milano 1998.
incapace di originalità: gli aguzzini agiscono sempre allo stesso modo e lo sforzo della
scienza di immunizzarci dalle malattie e di pronosticare le catastrofi naturali ci segnala
la possibile prevedibilità del male. C’è un punto, però, in cui quest’ultimo si presenta
intollerante alla comprensione del pensiero, un punto che, forse e solo in un certo senso,
può ancora legittimare la considerazione del male come mistero: l’affacciarsi del male
all’origine. Il male mai apparve con tutta la sua inquietante impenetrabilità come la
prima volta in cui si è mostrato; esso, segnalandosi fin dall’origine così radicalmente
contrario verso ogni ragione di vita, si è davvero dichiarato oscuro e tenebroso: “per noi,
non c’è alcuna causa comprensibile dalla quale il male morale possa per la prima volta
essere venuto in noi”7[7]. Se il male può ancora essere un mistero non è certo nel senso
di una sua presuntuosa quanto inesauribile grandezza – quale fasto può riservare il male?
- ma per il suo testardo rifiuto del logos, per la sua irrazionale ed ostinata stupidità, per la
sua ingiustificabile intolleranza verso ogni positivo. L’inizio del male non è
semplicemente assenza di ragione, ma pervicace contrarietà verso ogni verità. Per
questo le teodicee sono fallimentari: non ci sono ragioni per il male perché il male è
contro la ragione. Il male non si comprende, ma lo si estirpa, lo si assume affinché la sua
virulenza trovi nel perdono e nella speranza l’atteso spegnimento8[8].
7[7] I. KANT, La religione nei limiti della semplice ragione, in G. RICONDA (a cura
di), Scritti di filosofia della religione, Mursia, Milano 1986, p. 96 (corsivo mio).
8[8] Cfr. A. GESCHÉ, Dio per pensare. 1. Il male, ed. it. San Paolo, Cinisello Balsamo
1998.
“Nemmeno Gesù Cristo – che del resto, kierkegaardianamente parlando, non era
un presidente di accademia delle scienze – ha preteso di fornire una spiegazione o
comprensione del male; si è limitato, per così dire, a riscattarlo, e l’ha fatto con le
proprie sofferenze, prendendo su di sé i peccati dell’umanità. L’unico senso in cui si può
dire ch’egli dà una risposta al problema del male, è che egli è, lui stesso, questa
risposta”9[9].
Certamente, con Agostino, si può sostenere che il male è senz’altro privazione,
erosione del bene; ma, più ancora, si può dire che esso è essere contro, efficiente
opposizione al buono, alla ragione, alla vita. Proprio per questo esso non potrà mai
essere simmetrico al bene: il male necessita, per la propria esistenza, di una positività da
annullare e palesa, così, la propria eterna dipendenza e l’impossibilità di sussistere da sé;
il male può solo rinnegare il bene, ma mai negarlo veramente e definitivamente
sostituendosi come polo alternativo10[10]. Quando dal male ci si volge al malvagio,
allora il pensiero, che vuole raggiungere l’inizio della storia dell’iniquità, non sa
capacitarsi di come, da una creazione dove tutto era “buono/bello” o “molto
buono/bello”, possa essere spuntato il fiore perverso11[11]. La domanda “unde malum?”
9[9] L. PAREYSON, “La filosofia e il problema del male”, Annuario filosofico, 2, 1986,
p. 10, ora anche in IDEM, Ontologia della libertà, op. cit.
10[10] Solo se si mantiene all’orizzonte questa particolare inconsistenza del male, allora
diviene intelligibile la paradossale affermazione: “Si malum est, Deus est” (S.
TOMMASO D’AQUINO, Contra Gentiles, 1, III, c. 71).
11[11] Anche in Agostino si riscontra una debole traccia di distinzione tra male e
malvagio; quest’ultimo non è solamente assenza di bene, ma perversione della volontà
ed efficace rifiuto del positivo. “Chi mi ha creato? Il mio Dio, vero? Che non è soltanto
buono, ma la bontà in persona. Da chi mi viene dunque il consenso che do al male e il
rifiuto che oppongo al bene? Accade così per farmi scontare giusti castighi? Ma chi ha
piantato e innestato in me questo, virgulto d’infelicità, se sono integralmente opera del
porta con sé lo smarrimento che nasce dall’incomprensibilità del male nel suo apparire,
nel suo evidenziarsi a partire da un panorama completamente e assolutamente innocente.
“Dietro la scelta disobbediente dei nostri progenitori c’è una voce seduttrice, che
si oppone a Dio, la quale, per invidia, li fa cadere nella morte. La Scrittura e la
Tradizione della Chiesa vedono in questo essere un angelo caduto, chiamato Satana o
diavolo. La Chiesa insegna che all’inizio era un angelo buono, creato da Dio. ‘Diabolus
enim et alii daemones a Deo quidem natura creati sunt boni, sed ipsi per se facti sunt
mali – Il diavolo infatti e gli altri demoni sono stati creati da Dio naturalmente buoni, ma
da se stessi si sono trasformati in malvagi”12[12].
“Da se stessi”; è qui che può ancora aver senso il parlare di mistero del male. Si
dirà che la libertà dell’angelo da sempre include la possibilità della perversione, ma con
ciò non si fa altro che sostenere che il male, sebbene come semplice e mera possibilità,
sia già presente nel creato. Barth, intuendo la pazzia di voler pensare quell’abisso,
sosteneva che solo una teologia spezzata, vale a dire un pensiero di Dio che abbia
rinunciato alla totalizzazione sistematica, possa impegnarsi nell’ardua impresa di
mio dolcissimo Dio? E se fossi creatura del diavolo donde viene a sua volta il diavolo?
Se anch’egli diventò diavolo, da angelo buono che era, per un atto di volontà perversa,
questa volontà maligna che doveva renderlo diavolo donde entrò anche in lui, fatto
integralmente angelo da un creatore buono?” (S. AGOSTINO, Confessioni, VII, 3).
“Ricercando poi l’essenza della malvagità, trovai che non è una sostanza, ma la
perversione della volontà, la quale si distoglie dalla sostanza suprema, cioè da te, Dio,
per volgersi alle cose più basse, e, ributtando le sue interiora, si gonfia esternamente”
(cfr. Ibidem, VII, 16).
12[12] Catechismo della Chiesa cattolica, n. 391.
pensare il male13[13]. L’Antico Testamento ci lascia una debole ma inquietante traccia
di un male “già là”14[14], precedente il peccato originale e lo stesso angelo tentatore:
l’albero della conoscenza del bene e del male15[15]. Esso è lì, prima ancora che i nostri
progenitori peccassero, prima ancora che il serpente seduttore comparisse.
A mio avviso, accostare Pareyson, dopo aver posto in tutta la sua viscosità
l’inquietante mistero del male, può pungolare la ragione a non adagiarsi sui rassicuranti
quanto illusori luoghi comuni, a non considerare una strada lastricata dall’abitudine
l’orizzonte definitivo; in conclusione, a pensare filosoficamente. Egli, testimoniando
fino in fondo un’onestà intellettuale che caratterizza chi filosofa per vocazione, arrischia
un “discorso temerario”: il male in Dio.
2. Essere e libertà nell’itinerario di pensiero di Pareyson
13[13] Cfr. K. BARTH, Dogmatique, vol. III/III, ed. francese Labor et Fides, Genève
1963, § 50.
14[14] P. DE BENEDETTI, In margine a Ricoeur. Sul male dopo Auschwitz, in P.
RICOEUR, Il male. Una sfida alla filosofia e alla teologia, Morcelliana, Brescia 1993,
p. 63.
15[15] Cfr. Gn. 2, 17.
Fin dagli inizi del suo pensiero, alla fine degli anni trenta, Pareyson ha avvertito la
centralità del problema della libertà presentandolo come tema lasciatoci in eredità
dall’esistenzialismo. Nei primi scritti egli collega l’appello del valore con la libertà per
cui “l’assenza di norma sopprime la libertà”16[16]: l’esigenza che si concretizza nella
prescrizione sostanzia la stessa libera iniziativa. Tuttavia quest’ultima cela un’intima
contraddittorietà.
“L’iniziativa si svela come intimamente contraddittoria. Infatti essa, se è esigenza,
è insufficienza. Tende alla realizzazione perché manca della realtà. Cerca perché manca:
è ricerca perché è manchevolezza. Ma se è insufficienza, come può essere decisione,
cioè costituzione di validità? L’iniziativa è dover far valere. Se io debbo far valere, ciò è
perché non valgo. Ma se non valgo, come posso far valere?”17[17].
La fenomenologia dell’iniziativa deve cedere il passo ad un’ontologia della
libertà. In un primo tempo la libertà è presentata come “insopprimibile vocazione
ontologica”
e
“testimonianza
resa
all’essere”18[18]:
“essere
e
libertà
sono
inscindibili”19[19]. La positività originaria dell’essere è attestata anche quando si attua
come decisione contro l’essere: la rivolta della libertà contro l’essere è pur sempre un
atto dell’essere della libertà. Qui si dà lo sconcertante fatto di una libertà “che si afferma
16[16] L. PAREYSON, L’iniziativa morale, Giappichelli, Torino 1969, p. 69.
17[17] IDEM, Esistenza e persona, op. cit., p. 166.
18[18] IDEM, Essere e libertà, Giappichelli, Torino 1970, p. 27.
19[19] Ibidem, p. 41.
anche quando si nega, e che può negarsi solo affermandosi”20[20], cosicché si può dire
che la libertà è costituita dalla possibilità di negarsi21[21].
L’inseparabilità di essere e libertà trova la sua successiva esplicitazione in una
reciproca convertibilità, senza confusione, dei due poli.
“La libertà è stimolata e sorretta dall’essere nell’atto stesso in cui l’essere le si
consegna e affida; anzi, il fatto che l’essere stesso si affida alla libertà mostra che la
libertà è stimolata e sorretta dall’essere (…) Tanto la libertà è legata all’essere, ch’essa
lo afferma anche quando lo rinnega, nell’atto con cui essa, tradendo l’essere, distrugge
se stessa: il fatto che la libertà può negarsi solo affermandosi, cioè può distruggersi solo
con un atto di libertà, attesta che la libertà può esercitarsi solo in presenza dell’essere, sia
che si confermi affermandolo, sia che si neghi rinnegandolo.
E se la libertà distrugge se stessa proprio con un atto con cui si esercita, sia pure
per negarsi, cioè con un atto con cui attesta l’essere proprio in quanto lo tradisce, ciò è
perché l’essere stesso è libertà (…) Se la libertà non è tale senza l’essere, anche l’essere
non è tale senza libertà (…) Solo la libertà precede e può precedere la libertà, e quindi
l’essere stesso è libertà; ed è per questo che ciò che sta all’origine della libertà, cioè
l’essere stesso come libertà, non solo non limita, ma anzi slancia e stimola la libertà, e la
sorregge solo nel senso che la slancia. Sostenere che l’essere stesso è libertà è cosa ben
diversa che abbandonare l’essere alla libertà: abbandonare l’essere alla libertà significa
abbandonare la libertà a se stessa, e quindi votarla all’autodistruzione; sostenere che
l’essere è libertà significa invece approfondire il principio dell’inseparabilità di essere e
libertà, per cui la libertà non è tale senza l’essere e l’essere non è tale senza libertà, nel
senso che solo la libertà precede la libertà.
20[20] Ibidem, p. 37.
21[21] Cfr. IDEM, Esistenza e persona, op. cit., p. 32 - 37.
Nella loro suprema inseparabilità i due termini si convertono, e al culmine l’essere
stesso è libertà e la libertà stessa è essere, in una chiara e decisa convertibilità, non in
una confusione imprecisa e approssimativa (…) queste le linee della problematica d’una
‘ontologia della libertà’ che l’esistenzialismo ha affidato alla meditazione attuale, e in
nome della quale io desidero proclamarmi esistenzialista”22[22].
Dunque, per un verso essere e libertà convergono, ma per un altro permangono
distinti. Tuttavia, questo delicato equilibrio non sembra mantenuto da Pareyson negli
scritti posteriori a causa del tema dell’illimitatezza della libertà per cui non solo “la
libertà precede la libertà”, ma anche “la libertà segue la libertà”23[23]. La prima formula
indica, attraverso la passività/necessità che segna l’inizio della libertà umana, la libertà
originaria e originante: la nostra libertà, poiché non ci è stata sicuramente consegnata su
richiesta, ci è stata liberamente lasciata da un’altra precedente libertà. Invece la seconda
formula segnala che la libertà umana non è limitata né limitabile dalla libertà originaria
da cui pur deriva. A seguito di ciò, per Pareyson, non può più essere condivisibile la tesi
per cui l’uomo ha un fine naturale necessario da perseguire se vuole essere libero.
“Si suol dire: la libertà ha in sé la propria legge (altrimenti non è libertà ma
licenza), e se ne trae il principio che non c’è libertà senza legge, e che fa parte della
natura della libertà di avere una legge. Cioè la legge è considerata come una garanzia
interna contro il pericolo di negarsi che minaccia costantemente la libertà. Ora, la libertà
non ha bisogno di nessuna garanzia, perché, anche se la libertà si distrugge, anche se la
22[22] Ibidem, pp. 267 – 268.
23[23] Ibidem, pp. 26 – 27.
libertà si nega, tuttavia il suo atto di negarsi è pur sempre un atto di affermarsi. Quindi
questa affermazione è estremamente blanda, banale, di uno spiritualismo edulcorato e
ottimistico, di esito equivoco, sordo al carattere tragico della libertà e del suo esercizio.
Io rivendico la illimitatezza della libertà. La libertà è illimitata o non è. Meglio il male
libero che il bene imposto. Meglio la cosiddetta licenza che una legge razionale interna
alla libertà intesa come garanzia, come assicurazione del suo esercizio”24[24].
Certo l’illimitatezza della libertà non deve condurci alla libertà “abbandonata a se
stessa” di Sartre; l’illimitatezza della libertà “non è la libertà come pura attività”, ma
“capacità di contestare ogni limite, quindi ogni legge, ogni norma, ogni essere”. Quindi
possibilità di “contestare anche l’essere che le si affida e che sarebbe capace di
slanciarla. Essa è sempre in presenza di un limite originario, di un essere originario,
ch’essa è tuttavia libera di contestare”25[25].
Nonostante ciò, poiché la libertà è costituita dalla possibilità di negarsi,
l’illimitatezza della libertà non può che condurre ad una conclusione rischiosa:
l’affacciarsi dell’ambiguità originaria della libertà comporta che quest’ultima rimanga
identica a se stessa sia che scelga il bene sia che decida il male26[26]. La natura
ancipite della libertà le conferisce una netta indipendenza dall’essere, nonché una reale
superiorità dovuta alla sua capacità energizzante: “col solo atto di preferire l’essere al
24[24] IDEM, Ontologia della libertà, op. cit., pp. 19 – 20.
25[25] Ibidem, p. 20.
26[26] Sulla differenza tra “scegliere il bene” e “decidere il male” cfr. R. MANCINI,
Riconoscere il silenzio. Fonti ed eventi nella ricerca del senso, Edizioni Qiqajon –
Comunità di Bose, Magnano 2002.
non essere o il non essere all’essere, col solo atto di realizzarsi e confermarsi in presenza
della possibilità di negarsi e rinnegarsi e viceversa, la libertà istituisce sia la positività
dinamica dell’essere e del bene sia la negatività annichilatrice del nulla e del
male”27[27].
Mi pare che si possa sostenere che qui la comprensione della libertà proposta da
Pareyson non vada più verso una semplice radicalizzazione del tema dell’essere
attraverso la libertà; si assiste piuttosto ad un vero capovolgimento tra essere e
libertà28[28]. Infatti si tratta di “concepire l’essere stesso come libertà, cioè di
abbandonare la centralità dell’essere e di sostituire all’essere la libertà stessa”29[29].
Insomma, sembra che alla fine la libertà, non potendo più nutrirsi della ricchezza
dell’essere, sia lasciata a se stessa.
Al di là di questo rilievo critico rimane, comunque, l’importante tentativo di voler
indicare la trascendenza a partire sì dall’essere, ma per andare al di là di esso attraverso
l’originarietà della libertà. In questo modo Pareyson può essere iscritto in quel copioso
filone del pensiero che, da Platone a Levinas, ha tentato di pensare la trascendenza oltre
e senza l’essere30[30].
27[27] L. PAREYSON, Ontologia della libertà, op. cit., p. 258.
28[28] Di questo avviso è G. FERRETTI, “Fenomenologia e ontologia della libertà
nell’itinerario di Luigi Pareyson”, in P. CODA – G.LINGUA (a cura di), Esperienza e
libertà, Città Nuova, Roma 2000, pp. 227 - 270. Cfr. anche V. POSSENTI, Dio e il
male, SEI, Torino 1995.
29[29] L. PAREYSON, Ontologia della libertà, op. cit., p. 457.
30[30] Cfr. anche J. L. MARION, Dio senza l’essere, Jaca book, Milano 1987.
3. Il male in Dio
Per Pareyson dire che “in principio è la libertà”, che la libertà è prima dell’essere
significa dire che Dio è, radicalmente, libertà: dalla sua libertà dipende il suo stesso
essere, la sua essenza e la sua esistenza. C’è un “Dio prima di Dio” che va pensato e che
è meno stravagante di quanto non si pensi. Quando comunemente si sostiene che Dio –
Ipsum esse subsistens – è necessitato ad essere e non può non essere, si ammicca già,
implicitamente, ad un “prima di Dio”: la sua necessità di esistere. Ora, sulla base della
riflessione del filosofo piemontese precedentemente riepilogata, senz’altro in principio
non può esservi la necessità, ma la libertà.
“La necessità che Dio ha di essere è posteriore alla sua realtà: in lui
l’irreversibilità dell’essere non è che l’irrevocabilità dell’atto di libertà. Il ‘prima’ di Dio
non è la sua necessità di esistere, che se mai è posteriore all’esistenza, ma è la libertà
stessa di Dio. Con la crisi e la dissoluzione del concetto di Dio come essere necessario
s’apre dietro l’esistenza di Dio un baratro vertiginoso, che non può essere colmato che
dall’assoluta e arbitraria libertà divina.
Il ‘Dio prima di Dio’ è dunque l’abissalità stessa di Dio: quell’immane voragine
in cui l’abissale libertà divina si sprofonda, incontrandovi un altro elemento abissale
quale il nulla. Malgrado la fitta caligine che regna in questa profondità, una precisazione
s’impone. ‘Prima’ di Dio non c’è propriamente il nulla, né ci può essere, ché Dio non
sarebbe Dio. Ciò non implica un ritorno all’essere necessario: ‘prima’’ di Dio c’è il ‘Dio
prima di Dio’, cioè la sua libertà. Ma la sua libertà come volontà di esistere è
essenzialmente vittoria sul nulla, il che implica che del nulla essa abbia una qualche
percezione. Non è libertà quella che non fa in qualche modo esperienza del nulla, sia
pure conoscendolo solo nell’atto di debellarlo. È questo il caso della libertà originaria, la
quale appunto è conoscenza del nulla nella forma della vittoria su di esso: del nulla essa
non ha sentore se non attraverso l’espugnazione che ne fa, sì ch’essa lo avverte quando
lo ha già superato e soggiogato; ma averlo superato e sconfitto è pur sempre un modo di
conoscerlo e riconoscerlo, di farne conoscenza ed esperienza”31[31].
Poiché il “Dio prima di Dio” è scelta di essere, di bene e, insieme, rifiuto del
nulla, allora il “male in Dio” è la definitiva vittoria dell’essere sulla possibilità del nulla,
è la possibilità irrevocabilmente debellata in Dio del male. Può sconcertare il parlare di
Dio inserendovi una storia, una narrazione, il “Dio prima di Dio”; ma se Dio è
originariamente libertà è caratteristica di quest’ultima dare luogo ad una storia. “Dove
c’è libertà ci sono fatti, e dove ci sono fatti c’è storia. Anzi, dove c’è libertà c’è una
storia, e dove c’è storia c’è una libertà”32[32]. La storia eterna consiste proprio in
questo: gli atti di Dio, come ad esempio la sua esistenza e quella del mondo, sono atti
della libertà originaria e, in quanto tali, non effetti di una necessità eterna, bensì autentici
fatti i quali, come tutti i prodotti di libertà, sono fatti indeducibili ossia eventi storici:
“per quanto eterna questa storia non cessa di essere storia e i suoi eventi non potranno
mai diventare momenti dialettici”33[33].
31[31] L. PAREYSON, “Filosofia ed esperienza religiosa”, op. cit., pp. 40 – 41.
32[32] Ibidem, p. 43.
33[33] Ivi.
Pareyson suggerisce di pensare la positività divina non come una superficie piatta
e levigata, ma come una profondità contrastata in cui la possibilità della negazione
inerisce essenzialmente alla positività; la possibilità del nulla, anche se vinta e
sottomessa, perdura come una risonanza che avvolge la positività, come un residuo scuro
che vi si annida.
“L’ambiguità originaria è quella di Dio, più precisamente della positività divina,
la quale non può affermarsi se non come riconoscimento e al tempo stesso soppressione
della possibilità negativa. C’è un senso in cui si deve ammettere una presenza del
negativo in Dio, ed è che anche in lui l’affermazione non ha luogo se non con la
possibilità della negazione, e la positività non si accredita se non come vittoria su una
possibile negatività, sì che l’una e l’altra sono inseparabili dal loro retroscena
negativo”34[34].
L’ambiguità divina, il “male in Dio”, non significa certo che egli possa essere
l’attore del male; Pareyson, a riguardo, tiene a sottolineare la distinzione tra origine e
realizzazione del male. Dio è senza dubbio l’origine del male, ma certamente non ne è il
realizzatore, cosa che compete soltanto alle creature. Dio è origine di tutto e quindi
anche del male, ma questo va distinto in possibile e reale: “in Dio il male è presente
come possibile, e lì lo trova l’uomo, che lo realizza nella storia”35[35]. L’uomo è il
34[34] IDEM, Esistenza e persona, op. cit., p. 35.
35[35] IDEM, “La filosofia e il problema del male”, op. cit., p. 34.
ridestatore del male in Dio; il “già là” del male trova nell’uomo colui che ha la capacità
di risvegliare quanto sopito nel e dall’Eterno.
“Nel mondo della storia non è possibile indicare altro autore del male che l’uomo.
Certamente l’uomo e non Dio è autore del male reale, del peccato, della colpa. Ma un
rinvio a Dio è inevitabile, perché c’è un senso in cui il male preesiste all’uomo, ed è in
questa sua preesistenza che risiede il carattere ontologico che gli compete. Non si può
ammettere che l’uomo abbia tanta creatività da inventare il male: egli, ché l’unico autore
del male, non può tuttavia esserne l’inventore. La sua creatività e la sua potenza sono
limitate, e bastano tutt’al più a scoprire il male come possibilità da realizzare, e a
realizzarlo effettivamente una volta che ne ha scoperto la possibilità, e ciò è già molto
per lui. Ma dove può egli scoprire la possibilità del male se non in Dio, che dunque ne è
non l’autore, ma certamente l’origine?”36[36].
Come Dio è risultato tale perché, preferendo l’essere al nulla, ha deciso in senso positivo
l’ambiguità originaria, così l’uomo si è realizzato tale quale è scegliendo la possibilità
negativa.
Qui si affaccia un altro punto delicato e, contemporaneamente, accidentato della
riflessione di Pareyson: non solo la libertà di Dio e quella dell’uomo non differiscono –
entrambi possono scegliere sia l’essere che il nulla – ma anche la libertà umana, come
già quella divina, si mostra indifferente all’essere e al nulla. L’asperità di un simile
pensiero si cela nel misconoscere che la negazione della libertà, nonostante sia ancora un
atto della libertà, sia una negazione definitiva. Se la libertà è storia, la libertà che si
autodistrugge non lo può essere più: l’atto di libertà del suicida è pur sempre l’ultimo
atto e tutto ciò che è estremo non è identico a quanto lo precede. Scegliere l’essere o
scegliere il nulla non sono simmetrici e indifferenti per la libertà: la prima opzione la
mantiene nella sua illimitatezza, la seconda, scandendone la fine, la limita per sempre
mentre la sopprime.
36[36] Ivi.
4. Sofferenza e redenzione
A causa dell’uomo ha luogo una specie di fallimento dell’opera divina: la
creazione viene a trovarsi corrotta dal peccato e condannata alla sofferenza. Tuttavia se
il male è di per sé devastante e rovinoso, esso va distinto dalla sofferenza: “la potenza
del male è grande, ma la potenza del dolore è maggiore”. La potenza della sofferenza sta
nella sua forza soteriologica: “il dolore più forte del male e vittorioso su di esso è quello
dell’espiazione, il dolore accettato, anzi voluto, anzi desiderato e cercato”. È questa
“l’algebra della sofferenza: meno per meno più”. Nella grandiosa economia
dell’universo non importa che il malvagio venga punito, ma che egli si redima; è così
che “consapevole del proprio valore redentivo la sofferenza diventa rivelativa: apre il
cuore dolorante della realtà e svela il segreto dell’essere. Essa insegna che il destino
dell’uomo è l’espiazione”37[37]. In questo destino Dio è direttamente coinvolto.
“La vastità e la profondità del male esistente nel mondo sono tali che, anche
ammessa la sofferenza come espiazione e riscatto, a liberare l’umanità non basta la
sofferenza dei peccatori, ma è richiesta anche la sofferenza degli innocenti (…) Se il
peccato trascina nella sofferenza anche gli innocenti, allora il dolore trascina nella
sofferenza anche la divinità. La sofferenza degli innocenti è segno che la creazione è
così fallimentare che per porvi riparo è necessario anche il dolore di Dio. Lo scandalo
della sofferenza degli innocenti diventa tollerabile solo sullo sfondo d’uno scandalo ben
maggiore: l’estensione del dramma dell’uomo a Dio stesso, cioè la realtà d’un Dio
37[37] IDEM, Filosofia della libertà, il melangolo, Genova 1990, pp. 35 – 37.
sofferente. Si capisce allora come tutti, i peccatori e gli innocenti, l’uomo e il mondo,
l’umanità e la divinità, vengano implicati in un’unica – terribile e grandiosa – tragedia
cosmoteandrica”38[38].
La prospettiva aperta da Pareyson sulla sofferenza è suggestiva e può raccogliere
il consenso di tanta letteratura mistica; tuttavia, per certi versi, mi pare eccessivamente
tragica, quasi doloristica: a redimere è l’amore e non la sofferenza; certo, amare può
significare anche soffrire, ma proprio perché sofferenza d’amore essa può aspirare alla
redenzione. La sofferenza non è un meccanismo soteriologico; essa va, innanzitutto e se
si può, eliminata, estirpata, consolata; solo in seconda battuta, quando è sofferenza che
nasce dalla lotta contro la sofferenza altrui, allora e solo allora, in quanto sofferenza
d’amore, è sofferenza redentrice. Il pantragismo rischia di far dimenticare che l’uomo è
destinato ad amare e non a soffrire39[39].
5. L’innocenza di Dio
Che dire dell’ontologia della libertà e del connesso male in Dio? Senz’altro lo
sforzo speculativo è intenso e, nella misura in cui permette di riflettere sul “già là” del
male, stimolante. È evidente che l’arbitrarismo cui approda Pareyson non è il capriccio,
38[38] IDEM, “La filosofia e il problema del male”, op. cit., p. 44.
39[39] Cfr. C. MILITELLO, “Il superamento del dolorismo nella concezione cristiana
della sofferenza”, Ricerche teologiche, 8 (1997), pp. 195 – 204.
ma il riconoscimento della sovranità, della trascendenza di Dio rispetto ad ogni forma di
schematismo concettuale. Dire che l’essere di Dio dipende dalla sua libertà significa dire
anzitutto che la creazione del mondo prosegue, imprevedibilmente, un libero
cominciamento che è l’originarsi stesso di Dio, e poi che la libertà, superando la
necessità dell’essere in Dio, è la categoria più appropriata per pensare la sua alterità e la
sua signoria. Tuttavia, e lo si è già osservato, presentare la libertà come ancipite, neutra,
insensibile al bene ed al male, estranea alla bontà non può che generare sospetto e
diffidenza verso di essa40[40]. La libertà, privata della ricchezza dell’essere, finisce per
involversi in una forza che, appiattendo le differenze, rende tutto insignificante e indifferente.
Però, a mio avviso, vi è un’altra difficoltà che, meno legata all’esigenzialismo di
una certa sensibilità, è tanto più spinosa quanto più scaturisce da un’incongruenza
interna alla meditazione stessa del filosofo torinese: una volta che si è ammesso il male
in Dio, l’innocenza di quest’ultimo sembra irrimediabilmente compromessa e ciò getta
una pesante ipoteca sulla possibilità che ci possa essere una sofferenza divina e
innocente da un lato, e redentiva dall’altro. Eppure è lo stesso Pareyson ad invocare una
“cristologia laica” per la comprensione dell’enigma dell’esistenza umana41[41]. Anzi, a
me pare che Pareyson stesso abbia avvertito, con acume, questa difficoltà.
40[40] Cfr. R. MANCINI, “La libertà e il male. Riflessioni durante Auschwitz”, in G.
FERRETTI (a cura di), La libertà, Quaderni di ricerca del Dipartimento di Filosofia e
scienze umane, Università di Macerata, Macerata 2002 (in corso di pubblicazione).
41[41] “Il problema oggi non è più quello di una teologia naturale, che sia accettabile
anche dalla pura ragione, ma quello ben più attuale della cristologia, d’una cristologia
per così dire laica, la quale come pensiero tragico sia in grado di coinvolgere tutti,
“Non si può chiamare innocente né la libertà né la positività. Se l’innocenza è
ingenuità come ignoranza di bene e male, non la si può attribuire né alla libertà né alla
vera positività. Il discorso sull’innocenza è complesso. Sono propenso a ritenere ch’essa
non esiste, nemmeno nei fanciulli, di solito vantati per la loro innocenza e ingenuità. In
ogni caso essa è sempre relativa, cioè riferita a una colpa determinata o a una singola
responsabilità. Talvolta si chiama ingenuità la mancanza di malizia, che non è ancora, di
per sé, innocenza come ignoranza del male. Ma nessuno vorrà chiamare innocenza
quella diffusa superficialità che spesso degenera in un fatuo o falso infantilismo o in una
semplice inettitudine, né lasciarsi ingannare dall’apparenza d’innocenza di cui sempre
s’ammantano l’egoismo ‘inconsapevole’ e l’egocentrismo senza ‘sospetti’ su di sé. In
ogni caso l’innocenza, se pure esiste, non ha, di per sé, alcun pregio morale. Pregio
morale ha solo la virtù, come vittoria sulla colpa; ma forse aspetto d’innocenza può
acquistare la virtù diventata seconda natura.
E, tuttavia, onore all’innocenza! Essa merita ed esige rispetto, come cosa rara e
straordinaria, e insieme delicatissima e terribilmente esposta. Chi ha la ventura
d’incontrarla, sappia apprezzarne la limpida trasparenza, e tremi al pensiero di poterla
appannare col suo solo respiro (…) L’innocenza suppone un difficile e prezioso
equilibrio, perché si trova costantemente sull’orlo d’un baratro, di cui sente al tempo
stesso l’orrore e l’attrazione. Dall’innocenza all’angoscia il passo è brevissimo (…) Il
duplice pericolo dell’insensibilità e della torbidezza basta a comprometterla, lacerandola
in direzioni opposte, ma essa riesce ad evitarlo mantenendosi nel suo centro, ch’è uno
stato di tranquilla trepidazione e di ansia fiduciosa. Ma a parte queste considerazioni, che
non esauriscono l’ardua materia, è da dire che né la libertà né la positività possono
essere innocenti: la libertà non lo è perché realizza il bene solo in presenza della
possibilità del male, e si pone come positiva solo potendo essere alternativamente
negativa; non lo è la vera positività, che è tale solo in quanto è scelta e preferita alla
credenti e non credenti” (L. PAREYSON, “La filosofia e il problema del male”, op. cit.,
p. 69).
negatività, e quindi contiene in sé la possibilità della negazione. La libertà non potrebbe
essere una scelta fra positività e negatività, fra bene e male, se non fosse conoscenza del
male e della negatività, ciò che ovviamente esclude l’innocenza”42[42].
Questa lunga citazione permette di documentare l’oscillazione del filosofo
piemontese sul tema dell’innocenza. Egli è consapevole che sostenere il male in Dio la
esclude, e tuttavia dichiara che “la materia è ardua” e che si deve rendere “onore
all’innocenza” poiché essa è “cosa rara e straordinaria, e insieme delicatissima e
terribilmente esposta”. D’altra parte, dopo aver sostenuto l’inevitabilità della sofferenza
innocente per la redenzione del male, inevitabilità che coinvolge anche Dio – primo tra
gli innocenti, come poter poi sostenere che Dio non sia tale?
Senz’altro l’innocenza non è “ignoranza di bene”, né “infantilismo”, piuttosto è la
più decisa negazione che la libertà del/nel bene, per essere, abbia bisogno del male,
magari anche solo nella forma della possibilità tacitata; ma è proprio questo che
Pareyson non sarebbe disposto ad ammettere. L’eccellenza dell’innocenza non è del
bambino, ma di Dio stesso, ossia di colui che è e che continua a fare il bene malgrado
l’aggressione del male. Il turbamento dell’innocente posto dinanzi al male non è dato
dalla possibilità di subirne il fascino, ma dal disorientamento di chi sa che non c’è
ragione per il male: “se ho parlato male dimostrami dov’è il male, ma se ho parlato bene
perché mi percuoti?”43[43]. Dinanzi al male o si è innocenti, rifiutandone qualsiasi
42[42] IDEM, “Un discorso temerario: il male in Dio”, Annuario filosofico, 1988, n. 4,
pp. 30 – 31.
43[43] Gv. 18, 23.
legittimazione, qualsiasi coinvolgimento, resistendo alle sue spire, oppure si cede ad
esso praticandolo, magari giustificandolo attraverso il tentativo di una sua
razionalizzazione che poi non sarebbe altro che il suo malefico occultamento.
L’innocenza divina è scioccata dal male non perché quest’ultimo le si mostra seducente,
ma perché al suo sguardo penetrante esso non può che essere colto per quello che è:
tragica stupidità. L’idiozia del male è la causa dello sconcerto divino: “il Signore si
pentì di aver fatto l’uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo”44[44]. Dio è
innocente, al punto che può farsi neonato e continuare ad essere Dio; dire “se voi non
diventerete come bambini”45[45] equivale a dire, alla luce della rinascita
battesimale46[46], “se voi non ritornerete innocenti”. Qui sta la potenza dell’amore che
ha la capacità di riconsegnarci, dopo aver subìto e fatto subire la violenza del male, alla
nostra originaria innocenza, all’agostiniana capacità di fare il bene e, insieme, quel che si
vuole: ama et fac quod vis. Questo è il proprio dell’innocente.
44[44] Gn. 6, 6.
45[45] Mt. 18, 3. È significativo che questa pericope si leghi alla questione dello
scandalo, ossia alla possibilità di depredare l’innocenza altrui.
46[46] Cfr. Gv. 3, 3.