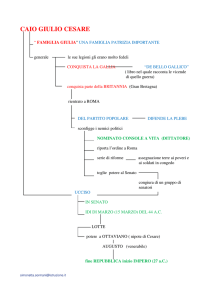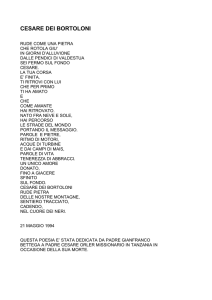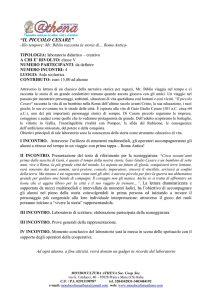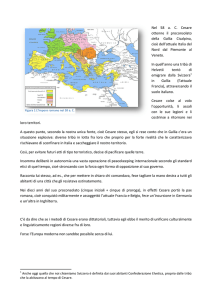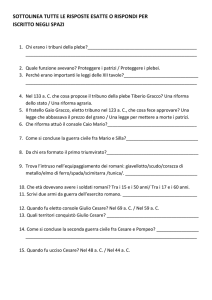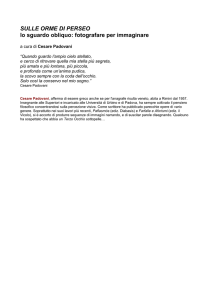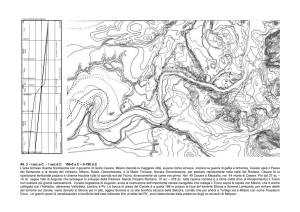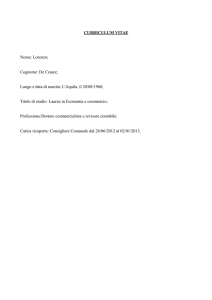Responsabile editoriale: Roberto De Meo
Redazione: Patrizia Vallario
Tavole cartografiche: Stefano Benini
Traduzione: Luigi Sanvito
Immagine di copertina: © Stephen Mulcahey / Arcangel Images
Titolo originale:
The Caesar’s Legion. The epic saga of Julius Caesar’s elite tenth legion and the armies
of Rome
Copyright © 2002 by Stephen Dando-Collins. ALL RIGHTS RESERVED
www.giunti.it
© 2015 Giunti Editore S.p.A.
Via Bolognese 165 – 50139 Firenze – Italia
Piazza Virgilio 4 – 20123 Milano – Italia
ISBN 9788809819429
Prima edizione digitale: settembre 2015
RINGRAZIAMENTI
La stesura di questo libro non sarebbe stata possibile senza l’immenso aiuto che mi
è stato fornito nel corso di molti anni dal personale di innumerevoli biblioteche,
musei ed enti di ricerca storica sparsi per tutto il mondo. A tutti questi addetti vanno
i miei più sentiti ringraziamenti: né loro né io, all’inizio, sapevamo quali risultati
avrebbe prodotto la mia passione per la storia romana. Un grazie di cuore anche a
coloro che hanno letto il manoscritto nelle sue diverse fasi di sviluppo, fornendomi
preziosi suggerimenti.
Più in particolare, la mia riconoscenza va a tre persone, per il ruolo che hanno
giocato nella stesura e nella pubblicazione di questo libro. Anzitutto, devo ringraziare
Stephen S. Power, senior editor alla John Wiley & Sons, per l’entusiasmo,
l’incoraggiamento, la lungimiranza e il talento professionale.
In secondo luogo, devo molto al mio meraviglioso agente letterario di New York,
Richard Curtis, che per molti anni ha sostenuto e orientato le mie aspirazioni,
propiziando un felice matrimonio con un’eccellente casa editrice. È stato Richard a
suggerirmi di dividere il mio massiccio manoscritto dedicato a tutte le legioni
dell’antica Roma in una serie di monografie che raccontassero in forma autonoma le
vicende di ciascuna delle principali unità dell’esercito romano. Senza di lui, La legione
di Cesare non avrebbe mai visto la luce. In quest’epoca sempre più dominata dalle
fredde tecnologie informatiche, vi assicuro che nell’Upper East Side esiste ancora un
uomo che incarna tutte le qualità «vecchio stile» che uno scrittore sogna di trovare
in un agente letterario. Per un autore, come il sottoscritto, che si avvale della
tecnologia ed è in prima linea nella rivoluzione dell’editoria elettronica, Richard era e
rimane un autentico gentiluomo della vecchia scuola.
Infine, c’è Louise, mia moglie da quasi vent’anni. Louise ha condiviso con me una
vita complicata e frenetica senza mai lamentarsi; al contrario, incoraggiandomi
continuamente. Come posso descrivere il ruolo che ha giocato nella stesura di questo
libro, e nell’affinamento delle mie doti letterarie? Penso che Tacito, nell’Agricola, mi
offra le parole per esprimerlo al meglio. Lo storico romano descrive la relazione tra
sua suocera Domizia e suo suocero Agricola con parole che sembrano rispecchiare il
mio rapporto con Louise in questi vent’anni: «Domizia e Agricola hanno vissuto in un
accordo perfetto, sostenuto da affetto e altruismo. In un’unione di questo tipo,
tuttavia, una buona moglie merita più della metà delle lodi, proprio come una cattiva
consorte merita più della metà dei rimproveri».
NOTA DELL’AUTORE
La legione di Cesare vuole colmare una lacuna nella produzione saggistica in
materia, narrando dettagliatamente la storia di una singola unità dell’antico esercito
romano. Il mio libro costituisce il frutto di trent’anni di ricerche sulle forze armate
dell’antica Roma; un lavoro che si è focalizzato soprattutto sulle più importanti tra le
cinquanta legioni di epoca augustea e postaugustea create tra l’84 a.C. e il 231 d.C.
Per nostra fortuna, abbiamo a disposizione le opere di molti storiografi
dell’antichità. Costoro hanno tramandato ai posteri le cronache delle guerre, delle
campagne, delle battaglie e delle scaramucce, svelandoci il carattere e le azioni dei
principali condottieri delle legioni romane. Penso ad autori come Giulio Cesare,
Appiano, Plutarco, Tacito, Svetonio, Polibio, Cassio Dione, Giuseppe Flavio, Plinio il
Giovane, Seneca, Livio, Arriano, senza i quali questo libro non sarebbe stato neppure
concepibile.
Grazie alle fonti classiche e moderne (per le quali rinvio alle appendici di questo
volume), esiste materiale sufficiente per dare alle stampe ponderosi tomi sulla
Quattordicesima Gemina Martia Victrix, la legione che sconfisse Boadicea (o Budicca,
com’è chiamata ai giorni nostri); sulla Terza Augusta, che salvò la vita all’apostolo
Paolo; sulla Sesta Victrix, che rapì Cleopatra e fu alla base della celebre quanto
lapidaria osservazione di Giulio Cesare Veni, vidi, vici («Venni, vidi, vinsi»); e sulla
Dodicesima Fulminata, che si guadagnò nome e fama nella battaglia di Marco Aurelio
contro i germani così vigorosamente rievocata nel film Il gladiatore. E questi sono
solo pochi esempi tra i tanti.
Ciò premesso, non c’è dubbio che la legione più famosa in epoca romana sia stata
la Decima legio, non a caso descritta come «famosa in tutto il mondo» quando
partecipò all’offensiva in Giudea nel 67 d.C. Costituita personalmente da Giulio
Cesare, la Decima svolse un ruolo di primo piano in tutte le sue battaglie, dal
sanguinoso esordio in Spagna alla conquista delle Gallie e all’invasione della
Britannia, senza tralasciare la partecipazione alla guerra civile contro Pompeo
Magno, che sfociò nell’ascesa di Cesare a dittatore di Roma. La Decima legione
marciò per Marco Antonio e Augusto; con Corbulone sconfisse duramente i parti;
con Vespasiano represse la rivolta ebraica; con Tito si impossessò del tempio di
Gerusalemme. Infine, espugnò Masada.
Durante le ricerche per questo libro, ho dovuto affrontare e chiarire una serie di
questioni controverse della storia legionaria, come la singolare unicità delle strutture
di comando in Egitto e Giudea. Ma l’aspetto più illuminante in assoluto ha riguardato
quello che in termini moderni chiameremmo il fattore della rafferma. Le legioni di
Roma erano reclutate in massa, mentre coloro che sopravvivevano erano congedati
altrettanto in massa alla fine del periodo di servizio (in origine dopo sedici anni; più
tardi, dopo venti). Durante questo arco di tempo, le perdite non erano sostituite da
nuovi soldati. La possibilità di raffermarsi (cioè di rinnovare il periodo di servizio)
spiega perché alcune specifiche unità venissero sostanzialmente annientate in
questa o quella battaglia, salvo poi risorgere con nuovi effettivi: in certi casi si
trattava di legioni composte da reclute, ma in altri casi i ranghi erano costituiti da
legionari che avevano usufruito della rafferma, con un’età compresa tra i trentanove
e i cinquantanove anni, e ormai prossimi al congedo definitivo. Per ulteriori
approfondimenti sul tema, rinvio all’appendice Il fattore della rafferma.
C’è poi la questione delle date e dei nomi. Per quanto riguarda il primo punto, ho
scelto di utilizzare il calendario romano, che inizialmente presentava una variazione
di due mesi in meno rispetto al nostro. I nomi dei luoghi sono riportati nella loro
dizione originale, con l’aggiunta, laddove possibile, di quella moderna, così che i
lettori possano facilmente identificarli. Per quel che concerne i nomi delle persone,
ho preferito attenermi alla dizione più conosciuta ai giorni nostri, rinunciando a
qualunque tecnicismo filologico: Antonio anziché Antonius, Giulio Cesare anziché
Gaius Caesar, Ottaviano invece di Caesar, Pilato piuttosto che Pilatus, Vespasiano al
posto di Vespasianus ecc.
Nel XIX e nel XX secolo, molti studiosi trovavano opportuno definire le legioni
«reggimenti», le coorti «battaglioni», i manipoli «compagnie», i centurioni
«capitani», i tribuni «colonnelli», e i legati «generali». Per quanto mi riguarda, ho
mantenuto nella narrazione termini come legione, coorte, manipolo e centurione,
considerando che si tratta di vocaboli ormai familiari al lettore moderno.
Tuttavia, alcuni termini antichi sono assai meno conosciuti. Questa circostanza mi
ha spinto ad alcuni aggiustamenti, in modo da facilitare la comprensione del testo. Di
conseguenza, ho tradotto «legato» come «generale» o «generale di brigata»;
«tribuno» come «colonnello» (laddove l’ho ritenuto necessario); «pretori» come
«generali di divisione», e (sempre dove l’ho ritenuto necessario) «consoli» come
«generali di corpo d’armata». Sono consapevole che questo approccio al tema dei
gradi militari potrà non piacere agli accademici (in fondo – lo ammetto – è come
tenere il piede in due scarpe), ma ho preferito anteporre la chiarezza divulgativa al
rigore filologico.
Questa è la storia dei soldati della Decima legione, militi che contribuirono in
misura decisiva alla grandezza di Roma; uno o due uomini straordinari e moltissimi
altri assolutamente ordinari, ma spesso capaci di imprese incredibili. Sotto molti
aspetti, non erano diversi da noi. Eppure è lecito chiedersi chi, al giorno d’oggi,
sarebbe in grado di fare (o anche solo di iniziare a fare) quello che hanno fatto loro,
di sopportare quello che hanno sopportato loro, di realizzare quello che hanno
realizzato loro.
NOTA DEL TRADUTTORE
Nel testo originale, l’Autore utilizza il moderno sistema anglosassone per definire
pesi e distanze. Dunque, miglia, piedi, pollici, iarde, libbre etc. Nella traduzione
italiana, abbiamo precisato volta per volta le corrispondenti unità di misura secondo
il sistema in vigore nel nostro Paese: ad esempio, cinque piedi e quattro pollici = circa
un metro e sessantacinque centimetri. Tuttavia, in alcuni passaggi, allo scopo di
mantenere intatta la scorrevolezza del testo, abbiamo tradotto i pesi e le misure
originali direttamente in chili e metri, senza fare alcun riferimento ai loro equivalenti
anglosassoni. C’è poi un’osservazione che riguarda il miglio: considerando che si
tratta di un termine il cui significato è ormai abbondantemente conosciuto anche in
Italia, abbiamo ritenuto superfluo tradurlo sempre in chilometri. Qui, per
completezza, aggiungiamo soltanto che un miglio terrestre è pari a circa un
chilometro e seicentodieci metri. [L.S.]
1. IL RISCHIO DELLA DISFATTA
Era un gran giorno per morire. E prima che il sole fosse tramontato, 34 000 uomini
avrebbero perso la vita in questa valle. I militi della Decima legio non si facevano
illusioni. Sapevano che molti di loro sarebbero caduti nella battaglia ormai
imminente. Tuttavia, per dei romani, non c’era nulla di più glorioso di una morte sul
campo. E se gli uomini di questa legione dovevano morire, probabilmente non
esisteva un luogo migliore, o un giorno più adatto, per andare incontro alla propria
sorte, sul suolo di casa, sotto un cielo di un azzurro perfetto.
Neppure un alito di vento sfiorava i legionari della Decima inquadrati nei loro
ranghi, mentre scrutavano l’esercito di Gneo Pompeo dall’altro lato della valle e del
fiume. L’armata avversaria aveva preso posizione a cinque miglia di distanza, sui
pendii di Munda, una città collinare dell’Andalusia nei pressi dell’odierna Osuna, a
sudest di Cordova. Il sole era sorto nel cielo sereno, illuminando una dolce mattina,
quella del 17 marzo del 45 a.C. Dopo sedici anni di battaglie in Spagna, Francia,
Belgio, Olanda, Germania, Albania, Grecia, Nord Africa, e dopo aver invaso due volte
la Britannia, la Decima legione di Giulio Cesare aveva fatto ritorno al punto di
partenza: di nuovo in azione sul suo territorio natio, pronta a misurarsi nello scontro
campale che avrebbe posto fine alla più sanguinosa guerra civile di Roma, oppure
alla carriera di Cesare, e forse alla sua vita.
Adesso la Decima comprendeva meno di 2000 effettivi, un numero ben lontano dai
6000 legionari che Cesare aveva personalmente reclutato nel 61 a.C. Due terzi dei
ranghi erano caduti nel corso degli anni. I sopravvissuti, la cui età oscillava tra i
trentatré e i trentasei anni, attendevano di essere congedati quello stesso mese.
Ancora una battaglia, aveva promesso Cesare ai suoi veterani ispanici, e poi sarebbe
stato felice di mandarli a casa. I legionari avrebbero ricevuto un supplemento di paga
e appezzamenti di terreno.
Riconosciuta da amici e nemici come la migliore unità militare di Cesare, la Decima
legione costituiva tradizionalmente l’ala destra dell’esercito del condottiero, ancora
fermo e in silenzio. La Quinta legione – un’altra unità ispanica – copriva l’ala sinistra
dello schieramento. Lo spazio tra le due estremità era occupato da uomini della
Terza, della Sesta, della Settima, della Ventunesima e della Trentesima legione. Come
la Decima, anche queste forze si presentavano a ranghi ridotti: la Sesta legione, per
esempio, aveva potuto schierare solo qualche centinaio di uomini. In tutto, Cesare
disponeva di circa 30000 tra legionari e ausiliari, inquadrati in ottanta coorti, o
battaglioni. C’erano poi 8000 cavalieri, distribuiti tra i due fianchi: la più grande forza
di cavalleria che Cesare avesse mai messo in campo. I cavalli scalpitavano inquieti,
fiutando l’odore della paura nell’aria del primo mattino.
Al centro dello schieramento della Decima, a cavallo con elmo e corazza e
attorniato dal suo stato maggiore, il cinquantaquattrenne Giulio Cesare indossava il
paludamentum, il vistoso mantello scarlatto dei generali romani. Mentre le truppe
rimanevano in attesa, Cesare si consultò rapidamente con il comandante della
cavalleria, Nonio Asprenate, mettendo a punto gli ultimi dettagli tattici. Dopodiché
Asprenate si allontanò a cavallo e raggiunse con i suoi uomini la posizione che gli era
stata assegnata – quasi certamente sull’ala destra –, mentre il suo vice, il colonnello
Arguezio, disponeva le proprie forze sull’ala sinistra.
Cesare impartì un ordine. Accanto a lui, un attendente a cavallo inclinò la bandiera
rossa del generale verso il fronte di battaglia. Un trombettiere disarmato suonò il
segnale dell’avanzata a passo di marcia. Lungo tutto lo schieramento, le trombe delle
singole unità ripeterono il segnale. Le aquile delle legioni e i vessilli delle unità più
piccole si inclinarono verso il nemico. Le truppe, disposte in tre linee di 10000 uomini
ciascuna, si mossero ordinatamente.
Cesare aveva sperato di attirare i suoi avversari su un terreno pianeggiante, ma le
truppe nemiche non sembravano volersi muovere; al contrario, mantenevano la loro
posizione sulla collina, aspettando che fosse l’esercito di Cesare a farsi sotto.
Il generale al comando dell’armata avversaria era Gneo Pompeo. Figlio maggiore di
un famoso generale, Pompeo Magno, e nipote di un altro, non aveva ancora
trent’anni e non possedeva una reputazione militare particolarmente brillante. Pochi
anni prima aveva assicurato a suo padre un successo navale nell’Adriatico, seguito
tuttavia da una disastrosa operazione via terra in Libia. In tempi più recenti, aveva
guidato le sue truppe in una sofferta ritirata attraverso la Spagna sudoccidentale,
mentre Cesare lo incalzava da vicino. Le sue esperienze di comando si fermavano lì.
Malgrado questi limiti evidenti, tuttavia, era pur sempre l’erede di Pompeo Magno e
si trovava in Spagna, dove il suo defunto padre era ancora onorato; una circostanza
che poteva fare la differenza. Inoltre, aveva ai suoi ordini come vicecomandanti due
dei migliori generali di Pompeo Magno, uno dei quali, per di più, era stato l’aiutante
di Cesare per nove anni e conosceva bene come pensava e come combatteva.
Mentre suo fratello minore Sesto presidiava Cordova, la capitale della provincia
iberica, Gneo aveva radunato ed equipaggiato un imponente esercito, forte di circa
50 000-80 000 uomini. Poche delle sue unità, tuttavia, erano di prim’ordine. Nove
delle sue tredici legioni erano nuove di zecca, costituite da giovani inesperti
frettolosamente raccolti nella Spagna occidentale e nel Portogallo. Di conseguenza, il
peso della battaglia sarebbe ricaduto in gran parte sulle sue quattro legioni di
veterani.
Gneo contava soprattutto sulla Prima legione, il reparto d’élite di suo padre,
l’equivalente della Decima di Cesare. Questa unità aveva combattuto le battaglie più
importanti della guerra civile ma, a differenza dell’imbattuta Decima legione, era
stata costretta ad aprirsi la strada disastro dopo disastro. Accanto alla Prima c’erano
anche la Seconda e la legione Indigena, due unità pompeiane che erano passate dalla
parte di Cesare, salvo poi ripensarci quando Gneo e Sesto erano arrivati in Spagna
l’anno prima. Infine, c’era l’Ottava legione, un’unità molto simile alla Decima e una
delle tre legioni di Cesare che in tempi recenti avevano disertato per unirsi alle forze
avversarie. Il giovane Gneo aveva accolto con sospetto queste defezioni di massa, al
punto che aveva tenuto con sé solo l’Ottava, inviando le altre due unità
«voltagabbana» (la Nona e la Tredicesima) a suo fratello a Cordova.
Il giorno prima, il giovane Pompeo aveva allestito il proprio campo nella pianura
nei pressi di Munda. Cesare era arrivato con le sue legioni dopo il crepuscolo, e si era
accampato a cinque miglia di distanza. Nelle prime ore del mattino successivo,
Pompeo aveva disposto le sue truppe, in schieramento di battaglia, sui pendii
sottostanti la città, determinato a costringere Cesare a uno scontro campale. Gneo
aveva deciso di giocarsi il tutto per tutto, sfruttando il fattore della superiorità
numerica prima che i suoi sostenitori si stancassero di ritirarsi e abbandonassero la
causa. I suoi consiglieri gli avevano garantito che Cesare avrebbe rapidamente
accettato lo scontro. In effetti, non si sbagliavano: l’ordine di prepararsi alla battaglia
risuonò per tutto il campo di Cesare poco dopo che gli addetti alle ricognizioni lo
avevano svegliato per riferirgli i preparativi di Pompeo vicino a Munda.
Dopo aver innalzato i vessilli, le legioni di Cesare si inoltrarono al passo nella
pianura, tra il frastuono di 60000 piedi in marcia e il clangore metallico del loro
equipaggiamento. La disciplina era rigida. Non una parola. Sui fianchi, la cavalleria
seguiva l’avanzata dei legionari. Cesare e il suo stato maggiore cavalcavano subito
dietro la prima linea della Decima legione.
Mentre avanzavano, gli uomini della Decima tenevano gli occhi bene aperti, decisi
a prevenire qualunque trappola. Intorno a loro c’erano solo colline, ma qui, sul
fondovalle, il terreno era pianeggiante; un aspetto che avrebbe favorito sia le
manovre della fanteria che quelle della cavalleria. Prima di ogni cosa, però, le truppe
dovevano coprire cinque miglia per agganciare il nemico. Sul loro percorso c’era un
fiumiciattolo poco profondo che tagliava la vallata. Avrebbero dovuto guadarlo e poi
attraversare un altro tratto di pianura arida, prima di raggiungere la collina dove si
era attestato l’esercito avversario. Forte della possibilità di scegliere il campo di
battaglia, il giovane Pompeo aveva optato per le alture. Inoltre, pronta a fornire
aiuto in caso di necessità, la città di Munda si ergeva sulla collina alle sue spalle,
circondata da alte mura con torri e guarnigioni di difesa.
Mentre la distanza tra i due eserciti si riduceva, i legionari della Decima poterono
constatare che le ali di Pompeo erano protette da reparti di cavalleria, appoggiati da
fanteria leggera e ausiliari (6000 per ogni lato). I soldati della Decima non vedevano
l’ora di scoprire l’identità della legione posizionata sul fianco che li fronteggiava,
sperando che non si trattasse dei loro fratelli ispanici dell’Ottava. Durante gli ultimi
sedici anni, la Decima e l’Ottava avevano affrontato assieme la buona e la cattiva
sorte. Non sarebbe stato facile combattere contro vecchi amici, ma lo avrebbero
fatto, nel nome di Cesare. Gli uomini della Decima capivano perché i loro scontenti
compagni dell’Ottava avessero deciso di defezionare e, come in passato, avvertivano
un moto di simpatia nei loro riguardi. Eppure, quando si trattava di passare alle vie di
fatto, la lealtà della Decima nei confronti di Cesare era fuori discussione.
Quando gli uomini del condottiero ruppero il passo nell’attraversare sguazzando il
fiumiciattolo, per poi ricomporsi e continuare ad avanzare a ritmo di marcia, il loro
comandante comprese che Pompeo si aspettava che scalasse la collina, dove si
sarebbe svolto lo scontro decisivo. A quel punto, del resto, c’era una sola alternativa:
o accettare il gioco del nemico, o ritirarsi. Quando la sua prima linea raggiunse la
base del pendio, Cesare, inaspettatamente, ordinò alle truppe di fermarsi. Gli uomini
obbedirono, aspettando con impazienza di lanciarsi all’attacco. A quel punto, Cesare
comandò loro di serrare i ranghi, così da concentrare la forza offensiva su uno spazio
più ristretto. La direttiva venne prontamente eseguita.
Mentre i legionari cominciavano a spazientirsi della tattica attendista del loro
generale, Cesare diede l’ordine di suonare la carica. Le trombe lo stavano ancora
eseguendo, quando i vessilli delle sue ottanta coorti si inclinarono verso il nemico.
Con un rombo assordante, le truppe si avventarono su per la collina.
Con un rombo altrettanto assordante, gli uomini di Pompeo scagliarono i loro
giavellotti. Gli attaccanti alzarono gli scudi per proteggersi. I dardi, lanciati dall’alto,
saettarono implacabili nell’aria, abbattendosi sulla prima linea di Cesare e
trafiggendo gli scudi. Le truppe all’assalto vacillarono per qualche momento, poi
riacquistarono lo slancio. Un’altra salva di giavellotti oscurò l’azzurro del cielo, e
un’altra, e un’altra ancora. La prima linea di Cesare, senza fiato e ancora lontana dal
nemico, con i cadaveri dei commilitoni che giacevano a mucchi, fu costretta a
fermarsi. Anche le unità alle sue spalle fecero lo stesso. L’intero attacco subì una
pericolosa battuta di arresto.
Per la prima volta nella sua carriera, Cesare si trovò di fronte al rischio di una
disfatta: una disfatta autentica, non una sanguinosa sconfitta come a Gergovia,
Dyrrhachium, Ruspina, o come le schermaglie fra le colline spagnole delle ultime
settimane. Cesare aveva infranto ogni regola: solo un dilettante avrebbe potuto far
marciare le sue truppe per cinque miglia, per poi costringerle a guadare un corso
d’acqua e avventarsi su una collina a passo di carica. Un dilettante, o un uomo che si
era abituato a vincere troppo facilmente, che aveva sottovalutato i suoi avversari,
che non frenava la sua impazienza di chiudere la partita della guerra civile una volta
per tutte. Se adesso le truppe di Pompeo si fossero scagliate giù dalla collina, lo
schieramento di Cesare – compresa la celebre Decima legione – quasi certamente
non avrebbe retto. I soldati, non importa se reclute o veterani, sarebbero fuggiti per
salvarsi la vita.
Dopo essere smontato rapidamente da cavallo, Cesare sottrasse lo scudo a uno
stupito legionario della retroguardia della Decima, quindi si fece largo tra le sue
truppe, su per il pendio, fino alla prima linea in frantumi. Il suo stato maggiore, con il
cuore in gola, scese da cavallo e si affrettò a seguirlo. Togliendosi l’elmo con la mano
destra e gettandolo via così che chiunque potesse riconoscerlo, Cesare raggiunse
l’avanguardia dello schieramento di attacco.
A questo punto, secondo lo storico Plutarco, il condottiero si rivolse alle sue
truppe, accennando col capo alle decine di migliaia di giovanissime reclute
dell’esercito pompeiano, e poi esclamò: «Non vi vergognate a permettere che il
vostro generale venga sconfitto da quei ragazzini?».
Nel silenzio generale, Cesare lusingò i suoi uomini, li rimproverò, li incoraggiò.
Eppure non uno dei legionari, ansimanti, coperti di sangue e grondanti sudore,
avanzò di un passo. Più in alto, le truppe di Pompeo assistettero a questo spettacolo
ridendo.
A quel punto, secondo la ricostruzione dello storico Appiano, Cesare si girò e disse
ai suoi ufficiali: «Se oggi falliremo, sarà la fine della mia vita, come pure delle vostre
carriere». Quindi sguainò la spada e si avviò su per la collina, verso le linee di
Pompeo, precedendo i suoi uomini di parecchi metri.
Un ufficiale inferiore dell’esercito di Pompeo gridò e diede l’ordine ai suoi uomini –
quelli nel raggio di azione di Cesare – di lasciar partire una raffica di dardi nella sua
direzione. Stando ad Appiano, duecento giavellotti volarono verso la solitaria, inerme
figura del condottiero. I soldati della Decima seguirono la scena trattenendo il
respiro. Nessuno poteva sopravvivere a un simile tiro di sbarramento, neppure un
uomo notoriamente fortunato come Giulio Cesare…
2. ALLA RICERCA DELLA GLORIA
Nella primavera del 61 a.C., il personale del palazzo governativo di Cordova
aspettava trepidante l’arrivo del nuovo governatore della provincia della Betica,
detta anche «Spagna ulteriore». Probabilmente molti di questi funzionari avevano
già servito sotto di lui otto anni prima, nel 69 a.C., quando era stato questore della
provincia e suo capo amministratore contabile, agli ordini del governatore
dell’epoca, il generale di divisione Antistio Vetere. Costoro avevano imparato a
conoscerlo come un uomo dalla memoria eccezionale e con una straordinaria
sensibilità ai dettagli. Il suo nome era Gaio Giulio Cesare, e all’età di trentotto anni
stava per intraprendere una carriera che lo avrebbe consegnato per sempre alla
storia.
Quel giorno, un generale di piccola statura, magro e dal viso affilato scese da una
lettiga e salì la scalinata del palazzo. Quasi certamente riconobbe gli uomini che non
vedeva da otto anni, e li salutò per nome. Lo scorrere del tempo aveva diradato la
sua capigliatura. Secondo Svetonio, Cesare, consapevole della sua crescente calvizie,
si spazzolava i capelli in avanti, così da mascherarla in qualche modo (peraltro con
scarso successo), e prese presto l’abitudine di indossare un parrucchino. Più tardi,
durante le occasioni ufficiali, avrebbe esibito la corona di foglie di alloro che gli era
stata conferita, con altri emblemi onorifici, dal senato. La sua carnagione era pallida
e delicata, e sembrava che, nonostante tutto il tempo passato all’aperto, non si
sarebbe mai scurita.
Appiano afferma che il viaggio via terra di Cesare da Roma alla Spagna durò
ventiquattro giorni. Qualcun altro si sarebbe concesso un periodo di riposo dopo tre
settimane di cammino, ma l’impazienza era un segno distintivo del carattere di Giulio
Cesare, che fremeva all’idea di lasciare la sua impronta sull’orbe terracqueo. Solo
l’anno precedente, all’età di trentasette anni, era stato nominato pretore, una carica
che, in termini militari moderni, equivaleva a quella di generale di divisione. Molti dei
suoi contemporanei avevano raggiunto il pretorato otto anni prima di lui. Quanto al
suo grande rivale, Pompeo Magno, era diventato un famoso generale all’età di
ventitré anni. Cesare, oltretutto, aveva sempre davanti agli occhi l’esempio di
Alessandro Magno, il re macedone che aveva conquistato gran parte del mondo
conosciuto quando non aveva ancora trent’anni. Svetonio ci riferisce che il generale
romano, durante il suo primo incarico in Spagna, mentre ammirava una statua di
Alessandro Magno a Cadice, si lamentò con il suo seguito che Alessandro, alla sua
età, aveva già fondato un impero.
Deciso a recuperare il tempo perduto, Cesare incaricò subito il suo capo di stato
maggiore, Lucio Cornelio Balbo, di arruolare una nuova legione nella Spagna
ulteriore. Balbo, che era di Cadice, gli ricordò che c’erano già due legioni di stanza
nella provincia – l’Ottava e la Nona –, acquartierate una accanto all’altra nei pressi di
Cordova. Cesare, solitamente bene informato, non poteva ignorare tale circostanza,
tantomeno che entrambe le unità erano state costituite in Spagna da Pompeo
quattro anni prima. Sia l’Ottava che la Nona, infatti, erano le ultime delle sette
legioni che Pompeo, forte dell’approvazione senatoriale, aveva creato nel 65 a.C. Ciò
nonostante, i progetti di Cesare richiedevano tre legioni; di conseguenza, insistette
per l’immediata costituzione di un nuovo reparto nella provincia ispanica.
Ben presto gli ufficiali reclutatori si sparpagliarono per tutta la Betica (grosso modo
l’attuale Andalusia), arruolando migliaia di giovani. Nel giro di qualche giorno, le
reclute furono radunate a Cordova. Seguendo la numerazione adottata da Pompeo,
Cesare diede alla nuova unità il numero dieci. Nacque così la Decima legio.
Come emblema della Decima fu scelto il toro, un simbolo molto popolare in
Spagna, allora come oggi: sarebbe apparso sullo scudo di ciascun soldato della
legione, come pure sui vessilli dell’unità. I romani credevano fermamente nei poteri
dello zodiaco e nelle capacità predittive degli oroscopi, al punto che il segno
astrologico corrispondente alla data di nascita di un reparto era mostrato in tutte le
sue insegne. Tuttavia, nel caso della Decima legione, che sembra essersi costituita a
marzo, l’emblema avrebbe dovuto essere il pesce dell’omonima costellazione,
oppure l’ariete.
Cesare si interessò personalmente alla nomina dei sei tribuni della Decima, tutti
giovani colonnelli tra i diciassette e i vent’anni, come pure a quella degli ufficiali
inferiori, i sessanta centurioni della legione. Entro trent’anni il ruolo del tribuno
sarebbe cambiato, ma per il momento i tribuni nominati da Cesare si sarebbero divisi
il comando dell’unità. A rotazione, uno di loro sarebbe stato il comandante in capo,
mentre ciascuno degli altri cinque avrebbe avuto ai suoi ordini due delle dieci coorti
(battaglioni) della Decima. Tutti costoro appartenevano all’ordine equestre, una
classe di cavalieri la cui importanza era seconda solo a quella del senato romano.
Naturalmente, i membri dell’ordine equestre provenivano da famiglie molto agiate e
influenti, che avevano assicurato loro un’ottima educazione.
Dal punto di vista di Cesare, tuttavia, la spina dorsale dell’esercito era il centurione;
non a caso, sarà proprio su questa figura che farà particolare affidamento nel corso
della sua carriera. Durante i sanguinosi scontri in Gallia, una decina di anni più tardi,
avrebbe incoraggiato i suoi centurioni chiamandoli per nome a uno a uno. E ben
presto, oltre ai loro nomi, avrebbe imparato a riconoscere anche i loro punti di forza
e di debolezza. Insomma, Cesare pensava che il proprio futuro fosse nelle mani dei
centurioni. Se costoro si fossero comportati bene, tutta la legione si sarebbe
comportata bene. E se la legione si fosse comportata bene, la reputazione dei suoi
generali sarebbe salita alle stelle.
I centurioni nominati da Cesare per la Decima provenivano dall’Ottava e dalla Nona
legione. Il capo centurione era l’ex centurione «semplice» con la maggiore anzianità
di servizio; tutti gli altri, divisi in undici gradi intermedi, provenivano direttamente dai
ranghi delle truppe. Non era insolito per un legionario essere promosso centurione
dopo quattro anni di servizio come soldato semplice. I centurioni controllavano le
vite dei loro uomini, facendo rispettare la disciplina con metodi talvolta brutali.
Tacito racconta di un centurione di stanza nei Balcani durante il I secolo d.C., che era
stato soprannominato dalle sue truppe «Portatemene un altro!», perché quando
spezzava il suo bastone sulla schiena di un legionario indisciplinato, ruggiva affinché
gliene procurassero subito uno nuovo.
E così, adesso Cesare aveva la sua Decima legio. Sei tribuni, tutti giovani e di buona
famiglia. Sessanta centurioni, tutti provenienti dai ranghi dell’esercito. E 5940 fra
soldati e sottufficiali. Ai tempi di Cesare, infatti, le dieci coorti di una legione
contavano ciascuna seicento uomini. Ogni legionario era un coscritto tra i diciassette
e i vent’anni, che avrebbe prestato servizio per un sedicennio. L’altezza media era di
cinque piedi e quattro pollici (circa un metro e sessantacinque); un modesto dato
fisico che dipendeva soprattutto dal regime alimentare in auge tra i legionari, basato
essenzialmente sul pane. La carne e le verdure erano considerati meri integratori,
mentre le patate, i pomodori, le banane e il caffè erano del tutto sconosciuti.
Eppure, a dispetto della loro bassa statura, i legionari di Roma erano combattenti
di prim’ordine. Dopo un duro addestramento al mestiere delle armi, potevano
marciare per venticinque miglia al giorno portandosi sulle spalle un peso di un
centinaio di libbre (circa cinquanta chili). La riforma dell’addestramento militare,
promossa dal console Gaio Mario quarant’anni prima, contemplava corse su lunghe
distanze con tutto l’equipaggiamento. Gli uomini della Decima dovevano essere in
perfetta forma fisica, non solo perché negli anni a venire avrebbero percorso migliaia
di miglia, ma anche perché alcuni dei loro scontri ravvicinati con il nemico non
sarebbero certo durati qualche ora, ma giorni interi.
Fin dall’inizio, tutte le vecchie competenze «civili» dei giovani della Decima furono
utilizzate pienamente. I fabbri si trasformarono in armaioli, i carpentieri si
specializzarono nella costruzione delle macchine da guerra e da assedio, i ciabattini si
occuparono delle calzature militari, coloro che sapevano leggere e scrivere divennero
degli addetti all’amministrazione. E se non avevi una specializzazione, ci pensava
l’esercito a dartene una. Potevi lavorare come geniere, o prestare servizio nelle
squadre di manutenzione delle strade, o diventare un inserviente alle macchine da
guerra. Ma quando le trombe davano il segnale di prepararsi alla battaglia, dovevi
inquadrarti immediatamente nella tua coorte come tutti gli altri, armi in pugno e
pronto a scendere in azione.
Una volta che la Decima legione fu organizzata, equipaggiata e sufficientemente
addestrata, Cesare la affiancò all’Ottava e alla Nona (due unità di veterani),
ordinando che lasciassero Cordova, attraversassero il Guadalquivir e si dirigessero a
nord, verso l’odierno Portogallo. Questa parte della penisola iberica – la Lusitania,
come la chiamavano i latini – doveva ancora essere sottomessa all’autorità di Roma.
Le sue colline sbarravano il passo ai nuovi conquistatori; le sue tribù resistevano
ferocemente a ogni tentativo di penetrazione. Scarsamente armati e organizzati, i
gruppi tribali della Lusitania fornivano un’occasione d’oro a un comandante esperto
e ambizioso come Giulio Cesare.
Non stupisce, quindi, che Cesare avesse preparato meticolosamente la sua
campagna. Durante i mesi che seguirono, il condottiero guidò la sua armata di 18000
legionari e diverse centinaia di cavalieri (appoggiati da macchine da assedio, migliaia
di carri per le vettovaglie e gli armamenti, bestie da soma e mulattieri) attraverso le
vallate del Portogallo. Gli uomini della spedizione presero d’assalto una collina
fortificata dopo l’altra, metodicamente, brutalmente, liquidando ogni tentativo di
resistenza. Entrando in azione prima dell’alba, i soldati di Cesare ponevano l’assedio
alle città della Lusitania che si rifiutavano di arrendersi; poi, dopo essersi lasciati alle
spalle solo rovine fumanti, proseguivano fino al prossimo obiettivo, marciando per
circa sei ore; infine, a mezzogiorno, si fermavano per allestire il campo dove
avrebbero trascorso la notte.
Mentre gli ausiliari si procuravano cibo, foraggio e legna da ardere, i legionari
estraevano dagli zaini i loro attrezzi e approntavano un campo fortificato – un nuovo
campo ogni giorno, quando erano impegnati in una campagna. Protette da reparti di
fanteria e cavalleria, le unità che dovevano tracciare o spianare la strada (al comando
di un tribuno) precedevano il grosso dell’esercito, sceglievano un sito elevato e lo
ripulivano; dopodiché, avvalendosi di specifici indicatori per le strade e le tende, lo
delimitavano come sede del nuovo accampamento, secondo un modello che rimarrà
inalterato per secoli. Trascorsi pochi mesi, quando il resto dell’armata giungeva in
loco, i legionari erano in grado erigere il loro campo praticamente a occhi chiusi.
Mentre una coorte proveniente da ciascuna legione montava la guardia, gli altri
soldati scavavano una trincea attorno al sito, usando il materiale rimosso per alzare
un terrapieno che circondasse tutto il fossato. Polibio, al quale dobbiamo
ricostruzioni molto dettagliate dei campi legionari, riporta che di solito il terrapieno
era alto dodici piedi (circa tre metri e mezzo), mentre il fossato, altrettanto
profondo, era largo tre piedi (quasi un metro). Cesare preferiva che quest’ultimo
fosse largo quindici piedi (più di quattro metri).
Dopo aver abbattuto il numero necessario di alberi, i legionari munivano il campo
di quattro cancelli di legno e di altrettante torri di guardia, che avrebbero bruciato
l’indomani prima di riprendere il cammino. I congegni balistici erano collocati lungo il
parapetto. Il bestiame, il bottino e i prigionieri occupavano uno spazio di duecento
piedi (quasi settanta metri) tra il terrapieno e le tende: una distanza attentamente
calcolata per evitare che frecce incendiarie potessero mandare a fuoco gli
alloggiamenti del campo.
Il praetorium – la tenda del quartier generale di Cesare – veniva allestito per primo,
poi veniva il turno delle tende dei suoi vice (compreso il generale Balbo, capo di stato
maggiore), seguite dagli alloggi individuali dei tribuni e dei centurioni. Fatto questo,
si passava alle officine, alla fureria e al mercato del campo. Per ultime venivano le
tende dei soldati, ciascuna delle quali ospitava dieci uomini. In origine queste tende,
disposte lungo gli spazi assegnati a ciascuna coorte, erano ricavate da pelli animali,
ma a partire dal I secolo le pelli furono accantonate in favore della tela di canapa.
Mentre lavorava all’allestimento del campo, un legionario poteva liberarsi di
scudo, giavellotto, elmo e zaino, ma non di lorica, spada e pugnale. In questo modo,
sarebbe sempre stato pronto a scendere in azione nel caso di un improvviso attacco
nemico. Chi contravveniva a questa disposizione rischiava la pena di morte. Una
volta che l’accampamento era completato – o sbocciato rapidamente come una
piccola città, per citare Giuseppe Flavio –, le sentinelle raggiungevano i loro posti e
iniziavano un turno di guardia di tre ore, sotto il controllo di quattro soldati della
cavalleria legionaria, incaricati di fare rapporto nel caso una sentinella si assentasse o
si addormentasse (due condotte punite entrambe con la pena capitale).
La spedizione in Lusitania costituì un perfetto «battesimo del fuoco» per le giovani
reclute della Decima legione. La fatica quotidiana di allestire un nuovo campo dopo
avere marciato per venticinque miglia; la disciplina di ferro e le punizioni brutali;
queste e altre esperienze contribuirono al rapido apprendistato militare della
Decima, temprandola e indurendola ancora prima che si scontrasse con le tribù del
Portogallo. In Lusitania molti legionari uccisero il loro primo uomo, imparando a
obbedire agli ordini di Cesare senza fiatare. La rigida disciplina inculcata dai
centurioni stava dando i suoi frutti. In quei mesi della primavera e dell’estate del 61
a.C., marciando, scavando fossati, partendo alla carica, abbattendo porte di città e
fortezze con gli arieti, appoggiando scale alle mura nemiche e salendoci sopra per
scavalcare l’ostacolo, scatenandosi come una tempesta su borghi e villaggi, passando
a fil di spada chiunque si parasse loro davanti, i giovani inesperti della Decima si
trasformarono in soldati. E la loro legione, in una macchina di morte.
Durante quei pochi, roventi mesi, la Decima legione aiutò Cesare a sottomettere le
tribù della penisola iberica occidentale tra i fiumi Tago e Duero – entità tribali come i
galleci e i lusitani (che avevano dato il nome alla regione) –, e ad aprirsi la strada
verso la costa nordoccidentale dell’Atlantico, «l’Oceano», come lo chiamavano i
romani. Le città caddero una dopo l’altra, e migliaia di indigeni furono uccisi o fatti
prigionieri. Questi ultimi vennero venduti ai mercanti di schiavi che seguivano le
legioni. Accanto a loro, le truppe di Cesare erano accompagnate da commercianti e
prostitute che si guadagnavano da vivere grazie alle legioni, oltre che da mogli de
facto e figli illegittimi dei soldati e dai servitori personali degli ufficiali. Spesso il loro
numero superava quello delle truppe alle quali si accodavano.
Secondo le regole di saccheggio in uso nell’esercito romano, il bottino di una città
espugnata andava diviso tra i legionari. Ma se una città si arrendeva, erano i generali
che dovevano decidere in totale autonomia le modalità di distribuzione. A costoro
spettava anche il compito di stabilire se i prigionieri andassero giustiziati o venduti
come schiavi. Per quanto riguarda i guadagni di quest’ultima attività, Tacito riporta
che il denaro ottenuto dalla vendita dei nemici «combattenti» andava ai legionari;
mentre quello ricavato dalla vendita dei prigionieri «civili», no. A ogni modo, generali
scaltri come Cesare si assicuravano sempre che alle truppe non mancasse mai, in
alcuna circostanza, una parte di bottino.
Molti prigionieri venduti come schiavi sarebbero morti in condizione servile; ma
alcuni di loro, più fortunati, avrebbero riottenuto la libertà grazie a padroni generosi.
Spesso erano le volontà testamentarie del proprietario a stabilire che uno o più
schiavi fossero liberati. Del resto, i romani più facoltosi potevano contare su almeno
20000 schiavi, divisi tra innumerevoli proprietà; sicché rinunciare a cento o duecento
tra costoro non era poi un gran sacrificio. Talvolta capitava che alcuni prigionieri di
guerra fossero condannati alla schiavitù per un preciso periodo di tempo, di solito
trent’anni. Quanto ai mercanti di schiavi, conducevano un’esistenza pericolosa,
accampati in tende prive di difesa all’esterno dei campi fortificati delle legioni. Come
testimoniato più volte durante il I secolo, non era raro che gli accampamenti degli
schiavisti venissero attaccati e distrutti dai nemici dell’esercito romano.
Quando, nell’autunno del 61 a.C., l’Ottava, la Nona e la Decima legione ritornarono
vittoriose ai loro quartieri invernali fuori Cordova, con poche perdite e un cospicuo
bottino, Cesare non solo fu salutato dalle sue truppe come un magnifico condottiero,
ma tornò a Roma con la fama dell’eroe.
Dopo appena un anno in Spagna ulteriore, il generale si congedò dalla Decima,
andando senza dubbio a salutare di persona tutti i centurioni. Quindi organizzò una
parata delle truppe, nel corso della quale, assiso sul tribunal del campo (la
piattaforma situata di fronte agli alloggi dei tribuni, utilizzata per tenere discorsi o
amministrare la giustizia), ringraziò i soldati delle tre legioni per il loro coraggio e la
loro lealtà. Un ringraziamento particolare andò alla Decima, che Cesare considerava
ormai la sua legione. Alla luce di quel che accadde in seguito, è probabile che il
generale abbia promesso agli uomini della Decima che, se avesse ancora avuto
l’opportunità di comandare truppe al servizio di Roma, senza dubbio si sarebbe
rivolto a loro, e non solo per utilizzarli come avanguardia dell’esercito, ma anche
come proprie guardie del corpo. Così, Cesare lasciò il campo legionario e si apprestò
a tornare a Roma, sempre via terra, con gli «evviva!» dei suoi soldati che gli
risuonavano nelle orecchie.
Appena rientrato nella capitale, il generale si trovò ad affrontare un dilemma. Dal
suo punto di vista, lo straordinario successo militare conseguito in Spagna lo rendeva
degno di un «trionfo», ovvero di uno dei riconoscimenti più prestigiosi che un
generale romano potesse ricevere. Durante il trionfo, il condottiero percorreva le
strade di Roma su un cocchio dorato tra due ali di folla esultante, seguito dalle sue
truppe e dal bottino di guerra. Di conseguenza, Cesare inviò dei messi per chiedere
che il senato gli concedesse tale onore. La risposta fu che poteva godersi un trionfo o
correre per la carica di console, ma non entrambe le cose.
Prima di vedersi assegnato un trionfo, il candidato doveva aspettare fuori dalle
mura di Roma che il senato decidesse in merito. Per essere eletto console, al
contrario, il candidato doveva restare in città. Costretto a scegliere tra consolato e
trionfo, Cesare optò per il primo. Nella tarda età repubblicana, i due consoli nominati
annualmente costituivano la più alta autorità romana; e il motto di Cesare era: «Il
potere prima della gloria». Così, al termine di un’elezione molto combattuta, il
condottiero conseguì il consolato nel 59 a.C., diventando l’equivalente antico di un
generale di corpo d’armata.
Cesare, tuttavia, non aveva ancora finito con la Decima legione. Anzi, il loro
rapporto era appena agli inizi.
3. ELVEZI E GERMANI
Cesare rimase pensieroso un istante, mentre osservava i visi impolverati degli
esploratori della cavalleria. Si sarebbe ricordato per tutta la vita di quel giorno ricco
di eventi, e ne avrebbe scritto nelle sue memorie.
Si rivolse al suo furiere e gli domandò: «Quanti giorni ancora dureranno le razioni
degli uomini?».
«Due giorni» rispose il furiere.
Cesare annuì. Un esploratore lo aveva informato che si trovavano a diciassette
miglia da Bibracte, la capitale della tribù degli edui. Un altro ricognitore aveva
aggiunto che l’imponente colonna della tribù svizzera degli elvezi, che avevano
inseguito per settimane attraverso la Francia orientale, era ancora accampata, come
il giorno prima, a tre miglia di distanza dall’esercito romano.
«Marceremo su Bibracte» annunciò Cesare; dopodiché chiamò il generale di
divisione Tito Labieno – poco più che trentenne e comandante in seconda – per
informarlo della sua intenzione di assicurarsi gli approvvigionamenti necessari dagli
edui, ancora prima di affrontare gli elvezi. Detto questo, ordinò che le trombe
suonassero il «prepararsi alla marcia».
Correva l’estate del 58 a.C., e Giulio Cesare aveva mantenuto la promessa fatta alla
Decima legione. All’inizio dell’anno, appena nominato governatore della Gallia
cisalpina e dell’Illirico, aveva ricevuto dal senato l’incarico di badare anche alla Gallia
transalpina, dopo la morte del suo governatore. Così, Cesare aveva richiamato la
Decima dalla Spagna, acquartierandola nella Francia meridionale.
Allo stesso tempo, forte dell’autorizzazione senatoriale (propiziata da Pompeo) a
disporre liberamente di quattro legioni per cinque anni, il condottiero aveva raccolto
le altre due unità che aveva comandato tre anni prima – l’Ottava e la Nona – e, in
compagnia della Settima (l’ennesimo reparto ispanico istituito da Pompeo), le aveva
accampate ad Aquileia, nell’Italia nordorientale, in modo tale che si trovassero a
metà strada tra le sue province. Ma prima che l’inverno fosse trascorso, Cesare
aveva ricevuto la notizia che la popolosa tribù svizzera degli elvezi stava migrando
alla volta della Gallia meridionale, dove Roma possedeva una grande e prosperosa
provincia. Gli elvezi avevano inviato messaggi a tutti i loro clan, nonché a quattro
tribù intenzionate a unirsi alla migrazione, affinché si raccogliessero sulle sponde del
Rodano il 28 marzo, per poi penetrare in Francia attraverso il ponte di Ginevra. Ma
Cesare era risoluto a fermarle.
Il condottiero romano non perse tempo: raggiunse Ginevra con la Decima legione,
distrusse il ponte sul Rodano e fece erigere dai soldati un terrapieno alto sedici piedi
(quasi cinque metri) e lungo diciotto miglia. Questo vallo difensivo costeggiava il
Rodano dal lago di Ginevra al massiccio del Giura. Gli elvezi tentarono per settimane,
con il favore delle tenebre, di attraversare il fiume su barche e zattere, o anche
semplicemente nuotando, ma le legioni romane e il terrapieno si rivelarono un
ostacolo insuperabile. Visto l’insuccesso dei loro tentativi, gli elvezi furono costretti a
scegliere un’altra via, tra il Rodano e il massiccio del Giura: un percorso che li portò a
sciamare nel territorio degli edui della Francia orientale (l’odierna Borgogna, tra la
Saona e la Loira). Gli edui chiesero aiuto a Cesare per respingere gli invasori, e lui non
tardò a rispondere. Dopo aver reclutato velocemente due nuove legioni nell’Italia
settentrionale (l’Undicesima e la Dodicesima), le riunì ai reparti già costituiti e marciò
alla volta della Francia meridionale per dare battaglia agli elvezi.
I suoi piani iniziali furono però compromessi dall’errore di un soldato. Cesare aveva
tallonato per settimane la retroguardia della poderosa colonna degli elvezi,
preoccupandosi di rimanere sempre a cinque o sei miglia di distanza dal nemico, in
attesa del momento propizio per sferrare l’attacco. A un certo punto, gli elvezi si
accamparono ai piedi di una grande collina. Una pattuglia di cavalleria, di ritorno da
una perlustrazione sul versante opposto del pendio, informò il condottiero che non
sarebbe stato difficile inerpicarsi lassù. Così, poco dopo mezzanotte, Cesare inviò il
generale Tito Labieno e due legioni a scalare la collina, mentre lui l’avrebbe assaltata
dalla parte opposta con le altre quattro legioni. Il condottiero spedì avanti la sua
cavalleria e, ancora più in avanscoperta, una pattuglia comandata da un ufficiale di
nome Publio Considio.
Poco dopo l’alba, Cesare si trovava a solo un miglio e mezzo dalla collina, quando
Considio lo raggiunse al galoppo e gli urlò con il fiato in gola: «Torna indietro, Cesare!
Il nemico occupa la cima del rilievo; ho riconosciuto le loro armi e i cimieri degli
elmi».
Uno dei più stretti aiutanti di Cesare, l’alto ufficiale (e futuro generale) Gaio Asinio
Pollione, avrebbe scritto in seguito che il suo superiore aveva l’abitudine di accettare
i rapporti dei subordinati senza alcuna verifica. Così avvenne anche quella volta:
messo sull’avviso da Considio, Cesare si ritirò e si assestò su un altro pendio. Solo più
tardi, quello stesso giorno, si accorse che erano le legioni di Labieno a occupare la
cima del colle, non il nemico.
Cesare ricorda che Labieno lo aspettò per tutto il giorno sulla collina, prima di
essere costretto a ritirarsi. In proposito, Plutarco sostiene che Labieno si scontrò
effettivamente con il nemico, ma il racconto fatto da Cesare di questa sfortunata
operazione appare più credibile. Tito Labieno pretese qualche spiegazione, quando si
riunì con il suo comandante in capo. Ottimo soldato, energico, intuitivo, provvisto di
un eccellente senso tattico, Tito era altresì noto per il suo sarcasmo, che di solito
riservava ai ranghi più bassi.
Stando alle sue memorie, Cesare disse bruscamente a Labieno: «Considio ha perso
la testa. Mi era stato raccomandato come un ufficiale di classe superiore, che aveva
servito sotto Silla e Crasso. Ma oggi mi ha riferito di aver visto qualcosa che in realtà
non aveva visto».
Le legioni si erano allontanate dalla colonna degli elvezi e si stavano dirigendo
verso Bibracte per rifornirsi di grano dagli edui, quando il colonnello Lucio Emilio,
comandante della cavalleria gallica, si staccò dalla retroguardia e raggiunse Cesare al
galoppo.
«Gli elvezi ci stanno seguendo» disse Emilio. «La loro cavalleria sta impegnando le
mie unità, e l’intera colonna nemica è in movimento sulla strada per Bibracte dietro
di noi.»
Cesare si precipitò verso la retroguardia dell’esercito e vide con i suoi occhi la
polvere sollevata a est dai piedi, dagli zoccoli e dai carri degli elvezi, che li seguivano
a decine di migliaia. Valutata la situazione, il condottiero ordinò a Lucio Emilio di
radunare tutta la cavalleria e di tenere testa al nemico, così che le legioni avessero
tempo di prepararsi alla battaglia. Dopo che i suoi 4000 cavalieri, reclutati nella
Francia centrale e meridionale, si furono allontanati con il colonnello, Cesare scelse
una collina erbosa lì vicino per schierare la sua prima linea, e in un’improvvisata
conferenza a dorso di cavallo concordò con gli altri generali la disposizione
complessiva delle truppe. Presto le trombe squillarono, gli stendardi si inclinarono; e
le legioni, lasciata la strada, si diressero verso la collina.
La Decima e altre tre unità ispaniche (la Settima, l’Ottava e la Nona) si schierarono
su tre linee a metà del colle. Le due nuove legioni (l’Undicesima e la Dodicesima)
presero posizione sulla cima del rilievo insieme agli ausiliari – Cesare non riponeva
grande fiducia in questi reparti. I veterani delle vecchie legioni occuparono la terza
linea e cominciarono a scavare freneticamente dei fossati attorno ai carri delle
vettovaglie. Gli zaini di tutti i soldati dell’armata furono accatastati in un unico
recinto. Mentre formavano le linee e preparavano le trincee, i legionari potevano
vedere gli elvezi occupare senza fretta la pianura di fronte a loro.
Tra gli uomini della Decima schierati in prima linea c’era il centurione Gaio
Crastino. Con il grado evidenziato da un pennacchio di piume d’aquila sull’elmo, gli
schinieri di metallo sugli stinchi, la spada agganciata al fianco sinistro anziché a
quello destro (a differenza dei coscritti), il centurione Crastino era stato in servizio
nell’Ottava o Nona legione nel 65 a.C., quando Pompeo Magno aveva costituito
nuove unità in Spagna. Poi era approdato alla Decima all’epoca della sua creazione,
quattro anni più tardi, assumendo il grado di centurione «semplice». Era stato Cesare
a sceglierlo personalmente. Adesso, all’età di ventisette anni, comandava una coorte
di seicento uomini. Crastino, senza dubbio, conosceva molto bene il suo mestiere.
Era un combattente temerario, ma c’era voluto ben più del coraggio per conquistare
la stima e il rispetto dei suoi uomini. Il fatto è che Crastino si interessava al loro
benessere, sia prima che dopo una battaglia, e non si stancava mai di incoraggiarli.
Poche settimane prima, le legioni avevano sventato un nuovo tentativo degli elvezi di
attraversare un fiume; non più il Rodano, stavolta, bensì la Saona. In quell’occasione
Crastino, fedele al suo modo d’essere, era corso da un manipolo all’altro della sua
coorte, per esortare e galvanizzare i suoi uomini.
Immobile all’estrema sinistra della prima linea, Crastino probabilmente rifletteva
sulla stessa questione che preoccupava i suoi soldati, quando avevano visto gli elvezi
attestarsi nella pianura. Qualche tempo dopo, i romani avrebbero trovato nel campo
avversario un registro, scritto in greco, contenente i nomi di 368 000 uomini, donne e
bambini che avevano partecipato alla migrazione dalla Svizzera. E adesso, gran parte
di costoro era lì sotto.
Intanto gli elvezi a cavallo erano riusciti a disperdere Lucio Emilio e la sua
cavalleria, dandole la caccia per tutta la pianura, mentre il grosso delle loro truppe si
stava avvicinando – con tanto di carri – alla collina. I vecchi, le donne e i bambini
degli elvezi ammassarono i veicoli alla base del colle, mentre i loro uomini, suddivisi
per clan di appartenenza, si disponevano in solide e profonde falangi d’attacco. Gli
avversari dei romani portavano il tradizionale elmo piumato delle tribù galliche (il
loro cimiero ricordava la coda di un cavallo), una piccola corazza e una lancia della
lunghezza di dodici piedi (circa tre metri e mezzo). Gli elvezi erano celti, di
costituzione più robusta rispetto a quella romana, molto coraggiosi e ottimi
conoscitori dell’arte della guerra. In passato avevano già sconfitto i soldati di Roma, e
confidavano di poterlo fare anche oggi.
Quando Crastino guardò giù dal pendio, vide Cesare scendere da cavallo e
allontanare l’animale. Come da istruzioni ricevute, tutti i suoi ufficiali fecero lo
stesso. Il centurione stimava profondamente Giulio Cesare fin dai tempi della
Spagna, ed era convinto che fosse un uomo eccezionale, destinato a grandi imprese.
Di conseguenza, Crastino capì subito che Cesare, con quel gesto, aveva voluto
lanciare un messaggio inequivocabile: ora tutte le truppe romane, dagli ufficiali
superiori all’ultimo dei soldati semplici, affrontavano gli stessi pericoli su un piede di
parità.
Se l’intelligenza di Crastino era pari al suo coraggio, sicuramente egli non avrebbe
apprezzato alcuni generali di Cesare assai meno di Cesare stesso. Infatti, molti
ufficiali superiori presenti sul campo erano semplici emissari del senato, di dubbia
preparazione militare, che Cesare era stato costretto a prendere con sé. Era facile
riconoscerli dai loro mantelli scarlatti. C’erano quelli che camminavano
nervosamente avanti e indietro; altri che confabulavano con i loro aiutanti; altri
ancora – non più di un paio – che brandivano risolutamente gli scudi. Anche se la
campagna era iniziata solo da pochi mesi, Crastino aveva già catalogato i vizi e le
virtù di ciascun componente dello stato maggiore di Cesare. Labieno, il comandante
in seconda: un generale dannatamente in gamba a dispetto della sua lingua
tagliente, impassibile di fronte al pericolo, capace di capire al volo sia i rischi che le
opportunità. Galba: troppo sicuro di sé, meschino, ambizioso. Pedio, congiunto di
Cesare: giovane, ma competente e affidabile. Sabino: sciocco, ingenuo, troppo
incline a non correre rischi; l’uomo sbagliato al posto sbagliato. Cotta: testardo,
polemico, ma ufficiale provetto. Crasso, il figlio minore del console Crasso che aveva
liquidato Spartaco e il suo esercito di schiavi: un ragazzo amabile, intelligente, con un
grande futuro davanti a sé. E infine Balbo, il capo di stato maggiore: un provinciale
della Spagna ulteriore, di famiglia molto benestante, leale, affidabile, gran
organizzatore e abile mediatore. Destinato più tardi a diventare segretario privato di
Cesare (nonché, alla morte di questi, curatore dei suoi scritti), sarà eletto console nel
40 a.C.: primo provinciale ad assumere questa carica.
Quando Crastino gettò una rapida occhiata a destra, vide le facce dei suoi uomini
perfettamente schierati: le espressioni risolute, gli occhi fissi alla pianura, qualche
viso esangue per la tensione. Il vento frusciava tra i cimieri gialli, di crine di cavallo,
che adornavano i loro elmi; il sole brillava sulle decorazioni al valore che, per ordine
di Cesare, avevano indossato per intimidire i celti; gli scudi erano pronti al braccio
sinistro di ogni soldato. Polibio ci racconta che lo scudo legionario – di forma
rettangolare e leggermente incurvato – aveva lo spessore di un palmo, era alto
quattro piedi (poco più di un metro) e largo due piedi e mezzo (quasi ottanta
centimetri). Era costituito da due strati di legno ricoperti di canapa e pelle di vitello;
la borchia metallica al centro era fissata al manico sul retro. Ogni scudo della Decima
recava dipinto l’emblema del toro. Ciascun soldato brandiva due giavellotti con la
mano destra, in attesa di scagliarli. La spada pendeva dal fianco destro. Una volta che
i giavellotti fossero stati lanciati, Crastino avrebbe ordinato ai legionari di sguainare
la spada, in vista del probabile corpo a corpo con il nemico.
Se Crastino avesse rivolto lo sguardo al cielo, si sarebbe accorto che il sole era
perfettamente perpendicolare alla sua testa.
Passando in rassegna la prima linea, Cesare arringò le sue truppe. Sopra di lui, la
collina era occupata da 40 000 uomini. Il condottiero aveva già tenuto innumerevoli
discorsi pubblici, e in futuro avrebbe persino scritto un libro sull’argomento. Scelse
ogni parola con cura, modulando attentamente il tono della voce affinché tutti,
compresi i ranghi più lontani, potessero sentirlo con chiarezza. Lodò i soldati, e
chiese loro l’ennesima vittoria. Deve essere stato un discorso breve, visto che gli
elvezi, dopo aver accorpato le falangi in un unico denso gruppo di lancieri, stavano
già avanzando verso la collina.
La falange – uno schieramento che gli antichi eserciti greci avevano portato alla
perfezione – si basava essenzialmente su due punti di forza. L’originale modello
ellenico era costituito da sedici file di soldati, tali da creare un muro di lance che
sporgevano dalla prima linea, simili agli aculei di un porcospino, per otto piedi, circa
due metri e mezzo. All’interno di questa formazione a ranghi serrati, gli uomini
univano strettamente i loro scudi, erigendo una barriera protettiva quasi
impenetrabile dalla prima all’ultima fila. Non sappiamo quanto fosse profonda la
falange degli elvezi, ma data la quantità di guerrieri a disposizione, doveva trattarsi di
uno spiegamento di tutto rispetto.
Cesare si ritirò dietro la sua seconda linea e attese che la falange cominciasse a
muoversi a passo d’uomo su per le prime balze della collina, verso il fronte romano;
dopodiché, impartì un ordine. Urlando a squarciagola, migliaia di legionari
scagliarono i loro giavellotti. Dopo pochi istanti, un’altra salva sibilò nel cielo.
Mentre si inerpicavano sul pendio, con la collina sopra di loro infestata di legionari
e il cielo punteggiato di giavellotti, gli elvezi alzarono istintivamente gli scudi per
proteggersi dai dardi nemici: manovra inutile, come si accorsero ben presto.
Quarant’anni prima, il console Mario aveva rivoluzionato il giavellotto romano,
forgiandolo in un metallo leggero (tranne la punta). Quando l’arma colpiva il
bersaglio, il peso dell’asta la faceva ondeggiare, distorcendola fino a renderla
inutilizzabile. In questo modo, come gli elvezi capirono quel giorno, il giavellotto non
poteva essere rispedito indietro, tantomeno estratto dallo scudo che aveva colpito.
Ancora peggio, visto che gli elvezi tenevano gli scudi accostati, ogni giavellotto
poteva infilzarne più d’uno, «inchiodandoli» assieme. Fu così che la falange elvetica
si sfaldò al primo tiro di sbarramento.
Cesare impartì un altro ordine. Fece inclinare la sua bandiera e ingiunse alle
trombe della prima linea di suonare la carica. Con un ruggito, la prima fila legionaria
si scagliò giù dalla collina con le spade sguainate. Molti elvezi cercarono
disperatamente di rimuovere i giavellotti dai loro scudi; non riuscendoci, se ne
liberarono, restando praticamente indifesi. Facendosi largo tra le lance nemiche
(numerosissime ma assai poco maneggevoli), i legionari fecero a pezzi i celti,
infliggendo loro terribili lesioni al collo, alle spalle, alle braccia e al torace.
Malgrado le loro ferite e il numero dei caduti che aumentava sempre di più, gli
elvezi si difesero coraggiosamente, ma alla fine dovettero cedere terreno e ritirarsi
dalla collina, aprendosi la strada armi in pugno e arretrando per un miglio. Dopo aver
lasciato l’Undicesima e la Dodicesima legione a guardia delle vettovaglie, Cesare
ordinò alle tre linee più avanzate di inseguire il nemico a passo di marcia e in
formazione di battaglia. Ma appena le truppe romane si avvicinarono al loro
obiettivo, 15 000 uomini appartenenti ai clan dei boi e dei tulingi, che fino a quel
momento erano rimasti nella retroguardia, si avventarono sul fianco destro dello
schieramento avversario. Incoraggiati da questo attacco a sorpresa, gli elvezi
ricomposero le loro fila e tornarono a farsi sotto.
Cesare reagì velocemente e risolutamente alla nuova minaccia, ordinando alla
prima e alla seconda linea romana di impegnare il grosso delle forze avversarie,
mentre la terza linea si sarebbe precipitata sul fianco destro per respingere i boi e i
tulingi. Con uno squillo di tromba, le legioni caricarono su due fronti. Più e più volte
partirono all’assalto, in una lunga serie di cariche. Lo scontro andò avanti per tutto il
pomeriggio. Neppure un guerriero elvetico si voltò per fuggire, ma a poco a poco le
unità dei celti furono isolate e costrette alla ritirata. Un analogo destino toccò anche
agli elvezi rimasti sulla collina: incalzati dagli uomini del centurione Crastino,
dovettero arretrare precipitosamente. Quanto ai nemici sul fianco destro, ci
pensarono i soldati delle altre legioni a farli retrocedere fin dove avevano ammassato
i loro carri.
Sulla collina, la Decima legione e le altre unità romane cessarono di combattere al
tramonto. Al contrario, gli scontri attorno alla zona dei carri si protrassero per parte
della notte, con gli elvezi, asserragliati sui veicoli, che si difendevano con lance e
picche. Alla fine, tuttavia, le legioni riuscirono a sfondare. Tutti i beni e le vettovaglie
della tribù caddero in mano romana, come pure parecchi «non combattenti» e alcuni
fanciulli della nobiltà elvetica. Il bottino fu diviso tra le legioni. Più tardi si stimò che
quella notte 130000 elvezi erano riusciti a scappare dal teatro della battaglia. Quanto
ai caduti, fu impossibile contarli: erano troppi.
A Cesare occorsero tre giorni per curare i feriti e seppellire i morti di entrambi gli
schieramenti; dopodiché riprese a inseguire quel che rimaneva degli elvezi. Il
centurione Crastino era al comando dei suoi uomini della Decima quando, lungo la
strada, la colonna romana fu avvicinata da alcuni ambasciatori del nemico. Allorché
furono condotti alla presenza di Cesare, costoro si prostrarono di fronte a lui e, in
lacrime, lo supplicarono di cessare le ostilità. Il condottiero ordinò loro di ricomporsi
e di aspettare le sue decisioni.
Gli elvezi obbedirono, e l’esercito romano li ritrovò mentre attendevano
ansiosamente a qualche miglio di distanza. Adesso la loro gente viaggiava a piedi:
donne, vecchi, bambini, guerrieri sopravvissuti; non uno che non fosse stanco,
affamato, infangato, e sconfitto. Le legioni li guardarono in silenzio deporre le armi,
restituire gli schiavi romani fuggiti e offrire ostaggi. Fatta eccezione per i 6000
guerrieri che, dopo essere sgusciati via con il favore delle tenebre, erano stati
rastrellati da tribù fedeli a Roma e messi a morte, gli elvezi furono trattati con
clemenza. Cesare, difatti, stabilì che dovessero semplicemente tornare in Svizzera,
non prima di aver riparato i danni che la loro migrazione aveva causato a città,
villaggi e fattorie. Così, la tribù rientrò nei suoi vecchi confini, per non uscirne mai
più. Non è un caso che ai giorni nostri la denominazione ufficiale della Svizzera sia
quella di Confederazione elvetica.
La Decima legione non aveva ancora finito di combattere quell’anno. A metà estate
del 58 a.C., sulla scia del successo della campagna di Cesare contro gli elvezi, le tribù
della regione si rivolsero al condottiero chiedendogli di liberarle dalla minaccia
costituita dai feroci guerrieri del re germanico Ariovisto, che avevano invaso la Gallia
settentrionale. Cesare impartì alle legioni il solito ordine: «Prepararsi alla marcia». Le
trombe legionarie, come d’abitudine, ripeterono il segnale tre volte.
L’accampamento trasecolò. Le truppe prepararono i carri delle vettovaglie e si
disposero in formazione. Al terzo segnale, le formazioni alla guida si misero in
marcia.
Poiché i germani avanzavano a sud verso il territorio dei sequani (corrispondente
all’odierna Alsazia, nella Francia orientale), Cesare raggiunse la capitale di quella
tribù, Vesonzione (l’odierna Besançon), dopo un cammino a tappe forzate di tre
giorni, quindi occupò la città, che sorgeva su un’ansa a ferro di cavallo del fiume
Doubs, a est dell’attuale Digione. Qui le truppe romane si mescolarono ai locali e
raccolsero molte voci sull’immensa forza e la terrificante bravura militare dei
germani che si stavano dirigendo verso di loro. I tribuni di nomina più recente e i
comandanti delle unità ausiliarie – viziati giovincelli appena arrivati da Roma e per lo
più privi di qualunque esperienza sul campo – furono negativamente colpiti da tali
chiacchiere. La loro paura crescente dei germani si diffuse tra le truppe. I discorsi
attorno ai bivacchi si incupirono; gli uomini si prepararono al peggio stendendo e
sigillando le loro ultime volontà. Veterani rotti a ogni esperienza come Gaio Crastino
si recarono da Cesare per avvertirlo che, quando avesse dato l’ordine di muovere
verso il nemico, le truppe avrebbero potuto rifiutarsi di eseguirlo.
A quel punto, il condottiero convocò tutti i centurioni, annunciando loro che
intendeva spostare il campo quella notte stessa. Se necessario – aggiunse –, avrebbe
marciato contro Ariovisto anche solo con la Decima legione; un’unità nella quale
riponeva la massima fiducia e che non l’avrebbe mai deluso. In quell’occasione,
ribadì la promessa di trasformare la Decima nella sua guardia del corpo. Dopo aver
ascoltato queste parole, gli uomini della legione chiesero ai loro tribuni di ringraziare
Cesare per l’alta considerazione espressa nei loro riguardi, e di assicurarlo che erano
pronti a seguirlo all’istante, infischiandosene di quello che avrebbero fatto le altre
legioni. Ma il resto dell’esercito non aveva alcuna intenzione di lasciare alla Decima
tutta la gloria (come pure il bottino); così, si preparò a entrare in azione. Nelle prime
ore del mattino, tutte le sei legioni dell’armata romana lasciarono Vesonzione e si
diressero al loro fatale appuntamento con le orde germaniche. Dopo sei giorni di
marcia ininterrotta, gli esploratori comunicarono a Cesare che Ariovisto era a solo
ventitré miglia di distanza.
Nessuno dubitava del coraggio di Giulio Cesare. Secondo Svetonio, il condottiero si
era già guadagnato la corona civica – uno dei massimi riconoscimenti romani al
valore – nell’81 a.C., quando era ancora un giovane ufficialetto di diciannove o
vent’anni. A quell’epoca aveva salvato la vita a un compagno durante l’assalto a
Mitilene, il centro principale dell’isola di Lesbo. E nel corso delle successive
operazioni in Spagna, Svizzera e Francia, era sempre stato in prima linea. Peraltro,
dire che Cesare fosse coraggioso non equivale a dire che fosse scioccamente incauto.
Contro Ariovisto, non a caso, scelse la via della prudenza.
Quest’ultimo, re della tribù germanica dei suebi (o svevi), aveva inviato al
condottiero romano un messaggio con il quale accettava la proposta di una
conferenza di pace, aggiungendo però una condizione piuttosto insolita: i capi dei
due eserciti avrebbero dovuto essere scortati soltanto da reparti a cavallo. Tale
clausola indusse Cesare a sospettare che i germani avessero corrotto qualche
membro della sua cavalleria gallica, dandogli l’incarico di ucciderlo nel corso della
conferenza o lungo la strada per arrivarci. Così, a titolo precauzionale, ordinò alla sua
cavalleria di smontare a terra, lasciando i destrieri agli uomini della Decima legione.
Fu a partire da questo momento – si disse più tardi – che egli iniziò a considerare i
legionari della Decima come uomini di cui si poteva fidare ciecamente.
Mentre i legionari montavano a cavallo, un soldato della Decima commentò:
«Cesare mantiene più di quanto ci aveva promesso. Altro che guardie del corpo;
adesso ci ha nominato addirittura cavalieri!». Il condottiero sorrise quando gli
riferirono la battuta, e se ne ricordò allorché scrisse le sue memorie.
L’incontro con i germani avvenne su un’altura a metà strada fra gli accampamenti
dei due eserciti. I «cavalieri» della Decima si schierarono a trecento iarde (poco più di
duecentocinquanta metri) dietro il loro generale; la scorta di Ariovisto fece lo stesso.
Accompagnati da dieci uomini ciascuno, e a dorso di cavallo, il condottiero romano e
il sovrano germanico si impegnarono in un confronto serrato, faccia a faccia. Mentre
i due continuavano a discutere – ciascuno voleva che fosse l’altro a ritirarsi dal
territorio –, un cavaliere dei germani tentò di provocare i legionari della Decima,
costringendo Cesare a interrompere la discussione per ordinare ai suoi uomini di non
reagire. La giornata si concluse senza vinti né vincitori.
Il giorno successivo, Cesare spedì due inviati per continuare la trattativa a suo
nome. Ariovisto li fece prigionieri, svelando le sue vere intenzioni. Per alcuni giorni,
le due armate cercarono di garantirsi un vantaggio tattico, con i germani che si
sforzavano di tagliare le linee di rifornimento romane da Vesonzione, e le truppe di
Cesare, schierate su due fronti, che facevano di tutto per sventare quella manovra.
Alla fine i germani sferrarono un attacco diretto, ma quando Cesare dispose le sue
truppe in formazione di battaglia, i germani sembrarono voler evitare uno scontro su
vasta scala. Interrogando dei prigionieri, Cesare venne a sapere che il nemico era
convinto che non avrebbe prevalso se si fosse impegnato in una battaglia campale
prima della luna nuova. Per il momento, Ariovisto preferiva attendere. A quel punto,
il condottiero romano decise di marciare sul campo avversario, a quindici miglia di
distanza dal fiume Reno, per costringere il re germanico a bruciare i tempi e
accettare un confronto diretto. Malgrado i suoi 40000 uomini fossero in inferiorità
numerica, Cesare era convinto di aver acquisito un vantaggio psicologico. Come si
sarebbe scoperto in seguito – Cesare ancora non lo sapeva – c’era anche un altro
vantaggio nell’ingaggiare subito battaglia. I rinforzi dei suebi, infatti, si stavano
avvicinando al Reno da est, con l’obiettivo di congiungersi all’esercito di Ariovisto.
Costretti a difendere il loro accampamento, i germani si precipitarono all’esterno e
si raggrupparono per tribù di appartenenza: gli arudi; i triboci; i vangioni; i nemeti; i
sedusi; i suebi (il gruppo tribale dominante) e i marcomanni. Questi ultimi,
provenienti dalla valle del Meno, erano destinati a crescere di numero e a esercitare
in futuro una notevole influenza. Entro mezzo secolo si sarebbero stabiliti in Boemia
e, 175 anni più tardi, durante il regno di Marco Aurelio, si sarebbero battuti
ferocemente contro la presenza romana. I guerrieri germanici superavano in statura i
soldati di Cesare; avevano spalle larghe, capelli lunghi e barbe fluenti. I loro nobili,
meglio armati ed equipaggiati delle truppe (prive di calzature e provviste solo di un
mantello di pelliccia), mostravano i capelli legati nel caratteristico nodo dei suebi.
L’arma principale dei germani era una lunga lancia.
La cavalleria di Cesare (4000 effettivi) e quella di Ariovisto (6000 uomini) si
trattennero mentre le legioni avanzavano nelle consuete tre linee di battaglia, con la
Decima sull’ala destra come da tradizione. Cesare assunse personalmente il
comando del fianco destro, perché su quel lato lo schieramento nemico appariva più
debole; e quando ordinò alle prime due linee di caricare, gli uomini della Decima si
avventarono entusiasticamente sul nemico.
Seppure colti di sorpresa, i germani reagirono così rapidamente che i legionari non
ebbero il tempo di scagliare i loro giavellotti. Di conseguenza, li deposero e
sguainarono le spade. Ormai le due armate erano faccia a faccia. I germani avevano
adottato la formazione a falange usata dagli elvezi, con le sue linee irte di lance che,
in teoria, li avrebbero tenuti fuori portata delle corte spade romane.
Imperterriti, gli uomini della Decima si scagliarono contro gli scudi della prima linea
nemica. Alcuni legionari riuscirono a strapparli dalle mani dei loro avversari; altri li
scavalcarono e iniziarono a menare fendenti sul viso dei nemici. Grazie a queste
tattiche aggressive, la Decima mise presto in rotta il fianco sinistro dello
schieramento di Ariovisto.
Nel frattempo, il fianco destro dei germani stava costringendo l’ala sinistra romana
ad arretrare. Conscio del pericolo, il giovane Publio Crasso, che Cesare aveva lasciato
in retroguardia con la cavalleria, ordinò alla terza linea di avanzare per alleggerire la
pressione su quel lato. Questa manovra segnò le sorti della battaglia. Poco dopo,
l’intero esercito di Ariovisto era in fuga. Le legioni inseguirono i nemici fino al Reno.
Qualche germano si salvò a nuoto; Ariovisto e un paio di dignitari scapparono a
bordo di barche, ma tutti gli altri, comprese le mogli e le figlie del re, furono uccisi o
fatti prigionieri dalla cavalleria romana. Quando i rinforzi dei suebi, a est del fiume,
seppero della disfatta del loro esercito, fecero dietrofront e si allontanarono in tutta
fretta. E così, la Decima legione poté aggiungere un’altra vittoria al suo albo d’onore.
4. ALLA CONQUISTA DELLA GALLIA
Per gli uomini della Decima era stata una campagna breve ma proficua. Avevano
spogliato dei loro beni migliaia di cadaveri elvetici e germani. Ne avevano
saccheggiato gli accampamenti e le salmerie. E tutto con pochissime perdite. In
autunno si erano attestati in un grande accampamento in Alsazia, non lontano
dall’odierna Besançon, preparandosi a svernare prima che Cesare li guidasse in
primavera verso altre avventure in Gallia. Il condottiero si era recato in Nord Italia
per espletare le sue funzioni di supremo magistrato in quella provincia, lasciando il
comando delle truppe al generale Labieno. Con l’arrivo dell’inverno, tuttavia,
Labieno cominciò a inviare a Cesare messaggi che riferivano come le tribù della Gallia
settentrionale – i belgi – pianificassero di attaccare i romani per impedire loro di
avanzare ulteriormente in quella regione. Cesare disponeva di spie all’interno delle
tribù, e quando queste confermarono i rapporti di Labieno, ruppe ogni indugio.
Dopo aver reclutato due legioni nell’Italia settentrionale – la Tredicesima e la
Quattordicesima –, Cesare tornò in Gallia per affrontare le tribù ribelli. Radunò le sei
legioni che svernavano in Alsazia e marciò con questo esercito rinforzato verso
l’odierna regione della Champagne-Ardenne, a nordest di Parigi, territorio dei remi,
alleati di Roma, con capitale l’attuale Reims. Si stima che le tribù belgiche potessero
contare su ben 260000 uomini, benché il numero che in effetti si schierò lungo il
fiume Aisne a nord di Reims ammontasse forse a un terzo di quella cifra.
Dopo che i due schieramenti avevano cercato di superarsi vicendevolmente in
astuzia, Cesare sconfisse i belgi utilizzando soltanto la cavalleria e gli ausiliari. Di
conseguenza, le tribù si ritirarono in disordine nei rispettivi territori. Questo permise
al condottiero romano di marciare contro di loro individualmente e di sconfiggerle
una alla volta nelle settimane successive, sovente accettandone la resa dopo aver
posto d’assedio le loro città. In tal modo, Cesare riuscì a sottomettere senza
spargimento di sangue i suessioni e i bellovaci – le due tribù belgiche più numerose –
, nonché gli ambiani, penetrando poi nel territorio dei nervi, a est della Schelda
(Belgio centrale).
I nervi erano un popolo di guerrieri valorosi, originari della Germania, che
proibivano la vendita di vino nelle loro terre reputando che rendesse gli uomini
imbelli. È quasi inutile aggiungere che non avevano alcuna intenzione di accettare
l’autorità di Roma. Grazie all’opera di alcune spie, riuscirono a scoprire l’ordine di
marcia legionario – Cesare era solito procedere con ogni legione separata dall’altra
dai carri delle salmerie – e scorsero l’opportunità di assalire parte della colonna
prima che le altre legioni potessero correre in aiuto. I nervi, disponendo di poche
truppe a cavallo, avevano da lungo tempo sbarrato i loro campi con alte siepi, per
rallentare la cavalleria nemica; questo stratagemma faceva sperare loro di poter
affrontare i romani senza temere l’intervento dei cavalieri di Cesare. Il re dei nervi,
Boduognato, convinse i suoi vicini belgici delle tribù degli atrebati e dei viromandui a
unirsi ai suoi guerrieri per preparare un’imboscata sulle rive del fiume Sambre.
Cesare, tuttavia, fu avvertito dai suoi esploratori dei movimenti nemici lungo il
fiume. Messo sull’avviso, il condottiero cambiò l’ordine di marcia man mano che si
avvicinava alla Sambre, disponendo in avanguardia la Decima e le cinque legioni più
esperte, seguite dalle salmerie al completo, mentre le due legioni costituite più di
recente sarebbero rimaste nella retroguardia. Vedendo piccoli drappelli della
cavalleria nemica sull’altra sponda, il condottiero fece guadare le sue truppe a
cavallo dove il fiume era profondo appena tre piedi (poco meno di un metro), e
ordinò ai legionari di cominciare ad allestire un campo fortificato sul fianco della
collina che digradava verso il corso d’acqua. La Decima e la Nona legione, agli ordini
di Labieno, furono assegnate al fianco sinistro del campo. La Settima e la Dodicesima
presero posizione a destra, mentre l’Ottava e l’Undicesima si piazzarono al centro.
La cavalleria dei nervi si ritirò a distanza di sicurezza, in un bosco che si affacciava
sulla riva scoscesa della Sambre, senza per questo rinunciare a qualche sortita contro
i cavalieri romani. Nel frattempo, deposti zaini, scudi e giavellotti, i legionari si misero
a lavorare alacremente all’allestimento del campo. Poco più tardi, sia pure a passo di
lumaca, arrivarono le salmerie. Ma era proprio questo il momento atteso dalle tribù
belgiche, che si erano accordate per gettarsi all’assalto solo dopo l’arrivo dei bagagli
romani. Ignorando che adesso si sarebbero trovati di fronte ben sei legioni, e non
solo una, i nervi si scagliarono a decine di migliaia fuori dal bosco. Cesare avrebbe poi
stimato in 60 000 il numero dei guerrieri affrontati sulla Sambre. Davanti a quella
muraglia di uomini urlanti, la cavalleria romana, presa alla sprovvista, si sparpagliò in
ogni direzione, e i nervi raggiunsero il fiume.
I belgi lo stavano già attraversando quando Cesare si rese conto della manovra. A
quel punto, il condottiero impartì solo gli ordini strettamente necessari: fece alzare
lo stendardo e suonare l’allarme. I legionari corsero a raggiungere le loro posizioni,
mentre il condottiero galoppava verso gli uomini della Decima alla sua sinistra.
Costoro abbandonarono gli attrezzi, afferrarono le armi e corsero a formare le coorti
sotto la trincea che avevano appena iniziato a scavare. I loro scudi erano ancora
coperti dalle fodere di cuoio; presi dalla fretta molti non ebbero il tempo di mettersi
l’elmo, tantomeno il cimiero o le decorazioni.
«Uomini della Decima!» tuonò Cesare. «Vi chiedo di tenere fede alla vostra
tradizione di coraggio. Tenete i nervi saldi, attaccate il nemico con audacia, e la
vittoria sarà nostra!»
I legionari della Decima gridarono un evviva, scuotendo i giavellotti. Fiducioso che
la sua unità preferita si sarebbe dimostrata all’altezza della situazione, Cesare rivolse
un cenno a Labieno e partì al galoppo per organizzare le difese negli altri punti
strategici.
La riva scoscesa, le siepi e l’attacco a sorpresa contribuirono a dividere l’esercito
romano. La Decima e la Nona si trovarono separate dalle altre unità quando i
guerrieri atrebati emersero dal guado e si avventarono lungo la riva contro di loro.
Labieno attese con calma che si avvicinassero, poi diede ordine alla prima linea di
lanciare i giavellotti. Una pioggia di dardi si abbatté sugli atrebati. Con il fiato mozzo,
mentre molti dei loro compagni crollavano a terra morti o feriti, i barbari
interruppero l’assalto.
Adesso fu il turno del comandante romano di ordinare l’attacco. Con le spade
sguainate e Labieno in testa, i legionari della Decima e della Nona si precipitarono giù
dalla collina e sbaragliarono il nemico. I barbari delle ultime file fecero dietrofront e
corsero verso il fiume, inseguiti dai romani che li massacrarono mentre fuggivano in
preda al panico. Presto la Sambre pullulò di corpi sanguinanti e mutilati. La Decima e
la Nona incalzarono gli atrebati fino in cima alla scoscesa riva opposta, e poi ancora
oltre, fino alle soglie del bosco da cui erano usciti per gettarsi all’attacco.
Sull’ala destra di Cesare, la Settima e la Dodicesima legione erano state quasi
circondate dai nervi di Boduognato. Qui, il caos in cui versavano i romani – specie
quelli della meno esperta Dodicesima, i cui centurioni erano stati in buona parte
uccisi o feriti – rischiava di provocare una disfatta. La quarta coorte, che aveva subìto
l’urto peggiore, non contava più alcun centurione, tantomeno il portabandiera.
Quando Cesare giunse sulla scena, trovò gli uomini che si stringevano impauriti
dietro le insegne. Il condottiero smontò da cavallo, afferrò lo scudo di un legionario
delle ultime file, e avanzò verso il nemico urlando: «Avanti! Sparpagliatevi! Datevi
spazio per combattere!».
Leggi la versione completa di questo libro