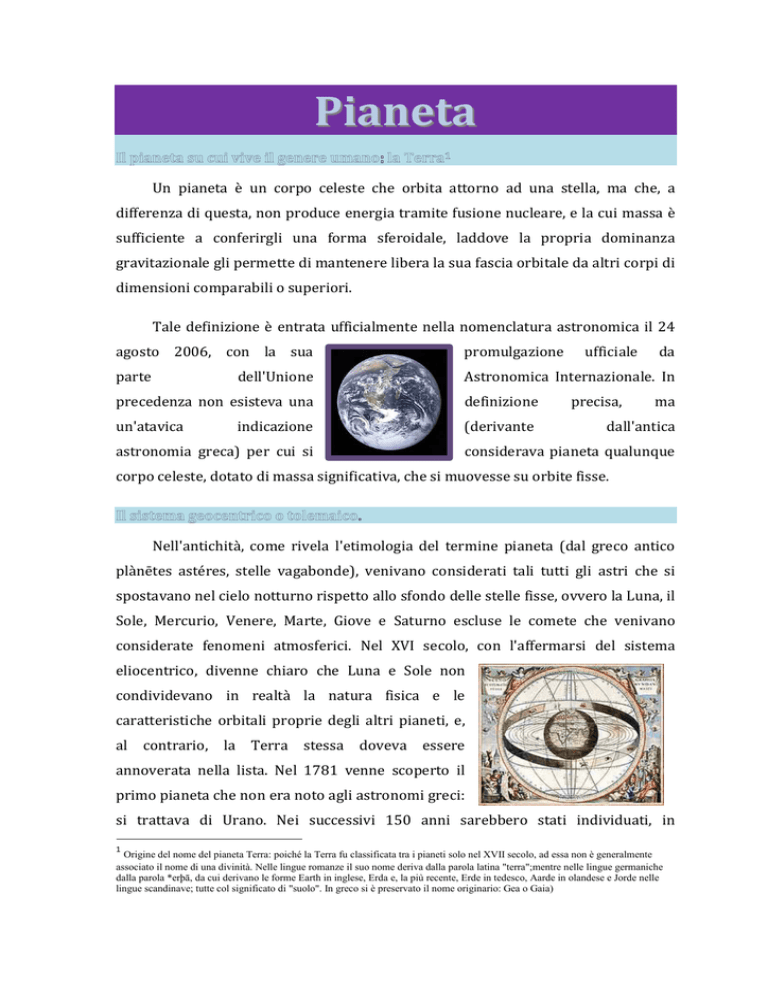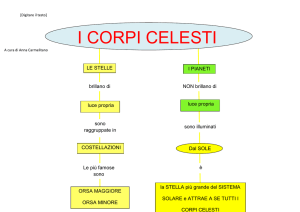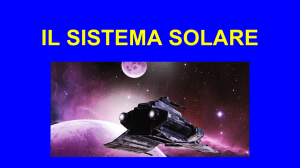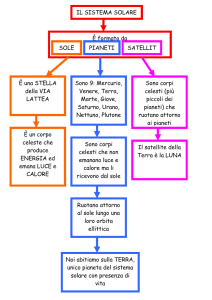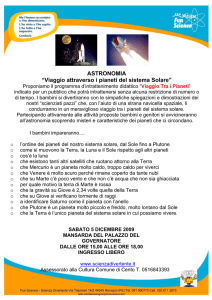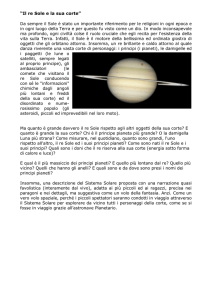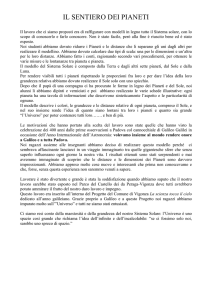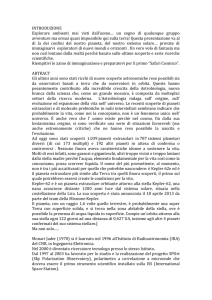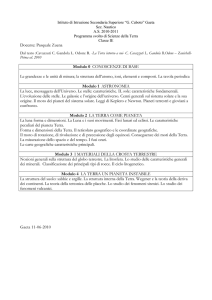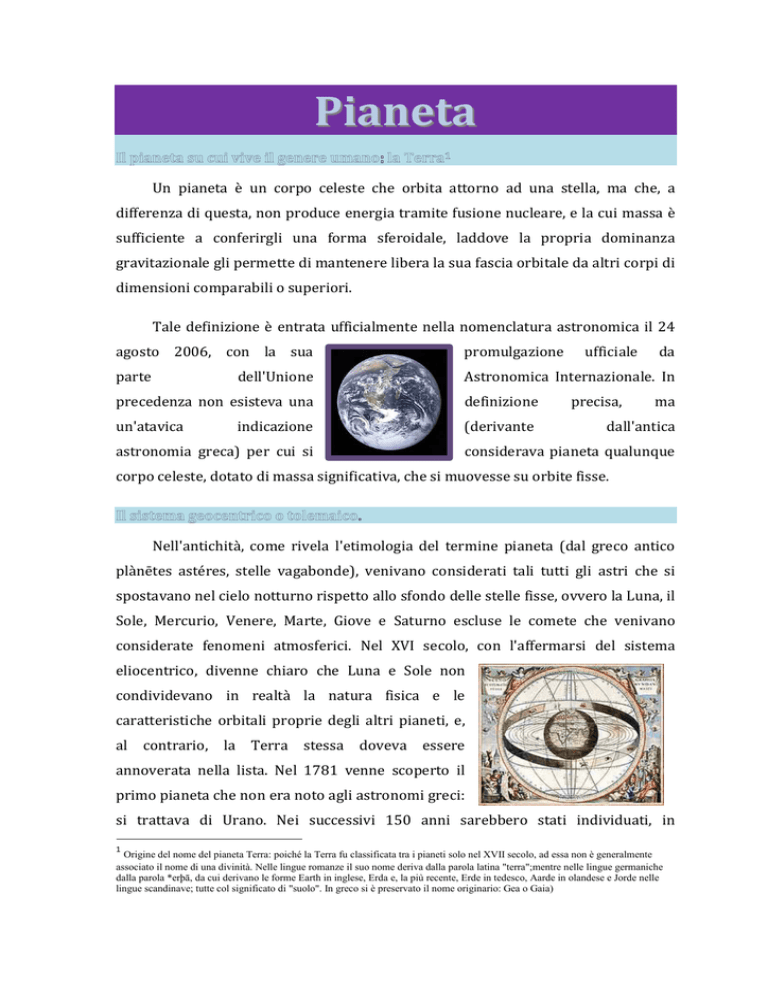
Pianeta
Un pianeta è un corpo celeste che orbita attorno ad una stella, ma che, a
differenza di questa, non produce energia tramite fusione nucleare, e la cui massa è
sufficiente a conferirgli una forma sferoidale, laddove la propria dominanza
gravitazionale gli permette di mantenere libera la sua fascia orbitale da altri corpi di
dimensioni comparabili o superiori.
Tale definizione è entrata ufficialmente nella nomenclatura astronomica il 24
agosto 2006, con la sua
promulgazione
parte
Astronomica Internazionale. In
dell'Unione
precedenza non esisteva una
definizione
un'atavica
(derivante
indicazione
astronomia greca) per cui si
ufficiale
precisa,
da
ma
dall'antica
considerava pianeta qualunque
corpo celeste, dotato di massa significativa, che si muovesse su orbite fisse.
Nell'antichità, come rivela l'etimologia del termine pianeta (dal greco antico
plànētes astéres, stelle vagabonde), venivano considerati tali tutti gli astri che si
spostavano nel cielo notturno rispetto allo sfondo delle stelle fisse, ovvero la Luna, il
Sole, Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno escluse le comete che venivano
considerate fenomeni atmosferici. Nel XVI secolo, con l'affermarsi del sistema
eliocentrico, divenne chiaro che Luna e Sole non
condividevano in realtà la natura fisica e le
caratteristiche orbitali proprie degli altri pianeti, e,
al contrario,
la
Terra
stessa
doveva
essere
annoverata nella lista. Nel 1781 venne scoperto il
primo pianeta che non era noto agli astronomi greci:
si trattava di Urano. Nei successivi 150 anni sarebbero stati individuati, in
1
Origine del nome del pianeta Terra: poiché la Terra fu classificata tra i pianeti solo nel XVII secolo, ad essa non è generalmente
associato il nome di una divinità. Nelle lingue romanze il suo nome deriva dalla parola latina "terra";mentre nelle lingue germaniche
dalla parola *erþā, da cui derivano le forme Earth in inglese, Erda e, la più recente, Erde in tedesco, Aarde in olandese e Jorde nelle
lingue scandinave; tutte col significato di "suolo". In greco si è preservato il nome originario: Gea o Gaia)
Mitologia
successione, altri due pianeti, Nettuno e Plutone; quest'ultimo è
stato annoverato tra i pianeti dalla scoperta, nel 1930, al 2006,
anno in cui venne promulgata la nuova definizione di pianeta.
A partire dal 1801, inoltre, vennero progressivamente
scoperti oltre centomila corpi di dimensioni subplanetarie
orbitanti attorno al Sole principalmente nella regione di spazio
compresa fra l'orbita marziana e quella gioviana (la cosiddetta
fascia principale); sebbene in un primo tempo designati come
pianeti, questi corpi, in virtù del loro numero sempre crescente,
vennero presto definiti come una classe di oggetti a sé, gli
asteroidi. Fra di essi, solo poche decine sono caratterizzati da una
forma approssimativamente sferica.
Lo schema dei nove pianeti classici rimase inalterato fino
agli anni novanta del XX secolo; alla fine del 2002, tuttavia, le
moderne
tecniche
osservative
avevano
già
permesso
l'individuazione di oltre cento corpi di questo tipo, fra pianeti
extrasolari e planetoidi ghiacciati orbitanti nelle regioni
periferiche del sistema solare esterno. Nel caso di questi ultimi, in
particolare, la scoperta di corpi dalle dimensioni confrontabili o
addirittura superiori a quelle di Plutone (il più piccolo dei nove
pianeti) riaccese un forte dibattito sulla necessità di promulgare
una definizione precisa di pianeta. Il problema nasceva dal fatto
che la classificazione dei corpi celesti derivava in parte
dall'astronomia dell'antica Grecia, che si limitava a chiarire che
un pianeta era un qualsiasi corpo celeste che si muovesse lungo
orbite ("schemi") fisse. Questa descrizione era stata limata col
tempo fino a quella corrente, che tuttavia peccava in vaghezza e
in genericità.
I nomi dei pianeti nella cultura occidentale
sono derivati dalle consuetudini dei Romani,
che in ultima analisi derivano da quelle dei
Greci e dei Babilonesi. Nell'antica Grecia, il
Sole e la Luna erano chiamati Helios e Selēnē;
il pianeta più lontano era chiamato Phàinōn, il
"più luminoso"; il penultimo pianeta era
Phaéthon, il "brillante"; il pianeta rosso era
indicato come Pyróeis, l'"ardente"; il più
luminoso era conosciuto come Phōsphóros, il
"portatore di luce", mentre il fugace pianeta più
interno era chiamato Stílbon, "lo splendido".
Inoltre, i Greci associarono ogni pianeta ad una
divinità del loro pantheon, gli Olimpi: Helios e
Selene erano i nomi sia dei pianeti, sia degli
dèi; Phainon era sacro a Crono, il Titano che
generò gli Olimpi; Phaethon era sacro aZeus,
figlio di Crono; Pyroeis ad Ares, figlio di Zeus
e dio della guerra; Phosphoros era retto da
Afrodite, la dea dell'amore; mentre Hermes,
messaggero degli dei e dio dell'apprendimento
e dell'ingegno, dominava Stilbon.
L'abitudine greca di dare i nomi dei propri dèi
ai pianeti derivò quasi certamente da quella dei
Babilonesi, che indicavano Phosphoros con il
nome della propria dea dell'amore, Ishtar;
Pyroeis dal dio della guerra, Nergal; Stilbon
dal dio della saggezza, Nabu, e Phaethon dal
capo degli dei, Marduk. Le concordanze tra i
due sistemi di nomenclatura sono troppe,
perché essi possano essere stati sviluppati in
modo indipendente. La corrispondenza tra le
divinità, ad ogni modo, non era perfetta. Per
esempio, Nergal fu identificato con Ares;
tuttavia, Nergal era per i Babilonesi il dio della
guerra ed anche delle pestilenze e
dell'oltretomba.
Oggi, i nomi utilizzati per designare i pianeti
nella maggior parte delle culture occidentali
derivano da quelli delle divinità olimpiche,
spesso in una versione mutuata dalla mitologia
romana. Infatti, l'influenza dell'Impero romano
prima e della Chiesa cattolica poi ha portato
all'adozione dei nomi in latino. Inoltre, il
pantheon romano, in conseguenza della
comune origine indoeuropea, aveva numerose
similitudini con quello greco, sebbene
mancasse di una ricca tradizione narrativa.
Durante l'ultimo periodo della Repubblica
romana, gli scrittori romani attinsero ai miti
greci e li estesero alle proprie divinità, al punto
che i due pantheon divennero quasi
indistinguibili. In seguito, quando i Romani
studiarono i testi di astronomia dei Greci,
assegnarono ai pianeti i nomi delle proprie
divinità: Mercurio (per Hermes), Venere (per
Afrodite), Marte (per Ares), Giove (per Zeus) e
Saturno (per Crono). Quando nei secoli XVIII
e XIX furono scoperti nuovi pianeti, la
comunità internazionale scelse di proseguire
nella tradizione e furono nominati Urano e
Nettuno.
Secondo una credenza originatasi in
Mesopotamia, ma sviluppatasi nell'Egitto
ellenistico ed in seguito diffusasi anche tra i
Romani, le sette divinità da cui i pianeti erano
nominati si prendevano cura degli affari della
Terra con turni orari, stabiliti in base alla
distanza dal nostro pianeta nell'ordine
seguente: Saturno, Giove, Marte, il Sole,
Venere, Mercurio e la Luna. Il giorno era poi
intitolato al dio che ne reggeva la prima ora,
così al giorno dedicato a Saturno (che reggeva
la prima ora del primo giorno e della
settimana) seguiva quello dedicato al Sole (che
reggeva la venticinquesima ora della settimana
e la prima del secondo giorno), a cui seguivano
i giorni dedicati alla Luna, a Marte, Mercurio,
Giove e Venere. Quest'ordine è stato quindi
ripreso dall'ordine dei giorni della settimana
nel calendario romano che sostituì il ciclo
nundinale e che ancora oggi è preservato in
numerose lingue e culture. Nella maggior parte
delle lingue romanze, i nomi dei prime cinque
giorni della settimana sono traduzione diretta
delle originarie espressioni latine: ad esempio
da lunae dies derivano lunedì, in italiano; lundi
in francese, lunes in spagnolo. Differentemente
è accaduto per il sabato e la domenica, i cui
nomi hanno subito l'influsso della tradizione
della Chiesa. Nelle lingue germaniche, invece,
nei nomi di questi due giorni è stato preservato
il loro significato originario. A titolo di
esempio, le parole inglesi Sunday e Saturday
tradotte letteralmente significano: "giorno del
Sole" e "giorno di Saturno"; analogamente è
accaduto per il lunedì. I nomi dei restanti giorni
della settimana, invece, sono stati riassegnati a
dèi considerati simili o equivalenti alle
corrispondenti divinità romane.
Il modello maggiormente accettato dalla comunità scientifica per spiegare la
formazione dei sistemi planetari è il modello della nebulosa solare, formulato
originariamente, come arguibile dal nome, per spiegare la formazione del sistema
solare.
In accordo con il modello standard
della formazione stellare, la nascita di
una stella avviene attraverso il collasso di
una nube molecolare, il cui prodotto è la
protostella. Non appena la stella nascente
conclude la fase protostellare e fa
ingresso nella pre-sequenza
sequenza principale
(fase di T Tauri), il disco che ne ha mediato l'accrescimento diviene protoplanetario;
la sua temperatura diminuisce, permettendo la formazione di piccoli grani di
polvere costituiti da roccia (in prevalenza silicati) e ghiacci di varia natura, che a loro
volta possono fondersi tra loro per dar luogo a blocchi di diversi chilometri detti
planetesimi Se la massa residua del disco è sufficientemente grande, in un lasso di
tempo astronomicamente breve (100.000–300.000 anni) i planetesimi possono
fondersi tra loro per dar luogo a embrioni planetari, detti protopianeti, i quali, in un
arco temporale compreso tra 100 milioni e un miliardo di anni, vanno incontro ad
una fase di violente collisioni e fusioni con altri corpi simili; il risultato sarà la
formazione, alla fine del processo, di alcuni pianeti terrestri.
La formazione dei giganti gassosi è invece un processo più complicato, che
avverrebbe al di là della cosiddetta frost line (chiamata in letteratura anche limite
della neve). I protopianeti ghiacciati posti oltre questo limite possiedono una massa
superiore e sono in maggior numero rispetto ai protopianeti esclusivamente
rocciosi.[ Non è completamente chiaro cosa succeda in seguito alla formazione dei
protopianeti ghiacciati; sembra tuttavia che alcuni di questi, in forza delle collisioni,
crescano fino a raggiungere una massa superiore alle 10 masse terrestri – M⊕ –
(secondo recenti simulazioni si stima 14-18), necessaria per poter innescare un
fenomeno di accrescimento, simile a quello cui è andata incontro la stella ma su scala
ridotta, a partire dall'idrogeno e dall'elio che sono stati spinti nelle regioni esterne
del disco dalla pressione di radiazione e dal vento della stella neonata. L'accumulo di
gas da parte del nucleo protopianetario è un processo inizialmente lento, che
prosegue per alcuni milioni di anni fino al raggiungimento di circa 30 M⊕, dopo di
che subisce un'imponente accelerazione che lo porta in breve tempo (poche migliaia
di anni) ad accumulare il 90% di quella che sarà la sua massa definitiva: si stima che
pianeti come Giove e Saturno abbiano accumulato la gran parte della loro massa in
appena 10.000 anni. Gli impatti con i planetesimi, così come il decadimento
radioattivo dei loro costituenti, hanno riscaldato i pianeti in formazione, causandone
una parziale fusione. Ciò ha permesso che il loro interno si sia differenziato
conducendo alla formazione di un nucleo più denso, di un mantello e di una crosta.
(si veda anche il paragrafo Differenziazione interna). Nel processo, i pianeti terrestri,
più piccoli, hanno perduto la maggior parte della loro atmosfera; i gas perduti sono
stati in parte reintegrati da quelli eruttati dal mantello e dagli impatti di corpi
cometari. I pianeti più piccoli in seguito hanno continuato a perdere la propria
atmosfera attraverso vari meccanismi di fuga.
Si è scoperto inoltre che la metallicità, ovvero l'abbondanza di elementi più
pesanti dell'elio, è un parametro importante nel determinare se una stella possegga
o meno pianeti. Si ritiene che sia meno probabile che una stella povera di metalli,
appartenente alla popolazione stellare II, possa essere circondata da un sistema
planetario articolato, mentre le probabilità aumentano per le stelle ricche di metalli,
appartenenti alla popolazione stellare I.
© Wikipedia