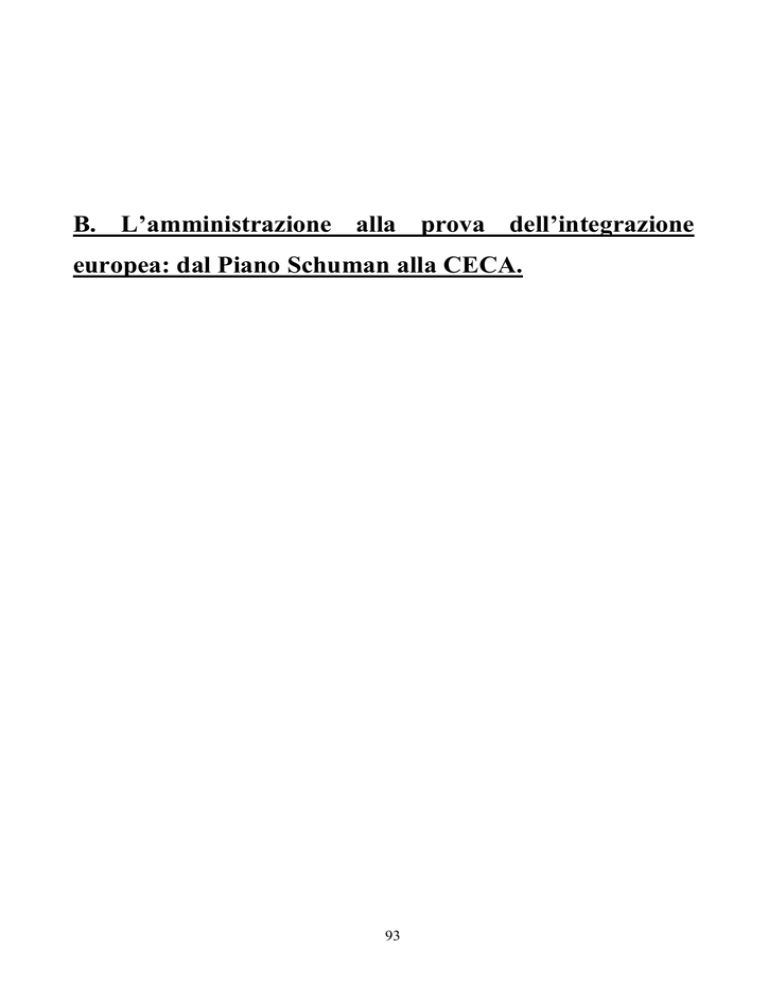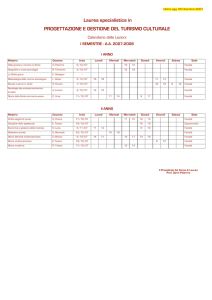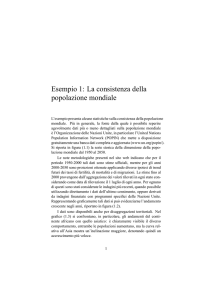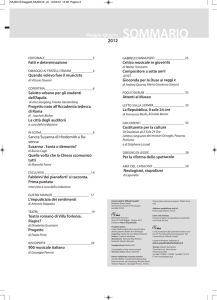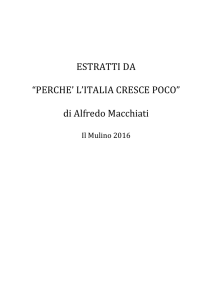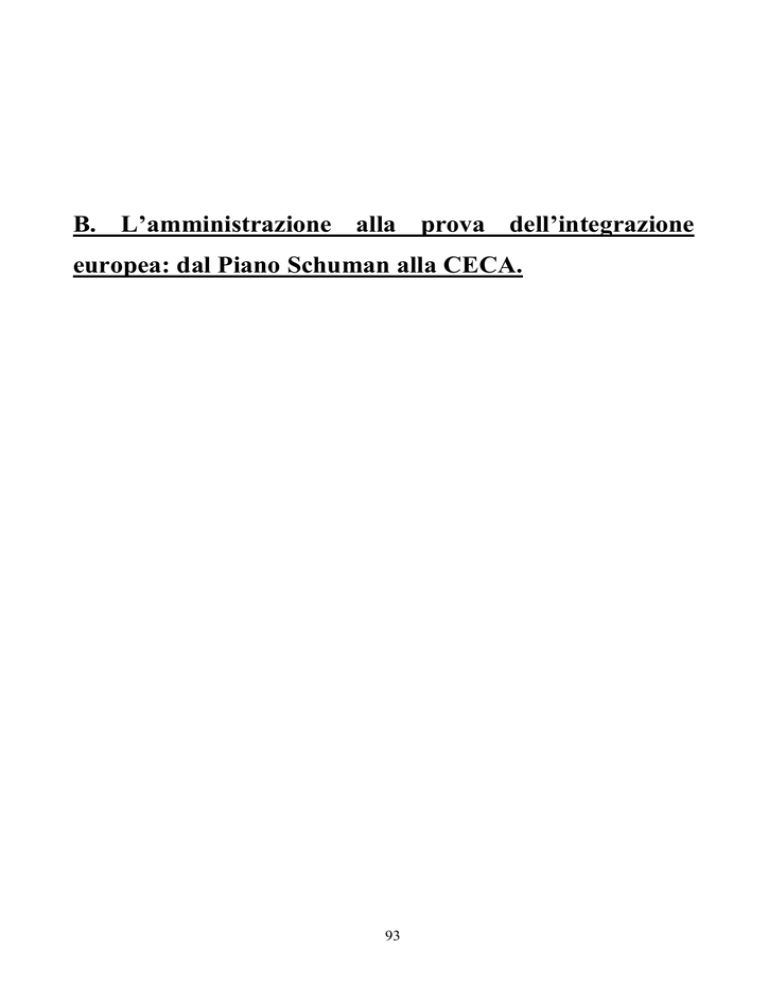
B. L’amministrazione alla prova dell’integrazione
europea: dal Piano Schuman alla CECA.
93
B.1.Lo sfondo storico
Il processo cosiddetto di “integrazione europea” non può valutarsi come una sorta di episodio
minore, semplicemente l’articolazione di un sotto-sistema regionale all’interno del blocco
occidentale. Piuttosto si tratta del processo di concreta riorganizzazione in Europa occidentale di un
nuovo sistema di relazioni diplomatiche, militari, economiche. Al suo interno il ruolo italiano non
fu affatto trascurabile, anche se rimaneva necessariamente subordinato a quello degli attori
principali come Francia, Gran Bretagna e Germania Occidentale. Gli studi più recenti sull’azione
europeistica hanno quindi portato a recuperare una dimensione più attiva della iniziativa
diplomatica italiana, mettendo meglio in chiaro alcuni nessi fra politica interna e politica estera e
indicando, anche la portata di una realistica politica di potenza dell’Italia volta a ritagliarsi uno
spazio nello scenario europeo, collegandosi fra l’altro alle esperienze passate. Questi rilievi
assumono ancora maggior peso nel campo delle relazioni economiche internazionali, dove il
processo di riorganizzazione europeo, a partire dall’Unione Doganale del 1947, non poteva che
costituire la proiezione delle scelte di ricostruzione e di espansione che le singole nazioni, e quindi
anche l’Italia, stavano conducendo al proprio interno 1 .
In questa sezione del nostro rapporto, ricostruiamo a grandi linee le vicende internazionali, con
particolare attenzione ai rapporti franco-tedeschi - che portarono al lancio del Piano Schuman, il 9
maggio 1950, riconosciuto universalmente come il primo passo nella costruzione europeistica. Ci
soffermiamo più da vicino, poi, sulla posizione italiana nella prima fase dell’integrazione europea,
esaminando tra l’altro l’interesse italiano per la liberalizzazione del trasferimento di manodopera; il
tentativo, sostanzialmente fallito, di formare una unione doganale francese; l’interesse italiano verso
una cauta apertura dei mercati europei, in particolare, tramite la liberalizzazione degli scambi
commerciali e che portò ad alcune iniziative significative quali il Piano Pella del 1950 e la
liberalizzazione effettuata da La Malfa nel 1951, e infine la posizione italiana rispetto
all’integrazione del carbone e dell’acciaio. A partire da questa ricostruzione di sfondo, sarà poi
possibile nelle sezioni successive focalizzare l’attenzione sull’amministrazione italiana, e sul modo
come si attrezzò al proprio interni per affrontare la complessa serie di negoziati europei che qui
descriviamo.
1
Sulla politica europeista di De Gasperi Pastorelli 1984; Pastorelli 1987; Varsori 1985; Ranieri 1985a, Vigezzi 1985.
94
B.1.a. Il Piano Schuman, i rapporti franco-tedeschi e gli inizi dell’integrazione
economica europea.
Il Piano Schuman per la creazione di una comunità europea nei settori del carbone e dell’acciaio,
lanciato nel maggio 1950 dal ministro degli Affari Esteri Francese Robert Schuman, è a ragione
considerato il punto di partenza nel processo di costruzione europea. I caratteri del progetto francese
elaborati in primo luogo da Jean Monnet e dai suoi più stretti collaboratori furono alla base degli
elementi fondamentali della CECA, Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio, che sarebbe
sorta nel 1952 a seguito del negoziato prima e del Trattato di Parigi, poi, firmato nell’aprile del
1951. Questi elementi del resto formano aspetti non secondari dell’edificio comunitario quale oggi
lo conosciamo.
Il problema che spinse la Francia a operare in favore di un processo di integrazione
sovranazionale fu il futuro della Germania. La Germania occidentale viveva fin dalla fine del
dopoguerra in un regime di occupazione, affidato alle potenze alleate occidentali, e cioè in primo
luogo agli Stati Uniti e alla Gran Bretagna, che fin dal 1947 avevano unificato le loro zone di
occupazione, e alla Francia stessa. Dal 1948 era iniziato il processo di ricostruzione di una entità
statuale tedesca, la Germania di Bonn che si dotava di una sua costituzione nel 1949 e, a seguire, di
un suo governo democraticamente eletto, e affidato al Cancelliere Konrad Adenauer, espresso da
una maggioranza dominata dalla CDU-CSU, partito di ispirazione cattolica. La Ruhr, il tradizionale
bacino dell’industria pesante tedesca, era stata, intanto, sottoposta a una Autorità internazionale, con
l’ambizione di controllarne le risorse e ritardarne lo sviluppo.
Ormai da tempo la storiografia ha individuato le origini del Piano Schuman in un processo di
revisione della politica estera francese, i cui obiettivi sia economici (sostituire la forza dell’industria
tedesca ponendosi come centro nevralgico della ricostruzione europea), che politici (indebolimento
della Germania attraverso una serie di controlli internazionali) trovavano crescenti ostacoli nel
nuovo quadro internazionale della Guerra fredda, al cui interno il controllo della Germania
rappresentava una delle poste più ambite, mentre la voce della Francia era marginale. Già, per
esempio, nel giugno 1947 il lancio del Piano Marshall indicava una chiara volontà americana di
ricostruire l’economia tedesca come parte integrante del blocco occidentale (Hogan 1988, cap. 3).
Durante il 1948, inoltre, la Francia fu impegnata in un logorante tentativo di contrattazione con gli
Stati Uniti e la Gran Bretagna. Si allineava alla richiesta americana di dare corso alla costituzione di
uno Stato tedesco occidentale, ma cercava di ottenere controlli e garanzie sul futuro assetto
dell’economia tedesca. Nonostante gli sforzi, tuttavia, i risultati furono modesti e provvisori. La
Francia non aveva, cioè, ottenuto di potere esercitare un controllo efficace e permanente sui modi e
i tempi della reintegrazione dell’economia tedesca.
95
Il problema era come superare la paura di una rinascita tedesca, che pareva fra l’altro imposta
dalla necessità per l’occidente di consolidare il blocco occidentale dalla minaccia sovietica e
comunista, che veniva avvertita sempre più forte, soprattutto dopo il blocco sovietico di Berlino del
giugno 1948, che aveva richiesto una energica risposta americana, in chiave di assoluta emergenza.
La forte espansione dell’economia tedesca, materializzatasi fra il 1949 e il 1950, rendeva ancora più
forte la tensione e l’apprensione. La Francia temeva l’aumento della produzione di acciaio tedesca,
se non altro perché essa veniva a ostacolare i propri progetti di rilancio economico, espressi nel
Piano quinquennale di modernizzazione, portato avanti sotto la direzione di Jean Monnet, che
contemplava, tra l’altro, un largo uso di risorse carbonifere tedesche. Tuttavia gli americani erano
pronti ad acconsentire ad un largo aumento della produzione siderurgica tedesca. Essi chiedevano
da tempo la normalizzazione della situazione tedesca e l’inserimento della Germania negli
organismi di collaborazione europea. La Francia avrebbe quindi dovuto cedere il passo. Le
conseguenze erano facilmente immaginabili e ben descritte da Jean Monnet nelle sue memorie.
L’economia tedesca si sarebbe sviluppata impetuosamente; sarebbero riprese le esportazioni
dell’industria pesante tedesca in Francia e in Europa e gli industriali francesi si sarebbero rinchiusi
in un atteggiamento protezionistico, tentando di ricreare i cartelli industriali d’anteguerra. Sarebbe
stata la fine dell’apertura dei mercati iniziata a partire dal Piano Marshall e dal processo di
liberalizzazione degli scambi. Si sarebbe ricaduti nella logica del primo dopoguerra, con la
ricostruzione di Stati nazionali ostili e divisi.
Nel corso del 1948 e del 1949 prendeva corpo a Parigi un processo di revisione: non solo nel
senso che molti precedenti obiettivi vennero ridimensionati, ma ancora di più nel maturarsi della
convinzione che, senza una forma di cooperazione e associazione con la costituenda Repubblica
Federale Tedesca (RFT), la Francia avrebbe visto restringersi drasticamente il campo della propria
libertà di azione. Già alla fine del 1948 questa percezione era evocata apertamente negli ambienti
diplomatici francesi, la possibilità, cioè, di costituire “un pool dell’acciaio europeo nel quale
francesi e tedeschi siederebbero in parità e eserciterebbero in comune un controllo della produzione
siderurgica”. Sarebbe stata, si osservava, una soluzione “ardita e pericolosa”, ma bisognava
purtuttavia tentarla in quanto “noi siamo ancora i più forti, potendo offrire alla Germania una simile
soluzione di cui noi prenderemmo la direzione” (Poidevin 1987, p.224).
Si trattava di creare un legame fra Francia e Germania capace di neutralizzare le due maggiori
fonti della potenza economica tedesca: il carbone e l’acciaio della Ruhr, e di conseguenza anche la
sua potenzialità industriale a scopo militare. Nacque così il concetto di una autorità sovranazionale
a cui la Germania Occidentale, ma nello stesso tempo anche la Francia avrebbero dovuto
sottomettersi. La sua creazione avrebbe portato anche alla fine degli altri controlli unilaterali degli
96
Alleati sulla Germania, e nel contempo avrebbe posto le basi per una unificazione più ampia estesa
al resto dell’Europa occidentale. In sostanza nel Piano Schuman confluiva una ricerca di un
compromesso fra il desiderio della Francia di continuare a controllare la Germania e le sue risorse e
lo sforzo della Germania di Adenauer, che ambiva a riguadagnare sovranità e prestigio e a liberarsi
dai controlli, di ottenere pari diritti. Il Piano offriva in prospettiva a Parigi di continuare, in un
contesto sovranazionale, a mantenere il controllo della Germania occidentale e a Bonn di ottenere
pari diritti in una nuova comunità sovranazionale.
Gli obbiettivi principali del Piano Schuman possono riassumersi nel modo seguente: in primo
luogo doveva risolvere il problema della sicurezza della Francia, sottraendo tutte le industrie pesanti
europee a una gestione congiunta internazionale e rendendo così impossibile un nuovo conflitto fra
Francia e Germania; in secondo luogo assicurava alla Francia il libero accesso al carbone della
Ruhr, che era prezioso per il rafforzamento dell’industria francese; in terzo luogo creava una
comunione di interessi franco-tedesca a lungo termine che avrebbe aiutato i due paesi a superare
una serie di dissidi su zone di confine (vedi la Saar) e su altre questioni aperte; infine gettava le basi
per una futura unificazione europea, su basi federali, che avrebbe potuto agire come mediazione
durante la Guerra Fredda, e contribuire a evitare una altra guerra mondiale.
Il progetto prese definitivamente corpo durante il mese d’aprile del 1950, alla scadenza di
importanti discussioni fra gli alleati occidentali sulla questione tedesca. Elaborato da un gruppo di
tecnici sotto la guida di Jean Monnet, esso venne abbracciato da Robert Schuman, poi dal Consiglio
dei Ministri francese e contemporaneamente dal Cancelliere Adenauer, e dal Segretario di Stato
Americano, Acheson. Dopo una intensa fase diplomatica, che vide da una parte l’adesione
dell’Italia e dei paesi del Benelux, e dall’altra la presa di distanza del Regno Unito, il progetto si
precisò ulteriormente. Per dargli sostanza venne convocata una conferenza diplomatica a Parigi il
20 giugno 1950 a cui parteciparono le delegazioni dei Sei paesi, che dovevano costituire il nucleo
originario del processo di integrazione europea. (Ranieri-Tosi 2004)
B.1.b. L’Italia e i primi passi dell’integrazione europea
La politica estera italiana ottenne, nel periodo che va dal 1946 al 1949, notevoli successi.
L’Italia, pur tra notevoli difficoltà e resistenze internazionali, entrò a far parte quale membro
fondatore nei principali organismi che costituivano il sistema occidentale (Consiglio d’Europa,
NATO). Inoltre l’Italia era divenuta parte integrante dei progetti multilaterali di ricostruzione
economica dell’Europa, a partire dal Piano Marshall e in particolare dell’OECE. Una particolare
importanza era stata attribuita dall’Italia al progetto di unione doganale italo-francese.
97
La linea politico-diplomatica portata avanti dal governo di Roma sul tema dell’Europa aveva
oscillato tra il sostegno a istanze sopranazionali e la ricerca pragmatica di spazi per un’iniziativa
italiana tendente a favorire la costruzione europea secondo il metodo intergovernativo dell’OECE.
Il ministro degli Esteri, Carlo Sforza, in un discorso all’Università per Stranieri di Perugia del 18
luglio 1948, aveva sostenuto per la costruzione europea una soluzione “federativa”, identificando
nei 16 Stati che facevano parte dell’OECE il fulcro del processo di unificazione. In questa chiave
pragmatica e disponibile a varie aggregazioni, molti osservatori hanno visto l’europeismo italiano
come un mantello sotto il quale riacquistare un’identità nazionale che nell’Italia post-bellica
appariva fortemente indebolita, oltre che come un utile strumento per delineare soluzioni
internazionali a problemi di lunga data della economia e società italiana, quali, per esempio, quello
della sovrabbondanza di manodopera con conseguente necessità di sbocchi migratori e la necessità
di un afflusso di capitali per generare gli investimenti necessari al completamento dello sviluppo
industriale del Paese.
Conviene ricordare brevemente, sia come l’eccedenza di manodopera costituisse un elemento
essenziale dell’economia italiana nella ricostruzione, sia come i negoziatori italiani avessero
sollevato il problema dovunque potessero: e quindi sia in sede OECE (tra l’altro con il Piano Pella
del luglio 1950), nella trattativa per l’Unione Doganale italo-francese, nella NATO, nel Consiglio
d’Europa etc. Il governo italiano mirava a legare la liberazione degli scambi delle merci
all’aumento dei flussi di emigrazione dalla penisola verso i Paesi dell’Europa centro-settentrionale,
e in una prima fase anche dell’Europa orientale, al fine di alleviare il peso della disoccupazione e di
contribuire, attraverso le rimesse, all’equilibrio della bilancia dei pagamenti. 2 Così, nel corso dei
negoziati per l’unione doganale con la Francia più volte i rappresentanti italiani cercarono di
introdurre il problema, ma la prospettiva di un massiccio afflusso di la manodopera non qualificata
italiana suscitava i timori e le resistenze degli ambienti economici di oltralpe, in particolar modo dei
sindacati dei lavoratori, mentre gli industriali si rivelarono interessati solo a lavoratori specializzati,
di cui però vi era scarsità anche sul mercato italiano. 3
In linea generale, la strategia seguita dal governo italiano in materia di emigrazione non si rivelò
di facile attuazione. Già nel gennaio 1948, durante la conferenza internazionale sulla manodopera
2
Alcuni interessanti risultati furono raggiunti a partire dal 1946 in una serie di accordi bilaterali con alcuni paesi
europei - Francia, Belgio, Inghilterra, Cecoslovacchia, Polonia - che contemplavano quote di immigrazione italiana in
cambio di materie prime e in particolare di partite di carbone. La Cecoslovacchia per esempio prometteva di inviare
77.000 tonnellate di fossile nel 1947 in cambio dell’arrivo di 5.000 lavoratori italiani.
3
Fin dall’inizio dei negoziati per l’unione doganale i francesi avevano mantenuto un atteggiamento molto prudente
riguardo alla possibilità di libera circolazione per la manodopera, indotti a ciò soprattutto dalle eccessive attese nutrite
dalla controparte che aveva dato l’impressione, secondo i rappresentanti confindustriali, di aspettarsi che dall’entrata in
vigore dell’unione venisse la soluzione del problema dei due milioni e mezzo di disoccupati che tormentava l’economia
italiana3. Si era trattato di «un passo molto sbagliato dal punto di vista tattico», in quanto aveva suscitato
preoccupazioni in tutta la delegazione francese e non solo nei sindacati.
98
svoltasi a Roma, l’Italia aveva dovuto prendere atto del fallimento, a causa dell’opposizione
francese, inglese e belga, dei suoi tentativi di conferire all’istituendo Comitato per le emigrazioni
europee poteri operativi (Romero 1991, pp. 43-44). Quest’ultimo avvenimento sottolineava ancora
una volta l’indisponibilità dei Paesi riceventi a superare la fase degli accordi bilaterali ad hoc che di
volta in volta stabilivano le quote di lavoratori ammessi 4 .
Negli anni dell’immediato dopoguerra, sul piano dell’integrazione europea, l’Italia si trovò
impegnata soprattutto su due fronti, sui quali conviene soffermarsi brevemente, per delinearne le
caratteristiche principali Da un lato le trattative per l’istituzione di un’unione doganale con la
Francia, dall’altro i primi passi del processo di liberalizzazione degli scambi in ambito OECE.
B.1.c. Il fallimento dell’unione doganale con la Francia
Le intricate vicende dell’unione doganale presero l’avvio durante l’estate 1947; mentre si
svolgevano i lavori della conferenza di Parigi sulla cooperazione europea, ebbero luogo colloqui tra
il ministero degli Esteri francese e quello italiano sulla possibilità di istituire un’unione doganale tra
i due Paesi. Questi abboccamenti preliminari portarono, come primo risultato, alla firma il 13
settembre a Parigi da parte del ministro degli Esteri francese Georges Bidault e di Pietro Campilli,
rappresentante italiano alla conferenza, di una dichiarazione congiunta in cui si affermava la volontà
dei due governi di procedere all’esame approfondito della possibilità di istituire un’unione doganale
bilaterale. A questo fine veniva istituita una commissione mista di studi, formata da funzionari
ministeriali. La commissione avrebbe dovuto redigere un rapporto da presentare ai due governi
entro il 31 dicembre 1947 5 . Tutti coloro che si sono occupati dell’abortito tentativo di unione
bilaterale hanno sempre concordato almeno su un punto: le ragioni alla base dell’azione di ambedue
i Paesi furono in primo luogo di carattere politico e solo in seconda battuta economiche (Bagnato
1995; Fauri 1998).
Fin dall’inizio apparve chiaro che l’iniziativa non era fine a se stessa, ma rientrava in un più
ampio quadro politico-diplomatico. In particolare risultava preminente, per entrambi gli Stati, l’idea
di lanciare un segnale di disponibilità e di buona volontà all’amministrazione statunitense che
spingeva per una maggiore cooperazione tra gli stati europei, tanto da farne la condizione per la
concessione degli aiuti del piano Marshall. Dal punto di vista italiano, poi, la possibilità di
un’unione doganale con la Francia costituiva un’occasione da non perdere per realizzare l’obiettivo
4
Vedi inoltre Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale dell’Emigrazione, Il lavoro Italiano all’Estero nel
quinquennio 1950-1954, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1955.
5
Per il testo della dichiarazione del 13 settembre cfr. Relazioni internazionali, n. 39, 1947, p. 606.
99
di un rientro a pieno titolo nel circuito politico ed economico internazionale. Accanto a questi
aspetti politico-diplomatici, altri hanno visto nell’iniziativa franco-italiana un primo tentativo di
elaborazione di un’alternativa europea, fondata sul bilateralismo e sul mantenimento di un certo
grado di protezione delle economie nazionali, al modello di cooperazione multilaterale e
liberalizzazione sostenuto dalle autorità statunitensi (Battilossi 1996).
Dal punto di vista economico emersero subito molti ostacoli e difficoltà. Già il rapporto della
prima Commissione mista, reso pubblico alla fine del 1947, non poteva nascondere le difficoltà. Le
agricolture dei due paesi erano molto simili e in alcuni settori - vino, ortofrutticoli - nettamente
concorrenziali: l’unica possibilità consisteva in accordi per l’esportazione in comune verso paesi
terzi. Nell’industria le cose non andavano molto meglio; si trattava, infatti, di due industrie di
trasformazione e non era un caso che gli industriali tessili francesi fossero i più decisi avversari del
trattato. I due paesi seguivano inoltre politiche economiche diverse: volta all’espansione e orientata
al dirigismo con il Plan de Modernisation quella francese, condizionata dal problema della stabilità
monetaria quella italiana. Per il commercio estero, le conclusioni erano anche poco incoraggianti,
non solo per il basso livello in percentuale dell’interscambio reciproco, con un netto attivo però a
favore dell’Italia, ma per il fatto che i due paesi dipendevano dall’estero per molte delle stesse
materie prime. Di qui la massima importanza attribuita a una tariffa comune esterna.
Il trattato firmato nell’aprile 1949 non poteva che essere quindi estremamente generico. Esso
faceva largo posto alla cosiddetta “armonizzazione”, un lungo processo relativo alle strutture fiscali,
sociali etc. che era visto come essenziale premessa per la creazione di un mercato unico. Le tariffe
interne dell’unione dovevano essere abolite ma solo per essere sostituite da imposizioni fiscali di
vario genere - e anche a questo si decise di rinunciare non appena all’OECE si cominciò a discutere
della abolizione dei contingenti. L’unico punto fermo era il ruolo conferito alle intese cartellistiche
fra produttori 6 . Ma l’auspicata collaborazione tra produttori per realizzare un’integrazione
concertata, attraverso la messa in opera di un’Europa dei cartelli, non si rivelò di facile
realizzazione, come misero in evidenza i primi contatti tra la Confindustria e il Conseil National du
Patronat Français (CNPF) avvenuti nel febbraio 1948 a Parigi, durante i quali gli industriali francesi
si dimostrarono ben poco disponibili al compromesso su alcuni dei punti che più stavano a cuore al
padronato italiano (movimento di persone e capitali, questioni daziarie).
In genere, gli ambienti economici francesi si dimostrarono poco interessati all’unione con
l’Italia, in molti casi temendone la capacità concorrenziale in alcuni settori (soprattutto del tessile)
6
Conseil ‘Economique, Etudes et Travaux nn. 7, 14, 16, Union Douaniere France-Italie, I, II, III, Presses U.F.
Paris,1949, 1950, 1951; Francesco Coppola d'Anna, "L'Unione Doganale italo-francese", RIVISTA DI POLITICA
ECONOMICA, a. XXXVIII, novembre 1948; Yves Mancel, L'union douaniére ou le mariage des nations, Hermann,
Paris, 1949.
100
in cui l’industria della penisola godeva di più bassi costi della manodopera. Per gli ambienti
industriali francesi l’unione doganale assumeva un valore essenzialmente strumentale, utile solo se
avesse consentito di migliorare, attraverso accordi e azioni concertate, le capacità dei due sistemi
industriali di vendere ed acquistare al di fuori dell’unione. In quest’ottica non appariva prioritario lo
sviluppo del commercio interno all’unione, per il quale, basandosi sui dati del presente, si
consideravano scarse le potenzialità, bensì risultava chiaro che «il problema fondamentale in
materia di commercio estero era quello della penetrazione comune sui mercati terzi»7 .
Nonostante le difficoltà economiche, tuttavia, l’iniziativa non venne abbandonata e si arrivò alla
firma da parte di Bidault e Sforza del protocollo di Torino, il 20 marzo 1948, col quale i due
governi dichiaravano formalmente la loro volontà di costituire un’unione doganale, in modo
graduale e con gli opportuni adattamenti durante il periodo transitorio per non compromettere gli
interessi economici nei due Paesi; si dicevano favorevoli alla sua estensione ad altri Paesi e
istituivano una seconda Commissione mista. Fu un atto dettato, ancora una volta, da esigenze
puramente politiche, in buona parte nato dall’incontro tra le richieste di appoggio fatte pervenire dal
governo italiano ai governi occidentali in risposta alle aperture compiute in febbraio dall’Unione
Sovietica sulla questione coloniale, che si temeva potessero avere un’eco favorevole presso
l’opinione pubblica interna, e la volontà del governo francese di aiutare il vicino italiano in vista
delle imminenti elezioni politiche
Dai lavori della seconda Commissione mista, formata sia da rappresentanti dei governi e dei
Parlamenti che degli ambienti economici dei due Paesi, in pratica uscì il testo del trattato che dava
avvio all’Unione, firmato a Parigi il 26 marzo 1949. Nel trattato, che sarebbe dovuto entrare in
vigore dopo la ratifica da parte dei due Parlamenti, si prevedeva la realizzazione dell’unione
tariffaria tra i due Paesi e la unificazione delle tariffe nei confronti di Stati terzi, entro un anno
dall’entrata in vigore dell’accordo (artt. 2-5) 8 . L’unione economica avrebbe dovuto essere instaurata
(«a misura che sarà conseguita l’armonizzazione delle legislazioni dei due Paesi», art. 6), entro un
termine che si auspicava non superiore ai sei anni.. Era infine istituito un Consiglio dell’unione
doganale, composto da nove membri per parte, con l’incarico di preparare l’unione tariffaria e
quella economica, presentando ogni ottobre un rapporto ai governi sui provvedimenti da prendere
nel corso dell’anno seguente (artt. 9-16). Nell’art. 11 si prevedeva che il Consiglio si avvalesse per
l’esame di problemi particolari, di commissioni miste costituite anche da rappresentanti delle
organizzazioni di categoria.
Ma il progetto di Unione doganale si arenò ben presto, soprattutto dopo la bocciatura subita dal
7
8
ASCGII, , f. Giunta esecutiva, b. 1.5/10, Verbale delle riunioni del 24-25-26/9/1948.
Per il testo del trattato cfr., ad esempio, ASCGII, f. Commercio estero, b. 102.11/1, fasc. Udif.
101
trattato, nel maggio 1949, da parte del Conseil économique, un organo consultivo in cui erano
rappresentati le principali organizzazioni dei lavoratori, dell’agricoltura e dell’industria. Il voto del
Conseil économique evidenziò resistenze talmente forti, soprattutto da parte degli agricoltori e dei
sindacati, che il governo francese non ritenne nemmeno opportuno presentare il trattato
all’Assemblea Nazionale per la discussione sulla ratifica.
Successivamente, fra il 1949 e il 1950, si tentò di tenere in vita il progetto di unione doganale
attraverso alcuni adattamenti. 9 Ma questi tentativi non valsero ad infondere nuova linfa al progetto.
In definitiva l’unione fu destinata al fallimento nel momento in cui si decise di affidare un ruolo
trainante nella sua definizione alle categorie economiche che, unite dal comune obiettivo di
restringere il più possibile gli spazi discrezionali a disposizione delle amministrazioni pubbliche,
ma divise dai timori di dover pagare un prezzo troppo consistente per l’unione, non furono in grado
di elaborare una costruzione solida e coerente. La fragilità delle intese tra gli industriali dei due
Paesi venne confermata dal fallimento dell’accordo siderurgico quinquennale che, sulla scia del
trattato del 26 marzo, era stato stipulato alla fine di maggio a Parigi (Ranieri 1985).
B.1.d. L’Italia e la liberalizzazione in ambito OECE
La concessione degli aiuti dell’European Recovery Program, fu condizionata dalle autorità
statunitensi all’avvio di un’effettiva cooperazione tra i Paesi europei destinatari, in vista del
raggiungimento di un’integrazione economica e politica. Per questi fini, il 16 aprile 1948, nacque
l’OECE (Barbezat 1997; Petrini 2003). Nell’ambiziosa visione dell’amministrazione statunitense, la
nuova organizzazione avrebbe dovuto rappresentare il prototipo di un governo federale dell’Europa
occidentale, con l’obiettivo di instaurare un’Unione doganale tra i Paesi partecipanti. Le enormi
difficoltà emerse durante i lavori della conferenza sull’Unione doganale europea, portarono ad un
accantonamento del progetto (Milward 1984, pp. 207-211; Hogan 1988, pp. 126-127). Fu
concordato, allora, che l’attività dell’OECE si sarebbe concentrata sulla rimozione dei controlli sui
cambi e sull’eliminazione delle barriere quantitative al commercio (Asbeek Brusse 1997, p. 134).
L’azione dell’OECE, per tutto il suo primo anno di vita, non fu particolarmente incisiva. Nel
9
Il 29 luglio fu firmato un protocollo che adeguava le previsioni in materia di unione tariffaria del trattato alle misure
prese in sede OECE di graduale soppressione dei contingentamenti. (CGII, Annuario 1950, Roma, Tipografia Failli,
1950, p. 456.) Il 7 marzo 1950 venne firmato un altro protocollo con cui i due governi decidevano di sopprimere
totalmente le restrizioni quantitative, a parte eccezioni giustificate, di avviare il processo di armonizzazione legislativa,
di preparare una tariffa doganale comune. Il protocollo del 7 marzo fu modificato, in senso più restrittivo, in seguito a
un voto del Conseil économique che lo aveva bocciato, da un nuovo trattato firmato il 23 giugno. Con il nuovo trattato il
concetto di unione economica veniva sostituito dalla graduale unione doganale da realizzarsi attraverso
un’armonizzazione delle legislazioni e delle condizioni di produzione. Inoltre non comparivano più gli impegni alla
liberalizzazione degli scambi. (Bagnato 1995, p. 202 e pp. 222-223)
102
novembre 1949 il Consiglio dell’OECE aveva fissato, su iniziativa inglese, la prima tappa della
liberalizzazione degli scambi commerciali, stabilendo che entro il 15 dicembre successivo doveva
essere rimosso il 50% dei contingenti sul commercio privato tra i Paesi membri, prendendo come
riferimento gli scambi del 1948. La misura avrebbe dovuto applicarsi separatamente a ciascuno dei
tre settori principali in cui si veniva suddiviso il commercio: prodotti agricoli, materie prime e
prodotti finiti. Mentre a dicembre 1949 nessun dei membri era arrivato al target fissato, al 31 marzo
1950 numerosi Paesi avevano raggiunto, e in molti casi superato, il livello del 50% di
liberalizzazione sul totale degli scambi, ma molti di questi risultati erano stati raggiunti violando la
regola della equa distribuzione della liberalizzazione tra i settori. L’Italia, nel campo dei prodotti
finiti aveva liberalizzato solo l’11,1% del commercio del 1948, subordinando la soppressione dei
contingenti per un altro 39% all’entrata in vigore della nuova tariffa doganale, che andava a
sostituire quella del 1921, resa ormai obsoleta dalla perdita di potere di acquisto della lira
(Cavalcanti 1984, pp. 99-100; Martinez Oliva, Stefani, 2001, p. 235).
Percentuali di liberazione delle importazioni italiane dall’OECE
Prodotti
agricoli
e Materie prime
Semilavorati e prodotti
Totale
alimentari
finiti
Dicembre 1949
52,6
76,7
11,1
54,1
Settembre 1950
71,1
81,9
66,2
75,6
Agosto 1951
74,3
82,7
69,2
77,0
Fonte: CGII, Annuario 1952, Roma, Tipografia Failli, 1952, pp. 476-477 e Martinez Oliva,. Stefani (2001), p. 235.
La liberalizzazione non decollò veramente fino al momento in cui la prospettiva di una
sistemazione delle questioni valutarie, attraverso la creazione dell’Unione Europea dei Pagamenti
(UEP), permise di adottare un’agenda più ambiziosa in materia di rimozione dei contingenti. Nel
giugno 1950 venne approvato il Codice della liberalizzazione che prevedeva all’art. 2 di
raggiungere entro ottobre 1950 il livello del 60% in ciascuno dei tre settori e, a partire dal febbraio
1951, il 75%, con almeno il 60% in ognuno dei settori previsti (OECE 1950). La nuova scadenza
non fu rispettata, ma, nel clima economico favorevole creato dal “boom coreano”, si registrarono
progressi soddisfacenti: nel giugno 1951 tutti i Paesi più grandi, con l’eccezione della Germania che
stava uscendo da un crisi della bilancia dei pagamenti, avevano raggiunto o superato la soglia del
75%; il Regno Unito era arrivato al 90% (Asbeek Brusse 1997, p. 140). Il primo anno di
funzionamento dell’Uep fu caratterizzato, per quanto riguardava l’Italia, da una tendenza debitoria
protrattasi fino al primo trimestre del 1951. Successivamente, a partire da luglio, tale tendenza si
invertì in modo brusco, tanto da giungere, a fine settembre, ad un saldo attivo di 142 milioni di
dollari, causato soprattutto dall’aumento delle vendite sui mercati del Regno Unito e della Francia.
Diveniva gradualmente evidente che l’Italia si avviava a diventare un creditore “estremo”
nell’ambito dell’Uep, cioè ad accumulare un surplus superiore alla sua quota di 205 milioni di unità
di conto. Si pose allora il problema di quali provvedimenti prendere per correggere tale tendenza,
103
mentre d’altra parte cresceva il disavanzo nei confronti dell’area del dollaro. A tali esigenze rispose,
in maniera decisa, il provvedimento adottato nell’autunno 1951 su iniziativa del ministro del
Commercio estero Ugo La Malfa, con cui venne liberalizzato il 99,7% delle importazioni dall’area
Uep e fu operato un tagli del 10% della tariffa doganale nei confronti di tutte le provenienze 10 .
Nel frattempo, le prospettive aperte dall’avvio dei negoziati per il pool del carbone e dell’acciaio
sembrarono favorire la ricerca di una nuova via per l’integrazione delle economie dell’Europa
occidentale, in alternativa al processo di liberalizzazione degli scambi perseguito in ambito OECE
che, per i criteri su cui era basato, generava asimmetrie, penalizzando le economie dei piccoli Paesi
a bassa tariffa. 11 . Fu in questo ambito che va valutata l’iniziativa italiana del Piano Pella, presentato
dal ministro del Tesoro Giuseppe Pella al Consiglio dell’OECE all’inizio di luglio 12 . Nel piano
Pella, pur non sconfessando il lavoro che contemporaneamente veniva condotto a Parigi sul piano
Schuman, si respingeva l’estensione ulteriore di una integrazione per settori 13 . Si sottolineava
infatti la difficoltà di trovare compensazioni all’interno dei singoli settori per i sacrifici che
l’apertura dei mercati avrebbe sicuramente comportato per le industrie più arretrate. In secondo
luogo, giocava un ruolo, particolarmente importante nel caso del ministro Pella, l’ostilità verso
ipotesi di integrazione che avrebbero con ogni probabilità comportato un cedimento di sovranità da
parte del governo italiano in materia di controllo della spesa. Infine, il documento italiano collegava
la possibilità di instaurare una totale libertà degli scambi alla realizzazione della completa libertà di
circolazione anche per la manodopera e per i capitali, un’ipotesi che, in un ambito settoriale,
sarebbe stata di difficile realizzazione.
Il governo italiano proponeva in alternativa di dare vita ad una zona preferenziale, attraverso un
processo di graduale abbattimento delle barriere al commercio, in un ambito di contrattazione
10
Sulla liberalizzazione del 1951 e le sue conseguenze, si vedano: Cavalcanti 1984, pp. 87-124; Bottiglieri 1984, pp.
154-165; Fauri (1997); Carli 1993, pp. 116-117; Battilossi 1996, pp. 321-327; Mechi 2003, cap. 2.
11
In questa cornice va collocato il progetto presentato in sede OECE nel giugno 1950 dal ministro degli Esteri dei Paesi
Bassi, Dirk Stikker, nel quale si ipotizzava di portare a compimento un processo di rimozione degli ostacoli al
commercio intereuropeo, non solo quelli quantitativi, ma anche quelli tariffari, agendo sui singoli settori, attraverso
l’azione di Comitati tecnici appositamente istituiti, partendo dalle industrie di base, come già stava accadendo col
carbone e l’acciaio, l’agricoltura (che era il settore che più stava a cuore all’Olanda), e quelle industrie di
trasformazione la cui specializzazione poteva offrire un contributo significativo alla crescita del commercio sia
intereuropeo che intercontinentale Sulla posizione olandese in merito all’integrazione europea (Griffiths 1990). Sul
piano Stikker cfr. anche Ministero dell’Industria, Direzione Generale Affari generali, Relazione sull’attivita dell’OECE,
n. 1, 1° aprile-30 giugno 1950, in ASCGII, f. OECE, b. 48.1/3, fasc. Relazioni su attività OECE. Il testo del piano è
riportato in Ducci, Olivi 1970, pp. 162-166.
12
AMDAE, DGAE C, IT 1950, b. 106, fasc. 4 Piano italiano all’OECE, OECE-Consiglio, Propositions et remarques
présentées par M. Pella au nom du gouvernement italien au sujet des méthodes à suivre pour l’organisation du marché
européen, 29/6/1950. Sul piano Pella la storiografia è scarsa; osservazioni interessanti in: Ranieri 1988, pp. 146-149;
Ranieri 1997, pp. 290-291; Petrini 2005, cap. 4.
13
«Il governo italiano […] osserva […] che la soluzione per settori si presenta sotto aspetti molto differenti a seconda
che si tenti di applicarla a uno, due o tre settori di massa e di base, o che si tenti di applicarla invece a tutti i settori
fondamentali dell’economia, vale a dire di applicarla di fatto a tutta l’economia europea.» (“Il piano Pella nel suo testo
integrale”, in Il Sole, 13/7/1950.)
104
esclusivamente intergovernativo, eliminando le restrizioni quantitative e riducendo i dazi, che
sarebbero stati comunque mantenuti come misura compensatrice delle disuguaglianze esistenti tra i
diversi Paesi. La riduzione delle tariffe avrebbe dovuto essere attuata in un periodo di dieci anni
circa, in parte attraverso un meccanismo automatico 14 , e in parte anche maggiore attraverso
negoziati tra i governi. Contestualmente il governo italiano richiedeva di realizzare «la liberazione
integrale delle transazioni invisibili», mentre per quanto riguardava la questione del trasferimento
della manodopera, si riconosceva che «una vera soluzione del problema» avrebbe dovuto «essere
ricercata e trovata su scala mondiale, con la cooperazione dei Paesi partecipanti e degli Stati
Uniti»15 . Si trattava, quindi, di un progetto che rifiutava ipotesi di cessione, anche parziale, di quote
di sovranità ad organismi sopranazionali, tanto più se l’integrazione era intesa in senso “verticale”.
Si optava piuttosto per un processo “orizzontale”, cioè riguardante tutti i settori produttivi, guidato
dai governi, dai tempi lunghi e dal ritmo molto graduale, con l’obiettivo di lungo periodo di
ricostituire un regime di interdipendenza in cui i beni e gli altri fattori produttivi potessero circolare
liberamente. Grazie al piano l’economia italiana si sarebbe visto garantito un periodo di protezione
sufficientemente lungo, al riparo delle nuove tariffe che stavano entrando in vigore proprio in quel
momento e che erano, insieme alle francesi, le più alte in Europa (Fauri 1995). Sul piano interno la
scelta di un metodo fondato sulla completa eliminazione delle restrizioni quantitative e sul
mantenimento delle barriere tariffarie, avrebbe limitato l’intrusione dei poteri pubblici nei
meccanismi di mercato alla sola manovra della leva daziaria, che comunque stava dimostrando di
essere uno strumento abbastanza flessibile da garantire un sufficiente spazio di manovra al governo.
B.1.e. L’Italia e il Piano Schuman: il Piano Sinigaglia e gli interessi dell’industria
carbo-siderurgica
Il Piano Schuman fu anche un momento importante per l’industria italiana – a partire dai settori
direttamente interessati, il carbone e la siderurgia – per collocare le proprie urgenti necessità di
riconversione, e insieme le proprie ambizioni di espansione, nel nuovo quadro delineato dalla
iniziativa francese e dal complesso negoziato che ne seguì.
La questione del carbone era, per l’Italia, relativamente meno importante. Il carbone copriva
all’inizio degli anni 1950 circa un terzo delle disponibilità energetiche nazionali; la massima parte –
14
«Alla fine del terzo e poi del sesto anno dovrebbero aver luogo riduzioni automatiche in tutte le voci delle tariffe
preferenziali, nella misura ad esempio del 15% […]. Così se […] il tasso della tariffa su una data voce fosse del 10%
esso dovrebbe ridursi all’8,5% alla fine del terzo anno e al 7% alla fine del sesto.» (“Il piano Pella nel suo testo
integrale”, Il Sole, 14/7/1950.)
15
“Il piano Pella nel suo testo integrale”, Il Sole, 14/7/1950.
105
intorno ai 10 milioni di tonnellate – veniva importato. L’importanza del carbone era andata
rapidamente decrescendo nei decenni e negli anni precedenti grazie agli investimenti nelle risorse
idroelettriche, nelle centrali termoelettriche, negli impianti di raffinazione del petrolio e nella
crescente valorizzazione dei giacimenti di gas naturale della pianura padana, accompagnata dalla
costruzione di una rete metanodotti (Petri 2002, p.157 e segg. e 347 e segg.).
La produzione di carbone e di lignite nazionale era abbastanza modesta, anche dal punto di vista
qualitativo. Il bacino carbonifero più significativo era quello del Sulcis, nella Sardegna sudoccidentale. Sviluppato nel periodo dell’autarchia fascista, dava lavoro a una intera comunità locale,
ma le sue prospettive, visti gli alti costi e la scarsa appetibilità del prodotto, erano incerte. 16. Il
settore della cokerie e delle officine gas era abbastanza ampio e complesso, e, senza contare le
lavorazioni secondarie, dava lavoro a circa 4.000 addetti. Si era sviluppato anch’esso durante il
periodo autarchico, soprattutto ad opera dei maggiori gruppi chimici, e, per quanto riguardava la
produzione di coke metallurgico, della siderurgia di stato. Gli impianti maggiori sorgevano lungo la
costa, per distillare il carbon fossile importato via mare. La produzione del coke metallurgico
avveniva presso gli stabilimenti siderurgici costieri dotati di altiforni: nel 1950 si trattava ancora di
un quantitativo modesto, ma era ma era destinato ad aumentare con l’espandersi della produzione a
ciclo integrale (ISTAT 1955; Confederazione Generale dell'Industria Italiana 1953, p. 1087 e segg).
Nel 1950 la produzione italiana di acciaio grezzo aveva raggiunto i massimi pre-bellici di 2,3
milioni di tonnellate; nel 1952 superò le 3,6 milioni di tonnellate, mentre la produzione di ghisa era
a livelli molto più bassi, appena sopra il milione di tonnellate. Si trattava di cifre decisamente
inferiori a quelle del Belgio e, per la ghisa, anche a quelle del Lussemburgo; la Germania e la
Francia producevano quantitativi di ghisa rispettivamente 14 e 8,5 volte superiori, e quantitativi di
acciaio 5 e 3 volte superiori all’Italia. L’Italia quindi era, nel pool carbo-siderurgico, una presenza
marginale dal punto di vista sia delle risorse, che della propria localizzazione rispetto ai principali
baricentri siderurgici continentali 17 .
La siderurgia italiana, come è noto, era composta di un settore di prevalente proprietà pubblica,
16
I più importanti settori consumatori di carbone erano le Ferrovie dello Stato, le quali, però, stavano rapidamente
elettrificando la rete nazionale, le cokerie e le officine gas. Cfr. Il piano italiano per il potenziamento del settore
carbonifero, "Il carbone", a.xiv, n. 2, febbraio 1950; Focaccia 1952. Il settore carbonifero in Italia comprendeva inoltre
alcune miniere di lignite nel centro Italia e di antracite in Val d'Aosta (Cogne), controllate per lo più da enti pubblici,
esse davano lavoro a circa 30.000 persone. Le attrezzature erano generalmente vecchie, la produttività bassa e i costi
alti; d'altra parte la produzione nazionale non copriva - per gli anni dal '47 al '50 - che una percentuale modesta
dell'approvvigionamento; per la gran parte della quantità e per tutto il combustibile di migliore qualità l'Italia rimaneva
tributaria dell'estero.
17
Vedi le statistiche in European Commission 2002, tav. 1.3.1 e 1.3.2. E' interessante notare come nel 1952 il Belux
(Belgio e Lussemburgo) fosse, tra i paesi della CECA, il più importante esportatore, con oltre 5,8 milioni di tonnellate
di esportazioni dirette di prodotti CECA, seguito dalla Francia (2,7 milioni) e dalla RFT (1.6). Anche negli anni
successivi il Belgio e il Lussemburgo (considerati spesso insieme in quanto legati da stretti accordi economici e
commerciali) rimasero i più importanti esportatori della CECA, insieme alla RFT. ivi tav. 1.4.1.
106
che faceva riferimento, in larga parte, al gruppo Finsider, e di un settore privato, i cui gruppi
maggiori erano il gruppo Falck e la FIAT siderurgica. L’accrescimento del ruolo del ciclo integrale
rifletteva la impostazione di Oscar Sinigaglia, presidente della Finsider, che proseguiva
aggiornandole le linee di politica industriale già messe in opera negli anni Trenta con il cosiddetto
“piano autarchico”. Il Piano di investimenti Finsider, o Piano Sinigaglia, puntava a una
modernizzazione della siderurgia costiera a ciclo integrale, con la ricostruzione su basi parzialmente
o totalmente nuove, e con le più moderne tecnologie americane, di tre grandi stabilimenti costieri,
Cornigliano, Bagnoli e Piombino, alimentati da approvvigionamenti di materie prime importate via
mare. Si puntava allo sviluppo delle produzioni di massa per sorreggere economie di scala, alla
specializzazione fra i maggiori stabilimenti, a una forte razionalizzazione per concentrare le
produzioni e chiudere o ridimensionare gli stabilimenti obsoleti, e soprattutto all’espansione del
settore dei laminati piani sottili a Cornigliano, in collaborazione con la produzione automobilistica
della FIAT. Nel complesso, il Piano Sinigaglia voleva alimentare la industria meccanica con
prodotti in serie a basso costo che la rendessero internazionalmente competitiva non solo, come in
passato, nelle produzioni di nicchia e di qualità (Sinigaglia 1946; Sinigaglia 1949, Finsider 1948).
Molti industriali siderurgici privati, guidati dalla influente famiglia Falck, avevano tentato di
contrastare il Piano Sinigaglia. La siderurgia padana era basata sulla lavorazione di semi-prodotti e
di rottame, importati dall’estero, in stabilimenti a carica solida, con larga presenza di forni elettrici.
Si dedicava, in buona misura, a produzioni di qualità (acciai speciali, ferroleghe, acciaio di qualità)
e di nicchia, e serviva i mercati regionali, in Lombardia e nel resto del Nord Italia. Era
sostanzialmente diffidente verso il progetto Finsider, teso a introdurre su larga scala in Italia, sotto
l’egida dell’industria di Stato, la grande siderurgia da altoforno per le produzioni in serie (Pozzobon
1982 e Idem 1978, pp. 277-308).
Il contrasto tra le due opposte posizioni emerse molto chiaramente tra il 1947 e il 1949,
soprattutto in sede di trattative sui crediti del Piano Marshall. Era prevalsa la linea di Sinigaglia,
appoggiata dalla FIAT di Valletta, con il risultato che l’Amministrazione americana aprì i rubinetti
per il finanziamento del Piano Finsider e in particolare della ammodernamento di Cornigliano.
Allorché fu lanciato il Piano Schuman, quindi, era già stata deciso un sostanziale mutamento negli
equilibri della siderurgia italiana, destinato a prendere corpo di lì a qualche anno, una volta giunto a
compimento il programma di investimenti della siderurgia di stato 18 .
I risultati dei nuovi investimenti restavano, tuttavia, da verificare, tanto più che aderire al Piano
Schuman significava per la siderurgia italiana, un settore storicamente protetto, affrontare la sfida
18
Sul contrasto Falck-Sinigaglia vedi Ranieri 1996, p. 145-190. Per il dibattito Sinigaglia-Falck vedi Ministero della
Costituente 1946 e "Il Mondo", dell’aprile e giugno 1949. Per un interessante prospettiva dal punto di vista Finsider
vedi Osti 1993, pp. 113-148; per la posizione della FIAT vedi Bairati 1983, p. 156 e segg.
107
dell’apertura di un mercato comune europeo insieme ai propri partners commerciali storicamente
più significativi e, quindi, pena la propria scomparsa, porre rimedio alla propria debolezza
strutturale sul piano dei prezzi e dei costi di produzione. Alcune stime relative alla fine del 1949,
mostravano come la differenza di prezzo fra l’Italia e i concorrenti, belgi, francesi e tedeschi, per
alcuni prodotti finiti di acciaio comune, si aggirasse in una forbice compresa fra il 40 e il 60%.
Anche volendo fare affidamento sul margine protettivo “geografico”, dovuto cioè alle spese di
trasporto in Italia, stimato, per i prodotti finiti, intorno al 20%, questo lasciava il mercato italiano
ampiamente esposto alla penetrazione, soprattutto nei periodi di domanda debole, salvo ottenere una
protezione doganale considerevole e garanzie contro pratiche di dumping da parte degli
esportatori 19 .
Il problema all’origine era quello dei costi di produzione. Una stima indicava che, nel 1951, la
produzione annua per operaio in Italia raggiungeva le 38 tonnellate, contro 72 in Francia, 80 in
Germania, 100 in Belgio. Un altro calcolo, effettuato dagli uffici di Ginevra delle Nazioni Unite
segnalava come produrre una tonnellata di barre commerciali in Italia costasse quasi il doppio che
non in Francia e ben il 130% in più che in Germania 20 . Tra gli elementi che penalizzavano
maggiormente le produzioni italiane c’era l’elevato consumo di rottame, i cui prezzi erano molto
alti, oltre ad essere soggetti a ampie oscillazioni. Non a caso uno degli obbiettivi principali del
Piano Sinigaglia era di diminuire il consumo di rottame, aumentando la produzione a carica liquida,
basata su minerale di ferro. Più in generale della dipendenza dall’estero per le principali materie
prime lasciava la siderurgia italiana esposta alla pratica dei cosiddetti “doppi prezzi”, un dumping
alla rovescia effettuato dai paesi esportatori a danno di quelli importatori 21 .
B.2. L’amministrazione italiana di fronte al Piano Schuman
19
Per un confronto fra prezzi italiani e prezzi degli esportatori europei nel dicembre 1949-gennaio 1950 vedi ACS,
SDG, b. 16, fasc. 126, Promemoria Finsider sui problemi siderugici, 31 marzo, 1950. La Finsider stimava, nel 1948, i
prezzi italiani superiori di una percentuale fra il 35% e il 60% superiori a quelli internazionali, Finsider 1948, p. 11.
20
Stime comparative in Gori 1952; U.N, Economic Commission for Europe 1953, tav. 79. Vedi anche Lister 1960, p. 60
segg.
21
I processi a carica liquida, o a ciclo integrale, erano quelli in cui la ghisa ottenuta dalla lavorazione d'altoforno (che
trattava, come è noto, coke e minerale di ferro) veniva passata direttamente nel convertitore, Thomas o Bessemer, a
secondo della ghisa trattata, oppure nel forno Martin-Siemens per ricavarne l'acciaio. Nei processi a carica solida,
invece, quantità percentuali variabili di ghisa solida e di rottame venivano caricate nei forni Martin-Siemens o nei forni
elettrici, riscaldate al punto di fusione, e trasformate in acciaio. Quindi mentre il convertitore era tipico delle produzioni
a ciclo integrale, e il forno elettrico di quelle a carica solida, il forno Martin-Siemens era utilizzato in entrambi i
processi. (Si aveva all'epoca qui considerata in Italia anche una limitata produzione a ciclo integrale al forno elettrico,
cioè direttamente dall'altoforno elettrico al forno elettrico) [ Osti 1993, pp. 302-303].
108
In questa sezione esaminiamo come l’amministrazione italiana raccolse la sfida dell’integrazione
europea, rispetto sia al Piano Schuman, sia alle iniziative che immediatamente lo precedettero. In
questo senso iniziamo l’esame del modo con cui vennero affrontate le trattative dell’Unione
Doganale, fra il 1947 e il 1950, in cui vi fu una forte presenza nel negoziato delle forze sociali, e
soprattutto delle associazioni imprenditoriali. Era questo un modello di rapporto fra
amministrazione pubblica e economia che riproduceva alcune caratteristiche del periodo fra le due
guerre, e cioè basato sul concetto della formazione di intese cartellistiche internazionali.
Esaminiamo poi l’articolazione di posizioni che si ebbe nell’amministrazione italiana a proposito
del processo di liberalizzazione degli scambi in sede OECE delineatosi fra il 1949 e il 1950, e che
vide, da una parte le forti resistenze delle categorie e di alcuni settori dell’amministrazione,
dall’altra l’emergere di una posizione più disponibile da parte di alcuni diplomatici e dei Ministeri
del Tesoro e del Commercio Estero.
Un interessante spaccato emerge anche dall’esame delle iniziative legislative e dei dibattiti
parlamentari che si ebbero in un breve lasso di tempo sulle questioni della nuova tariffa doganale,
dei finanziamenti all’industria siderurgica e sull’adesione al Piano Schuman.
Si evidenziava
innanzitutto la fitta rete di contatti fra commissioni parlamentari e interessi economici, per cui
anche esponenti di parte liberale e di fama liberista, come Corbino, si ponevano a difensori di
richieste da parte delle categorie di tono nettamente protezionista.
Emergono poi sintonie
inaspettate fra i partiti di sinistra, con le organizzazione sindacali di riferimento, e i progetti
dell’industria pubblica. Le contrapposizioni, fra forze di maggioranza governativa e opposizione s
su problemi di schieramento internazionale, come il Piano Schuman, si traducevano, quando si
parlava di interessi industriali nazionali, in ampie convergenze, fino ad arrivare a voti all’unanimità.
Il resto di questo capitolo è dedicato a un esame ravvicinato della adesione italiana al Piano
Schuman, a partire dal 9 maggio 1950 fino alla costituzione della delegazione italiana per la
Conferenza di Parigi, che si aprì il 20 giugno successivo. L’esame dei carteggi dell’amministrazione
relative a quelle settimane permette di delineare il ruolo delle varie strutture e anche di alcuni
funzionari. Una parte importante venne svolta dal Ministero degli Esteri, sotto la direzione
dell’allora ministro Carlo Sforza, attraverso l’operato sia dell’ambasciatore a Parigi, Pietro Quaroni,
che dei dossiers preparati dalla Direzione Generale degli Affari Economici. Importanti furono le
discussioni tenutesi al Ministero dell’Industria dove fu costituito una commissione interministeriale,
presieduta dal Ministro Giuseppe Togni, e a cui parteciparono anche gli industriali siderurgici. Da
quelle discussioni e dalla costituzione della delegazione italiana emergono gli equilibri interni al
governo, il ruolo svolto dalle varie amministrazioni. Il capo della delegazione italiana, Paolo
Emilio Taviani, venne scelto, però, in chiave politica, su intervento del Capo del Governo, De
109
Gasperi, che vedeva il Piano Schuman, non tanto come un negoziato tecnico, quanto come parte di
un processo europeistico che egli incoraggiava, al di là delle soluzioni concrete. Vi era, come
emerge, dai carteggi una iniziativa parallela svolta da De Gasperi a livello europeo, sulla base di
contatti fra i partiti democristiani fratelli, in particolare con la CDU-CSU di Adenauer.
B.2.a. I precedenti: forze sociali e amministrazione di fronte all’Unione
Doganale
Come accennato in precedenza, la vicenda dell’unione doganale italo-francese rappresenta la
prima, e al contempo, in maniera apparentemente paradossale, visto il fallimento complessivo del
progetto, la più compiuta applicazione di un metodo di integrazione che si può definire
“concertata”, caro agli interessi industriali europei. Con l’espressione “integrazione concertata” si
intende designare un’idea della costruzione europea secondo la quale l’unione economica era da
realizzare attraverso la creazione di intese transnazionali negoziate autonomamente dai produttori.
Si trattava in pratica di costruire un’”Europa dei cartelli”, attraverso la messa in opera di una rete di
intese e accordi col fine di regolare la concorrenza e spartirsi i mercati, evitando così le
conseguenze più spiacevoli che sarebbero derivate da un abbattimento delle barriere22 . Tale
modello aveva solide radici nel periodo tra le due guerre anteriore alla Grande Crisi, durante il
quale a più riprese erano stati avanzati progetti di intese internazionali di settore, soprattutto per le
industrie pesanti, nell’ambito dell’Europa cosiddetta “carolingia” (Bussière 2003)
Nel secondo dopoguerra l’Europe des cartels tornò ad essere il modello di riferimento del
capitalismo industriale privato, timoroso di un’integrazione economica internazionale che, sulla scia
del sempre maggiore protagonismo dello Stato nella vita economica, vedesse un ruolo sempre più
marcato dei poteri pubblici. Su questa linea conversero gli interessi, altrimenti divergenti su
questioni fondamentali, di diverse confederazioni industriali europee, come divenne evidente alla
Conferenza economica europea che si tenne a Westminster nell’aprile 1949 (Mioche 1993) 23 .
Ma proprio il profondo coinvolgimento delle categorie produttive nei negoziati, in origine
pensato anche per dare maggiore vitalità al progetto, diede origine a una creatura fragile, minata alla
base dai contrasti di interesse e paralizzata dagli opposti veti.
Nonostante le non poche perplessità presenti nel mondo imprenditoriale, furono proprio gli
22
I più decisi sostenitori di tale modello furono gli industriali privati francesi, sostenuti dai tedeschi. Su questi temi si
veda Moguen-Toursel 2002.
23
Cfr. anche la Résolution de la Commission des industries de base adoptée en séance plénière le 24 avril 1949, in
Archivio storico della Confederazione generale dell’industria italiana, Roma (ASCGII), f. Unice, b. 59.3/2, fasc. I e II
conferenza europea di Westminster.
110
ambienti industriali dei due Paesi a muoversi per primi, dopo la presentazione alla fine del 1947 del
Rapporto della commissione mista, prendendo la prima iniziativa concreta in vista dei negoziati
sull’Unione doganale 24 . Il protagonismo degli ambienti economici nelle trattative si realizzò grazie
soprattutto all’interessamento dell’ambasciatore italiano a Parigi, Pietro Quaroni, convinto che, di
fronte alle divergenti prospettive delle due diplomazie e al diverso peso da esse accordato alla
possibilità dell’unione doganale, solo rendendo gli interessi economici partecipi al progetto in prima
persona si sarebbero potuti raggiungere risultati concreti (Battilossi 1996, pp. 203-204). Anche
Grazzi, direttore generale degli Affari economici del Ministero degli Esteri, si espresse a favore
dell’Unione con la Francia in alcuni suoi interventi che decantavano le virtù del protezionismo in
un’Unione strutturata sotto forma di cartelli fra industriali sui quali avrebbero benevolmente
sorvegliato gli organi governativi, mostrando quanto in alcuni ambienti della burocrazia fosse vivo
il ricordo degli anni Trenta 25 .
A Parigi tra il 2 e il 6 febbraio si tenne una riunione tra le confederazioni industriali dei due
Paesi. Le delegazione italiana era stata allargata fino a comprendere, oltre al presidente Costa e a
Mario Saibante, capo dell’Ufficio studi della Confindustria che nell’occasione fungeva da
segretario, 29 rappresentanti di diversi settori produttivi. La composizione della delegazione
rispecchiava i rapporti di forza interni del capitalismo privato italiano, con la diretta rappresentanza
dei gruppi più importanti (FIAT, Falck, Edison, Montecatini, Italcementi) e una presenza
preponderante del settore tessile (nove rappresentanti, di cui quattro della sola industria
cotoniera) 26 . I colloqui si svolsero, dopo una prima riunione plenaria il 2 febbraio, su due piani
paralleli. Da una parte venne deciso di costituire una commissione ristretta (di cui entrarono a far
parte, per l’Italia, Costa, Eugenio Rosasco, industriale tessile, vicepresidente confederale, Pietro
Ferrerio, presidente dell’Edison, e Alberto Boyer), incaricata di esaminare il problema nel suo
complesso. Dall’altra parte vennero intavolati colloqui tra i rappresentanti delle singole categorie
24
Nel caso degli industriali italiani si trattava di agire per tempo in modo da poter condizionare l’azione del governo,
imponendo le proprie priorità. Per stare alle parole con cui si espresse Costa: “[…] è interesse degli industriali di non
stare inerti ad aspettare che la cosa sia fatta, ma di vedere in che senso e dentro quali limiti si possa appoggiare questa
iniziativa. Dobbiamo cercare di influire in senso positivo più o meno spinto, secondo gli interessi della nostra economia.
Se abbiamo il parere di una categoria che sia contraria per motivi particolari, dobbiamo superarlo, perché di fronte
all’interesse generale non possiamo preoccuparci dell’interesse di una o due categorie. Nel caso che sia leso l’interesse
di qualche categoria, vedremo cosa dobbiamo chiedere al governo per rimediarvi.” (ASCGII, f. Commercio estero, b.
102.11/1, fasc. Unione doganale italo-francese (Udif), Verbale della riunione del 12-13/1/1948.) Nello stesso senso cfr.
le dichiarazioni di uno dei vicepresidenti della Confindustria, Marco Segrè, secondo il quale era essenziale che il settore
industriale, “il settore preminente in questo complesso problema”, assumesse “un orientamento di carattere generale
deciso. Dobbiamo noi orientare il governo, e non farci orientare.” (Ivi.)
25
Per la posizione di Grazzi, AMDAE, AP, Francia, f. 30, telesp. 0122, da Parigi, “Trattative per l’Unione Doganale
Franco-Italiana”, 17/6/50; Grazzi, 1948.
26
Erano presenti sia Giovanni Falck, che Pietro Ferrerio, che Carlo Pesenti, il proprietario dell’Italcementi. Sulla
composizione della delegazione, cfr. ASCGII, f. Giunta esecutiva, b. 1.5/8, Riunione del 5-6/3/1948, Rapporto
dell’incontro fra le delegazioni industriali italiana e francese.
111
che, in riunioni separate, procedettero ad uno scambio di informazioni sulla situazione dei rispettivi
settori e ad un primo esame delle possibili conseguenze dell’unione.
La Commissione mista, istituita – come abbiamo visto – col protocollo di Torino del marzo
1948, aveva il compito di studiare i problemi derivanti dall’instaurazione di un’unione doganale e di
proporre ai due governi un progetto di trattato e un piano di attuazione di questa. Essa, a differenza
di quanto era accaduto nel caso della prima Commissione mista, non risultò composta
esclusivamente da funzionari ministeriali, ma, in gran parte ancora una volta grazie all’azione
dell’ambasciatore, Quaroni, sempre convinto che fosse necessario coinvolgere gli interessi
economici per assicurare maggiori probabilità di successo all’iniziativa 27 , fu aperta alla
partecipazione dei rappresentanti dell’agricoltura, dell’industria, dei sindacati e del commercio. Da
parte italiana, i delegati delle categorie economiche provenivano dalla Confindustria, dalla
Confcommercio, dalla Confagricoltura, dalle Camere di commercio, dalla Confederazione generale
del lavoro. La Confindustria designò quali suoi rappresentanti Ferrerio, Alberto Boyer e Saibante.
Nella commissione erano presenti anche cinque parlamentari per parte e rappresentanti ministeriali
di Tesoro, Esteri, Industria, Finanze, Commercio estero, Agricoltura e Trasporti 28 .
Presidente della delegazione italiana fu nominato il senatore Giovanni Battista Bertone,
piemontese, DC, già presidente del gruppo elettrico Sip, ministro del Tesoro nel II governo De
Gasperi e che sarebbe poi divenuto ministro del Commercio estero dopo le dimissioni di
Merzagora, nell’aprile 1949. Non sembra che la direzione di Bertone della delegazione italiana e in
generale l’impegno dei rappresentanti politici in seno alla commissione mista, siano stati
particolarmente efficaci, almeno nell’opinione di Umberto Grazzi, vice di Bertone in seno alla
commissione:
[…] la delegazione italiana, nei suoi dirigenti, non risponde come dovrebbe. Per turno, in
questa sessione [settembre 1948], ci spetta la presidenza dei vari comitati: ora un senatore non è
mai intervenuto, neppure nella sessione inaugurale; un deputato non presenzia alle riunioni; un
altro, pur presenziandole, ne risulta praticamente assente. Talora presiedono quindi i deputati
francesi, talaltra nostri funzionari e neppure di grado elevato. Tutta la delegazione manca di
coesione in mano alla presidenza. 29
La commissione fu suddivisa in cinque Comitati (doganale, economico, finanziario, del lavoro e
dei trasporti) che a loro volta si divisero in sottogruppi. Il Comitato economico si articolò nei
27
Scriveva Quaroni a Sforza: “[…] mi permetta di dirle con tutta franchezza che attraverso una commissione di
funzionari l’unione doganale italo-francese non si farà. I grandi interessi francesi non sono disposti ad accettare e ad
adattarsi a quello che avranno deciso i funzionari; sono in principio inclini a contrastare tutto quello che i funzionari
fanno”, perciò “se noi ci prestiamo al gioco, noi siluriamo l’unione doganale.” (AMDAE, Ambasciata di Parigi, b. 405,
Quaroni a Sforza, 3/3/1948.)
28
Sulla composizione della commissione cfr. la documentazione in AMDAE, DGAE B, IT 1948, b. 21, fasc. III
trimestre 1948.
29
AMDAE, DGAE B, IT 1948, b. 21, fasc. III trimestre 1948, Appunto per S.E. il ministro, 18/9/1948.
112
sottocomitati dell’industria, agricoltura e commercio estero. Carmine De Martino, deputato
campano della DC, portavoce degli interessi dei grandi proprietari agrari, fu nominato alla
presidenza, per parte italiana, del Comitato economico, suscitando le preoccupazioni dalla
Confindustria, timorosa che nelle trattative si imponessero gli interessi degli agrari (Battilossi 1996,
p 223).
L’impressione generale che si ricava dalle trattative, è che i governi delegarono ampiamente ai
rappresentanti degli interessi economici la risoluzione di numerosi problemi di adattamento. Consci
della posizione privilegiata conquistata, i rappresentanti confindustriali, coadiuvati dai colleghi del
CNPF, difesero attentamente gli spazi di autonomia guadagnati dalle possibili interferenze
provenienti sia dai poteri pubblici che dalle altre categorie. Come ha scritto Battilossi, si mirava “al
riconoscimento del diritto all’autogoverno sulle questioni direttamente attinenti agli interessi di
categoria” (Battilossi 1996, p 222). Tale orientamento era condiviso dagli industriali francesi,
preoccupati di escludere il più possibile le tentazioni dirigiste del loro governo.
Alla base di quest’impostazione vi era da parte degli industriali la coscienza di essere il soggetto
più forte nella contrattazione col potere politico, in grado di ottenere soddisfazione ai propri
interessi in un rapporto diretto con le forze di governo, senza dover passare attraverso i
compromessi che sarebbero stati necessari in un ambito che riuniva categorie con interessi
diversificati. Tale impostazione si scontrava con quella difesa dai rappresentanti dell’agricoltura i
quali, evidentemente assai meno fiduciosi nella loro capacità di contrattazione autonoma, volevano
invece che il Comitato procedesse ad approfondite indagini settoriali 30 . La posizione degli
industriali su questo punto fu ribadita in dicembre, in una lettera scritta dal presidente confederale al
ministro degli Esteri. In essa Costa, sulla base evidentemente di quanto espostogli da Boyer, si
lamentava del fatto che, nei lavori della commissione, alcuni settori (in particolare “agricoltura e
lavoratori”) si fossero indirizzati “anziché alla fissazione […] dei principi di carattere generale, alla
considerazione di elementi particolari”31 . Secondo Costa i provvedimenti particolari avrebbero
dovuto essere presi dopo che l’unione fosse stata realizzata, attraverso accordi tra i produttori,
evitando per quanto possibile l’ingerenza pubblica e le possibili interferenze da parte degli altri
soggetti sociali.
L’idea di procedere attraverso intese settoriali, al di fuori delle trattative ufficiali, era sostenuta
non solo dall’ambasciatore Quaroni, ma dallo stesso ministro Sforza che nel luglio 1948, ritenendo
indispensabile raggiungere intese nel campo della siderurgia e della meccanica, scriveva che a
30
AMDAE, DGAE B, IT 1949, b. 68, fasc. Udif, Appunto per S.E. il ministro, 14/12/1948.
Doc. 96, Lettera del 13 dicembre 1948 al ministro degli Esteri, Sforza, in A. Costa, Scritti e discorsi, Volume I: 19421948, Milano, FrancoAngeli, 1980, p. 641.
31
113
questo fine dovevano essere “incoraggiate le prese di contatto fra gli interessati dei due Paesi” 32 .
Significativa è la posizione assunta dal padronato durante le discussioni sulla composizione
dell’organo destinato a realizzare l’unione doganale, quello che nel trattato definitivo sarebbe
diventato il Consiglio dell’unione. Secondo gli industriali era preferibile che, data la composizione
ristretta di questo Comitato (inizialmente era previsto che fosse costituito da otto membri, quattro
per parte), ne entrassero a far parte i responsabili della politica economica di ciascuno dei due Paesi,
piuttosto che i rappresentanti degli interessi economici, come era stato richiesto dalle organizzazioni
sindacali 33 . Gli industriali avrebbero fatto sentire la loro voce nei comitati di settore, previsti come
organi consultivi del Consiglio, cioè in un ambito ristretto che escludeva l’intervento di altre
categorie e garantiva un rapporto diretto con le amministrazioni.
Ad ogni buon conto, la posizione degli imprenditori italiani e francesi fu in gran parte recepita
nelle conclusioni raggiunte dal sottocomitato dell’industria al termine della sessione romana dei
lavori della commissione, nel settembre 1948 34 . Nel documento si auspicava la progressiva
eliminazione del sistema di regolamentazione dei prezzi (che interessava un ventaglio più ampio di
prodotti in Francia che in Italia), “lo snellimento e appena possibile la soppressione delle misure” di
ripartizione e razionamento, infine, per quanto riguardava l’armonizzazione legislativa e
regolamentare, si prospettava l’opportunità “che le categorie interessate venissero chiamate a
procedere congiuntamente ad un esame di dettaglio delle singole questioni, formulando
raccomandazioni per l’esame di singoli problemi.” 35
L’impianto liberista, sui generis, difeso dai due padronati era prevalso, anche se nel documento
finale non era stato possibile consacrare questa impostazione come principio generale cui ispirare la
costruzione dell’unione in tutti i settori. Le parti, infatti, anche nella sottocommissione industria, si
erano divise: da una parte stavano gli industriali dei due Paesi, appoggiati, come disse Boyer, “da
32
AMDAE, DGAE B, IT 1948, b. 21, fasc. III trimestre 1948, Sforza a Tremelloni (Presidente del CIR-ERP), Campilli
(delegato per la cooperazione economica europea) e ai ministri dell’Agricoltura, dell’Industria e del Commercio estero,
24/7/1948. Il 27 agosto il ministro, rispondendo a Quaroni che insisteva sulla necessità di intese specialmente in campo
siderurgico (cfr. ad esempio AMDAE, Quaroni a Sforza, 2/8/1948, ibidem), scriveva: “Quanto alle intese dirette fra
interessati […] non posso che ripetere che tutto è stato fatto per favorirle, quando possibile.”.
33
A proposito dell’ipotesi di allargare la rappresentanza nel Comitato ai delegati degli interessi economici, Boyer
affermò: “[…] È da domandarsi se sarebbe utile stabilire questa specie di Parlamento nel quale si ripeterebbero
discussioni di interesse di parte che finirebbero per renderne difficile il funzionamento.” (Ivi.)
34
Come riconobbe Boyer: “[…] seppure i risultati conseguiti a Roma in questi giorni non possono essere ritenuti
soddisfacenti, essi sono orientati su quella linea che gli studi della nostra commissione industriale italo-fancese aveva
tracciato a Venezia”. A Venezia si era tenuta, il 6 e 7 settembre, una riunione della commissione industriale mista
istituita nell’incontro di febbraio a Parigi.
35
Cfr. Riassunto dei lavori svolti dalla commissione mista, 16/10/1948, in ASCGII, f. Commercio estero, b. 102.11/1,
fasc. Udif. Nella circolare indirizzata alle Associazioni di categoria, cui era allegato il documento, si rilevava che “la
Sottocommissione per l’industria […] si è mantenuta nella formulazione di principi generali, astenendosi volutamente
dall’entrare - e non avrebbe potuto neanche farlo data l’assenza di esperti e rappresentanti di categoria – nella
considerazione particolare dei singoli settori industriali. Su questo devono pronunciarsi le Associazioni di categoria.
[…] Le Associazioni di categoria sono pertanto pregate di provvedere, ove non lo avessero già fatto, alla presa di
contatto con le corrispondenti categorie francesi.” (Circolare n° 03180, in ASCGII, coll. cit.)
114
un funzionario intelligente”, cioè Ernesto Santoro, direttore generale del Ministero dell’Industria.
Anche la DGAE del MAE, rappresentata nella commissione economica dal suo direttore Umberto
Grazzi, condivideva l’impostazione degli industriali 36 . Dall’altra parte, “era asserragliata la difesa
del dirigismo”. In particolare Boyer indicava quale maggior ostacolo alla piena affermazione dei
principi sostenuti dagli industriali, “l’atteggiamento dirigista dell’amministrazione francese
attaccatissima alla realizzazione del piano Monnet” 37 .
Nelle altre commissioni si erano a volte imposti indirizzi del tutto opposti. In particolare gli
industriali lamentavano l’atteggiamento dei rappresentanti degli interessi agrari che ponevano,
come condizione pregiudiziale della loro adesione, il mantenimento del sistema dei prezzi
controllati per i prodotti agricoli e per i manufatti destinati all’agricoltura, muovendosi quindi in
direzione opposta a quella auspicata dagli industriali.
All’interno delle trattative sull’Unione doganale, particolare rilievo ebbero quelle per realizzare
una intesa siderurgica italo-francese. Le trattative furono condotte principalmente fra industriali
siderurgici dei due paesi. La delegazione italiana era composta sia da rappresentanti del settore
privato, di cui la maggior portavoce era la Falck, che della FINSIDER. In Francia la siderurgia era
privata, se pure lo Stato avesse ampiamente finanziato la sua ricostruzione e detenesse, quindi,
un’importante
voce
su
tutte
le
questioni
che
la
riguardavano,
dagli
investimenti,
all’approvvigionamento di materie prime ecc. La delegazione francese, infatti, insisteva perché i
programmi di sviluppo siderurgici italiani non contemplassero laminatoi a larghe fasce del tipo di
quelli che venivano installati in Francia, in particolare nella Francia del Nord dalla Usinor in Lorena
dalla compagnia Sollac. Questi programmi erano parte del Piano quinquennale francese e erano
stati programmati e finanziati dal Commissariat au Plan. In sostanza le richieste francesi miravano
ad annullare o ridimensionare il programma di investimento della siderurgia pubblica italiana che,
come abbiamo detto, programmava l’installazione di un laminatoio analogo a Cornigliano
nell’ambito del Piano Sinigaglia. Era chiaro quindi che le parti erano lontanissime e infatti non si
raggiunse alcun accordo. Importante era altresì il fatto che le questioni siderurgiche toccavano da
vicino le politiche pubbliche (Ranieri 1985).
B.2.b. I precedenti: la posizione sulla liberalizzazione degli scambi, 1949-50
All’interno del governo italiano il programma di liberalizzazione degli scambi, lanciato
dall’OECE nell’autunno del 1949, di cui abbiamo parlato, ebbe un’accoglienza carica di timori e di
preoccupazioni, anche se vi furono in sostanza linee diverse, da una parte una linea cauta e
36
37
Si veda ad es. Appunto per S.E. il ministro, 14/12/1948, cit..
Verbale delle riunioni del 24-25-26/9/1948, cit..
115
protezionista, dall’altra una, sempre cauta, ma più aperturista. Le due linee si intrecciano passo
passo nelle varie iniziative condotte all’interno e all’esterno dal governo italiano. Fin da novembre
1949, Giuseppe Pella, ministro del Tesoro, non mancava di rilevare che, fra molti rischi, le proposte
avrebbero potuto comportare, almeno in prospettiva, “enormi vantaggi”. Dalla consultazione del
governo con le categorie economiche, tenuta poco tempo dopo, emerse invece un memorandum
italiano, presentato all’OECE nell’inverno 1950, che era in effetti un lungo “cahier de doléances”.
Esso invocava, come condizioni di una piena adesione italiana al processo messo in moto
dall’OECE, la liberalizzazione nel campo della manodopera e delle transazioni invisibili, protestava
contro i vantaggi acquisiti dai paesi con una larga percentuale del commercio in mano allo Stato
(escluso dalla liberalizzazione), sollevava il problema della discriminazione nei prezzi delle materie
prime, i cosiddetti “doppi prezzi”, di cui l’Italia soffriva in quanto paese importatore. A tutto ciò la
Confindustria avrebbe voluto aggiungere una forte svalutazione della lira, ma si scontrava in ciò
con la linea rigidamente anti-inflazionistica del Tesoro e della Banca d’Italia.
Un interessante esempio di frizione fra elementi liberisti e protezionisti all’interno
dell’amminstrazione si ebbe nella primavera del 1950, a proposito della richiesta dell’ASSIDER,
l’associazione dei produttori siderurgici, per un contingente che limitasse le importazioni
dall’estero. Si era aperta infatti una fase di difficoltà per l’industria siderurgica europea, e vi era
stato un ribasso dei prezzi degli esportatori e ciò metteva a rischio ulteriore il mercato italiano, in
cui i prezzi dei produttori domestici, come abbiamo visto, erano notevolmente più alti della
concorrenza. La richiesta dell’ASSIDER, tuttavia, si muoveva in assoluta controtendenza con le
direttive degli organismi internazionali, e in particolare dell’OECE, che chiedevano a tutti paesi uno
sforzo per liberalizzare, e cioè eliminare i contingenti. Inoltre vi furono resistenza dell’industria
meccanica che non voleva un contingente che drasticamente limitasse le importazioni e elevasse i
prezzi dei prodotti siderurgici.
La richiesta, pertanto, fu esaminata dall’amministrazione e il
Ministero del Commercio Estero, dopo qualche tentennamento, decise di non accogliere la richiesta
dell’ASSIDER, nonostante che essa fosse caldeggiata, come vedremo, soprattutto dalla siderurgia
pubblica. 38 .
Piano Pella
La elaborazione del Piano Pella, di cui abbiamo già parlato, rappresentava una scelta del governo
e dell’amministrazione italiana, a favore della liberalizzazione commerciale e quindi l’emergere di
38
La trattativa meccanici-siderurgici in ASSIDER-Relazione 1950 pp. 54-55; vedi anche Confederazione Generale
dell’Industria, Annuario 1951, Roma, p. 44 fa un esplicito riferimento polemico alle importazioni di prodotti siderurgici
nella prima metà del 1950, suggerendo che venissero effettuate in previsione di un elevamento della tariffa.
116
una posizione anti-protezionista, se pure circondata da molte cautele. E’ interessante, quindi,
vedere come questa posizione emergesse all’interno dell’amministrazione. Una parte dei contenuti
del Piano Pellao erano stati anticipati in un rapporto spedito alla fine di dicembre 1949 da Giovanni
Malagodi, allora membro delle delegazione italiana presso l’OECE, a Vittorio Zoppi, segretario
generale del ministero degli Esteri 39 . Malagodi assumeva come perno centrale del suo ragionamento
la necessità per la penisola di aderire alla liberazione degli scambi, come condizione essenziale del
suo sviluppo, ma nel contempo si dichiarava scettico sulla possibilità che i cambiamenti di struttura
provocati nell’economia italiana da un aumento della concorrenza estera potessero trovare
facilmente compensazione nell’espansione in altri settori di attività, secondo i dettami della teoria
dei vantaggi comparati. Col venir meno delle condizioni (libera circolazione di merci, persone e
capitali) che avevano governato i mercati internazionali nell’età liberale, poteva diventare
“necessario per un Paese di sfruttare in via permanente talune risorse” produttive da esso possedute,
anche ad un costo superiore a quello prevalente sui mercati internazionali. Diveniva necessaria,
quindi, “una protezione di carattere permanente o semi permanente”. Tale protezione era da affidare
preferibilmente alla tariffa doganale piuttosto che ai contingenti, dato il carattere, al contempo più
rigido e più precario, di questi ultimi.
Il piano era stato poi concretamente steso, nella seconda metà del giugno 1950, dalla delegazione
italiana presso l’OECE, in particolare dall’ambasciatore Attilio Cattani, che ricoprì l’incarico di
delegato aggiunto della Rappresentanza permanente presso l’OECE dal febbraio 1949 al marzo
1955, da Malagodi e dal ministro Pella 40 . È importante sottolineare, quindi, come il piano fosse il
prodotto dell’incontro tra le concezioni di uno dei più brillanti diplomatici italiani, convinto della
necessità dell’integrazione europea e attento ai problemi economici, che in questo caso lavorò in
modo del tutto indipendente dalla struttura ministeriale 41 , le idee di un politico, con un passato di
consulente per l’industria tessile piemontese, e di un esperto vicino agli ambienti dell’industria
privata.
All’interno dell’amministrazione a raccogliere questa posizione era il Ministero del
Commercio Estero, mentre gli ambienti economici più protezionisti guardavano, piuttosto, al
Ministero dell’Industria.
39
Si veda Riflessioni sul nuovo piano americano per la liberazione degli scambi, allegato a Malagodi a Zoppi,
24/12/1949, in AMDAE, DGAE, IT 1949-1950, b. 91a, fasc. Lavori del Comitato dei Nove.
40
Si veda AMDAE, DGAE, IT 1950, b. 106 II, fasc. 4 Piano italiano all’OECE, Cattani a Zoppi, 20/6/1950 e l’allegato
appunto: Primo esame della proposta Stikker. Abbozzo di una proposta italiana.
41
Cfr. le perplessità sul piano espresse da Umberto Grazzi, in quel periodo a capo della DGAE, in AMDAE, DGAE, IT
1950, b. 106 II, fasc. 4 Piano italiano all’OECE, Grazzi a Massimo Magistrati, 27/6/1950, e l’allegato Appunto per il
ministro, 26/6/1950.
117
La elaborazione della nuova tariffa doganale e il ruolo del Parlamento.
La nuova tariffa venne approvata nel luglio 1950. Essa forniva al governo uno strumento molto
più agile di negoziato, in quanto il Governo era autorizzato per legge a sospendere o ridurne le
aliquote. E questa autorizzazione per legge veniva prorogata successivamente dando al governo uno
strumento ulteriore (Torricelli 1974, p. 785).
Introdotta il 7 luglio del 1950 la nuova tariffa generale era il risultato di una lunga mediazione
fra i dazi-progetto originari presentati dalle categorie, gli organi governativi e parlamentari. La
commissione interparlamentare, costituita in proposito nel dicembre 1949 42 , era presieduta da un
liberale indipendente, Epicarmo Corbino, il quale aveva la reputazione di essere un liberista, anche
grazie alla sua esperienza di Ministro del Tesoro nel 1946. Durante i lavori della commissione,
tuttavia, emerse una forte spinta ad appoggiare le richieste degli interessi di categoria, spinta cui
non si sottrasse neppure l’opposizione di sinistra alla quale se mai stavano a cuore il contenimento
dei dazi per alcune produzioni agricole e beni di più largo consumo. Di fatto i lavori della
commissione sembrarono registrare un certo grado di consenso per una tariffa appena al di sotto
delle richieste delle categorie, al punto che non ci fu mai il bisogno di portare la discussione in
Parlamento. Per i motori di piccola cilindrata, per esempio, le categorie avevano chiesto quote
variabili fra il 60 e l’80% mentre la Commissione insistette nel fissare una tariffa compresa fra il 40
e il 50%; inoltre non vennero intaccate che marginalmente le tradizionali roccaforti protezioniste
quali i dazi per frumento, zucchero e macchine elettriche (Grillo 1959, pp.117-118).
Il referente dal punto di vista governativo per fissare i dazi doganali sembra essere stato in primo
luogo il Ministero del Commercio Estero, i cui funzionari rappresentarono l’Italia alla Conferenza
di Annecy 43 .
42
La Commissione parlamentare per il parere sulla nuova tariffa generale dei dazi doganali fu costituita in base alla
legge n. 993 del 24 dicembre 1949. I suoi membri furono nominati dai Presidenti del Senato e della Camera
rispettivamente il 2 e il 4 febbraio 1950. [CAMERA DEI DEPUTATI I LEGISLATURA PP. 773-4]
Presidente Corbino Vicepresidente Medici e Vicentini e Pesenti (dep.)
Deputati: Arcaini-DC ; Barattolo-Monar.; Bernieri-PCI ; Chieffi-DC ; Dami-PCI ; Fascetti-DC ; Sansone-PSI ;
Troisi-DC ; Grilli-PCI ; Marenghi-DC; Pieraccini-PSI ; Preti-PSLI ; Rapelli-DC ; Saggia-DC ; Scoca-DC ; Todisco-DC.
Senatori: Boggino-DC; Cerruti-PCI; Berco-DC; DeLurenberg-DC; Giuia-PSI; Molinelli-PCI; Guglielmone-DC ; Mott-DC
; Parri-PRI ; Reale-PCI ; Salomone-DC; Tartufoli-DC; Pasquini-DC; Romita-PSI; Spezzano-PCI; Zotta-DC.
43
Notizie sul dazio generale in Grillo 1959; Lombardi 1961; Cavalcanti 1984, pp. 196 e ss.; per le posizioni della
minoranza Pesenti 1950,. Corbino aveva di fronte un progetto di tariffa approntato dagli organi ministeriali nel 1949.
Molte voci – 900 su 5600 – di questo progetto erano state convenzionate ad Annecy. Il punto di riferimento era il
regime vigente che prevedeva l’imposizione di un 10% come diritto di licenza + circa 1% del valore del dazio del 1921.
L’azione condotta dalla Commissione consistette nel tagliare secondo una formula matematica – +11 e diviso 2 – i dazi
superiore all’11%. La media aritmetica delle aliquote venne così ad abbassarsi dal 24,4% al 16,3%. Per i prodotti
siderurgici questo significava dei dazi più bassi di quelli convenzionati ad Annecy - una misura che non dispiacque ai
liberisti.
118
B.2.c. Forze politiche, amministrazione e parlamento di fronte alla politica
industriale nel campo siderurgico
Il Piano Sinigaglia fu discusso e approvato in alcune sedute del CIR nel corso del 1948. Le
obiezioni maggiori avanzate da ministri di tendenza liberista come Tremelloni e Giovannini
riguardavano i costi, ritenuti proibitivi, l’approvvigionamento di materie prime, che veniva
considerato molto difficile, e gli spazi di mercato lasciati ai privati, che si temeva potessero essere
soffocati dalla concorrenza statale. La difesa di Sinigaglia si concentrò invece sul problema
dell’abbassamento dei prezzi soprattutto per le lavorazioni in serie e sulla prevedibile crescita del
fabbisogno di acciaio nei prossimi anni, il quale avrebbe richiesto il concorso sia dei pubblici che dei
privati 44 .
La reazione dei comunisti, dei socialisti e della CGIL nei confronti del Piano Sinigaglia era stata
negativa. Il Piano venne criticato assai severamente per la sua logica di razionalizzazione e per i
conseguenti tagli nella manodopera che comportava e vi venivano contrapposte parole d’ordine sulla
lotta ai monopoli e il sostegno alla piccola e media industria. Una traccia di queste impostazioni
rimaneva ma ci fu un cambiamento di politica abbastanza marcato a partire dalla Conferenza
Economica di Roma della CGIL del 18-20 febbraio del 1950 che lanciò il cosiddetto Piano del
Lavoro. In sommario il Piano invocava l’intervento dello Stato in tre grandi branche: l’elettricità,
l’edilizia popolare, e la trasformazione fondiaria; in questi settori allo sforzo di intensificazione degli
investimenti pubblici sarebbe dovuta affiancarsi la creazione di tre Enti Nazionali. L’accento così
decisamente posto sulla necessità di un progetto di espansione diretto dalla mano pubblica
comportava il riconoscimento della necessità di una siderurgia nazionale come base di uno sviluppo
economico indipendente e come supporto di una forte industria meccanica. Ci si orientava così verso
un modello “autarchico”, con un occhio a possibili forniture dai paesi socialisti e in particolare al
carbone polacco. Il minerale di ferro invece, ed era una significativa convergenza con i programmi
della FINSIDER, sarebbe dovuto essere importato dall’Africa Settentrionale. Non mancavano certo le
critiche al Piano Sinigaglia, ma esse erano espresse in termini estremamente ragionevoli. Se ne
criticavano ancora i previsti tagli occupazionali e anche la timidezza degli obbiettivi produttivi, ma si
evitava però di ricordare le critiche di anti-economicita` avanzate dagli industriali privati. La scelta
del Piano del Lavoro era anzi decisamente in favore della produzione a ciclo integrale.
Un’interessante conferma degli schieramenti intorno alla questione siderurgica e delle apprensioni
suscitate dal Piano Schuman si ebbe dalla discussione parlamentare che si svolse alla fine del maggio
1950 sul disegno di legge per l’utilizzo del Fondo lire per finanziamenti all’industria siderurgica. Si
44
ARCHIVIO ROCCA, “Verbale seduta CIR del 5-8-1948, Discussione del problema siderurgico”; Pelaja 1982; Sinigaglia,
1949.
119
trattava dell’autorizzazione a devolvere la somma di 14 miliardi quasi esclusivamente a beneficio
della FINSIDER e del Piano Sinigaglia. Il provvedimento dopo un tortuoso iter fra aula e
commissioni era tornato in aula al Senato appunto il 26 maggio 1950, proprio nei giorni in cui si
discuteva dell’adesione al Piano Schuman. Il 30 maggio la discussione riprendeva e Togni sostenne la
necessità di rafforzare la siderurgia statale proprio in vista della adesione al Piano Schuman. Ai privati
che invocavano una diversa distribuzione dei fondi, egli faceva notare che si trattava di fondi gestiti
dallo Stato e quindi naturalmente destinati in forma prioritaria all’industria pubblica.
Il provvedimento fu infine approvato a larga maggioranza. Il successo maggiore lo ebbe un ordine
del giorno di Tito Oro Nobili, un anziano socialista di Terni, su cui confluirono maggioranza e
opposizione e che in sostanza era un avallo della linea della FINSIDER. Circa un mese dopo in
Commissione Industria della Camera la discussione fu più succinta e terminò - fatto davvero
interessante - con una votazione all’unanimità. In entrambi i casi le discussioni e le votazioni
fornirono interessanti indicazioni su come si era evoluto il pensiero dei principali gruppi politici. Al
termine dell’iter parlamentare, con la legge 28/7/1950, n° 722, si dispose l’utilizzazione di una
somma da prelevare sul fondo lire in favore di finanziamenti dell’industria siderurgica secondo gli
sviluppi del programma IRI. Il finanziamento concesso dall’IMI era sottoposto a previa
autorizzazione del Ministero del Tesoro, di concerto con il Ministero dell’Industria, su proposta del
comitato IMI-ERP (Pugliese 1974, p. 182). Un ulteriore esito della discussione parlamentare e del
consenso raccolto da Togni fu, dunque, quello di fare assumere al Ministero dell’Industria una
posizione determinante nella gestione dei fondi siderurgici, accanto al Ministero del Tesoro che era
preposto a tutte le pratiche concernenti fondi ERP. 45
B.2.d. Il Piano Schuman, la diplomazia e le riunioni interministeriali
La prima risposta italiana
La risposta della diplomazia italiana al Piano Schuman si articolò in due tempi. Una primissima
risposta, immediatamente seguente al lancio del Piano, si concretizzò in un assenso di massima. Si
trattò tuttavia di un assenso generico, che perciò non può definirsi, anche per le riserve che lo
caratterizzarono, come una vera e propria adesione. Secondo Pella, allora ministro del Tesoro,
l’adesione italiana venne data subito per ragioni politiche, lasciando in secondo piano le
considerazioni tecnico-economiche. Altre fonti confermano questa tesi. Il ministro degli Esteri Sforza,
dopo una breve consultazione con De Gasperi, dette istruzioni all’ambasciatore Quaroni di
45
CAMERA, ATTI, 1948-1953, Discussioni della x Commissione (Industria Commercio e Turismo)) in sede
legislativa, pp. 343 e ss.
120
comunicare al governo francese l’adesione dell’Italia. Si trattò quindi di una adesione politica, data in
una fase in cui i contorni stessi della iniziativa francese, al di là della dichiarazione del 9 maggio, che
pur conteneva zone d’ombra, non erano del tutto chiari (Olivi 1967; Pella 1957 p. 25).
Vi fu poi una seconda fase, a partire dall’ultima settimana del maggio 1950, in cui l’Italia fu
chiamata direttamente in causa e dovette definire la sua posizione. Per questo furono molto importanti
le consultazioni con gli ambienti economici coinvolti. Importante, inoltre, fu il ruolo svolto
dall’ambasciatore Quaroni, che attraverso una serie molto fitta di contatti con la diplomazia francese,
contribuì a chiarire meglio i termini dell’ iniziativa francese al governo italiano.
Per quanto riguarda la prima fase, essa fu quindi gestita essenzialmente dal ministro degli Esteri
sulla base dei rapporti dell’ambasciatore a Parigi, Quaroni, il quale godette di una ottima
comunicazione con il ministro degli Esteri francese, diretto responsabile della iniziativa in questione.
C’era quindi un interesse francese a tenere il governo italiano informato e coinvolto. Infatti l’Italia fu
informata del testo del Piano Schuman, in un colloquio tra il ministro Schuman e l’ambasciatore
Quaroni avvenuto qualche ora prima che fosse letta in pubblico alla conferenza stampa al Quai
d’Orsay, la sera del 9 maggio. Secondo Schuman, l’Italia avrebbe dovuto associarsi in un secondo
momento a una iniziativa franco-tedesca. Nei giorni e nelle settimane seguenti questa impostazione
sarebbe stata modificata. Poiché l’Italia, in questa prima fase, sembrava destinata a rimanere una
spettatrice di una iniziativa franco-tedesca, appare abbastanza significativo l’interesse francese,
espresso al massimo livello di coinvolgere e tenere informata la nostra diplomazia.
Le analisi che Quaroni spedì a Roma sulla base del suo colloquio con Schuman coglievano molto
bene l’importanza e la novità dell’iniziativa francese. Tuttavia Quaroni rimaneva ancorato a un
quadro di rapporti economici bilaterali, piuttosto che sottolineare la novità di fondo rappresentata dal
Piano Schuman. 46 Pur raccomandando a Roma di aderire, egli si mostrava molto preoccupato,
ricordando lo sgradito precedente del cartello siderurgico europeo della metà degli anni Venti da cui
l’Italia era stata esclusa, mentre industriali francesi, tedeschi, belgi e lussemburghesi si spartivano
quote di mercato e dettavano i livelli produttivi. Se dunque questa volta veniva richiesta, sia pure in
forma piuttosto vaga, la partecipazione italiana con quali garanzie essa avrebbe avuto luogo?
Nonostante che Schuman avesse dato allora alcune assicurazioni, il loro valore appariva a Quaroni
abbastanza simbolico.
La prima risposta ufficiale dell’Italia fu data da Sforza in una dichiarazione rilasciata prima a
Roma e poi a Parigi all’agenzia “France Presse”. Si trattava di una adesione essenzialmente di
principio, dietro cui non era difficile scorgere riserve e richieste di precisazioni. Sforza si felicitava
con Schuman e con Adenauer e indicava la disponibilità italiana a partecipare alla costituenda
46
AMDAE, Parigi, 478/1, da Parigi, t. 164/5, 9/5/50.
121
organizzazione. Anzi, continuava, l’iniziativa avrebbe acquistato significato storico solo se insieme
all’Italia vi avesse partecipato “la gran parte dei paesi europei”. Inoltre – sottolineava il ministro
italiano – la formazione del pool siderurgico non avrebbe mancato di risvegliare sia in Francia che
in Italia l’interesse delle opinioni pubbliche allo sviluppo dell’Unione Doganale. Era da parte di
Sforza un esplicito richiamo alla linea seguita dalla diplomazia italiana a partire dal 1947. Il suo
significato emergeva più chiaramente nelle istruzioni impartite a Quaroni il giorno successivo:
l’Unione Doganale e in particolare l’intesa siderurgica italo-francese, se approvata, avrebbe posto
Francia e Italia “in una situazione migliore di resistenza e direzione” nel nuovo organismo. 47
Nelle settimane successive un ruolo importante nel definire la posizione italiana fu svolto da
Umberto Grazzi, Direttore Generale degli Affari Economici del Ministero degli Esteri. I suoi
memorandum rappresentano un condensato delle paure e delle aspirazioni della politica europeistica
dell’amministrazione italiana. Le paure riguardavano soprattutto la possibile estromissione dell’Italia,
le aspirazioni si concentravano intorno a un’attiva partecipazione italiana alla risoluzione della
questione tedesca. I suoi documenti sono ancora più interessanti in quanto alla loro stesura diedero un
contributo importante gli industriali della siderurgia pubblica, che emersero, già in questa prima fase,
come uno degli interlocutori principali del governo.
I contenuti del Piano Schuman rimasero, in una primissima fase, incerti, il suo successo
estremamente dubbio. Per gli italiani si presentava come una sorta di Unione Doganale allargata. Né
nella prima settimana i francesi sembravano voler fornire spiegazioni più approfondite; in questi primi
giorni l’Italia fu lasciata ai margini, la sua adesione non poteva certo nuocere ma non sembrava
centrale alla riuscita del progetto, che doveva passare soprattutto al vaglio americano e superare in
qualche modo lo scoglio inglese. Poi i francesi se la sarebbero vista con i tedeschi.
Ferita nel suo protagonismo, la diplomazia italiana si interrogava ansiosamente su cosa potesse
riservarle l’iniziativa francese. Il suo assenso nascondeva molte riserve. Il peso della prima reazione
ricadde inoltre esclusivamente sul Ministero degli Esteri, mentre i ministeri economici e le categorie
industriali dovevano ancora ufficialmente pronunciarsi. Solo in forma molto approssimativa si può
sostenere però che le valutazioni di politica estera fecero aggio su quelle economiche. Nelle
elaborazioni della DGAE, infatti l’europeismo italiano rivelava infatti un sottinteso strato di ambizioni
economiche e le garanzie cui si riteneva di aver diritto inauguravano una linea di adesione che la
Francia avrebbe dovuto pagare a un prezzo piuttosto elevato.
Si trattava, secondo Grazzi, di cogliere quali spazi consentisse l’apertura francese. Se questa era
effettivamente un invito allora non solo ci si poteva inserire da protagonisti in una iniziativa
“europeista” - e forse, dal momento che l’iniziativa sarebbe potuta fallire, fare bella figura con poco 47
AMDAE, Parigi, 478/1 t. 322, Sforza a Quaroni, t. 322; AMDAE, AE4, f. 1, “Dichiarazione di Sforza”;
122
ma si poteva sperare anche di più. Si poteva, infatti, formare una intesa siderurgica franco-italotedesca che fornisse tutte le necessarie garanzie ai produttori italiani. E ancora: era possibile che la
Francia avrebbe finito per consentire agli italiani di partecipare direttamente allo sfruttamento in loco
della Ruhr, come era stato chiesto invano negli ultimi anni dai siderurgici italiani. Intanto bisognava
insistere sulle condizioni dell’eventuale partecipazione italiana; c’erano le assicurazioni date da
Schuman in ordine alla sopravvivenza della siderurgia italiana. C’era poi il patto siderurgico italofrancese che avrebbe potuto rappresentare una garanzia ancora più tangibile. E infine come ulteriore
controassicurazione di fronte ai rischi del pool, c’erano i programmi di investimento relativi alla
siderurgia italiana già approvati dall’OECE e finanziati dall’ECA.
In mancanza di informazioni più precise da parte francese nelle prime due settimane dopo la
dichiarazione del 9 maggio la principale fonte per la diplomazia italiana fu quella tedesca.
Interlocutore del rappresentante italiano Babuscio Rizzo era Blankenhorn, il vice di Adenauer, in
pratica il suo ministro degli Esteri. Dai tedeschi i diplomatici italiani cercarono di saperne di più sulle
vere intenzioni francesi e non ne furono del tutto rassicurati. Intanto sia Blankenhorn che Adenauer
ragionavano in termini esclusivamente franco-tedeschi e inoltre essi sottolineavano soprattutto il fatto
che si sarebbe trattato di una trattativa fra esperti industriali e che solo in un secondo tempo sarebbero
stati coinvolti i governi. Gli italiani furono quindi confermati nei loro maggiori sospetti. Si delineava
infatti la loro esclusione. Si insistette quindi con i tedeschi per essere tenuti informati dei colloqui
franco-tedeschi e si chiese inoltre ad Adenauer, in nome dell’europeismo e della solidarietà
interdemocristiana, di lasciare, almeno con una dichiarazione di intenti, aperta la porta a una eventuale
partecipazione italiana. Babuscio Rizzo si spinse fino a delineare il ruolo di mediazione che l’Italia si
riservava partecipando al nuovo ente internazionale. Naturalmente, non si mancava di far notare che
all’Italia doveva essere garantito il mantenimento dei propri programmi siderurgici. Sforza
comunicava ad Adenauer che avrebbe desiderato iniziare contatti “diretti” e non mancava di
richiamare l’importanza dell’Italia come mercato “consumatore”.
Proprio in quei giorni De Gasperi rilasciava una intervista al quotidiano di Monaco, “Die neue
Zeitung” in cui, pur non affrontando il tema specifico del Piano Schuman, esprimeva il favore italiano
per la riconciliazione franco-tedesca e la convinzione che occorresse valorizzare i punti di identità fra
partiti di ispirazione cattolica, in Francia, in Germania e in Italia. Era questa una linea parallela, di tipo
politico-ideologico, della iniziativa internazionale dell’Italia, che avrà una certa importanza, sia pure
di sfondo e di contorno, piuttosto che immediatamente operativa.
La posizione italiana si precisa
Il primo assenso di massima al Piano era stato dato dall’Italia all’interno delle coordinate abituali
123
della sua azione internazionale negli anni precedenti: presenza in tutte le iniziative europeiste, stretti
rapporti con la Francia attraverso il completamento dell’Unione Doganale, ricerca di garanzie
economiche. Allorché venne il momento di fare una chiara scelta rispetto alla partecipazione alla
conferenza internazionale convocata dai francesi durante l’ultima settimana di maggio, fu ancora
questo il criterio determinante. La definizione della posizione negoziale italiana fu un processo più
contraddittorio e impegnò le diverse istanze tecniche e economiche. La premessa era conoscere la
natura esatta del progetto francese, su cui, come abbiamo visto, nei primi giorni dopo il 9 maggio a
Roma si avevano più dubbi e supposizioni che non elementi di reale conoscenza. Questo chiarimento
fu portato in seguito ai colloqui parigini di Quaroni, fra il 23 e il 27 maggio, con Schuman, Hervé
Alphand, a capo della Direzione generale affari economici del Quai d’Orsay, e Monnet. E’ importante
osservare come negli stessi giorni fosse in svolgimento il negoziato franco-britannico. Fu proprio il
corso delle conversazioni con la Gran Bretagna che convinse la Francia a modificare l’impostazione
bilaterale adottata all’inizio e a cercare di coinvolgere fin dall’inizio l’Italia e il Benelux in una
conferenza internazionale.
Alphand e soprattutto Monnet si preoccuparono quindi di illustrare all’ambasciatore italiano i
contenuti del Piano. Il punto qualificante dell’iniziativa era la creazione di un’Alta Autorità e quindi il
carattere sovranazionale dell’iniziativa. Era quindi necessario che i governi inviassero a negoziare
delle personalità con competenze tecniche, ma con un ruolo politico e non degli industriali. Non era
questo un fatto puramente formale - magari fatto in ossequio agli americani che temevano che dietro
al Piano Schuman si nascondesse un cartello europeo - ma era l’essenza stessa del Piano Schuman,
che, del resto, rilevava Quaroni, i siderurgici francesi avversavano proprio perché riproponeva sul
piano internazionale quel dirigismo che essi erano riusciti a neutralizzare sul Piano interno, limitando
i poteri del Commissariat au Plan.
Le spiegazioni di Monnet e di Alphand toccarono un po’ tutti gli aspetti del progetto francese. Per
quanto riguardava i contenuti economici i francesi insistevano sulla liberalizzazione dell’accesso alle
materie prime, sulla fine dei doppi prezzi e di altre discriminazioni, sulla parificazione dei salari e
degli oneri sociali, sulla necessità di una cassa di riconversione per assistere la mano d’opera delle
industrie che il Mercato Comune avrebbe costretto a chiudere e non, precisava Monnet, per assistere i
cattivi produttori. Emergevano insomma, nelle linee essenziali, tutte le idee che il gruppo di Monnet
avrebbe riproposto alla conferenza di Parigi a un mese di distanza.
Monnet affrontò anche da vicino il problema della siderurgia italiana. E lo fece in termini nuovi.
Non si trattava di boicottare o ostacolare i programmi italiani di modernizzazione, secondo una
vecchia logica nazionalista di lotta per i mercati. Il nuovo pool avrebbe proposto la questione in
termini del tutto diversi. L’unica garanzia per la siderurgia italiana era nel libero accesso alle materie
124
prime garantito dall’AA. A queste condizioni era di fronte all’alternativa fra diventare competitiva o
fallire. Poca differenza avrebbero fatto le assicurazioni date dalla Francia su un piano
intergovernativo: i governi non dovevano più, per Monnet, sindacare in materia di acciaio
Da queste conversazioni con gli estensori del Piano, l’ambasciatore italiano fu tratto a rivedere
tutta l’analisi del Piano Schuman e a prospettare nuove linee di azione. Egli era visibilmente
preoccupato per il delinearsi di un progetto molto più ambizioso di quanto fino a quel momento non si
fosse potuto percepire. Non solo: le sue probabilità di successo sembravano notevoli, proprio in
quanto l’intesa franco-tedesca sembrava fondarsi su una obbiettiva convergenza di interessi. Di fronte
ad un blocco franco-tedesco anche le resistenze inglesi non sembravano capaci di produrre
significative incrinature; quanto poi agli interessi rappresentati dai paesi minori come l’Italia, essi
sarebbero passati decisamente in secondo piano. Nei primi giorni le reazioni di Quaroni erano state
dettate più che altro dall’istinto condizionato di tradizionale avversione a intese privilegiate francotedesche. Avute nuove spiegazioni egli rivide il suo primo giudizio: il Piano non era un nuovo cartello
europeo ma un’iniziativa di unificazione politica.
Giorni molto importanti furono quelli fra il 25 maggio e i primi di giugno. Si sviluppò, infatti, un
vero braccio di ferro franco-inglese sulla direzione che avrebbe dovuto assumere l’iniziativa. In realtà
più nel dialogo fra sordi in cui le due parti non fecero che ribadire le rispettive posizioni su cui si
erano attestate già il 25 maggio, non è difficile scorgere il tentativo di influenzare i partners minori
europei. Il momento in cui l’Italia si trovò a giocare un ruolo importante fu in occasione della sua
adesione al primo comunicato francese. Si trattava di un documento molto breve e generico: il punto
qualificante insisteva sul fatto che i negoziati si sarebbero aperti sulla base dei principi e “des
engagements essentiels” della Dichiarazione del 9 maggio. Questa proposizione fu leggermente
emendata - nel senso di rendere formalmente meno impegnativa l’adesione - nel secondo comunicato
proposto il 1 giugno. L’invito all’Italia fu ventilato il giorno 24 e venne formalizzato il giorno
successivo. L’adesione di Roma venne data quasi subito, il giorno 26. A questo punto i francesi
avevano in tasca oltre all’adesione tedesca anche quella italiana e non mancarono di farlo pesare con
gli inglesi.
La definizione della posizione negoziale italiana sugli aspetti economici
A definire la posizione negoziale italiana furono essenziali i lavori di un neo-costituito “Comitato
tecnico ministeriale per l’accordo intereuropeo del carbone e dell’acciaio”, istituito presso il Ministero
dell’Industria alla fine del maggio 1950, a cui parteciparono i principali rappresentanti siderurgici
italiani, insieme ai funzionari di vari rami dell’Amministrazione
Nelle prime reazioni al Piano Schuman emerse intanto con chiarezza la diversità di prospettive fra
125
gli industriali pubblici e quelli privati. Per i dirigenti della FINSIDER l’iniziativa francese costituiva
un’occasione per rilanciare le proprie richieste: queste comprendevano in primo luogo il libero
accesso alle materie prime e la fine delle discriminazioni sul loro prezzo. Inoltre si voleva l’acquisto
o, in alternativa, lo sfruttamento trentennale di un gruppo di miniere di carbone della Ruhr
equipaggiate da maestranze italiane. La stessa richiesta veniva avanzata per i giacimenti algerini
dell’Ouenza, già peraltro da tempo al centro delle attenzioni italiane. In altre parole si iniziava con il
presentare alla Francia una serie di richieste italiane di una redistribuzione delle capacità produttive
della siderurgia europea
La posizione dei Falck era alquanto differente. Secondo l’opinione di Giovanni Falck, espressa in
una lettera a Quaroni, il cartello europeo avrebbe dovuto includere l’Italia come paese importatore,
non solo di materie prime. L’accento di Falck batteva su due tasti: la possibilità di acquistare “grandi
quantità di semilavorati” dalla Francia e dalla Germania e l’accesso ad adeguati rifornimenti di
rottame.
Era chiaro che uno dei compiti della consultazione all’interno della categoria era di armonizzare
queste prospettive divergenti articolando una posizione negoziale credibile. Negli incontri romani di
fine maggio si precisarono inoltre le responsabilità dei diversi ministeri: il Ministero degli Esteri
condivise le responsabilità della trattativa con il Ministero dell’Industria, al quale però era devoluto
l’approfondimento degli aspetti economici del Piano Schuman. A sua volta il Ministero dell’Industria
si tenne in stretto contatto con gli interessi costituiti nel settore. Il ministro dell’industria Togni quindi
assunse un ruolo di mediatore fra i diversi gruppi di interesse. Egli si fece più volte portavoce degli
interessi delle industrie consumatrici di acciaio, schierandosi contro le proposte che miravano più
apertamente a irreggimentare il mercato interno; nello stesso tempo, però, rimaneva il principale
portavoce della proposta governativa di finanziare il Piano Sinigaglia..
Parteciparono al dibattito anche funzionari del ministero del Commercio Estero, i quali vennero
rimproverati da Togni e da una parte degli industriali per l’oscillante politica degli scambi e le
eccessive importazioni siderurgiche soprattutto dal Benelux e dall’Austria. Replicarono chiamando in
causa gli importatori privati. Questa polemica investiva l’intera impostazione della politica
commerciale: il Ministero dell’Industria sosteneva che essa avrebbe dovuto basarsi sulle esigenze dei
settori di base e non farsi guidare dalle convenienze momentanee, vedi la esportazione di prodotti
ortofrutticoli, tessili ecc.; il Ministero del Commercio Estero, il cui titolare era il socialdemocratico
Ivan Matteo Lombardo, si poneva di converso come il fautore dei vantaggi da trarre dalla
liberalizzazione degli scambi che stava investendo i mercati europei, ed era perciò contrario a
danneggiare gli interessi dell’industria meccanica, imponendo ulteriori restrizioni quantitative alle
importazioni siderurgiche.
126
Nella discussione emerse chiaramente che era interesse comune di tutta la categoria dei siderurgici
garantire una protezione al mercato italiano. Le soluzioni proposte erano però differenti. La
FINSIDER, riprendendo una proposta lanciata poco tempo prima, come abbiamo visto,
dall’ASSIDER nel suo complesso e caduta nel vuoto soprattutto per l’opposizione degli industriali
meccanici, insisteva sulla centralizzazione di ogni acquisto di acciaio dall’estero mediante la
fissazione di un contingente unico, strumento indicato come necessario per una più efficace politica
commerciale. Togni tuttavia criticò l’idea sostenendo che essa avrebbe avuto l’effetto di rialzare i
costi interni. Il contingentamento di Stato altro non era, del resto, che la continuazione delle pratiche
vincolistiche degli anni Trenta.
Per il professor Frumento, portavoce dei Falck, la risposta migliore invece era da ricercarsi nella
protezione tariffaria. L’Italia, secondo lui, avrebbe dovuto cercare condizioni più favorevoli di
ammissione al pool rialzando le tariffe di circa il 50%. Si trattava, bisogna notare, di una idea quasi
provocatoria, dal momento che l’Italia era già ampiamente criticata sul piano internazionale per le sue
tariffe doganali troppo protezioniste, ma essa ribadiva una propensione di lunga data di una parte
importante degli industriali privati: quella di poter contare in ogni caso su un comprensivo intervento
governativo in materia daziaria.
Parallela alla discussione sulla protezione si sviluppava quella sulla riduzione dei costi. Era un
argomento che interessava i tecnocrati della siderurgia pubblica, i quali, come sappiamo, sostenevano
da molto tempo che era solo dotandosi di impianti a ciclo integrale che l’Italia avrebbe potuto disporre
di una siderurgia competitiva e rifornire così una crescente industria meccanica sul mercato
dell’esportazione. Questi però nel 1950 erano ancora discorsi di prospettiva. Nell’immediato il Piano
Schuman poteva apparire come un’occasione per l’industria meccanica italiana che avrebbe potuto
aggirare gli alti costi italiani; molte aziende siderurgiche avrebbero inoltre potuto rinunciare a
produrre semilavorati per concentrare la propria attività nelle seconde lavorazioni. Di fronte a questa
prospettiva la FINSIDER sembrava arroccarsi in una posizione di difesa. Per Sinigaglia l’istituzione
di un contingente unico, di cui abbiamo parlato, era la premessa per installare un complicato
meccanismo di conguaglio per cui la differenza fra prezzi interni e prezzi esteri sarebbe stata versata
per agevolare sia le esportazioni siderurgiche che soprattutto quelle meccaniche. Si sarebbe così tolto
con una mano il possibile vantaggio arrecato dalla liberalizzazione del mercato - tutti i produttori
avrebbero dovuto pagare il prezzo interno - per dare con l’altra un incentivo alle aziende esportatrici.
All’interno di un simile meccanismo, lo Stato avrebbe finito per giocare un ruolo chiave, sia nella
fissazione dei contingenti, che nella determinazione dei costi, scavalcando del tutto il ruolo degli
organi consorziali della categoria in cui la Finsider sedeva accanto agli industriali privati..
C’erano tuttavia voci più ottimiste sulla prospettive di una riduzione dei costi: tra queste quella di
127
Taccone, portavoce della FIAT. Si trattava di valutare quanto avrebbe influito sul costo di produzione
la promessa liberalizzazione delle materie prime. L’industria italiana guardava innanzitutto alla fine
dei doppi prezzi, del carbone e ancora di più del rottame. Una volta che quest’ultimo fosse stato
incluso nel pool, come lasciavano ben sperare le specifiche assicurazioni date a Quaroni da Monnet,
era prevedibile un netto abbassamento dei costi di produzione in aziende come la FIAT, che basavano
la loro produzione siderurgica quasi esclusivamente sui forni elettrici. Sulla stessa linea, ma con un
tono molto più convinto, si poneva Bonaiti, il rappresentante dell’ISA. Egli affermava che le aziende,
in nome delle quali parlava, erano “la voce dei consumatori toccati dal Piano”. “Non appena continuava - il pool fosse in grado di fornire le materie prime alle migliori condizioni le piccole e
medie industrie italiane potrebbero immediatamente lavorare e prosperare in piena competizione con i
mercati esteri”. Fu certo questa una delle poche voci all’interno della categoria, e non solo in Italia, ad
abbracciare così spontaneamente le virtù del libero mercato.
Le obiezioni mosse da Togni alle proposte di Sinigaglia erano di diversa natura. Egli, infatti,
osservava che, in luogo di scaricare l’onere dell’aggiustamento prevalentemente sui consumatori
italiani, il Piano Schuman offriva la possibilità di stabilire un meccanismo di conguaglio su base
internazionale. Occorreva quindi proporre sul piano internazionale la debolezza dell’industria italiana.
Più avanti in questa stessa direzione si spingeva Santoro allorché osservava che occorreva
agganciare la nostra produzione a una percentuale fissa della produzione francese, così se la
Germania pretendesse di aumentare la sua quota, ciò non avverrebbe solo a detrimento
dell’Italia ma in egual percentuale anche della Francia, e perciò noi saremmo automaticamente
sicuri della difesa francese.
Le riunioni romane si conclusero quindi con un certo grado di consenso su due punti: tentare di
concludere il negoziato bilaterale con la Francia e difendere i livelli di produzione e gli investimenti
già accordati dall’OECE. Attorno a questi assi centrali si vennero definendo, nel dialogo tra gli
interessi e l’amministrazione, le condizioni per l’adesione italiana alla proposta lanciata da Schuman.
Già alla fine di maggio il ministro dell’Industria, Togni, in risposta ad alcune interpellanze
parlamentari, era in grado di precisare quattro condizioni:
•
un trattamento di assoluta parità con gli altri grandi Paesi produttori;
•
il libero accesso alle materie prime, in particolare carbone e minerale di ferro, con
l’eliminazione di ogni forma di doppio prezzo (“abolizione dei doppi prezzi sul
carbone, sui minerali, accesso alle fonti di materie prime alle stesse condizioni.”);
•
la conferma dei programmi di produzione approvati in sede OECE, e quindi del
piano Finsider;
128
•
garanzie per un adeguato mercato interno ed esterno 48 .
Le reazioni in Parlamento
In ambito parlamentare il Piano Schuman fu interpretato negli ambienti comunisti come un
tentativo di sabotare il programma industriale pubblico italiano. Esso veniva descritto come un
tentativo di organizzare la siderurgia europea su base monopolistica, tagliando i rami secchi, tra cui
quello italiano, e finalizzandola all’accrescimento della produzione militare del campo “imperialista”.
Da questa analisi, che non faceva gran conto degli obbiettivi specifici della Francia, discendeva la
denuncia della reintegrazione della Germania Occidentale sotto l’ombrello finanziario americano, di
cui l’Alta Autorità sarebbe stata la levatrice. L’adesione italiana veniva aspramente criticata come un
atto di rinuncia alla propria autonomia e sovranità nazionale.
Sulla stessa linea dei comunisti e della CGIL si collocarono i socialisti del PSI: no al Piano
Schuman e sì al Piano Sinigaglia. Il 18 maggio un Convegno nazionale dei lavoratori metalmeccanici
a Torino esprimeva una posizione completamente negativa sul Piano Schuman e si appellava al
governo italiano perché non vi aderisse.
Il comunicato finale era redatto in toni fortemente
propagandistici, tuttavia fra le righe vi traspariva preoccupazione per i ritardi nella attuazione del
Piano FINSIDER. Di nuovo il 4 giugno Di Vittorio a conclusione di un convegno su “L’industria e il
Piano del Lavoro” condannava recisamente l’adesione italiana al “cartello della guerra”. Entrambe le
manifestazioni fornivano un pretesto per rilanciare le proposte formulate con il Piano del Lavoro: si
indicava pertanto come realistico l’obbiettivo di una produzione di 4 milioni di tonnellate annue che
sarebbe stata utilizzata per accrescere le forniture alla flotta mercantile, e le produzioni di macchine
utensili e macchine agricole, tubi d’acciaio e prodotti per l’edilizia. Si insisteva anche sull’impiego
futuro di metano nella siderurgia, per ridurre la dipendenza energetica del paese. Questo sforzo di
articolare obbiettivi credibili suggerisce quindi che la strategia delle sinistre non fosse puramente
agitatoria ma implicasse in qualche modo una realistica conversione alle necessità di basarsi su un
ampio sviluppo del mercato interno, secondo una politica economica keynesiana volta a poggiare gli
incrementi di reddito sull’assorbimento dei fattori inutilizzati e quindi in primo luogo dei disoccupati.
Una singolare sintonia tra le posizioni della sinistra e quelle della FINSIDER si poteva notare a
proposito della politica doganale. In un dibattito parlamentare, infatti, Pieraccini (PSI) chiedeva
l’istituzione di un monopolio di Stato sul commercio dei prodotti siderurgici con la fissazione di un
48
Cfr. Atti parlamentari, I Legislatura. Camera dei deputati, discussioni. Seduta del 24/5/1950, p. 18583 e Atti
parlamentari, I Legislatura. Senato, discussioni. Seduta del 30/5/1950, pp. 16741-16742. Le stesse condizioni vennero
ripetute nella riunione del 15 giugno con i rappresentanti delle categorie industriali. (Cfr. ASCGII, f. CECA, s. Parte
generale, b. 50.1/2, fasc. Trattato istitutivo CECA, Riunione presso il ministro Togni relativa al piano Schuman,
16/6/1950.)
129
contingente di importazioni su base semestrale. Il monopolio veniva proposto in alternativa ai dazi
doganali essendo - si sosteneva - uno strumento protettivo molto più elastico e manovrabile che non la
tariffa doganale. I dazi, una volta stabiliti, non erano eliminabili e perciò impedivano, si sottolineava,
un “manovra ampia nell’interesse nazionale”. Lo stesso argomento veniva avanzato a proposito del
carbone, di cui si chiedeva quindi un pieno ripristino del monopolio di Stato.
Una posizione per alcuni aspetti originale, ma nettamente minoritaria, era quella espressa dai
socialisti riformisti di Unità Socialista (Pieraccini, Zanardi, Carmagnola). Essi sembravano
riallacciarsi ai temi liberisti della rivista “Critica Sociale” nel periodo giolittiano e alle polemiche di
stampo salveminiano di esponenti del campo laico radicale come Ernesto Rossi. Si schieravano infatti
a favore dello sviluppo di una siderurgia pubblica, ma non per massimizzarne gli obbiettivi produttivi
come faceva l’estrema sinistra, ma al contrario per sottolinearne l’obbiettivo di riduzione dei costi. La
costituzione di un mercato europeo sembrava loro dunque un’occasione positiva. Il socialdemocratico
(PSDI) Matteotti parlò invece a lungo del Piano Schuman nella discussione svoltasi alla Camera sul
bilancio del Ministero degli Esteri all’inizio di luglio. Egli portò molti argomenti anti-europeisti dei
laburisti inglesi richiamandosi in particolare alla Conferenza europea dei partiti socialisti svoltasi
pochi giorni prima a Londra. Avanzò anche decise critiche al federalismo che emergeva dai primi
documenti francesi alla Conferenza di Parigi sul Piano Schuman.
Nella Democrazia Cristiana coesistevano, come è noto, impostazioni molto diverse. Abbiamo già
visto il ruolo di mediazione svolto da Togni. Vi furono altri interventi che andarono nella stessa
direzione: Giovanni Uberti, per esempio, senatore, relatore del progetto di stanziamento a favore del
Piano Sinigaglia, si esprimeva con molta cautela sugli obbiettivi del Piano, giudicandoli alquanto
ottimisti. Spunti ancora più critici avanzava Paolo Cappa, senatore genovese, già ministro della
Marina mercantile, che sembrava tener presenti le rimostranze degli industriali privati e lo stesso
era vero per alcuni parlamentari liberali, tra i quali il senatore sardo Raffaele Sanna Randaccio che
estese le sue riserve anche al Piano Schuman, giudicandolo lesivo degli interessi nazionali.
C’erano quindi opinioni molteplici ma il dato di fondo era rappresentato dal formarsi di uno
schieramento abbastanza vasto a favore del Piano Sinigaglia - e questo era dovuto in parte non piccola
al convergere della sinistra intorno a una posizione “nazional-dirigista”. Le scelte fondamentali di
ristrutturazione produttiva potevano quindi svolgersi in un quadro di sostanziale consenso
politico-sociale, che sembra contrastare con l’immagine di lacerazione che una larga parte della
storiografia ci ha trasmesso dell’Italia centrista. E’ vero che ogni iniziativa di politica estera del
governo - e il Piano Schuman non faceva eccezione - veniva criticata con toni estremamente duri, e
richiedeva quindi uno schieramento diverso: la maggioranza governativa compatta con la simpatia
della destra contro i socialisti e i comunisti. Ma in questo frangente la sinistra si era posta in una
130
posizione scarsamente difendibile, poiché, mentre chiedeva di realizzare massicci investimenti
industriali nel settore siderurgico, contemporaneamente avversava quella che era stata individuata
come l’unica realistica via di negoziato a livello internazionale per renderli possibili.
B.2.e. La formazione della delegazione italiana
La composizione della delegazione italiana, decisa nei primi giorni del mese, veniva comunicata
ufficialmente a Parigi il 14 giugno. Le prime proposte di nomi contemplavano una folta
rappresentanza di esperti industriali. Tuttavia i francesi avevano messo in chiaro che si sarebbe
trattato di una conferenza a livello di governi e avevano invitato anche l’Italia a privilegiare l’aspetto
politico su quello economico-industriale. L’Italia accolse questo invito. Venne formata, così, una
delegazione di funzionari ad alto livello e vi venne preposto un uomo politico democristiano di una
certa notorietà come Taviani, che apparteneva all’ala moderata e degasperiana del Partito. Taviani
infatti era stato fino a due mesi prima segretario della Democrazia Cristiana ed era stato poi sacrificato
in omaggio al compromesso fra De Gasperi e le correnti democristiane di sinistra, raggiunto
nell’aprile 1950. Nella geografia interna della DC apparteneva alla generazione dei giovani: si era
distinto nella resistenza genovese, era tra i più vicini a De Gasperi e in politica estera era un convinto
atlantista. Era inoltre professore di economia, formatosi negli ambienti della Università Cattolica di
Milano agli indirizzi economici ispirati ai valori del cattolicesimo sociale, da questo punto di vista
non poteva quindi essere considerato come un liberista.
Taviani, peraltro, condivideva l’europeismo di De Gasperi. Membro delle Nouvelles équipes
internationales, movimento europeista di ispirazione democristiana, e del Movimento Federalista
Europeo, con l’accordo di De Gasperi, Taviani era impegnato a sviluppare le relazioni fra i partiti
democristiani europei, in particolare tra l’Italia e la Germania. (Preda 2004, p.510)
Secondo la testimonianza dello stesso Taviani il primo a consultarlo sarebbe stato proprio Togni.
Seguì una riunione a tre, De Gasperi, Togni e Sforza, presso la presidenza del Consiglio. Togni
avrebbe cercato di convincere De Gasperi, che evidentemente nutriva qualche perplessità. Decisivo
quindi per la nomina fu il sostegno di Sforza che si convinse quando appurò che Taviani avrebbe
fornito le necessarie garanzie di indipendenza sia di fronte all’IRI che ai siderurgici privati. 49
Gli ospiti francesi non fecero mistero di voler dare alla conferenza un tono politico di alto livello,
mentre in particolare le delegazioni del Benelux si presentarono armate per un negoziato tecnico,
comunque per discutere questioni pratiche. La delegazione italiana fu presa in un certo senso meno
alla sprovvista essendo, come rilevava Monnet, l’unica ad essere guidata da una personalità politica di
49
La comunicazione ufficiale della composizione della delegazione italiana in AMDAE, PARIGI, 478/1, t. 435, Roma,
14/6/50.
131
un certo livello.
Altri componenti della delegazione erano, per il Ministero degli Esteri, Antonio Venturini,
membro della Direzione Generale degli Affari Economici, vice quindi di Grazzi cui sarebbe stato
affiancato De Rossi; per il Ministero dell’Industria, Santoro e Panunzio e infine un funzionario del
Ministero del Tesoro, Balladore Pallieri, e uno del Ministero del Commercio Estero, Di Martino.
Sotto la direzione politica di Taviani le responsabilità maggiori erano affidate dunque a Santoro e a
Venturini, Santoro in particolare era un veterano di trattative economiche internazionali: durante gli
anni Trenta, come Direttore Generale del Ministero delle Corporazioni egli era stato uno dei massimi
responsabili dell’indirizzo “autarchico” della politica economica italiana. Nel dopoguerra aveva perso
sì la prestigiosa carica, ma non, a quanto sembra, la fiducia dei superiori.
La delegazione risultava quindi da un attento dosaggio fra i vari rami dell’amministrazione, con i
Ministeri dell’Industria e degli Esteri sullo stesso piano. Gli esperti industriali vi parteciparono
come aggregati. Si trattava di Guido Vignuzzi della FINSIDER, Armando Frumento, capo
dell’ufficio studi della Falck e docente di economia alla Bocconi, Domenico Taccone, responsabile
del settore siderurgico della FIAT ed Ernesto Bonaiti, presidente delle Industrie siderurgiche
associate (ISA), l’associazione di settore che riuniva le piccole industrie, cioè di quegli stessi che
avevano partecipato alla discussione preliminare sull’adesione italiana 50 . Inoltre, la Confindustria
incaricò il suo vicepresidente Quinto Quintieri di seguire l’evoluzione del negoziato, mantenendo
contatti diretti con Taviani.. Mancava invece almeno in un primo momento un delegato sindacale, e
come esperto dei problemi del lavoro fu inviato a Parigi un funzionario del Ministero del Lavoro,
Franco Volontè, proveniente dalla CISL. In sede di discussione del bilancio del Ministero
dell’Industria al Senato emerse fra l’altro il problema della mancata partecipazione, almeno iniziale,
dei sindacati alla delegazione del Piano Schuman. Giovanni Roveda – deputato del PCI eletto in
Umbria - criticò la mancata immissione nella delegazione italiana di un rappresentante dei
lavoratori. Togni ripose che c’era anche un rappresentante dei lavoratori. Roveda replicava però che
anche la CISL aveva protestato. 51
Giulio Pastore, il segretario generale della CISL, attraverso un settimanale legato alla
confederazione, “Conquiste del lavoro”, fin dall’inizio si dimostrò particolarmente interessato al
progetto Schuman. Il segretario della CISL si dichiarava a favore alla costituzione della CECA nella
prospettiva di un allargamento dei mercati che consentisse condizioni migliori per il mondo del
lavoro. L’adesione del sindacato di ispirazione cattolica era condizionata alla risoluzione del
problema dell’eccedenza di manodopera e, soprattutto, si richiedeva la presenza diretta di
50.
Sulla composizione della delegazione italiana cfr. la documentazione in ASUE, f. MAEI, PS, b. 9.
Senato della Repubblica, Atti Parlamentari, Resoconti delle discussioni 1948-50, volume XIV, Roma, Tip. del
Senato, 1950 pp. 17794 e ss]
51
132
rappresentanti sindacali nelle trattative di Parigi. Le richieste della CISL furono soddisfatte nel
luglio 1950, attraverso contatti diretti tra Pastore e Taviani che riconobbe la necessità di aggregare
alla delegazione un rappresentante della CISL in quanto tale 52 . Fu così nominato, in qualità di
esperto e rappresentante CISL, Giuseppe Glisenti che seguì il negoziato soprattutto per quanto
riguarda i temi della manodopera, rimanendo in stretto contatto con l’ufficio studi CISL guidato da
Mario Romani (Serra 1995, pp.130-131; Roy Willis 1971 pp. 241-243; Bozzo 1974, pp. 327-328) 53 .
Altri mutamenti e integrazioni della delegazione
Vignuzzi fu sostituito poi da Alberto Capanna per la Finsider. Capanna aveva lavorato con
Saraceno all’ufficio studi IRI; in seguito venne cooptato da Sinigaglia e Manuelli. Il Ministero del
Commercio Estero designò Parbone come esperto in materia doganale il 2/9/50; gli esperti per i
problemi del coke designati dal Ministero dell’Industria furono Arrigo Cajumi amministratore
delegato della società Cokitalia, Carlo Tomatis, presidente del Comitato produttori coke e Luigi
Nerbini, direttore dell’Associazione Nazionale Industriali Gas. Per il carbone Sandulli rappresentava
il Minindustria; Santoro agli inizi di settembre venne inviato a Washington a capo di una missione
italiana per l’esame dei problemi di mobilitazione industriale e tornerà a Parigi alla fine di settembre;
Gianni Perazzo funzionario del Ministero del Lavoro sostituiva Volonté in luglio.
B.3. Negoziato, interessi nazionali e imperativi europei: la
posizione italiana alla Conferenza di Parigi (1950-1951)
Iniziamo questa sezione con un breve sommario della Conferenza di Parigi, nel corso della quale
venne elaborato il Trattato della CECA. La Conferenza fu molto laboriosa, e affrontò in dettaglio
una serie di questioni sia istituzionali che tecniche, alla fine della quale emerse un Trattato molto
diverso dall’originario Piano Schuman. La delegazione italiana che aveva affrontato la Conferenza
molto timorosa per le proprie industrie, che erano più piccole e più deboli di quelle francesi,
tedesche e belghe, ottenne soddisfazione su vari punti ritenuti importanti per l’interesse nazionale
(tariffe doganali transitorie, approvvigionamenti di minerali di ferro ecc).
52
53
Taviani a Pastore, 21/7/1950, AMDAE, f. Amb. d’Italia a Parigi,, Francia 1950, fasc. 1 CECA.
Sulla inclusione di Volonté vedi AMDAE, Parigi, 487, f. 1, t.n.311, da Parigi, 21-7-1950.
133
I paragrafi seguenti esaminano da vicino il modo in cui vennero difesi gli interessi italiani
durante la conferenza sulla base dei carteggi tenuti dal capo della delegazione Taviani, dal Ministro
degli Esteri Sforza, dal presidente della Finsider Sinigaglia e da altre corrispondenze tratte da
archivi diplomatici e delle associazioni economiche. Un punto molto significativo fu il modo in cui
l’amministrazione fu in grado in una prima fase di collaborare con gli interessi economici, per poi,
in una seconda fase, selezionarne le richieste. In altre parole, alcune richieste delle categorie
vennero giudicate impresentabili e non suscettibili, quindi, di essere difese dalla delegazione
italiana. Gli esempi più significativi furono le richieste degli industriali privati in materia di prezzi
siderurgici e quelle, iper-protezioniste, degli industriali del coke.
Attraverso un esame di alcuni aspetti dei negoziati vengono messi in evidenza i ruoli
esercitati dai diversi spezzoni dell’amministrazione italiana, e dalle categorie economiche. In
particolare viene esaminato il ruolo del Ministero degli Esteri e di quello dell’Industria nella
trattativa italo-francese sui minerali di ferro, trattativa in cui assunse un ruolo di primo piano la
Finsider. Di notevole interesse anche il ruolo svolto dagli esperti sindacali CISL nel definire le
questioni sociali, e il ruolo del Ministero del Tesoro nel bloccare ogni tentativo di risolvere le
debolezze italiane attraverso meccanismi di compensazione che potessero andare a gravare sulle
finanze pubbliche.
B.3.a. Breve storia dei negoziati. La posizione italiana sui vari dossiers.
Il testo del Trattato venne faticosamente elaborato durante la Conferenza di Parigi, fra la fine del
giugno 1950 e l’aprile del 1951. E’ utile brevemente riflettere sui mutamenti del quadro
internazionale che ne accompagnarono lo svolgimento: in particolare lo scoppio della Guerra di
Corea, pochi giorni dopo che i delegati erano convenuti a Parigi, impresse un’accelerazione
notevole ai programmi di riarmo del blocco occidentale. Sul piano economico il mutamento di
congiuntura comportò innanzitutto lo scatenarsi di una corsa alle materie prime, seguito dal rialzo
generalizzato dei prezzi e da un’impennata della domanda, in particolare di quella di prodotti
siderurgici, da cui conseguirono forti guadagni le siderurgie, come quella tedesca, che marciavano
ancora a basso regime, con ampi margini, cioè, di capacità da utilizzare. Mentre gli ideatori del
piano Schuman, quindi, avevano pensato in termini di meccanismi per arginare una prevedibile
sovrapproduzione, ben presto le previsioni furono ribaltate e questo, se rese più agevole raggiungere
soluzioni di compromesso su molti punti delicati dell’agenda economica, complicò le cose dal
punto di vista degli equilibri franco-tedeschi, dando più voce in capitolo alla siderurgia della Ruhr,
in grado di proporsi come indispensabile fornitrice dell’alleanza occidentale (Gillingham 1991).
134
Il negoziato si articolò in tre fasi. Una prima discussione del Document de Travail si svolse alla
fine di giugno 1950; durante la seconda fase, da luglio a ottobre, si elaborarono i contenuti del
trattato negli appositi gruppi di lavoro mentre, nella terza fase, fra novembre e dicembre, il testo del
Trattato venne preparato per sottometterlo ai governi; l’approvazione dei governi era però legata a
una risoluzione di alcune questioni legate alla Germania, cosicché, dal gennaio al marzo 1951, le
potenze occupanti della RFT elaborarono un piano per la deconcentrazione dell’industria del
carbone e dell’acciaio tedesca, che fu, poi, accettato dal governo di Bonn. Subito dopo i delegati dei
Sei si riunirono di nuovo e il 19 marzo 1951 finalizzarono il testo del Trattato mentre i ministri
degli Esteri, dopo tre giorni di ulteriore negoziato, vi apposero la loro firma il 18 aprile 1951.
Durante la seduta inaugurale della Conferenza Monnet sottopose alle altre delegazioni, in modo
alquanto perentorio, il cosiddetto “Document de Travail”, un succinto elaborato in 40 articoli. Egli
indicava, peraltro, di voler limitare il negoziato a poche settimane, con il limitato obbiettivo di
installare l’Alta Autorità, la quale, in un secondo tempo, avrebbe provveduto a sistemare le questioni
“tecniche”. Questa impostazione venne giudicata inaccettabile dai paesi del Benelux, i quali si
rifiutarono di contrarre alcun impegno, senza precise garanzie, tradotte in accordi chiaramente
codificati. Fu sufficiente questa decisa opposizione perché i lavori si prolungassero e si articolassero
in diversi gruppi e sottogruppi di lavoro, all’interno dei quali, si può dire, che si assistette a una
insistente azione volta a correggere e integrare la filosofia del Document de Travail (Ranieri 1988;
Griffiths 1988).
La battaglia più accesa, in cui si distinse la delegazione dei Paesi Bassi, fu quella volta ad arginare
i poteri dell’Alta Autorità con la costituzione di un nuovo organo di rappresentanza intergovernativa
(Griffiths). Questa azione metteva a rischio il principio stesso del piano Schuman e costrinse,
pertanto, Monnet e Schuman a piegarsi a una serie di aggiustamenti, dai quali finì per emergere un
complesso edificio istituzionale, composto da un Consiglio Speciale dei Ministri, una Corte di
Giustizia, un’Assemblea Comune e un Comitato Consultivo aperto alle categorie produttrici e agli
utilizzatori - tutti organi che circoscrivevano la libertà d’azione dell’Alta Autorità. E’ interessante
notare che si veniva così a configurare un metodo comunitario, caratterizzato non tanto
dall’accentramento decisionale, quanto, piuttosto, da un complesso e articolato dialogo istituzionale.
Anche sulla natura economica del pool carbo-siderurgico, l’ispirazione iniziale di Monnet subì
importanti rettifiche. Secondo il Document de Travail vi sarebbero dovute essere due spinte
convergenti: da una parte, la rapida eliminazione di tutte le barriere daziarie e contingentarie;
dall’altra, un’ azione dell’Alta Autorità volta a parificare i prezzi e gli altri elementi fondamentali del
costo di produzione (salari, materie prime ecc), controllare gli investimenti, assegnare quote di
mercato, intervenendo, se necessario, sulle singole aziende. La liberalizzazione era concepita, quindi,
135
come un processo da pilotare, dovendo l’Alta Autorità stabilire se la concorrenza fosse “sana”, i
prezzi “ragionevoli”, e così via. In uno dei primi interventi della delegazione tedesca emerse, però,
una filosofia assai diversa, secondo la quale l’Alta Autorità si sarebbe dovuta astenere il più possibile
da ogni azione in tema di investimenti e avrebbe dovuto demandare la determinazione dei prezzi alle
pratiche consuete del mercato, consultandosi strettamente con le associazioni degli industriali. In
sostanza essa doveva aderire all’azione dei produttori, non sovrapporvisi.
Nel corso dei lavori le due visioni si misurarono con esiti alterni. Monnet riuscì a fissare una serie
di misure anti-cartellistiche e a conservare all’Alta Autorità una funzione di orientamento in tema di
investimenti e alcuni poteri di allocazione di quote produttive, limitatamente però ai periodi di crisi
(scarsità o sovrapproduzione) e da esercitare solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione del Consiglio
dei Ministri. Nello stesso tempo, però, essa dovette rinunciare ad alcuni dei suoi poteri, per esempio in
tema di parificazione di prezzi e di salari. I suoi poteri vennero, quindi, a definirsi soprattutto come
“negativi” – come tutela dalle pratiche discriminatorie - e orientativi, cosicché, per esempio, in
materia di prezzi il suo raggio d’azione venne a definirsi come complementare a quello di industriali e
governi.
Parallelamente si andava manifestando la richiesta di sovvenzioni o di misure speciali, da parte
dei settori produttivi più deboli della Comunità, che si sentivano minacciati dalla concorrenza, come
le miniere di carbone belghe e la siderurgia italiana. Unendo i loro sforzi, e sostenuti dalle proprie
delegazioni nazionali, essi ottennero di poter rimandare la liberalizzazione comunitaria fino al termine
di un periodo transitorio quinquennale, nonché di iscrivere nel trattato elementi di una politica sociale
volta a mitigare, con sussidi comunitari, le necessarie ristrutturazioni produttive, in particolare per le
loro conseguenze sulla manodopera.
Parallelamente, erano entrati in fibrillazione i rapporti franco-tedeschi, a partire dal momento in
cui, nel settembre 1950, l’Amministrazione Truman aveva proposto il riarmo della Germania
Occidentale nel quadro della NATO, aprendo, così, per quel paese la prospettiva di essere riammesso
a pieno titolo nel concerto occidentale al di fuori e al di là dei meccanismi previsti dal Piano
Schuman. E non mancarono infatti nell’autunno del 1950 i segnali di questo cambiamento di equilibri
nella crescente insoddisfazione da parte degli industriali della Ruhr e nell’esasperarsi del
contrattualismo del cancelliere Adenauer. La tensione si accrebbe ulteriormente, nell’inverno 1951,
allorché si passò a discutere della deconcentrazione e de-cartellizzazione della Ruhr, trattativa che
diede luogo a un vero e proprio braccio di ferro nei confronti degli industriali tedeschi da parte
dell’Amministrazione USA e di Jean Monnet, per la Francia (Willis 1965 , p. 119 sgg;).
Il Trattato Istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio, siglato a Parigi il 18
aprile del 1951, entrò in vigore il 25 luglio 1952 quando, al termine delle procedure proprie a ogni
136
paese partecipante per ratificare il Trattato, avvenne lo scambio dei documenti di ratifica.
Il Trattato si componeva di 100 articoli e di tre Annessi. Esso era completato da una
Convenzione relativa alle disposizioni transitorie, articolata in 31 paragrafi. Il Trattato CECA
costituiva un insieme complesso di norme e di procedure scaturito, peraltro, come abbiamo visto, da
un compromesso fra visioni economiche e politiche diverse. Tuttavia si può osservare, come l’Alta
Autorità venisse a godere di un grado di autonomia rilevante, garantita dai suoi poteri di prelievo, e
suggellata dalla possibilità di intervento diretto sulle imprese (Reuter 1953 ; Prieur 1962). Il potere
sovranazionale dell’Alta Autorità era, quindi, ben più rilevante di quanto non si verificasse per i
successivi trattati europei. E’ da sottolineare, fra l’altro, come per la prima volta in Europa, il
Trattato introducesse una precisa normativa anti-trust, affidandone le competenze all’Alta Autorità.
Nel complesso, quindi, i compiti definiti dal Trattato erano abbastanza precisi e affidavano all’Alta
Autorità la missione di aprire e organizzare il mercato carbosiderugico e di esercitarvi una sorta di
azione di polizia. In questo senso si trattava di un traité loi o traité règle, cioè di un trattato da cui
emanavano regole specifiche e non, come invece il successivo trattato CEE, di un traité–cadre
(trattato-quadro), che lasciava aperti definizioni e sviluppi ulteriori, secondo gli indirizzi impressi
dagli Stati membri (Frumento 1962).
La posizione italiana.
Prima della conferenza, come abbiamo visto, un assenso di massima era stato espresso dal governo
italiano e ribadito da Taviani, condizionato al soddisfacimento di determinate condizioni. Ma
permaneva una discordanza col punto di vista francese. Per Monnet in cima a ogni altra cosa c’era la
sopranazionalità, in quanto essa, a suo giudizio, era la chiave per risolvere il contenzioso
franco-tedesco. Per gli italiani tutto ciò era abbastanza incomprensibile, ma anche una volta che fosse
stato capito, era pur sempre un’intesa franco-tedesca da cui proteggersi o all’interno della quale
cercare il maggior numero possibile di garanzie.
Decisiva per questo sviluppo era stata la crisi negoziale del luglio, che aveva provocato una prima
fondamentale revisione del Document de Travail sotto la spinta delle preoccupazioni dei paesi del
Benelux cui si erano aggiunte le riserve italiane.
Nel corso del negoziato avevano trovato espressione alcuni dei problemi posti già dal Piano
Sinigaglia: la bassa produttività e l’eccedenza di manodopera, gli alti prezzi e le alte tariffe. Mirando
alla loro migliore risoluzione la delegazione italiana trovava validi alleati: i siderurgici francesi per la
protezione, gli interessi carboniferi belgi per le sovvenzioni, l’industria pubblica olandese per gli
investimenti, trovò poca comprensione invece nei pianificatori francesi, i quali sembravano rifiutarsi
di ammettere che il negoziato si riducesse a una serie di casi particolari. Il contributo italiano nella
137
costruzione comunitaria sembra quindi essere stato soprattutto nella direzione del realismo, la
delegazione contribuì a indebolire alcune delle pretese del Document de Travail, ma nello stesso
tempo, iscrivendo il Piano Schuman nel quadro degli obbiettivi e dei problemi della ricostruzione
economica nazionale, a irrobustire le possibilità di una fruttuosa collaborazione europea.
Cosa ottenne l’Italia? Innanzitutto veniva istituito un periodo transitorio che avrebbe avuto corso
per cinque anni a partire dall’apertura del mercato comune. Durante questi cinque anni erano
previste alcune clausole speciali, che comportavano misure di salvaguardia, per le produzioni
italiane 54 . La più importante riguardava la concessione di una protezione doganale decrescente per i
prodotti siderurgici italiani, che si estendeva anche agli acciai speciali, all’interno della Comunità,
insieme alla proscrizione, anche essa temporanea, agli allineamenti dei prezzi di listino sul mercato
italiano, normalmente previsti dal Trattato – in sostanza una garanzia contro pratiche di dumping da
parte degli esportatori (Convenzione Relativa alle Disposizioni Transitorie, § 30).
Una seconda clausola speciale, che interessava da vicino la siderurgia italiana e offriva una
importante garanzia al programma di sviluppo della Finsider, era quella che sottraeva ai normali
poteri di scrutinio e di giudizio dell’Alta Autorità gli investimenti già in corso alla data del 1 marzo
1951, e cioè prima della conclusione del Trattato.
Alla produzione italiana di coke veniva consentita una protezione doganale decrescente nella
CECA di cinque anni, mentre le miniere del Sulcis beneficiavano di un aiuto perequativo
comunitario di due anni per affrontare la concorrenza del mercato comune. 55 Infine, a beneficio sia
del carbone che della siderurgia, il periodo transitorio contemplava misure sul piano sociale, sotto
forma di contributi di riadattamento che l’Alta Autorità, insieme ai governi nazionali, avrebbe
potuto elargire per lavoratori che avessero perso il posto in seguito a misure di ristrutturazione
provocate dalla disciplina del mercato comune
Per esempio l’articolo 79 del Trattato ne limitava l’applicazione ai territori europei degli Stati
contraenti, escludendo quindi i Territori francesi d’Oltremare, quali l’Algeria che l’Italia avrebbe
voluto includere in ragione del fatto che deteneva importanti giacimenti di ferro, molto convenienti
per l’approvvigionamento della siderurgia costiera Finsider. Si giunse, in questo caso, a una
soluzione di ripiego, sotto forma di una convenzione bilaterale fra i governi francesi e italiano,
54
La delegazione italiana e belga si espressero a favore di un periodo transitorio già il 22 giugno 1950 (Mechi, 1997-8,
p. 82).
55
Vedi Testo Trattato, Convenzione Relativa alle Disposizioni Transitorie, § 25, 26 e 27 (Disposizioni particolari al
carbone, Italia). Il contributo di perequazione era alimentato da un prelievo sulla produzione delle industrie carboniere
tedesche e olandesi, i cui costi erano inferiori alla media ponderata dei costi di produzione nella comunità e il Sulcis ne
beneficiava come anche le miniere belghe.Precisava Taviani al Senato sulla questione del Sulcis: mentre i contributi
dell’AA erano limitati ai primi due anni del mercato comune, questo non valeva per gli aiuti governativi che potevano
essere elargiti per tutta la durata del periodo transitorio, (Taviani 1954, p. 26). Sulla protezione per il coke vedi Petrini
2004.
138
stipulata nel 1951, per la fornitura all’Italia di un quantitativo ragguardevole di minerali di ferro
algerino per un quinquennio
Un punto di grande importanza per l’Italia era la liberalizzazione del mercato del rottame. Infatti
si stimava che, una volta eliminate le restrizioni nazionali imposte da Francia e Germania, la
siderurgia padana poteva attivare correnti di acquisto preferenziale, a prezzi convenienti, del
rottame di raccolta presenti in zone geograficamente contigue quali la Francia sud-orientale e la
Germania meridionale. Nel Trattato la questione era, tuttavia, lasciata in un certo grado di
ambiguità. Da una parte infatti, il rottame era annoverato fra i prodotti da includere nel mercato
comune; dall’altra, però, un apposito allegato al Trattato ne decretava un probabile stato di penuria
che avrebbe quindi dovuto attivare un meccanismo di ripartizione su base nazionale.
Meno che soddisfacente fu per la delegazione italiana la regolamentazione adottata dal Trattato
in materia di prezzi. L’Italia aveva infatti due interessi: da una parte voleva eliminare le
discriminazione nazionali che favorivano i cosiddetti “doppi prezzi” per le materie prime, e
dall’altra, in relazione ai prezzi dell’acciaio, voleva che venisse mantenuto nelle quotazioni un
margine di protezione geografica, stabilendo quindi un sistema di prezzi-partenza - i listini di
ciascun produttore sarebbero stati fissati su base fob, mentre gli acquirenti si sarebbero fatti carico
delle spese di trasporto. Sul primo punto la delegazione ebbe soddisfazione, mentre sul secondo
dovette piegarsi ad accettare un sistema basato sostanzialmente su prezzi-arrivo, che favorivano i
produttori dei paesi esportatori, consentendo loro di allineare le proprie quotazioni in altri punti del
mercato comune, assorbendo nel prezzo finale i costi del trasporto
Per quanto riguardava le politiche sociali, accogliendo, con qualche distinguo, una richiesta
italiana, il Trattato conteneva il riconoscimento del principio del libero movimento all’interno del
mercato comune dei lavoratori delle industrie interessate. Si restringeva, però, questo diritto ai
lavoratori che avessero già maturato una esperienza di lavoro all’interno dei due settori e se ne
demandava la applicazione a un accordo da raggiungere fra i governi membri della CECA. (Romero
2004)
B.3.b. Il motore della posizione italiana: il rapporto fra politici, industriali
pubblici e privati durante la trattativa
Il 23 giugno si tennero conversazioni riservate ai margini dei lavori, fra Monnet e Parodi,
segretario del Quai d’Orsay, e i tre capo-delegazione italiani e cioè Venturini, Santoro e Taviani.
Questa riservatezza di contatti italo-francesi diede luogo a qualche equivoco in quanto gli italiani
139
pensarono che esso fosse il suggello di una sorta di relazione speciale, che invece si dimostrò alquanto
illusoria nel prosieguo del negoziato, o perlomeno richiedette sforzi diplomatici continuativi e
persistenti. 56 .
Nel corso delle trattative Taviani si contraddistinse per una enfasi sulle questioni politiche
generali di insieme, piuttosto che per una attenzione dettagliata ai problemi tecnici, la cui gestione
venne affidata alle cure degli esperti ministeriali coadiuvati dai rappresentanti delle categorie. Il
capo delegazione intervenne, per esempio, per deprecare ogni terzaforzismo, per un eventuale
raccordo del Piano Schuman con la Nato o, in ambito più tecnico, per cercare soluzioni al problema
della manodopera favorevoli al punto di vista italiano, mantenendo tuttavia, come avremo modo di
vedere, uno sguardo attento al quadro politico generale.
Importante fu poi l’opera di Taviani, in stretto contatto con Sforza, nel contenere il montante
dissenso degli industriali privati. A questo riguardo risultano significative le vicende relative ad un
controprogetto di trattato presentato dalle associazioni padronali dei sei Paesi coinvolti all’inizio del
1951. Le Associazioni padronali proponevano un vero e proprio progetto alternativo di trattato,
elaborato in gran parte dal CNPF, contenente una serie di emendamenti che comportavano una
profonda revisione dei poteri dell’Alta Autorità, in pratica sostituendo a questa, come perno degli
assetti interni della Comunità, le Associazioni di categoria 57 . In questo modo si rovesciava del tutto
l’impostazione del Document de travail monnettiano, in cui si prevedeva un ruolo per le
Associazioni come interlocutrici dell’Alta Autorità, in omaggio ai principi della pianificazione
concertata, ma in un rapporto subordinato rispetto alle direttive sopranazionali comunitarie (Ranieri
1988, p. 170) 58 .
Le indicazioni contenute nel documento padronale vennero comunicate dalla Confindustria al
governo italiano, ai ministeri dell’Industria e degli Esteri, e a Taviani e Santoro il 22 gennaio, ma
non vennero rese pubbliche perché nel frattempo erano intercorsi colloqui tra Georges Villiers,
presidente del CNPF e del CIFE (l’organizzazione raggruppante le associazioni padronali dei Paesi
membri dell’OECE), e Schuman nel corso dei quali il ministro francese aveva operato una cauta
apertura alle richieste degli industriali 59 . In considerazione dei possibili sviluppi di questi colloqui,
Villiers riteneva necessario “non dare corso, per ora, a nessuna pubblicità del documento approvato
56
AMDAE, Parigi 478, f.1, t. 261 da Parigi, 23/6/1950. ARCHIVIO TAVIANI, Lettera di Taviani a Sforza, 21/11/1950.
Cfr. Appunto riservato n. 56, 22/1/1951, in ASCGII, f. CECA, parte generale, 50.1/1, fasc. PS.
58
La concezione monnettiana del ruolo delle organizzazioni di categoria era stata esposta da Santoro Ai rappresentanti
delle categorie industriali in una riunione del 17 luglio 1950: “Nell’esplicazione della sua attività l’Alta Autorità
dovrebbe tenersi in contatto con organismi regionali costituiti eventualmente non sulla base dei singoli territori
nazionali ma anche sulla base di territori contigui. […] Attraverso detti organismi regionali l’Alta Autorità si terrebbe al
corrente della situazione nei singoli mercati.” (Cfr. Resoconto della riunione al ministero dell’Industria, 17/7/1950, in
ASCGII, f. CECA, parte generale, b. 50.1/2, fasc. Trattato istitutivo CECA.)
59.
Cfr. Mario Morelli (segretario generale della Confindustria) a Giovanni Falck, 1/2/1951, in ASCGII, f. CECA, parte
generale, 50.1/1, fasc. PS.
57.
140
dalle Federazioni” e pregava anche di considerare segrete le notizie riguardanti i colloqui tra lui e
Schuman.
Nei giorni seguenti il passo compiuto dagli imprenditori fu fatto oggetto di critiche da più parti.
Il 2 febbraio Taviani, in un colloquio con Quintieri, riferiva di aver parlato a lungo con Schuman e
Monnet dell’atteggiamento assunto dagli industriali e di aver tratto la conclusione che la
dichiarazione, così come era stata concepita, non rappresentasse “un elemento di particolare utilità
circa le future evoluzioni del piano”60 . Il punto più delicato emerso nei colloqui con i due promotori
del pool, era che attraverso un maggiore ruolo affidato alle categorie si sarebbe consentito ai
sindacati “di poter richiedere un’uguale partecipazione nella gestione del piano”, si sarebbe cioè
introdotto e legittimato sul piano internazionale il sistema dei consigli di gestione 61 . Sarebbe stato
preferibile, concludeva il capo della delegazione italiana, non dare un particolare rilievo al
comunicato delle sei Confederazioni, perché ciò avrebbe dato modo ai sindacati di intervenire nel
negoziato su un punto particolarmente delicato. Si trattava di un argomento scelto con abilità, che
contrastava le proposte avanzate dal padronato agitando lo spauracchio del concretizzarsi di una
delle eventualità più temute dall’imprenditoria: l’intervento diretto di tutte le organizzazioni
sindacali, comprese quelle di ispirazione social-comunista, molto forti in Francia e in Germania, nei
meccanismi comunitari. Più in generale Taviani riteneva inutile assumere posizioni “troppo decise e
troppo precise” nei confronti del piano Schuman: “quanto meno se ne parla, tanto più facile può
riuscire l’azione della delegazione italiana e tanto più facilmente si possono ottenere posizioni di
vantaggio” 62 .
Industriali e amministrazione di fronte al problema del protezionismo.
Sulla questione dei prezzi, si verificò una altra divaricazione fra interessi e industriali e i leaders
politici della delegazione. Il punto di vista degli industriali siderurgici italiani era a favore di un
meccanismo di prezzi-partenza che, in sostanza, avrebbe costituito un elemento di protezione del
mercato interno e avrebbe ostacolato le vendite in Italia dei produttori esteri. Questa richiesta,
espressa in termini ultimativi, venne accolta con un certo scetticismo da parte della DGAE, di Sforza
e di Taviani. In una lettera a Sforza del novembre, Taviani si domandava:
60.
ASCGII, f. CECA, parte generale, b. 50.1/1, fasc. PS, Appunto riservato n. 85, 3/2/1951.
Ivi.
62
Ivi. Il 19 febbraio fu reso pubblico il comunicato congiunto delle federazioni industriali dei sei Paesi, in una forma
molto più stringata rispetto alla prima bozza, in cui non si scendeva nei particolari delle proposte di revisione del
trattato e si parlava genericamente di cooperazione delle categorie industriali alla “preparazione dei provvedimenti
destinati ad assicurare il regolare funzionamento del mercato comune”. Non veniva fatta menzione del coinvolgimento
diretto delle Associazioni di categoria nel governo della Comunità, se non per un accenno alla possibilità per le imprese
di creare, su base volontaria, raggruppamenti secondo la legislazione vigente nei singoli Paesi. (Comunicato stampa,
allegato a Appunto informativo n. 416, 19/2/1951, in ASCGII, f. CECA, parte generale, 50.1/1, fasc. PS.).
61
141
Possiamo elevare a questione politica essenziale una questione che non verrebbe capita
dall’opinione pubblica, né dal parlamento, e sarebbe vista unicamente in funzione di protezione
della nostra industria siderurgica? Non mi pare […].” 63
Dopo tutto si faceva rilevare in alcuni ambienti della Direzione Generale del Ministero degli Esteri,
il sistema dei prezzi-parità offriva vantaggi non indifferenti all’industria meccanica, assicurandole, nei
periodi di penuria, le necessarie forniture di semilavorati, cosa che non sarebbe stata necessariamente
vera se si fosse adottato un regime più protezionista. D’altra parte i rappresentanti dell’industria
siderurgica, privata e pubblica, non demordevano e il carteggio della delegazione è pieno di appelli,
proteste, e invocazioni con cui l’Assider cercava di attirare la attenzione delle autorità governative
sull’importanza della battaglia in corso. Taviani però registrava con un certo rammarico che, dal
momento che la Francia aveva cambiato posizione, non c’era ormai da sperare molto.
Diverso in questo caso il comportamento di Santoro, che riprendeva letteralmente una citazione
di una lettera di Sinigaglia. Allorché i francesi mostrarono di non voler appoggiare la richiesta
italiana di prezzi-partenza, parlò di “improvviso e inspiegabile voltafaccia”. Al delegato belga che
avrebbe detto che ormai era “inutile discutere la questione, perché erano cinque contro uno”,
Santoro avrebbe risposto che “con questa pregiudiziale era inutile qualsiasi discussione visto che si
intendeva fare un atto di forza”.
Sforza però invitava la delegazione a soprassedere alle ultime resistenze della categoria e a
perfezionare ugualmente l’accordo.
Che la siderurgia - scriveva - continui a fruire di vantaggi che non hanno neppure gli
zuccherieri, sia pure, fin che durerà. Ma arrogargli di fare i giudici e le vittime di quanto fa il
Ministero degli Esteri non le pare che sia pretendere da noi più umiltà cristiana che non sia
necessario? 64 .
In sostanza Sforza, come prima Taviani, attento alle implicazioni politiche più generali del trattato,
si rifiutava di impegnare oltre una certa misura il governo dalla parte degli industriali.
L’Italia e l’Alta Autorità: la posizione di Sinigaglia
Per un sistema economico-politico debole come quello italiano, la questione dei poteri da attribuire
all’Alta Autorità assumeva contorni ben precisi se guardata nel più vasto contesto del mercato
europeo. Nel negoziato sui vari punti del Document de Travail quali prezzi, investimenti e programmi
di produzione infatti la siderurgia italiana si era trovata sul fronte opposte a quello delle siderurgie
nord-europee, a partire da quella tedesca, schierate su posizioni sostanzialmente cartellistiche,
richiamandosi, in qualche misura, al ruolo arbitrale dell’AA. In altre parole, per la siderurgia italiana,
63
64
ARCHIVIO TAVIANI, Lettera di Taviani a Sforza, 21-11-1950.
ARCHIVIO TAVIANI, Lettera manoscritta di Sforza a Taviani, 11 dicembre 1950.
142
vaso di coccio tra i vasi di ferro, poteva risultare conveniente trovare sostegno in un’AA per quanto
possibile indipendente dagli interessi più forti. Tale punto di vista fu fatto proprio in maniera quasi
immediata dai rappresentanti dell’industria pubblica, mentre i privati rimasero attardati, almeno fino
alla fine del 1952, in una polemica frontale con il dirigismo sovranazionale. Nel novembre 1950, in
un momento di particolare difficoltà nel rapporto con Monnet, era stato Sinigaglia in una lettera a
Taviani a dare voce a queste esigenze in modo significativo:
[…] mi pare che dovrebbe essere opportuno cominciare a prendere qualche contatto personale
e riservato con alcuni dei componenti delle altre delegazioni o, eventualmente, addirittura da
Governo a Governo, per stabilire che il capo del pool non possa appartenere a nessuno dei paesi
partecipanti, ma per esempio, essere un americano opportunamente scelto, sulla cui assoluta
imparzialità ed obiettività si possa fare sicuro affidamento. 65
Sforza, Il Piano Pleven, i minerali di ferro e la Conferenza di Santa Margherita.
Il rapporto italo-francese fu un elemento centrale della trattativa e delle posizioni di Sforza. Il
motivo principale di discordia fu costituito, come abbiamo visto, dalla inclusione dell’Algeria e
dell’Africa settentrionale nel pool, chiesto dall’Italia e rifiutata dalla Francia. Poiché, nell’autunno
1950, si era aperto, su pressione USA, il problema del riarmo tedesco e la Francia cercava un
appoggio italiano per le sue proposte alternative (il Piano Pleven), l’Italia poteva esercitare un certo
potere di ricatto.
Sforza fu molto esplicito nel legare la questione del riarmo a quella dei minerali di ferro in un
discorso parlamentare pronunciato il 10 novembre. Sul Piano Schuman egli diede un avvertimento
molto serio alla Francia: l’Italia, diceva Sforza, restava a favore del Piano Schuman ma
ci sarebbe estremamente difficile non sollevare obiezioni serissime se certe regioni minerarie
dell’Africa del Nord appartenenti alla Francia non venissero a far parte del pool 66 .
La trattativa continuava fra alti e bassi nelle prossime settimane e si delineava una soluzione di
compromesso consistente nella garanzia da parte francese di un certo quantitativo di
approvvigionamenti di minerale di ferro all’Italia per i prossimi anni.
L’accordo, tuttavia, si
raggiunse solamente al termine di un vertice diplomatico, in cui l’Italia si impegnava ad appoggiare
l’iniziativa francese per una Comunità Europea di Difesa.
Il 9 gennaio 1951 il Quai d’Orsay annunciava un incontro De Gasperi-Pleven da tenersi in Francia
meridionale e il governo di Roma, dopo un iniziale riserbo, accettava. Un editoriale ispirato da Sforza
su Esteri, la rivista ufficiosa del Ministero degli Esteri, analizzava le ragioni per cui si era arrivati a
65
66
ARCHIVIO TAVIANI, Lettera di Sinigaglia a Taviani, 25/11/1950.
CAMERA, DISCUSSIONI, v. xvi, 1950, pp. 23551-23556;
143
fissare il “vertice”: infatti per il numero di Ministri coinvolti e anche per il tipo di procedura adottata
si trattava di qualcosa di più di un incontro diplomatico. L’intesa italo-francese - vi si affermava - pur
rimanendo cordiale non aveva fatto nell’ultimo anno concreti passi avanti e anzi si erano registrate
ombre, sia sul Piano Schuman, che sul riarmo tedesco. Di qui la necessità di un convegno 67 .
Nel corso dell’incontro emerse un forte interesse di De Gasperi ad appoggiare il governo tedesco di
Adenauer. Egli espresse l’opinione che era necessario sostenere Adenauer contro i socialdemocratici
di Schumacher, portatori di una opzione neutralista. Trovò il pieno accordo di Schuman il quale
ricordò anzi che il Piano Schuman era servito proprio a quello scopo. Di fatto, pure in questo clima di
non piena comprensione, le due delegazioni si accordarono sulla necessità di collaborare nella
prossima conferenza per la creazione della CED (Comunità Europea di Difesa) e questo in sostanza
significava che l’Italia garantiva alla Francia il proprio sostegno. I francesi apprezzarono tanto questo
gesto da mostrarsi pronti a concedere una parte importante delle partite di minerali richieste dalla
siderurgia italiana. Venne così a cadere l’ultima ragione di resistenza italiana nei confronti della
futura Comunità del Carbone e dell’Acciaio.
La Conferenza fu importante soprattutto per il clima che si stabilì fra le due delegazioni, per molto
tempo si parlò ancora dello “spirito di Santa Margherita” a indicare l’esistenza di un rapporto
privilegiato fra Roma e Parigi. Sembrava di essere tornati ai primi tempi dell’Unione Doganale.
(Pastorelli 1984)
Organizzazione della delegazione italiana .Questioni particolari.
Lo svolgersi dei lavori della Conferenza suggerisce alcune osservazioni sulla articolazione interna
della delegazione italiana. Le prime riunioni interne, incaricate di esaminare il Document de Travail
francese, presentato all’inizio della Conferenza, si svolsero presso il Ministero degli Esteri fra la
fine di giugno e l’inizio di luglio 1950. Vi fu, prima, una discussione plenaria del Document de
Travail da parte di tutta la delegazione e quindi due sottocomitati furono incaricati di formulare
osservazioni specifiche, rispettivamente sugli aspetti economici e su quelli istituzionali.
Successivamente la conferenza si divideva in 5 gruppi di lavoro, dei quali il più importante era
quello per la definizione delle istituzioni comunitarie, presieduto da Monnet e a cui per l’Italia
partecipò il capo delegazione, Taviani. Lo stretto collaboratore di Monnet, E. Hirsch prese invece la
direzione del gruppo di lavoro su “produzione, prezzi e investimenti”, investito della definizione delle
principali questioni economiche, al quale per l’Italia partecipavano gli esperti industriali e i funzionari
67
“L’incontro italo-francese” ESTERI, a.ii, n. 2, 31 gennaio 1951.
144
dei Ministeri dell’Industria e del Tesoro.68
Si formarono inoltre un gruppo di lavoro sulla politica doganale, e un altro sui problemi sociali e
sindacali che iniziò però a lavorare solo il 20 luglio per potersi collegare con i risultati delle
discussioni del gruppo di Hirsch. Infine fu costituito un gruppo di carattere più tecnico sulla
“nomenclatura”, cioè sulla definizione e sul censimento di ciò che avrebbe dovuto essere incluso nel
pool. (Racine, p. 89)
Nel gruppo di lavoro sulle questioni doganali la parte maggiore fu svolta dai rappresentati delle
diplomazie, esso si riuniva infatti al Quay d’Orsay e era presieduto da Alphand e da parte italiana vi
parteciparono i funzionari membri della delegazione del Ministero degli Esteri e del Ministero del
Commercio Estero.
Al gruppo sui problemi sociali parteciparono invece i funzionari del Ministero dell’Industria,
Santoro e Panunzio, nonché Balladore Pallieri del Tesoro, mentre l’esperto del Ministero del Lavoro
Volonté venne affiancato da Giuseppe Glisenti della CISL. A significare l’importanza che la
delegazione italiana attribuiva agli aspetti sociali, anche il capo-delegazione Taviani vi intervenne, per
difendere il principio della libera circolazione dei lavoratori, che abbiamo visto era al centro della
politica italiana per l’integrazione europea.
Atteggiamento finale dell’amministrazione italiana e degli interessi economici verso il Trattato
A pochi giorni dalla Conferenza finale dei Ministri degli Esteri di Parigi, nell’aprile 1951,
Sinigaglia scriveva a Sforza chiedendogli di battersi perché fosse accordato all’Italia il diritto di
recesso alla fine del periodo transitorio, troppe, secondo Sinigaglia, erano le incognite –
riguardavano in particolare la fornitura di minerale e la politica commerciale, cioè la possibilità
stessa di sostenere la concorrenza – e troppi i punti negativi inscritti nell’accordo. Il giudizio però
non era definitivo dal momento che Sinigaglia continuava a sperare in un efficace intervento
riequilibratore dell’Alta Autorità 69 .
Una parte importante dell’industria privata sembrava invece voler accentuare i motivi di dissenso
fino a porsi in una posizione di aperto contrasto. Le questioni che avevano provocato questo
atteggiamento erano in particolare quella dei prezzi e quella del rottame. Già nel novembre 1950
68
AMDAE AE1, f.1, “Alcune osservazioni del gruppo di lavoro per gli aspetti economici del Piano Schuman - primo
esame sommario del documento di lavoro” Roma 30/6//1950; AE1 f.1 “Ricapitolazione del documento di lavoro francese
per il pool del carbone e dell’acciaio” di Armando Frumento, Milano 3/7/1950; AE1, f.1 “Progetto francese di trattato Osservazioni preliminari e generali da un punto di vista giuridico, 30/6/1950; AE1, f.1 “Appunto per sua eccellenza il
Ministro” 27/6/1950. AMDAE, AE3 f.2, “Appunti sulla riunione della delegazione italiana alla Conferenza del Piano
Schuman presso il Ministero degli Esteri”, 29/6/1950.
69
ACS SFORZA, sc. 6, f. IV, Sinigaglia a Sforza, 24/3/1951.
145
infatti Frumento agitò la possibilità che gli esperti industriali si dimettessero, provocando una
“apposita e ampia campagna giornalistica”, più caute, ma di analogo segno, erano state le
indicazioni dei piccoli industriali volte a spingere l’associazione di categoria a fare pressioni sul
governo, pressioni che erano state poi, come abbiamo visto, esercitate senza però che avessero
potuto modificare i termini degli accordi raggiunti.
Taccone, esperto della Fiat, distingueva invece fra “l’impostazione di principio” e il testo.
Non si può dire - sosteneva - che tutte le aziende siano contrarie ai principi del Piano
Schuman... Non bisogna infatti dimenticare che alcuni complessi industriali come per esempio la
FIAT hanno una multiforme attività e considerano quindi il Piano Schuman sotto diversi aspetti,
non soltanto sotto il profilo siderurgico.
Se quindi si potevano ottenere delle modifiche, tanto meglio, concludeva Taccone, “ma se si
dovesse scegliere fra il Piano cosi come è stato redatto e la sua non applicazione”, egli non avrebbe
avuto il minimo dubbio a pronunciarsi per la prima ipotesi. Vignuzzi convergeva su questa
posizione e auspicava che il settore non si estraniasse “dall’organizzazione burocratica del pool”.
Enrico Falck insisteva invece per una azione radicale volta a impedire o ritardare la ratifica,
facendo leva su tutti gli argomenti possibili, ivi compresa una campagna giornalistica sui giornali
controllati dalla Confindustria, “Il Sole”. “24 Ore”, “Il Globo” (Decleva, 1988; Petrini 2005, cap. 3.).
All’interno del governo la disposizione era abbastanza ottimista, con qualche differente
sfumatura fra le varie amministrazioni. Pella, riprendendo istanze avanzate dagli industriali privati,
criticava, in termini molto generale, le unioni di settore e rilanciava un modello di integrazione
“orizzontale”. Togni avrebbe voluto che Sforza accompagnasse la firma del trattato con una
dichiarazione preliminare che sottolineasse il grave rischio che si assumeva l’Italia, una
dichiarazione che sarebbe stata un elemento da spendere nel corso di dibattiti sulla ratifica, Togni
insisteva, poi, perché l’Italia fosse rappresentata nell’AA. Per gli uffici del Ministero degli Esteri, le
questioni economico-sociali più importanti erano state risolte favorevolmente: così, per la
protezione siderurgica, per il coke, per la questione del Sulcis, gli investimenti, i minerali di ferro,
non si sarebbe potuto chiedere di più. Sforza era, però, disposto ad accogliere la sostanza delle
dichiarazioni di Togni; accettava cioè di fare una dichiarazione, peraltro abbastanza innocua,
all’atto della firma e pensava che si potesse insistere per un italiano nell’AA nonostante le
preoccupazioni francesi per la sopranazionalità. Molto – secondo il ministro degli Esteri –
probabilmente si sarebbe potuto ottenere anche per la ponderazione riservata al voto italiano in
Consiglio dei Ministri 70 .
Su questa linea si mosse la rappresentanza italiana alla conferenza finale con cui si chiusero i
70
ACS VERBALI 28/VIII E 28/IX- Riunioni del 7 e del 9 aprile 1951 ACS SFORZA, sc. 6, f.iv, Togni a Sforza, Roma
6/4/1951.
146
negoziati di Parigi. In questa circostanza la delegazione italiana operò, di concerto con i
rappresentanti dei Paesi più piccoli, per limitare il peso dei due grandi nel Consiglio dei Ministri. In
seguito a questa azione si ottenne l’allargamento da sette a nove, del numero dei membri dell’AA
(inizialmente i francesi pensavano a cinque soli membri) e si ottenne il riconoscimento di un peso
paritario per i tre Paesi più grandi, Italia, Francia e Germania occidentale all’interno dell’Assemblea
comune, organismo peraltro sprovvisto di reali poteri, a parte quello di “sfiduciare”, a maggioranza
di 2/3 (con il potere di veto quindi dei due grandi che disponevano di 36 deputati su 78), l’AA. Nel
Consiglio dei Ministri, attraverso la ponderazione dei voti, Francia e Germania rimanevano in
posizione predominante.
Al termine della maratona gli italiani constatavano che le proposte iniziali franco-tedesche non
avevano retto alle critiche dei partners minori. Sforza fu pronto a tirarne le conseguenze. Egli
dichiarava che il ruolo italiano era stato determinante nel favorire il compromesso fra Francia e
Germania nello stesso tempo fornendo una garanzia contro una intesa esclusiva. La politica europea
dell’Italia secondo l’accattivante retorica del ministro tendeva
a fare dell’amicizia con la Francia un pilastro permanente per l’unificazione europea, creando
un nuovo mondo nel quale i due paesi avevano tanto da dire a condizione che la Germania sia
collegata per la pace e la libertà con noi. (Sforza 1952, p. 317)
B.3.c. Il problema delle tariffe doganali e l’intervento del Ministero del Tesoro
Nel caso della siderurgia italiana, la discussione sul sistema di garanzie più appropriato
all’interno del Mercato Comune rivelava l’esistenza di interessanti contraddizioni interne al
governo. Nessuno dubitava che una forma di aiuto fosse necessaria; questo era stato un punto
sollevato fin dall’inizio e aveva determinato tutta la strategia negoziale italiana. Nel fissarne tuttavia
le modalità comparvero molte incertezze.
In settembre si scontravano due tesi: da un lato quella francese e belgo-lussemburghese,
favorevole a una Cassa di Perequazione gestita dall’AA e alimentata dai contributi provenienti da
un prelievo sulle produzioni a più basso costo; dall’altro, quella tedesca che delineava un diverso
meccanismo con oneri sugli scambi da paese a paese, tariffe doganali in sostanza. A essere
danneggiata da questo sistema sarebbe stata indubbiamente l’industria meccanica italiana ed è
perciò che, sebbene la proposta fosse allettante in quanto avrebbe regalato l’auspicata salvaguardia
per la siderurgia, la delegazione italiana decise di sostenere, almeno in un primo momento, la tesi
franco-belga.
Si trattava di calcolare i costi di produzione delle imprese siderurgiche, problema quanto mai
147
complesso a cui lavorarono in un primo tempo l’Assider e poi il Ministero dell’Industria.
In questa fase un certo interesse alla perequazione venne manifestandosi in seno all’ASSIDER
ad opera degli industriali privati, tuttavia i calcoli si rivelarono non solo laboriosi, ma ben presto
impossibili, per lo meno in tempo utile per il negoziato, troppo diverse e numerose erano le aziende
di cui si sarebbero dovuti verificare i costi. A questo punto che il Ministero dell’Industria assunse in
proprio l’iniziativa e i suoi uffici operarono un calcolo di massima, non prendendo però a
riferimento i costi di produzione bensì i prezzi; e neppure i prezzi di mercato ma quelli fissati per
via amministrativa nell’ottobre precedente, che non avevano una rispondenza reale nelle condizioni
di mercato. La conclusione raggiunta dagli uffici del ministero quantificava in 106 miliardi per
cinque anni l’onere derivante dall’istituzione di un meccanismo di perequazione per la produzione
siderurgica italiana 71 .
La metà di questa somma sarebbe stata di competenza del Governo Italiano e fu proprio dal
Ministro del Tesoro che venne l’opposizione più recisa alle volonterose indicazioni di Togni.
Secondo Pella era inimmaginabile che il Tesoro potesse porre “a carico del Bilancio un qualsiasi
onere per una eventuale nostra partecipazione all’accordo internazionale per il carbone e
l’acciaio.” 72 Già il Tesoro - continuava Pella - aveva dovuto essere molto severo rispetto a
“esigenze di grande rilievo” - eufemismo per indicare le spese militari - perché non essendoci in
prospettiva nuove entrate, “non può in alcun modo ridurre i programmi di investimento già stabiliti
e che rispondono ad essenziali necessità di ordine economico e sociale”.
Infine anche l’ASSIDER, con un messaggio diretto al Ministro degli Esteri, prese le distanze
dalla sfortunata proposta del Ministro dell’Industria, dichiarando che la soluzione suggerita dai
partner alla Conferenza di sostituire i dazi ai contributi perequativi era accettabile, perché, “se bene
articolata nella misura e nel tempo”, avrebbe potuto servire allo scopo di garantire una difesa
adeguata all’industria siderurgica nazionale 73 .
In questo caso, quindi, il Ministero del Tesoro fu in grado di esercitare un vero e proprio veto su
una iniziativa dell’amministrazione italiana (Quaroni 1967, pp. 803-804). Occorre domandarsi se
questo fosse il risultato di un fatto prevalentemente politico, il peso del Ministro del Tesoro, Pella,
era all’interno dei governi De Gasperi, molto forte, o se fosse risultato soprattutto della prevalenza
amministrativa del ministero del Tesoro su altre amministrazioni in omaggio a una linea di rigore
nei conti pubblici adottata dall’Italia, la cosiddetta linea “Pella-Menichella”. L’evidenza di questo
incidente sembra suggerire più la seconda risposta che non la prima: si trattò in fatti di una
71
Si veda AMDAE, DGAE, IT 1950, b. 1, fasc. Corrispondenza varia, Ministero dell’Industria, Piano Schuman.
Perequazione produzione italiana acciaio, 25/11/1950.
72
AMDAE, AE1 f. 4, Ministero dell’Industria Gabinetto, Prot. n. 4123, 25/11/1950, “Perequazione produzione italiana
acciaio”. AMDAE, AP Francia, b. 30, Pella a Taviani, Roma 29/11/1950.
73
ASUE, f. MAEI, PS, b. 10, Rebua a Sforza, 22/12/1950.
148
questione prevalentemente tecnica che non si sviluppò a livello politico. Il Ministro dell’Industria,
Togni, era, d’altra parte una personalità abbastanza rilevante, ma in questo caso le ragioni della sua
amministrazione contraddicevano la linea scelta dal governo nel suo complesso
B.3.d. Le trattative sui dossiers sociali
La posizione negoziale italiana fu definita nelle sedute del gruppo di lavoro sulla politica salariale
cui parteciparono i funzionari del Ministero dell’Industria Santoro e Panunzio e Balladore Pallieri del
Tesoro, mentre l’esperto del Ministero del Lavoro Volonté venne affiancato, come abbiamo detto,
solo in un secondo momento da Glisenti della CISL
Uno dei caratteri molto particolari di questa discussione era dunque quello di vedere riunite intorno
allo stesso tavolo le rappresentanze sindacali dei Sei paesi in un confronto sui modi di superare le
differenze nelle retribuzioni. Questo nella storia sindacale dell’Europa Occidentale era certamente un
motivo di estremo interesse. Tuttavia c’erano anche delle difficoltà: la prima e la maggiore era che i
rappresentanti dei sindacati di ispirazione comunista erano stati esclusi dalla Conferenza, per esplicito
consenso dei governi sembra e di Monnet che non voleva altri fastidiosi oppositori dei suoi disegni.
Alcuni governi, inoltre, per esempio quello olandese, si mostrarono sempre molto timorosi di
un’eventuale partecipazione dei sindacati comunisti italiani nei lavori della Comunità. Restava
comunque il fatto che per l’Italia fu ammesso ai lavori un sindacato come la CISL, che era all’epoca
assai poco rappresentativo, soprattutto nella categoria dei metalmeccanici che era egemonizzata dalla
CGIL. La CISL si era costituita solo il 30 aprile del 1950 quasi contemporaneamente alla UIL e dopo
che entrambi i gruppi erano convissuti nel sindacato non comunista derivato dalla scissione del 1948.
Segretario generale ne era Giulio Pastore, democristiano, il quale era stato attivo anche sul piano
europeo e aveva partecipato alla fondazione nel 1949 dell’ICFTU, cioè del più importante
raggruppamento europeo dei sindacati non comunisti che ebbe modo anche di recitare un certo ruolo
durante le trattative sul Piano Schuman. All’interno dell’ICFTU tuttavia la CISL si trovava ad essere
l’unico sindacato cattolico e il suo peso non era molto considerevole se paragonato a quello della
DGB tedesca, nonché dei sindacati belgi e neppure di quelli francesi (Force Ouvrière), che pure si
trovavano in una posizione simile, essendo minoritari rispetto alla CGT comunista.
Ancora più importante tuttavia della geografia sindacale era il possibile ruolo dei rappresentanti
sindacali nell’ambito della conferenza. Sembra che sulla maggior parte dei problemi essi stentassero
ad elaborare posizioni comuni e finissero per sostenere le posizioni delle rispettive delegazioni
nazionali. Il rappresentante della CISL si segnalò per esempio per il vigore con cui sostenne le
rivendicazioni sulla libera circolazione dei lavoratori, incontrando l’opposizione dei sindacati dei
149
paesi potenziali ricevitori di manodopera. Il problema della libera circolazione della manodopera fu
sollevato dalla delegazione italiana nel settembre 1950. Le resistenze maggiori vennero espresse dal
Belgio. La delegazione francese con Monnet sostenne il punto di vista italiano. L’unico punto su cui
si accordò senza problemi fu che i sindacati avrebbero insistito per partecipare agli organi della
Comunità: l’AA - cui venne infine designato il belga Paul Finet, ex presidente dell’ICFTU -, la Corte
di Giustizia e il Comitato Consultivo, un organo consultivo rappresentativo cioè dei vari interessi
sociali e economici, che prese forma nei lavori negoziali della seconda parte della Conferenza. (Mechi
2000)
Secondo il parere formulato congiuntamente dai rappresentanti del Ministero del Lavoro e della
CISL la libertà di circolazione della manodopera doveva essere vista come un complemento della
politica sociale della Comunità: solo infatti se fosse stato consentito alle maestranze italiane di
emigrare potevano essere accolti gli inviti alla razionalizzazione e alla parificazione dei trattamenti
salariali su cui insistevano i testi francesi. Taviani non esitò a farne una questione di principio: alla
libertà di movimento dei capitali e a quella di accesso alle materie prime doveva affiancarsi quella
del fattore produttivo lavoro. Non si trattava quindi di un problema accessorio da regolare con un
accordo separato, ma di materia che ineriva alla sostanza stessa del Mercato Comune. Scrivendone
a De Gasperi alla fine di novembre, il capo delegazione italiano definiva la questione della
manodopera come l’unico punto negoziale, insieme a quello dell’Africa del Nord, che si prestava
alla “facile comprensione” e al sostegno dell’opinione pubblica. Era importante pertanto ottenere in
proposito un qualche riconoscimento (Taviani 1967, p. 172)74 . È da notare come anche in questo
caso Taviani, svolgendo correttamente il ruolo che gli era stato affidato, entrasse nel merito di una
questione tecnica con una finalità ultima di tipo politico: ottenere un più vasto consenso interno al
trattato.
B.3.e. L’amministrazione e la questione del carbone e del coke
Per quanto riguarda il carbone e i suoi sottoprodotti, primo fra tutti il coke, la posizione
dell’Italia di fronte a un processo di liberalizzazione come quello previsto dal Piano Schuman era
imbarazzante, in quanto il settore era gestito dalla Stato con forti finalità protezionistiche.
Il monopolio del commercio di importazione del carbone era stato detenuto dallo Stato a partire
dal 1938. Dal 1947, tuttavia, questo si era esercitato attraverso l’EAC (Ente Approvvigionamento
Carbone), un consorzio misto, di cui metà delle partecipazioni era detenuta da un gruppo di
74
ARCHIVIO TAVIANI, Taviani a De Gasperi, Parigi 24/11/1950; AMDAE AE5 f. 1, “Osservazioni sul documento del
27 settembre 1950 - dr Perazzo e dr Glisenti” 2/10/1950.
150
commercianti privati e da alcune importanti imprese industriali, fra cui l’Italcementi e la FIAT.
L’EAC, che fu parte attiva soprattutto nella gestione del carbone americano, rappresentava una
soluzione di compromesso, giacché i privati lasciavano capire che, non appena normalizzatosi il
commercio internazionale, essi avrebbero cercato di liberalizzare il commercio in funzione di una
possibile riduzione dei prezzi. In questo senso furono soccorsi dai provvedimenti di liberalizzazione
in quanto questi comportarono lo smantellamento, sia pure graduale, della posizione monopolistica
dell’EAC. Gli acquisti dall’estero da parte di privati che fino a tutto l’agosto del 1949 si aggiravano
intorno a circa il 14% del totale, salirono in settembre al 18,6%, in ottobre al 24% e in dicembre al
65%.
Poiché il carbone era soggetto alla liberalizzazione degli scambi, il Ministero del Commercio
Estero cessava di determinarne le licenze per quanto riguardava le spedizioni dei paesi OECE.
Tuttavia questo, di fatto, non eliminava gli ostacoli burocratici: infatti rimanevano intatte le
competenze del Comitato Carboni al quale spettava ora, sia di rilasciare i buoni di sdoganamento,
che stabilire quanto carbone e di che qualità fosse permesso importare ai privati e quanto all’EAC.
Il prezzo inoltre continuava ad essere fissato dal CIP (Comitato interministeriale prezzi) sulla base
di un prezzo massimo cif porto d’importazione o per vagone franco frontiera cui erano
successivamente applicati coefficienti prestabiliti per i prezzi franco-vagone nelle differenti località
e province 75 .
L’industria italiana del coke era abbastanza piccola, occupando circa 4.000 addetti, cui se ne
potevano aggiungere altri 2.000 delle lavorazioni secondarie. Tuttavia, attraverso la rappresentanza
del Comitato Produttori Coke, esso assunse un atteggiamento estremamente aggressivo in difesa
della rendita di posizione goduta fin dalla nascita. Ancora nel 1949, all’atto della liberalizzazione
nel campo degli acquisti di carbone, il Comitato Carboni aveva pensato bene addirittura di vietare
l’importazione di coke estero. Accanto alla manovra dei contingenti c’era poi quella dei dazi per cui
l’Italia era l’unico paese dei Sei a gravare le importazioni di coke non metallurgico con una tariffa
del 12%.
Secondo i produttori di coke queste misure di protezione dimostravano l’impossibilità per le
produzioni italiane di mantenersi competitive, per cui esse avrebbero avuto diritto non tanto a un
periodo di adattamento quanto a una integrazione-compensazione permanente.
75
Con i D.L.C.P.S. 12/11/47 n. 1590, DL 9/4/1948, n. 462 fu disposta l’esenzione dal diritto di licenza di importazione
per il carbon coke e il fossile, inizialmente per un anno; l’esenzione fu poi confermata dalla legge. 21/1/1949, n.9
(Torricelli 1974, p. 782). Sulla liberalizzazione del carbone vedi CAMERA DISCUSSIONI 1950, v.XII, pp. 18500 e ss.,
intervento di Togni nella discussione sul bilancio del Ministero dell’Industria il 24 maggio 1950; più in generale sul
mercato del carbone, vedi Regis 1949, pp. 153-165. Sul divieto di importazione di coke notizie in SENATO
DISCUSSIONI, 1950, volume xiv, pp. 17957 e ss.; vedi inoltre “Procedure per l’importazione di carbone” ERP, a. II, n.
12, 16-31/12/1949; AJMONNET, AMG 7/6/20, Groupe de travail: informations “Réponse au questionnaire concernant les
matières traitées dans les articles 20 à 25 et 37 à 30: Italie”.
151
Di fronte al profilarsi di una soluzione che accoglieva solo in parte le loro richieste, le cokerie
italiane protestarono, dando vita fra l’altro a una forte campagna di stampa contro il Piano
Schuman. Riuscirono anche a mobilitare a sostegno delle proprie rivendicazioni un ampio spettro di
forze politiche, se è vero che nel corso del dibattito senatoriale sul bilancio del Ministero
dell’Industria dal 6 al 13 luglio 1951, sia l’industriale e vecchio magnate del settore Ferdinando
Ricci, senatore democristiano, che il senatore socialista nenniano Michele Giua ribadirono il favore
per la protezione alle cokerie.
Tuttavia non fu sufficiente. Taviani era infatti costretto a riferire a Roma che ciò che si era
ottenuto era il massimo a meno che non si volesse sollevare un caso politico di prima grandezza;
questo però né il Ministero degli Esteri e neppure quello dell’Industria erano disposti a fare. In
ultima analisi, infatti, negli ambienti governativi si riconosceva che la protezione iniziale metteva
fuori pericolo le cokerie, mentre la liberalizzazione costituiva un argine ai prezzi troppo facili, e
concorreva quindi a un indubbio beneficio per i consumatori italiani76 .
In relazione alla questione del coke è possibile ricostruire, grazie ai documenti confindustriali, la
genesi e i modi di funzionamento delle relazioni tra delegazione a Parigi e interessi economici. Gli
esperti del settore del carbone che avrebbero dovuto collaborare con la delegazione a Parigi erano,
come abbiamo già visto, Luigi Nerbini, direttore generale dell’Assogas, Arrigo Cajumi
amministratore delegato della società Cokitalia e Carlo Tomatis, presidente del Comitato produttori
coke. Già al momento della loro nomina era nata una querelle tra il Ministero dell’Industria, che
intendeva limitare al minimo indispensabile il numero degli esperti, e la Confindustria che puntava
ad inserire una congruo numero di esperti, anche per venire incontro alle richieste delle
Associazioni di settore interessate alla questione. Dopo un lungo tira e molla e un fitto intreccio
epistolare tra ministero, Confindustria e Associazioni, finalmente il 31 ottobre si completò il
collegio degli esperti 77 . Pur non avendo raggiunto tutti i loro obiettivi, gli industriali avevano
ottenuto gran parte di quel che avevano richiesto, in pratica imponendo la presenza di tre esperti di
loro nomina rispetto all’uno solo offerto all’inizio dal ministero. Ma come fu sfruttata questa
rappresentanza degli interessi industriali in sede negoziale?
Poche settimane prima della firma del trattato, nel mese di febbraio, il ministro Togni scrisse a
Costa, su sollecitazione di Taviani, per lamentarsi della scarsa collaborazione prestata dagli esperti
designati dalla Confindustria ai lavori della delegazione. Sembra che Taviani avesse segnalato al
ministro che gli esperti in materia di coke si rifiutavano di partecipare alle trattative, nonostante le
76
AMDAE AE2, f. 5, Documento Nerbini, Cajumi ricevuto dalla delegazione italiana (Sandulli) il 27/1/1951. vedi inoltre
l’opuscolo di propaganda, Le cokerie italiane e il Piano Schuman, a cura del Comitato Produttori Coke. AMDAE, Parigi,
Teleg.Partenza, t. 78, 7/2/1951 TRATTATO CECA, Parag. 27 Convenzione disposizioni Transitorie coke.
77
Cfr. la documentazione in ASCGII, f CECA, parte generale, b. 50.1/2, fasc. Trattato istitutivo CECA.
152
sollecitazioni pervenutegli sia da parte della delegazione, sia da parte del ministero. Dalle critiche di
Taviani scaturì, anche in questo caso, una fitta corrispondenza triangolare, con i tre esperti che
rendevano conto del loro operato al presidente Costa che a sua volta trasmetteva le loro
osservazioni al ministero 78 . Ciò che emerge di interessante da questo scambio epistolare è la labilità
dei collegamenti tra le varie istanze (delegazione a Parigi, esperti, Associazioni di categoria) che
invece avrebbero dovuto interagire per ottenere i migliori risultati e presentare in modo efficace il
loro punto di vista al tavolo dei negoziati. Da una parte, infatti, se, come abbiamo visto, la
delegazione si lamentava dell’“assenteismo” degli esperti, questi ultimi deploravano il fatto di non
aver mai ricevuto in via ufficiale alcuna richiesta di collaborazione o di un parere, né una
convocazione a Parigi, né documenti sulle trattative e neppure un piano dei lavori o l’ordine del
giorno delle sedute 79 . A questo proposito Tomatis riferiva un episodio emblematico dei difficili
rapporti tra tecnici e delegazione. Il 26 gennaio egli si era recato a Parigi per partecipare ai lavori
del Comitato carboni dell’OECE. Alla stazione, inaspettatamente, era venuto a prelevarlo
Savorgnan, membro della delegazione guidata da Taviani, che aveva “vivamente” insistito, scriveva
Tomatis, “perché immediatamente andassi con lui ad una riunione conclusiva” sul pool. Nonostante
le proteste dell’esperto, che non aveva con sé nessun documento relativo al piano Schuman, né,
come affermava lui stesso, era “preparato ad una discussione che egli (Savorgnan) mi segnalava
decisiva su tale argomento”, Savorgnan continuò ad insistere finché l’arrivo di Sandulli, l’esperto
per il carbone del ministero dell’Industria, non tolse Tomatis dall’imbarazzante situazione.
Concludeva sconsolatamente Tomatis: “È stata questa l’unica volta in cui venni in qualche modo
interpellato dalla delegazione […].” 80
In sostanza la collaborazione tra la delegazione e gli esperti industriali, almeno nel caso del coke,
si era risolta in “un susseguirsi di malintesi, di equivoci, di mancate segnalazioni, che praticamente
resero impossibile un regolare e completo contributo degli esperti in così varie riprese nominati.” 81
Con tutta probabilità questo deludente risultato fu il frutto di una scelta consapevole dei responsabili
della delegazione che, consci delle difficoltà che un eccessivo protagonismo degli interessi privati
avrebbe potuto generare, in una questione tutto sommato secondaria, optarono per tenere il più
possibile al margine delle trattative gli esperti dell’industria privata.
78
Anche questo carteggio è in ASCGII, f. CECA, parte generale, b. 50.1/2, fasc. Trattato istitutivo CECA.
Si veda ad esempio Cajumi a Costa, 26/2/1951, in ASCGII, f. CECA, parte generale, b. 50.1/2, fasc. Trattato
istitutivo CECA..
80.
Tomatis a Costa, 20/3/1951, in ASCGII, f. CECA, parte generale, b. 50.1/2, fasc. Trattato istitutivo CECA.
81
Ivi.
79
153
B.3.f. La questione dei minerali di ferro e il ruolo della Finsider
La posizione italiana sulla questione dei minerali di ferro venne elaborata dal Ministero
dell’Industria in consultazione con la FINSIDER, e in particolare con il suo presidente Sinigaglia che
ebbe un ruolo centrale in tutta la vicenda, in uno stretto dialogo con i vertici della delegazione italiana.
In effetti su questa questione sembra allora doversi giocare il futuro stesso del piano Sinigaglia, e cioè
dell’ammodernamento produttivo dell’industria di base. Infatti i minerali di ferro provenienti
dall’Algeria francese venivano considerati importantissimi per caricare gli altiforni dei grandi
stabilimenti Finsider, come Bagnoli e Cornigliano, sulla costa tirrenica.
La Francia non sembrava, però, stare al gioco, e in primo luogo rifiutò, come si è visto di includere
l’Algeria nel pool carbo-siderurgico. 82 .
A invocare una condotta negoziale più rigida era il Ministero dell’Industria, che sottolineava come,
essendo il problema dell’approvvigionamento di materie prime in quantità e a prezzi di assoluta
normalità alla base della partecipazione italiana al Piano Schuman, si dovesse rimanere intransigenti,
preparati finanche ad abbandonare la trattativa. Dal Ministero degli Esteri usciva una indicazione più
possibilista: Sforza sollecitava sì all’intransigenza sia Taviani che Quaroni, incaricato di una azione
collaterale sul governo francese, ma indicava come il vero punto discriminante su cui attestarsi
dovesse essere un impegno francese a non costituire una siderurgia africana fuori dal pool. Sui
minerali si sarebbe potuto invece far balenare l’ipotesi di un accordo su scala bilaterale.
Il governo italiano sviluppava parallelamente un’azione diplomatica per assicurarsi l’appoggio di
altri governi, a partire dagli Stati Uniti. Ricevettero un appoggio tedesco, del tutto platonico e un
interessamento americano, che però non fecero niente di concreto 83 .
In Francia Monnet fu del tutto contrario alle contropartite per gli italiani. Il 6 Novembre il nuovo
progetto di trattato presentato dai francesi ufficializzava per la prima volta l’esclusione dei territori
coloniali. A questo punto la pressione italiana salì di tono. Ci fu una nota ufficiale presentata
dall’ambasciata di Parigi al governo francese in cui, dopo aver affermato che il Parlamento non
avrebbe mai approvato un piano discriminatorio verso gli interessi italiani, si prospettava l’eventualità
di una ripresa della propria libertà d’azione da parte della delegazione italiana, sotto forma di una
partecipazione passiva, in veste di osservatori, ai lavori della conferenza 84 .
Fu questo il punto di massima distanza delle posizioni: è interessante seguirlo dalle corrispondenze
dei due principali protagonisti della vertenza da parte italiana: Quaroni e Sinigaglia. Abbiamo infatti
82
ARCHIVIO TAVIANI, “Appunti per l’onorevole Taviani sulla questione del Nord-Africa francese” Oscar Sinigaglia,
Parigi, 9/9/1950.
83
AMDAE, Parigi, b. 478, f. 2, t. 399, Roma 2/9/1950 e t. 494, Roma 5/9/1950. Sulla “via americana” vedi AMDAE,
Parigi, b. 478 f. 2, t. 411, Roma 8/9/1950; unico effetto concreto di questa manovra sembra essere stato quello di irritare
maggiormente i francesi.
84
AMDAE, Parigi, b. 478, f. 3, t. 9837-C, Roma 13/11/1950.
154
la corrispondenza di Quaroni con Sforza e quella di Sinigaglia con Taviani. Il punto di vista difeso da
Sinigaglia fu totalmente accolto dai rappresentanti italiani ai massimi livelli, fino a minacciare il ritiro
italiano dalle trattative nel caso di una mancata soddisfazione delle richieste del governo di Roma.
Quaroni, individuava nel contrasto franco-americano in tema di riarmo tedesco la migliore
occasione per ottenere contropartite sul problema dei minerali. Egli indicava le linee di un possibile
compromesso: un accordo con le miniere che fissasse i quantitativi - e a questo proposito Quaroni
avvertiva i siderurgici che bisognava avere ben chiari i quantitativi che si volevano - e un accordo con
il governo per le licenze relative. Sinigaglia appariva più preoccupato e pessimista, dubitava, per
esempio, che ci si potesse mettere d’accordo con la società algerina dell’Ouenza in quanto un accordo
a lungo termine sarebbe stato del tutto contrario alla convenienza commerciale della compagnia, era
completamente negativo sull’atteggiamento francese imputandone le maggiori responsabilità a
Monnet che egli avrebbe visto volentieri rimosso da ogni posizione di influenza, continuava, d’altra
parte, a confidare nell’aiuto americano che gli sembrava conseguire logicamente dai finanziamenti
accordati al progetto di Cornigliano. Si esprimeva poi per usare la tecnica della sedia vuota: senza
l’aiuto dell’Italia nel pool la Francia avrebbe rischiato di trovarsi sola di fronte alla Germania e al
Belux. Secondo Sinigaglia, infatti, il Belgio e il Lussemburgo, temendo essenzialmente la
concorrenza tedesca sui mercati terzi, sarebbero stati, in ultima analisi, propensi a trovare un
compromesso con i tedeschi, la Francia quindi si sarebbe trovata nella necessità di comprare a ogni
costo l’appoggio italiano. Indicava infine i termini di un possibile compromesso, secondo cui si
sarebbe dovuto ottenere dai francesi un impegno a non far sorgere impianti nel Nord-Africa senza
autorizzazione dell’AA, oltre a forniture stabilite di minerale alla siderurgia italiana. L’accordo
avrebbe dovuto essere siglato per 50 anni.
La trattativa entrò nel vivo nel mese di dicembre, quando si svilupparono contatti paralleli, a livello
diplomatico - Quaroni con Clappier e Schuman - e a livello industriale - Sinigaglia con rappresentanti
dell’Ouenza, Langeron e Laffont, e dei ministeri tecnici francesi, Charpentier. La missione di Grazzi a
Parigi agli inizi di dicembre sembrò in effetti abbozzare una soluzione di compromesso: il governo
italiano avrebbe presentato al governo francese una indicazione di quantità, quinquennio per
quinquennio. Le basi di questo accordo erano nel complesso favorevoli agli italiani e Grazzi aveva
riscontrato una certa disposizione a cooperare da parte del Quai d’Orsay. Ben presto tuttavia da parte
francese si cominciava a fare marcia indietro: nelle conversazioni che si svilupparono intorno al 20
dicembre fra Santoro, Charpentier, Sinigaglia e i dirigenti minerari, furono appunto questi ultimi che
rifiutarono ogni eventualità di impegni a lunga scadenza con la FINSIDER.
Quaroni, riprendendo l’argomento con Schuman, era costretto perciò a riproporre i termini
dell’intesa raggiunta con Grazzi, vi aggiungeva, su suggerimento di Grazzi, l’idea di uno scambio di
155
partecipazioni: italiana nelle miniere dell’Ouenza e francese nelle miniere siciliane di zolfo. Schuman
parve interessato. Si trattava del resto di una questione che era sul tappeto da parecchio tempo,
sollevata per esempio nel periodo già richiamato delle discussioni fra italiani, tedeschi e francesi
durante la guerra. Più recentemente si era tornato a parlare di parecchi miliardi di franchi da investire
nell’Ouenza.
Bisogna avere il coraggio di tirarli fuori e subito - scriveva a Roma Quaroni - ... per avere i
minerali dell’Algeria, fra l’altro noi abbiamo fatto e perduto una guerra. Se ci riusciamo per altre
vie, costi quel che costi è una economia. 85
Di fronte alle difficoltà parigine, Roma scelse di riprendere l’iniziativa diplomatica in termini
formali con una nota verbale all’Ambasciata di Francia in cui si riassumevano i termini della
questione e si indicava una possibile soluzione su base bilaterale Il tono complessivo della nota era
abbastanza ultimativo e si muoveva lungo l’impostazione scelta già, come abbiamo visto, da Taviani e
da Sforza: l’esclusione della Algeria era una mossa unilaterale della Francia e non aveva una valida
giustificazione giuridica. L’Italia era disposta sì a sacrifici per l’Unione Europea, ma solo in
condizioni di reciprocità, spettava ora alla Francia venire incontro ai legittimi interessi italiani86
L’esplorazione della via delle partecipazioni incrociate non sembra essere stata un elemento
importante per il raggiungimento di un accordo. I meno interessati all’affare apparvero i
rappresentanti dell’Ouenza. La FINSIDER si dichiarava invece disposta a assumere una
partecipazione intorno ai due miliardi di franchi (circa tre miliardi e mezzo di lire), mentre per i
viticoltori francesi, il Ministero dell’Industria, offriva di rilasciare una concessione di ricerca nella
zona zolfifera siciliana e a questo proposito la Montecatini, contattata dal Ministero degli Esteri, si
dichiarava disposta a studiare la cosa insieme all’Ouenza. Dalla società mineraria francese giunse
però una risposta negativa e Langeron dichiarò che tutto ciò che era disposto a contemplare era che gli
italiani unilateralmente estendessero un prestito obbligazionario! 87 La ricerca di un accordo avvenne
piuttosto lungo le linee indicate da Grazzi a Venturini: quantità, garanzie di licenze di esportazione,
prezzi e impegno francese a non erigere una siderurgia nord-africana
Era, comunque, Quaroni ad aver visto giusto: la Francia si apprestava a concessioni significative
unicamente per ragioni politiche legate al quadro internazionale e in particolare al dissenso
franco-americano. Dopo la Conferenza di Santa Margherita, la lunga trattativa fu risolta con uno
scambio di note. Le forniture, per cui il governo francese si impegnava a rilasciare licenze di
esportazione, ammontarono a 480.000 tonn. per il primo anno, 575.000 per il secondo fino a un
85
AMDAE, Parigi, b. 478, f. 3, Quaroni a Sforza, prot. n. 912-4496, Parigi 26/12/1950.
AMDAE, Parigi, b. 478 f. 3, tel. 17926-117, DGAE. uff.II, Roma 30/12/1950 con allegata “Nota verbale all’Ambasciata
di Francia”.
87
AMDAE, AE1 f4, teles. 42-00270, DGAE, uff. 2, Roma 5/1/1951; AE2, f. 5, t. 37, da Esteri Roma, 17/1/1951.
86
156
massimo di 830.000 per il quinto anno. Le trattative si sarebbero svolte fra le parti interessate, ma i
contatti di Parigi con i proprietari delle miniere fornivano una garanzia supplementare, che si
sarebbero concluse positivamente. I francesi inserirono poi una clausola secondo cui, qualora le cifre
pattuite risultassero superiori alle effettive richieste italiane, questo avrebbe fatto scattare una
diminuzione delle forniture degli anni successivi, continuando quindi a manifestare un certo
scetticismo sulla fondatezza degli argomenti della Finsider. A proposito di prezzi si parlava di prezzi
normali, ragionevoli, e comparabili a quelli fatti ad altri acquirenti, senza ulteriori specificazioni.
Quanto infine al timore espresso dagli italiani, ma condiviso da olandesi e tedeschi, e cioè che
sorgessero stabilimenti siderurgici in Africa del Nord, i francesi risposero che erano stati sì formulati
alcuni progetti, ma unicamente in relazione a situazioni di emergenza e comunque che avrebbero
consultato in proposito il governo italiano 88 .
Da parte italiana l’accordo fu negoziato nei dettagli da Grazzi e da Ferrari Aggradi, Segretario
Generale del CIR.. Sembra che a convincere i francesi a venire incontro alle richieste italiane di
minerale fosse anche l’aumento del contingente di zolfo destinato alla Francia: da 26.000 tonn. nel
1950 si decise di portarlo a 60.000 nel 1951 89 .
Occorre dire, a conclusione di questo episodio, che negli anni successivi l’importanza dei minerali
algerini per la siderurgia italiana si sarebbe dimostrata molto minore di quanto non si pensasse nel
1950 e 1961. Infatti nel corso del decennio successivo le partecipazioni assunte in vari giacimenti del
Terzo Mondo e lo sviluppo di un’ingente flotta per il trasporto del minerale, avrebbero permesso alla
Finsider di approvvigionarsi ma molte altre fonti. (Ferraro 1961)
Occorre anche aggiungere che aumentarono moltissimo i quantitativi di minerale di ferro estratti
dal sottosuolo nazionale, ad opera di enti pubblici come l’AMMI e la Ferromin, una sussidiaria della
Finsider. In effetti si trattò di uno sforzo produttivo senza precedenti, che portò, nel giro di una decina
d’anni, ad esaurimento le riserve relativamente esigue del sottosuolo italiano, a cominciare da quelle
dell’isola d’Elba, fino a quelle sarde e delle Prealpi bresciane e bergamasche. Nel 1954 la quantità di
ferro estratta, in prevalenza ad opera della Ferromin, era già salita a 1,6 milioni di tonnellate per
toccare nel 1957 i 2,6 milioni. (Massi 1959, pp. 58-9)
88
Lo confermava l’acceso dibattito in Francia prima della Conferenza di Santa Margherita fra le categorie appoggiate dai
Ministeri tecnici e il Ministero degli Esteri. (AMDAE, Parigi, Serie telegrammi arrivo, t. 97, 8/2/1951, “Accordi
italo-francesi”.)
89
“La Conferenza di Santa Margherita” ESTERI a. II, n. 3, febbraio 1951; ai quantitativi stabiliti venne prevista
un’integrazione di 400.000 tonn. di minerale della Guinea Francese, vedi sull’esito della trattativa anche le seguenti fonti:
AMDAE, AE2, f. 5, t. 92370-c, DGAE uff. 2 a Ministero dell’Industria, “Forniture Minerali Nord-Africani per il Piano
Schuman” (Taviani 1967, p. 162; Taviani 1954, pp. 39 e 40; ASSIDER-Relazione 1951 pp. 36-55). Il tema di una possibile
siderurgia nordafricana continuò a essere discusso lungo tutti gli anni Cinquanta dando luogo ancora a preoccupazioni
italiane.
157
B.4. La ratifica del Trattato e l’avvio della CECA
La ratifica del Trattato CECA, che esaminiamo in questa sessione, fu l’occasione di un aspro
scontro fra le posizioni contrarie del mondo della siderurgia privata, che fu appoggiata da una parte
importante dell’establishment imprenditoriale e dalla Confindustria, e le forze politiche della
maggioranza. Abbiamo visto in precedenza, tuttavia, che non tutta la siderurgia era allineata su queste
posizioni: la Finsider era, in linea di massima, favorevole al Trattato. In ogni caso le manovre e le
pressioni della Confindustria a favore di una linea di rinegoziazione del Trattato non ebbero seguito.
Molto interessante fu la discussione che si svolse nel Consiglio dei Ministri sulla scelta del
rappresentante italiano all’Alta Autorità della CECA. Vi riemersero alcune delle differenze interne
all’amministrazione, e in particolare fra Ministero degli Esteri e Ministero dell’Industria, che abbiamo
visto già presenti durante la trattativa. Tuttavia a imporsi fu una terza linea, quella federalista di De
Gasperi, che abbiamo visto era stata molto influente anche in precedenza. Il candidato, Enzo
Giacchero, prescelto era un uomo politico democristiano, molto attivo nel movimento federalista.
Nell’ultima parte di questa sezione viene esaminata la scelta dei parlamentari italiani per
l’Assemblea Comune della CECA. Vi prevalevano i federalisti, ma vi erano rappresentati anche
esponenti politici che avevano svolto un ruolo durante le trattative, come Giuseppe Togni, o
ricoprivano incarichi presso i Ministeri competenti, quali il Ministero degli Esteri e quello del
Commercio Estero.
B.4.a. Il dibattito parlamentare di ratifica del Trattato: pressioni e composizioni
di interessi
Dopo la firma del trattato, avvenuta il 18 aprile 1951, si aprì nei Paesi aderenti il processo di
ratifica. In Italia la discussione in Parlamento iniziò diversi mesi dopo la firma del trattato: in
Senato l’11 marzo 1952, per poi concludersi il15, alla Camera il 12 e il 16 giugno, quando il trattato
fu ratificato con 265 voti a favore e 98 contrari (legge 25 giugno 1952, n. 766. lo strumento di
ratifica fu depositato il 22 luglio.)
A Palazzo Madama il dibattito fu più articolato che alla Camera. Il relatore di minoranza, il
comunista Ottavio Pastore, sostenne che il trattato avrebbe dovuto essere approvato con procedura
158
costituzionale; De Gasperi si oppose appellandosi all’art. 11 della Costituzione. Intervennero a
favore: Galletto (DC), Ziino (DC), Santero (DC), Zotta (DC), Bergmann (PRI), Falck (DC),
Giardina (DC), Guglielmone (DC), Merzagora (Gruppo misto)e Sanna Randaccio (PLI). Contro:
Casadei (PSI), Federico Ricci (PRI), Roveda (PCI), Giua (PSI), Montagnani (PCI), Molinelli
(PCI), Castagno (PSI), Lanzetta (PSI), Li Causi (PCI), Jannacone (PLI/Gruppo misto), Domenico
Rizzo (PSI)e Lussu (PSI). Conclusero il dibattito i due relatori (Pastore e Stefano Jacini (DC)),
seguiti da Taviani e De Gasperi.
Alla Camera il dibattito risentì di un contingentamento dei tempi 90 e soprattutto dell’inasprirsi
della contrapposizione tra maggioranza e opposizione sui temi internazionali. Oltre ai relatori,
intervennero solo Martuscelli (PCI) per presentare una mozione pregiudiziale simile a quella
presentata da Pastore al Senato, che fu respinta per appello nominale. Intervennero a favore Bima
(DC), Corbino (PLI), Russo Perez (Gruppo misto), Sabatini (DC). Contro: Pessi (PCI), Lombardi
(PSI) e Di Vittorio (PCI). Lo stesso Di Vittorio presentò il 1° luglio un’interpellanza sullo “stato di
inferiorità dell’Italia in seno alla Ceca”. (Bonini 2004, pp. 185-186)
In genere gli argomenti dei contrari facevano leva su una presunta prevalenza in seno alla nuova
comunità degli interessi dei gruppi monopolistici francesi, tedeschi e, indirettamente, americani e
del sacrificio che questo stato di cose comportava per la siderurgia italiana. Da parte dei favorevoli
si ricordavano, oltre alle implicazioni politiche del trattato, i vantaggi che ne sarebbero derivati per
l’industria meccanica della penisola e per l’occupazione in questo settore che era il più importante
dell’industria italiana. Ad esempio Cesare Merzagora disse in aula:
La nostra produzione di carbone e di prodotti siderurgici rappresenta pochissima cosa […].
Ma lasciatemi dire che non è concepibile avere un’industria meccanica sana, in pieno e continuo
sviluppo, come noi abbiamo bisogno di avere per la nostra violenza demografica, se non
abbiamo anche una siderurgia adeguata ai prezzi internazionali […] Abbiamo bisogno oggi
dell’industria meccanica, perché essa occupa 650.000 lavoratori, e può sempre espandersi
maggiormente […]. Finora quel che ci è mancato è la materia prima. Il pool l’offre a prezzo
internazionale 91 .
In questa fase in Italia furono protagonisti gli industriali privati che tentarono in extremis di
imporre alcune modifiche ad un disegno istituzionale di cui temevano soprattutto il l’impostazione
ritenuta eccessivamente dirigistica e il prevalere degli interessi dei Paesi più grandi. Nonostante le
numerose critiche e i pesanti rilievi mossi dal padronato alla nuova Comunità, sia dal punto di vista
dell’ispirazione generale, sia sotto l’aspetto delle questioni economiche particolari, la Confindustria
non prese mai ufficialmente una posizione contraria al progetto, né prima della firma del trattato, né
90
In effetti alla Camera la discussione era stata concentrata praticamente in soli due giorni: vi fu una doppia seduta il 12
giugno pomeriggio e notte e un’altra seduta il 16. (Cfr. Atti parlamentari, I Legislatura. Camera dei deputati,
discussioni. Seduta del 12/6/1952, pp. 38743-38829 e Seduta del 16/6/1952, pp. 38831-38885.)
91
Atti parlamentari, I Legislatura. Senato, discussioni. Seduta del 14/3/1952, p. 31707.
159
dopo, durante i 14 mesi che trascorsero prima della ratifica da parte del Parlamento italiano. Ciò
non significa che tale possibilità non fosse stata considerata. Certamente tentazioni del genere
esistevano, ma furono accantonate per ragioni di opportunità politica e perché i vertici confederali si
rendevano conto che l’Italia non avrebbe potuto rimanere fuori dalla nuova Comunità se questa
avesse visto la luce.
Il 12 luglio 1951, in occasione dell’inizio del dibattito sulla ratifica del trattato di Parigi nel
Parlamento tedesco, la Confindustria rese noto il suo orientamento riguardo agli indirizzi che il
dibattito avrebbe dovuto seguire in Italia. In un comunicato stampa si rilevava che nel corso delle
trattative da parte italiana era prevalsa una visione di tipo politico dei vantaggi del trattato, tanto da
porre in ombra “quegli elementi di carattere tecnico-economico che hanno, invece, preoccupato, e
largamente preoccupato, alcune delle potenze firmatarie del piano stesso”, cosicché si era arrivati a
una sistemazione nella quale gli interessi economici dell’Italia si trovavano sacrificati rispetto a
quelli dei Paesi esportatori 92 . Giunto il momento delle discussioni parlamentari sulla ratifica, era
necessario, secondo la Confindustria, che anche in Italia si prestasse maggiore attenzione al lato
tecnico ed economico, “senza preoccupazioni di ordine politico o senza interferenze di carattere
extra-economico”, in considerazione dell’importanza della nuova Comunità e, soprattutto, del fatto
che sul modello della CECA si stava procedendo ad avanzare altre ipotesi di integrazione settoriale
(pool verde, pool dei trasporti) 93 .
Un momento importante per la definizione della strategia confindustriale nei riguardi della
ratifica, fu rappresentato dalla riunione del Comitato di presidenza del 17 luglio 1951, tre mesi dopo
la firma del trattato di Parigi. In quella sede si confrontarono i sostenitori della una linea di aperta
opposizione alla nascente Comunità e coloro che propendevano per un atteggiamento più
conciliante 94 . Fautore della linea dura fu una figura di primo piano del mondo industriale privato,
Vittorio De Biasi, direttore generale dell’Edison. De Biasi esordì sulle linee già note di opposizione
ai tratti dirigistici del pool, affermando di aver tratto l’impressione dalla lettura delle disposizioni
del trattato, che la nascita della CECA avrebbe significato la fine della libera iniziativa nel settore
carbo-siderurgico. Secondo il direttore generale dell’Edison, un’iniziativa come quella avviata da
Schuman poteva avere senso solo se estesa a tutti i settori produttivi e fondata sul principio
dell’eguaglianza di tutti gli Stati di fronte “ai principali problemi economici quali quelli dello
scambio, non solo dei capitali, ma anche della manodopera.” Solo in questo modo si sarebbero
poste le basi per la soluzione dei problemi che affliggevano l’economia italiana. Riguardo
all’atteggiamento che la Confederazione avrebbe dovuto assumere, De Biasi sosteneva che sarebbe
92
. Appunto informativo n. 466, 12/7/1951, in ASCGII, f. CECA, parte generale, b. 50.1/1, fasc. PS.
93 Ivi.
94
ASCGII, f. Comitato consultivo di presidenza, b. 1.4/12, Verbale della riunione del 17/7/1951.
160
stato “opportuno, o meglio ancora indispensabile, smentire i rappresentanti dell’Italia” che fin
dall’inizio, a suo dire, avevano compromesso la situazione. A suo parere il Comitato di presidenza
avrebbe dovuto costituire “il centro di diffusione delle ostilità al piano Schuman”.
Questa impostazione fu immediatamente contrastata dal vicepresidente Quintieri che, avendo
mantenuto i contatti con Taviani per conto della Confederazione, si assunse tutte le responsabilità
per la conduzione da parte industriale delle trattative sulle questioni generali e politiche e difese
l’operato della Confindustria, che, a suo dire, non aveva mancato “di sollevare, per quanto
possibile, le dovute eccezioni.” Quintieri non negava che molti aspetti del piano fossero
inaccettabili per la siderurgia privata, 95 ma riteneva che al momento gli industriali privati non
avrebbero avuto la forza per opporsi al trattato. Allo stato dei fatti occorreva limitarsi a mantenere i
contatti con le altre confederazioni europee e, sul piano interno, seguire gli avvenimenti, “per
intervenire al momento opportuno nel senso più favorevole agli interessi del Paese.” In sostanza,
secondo Quintieri, occorreva abbandonare ogni velleità di scontro aperto e impostare l’azione
propagandistica confederale sul piano della tutela dell’interesse nazionale e non su quello del
confronto tra liberismo e dirigismo. Su questa linea di wait and see e di appello all’interesse
nazionale, Quintieri trovò due autorevoli alleati in Falck e Costa. Falck riteneva conveniente cercare
di rinviare ogni decisione in sede parlamentare, in funzione degli sviluppi del dibattito francese
sulla ratifica, poiché in Francia il Parlamento avrebbe potuto, a suo dire, mettere in discussione la
ratifica ed emendare il trattato su vari punti importanti. Perciò sarebbe stato opportuno “seguire il
gioco delle opposizioni e delle riserve”in seno al Parlamento francese ed orientarsi di conseguenza.
Il presidente confederale, per parte sua, si dichiarò favorevole ad una linea attendista, facendo
“tutto il possibile per non pronunciarsi per primi.” Oltretutto, nell’ipotesi di una netta presa di
posizione contraria da parte della Confindustria, si poneva un delicato problema di equilibri politici,
considerato che proprio in quei giorni era entrato in crisi il sesto governo De Gasperi e si stavano
svolgendo le trattative per la formazione del nuovo esecutivo. Poiché la sinistra era compattamente
contraria al trattato, prima di prendere una posizione definita sarebbe stato preferibile attendere la
formazione del nuovo gabinetto, nell’ipotesi che questo potesse godere di una maggiore stabilità. In
questo caso la Confindustria avrebbe avuto più possibilità di manovra, senza correre il rischio di
ritrovarsi oggettivamente alleata con le forze della sinistra nelle more della crisi di governo.
95
Nell’analisi del vicepresidente confederale fino all’8 agosto 1950, cioè nella sua prima stesura, il progetto di trattato
era rimasto accettabile, avendo un orientamento relativamente liberale ed essendo state accolte gran parte delle proposte
dei tecnici. In seguito – sosteneva Quintieri – «l’intervento del governo francese e di alcuni elementi influenti
prettamente dirigisti – le cui intenzioni politiche fondamentali sono peraltro da mettersi in dubbio date le idee
neutraliste nel conflitto tra l’est e l’ovest che vengono loro attribuite – ha modificato l’orientamento iniziale, nel senso
che questo è diventato qualcosa di informe, un congegno di cui nessuno è in grado di vedere con chiarezza il
funzionamento e tale da non poter essere più accettato da nessuno dei gruppi rappresentanti gli interessi della siderurgia
privata.” (Ivi.)
161
Seguendo questa logica, nel corso della stessa riunione fu respinta l’ipotesi avanzata da
Michelangelo Pasquato, vicepresidente confederale, di concertare l’opposizione al trattato con i
rappresentanti sindacali, magari mantenendo i contatti anche solo a livello personale 96 . Costa,
d’accordo su questo punto con De Biasi, definì “inopportuna” la proposta di Pasquato. La
tentazione di concertare insieme ai sindacati l’opposizione al trattato era comunque presente tra i
siderurgici: all’inizio di agosto Frumento scrisse al presidente confederale di ritenere opportuna
un’eventuale presa di posizione sul trattato “di un qualche organo misto in cui fossero rappresentati
anche i lavoratori” 97 . Frumento proponeva di “studiare la possibilità e l’opportunità di una specie di
conferenza dei rappresentanti industriali con quelli dei lavoratori sul tema del piano Schuman”,
proposta che fu immediatamente bocciata da Costa 98 . Nonostante la cautela del suo presidente, la
Confindustria in seguito dovette comunque difendersi dalle accuse di fomentare una collaborazione
sottobanco con l’opposizione di sinistra per impedire la ratifica del trattato 99 .
Frumento nella lettera a Costa del 7 agosto stabiliva, parlando a nome di G. Falck, la linea da
seguire nei mesi successivi nei riguardi della ratifica. Secondo il direttore del centro studi della
Falck, per modificare le parti meno accettabili del trattato si sarebbe potuto sfruttare l’ultimo
comma dell’art. 99 dove si stabiliva che, nel caso non fossero state depositate tutte le ratifiche entro
sei mesi dalla firma, “les gouvernements des États ayant effectué les dépôts se concerteraient sur les
mesures a prendre.” 100 A parere di Frumento, alla luce di tale disposizione, “sarebbe bastato non
ratificare il trattato entro il 18 ottobre 1951 per riaprire i negoziati ed avere quindi il modo di
esporre gli argomenti più utili per l’economia italiana.” Avendo alle spalle un segnale politico di
tale portata, quasi un ultimatum lanciato agli altri Paesi, la delegazione italiana sarebbe stata
avvantaggiata nell’ipotesi di una nuova sessione negoziale 101 . Sarebbe stata questa la linea seguita
dagli industriali. Il 12 ottobre, all’approssimarsi della scadenza stabilita dall’articolo 99, la
Confindustria, constatando che nessun Paese aveva ancora ratificato il trattato, esprimeva la
convinzione che vi fosse la possibilità per un’azione “diretta a correggere o modificare il
trattato.” 102 Le attese del padronato andarono, però, deluse e i procedimenti di ratifica proseguirono
96
Falck, intervenendo subito dopo Pasquato, sembrò adombrare, senza dichiararla esplicitamente, la possibilità di una
convergenza con le sinistre: «Prendo la parola per far presente che sono convinto di una ostilità vivissima da parte delle
estreme sinistre che si sono dimostrate nettamente contrarie all’iniziativa.” (ASCGII, f. Comitato consultivo di
presidenza, b. 1.4/12, Verbale della riunione dl17/7/1951.)
97
Frumento a Costa, 7/8/1951, in ASCGII, f. CECA, parte generale, b. 50.1/1, fasc. PS.
98
Costa a Frumento, 8/8/1951, in ASCGII, f. CECA, parte generale, b. 50.1/1, fasc. PS.
99
Cfr. Appunto informativo n. 542, 5/1/1952, in ASCGII, f. CECA, parte generale, b. 50.1/1, fasc. PS, con cui si
intendevano smentire le voci di «pretese collusioni fra industriali e comunisti nell’opporsi alla ratifica del piano.”
100
Cfr. il testo del trattato in Atti parlamentari, I Legislatura. Senato, discussioni,. Seduta del 15/3/1952, p. 31835.
101
ASCGII, Frumento a Costa, 7/8/1951, in ASCGII, f. CECA, parte generale, b. 50.1/1, fasc. PS.
102
ASCGII, f. CECA, parte generale, b. 50.1/1, fasc. PS, Appunto informativo n. 497, 12/10/1951.
162
senza che si aprissero spiragli per una revisione del trattato 103 . Le speranze confindustriali di un
blocco dei processi di ratifica ripresero vigore nel marzo, quando il trattato fu preso in esame dal
Conseil de la République, la Camera alta francese, in cui sembrava esserci una consistente
opposizione. Abbastanza intempestivamente la Confindustria diramò un comunicato in cui si
affermava la convinzione di trovarsi di fronte ad una “battuta di arresto nelle ratifiche del piano
Schuman”: 104 il giorno dopo, il 1° aprile, il Conseil de la République ratificò il trattato con 177 voti
contro 31, pur avendosi 87 astensioni in prevalenza nelle file golliste e moderate (D. Spierenburg e
R. Poidevin 1993, p. 43).
Intanto, il 15 marzo 1952, il Senato italiano aveva approvato la legge di ratifica. Nel corso della
discussione non furono molti gli interventi dei senatori vicini all’organizzazione degli industriali, e
alcuni di questi andarono decisamente controcorrente rispetto alla linea ufficiale adottata dalla
Confindustria. Ad esempio, il senatore Vinicio Ziino, democristiano, che Mattina classifica tra gli
“amici” dell’associazione degli industriali (Mattina 1991, pp. 251-262) 105 , difese la CECA in
ragione dei vantaggi che essa avrebbe offerto all’industria meccanica italiana, arrivando a definire
la siderurgia italiana “antieconomica e parassitaria per la collettività nazionale” 106 , e concluse il suo
intervento dicendo:
Diciamo francamente la verità: il piano Schuman, considerato dal punto di vista economico a
prescindere dai riflessi politici, costituisce un’innovazione della nostra politica economica quale
è stata condotta dal 1887 ad oggi. La politica economica fino ad oggi è stata protezionista, […]
all’ombra della protezione sono sorte molte aziende e sono state costituite poderose fortune.
Però il mondo non può rimanere fermo ed estatico in contemplazione di queste fortune. Il
mondo cammina: quello che è stato ieri, quello che è oggi, può darsi che non sia domani. 107
Una figura di primo piano come Merzagora, ben addentro al mondo industriale italiano, prese,
come abbiamo visto, una posizione del tutto simile a quella di Ziino, in difesa del trattato per i
vantaggi che ne sarebbero venuti all’industria meccanica, un settore produttivo che per l’economia
della penisola rivestiva un’importanza ben maggiore rispetto alla siderurgia 108 .
Emergeva, quindi, l’isolamento della siderurgia privata anche all’interno del mondo industriale,
mentre diveniva evidente come lo sforzo propagandistico e i tentativi di mantenere un fronte
unitario messi in campo dalla Confederazione non avessero dato risultati fruttuosi. L’apparente
103
Ma ancora nel gennaio 1952 la Confindustria ricordava all’opinione pubblica ed ai parlamentari la possibilità di
modifica contenuta nell’art. 99. (Cfr. ASCGII, f. CECA, parte generale, b. 50.1/1, fasc. PS, Appunto informativo n. 542,
5/1/1952.)
104
Appunto informativo n. 598, 31/3/1952, in ASCGII, f. CECA, parte generale, b. 50.1/1, fasc. PS.
105
Gli “amici” sono definiti da Mattina come «tutti coloro che pur non essendo associati alla CGII [in questo caso sono
definiti “affiliati”] apparvero impegnati in modo abbastanza sistematico a tutelare nelle sedi parlamentari gli interessi
rappresentati dalla Confederazione.” (p. 255.)
106
Atti parlamentari, I Legislatura. Senato, discussioni. Seduta dell’ 11/3/1952, p. 31515.
107.
Ivi, p. 31525.
108
Atti parlamentari, I Legislatura. Senato, discussioni. Seduta del 14/3/1952, p. 31707.
163
unità di intenti del padronato italiano riguardo al pool del carbone e dell’acciaio era stata agevolata
dal basso profilo fino a quel momento adottato dai consumatori dei prodotti siderurgici, che
avrebbero dovuto invece essere interessati alla possibilità di importare semilavorati a prezzi più
bassi. Per comprendere questa circostanza si deve considerare il fatto che vasti settori della
meccanica italiana in mano ai privati erano strettamente legati alla siderurgia109 . Ma nel momento
in cui le prospettive si facevano concrete, non era più possibile, in nome dell’unità tra produttori,
rinunciare a vantaggi cospicui, mentre si faceva sentire la voce della vasta porzione di industria
meccanica, circa un quarto del totale, controllata dall’IRI 110 .
D’altra parte, visto come si evolvevano le cose negli altri Paesi, non vi era forse nemmeno più
l’idea di raggiungere risultati eclatanti, se mai questa prospettiva era stata accarezzata dagli
industriali siderurgici; si pensava più che altro all’adozione di ordini del giorno che specificassero il
punto di vista italiano sulle disposizioni più controverse. In questo senso si mosse il senatore Enrico
Falck, che ovviamente tenne una posizione del tutto in linea con quella ufficiale della Confindustria,
ricordando nel suo intervento, punto per punto, tutte le obiezioni avanzate dagli industriali e
presentò un ordine del giorno, che venne approvato dall’Assemblea, nel quale erano elencate tutte le
modifiche che l’Italia auspicava venissero apportate al trattato 111 .
Infine il 16 giugno anche la Camera ratificò il trattato. Nell’occasione la Confindustria diramò un
comunicato in cui si ricordavano ancora una volta le critiche “alle direttive dirigistiche che avevano
informato il piano” e si sollevavano obiezioni al metodo dell’integrazione settoriale, considerato
dannoso in vista di una rapida realizzazione dell’unificazione dei mercati, per le disparità e gli
squilibri che determinava tra i singoli settori 112 . Inoltre gli industriali recriminavano per la
ristrettezza eccessiva dei tempi riservati alla discussione del trattato che non avevano consentito un
esame approfondito e, a differenza di quello che era accaduto in altri Parlamenti, avevano impedito
109
Sugli intrecci tra siderurgia privata e meccanica si veda Radar (1948). Ad esempio il gruppo Falck controllava la
Franco Tosi di Legnano, una della maggiori aziende meccaniche italiane. Lo stesso gruppo, insieme alla FIAT
controllava la Ercole Marelli di Sesto S. Giovanni, società costruttrice di motori elettrici. Innumerevoli, naturalmente,
erano le partecipazioni del gruppo FIAT-IFI, il primo produttore privato di acciaio, in aziende meccaniche di ogni
genere. (Ivi, pp. 228-229 e 250-251.)
110
A questo proposito si veda ASUE, f. MAEI, PS, b. 11, Piano Schuman e ripercussioni in Europa e in Italia, dal
punto di vista dell’industria meccanica (relazione del presidente ing. Senesi al Consiglio di amministrazione di
Finmeccanica), ottobre 1951, in cui si legge: «Sappiamo che questo piano rappresenta una grave preoccupazione per la
siderurgia interna, ma essa non deve dimenticare che questo suo travaglio è indispensabile se si vogliono alleviare i
gravissimi danni che oggi affliggono e arrestano la marcia della meccanica, la quale, comunque, rappresenta per la
siderurgia il cliente dei 2/3 della sua produzione e per il Paese la sola grande valvola per assorbire, con la sua
espansione, grandi masse di disoccupati.”. In una seconda fase, dopo la ratifica del trattato, in realtà le prospettive per
l’industria meccanica non sembravano così rosee. Soprattutto a causa dei temperamenti previsti a favore della siderurgia
italiana nel periodo transitorio, non si riteneva che le industrie meccaniche italiane avrebbero potuto godere di grossi
vantaggi per alcuni anni a venire. (ASCGII, f. CECA, parte generale, b. 50.1/1, fasc. PS, Appunto, 20/8/1952.)
111
L’intervento di Falck è in Atti parlamentari, I Legislatura. Senato, discussioni. Seduta del 13/3/1952, pp. 3164131649.
112
Appunto informativo n. 633, 16/6/1952, in ASCGII, f. CECA, parte generale, b. 50.1/1, fasc. PS.
164
la presentazione di mozioni e ordini del giorno su aspetti particolari del trattato 113 . Grave motivo di
scontento, infatti, era per gli industriali il fatto che alla Camera non fosse stato approvato un ordine
del giorno simile a quello passato al Senato per iniziativa di Falck.
La vicenda della ratifica del trattato, come più in generale tutta la vicenda che portò alla nascita
della CECA, si risolse in una sconfitta innegabile per i proprietari della siderurgia privata e per la
stessa Confindustria che li appoggiò. Certamente alcune delle richieste avanzate dagli industriali
furono accolte, in particolare il mantenimento della protezione doganale per un periodo di tempo
sufficientemente lungo da permettere un adattamento soft alla creazione del mercato comune, ma
nel complesso, come abbiamo visto i motivi di scontento erano molti. Come è stato rilevato, la
condotta negoziale italiana mirò a tutelare soprattutto le esigenze dell’industria a partecipazione
statale (accesso al minerale algerino, tutela dei programmi di investimento), che ebbe ultima parola
sull’accettabilità degli aspetti tecnico-economici del trattato di Parigi (Ranieri 2002, p. 223). Da un
punto di vista economico, l’obiettivo ultimo, come aveva dichiarato Sinigaglia già nel 1946 114 ,
restava quello di creare una siderurgia economicamente sana in grado di rifornire l’industria
meccanica a prezzi competitivi. Da un punto di vista politico, come abbiamo già accennato, il fine
supremo era rientrare a pieno titolo nel gioco diplomatico. In un documento del ministero degli
Esteri del maggio 1950 questi due aspetti furono riassunti in modo lampante, in un brano che vale la
pena di riportare nella sua interezza:
Potevamo, a fronte dei pericoli e delle rinunce cui rischiamo di andare incontro, declinare a
priori la nostra partecipazione all’accordo […]? La risposta non può essere che negativa. Da un
punto di vista politico, l’inserzione dell’Italia nel complesso franco-tedesco e soprattutto in
quello germanico, costituisce un vantaggio di tutta evidenza. La non inserzione, costituirebbe
uno svantaggio di evidenza pari, in quanto significherebbe l’estromissione dell’Italia (che tanto
cammino ha da rimontare) dal consesso europeo e la relegherebbe ai margini della vita
internazionale, quasi una no man’s land fra l’Ovest e l’Est. Dal punto di vista economico si
perviene alle stesse conclusioni. Non si può praticare l’autarchia siderurgica in un mondo che
liberalizza, senza restare soffocati: non si può rinunciare alle esportazioni meccaniche perché
abbiamo bisogno di importazioni essenziali; e non si può rischiare di vedere (in questo caso con
certezza assoluta) la siderurgia italiana realmente spazzata via, se rimanessimo fuori per volontà
nostra dai mercati di rifornimento delle materie prime che debbono alimentarla. 115
113.
Ivi.
Interrogatorio dell’ingegner Oscar Sinigaglia, in Ministero per la Costituente 1946.
115.
ASUE, f. MAEI, PS, b. 4, Nota della DGAE, 2/6/1950.
114
165
B.4.b. L’avvio della CECA - La scelta degli uomini e l’avvio delle istituzioni
La nomina del membro italiano dell’AA
Il 25 luglio 1952 il Consiglio dei Ministri comunica l’entrata in vigore del Trattato e nomina i
membri dell’AA e della Corte. L’Italia otteneva la presidenza della Corte di Giustizia, affidandola a
Massimo Pilotti, e un rappresentante all’AA, nella persona del federalista e deputato democristiano
Enzo Giacchero.
Massimo Pilotti era uomo di provata esperienza giuridica internazionale, che aveva ricoperto una
serie di incarichi di prestigio: membro della delegazione italiana alla Conferenza di Pace di Parigi nel
1919, Pilotti aveva partecipato dal 1924 come esperto legale ai lavori delle Nazioni Unite di Ginevra e
dal 1932 al 1935 ne era stato anche Segretario Aggiunto. Al 1925 risaliva la sua prima esperienza di
mediatore nelle dispute franco-tedesche. Infatti era stato allora chiamato a presiedere la Commissione
che doveva arbitrare la liquidazione dei costi dell’esercito di occupazione nella Renania. Dal 1934 era
stato pubblico Ministero alla Corte di Cassazione e dal 1949 ne era stato eletto presidente onorario 116 .
Soprattutto la nomina di Giacchero forniva un’ulteriore prova della tenacia con la quale De
Gasperi perseguiva le proprie priorità. La prima discussione sulle candidature italiane si era avuta a
Roma in Consiglio dei Ministri agli inizi dell’aprile 1951. 117 Si era allora trattato di uno scambio di
vedute, nel corso del quale tuttavia erano emerse le soluzioni più probabili. Sforza avanzava come
sua prima candidatura quella di Grazzi, mentre come seconda scelta indicava Ricci, che abbiamo
già incontrato come uno degli esponenti di punta della resistenza protezionistica delle cokerie. La
seconda candidatura appariva però tanto poco credibile che si può supporre che fosse avanzata
come semplice copertura. Togni dal canto suo avanzava perplessità sulla candidatura di Grazzi:
occorreva, disse, un uomo “duro”, che difendesse gli interessi italiani, tuttavia scartare la
candidatura di Grazzi sulla base della sua presunta debolezza, appare oggi, e doveva apparire anche
allora, abbastanza pretestuoso dal momento che si trattava di uno degli uomini più ostinati nel
difendere le posizioni e gli interessi economici italiani. Grazzi però era pur sempre un alto
funzionario di Palazzo Chigi e il suo ingresso nel pool come rappresentante italiano avrebbe di fatto
significato l’emarginazione degli altri Ministeri. A quel punto si inseriva nella discussione La Malfa
indicando il nome di Taviani, che gli sembrava il logico contraltare di Monnet. La Malfa aveva
affiancato le iniziative europeistiche di De Gasperi nei mesi immediatamente precedenti. Nessuno
però raccolse l’idea. Togni procedeva invece a indicare nella persona di Sinigaglia - l’uomo “duro”
di cui aveva già parlato. Sforza obbiettava che se fosse occorso un industriale egli avrebbe preferito
116
117
Note biografiche su Pilotti in ASUE, CEAB 1, N.1062 Lebenslauf des italienische kandidaten.
ACS, Verbali 28/VIII E 28/IX- Riunioni del 7 e del 9 aprile 1951.
166
Frumento, non mancando di accompagnare questa preferenza ad una chiara mozione di sfiducia
verso la siderurgia statale.
La discussione sembrò rivestire soprattutto il carattere di una schermaglia, opponendo soprattutto
i due Ministeri che si erano occupati più da vicino delle trattative. Appariva però chiaro che ci si era
orientati per scegliere un alto burocrate o in alternativa una persona appartenente alle categorie
industriali. Queste erano ancora le opzioni allo studio un anno dopo, allorché il momento della
scelta si avvicinava. Giovanni Falck, parlando il 24 giugno 1952 al Politecnico di Milano, auspicava
che venisse prescelto un candidato italiano di solida preparazione economica e di autorità personale,
dicendo di pensare più a una personalità economico-governativo che non a un industriale. (Falck
1955, p.363). Era quindi la candidatura di Grazzi, che intanto aveva lasciato la direzione economica
del Ministero a Roma per diventare ambasciatore a Bruxelles, a prendere quota anche al di là degli
ambienti diplomatici. Fu De Gasperi a scavalcarla, per imporre la candidatura di Enzo Giacchero.
Enzo Giacchero, ingegnere e ferito a El Alamein fece poi parte della Resistenza piemontese.
Prefetto di Asti, eletto deputato alla Costituente e rieletto nel 1948 nelle liste democristiane. Nella
prima legislatura era diventato vice presidente del gruppo democristiano alla Camera. Non era però
strettamente parlando un uomo di partito, a testimonianza di un rapporto molto diverso fra società
civile e partiti nel primo dopoguerra. Si trattava, invece, di un professionista formatosi politicamente
nella Resistenza piemontese, era diventato contemporaneamente molto attivo nel movimento
federalista e si era particolarmente distinto come presidente del gruppo federalista della Camera dei
Deputati, aveva anche partecipato all’Assemblea del Consiglio d’Europa, presiedendo la
Commissione per gli affari scientifici e culturali, ed era stato vice presidente dell’Unione
Interparlamentare di Coudenhove Kalergi. Giacchero aveva quasi 40 anni quando fu mandato a
Lussemburgo dove rimase fino al 1959, che fu anche il termine della sua carriera politica. Era quindi
un uomo che non traeva le proprie credenziali tanto da una attività di partito quanto da una attività
politica abbastanza indipendente, di cui tutta l’ultima fase era stata caratterizzata da un attivo
impegno federalista, inoltre egli non aveva alcuna competenza specifica nei settori economici
connessi al pool. Si trovò da questo punto di vista in una posizione singolare, essendo affiancato o
da esperti tecnocrati e burocrati, come Monnet, Spierenburg, Wehrer, da sindacalisti, Finet e
Pothoff, o da uomini dell’industria come l’industriale lorenese Leon Daum. 118
118
I primi membri dell’AA furono: Monnet - presid.; Etzel F. vicepresidente tedesco - CDU; Albert Coppé - belga,
economista e politico cristiano sociale; Leon Daum - industriale lorenese, legato già al Comité de Forges; P. Finet - belga
ex sindacalista, fu il nono membro cooptato; H. Potthoff - ex sindacalista tedesco; Giacchero; Spierenburg, alto funzionario
olandese; Wehrer - del Lussemburgo. La prima Corte istituita nel 1952 era costituita da: Massimo Pilotti - presidente;
L.Delvaux - Belgio; Ch. Hamnes - Lussemburgo; Van Kleffens - Olanda; O. Riese - Germania; J. Rueff - Francia; P.
Serrarens - Olanda (Mason 1955, pp. 35-41).
167
B.4.c. L’elezione dei membri italiani dell’Assemblea comune della CECA
Terminato il processo di ratifica (l’Italia fu l’ultima a ratificare), il 18 luglio la Camera e il 21
luglio il Senato procedettero all’elezione dei 18 (9 deputati e 9 senatori) rappresentanti italiani presso
l’Assemblea comune. Come era avvenuto per il Consiglio d’Europa, si scelse, stabilendo come
requisito dell’elezione la maggioranza assoluta, di escludere le opposizioni dalla delegazione. Il PCI
(Umberto Terracini e Renzo Laconi) e il PSI (Riccardo Lombardi) protestarono vivacemente, ma la
maggioranza non cedette. La delegazione italiana risultò così essere composta da dodici
democristiani, due socialdemocratici, due repubblicani e due liberali 119 . Nutrita e qualificata era la
presenza di esponenti dei movimenti federalisti (i democristiani Giacchero e Lodovico Benvenuti, il
repubblicano Parri, il socialdemocratico Mario Zagari). Più della metà degli eletti (dieci) avevano
fatto parte della delegazione eletta per il Consiglio d’Europa all’inizio della legislatura; come
sottolineano Corciulo e Guerrieri la rappresentanza italiana era quindi più “coesa, rispetto alle altre,
nell’esprimere un indirizzo ampiamente favorevole all’integrazione europea” (Corciulo-Guerrieri
2004, p. 234). Ciò anche in virtù del fatto che già dai tempi della Costituente nel Parlamento italiano
si era sviluppato un indirizzo federalista trasversale alle varie forze politiche, soprattutto su iniziativa
di Giacchero. Nella prima legislatura si era venuto a creare il Gruppo parlamentare per l’Unione
europea, presieduto alla Camera, dove riuniva 167 deputati di diversa provenienza, dallo stesso
Giacchero e al Senato, dove aderivano 106 senatori, da Ferruccio Parri.
Molti dei membri eletti per l’Assemblea comune della CECA erano figure politiche di primo piano
che ricoprivano o avrebbero ricoperto importanti funzioni di partito o di governo. Per il PSDI vi erano
Giovanni Persico, già prefetto di Roma nel 1944-45 per nomina del CLN, sottosegretario al Tesoro
nel governo Parri e nel primo De Gasperi, era uno dei principali esponenti del gruppo senatoriale
socialdemocratico. Mario Zagari, ancorché il più giovane insieme al repubblicano Francesco De Vita,
era il leader della corrente di Iniziativa socialista ed era stato tra i promotori della scissione di Palazzo
Barberini nel settembre 1947. Per il PRI, insieme al citato De Vita, già sottosegretario alle Poste, vi
era una figura di grande prestigio come Ferruccio Parri. Per il PLI vi erano due esponenti di lungo
corso: il vicepresidente del partito Alberto Giovannini e Alessandro Casati, già ministro nei governi
Bonomi. Tra i democristiani Lodovico Benvenuti era sottosegretario al Commercio Estero e uno degli
esponenti più attivi del MFE, Francesco Mario Dominedò era sottosegretario agli Esteri con delega
all’’emigrazione, Mario Cingolani era il presidente del gruppo senatoriale ed era stato ministro
dell’Aeronautica e poi della Difesa all’epoca della Costituente. Pietro Campilli (che fu sostituito nel
119
Per la Camera furono eletti: Benvenuti (DC), Campilli (DC), De Vita (PRI), Dominedò (DC), Giovannini (PLI),
Montini (DC), Sabatini (DC), Togni (DC) e Zagari (PSDI). Per il Senato: Azara (DC), Boggiano Pico (DC), Casati
(PLI), Cingolani (DC), Mott (DC), Parri (PRI), Persico (PSDI), Sacco (DC) e Ziino (DC).
168
febbraio 1953 da Antonio Cavalli) era una figura di spicco della DC per quanto riguarda i rapporti col
mondo dell’economia e così Giuseppe Togni, già ministro dell’Industria. Altri vantavano importanti
esperienze internazionali, come Antonio Azara, giurista procuratore generale in Cassazione che
sarebbe divenuto ministro della Giustizia nel 1953 nel governo Pella, che negli anni Trenta aveva
partecipato a diverse missioni all’estero per lo studio e il coordinamento delle norme giuridiche;
Ludovico Montini – fratello di Giovan Battista Montini, il futuro Paolo VI, allora sostituto alla
segreteria di Stato vaticana – che aveva presieduto la delegazione italiana presso l’UNRRA. Vi erano
poi Vinicio Ziino, sottosegretario all’Industria, vicino al mondo imprenditoriale e il sindacalista
Armando Sabatini, dirigente della FIM-CISL che sarebbe divenuto in seguito sottosegretario al
Lavoro. Il decano della delegazione era Antonio Boggiano Pico, esponente in epoca prefascista del
Partito popolare, che era già stato delegato alla SDN nel 1923. Completavano il gruppo Italo Mario
Sacco, avvocato, docente universitario, che vantava anch’egli una lunga militanza nel movimento
cattolico e Angelo Giacomo Mott, anch’egli con iniziò la sua carriera politica nel PPI, sarebbe
diventato nella seconda legislatura sottosegretario alle Finanze e al Tesoro. (Corciulo, Guerrieri 2004,
pp. 232-235; Bonini 2004
B.5. Fattori politici e tecnico-economici nell’articolazione
dell’interesse nazionale italiano
Dall’esame che abbiamo svolto di alcune fasi del ruolo dell’amministrazione italiana nel
processo di costruzione della CECA si sono evidenziati molti nodi importanti. Ci limitiamo qui a
sottolinearne alcuni, rimandando alle conclusioni generali per un quadro di insieme. Ci sembra
intanto di rilevare come vi fosse durante tutta la trattativa un sovrapporsi di due piani: da una parte
un modo diciamo ‘vecchio’ di fare i negoziati internazionali, che ricalcava l’esperienza degli anni
Trenta, di spartizione di mercati, accordi di cartello, intese governative bilaterali. Dall’altra, vi
erano esigenze politiche “nuove” che erano in parte risultato del processo di liberalizzazione che
investiva, sia pure gradualmente, l’Europa occidentale, e delle nuove filosofie di apertura e
trasparenza dei mercati che lo accompagnavano sotto il patrocinio statunitense, e in parte
derivavano dalla accresciuta influenza sul proscenio europeo di fattori democratici e pluralisti, quali
partiti politici, sindacati di vario orientamento, e più in generale della necessità per gli uomini di
governo di tenere conto dei loro elettorati.
169
Tutta la trattativa era punteggiata di esempi dell’uno e dell’altro modo di operare, e, per
quanto riguarda l’Italia, questa dicotomia si rifletteva molto bene nella differenza fra l’operato dei
funzionari ministeriali e degli interessi economici da una parte, dei responsabili politici dall’altra. I
dirigenti dell’amministrazione, sia del Ministero dell’Industria che degli Esteri, come pure gli
interessi organizzati, e in particolare la siderurgia pubblica, partecipavano a una sorta di riedizione
di un negoziato già sperimentato in passato, del resto confortati dai loro omologhi francesi e
europei. Il capo delegazione, Taviani, i Ministri e il capo del Governo, talvolta anche gli alti
dirigenti industriali, si rendevano conto, sia pure non sempre con coerenza e continuità, che
occorreva mettere in secondo piano vecchie pratiche della politica di potenza e attrezzarsi a una
operazione politica più ambiziosa. Già all’inizio della trattativa, poco dopo il lancio del Piano
Schuman, l’ambasciatore Quaroni si era reso conto che questa volta si era di fronte a un fenomeno
nuovo, dove parole come “integrazione” “messa in comune delle risorse”, “Autorità
soprannazionali” non andavano prese alla leggera. Abbiamo cercato di fare intravedere come volta
per volta scoppiassero contrasti, e si raggiungessero compromessi, fra i due modi di intendere la
trattativa.
Un altro nodo che emerge dall’esame della trattativa è quello che riguarda il rapporto fra
Ministero degli Esteri e altre amministrazioni. Si trattò di un rapporto complicato, in quanto la
tradizionale supremazia dei funzionari del MDAE veniva messa in discussione dall’emergere di
tematiche e interlocutori che richiedevano la presenza di altre competenze, in primis quelle del
Ministero dell’Industria, con il suo stretto rapporto con le categorie industriali e le sue competenze
in tema di materie prime e fonti energetiche. Accanto al Ministero dell’Industria, tuttavia, si
affacciavano sul proscenio europeo altre amministrazioni come il Ministero del Commercio Estero,
il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Ministero del Tesoro, e in prospettiva,
considerate le prerogative della CECA, anche i Trasporti, la Ricerca Scientifica e altri ancora. Del
resto il Ministero degli Esteri perdeva anche ufficialmente, a norma di Trattato, il crisma ufficiale di
assommare su di sé poteri e competenze nei rapporti internazionali. Infatti il Consiglio di Ministri
CECA era composto di uno dei membri del Governo di ciascun paese membro a ciò delegato (art. 7
del Trattato), con la chiara indicazione che questo poteva essere sia il Ministro degli Esteri che un
Ministro tecnico. La prassi che stabilì a partire dal 1953 fu che alle sedute del Consiglio
partecipavano spesso Ministri tecnici diversi, a seconda delle materie trattate.
E’ possibile, infine, proporre qualche elemento di raffronto fra la azione condotta dal governo e
dall’amministrazione italiana e quella degli altri paesi nel corso delle stesse trattative (Griffiths
1988). Un caso a parte è rappresentato dalla Francia, dove tutta la condotta negoziale fu posta nelle
mani di Jean Monnet e del Commissariat au Plan, esautorando gli altri ministeri e allontanando
170
dalle trattative le categorie economiche. Fu questa una condotta efficace nel breve termine, di
grande impatto all’esterno, ma che portò, in seguito, a innumerevoli conflitti interni e a posizioni
contraddittorie.
Nei paesi del Benelux, invece, e in Germania il peso degli interessi carbo-
siderurgici sulle rispettive delegazioni fu più forte che non in Italia, in quanto essi rappresentavano
realtà produttive più corpose e importanti. La Germania occidentale era agli albori della propria
esperienza amministrativa, essendo ancora un paese sotto la tutela dell’Alta Commissione alleata, il
che rende il paragone con l’Italia non molto probante. Certo il ruolo del Cancelliere Adenauer nella
trattativa fu ben più importante che non quello di De Gasperi. Come la Germania, l’Italia aveva
accolto l’invito di Schuman di far presiedere la propria delegazione da una personalità politica, non
legata agli interessi economici. Come abbiamo visto questo rappresentò un punto di forza della
condotta negoziale italiana, dove agli argomenti tecnici, si affiancarono spesso espressioni di
interesse politico e sociale che trovarono una certa risonanza nella conferenza e anche nel Trattato.
Non sembra quindi che la compenetrazione fra politica ed economia realizzata dall’Italia, in questa
occasione, avesse nulla da invidiare alle altre delegazioni.
171
Conclusioni: Prospettive della ricerca: contenuti, strutture,
attori e metodi della politica industriale italiana in un quadro
di interdipendenza.
La nostra ricerca si ferma alle soglie dell’inizio dei lavori della CECA, la prima comunità
europea. Un rapido sguardo al Trattato CECA, composto di 100 articoli, tre annessi, tre Protocolli
allegati, e una Convenzione relativa alle Disposizioni Transitorie di 31 paragrafi, basta per confermare
l’articolazione e la complessità della sua costruzione istituzionale e l’ampiezza delle materie
sottoposte a regime soprannazionale. Le nuove istituzioni definite dal Trattato erano l’Alta Autorità, il
Consiglio dei Ministri, l’Assemblea Comune, il Comitato Consultivo e la Corta di Giustizia. All’Alta
Autorità era attribuito il potere di emettere decisioni, raccomandazione e pareri. All’Alta Autorità
(art. 14) era attribuito il potere di emettere decisioni, raccomandazioni e pareri. Le sue decisioni
erano obbligatorie in ogni loro elemento e riflettevano il fatto che l’Alta Autorità era dotata di
sovranità autonoma nei confronti dei paesi membri. In alcuni casi previsti, tuttavia, essa poteva
agire solo con il parere “conforme” del Consiglio dei Ministri – che poteva essere espresso, a
seconda della materia considerata, con voto unanime, a maggioranza qualificata o a maggioranza
semplice (art. 28).
Il terzo Capo del Trattato dedicato alle “Disposizioni economiche e sociali” (art. 46-75) era
il più ampio e dettagliato e conteneva le principali indicazioni su come dovessero essere condotti gli
affari della Comunità. Alla Alta Autorità venivano conferiti i mezzi necessari per attuare i propri
fini, con prelievi sul carbone e sull’acciaio prodotto dalle imprese della Comunità (art. 49). I
proventi del prelievo erano destinati a coprire: le spese amministrative dell’AA; i fondi necessari
per gli aiuti di riadattamento per lavoratori di imprese colpite da processi di ristrutturazione (art 56);
eventuali addebiti di interesse sui prestiti contratti o garantiti dall’AA (art. 54) e gli investimenti per
attività di ricerca promosse dall’A.A (art. 55). Il prelievo veniva riscosso sul carbone e l’acciaio
prodotto nella Comunità per un montante inferiore all’1% del suo valore, a meno di un voto a due
terzi del Consigli di Ministri (art. 50).
L’Alta Autorità poteva, in prima persona, contrarre prestiti a favore di imprese carbosiderurgiche comunitarie o garantire prestiti concessi alle aziende da soggetti terzi (art. 51). Essa
esercitava un potere di guida e di indirizzo sugli investimenti e poteva usare i propri fondi per
favorire alcuni progetti giudicati particolarmente importanti (art 54); promuoveva e finanziava
attività di ricerca tecnica e sociale (art. 55); interveniva con aiuti per il ricollocamento e la
172
rieducazione della manodopera colpita da gravi crisi di ristrutturazione (art. 56). In caso di “crisi
manifesta” (art 58) poteva, con il parere conforme del Consiglio dei Ministri, intervenire
attivamente sul mercato, restringendo la produzione con un regime di quote, o ripartendo le risorse
in caso di penuria. Era vietata la formazione di intese cartellistiche, se non in casi specifici
determinabili dall’Alta Autorità (art. 65) e quest’ultima aveva potere di approvare o vietare
concentrazioni e fusioni fra imprese (art. 66). Vi erano regole per impedire una competizione al
ribasso sui salari (art. 68) e per favorire la libera circolazione dei lavoratori nella Comunità, purché
dotati di “qualifica confermata” (art. 69). Erano vietate le discriminazioni nei costi di trasporto (art.
70), mentre il commercio fra gli Stati membri e il resto del mondo era soggetto, entro certi limiti, al
controllo della Comunità (art. 71-75). All’Alta Autorità era dato potere di comminare ammende
alle imprese che violassero le condizioni di concorrenza e di non discriminazione poste dal Trattato
(art. 63 e 64).
Il Capo IV del Trattato (art. 76-100) conteneva le disposizioni generali e le normative
specifiche per far funzionare la Comunità, dall’impegno formale contratto dagli Stati membri per
rendere possibile la azione degli organi CECA (art. 86), alle procedure per infrazione degli Stati
membri sollevate dall’Alta Autorità davanti alla Corte di Giustizia (art. 88), alle procedure per
eventuali emendamenti (art. 95 e 96), alla fissazione della durata cinquantennale del Trattato
(art.97).
La Convenzione Relativa alle Disposizioni Transitorie definiva una serie di azioni e di
compiti da svolgersi nell’arco del periodo transitorio fissato per il periodo di cinque anni. Si
dettavano le modalità della costituzione degli organi CECA e si indicavano le misure necessarie
per unificare i mercati, per intavolare i negoziati con i paesi terzi, fare fronte alle eventuali misure
di ricollocamento, e infine si prevedevano alcune disposizioni particolari previste in relazione ad
alcuni paesi sia per il carbone (Francia, Belgio, Italia) che per l’acciaio (Italia, Lussemburgo).
La messa in opera di questo trattato avrebbe richiesto un sforzo enorme da parte di vari
soggetti: le nuove istituzioni comunitarie, che una volta create, dovevano dotarsi di funzionari,
modalità e procedure; le amministrazioni nazionali che dovevano trasformarsi per poter operare
efficacemente nel nuovo sistema e anche i sistemi giuridici e legislativi dei singoli stati membri che
erano sollecitati a riformarsi e rimodularsi sia dall’esistenza del trattato che dalla Corte di Giustizia
da cui sarebbe scaturito una corpus di norme interpretative da conciliare con le leggi nazionali.
Sembra, quindi, aprirsi un campo di estremo interesse per gli storici dell’amministrazione: lo
studio cioè dell’adattamento, delle resistenze, delle tensioni interpretative, delle interdipendenze e
delle relazioni fra livelli nazionali ed europei, del rapporto fra interessi e amministrazione ai vari
livelli, che furono innescate dalla costruzione comunitaria. D’altra parte, come è noto, poiché la
173
CECA fece da battistrada alle altre comunità europee, la CEE e l’EURATOM; e ne influenzò i
modelli organizzativi è chiaro come un’indagine di questo genere non può che gettare importanti
fasci di luce su tutto il processo di unificazione europea.
Troviamo, però, che, in questo campo, siamo appena all’albore degli studi.
Grazie
all’apertura degli archivi della CECA, qualche interessante indagine vi è stata sulla strutturazione
amministrativa delle varie istituzioni comunitarie, a partire dall’Alta Autorità (Mazey 1992;
Spierenburg-Poidevin 1993). Tuttavia si tratta di indagini iniziali, da cui per esempio, non è facile
ricavare molte indicazioni sul modo in cui le amministrazioni nazionali si rapportarono alla CECA.
Dal punto di vista nazionale, inoltre, lo stato degli studi è ancora più embrionale. Non vi sono studi
sul contributo italiano alla creazione della burocrazia CECA, al di là di qualche spunto nella
memorialistica (Spinelli 1965; Fantoli 1995) Né si è affrontato in modo organico il tema del
rapporto integrazione europea, politiche industriali di settore e amministrazioni nazionali, al di là di
alcuni brevi saggi, su argomenti in qualche modo collegati alla CECA, come quello dell’Euratom
(Curli 1998). Anche a proposito dei Trattati di Roma e della CEE non esistono studi specifici di
storia amministrativa. Qualche studio più organico sul rapporto pubblica amministrazione e
ordinamento comunitario vi è stato per gli anni Ottanta, in particolare per quanto riguarda l’Atto
Unico e il processo che portò al Trattato sull’Unione. (Massera 1994).
E’ opportuno quindi che anche l’integrazione europea venga portata al centro dell’esame
della storia dell’amministrazione, soprattutto quando si accetta, secondo la linea che abbiamo scelto
in questo lavoro, la esistenza di una stretta interrelazione fra interessi nazionali e strutture
comunitarie. In particolare le interpretazioni più recenti sul funzionamento delle comunità mettono
in evidenza la coesistenza di vari livelli di sovranità, nazionale, sovrannazionale, e transnazionale
che si rinforzano a vicenda. Viene riconosciuto, inoltre, come il peso degli elementi nazionali sia
rimasto un elemento centrale dell’intero sviluppo dell’integrazione, guidandone, indirizzandone o
ritardandone lo sviluppo. (Milward 2000; Della Cananea 2003).
In sostanza numerose indicazioni, convergenti sia dal punto di vista della storia e della teoria
dell’integrazione europea che dal punto di vista della storia dell’amministrazione suggeriscono di
continuare nella direzione intrapresa in questo progetto, procedendo ad affrontare il periodo
successivo al 1953, secondo l’ottica del rapporto fra amministrazione pubblica italiana e vicenda
comunitaria iscritta nel Trattato CECA e nei trattati successivi.
174