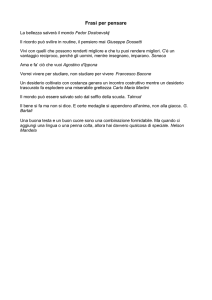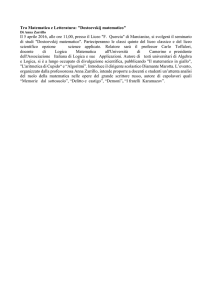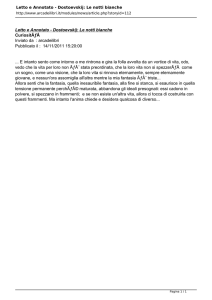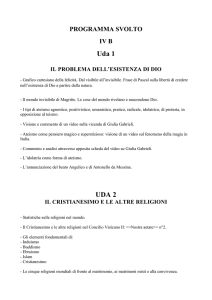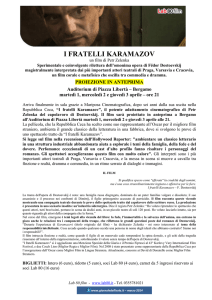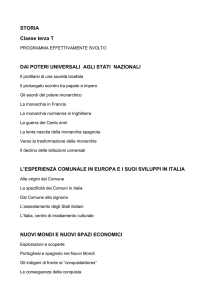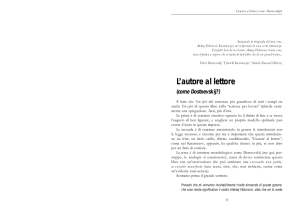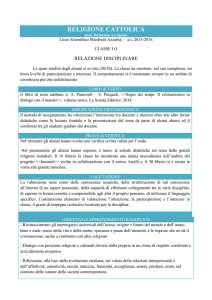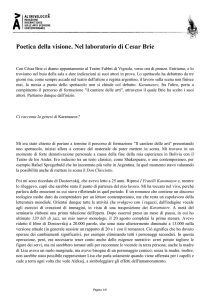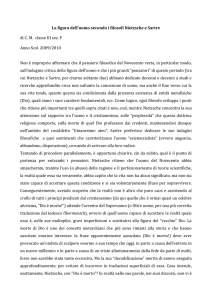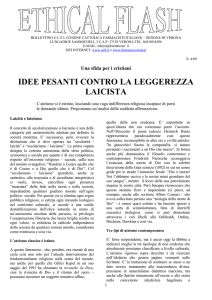Henri de Lubac
(1896-1991)
“Il dramma
dell’umanesimo ateo”
Cenni biografici
H. de Lubac è uno dei più influenti teologi del XX secolo. I suoi scritti hanno giocato
un ruolo chiave nella preparazione del Vaticano II. Gesuita dal 1913 e prete dal 1927,
insegna alla Facoltà teologica di Lione dal 1929 al 1961. Nel 1938 pubblica il suo
primo libro, Catholicisme, les aspects sociaux du dogme.
Durante l’occupazione tedesca, insieme ad amici e compagni gesuiti, si batte per il
vero spirito cristiano contro gli ideali antisemiti del nazismo con i Cahiers du
témoignage chrétien. Del 1946 è Surnaturel. Études historiques, accusato di
modernismo. L’enciclica Humani generis del 1950 sembra accusarlo direttamente.
Sospeso dall’insegnamento, i suoi libri sono ritirati dalle scuole. Lascia Lione e va a
Parigi, dove continua a scrivere.
Nel 1958 può di nuovo insegnare. Nel 1960 è nominato da Giovanni XXIII
consultore della Commissione Teologica preparatoria al Concilio e poi “perito” dello
stesso Vaticano II. Nel 1969 papa Paolo VI, suo grande ammiratore, gli offre il
cardinalato, ma lui lo rifiuta. Nel 1983 papa Giovanni Paolo II lo nomina cardinale,
ma senza consacrarlo vescovo.
Negli ultimi anni continua a scrivere, nonostante l’età, la malattia, la paralisi e
l’afonia. Muore a 95 anni.
Il “Newman francese”
Il “Newman francese”
Cattolicismo. Aspetti sociali del dogma raccoglie alcune conferenze a studenti
asiatici sul dogma cattolico. Corpus mysticum tratta del rapporto tra Chiesa ed
Eucaristia. Collabora alla stesura della collana di testi di autori cristiani antichi
Sources chrétiennes che avrà enorme successo. Surnaturel. Études historiques
tratta il rapporto tra filosofia e teologia, fede e ragione: è un tema trattato a più
riprese lungo l’arco della vita e che gli procura forti critiche dagli ambienti
teologici.
Libero dall’insegnamento, si sposta spesso; soggiorna per breve tempo anche a
Cartagine. In quegli anni travagliati scrive opere sul Buddismo (Sulle vie di Dio),
lavori sull’esegesi in Origene (Storia e spirito) e nei padri del Medioevo
(Esegesi Medievale).
Riammesso all’insegnamento, partecipa ai lavori del Concilio come perito e
stringe amicizia con Wojtyla. Nel frattempo si occupa di Teilhard de Chardin
difendendone l’ortodossia. Nominato consultore del Segretariato per le religioni
non cristiane, fa parte della Pontificia Commissione teologica internazionale.
Nel 1972 fonda la rivista
Communio con J. Ratzinger.
Vive con amarezza la
secolarizzazione della Chiesa, il
dramma del 1968 e le derive di
contestazione.
Parla della crisi che attraversa la
Chiesa (Paradosso e mistero della
Chiesa, La Chiesa nella crisi
attuale, Les Églises particulières
dans l’Église universelle).
Ha il culto dell’amicizia e grande
passione per la Chiesa.
L’opera di de Lubac: “una foresta”
«Chi si mette davanti agli oltre 40 volumi di Henri de Lubac, con le loro oltre
10.000 pagine e con ben più di 100.000 riferimenti, si trova come all’ingresso
di una foresta vergine, anche se tralascia di considerare i numerosi articoli e gli
altri piccoli lavori.
I temi dello studioso non potrebbero essere più disparati. Il suo sguardo spazia
apparentemente senza sforzo su tutta la teologia e la storia dello spirito, mentre
non gli sfuggono i più piccoli dettagli, come potrebbe essere un trattato dell’alto
medioevo difficilmente accessibile o una recensione in una rivista sconosciuta.
A chi però si immerge nelle sue opere fondamentali acquistando familiarità con
il suo lavoro, l’apparente foresta appare subito ordinata e diventa un tutto
organico: certo, non si tratta di un manuale scolastico di teologia, ma si presenta
come uno dei tentativi più riusciti di offrire all’uomo moderno lo spirito del
cattolicesimo in modo tale da apparire credibile in se stesso, nel suo sviluppo
storico come pure nel dialogo con le altre visioni fondamentali del mondo»
(H.U. von Balthasar, Il padre Henri de Lubac. La tradizione fonte di
rinnovamento, tr. it., 1976)
Il metodo di de Lubac
De Lubac introduce tutti i suoi ritratti
storici mediante una lettura che è il più
possibile esauriente. Non vengono
esaminate soltanto le opere principali,
ma anche quelle minori, i diari, le
lettere, le notizie, tutto ciò che ha a che
vedere con la figura considerata,
comprese le biografie e i saggi
accessibili. Da questa dettagliata
conoscenza può poi anche crescere un
giudizio di valore ben differenziato.
Se all’inizio l’autore appare
completamente preso dal soggetto
trattato, poi sa fare anche un passo
indietro. L’ultimo sguardo è di una
oggettività del tutto imparziale.
Un’opera composita
«Il dramma dell’umanesimo ateo è
un’opera composita. Alcuni mi hanno
chiesto in quanto tempo l’avevo
composta; ho risposto: “Più o meno in
un’ora”. Era solo una battuta. In realtà
non ci volle molto di più per scegliere e
raccogliere diversi scritti indipendenti tra
loro e trovare un titolo comune. Parecchi
capitoli erano apparsi nel 1942 e nel 1943
[…].
In una prima parte raccolsi alcuni articoli
disparati, la cui matrice principale era
costituita da conferenze semi-clandestine,
con spunti antinazisti; la seconda parte,
più omogenea, era costituita da un corso
tenuto alla facoltà su A. Comte; la terza
parte era composta da articoli appassionati
su Dostoevskij»
(Memorie intorno alle mie opere).
Un’opera “militante”
Nell’opera Il dramma dell’umanesimo ateo, uscita nel 1944, de Lubac analizza lo
sviluppo dell’ateismo, attraverso la filosofia di grandi pensatori come Feuerbach,
Nietzsche, Comte e Dostoevskij.
Il volume non è un testo accademico, ma un lavoro “militante” che si inquadra nella
coraggiosa partecipazione alla resistenza alla dominazione nazista.
Se si escludono Dostoevskij, e in parte Kierkegaard, che svolgono il ruolo di figure
positive, i tre autori presi in considerazione nel libro, Feuerbach (e dietro di lui
Marx), Nietzsche, Comte, rappresentano i tre avversari del momento.
De Lubac nega che l’affermazione di Dio implichi la negazione dell’uomo.
Riferendosi a Kierkegaard e a Dostoevskij sostiene che è la negazione di Dio a
produrre la negazione dell’uomo, come provano le tragedie del Novecento.
Umanesimo e cristianesimo, lungi dall’eliminarsi a vicenda, sono coessenziali.
Se la critica al marxismo risulta sfumata, per motivi facilmente comprensibili data la
rilevanza della componente comunista nell’opposizione ai nazisti, quella a Nietzsche
è manifestamente volta contro il neopaganesimo germanico, padrone della Francia.
Un’opera che fa
discutere
«Il libro ebbe parecchie edizioni. Dopo
qualche anno mi valse non tanto
l’opposizione o la confutazione, quanto
il disprezzo ostentato di tutta una nuova
scuola, divenuta trionfante nel seno
stesso della Chiesa e soprattutto della
Compagnia di Gesù. Essa mi attribuiva
un grande semplicismo.
Bisognava – dicevano – essere un
“idealista” per azzardarsi a criticare
Feuerbach, Marx o Nietzsche, che
invece devono essere i nostri “maître à
penser”…».
(Memorie intorno alle mie opere)
In dialogo con l’ateismo moderno
De Lubac dialoga con l’ateismo moderno in tre opere: Il dramma dell’umanesimo
ateo (1944), Proudhon e il cristianesimo (1945) e Ateismo e senso dell’uomo (1968).
Il più importante è il primo, composto di tre parti:
1) Feuerbach-Marz-Nietzsche-Kierkegaard: la tragica profezia dell’ateismo.
Feuerbach è l’nnestatore immediato della catastrofe: «La congiunzione tra il
socialismo francese, la dottrina economica inglese e la metafisica tedesca avrebbe
potuto produrre qualcosa di molto diverso dal marxismo, se Marx non avesse trovato
in Feuerbach il suo maestro». Ma anche Nietzsche deve molto a Feuerbach: anche
per lui Dio può nascere solo nella coscienza dell’uomo, come vi può morire.
2) A. Comte, la festosa e grottesca consacrazione della nuova religione dell’umanità
senza Dio. Con lui si ha il compimento della sociocrazia che ha fagocitato ogni
teologia e filosofia, ogni pensiero che trascende i puri fatti.
3) L’anti-ateistico profeta Dostoevskij con la sua profondità, la sua ambiguità e la
sua finale emergenza
La “salutare sferzata”
di Nietzsche (1844-1900)
La “salutare sferzata” di Nietzsche
«Nel cristianesimo Nietzsche ha intravisto più che un ideale falso, un ideale
svigorito e decaduto […]. Egli ce l’ha con i cristiani del nostro tempo, con noi
stessi. Il suo sferzante disprezzo ha di mira le nostre mediocrità, le nostre ipocrisie.
Esso prende di mira le nostre debolezze ammantate di bei nomi.
Ricordandoci la gioiosa e forte austerità del “cristianesimo primitivo”, svergogna
il “nostro cristianesimo attuale”, talvolta effettivamente “dolciastro e nebuloso”.
Gli si può dare completamente torto? Dobbiamo, contro di lui, prendere le difese
di tutto ciò che “oggi porta il nome di cristiano”? Quando egli per esempio
esclama, parlando di noi: “Bisognerebbe che essi mi cantassero dei canti migliori,
perché io imparassi a credere al loro Salvatore! Bisognerebbe che i suoi discepoli
avessero più aria da gente salvata!”, come oseremo indignarci? […].
Gli infedeli che ci stanno accanto ogni giorno osservano sulle nostre fronti
l’irraggiare di quella gioia che, venti secoli fa, rapiva gli spiriti eletti del mondo
pagano? Abbiamo noi cuori di uomini risuscitati con il Cristo? Siamo noi in mezzo
al secolo XX i testimoni delle Beatitudini?»
Nietzsche
impone ai cristiani
una severa
autocritica
Nietzsche impone ai cristiani una severa autocritica
«Preso nel suo insieme, il nostro cristianesimo è diventato insipido, nonostante
tanti sforzi meravigliosi per restituirgli vita e freschezza, esso è snervato,
sclerotizzato. Cade nel formalismo e nell’abitudine.
Così come noi lo pratichiamo, come anzitutto lo pensiamo, è una religione
debole, inefficace: religione di cerimonie e di devozioni, di ornamenti e di
consolazioni volgari, talvolta perfino senza sincerità, senza presa reale
sull’attività umana. Religione che sta fuori della vita, e che mette noi stessi fuori
di essa.
Ecco ciò che è diventato nelle nostre mani il Vangelo: ecco come è finita questa
immensa speranza che si era levata sul mondo […]. L’insofferenza a ogni
critica, l’impotenza a ogni riforma, la paura dell’intelligenza non ne sono forse
segni evidenti? Cristianesimo clericale, cristianesimo formalista, cristianesimo
spento e indurito?»
Ritornare alle sorgenti del cristianesimo
«Quello di cui abbiamo bisogno non è un cristianesimo più virile, più energico, o
più eroico o più forte; invece abbiamo bisogno di vivere il nostro cristianesimo
più virilmente, più efficacemente, più fortemente, più eroicamente se è
necessario, ma di viverlo così come è.
Non c’è nulla da cambiare, da aggiungere (questo però non vuol dire che non si
debba approfondirlo senza posa); nulla c’è da adattare alla moda corrente.
Bisogna riportarlo a se stesso, nelle nostre anime […].
Dobbiamo ritrovare lo spirito del cristianesimo. Per questo, dobbiamo ritemprarci
alle sue sorgenti, e anzitutto nel vangelo. Così come la Chiesa continuamente ce
lo presenza, questo Vangelo ci basta. Solo che, sempre nuovo, esso deve essere
sempre ritrovato.
I migliori tra quelli che ci criticano, sanno qualche volta apprezzarlo meglio di
noi. Essi non gli rimproverano le sue pretese debolezze; rimproverano a noi si
non saper sfruttare abbastanza la sua forza»
Auguste Comte
(1798-1857)
Il positivismo, al di là del teismo e dell’ateismo
Comte non vuole che lo si tratti da ateo. Un giorno scriveva a Stuart Mille:
“Questa qualifica ci conviene solo rifacendoci rigorosamente all’etimologia
poiché noi di comune con quelli che si chiamano così abbiamo solo che non
crediamo in Dio, senza per altro condividere in alcun modo le loro fantasticheria
metafisiche sull’origine del mondo e dell’uomo”.
Un positivista non afferma né nega l’esistenza di Dio, perché questo fa parte di
quelle “ipotesi indiscutibili” che non comportano più affermazione che negazione,
che sono non soltanto inaccessibili ma vuote di senso: “Si potrebbe mai decidere,
direbbero i vecchi buddisti, se i peli della tartaruga sono corti o lunghi?”.
“L’ateismo non costituisce che una emancipazione insufficiente poiché tende a
prolungare indefinitamente lo stato metafisico, ricercando senza posa nuove
soluzioni dei problemi teorici invece di eliminare come radicalmente vane tutte le
ricerche accessibili. Il vero spirito positivo consiste soprattutto nel sostituire
sempre lo studio delle leggi invariabili dei fenomeni a quelle delle loro cause.
In una parola: sostituisce la determinazione del COME a quella del PERCHÉ”.
L’ateismo non estirpa
la radice del male
Per Comte, l’ateismo non prende le
cose abbastanza da lontano, non
estirpa la radice del male.
Conservando, con i termini del
problema di Dio, le abitudini di
pensare e i modi di ragionare del
credente, esso si espone a dei
contraccolpi, conserva il solco in cui
lo spirito rischia di affondare di
nuovo.
Il positivismo non cade in questa
insidia: oltrepassa l’ateismo per
liquidare meglio il teismo. Questo
regno era una “reggenza”
corrispondente alla lunga minorità
dell’umanità. Ora l’umanità è adulta.
Ora l’Umanità si sostituisce
definitivamente a Dio.
Il positivismo è la vera religione dell’Umanità
A giudizio di Comte si distrugge solo ciò che si sostituisce. Pertanto il
cristianesimo va sostituito con una vera religione, pena il vederlo prolungarsi
indefinitamente. Al suo posto deve subentrare il positivismo, il solo capace di
condensare sentimenti, pensieri, affetti, azoni intorno all’Umanità, “il solo vero
grande essere di cui noi siamo consapevolmente i membri necessari”.
L’Umanità ha la stessa funzione che prima aveva Dio: “In essa noi viviamo, ci
muoviamo e siamo”, essa è il “centro delle nostre affezioni”
Per Comte «solo il positivismo può renderci sistematicamente liberi, cioè
subordinati a leggi immutabili e conosciute, che ci liberano da ogni impero
personale». Agli “schiavi di Dio” oppone i “servitori dell’Umanità”.
Comte ritiene che il cristianesimo sia per sua natura “antisociale”. Il suo male sta
in quel personalismo “egoista” e “anarchico” che dissolve la vita pubblica e fa di
ogni uomo un assoluto come Dio stesso e subordina il mondo all’uomo.
Invece la meta del positivismo è il superamento degli “istinti personali”, la
sostituzione del punto di vista sociale a quello personale
De Lubac definisce Dostoevskij “un
giudice del nostro tempo”. Il suo
merito sta nell’aver intuito e mostrato
con uno sguardo di introspezione
alcuni lineamenti dell’uomo che nega
Dio.
Per Dostoevskij chi considera il Cristo
semplicemente come l’ideale più alto,
come il saggio maestro dell’umanità,
uccide il Cristo, ne fa un travestimento.
Accostando il pensiero di Dostoevskij,
de Lubac critica una certa teologia
occidentale, malata di razionalismo
estremo. Anche Barth assumerà una
posizione simile contro il pensiero
teologico liberale elaborato dal
protestantesimo del XIX secolo.
Fëdor Dostoevskij
(1821-1881
Dostoevskij, un profeta
“La statura di Dostoevskij si ingigantisce con il passare degli anni […]. Egli
assume la figura di un profeta, e ciò non per aver predetto questo o
quell’avvenimento accaduto dopo […].
Più profondamente ha per così dire prevenute certe forme nuove di pensiero e
di vita interiore che per opera sua si impongono all’uomo ed entrano nel suo
patrimonio […].
Un profeta, sì: perché non soltanto ha svelato all’uomo i suoi abissi, ma
gliene ha anche in qualche modo aperti dei nuovi, dandogli come una nuova
dimensione; perché così egli ha prefigurato, cioè annunciato, realizzandolo,
un certo stato nuovo dell’umanità; perché in lui si è concentrata la crisi del
nostro mondo moderno”.
Fenomenologia
dell’ateismo moderno
L’uomo che ha perso il legame ontologico
con Dio, è diventato preda dei demoni (da
qui il titolo del romanzo di Dostoevskij, la
più completa fenomenologia dell’ateismo).
Dostoevskij è un romanziere, ma scopre che
l’uomo non può organizzare la terra senza
Dio; quando ci prova, non fa altro che
organizzarla contro l’uomo, come si è visto
soprattutto nel corso del XX secolo ma che
egli ha anticipato in modo sorprendente.
In Dostoevskij troviamo una triplice
tipologia dell’uomo ateo: l’uomo-dio, la
“torre di Babele” e il “palazzo di cristallo”.
Dostoevskij e Nietzsche a confronto
“Come non essere colpiti dal giudizio simile che entrambi hanno pronunciato sul
loro secolo? La stessa critica del razionalismo e dell’umanesimo occidentale;
la stessa condanna dell’ideologia del progresso,
la stessa insofferenza per il regno scientista e per le prospettive stoltamente
idilliache che in molti lo prolungano,
lo stesso sdegno per una civiltà tutta superficiale di cui essi fan saltare la vernice,
lo stesso presentimento della catastrofe che ben presto la inghiottirà […].
L’uno e l’altro annunciano la rivincita degli elementi irrazionali che il mondo
moderno reprime senza per altro rinunciare ad estirparli. Si sente in loro una
volontà di distruzione, e il martello iconoclasta del pensatore tedesco ha un
compito analogo alle immaginazioni apocalittiche del visionario russo […].
In loro due l’umanità cerca di evadere dalla prigione in cui una cultura ristretta
l’ha rinchiusa […].
Nel nostro tempo, Nietzsche, maledicendolo, vede un’eredità del Vangelo, mentre
Dostoevskij, che pure non maledice di meno questo tempo, vi scorge il risultato di
un rinnegamento del Vangelo”.
L’“uomo-dio”
«Siccome non c’è Dio, né
immortalità dell’anima, così
all’uomo nuovo è permesso di
diventare un uomo-dio, anche se
fosse l’unico la mondo a vivere così.
Egli potrebbe ormai, con cuore
leggero, emanciparsi dalle regole
della morale tradizionale, alle quali
l’uomo era soggetto come uno
schiavo.
Per Dio, non c’è legge. Dovunque
Dio si trovi, è sempre al suo posto»
(Dostoevskij, I Fratelli Karamazov)
L’“uomo-dio”
È l’ideale spirituale dell’uomo che si eleva al di sopra di ogni legge. Esso
conduce inevitabilmente al delitto.
La vicenda di Raskolnikov in Delitto e castigo è esemplare: egli uccide la
vecchia usuraia persuaso di aver oltrepassato i naturali limiti dell’umano,
consegnando la sua persona, il suo essere “oltre-uomo”, a un livello
puramente ideale; non a caso il pentimento subentra proprio nel momento in
cui Raskolnikov recupera la dimensione dell’umano, quella della vita.
Secondo Dostoevskij l’ateismo, prima ancora di essere un’offesa a Dio, è un
crimine contro la vita. L’uomo è stato creato a immagine e somiglianza di
Dio per cui non tutto è lecito; non può uccidere un suo simile senza
commettere un suicidio spirituale e procedere così alla propria
disumanizzazione.
La “torre di Babele”
La “torre di Babele”
Questo ideale propone di far scendere i cieli sulla terra, per creare un nuovo paradiso,
nato dalle mani dell’uomo; un paradiso materiale, fatto di benessere, felicità (utopia
liberal-capitalista) e di uguaglianza (utopia socialista), ma dove mancherà la libertà.
Lo stesso Dostoevskij ha creduto nel potere liberatorio della rivoluzione: membro del
circolo socialista di Petrasevskij, fu arrestato e condannato a morte, pena che in
seguito venne commutata in quattro anni di lavori forzati. Egli non ha né interessi né
sentimenti né affetti personali, nulla che gli appartenga. Tutto è sopraffatto da un
esclusivo interesse, un solo pensiero, una sola passione: la rivoluzione.
La critica di Dostoevskij non colpisce solo il socialismo ma attacca ogni teoria del
progresso; sacrificare una persona in questo istante per il beneficio di un’astratta
umanità del domani, è il più grande crimine che l’uomo possa compiere.
Pur essendo qualcosa di astratto, l’ideale risulta essere più forte e, in un certo senso
più vero, della realtà: «Questa Torre di Babele, supposto che un giorno si innalzi, che
alla fine essa offra una dimora stabile, in nome di che cosa oggi mi si può costringere
a seppellirmi nelle sue fondamenta? Ogni generazione vale come un’altra, e la città
futura non potrebbe mai interessarmi, come invece mi interessa un Regno eterno».
Il Grande Inquisitore
Una volta che l’uomo si sia liberato di Dio,
sarà poi libero di fatto? Per Dostoevskij i
sistemi sociali che si sviluppano rifiutando le
loro basi cristiane, diventano fatalmente
sistemi di violenza e di schiavitù.
È il tema che attraversa la Leggenda del
grande Inquisitore, che pone in antitesi
libertà e felicità: «Tu hai concessa la libertà
agli uomini, invece di confiscarla: avevi
dunque dimenticato che, alla libertà di
scegliere tra bene e male, l’uomo preferisce
la pace, fosse pure la pace della morte? […]
Noi abbiamo corretto la tua opera. Gli uomini
si sono rallegrati di essere di nuovo condotti
come un branco. Noi ci siamo dichiarati i
padroni della terra».
La grave preoccupazione di scegliere è loro
risparmiata: non hanno più né da pensare né
da volere.
Il “palazzo di cristallo”
Il “palazzo di cristallo”
Il “palazzo di cristallo” spesso fa lega con la “torre di Babele”. Dostoevskij ci
presenta un esempio in Rakitin, il seminarista amico di Alioscia, impomatato di
scienza e di mondanità, giovane ambizioso, pieno di pretese, la cui vita
monastica non è altro che una tappa per la carriera politica.
La critica è posta sulle labbra di Mitia, il primo dei fratelli Karamazov. Egli
riceve la visita di Rakitin in carcere, dove attende il giudizio, accusato di aver
ucciso suo padre. Rakitin gli confida l’idea di scrivere un articolo su di lui, per
provare con la scienza che non è affatto colpevole, che egli è una vittima
dell’ambiente e dell’eredità. Mitia riferisce la cosa ad Alioscia:
« – Se si prende l’insieme, io rimpiango Dio; ecco! – Che vuoi dire? – Figurati
che nella testa, cioè nel cervello, ci sono dei nervi… Questi nervi hanno delle
fibre, e appena vibrano […]. Il pensiero viene in seguito, perché io ho delle fibre,
e niente affatto perché ho un’anima e sono creato a immagine di Dio: che
sciocchezza! Michele mi spiegava ciò, anche ieri, ciò mi esaltava. Che bella cosa
è la scienza! Alioscia! L’uomo si trasforma, io lo comprendo… tuttavia
rimpiango Dio. – È già qualcosa, disse Alioscia. – Che io rimpianga Dio? La
chimica, fratello, la chimica: mille scuse, Vostra Reverenza, scostatevi un po’,
passa la chimica! Rakitin non ama più Dio».
L’uomo è schiavo della scienza e della ragione
Per Dostoevskij l’ateismo contemporaneo si è costruito un palazzo di cristallo in cui
tutto è luce, e fuori del quale esso ha deciso che non c’è nulla. Questo palazzo è
l’universo della ragione, così come hanno finito per costruirlo la scienza e la
filosofia moderne.
Dostoevskij non attacca né la scienza né la filosofia: egli se la ride solo dell’uomo
che è diventato il loro schiavo.
Egli contesta la tesi secondo cui “l’uomo non è che un tasto di piano sotto le dita
della natura”. Niente caso, niente libertà! Se dunque si vuole assicurare la felicità
degli uomini, “non c’è da fare altro che conoscere bene le leggi della natura: tutte le
azioni umane saranno allora calcolate.
L’autore russo respinge inoltre la pretesa razionalista che vuole valutare ambiti che
non sono suoi, rinchiudendo l’uomo “in quella regione incantata dove regnano le
leggi e i principi”. L’evidenza razionale è quella della vita in superficie, ma l’uomo
del sottosuolo conosce un altro regno.
Le prime avvisaglie della “tempesta”
Nell’agosto 1946 si riunisce a Roma una congregazione generale della Compagnia di
Gesù per eleggere il nuovo preposito generale, dopo la morte di p. Ledochowski, non
ancora rimpiazzato a causa della guerra in corso.
Nell’occasione, il 16 settembre 1946, a Castelgandolfo, papa Pio XII concede
un’udienza al capitolo generale dei Gesuiti: rivolge loro un discorso; insieme a molti
incoraggiamenti c’è la messa in guardia contro la “nuova teologia”.
Ricorda de Lubac: «Alla fine dell’udienza eravamo sfilati tutti davanti al santo Padre
e i nostri rispettivi assistenti gli suggerivano il nome di ognuno: mi aveva detto, in
tono gentile: “Ah! conosco bene la sua dottrina”. La frase, vagamente percepita dai
più vicini, ripetuta, deformata, amplificata, fu commentata in tutti i modi. Per alcuni
era, senza dubbio, un elogio; per altri un rimprovero o almeno un avvertimento […].
Alla fine della congregazione generale, padre Janssens, nuovo generale dei Gesuiti,
prese l’iniziativa di chiamarmi… ci teneva a vedermi per dirmi: “lei ha potuto sentire
qui molte voci; ci tengo a rassicurarla; nelle inquietudini che si sono manifestate, lei
non c’entrava affatto; le parlo con cognizione di causa, dopo essermi informato a una
fonte sicura: ho visto il segretario del Sant’Ufficio e anche il Santo Padre stesso.
Sappia che ha la piena fiducia del padre generale e non si preoccupi di nulla»
(Memorie intorno alle mie opere)
“L’esame di coscienza
teologico”
di H. de Lubac
(6 marzo 1947)
«1. Non ho il temperamento di un riformatore, ancor meno di un “novatore”.
Ben lontano dall’aver mai avuto l’idea di promuovere una “teologia nuova”,
confesso di aver conosciuto questa espressione solo perché la usò il Santo
Padre nella sua allocuzione del settembre 1946. Credetti allora, secondo certe
voci, che potesse provenire da discussioni recenti tra teologi tedeschi […]
2. Non sono mai stato, se non per breve tempo, professore di dogmatica. È una
delle ragioni per cui il mio lavoro teologico non ha preso la forma di trattati di
dogmatica. Ho fatto molte letture facili che hanno orientato il mio lavoro in
senso piuttosto storico, benché io non abbia nessuna formazione tecnica di
storico. Non si tratta qui di una preferenza teorica data alla storia piuttosto che
alla dottrina; ancor meno di una specie di relativismo rovinoso per l’idea di
verità.
3. Come tutti, o quasi, mi rendo ben conto di certe necessità di rinnovamento,
perfino della teologia. Offro soltanto un po’ di materiale e qualche idea, presi
dal tesoro della Tradizione, a chi vorrà utilizzarli […]. Io non ho da proporre né
un progetto né un programma. A maggior ragione io non sono un caposcuola.
Credo molto semplicemente che se ciascuno nella Chiesa fa il suo dovere
secondo la competenza propria, seguendo le indicazioni della Provvidenza ,
l’opera si compirà per così dire da sola…
4. Quelli che mi leggono veramente, ancora più quelli che mi conoscono
attraverso l’insegnamento o le conversazioni, sanno che le mie tendenze sono
molto tradizionali.
Continuo a reagire contro i partiti-presi per la modernità, contro la foga di
mode intellettuali, contro le eccessive preoccupazioni di adattamento o le teorie
troppo compiacenti sul progresso del dogma.
Cerco sempre di riportare, e qualche volta in modo abbastanza duro, alle fonti
tradizionali e ai dati classici coloro che mi sembrano troppo appassionati di
pensiero “moderno”.
A me piace la tradizione della Chiesa, nella sua unità così varia. Mi piace in
tutte le sue forme, e non soltanto nelle forme che i casi della vita mi hanno
portato a valorizzare.
Io mi attacco a tutto quello che si è sviluppato nella Chiesa con la sua
approvazione, in venti secoli, per esplorare le inesauribili ricchezze di Cristo»
(Memorie intorno alle mie opere)
Enciclica Humani generis
(1950)
… Certi professori, rari per fortuna,
insegnano l’errore «in modo prudente e
coperto»; «se si parla con prudenza nei
libri stampati, ci si esprime più
liberamente negli scritti trasmessi
privatamente nelle lezioni e nelle
riunioni».
«Beatissimo Padre, la Compagnia di Gesù ha
fatto ai suoi figli un obbligo speciale di
obbedienza al Sommo Pontefice. Questa
sottomissione vale soprattutto in campo
dottrinale. Nelle sue regole di ortodossia, il
nostro santo padre Ignazio di Loyola ci invita a
pensare sempre in sintonia con la Chiesa
cattolica romana.
Posti dalla divina Provvidenza in un paese, in
un’epoca in cui i progressi scientifici,
l’evoluzione delle istituzioni e dei costumi, la
diversità e il conflitto delle correnti filosofiche
pongono ai fedeli colti, alle persone impegnate
nell’apostolato e più ancora ai teologi problemi
preoccupanti e pieni di molteplici pericoli, noi
siamo persuasi che, senza una straordinaria
vigilanza, è difficile conservare la purezza della
fede e progredire nella comprensione del
messaggio rivelato. Perciò vogliamo esprimere a
S. Santità la nostra riconoscenza filiale per gli
insegnamenti molto sicuri che ha dato al mondo
nella sua enciclica del 12 agosto 1950 […].
Lettera dei gesuiti di
Lyon-Fourvière a Pio
XII (19.08.1951)
Sappiamo bene che, su parecchi punti, l’enciclica Humani generis costituiva per
noi un paterno avvertimento. Secondo le direttive pontificie, avevamo cercato “di
esprimerci, nei nostri discorsi e nei nostri scritti, in modo che gli uomini del nostro
tempo ci capissero e ci ascoltassero volentieri” (cfr. Pio XII, Discorso di
Castelgandolfo).
Ma in questo sforzo apostolico, che sente l’urgenza di problemi finora poco
dibattuti, che vuole esprimere in un linguaggio più moderno verità tradizionali,
scegliendo tra le tesi che sembravano liberamente discutibili, alcuni di noi hanno
usato talvolta formule meno felici, inadeguate, perfino teologicamente inesatte.
Non tutti e sempre abbiamo fatto abbastanza distinzione tra la trasmissione della
dottrina comune e la ricerca scientifica in cui il teologo, come gli scienziati, può
avanzare delle ipotesi la cui discussione potrà mostrarne la fondatezza, aspettando
che il Magistero, se lo ritiene necessario, metta fine alla discussione tra le varie
scuole […].
Però, una volta conosciuto il testo dell’enciclica, ognuno di noi si è sforzato di
verificare, di precisare e, se c’era bisogno, di correggere il proprio pensiero e il
proprio insegnamento, per accordarli con il pensiero della Chiesa»
«Fin dall’inizio del caso, nel quale mi è sempre più
impossibile capire qualcosa, credo di essermi
messo, con l’aiuto della grazia di Dio, in una
disposizione di obbedienza completa e filiale,
secondo lo spirito della Chiesa e le costituzioni della
Compagnia, senza cercare di eludere nulla con
qualche interpretazione soggettiva. Sono
fermamente deciso, sempre con l’aiuto della grazia
di Dio, a perseverare in questa via, qualunque cosa
capiti!
Ma ecco che il padre generale solleva ancora un
altro problema, su un altro punto. In una lettera
appena ricevuta dal padre rettore di Fourvière, egli
mi accusa di “errori perniciosi su punti essenziali”
del dogma! Errori, aggiunge, nei quali io mi sono
ostinato, senza curarmi degli avvertimenti più
autorizzati.
Il padre generale si è reso conto dell’eccezionale
gravità di una simile accusa? In ogni caso, la sua
carica non lo dispensa più di ogni altro cristiano dal
dovere di giustificarla, e prima di precisarla. Egli si
basa, dice, sull’opinione di “numerosi teologi”. Chi
sono questi teologi? Ho il diritto di saperlo, di
sapere ciò che mi rimproverano, di conoscere le loro
ragioni, di discuterle, se occorre…»
Lettera di
de Lubac
al Padre provinciale ( 01.07.1950)