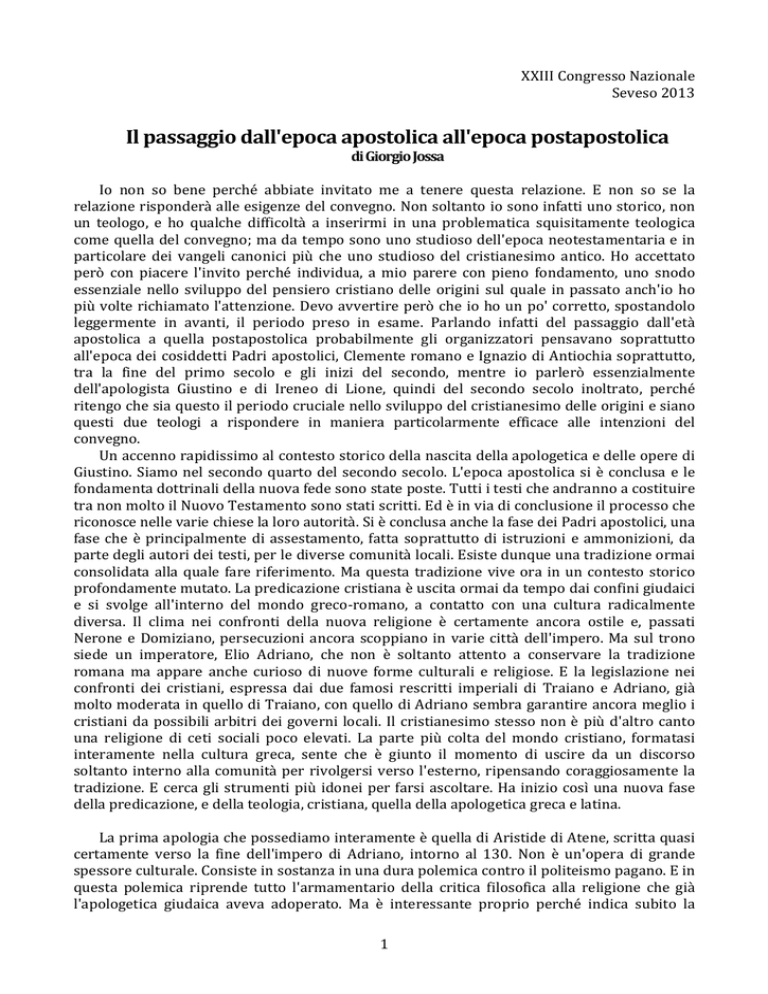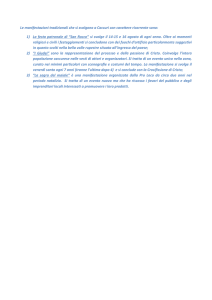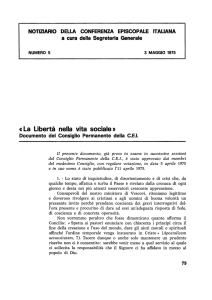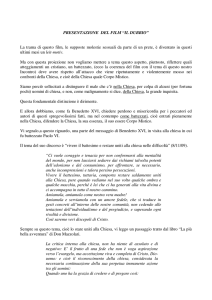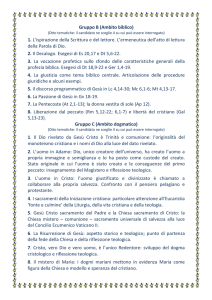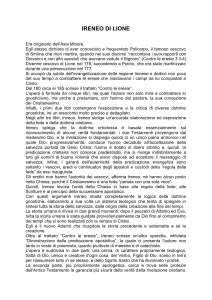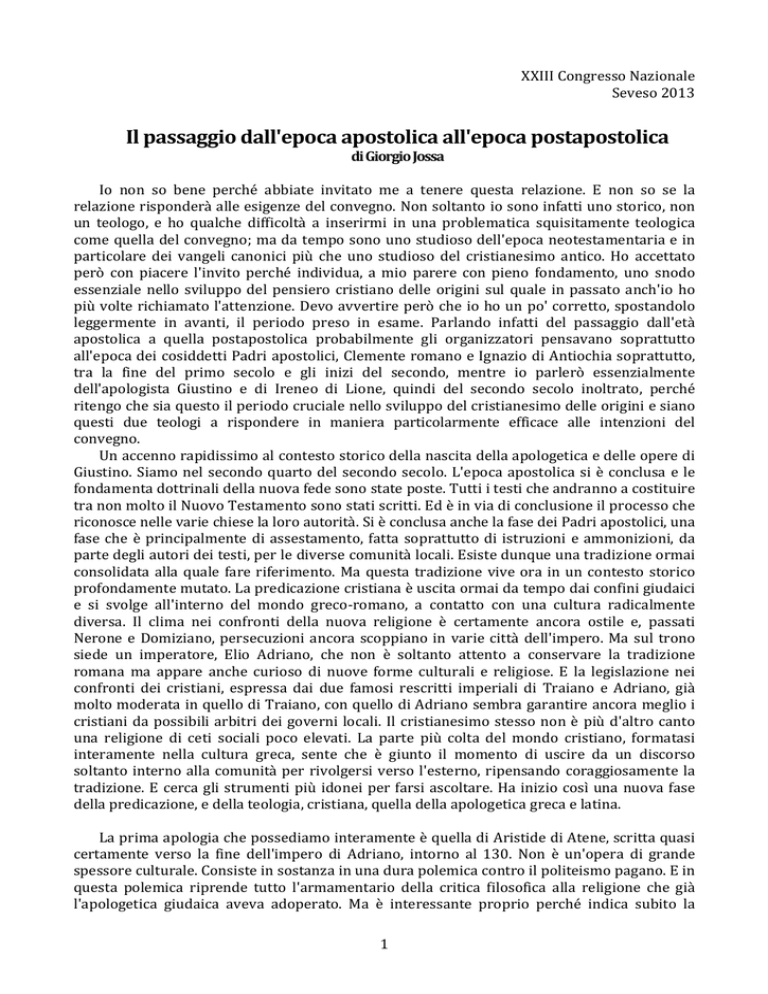
XXIII Congresso Nazionale Seveso 2013 Il passaggio dall'epoca apostolica all'epoca postapostolica di Giorgio Jossa Io non so bene perché abbiate invitato me a tenere questa relazione. E non so se la relazione risponderà alle esigenze del convegno. Non soltanto io sono infatti uno storico, non un teologo, e ho qualche difficoltà a inserirmi in una problematica squisitamente teologica come quella del convegno; ma da tempo sono uno studioso dell'epoca neotestamentaria e in particolare dei vangeli canonici più che uno studioso del cristianesimo antico. Ho accettato però con piacere l'invito perché individua, a mio parere con pieno fondamento, uno snodo essenziale nello sviluppo del pensiero cristiano delle origini sul quale in passato anch'io ho più volte richiamato l'attenzione. Devo avvertire però che io ho un po' corretto, spostandolo leggermente in avanti, il periodo preso in esame. Parlando infatti del passaggio dall'età apostolica a quella postapostolica probabilmente gli organizzatori pensavano soprattutto all'epoca dei cosiddetti Padri apostolici, Clemente romano e Ignazio di Antiochia soprattutto, tra la fine del primo secolo e gli inizi del secondo, mentre io parlerò essenzialmente dell'apologista Giustino e di Ireneo di Lione, quindi del secondo secolo inoltrato, perché ritengo che sia questo il periodo cruciale nello sviluppo del cristianesimo delle origini e siano questi due teologi a rispondere in maniera particolarmente efficace alle intenzioni del convegno. Un accenno rapidissimo al contesto storico della nascita della apologetica e delle opere di Giustino. Siamo nel secondo quarto del secondo secolo. L'epoca apostolica si è conclusa e le fondamenta dottrinali della nuova fede sono state poste. Tutti i testi che andranno a costituire tra non molto il Nuovo Testamento sono stati scritti. Ed è in via di conclusione il processo che riconosce nelle varie chiese la loro autorità. Si è conclusa anche la fase dei Padri apostolici, una fase che è principalmente di assestamento, fatta soprattutto di istruzioni e ammonizioni, da parte degli autori dei testi, per le diverse comunità locali. Esiste dunque una tradizione ormai consolidata alla quale fare riferimento. Ma questa tradizione vive ora in un contesto storico profondamente mutato. La predicazione cristiana è uscita ormai da tempo dai confini giudaici e si svolge all'interno del mondo greco-­‐romano, a contatto con una cultura radicalmente diversa. Il clima nei confronti della nuova religione è certamente ancora ostile e, passati Nerone e Domiziano, persecuzioni ancora scoppiano in varie città dell'impero. Ma sul trono siede un imperatore, Elio Adriano, che non è soltanto attento a conservare la tradizione romana ma appare anche curioso di nuove forme culturali e religiose. E la legislazione nei confronti dei cristiani, espressa dai due famosi rescritti imperiali di Traiano e Adriano, già molto moderata in quello di Traiano, con quello di Adriano sembra garantire ancora meglio i cristiani da possibili arbitri dei governi locali. Il cristianesimo stesso non è più d'altro canto una religione di ceti sociali poco elevati. La parte più colta del mondo cristiano, formatasi interamente nella cultura greca, sente che è giunto il momento di uscire da un discorso soltanto interno alla comunità per rivolgersi verso l'esterno, ripensando coraggiosamente la tradizione. E cerca gli strumenti più idonei per farsi ascoltare. Ha inizio così una nuova fase della predicazione, e della teologia, cristiana, quella della apologetica greca e latina. La prima apologia che possediamo interamente è quella di Aristide di Atene, scritta quasi certamente verso la fine dell'impero di Adriano, intorno al 130. Non è un'opera di grande spessore culturale. Consiste in sostanza in una dura polemica contro il politeismo pagano. E in questa polemica riprende tutto l'armamentario della critica filosofica alla religione che già l'apologetica giudaica aveva adoperato. Ma è interessante proprio perché indica subito la 1 strada che questi primi intellettuali cristiani seguiranno per ripensare la tradizione apostolica e parlare al mondo greco-­‐romano. Già all'inizio della sua opera Aristide adopera infatti un concetto che è ben noto a questo mondo, e in particolare alla filosofia stoica: l'ordine dell'universo (la diakosmesis), per dimostrare l'esistenza di Dio. E nel corso dell'opera critica in particolare l'assurdità dei miti greci e l'immoralità dei loro dei. È individuato in tal modo con chiarezza il terreno sul quale svolgere il dialogo con la cultura greca: l'idea di Dio e la vita morale. I cristiani si presentano al mondo pagano come un nuovo gruppo sociale (è Aristide che per la prima volta, col Kerygma Petri, parla dei cristiani come un nuovo ghenos e di una tripartizione perciò della umanità in giudei, pagani e cristiani) e in particolare come una nuova filosofia in possesso, rispetto ai pagani, di una idea più razionale di Dio e di una più elevata vita morale. Ma è Giustino che segna una svolta veramente significativa nella riflessione teologica sulla tradizione. Giunto al cristianesimo non per una conversione improvvisa, ma attraverso un itinerario squisitamente filosofico di ricerca della verità, egli sente in maniera vivissima la sfida che pone al messaggio cristiano il passaggio dalla tradizione giudaica alla cultura greca. Ripensare la tradizione nel mutato contesto storico del mondo greco-­‐romano è il compito che egli sente necessario. Rivolto quindi ai rappresentanti più eminenti di quella cultura, l'imperatore e il senato romani, non esita nelle sue due apologie (negli anni 50 del secondo secolo) a utilizzarne gli strumenti più efficaci. La figura di Gesù che egli presenta ai suoi lettori non è più quella del Messia di Israele, strettamente legata al contesto culturale giudaico di origine, e in quanto tale poco comprensibile da un pubblico pagano, ma quella del Logos ben noto alla filosofia greca. Facendo suo uno dei concetti fondamentali del pensiero stoico, quello del Logos spermatikos, della "ragione seminale", e innestandolo su quello, di origine prevalentemente giudaica, del prologo del quarto vangelo, egli afferma infatti che il fondatore del cristianesimo, Gesù Cristo, è il Logos divenuto carne. Ma aggiunge che questo Logos non soltanto esisteva e si rivelava già prima della sua incarnazione nelle apparizioni divine (le teofanie) narrate dalla Scrittura giudaica, ma già allora spargeva i suoi semi di verità non solo su Mosè e i profeti ebrei, ma anche sui filosofi e i legislatori pagani. Il cristianesimo non è quindi qualcosa di assolutamente nuovo ma è il punto di arrivo, il culmine, di una lunga storia della umanità che ha i suoi inizi non soltanto nella religione giudaica, ma anche nella filosofia greca. E i filosofi greci, essendo stati, come i profeti ebrei, in qualche modo partecipi del Logos, e avendo perciò intravisto, sia pure in maniera imperfetta, la verità, possono dirsi "cristiani prima di Cristo". Gli intellettuali pagani non hanno motivo quindi di temere o di disprezzare il cristianesimo. Il cristianesimo partecipa in maniera eminente di quello stesso Logos che è presente nelle varie forme del pensiero greco, è perciò religione razionale. E si presenta come l'esito finale di una lunghissima tradizione culturale. Aderire alla religione cristiana non significa perciò rinunciare alla filosofia greca, alla cultura umana, ma portarle invece al loro compimento. È incredibile l'audacia e la modernità, oltre il sicuro valore apologetico, di questo pensiero di Giustino; una audacia e una modernità che non saranno infatti seguite da tutti i suoi successori e verranno anzi progressivamente sostituite, prima per gli eretici, poi per i non cristiani, dal principio che "extra Ecelesiam non est salus", e che solo in epoca relativamente recente sono state riproposte nell'idea dei "cristiani anonimi" di K. Rahner. Il suo stesso discepolo Taziano riprenderà anzi tutti gli argomenti della polemica contro la filosofia e la religione greche, portandoli alle più estreme conseguenze. Di che cosa traggono vanto i Greci? Se c'è qualcosa di buono che essi hanno creato lo hanno preso dai barbari. Ma in realtà non c'è nulla nella loro civiltà di veramente buono. La loro filosofia trasuda infatti soltanto immoralità e la loro legislazione rivela soltanto diversità e disordine. Tanto più Giustino ci appare come un modello del fare teologia nella tradizione. Egli non si allontana infatti dalla tradizione. È il primo autore a nostra conoscenza a parlare dei quattro vangeli che diventeranno canonici come le "memorie degli apostoli" su cui fondare la teologia ecclesiastica. E il concetto del 2 Logos, prima ancora che alla filosofia stoica, si richiama al quarto vangelo. È alla tradizione apostolica che Giustino fa quindi riferimento. Reinterpreta tuttavia la tradizione nel nuovo contesto della civiltà greco-­‐romana, aprendosi coraggiosamente al contributo migliore di questa civiltà. Uno studioso (R. Seeberg) ha parlato a proposito di questa posizione di Giustino di "imperialismo della religione cristiana", per quello che può apparire il tentativo del cristianesimo di appropriarsi di una tradizione culturale del tutto estranea ad esso. Ma è un giudizio senza senso. Giustino vuole dare alla tradizione giudeo-­‐cristiana che ha ricevuto una formulazione che la renda comprensibile ai suoi nuovi destinatari. E per far questo inserisce il cristianesimo in una più larga storia della umanità, leggendo quella tradizione all'interno di una teologia universale della storia che sa far proprie anche le intuizioni più feconde del pensiero greco. Più difficile e complesso è un altro punto della sua riflessione teologica, che egli ha sviluppato più tardi nel suo Dialogo con l'ebreo Trifone. Questo dialogo è una lunga esegesi dei passi più controversi della Scrittura giudaica. A differenza del suo contemporaneo Marcione, che propugnava l'abbandono di quella Scrittura da parte dei cristiani, per la sua incompatibilità col messaggio di Gesù, Giustino non ha infatti alcuna esitazione ad appropriarsi della Scrittura giudaica. Ma ne dà una spiegazione completamente diversa da quella dei Giudei. Pur innestandosi sul tronco della storia di Israele, l'evento di Cristo ha avuto infatti per lui un effetto rivoluzionario riguardo alla tradizione giudaica. Il Dio della Scrittura, che non è soltanto il Dio dei Giudei e della Legge, ma è il creatore del mondo e il signore della storia, è anche il Dio dei cristiani. E la Scrittura contiene indubbiamente la sua rivelazione. Ma il valore della Scrittura è essenzialmente di annunciare il Cristo. Negli eventi raccontati dalla Scrittura e nelle parole pronunciate dai profeti erano infatti prefigurate la vita e la predicazione di Gesù. Le prescrizioni date da Mosè ai Giudei e le istituzioni del popolo giudaico erano «figure, simboli e annunci [...] di quanto doveva accadere a Cristo». E, venuto Cristo, non hanno più valore. Le promesse fatte da Dio a Israele hanno trovato infatti il loro compimento e la loro realizzazione nel popolo cristiano, che è «la vera stirpe di Israele». E la Scrittura stessa va interpretata quindi in maniera del tutto diversa da come la interpretano i Giudei. Essa non ha un valore autonomo, ma rinvia alla rivelazione di Gesù. E un testo che non appartiene più quindi ai Giudei, ma di cui solo i cristiani posseggono la chiave. È facile oggi, con la nuova sensibilità che abbiamo nei confronti del popolo giudaico e dell'Antico Testamento, vedere i rischi di questa posizione. Appaiono già in sostanza nelle parole di Giustino la teoria della sostituzione, che toglie qualunque valore permanente alla storia di Israele, soppiantato ormai dalla Chiesa; e quella della praeparatio evangelica, che non attribuisce alcun valore autonomo all'Antico Testamento, realizzatosi ormai nel Nuovo; due teorie che troveranno infatti di lì a poco conclusioni durissime, e oggi per noi inaccettabili, nel pensiero di Melitone vescovo di Sardi. Il popolo giudaico, dirà infatti Melitone nella sua Omelia sulla Pasqua, era come lo schizzo di un progetto e la Chiesa è la sua realizzazione. Questo significa che «il popolo aveva il suo valore prima che la Chiesa fosse edificata e la legge era ammirabile prima che il vangelo cominciasse a splendere». Ma «quando il vangelo ha cominciato a splendere la legge è stata compiuta e quando la chiesa è stata edificata il popolo ha perso il suo valore». Non è soltanto la legge mosaica, è il popolo giudaico che non ha più valore. Sono anzi le stesse Scritture giudaiche che sono fatalmente "invecchiate". Dirà infatti Melitone che esse sono "i libri del vecchio patto" (palaia diatheké). E tuttavia sarebbe profondamente ingiusto, e comunque antistorico, condannare queste conclusioni, perché esse nascono da una valutazione dell'incarnazione del Logos come un evento che si pone non soltanto in continuità ma in rottura con la storia precedente, perché ha portato qualcosa di totalmente nuovo (kainós) rispetto al passato. È la coscienza fortissima della "novità" cristiana, che percorre da un capo all'altro il Dialogo con Trifone e l'Omelia sulla Pasqua (kainós è termine preferito di Giustino, e soprattutto di Melitone), a provocare infatti il 3 mancato riconoscimento del ruolo permanente di Israele e del valore autonomo della Scrittura. E giusto d'altra parte ricordare anche che Giustino non condanna coloro che vogliono restare fedeli alla legge giudaica. Egli sa infatti della esistenza di gruppi giudeocristiani che, leggendo in maniera tradizionale i testi della Scrittura, sono ancora attaccati alle osservanze giudaiche. E pur non condividendo la loro posizione, riconosce loro il diritto, purché restino in comunione con i loro fratelli, di conservare le loro tradizioni. Noi non possediamo purtroppo l'opera di Giustino contro Marcione, che dava inizio a quella letteratura che sarebbe stata definita eresiologica e che probabilmente cominciava quindi a elaborare i concetti stessi di eresia e ortodossia, anche se è comunque significativo che egli non sembra avere scritto un Adversus haereses, un libro quindi contro tutte le eresie, ma soltanto un Adversus Marcionem (come del resto ha scritto un Dialogo con Trifone, sulla interpretazione di determinati passi della Scrittura, non un Adversus ludaeos). Sono segnali di un modo di fare teologia che mira a risolvere problemi specifici, più che a introdurre indebite generalizzazioni. Stando comunque alle opere che possediamo, si può dire che quella di Giustino è una teologia fondamentalmente inclusiva, che cerca soprattutto di recuperare e valorizzare quanto c'è di buono nel pensiero umano, innestando sulla tradizione elementi storici nuovi senza necessariamente eliminare del tutto quelli passati. Un quarto di secolo più tardi la Chiesa si trova in una situazione molto diversa. Da un lato il processo di sistemazione dottrinale e di organizzazione ecclesiastica della nuova religione appare ormai compiuto. La scelta dei testi che costituiranno il Nuovo Testamento, pur tra incertezze e differenze non lievi, è sostanzialmente fatta. Proprio in questo periodo appaiono infatti, col cosiddetto frammento muratoriano e l'opera di Ireneo, le prime testimonianze di un elenco canonico di libri. E l'organizzazione ecclesiastica ha fatto passi enormi. Nella maggior parte delle chiese locali esiste una gerarchia fatta di vescovi, presbiteri e diaconi. E i rapporti tra queste chiese locali sono non soltanto assai intensi ma si esprimono anche per la prima volta in assemblee regionali aperte alla partecipazione di vescovi esterni. Nello stesso tempo, dopo un periodo difficile sotto Marco Aurelio, che ha conosciuto una recrudescenza di persecuzioni, soprattutto nella provincia d'Asia, la Chiesa gode sotto Commodo di una pace sostanziale. E non può non apprezzare le prospettive che si aprono alle comunità cristiane di una vita tranquilla e di una più agevole evangelizzazione. Ma la situazione interna del cristianesimo è diventata invece molto più difficile. Tendenze carismatiche e apocalittiche, tra cui in particolare il movimento della Nuova profezia, dal suo leader Montano detto del montanismo, tendono a recuperare, e a radicalizzare, in opposizione alla organizzazione ecclesiastica, lo spirito profetico originario della nuova religione. E soprattutto si è diffuso enormemente, fuori ma anche dentro la Chiesa, lo gnosticismo: una dottrina dualistica che nella tradizione apostolica minaccia di introdurre dovunque la divisione: tra il Dio di Israele e il Dio dei cristiani, tra la Scrittura giudaica e gli scritti apostolici, tra l'umanità di Gesù e la divinità del Cristo, tra l'insegnamento pubblico dei vescovi e quello segreto dei propri maestri. Non è più il momento di aprire nuove strade alla riflessione teologica. Sembra giunto invece il momento di indicare i confini precisi della tradizione, respingendo decisamente questo pensiero che rischia di distruggere l'unità della Chiesa e la certezza della sua dottrina. E il vescovo di Lione Ireneo, originario probabilmente di Smirne e allievo del vescovo quartodecimano Policarpo, ma radicato ormai in ambienti vicini alla chiesa di Roma, scrive Adversus haereses, la prima grande opera eresiologica cristiana, dando impulso fortissimo a un genere letterario che era già nato con lo stesso Giustino e che conoscerà in seguito enorme fortuna. Ireneo può essere definito a ragione il primo grande teologo della tradizione, e più esattamente il primo grande assertore della tradizione apostolica. La sua opera altro non vuole essere infatti se non l'esposizione sistematica di un insegnamento che ha il suo fondamento e trova la garanzia della propria autenticità nella dottrina degli apostoli. Ma è probabilmente opportuno distinguere due ambiti diversi della sua riflessione teologica. 4 Contro Marcione e gli gnostici egli è anzitutto il teologo della continuità e della unità. Contro Marcione, che contrapponeva il Dio creatore di Israele al Dio redentore dei cristiani, e rilevava tutte le antitesi (è questo il titolo della sua opera principale) tra l'Antico e il Nuovo Testamento, ha riaffermato l'unità di Dio e la continuità dei testamenti. Non esistono due dei, ma un solo Dio governa la storia conducendola dalla creazione di Adamo all'evento di Cristo. E c'è continuità, non contrapposizione, tra l'Antico e il Nuovo Testamento. I precetti fondamentali dell'uno sono identici a quelli dell'altro. E Cristo non ha quindi abolito la legge mosaica, ma la ha completata. Di più. La storia non è finita con l'avvento di Cristo, come ritengono alcuni carismatici entusiasti, ma continua fino alla instaurazione futura del regno di Dio. E questa instaurazione sarà preceduta da un periodo di mille anni di regno dei giusti con Cristo sulla terra (il millenarismo di ispirazione apocalittica è il legame conservato da Ireneo con una tradizione specificamente asiatica e che lo contrappone nettamente alla successiva teologia alessandrina). Un'unica linea di sviluppo conduce dalla creazione del mondo al regno futuro. E contro gli gnostici valentiniani, che dividevano la figura di Cristo, parlando di un Gesù terreno nato da Maria e di un Cristo celeste disceso dall'alto, e di una passione e risurrezione puramente apparente di questo Cristo, Ireneo ha affermato anzitutto l'unità della figura di Cristo. Non ci sono un Gesù terreno e un Cristo celeste, ma c'è un solo Cristo, che è il Logos di Dio incarnatosi nel seno di Maria, realmente morto e realmente risuscitato. Ma ha anche rilevato il nesso assai stretto che c'è nel pensiero gnostico tra la cristologia, la cosmologia e l'antropologia. Gli gnostici negano l'incarnazione di Cristo perché condannano il mondo materiale, che non è destinato alla salvezza. Ma Cristo invece si è realmente incarnato e non lo avrebbe fatto se la carne non fosse destinata anch'essa alla salvezza. E questo il motivo per cui Ireneo respinge con estrema durezza l'orientamento di Taziano e dei cosiddetti encratiti che con la loro condanna del matrimonio e il loro rifiuto di ogni convivenza civile svalutano gravemente il mondo materiale. La creazione è opera di Dio ed è sostanzialmente buona. È questo probabilmente l'aspetto più convincente della teologia di Ireneo, quello in cui il suo ripensamento della tradizione appare più aperto a soluzioni future. Sollecitato dalle negazioni del pensiero gnostico, che escludono dalla salvezza intere parti del mondo umano e materiale, egli sente il bisogno di riaffermare il carattere onnicomprensivo della salvezza portata da Cristo. Non c'è nulla nel mondo umano e materiale che rimanga fuori dall'azione salvifica di Cristo. E per far questo Ireneo utilizza in maniera originale un concetto preso dalla tradizione apostolica: l'idea paolina della ricapitolazione di tutte le cose in Cristo. Cristo ha assunto, e ricapitolato, in sé l'intera creazione, liberandola dal peccato. Un ripensamento della tradizione che, messo a confronto con i problemi nuovi posti dallo gnosticismo, ne sviluppa coraggiosamente le potenzialità in essa implicite. Già qui tuttavia l'opera di Ireneo si caratterizza anche per un certo irrigidimento e per troppe esclusioni. A determinarli è la scelta stessa di un genere letterario, quello eresiologico (il suo è il primo Adversus haereses da noi conosciuto), i cui rischi sono evidenti. L'enunciazione dei principi dottrinali avviene sempre in contrapposizione alle tesi degli eretici. E non è ricerca di nuove soluzioni, come sarà per esempio di lì a poco il pensiero di un altro grande teologo, Origene. È affermazione di dottrine che tendono a delimitare con chiarezza i confini di una possibile riflessione teologica. È Ireneo che, con questa opera, dà un significato preciso al concetto di eresia, e al termine stesso hairesis. Questo comporta in maniera inevitabile il rischio di un irrigidimento: con un procedimento che diventerà tipico della letteratura eresiologica, mediante collegamenti e successioni spesso del tutto arbitrari, egli non distingue tra i vari eretici e include tra loro chi non lo è affatto. Così, perché negano la salvezza di Adamo e la bontà del matrimonio, Taziano e gli encratiti diventano per lui gnostici, e quindi eretici. E anche gli entusiasti che vedono nell'avvento di Cristo la fine della storia sono accostati agli gnostici. In realtà, sono tutti gli atteggiamenti ancora molto diffusi di rifiuto del mondo che non trovano in lui nessuna comprensione. 5 Ma Ireneo è anche, e soprattutto, il teologo della Scrittura e della tradizione: di un rapporto anzi tra la Scrittura e la tradizione che fino a qualche decennio fa (oggi forse un po' meno) poteva farlo indicare da qualche studioso come l'ultimo rappresentante di una concezione della Scrittura e della tradizione che non conosce alcuna frattura fra di esse ed è in grado quindi di mettere d'accordo cattolici e protestanti. Contro la manipolazione marcionita dei testi cristiani e il carattere esoterico dello gnosticismo egli ha riaffermato in effetti due principi fondamentali per la lettura e l'interpretazione della Scrittura: il rispetto dei testi nella loro unità materiale e l'esigenza di una loro lettura ecclesiale. I profeti montanisti, ma soprattutto Marcione e gli gnostici, leggono la Scrittura tagliandone arbitrariamente i libri e aggiungendo le proprie rivelazioni ai testi tramandati. Ma la Scrittura non tollera queste manipolazioni. La Scrittura è soltanto una. I testi che ad essa appartengono sono quelli consegnati alla Chiesa dalla tradizione apostolica (Ireneo, come ho detto, è anche il primo autore, col frammento muratoriano, a testimoniare l'esistenza di un canone neotestamentario quasi completo). La loro interpretazione autentica non è affidata a nuove rivelazioni di individui carismatici o a insegnamenti segreti di falsi maestri, ma è quella garantita dalle autorità episcopali che a partire dagli apostoli si sono succedute nelle diverse chiese (Ireneo fa qui riferimento esplicito alle liste episcopali che in ogni chiesa, a suo dire, testimoniano questa ininterrotta successione). E a maggiore garanzia della permanenza della Chiesa nella fedeltà alla tradizione apostolica tra le autorità episcopali ve n'è una che per la sua potentior principalitas, cioè la sua più eminente antichità, soprattutto garantisce l'integrità e l'autenticità della Scrittura: la chiesa di Roma fondata da Pietro e Paolo (tutti conoscono il passo famoso dell’Adversus haereses in cui appare questa affermazione: «Ad hanc enim ecclesiam propter potentiorem principalitatem necesse est omnem convenire ecclesiam, hoc est eos qui sunt undique fideles»). E qui è difficile a mio parere non cogliere i rischi di una riflessione teologica che non si limita a respingere i criteri dottrinali di Marcione e degli gnostici, ma appare preoccupata soprattutto di indicare i confini precisi della tradizione contro ogni possibile deviazione interna. La teologia di Ireneo è infatti il primo tentativo di una esposizione organica del pensiero cristiano. E ha indubbiamente qualcosa di grandioso. Ireneo è l'interprete più autorevole di quel processo di sistemazione dottrinale e di organizzazione ecclesiastica che A. Harnack definì a suo tempo la "cattolicizzazione" della Chiesa uscita vittoriosa dalla lotta contro il montanismo e lo gnosticismo: la nascita cioè di una Chiesa universale, fornita ormai di una dottrina condivisa, di un culto uniforme e di una organizzazione gerarchica. E sarebbe anche ingiusto in questa opera di sistemazione cercare soluzioni particolarmente coraggiose e originali ai problemi teologici posti alla tradizione dalle posizioni gnostiche. Ireneo è un vescovo e scrive per i fedeli comuni, non per gli intellettuali. La sua teologia è preoccupata quindi soprattutto di offrire ai cristiani il quadro completo e chiaro delle dottrine e delle nonne. Diffida invece apertamente di coloro che si interrogano continuamente su problemi teologici di impossibile soluzione. È l'espressione di una Chiesa che più che ricercare nuove soluzioni teologiche tende a delimitare i confini della propria tradizione. Ma è proprio questo che in più di un caso finisce con l'impoverire la sua riflessione teologica. La fissazione di un canone neotestamentario era in qualche modo resa necessaria dal pullulare di scritti che pretendevano rifarsi alla tradizione apostolica; e in una certa misura può accogliersi anche la tesi fino a non molti decenni fa dominante tra gli studiosi per cui, più che le chiese a scegliere i testi, sarebbero stati i testi stessi a imporsi con la loro autorità alle diverse chiese. Ma ha introdotto una separazione netta tra libri canonici e libri apocrifi, che avrebbe fatalmente portato a considerare questi ultimi quasi sempre come eretici. L'affermazione della autorità dei vescovi nella interpretazione della Scrittura era altrettanto necessaria di fronte alla pretesa di esegesi carismatiche e rivelazioni segrete da parte dei maestri gnostici, ma il suo carattere di esclusivo charisma veritatis certum, garantito dal principio della successione episcopale, ha impoverito la riflessione sulla tradizione. Tipico è il caso del carisma profetico 6 che, pur riconosciuto come ancora presente nella Chiesa contro coloro che per combattere la falsa profezia arrivano a mettere in discussione il Vangelo stesso di Giovanni, di fronte al pericolo del montanismo viene considerato tuttavia da Ireneo con un certo sospetto e sostanzialmente assorbito nella stessa funzione episcopale. E per quanto oggi si tenda spesso a ridimensionarne la portata, l'affermazione di una preminenza della chiesa di Roma sulle altre chiese, che segna il vero inizio del primato romano, ha contribuito alla scomparsa di tradizioni locali antiche. Non a caso Ireneo, che pure da discepolo di Policarpo era stato quasi certamente quartodecimano (osservante cioè del 14 nisan) nella celebrazione della pasqua, aderisce all'orientamento romano contrario a questa tradizione, anche se critica poi la decisione del vescovo di Roma Vittore di non tollerare più l'esistenza di una tradizione evangelica differente da quella di Roma. Posso allora concludere qui questa esposizione rapidissima e necessariamente incompleta. Giustino e Ireneo mi sembrano due esponenti tipici, e profondamente diversi tra loro, di quel fare teologia nella tradizione che è oggetto del convegno. Hanno un punto in comune: ripensano ed elaborano la tradizione guardando attentamente al contesto storico nel quale si trovano; esprimono quindi in maniera evidente l'esigenza che il ripensamento e lo sviluppo della tradizione avvengano nel confronto costante con le nuove realtà storiche. Ma reagiscono in maniera profondamente diversa. Trovandosi in un contesto storico che gli appare ricco di nuove potenzialità Giustino pensa che la tradizione cristiana possa e debba allargare i propri confini, appropriandosi coraggiosamente di quegli elementi di pensiero che appaiono conciliabili con essa. E cerca un punto di incontro tra il messaggio cristiano e la cultura greca. Trovandosi di fronte alla presenza di un pensiero che gli appare terribilmente minaccioso per l'esistenza della Chiesa, Ireneo pensa invece che la Chiesa debba anzitutto fissare chiaramente i propri confini e difendere l'autenticità della propria dottrina. E condanna non soltanto gli gnostici, ma tutti coloro che gli appaiono troppo vicini alle loro posizioni. Se Giustino è per così dire all'offensiva nei confronti del pensiero greco, e decisamente aperto al futuro, Ireneo è invece sulla difensiva nei confronti di quello gnostico, e preoccupato di tutelare il presente. È difficile dire chi dei due abbia svolto un compito teologico migliore. Personalmente tuttavia sono convinto che non è il timore del confronto col diverso che debba guidare la riflessione teologica, ma il coraggio di misurarsi con esso, prospettando e proponendo nuove soluzioni. Mi sembra infatti che l'esperienza storica, anche proprio questa del passaggio dalla età apostolica alla età postapostolica, dimostri che l'incontro della tradizione con la storia sia sempre occasione non soltanto di crisi ma anche di opportunità e contribuisca in ultima analisi a una più autentica comprensione della tradizione stessa. 7