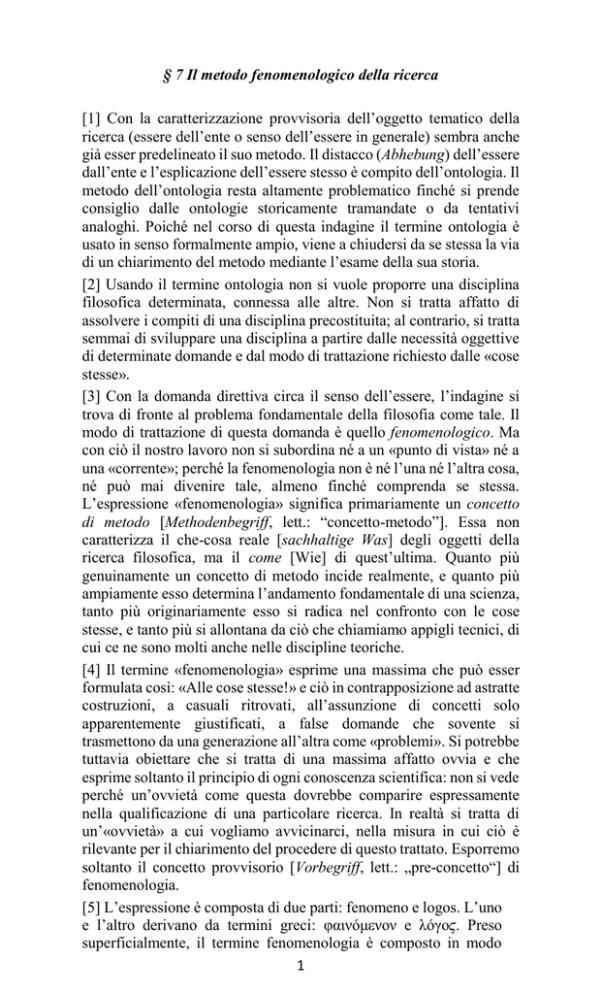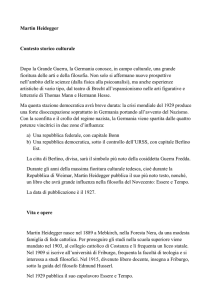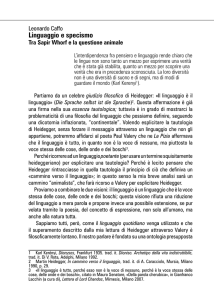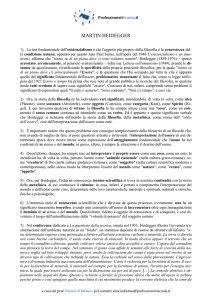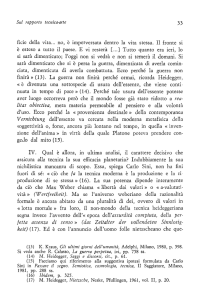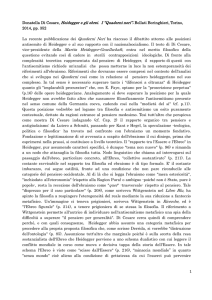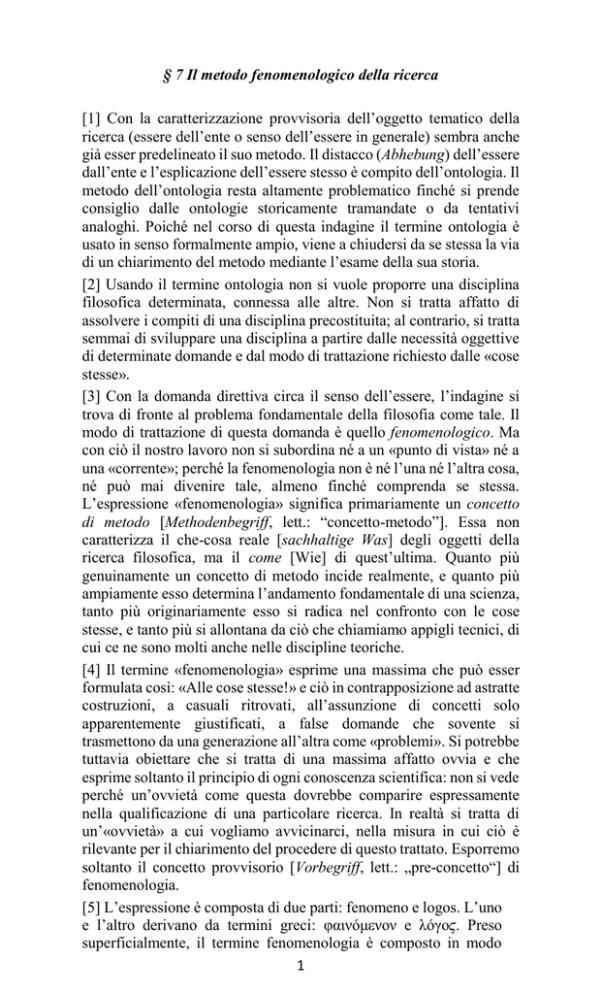
§ 7 Il metodo fenomenologico della ricerca
[1] Con la caratterizzazione provvisoria dell’oggetto tematico della
ricerca (essere dell’ente o senso dell’essere in generale) sembra anche
già esser predelineato il suo metodo. Il distacco (Abhebung) dell’essere
dall’ente e l’esplicazione dell’essere stesso è compito dell’ontologia. Il
metodo dell’ontologia resta altamente problematico finché si prende
consiglio dalle ontologie storicamente tramandate o da tentativi
analoghi. Poiché nel corso di questa indagine il termine ontologia è
usato in senso formalmente ampio, viene a chiudersi da se stessa la via
di un chiarimento del metodo mediante l’esame della sua storia.
[2] Usando il termine ontologia non si vuole proporre una disciplina
filosofica determinata, connessa alle altre. Non si tratta affatto di
assolvere i compiti di una disciplina precostituita; al contrario, si tratta
semmai di sviluppare una disciplina a partire dalle necessità oggettive
di determinate domande e dal modo di trattazione richiesto dalle «cose
stesse».
[3] Con la domanda direttiva circa il senso dell’essere, l’indagine si
trova di fronte al problema fondamentale della filosofia come tale. Il
modo di trattazione di questa domanda è quello fenomenologico. Ma
con ciò il nostro lavoro non si subordina né a un «punto di vista» né a
una «corrente»; perché la fenomenologia non è né l’una né l’altra cosa,
né può mai divenire tale, almeno finché comprenda se stessa.
L’espressione «fenomenologia» significa primariamente un concetto
di metodo [Methodenbegriff, lett.: “concetto-metodo”]. Essa non
caratterizza il che-cosa reale [sachhaltige Was] degli oggetti della
ricerca filosofica, ma il come [Wie] di quest’ultima. Quanto più
genuinamente un concetto di metodo incide realmente, e quanto più
ampiamente esso determina l’andamento fondamentale di una scienza,
tanto più originariamente esso si radica nel confronto con le cose
stesse, e tanto più si allontana da ciò che chiamiamo appigli tecnici, di
cui ce ne sono molti anche nelle discipline teoriche.
[4] Il termine «fenomenologia» esprime una massima che può esser
formulata così: «Alle cose stesse!» e ciò in contrapposizione ad astratte
costruzioni, a casuali ritrovati, all’assunzione di concetti solo
apparentemente giustificati, a false domande che sovente si
trasmettono da una generazione all’altra come «problemi». Si potrebbe
tuttavia obiettare che si tratta di una massima affatto ovvia e che
esprime soltanto il principio di ogni conoscenza scientifica: non si vede
perché un’ovvietà come questa dovrebbe comparire espressamente
nella qualificazione di una particolare ricerca. In realtà si tratta di
un’«ovvietà» a cui vogliamo avvicinarci, nella misura in cui ciò è
rilevante per il chiarimento del procedere di questo trattato. Esporremo
soltanto il concetto provvisorio [Vorbegriff, lett.: „pre-concetto“] di
fenomenologia.
[5] L’espressione è composta di due parti: fenomeno e logos. L’uno
e l’altro derivano da termini greci: φαινόμενον e λόγοϛ. Preso
superficialmente, il termine fenomenologia è composto in modo
1
analogo a teologia, biologia, sociologia, che noi rendiamo
solitamente con scienza di Dio, della vita, della società. In tal caso,
fenomenologia verrebbe a significare scienza dei fenomeni. Il
concetto provvisorio [Vorbegriff] di fenomenologia deve essere
costruito attraverso la caratterizzazione di ciò che si intende coi due
termini che lo compongono: «fenomeno» e «logos», e attraverso la
fissazione del senso del nome da essi composto. La storia della
parola stessa, che nasce presumibilmente nella scuola di Wolff, non
ha qui importanza.
A - Il concetto di fenomeno
[6] L’espressione greca φαινόμενον, a cui risale il termine
«fenomeno», deriva dal verbo φαίνεσθαι che significa manifestarsi
[sich zeigen]; φαινόμενον significa quindi ciò che si manifesta, il
manifestantesi [das Sichzeigende], il manifesto [das Offenbare];
φαίνεσθαι stesso è una forma verbale medio-passiva di φαίνω,
illuminare, porre in chiaro; φαίνω deriva dalla radice φα come φῶϛ, la
luce, il chiaro, ossia ciò in cui qualcosa può manifestarsi, può rendersi
visibile in se stesso. Quale significato dell’espressione «fenomeno», è
da tener fermo: ciò-che-si-manifesta-in-se-stesso- [das Sich-an-ihmselbst-zeigende] il manifesto [das Offenbare]. I φαινόμενα, i
«fenomeni», sono dunque la totalità [Gesamtheit] di ciò che sta alla
luce del giorno oppure che può essere portato alla luce, ciò che i greci
a volte identificarono [identifizierten, lett.: “resero identico”]
semplicemente con τὰ ὄντα (l’ente). L’ente può dunque manifestarsi
da se stesso in maniere diverse, a seconda del rispettivo modo di
accesso a esso. Si dà persino la possibilità che l’ente si manifesti come
ciò che esso in se stesso non è. In questo manifestarsi l’ente «pare così
come…». Tale manifestarsi noi lo chiamiamo sembrare [Scheinen,
“parere"]. Così anche in greco l’espressione φαινόμενον, fenomeno, ha
il significato di ciò che sembra in un determinato modo, «il parvente»
[das »Scheinbare«], la «parvenza» [der »Schein«]; φαινόμενον ἀγαθόν
vuol dire un bene che pare essere tale ma che, in «realtà», non è ciò per
cui si spaccia. Per una più ampia comprensione del concetto di
fenomeno tutto sta nel vedere come ciò che è nominato nei due
significati di fenomeno («fenomeno» come ciò che si manifesta e
«fenomeno» come parvenza) si connetta strutturalmente. Soltanto
perché qualcosa, in base al suo senso, pretende di manifestarsi, cioè di
esser fenomeno, esso può manifestarsi come qualcosa che esso non è,
cioè può «solo sembrare così come…». In questo significato di
φαινόμενον («parvenza») è già incluso il significato originario
(fenomeno: il manifesto) come fondante il secondo. All’espressione
«fenomeno» assegniamo terminologicamente il significato positivo e
originario di φαινόμενον e distinguiamo fenomeno da parvenza,
considerando la seconda come modificazione privativa del primo.
Entrambi i termini esprimono però qualcosa [was] che, innanzi tutto,
2
non ha nulla a che fare con ciò che si usa chiamare «apparizione»
[Erscheinung] o addirittura «mera apparizione».
[7] In questo senso si parla dei «sintomi patologici»
[»Krankheitserscheinungen«]. Si intendono eventi del corpo che si
manifestano [sich zeigen] e che, nel manifestarsi come questi
manifestantisi, fanno da «indizi» di qualcosa che a sua volta non si
manifesta. L’insorgere di tali eventi, il loro manifestarsi, è associata
alla semplice presenza di disturbi che non si manifestano. Apparizione
come apparizione «di qualcosa» non significa dunque affatto:
manifestare se stesso, ma: annunciarsi di qualcosa che non si manifesta,
mediante qualcosa che si manifesta. L’apparire [Erscheinen] è16n un
non-manifestarsi. Ma questo «non» non deve assolutamente venir
confuso col «non» privativo che come tale caratterizza la struttura della
parvenza. Ciò che non si manifesta in quel modo, in cui l’apparente
[das Erscheinende] non si manifesta, non può mai neppure sembrare
[scheinen]. Indicazioni, presentazioni (Darstellungen), sintomi,
simboli, per quanto molto diversi fra di loro, hanno tutti questa struttura
formale fondamentale dell’apparire (Erscheinen).
[8] Benché l’«apparire» (»Erscheinen«) non sia mai un manifestarsi
nel senso del fenomeno, esso è tuttavia possibile soltanto sul
fondamento di un manifestarsi di qualcosa. Ma questo manifestarsi che
assieme rende possibile l’apparire, non è l’apparire stesso. Apparire è:
annunciarsi mediante qualcosa che si manifesta. Quando allora si dice:
con la parola «apparizione» (Erscheinung) rinviamo a qualcosa in cui
qualcosa appare senza essere esso stesso apparizione, con ciò non
abbiamo delimitato (umgrenzt, “circoscritto”) il concetto di fenomeno,
lo abbiamo bensì presupposto; e tale presupposizione rimane però
occultata [verdeckt], perché in questa determinazione di «apparizione»
[»Erscheinung«] l’espressione «apparire» (»erscheinen«) è usata in
duplice senso. Ciò in cui qualcosa «appare», significa ciò in cui
qualcosa si annuncia, ovvero non si manifesta; mentre nel discorso
[Rede]: «senza essere esso stesso ‘apparizione’», la parola
«apparizione» significa il manifestarsi. Ma questo manifestarsi
appartiene in modo essenziale a quell’«in cui» (Worin) entro il quale
qualcosa si annuncia. Dunque, i fenomeni non sono mai apparizioni,
anche se ogni apparizione è dipendente da fenomeni. Se si definisce il
fenomeno con l’ausilio di un concetto ancora oscuro di «apparizione»,
tutto è messo sottosopra e una «critica» della fenomenologia su queste
basi diviene una impresa ben stramba.
[9] La stessa espressione «apparizione» può, di nuovo, avere un
significato duplice: da un lato, [può significare] l’apparire nel senso
dell’annunciarsi come non manifestarsi, e dall’altro l’annunciante
stesso che, nel suo manifestarsi, indica [anzeigt] qualcosa di non
manifestantesi. E, infine, il termine apparire può essere usato per
significare il senso genuino di fenomeno come manifestarsi. Se si
designano questi tre diversi stati di cose con il termine «apparizione»,
la confusione diventa allora inevitabile.
3
[10] Ma la confusione è in più aggravata in modo essenziale dal fatto
che «apparizione» può assumere un altro significato ancora. Se
l’annunciante che nel suo manifestarsi indica [anzeigt] il nonmanifesto è inteso come qualcosa che sorge dal non-manifesto stesso,
da questo si irradia, in modo tale che il non-manifesto sia concepito
come non mai manifestabile per essenza, in questo caso apparizione
significa produzione o prodotto, tale però da non esprimere l’essere
autentico del produttore: apparizione nel senso di «semplice
apparizione». L’annunciante così prodotto manifesta certamente se
stesso, ma in modo tale che, in quanto irradiazione di ciò che annuncia,
lo vela costantemente in se stesso. Ma questo velante non manifestare
non è, di nuovo, parvenza. Kant usa il termine Erscheinung in questa
combinazione di significati. Erscheinungen sono per lui, da un lato, gli
«oggetti dell’intuizione empirica», ciò che in questa si manifesta.
Questo manifestantesi (fenomeno nel senso genuino e originario) è, nel
contempo, «apparizione» come annunciante irradiazione di qualcosa
che nell’apparizione si nasconde.
[11] Poiché per l’«apparizione», nel significato dell’annunciarsi
mediante un manifestantesi, è costitutivo un fenomeno, ma questo può
però modificarsi in parvenza (Schein), anche l’apparizione può
diventare una semplice parvenza. In una particolare illuminazione un
individuo può parere tale da avere le guance rosse: questo rossore
manifestantesi può esser preso per l’annuncio della presenza di febbre,
la quale, a sua volta, indicherebbe, di nuovo, un’indisposizione
dell’organismo.
[12] Fenomeno, il manifestarsi-in-se-stesso, significa un modo di
incontro eminente (ausgezeichnet) di qualcosa. Apparizione
[Erscheinung], invece, significa un essente rapporto di rimando
nell’ente stesso, tale per cui il rimandante (l’annunciante) è in grado di
assolvere la sua funzione possibile solo se si manifesta in se stesso, se
è «fenomeno». Apparizione (Erscheinung) e parvenza (Schein) sono
essi stessi, in modo diverso, fondati nel fenomeno. La disorientante
molteplicità di «fenomeni» che vanno sotto il nome di fenomeno,
parvenza, apparizione, semplice apparizione, può essere riordinata solo
se è fin dall’inizio compreso il concetto di fenomeno: il manifestantesiin-se-stesso.
[13] Se, in questa accezione del concetto di fenomeno, resta
indeterminato quale ente venga chiamato in causa come fenomeno, e
se resta in generale indeciso se il manifestantesi è ogni volta un ente o
un carattere d’essere dell’ente, allora non si è raggiunto che il concetto
formale di fenomeno. Quando, però, si comprende il manifestantesi,
come ad esempio in Kant, nel senso dell’ente a cui si accede mediante
l’intuizione empirica, allora in questo caso il concetto formale di
fenomeno giunge ad una applicazione legittima [rechtmäßigen
Anwendung]. Fenomeno in questo uso soddisfa [erfüllt] il concetto
ordinario di fenomeno. Tale concetto ordinario non è però il concetto
fenomenologico di fenomeno. Nell’orizzonte della problematica
kantiana, quel che si intende fenomenologicamente per fenomeno può
4
essere illustrato (facendo riserva per altre differenze) dicendo: ciò che
nelle apparizioni (Erscheinungen), nel fenomeno in senso ordinario,
ogni volta si manifesta preliminarmente e contemporaneamente,
benché non tematicamente, può essere portato tematicamente al
manifestarsi: e questo così-manifestantesi-in-se-stesso (le «forme
dell’intuizione») sono i fenomeni della fenomenologia. Giacché è
evidente che spazio e tempo debbono potersi manifestare a questo
modo, ossia debbono poter divenire fenomeni, se Kant, affermando che
lo spazio è l’in-cui [Worinnen] apriori di un ordine, pretende di
formulare una asserzione trascendentale fondata nella cosa stessa
[sachbegruendete Aussage].
[14] Ma se, ora, il concetto fenomenologico di fenomeno va compreso
in quanto tale, prescindendo dal modo cui il manifestantesi possa più
da vicino venir determinato, allora, indispensabile presupposto è il
coglimento evidente [Einsicht] del senso del concetto formale di
fenomeno e della sua applicazione legittima in un significato ordinario.
Prima di poter fissare il concetto preliminare [Vorbegriff] di
fenomenologia, occorre delimitare il significato di λόγοϛ, affinché sia
chiaro in quale senso la fenomenologia possa in generale essere una
«scienza di» fenomeni.
B - Il concetto di logos
[15] In Platone e Aristotele il concetto di λόγοϛ è plurivoco, e
precisamente in modo tale che i diversi significati vanno uno da una
parte, uno dall’altra, senza essere guidati positivamente da un
significato fondamentale [Grundbedeutung]. Questa è di fatto soltanto
apparenza [Schein], che si mantiene finché l’interpretazione
[Interpretation] è in grado di afferrare non adeguatamente il significato
fondamentale nel suo contenuto primario. Se noi diciamo: il significato
fondamentale [Grundbedeutung] di λόγοϛ è discorso [Rede], allora
questa traduzione letterale diventerà pienamente valida soltanto
muovendo dalla determinazione di ciò che discorso stesso significa. La
più tarda storia semantica [Bedeutungsgeschichte] della parola λόγοϛ
e, soprattutto, le diverse e arbitrarie interpretazioni della filosofia
successiva occultano [verdecken] costantemente il significato
autentico [eigentliche Bedeutung] di discorso, che è manifesto in modo
abbastanza aperto. Λόγοϛ è «tradotto», cioè sempre interpretato, come
ragione, giudizio, concetto, definizione, fondamento, relazione. Ma
come può «discorso» modificarsi così che λόγοϛ significhi tutto ciò che
è stato enumerato, e per di più nell’ambito di un uso linguistico di
carattere scientifico? Anche quando si intende λόγοϛ nel senso di
asserzione, l’asserzione, però, nel senso di «giudizio», con questa
traduzione apparentemente legittima, il significato fondamentale
[Grundbedeutung] può venir mancato [verfehlt], specialmente se
giudizio è concepito nel senso di qualcuna delle attuali «teorie del
giudizio». Λόγοϛ non significa e comunque non significa
5
primariamente giudizio, se si comprende con ciò un «collegare» o un
«prender posizione» (riconoscere o respingere).
[16] Λόγοϛ, in quanto discorso, significa piuttosto qualcosa come
δηλοῦν, render manifesto ciò di cui, nel discorso, «il discorso» è.
Aristotele ha esplicato più precisamente questa funzione del discorso
come ἀποφαίνεσθαι (cfr. de interpretatione cap. 1-6. Inoltre Met. Z. 4
e Eth. Nic. Z.) Il λόγοϛ fa vedere (φαίνεσθαι) qualcosa, ovvero ciò su
cui il discorso verte; e precisamente lo fa vedere per i discorrenti
(forma verbale mediopassiva) ossia per coloro che discorrono fra di
loro. Il discorso «lascia vedere» ἀπὸ…, a partire da ciò stesso di cui si
discorre. Nel discorso (ἀπόφανσιϛ), nella misura in cui esso è genuino,
ciò che [was] è detto deve esser attinto muovendo da ciò intorno a cui
si discorre, in modo che la comunicazione discorsiva, in ciò che è detto,
renda manifesto e come tale accessibile agli altri ciò intorno a cui
discorre. Questa è la struttura del λόγοϛ in quanto ἀπόφανσιϛ. Questo
modo del render manifesto nel senso del far vedere esibendo. La
preghiera (εὐχή), ad esempio, è anch’essa un render manifesto, ma in
un altro modo.
[17] Nel compimento [Vollzug] concreto il discorrere (far vedere) ha il
carattere del parlare, della verbalizzazione vocale in parole. Il λόγοϛ è
φωνή, e precisamente φωνή μετὰ φαντασίαϛ, verbalizzazione vocale in
cui qualcosa è ogni volta visto.
[18] Ed è soltanto perché la funzione del λόγοϛ come ἀπόφανσιϛ
consiste nel far vedere qualcosa mostrando, che il λόγοϛ può avere la
forma strutturale della σύνθεσιϛ. Sintesi non significa qui collegamento
e connessione di rappresentazioni, manipolazione di eventi psichici,
nei cui riguardi nasca poi il «problema» della concordanza di essi, in
quanto interni, coi fatti fisici esterni. Qui il συν ha un significato
prettamente apofantico e significa: lasciar vedere qualcosa nel suo
essere insieme a qualcosa, lasciar vedere qualcosa in quanto qualcosa.
[19] E di nuovo, poiché il λόγοϛ è un lasciar vedere, per questo esso
può essere vero o falso. Anche qui tutto sta nel liberarsi da un concetto
artificioso di verità nel senso di una «concordanza». Questa idea non è
per nulla l’elemento primario del concetto di ἀλήθεια. L’«esser vero»
del λόγοϛ, in quanto ἀληθεύειν, significa: nel λέγειν, in quanto
ἀποφαίνεσθαι, trarre fuori l’ente, di cui è il discorso, dal suo esser
nascosto (Verborgenheit) e lasciarlo vedere come non nascosto
[Unverborgenes]
(ἀληθέϛ),
scoprirlo
[entdecken,
lett.:
“disoccultarlo”]. Corrispondentemente l’«esser falso», ψεύδεσθαι,
vuol dire ingannare nel senso di occultare [verdecken]: porre (nel modo
del lasciar vedere) qualcosa dinanzi a qualcosa e spacciarla in quanto
qualcosa che essa non è.
[20] Poiché però «verità» ha questo senso e il λόγοϛ è un modo
determinato del lasciar vedere, il λόγοϛ non può affatto esser
considerato il «luogo» primario della verità. Quando, come oggi ormai
tutti fanno, la verità è definita come ciò che appartiene «propriamente»
al giudizio, facendo per di più risalire questa tesi ad Aristotele, si cade
in un duplice errore: perché il richiamo ad Aristotele è infondato e
6
perché, soprattutto, il concetto greco di verità è frainteso. «Vero» in
senso greco, certo più originariamente del λόγοϛ suddetto, è la
αἴσθησιϛ, la diretta apprensione sensibile di qualcosa. Poiché una
αἴσθησιϛ mira ogni volta ai propri ἴδια, cioè all’ente genuinamente
accessibile solo mediante essa e per essa (ad esempio, il vedere ai
colori), l’apprensione è sempre vera. Il che significa: il vedere scopre
sempre colori, l’udire scopre sempre suoni. «Vero», nel senso più puro
e originario, cioè esclusivamente scoprente, cosicché non possa mai
occultare, è il puro νοεῖν, l’apprendere, direttamente osservante, delle
più semplici determinazioni d’essere dell’ente come tale. Questo νοεῖν
non può mai occultare, non può mai esser falso; potrà, tutt’al più,
restare un non apprendere, un ἀγνοεῖν, non essere sufficiente
all’accesso diretto, adeguato.
[21] Ciò che non ha più la forma di attuazione [Vollzugsform] del puro
lasciar vedere, ma che, nel mostrare, ricorre di volta in volta a
qualcos’altro e fa così vedere qualcosa in quanto qualcosa, assume, con
questa struttura sintetica, la possibilità dell’occultare [Verdecken]. La
«verità del giudizio», comunque, non è che il contrario di questo
occultare [Verdecken], cioè un fenomeno di verità fondato per più
aspetti. Realismo e idealismo, con pari fondamentalità, mancano il
senso del concetto greco di verità, in base al quale soltanto è possibile
comprendere la possibilità di qualcosa come una «dottrina delle idee»
quale conoscenza filosofica.
[22] Proprio perché la funzione del λόγοϛ sta nel diretto lasciar vedere
qualcosa, nel lasciar apprendere l’ente, il λόγοϛ può significare
ragione. E proprio perché, di nuovo, λόγοϛ viene usato non soltanto
nel significato di λέγειν ma ugualmente in quello di λεγόμενον (il
mostrato [das Aufgezeigte] come tale), e poiché questo è null’altro che
l’ὑποκεί- μενον (ciò che in ogni interpellare e discutere sta già ogni
volta, come semplicemente presente, a fondamento), il λόγοϛ, in quanto
λεγόμενον, significa fondamento [Grund], ratio. E infine, poiché
λόγοϛ in quanto λεγόμενον può anche significare ciò che è chiamato in
questione in quanto qualcosa che diviene visibile mediante la sua
relazione a qualcosa, mediante la sua «relazionalità», λόγοϛ assume il
significato di relazione e rapporto.
[23] Questa interpretazione del «discorso apofantico» può bastare per
il chiarimento della funzione primaria del λόγοϛ.
C - Il concetto preliminare [Vorbegriff] di fenomenologia
[24] Tenendo concretamente presente il prodotto dell’interpretazione
di «fenomeno» e di «logos», salta subito agli occhi l’intima
connessione tra ciò che è inteso con questi due termini. L’espressione
fenomenologia può essere formulata grecamente: λέγειν τὰ φαινόμενα;
λέγειν però significa ἀποφαίνεσθαι. Fenomenologia significa allora
7
ἀποφαίνεσθαι τὰ φαινόμενα: lasciar vedere da se stesso ciò che si
manifesta, così come si manifesta da se stesso. Questo è il senso
formale dell’indagine che si dà il nome di fenomenologia. Ma in tal
modo non si fa che esprimere la massima formulata più sopra: «Alle
cose stesse!»
[25] Quanto al suo senso, perciò, il termine fenomenologia è diverso
da designazioni come teologia e simili. Queste denotano gli oggetti
della relativa scienza nel loro rispettivo contenuto reale
[Sachhaltigkeit]. «Fenomenologia» non denota l’oggetto delle sue
ricerche, né il termine caratterizza il contenuto reale di tali ricerche. La
parola informa esclusivamente sul come [Wie] della esibizione e della
trattazione del che cosa [Was] deve venir trattato in questa scienza.
Scienza «dei» fenomeni significa: un afferramento dei propri oggetti
tale che tutto ciò che di essi è in discussione sia trattato in esibizione
[Aufweisung] diretta ed in giustificazione [Ausweisung] diretta. Il
medesimo significato ha l’espressione, sostanzialmente tautologica,
«fenomenologia descrittiva». Qui descrizione non ha affatto il
significato di un procedimento del genere di quello impiegato, ad
esempio, dalla morfologia botanica. L’espressione ha di nuovo un
senso proibitivo: tener lontano ogni determinare non giustificante
[nicht ausweisendes Bestimmen]. Il carattere della descrizione stessa,
il senso specifico del λόγοϛ, potrà esser fissato prima di tutto soltanto
muovendo dalla «realtà» [Sachheit, lett.: “cosità”] di ciò che deve
essere «descritto», che deve cioè essere condotto a determinatezza
scientifica nel modo di incontro di fenomeni. Formalmente, il
significato del concetto formale e ordinario di fenomeno autorizza a
chiamare fenomenologia ogni esibizione dell’ente così com’esso si
manifesta in se stesso.
[26] In riferimento a che cosa il concetto formale di fenomeno deve ora
essere deformalizzato in concetto fenomenologico, e come questo si
distingue dal concetto ordinario? Che cos’è [Was] ciò che la
fenomenologia deve «lasciar vedere»? Che cos’è [Was] ciò che, in un
senso eminente [in einem ausgezeichneten Sinne], deve venir chiamato
«fenomeno»? Che cosa [Was], per sua essenza, è necessariamente
tema di una esibizione esplicita [ausdrueckliche Aufweisung]?
Manifestamente, ciò che innanzi tutto e per lo più non si manifesta, ciò
che, rispetto a ciò che innanzi tutto e per lo più si manifesta, è nascosto
[verborgen], ma è al contempo ciò che appartiene essenzialmente a ciò
che innanzitutto e per lo più si manifesta, in modo tale da costituirne il
senso o fondamento. 17n.
[27] Ma ciò che [Was], in un senso eccellente [in einem ausnehmenden
Sinne], resta nascosto [verborgen] o ricade di nuovo nell’occultamento
[Verdeckung] o si manifesta solo in modo «distorto» [»verstellt«], non
è questo o quell’ente, ma, come le considerazione precedenti hanno
mostrato, l’essere dell’ente. Esso può essere occultato così
ampiamente che esso cade nell’oblio e la domanda su di lui e sul suo
senso viene a mancare. Pertanto, ciò che [Was], in un senso eminente
[in einem ausgezeichneten Sinne] esige per il suo più proprio
8
contenuto reale [Sachgehalt] di diventare fenomeno, la fenomenologia
lo ha tematicamente «afferrato» quale oggetto.
[28] Fenomenologia è modo di accesso a, modo di determinazione
giustificante di, ciò che [Was] deve costituire il tema dell’ontologia.
Ontologia è possibile soltanto come fenomenologia. Il concetto
fenomenologico di fenomeno intende, come manifestantesi, l’essere
dell’ente, il suo senso, le sue modificazioni e i suoi derivati. E il
manifestarsi [das Sichzeigen] non è un casuale manifestarsi, e
nient’affatto qualcosa come apparire [Erscheinen]. L’essere dell’ente
non può assolutamente essere qualcosa «dietro» cui stia ancora
qualcosa «che non appare».
[29] «Dietro» i fenomeni della fenomenologia non c’è essenzialmente
nient’altro, ma ciò che deve divenire fenomeno può ben essere
nascosto. È proprio perché i fenomeni, innanzi tutto e per lo più, non
sono dati, che occorre la fenomenologia. Esser-occultato
[Verdecktheit] è il controconcetto [Gegenbegriff] di «fenomeno».
[30] I modi del possibile esser-occultato dei fenomeni sono diversi. In
primo luogo il fenomeno può esser occultato nel senso che esso è come
tale ancora non scoperto. Della sua sussistenza non si ha né conoscenza
né ignoranza.13 Ma un fenomeno può essere anche ricoperto
[verschüttet]. Sta in ciò: esso era un tempo scoperto, ma ricadde
successivamente nell’occultamento. Quest’ultimo può diventare totale;
di regola però accade che quel che era prima scoperto risulta ancora
visibile, benché solo come parvenza [Schein]. Senonché, quanta
parvenza, altrettanto «essere» [Wieviel Schein jedoch, soviel »Sein«].
Questo occultamento nel senso di «distorsione» è il più frequente e il
più pericoloso, perché qui le possibilità dell’inganno e dello sviamento
sono particolarmente ostinate. Strutture d’essere (e relativi concetti)
disponibili, ma velate quanto al loro suolo d’origine
[Bodenständigkeit], possono rivendicare il proprio diritto forse
all’interno di un «sistema». Grazie alla loro esser costruttivamente
agganciate ad un sistema, esse possono spacciarsi per qualcosa di
«chiaro», che non ha bisogno di ulteriore giustificazione, e può perciò
servire come punto di avvio di un processo deduttivo progrediente.
[31] Comunque inteso — nel senso di nascondimento [Verborgenheit],
ricoprimento [Verschüttung] o distorsione [Verstellung] —
l’occultamento [Verdeckung] ha di nuovo una duplice possibilità. Ci
sono occultamenti casuali e occultamenti necessari, cioè tali da
radicarsi nel modo di sussistere di ciò che è scoperto. Ogni concetto e
principio fenomenologico attinto originariamente è esposto, in quanto
asserzione comunicata, alla possibilità della degenerazione
[Entartung]. Viene trasmesso in una comprensione vuota, perde il
proprio suolo d’origine [Bodenständigkeit] e diventa una tesi astratta
[freischwebend, lett.: «sospesa per aria»]. La possibilità dello
sclerotizzarsi e del perdere di «presa» di ciò che originariamente
l’aveva è insita anche nel lavoro concreto della fenomenologia. E la
difficoltà di questa ricerca sta proprio nel renderla critica verso se
stessa in un senso positivo.
9
[32] Agli oggetti della fenomenologia, il modo di incontro dell’essere
e delle strutture d’essere nel modus del fenomeno deve in primo luogo
essere strappato. Perciò, il punto di partenza [Ausgang] dell’analisi,
così come l’accesso [Zugang] al fenomeno,
e il passaggio
[Durchgang] attraverso gli occultamenti predominanti richiedono una
peculiare assicurazione metodologica. Nell’idea dell’afferramento e
della esplicazione «originari» ed «intuitivi» dei fenomeni c’è proprio
il contrario dell’ingenuità di un casuale, «immediato» e pacifico «star
a guardare».
[33] Sulla base del concetto preliminare [Vorbegriff] di fenomenologia
che abbiamo delimitato, possono ora esser fissati nel loro significato
anche i termini «fenomenico» e «fenomenologico». «Fenomenico» è
detto ciò che [was] nel modo di incontro del fenomeno è dato ed
esplicabile; perciò si parla di strutture fenomeniche. Per
«fenomenologico» si intende invece tutto ciò che appartiene al modo
di esibizione [Aufweisung] e di esplicazione, e ciò che costituisce la
concettualità richiesta da questa ricerca.
[34] Poiché fenomeno, in senso fenomenologico, è sempre e soltanto
ciò che [was] costituisce essere, ma essere è ogni volta essere dell’ente,
per giungere a mettere lo scoperto l’essere, c’è prima bisogno di una
corretta presentazione dell’ente. Questo si deve parimenti manifestare
nella modalità di accesso che è genuinamente propria di esso. In tal
modo, diviene fenomenologicamente rilevante il concetto ordinario di
fenomeno. Il compito preliminare [Voraufgabe] di un’assicurazione
«fenomenologica» dell’ente esemplare come punto di partenza per
l’analitica autentica è già sempre predelineato muovendo dal fine di
questa analitica stessa.
[35] Considerata materialmente [sachhaltig genommen], la
fenomenologia è la scienza dell’essere dell’ente: ontologia. Nel corso
dei chiarimenti che abbiamo dati circa i compiti dell’ontologia, risultò
la necessità di una ontologia fondamentale [Fundamentalontologie],
che ha a tema l’ente privilegiato ontologico-onticamente, l’Esserci, in
modo da portarsi di fronte al problema cardinale, la domanda sul senso
dell’essere in generale.18n Dall’indagine stessa risulterà: il senso
metodico della descrizione fenomenologica è l’interpretazione
[Auslegung]. Il λόγοϛ della fenomenologia dell’Esserci ha il carattere
dell’ἑρμηνεύειν, per il tramite del quale l’autentico senso d’essere e le
strutture fondamentali del suo proprio essere vengono resi noti alla
comprensione d’essere propria dell’Esserci. La fenomenologia
dell’Esserci è ermeneutica nel significato originario della parola,
secondo il quale essa designa il lavoro di interpretazione. Poiché però,
attraverso lo scoprimento del senso dell’essere e delle strutture
fondamentali dell’Esserci in generale, viene prodotto l’orizzonte di
ogni indagine ontologica ulteriore concernente l’ente difforme
dall’Esserci, questa ermeneutica è «ermeneutica» anche nel senso della
elaborazione delle condizioni di possibilità di qualsiasi ricerca
ontologica. E infine, poiché l’Esserci vanta il primato ontologico
rispetto ad ogni essente (in quanto ente avente la possibilità
10
dell’esistenza), l’ermeneutica, nella sua qualità di interpretazione
dell’essere dell’Esserci, acquista un terzo senso specifico (che,
filosoficamente parlando, è primario), quello di analitica
dell’esistenzialità dell’esistenza. Pertanto in questa ermeneutica, che
elabora ontologicamente la storicità dell’Esserci quale condizione
ontica della possibilità della storiografia, getta le sue radici ciò che può
esser detto «ermeneutica» solo in senso derivato: la metodologia delle
scienze storiche dello spirito.
[36] L’essere, in quanto tema fondamentale della filosofia, non è un
genere dell’ente, e tuttavia riguarda ogni ente. La sua «universalità» è
da ricercarsi più in alto. L’essere e la struttura dell’essere si trovano al
di sopra di ogni ente e di ogni determinazione possibile di un ente.
L’essere è il transcendens puro e semplice.19n La trascendenza
dell’essere dell’Esserci è eminente perché in essa hanno luogo la
possibilità e la necessità dell’individuazione più radicale. Ogni
aprimento dell’essere in quanto transcendens è conoscenza
trascendentale. La verità fenomenologica (l’apertura dell’essere) è
veritas transcendentalis.
[37] L’ontologia e la fenomenologia non sono due diverse discipline
che fanno parte della filosofia assieme ad altre. I due termini denotano
entrambi la filosofia stessa nel suo oggetto e nel suo procedimento. La
filosofia è ontologia universale fenomenologica, muovente
dall’ermeneutica dell’Esserci, la quale, in quanto analitica
dell’esistenza, 20n ha fissato il capo del filo conduttore di ogni
domandare filosofico nel punto da cui tale domandare salta fuori ed in
cui è risospinto.
[38] Le ricerche che seguono sono state possibili solo sulla base posta
da Edmund Husserl, con le cui Ricerche logiche la fenomenologia fece
irruzione. Le discussioni del concetto preliminare [Vorbegriff] di
fenomenologia indicano che l’essenziale per essa non sta nell’esser
realmente effettiva come «corrente» filosofica.21n Più in alto della
realtà effettiva sta la possibilità. La comprensione della fenomenologia
consiste esclusivamente nell’afferrarla come possibilità.14
[39] Per quanto concerne la goffaggine e la «ineleganza» di espressione
delle analisi che seguono, si può aggiungere che un conto è informare
sull’ente raccontando, e un altro è cogliere l’ente nel suo essere. Per
questa seconda impresa mancano non solo la maggior parte delle
parole, ma, prima di tutto, la «grammatica». Se ci è lecito richiamare
precedenti analisi sull’essere, impareggiabili quanto al loro livello, si
paragonino le sezioni ontologiche del Parmenide di Platone o il quarto
capitolo del settimo libro della Metafisica di Aristotele con qualche
passo narrativo di Tucidide, e si vedrà quale sforzo inaudito fu richiesto
ai greci dai loro filosofi in fatto di formulazioni linguistiche. Quando
le forze siano essenzialmente inferiori e, per di più, l’ambito ontologico
da esplorare assai più arduo di quello che fu pre-dato ai greci, è
inevitabile che crescano anche la prolissità della elaborazione
concettuale e la durezza dell’espressione.
11
§ 54 Il problema dell’attestazione di una possibilità esistentiva
autentica
[1] Cercato è un poter-essere autentico dell’Esserci che sia da questo
stesso attestato nella sua possibilità esistentiva. Anzitutto occorre che
sia questa attestazione stessa a lasciarsi trovare. Se tale attestazione
deve «dar ad intendere» all’Esserci esso stesso nella sua esistenza
autentica possibile, avrà le proprie radici nell’essere dell’Esserci.
L’esibizione fenomenologica di una attestazione di questo genere
racchiude perciò in sé la dimostrazione della sua origine dalla
costituzione d’essere dell’Esserci.
[2] L’attestazione deve dar ad intendere un poter-esser-se-Stesso
[Selbstseinkoennen] autentico. Con l’espressione «se-Stesso»
[»Selbst«] abbiamo risposto alla domanda intorno al Chi è [Wer]
dell’Esserci. L’ipseità [Selbstheit] dell’Esserci fu determinata
formalmente come una maniera di esistere e cioè non come un ente
semplicemente-presente. Non io stesso [ich selbst], ma il Si-stesso
[Man-Selbst] è per lo più il chi è [Wer] dell’esserci. L’esser se-Stesso
autentico si determina come una modificazione esistentiva del Si, che
è da delimitare esistenzialmente. In che cosa consiste questa
modificazione esistentiva e quali sono le condizioni ontologiche della
sua possibilità?
[3] Con la perdizione dell’Esserci nel Si, tutto è già ogni volta deciso
circa il più immediato poter-essere fattizio dell’Esserci, cioè circa i
compiti, le regole, le misure, l’urgenza e la portata dell’essere-nelmondo prendente e avente cura. Il cogliere [Ergreifen] queste
possibilità d’essere il Si l’ha già da sempre sottratto all’esserci. Il Si ha
già sempre esonerato l’Esserci dal cogliere [Ergreifen] queste
possibilità di essere. Il Si nasconde perfino il tacito sgravamento che
esso compie dalla esplicita scelta di queste possibilità. Resta
indeterminato chi «propriamente» [»eigentlich«] scelga. Questo privo
di scelta esser presi da nessuno, per il quale l’Esserci è irretito
nell’inautenticità, può essere revocato soltanto se l’Esserci, dalla
perdizione nel Si, va a appositamente a riprendersi per riportarsi a sé
stesso. Senonché, questo andare a riprendere deve avere quel modo di
essere per la cui omissione [Versaeumnis, “inosservanza”,
“inadempimento”,
“mancanza”]
l’Esserci
si
è
perduto
nell’inautenticità. L’andare a riprendersi [das Sichzurueckholen] dal
Si, cioè la modificazione esistentiva del Si-stesso [Man-Selbst] in
autentico esser-se-Stesso [Selbstsein], deve compiersi (sich vollziehen)
come recuperare [Nachholen] una scelta. Ma recuperare la scelta
significa scegliere questa scelta stessa, decidersi per un poter-essere a
partire dal proprio se-Stesso. È anzitutto scegliendo la scelta che
l’Esserci rende possibile a se stesso il suo autentico poter-essere.
[4] Poiché però è perduto nel Si, si deve prima trovare. Per trovarsi in
generale, deve venir «mostrato» a lui stesso nella sua possibile
autenticità. L’Esserci ha bisogno dell’attestazione di un poter-esserese-stesso, che esso ogni volta già è secondo la possibilità.
12
[5] Nella seguente interpretazione [Interpretation] si pretende che una
siffatta attestazione sia quel che all’autointerpretazione quotidiana
[alltaegliche Selbstauslegung] dell’esserci è noto come voce della
coscienza morale [Stimme des Gewissens]. Che il «fatto» [Tatsache]
della coscienza morale sia contestato, che la sua funzione di istanza per
l’esistenza dell’Esserci sia diversamente valutata, che ciò che
«la coscienza morale dice» sia interpretato in vari modi, dovrebbe
indurci a rigettare questo fenomeno se non fosse che proprio la
«dubbiosità» [»Zweifelhaftigkeit«] di questo fatto [Faktum], ossia
dell’interpretazione di esso, non stesse proprio a dimostrare che ci
troviamo innanzi a un fenomeno originario dell’Esserci. L’analisi che
segue pone la coscienza morale nella progettazione [Vorhabe] tematica
di una indagine puramente esistenziale con intento ontologicofondamentale.
[6] Innanzi tutto bisogna ripercorrere la coscienza morale quanto ai
suoi fondamenti e alle sue strutture esistenziali e renderla visibile come
fenomeno dell’Esserci, tenendo ben ferma la costituzione d’essere di
questo ente finora chiarita. L’analisi ontologica della coscienza morale
così impostata precede ogni descrizione psicologica delle «esperienze
vissute» della coscienza morale e la loro classificazione, ed è estranea
a ogni «spiegazione» biologica, cioè a ogni dissolvimento del
fenomeno. Ma non minore è la sua distanza da ogni spiegazione della
coscienza morale di natura teologica e anche da ogni assunzione di
questo fenomeno come base per la dimostrazione dell’esistenza di Dio
o di una coscienza «immediata» di Dio [Gottesbewusstsein].
[7] Tuttavia, anche in questa indagine limitata della coscienza morale,
il suo risultato non dovrà né esser sopravvalutato, né fatto oggetto di
rivendicazioni distorte e così sminuito. La coscienza morale, in quanto
fenomeno dell’Esserci, non è un fatto (Tatsache) accidentale e
semplicemente-presente. Questo fenomeno «è» soltanto nel modo di
essere dell’Esserci e si dà a conoscere come fatto (Faktum) sempre e
solo con e nell’esistenza fattizia [faktischen Existenz]. L’esigenza di
una «prova empirico-induttiva» della «fattualità» (»Tatsaechlichkeit«)
della coscienza morale e della legittimità della sua «voce» riposa su un
stravolgimento ontologico del fenomeno. Cade in questo
stravolgimento anche ogni critica «altezzosa» della coscienza morale
che veda in essa un evento occasionale e non un «fatto (Tatsache)
universalmente noto e constatabile». Il fatto (Faktum) della coscienza
morale in quanto tale non si lascia sottoporre a prove e controprove di
questo genere. Il che non attesta affatto una sua manchevolezza, ma è
semplicemente l’indice della sua difformità ontologica dalla semplicepresenza nel mondo-ambiente.
[8] La coscienza morale dà ad intendere «qualcosa», essa dischiude
(erschliesst, “rende accessibile”). Da questa caratterizzazione formale
scaturisce la prescrizione di riprendere il fenomeno nella schiusura
(Erschlossenheit, “accessibilità”) dell’Esserci. Questa costituzione
fondamentale dell’ente che noi stessi di volta in volta siamo, è
costituita dalla situazione emotiva, dalla comprensione, dalla deiezione
13
e dal discorso. L’analisi più approfondita della coscienza morale la
rivela come chiamata [Ruf]. Il chiamare [Rufen] è un modo del
discorso [Rede]. La chiamata della coscienza morale [Gewissensruf]
ha il carattere del richiamo [Anruf] dell’Esserci al suo più proprio
poter-essere-se-stesso e ciò nel modo dell’incitamento [Aufruf] al suo
più proprio essere-colpevole.
[9] Questa interpretazione [Interpretation] esistenziale è
necessariamente lontana dalla comprensibilità ontica quotidiana,
benché ponga davanti [herausstellt, lett.: “produca”] i fondamenti
ontologici di ciò che l’interpretazione ordinaria della coscienza morale,
entro certi limiti, ha sempre compreso e concettualizzato sotto forma di
«teoria» della coscienza morale. L’interpretazione esistenziale ha
bisogno perciò di essere messa alla prova [Bewährung], mediante una
critica dell’interpretazione ordinaria della coscienza morale.
Muovendo dal fenomeno posto davanti [lett.: “prodotto”], si potrà
stabilire in che misura esso attesta un poter-essere autentico
dell’Esserci. Alla chiamata della coscienza morale corrisponde un
possibile sentire (Hören). La comprensione del richiamo
[Anrufverstehen] si rivela come un voler-aver-coscienza-morale. Ma in
questo fenomeno sta quel cercato scegliere esistentivo della di scelta di
se-Stesso che noi, corrispondentemente alla sua struttura esistenziale,
chiamiamo decisione (Entschlossenheit “risolutezza”]. Con ciò è data
l’articolazione dell’analisi di questo capitolo: i fondamenti ontologicoesistenziali della coscienza morale (§ 55); il carattere di chiamata della
coscienza morale (§ 56); la coscienza morale come chiamata della Cura
(§ 57); comprensione del richiamo e colpa (§ 58); l’interpretazione
esistenziale e l’interpretazione ordinaria della coscienza morale (§ 59);
la struttura esistenziale del poter-essere autentico attestato dalla
coscienza morale (§ 60).
§ 55 I fondamenti ontologico-esistenziali della coscienza morale
[1] L’analisi della coscienza morale prende avvio da un reperto
indifferente di questo fenomeno: che essa, in qualche modo, dà ad
intendere qualcosa. La coscienza morale dischiude [erschließt, “apre”,
“rende accessibile”] e appartiene perciò alla cerchia dei fenomeni
esistenziali che costituiscono l’essere del Ci in quanto apertura
(Erschlossenheit, “accessibilità”).142 Le sue strutture più universali,
cioè la situazione emotiva, la comprensione, il discorso e la deiezione,
sono già state dispiegate. La collocazione della coscienza morale in
questo complesso fenomenico non è un’applicazione schematica delle
strutture a suo tempo rintracciate a un «caso» particolare di apertura
dell’Esserci. Al contrario, l’interpretazione della coscienza morale non
solo vuol essere un ampliamento della precedente analisi dell’apertura
del Ci, ma anche un suo più originario afferramento in relazione
14
all’essere autentico dell’Esserci.
[2] Per il tramite dell’apertura (Erschlossenheit, “essere accessibile”),
l’ente che noi chiamiamo Esserci è nella possibilità di essere il suo Ci.
Col suo mondo, l’esserci c’è (ist…da) per esso stesso, e ciò innanzi
tutto e per lo più in modo da essersi reso accessibile (erschlossen) il
suo poter-essere a partire dal «mondo» di cui si prende cura. Il poteressere in cui l’Esserci esiste si è già ogni volta affidato a possibilità
determinate. E ciò perché l’Esserci è un ente gettato, il cui esser-gettato
è reso accessibile (erschlossen, “dischiuso”, “aperto”), in modo più o
meno chiaro e profondo, da un esser emotivamente intonato. Della
situazione
emotiva
(tonalità
affettiva
[Stimmung])
fa
cooriginariamente parte la comprensione. Così l’Esserci «sa» l’affar
suo nei propri riguardi, e ciò in quanto si è progettato in possibilità di
se stesso, cioè in possibilità che esso, immedesimato col Si, si è lasciato
prescrivere [vorgeben] dallo stato interpretativo pubblico del Si-stesso.
Ma questa prescrizione [Vorgabe] è resa esistenzialmente possibile dal
fatto che l’Esserci, in quanto comprendente con- essere, può star a
sentire (hören) gli altri. Perdendosi nella pubblicità del Si e nelle sue
chiacchiere, l’Esserci non ascolta [überhört] il proprio se-Stesso. Se
l’Esserci deve poter-essere sottratto alla perdizione del non- ascoltarsi
(Sichüberhören) - e se lo deve proprio attraverso se stesso - è
necessario che esso possa anzitutto trovarsi, che possa trovare quel seStesso che esso ha trascurato di sentire prestando ascolto (Hinhören)
al Si. Questo dare ascolto dev’essere interrotto, cioè dev’essere data
all’Esserci, dall’Esserci stesso, la possibilità di un sentire che
interrompa il prestare ascolto. La possibilità di una interruzione di
questo genere è data da un venir improvvisamente chiamati
(unvermittelt Angerufenwerden). La chiamata (Ruf) interrompe il non
ascoltantesi prestar ascolto (das sich überhörende Hinhören) al Si
dell’Esserci soltanto se essa, in corrispondenza col suo carattere di
chiamata, suscita un sentire in tutto opposto al sentire perduto. Laddove
quest’ultimo sentire è stordito dal «chiasso» e dalla rumorosa
equivocità della chiacchiera ogni giorno
«nuova», la chiamata deve chiamare senza rumore, inequivocamente
(unzweideutig), senza offrire appiglio per la curiosità. Ciò che dà ad
intendere chiamando in questo modo è la coscienza morale.
[3] Noi concepiamo la coscienza morale come un modo del discorso.
Questa articola la comprensibilità. Definendo la coscienza morale
come chiamata, non intendiamo affatto far ricorso a una «immagine»,
quale ad esempio la rappresentazione kantiana della coscienza morale
come un tribunale. Soprattutto non dobbiamo dimenticare che il
discorso, e quindi anche la chiamata, non implicano necessariamente
la verbalizzazione sonora. Ogni espressione e ogni «esclamazione»
presuppongono già il discorso. Quando l’interpretazione quotidiana
parla di una «voce» della coscienza morale, non intende alludere a una
comunicazione verbale che non ha effettivamente [faktisch] luogo;
«voce», qui, significa dar-a-intendere. Nella tendenza ad aprire, propria
della chiamata, c’è un momento di urto, di brusco scuotimento. Viene
15
chiamato dalla lontananza nella lontananza. È colpito dalla chiamata
chi vuole venir ripreso [zurueckgeholt].
[4] Con questa caratterizzazione della coscienza morale è soltanto
delineato l’orizzonte fenomenico per l’analisi della sua struttura
esistenziale. Il fenomeno non è paragonato a una chiamata, ma, in
quanto discorso, è compreso muovendo dalla schiusura
(Entschlossenheit) costitutiva dell’Esserci. La considerazione evita sin
dal principio la via che si offre per prima all’interpretazione della
coscienza morale, e che la riconduce a una facoltà dell’anima
(intelletto, volontà o sentimento) o la spiega come un suo prodotto. Di
fronte a un fenomeno come la coscienza morale salta subito agli occhi
l’inadeguatezza
ontologico-antropologica
di
ogni
astratta
classificazione di facoltà dell’anima o di atti personali.
§ 56 Il carattere di chiamata della coscienza morale
[1] Del discorso (Rede, “parlare”, logos-leghein) fa parte ciò-su-cui il
discorso [das beredete Worueber, kata ti] discorre. Il discorso da
chiarimenti su qualcosa e ciò sotto un determinato riguardo. Da ciò su
cui il discorso discorre [Aus dem so Beredeten], il discorso attinge ciò
che di volta in volta esso, in quanto questo discorso, dice, il detto come
tale [das Geredete als solches, “il parlato come tale”, legomenon]. Nel
discorso, in quanto comunicazione [Mitteilung], ciò che è detto è reso
accessibile al con-esserci di altri e, per lo più, nella forma della
pronuncia verbale nel linguaggio (Sprache, “lingua”, fr. “parole”).
[2] Nella chiamata della coscienza morale, che cos’è [Was ist] ciò di cui
si discorre [das Beredete], ovvero il chiamato [das Angerufene,
“appellato”]? Manifestamente l’Esserci stesso. Questa risposta è tanto
incontestabile quanto indeterminata. Se la chiamata avesse uno
bersaglio (Ziel, “scopo”, “obiettivo”) così vago, non sarebbe per
l’Esserci che un’occasione per far attenzione a sé. Ma l’Esserci è tale
nella sua essenza che esso, con l’apertura del suo mondo, è dischiuso
(erschlossen) a se stesso, cosicché già da sempre si comprende. La
chiamata colpisce (trifft) l’Esserci in questa suo quotidiano-medio giàsempre-comprendersi prendente cura. Dalla chiamata viene colpito il
Si-stesso del con-essere con gli altri prendente cura. [3] A che
(woraufhin) l’Esserci è chiamato? Al proprio sé. Non [è chiamato] a
ciò a cui l’Esserci, nell’essere-assieme pubblico, conferisce valore, a
ciò che esso può, di cui si prende cura, che ha afferrato [ergriffen], per
cui si è impegnato, da cui si è lasciato coinvolgere. L’Esserci, quale
risulta mondanamente compreso per se stesso e per gli altri, è in questo
richiamo ignorato (übergangen, , “tralasciato”, “eluso”,
“disdegnato”). Di ciò la chiamata rivolta al se-Stesso non prende
minimamente atto (nimmt … das mindeste Kenntnis, “non ha la
menoma conoscenza”). Poiché soltanto il Sé-stesso del Si- Stesso [das
Selbst des Man-selbst] è chiamato e indotto a sentire, il Si si ritira in sé.
16
Tuttavia, il fatto che la chiamata ignori [“eluda”, “disdegni”] il Si e lo
stato interpretativo pubblico dell’Esserci, non significa affatto che essa
non colpisca insieme (mittrifft) anche il Si. Proprio nell’ignorare (im
Uebergehen, “nell’eludere”, “nel disdegnare”) essa respinge nella
insignificanza (Bedeutungslosigkeit) il Si avido di pubblica
reputazione. Il Sé, però, deprivato (beraubt) nel richiamo [im Anruf] di
questo rifugio e di questo nascondiglio, è condotto a se stesso per il
tramite della chiamata [durch den Ruf].
[4] Il Si-stesso è richiamato il Sé. Non si tratta però del Sé quale
possibile «oggetto» di apprezzamenti o del Sé della inconsistente,
eccitata e curiosa anatomia della propria «vita interiore», e neppure del
Sé della del semplice stare a guardare «analitico» gli stati d’animo e i
loro retroscena. Il richiamo del Sé-stesso nel Si-stesso non lo relega in
sé nel senso di un’interiorità che lo separerebbe dal «mondo esterno».
Tutto ciò, la chiamato lo salta [ueberspringt] e lo disperde, per
richiamare unicamente il Se-stesso, il quale, nondimeno, non è mai
altrimenti che nel modo dell’essere-nel-mondo.
[5] Ma come dobbiamo determinare il ciò-che-viene-detto di questo
discorso [das Geredete dieser Rede]? Che cosa ( Was) la coscienza
morale grida (zurufen) al chiamato? A rigore, nulla. La chiamata non
asserisce nulla, non dà alcuna informazione su eventi mondani, non ha
nulla da raccontare. Meno che meno aspira ad inaugurare un
«soliloquio» (»Selbstgespraech«, “colloquio tra sé e sé”) nel se-Stesso
richiamato. Al se-Stesso richiamato non è gridato
(zu-gerufen)
«nulla»; esso è incitato [aufgerufen] a se-Stesso, cioè al suo più proprio
poter-essere. La chiamata, secondo la sua tendenza di chiamata, non
coinvolge il se-Stesso richiamato in una «negoziazione» (Verhandlung,
“trattativa”), ma, quale incitamento al suo poter-essere più proprio, è un
chiamar-dinanzi [Vor-rufen], un chiamare al «proscenio» l’Esserci
nelle sue possibilità più proprie.
[6] La chiamata non ha bisogno di pronuncia sonora (Verlautbarung).
Essa nemmeno proferisce parola, ma non resta per questo oscura e
indeterminata. La coscienza morale parla unicamente e costantemente
nel modo del tacere. Con ciò essa non solo non perde nulla in fatto di
percepibilità, ma costringe l’Esserci, chiamato e incitato, alla
silenziosità di se stesso. La mancanza di una formulazione verbale di
ciò che nella chiamata viene invocato (gerufen) non condanna il
fenomeno alla nebulosità di una voce misteriosa, ma sta
semplicemente a indicare che la comprensione dell’«invocato» (des
»Gerufenen«) non può aggrapparsi all’attesa di una comunicazione o
di qualcosa di simile.
[7] Ciò nonostante, quel che la chiamata dischiude (erschliesst) è
univoco, anche se essa, nel singolo esserci a seconda delle sue
possibilità di comprensione, può andar incontro ad una diversa
interpretazione. Al di là dell’apparente indeterminatezza del contenuto
della chiamata, non può non esser colta la sicura traiettoria
[Einschlagsrichtung, “direzione d’impatto”] della chiamata. La
chiamata non ha bisogno di un primo ricercare a tastoni di colui che
17
deve esser richiamato, non abbisogna di alcun segno di riconoscimento
che permetta di stabilire se è o no proprio lui ad essere inteso. Nella
coscienza morale, le «illusioni» non sorgono per uno stravedere (strachiamare [Sichver-rufen]) da parte della chiamata, ma solo per il modo
in cui la chiamata è udita, cioè per il fatto che essa, anziché essere
compresa autenticamente, è stornata dal Si in un negoziante
(verhandelnden) dialogo tra sé e sé e così pervertita nella sua tendenza
di schiudimento (Erschliessungstendenz).
[8] Occorre tener fermo: la chiamata con cui caratterizziamo la
coscienza morale è richiamo del Si-stesso nel suo Sé; in quanto tale è
incitamento del Sé al suo poter-esser-sé, e perciò una chiamata
dell’Esserci di fronte alle proprie possibilità. [9] Ma potremo ottenere
un’interpretazione ontologica adeguata della coscienza morale solo
quando avremo posto in chiaro non soltanto chi sia il chiamato nella
chiamata della coscienza morale, ma chi sia che chiama, in quale
rapporto il chiamato stia col chiamante e come debba essere
ontologicamente inteso questo «rapporto» come connessione d’essere.
§ 57 La coscienza morale come chiamata della Cura
[1] La coscienza morale incita il se-Stesso dell’Esserci dalla sua
dispersione nel Si. Il se-Stesso richiamato resta indeterminato e vuoto
nel suo che-cosa (Was). L’in quanto che cosa l’Esserci, innanzi tutto e
per lo più, comprende se stesso nell’interpretazione a partire dall’ente
di cui si prende cura, è ignorato (uebergangen) dalla chiamata. E
tuttavia il se-Stesso è univocamente (eindeutig) e inequivocabilmente
(unverwechselbar) colpito. Non solo il richiamato è investito dalla
chiamata «senza riguardo alla persona», ma il chiamante resta a sua
volta in una vistosa indeterminatezza. Non solo esso [scil.: il
chiamante, der Rufer] si rifiuta di rispondere alle domande concernenti
il suo nome, il suo stato, la sua origine e il suo rango, ma il chiamante,
benché nella chiamata non finga affatto, non concede la minima
possibilità di rendersi familiare a una comprensione dell’Esserci
orientata «mondanamente». Il chiamante della chiamata – ciò
appartiene al suo carattere fenomenico – tiene assolutamente lontano
da sé ogni «notorietà». Sottoporsi a osservazione o a discorso va contro
il suo modo di essere. L’indeterminatezza e l’indeterminabilità che
caratterizzano il chiamante non sono un nulla, ma un suo positivo
contrassegno distintivo (Auszeichnung). Esse attestano che esso si
risolve [aufgehen] unicamente nel puro e semplice «incitare a…», e
che solo in quanto tale esso vuol essere ascoltato, e che non vuole
chiacchiere su di sé. Non è allora il fenomeno stesso a richiedere che
la domanda sul Chi del chiamante non abbia luogo? Certamente sì, per
lo stare a sentire esistentivo (existentiellen Hoeren) della chiamata
effettiva della coscienza morale (faktischen Gewissenruf); non, però,
per l’analisi esistenziale dell’effettività (Faktizitaet) del chiamare e
dell’esistenzialità (Existentialitaet) dello stare a sentire.
18
[2] Ma c’è in generale necessità di porre ancora espressamente la
questione del Chi chiami? L’Esserci non porta forse con sé la risposta
a questa domanda in modo altrettanto univoco (eindeutig) che in quella
circa il richiamato nella chiamata? Nella coscienza morale, l’Esserci
chiama se stesso. Questa comprensione del chiamante può essere più o
meno viva nell’ascolto effettivo della chiamata. Ontologicamente,
però, non è affatto sufficiente rispondere che l’Esserci è ad un tempo il
chiamato e il chiamante. Ma allora, l’Esserci «ci» è [ist «da»], in
quanto chiamato, non diversamente che in quanto chiamante? Funge
forse da chiamante il più proprio poter-essere-se-Stesso?
[3] La chiamata non è mai né progettata né preparata né volutamente
effettuata (vollzogen) da noi stessi. «Esso» chiama, contro la nostra
attesa e persino contro la nostra volontà. D’altra parte la chiamata
indubbiamente (zweifellos) non viene da un altro che sia nel-mondoinsieme a me. La chiamata viene da (aus) me e tuttavia su (ueber) di
me.
[4] Questo reperto fenomenico non va destituito di senso (ist nicht
wegzudeuten). Da esso ha infatti preso le mosse anche l’interpretazione
della voce della coscienza morale come un potere (Macht) estraneo
pervasivo nell’Esserci. Seguendo tale direzione interpretativa, si pone
alla base di questo potere un possessore, o si assume esso stesso come
persona annunciantesi (Dio). All’inverso, si tenta di respingere questa
interpretazione del chiamante come espressione di un potere estraneo,
e al contempo di spiegare riduzionisticamente (wegerklaeren, lett.:
“cancellare, destituire di senso qualcosa spiegandolo”) la coscienza
morale in generale in modo «biologico». Entrambe queste
interpretazioni sorvolano (ueberspringen, “passano oltre”)
precipitosamente il reperto fenomenico. Il procedere viene facilitato da
una tacita tesi-guida, ontologicamente dogmatica: ciò che è, ossia ciò
che, come la chiamata, è di fatto (tatsaechlich), deve essere
semplicemente presente; ciò che non può essere oggettivamente
dimostrato in quanto semplicemente-presente, non è affatto.
[5] Contro questa precipitosità metodica occorre tenere ben fermo, non
solo il reperto fenomenico come tale – cioè che la chiamata è diretta a
me provenendo da me sopra di me –, ma anche la predelineazione
ontologica, in ciò contenuta, del fenomeno in quanto fenomeno
dell’Esserci. Solo la costituzione esistenziale di questo ente può offrire
il filo conduttore per l’interpretazione del modo di essere dello «esso»
[»Es«] che chiama.
[6] L’analisi si qui svolta della costituzione dell’essere dell’Esserci
mostra forse una via per rendere comprensibile ontologicamente il
modo di essere del chiamante e quindi del chiamare? Il fatto che la
chiamata non sia effettuata (vollzogen) esplicitamente da me, ma che
sia «esso» a chiamare, non autorizza ancora a cercare il chiamante in
un ente non conforme dall’Esserci. Certo, ogni volta l’Esserci esiste
sempre effettivamente [faktisch]. Esso non è un auto-progettarsi
sospeso per aria; bensì — determinato, grazie (durch) all’esser-gettato
[Geworfenheit], come fatto [Faktum] dell’ente che esso è — esso
19
venne ogni volta già, e rimane costantemente, rimesso
(ueberantwortet, “affidato”, “consegnato”) all’esistenza. Ma
l’effettività [Faktizitaet, “fatticità”] dell’Esserci si distingue
essenzialmente dalla fattualità [Tatsaechlichkeit] di un semplicementepresente. L’Esserci esistente non va incontro (begegnet) ad esso stesso
come ad un qualcosa di semplicemente presente nel mondo. Né, però,
l’esser-gettato (Geworfenheit) inerisce all’Esserci come carattere
inaccessibile e irrilevante per la sua esistenza. In quanto gettato, esso è
gettato nell’esistenza. Esso esiste come ente che ha da essere così come
è, e come può essere.
[7] Che (Dass) l’Esserci effettivamente sia, può anche esser nascosto
(verborgen) quanto al suo perché; il «che» stesso (das »Dass« selbst),
però, è dischiuso (erschlossen) all’Esserci. L’esser-gettato dell’ente
appartiene alla schiusura del «Ci» [Erschlossenheit des »Da«] e si
rivela (enthuellt sich) costantemente nel rispettivo esseremotivamente-situato (Befindlichkeit). Questo [scil: l’esseremotivamente-situato] porta l’Esserci, in modo più o meno esplicito e
autentico, davanti al suo «che è [dass es ist] e che, in quanto è l’ente
che è, ha da essere potendo essere». Ma per lo più la tonalità emotiva
(Stimmung) chiude [verschliesst] l’esser-gettato. Davanti a questo
esser-gettato, l’Esserci si rifugia nell’alleggerimento della presunta
libertà del Si-stesso. Abbiamo definito tale fuga come fuga dinanzi allo
spaesamento (Unheimlichkeit) che determina fondamentalmente
l’essere-nel-mondo singolarizzato. Lo spaesamento si rivela (enthuellt
sich)
autenticamente nella situazione emotiva fondamentale
dell’angoscia e, in quanto schiusura più elementare dell’Esserci
gettato, pone il suo essere-nel-mondo davanti al nulla del mondo; di
fronte a questo nulla l’Esserci si angoscia nell’angoscia per il più
proprio poter-essere. E se il chiamante della chiamata della coscienza
morale fosse l’Esserci nel profondo del suo sentirsi emotivamente
spaesato?
[8] Contro di ciò non parla nulla; in suo favore parlano invece tutti i
fenomeni che sono stati fin qui posti in rilievo per la caratterizzazione
del chiamante e del suo chiamare.
[9] Il chiamante, nel suo Chi (Wer), non è «mondanamente»
determinabile mediante nulla. Esso è l’Esserci nel suo spaesamento,
l’originario gettato essere-nel-mondo in quanto non-essere-a-casapropria, il nudo «che» (»Dass«) nel nulla del mondo. Al Si-stesso
quotidiano, il chiamante non è familiare — qualcosa come una voce
estranea. Che mai vi può essere di più estraneo al Si, perduto nel
variegato «mondo» di cui si prende cura, del se-Stesso isolato nel suo
spaesamento e gettato nel nulla? «Esso» chiama, e tuttavia non dice
nulla di udibile da un orecchio immerso nelle cure e curioso, nulla che
possa passare indifferentemente da orecchio a orecchio ed essere
pubblicamente chiacchierato. Che può mai avere da raccontare
l’Esserci dallo spaesamento del suo essere-gettato? Che cosa (Was) gli
rimane d’altro, infatti, all’infuori di quel poter-essere di se stesso
20
svelato nell’angoscia? Come potrebbe chiamare altrimenti se non
incitando a questo poter-essere di cui ad esso unicamente importa?
[10] La chiamata non racconta storie e chiama anche senza
verbalizzazione sonora. La chiamata parla nel modo spaesante del
tacere. E ciò perché la chiamata non chiama il richiamato alle
chiacchiere pubbliche del Si, ma lo chiama indietro da queste al
silenzio del poter-essere esistente. Ed in che cosa si fonda la spaesante,
«disabituale» e fredda sicurezza con cui il chiamante colpisce il
chiamato, se non nel fatto che l’Esserci singolarizzato su di sé nel suo
spaesamento è per esso stesso assolutamente inconfondibile? Che cosa
sottrae all’Esserci in modo tanto radicale la possibilità di rifugiarsi
nell’equivoco, fraintendendosi e disconoscendosi, se non lo stato di
abbandono nell’esser affidato (die Verlassenheit in der
Ueberlassenheit) ad esso stesso?
[11] Lo spaesamento è il modo fondamentale, anche se
quotidianamente coperto, dell’essere-nel-mondo. L’Esserci stesso,
come coscienza morale, chiama dal fondo di questo suo essere. «Mi
chiama» è una discorso eminente dell’Esserci. La chiamata,
emotivamente pervasa di angoscia, fa sì che l’Esserci possa progettarsi
nel suo poter-essere più proprio. La chiamata della coscienza morale,
compresa esistenzialmente, annuncia ciò che prima abbiamo
semplicemente asseverato: lo spaesamento incalza l’Esserci e minaccia
il suo oblio nella perdizione.
[12] L’affermazione che l’Esserci è ad un tempo il chiamante e il
chiamato ha perso ora la sua formale vuotezza ed ovvietà. La coscienza
morale si rivela come chiamata della Cura: il chiamante è l’Esserci
che, nell’esser-gettato (esser-già-in…), si angoscia per il suo poteressere. Il richiamato è questo Esserci stesso, incitato al suo più proprio
poter-essere (esser-avanti-a-sé). E incitato è l’Esserci mediante il
richiamo dalla deiezione nel Si (esser-già-presso-il mondo di cui ci si
prende cura). La chiamata della coscienza morale, cioè la coscienza
morale stessa, trova la sua possibilità ontologica nel fatto che l’Esserci,
nel fondamento del suo essere, è Cura.
[13] Non c’è quindi bisogno di prender rifugio in potenze non conformi
all’esserci, tanto più che il regresso verso di esse illumina tanto poco
lo spaesamento della chiamata, che esso piuttosto lo annienta. La
ragione di fuorvianti «spiegazioni» della coscienza morale non starà in
fondo nel fatto che, già nella fissazione del reperto fenomenico della
chiamata, lo sguardo è stato troppo limitato e l’Esserci è stato
tacitamente presupposto in una casuale determinazione o
indeterminazione ontologica? Perché cercare una via d’uscita in
potenze estranee prima di assicurarsi che, nell’impostazione
dell’analisi, l’essere dell’Esserci non sia stato sottovalutato,
concependolo come innocuo soggetto (Subjekt), in qualche modo
presente, dotato di coscienza (Bewusstsein) personale?
[14] Eppure sembra che l’interpretazione del chiamante – che dal punto
di vista mondano è «nessuno» – come una potenza riposi sul
riconoscimento non prevenuto della sussistenza di qualcosa di
21
«oggettivamente rinvenibile». Ma, a ben guardare, questa
interpretazione è null’altro che una fuga davanti alla coscienza morale,
una scappatoia dell’esserci, con la quale esso se la svigna passando per
la sottile parete che, per così dire, separa il Si dallo spaesamento del
proprio essere. Tale interpretazione della coscienza morale suole anche
spacciarsi come riconoscimento della chiamata nel senso di una voce
obbligante in modo generale e non «semplicemente soggettivo».
Ancor di più: questa coscienza morale «generale» è elevata a
«coscienza morale universale» (Weltgewissen) , la quale, per il suo
carattere fenomenico, è un «esso», un «nessuno», che dunque parla,
come questo indeterminato, nel singolo «soggetto».
[15] Ma questa «coscienza morale pubblica» che altro è se non la voce
del Si? Alla dubbia invenzione di una «coscienza morale universale»
l’esserci può arrivarci solo perché la coscienza morale, nel suo
fondamento e nella sua essenza, è ogni volta mia. E ciò non solo nel
senso che è ogni volta il poter-essere più proprio a essere richiamato,
ma anche perché la chiamata proviene dall’ente che io stesso di volta
in volta sono.
[16] Nella nostra interpretazione del chiamante, fondata
esclusivamente sul carattere fenomenico del chiamare, la «potenza»
della coscienza morale non è né sminuita né resa «semplicemente
soggettiva». All’opposto, solo in essa hanno via libera l’inesorabilità e
l’inequivocabilità della chiamata. L’«oggettività» del richiamo trae la
sua legittimità soltanto nella misura in cui l’interpretazione lasci ad
esso la sua «soggettività», la quale però rifiuta il predominio del Sistesso.
[17] Contro questa interpretazione della coscienza morale come
chiamata della Cura si potrebbero tuttavia sollevare le seguenti
obiezioni: che fondamento può avere un’interpretazione della
coscienza morale così lontana dall’«esperienza naturale»? In qual
modo la coscienza morale potrà fungere da incitamento al più proprio
poter-essere quando essa, innanzi tutto e per lo più, non fa che
rimproverare e ammonire? La coscienza morale parla in modo così
indeterminato e vuoto di un poter-essere più proprio dell’Esserci, o
piuttosto parla in modo ben determinato e concreto degli errori e delle
omissioni che hanno già avuto luogo o che si intendevano commettere?
Il richiamo che abbiamo stabilito proviene dalla «cattiva» coscienza
morale o dalla «buona»? La coscienza morale fornisce qualcosa di
positivo o svolge una funzione esclusivamente critica?
[18] La legittimità di queste perplessità è incontestabile. Da
un’interpretazione della coscienza morale si può esigere che «si»
riconosca in essa il fenomeno così com’esso è esperito
quotidianamente. Ma soddisfare tale esigenza non significa
riconoscere la comprensione ontica ordinaria della coscienza morale
quale istanza prima dell’interpretazione ontologica. D’altra parte le
obiezioni suddette risultano premature nella misura in cui l’analisi
della coscienza morale da esse presa di mira non è stata ancora portata
a termine. Finora abbiamo semplicemente tentato di ricondurre la
22
coscienza morale, in quanto fenomeno dell’Esserci, alla costituzione
ontologica di questo ente. E ciò in vista del compito di render
comprensibile la coscienza morale come un’attestazione nell’Esserci
stesso del suo poter-essere più proprio.
[19] Ciò che la coscienza morale attesta giunge a piena determinazione
soltanto se è stato delimitato con sufficiente chiarezza quale carattere
debba avere l’ascoltare che corrisponde in modo genuino al chiamare.
La comprensione autentica, «conseguente» alla chiamata, non è una
semplice appendice del fenomeno della coscienza morale, un evento
che accade e potrebbe anche mancare. L’esperienza vissuta della
coscienza morale si può cogliere nella sua pienezza soltanto a partire
dalla comprensione del richiamo e assieme ad essa. Se il chiamante e
il richiamato sono ogni volta il medesimo Esserci proprio, ne consegue
che in ogni non-sentire-ascoltando (Ueberhoeren) la chiamata, in ogni
fraintendersi, è insito un determinato modo di essere dell’Esserci. Una
chiamata a vuoto a cui «non segue nulla» è una finzione inconcepibile
da un punto di vista esistenziale. «Che non segue nulla» significa
qualcosa di conformemente all’esserci positivo.
[20] Così, allora, soltanto l’analisi della comprensione del richiamo è
in grado di condurre all’esplicito chiarimento di ciò che la chiamata dà
ad intendere. Ma solo muovendo dalla precedente caratterizzazione
ontologico-universale della coscienza morale, è possibile capire
esistenzialmente quel «colpevole!» evocato nella coscienza morale.
Tutte le esperienze e le interpretazioni della coscienza morale sono
concordi nel riconoscere che la «voce» della coscienza morale parla in
qualche modo di «colpa».
§ 58 Comprensione del richiamo (Anrufverstehen) e colpa
[1] Per cogliere fenomenicamente ciò che è udito (das Gehoerte) nella
comprensione del richiamo (Anrufverstehen), bisogna tornare di nuovo
al richiamo (Anruf). Richiamare il Si-stesso significa incitare il seStesso più proprio al suo poter-essere, e precisamente in quanto
Esserci, cioè in quanto essere-nel-mondo prendente cura e con-essere
con gli altri. L’interpretazione esistenziale di ciò a cui la chiamata
incita, se si comprende rettamente nelle sue possibilità metodiche e nei
suoi compiti, non può quindi pretendere di delimitare alcuna singola e
concreta possibilità dell’esistenza. Ciò che può e vuole essere fissato,
non è il di volta in volta esistentivamente evocato (Gerufene) nel
rispettivo Esserci, ma ciò che appartiene alla condizione esistenziale
di possibilità del poter-essere di volta in volta effettivo-esistentivo.
[2] La comprensione esistentivamente-udente della chiamata è tanto
più autentica quanto più incondizionatamente l’Esserci ode e
comprende il suo esser-richiamato e quanto meno il senso della
chiamata è pervertito da ciò che si dice, si sente dire e si ritiene valido.
Ma qual è l’elemento costitutivo essenziale dell’autenticità della
23
comprensione del richiamo? Che cos’è ciò che è dato essenzialmente
ad intendere di volta in volta nella chiamata, anche se non sempre è
effettivamente compreso?
[3] Abbiamo già risposto a questa domanda con la tesi: la chiamata non
«dice» nulla di cui si possa discorrere; non dà notizia di eventi
mondani. La chiamata pone l’Esserci innanzi al suo poter-essere, e ciò
in quanto chiamata che viene dallo spaesamento. Il chiamante è
certamente indeterminato, ma il da-dove esso chiama non è
indifferente per il chiamare. Questo da-dove – lo spaesamento
dell’esser-gettato nell’isolamento – è «evocato» assieme al chiamare,
cioè è dischiuso insieme ad esso. Il da-dove viene la chiamata
chiamando-innanzi-a (Vorrufen auf…) coincide con il verso-dove del
richiamo che chiama indietro (des Zurueckrufens). La chiamata non dà
ad intendere un poter-essere ideale e universale: essa dischiude il poteressere come il poter-essere ogni volta individuato d’un rispettivo
Esserci. Il carattere di apertura della chiamata è determinato
pienamente solo se è inteso come richiamo-indietro chiamante-innanzi
(vorrufenden Rueckruf) . È a partire dalla chiamata così intesa che
diviene possibile chiedersi che-cosa (Was) essa dia ad intendere.
[4] Ma la risposta alla domanda circa che-cosa la chiamata dice non
potrà forse essere data più facilmente e sicuramente col «semplice»
rinvio a ciò che è in genere udito (gehoert) o non-udito-ascoltando
(ueberhoert) in tutte le esperienze comuni della coscienza morale? E
cioè che la chiamata appella l’Esserci come «colpevole!», oppure,
come accade nella coscienza morale ammonente, rinvia ad un possibile
esser-«colpevole», o ancora, come accade nella «buona» coscienza
morale, che essa conferma una «consapevolezza di mancanza di
colpa»? Se almeno quel «colpevole!» che è «concordemente»
(uebereinstimmend) riscontrato nelle esperienze e nelle interpretazioni
della coscienza morale non fosse determinato in modi così nettamente
contrastanti! Ma anche se il senso di questo «colpevole!» si potesse
determinare univocamente (einstimmig), il concetto esistenziale di
questo esser-colpevole continuerebbe a restare oscuro. Se tuttavia
l’Esserci appella se stesso come «colpevole!», da dove potremo
ricavare l’idea di colpa se non dall’interpretazione dell’essere
dell’Esserci? Ma allora rinasce il problema: chi dice come (wie) noi
siamo colpevoli e che cosa (was) significa colpa? L’idea di colpa non
può certo essere escogitata arbitrariamente e poi appiccicata
all’Esserci. Se è mai possibile una comprensione dell’essenza della
colpa, tale possibilità dovrà essere prefigurata nell’Esserci. Dove
troveremo la traccia che possa guidare allo svelamento del fenomeno?
Ogni ricerca ontologica concernente fenomeni come la colpa, la
coscienza morale, la morte deve prender le mosse da ciò che di essi
«dice» l’interpretazione quotidiana dell’Esserci. Nel modo d’essere
dell’Esserci deiettivo è implicito al tempo stesso che la sua
autointerpretazione è per lo più «orientata» inautenticamente e non
coglie l’«essenza» del fenomeno; e ciò perché le è estranea
l’impostazione ontologica del problema originaria e adeguata.
Tuttavia, in ogni visione manchevole è insieme svelato un rinvio
24
all’«idea» originaria del fenomeno. Ma da dove prendiamo il criterio
per determinare il senso esistenziale originario di «colpevole!»? Dal
fatto che questo «colpevole!» funge da predicato dell’«io sono». E se
ciò che l’interpretazione inautentica intende come «colpa» fosse insito
nell’essere dell’Esserci in quanto tale, e precisamente in modo che
l’Esserci fosse colpevole in quanto esiste di volta in volta
effettivamente?
[5] L’evocazione (Berufung) del «colpevole!» concordemente udito
non è perciò ancora la risposta al problema del senso esistenziale
dell’invocato nella chiamata (im Ruf Gerufenen). Questo deve prima
esser concettualizzato, affinché sia possibile rendere comprensibile che
cosa significa l’evocato «colpevole!», come e perché l’interpretazione
quotidiana ne travisa il significato.
[6] La comprensibilità quotidiana assume l’«esser-colpevole»
(»Schuldigsein«) innanzi tutto nel senso di «esser in debito»
(»Schulden haben«), «avere un conto aperto con qualcuno». Si deve
restituire un qualcosa a qualcuno che lo rivendica. Questo «esser
colpevole» nel senso di «indebitarsi» (»schulden«) è una maniera di
con-essere con gli altri nel quadro del prendersi cura procurando,
producendo eccetera. Modi di tale prendersi cura sono anche il privare,
il prendere a prestito, il defraudare, il sottrarre, il rubare, cioè il non dar
soddisfazione in qualche modo a rivendicazioni di possesso avanzate
da qualcuno. L’essere colpevole di questo tipo è sempre riferito a ciò
che è oggetto possibile del prendersi cura.
[7] Esser colpevole ha allora l’ulteriore significato di «esser colpa di»
[»schuld sein an«, “essere responsabile di”] cioè di esser motivo, esser
autore di qualcosa o anche «esser occasione» di qualcosa. Nel senso di
questo «aver colpa» di qualcosa si può «esser colpevole» senza «essere
in debito» con qualcuno o essergli debitore. Viceversa, si può esser in
debito di qualcosa presso qualcuno senza tuttavia averne colpa [esserne
responsabile]. Un altro può «fare debiti» presso un terzo «per me».
[8] Questi significati ordinari dell’esser-colpevole, come l’«aver debiti
presso» o l’«aver colpa di» [“esser responsabile di”], possono confluire
e determinare un comportamento che chiamiamo «rendersi colpevole»
[»sich schuldig machen«, “rendersi debitore”] cioè: essendo colpevole
di aver-debiti, ledere un diritto e rendersi così punibile. L’esigenza che
non viene soddisfatta, però, non è necessariamente riferita a un
possesso, può regolare in generale l’essere-assieme pubblico. Il
«rendersi colpevole» nella violazione in senso giuridico
(Rechtsverletzung), quale abbiamo ora chiarito, può però assumere
anche la forma di un «rendersi-colpevole verso altri». Ciò non accade
in virtù della violazione come tale, ma per il fatto che è colpa mia [“è
mia responsabilità”] se l’altro, nella sua esistenza, è messo a
repentaglio, è indotto in errore, è rovinato. Questo rendersi-colpevole
verso altri è possibile senza violazione della legge «pubblica». Il
concetto formale dell’esser-colpevole nel senso dell’essersi-resocolpevole verso l’altro può essere determinato così: esser-causa
[Grundsein, “esser fondamento”, “esser ragione”, “esser motivo”] di
25
una deficienza nell’Esserci dell’altro in modo tale che questo essercausa stesso si determini, muovendo dal suo per-che, come «difettivo».
Questa difettività consiste nel non soddisfare una esigenza che
concerne l’esistere come con-essere con gli altri.
[9] Resterebbe da vedere come nascano queste esigenze e in qual modo
siano da concepirsi in base a tale origine i rispettivi caratteri di esigenza
e di legge. Comunque, l’esser-colpevole, nell’ultimo significato di
violazione di un’«esigenza morale», è un modo di essere dell’Esserci.
Ciò vale certamente anche per l’esser-colpevole come «rendersi
punibile», «indebitarsi» e «aver colpa di» [“esser responsabile di”].
Anche questi sono comportamenti dell’Esserci. Quando si concepisce
l’«esser gravati di colpa morale» come una «qualità» dell’Esserci, si
dice in realtà ben poco. Questa interpretazione rivela soltanto che una
siffatta caratterizzazione non basta a definire ontologicamente questo
genere di «determinazione d’essere» dell’Esserci rispetto ai
comportamenti precedentemente analizzati. Il concetto di colpa morale
è così poco chiarito dal punto di vista ontologico che poterono divenire
e restare predominanti interpretazioni di questo fenomeno che fanno
rientrare in tale concetto anche l’idea delle punibilità e perfino quella
dell’aver debiti presso…, o addirittura interpretazioni che lo
determinano a partire da queste idee. Ma in tal modo il «colpevole!» è
ancora una volta ricondotto nell’ambito del prendersi cura nel senso
del calcolo inteso a pareggiare le rivendicazioni.
[10] Il chiarimento del fenomeno di colpa (Schuldphaenomen), che non
è necessariamente connesso all’«aver debiti» o alla violazione in senso
giuridico, può riuscire solo se prima si pone la questione di fondo
dell’esser-colpevole dell’Esserci, cioè se si concepisce l’idea di
«colpevole!» a partire dal modo di essere dell’Esserci.
[11] A tal fine l’idea di «colpevole» deve esser formalizzata quanto
occorre affinché i fenomeni di colpa ordinari, legati al con-essere con
gli altri prendendo cura, cadano fuori. L’idea di colpa non solo deve
essere innalzata oltre l’ambito del prendersi cura calcolante, ma deve
anche essere sciolta dal riferimento al dovere e alla legge, violando i
quali si diventa colpevole. Anche in questo caso la colpa è ancora
necessariamente assunta come deficienza, come mancanza di qualcosa
che può e deve essere. Ma «mancare» significa non essersemplicemente-presente. Deficienza come non-esser-presente di
qualcosa di dovuto è una determinazione d’essere della semplicepresenza. In questo senso all’esistenza non può mancare per essenza
nulla, non perché essa sia completa, ma perché il carattere del suo
essere è del tutto diverso da quello della semplice-presenza.
[12] Senonché, dell’idea di «colpevole!» è proprio il carattere del non.
Se il «colpevole!» deve poter determinare l’esistenza, si presenta allora
il problema ontologico di chiarire sul piano esistenziale il caratteredi-«non» (»Nichtcharakter«) di questo «non». Inoltre, all’idea di
«colpevole!» appartiene quel che nel concetto di colpa come «aver
colpa di» [“esser responsabile di”] è indifferentemente espresso, ossia,
l’esser causa di… [das Grundsein fuer…, “esser fondamento di…”,
26
“esser motivo di….”, “esser ragione di….”]. L’idea formale
esistenziale di «colpevole!» la definiamo quindi così: esser-causa di un
essere che è determinato da un «non», cioè esser-causa di una nullità.
Se l’idea del «non», quale si trova nel concetto di colpa
esistenzialmente compreso, esclude il riferimento a ogni sorta di
semplice-presenza (o possibile o richiesta), se, conseguentemente,
l’Esserci non deve affatto esser commisurato a qualcosa di
semplicemente-presente o di valido che esso stesso non sia o che non
sia nel suo modo di essere (cioè non esista), allora viene meno la
possibilità, riguardo all’esser causa di una mancanza, di calcolare
come «manchevole» un siffatto essente-causa stesso stesso. Muovendo
da una mancanza «causata» in modo conforme all’esserci, dal non
adempimento di un’esigenza, non si può affatto calcolare la
manchevolezza della «causa». L’esser causa di… non ha bisogno di
avere il medesimo carattere del «non» proprio del «privativo» che in
esso si fonda e da esso scaturisce. La causa non ha bisogno di ricevere
indietro la propria nullità soltanto da ciò che essa causa. Ma allora ne
consegue: l’esser-colpevole non risulta anzitutto da un indebitamento,
ma, al contrario, questo diviene possibile solo «a causa di» di un
originario esser-colpevole. È possibile esibire qualcosa di simile
nell’essere dell’Esserci? E come è possibile, in generale, sul piano
esistenziale?
[13] L’essere dell’Esserci è la Cura. Essa comprende in sé l’effettività
(esser-gettato), l’esistenza (progetto) e la deiezione. Essendo, l’Esserci
è gettato, non è condotto nel suo Ci da se stesso. Essendo, l’Esserci è
determinato come un poter-essere (Seinkoennen, “esser in grado di
essere”) che gli appartiene, ma tuttavia non in quanto se lo sia dato da
sé. Esistendo, esso non può aggirare il proprio esser-gettato, come se il
«che c’è e ha da essere» potesse esser svincolato dal suo esser se-Stesso
e portato come tale nel Ci. Ma l’esser-gettato non sta alle spalle
dell’Esserci come un evento fattuale (tatsaechlich), irrelativo
all’Esserci e semplicemente accaduto a esso: l’Esserci, fin quando è,
è costantemente (in quanto Cura) il proprio «che». In quanto questo
ente, affidato al quale esso unicamente può esistere come l’ente che
esso è, esso è esistendo la causa del suo poter essere. Benché non abbia
esso stesso posto la causa, l’esserci riposa nel peso di quest’ultima, che
la tonalità emotiva gli rende manifesto come disagio.
[14] In qual modo (wie) l’Esserci è questa causa gettata? Unicamente
progettandosi nelle possibilità in cui è stato-gettato. Il se-Stesso, che
come tale ha da accollarsi la causa di se stesso, non può mai insignorirsi
di questa causa; ma, esistendo, ha da assumere l’esser-causa. L’aver da
essere la proprio causa gettata (geworfenes Grund, “fondamento
gettato”, “ragione gettata”) è il poter-essere in cui ne va nella Cura.
[15] Essendo-causa, cioè esistendo come gettato, l’Esserci è
costantemente in ritardo rispetto alle proprie possibilità. Esso non è mai
esistente in anticipo (vor) rispetto alla propria causa, ma sempre solo
dalla propria causa e in quanto propria causa. Esser-causa significa,
quindi, non esser mai, fondamentalmente, signore dell’essere più
27
proprio. Questo non rientra nel senso esistenziale dell’esser-gettato.
L’Esserci, essendo-causa, è, come tale, una nullità di se stesso. Ma
«nullità» non significa affatto non esser-presente, insussistenza; essa
concerne un «non» che è costitutivo dell’essere dell’Esserci, del suo
esser-gettato. Il carattere-di-non di questo non si determina
esistenzialmente: essendo se-Stesso, l’Esserci è l’ente gettato in quanto
se-Stesso; svincolato dalla causa, non in virtù di se stesso, ma in se
stesso, per essere in quanto questa causa. L’Esserci non è esso stesso
la causa del suo essere nel senso che questa causa derivi da un progetto
dell’Esserci; ma l’Esserci, in quanto se-Stesso, è l’essere della causa.
Questa causa è sempre e solo causa di un ente il cui essere ha da
accollarsi l’esser-causa.
[16] L’Esserci è la sua causa esistendo, ossia è tale da comprendersi a
partire da possibilità e, così comprendendosi, esser l’ente gettato. Dal
che deriva: potendo essere, l’Esserci sta di volta in volta o nell’una o
nell’altra possibilità; esso costantemente non è un’altra [possibilità], e
vi ha rinunciato nel progetto esistentivo. Il progetto, in quanto di volta
in volta gettato, non è soltanto determinato dalla nullità dell’essercausa, ma è essenzialmente nullo proprio in quanto progetto. Questa
determinazione non indica affatto, daccapo, una qualità ontica come
l’«inefficienza» o il «disvalore», ma è un costitutivo esistenziale della
struttura dell’essere del progettare. La nullità di cui parliamo fa parte
dell’esser-libero dell’Esserci per le sue possibilità esistentive. Ma la
libertà è solo nella scelta di una possibilità, cioè nel sopportare di nonaver-scelto e di non-poter-scegliere le altre.
[17] Tanto nella struttura dell’esser-gettato quanto in quella del
progetto è insita per essenza una nullità. Essa è la causa della possibilità
della nullità dell’Esserci non-autentico nella deiezione, in cui esso di
volta in volta già da sempre effettivamente è. La Cura stessa, nella sua
essenza, è totalmente permeata di nullità. Perciò la Cura, cioè l’essere
dell’Esserci, significa in quanto progetto gettato: il (nullo) esser-causa
di una nullità. Il che significa: l’Esserci è, come tale, colpevole;
ammessa che sia legittima la determinazione esistenziale formale della
colpa come esser-causa di una nullità.
[18] La nullità esistenziale non ha affatto il carattere di una privazione,
di una manchevolezza rispetto a un ideale proclamato e non raggiunto
nell’Esserci. È l’essere di questo ente a esser nullo precedentemente a
tutto ciò che può progettare e per lo più raggiunge, a esser nullo già
come progettare. La nullità non compare occasionalmente nell’Esserci
per inerirgli come una qualità oscura che esso – qualora fosse
abbastanza progredito — potrebbe anche rimuovere.
[19] Ciò nonostante il senso ontologico della nullezza di questa nullità
esistenziale resta ancora oscuro. E ciò vale anche per l’essenza
ontologica del «non» in generale. L’ontologia e la logica hanno preteso
molto dal «non» e, di conseguenza, hanno fatto vedere a tratti le sue
possibilità, senza però giungere al suo disvelamento ontologico.
L’ontologia trovò il «non» e ne fece uso. Ma è proprio così ovvio che
ogni «non» significhi una negatività nel senso di una deficienza? La
28
sua positività si esaurisce nel costituire un «passaggio»? Perché ogni
dialettica si rifugia nella negazione, senza essere in grado di fondarla
essa stessa dialetticamente, o almeno di determinarla in quanto
problema? È mai stato posto il problema dell’origine ontologica della
nullezza o, in primo luogo, si sono almeno cercate le condizioni sulla
cui base può essere posto il problema del «non», della sua nullezza e
della sua possibilità? E dove mai queste condizioni potranno esser
reperite se non nella chiarificazione tematica del senso dell’Esserci in
generale?
[20] I concetti di privazione e di manchevolezza, oltre tutto poco chiari,
non sono sufficienti nemmeno per l’interpretazione ontologica del
fenomeno della colpa, anche se, intesi in termini sufficientemente
formali, ammettono un’ampia utilizzazione. Meno che mai, però, è
possibile orientare la ricerca intorno al fenomeno esistenziale della
colpa sull’idea del malum in quanto privatio boni. Bonum e privatio
provengono entrambi dall’ontologia della semplice-presenza, non
diversamente dall’idea di «valore» che da ciò essi «tirata fuori».
[21] L’ente il cui essere è la Cura non solo si può coprire di colpe
effettive, ma è colpevole nel fondamento del suo essere; questo essercolpevole costituisce la condizione ontologica della possibilità che
l’Esserci, esistendo, diventi colpevole. Questo esser-colpevole
essenziale è cooriginariamente la condizione esistenziale della
possibilità del bene e del male «morale», cioè della moralità in generale
e della possibilità delle sue modificazioni effettive. L’esser-colpevole
originario non può essere determinato in base alla moralità perché
questa già lo presuppone per se stessa.
[22] Ma quale esperienza parla in favore di questo esser-colpevole
originario dell’Esserci? Non si trascuri però la contro-domanda: la
colpa «c’è» (ist… da) solo quando si risveglia una consapevolezza
della colpa? Oppure, proprio nel fatto che la colpa «dorme» si
annuncia l’originario esser colpevole? Che l’esser-colpevole, innanzi
tutto e per lo più, resti non aperto e che la deiettività dell’Esserci lo
mantenga nella chiusura, non fa che rivelare la nullità di cui abbiamo
discorso. L’esser-colpevole è più originario di ogni sapere che lo
concerne. Soltanto perché l’Esserci è colpevole nel fondo del suo
essere e soltanto perché, in quanto gettato nella deiezione, si chiude a
se stesso, diviene possibile la coscienza morale, se è vero che la
chiamata in fondo dà ad intendere questo esser-colpevole.
[23] La chiamata è chiamata della Cura. L’esser-colpevole costituisce
l’essere che noi denominiamo Cura. Nello spaesamento, l’Esserci sta
originariamente con se stesso. Lo spaesamento porta l’Esserci in
cospetto della sua integra nullità che rientra nella possibilità del suo
poter-essere più proprio. Poiché nell’Esserci, in quanto Cura, ne va del
suo essere, è dallo spaesamento che l’Esserci si incita, quale Si-stesso
effettivamente deietto, al suo poter-essere. Il richiamo è un richiamoindietro chiamando-innanzi (ein vorrufende Rueckruf): Innanzi (vor)
alla possibilità di assumere, esistendo, quell’ente gettato che l’Esserci
è; indietro (zurueck) nell’esser-gettato, per comprenderlo come la nulla
29
causa che l’Esserci, esistendo, ha da assumere. Il richiamo-indietro
chiamando-innanzi, proprio della coscienza morale, dà ad intendere
all’Esserci che esso – nulla causa di un progetto nullo stando nella
possibilità del suo essere — deve andare riprendersi dall’essersiperduto nel Si; dà cioè ad intendere all’Esserci che è colpevole.
[24] Ciò che l’Esserci dà così ad intendere, sarebbe allora una semplice
notizia di sé stesso. E l’ascoltare corrispondente ad una tale chiamata
non sarebbe allora che un prender atto del fatto «colpevole!». Ma se la
chiamata ha il carattere di incitare a…, questa interpretazione della
coscienza morale non condurrà ad un completo pervertimento della
funzione della coscienza morale? «Incitare all’esser-colpevole» non
verrà a significare incitare alla malvagità?
[25] Anche l’interpretazione più forzata della coscienza morale si
rifiuterà di attribuirle questo senso di chiamata. Ma che significa allora
«incitare all’esser colpevole»?
[26] Il senso di chiamata diviene chiaro solo se la comprensione,
anziché assumere un concetto di colpa derivato (nel senso di
colpevolezza «risultante» da un’azione o da una omissione), si atterrà
al senso esistenziale dell’esser-colpevole. Un’esigenza di questo
genere non è arbitraria, se si tiene presente che la chiamata della
coscienza morale muove dall’Esserci e si indirizza esclusivamente
all’Esserci stesso. Ma in tal caso l’incitare al proprio esser-colpevole
equivale a un chiamare-innanzi a quel poter-essere che, in quanto
Esserci, già sempre sono. Questo ente non ha bisogno di contrarre una
«colpa» mediante azioni od omissioni, esso non deve che essere
autenticamente quel «colpevole!» che, essendo, è.
[27] L’ascolto genuino del richiamo equivale allora
all’autocomprensione dell’Esserci nel suo poter-essere più proprio,
cioè a un autoprogettarsi nel poter-divenir-colpevole più proprio e
autentico. Il comprendente lasciarsi-chiamare-innanzi a questa
possibilità porta con sé il rendersi libero da parte dell’Esserci per la
chiamata: la disponibilità per il poter-esser-chiamato. Comprendendo
la chiamata, l’Esserci è obbediente (hoerig) alla sua possibilità di
esistenza più propria. Ha scelto se stesso.
[28] Con questa scelta, l’Esserci rende possibile a se stesso quel più
proprio esser-colpevole che resta invece precluso al Si-stesso. La
comprensione comune, propria del Si, non conosce che l’ottemperanza
o la violazione di regole pratiche e norme pubbliche. Essa procede
computando manchevolezze ed escogitando compensazioni. Si è già
sottratta all’esser-colpevole più proprio per parlare a voce tanto più alta
di mancanze. Ma nel richiamo il Si-stesso è richiamato all’essercolpevole che è più proprio del suo se-Stesso. La comprensione della
chiamata è una scelta; non però della coscienza morale che, in quanto
tale, non può essere scelta. Ciò che è scelto è l’aver-coscienza morale
come esser-libero per il più proprio esser-colpevole. Comprensione del
richiamo significa: voler-aver-coscienza morale.
[29] Con questa espressione non si vuole alludere al voler avere una
«buona coscienza morale» e neppure alla sollecitazione volontaria
30
della chiamata, ma unicamente alla disponibilità per l’essere chiamati.
Il voler-aver-coscienza morale è tanto lontano dalla ricerca di
colpevolezze effettive quanto lo è dalla tendenza a una liberazione
dalla colpa in quanto esser «colpevole!» essenziale.
[30] Il voler-aver-coscienza morale è invece il presupposto esistentivo
più originario per la possibilità del divenir-colpevole effettivo.
Comprendendo la chiamata, l’Esserci lascia agire in sé il se-Stesso più
proprio in base al poter-essere che ha scelto. Solo così l’Esserci può
essere responsabile. Ma ogni agire è di fatto necessariamente
«incosciente» (»gewissenlos«), non soltanto perché non evita colpe
morali effettive, ma perché, con-essendo già sempre con gli altri sul
nullo fondamento del suo nullo progettare, si è reso colpevole nei loro
confronti. In tal modo il voler-aver-coscienza morale diventa
l’accettazione della essenziale mancanza di coscienza morale entro la
quale soltanto sussiste la possibilità esistentiva di essere «buono».
[31] Sebbene nell’immediato la chiamata non dia nulla a conoscere,
essa non è soltanto critica, bensì positiva. La chiamata apre il poteressere più originario dell’Esserci in quanto esser-colpevole. La
coscienza morale si rivela quindi come un’attestazione appartenente
all’essere dell’Esserci, in cui l’Esserci è chiamato davanti al suo poteressere più proprio. Questo poter-essere autentico, così attestato, può
essere definito esistenzialmente in modo più concreto? Prima di tutto
bisogna chiedersi: l’analisi da noi compiuta di un poter-essere attestato
dall’Esserci stesso potrà vantare una sufficiente evidenza finché non
sia stato fugato il timore che la coscienza morale sia stata interpretata
unilateralmente col riportarla alla costituzione dell’Esserci, senza tener
conto dei dati noti all’interpretazione ordinaria della coscienza morale?
Nell’interpretazione da noi proposta, il fenomeno della coscienza
morale è ancora riconoscibile così com’esso «realmente» è? Non sarà
stata eccessiva la sicurezza con cui abbiamo desunto l’idea della
coscienza morale dalla costituzione dell’Esserci?
[32] Si deve ora garantire anche alla comprensione ordinaria della
coscienza morale la via d’accesso all’ultimo passo della
interpretazione della coscienza morale, ossia alla delimitazione
esistenziale del poter essere autentico attestato nella coscienza morale.
A tal fine, c’è bisogno della dimostrazione esplicita della connessione
fra i risultati dell’analisi ontologica e le esperienze quotidiane della
coscienza morale.
Da: M. Heidegger, Essere e tempo (tr. di P. Ciccarelli)
31
0140.p000-000_heidegger.qxd
12-12-2006
16:07
Pagina 2
Da: Filosofia e cultura, vol. 3b, Il Novecento (La Nuova Italia, 20o7) capitolo: Martin Heidegger (a
cura di P. Ciccarelli)
Introduzione
Heidegger
L
a filosofia di Heidegger ruota tutta intorno a un problema molto antico, posto per
la prima volta dai pensatori greci agli esordi
della filosofia occidentale: il problema dell’essere. Non si tratta però di un semplice
ritorno al passato. Heidegger muove infatti dall’insegnamento del suo maestro Edmund Husserl, il fondatore
della fenomenologia. Il problema dell’essere coincide
cioè con quello dell’apparire o manifestarsi degli enti.
Per Heidegger, però, l’apparire non dipende, come
Husserl aveva sostenuto, dalla coscienza, dipende bensì dall’attività pratica umana. Questa è la tesi di fondo espressa nella sua opera principale, Essere e tempo,
nella quale vengono analizzati i due modi principali dell’attività umana: l’esistenza inautentica e l’esistenza
autentica. Quella inautentica è l’esistenza quotidiana,
nella quale l’uomo si immedesima con il mondo in cui
vive, lasciandosi guidare acriticamente dalle convenzioni sociali. L’esistenza autentica è invece l’esperienza
umana della libertà.
1
Alla fine degli anni Trenta, Heidegger riesamina criticamente alcuni presupposti basilari di Essere e tempo. Si convince così che l’apparire non dipende, come lui stesso
aveva sostenuto, dall’uomo, ma è un puro e semplice
evento storico che non ha né causa né autore. Si
tratta dell’evento o storia dell’essere, con la quale l’uomo
è in contatto soprattutto grazie al linguaggio. La filosofia
diventa così per Heidegger essenzialmente interpretazione delle parole di pensatori e poeti del passato,
nelle quali la storia dell’essere si è resa manifesta. In base
a questa interpretazione o meditazione storica, Heidegger denuncia il nichilismo dell’umanità occidentale,
il fatto cioè che l’essere sia stato dimenticato o considerato come equivalente a nulla. Espressione suprema del
nichilismo occidentale è la tecnica moderna. L’opera di
Heidegger è stata tradotta e studiata in tutto il mondo,
riscuotendo consensi e suscitando critiche, talvolta anche
aspre. L’attualità di Heidegger è da attribuire anzitutto
alla sua capacità di interrogarsi criticamente sull’identità
culturale dell’Occidente.
Vita e opere
Martin Heidegger nacque a Meßkirch, in Germania, nel 1889. Dopo aver intrapreso studi teologici, nel 1919 decise di allontanarsi dal cattolicesimo per dedicarsi completamente alla filosofia. Studiò con il neokantiano Heinrich Rickert (1863-1936), ma l’impronta decisiva al suo pensiero fu impressa dal fondatore della fenomenologia, Edmund Husserl (1859-1938). Non tardò
ad acquisire notorietà pubblica con lezioni, tenute nelle Università di Friburgo e Marburgo, che
affascinarono gli ascoltatori per l’inaudita radicalità e spregiudicatezza del modo di leggere i
testi filosofici. Notorietà che si consolidò e allargò oltre i confini della Germania quando Heidegger pubblicò il suo primo importante libro, Essere e tempo (Sein und Zeit, 1927). La personalità di Heidegger presenta una sconcertante mescolanza di radicalismo critico, a tratti anche
rivoluzionario, e di filisteismo morale. Ne è prova la sua pronta adesione al nazionalsocialismo
nel 1933 (un episodio su cui torneremo più avanti, v. §§ 3.1 e 3.3.1). Da un lato, Heidegger spronava i suoi colleghi filosofi e scienziati a non starsene in disparte, ad assumersi eroicamente la
propria responsabilità partecipando attivamente alla «rivoluzione nazionalsocialista». Dall’altro, però, accettava compromessi meschini, come accadde ad esempio quando, in occasione di
una nuova edizione di Essere e tempo, in ossequio alla politica antisemita del regime tolse la dedica al suo maestro Husserl, ebreo. Anche l’atteggiamento dopo la guerra non è privo di ambiguità. Dopo essere stato sospeso dall’insegnamento per ordine delle forze di occupazione, Heidegger accettò di buon grado l’aiuto offertogli da allievi e estimatori per riabilitarlo. Si difese da
chi gli rimproverava le trascorse scelte politiche, dicendo di essersene subito pentito e di aver poi
sempre mantenuto un atteggiamento ostile nei confronti del regime. Eppure, in nessuno degli
Il Novecento
2
0140.p000-000_heidegger.qxd
12-12-2006
16:07
Pagina 3
scritti e in nessuna delle conferenze
pubbliche tenute dal dopoguerra in
poi, troviamo una presa di posizione
chiara e univoca contro il nazismo.
Ostinato, e da molti giudicato gravissimo, fu il silenzio di Heidegger
sui temi più inquietanti legati al passato politico del suo paese, ossia la
deportazione e lo sterminio degli
ebrei. Morì nel 1976.
Tra le sue opere, oltre al già ricordato Essere e tempo: La dottrina delle
categorie e del significato in Duns Scoto
(Die Kategorien- und Bedeutungslehre
des Duns Scotus, 1916), Kant e il problema della metafisica (Kant und das
Problem der Methapysik, 1929), Che
cos’è metafisica? (Was ist Metaphysik?,
1929), Dell’essenza del fondamento
(Vom Wesen des Grundes, 1929), La
dottrina platonica della verità (Platons
Lehre der Wahrheit, 1942), Dell’essenza della verità (Vom Wesen der
Wahrheit, 1943), Lettera sull’«umanismo» (Brief über den «Humanismus»,
1946), L’origine dell’opera d’arte (Der
Ursprung des Kunstwerkes, 1950 ma
risalente al 1935-36), Il detto di Anassimandro (Der Spruch des Anaximan- i Martin Heidegger
der, 1950) Introduzione alla metafisica
(Einführung in die Metaphysik, 1953, ma risalente al 1935), Il principio del fondamento (Der Satz
vom Grund, 1957), Abbandono (Gelassenheit, 1959), In cammino verso il linguaggio (Unterwegs zur
Sprache, 1959), Nietzsche (Nietzsche, 1961), La tecnica e la svolta (Die Technik und die Kehre, 1962),
Sulla cosa del pensiero (Zur Sache des Denkens, 1969).
2
2.1
Problema
dell’essere
e analitica
esistenziale
Il primo Heidegger: la fenomenologia dell’esistenza umana
Problema dell’essere e analitica esistenziale
Il primo libro importante di Heidegger, rimasto altresì il più famoso, Essere e tempo si apre con una
strana affermazione: «la domanda sull’essere è oggi dimenticata». Compito della filosofia è
anzitutto «ricordare» la domanda sull’essere (o «problema dell’essere», Seinsfrage) al fine di fare
dell’essere il tema specifico di una scienza apposita, l’ontologia. Sennonché, a parte questi e altri
brevi cenni contenuti nell’introduzione, il libro non tratta affatto dell’essere. Tratta bensì di un
«ente particolare», quell’ente cioè che, rispetto a tutti gli altri enti, ha la «peculiarità» di «comprendere l’essere». È l’ente che pone la domanda sull’essere: l’uomo o, secondo la terminologia
adottata da Heidegger, l’«esserci» (Dasein). In Essere e tempo, il termine «esserci» è sempre sinonimo di “uomo”: un uso terminologico dovuto al ruolo che l’indagine sull’uomo svolge nell’ambito
del progetto più generale abbozzato, ma non realizzato, in Essere e tempo, l’edificazione di una
«scienza dell’essere» od «ontologia generale». L’uomo è l’esserci nel senso che è l’essere che è anzitutto dato, ossia l’essere che «c’è», qui e ora, ogni volta che ne venga posto il problema. L’espressione “ci” contenuta nella parola “esserci” chiama dunque direttamente in causa l’e3
Heidegger
0140.p000-000_heidegger.qxd
12-12-2006
16:07
Pagina 4
Di cosa si occupa Essere e tempo?
In sintesi
Il progetto di
Essere e tempo
è
una indagine ontologica
basata su una critica
del soggetto
trascendentale
infatti
prima di edificare una scienza dell’essere
occorre svolgere una analitica esistenziale
(ossia un’analisi
dell’esserci dell’uomo – Dasein)
sperienza umana dell’essere. Affinché si possa edificare una vera e propria scienza dell’essere,
occorre dunque prima svolgere un’analisi dell’essere dell’uomo, o «analitica esistenziale» (l’aggettivo “esistenziale” viene da “esistenza”, appellativo dato da Heidegger all’essere dell’uomo).
attenzione, glossa su tre righi
Il problema
dell’essere
nell’antichità
Il tema dell’essere su cui Heidegger richiama l’attenzione è antico quanto la filosofia stessa. È
infatti il tema del pensiero filosofico greco sin da Parmenide ❚ v. vol. I, capitolo, pp. 000-000 ❚. C’è
però un’evidente differenza tra il modo antico e quello heideggeriano di porre il problema dell’essere. In Parmenide, infatti, la nozione di “essere” è definita in opposizione a quella di “esserci”.
Parmenide stabilisce cioè una separazione netta tra l’essere, o «verità», e quella che chiama doxa,
l’«opinione», ossia il modo in cui le cose appaiono all’esperienza umana (il sostantivo doxa deriva
infatti dal verbo dokèin, “apparire”, “mostrarsi”). Si tratta della medesima separazione che Platone stabilisce tra il mondo delle idee, accessibile solo alla mente, e la realtà visibile. Già Platone, ma
soprattutto Aristotele avverte la necessità, per così dire, di “gettare un ponte” tra la dimensione
della verità dell’essere e quella dell’opinione umana. Tanto nella filosofia antica quanto in quella
medioevale, però, il discorso sull’essere (ontologia) si congiunge con difficoltà al discorso sull’uomo (antropologia) e, per questa ragione, viene per lo più articolato come discorso su Dio (teologia), inteso come l’unico ente in grado di conseguire una conoscenza assolutamente vera.
Il problema
della coscienza
nel pensiero
moderno
Proprio questa difficoltà a far coesistere ontologia ed esperienza umana determina, nel corso della
filosofia moderna, il progressivo accantonamento del problema dell’essere e lo spostamento dell’attenzione su un’altra questione, il problema della coscienza. A questa tradizione moderna,
che parte da Cartesio e passa per Kant e l’idealismo classico tedesco (Fichte, Hegel, Schelling), si
ricollega il maestro di Heidegger, Edmund Husserl ❚ v. vol. III, nome capitolo, § 4, pp. 000-000 ❚.
Come testimoniano i corsi universitari tenuti da Heidegger negli anni Venti, Essere e tempo nasce
da un confronto critico con la fenomenologia di Husserl. Richiamandosi alla necessità di porre il problema dell’essere, Heidegger intende anzitutto rivolgere una critica alla tradizione moderna. Per capire perché mai Heidegger ponga un problema così singolare e, per così dire, “superato”
come il problema dell’essere, occorre dunque per prima cosa capire la sua critica a Husserl.
2.2
Il confronto critico con Husserl
L’idealismo
fenomenologico
di Husserl
In un corso universitario del 1925, intitolato Prolegomeni alla storia del concetto di tempo (Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs), Heidegger individua nel pensiero di Husserl un dogma,
ossia un presupposto ereditato dalla tradizione senza adeguata giustificazione. Si tratta
dell’«idealismo fenomenologico» di Husserl, più precisamente, della tesi secondo cui il
manifestarsi delle cose, dunque il «fenomeno» nel senso strettamente fenomenologico dell’espressione, ha luogo soltanto nella coscienza e per la coscienza ❚ v. vol. III, nome capitolo, § 5, pp.
000-000 ❚. Husserl dà cioè per scontato che, ad esempio, il manifestarsi di un albero si possa
spiegare soltanto presupponendo che vi sia una coscienza che lo percepisce (o lo ricorda, lo
immagina, lo giudica scientificamente ecc.). Il percepire (o il ricordare, l’immaginare, il giudicare) è il vissuto di coscienza grazie al quale l’albero si manifesta. La fenomenologia è di conseguenza per Husserl riflessione sui modi della coscienza nei quali tutto ciò che è si manifesta.
Il problema
fenomenologico
della trascendenza
Più in particolare, la fenomenologia ha il compito di spiegare il darsi alla coscienza soggettiva di
ciò che è oggettivo, ossia di ciò che si manifesta come un in sé indipendente dal soggetto. L’albero, infatti, qualunque sia il modo in cui lo colgo (sia quindi che lo percepisca, lo immagini, lo
Il Novecento
4
0140.p000-000_heidegger.qxd
12-12-2006
16:07
Pagina 5
giudichi ecc.) si presenta come un oggetto, ossia come qualcosa che è indipendente dal mio
coglierlo. Husserl chiama questa indipendenza dell’oggetto dal soggetto la sua «trascendenza»:
la cosa percepita trascende, sta oltre la coscienza, dunque sta fuori della coscienza che la percepisce. La fenomenologia husserliana riconduce la trascendenza dell’oggetto all’«immanenza»
dei vissuti intenzionali, la spiega cioè come un prodotto della coscienza. In parole più semplici,
l’albero si manifesta come indipendente dalla coscienza che lo percepisce perché, secondo Husserl, la coscienza stessa attribuisce all’albero questa sua indipendenza da lei. Per Husserl, quindi,
non c’è essere che non sia essere di coscienza, giacché anche tutto quanto si presenta come altro
dalla coscienza è tale, in realtà, soltanto nella coscienza e per la coscienza.
La critica di
Heidegger al
coscienzialismo
moderno
Heidegger critica il primato attribuito da Husserl alla coscienza, ossia il suo «coscienzialismo» o
«soggettivismo». Lo critica però rimanendo sul terreno stesso della fenomenologia, condividendo
cioè con Husserl il problema che, secondo Heidegger, l’idealismo non riesce a risolvere. Quale
problema? Il problema fenomenologico, cioè dell’indagine filosofica circa l’apparire, il manifestarsi di ciò che è. Benché Heidegger trasformi profondamente la terminologia di Husserl (soprattutto
nella sua seconda fase, come vedremo), il suo può essere definito un pensiero fenomenologico.
Diverse sono però le vie fenomenologiche aperte da Husserl e da Heidegger. Husserl, considerando la coscienza come luogo d’origine dell’apparire, rimane saldamente legato alla tradizione soggettivistica moderna iniziata da Cartesio. Heidegger, invece, criticando il primato della coscienza,
cerca di aprire all’indagine fenomenologica una via nuova, alternativa a quella moderna.
Il primato
della presenza
percettiva
in Husserl
Questa esigenza di liberarsi dalla tradizione moderna, viva e presente lungo tutto lo svolgimento del pensiero di Heidegger, nasce da una considerazione tanto semplice quanto basilare circa
la natura del fenomeno, ossia dell’apparire stesso. Per Husserl, l’apparire di qualcosa
significa anzitutto il suo essere presente. La cosa si manifesta quando è presente «direttamente» o – come Husserl ama dire – «in carne e ossa». Tutti gli altri modi di manifestazione
(come ad esempio, il ricordo, l’immaginazione, il simbolismo matematico ecc.) sono modi soltanto indiretti, dunque secondari e imperfetti. La «presentazione» dell’oggetto, ossia la sua percezione diretta, ha dunque un primato rispetto a tutte le forme di manifestazione nelle quali
l’oggetto rimane ancora in parte assente.
La critica
di Heidegger
alla presenza
percettiva
Heidegger contesta il primato attribuito da Husserl alla presenza. L’apparire – osserva
Heidegger – non ha luogo anzitutto nella forma della percezione diretta, ossia dell’avere in presenza l’oggetto da parte della coscienza. Si tratta, in fondo, di un’osservazione ovvia che ciascuno di noi può fare riflettendo, ad esempio, su quanto accade ora, mentre ci troviamo nella nostra stanza a studiare. Dinanzi a noi c’è il libro, la penna, la scrivania, il computer, accanto c’è
la finestra, la porta ecc. La domanda che guida il pensiero fenomenologico di Heidegger è: in che senso
tutte queste cose «ci sono», «sono
qui»? Noi possiamo, certo, guardare
separatamente ciascuna di esse, considerarle cioè in sé come oggetti presenti dinanzi a noi. Tuttavia, il libro,
la penna, la scrivania, il computer, la
finestra, la porta ecc. ci sono anche
o René Magritte, La rivelazione del presente
(1936, New York, collezione privata). La
critica di Heidegger al suo maestro Edmund
Husserl ruota attorno al concetto di
presenza e al primato che Husserl aveva ad
essa attribuito. Per Heidegger, invece,
fenomeno è soprattutto ciò che non si
manifesta rimanendo assente.
5
Heidegger
0140.p000-000_heidegger.qxd
12-12-2006
16:07
Pagina 6
Per Heidegger il primato della presenza non è valido
In sintesi
Non c’è niente che
determini l’esistenza.
L’esistenza
precede
l’essenza
(Gli enti, ad esempio,
si manifestano
in quanto mezzi
adatti a uno scopo).
Esistere significa
anzitutto
attuare possibilità di agire
(e non semplicemente
conoscere oggetti).
La prassi precede la
conoscenza.
senza che vi prestiamo attenzione. Il libro, ad esempio, è qui ma non lo vediamo come libro,
piuttosto lo leggiamo per apprenderne il contenuto. La penna accanto al libro c’è ma non ci
facciamo caso, e se vi prestiamo attenzione è soltanto per afferrarla e scrivere. La sedia su cui
siamo seduti c’è senza che la guardiamo, né la guardiamo quando la spostiamo per alzarci. Se
ci alziamo e apriamo la porta, non osserviamo direttamente la porta, né guardiamo la maniglia
che afferriamo per aprirla. Insomma, anzitutto le cose ci sono, dunque si manifestano, appaiono senza essere «tematicamente» presenti, senza cioè essere il tema esplicito di una percezione
diretta. Possono divenire «tematiche», possono essere percepite, ma «innanzitutto e per lo più»
non sono oggetti percepiti, dunque non hanno il carattere della presenza.
Il non
manifestarsi
del fenomeno
in senso
fenomenologico
2.3
Per comprendere il senso di queste osservazioni occorre tener presente quanto abbiamo già detto, ossia che, pur criticando Husserl, Heidegger intende rimanere sul terreno della fenomenologia. Questo implica però una revisione radicale del concetto stesso di fenomeno. Fenomeno
non è soltanto ciò che si manifesta, ma anche e soprattutto ciò che rimane assente e
che dunque, in un certo senso, non si manifesta. Sembra un paradosso, ma è in realtà
quanto risulta dalle osservazioni che abbiamo appena fatto. Il libro, la penna, la sedia, la porta,
la maniglia, l’intera stanza con tutto quanto vi è contenuto si manifesta rimanendo
assente. Per accorgercene basta riflettere su quanto ci accade in questo momento. Il rapporto
che c’è ora tra me e il libro non è di tipo percettivo, cioè io non vedo il libro, ma lo leggo. Lo stesso vale per la sedia: non la percepisco, ma ci sto seduto. Parimenti per la maniglia: non la osservo, ma la afferro per aprire la porta.
L’essere nel mondo
L’ente in quanto
mezzo
utilizzabile
Il rapporto con le cose che abbiamo appena esemplificato è chiamato in Essere e tempo «prendersi cura» o anche «commercio», «avere a che fare» con gli enti. Nel prendersi cura, ossia nell’atteggiamento pratico dell’uomo, gli enti si manifestano in quanto mezzi adatti a un
determinato scopo ❚ Lettura 1 ❚. Il libro si manifesta nel leggerlo, la penna nello scrivere, la porta nell’aprirsi e consentire il passaggio. Il libro, la penna, la sedia, la porta sono cioè anzitutto enti
«utilizzabili». Un utilizzabile – questa è appunto la sua peculiarità fenomenologica – si manifesta assentandosi, sottraendosi alla percezione diretta. Per poter scrivere, infatti, non devo guardare la penna; questa deve – afferma Heidegger – «ritirarsi nella sua utilizzabilità», non deve diventare vistosa, presentarsi isolatamente. La penna diventa vistosa soltanto quando, ad esempio, non
scrive più perché è finito l’inchiostro, ossia quando costringe a interromperne l’utilizzo.
Utilizzabilità
e semplice
presenza
Heidegger chiama il modo d’essere degli enti utilizzabili «utilizzabilità». Con il termine
«modo d’essere» Heidegger intende l’apparire, il manifestarsi dell’ente. Un altro modo d’essere,
dunque un’altra forma di apparire, è la «semplice presenza». L’ente diventa una semplice
presenza quando è considerato come oggetto. È così, ad esempio, quando osservo un libro per
metterne in evidenza analiticamente le proprietà, quando cioè affermo: “questo libro è un solido di forma rettangolare, è lungo 20 centimetri, largo 15, alto 5, pesa 500 grammi, è di colore
bianco, è composto da una copertina, un certo numero di pagine ecc.” La semplice presenza è
dunque il modo di apparire degli enti allorché divengono oggetti di conoscenza.
Il Novecento
6
0140.p000-000_heidegger.qxd
12-12-2006
16:07
Pagina 7
Il sistema
di rimandi
La conoscenza che mira a determinare l’ente in quanto semplice presenza è secondo Heidegger
soltanto uno dei possibili modi in cui l’uomo si rapporta agli enti. Ma non è il modo primario.
Primario è invece il prendersi cura, il rapporto pratico nel quale gli enti appaiono come mezzi
utilizzabili adatti a uno scopo. Nell’apparire come mezzi, gli enti si inseriscono in quello che
Heidegger chiama «sistema di rimandi». Ogni singolo mezzo cioè rimanda allo scopo possibile a cui è adatto, scopo che, a sua volta, è sempre mezzo che rimanda a un altro scopo possibile. La sedia rimanda alla possibilità di stare seduti, lo stare seduti alla possibilità di leggere il
libro, il leggere il libro alla possibilità di apprendere la lezione ecc. Il sistema dei rimandi è dunque la totalità, l’insieme unitario delle connessioni tra i mezzi
Il concetto
di mondo
e la critica
dell’io come
sfera
immanente
La totalità dei rimandi è chiamata da Heidegger anche «mondo». L’essere dell’esserci (così,
ricordiamo, Heidegger chiama l’uomo) è un «essere nel mondo». Anche questa nozione centrale dell’analitica esistenziale implica una critica nei riguardi di Husserl e, più in generale, della
tradizione soggettivistica. Affermando che l’esserci è in se stesso un essere nel mondo, Heidegger vuole contrastare l’idea di origine cartesiana secondo cui l’uomo sarebbe anzitutto chiuso
nel proprio io, in quella che Husserl chiamava l’«immanenza di coscienza», e debba quindi cercare il modo di uscire da sé, ossia di trascendere la propria immanenza per entrare in contatto
con oggetti posti fuori di lui. Essere nel mondo significa che l’esserci è in se stesso «trascendente», è cioè – afferma Heidegger – «già sempre fuori di sé presso il mondo». Che cosa significa? Torniamo ai nostri esempi. Nello stare seduti sulla sedia, nel leggere il libro, nello scrivere
con la penna, nell’aprire la porta, tutti questi enti non ci stanno semplicemente di fronte come
oggetti estranei. Ci sono bensì familiari nel senso che sono commisurati a noi, al nostro poterli
usare, e noi stessi ci adattiamo perciò alla loro forma. La penna, ad esempio, è anzitutto una
cosa che può essere afferrata e dunque è fatta a misura della nostra mano (per questo il termine
tedesco usato da Heidegger per “utilizzabile” è Zuhandenes, che letteralmente significa: “ciò che
è portata di mano”). Per usare la penna, però, occorre imparare a disporre le dita, la mano, il
braccio e tutto il corpo in un certo modo. Usare un mezzo significa cioè saperlo padroneggiare
con il corpo, dunque non osservarlo astrattamente dall’esterno, ma «immedesimarsi», fare
tutt’uno con esso. Questa immedesimazione con il mezzo, necessaria al suo funzionamento, è
appunto l’essere fuori di sé presso il mondo.
2.4
Autenticità e inautenticità
2.4.1
La fonte aristotelica: pòiesis e praxis
L’antecedenza
della prassi
alla conoscenza
Mostrando che gli enti con cui l’esserci è quotidianamente in rapporto sono anzitutto mezzi utilizzabili, e soltanto secondariamente semplici presenze oggetto di osservazione teorica, Heidegger, per così dire, assegna alla prassi un primato sulla teoria. Esistere significa anzitutto
attuare possibilità di agire e non semplicemente conoscere oggetti ❚ Lettura 1 ❚.
L’origine storica
di quest’idea
nell’Ottocento<
GLOSSA
SENZA A
CAPO>
È questa un’idea largamente diffusa nella cultura europea, non soltanto filosofica, sin dall’Ottocento. Basti pensare al maggior esponente del romanticismo tedesco, Goethe ❚ v. vol. III, nome
capitolo, § 0, pp. 000-000 ❚, che aveva fatto dire al protagonista di un suo celebra dramma, il Faust: «in principio fu l’azione». E, per restringerci alla filosofia, si pensi alle critiche dell’idealismo
speculativo di Hegel da parte di Marx ❚ v. vol. III, nome capitolo, § 0, pp. 000-000 ❚ e di Kierkegaard ❚ v. vol. III, nome capitolo, § 0, pp. 000-000 ❚. Si pensi inoltre alla veemente polemica nei confronti dell’ideale platonico e cristiano della vita contemplativa e ascetica e alla celebrazione dell’attività creatrice in Nietzsche ❚ v. vol. III, nome capitolo, § 0, pp. 000-000 ❚.
Il ritorno
all’Etica
nicomachea
di Aristotele
Sennonché, nel riprendere questa idea tipicamente ottocentesca del primato dell’attività pratica
sul conoscere, Heidegger avverte l’esigenza di articolare il concetto della prassi umana meglio di
quanto non sia stato fatto in epoca moderna. A tal fine, ricorre soprattutto all’opera di un filosofo antico: l’Etica nicomachea di Aristotele ❚ v. vol. 1, nome capitolo, § 0, pp. 000-000 ❚. Più in
particolare, in un corso universitario su Platone e Aristotele che precede la pubblicazione di
Essere e tempo ed è intitolato Il Sofista di Platone (Platon: Sophistes, pubblicato nel 1992, ma tenu7
Heidegger
0140.p000-000_heidegger.qxd
12-12-2006
16:07
Pagina 8
to nel 1924-25), Heidegger analizza la distinzione aristotelica tra due forme di attività umana: la
pòiesis, il produrre nel senso del “fare”, e la praxis, l’“agire” in senso vero e proprio. Normalmente non distinguiamo il fare dall’agire, o meglio ci rappresentiamo l’agire come un fare. Per
Aristotele, invece, si tratta di attività fondamentalmente diverse. Entrambe sono attività, hanno
cioè un fine o uno scopo a cui tendono. L’una, però, la pòiesis, ha il fine fuori di sé, mentre
l’altra, la praxis, ha il fine in se stessa. Heidegger interpreta questa distinzione in senso
fenomenologico. Secondo lui, cioè, distinguendo la praxis dalla pòiesis Aristotele ha inteso
distinguere due modi di manifestarsi dell’essere umano.
Storie
per approfondire
Il carattere
fenomenologico
della pòiesis:
l’eclissarsi
del produttore
nel prodotto
Riflettiamo su un esempio di pòiesis: la produzione di un tavolino da parte del falegname.
Affermando che la pòiesis è un’attività che non ha il fine in se stessa, Aristotele intende dire che
gli atti compiuti dal falegname per produrre il tavolino (dunque, la progettazione, la scelta del
legname, il montaggio, la rifinitura ecc.) sono tutti orientati verso uno scopo che sta oltre gli
atti stessi. Ciò significa, sotto il profilo fenomenologico, che l’apparire del produttore è secondario rispetto all’apparire dell’opera da produrre. La realizzazione del tavolino è infatti un
modo di rendere manifesto qualcosa. Grazie alla produzione, cioè, la cosa prodotta appare,
diventa presente. Benché, però, debba il proprio apparire all’attività del produrre, la cosa prodotta appare soltanto quando l’attività del produrre è cessata. In altre parole, nel momento in
cui il tavolino è realizzato, diventa cioè concretamente presente, l’attività del falegname è finita. Nel tavolino non vediamo più il falegname che l’ha prodotto. Si comprende allora il rilievo
fenomenologico che ha per Heidegger la nozione aristotelica di pòiesis. Nella produzione, il
produttore scompare, dilegua nel prodotto. L’atto del manifestare si eclissa nella
cosa manifestata.
Heidegger e la riflessione
sul politico:
Leo Strauss e Hannah Arendt
Benché il primo Heidegger abbia prestato scarsa
attenzione al fenomeno della politica, due suoi studenti, Leo Strauss (1899-1973) e Hannah Arendt
(1906-1975), hanno ricevuto da lui l’impulso a
porre questo tema al centro dei propri interessi.
Negli anni Venti, essi frequentarono un corso universitario
nel quale Heidegger attirò la loro attenzione su due testi
della filosofia greca, il Sofista di Platone e l’Etica Nicomachea di Aristotele. Un punto, in particolare, sembra essere
stato per loro decisivo: il rilievo dato da Heidegger alla differenza tra il modo di vita del filosofo, ossia di colui che
ricerca la verità, e quello di chi si occupa di affari pubblici,
cioè il politico in senso lato (il retore, l’avvocato, il capo di
un partito, lo stratega militare ecc.). Strauss e Arendt arrivarono così a maturare una convinzione che, nonostante
gli esiti differenti delle loro riflessioni, è comune a entrambi: la filosofia intrattiene un rapporto conflittuale con la
sfera politica. Una “filosofia politica” è, dunque, a rigor di
termini, impossibile. La filosofia nasce infatti soltanto nel
momento in cui viene messa radicalmente in questione la
dimensione dell’opinione (quella che i greci chiamavano
dòxa), dimensione che è invece propria dell’agire politico.
Molto diverse sono, però, le conseguenze che Strauss e la
Arendt traggono da questa consapevolezza.
Per Strauss si tratta anzitutto di difendere la filosofia dagli
imperativi della politica. Strauss scopre così che, per
Il Novecento
difendersi dal potere politico, i filosofi antichi e della prima modernità (Cartesio, Spinoza, Hobbes, Leibniz ecc.)
adottarono un’abile tecnica comunicativa, la «scrittura
essoterica». Essendo consapevoli, cioè, che la filosofia
deve necessariamente mettere in discussione le convenzioni su cui si fonda il potere politico e corre quindi sempre il pericolo di diventare oggetto di persecuzione, i filosofi comunicavano i propri insegnamenti “tra le righe”, in
modo indiretto, stando attenti a non offendere l’opinione
comune.
La Arendt, il cui pensiero è più chiaramente legato a quello di Heidegger, solleva un problema diverso: riflettere
sulle questioni civili senza lasciarsi condizionare da pregiudizi che scaturiscono da esperienze estranee alla sfera
politica. Ad esempio, a causa di un modo di pensare che
ha un’origine filosofica e quindi necessariamente “antipolitica”, siamo di norma inclini a considerare l’imprevedibilità e la provvisorietà dei risultati dell’azione politica come
difetti da cui occorre liberarsi. Comunemente, cioè, si
attribuisce al pensiero politico il compito di prevedere
nel modo più esatto possibile i comportamenti umani. La
Arendt giudica un atteggiamento del genere, basato sull’idea tipicamente scientifica della prevedibilità degli eventi fisici, incompatibile con la sfera politica. Se infatti –
osserva – un’azione umana fosse completamente prevedibile, non sarebbe più un’azione umana. Avrebbe perso
quelle caratteristiche che rendono l’azione diversa da un
processo fisico, ossia, anzitutto la libertà e, quindi, l’imprevedibilità e la provvisorietà.
8
0140.p000-000_heidegger.qxd
12-12-2006
16:07
Pagina 9
Il rendersi
visibile
dell’agente
nella praxis
La praxis, l’agire in senso vero è proprio si distingue dalla pòiesis perché il suo scopo consiste nell’esecuzione stessa degli atti necessari a compierlo. Un esempio di praxis che si trova spesso negli
scritti di Aristotele è l’attività del suonare uno strumento musicale. Quando suoniamo uno strumento, ad esempio il flauto, siamo impegnati in un’attività il cui fine è l’attività stessa. Se infatti
cessa l’attività, cessa anche il suono. Il manifestarsi del suono coincide dunque con il manifestarsi di colui che suona. Il suono non è dunque un prodotto che appare successivamente all’attività
del suonare lo strumento, mentre il tavolino appare soltanto dopo l’esecuzione degli atti necessari alla sua costruzione. Il suono, dunque lo scopo del suonare, coincide con l’atto stesso del
suonare. Questa elementare osservazione aristotelica ha per Heidegger un’importanza decisiva.
Essa indica infatti che la prassi umana può attuarsi in due modi fenomenologicamente opposti.
Se si attua come produzione, l’attività umana scompare nel prodotto, se invece si
attua come azione in senso proprio, si rende visibile in se stessa.
Esistenza
autentica,
o propria,
e esistenza
inautentica,
o impropria
Benché non ne faccia esplicita menzione, in Essere e tempo Heidegger si serve della distinzione
aristotelica tra pòiesis e praxis per individuare due diversi modi di essere dell’esserci, cioè dell’uomo: l’esistenza inautentica e l’esistenza autentica. Pur essendo entrambe attività pratiche,
nell’una, l’esserci non si rivela, nell’altra si rivela a se stesso. Si osservi, al proposito, che la radice
della parola tedesca che rendiamo in italiano con “autenticità”, Eigentlichkeit, è eigen, “proprio”.
L’esistenza inautentica è dunque l’esistenza “non propria”, “impropria”, che non si appropria
di sé, ossia che non incontra se stessa in quello che fa. L’uomo è viceversa autentico quando agisce in modo da svelare quello che gli è proprio. Si tratta, a guardar bene, di una distinzione del
tutto ovvia. Quando, ad esempio, di una attività ripetitiva e noiosa, come imparare a memoria
un testo o compilare bollettini postali, diciamo che è “alienante”, intendiamo appunto dire che
ci aliena o espropria di quello che siamo capaci di fare, ossia che non consente di mostrarci nella nostra individualità. Attività creative che chiamano direttamente in causa le nostre attitudini
personali, ad esempio una partita di calcio o la risoluzione di un quiz di intelligenza, consentono
invece di mostrarci in quello che abbiamo di più proprio.
2.4.2
Il decadimento dell’esserci e il «si» impersonale
Gli strumenti
come
possibilità
di attuare
la libertà
Si tenga anzitutto presente un’avvertenza che Heidegger stesso fa all’inizio dell’analisi dell’esistenza inautentica. Con «inautenticità» Heidegger non intende un modo di vivere privo di valori o immorale. Intende, molto semplicemente, la consueta prassi quotidiana, la vita vissuta in
base alle possibilità offerte dalle circostanze in cui l’uomo viene giorno per giorno a trovarsi.
Come abbiamo visto, il quotidiano prendersi cura delle cose è in sostanza il loro utilizzo come
strumenti per fare qualcosa. Gli strumenti offrono dunque all’uomo la possibilità di realizzare i
suoi progetti pratici, gli consentono cioè di attuare la sua libertà.
Il carattere
vincolante
degli strumenti
Sennonché, gli strumenti offrono possibilità di attuare la libertà, ma le pongono anche vincoli.
Vincoli necessari al funzionamento stesso degli strumenti. Come abbiamo osservato, infatti, per
essere utilizzabile il mezzo deve rimanere assente, o meglio, deve manifestarsi assentandosi. Lo
strumento funziona, cioè, non quando è osservato, quando si crea quella distanza tra l’uomo e
l’ente che consente la conoscenza oggettiva, bensì quando colui che usa il mezzo fa tutt’uno con
esso, vi «si affida» cioè completamente. Proprio questa immedesimazione, necessaria al funzionamento dello strumento, ne fa un vincolo per colui che lo utilizza.
La dipendenza
da ciò
che rende
indipendenti
Il carattere vincolante dei mezzi ci è noto per esperienza diretta. A tutti è infatti capitato di fare
qualche volta esperienza dell’irritante sensazione di impotenza che sopraggiunge quando si
rompe un mezzo, ad esempio l’automobile, su cui facciamo normalmente affidamento. In casi
simili ci accorgiamo di essere dipendenti da quello che, per altro verso, rappresenta uno straordinario ampliamento delle nostre possibilità. Siamo cioè dipendenti da quello che ci rende
indipendenti. Scopriamo di essere dipendenti dall’automobile quando si guasta, perché quotidianamente vi facciamo affidamento e, ad esempio, programmiamo la nostra giornata contando sul fatto che possiamo usarla. Se improvvisamente non funziona, non possiamo andare al
lavoro, rispettare gli appuntamenti presi, insomma, non riusciamo più a venire a capo di nulla.
9
Heidegger
0140.p000-000_heidegger.qxd
12-12-2006
16:07
Pagina 10
La dipendenza
delle attitudini
tecnico-pratiche
dagli strumenti
La paradossale dipendenza dell’uomo dagli strumenti che lo rendono per altro verso indipendente è espressa da Heidegger con la seguente formula: «l’esserci comprende se stesso a
partire dagli enti che incontra nel mondo». Al proposito, occorre tener presente che, quando parla di «comprendere» o «comprensione» (Verstehen), Heidegger non intende un atto di
natura teorico-conoscitiva. Intende invece un’attitudine pratica, ossia l’«esser capace di essere» o «saper fare qualcosa» (Sein-können). Si tratta perciò di un sapere, ma nel senso tecnicopratico che intendiamo quando diciamo, ad esempio, di “saper andare in bicicletta”, “saper
nuotare”, “sapere come si compila un modulo” e simili. Che l’esserci comprenda se stesso a partire dagli enti che incontra nel mondo significa dunque che il suo saper fare, ossia le sue attitudini dipendono dagli strumenti che consentono di metterle in pratica. Più in particolare, gli strumenti vincolano la prassi umana alle possibilità determinate che essi permettono di realizzare.
Un martello, ad esempio, consente di conficcare chiodi, ma non consente di scrivere e, viceversa, una penna consente di scrivere ma non consente di conficcare chiodi.
Il decadimento
da sé
dell’esistenza
inautentica
La prassi umana quotidiana è dunque essenzialmente un “produrre” nel senso, prima chiarito,
del termine aristotelico pòiesis. Al pari della pòiesis aristotelica, infatti, il prendersi cura pratico
di cui parla Heidegger è un’attività orientata verso uno scopo che sta al di là, ossia fuori, all’esterno dell’attività stessa. Ciò significa che l’esserci «si disperde» nei mezzi di cui fa uso. L’essere
nel mondo è dunque un perdersi o – per usare il termine tecnico che troviamo in Essere e tempo
– un Verfallen, espressione traducibile in italiano con «decadimento» (o anche «deiezione»),
da intendere però secondo il duplice significato del «decadere da sé» dell’esserci e del suo contemporaneo «cadere nel mondo» di cui l’esserci si prende cura.
Il conformismo
del «si»
impersonale
La perdita di sé o decadimento che caratterizza l’essere
nel mondo dell’esserci non riguarda però soltanto il singolo individuo. Riguarda bensì anche quello che Heidegger chiama l’«essere assieme», dunque la dimensione
sociale, intersoggettiva dell’esistenza umana. L’esistenza inautentica è anche e soprattutto un «essere assieme» inautentico. Si tratta, in sostanza, di quello che
siamo soliti chiamare “conformismo”, ossia la tendenza
ad allinearsi alle opinioni dei più, a comportarsi secondo
schemi prestabiliti, a rendersi uniformi alla collettività.
Heidegger parla, in proposito, di predominio di un «si
impersonale» (Man è la parola con la quale in tedesco
si designa il soggetto di frasi impersonali: ad esempio, man
sagt, “si dice”): l’esserci inautentico agisce e pensa
così come si agisce e si pensa (tema anticipato da
Nietzsche, ❚ v. vol. III, nome capitolo, Lettura 2 ❚). Caratteristiche dell’esistenza inautentica sono secondo Heidegger i La spersonalizzazione nella società di
massa è stato uno dei temi della Pop Art: ecco
la «chiacchiera», la «curiosità» e l’«equivoco». La come Roy Lichtenstein raffigura se stesso in
chiacchiera è il modo vacuo di discorrere di cose o di vi- questo Autoritratto (1978, collezione privata).
cende umane, basato sulla ripetizione acritica di pregiudizi comunemente accettati. La curiosità è un desiderio di conoscenza fine a se stesso, che si appaga della superficie delle cose senza mai essere disposto a andare a fondo. Chiacchiera e curiosità
fanno sì che nel vivere l’uno con l’altro predomini l’equivoco ossia l’incomprensione reciproca.
2.4.3
Il problema
del sé e
l’insufficienza
della soluzione
tradizionale
L’autenticità come scoperta della libertà
C’è un tratto che accomuna i diversi aspetti dell’esistenza inautentica: l’esserci inautentico,
secondo Heidegger, «fugge da se stesso», dunque si nasconde a stesso, non si rivela per
quello che è. Si tratta di quella incapacità di essere propriamente se stessi designata dalla parola
tedesca Uneigentlichkeit, che traduciamo con “inautenticità”, ma che letteralmente significa
“non proprietà”, “improprietà” (il termine Uneigentlichkeit è infatti formato da un, “non”, e
Il Novecento
10
0140.p000-000_heidegger.qxd
In sintesi
12-12-2006
16:07
Pagina 11
L’essenza dell’uomo e l’esistenza autentica
per Heidegger è il da-sein
(ossia la sua esistenza)
Che cos’è
l’essenza dell’uomo?
å
siamo abitatori del tempo,
gettati nel mondo,
consapevoli della nostra morte.
dunque
la morte è la possibilità
che rende ogni possibilità impossibile
pertanto
la vita autentica accetta la morte,
facendo propria la dimensione dell’angoscia
e non si disperde nell’inautentico.
l’inautentico si rivela
nella chiacchiera
e nelle occupazioni
frenetiche.
eigen, “proprio”). Giunto a questo punto dell’analitica esistenziale, Heidegger si chiede: c’è un
modo d’essere in cui l’esserci è propriamente se stesso? Un modo di vita, cioè, nel quale l’uomo non fugge da se stesso, ma si rivela invece per quello che propriamente è? Il problema
può sembrare di semplice soluzione, e tale è per lo più sembrato, secondo Heidegger, nella tradizione filosofica. Da Socrate fino a Husserl, infatti, si è concordemente ritenuto che l’uomo
acceda a se stesso grazie a un atto di riflessione interiore, grazie cioè alla conoscenza di sé. Sennonché, una soluzione del genere è per Heidegger necessariamente inadeguata. Per lui, infatti,
l’esistere umano non è anzitutto conoscere, ma agire. La prassi ha un primato sulla teoria. Affidare il compito di manifestare l’esserci a un atto conoscitivo quale la riflessione interiore, come
ha per lo più fatto la tradizione filosofica, significherebbe attribuire alla conoscenza maggiore
importanza che alla prassi.
L’esistenza
autentica quale
autorivelazione
dell’agente
Per Heidegger, dunque, non si tratta di trovare una via di conoscenza capace di condurre l’uomo dinanzi alla sua vera natura. Si tratta piuttosto di individuare quei modi d’essere in cui l’esserci non si nasconde a se stesso, non si immedesima cioè negli strumenti che usa, non decade
da sé cadendo nel mondo, non si conforma acriticamente agli schemi del «si» impersonale.
Saranno modi di essere “pratici” nel senso della praxis di Aristotele, dunque azioni tali da far sì
che l’agente si riveli a se stesso nell’atto in cui agisce, come accade al flautista dell’esempio aristotelico, il quale, suonando, produce il suono, ma esibisce al contempo anche se stesso. Azioni
di questo tipo sono i fenomeni esistenziali che Heidegger chiama «angoscia» ed «essere per
la morte».
La necessità
di un’analisi
fenomenologica
e non psicologica
della dimensione
emotiva
L’angoscia è uno «stato d’animo» ossia un modo di quella che Heidegger chiama «situatività emotiva» (Befindlichkeit, ❚ Lettura 2 ❚). Stati d’animo sono ad esempio, la paura (a torto,
secondo Heidegger, confusa con l’angoscia), l’allegria, la noia, la depressione, il pudore ecc. Si
tratta dunque di quelli che normalmente chiamiamo “sentimenti” o “stati psicologici”. Heidegger avverte però che la natura degli stati d’animo è totalmente travisata quando si considerano
in modo psicologico, ossia come proprietà di una sfera psichica, interna, soggettiva, estranea
alla sfera mondana, esterna, oggettiva. Anche negli stati d’animo l’esserci è in rapporto con il
mondo, non rimane isolato nella propria privata interiorità. Gli stati d’animo sono dunque
fenomeni in senso fenomenologico, ossia modi di apparire degli enti.
11
Heidegger
0140.p000-000_heidegger.qxd
12-12-2006
16:07
Pagina 12
L’autorivelazione
emotiva
nella paura
Che cosa appare negli stati d’animo? Pensiamo a un caso che è sicuramente capitato a tutti: lo
spavento che ci prende quando, camminando distrattamente lungo un viale, avvertiamo improvvisamente la presenza di un cane che, dietro un cancello, si rivolge a noi ringhiando e abbaiando.
In un caso simile, ci assale la paura perché il cane ci appare come qualcosa di minaccioso. Perché
nasca il sentimento di paura, però, non è sufficiente che qualcosa si riveli minaccioso. La paura
nasce dal fatto che la minaccia si manifesta nelle nostre immediate vicinanze. Se infatti osserviamo il cane di lontano, oppure se siamo sin da principio consapevoli che c’è una rete a proteggerci, anche se sappiamo che si tratta di un cane pericoloso, di norma non ne abbiamo paura. Ciò
significa che il sentimento di paura nasce soltanto quando la minaccia ci coinvolge, ci riguarda
direttamente. In termini fenomenologici: la minaccia fa paura quando ci si manifesta in modo
tale da renderci manifesti a noi stessi. La paura fa sì che l’esserci si riveli a se stesso.
Il rivelarsi
all’esserci
del suo essere
gettato
Tutti gli stati d’animo sono secondo Heidegger modi in cui l’esserci si rivela a stesso. Non si tratta però di atti di riflessione o di autopercezione nel quale l’io osservi se stesso come un oggetto.
Al contrario, negli stati d’animo l’esserci avverte la propria esistenza come una possibilità da
attuare, ossia come un «aver da essere». La paura, infatti, non è soltanto paura «di» qualcosa
(del cane, ad esempio), ma anche sempre paura «per» qualcosa (ad esempio, per la nostra integrità fisica). Ciò per cui abbiamo paura, ossia ciò che sentiamo minacciato è sempre una nostra
attuale possibilità di fare qualcosa: se il cane ci mordesse, non potremmo compiere ciò che stavamo facendo, ad esempio, continuare la nostra passeggiata. Rivelando l’esistenza come possibilità, la paura, così come ogni altro stato d’animo, fa sì che l’uomo avverta – afferma Heidegger
– la propria «gettatezza » (Geworfenheit). L’esistenza umana è «gettata», è cioè una condizione
precaria, priva di garanzie, irrimediabilmente esposta al rischio del fallimento.
La cura come
costrizione
a essere liberi
Non si leggano però queste parole di Heidegger come espressione di un esangue pessimismo,
come un ammonimento a considerare insensato ogni progetto e ideale di vita, insomma come
un invito alla rassegnazione. Per Heidegger, infatti, il carattere di gettatezza dell’esistenza implica il contrario della rassegnazione. Essendo gettata, l’esistenza è «affidata» all’uomo come un
compito da attuare e verso cui egli è responsabile. Si rifletta, per capire questo punto, sul significato dell’espressione “affidare”. Quando qualcosa o qualcuno – ad esempio, un bambino – ci
viene affidato, veniamo a trovarci in una condizione che è, insieme, libera e non libera. Per un
verso, siamo liberi di disporre di ciò che ci viene affidato: un bambino affidato alla nostra cura
va guidato e educato. Per altro verso, però, proprio questa libertà ci pone vincoli ben precisi:
nell’aver cura di un bambino dobbiamo mirare al suo bene, siamo cioè responsabili della sua
crescita. Il bambino suscita la nostra apprensione perché, per tutto il tempo in cui è affidato alla
nostra cura, ci pone costantemente dinanzi alla necessità di agire, di prendere decisioni nei suoi
riguardi, di valutare ciò che è bene e ciò che è male per lui. La cura di un bambino che ci è stato
affidato è dunque una condizione nella quale siamo, per così dire, “costretti a esser liberi”: la
libertà è avvertita come un «peso», un’incombenza a cui non possiamo sottrarci. Per designare il
rapporto dell’esserci con la propria esistenza, Heidegger usa l’espressione «cura» (Sorge) nel
senso appena chiarito. L’esserci ha cura della propria esistenza, si trova cioè nella
necessità di assumere su di sé il peso della libertà di agire.
L’angoscia
come stato
d’animo
autentico
La paura, così come la maggior parte degli stati d’animo, pur rivelando all’esserci il fatto di essere gettato nella propria esistenza, è però secondo Heidegger un modo per evitare di assumersi il
peso della libertà. La paura offre all’uomo una via di fuga dalla costrizione di essere libero: gli
consente di rifugiarsi nel «si» impersonale. Le possibilità di esistenza a cui l’uomo è rinviato nella paura non sono cioè possibilità liberamente progettate, sono bensì passivamente accettate in
conformità a ciò che gli altri fanno. Diverso è invece il caso di quello che Heidegger chiama lo
«stato d’animo fondamentale» o «autentico»: l’angoscia ❚ Lettura 3 ❚, un tema centrale
già in Kierkegaard ❚ v. vol. III, nome capitolo, § 0, pp. 000-000 ❚.
L’effetto
liberatorio
dell’angoscia
Benché apparentemente simile alla paura, l’angoscia (Angst) presenta una caratteristica che la
distingue da tutti gli altri stati d’animo. L’angoscia – afferma in sostanza Heidegger – è uno stato d’animo senza oggetto. Non c’è propriamente niente che susciti l’angoscia. O meglio, ciò che
Il Novecento
12
0140.p000-000_heidegger.qxd
12-12-2006
16:07
Pagina 13
suscita l’angoscia non è, come accade nella paura, questo o quell’ente che si incontra nel mondo, ma è il mondo stesso come tale. Quando è angosciato, l’esserci avverte l’insensatezza di tutto quello che normalmente per lui ha senso. Lo stato d’animo dell’angoscia produce cioè un
effetto «spaesante» o «inquietante» (unheimlich) perché priva l’esserci dell’abituale confidenza
con l’ambiente circostante. Nell’angoscia – afferma Heidegger – l’uomo «non si sente più a casa
propria», avverte cioè che ogni possibilità di agire che il mondo gli offre non ha più senso, non
rappresenta più uno scopo degno di essere perseguito. Ciò non significa però che l’angoscia inibisca o paralizzi l’azione. Al contrario, secondo Heidegger, l’angoscia, rivelando l’insensatezza
di ogni singolo scopo determinato, libera l’esserci dalla tendenza inautentica a interpretare se
stesso e le proprie possibilità di agire accettando acriticamente quello che impersonalmente tutti pensano e tutti fanno. L’angoscia, insomma, libera l’uomo dall’inautenticità e lo
dispone a esistere autenticamente.
Autenticità
e inautenticità
come diversi
di modo
di esistere
Ma che cosa significa, propriamente, esistere in modo autentico? Che cosa deve fare l’uomo, in
concreto, per essere autentico? La risposta a queste domande in Essere e tempo può apparire
deludente. Heidegger, infatti, non stabilisce nessuno scopo, ideale, valore concreto da realizzare. La differenza tra autenticità e inautenticità non risiede cioè in un diverso contenuto dell’esistenza, ma soltanto in un diverso modo di esistere. Abbiamo già osservato
che quando Heidegger parla di «modo di essere» intende l’apparire, il manifestarsi di ciò che è.
L’esistenza autentica è appunto un diverso modo di manifestarsi del medesimo contenuto che
si manifesta nell’esistenza inautentica. Nell’esistenza inautentica, l’esserci fugge da se stesso,
ossia, si nasconde, non si manifesta a se stesso. Ciò significa che le possibilità di agire, i progetti, gli scopi, i valori che lo guidano non sono vissuti da lui come sue libere scelte. Nascondendosi a se stesso, l’esserci non afferra le possibilità di esistenza in quanto proprie possibilità, possibilità cioè a cui si può dire sì o no, ma soltanto come schemi di comportamento prestabiliti a cui
si deve adeguare in ossequio all’autorità del «si» impersonale. L’angoscia, rivelando l’insensatezza del mondo, libera l’esserci da questa tendenza inautentica a fuggire da sé, lo spinge cioè a
porsi dinanzi a se stesso e a riconoscere senza finzioni rassicuranti il proprio essere gettato nell’esistenza.
La rivelazione
autentica
di sé come
scoperta della
libertà finita
In altre parole, l’angoscia fa sì che l’uomo scopra la propria libertà. Non si tratta però di
una libertà senza vincoli. Quella umana è – afferma Heidegger – una «libertà finita», vale a
dire, non è infinita come la libertà creatrice che la tradizione filosofico-teologica attribuisce
all’onnipotenza divina. Che la libertà umana sia finita significa essenzialmente due cose. Significa anzitutto che l’esserci è costretto a concretizzare di volta in volta la propria libertà in una scelta determinata la quale esclude inevitabilmente altre possibili scelte. Significa inoltre che una
volta compiuta la scelta, abbracciato un ideale, optato per un fine, l’uomo rimane vincolato alla
necessità di portarlo a compimento. L’esistenza umana è insomma caratterizzata da quella condizione duplice, libera e vincolata a un tempo, che abbiamo sopra esemplificato riflettendo su
che cosa implichi aver cura di qualcosa o qualcuno che ci è stato affidato. Ciò significa, secondo
Heidegger, che l’esserci è autenticamente libero quando sceglie le sue possibilità di
esistenza in vista della propria morte. L’esserci è autentico, cioè, quando esiste come
«essere per la morte» o «anticipazione della propria morte».
La scelta
autentica
resa possibile
dall’essere
per la morte
Parlando di essere per la morte, Heidegger non allude alla necessità di pensare alla morte o,
peggio, di suicidarsi. La morte è presa da lui in considerazione come la «la possibilità più propria» dell’esserci. Tra tutte le possibilità, osserva infatti Heidegger, la morte è una possibilità
assolutamente eccezionale, perché è «la possibilità dell’impossibilità dell’esistenza
come tale». Ciò significa che nell’anticipazione della propria morte, l’esserci si trova confrontato con l’«impossibilità», ossia con la negazione della possibilità come tale, dunque con il
limite oltre il quale l’esistenza non può andare. La morte non offre niente da realizzare, niente
che possa essere concretamente attuato, giacché rappresenta l’annullamento di ogni possibilità di esistenza concretamente realizzabile nel mondo. La morte è infatti il non essere più nel
mondo dell’esserci. Tuttavia, come abbiamo già osservato a proposito dell’insensatezza del
13
Heidegger
0140.p000-000_heidegger.qxd
12-12-2006
16:07
Pagina 14
o Edvard Munch, Il letto di morte (Oslo,
Munchmuseet, 1896). Heidegger identifica la
vita autentica con l’accettazione della morte
come possibilità più propria, incondizionata,
insuperabile e certa dell’Esserci. L’autenticità
si manifesta nella decisione anticipatrice di
progettare la propria esistenza come un
essere per la morte.
mondo sperimentata nell’angoscia,
l’anticipazione dell’annullamento
di ogni possibilità mondana, secondo Heidegger, non implica affatto la
paralisi dell’azione. Al contrario,
soltanto anticipando la propria morte, l’uomo è in grado di scegliere autonomamente le possibilità di esistenza e di non conformarsi acriticamente agli schemi del «si»
impersonale.
3
3.1
Il secondo Heidegger: il pensiero dell’essere come evento
La svolta antiumanistica
Il clima
culturale
esistenzialista
tra le due
guerre
Alla sua apparizione nel 1927, Essere e tempo suscitò consensi in Germania, in Francia e in altri
paesi europei. A determinarne il successo fu anzitutto il rilievo che Heidegger aveva conferito
ad aspetti dell’esistenza umana che la filosofia del tempo, soprattutto quella che si insegnava
all’università, aveva trascurato: la dimensione della vita pratica quotidiana, l’emotività, il carattere tragico della libertà, il senso della mortalità ecc. Essere e tempo andava incontro a un’esigenza culturale che aveva già trovato espressione nel primo diffondersi dell’esistenzialismo,
determinato dalla ripresa di Kierkegaard da parte del teologo Karl Barth (1886-1968) e dai
primi scritti di Karl Jaspers (1883-1969). La lettura di Essere e tempo divenne decisiva nella formazione di altri pensatori esistenzialisti come il teologo Rudolph Bultmann (1884-1976) e,
soprattutto, il maggiore esponente dell’esistenzialismo francese, Jean-Paul Sartre (1905-1980)
❚ v. vol. III, L’esistenzialismo, § 0, pp. 000-000 ❚.
L’interpretazione esistenzialista di Essere
e tempo
Essere e tempo fu avvertito come un libro rivoluzionario perché poneva finalmente al centro l’uomo nella sua esistenza concreta. Per farsi un’idea dell’effetto di rottura suscitato dall’analitica
esistenziale si pensi soltanto alla differenza tra l’aspirazione di fondo della fenomenologia di
Heidegger e quella del suo maestro Husserl. Per Husserl il problema fondamentale della fenomenologia non era sostanzialmente diverso dal problema sul quale la filosofia da Platone in poi
si era continuamente affaticata senza mai trovare, secondo lui, una soluzione adeguata: il problema dell’episteme o «scienza rigorosa» ❚ v. vol. III, nome capitolo, § 4 e 6, pp. 000-000 ❚. Husserl era
cioè persuaso che la ragione umana, qualora fosse riuscita a realizzare il suo scopo, giungere a
un sapere incontrovertibile, assolutamente certo e al riparo da ogni possibile dubbio, avrebbe
gradatamente risolto ogni problema umano. In Essere e tempo, nonostante l’evidente presenza
dell’insegnamento husserliano, non c’è più traccia dell’entusiasmo razionalistico che animava
Husserl. Mentre Husserl si richiamava ai «compiti infiniti della ragione», da realizzare grazie
all’applicazione rigorosa del metodo fenomenologico, Heidegger batteva l’accento sulla «finitezza» dell’esistenza, vale a dire, sul carattere limitato e dunque problematico e aperto di ogni
risultato pratico o teorico conseguito dall’attività umana. Proprio questa tonalità esistenzialista e antropologica di Essere e tempo ne favorì il successo in un’epoca – gli anni tra la prima e
Il Novecento
14
0140.p000-000_heidegger.qxd
12-12-2006
16:07
Pagina 15
la seconda guerra mondiale – segnata da profondissime inquietudini, incertezze e crisi di carattere morale, politico e sociale ❚ v. vol. III, Crisi della civiltà?, § 0, pp. 000-000 ❚.
La smentita
dell’interpretazione esistenzialistica
Sennonché, subito dopo la seconda guerra mondiale, Heidegger pubblica uno scritto, la Lettera sull’«umanismo» (Brief über den «Humanismus», 1946), nel quale avverte che l’interpretazione esistenzialistica di Essere e tempo ne aveva frainteso il vero significato. La polemica è diretta,
in particolare, contro lo slogan che fa da titolo a un saggio di Sartre, L’esistenzialismo è un umanismo (L’existentialisme est un humanisme, 1946). Heidegger richiama l’attenzione sul fatto che
l’analitica dell’esistenza umana era stata concepita in Essere e tempo come «preparazione» o
«elaborazione» di un problema filosofico di gran lunga più importante e urgente del problema
dell’uomo, su cui l’esistenzialismo insisteva: il problema dell’essere. L’indagine svolta in
Essere e tempo non aveva cioè un carattere antropologico, bensì ontologico. Il discorso sull’uomo – l’antropologia – era soltanto una «via» per giungere al discorso sull’essere – l’ontologia
–. Nel richiamare l’attenzione su questo, però, Heidegger segnalava anche che il progetto
intrapreso in Essere e tempo, ossia l’«elaborazione del problema dell’essere», era andato incontro a un fallimento.
La svolta come
mutamento
dell’orientamen
to umanistico di
Essere e tempo
Per ragioni che tra poco cercheremo di chiarire, Heidegger ritiene che il pensiero esposto in
Essere e tempo debba necessariamente compiere una «svolta» (Kehre). Per comprendere questa
nozione, si rifletta sulla metafora della “via”, del “cammino” e del “sentiero”, metafora presente, non a caso, nei titoli delle raccolte heideggeriane dei saggi successivi a Essere e tempo, come
Sentieri interrotti (Holzwege, 1950), In cammino verso il linguaggio (Unterwegs zur Sprache, 1959),
Segnavia (Wegmarken, 1967). Come si è appena detto, l’analisi dell’esistenza umana era stata
concepita da Heidegger come una via per giungere a quello che sin dalle pagine introduttive era
stato indicato come il vero scopo della ricerca: il chiarimento del senso dell’essere in generale,
vale a dire l’ontologia. La svolta a cui si richiama la Lettera sull’«umanismo» va appunto intesa
come il mutamento della direzione della via percorsa dall’analitica esistenziale. Heidegger invita cioè la filosofia contemporanea a abbandonare proprio quell’orientamento antropologico e,
più in generale, «umanistico» che gli interpreti esistenzialisti di Essere e tempo avevano invece
accentuato. Invitando alla svolta, dunque, Heidegger suggerisce implicitamente che l’esistenzialismo umanistico non era stato introdotto arbitrariamente in Essere e tempo dai suoi interpreti,
era bensì, per così dire, un suo “esito indesiderato” da cui occorre ora guardarsi per imboccare
una strada alternativa.
Motivi biografici
della svolta
All’origine della svolta del pensiero di Heidegger sono da individuare motivi di carattere sia biografico sia teorico. Sotto il profilo biografico, occorre anzitutto tener presente che, nel 1933,
l’anno in cui Hitler prende il potere in Germania, Heidegger aderisce al nazismo assumendo la
carica di rettore dell’Università di Friburgo. In quell’occasione pronunciò un discorso, L’autoaffermazione dell’università tedesca (Die Selbstbehauptung der deutschen Universität, 1933), entusiasticamente animato dalla persuasione che il nuovo regime offrisse una straordinaria possibilità di
rinnovamento delle istituzioni politiche e sociali. Era convinto che fosse arrivato il momento
propizio alla realizzazione dell’utopia di Platone, che nella Repubblica aveva assegnato ai filosofi
il ruolo di supremi ph?lakes, «duci reggitori» dello stato. Ammoniva perciò la filosofia e la scienza contemporanea a intervenire attivamente nella «rivoluzione nazionalsocialista». Heidegger
non tardò però a rendersi conto che il nuovo tiranno non aveva affatto intenzione di lasciarsi
condurre dai filosofi ma, al contrario, mirava alla completa politicizzazione della cultura, a
ridurla cioè a semplice strumento di propaganda dell’ideologia di partito. Dopo nemmeno un
anno, Heidegger si dimise dalla carica di rettore e si dedicò esclusivamente all’insegnamento.
L’esigenza
di ripensare
l’essenza
dell’agire
La fallimentare esperienza politica con il nazismo indusse Heidegger a riflettere su un problema
che, come abbiamo visto, era già stato al centro di Essere e tempo: il rapporto tra teoria e
prassi o tra pensare e agire. L’esigenza di mutare l’orientamento umanistico e antropologico
dell’analitica esistenziale è strettamente connesso con questa riflessione. Non a caso, il testo in
cui si parla della svolta, La lettera sull’umanismo, scritto immediatamente dopo il crollo della
Germania nazista, si apre con un’affermazione che può essere letta anche come un’autocritica:
15
Heidegger
0140.p000-000_heidegger.qxd
12-12-2006
In sintesi
16:07
Pagina 16
Gli interessi del secondo Heidegger
riflessione
Opere successive
a Essere e tempo
sull’essenza dell’agire, sul rapporto tra prassi umana e verità,
sulla fondazione, sulla differenza ontologica
polemica
contro l’esistenzialismo umanista
«Noi non pensiamo ancora in modo abbastanza decisivo l’essenza dell’agire». Sotto il profilo
strettamente teorico, quindi, la svolta trae origine dalla critica del modo in cui, in Essere e tempo
e in altri scritti immediatamente successivi, era stato concepito l’agire umano. Più in particolare,
nella seconda metà degli anni Trenta, Heidegger rimette in discussione il rapporto tra
prassi umana e verità.
3.2
L’essenza della verità e il problema della fondazione differenza ontologica
La verità come
adeguamento
Per comprendere i motivi teorici della svolta occorre dunque prendere le mosse dalla riflessione
che Heidegger dedica al concetto di verità. Già in Essere e tempo e, successivamente, nelle parti
iniziali di una conferenza intitolata Dell’essenza della verità (Vom Wesen der Wahrheit, 1943), Heidegger critica quello che lui considera il «concetto corrente della verità come adeguamento» ❚ Lettura 4 ❚. Si tratta della concezione, ovvia anche per il senso comune, secondo cui la
verità è una proprietà della conoscenza, in particolare di quella conoscenza che è «conforme» o «adeguata» alla realtà conosciuta. La frase “la neve è bianca”, ad esempio, è vera perché, in effetti, ossia nella realtà stessa, la neve è bianca. L’affermazione “la neve è nera” è invece
falsa perché, di fatto, la neve non è nera. L’una è vera perché si adegua alla realtà, l’altra falsa
perché non vi si adegua.
Il problema
dell’origine
della differenza
tra l’atto
conoscitivo
e il suo oggetto
Perché mai criticare una simile ovvietà? Si tenga presente che quella di Heidegger è una critica
fenomenologica. Mira cioè anzitutto a rendere manifesti i presupposti che i sostenitori della concezione criticata danno per scontati senza riflettervi. Ebbene, se si dice che la verità consiste nell’adeguarsi della conoscenza (il giudizio o la rappresentazione “la neve bianca”) allo stato di cose (la
neve bianca reale) si presuppone, consapevolmente o inconsapevolmente, che l’atto conoscitivo
è differente dall’oggetto conosciuto. Heidegger pone in sostanza il problema dell’origine
di questa differenza. Un problema che, secondo lui, l’intera tradizione filosofica occidentale
non era stata fino ad allora in grado di risolvere in modo adeguato. Più in particolare, Heidegger
ritiene che nessuna teoria della conoscenza o gnoseologia possa venire a capo del problema, giacché la differenza tra conoscenza e oggetto conosciuto è da intendere come un caso particolare della «differenza ontologica» o «differenza tra essere ed ente». Il conoscere è cioè, secondo lui,
un particolare modo di essere dell’ente conosciuto. Il problema dell’origine della differenza tra
atto conoscitivo e oggetto conosciuto è dunque un problema ontologico e non gnoseologico.
La differenza
tra essere
e ente
Ma che cosa vuol dire che la conoscenza è un modo di essere della cosa conosciuta? Si ricordi
quanto abbiamo più volte osservato, ossia che, per Heidegger, l’ontologia è essenzialmente fenomenologia. L’essere dell’ente è cioè da intendere come il suo apparire, manifestarsi, svelarsi o
venire alla presenza. Il «modo di essere di qualcosa» non è altro che il suo apparire (v. sopra §
2.2). Affermando che il conoscere è un modo di essere dell’ente, Heidegger intende dunque dire
che, nel conoscere, l’ente si presenta, appare, si svela. La conoscenza è un modo di essere dell’ente nel senso che è il manifestarsi (l’essere) della cosa conosciuta (l’ente). I termini “essere” e
“ente” stanno dunque a significare l’azione (espressa dal verbo “essere”) grazie alla quale qualIl Novecento
16
0140.p000-000_heidegger.qxd
12-12-2006
16:07
Pagina 17
cosa (espresso dal nome “ente”) è, ossia si manifesta. In base a questa concezione ontologicofenomenologica, la conoscenza è quel particolare modo di essere o presentarsi nel
quale l’ente si presenta come differente dal suo stesso essere o presentarsi.
La conoscenza
come differenza
ontologica
Questo ragionamento consente a Heidegger di mostrare che l’asserzione, così come ogni atto
conoscitivo è uno svelamento soltanto secondario o «derivato», fondato cioè su uno svelamento
preliminare o «originario», grazie al quale l’ente si manifesta come ciò a cui la conoscenza deve
adeguarsi. In altre parole, Heidegger sostiene che, quando si asserisce qualcosa intorno alla
Storie
Chiariamo questo concetto con un esempio concreto. Un atto conoscitivo è, ad esempio, l’asserzione “la neve è bianca”. Essa manifesta o – come Heidegger dice anche – «svela» l’ente, la
neve bianca reale. Asserire significa svelare l’ente, nell’asserzione si produce uno «svelamento». I termini “svelamento” e “svelatezza” sono il calco letterale della parola greca che
designa la verità: alètheia (da a-, “non”, e lèthe, “nascondimento”, “velatezza”). “Svelato” significa dunque “vero”. Quello conoscitivo, però, è uno svelamento, per così dire, “condizionato” o
“subordinato”. L’asserzione “la neve è bianca”, infatti, è vera, ossia svela l’ente se e solo se la
neve è effettivamente bianca, dunque se ciò che l’espressione linguistica esprime è conforme allo
stato di cose reale. Per stabilire se l’asserzione (“la neve è bianca”) è conforme alla cosa asserita
(la neve bianca reale) occorre verificarla. Occorre, ad esempio, guardare direttamente la neve e
constatarne l’effettiva bianchezza. È dunque l’ente in se stesso (la neve bianca reale) il «criterio»
o la «misura» in base alla quale possiamo stabilire se l’asserzione (“la neve è bianca”) è vera o
falsa, se cioè è svelante o velante.
per approfondire
La verità come
svelamento
A-lètheia: i Greci e noi
Heidegger ha prestato sempre grande attenzione
al mondo greco. Le sue interpretazioni dei presocratici, dei poeti tragici, di Platone e Aristotele
muovono tutte da una convinzione di fondo: benché sia la base della nostra moderna civiltà occidentale, il mondo greco è divenuto per noi pressoché inaccessibile. In altre parole, noi pensiamo e
agiamo in base a principi che sono stati scoperti per la
prima volta dai Greci, ma non siamo più in grado di comprendere perché pensiamo e agiamo, per così dire, “in
modo greco”. Prendiamo ad esempio il concetto di
«verità», un principio per noi indispensabile, di cui facciamo uso ogni giorno. Senza di esso, infatti, non vi sarebbero tribunali (dove i testimoni “giurano di dire la verità”),
istituzioni scientifiche (in cui “si ricerca la verità”), passaporti (che “attestano la vera identità” di una persona),
banconote (che, per avere valore, “non devono essere
false”) ecc. Ebbene, secondo Heidegger, il fatto che cose
come tribunali, enti di ricerca, passaporti, banconote
abbiano così grande importanza nella nostra vita quotidiana attesta la «presenza» dell’antica Grecia tra noi. I
filosofi greci furono infatti i primi a porre a tema il concetto di “verità” (in greco: <PAROLA GRECA>, alètheia) e a
farne un principio del pensare e dell’agire quotidiani. Si
rifletta, però, sulla natura di questa presenza. Heidegger
non intende tanto quella che possiamo percepire direttamente quando, ad esempio, visitando un sito archeologico nel sud dell’Italia (l’antica magna Grecia), vediamo le
rovine di un tempio. Si tratta, piuttosto, di una presenza
che non appare direttamente, di una «presenza assente».
17
Una presenza che, quanto più «rimane assente», «si
cela», «si ritrae», tanto più ci tiene in suo dominio, impedendoci di riflettervi sopra criticamente. Ritornare al
mondo greco significa dunque per Heidegger riflettere
criticamente su noi stessi, sui principi che informano il
modo di vivere occidentale.
La scoperta più importante fatta da Heidegger in questa
sorta di “viaggio a ritroso” nell’identità dell’Occidente
riguarda proprio il concetto di verità (scoperta contestata, in realtà, da alcuni filologi classici). La parola alètheia –
osserva Heidegger – è composta dalla a privativa (“non”)
e dal verbo lanthànein (“nascondersi”). Heidegger ne conclude che, quando i Greci usavano questa parola, la intendevano come a-lètheia, «non nascondimento», «non velatezza». Avvertivano cioè che la verità reca in sé un nesso
indissolubile tra la presenza e l’assenza. “Vero” era per
loro, anzitutto, quello che è stato portato alla luce strappandolo a un occultamento. Ad esempio, vero è l’ordine
naturale delle cose, ordine che non è immediatamente
evidente, giace per lo più nascosto, occultato dalle convenzioni, dalle opinioni e dai costumi comunemente condivisi. La verità è insomma il risultato di una critica della
tradizione. Che cosa significa per Heidegger questa scoperta filologica? Significa che i Greci non soltanto pensavano e agivano, come anche noi facciamo, in base al principio della verità, ma erano anche consapevoli del modo in
cui questo principio si impone, ossia come una presenza
inestricabilmente connessa con l’assenza. Per Heidegger, la
differenza tra noi e i Greci sta tutta qui: noi ci lasciamo guidare acriticamente dai principi scoperti dai Greci, i Greci
sapevano invece di essere guidati da tali principi.
Heidegger
0140.p000-000_heidegger.qxd
12-12-2006
16:07
Pagina 18
i Marcel Duchamp, Ruota di bicicletta, 1915-1964. Si tratta di una delle prime sculture ready-made (“già
fatte”), costituita da una ruota mobile fissata a uno sgabello. «Questa macchina – afferma Duchamp –
non ha altra intenzione che quella di sbarazzarsi dell’apparenza di opera d’arte […].Voleva porre fine
al desiderio di creare l’opera d’arte».
realtà, la realtà stessa è già svelata come il criterio oggettivo
di tutto quello che possiamo dire al suo riguardo. Si comprende allora perché, per Heidegger, quella tra conoscenza
e oggetto conosciuto è una differenza tra essere ed ente (o
differenza ontologica). Presentandosi come il criterio a cui
l’atto conoscitivo deve adeguarsi, l’ente si presenta altresì
come altro, dunque come differente dal modo di essere che
esso assume nell’atto conoscitivo stesso.
La dipendenza
della conoscenza
dalla svelatezza
dell’ente
in quanto tale
La cosa si chiarisce meglio se riflettiamo sul significato del
verbo “rappresentare”, con il quale per lo più designiamo l’attività della mente in genere. Il sostantivo “rappresentazione” deriva
dal latino repraesentatio che significa letteralmente “ripresentazione”,
“presentazione di ciò che è già presente”. Perché questo raddoppiamento del presente e della presenza? Perché qualsiasi rappresentazione, anche una puramente fantastica come, ad esempio,
l’immagine di un abitante di Marte, allude sempre a qualcosa che
sta oltre la sfera del nostro attuale rappresentare. In ogni rappresentazione, quindi, il rappresentato si presenta come altro, ossia
come già presente rispetto alla presentazione che ne stiamo
facendo. In questo senso, la rappresentazione è un ripresentare,
un presentare ancora una volta ciò che è già presente. Non c’è
rappresentazione conoscitiva (o immaginativa, simbolica ecc.)
che non presupponga l’essere già presente del rappresentato
in quanto differente dalla rappresentazione attuale che ne
abbiamo. Heidegger chiama questa presenza preliminare
dell’ente, in quanto differente dall’attività rappresentativa,
«svelatezza dell’ente in quanto tale».
La differenza
ontologica quale
fondamento
del riferirsi
della
conoscenza
alla realtà
Sembra un ragionamento molto astratto ma, a guardare
bene, Heidegger non fa altro qui che evidenziare un’ovvietà per indurci a riflettervi sopra criticamente. Quando
diciamo “la neve è bianca”, o in qualsiasi altra asserzione sulla realtà, intendiamo naturalmente
esprimere il sussistere oggettivo di un fatto o di uno stato di cose reale. Lo stato di cose reale (la
neve bianca sussistente di fatto) a cui si riferisce l’asserzione (“la neve è bianca”) è dunque il criterio in base al quale diciamo quello che diciamo. In altri termini, quando asseriamo qualcosa
riguardo alla realtà, non vogliamo dare semplicemente espressione a una nostra privata impressione soggettiva, ma intendiamo cogliere le cose così come sono indipendentemente dalla rappresentazione con cui le cogliamo. In ogni asserzione facciamo dunque valere, implicitamente o
esplicitamente, la pretesa che quello che asseriamo si riferisca alla realtà. Lo differenza ontologica su cui Heidegger richiama l’attenzione è la «ragione» o il «fondamento» che ci consente di
avanzare questa ovvia pretesa di riferirci alla realtà.
3.3
Il carattere
problematico
della differenza
ontologica
Le due soluzioni del problema della differenza ontologica
Proprio perché ovvia, la pretesa avanzata in ogni conoscenza di riferirsi alla realtà non diviene
abitualmente oggetto di riflessione critica. Nel conoscere diamo cioè per scontato che l’ente sia
il criterio o la misura della conoscenza stessa, che sia cioè differente dall’essere. Portando alla
luce il fenomeno della differenza ontologica o svelatezza dell’ente in quanto tale, Heidegger
Il Novecento
18
0140.p000-000_heidegger.qxd
12-12-2006
16:07
Pagina 19
intende altresì indicarne il carattere problematico. La differenza ontologica esige cioè una fondazione filosofica che sia in grado di dimostrarne l’origine. Come abbiamo già osservato, Heidegger ritiene che nessuna filosofia abbia sinora fornito una soluzione soddisfacente a questo
problema. Benché in non pochi luoghi lasci intendere che il problema rimanga per lui in sostanza aperto, prima e dopo la svolta Heidegger prospetta due soluzioni differenti. Due soluzioni
che differiscono per il diverso ruolo che viene attribuito alla volontà e, dunque, all’agire dell’uomo.
3.3.1
La differenza ontologica come apertura umana
La soluzione
trascendentale
La prima soluzione, adottata in Essere e tempo e negli scritti immediatamente successivi, consiste nell’attribuire all’uomo la peculiare facoltà di «aprire» o «attuare» la differenza
ontologica. Si tratta di una soluzione umanistica o antropologica con la quale Heidegger, pur
criticandone i limiti, rimane parzialmente legato alla tradizione filosofica. Più in particolare,
come afferma in Kant e il problema della metafisica (Kant und das Problem der Metaphysik, 1929),
intende realizzare quello che, a suo parere, rappresenta il progetto incompiuto della filosofia
trascendentale kantiana, ossia la «fondazione della metafisica». Il termine “metafisica” è un
altro nome per designare l’apertura della differenza ontologica, dunque lo svelamento dell’ente
in quanto tale che precede e fonda ogni conoscenza. La fondazione trascendentale della conoscenza fisica compiuta da Kant nella Critica della ragion pura è, secondo Heidegger, soltanto un
momento di un più ampio, ma incompiuto, progetto kantiano di fondazione della differenza
ontologica.
L’autonomia
della volontà
e lo svelamento
La soluzione del problema della differenza ontologica prima della svolta si ispira dunque al trascendentalismo kantiano. Heidegger si richiama anche alla Critica della ragion pratica di Kant e,
in particolare, al tema dell’autonomia della volontà morale. Kant aveva attribuito all’uomo
la facoltà di agire liberamente, ossia di determinare la propria volontà indipendentemente da
ogni movente sensibile ❚ v. vol. II, nome capitolo, § 0, pp. 000-000 ❚. Nell’Essenza del fondamento (Vom
Wesen des Grundes, 1929) e in altri corsi universitari degli stessi anni, Heidegger collega esplicitamente il concetto della volontà libera al problema della differenza ontologica. Lo svelamento
dell’ente in quanto tale viene così definito come «l’azione originaria dell’esistenza umana,
nella quale tutto l’esistere in mezzo all’ente deve essere radicato». In altre parole, per
Heidegger, lo svelamento preliminare, grazie al quale l’ente si presenta come differente dall’essere rendendo così possibile la conoscenza, è il risultato di un’iniziativa umana.
Il volontarismo
teologico
nel tardo
medioevo
Benché Heidegger faccia soprattutto riferimento al trascendentalismo kantiano (oltre che a
Nietzsche), la fondazione della verità nella libertà del volere richiama in realtà un’altra dottrina
filosofica, sostenuta nel tardo Medioevo soprattutto da Duns Scoto e Occam ❚ v. vol. II, nome capitolo, pp. 000-000 ❚: il volontarismo. Si tratta di una concezione sorta, come era consueto in
epoca medioevale, per risolvere problemi di carattere teologico. La questione era se l’atto di
volontà con cui Dio ha creato il mondo fosse stato o no conforme a un piano razionalmente
comprensibile, dunque a una verità che avesse fatto da guida al volere divino. I volontaristi più
radicali non ammettevano nessuna verità preesistente alla volontà di Dio, perché altrimenti si
sarebbe dovuto anche ammettere che la libertà divina non è completamente libera. Non essendo possibile concepire niente che preesista all’atto di creazione del mondo, non potendosi cioè
ammettere nessuna limitazione della libertà divina, la volontà di Dio è da considerare indipendente da ogni verità che non sia essa stessa il risultato di una decisione divina. Nel volontarismo
teologico l’intelletto (o conoscenza) è dunque completamente subordinato alla volontà (o prassi).
Il carattere
volontaristico
e attivistico
della soluzione
trascendentale
La soluzione trascendentale del problema della differenza ontologica negli scritti heideggeriani
dei primi anni Trenta presenta una certa analogia con questo schema concettuale volontaristico. Schema che Heidegger, naturalmente, non riferisce a Dio, ma all’uomo. In particolare, Heidegger accentua nel senso volontaristico appena chiarito un’idea cardine di Essere e tempo, quella secondo la quale l’uomo è l’unico tra tutti gli enti a possedere, come suo carattere essenziale,
la capacità di comprendere l’essere (v. sopra § 2.1). In Essere e tempo, Heidegger aveva inoltre
19
Heidegger
Storie
per approfondire
0140.p000-000_heidegger.qxd
12-12-2006
16:07
Pagina 20
Heidegger e il nazismo:
l’illusione della filosofia al potere.
Una questione ancora assai controversa è quale sia
il rapporto tra la filosofia di Heidegger e la sua scelta politica a favore del nazismo. Una questione analoga a quella che, nel secondo dopoguerra, è sorta
in Italia a proposito di Giovanni Gentile, importante filosofo e eminente personalità politica del regime fascista (v. vol. III, cap. 00, § 3.2). Nel Novecento non
mancano altri casi di filosofi schierati a fianco di regimi politici tirannici, basati sulla repressione violenta della libertà. Si
pensi ai numerosi filosofi e uomini di cultura comunisti, come ad esempio l’ungherese György Lukács (1885-1971) e,
in Francia, Jean-Paul Sartre, che hanno dato pubblicamente
il proprio consenso a una dittatura totalitaria come quella
di Stalin, ferocemente avversa a ogni espressione di dissenso. Si tratta di un fatto non nuovo nella storia della filosofia.
Già Platone, infatti, aveva manifestato la propria propensione per la dittatura tentando di diventare consigliere di un
tiranno, Dionigi di Siracusa. Il rapporto tra filosofia e tirannide si può interpretare in modi diversi. Un primo modo consiste nell’individuare quali sono gli elementi ideologici che
rendono affine una certa filosofia al regime politico tirannico. Il caso di Heidegger, osservato da questa angolazione
prospettica, appare a molti indubbio. Molti interpreti, cioè,
ritengono che quella di Heidegger sia stata una filosofia irrazionalista, ostile alla scienza, all’argomentazione razionale,
alla libertà di pensiero, politicamente incline, quindi, a forme di governo come la dittatura. Si può tuttavia avanzare
un’interpretazione diversa e, forse, meno sommaria della
questione. L’accusa di irrazionalismo è infatti spesso indizio
della preconcetta volontà di liquidare l’avversario senza capirlo. E, nel caso della filosofia di Heidegger, il rimprovero di
essere un pensiero ostile alla libertà umana appare particolarmente inadeguato, visto il rilievo assolutamente centrale che questa nozione assume in tutta la sua opera. Sembra dunque più corretto spiegare la scelta politica di Heidegger come il frutto di un’illusione. È l’illusione, ricorrente
nella storia della filosofia, di potersi servire della dittatura
come di uno strumento, più rapido ed efficace di altre forme di governo, per condurre la filosofia al potere e rendere così compiutamente razionale la vita politica. Non c’è
dubbio quindi che a Heidegger vada rimproverata la sconcertante incapacità di capire in tempo gli evidenti propositi
criminali di Hitler e della sua cricca. Ma si tratta appunto di
mancanza di intelligenza politica e di scarso coraggio civile,
non di affinità ideologica tra la sua filosofia e la brutale mitologia irrazionalista propagandata dai nazisti.
inteso la nozione di «comprensione» (Verstehen) in senso non teoretico ma pratico, ossia come la
capacità dell’esserci di progettare la propria esistenza (v. sopra § 2.4.2). Estendendo all’ente in
quanto tale questa nozione di comprensione pratica, che in Essere e tempo rimaneva invece
ancora limitata all’esistenza umana, Heidegger conferisce al proprio pensiero un carattere
volontaristico e, per così dire, “attivistico”. Dalla capacità umana di svelamento – si legge ad
esempio nella conferenza sull’Essenza della verità – «nascono le decisioni semplici e rare della
storia». Non è un caso che gli scritti nei quali viene prospettata questa soluzione volontaristica
del problema della differenza ontologica risalgano agli anni in cui Heidegger compì la fatale
scelta di impegnarsi in politica.
3.3.2
La soluzione
antivolontaristica: la differenza
ontologica
come evento
La differenza ontologica come evento
In concomitanza con il suo ritiro dalla vita pubblica, Heidegger inizia la revisione critica della
propria concezione della prassi umana e del suo rapporto con la verità. Dalla seconda metà
degli anni Trenta, in particolare dal secondo dei due volumi intitolati Nietzsche (Nietzsche, 1961,
ma risalente al decennio 1936-46) fino a scritti tardi come Abbandono (Gelassenheit, 1959), Heidegger assume una posizione nettamente antivolontaristica. La differenza ontologica o
verità dell’ente in quanto tale non viene cioè più concepita come il prodotto di una libera
decisione umana, bensì come un «accadimento» o «evento storico» (Ereignis) di cui né
l’uomo né nessun altro ente è causa. La storia assume ora un rilievo molto diverso da quello che aveva prima della svolta. Prima della svolta, la storia era concepita da Heidegger come un
dominio specificamente umano contrapposto alla natura. Un dominio nel quale veniva a
espressione quella facoltà di agire liberamente che Heidegger riservava esclusivamente all’uomo, negandola agli enti non umani. Dopo la svolta Heidegger parla della storia in termini molto diversi, a una prima lettura piuttosto oscuri. Parla infatti del «destino dell’essere» che si esprime nel linguaggio mediante «appelli» ai quali l’uomo si trova di volta in volta a dover «rispondere». Che vorrà mai dire Heidegger con queste enigmatiche parole? Cerchiamo di chiarirle
analizzando distintamente due temi: la storia (§ 3.3.2.1) e il linguaggio (§ 3.3.2.2)
Il Novecento
20
0140.p000-000_heidegger.qxd
12-12-2006
16:07
Pagina 21
qui ci sono sotto-sotto paragrafi e sotto-sotto-sotto paragrafi:mi sa che è la prima volta che succede…
X ora ho messo in rosso i sotto-sotto-sotto paragrafi, ma se si decide di metterli farò nuovo stile.
3.3.2.1
La storia dell’essere come svelamento senza autore
Il senso verbale
dell’espressione
essere: l’azione
dell’accadere
Per comprendere il significato del concetto heideggeriano di «storia dell’essere» occorre anzitutto guardarsi dall’interpretarlo nel modo più ovvio e banale. Heidegger non intende affermare
che la prassi umana è soggetta al potere discrezionale di un’entità superiore – l’essere – che, come
una sorta di burattinaio, reggerebbe i fili delle vicende che si svolgono sul palcoscenico della storia. Non è questo quello che Heidegger intende dire. Intende semmai dire proprio il contrario,
ossia che non c’è nessun principio che governi l’accadere storico. Si ricordi ancora una
volta che Heidegger usa l’espressione “essere” in senso fenomenologico. L’essere è cioè il manifestarsi di ciò che è, il venire alla presenza dell’ente. Al pari di ogni altro verbo (“camminare”,
“mangiare”, “vedere” ecc.), l’espressione “essere” indica un’azione. O meglio, indica l’azione
dell’accadere in quanto tale, l’azione nella quale qualcosa in generale accade, si presenta.
Accadere
e ordine causale
dell’accadere
L’espressione “storia dell’essere”, osservata sotto questo profilo, risulta composta da due parole
aventi il medesimo significato. Per “storia” si intende infatti normalmente l’accadere, dunque il
manifestarsi di qualcosa. Quando ad esempio parliamo della “storia dei Romani”, intendiamo
l’insieme degli avvenimenti rilevanti (di carattere politico, sociale, culturale, economico ecc.) nei
quali gli uomini in un tempo e in uno spazio determinati si sono manifestati e ci si rendono oggi
manifesti grazie alle testimonianze di tali avvenimenti (narrazioni, monumenti, resti archeologici ecc). Per lo più, però, associamo a questo significato del termine storia anche l’idea di un ordine secondo il quale gli avvenimenti si sono prodotti. La storia ci appare allora come il risultato
di azioni compiute da persone o forze determinate. Quando pensiamo agli avvenimenti storici,
cioè, tendiamo a identificarli con qualcuno o qualcosa che li compie. Gli avvenimento ci
appaiono allora come conseguenze di una causa.
L’avvenimento
storico
e la successiva
esigenza di
comprenderlo
Ad esempio, diciamo che la crisi economica subita dalla Germania nel 1929 fu la causa dell’avvento al potere di Hitler, individuiamo cioè una forza economica come autrice dell’avvenimento. Oppure diciamo che l’invasione tedesca della Polonia nel 1939 scatenò la seconda guerra
mondiale. Questo modo di ragionare per cause è giustificato dall’esigenza di spiegare, comprendere, rendere ragione degli avvenimenti, un’esigenza che nasce sempre dopo che sono accaduti.
Non è difficile accorgersi, però, che quando si riconduce un avvenimento a una causa determinata, ossia a qualcuno o qualcosa che l’ha compiuto, si finisce inevitabilmente con l’“immobilizzare”, per così dire, il carattere dinamico di ogni avvenimento. Un avvenimento storico, nel
momento in cui accade, non è altro che se stesso, è cioè qualcosa di imprevisto, dunque qualcosa che, propriamente, non ha né causa né autore. Le intenzioni stesse di chi è protagonista di un
avvenimento storico, ad esempio le intenzioni di Hitler quando dà l’ordine di invadere la Polo-
i Passato e presente si confrontano in un processo interpretativo tipico di molta pittura contemporanea: il quadro di Magritte qui a destra
(Prospettiva: Madame Recamier di David, 1950) ripropone – con una macabra variazione – il soggetto di un famoso dipinto del 1771 di
Jacques-Louis David (Ritratto di Madame Recamier, Parigi, Louvre).
21
Heidegger
0140.p000-000_heidegger.qxd
12-12-2006
16:07
Pagina 22
nia, rappresentano soltanto, per così dire, “uno degli infiniti fili” di quella gigantesca “trama” di
fatti che, soltanto retrospettivamente, quando cioè l’avvenimento si sarà compiuto, potrà essere
individuata come “seconda guerra mondiale”.
La storicità
di ogni pensare
e agire umano
Con le espressioni «storia dell’essere», «evento» o anche «verità dell’essere» Heidegger designa
proprio questa dimensione della storia come un accadere che non ha nessun autore o causa,
dunque nessun ente a cui possa venir ricondotto. In altre parole, dopo la svolta, Heidegger considera lo svelare come un essere (nel senso verbale della parola) senza ente, uno svelamento senza autore. Si comprende meglio, a questo punto, che cosa implichi la svolta antiumanistica. Affermando che la differenza ontologica, dunque la svelamento grazie al quale l’ente
in quanto tale si impone come criterio della conoscenza, è un destino della storia dell’essere,
Heidegger colloca sia il pensare sia l’agire umano in una prospettiva integralmente
storica. Non ammette più quindi, come invece faceva prima della svolta, un primato della
prassi sulla teoria. Tanto l’agire quanto il pensare sono modalità di un puro svelare o venire alla
presenza che non è opera né dell’uomo né di nessun altro ente.
L’impossibilità
di dominare
e calcolare
l’evento
In altri termini, secondo Heidegger, quando pensiamo e agiamo, noi non siamo mai la causa, ossia
non produciamo il nostro pensare e agire. Possiamo, certo, produrre concetti (idee, dottrine, ideologie) o cose (scarpe, automobili, centrali nucleari). Con le moderne tecniche di manipolazione
genetica, siamo persino in grado di produrre esseri umani così come produciamo scarpe, facendo
sì, cioè, che vengano fuori perfettamente conformi a un modello. Tuttavia, secondo Heidegger,
non saremo mai in grado di produrre l’essere, dunque l’accadere, il manifestarsi della produzione
stessa. Anche là dove, come accade nella tecnica contemporanea ❚ v. sotto § 3.3.3 e Lettura 5 ❚, tutto viene ricondotto alla capacità umana di «disporre» o «dominare» grazie all’«organizzazione» e
al «calcolo», questa stessa capacità illimitata di disposizione e dominio rimane «indisponibile» e
«indominabile». Ci si chiederà: che fare allora? La conseguenza che Heidegger invita a trarre da
questa radicale storicizzazione di ogni attività umana è, in fondo, molto semplice. Si tratta in
sostanza di «meditare» sull’evento, ossia di tenere desto il ricordo del puro e semplice accadere che
l’uomo non può né dominare né calcolare in anticipo. Una conseguenza che, a chi chiede alla filosofia indicazioni per concrete soluzioni pratiche, appare certo molto deludente. Al proposito, però,
non si dimentichi la circostanza biografica in cui è maturato questo pensiero, ossia la delusione
riguardo a quella «rivoluzione nazionalsocialista» a cui Heidegger era andato incontro con le più
grandi speranze. Fu anzitutto questa delusione a persuadere Heidegger dell’impossibilità di ogni
soluzione tecnica, dunque volontaristica e attivistica, dei problemi del mondo contemporaneo.
3.3.2.2
Il linguaggio e il confronto critico con la tradizione occidentale
La filosofia
come
interpretazione
o meditazione
storica
Dagli anni Trenta in poi, molti degli scritto e dei corsi universitari di Heidegger sono dedicati alla
lettura di testi filosofici, dai frammenti dei presocratici fino ai libri di Nietzsche. Particolare attenzione inoltre viene da lui prestata all’arte, in particolare alla poesia di Hölderlin ❚ v. vol. III,
nome capitolo, § 0, pp. 000-000 ❚. Il secondo Heidegger indica dunque come compito del pensiero
l’«interpretazione» (Erörterung) o «meditazione storica» (Besinnung) sui testi in cui prende
corpo quella che chiamiamo “tradizione occidentale”. A questa indicazione di Heidegger ha fatto seguito una parte rilevante dell’attuale filosofia contemporanea, in particolare l’ermeneutica
di Hans Georg Gadamer ❚ v. vol. III, L’ermeneutica, § 0, pp. 000-000 ❚ e, con atteggiamento più critico, il decostruzionismo di Jacques Derrida ❚ v. vol. III, nome capitolo, pp. 000-000 ❚.
L’appartenenza
dell’uomo
allo svelamento
testimoniata
dal parlare
Perché, secondo Heidegger, la filosofia deve confrontarsi con la tradizione? Il motivo è
strettamente connesso alla soluzione del problema della differenza ontologica adottata dopo la
svolta. Conseguenza decisiva di tale soluzione è, come abbiamo visto, l’affermazione secondo
cui il pensiero umano è soltanto un modo della storia dell’essere, dunque dell’evento dello svelamento. L’uomo non è autore dello svelamento né quando agisce né quando pensa. Pur non
essendone l’autore, però, l’uomo, così come ogni altro ente, «appartiene» all’essere, è, per così
dire, “immerso” nello svelamento. C’è un modo di essere dell’uomo, dunque un suo modo di
manifestarsi, secondo Heidegger, nel quale la sua «appartenenza allo svelamento» diventa parIl Novecento
22
Storie
per approfondire
0140.p000-000_heidegger.qxd
12-12-2006
16:07
Pagina 23
Perché i poeti?
Perché i poeti? (Wozu Dichter?, 1950, ma risalente
al 1946) è il titolo di una conferenza di Heidegger
che riecheggia un verso del poeta da lui più amato, il tedesco Friedrich Hölderlin (1770-1840).
Nell’elegia Pane e vino (Brod und Wein) Hölderlin
si era infatti chiesto: «Perché i poeti in un tempo
di miseria?». Nella conferenza, Heidegger afferma
che poeti sono coloro che «scendono nell’abisso» e,
facendo così esperienza della «notte del mondo», si mettono sulle tracce degli «dèi fuggiti». Per comprendere
simili affermazioni, così suggestive ma anche così provocatoriamente lontane dal linguaggio consueto della filosofia, occorre anzitutto prestare attenzione all’anno in cui
Heidegger tenne la conferenza: 1946. Siamo dunque nell’immediato dopoguerra, nella Germania bombardata e
ridotta a un cumulo di macerie e occupata dalle potenze
alleate. Parole come «abisso», «notte del mondo», «fuga
degli dèi» danno immediata espressione lirica alla miseria,
al dolore, alla lacerazione del momento presente. Esprimono cioè l’esperienza concreta di quello che Nietzsche
aveva chiamato «nichilismo europeo». «Perché i poeti?»
è quindi una domanda volutamente paradossale, giacché
chiede il senso o lo scopo di una esperienza il cui “oggetto” è proprio il «nulla», la mancanza di senso, l’assenza di
direzione o scopo. Wozu? significa infatti, letteralmente,“a
che scopo?”,“verso dove?”. In un luogo e in un momento
che verranno di lì a poco icasticamente ritratti dal titolo
di un film del regista italiano Roberto Rosselini (19061977), Germania anno zero (1948), Heidegger poneva
dunque la domanda sul senso dell’insensatezza. Si chiedeva cioè quale fosse lo scopo e la direzione di una esperienza di mancanza di scopo e di direzione che ogni tede-
sco, e non soltanto i poeti, stava tragicamente vivendo
sulla propria pelle.
Nella conferenza, Heidegger non dà risposte, non pretende cioè di attribuire un senso alla mancanza di senso,
né considera la poesia uno strumento per superarla. Il
richiamo ai poeti, però, serve a marcare la differenza tra
due atteggiamenti umani: l’atteggiamento dei tecnici, che
vogliono dominare la mancanza di senso organizzando in
modo sempre più esatto e capillare la vita umana, e l’atteggiamento dei poeti, che invece «scendono nell’abisso»
della «notte del mondo» sulle «tracce degli dèi fuggiti». I
primi, per Heidegger, non sono capaci di «sopportare» la
mancanza di senso, cercano di dimenticarla dando sfogo
alla propria «volontà di potenza» e finiscono così con
l’accrescere l’insensatezza. Per Heidegger, infatti, la guerra
non è altro che lo scatenamento di questa volontà di
dominio tecnico. I poeti, invece, sono in grado di sopportare la «miseria» del proprio tempo. Heidegger assegna
perciò alla poesia e, più in generale, all’arte il compito di
«preparare» gli uomini a un possibile mutamento del
loro destino storico. Per Heidegger è infatti evidente che
nessuna tecnica umana potrà mai rischiarare la «notte
del mondo». Il nichilismo non può cioè essere superato
tecnicamente, perché la tecnica è l’espressione suprema
del nichilismo. Il paesaggio che fa da sfondo alla conferenza, le macerie dell’«anno zero» della Germania sono per
Heidegger la più eloquente testimonianza del carattere
inesorabilmente distruttivo della tecnica. Senonché, proprio l’esperienza non tecnica della «notte del mondo», di
cui i poeti si fanno portavoce, può essere l’occasione per
un «nuovo inizio» della storia umana. I poeti sono dunque per Heidegger una sorta di “profeti” che annunciano
agli uomini la possibile via d’uscita dal nichilismo tecnico.
ticolarmente evidente: il parlare. Il parlare è infatti evidentemente uno svelare. Quando diciamo qualcosa, ad esempio, “fuori piove”, rendiamo manifesta la pioggia che sta cadendo.
Il senso non
soggettivistico
del possesso
umano
del linguaggio
Ma c’è di più: l’uomo è l’unico tra tutti gli enti animati e inanimati a essere dotato del
linguaggio. Che il linguaggio sia una caratteristica specificamente umana è noto da lungo tempo, come attesta l’antica definizione greca dell’essenza dell’uomo come «animale dotato di
discorso» (zoòn logon echon). Sennonché Heidegger, nel richiamare l’attenzione su questa definizione, precisa che non va intesa nel senso che l’uomo sia l’autore del parlare. Non va inteso cioè
in senso soggettivistico. Il parlare, in quanto svelare, è piuttosto il modo d’essere nel quale l’uomo diviene manifesto. Quando diciamo “fuori piove”, infatti, non manifestiamo soltanto l’evento atmosferico che sta avendo luogo, ma rendiamo inevitabilmente manifesti anche noi stessi. O
meglio, rendiamo manifesti noi stessi a qualcun altro che in questo momento ci sta ascoltando.
Se non c’è nessuno che ci sente, le nostre parole – come si dice – “cadono nel vuoto”, ossia non
ha luogo alcuna manifestazione, né quella della pioggia, né quella che ci riguarda.
La possibilità
offerta all’uomo
di rispondere
all’appello
del linguaggio
Muovendo da queste elementari osservazioni fenomenologiche riguardo al parlare o «dire»,
Heidegger giunge all’affermazione paradossale secondo cui ciò che parla, ossia il «parlante», non è propriamente l’uomo, ma il linguaggio stesso. Si faccia attenzione: Heidegger
non dice che il linguaggio sia un’entità trascendente che parla per bocca dell’uomo, bensì, proprio al contrario, che il parlare, così come ogni altro accadere dello svelamento, non è causato
23
Heidegger
0140.p000-000_heidegger.qxd
12-12-2006
16:07
Pagina 24
x risparmiare una pagina, secondo me questo è il punto migliore x tagliare: è una
"zona" piena di box che, oltretutto, sono anche molto lunghi
Storie
per approfondire
L’ascoltare
e il ringraziare
come
autoriflessione
dell’umanità
occidentale
Secondo Heidegger, la tradizione storica è il susseguirsi delle risposte date dall’uomo
all’appello del linguaggio. Possiamo ora capire meglio perché Heidegger ritenga che il compito del pensiero sia il confronto con la tradizione. Rispondendo all’appello che il linguaggio ha
loro rivolto, i pensatori e i poeti che ci hanno preceduto non hanno fatto altro, in sostanza, che
comprendere se stessi. Nelle loro parole si è, per così dire, “sedimentato” e “conservato” lo svelamento, il venire alla presenza, l’evento, l’accadere dell’essere nel quale l’umanità è divenuta
quello che è. L’interpretazione della tradizione o meditazione sulla storia dell’essere è per Heidegger un «porsi all’ascolto» delle «parole essenziali» di pensatori e poeti grazie alle quali
l’evento dell’essere si è reso manifesto. A tale scopo Heidegger ricorre sovente alle etimologie,
vale a dire, allo studio dell’origine delle parole. Si tratta, a dire il vero, di etimologie che la linguistica contemporanea considera in molti casi prive di fondamento scientifico, frutto di semplici giochi di parole. Un esempio di questo controverso metodo etimologico è l’affinità rilevata da
Heidegger tra le espressioni che nella lingua tedesca designano le attività del denken, “pensare”, e del danken, “ringraziare”. In base a questa consonanza, Heidegger ritiene che il pensie-
La domanda «che cos’è una cosa?»
e le scarpe di Van Gogh
Heidegger pone, in diverse occasioni, una strana
domanda: «Che cos’è una cosa?». Una domanda
strana e singolare perché, a ben vedere, la comprendiamo soltanto se già possediamo una risposta. La domanda chiede infatti che cosa una cosa
è. Presuppone dunque implicitamente proprio
quella nozione di “cosa” che pone invece esplicitamente
in questione. Si tratta quindi di una domanda che gira in
circolo. Un circolo che sembra il frutto di un inutile gioco
speculativo, ma che, invece, secondo Heidegger è presente in modo latente in ogni nostra esperienza, anche la più
comune. Qualsiasi cosa, cioè, guardiamo, sentiamo, odoriamo, amiamo, odiamo, dimentichiamo ecc. è sempre, ad
un tempo, nota e ignota, familiare ed estranea, saputa e
non saputa, presente e assente. Nel saggio L’origine dell’opera d’arte (1950), Heidegger mostra che questa caratteristica paradossale di ogni esperienza umana giunge ad
espressione soprattutto nelle opere d’arte. Più precisamente, Heidegger afferma che l’opera d’arte «pone in
opera la verità». Cerchiamo di capire meglio. Il saggio sull’arte comincia proprio con la domanda: «Che cos’è una
cosa?». Diversamente, però, da quanto accade in altri suoi
testi in cui il problema viene sollevato, Heidegger si serve
qui di un esempio tratto dalle arti figurative: un quadro
del pittore olandese Vincent Van Gogh (1853-1890) raffigurante un paio di scarpe visibilmente deformate dall’uso. Heidegger immagina che siano scarpe da lavoro di una
contadina, e se ne serve per chiarire che cosa sia un mezzo o strumento, ossia una cosa che serve a qualcos’altro.
La caratteristica di ogni strumento, infatti, è di essere in
Il Novecento
rapporto con quello a cui serve. Un paio di scarpe, ad
esempio, rinvia necessariamente ai piedi, in funzione dei
quali le scarpe sono state prodotte. Un paio di scarpe
non è dunque una cosa isolata, ma rende implicitamente
presente una quantità di altre cose (i piedi, le gambe, l’uomo che le calza, il suo camminare, la materia di cui le scarpe sono fatte ecc). Per rendere espliciti questi riferimenti occorre interpretarli, seguire cioè i rinvii contenuti in
quello che abbiamo dinanzi. Nell’interpretare il quadro di
Van Gogh, Heidegger non fa altro che esplicitare, dunque
seguire, i possibili rinvii contenuti nell’immagine delle
scarpe. Ecco allora che, secondo Heidegger, «dall’interno
logoro» delle scarpe «si palesa la fatica del cammino percorso lavorando», sul «cuoio» vediamo depositato
l’«umidore» e il «turgore del terreno», «sotto le suole»
avvertiamo «la solitudine del sentiero campestre nella
sera che cala» ecc.Tutto ciò, naturalmente, non è contenuto nel quadro nello stesso modo in cui vi sono contenuti i colori, le pennellate, la tela e tutto quanto lo costituisce materialmente.Tuttavia, questi e altri rinvii che ciascuno di noi può vedere mettendosi dinanzi all’immagine
di Van Gogh fanno indubbiamente parte del quadro. Ne
fanno parte come una sorta di alone in cui è contenuto
l’assente, l’ignoto, l’estraneo, l’implicito a cui il presente, il
noto, il familiare, l’esplicito rinvia. Non è difficile, a questo
punto, capire perché Heidegger dica che l’arte è la «messa in opera della verità». Sappiamo, infatti, che la verità è
per Heidegger la «svelatezza», ossia il nesso tra presenza
e assenza (v. box A-letheia). Il quadro di Van Gogh mette
in opera le verità nel senso che espone il nesso della presenza con l’assenza, dell’esplicito con l’implicito, del familiare con l’estraneo.
24
ro filosofico debba assumere l’atteggiamento di chi accoglie un dono, ossia «rendere grazie»
all’evento dell’essere che «si dona» nella parola. La concezione del pensiero come ascolto e ringraziamento può essere considerata come un modo diverso di mettere in atto l’atteggiamento
né dall’uomo né da nessun altro ente. Tuttavia, come abbiamo appena osservato, il parlare è
svelante soltanto se c’è qualcuno che ascolta o – come Heidegger dice – che è «appellato». Da
ciò segue, secondo Heidegger, che lo svelamento linguistico offre all’uomo, per così dire, “un
margine d’iniziativa”. Benché non sia autore del parlare, l’uomo può «rispondere all’appello che il linguaggio gli rivolge».
16:07
Pagina 25
Tra gli scritti heideggeriani raccolti in In cammino
verso il linguaggio (1959) ce ne è uno che si intitola
Da un colloquio dal linguaggio (Aus einem Gespräch
von der Sprache). È un dialogo tra due personaggi,
l’uno chiamato «l’interrogante», l’altro «il giapponese». Si tratta del resoconto di un colloquio realmente avvenuto tra Heidegger e un suo ospite venuto dal
Giappone, attento studioso del pensiero heideggeriano e
della letteratura tedesca. Inoltre, particolare importante in
questo contesto, l’ospite straniero aveva tradotto in giapponese alcune opere di Heidegger. L’incontro tra i due
diventa così l’occasione per una riflessione sul linguaggio e,
in particolare, sulla possibilità di tradurre da lingua a un’altra. La discussione si concentra, tra l’altro, su una parola
giapponese, iki, espressione che potremmo considerare
approssimativamente equivalente a “seduzione della bellezza”. L’«interrogante», dunque Heidegger stesso, esprime
la propria difficoltà a comprendere quello che iki veramente significa per un madrelingua giapponese. Più in particolare, la difficoltà consiste nel fatto che, tradotta in tedesco, la
parola assume inevitabilmente, per così dire, un “significato
occidentale”. Secondo una tradizione che parte da Platone, la bellezza è l’apparire sensibile di ciò che non è sensibile, ossia del «sovrasensibile» o «ideale».Tradotta in una lingua occidentale, la parola iki assume dunque secondo Heidegger una connotazione “metafisica” nel senso letterale
del termine di origine greca, vale a dire significa qualcosa
“che sta al di là” (in greco: metà) di ciò che è “fisicamente”,
ossia sensibilmente,“presente”. Grazie ad alcuni chiarimenti dell’ospite giapponese, il dialogo giunge a mostrare che la
parola iki è intesa dai madrelingua in modo completamente diverso. Si osservi, al proposito, che il termine è usato
per designare la particolare seduzione esercitata dalle geishe, le donne che sin dall’antichità, in Giappone, intrattenevano gli ospiti di sesso maschile delle case da tè danzando,
cantando e conversando amabilmente. Si tratta dunque di
una seduzione artistica, strettamente legata, però, alla sfera
dell’erotismo e della sessualità, dunque del corpo e della
sensibilità. Si comprende dunque perché la traduzione
occidentale, ossia “metafisica” della parola porti completamente fuori strada.
Ci potremmo però chiedere perché mai l’«interrogante»
insista sulla difficoltà a intendere quello che la parola propriamente significa. Non è sufficiente osservare che l’iki è
legato all’erotismo, al corpo, non ha cioè nulla di metafisico,
ideale o sovrasensibile? Cosa c’è qui, ancora, da interrogare, da mettere in questione? In realtà, il senso del dialogo
sta proprio in questo insistere sull’interrogazione (per questo Heidegger chiama se stesso l’«interrogante»). Heidegger intende cioè richiamare l’attenzione sul fatto che le
distinzioni metafisiche, in particolare la distinzione paradigmatica della metafisica occidentale, quella tra sensibile e
sovrasensibile, è, per così dire, “incorporata” nella lingua
stessa che parliamo. Ne deriva che anche quando proviamo a correggerne le parole, precisando ad esempio che iki
designa una forma di seduzione soltanto corporea, siamo
costretti a distinguere ciò che è corporeo da ciò che non
lo è. Le lingue occidentali recano dunque con sé una
«grammatica metafisica», costringono cioè a pensare in
base a categorie come sensibile/sovrasensibile o soggetto/oggetto, materiale/spirituale ecc. Senonché, proprio il
fatto che le categorie, i principi, i modi di pensare metafisici
hanno questa natura linguistica consente, secondo Heidegger, di «oltrepassare» la metafisica. Come? Tentando di fare
esperienza dell’«accadere» della lingua, ad esempio, traducendola in una radicalmente diversa o, più in generale,
facendo dialogare mondi linguisticamente eterogenei
come l’Occidente e l’Oriente. La traduzione e il dialogo fra
culture estranee richiede però la disposizione a «rispondere all’appello del linguaggio», ossia a fare esperienza del linguaggio come ciò che struttura il nostro modo di pensare.
L’intero dialogo col giapponese è la messa in scena di questa esperienza della lingua occidentale, esperienza rivolta a
superarne la grammatica metafisica.
più tipico della filosofia: la riflessione su di sé. Non si tratta però evidentemente né di una riflessione psicologica, né della riflessione trascendentale che, secondo la filosofia moderna da Cartesio a Husserl, consente di accedere alla soggettività umana come a una fonte di certezza incontrovertibile, al riparo del divenire storico. L’uomo al quale le interpretazioni offerte da Heidegger danno accesso è soltanto una figura storicamente determinata, più in particolare, è la figura
assunta dall’umanità occidentale dall’antichità greca ai nostri giorni.
g
3.3.3
Occidente
e metafisica
L’oltrepassamento della metafisica e il problema della tecnica
La meditazione storica del secondo Heidegger persegue uno scopo essenzialmente critico. Non
si tratta di accertare quanto è accaduto nel passato e di farne così un modello a cui il presente
debba tornare. Si tratta, piuttosto, di comprendere l’originarsi storico del presente, ossia dell’umanità occidentale così come essa è attualmente. La domanda che guida la meditazione storica
è insomma: “chi siamo noi occidentali?”. Per comprendere la risposta di Heidegger occorre tornare al problema della differenza ontologica. La sua tesi è infatti che l’umanità occidentale è l’a25
Heidegger
prirsi della differenza ontologica, ossia l’imporsi dell’ente in quanto tale. L’espressione
“Occidente” diventa cioè sinonimo di “metafisica”. Occorre qui fare attenzione al capovolgimento di significato che, con la «svolta», subisce la parola “metafisica”.
Storie
12-12-2006
Che cos’è l’iki? Il colloquio
di Heidegger con un giapponese
p
gg
per approfondire
0140.p000-000_heidegger.qxd
0140.p000-000_heidegger.qxd
12-12-2006
16:07
Pagina 26
Il
capovolgimento
del significato
della metafisica
dopo la svolta
Avevamo osservato che, già prima della svolta, Heidegger intendeva con “metafisica” la differenza ontologica, ossia l’imporsi dell’ente come criterio del conoscere e dell’agire liberamente
voluto dall’uomo. Dopo la svolta, questo significato del termine “metafisica” in parte si mantiene, ma assume però una connotazione nettamente negativa. La metafisica diventa espressione,
non già della libertà, ma di una «necessità» o «costrizione» (Not) che vincola dispoticamente
tanto la conoscenza quanto la prassi. Il mutamento del giudizio di Heidegger riguardo alla
metafisica è diretta conseguenza della nuova soluzione da lui data dopo la svolta al problema
della differenza ontologica. Come avevamo visto, la differenza ontologica, o svelatezza dell’ente
in quanto tale, è il manifestarsi o svelarsi dell’ente come differente dall’essere. In altre parole,
l’ente è svelato in quanto tale quando si presenta come indipendente dall’atto di svelamento che
lo fa essere presente (v. sopra § 3.2).
La necessità
di portare
a compimento
la metafisica
prima della
svolta
Sennonché, in base alla dottrina volontaristica che precede la svolta, lo svelarsi dell’ente come
indipendente e altro dall’essere accade grazie all’uomo e, in particolare, alla sua capacità di “creare liberamente”, per così dire, lo svelamento. Con ciò Heidegger intendeva proseguire quella che
gli sembrava essere la linea di pensiero predominante e più feconda dell’intera tradizione filosofica
occidentale da Platone fino a Husserl: la concezione metafisica dell’uomo come origine della verità. Di più: Heidegger assegnava a se stesso il compito di «portare a compimento» questo
umanismo metafisico. A suo giudizio, infatti, la metafisica tradizionale richiedeva di essere perfezionata. In particolare, Heidegger riteneva che la metafisica si fosse fino a quel momento limitata a
svelare l’ente in quanto tale in modo soltanto parziale, come ad esempio era accaduto a Kant, che
non era andato in sostanza oltre lo svelamento della natura, ossia della «regione» degli oggetti della conoscenza fisico-matematica. La metafisica – come Heidegger diceva prima della svolta in
Kant e il problema della metafisica – andava dunque «ripetuta», ossia portata a compimento realizzando integralmente il suo progetto di svelamento dell’ente in quanto tale.
L’oltrepassamento della
metafisica
Heidegger prima della svolta vedeva dunque la metafisica come una possibilità che la filosofia
doveva finalmente mettere in pratica realizzandone le potenzialità ancora inespresse. Con la
svolta, la posizione di Heidegger riguardo al «compito del pensiero» e, più in generale, riguardo
alla possibilità stessa di una traduzione pratica della filosofia muta radicalmente. Non si tratta più
ora di portare a compimento quello che la metafisica aveva lasciato incompiuto ma, semmai, di
«oltrepassare la metafisica», ossia di criticare e abbandonare il suo progetto di svelare l’ente
in quanto tale. Ma che cosa significa, in concreto, oltrepassare o «superare» la metafisica? Heidegger invita a lasciarsi alle spalle quello che considera l’atteggiamento più caratteristico dell’umanità occidentale. È, in sostanza, l’atteggiamento che rende il pensiero una funzione
della prassi, che ne fa cioè uno strumento per modificare, guidare, trasformare, dominare la
realtà in vista di scopi posti dall’uomo. La metafisica va oltrepassata perché fornisce il principio
che giustifica teoricamente questa subordinazione del pensiero alla prassi. Principio che coincide
con la soluzione umanistica che Heidegger stesso aveva dato al problema della differenza ontologica prima della svolta. Affermando, infatti, che lo svelamento grazie al quale l’ente si presenta
come indipendente dallo svelamento stesso è opera dell’uomo, Heidegger aveva vincolato la svelatezza, dunque la verità, il pensiero, la teoria alle esigenze pratiche dell’uomo.
Metafisica
e tecnica
Con la svolta Heidegger diventa dunque consapevole che l’apertura umana della differenza
ontologica, ossia la metafisica, l’umanismo, il soggettivismo e tutto quanto è per lui sinonimo di
“Occidente”, ha un carattere essenzialmente tecnico. Proviamo a chiarire con un esempio.
Se intendiamo abbreviare la distanza tra due città costruendo un’autostrada, dobbiamo anzitutto procurarci la rappresentazione esatta di tale distanza, poi dei mezzi che occorrono per aprire
la via, dei materiali necessari per costruirne le strutture ecc. Ciascuna delle rappresentazioni che
precedono e rendono possibile la costruzione dell’autostrada è uno svelamento nel quale le cose
si presentano in modo oggettivo, indipendentemente cioè dai modi soggettivi in cui ne facciamo
quotidianamente esperienza. Si tratta dunque di rappresentazioni che presuppongono l’apertura della differenza ontologica. La distanza oggettiva tra le due città, ad esempio, è del tutto indipendente dal senso della distanza che avvertiamo quando viaggiamo dall’una all’altra. In viaggio, infatti, la distanza rimane legata alla nostra soggettiva esperienza, allo stato d’animo, ad
Il Novecento
26
0140.p000-000_heidegger.qxd
12-12-2006
16:07
Pagina 27
o Vincent Van Gogh, Un paio di scarpe
(1886, Amsterdam Rijksmuseum).
Nell’Origine dell’opera d’arte (1936)
Heidegger conduce un’analisi approfondita
del dipinto di Van Gogh: le scarpe non
vengono colte nel loro funzionamento, ma
sono sospese da ogni funzione e, proprio in
virtù di ciò, ci si accorge che sono cose. La
cosa, quindi, è cosa solamente nell’opera
d’arte e non perché questa coglie la
bellezza, ma perché mostra la cosa nel suo
essere cosa: diventando opera d’arte,
l’oggetto si preserva dalla dissoluzione,
perché lo sguardo estetico, sostiene
Heidegger, è uno sguardo che preserva.
esempio all’ansia di arrivare in tempo che dilata il percorso, alla gioia di
incontrare qualcuno all’arrivo che
rende la strada interessante e varia,
alla noia del ritorno che la rende vuota e ripetitiva ecc. La misurazione esatta prescinde ovviamente da tutto ciò per presentare la distanza così come è in se stessa, ossia come una quantità numerica.
Oggettività e
dominio tecnico
della realtà
Qual è la differenza tra la distanza vissuta in occasione di un viaggio e la distanza misurata in
modo esatto? La prima è indissolubilmente legata al suo modo di presentarsi, al punto che non
è mai la stessa distanza, ma varia di volta in volta a seconda delle circostanze (un viaggio di lavoro, ad esempio, è diverso da una vacanza, l’andata è sempre diversa dal ritorno). La distanza
esatta è invece indipendente dal suo modo di presentarsi. Tuttavia, proprio questa indipendenza
oggettiva della distanza dal modo soggettivo di presentarsi ne fa qualcosa che sta a disposizione
del fare umano e può così essere modificato. Soltanto se misurata esattamente, infatti, la distanza tra due città può essere abbreviata, ad esempio costruendo viadotti e gallerie. Soltanto in
quanto oggettiva, quindi, la distanza diventa suscettibile di essere modificata, trasformata, ordinata e dominata da parte dell’uomo.
La tecnica
come
compimento
della metafisica
Risulta a questo punto chiaro il nesso tra l’esigenza, sollevata da Heidegger dopo la svolta, di
oltrepassare la metafisica e il problema della tecnica. Una delle tesi centrali del secondo Heidegger è infatti che la metafisica «si compie» nella tecnica moderna. Si faccia però attenzione al significato strettamente fenomenologico che assume in Heidegger il termine “tecnica”.
Per Heidegger, la tecnica non è, o non è soltanto, l’insieme dei dispositivi escogitati dall’ingegneria umana per soggiogare le forze della natura e consentire la completa antropizzazione del pianeta. Espressione della tecnica non sono soltanto la ruota, il martello, il motore, la bomba atomica ecc. Heidegger intende la tecnica in senso fenomenologico, ossia come un modo di manifestarsi delle cose. La ruota e la bomba atomica rientrano dunque certamente nell’ambito della tecnica, ma nel senso specifico che, al pari di tutti gli altri dispositivi, fanno sì che gli enti appaiano in
un determinato modo. In particolare, la tecnica moderna fa sì che l’ente appaia come un
«fondo», ossia come qualcosa il cui essere consiste nel puro e semplice «stare a disposizione» del
fare umano ❚ Lettura 5 ❚. La tecnica è, in altre parole, quella svelatezza nella quale l’ente si presenta come tale da essere suscettibile di manipolazione, organizzazione, calcolo, dominio ecc.
Il nichilismo
tecnicometafisico
Si comprende dunque meglio il senso dell’affermazione di Heidegger secondo cui la metafisica si
compie nella tecnica. La tecnica non è altro che il definitivo compiersi, ossia realizzarsi, concretizzarsi del progetto metafisico che secondo Heidegger guida l’intera storia occidentale (e avrebbe
guidato Heidegger stesso prima della svolta): fare dello svelamento dell’ente in quanto tale un prodotto dell’uomo. Nello svelamento tecnico, cioè, l’essere dell’ente, ossia l’accadere in cui le cose si
27
Heidegger
0140.p000-000_heidegger.qxd
12-12-2006
16:07
Pagina 28
manifestano appare come il risultato del volere umano. Ciò significa che tanto la metafisica quanto la tecnica sono per Heidegger espressioni del «nichilismo». Concepire l’essere come ciò che è
posto dalla volontà umana equivale infatti per Heidegger a negargli ogni significato autonomo,
renderlo dunque pari a nulla (l’espressione “nichilismo” viene dal latino nihil, “nulla”).
Il carattere
nichilistico
della riduzione
tecnica
della cosa
a funzione
Chiariamo questa concezione con un esempio concreto. Pensiamo al modo in cui un albero da
frutta si presenta allo sguardo di un ingegnere biochimico. Che cosa vede un ingegnere biochimico quando analizza, ad esempio, un arancio? Vede le diverse funzioni chimiche che presiedono al nascere del frutto, l’arancia che possiamo cogliere e mangiare. Il suo sguardo non si limita
però a rilevare processi naturali. Nel comprendere le funzioni chimiche, l’ingegnere vede anzitutto le possibilità di modificarle e combinarle in modo da creare qualcosa che l’albero da solo
non può creare. Ad esempio, modificandone opportunamente il patrimonio genetico, il biochimico può far sì che l’albero produca arance di dimensioni, colore e peso omogenei, più adatte
alla vendita. Il biochimico vede dunque l’arancio anzitutto come qualcosa che può essere manipolato, ossia adattato in modo potenzialmente infinito a funzioni che possono anche non avere
alcun rapporto con l’arancio. È il caso delle più recenti tecniche di produzione dei cosiddetti “organismi geneticamente modificati” (OGM), grazie alle quali, ad esempio, cellule di origine animale possono essere utilizzate per modificare le caratteristiche proprie di una specie vegetale.
La violazione
tecnica
dei vincoli
naturali
Sono esempi, questi, tratti dall’attualità più recente che si adattano bene a chiarire quello che
Heidegger intende per nichilismo. Il modo di considerare l’arancio da parte del biochimico è
infatti caratterizzato dal fatto che, per lui, la cosa non ha alcuna essenza propria. Il biochimico non suppone cioè che vi sia un principio che renda l’arancio un arancio, che lo distingua
cioè, ad esempio, da un pero o da una mucca o da un uomo. Nell’ottica dello svelamento tecnico, distinzioni ontologiche elementari, ovvie per il senso comune, come quella tra piante, animali e uomini, diventano irrilevanti. Ciò che è tecnicamente rilevante è infatti soltanto la disponibilità delle cose ad essere funzioni in vista di scopi che non hanno alcun legame con le cose stesse. Si pensi, in proposito, alla differenza tra l’antica pratica di incrociare
varietà diverse di piante mediante il cosiddetto “innesto” e le manipolazioni genetiche consentite dalla moderna bioingegneria. L’agricoltore che innesta un mandarino su un arancio interviene nel processo di maturazione del frutto modificandone la finalità (il mandarancio anziché
l’arancia). Si tratta però soltanto della deviazione di un corso naturale compiuta in vista di uno
scopo anch’esso naturale. Una deviazione, dunque, che rimane intimamente vincolata alla natura. Le tecniche di bioingegneria, ad esempio la clonazione, ossia la produzione di individui
aventi identico corredo genetico, mira invece proprio a oltrepassare il principale vincolo imposto dalla natura, la cosiddetta “biodiversità” o varietà genetica tra gli individui.
Il nichilismo
come oblio
dell’essere
Heidegger ritiene che la metafisica e il suo compimento tecnico, dunque il definitivo imporsi dell’ente abbia fatto sì che l’essere venisse completamente «dimenticato» (o «obliato»). All’«oblio
dell’essere» Heidegger riconduce aspetti della modernità che considera in modo fortemente critico, come ad esempio la «fuga degli dei», ossia il definitivo tramonto della forza di coesione esercitata dalle religioni, «la distruzione della terra», la «massificazione dell’uomo», il «prevalere della
mediocrità». La modernità è insomma considerata da Heidegger come un’epoca di profonda
decadenza. Si tratta di una diagnosi critica che avvicina Heidegger alla tradizione culturale conservatrice e antimoderna nata dalla reazione alla Rivoluzione francese ❚ v. vol. III, nome capitolo, §
0, pp. 000-000 ❚. Occorre notare, però, che il concetto heideggeriano di oblio dell’essere o nichilismo non allude a una “restaurazione” o ritorno a un passato idealizzato. Oblio dell’essere significa, molto semplicemente, l’oblio dell’accadere, dell’evento nel quale ogni ente viene alla presenza. La meditazione storica, l’interpretazione dei testi filosofici e poetici, dunque il confronto con
la tradizione serve a oltrepassare la metafisica e il nichilismo, ossia a destare l’umanità contemporanea dal suo secolare oblio dell’essere. Ciò significa che per Heidegger la meditazione storica,
benché critica verso ogni volontarismo, può avere un effetto liberante, dunque un rilievo pratico.
Il ricordo dell’essere, del venire alla presenza, dell’accadere senza soggetto della storia, può preparare l’Occidente a liberarsi un giorno dalla costrizione a pensare e agire in modo tecnico.
Il Novecento
28
0140.p000-000_heidegger.qxd
4
12-12-2006
16:07
Pagina 29
Attualità di Heidegger
La prima
ricezione
dell’opera
di Heidegger
Il pensiero di Heidegger ha avuto grande influenza, non soltanto sulla filosofia ma anche su ampi
settori della cultura del Novecento. Tradotte in tutto il mondo, le sue opere hanno suscitato e suscitano ancora oggi reazioni diverse, talvolta aspramente contrapposte. La storia della sua ricezione
va suddivisa in due fasi nettamente distinte. La prima, precedente alla seconda guerra mondiale, è
caratterizzata dalla prevalenza di un’interpretazione sostanzialmente positiva, quella basata sulla
lettura esistenzialista di Essere e tempo a cui abbiamo già fatto cenno ❚ v. § 3.1 ✉. Fa eccezione la
stroncatura da parte di un esponente del positivismo logico ❚ v. vol. III, nome capitolo, pp. 000-000 ❚,
Rudolf Carnap (1891-1970), che nel 1932 sottopose ad analisi logica alcune frasi di Heidegger e
ne concluse che si trattava di proposizioni insensate. Occorre però osservare che, agli occhi di Carnap, Heidegger rappresentava soltanto un esempio particolarmente vistoso di un uso incontrollato
del linguaggio quale poteva essere rimproverato a quasi tutte le filosofie del passato. Si trattava, in
altre parole, di una critica alla metafisica in generale allo scopo di smascherarne il carattere non
conoscitivo e escluderla così dal novero delle discipline scientifiche in senso stretto.
Le accuse di
irrazionalismo
nel dopoguerra
Ben più roventi sono invece le controversie suscitate da Heidegger dopo la seconda guerra mondiale. Polemiche la cui asprezza di toni si spiega con la circostanza biografica che abbiamo più
volte richiamata, ossia con il breve ma fatale coinvolgimento di Heidegger con il regime nazista.
Molti interpreti, soprattutto in Germania e in Francia, hanno ritenuto che le scelte politiche di
Heidegger fossero diretta conseguenza di un atteggiamento ostile ai principi della razionalità
che, ancora implicito in Essere e tempo, si palesa senza alcuna reticenza nelle opere successive
alla svolta. Letto in questa chiave interpretativa, il «pensiero dell’essere» del secondo Heidegger
è stato accostato al misticismo, ossia a un atteggiamento essenzialmente affine alla fede religiosa.
Heidegger stesso ha fornito non pochi appigli a questa interpretazione del suo pensiero. Alcune
sue affermazioni dal tono spiccatamente oracolare sono diventate emblematiche: «sorge la
scienza, sparisce il pensiero», oppure: «soltanto un dio ci può salvare». Se a queste affermazioni
si aggiunge l’enigmaticità che, come abbiamo visto, caratterizza lo stile degli scritti successivi
alla svolta, si comprende bene come mai il filosofo tedesco di origine ebraica Karl Löwith
(1897-1973), che era stato allievo di Heidegger e fu poi costretto all’esilio a causa delle leggi
naziste contro gli ebrei, abbia potuto definire il suo maestro il «mistagogo dell’essere». Löwith
vede cioè in Heidegger una sorta di sacerdote di un culto religioso primitivo che, esercitando le
arti della persuasione irrazionale, ha saputo raccogliere attorno a sé adepti fanaticamente convinti di possedere la verità. Non molto diversa è la critica del maggior esponente della «Scuola
di Francoforte», Theodor Wiesengrund Adorno (1903-1969) ❚ v. Critica della razionalità tecnica, pp. 000-000 ❚, che definisce il linguaggio di Heidegger un «gergo dell’autenticità». Secondo
Adorno, Heidegger è sostanzialmente un reazionario, qualcuno, cioè, che intende “reagire” allo
sconquasso civile determinato dalla razionalizzazione capitalistica. Il suo enfatico richiamo alla
vita autentica è dunque un tentativo, secondo Adorno necessariamente votato al fallimento, di
preservare l’uomo dalle forme di dominio create dell’organizzazione sociale capitalistica, forme
di dominio che Heidegger presenta falsamente quali modi di vita inautentici. A questo scopo
Heidegger ha creato un «gergo», ossia una lingua speciale che sollecita nell’ascoltatore, non già
la riflessione critica, ma l’adesione cieca e irrazionale, e contribuisce così a suscitare una fede
settaria, essenzialmente affine al fanatismo ideologico dei nazionalsocialisti.
L’ateismo
di principio
della filosofia
In tempi più recenti, l’interpretazione in chiave irrazionalistica ha incontrato meno sostenitori.
La pubblicazione di corsi universitari e scritti inediti, consentendo di comprendere meglio la
formazione culturale di Heidegger, ha contribuito a una valutazione più obiettiva del significato
della sua opera. Significato che è anzitutto filosofico e non religioso. Benché infatti abbia
costantemente sottolineato l’importanza del «sacro» nella vita umana, su un punto Heidegger è
stato sempre chiaro: l’essere non è Dio. Non infrequenti sono inoltre le sue dichiarazioni a
proposito del carattere essenzialmente ateo del pensiero filosofico. L’affermazione già
citata, sovente addotta a testimonianza della sua ispirazione religiosa, secondo cui «soltanto un
29
Heidegger
0140.p000-000_heidegger.qxd
12-12-2006
16:07
Pagina 30
dio ci può salvare», si limita in realtà a esprimere la convinzione, condivisa da tanti filosofi razionalisti di ogni epoca, che senza base religiosa non è possibile alcuna vita umana associata.
Anche l’ostilità nei confronti della razionalità scientifica espressa nel motto «sorge la scienza,
sparisce il pensiero», non è affatto nuova nella storia della filosofia e, soprattutto, non è necessariamente un’espressione di irrazionalismo. Si pensi ad esempio a Hegel, il più vigoroso sostenitore del carattere intimamente razionale della realtà. Anche per lui, le scienze sono basate sul
principio dell’astrazione intellettuale che conosce la realtà dividendola e mantenendola separata e, di conseguenza, non è in grado di afferrarne la vera natura. È opportuno, al proposito,
richiamare il giudizio particolarmente equilibrato dato dalla filosofa tedesca di origine ebraica
Hannah Arendt (1906-1975), che fu allieva di Heidegger ed ebbe con lui anche una relazione
sentimentale intensa e dolorosa. In un breve testo, scritto in occasione dell’ottantesimo compleanno del maestro, Heidegger ha ottant’anni (Martin Heidegger ist achtzig Jahre alt, 1969),
Arendt stigmatizza coloro che pretendono di stabilire affinità tra il pensiero di Heidegger (o, a
seconda dei casi, quello di Platone, Lutero, Hegel, Nietzsche ecc.) e il totalitarismo nazista.
Arendt sostiene invece che Heidegger, come pochi altri nel Novecento, ha testimoniato l’estraneità del modo di vita del filosofo, incentrato sull’esperienza solitaria del pensare, rispetto alla
vita politica, basata invece sulla condivisione di un mondo comune.
Letture consigliate
Il domandare
critico
come pietas
del pensiero
L’attualità, se non addirittura l’esemplarità dell’opera di Heidegger sta anzitutto nella capacità
di porre in atto un’interrogazione filosofica radicale, facendo così comprendere che la filosofia
consiste essenzialmente in un domandare critico che sappia però porsi all’altezza dell’oggetto interrogato. Emblematica è, a questo proposito, la frase con cui si chiude il saggio
sulla Questione della tecnica (Die Frage nach der Technik, 1954; ❚ Lettura 5 ❚): «il domandare è la
pietà del pensiero». Frase assai suggestiva nella quale si trovano associati due atteggiamenti
antitetici: il domandare, dunque l’atteggiamento critico del filosofo che non riconosce altra
autorità che non sia quella della verità; e la pietas, parola che nella religione romana designava
la fedeltà e il rispetto nei riguardi della propria appartenenza (famigliare, politica, religiosa, culturale). Ricordando che l’identità culturale dell’Occidente è il risultato dell’incontro tra questi
due atteggiamenti, Heidegger ha additato il pericolo che deriva dalla tentazione di dissociarli.
Ha cioè mostrato come la critica razionale non possa essere esercitata senza memoria storica,
né è possibile richiamarsi a radici storiche senza alimentare la capacità critica. Il pericolo di una
tale dissociazione è insito, a suo avviso, nella tecnica, il tema più attuale della sua opera. Un
tema che Heidegger affronta escludendo anzitutto che se ne possa dare un giudizio semplificante: esecrandola come fonte di tutti i mali contemporanei o, all’opposto, celebrandola come unico strumento in grado di curarli. Heidegger si limita a mostrare la paradossale ambivalenza della tecnica moderna, figlia tanto del domandare che dissolve ogni tradizione quanto di una specifica tradizione, quella, come abbiamo visto, formatasi in Occidente grazie alla metafisica.
Benché, quindi, non formuli programmi né offra soluzioni, l’opera di Heidegger è in grado di
suscitare in chi voglia leggerla senza pregiudizi la vigilanza critica necessaria a individuare e
capire i problemi del mondo contemporaneo.
AA. VV., Heidegger, a cura di F. Volpi, Roma-Bari, Laterza, 1997
R. Safranski, Ein Meister aus Deutschland, München/Wien Carl Hanser Verlag, 1994; trad. it. di N. Curcio,
Heidegger e il suo tempo. Una biografia filosofica, Milano, Longanesi, 1996
R. Schürmann, Heidegger on Being and Acting: From Principles to Anarchy, Bloomington, Indiana University
Press, 1986: trad. it. di G. Carchia, Dai principî all’anarchia. Essere e agire in Heidegger, Bologna, Il Mulino, 1995
O. Pöggeler, Der Denkweg Martin Heideggers, Pfullingen, Verlag Günther Neske, 1990; trad. it. di G. Varnier, Il
cammino di pensiero di Martin Heidegger, Napoli, Guida, 1991
G. Vattimo, Introduzione a Heidegger, Roma-Bari, Laterza, 1981
H. Arendt, Martin Heidegger ist achtzig Jahre alt, in «Merkur» X (1969), pp. 893-902; trad. it. di N. Curcio, Martin
Heidegger compie ottant’anni, in AA. VV., Su Heidegger. Cinque voci ebraiche, Roma, Donzelli, 1998, pp. 63-73.
Il Novecento
30
0140.p000-000_heidegger.qxd
12-12-2006
16:07
Pagina 31
Sintesi
IL PRIMO HEIDEGGER:
IL PENSIERO UMANISTA
Il problema dell’essere In Essere e tempo (1927), la
sua opera più celebre, Heidegger muove dal proposito di
tornare a porre la domanda sull’essere, che nel corso
della tradizione filosofica è stata tralasciata in favore dello
studio della coscienza. Il testo però non affronta direttamente il problema ontologico dell’essere, ma prende in
esame l’ente particolare che ha la prerogativa di comprendere l’essere, cioè l’uomo. Heidegger chiama l’uomo
“esserci” proprio per mettere in rilievo che il modo di
essere dell’uomo, che è l’esistenza, è chiamato in causa
ogniqualvolta venga posta la domanda generale sull’essere. Per comprendere l’essere è dunque necessario uno studio preliminare dell’essere dell’uomo e questa analisi è
definita da Heidegger “analitica esistenziale”.
La critica a Husserl e l’essere nel mondo Il ritorno ai temi dell’ontologia è collegato al ripensamento critico a cui Heidegger sottopone la filosofia del suo maestro
Husserl. La fenomenologia di Husserl è basata sull’idea
che i fenomeni, nei quali le cose si manifestano, abbiano
luogo solo nella e per la coscienza. Heidegger, pur condividendo l’attenzione fenomenologica al manifestarsi degli
enti, contesta il primato della coscienza affermato da
Husserl e sostiene che i fenomeni si manifestano all’uomo
anche e soprattutto senza essere percepiti direttamente,
cioè senza divenire presenti alla coscienza. Tale è il caso
degli «utilizzabili», che sono gli enti considerati nella
dimensione quotidiana del prendersi cura degli oggetti,
dove assumono il valore di mezzi per raggiungere degli
scopi. Gli enti si presentano infatti all’uomo innanzitutto
non nella forma della semplice presenza dinanzi alla
coscienza, come oggetti estranei da conoscere, ma come
strumenti d’uso dati per scontati che rientrano in un rapporto pratico di familiarità. Ognuno di essi, in quanto
mezzo per ottenere un risultato, si riferisce a qualcos’altro, creando un sistema di rimandi la cui totalità viene
chiamata da Heidegger «mondo». L’esistenza umana è
un «essere nel mondo», perché nell’uso degli enti
come strumenti l’uomo tende a mettere tra parentesi se
stesso per immedesimarsi nel loro funzionamento. Questa vicinanza agli utilizzabili è ciò che Heidegger definisce l’essere fuori di sé presso il mondo.
La ripresa di Aristotele: pòiesis e praxis Considerando gli oggetti prima di tutto come mezzi utilizzabili,
e solo secondariamente come oggetti di osservazione,
Heidegger antepone la prassi alla teoria. La concezione
della prassi umana che ne risulta fa riferimento alla
31
distinzione aristotelica tra pòiesis e praxis. Nell’Etica nicomachea Aristotele osserva che la pòiesis, cioè il produrre,
ha il fine fuori di sé, nell’oggetto da produrre, mentre la
praxis, cioè l’agire, è fine a se stessa. Su questa base Heidegger osserva che nella pòiesis l’attività umana è secondaria rispetto al prodotto da realizzare e si esaurisce al
comparire dell’opera ultimata. Viceversa nella praxis lo
scopo è l’esecuzione stessa dell’azione, che ha l’effetto di
rendere attuale e visibile in se stessa l’attività umana eseguita. Per Heidegger il produrre individua l’esistenza
inautentica, perché in tale attività l’uomo non esprime
né rivela se stesso, mentre l’agire è correlato all’esistenza
autentica, essendo in grado di svelare ciò che è proprio
all’attività umana.
Inautenticità e decadimento Con «inautenticità»
Heidegger intende l’ordinaria prassi quotidiana, caratterizzata dall’uso degli oggetti come mezzi per realizzare
qualcosa. Il ricorso agli strumenti fa sì che l’uomo sviluppi un rapporto di immedesimazione con le cose diventando tutt’uno con il loro utilizzo. Questa familiarità con gli
oggetti utilizzabili finisce per diventare un vincolo, perché, come avviene nella pòiesis, l’attività è condizionata
dai mezzi utilizzati e subordinata agli scopi limitati che
tali mezzi permettono di realizzare. Il risultato è il «decadimento» nell’esistenza inautentica, nella quale gli scopi
imposti alla prassi dagli strumenti portano l’uomo ad
adattarsi alle cose del mondo, allontanandosi da se stesso.
Nell’«essere assieme» delle persone, l’inautenticità si
esprime come tendenza ad adeguarsi ai comportamenti
più diffusi, designati da Heidegger come il prevalere del
«si impersonale».
La libertà nell’esistenza autentica Heidegger cerca di individuare un modo di vita e un tipo di agire in cui
l’uomo si riveli a se stesso. Fenomeni esistenziali di questo
tipo sono l’«angoscia» e l’«essere per la morte». Nell’angoscia, così come nella paura e nella maggior parte
degli «stati d’animo», si rivela ciò che nella vita sta a
cuore all’uomo. Questo interesse primario non è altro che
l’esistenza come possibilità da progettare e attuare, vale a
dire la possibilità di realizzarsi liberamente nel vivere.
Insieme a questa libertà gli stati emotivi rivelano anche la
«gettatezza», cioè il fatto che l’esistenza come libera
possibilità non è a sua volta frutto di una libera scelta, ma
è una condizione in cui l’uomo è gettato e di cui deve
assumersi la «cura», ossia la responsabilità. Tra gli stati
d’animo però solo l’angoscia conduce realmente all’esistenza autentica. L’angoscia sorge dinanzi al mondo
come totalità e ha un benefico effetto «spaesante», perché
è capace di rimuovere l’immedesimazione dell’uomo con
il suo ambiente e l’inautenticità che ne deriva. Tramite
l’angoscia l’uomo cessa di abbandonarsi a scopi e attività
in cui non si riconosce per concentrarsi sulla scoperta della propria libertà. Nell’«anticipazione della propria
morte» l’uomo si fa carico di tale libertà e insieme dei
Heidegger Sintesi
0140.p000-000_heidegger.qxd
12-12-2006
16:07
Pagina 32
suoi limiti, che consistono nell’effetto esclusivo e condizionante di ogni scelta tra le possibilità. Il pensiero della
morte conduce alla presa di coscienza più forte della
libertà perché la morte è intesa da Heidegger come la
possibilità più estrema, che prevedendo l’impossibilità
dell’esistenza rompe nel modo più netto la familiarità con
il mondo.
IL SECONDO HEIDEGGER:
L’ABBANDONO DELL’UMANISMO
La svolta e il suo significato Il forte influsso esercitato da Essere e tempo sulla cultura del tempo aveva contribuito a mettere in rilievo l’ orientamento esistenzialista e
antropologico dell’opera, cioè la sua attenzione ai fenomeni e ai problemi dell’esistenza concreta dell’uomo.
Tuttavia dopo la seconda guerra mondiale Heidegger
smentisce questa interpretazione, sottolineando che l’indagine sull’uomo condotta nel suo libro doveva essere
solo la preparazione per una fase più importante, dedicata al problema dell’essere. Nella Lettera sull’«umanisimo»,
infatti, Heidegger ritiene necessaria una «svolta» che
abbandoni l’impostazione antropologica adottata nell’analitica esistenziale. All’origine di questo mutamento c’è
il ripensamento avviato da Heidegger in seguito alla sua
adesione al nazismo. Illuso circa le possibilità di rinnovamento presentate dal regime, nel 1933 aveva accettato la
carica di rettore a Friburgo e aveva sostenuto con entusiasmo le iniziative del nazismo, per poi dimettersi dopo
meno di un anno. Il fallimento di questo infelice coinvolgimento politico spinse Heidegger a ripensare il modo in
cui il rapporto tra la verità e l’agire umano era definito in Essere e tempo.
La differenza ontologica tra essere ed ente Sin
da Essere e tempo Heidegger criticava l’idea della verità
come «adeguamento», secondo la quale la conoscenza
è vera se si adegua alla realtà conosciuta. Il problema di
questa concezione è che riduce la distinzione tra atto
conoscitivo e oggetto conosciuto a una semplice differenza cognitiva, mentre per Heidegger si tratta di una differenza ontologica tra essere ed ente. La conoscenza è
infatti un modo d’essere dell’ente, cioè un modo in cui
l’oggetto si svela all’uomo. Nel conoscere si avverte però
la necessità di cogliere le cose in maniera oggettiva, per
come sono indipendentemente dal modo in cui l’uomo se
le rappresenta. Questa realtà effettiva degli oggetti, definita da Heidegger «svelatezza dell’ente in quanto
tale», è preliminare e prioritaria rispetto alla svelamento
che ha luogo nel conoscere, perché è il criterio di raffronto per definire la verità della conoscenza. Il conoscere
corrisponde all’essere dell’oggetto, che significa il suo
modo di apparire all’uomo, mentre la realtà oggettiva che
serve da termine di confronto per la verità corrisponde
all’ente in se stesso. L’aspirazione della conoscenza a
Il Novecento
cogliere le cose in se stesse viene dunque spiegata da Heidegger come differenza ontologica tra essere ed ente.
La differenza ontologica nel primo e nel secondo Heidegger Il desiderio di riferirsi alla realtà effettiva delle cose fa emergere il primato dell’ente nella sua differenza ontologica dal modo in cui appare nella conoscenza, ma non chiarisce l’origine della differenza. In
Essere e tempo e negli scritti dei primi anni trenta Heidegger attribuisce all’uomo la facoltà di «attuare» la
differenza ontologica. Ciò significa che lo svelamento
preliminare dell’ente, che suscita l’impressione di riferirsi
alle cose in se stesse, è in realtà risultato dell’iniziativa
umana. Rifacendosi al trascendentalismo kantiano e al
volontarismo medievale, Heidegger fa dipendere la differenza ontologica dalla capacità umana di comprendere e
progettare l’esistente. L’ente si svela nella sua differenza
dal conoscere perché un atto della volontà e della comprensione umana lo rivela in questa dimensione. Dalla
seconda metà degli anni trenta, dopo la sua infausta esperienza politica, Heidegger adotta tuttavia una posizione
di segno opposto. La differenza ontologica è concepita in
chiave antivolontaristica, come «accadimento» o
«evento storico» che non può essere ricondotto né
all’uomo, né a nessun altra causa singola.
La storia come storia dell’essere Dopo la svolta
Heidegger concepisce la storia non più come il frutto dell’agire umano, ma come «storia dell’essere». Con tale
espressione Heidegger non intende alludere ad un essere
superiore che dirige gli avvenimenti, ma al contrario vuole sottolineare che la storia riguarda l’essere, cioè il semplice manifestarsi di ciò che è. La storia è il puro accadere, il venire alla presenza degli enti senza un principio
identificabile che ne governi l’apparire. Questo manifestarsi degli enti è uno svelamento senza autore né
causa, perché possiede un carattere unico e imprevedibile che non si lascia derivare da nessun ente o stato di cose.
Quando sostiene che la differenza ontologica è un evento
della storia dell’essere, Heidegger intende dire che lo svelamento dell’ente come criterio di verità della conoscenza
è un fenomeno più grande dell’uomo, che esula dal suo
controllo. Lo stesso manifestarsi degli enti nel pensare e
nell’agire non è prodotto dall’uomo, e in questo senso
l’uomo non è autore del pensare e dell’agire, perché in
queste attività c’è un essere, vale a dire uno svelarsi, un
accadere, che nella sua imprevedibilità non può essere
dominato dall’uomo.
Meditazione storica e linguaggio Heidegger esorta alla «meditazione storica» come fedeltà al puro
accadere che è sottratto al potere umano di calcolo e di
previsione. La meditazione viene rivolta in particolare ai
testi della “tradizione occidentale”. Secondo Heidegger
nelle parole dei pensatori e dei poeti del passato si è conservato lo svelamento dell’essere. Questo è possibile per32
0140.p000-000_heidegger.qxd
12-12-2006
16:07
Pagina 33
ché nel linguaggio l’uomo rivela la sua prerogativa di
essere “immerso” nel modo più profondo nell’essere, cioè
nello svelamento. Nel parlare, infatti, l’uomo svela continuamente gli enti e se stesso. In realtà l’uomo non è autore del parlare, ma è il linguaggio stesso che parla,
perché il parlare, come ogni altra forma di svelamento,
riguarda l’essere ed è un evento non riducibile a opera
dell’uomo o di un altro ente. Tuttavia il rilievo che nel
parlare ha l’ascolto consente all’uomo di rispondere
agli appelli del linguaggio. La meditazione sulla tradizione storica ha proprio il compito di far emergere lo svelamento che i pensatori e i poeti hanno espresso dando
ascolto e risposta all’appello del linguaggio.
La critica della metafisica e della tecnica La
meditazione storica si propone di rintracciare l’origine
della cultura occidentale, la cui caratteristica è secondo
Heidegger l’emergere della differenza ontologica, ovvero
l’imporsi dell’ente nella sua indipendenza dall’atto dello
svelamento. Sin da prima della svolta Heidegger designa
con il termine “metafisica” questo aprirsi della differenza ontologica che contraddistingue l’Occidente. Nel
primo Heidegger il principio della metafisica così intesa è
l’umanismo, perché l’affermarsi dell’ente in se stesso
come criterio di verità è derivato dall’attività umana. Hei-
teorico-conoscitiva. Si tratta dell’essere capace di
essere.
Guida allo studio
e alla riflessione
6 L’esistenza ......................................................................
è l’autorivelazione dell’agente, che avverte la propria
esistenza come un’attività da attuare e assume su di
sé il peso della libertà di agire.
Per studiare
Ricerca le parole chiave
1 L’essere dell’uomo è un ..................................................
(“esser-ci”). È un “essere-nel-mondo” (in-der-Weltsein).
2 Il modo di essere dell’esser-ci è l’ ..................................
.................
degger si riallaccia alla concezione metafisica dell’uomo
come origine della verità, emersa nel corso della tradizione filosofica, con l’intento di portarla a compimento
riconducendo l’intero svelamento dell’ente a opera umana. Dopo la svolta, tuttavia, Heidegger adotta la posizione opposta, ponendosi l’obiettivo di «oltrepassare la
metafisica». La metafisica, ossia l’apertura umana della
differenza tra essere ed ente, assume un senso negativo:
diventa sinonimo di un atteggiamento che considera il
mondo soltanto in funzione dell’uomo e che riduce il pensiero a strumento per controllare e trasformare la realtà.
Con l’imporsi degli enti nella differenza ontologica, cioè
nella loro realtà oggettiva, che è indipendente dal loro
modo di presentarsi, le cose diventano adatte ad essere
liberamente manipolate dall’uomo, perché vengono private del loro lato inatteso e incalcolabile, legato al loro
manifestarsi. Proprio per questo la metafisica come differenza ontologica trova il suo compimento nella tecnica
moderna, che considera la realtà un oggetto a disposizione del fare umano. Questo modo di sottoporre tutto
l’esistente al volere umano conduce al nichilismo, perché priva le cose della loro essenza autonoma, e produce
«l’oblio dell’essere», cioè la dimenticanza dell’essere
come accadimento imprevedibile senza autore, che non
può essere assoggettato alla manipolazione umana.
(dal latino ex-sistere,“venire fuori da”).
7 La ................................................................ (alétheia)
per Heidegger è un uscire dalla dimenticanza, è il
manifestarsi a partire da un occultamento, è
disvelamento.“Vero” significa dunque “svelato”.
14 Associa i titoli delle opere alle relative date di pubblicazione
3 L’analisi del modo di essere dell’esser-ci viene
condotto attraverso l’ ..................................................
esistenziale.
4 L’esistenza caratterizzata dall’ .........................................
(Uneigentlichkeit, da un, “non” e eigen
“proprio”) è quella in cui l’essere è incapace di
essere se stesso.
Lettera sull’umanismo
1927
Essere e tempo
1946
Hörderlin e l’essenza della poesia
1937
....................
Rispondi alle domande:
9 Quali sono i rapporti tra Husserl e Heidegger?
5 La ................................................................... (Versthen)
è un’attitudine pratica, non un atto di natura
10 Quali aspetti della fenomenologia sono stati
determinanti per il pensiero di Heidegger?
33
Heidegger Laboratorio
0140.p000-000_heidegger.qxd
12-12-2006
16:07
Pagina 34
11 Completa lo schema relativo al diverso significato
20 Completa la tabella, relativa agli stati d’animo della
dell’apparire in Husserl e in Heidegger, inserendo in
modo appropriato le seguenti espressioni: dalla
coscienza; dall’attività pratica umana.
nel pensiero
di Husserl
l’APPARIRE
(= manifestazione
degli enti)
dipende
nel pensiero
di Heidegger
paura e dell’angoscia:
nel pensiero
di Husserl
significato
della paura
nel pensiero
di Heidegger
.................................. ..................................
.................................. ..................................
.............................. ..............................
.................................. ..................................
.............................. ..............................
.................................. ..................................
.............................. ..............................
.................................. ..................................
.............................. ..............................
.................................. ..................................
.............................. ..............................
.............................. ..............................
.............................. ..............................
significato
dell’angoscia
.................................. ..................................
.................................. ..................................
.................................. ..................................
.............................. ..............................
.................................. ..................................
.................................. ..................................
Rispondi alle domande:
12 Heidegger afferma che ogni pensatore essenziale
pensa un unico pensiero. Il suo unico pensiero è
stato l’essere (Sein). Come viene affrontata in Essere
e tempo la domanda essenziale, l’unica e assoluta
questione di tutta una vita: «che cosa significa
essere? – che cos’è l’essere?»?
.................................. ..................................
Rispondi alle domande:
21 Qual è la differenza tra l’esistenza autentica e
l’esistenza inautentica?
13 La riflessione di Heidegger parte dall’uomo: perché
22 Come e perché nascono l’angoscia e la dimensione
tra la molteplicità degli enti l’uomo è un ente
privilegiato?
23 Che cosa significa l’espressione “prendersi cura”? In
dell’esser-ci come cura (Sorge)?
che modo il “prendersi cura” rappresenta una
modalità ontologica dell’esserci?
14 Che cosa esprimono i concetti di esser-ci e di
essere-nel-mondo ?
15 Qual è la caratteristica fondamentale dell’uomo?
24 Di che cosa ci si può prendere cura?
16 In cosa consiste la funzione strumentale delle cose ?
25 Perché il problema della morte è essenziale per
affrontare la nostra esistenza in modo autentico?
Scelta multipla
17 L’analisi compiuta da Heidegger sull’essere
dell’uomo è di tipo
a
metafisico
b
antropologico
c
ontologico
d
psicologico
18 Secondo Heidegger ogni essere umano
a
b
c
d
crea idealisticamente il proprio mondo
è isolato in se stesso
acquista la propria identità solo attraverso gli
altri
è aperto nei confronti del mondo
19 Per Heidegger la metafisica occidentale non ha
Scegli il completamento corretto:
26 L’esistenza inautentica si basa soltanto sulla
considerazione
a
dell’essere
b
dell’utile
c
del vero
d
dell’ente
27 L’esistenza inautentica non conosce
a
b
c
d
28 La risposta autentica alla consapevolezza
del nulla è
a
l’ascesi
b
l’impegnarsi nel mondo
c
il vivere-per-la-morte
d
l’umanismo
riconosciuto all’essere la sua dimensione
a
spaziale
b
ontologica
c
psicologica
d
temporale
Il Novecento
l’angoscia
la curiosità
la paura
la chiacchiera
34
0140.p000-000_heidegger.qxd
12-12-2006
16:07
Pagina 35
Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false
e motiva le tue risposte:
29 L’uomo può scegliere tra un’esistenza
V F
autentica e un’esistenza inautentica.
perché ...............................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
30 La differenza tra autenticità e l’inautenticità
V F
è in un diverso contenuto dell’esistenza.
perché ...............................................................................
40 Per Heidegger l’essenza della scienza moderna è
rappresentata
a
dalla conoscenza intellettuale
b
dalla relatività delle conoscenze
c
dalla superficialità dei giudizi
d
dalla tecnica
41 L’essere si può disvelare soltanto attraverso
a
b
c
d
la tecnica
la scienza
il linguaggio
la metafisica
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
31 L’esserci si trova nella necessità di assumere
Rispondi alle domande:
42 Qual è la differenza tra la praxis e la pòiesis?
43 In che senso Aristotele usava questi termini? Quali
V F
su di sé il peso della libertà di agire.
perché ...............................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
significato assumono all’interno del pensiero di
Heidegger?
44 Che cos’è per Heidegger la tecnica? Quali sono i
suoi fini?
45 In cosa consiste il nichilismo per Heidegger?
46 Perchè l’opera d’arte è in grado di rivelare il senso
Rispondi alle domande:
32 Qual è la dimensione temporale fondamentale
dell’esistenza autentica?
delle cose in modo migliore rispetto alle cose stesse?
47 Quali sono le caratteristiche principali della dottrina
heideggeriana del linguaggio?
33 Quali sono gli stati d’animo conseguenti
all’accettazione delle possibilità?
34 Perché soltanto figurandosi la propria morte l’uomo
è in grado di scegliere autonomamente le possibilità
dell’esistenza, senza conformarsi acriticamente agli
schemi del “si” impersonale (il “si dice”, il “si fa”, il “si
pensa”) ?
35 Che cosa significano nel pensiero di Heidegger i
termini “trascendenza” e “differenza ontologica” ?
36 In che cosa consiste la svolta antiumanistica di
Spiega, alla luce delle tue conoscenze, il seguente
giudizio:
48 «Heidegger interpreta in modo personale, ma
niente affatto arbitrario, lo spirito dell’avanguardia e
la sua problematica della difesa della libertà interiore
contro la pressione dell’organizzazione tecnoscientifica del mondo». (G.Vattimo, Tecnica ed
esistenza, Torino, Paravia, 1997, p. 29).
Tratta in modo sintetico i seguenti argomenti:
Heidegger?
49 L’idea che l’uomo sia sempre “apertura” può essere
collegata all’oltre-uomo di cui parla Nietzsche? (max
10 righe)
37 Quali sono stati, secondo Heidegger, gli errori
fondamentali della metafisica occidentale ?
38 Quali sono le tematiche principali dell’ultima fase del
pensiero di Heidegger ?
Scegli il completamento corretto:
50 Nel corso della storia della filosofia quello del
tempo è stato uno dei concetti più problematici.
Evidenzia in un testo espositivo i risultati delle analisi
di Kant, Hegel e Husserl. (max 25 righe)
51 Quali aspetti del pensiero di Hölderlin e di
39 La svolta (Kehre) cui Heidegger si richiama nella
Lettera sull’umanismo va intesa come
a
il cambiamento totale dell’oggetto della
conoscenza
b
il mutamento radicale degli strumenti di
indagine filosofica
c
la crisi che lo porta a non occuparsi più
dell’essere
d
il mutamento della direzione della via percorsa
dall’analitica esistenziale
35
Kierkegaard hanno influenzato la tematica
esistenzialista heideggeriana? (max 12 righe)
52 Heidegger esalta il “pensiero poetante”, rinnovando
così l’alleanza tra poesia e filosofia. In che modo il
pensiero poetante può dare voce a ciò che il
linguaggio della metafisica non riesce più a
esprimere? (max 15 righe)
53 In che modo nichilismo e umanismo sono collegati?
(10 righe)
Heidegger Laboratorio
0140.p000-000_heidegger.qxd
12-12-2006
16:07
Pagina 36
Per riflettere
render grazie. Ci sono metafore peggiori con cui
vivere» (G. Steiner, Heidegger, London, Harvester
Press, 1978; trad. it. di D. Zazzi, Heidegger, Milano,
Mondadori, 1990, pp.183-184).
Partendo dall’analisi di questo giudizio, illustra qual è
il rapporto tra la filosofia e la meraviglia. Spiega, in un
testo argomentativo, il legame che si può instaurare,
da un lato, tra i concetti di “ovvio” e “vita
inautentica” e, dall’altro, tra i concetti di “stupore” e
“vita autentica”. (max 25 righe).
54 Il legame tra le scelte di vita di un uomo e la sua
opera spesso è problematico. Questa
considerazione vale in particolare per Heidegger, a
causa della sua adesione al nazismo e del suo
silenzio successivo al 1945. Siamo anche in presenza
di un paradosso storico, dato dal fatto che
Heidegger era circondato da studiosi di altissimo
livello di origine ebraica, molti dei quali lo
consideravano come il proprio maestro, tra i quali:
Herbert Marcuse, Hannah Arendt, Karl Löwith, Hans
Jonas. Il saggista e critico letterario statunitense
George Steiner (1929-vivente), anch’egli ebreo,
scrive che «il problema è a un livello diverso [...] Il
problema è nelle alleanze sconcertanti tra la più alta
filosofia e il dispotismo. [...] È il fascino esercitato
sull’alta astrazione dalla tirannia e persino
dall’inumano. [...] Nel centenario del filosofo il suo
successore e discepolo Hans Gadamer – grande
filosofo e pensatore – ascolta per tutto il giorno; non
ne può più e mi lancia questa frase attraverso la sala:
“Basta con questo cose, è talmente semplice! Perché
tutte queste spiegazioni contorte, storiche: Martin
Heidegger era il più grande dei pensatori e il più
piccolo degli uomini”. Questa è una spiegazione che
ha in sé molto buon senso. Ne conosciamo tanti, di
grandi artisti, che sono abietti nella loro vita
personale! Forse che non dovrei leggere Proust che
infligge torture agli animali [...]e ne trae pagine che
mi sembrano indispensabili, non soltanto per la mia
vita, ma per la nostra cultura?» (G. Steiner, Barbarie
de l’ignorance: juste l’ombre d’un certain ennui.
Entretiens avec Antoine Spire, Paris, Le Bord de L’Eau,
1998; trad. it. di A. Cariolato, La barbarie
dell’ignoranza. Conversazioni con Antoine Spire, Roma,
Nottetempo, 2005, pp. 57-58).
Quali sono le tue riflessioni a questo riguardo? (max
15 righe).
57 Per Heidegger l’esistenza inautentica è caratterizzata
dall’omologazione delle idee, dei comportamenti e
del gusto. C’è un rapporto, a tuo avviso, tra la
pervasività dei mass media attuali e un modo di
vivere e di sentire inautentico? Esponi le tue riflessioni,
dopo aver letto anche il cap. Informatizzazione e
comunicazione (p. xxx). (max 20 righe)
58 Nel paragrafo 32 di Essere e tempo, intitolato
Comprensione e interpretazione (Verstehen und
Auslegung), Heidegger afferma che il “comprendere”
rappresenta una delle strutture costitutive
dell’esserci: «la comprensione, comprendendo, si
appropria di ciò che ha compreso.
Nell’interpretazione la comprensione non diventa
altro da sé, ma se stessa». Dopo aver letto anche il
cap. Ermeneutica (par. xxx, p. xxx) spiega questa
convinzione di Heidegger, a cui si rifà esplicitamente
il filosofo tedesco Hans Georg Gadamer (19002002). (max 15 righe)
59 A proposito del linguaggio di Heidegger e del
linguaggio filosofico in genere, leggiamo: «Talvolta ciò
che pervade l’opera di Heidegger e a cui egli
costringe chiunque voglia pensare con lui, è un
tragico lottare per il linguaggio appropriato e per il
concetto parlante. Da dove viene questa povertà? Il
linguaggio adoperato abitualmente dai filosofi è
quello della metafisica greca e del suo sopravvivere,
del suo perfezionamento, oltre il latino antico e
medievale, fino alle moderne lingue nazionali. Molti
concetti della filosofia sono quindi parole straniere.
Ma i grandi pensatori hanno per lo più la forza di
inventare nuovi mezzi per esprimere quello che
voglion dire, mezzi che la loro lingua materna è
pronta a fornire loro. In questo senso Platone e
Aristotele hanno creato un linguaggio concettuale
che attinge da quello, vivo e duttile, dell’Atene del
loro tempo. In questo senso Cicerone ha proposto
termini latini per rendere concetti greci. In questo
senso, Meister Eckhart alla fine del Medioevo,
Leibniz, Kant e soprattutto Hegel, hanno procurato
nuovi mezzi espressivi al linguaggio concettuale della
filosofia. Anche il giovane Heidegger ha liberato
energie linguistiche dal suolo della sua terra natia
alemanna, in cui è profondamente radicato,
arricchendo il linguaggio.
L’ultimo Heidegger però si trova in una situazione
molto più difficile. Non sole le consuetidini
linguistiche e di pensiero altrui, ma anche le proprie,
55 «Che cos’è l’essere?» Senza questa domanda, per
Heidegger, non ci può essere né un’umanità
autentica, né una modalità coerente di esistenza
individuale e sociale e nemmeno una filosofia degna
di questo nome. Perché si tratta di un problema
autenticamente “filosofico”? Perché questo
problema è così importante,“essenziale”, tanto da
occupare il pensiero di tutta una vita? (max 15
righe)
56 È stato scritto: «Martin Heidegger è il grande
maestro della meraviglia, l’uomo il cui stupore di
fronte al semplice fatto che noi siamo invece di non
essere ha posto un luminoso ostacolo sul sentiero
dell’ovvio. Suo è il pensiero che rende
indimenticabile un’affabile attenzione, anche
momentanea, all’esistere. Nella radura del bosco, in
cui conducono i suoi sentieri circolari, sebbene non
la raggiungano, Heidegger ha postulato l’unità di
pensiero e poesia; di pensiero, poesia e dell’atto più
alto dell’orgoglio e della celebrazione umana che è il
Il Novecento
36
0140.p000-000_heidegger.qxd
12-12-2006
16:07
Pagina 37
determinate dalla tradizione del pensiero
occidentale,si rivelano consuetudini che cercano di
spingerlo costantemente fuori direzione rispetto al
proprio problema. Infatti il suo problema è
realmente nuovo. Non viene posto all’interno della
metafisica occidentale, ma è comunque diretto a
questa metafisica. Non problematizza la questione
della metafisica circa l’ente supremo (Dio) e circa
l’essere di ogni ente. Si interroga piuttosto circa ciò
che, solo, apre la sfera di questo domandare e forma
lo spazio in cui si muove il domandare della
metafisica. Heidegger dunque si interroga circa
qualcosa che la tradizione della metafisica
presupponeva come problematico: cosa significa in
generale essere?» (H.G. Gadamer, Heideggers Wege:
Studien zum Spaetwerk Tübingen, Mohr, 1983; trad. it.
di R. Cristin, I sentieri di Heidegger, Marietti, Genova,
1987, pp. 22-23).
Rifletti su queste considerazioni, evidenziando i vari
lati del rapporto problematico tra la filosofia e il
linguaggio. (max 20 righe)
60 Scrive Heidegger: «La filosofia si spinge molto più
avanti del suo presente attuale, essa ricongiunge il
proprio presente al suo remoto e principale
passato. In ogni caso la filosofia permane un genere
di sapere che non solo non si lascia attualizzare ma,
37
al contrario, sottopone alla propria misura il tempo»
(Introduzione alla metafisica).
Alla luce di quanto hai studiato spiega questa
posizione, rispondendo alle domande: la filosofia, per
Heidegger, dipende interamente dalla propria
epoca? Qual è la sua funzione? Prova a cimentarti
con questo tema. (max 20 righe).
61 Secondo parte della critica con Heidegger la filosofia
ha assunto una nuova importanza, diventando
nuovamente qualcosa che non è più o meno
indifferente praticare o no, qualcosa che “deve
essere”, affinché noi possiamo essere uomini. Per
questo motivo Heidegger avrebbe rivalutato la
storia della filosofia, in modo organico e completo,
per la prima volta dopo Hegel. Prova a spiegare
queste valutazioni e assumi una posizione riguardo
all’idea che l’occuparsi di filosofia sia un requisito
essenziale per essere uomini in un senso più
autentico (max 20 righe).
62 La concezione heideggeriana del Da-sein ha
influenzato profondamente le arti visive. In
particolare, ha contribuito alla nascita della pittura
informale. Dopo aver cercato notizie sul tuo libro di
storia dell’arte, prova a illustrare i nessi tra la
concezione del “segno” e della “materia” di questa
tendenza pittorica e la filosofia di Heidegger.
Heidegger Laboratorio