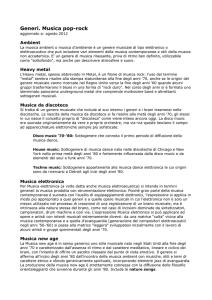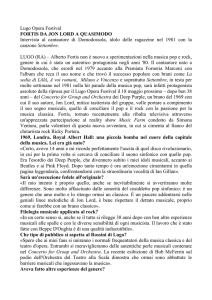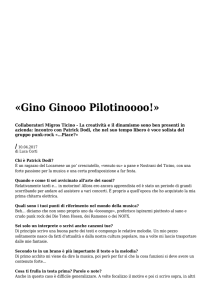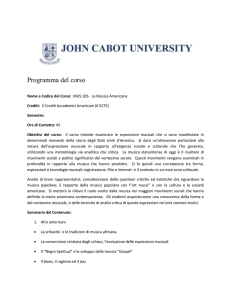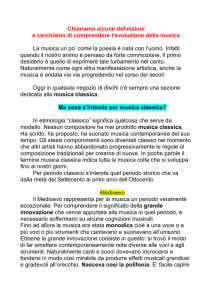IAIN CHAMBERS
RITMI URBANI
Pop music e cultura di massa
Copyright
© 2015 Iain Chambers
Worlding the word - Naples
Ritmi Urbani by Iain Chambers is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Titolo originale: Urban Rhythms. Pop Music and Popular Culture
Copyright © 1985 by Iain Chambers
Traduzione di Paolo Prato
a Lidia… per la musica, il ballo e tutto il resto
Prefazione
Questo libro è stato scritto quasi trent’anni fa. Per certi versi,
e con il senno di poi, il volume che il lettore si trova tra le
mani offre una parabola della storia della cultura europea del
dopoguerra: dall’arrivo dei suoni alieni dagli Stati Uniti negli
anni ‘40 e ‘50, rappresentati dal jazz, dal R&B e dal rock‘n’roll,
ad una conclusione quasi apocalittica nel calore bianco del
suono domestico del punk trent’anni dopo. Si passava in
quell’arco di tempo dall’ingresso epocale della musica nera,
afroamericana e sue derivazioni, alla liberazione delle musiche locali dalla prigione del provincialismo. L’americanizzazione, notava Antonio Gramsci già negli anni Trenta, era destinata a distruggere il vecchio ordine locale, creando delle possi-
bilità inaspettate, soprattutto per le culture subalterne, in un
mondo divenuto sempre più mercato. La tecnica, i mezzi per
produrre e riprodurre la musica occupano una parte centrale
in questa storia. Ma più significativo, e questo ci aiuta a capire
perché la tecnica viene utilizzata in un modo anziché un altro,
è il cambiamento radicale nell’orizzonte del senso rappresentato dalla musica di questi anni.
Certamente la logica di mercato, la mercificazione del gusto,
l’egemonia iniziale dei suoni angloamericani, sono stati pressanti e onnipresenti. Ma va anche detto che l’instaurarsi della
cosiddetta ‘industria culturale’ non ci offre un quadro conclusivo, ma semplicemente un punto di partenza. Alla luce degli
eventi successivi, nei suoni e negli stili che hanno caratterizzato gli sviluppi musicali dalla metà degli anni Cinquanta in
poi, dobbiamo registrare le evoluzioni paradossali di un’industria discografica che cercava di gestire, accogliere e disciplinare una serie di proposte spesso nate altrove. Se, alla fine,
tutto si trova nel mercato, non tutto è del mercato. Le figure
storiche, culturali, etniche, sessuate, religiose, inscritte nei
suoni che arrivano da Trenchtown, Kingston, dalla periferia di
Londra o dai quartieri di Napoli, viaggiano nello spazio offerto
dal suono senza lasciarsi ridurre all’istanza dello scambio
economico. Qualcosa resta, resiste senza farsi assorbire completamente dai circuiti autoreferenziali del commercio. Tra la
certezza del denaro l’incertezza storico-culturale si apre un intervallo, una spaccatura da cui nascono proposte che possono
irritare, interrogare e interpretare lo stato attuale delle cose.
Questo sarebbe il nucleo storico e, se si vuole, anche teorico,
della musica pop (e non solo ‘pop’, ma della musica tout
court) nella tarda-modernità. Quello che si è verificato dagli
anni Ottanta in poi - la presenza globale della musica rap declinata in migliaia di dialetti locali; la completa fusione tra tecnica e linguaggio dove i mezzi di riproduzione musicale (il microfono, il giradischi, il campionatore, il computer) diventano
essi stessi mezzi di produzione musicale, mentre il mediatore
(il DJ) diviene il mezzo; la perpetua ricerca di suoni diversi
sotto l’etichetta di ‘World Music’; la piena realizzazione dell’estetica metropolitana del collage e bricolage tenuta insieme
dalla consacrazione del basso diasporico che si riverbera attorno all’Atlantico nero - era già in incubazione nei decenni
precedenti. Con questo non voglio certo suggerire che la vera
stagione di questa musica si sia conclusa vent’anni fa, o che
non esistano oggi delle voci e dei suoni in grado di riportarci
alla sostanza del mondo complesso e variegato che esprimono.
Vorrei piuttosto sottolineare la specificità di quel momento
storico e culturale, visto e vissuto in modo immediato sia in
Inghilterra (e qui il libro parla spesso in vena autobiografica)
che in Europa, dove si assisteva in modo viscerale al passaggio
turbolento, contorto e sempre incompleto dal vecchio al
nuovo ordine.
In questo passaggio abbiamo assistito alla radicale rivalutazione degli oggetti di consumo, dei loro linguaggi, e, con essi,
del senso che compone una vita. La vetrina drammatica degli
stili musicali e giovanili offerta dalla storia della musica dagli
anni ‘50 in poi ha suggerito che le superfici rivelano un senso
profondo della storia e della cultura che stiamo vivendo. Risucchiati dai suoni e dai segni, siamo trasportati altrove per scoprire che il suono stesso offre un altro modo di concepire la
vita e, dunque, la storia che ci si è portati dietro. Attraverso le
merci - i dischi, la radio, l’abbigliamento, la televisione e tutti
gli altri strumenti più banali della vita quotidiana - scopriamo
i poteri: non solo il potere di uscire dalla logica quotidiana, inseguendo un suono, uno stile, che ci porta altrove; ma anche i
poteri che vorrebbero annullare il significato di questi suoni.
Da questa prospettiva la storia della musica pop non testimonia solo quei momenti in cui si riesce a sottrarsi dalla logica di
una cultura imposta, ma testimonia anche la lotta per rivalutare tale cultura.
Sarebbe questo lo scontro - semiotico, stilistico, e di suoni, ma
anche, e soprattutto, storico - che resta nella musica di oggi,
come trenta o quarant’anni fa. Il vecchio ordine, come si sa,
stenta a morire, e il cosiddetto nuovo, proposto e pubblicizzato nello spettacolo soave del buonismo e del lieto fine, cerca
di ignorare, nella speranza di cancellarla, questa interferenza.
Ma l’arte, e qui emerge la misura poetica ed estetica del
suono, prende in custodia quello che resta. Se l’arte è quel linguaggio, quell’evento che ci porta altrove, lontano da sé, allora
siamo dinanzi a qualcosa che non può venire semplicemente
accolto nei canoni della cultura ufficiale o in quelli dello spettacolo. Il suono, l’oggetto, il gesto possono certamente fare la
loro comparsa in quei luoghi, ma quello che recano in sé precede ed eccede tali confini. L’arte non propone la consolazione, l’arte vera è scioccante, perfino traumatica, certamente
inquietante; essa non propone la riconferma dell’identità,
bensì il suo spaesamento. Concludo con il suggerimento, da
verificare nei dettagli musicali, storici e culturali esposti nelle
pagine che seguiranno, che la poetica e l’estetica della musica
pop, rock, reggae, rap, raï, soul, trip-hop, drum‘n’bass… si ritrovano proprio lì, nello spaesamento che richiede la continua
rivalutazione del nostro divenire.
Iain Chambers, Napoli, 2015
Introduzione
Nel tentativo di cogliere il significato del pop, i testi delle canzoni sono sembrati spesso percorsi eleganti e allettanti da seguire. Tuttavia le ambiguità semantiche della musica sfuggono
di continuo a questo tentativo di coglierli. Sotto le influenze
della musica afroamericana, il pop si è spesso trovato coinvolto in tentativi di sovvertire le basi stesse del linguaggio.
Dall'enunciazione singhiozzante di Elvis Presley in ‘Heartbreak Hotel’ alla incoerenza strozzata di James Brown che
declama i timbri fuggevoli del soul, le parole sono state in
larga misura usate per creare un metalinguaggio di immediatezze acustiche. Questi suoni giungono al corpo del ballerino
o dell'ascoltatore molto prima che il loro significato abbia
tempo di essere colto: “Le parole sono suoni che noi sentiamo,
prima che affermazioni da comprendere” (Greil Marcus).
Un senso di minaccia proveniente da due occhi trincerati dietro un ciuffo imbrillantinato, mentre un juke-box dalla sagoma futurista diffonde in sottofondo rock'n'roll americano.
Un monolocale, una tazzina di caffé, è notte fonda, Joni
Mitchell sul giradischi. I colpi allo stomaco di un basso che coordina i movimenti dei ballerini nel fumo azzurrino di uno stipato locale del quartiere nero dove si suona reggae...
È la riproducibilità del suono che domina la superficie del
pop, dalla discoteca all'acquisto di un Walkman, dall'accendere la radio al leggere il “New Musical Express” ogni settimana. La musica registrata mette anche in relazione un'imponente industria discografica, con scelte musicali e usi culturali tra i più vari. Infatti, una volta riconosciuto il potere
commerciale delle case discografiche, ammessa la funzione
persuasiva delle “sirene” radiofoniche e preso nota delle raccomandazioni della stampa musicale, sono coloro che comprano
i dischi, danzano e vivono al loro ritmo, che alla fine dimostrano, nonostante le condizioni predeterminate della sua
produzione, il più vasto potenziale del pop. Da questa prospettiva consegue che dischi e canzoni non possono più essere considerati come oggetti isolati di critica. Riscattati da un tradizi-
Queste sono soltanto tre delle tante immagini che si possono
raccogliere nella storia del pop. In questo libro cercherò di
esaminare il senso di questa diversità, concentrandomi su alcuni dei vari usi a cui è servita la musica pop in Inghilterra nei
suoi trent'anni o quasi di esistenza.
onale vuoto estetico, determinati suoni diventano indicazioni
o sintomi specifici di tendenze culturali che si intrecciano nel
panorama musicale. Scopriremo come queste tendenze siano
multiformi; come esse talvolta si scontrino mentre altrove si
sovrappongono; come si fondino su divisioni sessuali così
come su precisi stili sottoculturali, su criteri sia razziali sia
commerciali. I dischi saranno regolarmente citati e ordinati in
una discografia in appendice al libro. Indicati come testimoni
potenziali delle vicende di cui qui si parla, essi sono le “forme
sonore del sapere” (Jacques Attali) che hanno funzionato
come stimolo iniziale per la scrittura. Essi rappresentano una
dimensione assente ma integrativa: una infrastruttura sonora
sulla quale le mie osservazioni si sono fondate. Quando è possibile, si dovrebbe ascoltarli.
C HAPTER 1
Vivere nel
mondo
moderno
Quelli che deridono Elvis Presley dovrebbero... indirizzare altrove il
loro spirito antagonistico. Presley doveva semplicemente succedere.
Egli è un sintomo dei tempi. Ciò che dovremmo esaminare e cercare di
capire sono le travagliate circostanze che lo hanno prodotto.
Tony Brown, “Melody Maker”, 1956
importanti di una cultura emergente, basata sulla circolazione
immediata di beni e messaggi non necessariamente legati a
un particolare luogo sociale o culturale. La facilità di
movimento di corpi, suoni, immagini e informazioni minacciava di sconvolgere una realtà particolare, quale essa fosse,
“sopraffacendo l’unicità di ogni realtà” (Walter Benjamin).
In un breve articolo sul cantante pop inglese Tommy Steele
scritto nel 1957, Colin MacInnes faceva accenno alla “strana
ambivalenza” di Steele e altri cantanti inglesi come lui che giungevano al successo discografico “a costo di scindere le loro
personalità e diventare bilingui: parlare americano nello studio di registrazione e in inglese nel pub all’angolo” (MacInnes
1961, p. 14). Allora il fatto veniva di solito liquidato come una
posa superficiale, un vacuo atteggiamento a fini commerciali.
Eppure quella transizione apparentemente indolore che stava
avvenendo tra due mondi così diversi come la Gran Bretagna
e l’“America”, era diventata, verso la fine degli anni Cinquanta, un tratto distintivo di gran parte della cultura giovanile inglese.
Gli oggetti culturali sono sciolti dalla tirannia della tradizione
(Benjamin 1973). Le luccicanti superfici della cultura urbana
contemporanea si fanno béffe delle sicurezze estetiche acquisite erestituiscono quei criteri di giudizio ai critici, colti di sorpresa, spiazzandoli definitivamente. D’altro canto, appena
sotto la patina lucente della plastica e del cromo, dietro le
quinte della moda e ben oltre il limitato accesso imposto
dall’arte tradizionale, un complesso e minuzioso insieme di
scelte, piaceri, desideri e possibilità viene proposto senza sosta. Le vicende apparentemente banali che un tempo riempivano i cinema, imbottivano i jukebox di monete, affollavano le
discoteche e i bar – quegli “eventi senza prestigio” (Henri Lefebvre) – hanno conosciuto da sempre una dimensione più
profonda.
Riconosciuta a malincuore come sintomo di un più ampio cambiamento, l’“americanizzazione” era divenuta spesso anche l’amaro sinonimo del precipitoso e sgradito avvento del mondo
industriale. Sedici anni prima, nel 1941, George Orwell aveva
rilevato un nuovo e “inquieto” spirito nella cultura di massa
inglese, “centrato sul cibo in scatola, il ‘Picture Post’ e il motore a combustione interna” (Orwell 1970, p. 98). Rapidità di
trasporti, comunicazione e alimentazione fast food: tutti segni
L’eterna cronaca della vita quotidiana viene a essere interrogata dal dirompente emergere del represso. Le banalità sulla
natura e sugli scopi del tempo libero, in genere dati come scontati, sono messi in questione da sintomi carichi di insospettata
complessità: nessun “piacere” è in ultima analisi innocente,
nessun passatempo è in fondo senza scopo.
9
Edgar Morin ha colto efficacemente questo fertile, ancorché
raramente riconosciuto, aspetto della moderna cultura di
massa quando ha suggerito che si tratta di una cultura “in soluzione”, immersa nella società e nella storia contemporanea:
una cultura che pone problemi mai formulati né considerati
prima d’ora (Morin 1962).
CULTURA DI MASSA
Un territorio dove i beni si confrontano con i bisogni più o meno trasformati in desideri.
Henri Lefebvre
La critica principale indirizzata contro la cultura di massa o
popolare, con impeto crescente dopo il 1945, riguardava la sua
natura “plastificata’ e “non autentica”. Una cultura “sostitutiva” fatta di emozioni effimere, dominata dalle star hollywoodiane e dai focosi giovinastri delle Hit Parade, sembrava
orchestrare lo spettacolo dei consumi. Scrittori e osservatori,
che altrove dimostravano un profondo disaccordo sulle questioni politiche e sociali, si ritrovarono sorprendentemente allineati nel giudicare il fenomeno. La cultura commerciale per
le masse e il “peso” rappresentato dalle varie americanate che
stavano apparentemente drogando la nazione nei tardi anni
Quaranta e Cinquanta furono da tutti condannati
severamente.1
La seconda guerra mondiale, la presenza delle truppe americane di stanza in Inghilterra dopo il 1942 per preparare l’inva-
sione del continente europeo, lo swing e le commedie brillanti
dell’American Forces Network, e gli effetti di ambedue sul pubblico inglese e sulla BBC, hanno lasciato chiaramente influenze profonde.2 Ma gli Stati Uniti non erano una novità per la
cultura di massa inglese. Le influenze americane si possono
rintracciare, attraverso la pubblicità, il cinema, la musica leggera, il ballo e i divertimenti vari, già nel tardo Ottocento e nel
music hall londinese.3 Diversi aspetti della cultura di massa
americana erano assai rilevanti in Inghilterra già verso la fine
della prima guerra mondiale, grazie in particolare al successo
delle sue due forme più diffuse: il cinema e la musica da ballo.
Accanto al risentimento che accompagnava la diffusione planetaria della Coca-Cola, del chewing gum e di Hollywood, le reazioni britanniche erano spesso radicate in un astio ben più antico del semplice antiamericanismo. Fu l’inedito e per nulla
sollecitato ingresso di nuovi gusti che provenivano dal
“basso”, e la sua evidente capacità di mettere in discussione e
ridisegnare le tradizionali mappe delle abitudini culturali che
generò acide quanto timorose manifestazioni di rifiuto.
È una vita senza senso o qualità, un mondo volgare i cui abitanti hanno
più soldi di quanto sia loro necessario, è la barbarie con la luce elettrica... una teleutopia “cockney”, un nirvana di infimo grado per
quartieri popolari, lo sperpero delle vendite rateali, bambini indisciplinati, squallore domestico ostentato, e patatine fritte con qualsiasi
cosa.4
L’indiscriminata riproduzione tecnologica di artefatti culturali, l’incontrollato frastuono del commercio senza pudori e
il volgare stile transatlantico delle auto con le code a pinna, le
chitarre elettriche e le giacche a quadroni multicolori, tutto
10
ciò era causa di incubi culturali per i custodi della cultura del
vecchio mondo. Una libertà spaventosa, governata soltanto
dal simbolo del dollaro o dal suo equivalente in sterline.
E i nodi vengono al pettine: le grida di protesta e di indignazione che accolsero i segni chiassosi della ricostruzione del dopoguerra e la scoperta del consumismo alla fine degli anni Cinquanta non erano dirette solamente a ovest, al di là dell’Atlantico. Il bersaglio vero e proprio era la società industriale in
quanto tale. Erano l’industria e la tecnologia tout court a
essere poste sotto processo, accusate di distruggere la “cultura.” e i “valori” del mondo moderno. Le persone “colte” e gli
“opinion leader”, in genere ben lontani dal lavoro quotidiano e
dalle esperienze della cultura urbana del dopoguerra, sostenevano che essa racchiudeva l’allarmante capacità di “livellare
verso il basso” la cultura e di spazzarla via.5 La “cultura” era
sostituita dal commercio, ridotta cioè al livello di shampoo per
capelli o di polli allo spiedo precotti.
Negli anni Cinquanta, la cultura di massa stava comunque
prosperando senza bisogno di benedizioni ufficiali ed era sempre più indifferente agli anatemi che le erano lanciati
dall’“alto”. Ormai esistente al di là della ristretta cerchia rappresentata dai programmi scolastici, dai commenti “seri” e dal
“buon gusto”, gli interessi di massa infransero le regole della
“cultura” mettendo in primo piano l’immediato, l’effimero e il
vissuto. Ciò che quegli interessi rivelavano era una storia, contraddittoria e contestata, di esperienze quotidiane produttive
e vitali, che “hanno senso”, contengono piaceri, sono vivibili.
Il reciproco coinvolgimento di cultura e industria, produzione
commerciale e gusto popolare, e il conseguente sviluppo di
una nuova estetica mettono in evidenza anche una divisione
del lavoro che pone in questione la voce, un tempo indiscussa,
dell’autore del prodotto culturale. Laddove la presenza individuale di uno scrittore o pittore implicava un unico momento
di produzione, i processi tecnologici collettivi che comportano
la radio, il cinema, la televisione e la musica riprodotta frammentano la figura dell’“artista” e disperdono l’idea di un unico
punto di origine.
Nella musica pop, per esempio, la voce del cantante, le intenzioni del paroliere, il sound del gruppo – passati al setaccio
dell’arrangiatore, del produttore, del tecnico di studio, della
distribuzione della casa discografica e delle stazioni radio –
sono completamente ridimensionati. Non c’è più una “fonte”
facilmente identificabile; nessun autore ufficiale ma una pluralità di autori: “Cosi, quando tutti sono andati a casa, prendi
quello che hai registrato e lo cambi completamente” dice Glyn
Johns, produttore discografico (Wale 1972, p. 67).
Il mercato per tali prodotti non è libero, naturalmente. Si può
scegliere, ma la scelta è determinata da ciò che è offerto e dai
mezzi a disposizione per compierla. Rivelando una “originalità
orientata al mercato” (Walter Benjamin), quella che si produce attraverso modelli differenziati di consumo è una diversa
cultura; un modello denso di significato si costituisce attraverso scelte, gusti, usi, con una metodologia da “bricolage”.
L’oggetto acquistato viene rielaborato, accumula un valore
d’uso, un “senso”; la merce viene avvolta nel desiderio, entra a
11
far parte della mappa di una realtà particolare e individuale.
Nel corso di questo processo si diffondono, si apprendono e si
applicano nuove modalità di potere culturale, di decisione,
scelta e intervento. La storia della cultura di massa contemporanea è anche la storia di questi sviluppi.
Commerciale nella sua organizzazione e peculiarmente urbana nel carattere: ecco i due tratti principali della odierna cultura di massa. Il suo flusso amorfo, che attraverso cinema, radio, dischi e televisione si infiltra in ogni settore della nostra
vita quotidiana, è stato spesso considerato una grave minaccia
nei confronti di quella che un tempo era considerata una cultura popolare più “sana” e “genuina». Eppure, esaminando attentamente l’epoca precedente, prima che l’americanizzazione
fornisse una comoda spiegazione, scopriamo che la cultura urbana di massa, per lo meno in Gran Bretagna, porta con sé già
da tempo tutti i segni della moderna industria dello spettacolo. Già nel 1860-70 il music hall “trasformato il divertimento in merce” (Waites 1981). Alla fine del diciannovesimo
secolo, sport popolari come il cricket e il football erano a pieno titolo professionistici e finanziati direttamente dalle
tasche del pubblico. Come è stato osservato, quasi tutte le tendenze evidenti nella situazione contemporanea, in particolare
quelle che rientrano nella categoria della “commercializzazione”, erano presenti nella cultura urbana britannica già prima
del 1880 (Cunningham 1980).6
solida cultura operaia urbana, egli stava involontariamente indicando qualcos’altro. La cultura popolare urbana non era,
com’egli pensava, “svalutata” dal commercio e dalla luccicante
pubblicità “che invitavano a entrare in un mondo di zucchero
filato”, ma stava inequivocabilmente cambiando marcia e
forma. Al mutamento del rapporto tra il mondo della produzione e quello del tempo libero e alla nascita di una cultura commerciale di massa che ebbero luogo nel tardo Ottocento, il
mondo del secondo dopoguerra aggiunse una massiccia espansione dei consumi. La scoperta di un mercato interno, ora che
l’impero britannico stava ormai diventando uno sbiadito ricordo, si accompagnava a una notevole crescita della produzione ci beni di consumo – automobili, frigoriferi, lavatrici, televisori – e delle relative industrie legate al terziario. Fu in
questo clima economico e sociale fortemente trasformato che
“l’accecante barbarie” del consumismo e l’imitazione di modelli americani da parte degli “amanti del jive e del boogiewoogie” (Hoggart 1958) ebbero il loro corso. Per quanto esagerati fossero i clamori sollevati attorno a questo mutamento,
la precedente insularità della classe lavoratrice e la sua “cultura consolatoria” (Stedman-Jones 1974) e difensiva venivano
apertamente messe a nudo. Una cultura urbana di massa,
meno precisa e più amorfa, stava mettendo irreversibilmente
le sue radici. In altri termini, come sentenzia il giovane adolescente protagonista di Absolute Beginners di Colin MacInnes:
non era “giusto” essere “antiamericani”.
Quando, in The Uses of Literacy (1958), Richard Hoggart
protestava contro una «nuova» (sic) cultura commerciale di
massa che “assopiva gli stimoli d’azione” di una più vecchia e
12
POPULAR MUSIC
Lasciamo per il momento le vicende più generali della cultura
di massa in Inghilterra e altrove per rivolgerci al mondo più
particolare della musica leggera e all’emergere del “pop”. Si è
tentati di vedere nel mutamento terminologico dal “popular”
(leggero) al “pop”, che avvenne intorno alla metà degli anni
Cinquanta, una semplice divisione storica tra il campo della
musica di consumo in genere e una zona più ristretta, associata a un pubblico di adolescenti. Tuttavia, l’abbreviazione del
termine comportava qualcosa più di una diversità di gusti generazionali: suggeriva anche un preciso mutamento musicale e
culturale. Le voci di Little Richard e di Elvis Presley emersero
da una tradizione ben diversa da quella di Frank Sinatra, Rosemary Clooney e degli altri decani della musica leggera americana del dopoguerra. Questa specie di scontro sonoro sta dietro a gran parte delle vicende successive della musica leggera
e all’avvento del pop come sonorità particolare.
Nel novembre 1956 il cantante americano Johnny Ray occupò
i primi posti dell’Hit Parade inglese per parecchie settimane
con la canzone “Just Walking in the Rain” (cfr. Discografia),
che rappresenta la forma archetipica impiegata nella musica
leggera di largo consumo: la struttura a trentadue battute.
Questo significa che il “nucleo” della canzone consiste di due
cellule, ciascuna di otto misure o battute, che si alternano tra
loro secondo lo schema A/A/B/A o A/B/A/B. I critici della musica leggera del ventesimo secolo hanno costantemente preso
di mira l’uso di questa formula, che secondo loro era il sintomo più evidente di una produzione commerciale standardiz-
zata, se non automatizzata.7 Costoro dimenticano opportunamente che gran parte delle musiche a noi note, europee e no,
ha fatto un uso assiduo di strutture musicali che godevano di
un consenso generale e avevano un’impostazione rimasta relativamente stabile. La principale eccezione in questo caso, e
non la regola, è stata la musica classica europea del diciannovesimo secolo.
L’involontaria ironia della sorte, che vale anche come parziale
spiegazione della successiva acrimonia critica, è che proprio la
tradizione classica europea si erge come un’ombra autorevole
dietro alle tecniche compositive dell’industria di Tin Pan Alley. Distillata attraverso gli approcci popolareggianti dell’operetta, dei balli viennesi, del musical e del varietà, è stata la tradizione “classica.” che ha ampiamente legittimato e ispirato i
criteri estetici e i canoni musicali impiegati nella musica di
consumo degli euroamericani. Architetture armoniche e sviluppo lineare – i paradigmi principali della musica classica –
possono essere stati semplicemente tradotti nell’idea di una
melodia attraente o di un motivo orecchiabile, ma la logica
aveva origine dalla stessa matrice.
D’altronde, una spiegazione della formula musicale di “Just
Walking in the Rain” in termini di semplice riflesso del mercato nella sua struttura compositiva significa francamente non
afferrare il tessuto complessivo dell’evento musicale. Altrettanto importante è lo stile canoro “aperto” che distingue nettamente Johnny Ray dal popolare stile “confidenziale” di Frank
Sinatra e Bing Crosby. È questo, insieme col fischiettare che
apre e accompagna gran parte del brano, che dà alla canzone
13
una sua peculiare identità. Senza dubbio i tre autori della canzone avrebbero tranquillamente concordato con il severo verdetto dei critici della cultura di massa, secondo cui il fischiettare era 1’“esca.” necessaria, l’ornamento calcolato o la novità
sonora che erano richiesti per fare di questa formula ormai collaudata un successo. Ma tale critica introduce anche, inavvertitamente, un aspetto ben diverso, là dove l’interesse per la melodia e le strutture armoniche lineari, il “motivo”, scompare
radicalmente per far posto a intense variazioni di tipo “ornamentale”.
Questa seconda possibilità è stata esplorata in un altro contesto musicale. L’ingresso nelle classifiche di artisti neri come
Fats Domino, Little Richard e Chuck Berry, verso la metà degli anni Cinquanta, aveva fornito talvolta una dimostrazione
di questa alternativa. Tuttavia, nonostante l’eccezionale effetto traumatico prodotto all’epoca di Elvis,Presley e dei suoi
scatenati compagni di scuderia della Sun Records (Jerry Lee
Lewis, Carl Perkins, Bill Riley) che integravano la loro musica
con sonorità “nere”, questa alternativa tendeva a rimanere
una connessione oscura e sotterranea. Il cantante bianco
americano Pat Boone costruì i primi anni della sua carriera
sulla base di versioni “accettabili” di ritmi neri e melodie
blues. Nella sua versione, “Long Tall Sally” di Little Richard
acquista “chiarezza e un piacevole sapore di svago” (“Melody
Maker”, 7 luglio 1956).
Pat Boone era solo l’ultimo esempio di una lunga storia di
blandi camuffamenti che l’industria della musica leggera operava nei confronti del sound afroamericano. La musica dei
neri americani ha sempre svolto un ruolo di cruciale importanza negli sviluppi della musica e della danza popolare dei bianchi fin dall’inizio del secolo, dal ragtime alle orchestre da
ballo, fino allo swing e al rock’n’roll. Ma fino agli anni Sessanta, con le rare eccezioni di Louis Armstrong e Duke Ellington, la sua presenza diretta restava confinata in un sottobosco
scarsamente riconosciuto dell’industria musicale. Un complesso interscambio fra le vestigia subalterne dell’Africa nera e
le istituzioni dell’America bianca (la sua disciplina del lavoro,
la Chiesa, gli svaghi organizzati) e, attraverso queste, le musiche europee, ha creato la complessa matrice delle sonorità
afroamericane. Una tensione costante si è mantenuta nel
corso di questo processo, dapprima attorno al tema della
schiavitù, poi del razzismo e dell’emarginazione sociale, conservando in questo modo gran parte dell’autonomia della musica nera americana: “soul è sopravvivenza”, come giustamente ricorda James Brown. È da questa storia, dal blues e
dal gospel e dal loro successivo fondersi nel jazz, R&B e soul,
che si è sviluppata una sintassi musicale diversa, profondamente distinta dalla “canzone popolare” di derivazione europea.
Mentre la struttura di trentadue battute è il fondamento musicale di Tin Pan Alley, nella tradizione afroamericana questo
ruolo è occupato dal blues di dodici battute: tre accordi che si
alternano secondo uno schema fisso.8 Nella prospettiva dell’armonia classica europea, questo rappresenta una struttura musicale ancora più rigida e “povera” di quella usata dalla musica
leggera bianca. La “scala del blues” è anche ridotta, poiché con14
siste di cinque anziché sette note come la scala europea
ufficiale.9 Questo produce un sintomatico senso di disorientamento per le nostre orecchie, perché il cantante di blues forza
e scivola su quegli intervalli (“blue notes”) che siamo abituati
ad aspettarci. Tale sensazione di “estraneità” è la peculiarità
uditiva più riconoscibile del blues e della musica afroamericana traslata nel pop: i glissandi, le legature, le note scivolate,
“sporche” e imprecise della voce, della chitarra, del sassofono
e del basso.10 Rimane l’irriducibile testimonianza dello scontro tra una tradizione bianca, di origine europea e ufficiale, e
una tradizione afroamericana scarsamente riconosciuta.
Alla ricerca di spazi distinti da quelli occupati dalle strutture
conseguenziali dell’armonia europea, la musica afroamericana
sembra derivare la sua forma dall’“interno”. Una semplicità
orizzontale - nel caso del blues solo tre accordi che fanno da
guida - si trasforma in inaspettata complessità. Le note sono
spezzettate, assemblate, dimezzate, aumentate, contorte, allungate e diminuite. Questa insistente esplorazione degli “interni” verticali della musica porta Jackie Wilson a spremere
trentadue note nel monosillabo “for”, nella versione che i
Dominoes fanno di “Danny Boy” (Miller 1971).
In questa diversa logica musicale, il ritmo è molto più importante delle differenze armoniche, o addirittura della «mancanza» di armonia. È qui che sta la differenza più palese fra musica europea e afroamericana. Sia la musica classica europea
sia quella leggera bianca sono decisamente carenti a questo
proposito, limitandosi per lo più ad accentuare una cadenza
regolare. La musica afroamericana, al contrario, fa riferi-
mento alle tradizióni percussive dell’Africa occidentale, attraversando la multiforme stratificazione del Nuovo Mondo,
dagli inni battisti alle danze francesi, dalle melodie celtiche ai
ritmi latini. Si sforza di piegare, turbare e sovvertire la regolarità del “beat”. E una musica poliritmica.
La combinazione di differenti strati ritmici, che si sovrappongono e si intersecano, e i grappoli verticali di note che portano
con sé diregono la nostra attenzione verso l’“interno” dell’esperienza musicale. Che si tratti di blues, di soul, di reggae o
disco music, siamo trascinati in un’insistente “immediatezza”.
Non è un caso che la musica afroamericana faccia costantemente ricorso ad aggettivi che indicano sensazioni di tipo tattile per descrivere i suoi effetti, come “hot”, “funky”, “feeling”.
La musica, in questo caso, non obbedisce alla rigida logica
lineare, così affine alla scrittura, di un inizio, una fase di
mezzo, una fine, ma alla viscerale intensità del parlato. Legata
solo vagamente alle strutture armoniche lineari, spesso svincolata da un sistema preesistente di scrittura musicale, e stimolata da continui movimenti intorno alle “blue notes” e alle variazioni ritmiche e accordali, l’intensità immediata dell’improvvisazione diviene il canone privilegiato della musica
afroamericana.11
Gli effetti di tale interscamb tra questi linguaggi musicali,
quello afroamericano e quello della musica leggera bianca,
non si sono verificati isolatamente ma nel contesto di una serie di mutamenti a lungo termine che hanno caratterizzato la
musica leggera nei periodi tra le due guerre e in questo dopoguerra. Negli Stati Uniti come in Inghilterra, un precedente
15
stile di produzione musicale, ancora legato alla partitura
scritta (spesso opera di compositori “a cottimo”) e alla vendita
di spartiti, ha ceduto il passo all’impatto crescente della radio
e del disco negli anni Venti e Trenta. Su ambedue le sponde
dell’Atlantico, la radio faceva sì che le orchestre e i cantanti da
ballo entrassero contemporaneamente in milioni di case, conseguissero un loro seguito a livello nazionale, si affermassero
come divi della musica registrata. L’ascesa di Benny Goodman
e della musica swing negli Stati Uniti verso la metà degli anni
Trenta ne è stato l’esempio più clamoroso ma non l’unico.
Naturalmente fu negli Stati Uniti che le possibilità della riproduzione musicale elettrica, a scapito della più vecchia e rigida
organizzazione della musica leggera, furono maggiormente
sfruttate. Alla fine degli anni Trenta, scoppiò una vera e propria guerra commerciale tra gli editori musicali e le stazioni
radio americane, quando i primi aumentarono le tariffe del
copyright. Le stazioni radio replicarono formando proprie organizzazioni per il controllo sui diritti, ma così facendo si trovarono obbligate a cercare una propria musica al di fuori della
giurisdizione di Tin Pan Alley. Poi, tra l’agosto del 1942 e l’ottobre del 1943, 1’American Federation of Musicians scese in
sciopero per ottenere aumenti sulle prestazioni relative alle incisioni discografiche. Le case discografiche, che ora attingevano ai remunerativi profitti dei juke-box, e si trovavano con
l’acqua alla gola per mancanza di nuovo materiale da incidere
a causa dello sciopero, furono costrette a cedere alle richieste
dei musicisti. Questi due avvenimenti segnarono la fine del
monopolio di Tin Pan Alley sul mercato della musica popolare.
Fra le conseguenze immediate di quel secondo avvenimento ci
fu il drammatico declino dello swing. Legato alla precedente
associazione sui copyright controllata da Tin Pan Alley, e di
conseguenza bandito dalle radio, lo swing fu anche colpito duramente dal boicottaggio dei musicisti e fu così escluso dall’ascolto del grande pubblico. Le orchestre di Benny Goodman,
Harry James e Tommy Dorsey si sciolsero nell’arco di poche
settimane nel 1946. Il vuoto lasciato da queste orchestre nei
favori del pubblico fu colmato dai cantanti solisti (che non erano stati coinvolti nello sciopero dei musicisti): Bing Crosby e,
soprattutto, Frank Sinatra. Ma fu il primo avvenimento che si
rivelò il più importante: con la costituzione di un’organizzazione alternativa per i diritti d’autore, l’etere americano si apri
ad altri sound precedentemente esclusi, in particolare alla musica country & western e, in modo più discreto, alla musica
nera.
Verso i primi anni Cinquanta, chi abitava in una grande città
americana come Memphis o Chicago poteva sintonizzare la
propria radio su più stazioni, con buone possibilità di ascoltare blues o R&B. In quel periodo B.B. King faceva il disc
jockey e conduceva un programma di R&B sulla stazione di
Memphis WDIA. Tra i suoi ascoltatori più assidui c’era un
giovane, tale Elvis Presley. Non più ghettizzata in un mercato
a parte, quello dei race records (“dischi etnici”), o confinata
nell’appartato mondo degli “intenditori” di jazz, la musica
nera americana intraprese un processo di rinnovamento che
16
coinvolse l’intera industria della musica leggera, e trovò così
un nuovo pubblico.
I’eco, il missaggio e il montaggio da effettuare in un secondo
tempo, non erano possibilità solo tecniche ma anche musicali.
La scomparsa dei precedenti modelli culturali e le nuove prospettive che si aprivano nell’euforia del dopoguerra furono accompagnate anche da importanti cambiamenti nella riproduzione tecnologica della musica. L’introduzione del microfono
mobile a mano e la sostituzione del fragile 78 giri di gommalacca col più durevole e piccolo 45 giri di plastica furono significative innovazioni. Ma la novità più importante per il futuro si verificò verso la fine del 1948, quando fu introdotto per
la prima volta il nastro magnetico. Il nastro prospettava una
nuova duttilità nei processi di registrazione. L’adozione diffusa del nastro magnetico entro i primi anni Cinquanta sostituì il precedente sistema di registrazione, quello di “incidere
un disco”, che consisteva nel registrare direttamente su un
disco di alluminio rivestito di lacca. Con quel precedente
sistema un errore musicale o un’esecuzione sotto tono comportavano l’eliminazione del disco, che non era nemmeno poco
costoso. Mancavano gli incentivi per esplorare le potenzialità
specifiche della registrazione elettrica, ma lo studio di registrazione doveva essere usato il più velocemente ed economicamente possibile. Il nastro permetteva invece di tagliare, giuntare e montare: il sound finale, cioè il disco che veniva prodotto, poteva essere assemblato completamente in studio.
“Keep A-Knockin” di Little Richard era n origine un “demotape” (nastro prova) di cinquantasette secondi che fu poi
abilmente trasformato in un disco di due minuti e dieci secondi. Assemblare pezzi di nastro, aggiungere effetti come
Il nastro magnetico trasformava la registrazione, da istantanea congelata qual era, in montaggio musicale. Si era giunti
così al punto in cui, nella musica registrata, le “coordinate”
geografiche e temporali di un’interpretazione “originale” avevano sempre minore importanza e andavano perse infine nella
particolare “esecuzione” costruita durante il processo di registrazione. Le pretese della composizione scritta e le intenzioni
musicali alla base della registrazione subivano così continue
interferenze da parte del linguaggio elettronico che si parla
nello studio di produzione.12 Il concetto di “autenticità” perdeva significato a causa della riproduzione tecnica (Benjamin
1973).
Le nuove possibilità offerte dalla registrazione in studio e
dalla distribuzione di massa del sound così prodotto tramite la
radio e i dischi aprirono anche la strada verso un’ulteriore possibilità: quella dell’importante sovrapposizione tra i confini ancora ignorati della musica leggera bianca (country, hillbilly,
southern gospel) e l’immediatezza musicale dell’America nera,
anch’essa ufficialmente ignorata. Era questa una connessione,
per nulla inevitabile, che fu inserita in un contesto di cui la
manifestazione più importante era a quel tempo il rock’n’roll,
solo con la comparsa di un altro protagonista: il confluire dei
profondi cambiamenti avvenuti in seno alla cultura giovanile
nella figura più precisata del “teenager”.
17
GIOVANI E TEMPO LIBERO
I giovani sono una specie aliena.
William Burroughs
È la nostra cultura, il nostro spettacolo, la nostra forma d’arte. La maggioranza della gente non ascolta altro che musica pop. Afferri il ritmo,
senti il bisogno di ballare: cioè, fai due chiacchiere con una ragazza e
cominci a ballare. I tuoi piedi scalpitano e poi partono le mani. Nasce
proprio dentro di te.
Programma radiofonico della BBC
Posti di fronte ai giovani come nuovi protagonisti della società, la maggioranza dei commentatori ha guardato d’istinto ai
cambiamenti avvenuti nell’uso del tempo libero per trovare
una spiegazione. L’inquietante figura del teddy boy degli anni
Cinquanta, con la sua capigliatura pesantemente imbrillantinata e accuratamente acconciata, la sua giacca penzoloni e la
sua ostentata “camminata” americana o, più semplicemente, il
guardaroba sgargiante e la musica assordante del teenager, erano segni evidenti di ciò che, con un certo senso di disagio, era
percepito come semplice eccesso di una volgare cultura per le
masse. In particolare, era il teenager, anche se solo vagamente
definito – un prodotto ma anche un grosso consumatore della
cultura di massa – che era considerato il rappresentante di
questo cambiamento.
La centralità dei giovani nel festival del consumismo, già iniziata alla fine degli anni Cinquanta, non era affatto casuale. Dapprima questo fenomeno fu accentuato inevitabilmente quando
alcuni gruppi giovanili degli anni Cinquanta entrarono in contatto con un mercato di consumo in via di espansione, grazie a
qualche soldo in più che avevano in tasca. La disponibilità diffusa e spesso sconosciuta prima, di abiti alla moda ed
economici, di dischi di plastica, di cosmetici e di transistor da
supermercato, sembrò allargare ancora di più il “gap generazionale”.
Naturalmente questa era anche un’immagine metropolitana
opportunamente gonfiata della vita giovanile, un mito assai
potente che si sarebbe inculcato nell’immaginazione e nella
memoria dei giorni a venire. La vita che la maggioranza dei
teenager conduceva si rivelava poi invariabilmente più piatta
e più povera nella realtà di tutti i giorni.
Ma il termine “giovane” aveva un’accezione anche più ampia:
si riferiva cioè a quell’impulso di modernizzazione che, pur toccando solo una parte del commercio in Gran Bretagna, era
l’ideaguida dello sviluppo di settori sempre più ravvicinati tra
loro come la pubblicità e le arti visive. Riorganizzare l’industria secondo una logica consumistica comportava la necessità
di presentare continue novità e di far decadere modelli, stili e
mode del giorno prima. Era la “gioventù”, che l’esperienza di
poi ha dimostrato essere un sinonimo fluttuante di modernità
- la gente di oggi, il mondo di domani - più che una fase particolare della vita biologica, a prospettare la necessaria successione di “momenti” contemporanei, quel perpetuo “adesso”.13
Una trasformazione di tali sproporzioni diede spunto a maggiori investimenti economici e psichici verso le attività del
18
tempo libero. Il tempo libero non era più semplicemente un
momento di riposo e di recupero dopo il lavoro, il particolare
ambito degli interessi familiari e della formazione individuale,
ma fu ampliato in un potenziale stile di vita reso possibile dal
consumismo. Comperare un certo disco, scegliere una giacca o
una gonna tagliata secondo una determinata moda, meditare
attentamente sul colore delle proprie scarpe è come aprire
una porta su un modo di vita costruito attivamente. L’importanza dell’attualità, il fascino della sua presenza nel presente
può diventare un fattore fondamentale che rende possibile
una sensazione di “fuga dalla coscienza di sé come storia di investimenti sbagliati, di tempo sprecato” (Brooks 1982). A
questo punto il tempo libero si trasforma oggi nella materia
prima dell’esistenza personale, il contesto più significativo in
cui abbiamo la possibilità di affermare il nostro “io”.
È soprattutto il corpo, avvolto nel suono e nella danza, che ha
parte di primo piano nell’incrocio in cui musica pop e tempo
libero si incontrano. Il ballo, dove le zone esplicite e implicite
dei piaceri socializzati e dei desideri individuali si intrecciano
nella momentanea riscoperta della “ragione del corpo” (Nietzsche), è indubbiamente una delle direzioni principali lungo le
quali si orienta il “senso” del pop. Sospeso sui ritmi prevedibili della vita quotidiana, il ballo spesso coinvolge un modello
di tensioni registrate trasversalmente, che rappresentano non
solo le spinte contrastanti fra lavoro e piacere, ma anche tra
una visione tradizionale del piacere (“rilassarsi”, “un meritato
riposo”, “divertirsi”) e un momento più profondo, interioriz-
zato, in cui si persegue un’autentica autorealizzazione sessuale
e sociale, privata e pubblica.
Un investimento come questo non è caratteristico solo del
ballo, comunque, ma è proprio del variegato universo pop, che
intreccia storie d’amore, gusti popolari e piaceri sulle sue molteplici superfici. La presunta banalità della musica pop acquista così un aspetto diverso. Una volta riconosciuto questo
dato di fatto, ci sentiamo incoraggiati, come ha detto Walter
Benjamin, “a passare al contropelo la storia”.
NOTE
1 Dick Hebdige ha condotto un’attenta analisi su alcuni dei principali
motivi culturali che avevano allineato intellettuali inglesi così diversi
fra loro come Evelyn Waugh, George Orwell e Richard Hoggart in un
fronte comune contro lo “spettro dell’americanizzazione” (Hebdige
1981).
2 In seguito a esperimenti dettati dall’esperienza del periodo bellico, la
BBC rese più “dinamici” i suoi programmi e adottò i “metodi americani
di presentazione e di sceneggiatura, cambiando anche politica riguardo
alla programmazione dei palinsesti, il che impose un nuovo modello di
radiodiffusione di massa e favori lo sviluppo dei programmi a puntate
o serial” (Cardiff-Scannell 1981, p. 69).
3 Riferendosi al music hall, Bernard Waites osserva che verso “la fine
del secolo XIX, la canzone popolare stava gradátamente assorbendo e
facendo proprie le influenze americane” (Waites 1981, p. 45).
4 Charles Curran in “Crossbow”, 1962, la rivista del partito conservatore, riportata in Gamble (1974, p. 78).
19
5 Nella classica discussione su questa tradizione, Raymond Williams
osservò verso la metà degli anni Cinquanta che il termine “masse” era
un neologismo col significato di “plebaglia”, e che le tradizionali caratteristiche della plebaglia rimasero insite nel nuovo termine: credulità,
incostanza, pregiudizi di gruppo, volgarità di gusti e dei costumi. Le
masse, perciò, costituivano una perpetua minaccia alla cultura (Williams 1963, p. 288).
6 Studi storici recenti concordano nell’affermare che tra il 1880 e il
1920 si verificò un importante cambiamento nella cultura urbana britannica. La crescente separazione fra il posto di lavoro e l’abitazione,
l’aumento dei sobborghi cittadini e dei trasporti pubblici economici
condussero alla scomparsa di una cultura legata al posto di lavoro. La
vita domestica e gli svaghi divennero sempre più indipendenti dalla
routine e dalle consuetudini del lavoro (Stedman-Jones 1974). La
nuova concentrazione dei processi lavorativi nelle zone industriali e la
conquista di un orario di lavoro più breve attraverso le agitazioni sindacali, favorirono e allargarono una nuova dimensione del “tempo libero”, che adesso era sempre più organizzato nel tempo “privato” e finanziato con le proprie tasche.
7 In generale questa posizione contro la popular music e l’industria culturale era sostenuta con particolare energia dal filosofo tedesco Theodor Adorno. Per una risposta critica ad alcune precise obiezioni di
Adorno cfr. Chambers 1982.
8 La forma di dodici battute tende a diventare la tipica struttura del
blues. Questa è però una tendenza, non una regola ferrea. Incontreremo il blues a otto e sedici battute, per non parlare di tempi ancora più inusuali.
9 Si noti che uso il termine “ufficiale” (o “classico”). La musica folk europea contiene numerosi esempi di scale pentatoniche di tipo blues.
10 Un esempio più importante è dato dal suono della chitarra con il bottleneck (collo di bottiglia). In questo caso un coltello o un collo di botti-
glia appoggiati alle corde delle chitarre permettono all’esecutore di tirare, di far scorrere e scivolare interi blocchi di accordi su e giù lungo il
manico della chitarra. Come ha osservato Trevor Wisehart, non esiste
un equivalente di questa tecnica nell’“armonia funzionale” europea.
(Shepherd et al. 1977, p. 171).
11 “Nei 27 anni che sono trascorsi da quando B.B. (King) raggiunse il
successo con Three O’Clock Blues, egli deve aver suonato il brano, secondo una stima approssimativa, circa cinquemila volte. Cinquemila
volte. Ebbene, io non posso parlare riguardo alle restanti 4.997, ma
sono stato presente all’esecuzione di tre di esse e, se la memoria non
mi inganna, in ogni occasione B.B. tirava fuori degli assoli il cui unico
denominatore comune era la struttura a dodici battute sulla quale essi
erano stati costruiti” (Chris May, “Black Music & Jazz Review”, November 1978, p. 43).
12 Tutto ciò apparve molto più chiaramente, soprattutto nell’epoca del
rock progressivo in cui i musicisti trascorrevano centinaia di ore in uno
studio per la registrazione di un LP. Gli inizi del pop non furono però
molto differenti. Elvis passava molte ore nello studio di registrazione
lavorando sul suo sound fino a quando Sam Phillips era soddisfatto per
aver registrato qualcosa di originale sul nastro. Non voglio dire che
Presley fosse semplicemente “costruito” con i mezzi molto rudimentali
dello studio di registrazione Sun, ma soltanto evidenziare che lo studio
e il disco che ne derivava erano allora un punto di partenza per una carriera musicale basata su trasmissioni radiofoniche, su spettacoli dal
vivo e su apparizioni televisive, e non più, come era stato un tempo, un
punto d’arrivo.
13 Questo eterno “ora” rese la morte “ancora più assurda che mai”
(Morin 1962). L’assurdità della morte in un contesto di riproduzione
meccanica è controbilanciata dall’idea della morte come trascendenza.
Questo fatto crea la possibilità di raggiungere un’immortalità iconica
nella perpetua circolazione di un’immagine riproducibile: James Dean,
Marilyn Monroe, Jimi Hendrix, Brian Jones, Sid Vicious sopravvivono
20
simbolicamente su innumerevoli magliette, borse per la spesa, poster e
gesti ritualizzati, al di là della storia e del tempo cronologico.
21
C HAPTER 2
Un momento
formativo
1956-1963
Teenager esaltati dalla musica terrorizzano una città la notte scorsa.
“Daily Sketch”, 1956
Il 1956 è l’anno d’inizio. C’erano stati, ovviamente, i precedenti. Senza soffermarci sui rapporti spesso oscuri intercorsi
in America tra il blues e il country, potremmo risalire ai primi
anni Cinquanta o addirittura ai tardi anni Quaranta, ma fu
solo nel 1956 che in Inghilterra e altrove sintomi variamente
diffusi si coagularono nella forma riconoscibile del rock‘n’roll.
Nel corso di quell’anno, la frattura tra l’eredità musicale associata alla musica “leggera” o “popolare” e al rock‘n’roll inequivocabilmente “pop” acquista una rilevanza sempre crescente.
Prima del 1956, la musica leggera inglese era dominata dal
sound americano: un cocktail musicale che spaziava dallo
“show business” al jazz leggero. Sfogliando le pagine delle più
importanti riviste musicali inglesi, il “Melody Maker” e il
“New Musical Express”, incontriamo il trombettista di musica
leggera Eddie Calvert, Gerry Mulligan sassofonista di “cool”
jazz, cantanti quali Kay Starr e Dickie Valentine, vocalisti jazz
quali Sarah Vaughan e Billy Eckstine, chitarristi come Barney
Kessel e Bert Weedon. II tutto si compone in un’immagine di
stabilità dell’industria discografica e degli standard musicali:
il soporifero aroma di un mondo in cui le melodie “orecchiabili”, i “successi sempreverdi”, e 1’“entertainment” potevano
essere dibattuti e chiarificati con un senso di fiducia. Un calderone dai confini incerti, e tuttavia apparentemente solido.
Immagini di attrici che non avevano quasi nulla a che fare con
la scena musicale, come Jayne Mansfield, Sabrina, e ritratti ac-
cattivanti di cantanti in abbligiamento provocante o in costume da bagno, comparivano accanto a ponderose recensioni
di musica jazz ed esaltazioni di Frank Sinatra.
Continuando a sfogliare il “Melody Maker”, si arriva all’anno
1956, quando si incontra un tipo di sound più “audace” che
comincia a trovare spazio sulla carta stampata. All’inizio
dell’estate leggiamo:
Verrà il giorno del giudizio, quando l’industria discografica americana,
seguita (come sempre) dalla nostra, ansimante e credulona, si troverà a
dover rendere conto a San Pietro. Non mi meraviglierei se nei primi
posti della lista ci fosse il “rock-and-roll” (...) Visto come fenomeno sociale, la mania attuale per il rock-and-roll è una delle cose più terrificanti
che siano accadute nella musica leggera (...) La tecnica del rock-androll, dal punto di vista vocale e strumentale, è l’antitesi di tutto ciò che
il jazz si era sforzato di conquistare nel corso degli anni - in altre parole
buon gusto e integrità musicale.1
La bandiera del “buon gusto”, insieme con l’immagine della
sua negazione, a essa generalmente associata, l’“americanizzazione”, rivela una crescente polemica su ciò che realmente costituisce la “musica popolare”.
Tuttavia, mentre i giornalisti del “Melody Maker” iniziavano
una campagna per mettere a tacere il rock‘n’roll, non solo i
cantanti “confidenziali” e il jazz americano, ma anche il blues,
continuavano a essere recensiti regolarmente. Il legame potenziale tra quest’ultimo genere musicale e il rock‘n’roll era accuratamente ignorato. In parte ciò era facilitato dal fatto che
soltanto una certa forma di blues era considerata seriamente.
Lo stile elettrico del blues urbano contemporaneo era quasi to23
talmente ignorato; l’interesse era prevalentemente accademico ed era rivolto alla preistoria del jazz, considerato ora
come musica “rispettabile”, con un sound “autentico” - quindi
acustico e non elettrico,“umano” e non meccanico - di una
“musica folk”. Big Bill Broonzy - idolatrato dalla critica jazz inglese degli anni Cinquanta - fu spinto ad abbandonare il suo
stile elettrico di Chicago e a ritornare alla musica rurale che
suonava nel Mississippi negli anni Trenta. L’ostinata insistenza sulla “autenticità” produsse paradossalmente risultati
estremamente artificiali.
In effetti, davanti alla minaccia della “mania’ del rock‘n’roll,
furono subito elevate le più arbitrarie distinzioni entro confini
estetici difesi a spada tratta. Ma come fu possibile che
nell’Inghilterra del 1956 si fosse creata una frattura così profonda tra l’approvazione di molte forme di “popular music”
che avevano successo commerciale e la caparbia negazione di
una novità che alla fine dell’anno doveva essere riconosciuta
come il più significativo avvenimento del calendario musicale? Che cos’era esattamente questa distinzione secondo cui
la voce di Elvis era “costruita”, “di maniera’ (secondo “Melody
Maker”, nella recensione di “Heartbreak Hotel”), mentre
quelle di Norman Wisdom e di David Whitfield non lo erano?
Per capire meglio è necessario estendere la questione in altri
settori. Allora sarà forse possibile comprendere il senso più
ampio di una distinzione che all’epoca appariva scontata:
quella tra una musica popolare “buona” e una “cattiva”.
SCUOTENDO IL BLUES
Il linguaggio del rock‘n’roll era qualcosa di alieno a confronto
con quello che aveva dominato precedentemente i gusti musicali in generale. La maggior parte delle obiezioni mosse dall’establishment della musica leggera insisteva sul fatto che il
rock‘n’roll era una musica volgare e assordante, che anzi non
era musica ma soltanto rumore e, peggio ancora, un rumore
sfacciatamente commerciale. Ma la vera estraneità di questa
musica, quando penetrava nelle orecchie, consisteva nell’eccitante turbamento prodotto dall’insistente, quasi sfrenata vitalità del corpo che accompagnava la voce. Quando ascoltiamo i
dischi e la voce di Elvis, che canta “Heartbreak Hotel”, “All
Shook Up”, o Gene Vincent con il suo “Be Bop a Lula”, la nostra attenzione è distratta dalla persistenza subliminale del
tempo in 4/4, per rivolgersi al ritmo sussultante delle terzine
della parte vocale. La voce e altri strumenti in primo piano,
quali la chitarra e il piano, distraggono dalla regolarità del
ritmo. La cadenza nervosa della musica pone l’accento sul
sound stesso come elemento fondamentale della canzone. È la
presenza quasi fisica della esibizione che cattura il nostro interesse. Gli stili strumentali, quali il tipico glissando del piano
di Jerry Lee Lewis o gli accordi fragorosi di Little Richard, i
timbri sordi del basso (si pensi all’inizio di Heartbreak Hotel),
i sassofoni gracidanti, i break di chitarra acuti e laceranti evidenziano ancor più questi effetti. Entriamo in una sensazione
di immediato, di particolare esibizione musicale che, una volta
impressa sul vinile, si può ripetere per oltre un milione di
volte.
24
Richard Middleton ha avanzato l’ipotesi che questo fermento
musicale e gli sforzi fisici che i concerti di rock‘n’roll dal vivo
richiedevano erano i sintomi frenetici dell’interscambio esplosivo avvenuto tra la musica nera e la tradizione popolare bianca (Middleton 1972). Indubbiamente, la musica nera, costruendo i suoi effetti su un asse verticale, evidenziava la particolarità dell’esibizione individuale che, a differenza di una “interpretazione”, deve rendere conto solo a se stessa. Questo, insieme con le più ampie manifestazioni di energie scaturite dagli incontri fra la musica bianca e la musica nera subalterna
nell’America del dopoguerra, comporta la necessità di
guardare il rock‘n’roll in un’ottica diversa da quella adottata
dalla critica ufficiale degli anni Cinquanta. Infatti, nel contesto della musica tradizionale, ciò che il rock‘n’roll aveva da
rappresentare rimaneva in larga parte irriconoscibile.
tarra elettrica soppiantò ovunque quella acustica: nello stile
sofisticato del blues texano di T Bone Walker o nei timbri
malinconici di Muddy Waters e John Lee Hooker, per divenire
poi parte integrante del country con Merle Travis, Chet Atkins, Emest Tubb e altri ancora a Nashville. Il rock‘n’roll
americano, con i suoi debiti nei confronti del country e del
blues, ne fu dominato, come dimostrano gli sviluppi successivi
nei tardi anni Cinquanta (si ascoltino le diversità di suono di
Bo Diddley, Chuck Berry, Buddy Holly e degli Everly Brothers,
tutti citati nella Discografia).
Insieme col suo “attacco” enfatizzato vocalmente e strumentalmente, la nuova musica rivela anche una peculiare attenzione
per l’aspetto percussivo. Inizialmente questo aspetto si poteva
avvertire nello stile pianistico “gonfiato” preso a prestito dalla
tradizione degli honky tonks e dal country-boogie bianco, ma
fu ben presto trasferito nelle possibilità ritmiche offerte dalla
chitarra, strumento più economico e maneggevole.
In Inghilterra l’adozione della chitarra fu un evento più sconcertante. In mancanza di precedenti americani, la chitarra era
considerata uno strumento piuttosto esotico, in gran parte
confinato nelle sezioni ritmiche delle orchestrine da ballo. Fu
il rock‘n’roll e la successiva popolarità dello skiffle che affermarono la sua presenza nel pop inglese. Gli Shadows, che erano
anche il gruppo che accompagnava Cliff Richard, ebbero qui
un’influenza determinante. Gli “Shads”, com’erano chiamati,
con Hank Marvin alla chitarra solista e con quella che sarebbe
stata poi la formazione classica di un complesso - chitarra ritmica e solista, basso e batteria - ispirarono probabilmente più
di ogni altro evento musicale gli inizi del pop inglese.
Negli Stati Uniti, questa non era certo un’innovazione sorprendente. La chitarra era da sempre lo strumento centrale in
molte forme di musica popolare, sia bianca che nera. L’introduzione della chitarra elettrica nei tardi anni Quaranta, dapprima nel jazz e poi nel blues urbano e nel country & western,
amplificò le possibilità sonore di questo strumento. La chi-
Tutte queste tonalità americane, trasportate in un diverso contesto, aprivano altre possibilità musicali a nuovi investimenti
culturali. Una matrice culturale in parte affine e una lingua
comune costituivano già un rapporto “privilegiato” che consentiva l’ingresso della cultura popolare americana in Inghilterra,
ma davano anche alla cultura britannica la possibilità di ac25
cedere agli strati diversi e più profondi della musica americana sui quali il rock‘n’roll si era formato. I modelli musicali
americani furono assunti e infine tradotti in un contesto culturale inglese, diventando in seguito parte integrante del pop
britannico. In questo reciproco scambio, 1’“America” esibita
nello stile dei teddy boy, dei fan di Elvis e in seguito dei fan
del soul e del rhythm and blues, aveva molto da dire nella cultura popolare inglese.
“UNO DEI MOTIVI D’IMBARAZZO DELLA DEMOCRAZIA”2
Gli anni Cinquanta: un panorama composto da teddy boy e
rock‘n’roll , dalla letteratura dei “giovani arrabbiati”, dal Comitato per il disarmo nucleare, dal trad jazz, dall’abolizione del
Servizio nazionale di leva, dalla diffusione della televisione e
delle auto private: il tutto apparentemente spiegato e contenuto nell’espressione di Harold Macmillan “Non ve la siete
mai passata così bene”. Le reazioni iniziali a queste multiformi manifestazioni furono in gran parte differenziate, ma
quasi tutte espresse in termini difensivi. Le reazioni al
rock‘n’roll divennero rapidamente parte del più generale
clima di ostilità nei confronti delle trasformazioni culturali e
sociali che l’Inghilterra stava attraversando in quel momento.
In gran parte, le critiche erano dirette contro i presunti poteri
di persuasione dei mass media, gli effetti dell’“opulenza” e la
crescente tendenza a vedere nei giovani “la punta più avanzata
del cambiamento sociale” (Hall & Jefferson 1976). Così, lo
“scandaloso” aspetto del teddy boy, oppure la presenza più diffusa della musica pop e degli stili giovanili, offrivano il destro
a una più generale diagnosi dei mali sociali e culturali che affliggevano l’Inghilterra. Il rock‘n’roll e la musica pop giovanile
apparivano un assordante rumore, una sorta di potenziale rifiuto del consenso culturale.
Questo era particolarmente evidente nel caso dei teddy boy. II
clima di isterismo che circondava i teddy boy dopo il delitto di
Clapham Common nel 1953, quando un ragazzo fu trascinato
fuori da un autobus e pugnalato a morte, diede spunto al tema
della violenza fisica e dell’abbigliamento selvaggio, già introdotto dai film The Blue Lamp (1949), in cui Dirk Bogarde rappresentava la minaccia giovanile, e Cosh Boy tre anni più
tardi. Tuttavia, a dispetto delle credenze comuni, lo stile dei
teddy boy non era semplicemente l’espressione aggressiva e
fisica del rock‘n’roll. I “ted” fecero le loro prime apparizioni
nel sud londinese nel 1954, e nel 1956, quando il rock‘n’roll
raggiunge la sua piena affermazione, questa sgargiante sottocultura di stampo prettamente maschile era già in fase declinante nella metropoli. È senza dubbio vero che nel catturare
l’immaginazione popolare con la diffusione del suo “look” - giacche edwardiane,“brothel creepers” (scarpe con una spessa
suola di gomma), pantaloni a tubo molto stretti e capigliature
scolpite nel Brylcreem - questo stile sottoculturale fu retrospettivamente identificato con il rock‘n’roll .
I particolari dettagli di una storia sono spesso inglobati all’interno dei miti che si impongono nella credenza popolare. Allora, come dopo, i ted rappresentarono per molti semplice26
mente il primo momento cruciale del dopoguerra, in cui un
modo di vestire riconoscibile, una musica particolare, un determinato taglio di capelli, insieme con i bar, le sale da ballo,
certi angoli di strade e zone della città si confondevano tutti in
un alone indistinto e leggermente misterioso. È da quella nebbia che uscì poi il teenager. Il termine teenager si trasformò
rapidamente in una parola chiave che indicava una specie di
mondo sotterraneo compreso tra l’infanzia controllata e la maturità adulta. Era visto come una sorta di fuga momentanea
nell’edonismo e nell’esibizionismo consumistico (perciò deplorato pubblicamente, anche se a volte segretamente invidiato) fino a che il “vero” mondo del lavoro e della famiglia si
fosse di nuovo riaffermato.
In realtà, questo periodo di spensieratezza giovanile era un po’
più grigio di quanto alcune delle sue immagini potrebbero suggerire. La cultura giovanile inglese degli anni Cinquanta non
era tanto associata a un’adolescenza scolastica (il contesto
prevalente dei giovani bianchi americani) quanto agli immutabili ritmi settimanali del sabato sera e del lunedì mattina. Era
prevalentemente una cultura della classe operaia giovanile, la
manifestazione dei giovani che lasciavano la scuola a quindici
anni per andare a lavorare. Ciò che offriva questa cultura
giovanile era la possibilità di costruire uno stile generazionale
che in precedenza era impedito dalla mancanza di strumenti
non solo economici, ma anche culturali. Questa prospettiva
era particolarmente allettante per i giovani della classe operaia che si trovavano di fronte a forme culturali antiquate, ormai sul punto di scomparire o già estinte. Verso la metà e la
fine degli anni Cinquanta nuovi elementi contribuirono ad ampliare e a deviare il passaggio, in precedenza rapido, dai cortili
scolastici a quelli delle fabbriche e al pub. Anche se il lavoro
continuava forse a essere frustrante come sempre, i salari erano quintuplicati ed era raddoppiato il potere d’acquisto dei
giovani. Questo era anche il riflesso di un cambiamento strutturale nell’economia domestica. Nel momento in cui il reddito
dei giovani non era più indispensabile in casa, le loro spese si
trasferirono all’esterno, differenziandosi notevolmente da
quelle degli adulti, sempre più indirizzate verso i consumi familiari (la televisione, il frigorifero, magari l’auto).
È qui, nel consumo dei giovani operai che si inizia a scoprire
l’impalcatura materiale sulla quale si costruisce il senso della
pop music. In un paese in cui un esame sostenuto a undici
anni decideva chi poteva accedere alle scuole superiori, il
rock‘n’roll e la pop music in generale proponevano l’idea di
una cultura immaginativa e alternativa rispetto a quella ufficiale. Era un significativo segno di mutamento.
Mentre i ted agivano momentaneamente come catalizzatori di
una serie di scelte stilistiche spettacolari, la loro consapevole
selezione di oggetti d’abbigliamento (le scarpe a punta, le giacche col collo di velluto, i ciuffi che caratterizzavano la loro presenza) divenne, solitamente a un livello meno definito, parte
di un insieme più ampio di stili giovanili. Il protagonista di Absolute Beginners di Colin MacInnes (1959) rappresenta un più
tardo modello di eleganza maschile urbana, la cui attenzione
per il particolare è chiaramente “alternativa” a quella del
grigio mondo degli adulti e alla mancanza di stile delle per27
sone “inquadrate”. L’attenzione narcisistica che si manifesta
nella gioventù urbana di estrazione operaia nel periodo postbellico, anticipata dagli irrispettosi e generalmente disprezzati
“spiv”, e poi esaltata più apertamente dai ted, costituisce un
importante precedente per le generazioni a venire, in quanto
anticipa lo stile molto diverso dei successivi “modernisti” o
“mod” e reinterpreta, in un contesto di consumi resi più mobili dal crescente ruolo dei media, una tradizionale preoccupazione della classe operaia, quella di apparire “elegante” o “far
bella figura”.
Questi canoni stilistici, costruiti con cura su un collage di vestiti, acconciature, musica, gergo e corpo, ebbero un’importanza che viene frequentemente messa in ombra da altri aspetti più immediati della sottocultura. Infatti, al di là della
genesi particolare di questa sottocultura - cioè i ted, come
giovani lavoratori non specializzati del sud londinese che
fanno proprio il tentativo del centro di alta moda di Savile
Row di rilanciare lo stile edwardiano per i giovani aristocratici
dei primi anni Cinquanta, mescolandolo con lo stile “hard
boiled” ripreso dal cinema americano - si può dire che queste
esibizioni spettacolari agirono come potenti fattori propulsivi.
Offrirono, cioè, suggerimenti in fatto di stile a quei giovani
che non appartenevano a nessuna sottocultura particolare.
Per i “ted della domenica” come per i giovani che intrecciavano ancora esitanti legami con una sottocultura attiva, questi
nuovi orizzonti delineavano un significato alternativo della cultura giovanile, ben diverso da quello proposto dai tradizionali
circoli ricreativi (“dove i bravi ragazzi giocavano a ping-pong”,
Melly 1972). Spesso ammirate a distanza e adottate direttamente solo da pochi, le soluzioni offerte da queste sottoculture
ebbero l’importante effetto di mediare e diffondere le due più
importanti forme espressive ricercate dalle culture giovanili
degli anni a venire: la musica pop e l’abbigliamento. Si creò
così fra questi due poli una corrente di intenso spirito romantico urbano, che diffondendosi rapidamente dalla metropoli
alla provincia rinnovò e arricchì il significato dell’uso abituale
del tempo libero speso il sabato sera, sia che si trattasse delle
sale da ballo e dei club giovanili, sia che fossero semplicemente le strade in cui i giovani s’incontravano.
In seguito sarebbe diventato sempre più difficile identificare
la pop music con un preciso gruppo sociale, e non perché,
come profetizzavano alcuni, le classi sociali erano state abolite. Ma i mass media, e in particolare la televisione, furono
costretti a ricercare il senso del “popolare” mutando profondamente il modo in cui essi stessi avevano in precedenza reagito
alle idee di “classe” e di “cultura popolare”.3
L’emergere di un pubblico popolare schierato a favore dei
nuovi media - televisione, rock‘n’roll , pop e “cultura di
massa” in generale - continuò tuttavia a scontrarsi con le persistenti barriere culturali e sociali. Mentre il vasto accesso ai
dischi rendeva la musica pop più “aperta” a gruppi sociali eterogenei di quanto lo fossero state le musiche precedenti (sia
quelle di origini basse sia quelle colte), nel suo periodo iniziale
le volgari sonorità del pop erano generalmente considerate
adatte solo per il consumo culturale dei giovani proletari e degli studenti di liceo più scapestrati. Nonostante le condizioni
28
più accessibili, nonostante l’indifferenza sociale creata dalla
musica registrata, “concepita per la riproducibilità” (Walter
Benjamin), il primo pop fu quindi per lo più confinato entro la
cultura della classe operaia giovanile. Questo non era soltanto
l’effetto di uno spartiacque economico che divideva i giovani
lavoratori dagli studenti, ma comportava evidentemente anche una logica ideologica. Era raro il caso di uno studente di
liceo e, ancor più una studentessa, che riuscisse a superare le
barriere culturali della propria situazione scolastica, familiare
e sociale, per rivolgersi alla tanto disprezzata sonorità del pop.
Secondo una studentessa di liceo in una città industriale del
nord:
I “coffee bar”, gli “snack bar”, eccetera, sono i luoghi di ritrovo principali per gli altri ragazzi, ma io personalmente non frequento questi
posti, perché preferisco bere il Nescafé caldo a casa mia, piuttosto che
un liquido freddo e insipido tra gli schiamazzi di un juke box da otto
pence il disco in un buco pieno di gente urlante (Jackson 1968, p. 143).
Dietro il vuoto deprimente e claustrofobico di tali sentimenti
si profilava una segreta via d’uscita che veniva esplorata mentre trascorrevano gli anni Cinquanta e si avvicinava il nuovo
decennio. Mentre erano pochi gli studenti che guardarono al
rock‘n’roll e al pop come prospettiva culturale, molti altri si
rivolgevano al revival del trad jazz e alla canzone folk (cui partecipavano attivamente anche molte ragazze) nonché al blues
urbano contemporaneo. Ma tutto ciò rimaneva, per il momento, un movimento sotterraneo. La sua crescente presenza,
durante i tardi anni Cinquanta, soprattutto intorno al trad
jazz, ricevette talvolta stimoli occasionali, come nel caso dello
skiffle (il cui boom avvenne tra il 1956 e il 1958), ma la sua
reale importanza nel pop inglese si manifestò pienamente solo
nei primi anni Sessanta.
Chiaramente non erano soltanto i giovani della classe operaia
che compravano i dischi dopo il 1956 e ne sancivano il successo. Molti cantanti già affermati continuarono con successo
la loro scalata alla Hit Parade, e quando esaurirono la loro
vena, furono sostituiti da cantanti analoghi, più giovani e aggiornati. Russ Conway, Shirley Bassey, Matt Monro e Frank
Ifield dovettero la loro popolarità a un vasto pubblico che
amava senza riserve lo spettacolo e il varietà televisivo, e propendeva per le melodie orecchiabili delle star del momento.
Qualcosa, però, era comunque cambiato. Alla fine degli anni
Cinquanta non era più possibile inquadrare le diverse sonorità
di Buddy Holly, dei numerosi gruppi americani neri, maschili
o femminili, o di voci inglesi come quelle di Cliff Richard e
Billy Fury, in un generale contesto di musica popolare preesistente al rock‘n’roll .
Nel frattempo i critici di musica popolare si trovarono divisi
fra la deprecazione della “mancanza di gusto” del rock‘n’roll e
la necessità di riconoscerne, loro malgrado, il successo. Nella
breve ma aspra opposizione della critica contro questa nuova
musica americana, appariva chiaro che quel dibattito su
“gusto” e “musicalità” non era altro che un sintomo di una più
ampia divergenza culturale.
Quando “Hound Dog” fu lanciato sul mercato - e credetemi “lanciato” è
la parola giusta - vi prestai un’attenzione tutta particolare. Molte volte
mi è capitato di sentire brutti dischi, repellenti, monotoni e incoerenti,
ma Hound Dog rappresentava qualcosa di ancora più basso nella mia
29
esperienza (...) Deve esserci un minimo di criterio, anche nella musica
popolare. Se qualcuno canta delle parole, non abbiamo il diritto di pretendere che queste parole siano comprensibili? (...) Fino a che punto il
pubblico pub essere spinto ad allontanarsi dall’arte di Ella Fitzgerald e
dalla sofisticata e sensuale musicalità di Frank Sinatra? (“Melody
Maker”, 10 ottobre 1956).
Il giornalista Steve Race prosegue poi recitando quel familiare
catechismo che associava la popolarità commerciale (“che consente di soddisfare i gusti di un gruppo generazionale demenziale, a scapito delle masse che vogliono ancora ascoltare una
canzone musicale, cantata con musicalità”) con un paventato
futuro di “americanizzazione”: “E nutro timori per questo
paese che avrebbe dovuto mostrare il buon gusto e il buon
senso di rifiutare una musica così decadente” (ibidem).
Ma il “buon gusto” era chiaramente impotente davanti alle
forze che avevano prodotto un Elvis Presley, il disco pop “commerciale” e elementi mutanti come la chitarra elettrica. Mentre il rock‘n’roll veniva deriso dalla stampa, “Melody Maker”
dovette soccombere a opposte pressioni e il 17 aprile del 1956
introdusse la consuetudine tipicamente americana di inserire
una “Top Twenty”, la classifica settimanale dei dischi più
venduti.4 Ma ciò che realmente sfidava i criteri della critica
della musica popolare non era solo quella disgregazione delle
categorie del buon gusto, stimolato dal rock‘n’roll o il cattivo
uso della lingua inglese per opera di Elvis, un ex camionista di
Tupelo, Mississippi, ma la scoperta di una dimensione culturale e musicale fino ad allora sconosciuta. Le regole musicali, sia nei concerti sia nelle sale da ballo, così come la politica delle case discografiche inglesi, si modificarono molto più
rapidamente della critica, per venire incontro a questa realtà
in movimento. Già alla fine del 1956 da molte orchestre di musica da ballo si erano generati complessi di rock‘n’roll . Questi
primi approcci un po’ sperimentali dei musicisti inglesi, esclusi dalle tradizioni musicali che avevano contribuito alla nascita del rock‘n’roll, erano deboli tentativi di imitazione, ma a
loro modo erano fattori di innovazione. Nel 1956 la novità era
il rock‘n’roll americano.
UN “MODELLO AMERICANO”
Abita a Birmingham, non a Hollywood - in un impero morto, in un
mondo al tramonto, ma spera ancora che in qualche modo un Eden si
schiuda, che Super Mac apra i suoi cancelli dorati e qui, lungo l’autostrada M1, fioriscano gli aranci della California. Dev’esserci una carta
fortunata, una trasformazione che nessuno ha ancora scoperto, un
nuovo movimento del corpo più piacevole di quello precedente.
Ray Gosling
Gli americani hanno colonizzato il nostro subconscio.
Wim Wenders
Quell’idea che era l’America per molti ragazzi inglesi degli
anni Cinquanta aveva due inconfondibili caratteri distintivi: il
film hollywoodiano e la musica leggera. Questi elementi, insieme con gli effetti che produssero nei loro corrispondenti britannnici, furono due delle esperienze più immediate che contribuirono alla formazione di un repertorio di cultura popolare in quegli anni. Per molti giovani, il modello cinema30
tografico del gangster dei tardi anni Quaranta e poi il giovane
eroe problematico (Montgomery Clift, Marlon Brando, James
Dean) fissarono e condensarono, in uno stile tipicamente
maschile, la vita come gesto simbolico. Come ebbe a scrivere il
critico americano Robert Warshow “per il gangster esiste solo
la città; deve viverci dentro per personificarla: non la città
reale, ma quella pericolosa e triste città dell’immaginazione,
tanto più importante, che è il mondo moderno” (McArthur
1972, p. 28). Tale è la New York o la Los Angeles dell’immaginazione. Nel contesto inglese, la personificazione dell’ambiente urbano potrebbe sembrare meno drammaticamente motivata, ma ciò non esclude la persistenza di un rapporto immaginario con esso.
Il Royal era un’ampia sala da ballo lussuosamente arredata. Era colma
d’atmosfera: luci soffuse, un bar che vendeva alcoolici e tavolini attorno alla pista da ballo. Questo era lo sfarzo che noi avevamo visto al
cinema. Ora avevamo la scena e così diventavamo attori. Un ragazzo si
credeva Errol Flynn e attaccava discorso con una ragazza dopo l’altra,
un altro poteva essere un secondo Bob Hope, che racconta barzellette
tutta la notte. Poi c’erano quelli più aggressivi; gli Humphrey Bogart, i
George Raft e tutti i tipi di gangster (Barnes 1976, p. 174).
In questo attivo rapporto tra “immaginario” e “reale” (Morin
1962), fiori uno stile giovanile, necessariamente diverso dalle
condizioni ambientali, e sempre più americano nell’ispirazione. Dick Hebdige lo ha definito, in termini assai suggestivi,
come “opzione esistenziale” (Hebdige 1979). Quello che i
giovani prendevano in prestito dalla tenebrosa America urbana, che alla fine si identificava in termini esistenziali col “negro”, offrì all’immaginazione la possibilità di vivere oltre le
categorie esistenti, in una notte profonda e infinita. Era l’occasione, per quanto fugace, di andare oltre i confini ereditati. La
speranza, il gioco simbolico, che dietro agli specchi accumulati
di un senso comune nullificante debba esserci qualcos’altro, fu
identificato con l’immaginario mondo sotterraneo dei gangster americani, degli spacconi, dei negri, con i loro modi di parlare, muoversi, vestirsi, e con la loro musica. Queste erano le
alternative disparate, deliberatamente esotiche, della giovane
classe operaia inglese. L’avvento del rock‘n’roll e di una pop
music orientata verso i giovani, ambedue “made in America”,
prometteva di cucire tali tendenze in una sintesi comprensiva.
Il senso di isolamento nel quale la cultura inglese si trovava
avvolta nell’immediato dopoguerra è stato spesso dimenticato. Questi erano gli anni bui del razionamento: pochi libri e
riviste, un periodo di fosche prospettive, affidate a antiquate
istituzioni che si confrontavano con un futuro incerto. Era in
questo contesto che il cinema hollywoodiano, i fumetti americani e il rock’riroll sembravano cosi seducenti. Tutto ciò offriva il “senso delle possibilità illimitate della vita americana,
che non esistevano in Inghilterrà’ (John Russell, in RussellGablik 1969, p. 33). Questo era anche il lato immaginario di
ciò che altrove era inteso dal senso comune come simbolo di
progresso, di mobilità e di futuro (Hoggart 1958).
Negli Stati Uniti un disc jockey appassionato come Alan Freed
riuscì a “lanciare” il R&B nero e a portare una stazione radio
di New York ai massimi indici di ascolto. Intanto, al 706 di Union Avenue, a Memphis, un produttore bianco altrettanto appassionato, Sam Phillips, stava cercando, secondo quanto si
31
diceva, “un bianco che avesse una voce e un feeling da negro”
(Guralnick 1978). Riuscì a trovare Elvis Presley, cui seguirono
rapidamente Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Ray Orbison e
Johnny Cash. Pur essendo destinati ad avere un profondo impatto sulla musica inglese, queste nuove sonorità americane
dovettero confrontarsi con modelli allora dominanti nell’industria musicale britannica. Gli imperativi commerciali delle
case discografiche determinarono un rapido processo di adattamento: se era il rock‘n’roll a vendere, loro lo avrebbero venduto; e si trascinarono dietro una critica musicale inizialmente riluttante. Altrove, l’opposizione poté anche permettersi di resistere più a lungo. La combinazione tra monopolio
e non commercializzazione delle reti radiofoniche inglesi fece
sì che queste fossero il barometro più preciso per misurare la
resistenza ufficiale al rock‘n’roll e alle trasformazioni introdotte dal pop. Questo era particolarmente significativo per il
pop, una musica che si era formata quasi completamente all’interno del medium elettronico.5 I concerti dal vivo continuavano a promuovere cantanti e dischi, ma furono la radio e soprattutto la televisione a stimolare la gente ad appropriarsi di
questa musica.
In questo contesto, l’effettivo monopolio che godeva la BBC,
con il suo limite di ventidue ore settimanali di programmazione discografica (“needle time”), ebbe conseguenze importanti. Radio Luxemburg, che era sponsorizzata dalle case discografiche inglesi, trasmetteva dal continente una notevole
quantità di musica pop e di conseguenza aumentava il suo pubblico, mentre la BBC continuò a opporre resistenza al
rock‘n’roll e al pop per molto tempo. Fu solo la sorprendente
conferma della popolarità raggiunta verso la metà degli anni
Sessanta dalle stazioni radio pirate che trasmettevano musica
beat e underground, a indurre la BBC a riconsiderare la situazione. L’importanza della radio nello sviluppo della musica
pop in Inghilterra è stata perciò piuttosto marginale e certamente non paragonabile a quella che aveva avuto negli Stati
Uniti. In Inghilterra le nuove proposte della musica pop
hanno spesso assunto uno stile alternativo di base, di solito localizzato in qualche club particolare. Non furono gli studi di
registrazione della Sun o le radio locali costituite intorno
all’esperienza di Memphis, ma il locale Two I’s, in Old Compton Street, a Soho, che divenne la mitica sede della musica
pop inglese, così come dopo sarebbero stati il Cavern a Liverpool, il Crawdaddy Club a Richmond, il Club Go Go a Newcastle, e il Nashville a Kensington, a diventare il teatro dei successivi sviluppi musicali in Inghilterra.
In altri settori della musica pop il “modello americano” guadagnò terreno con maggiore facilità. Uno di questi modelli fu
la nuova importanza acquistata dai cantanti, favoriti dall’uso
del microfono elettrico portatile che consentiva uno stile personale, intimo e confidenziale. I cantanti non erano più parte
di un’orchestra, ma erano accompagnati da un’orchestra. L’effetto di questo cambiamento doveva svincolare il canto dai rigidi ritmi della danza, stimolando una svolta verso uno stile
“individuale” del cantante e preannunciando una nuova fase
della musica popolare. Sarebbe stata l’accessibilità dei media
offerta a un cantante particolare, piuttosto che a una canzone,
32
ad assumere determinante importanza. I pionieri, Bing
Crosby e Frank Sinatra, generarono innumerevoli proseliti:
Tony Bennett, Dean Martin, Buddy Greco, Al Martino, Perry
Como. Ma, all’inizio degli anni Cinquanta, lo straordinario divulgatore di questo stile di personalizzazione musicale - che in
certa misura anticipava l’isterica reificazione dell’idolatria del
rock‘n’roll - fu “The Nabob of Sob” (Il nababbo del
singhiozzo), Johnny Ray. Famoso per il fiume di lacrime che
versava durante le sue esibizioni, Ray fu il cantante che “passò
dall’anonimato alla fama mondiale per l’esibizione delle sue
emozioni in pubblico”, come scriveva acidamente il “New Musical Express” nel 1953.
Il successo senza precedenti di Elvis Presley in Inghilterra era
dovuto a una più complessiva e ricca immagine dell’“americanità”. Una suggestiva combinazione di bellezza latina, di atteggiamenti e modi di parlare da cowboy, di abbigliamento e
spettacolarità nere, e il loro equivalente musicale, le ballate, la
musica country e il R&B, produssero in Presley “un centro nel
quale potevano convergere atteggiamenti diversi” (Nuttall
1970). In termini musicali non fu una combinazione puramente casuale, ma aveva una sua specificità biografica e una
sua impronta personale. Il rockabilly e il rock‘n’roll stavano
per arrivare insieme sulla scena, ma senza Elvis avrebbero anche potuto assumere caratteri diversi. Fu Presley che diede a
questa nascente sintesi musicale la sua iniziale autorità. Fu la
sua forza vocale e spettacolare, esercitata su un materiale musicale eterogeneo, che fuse il gospel bianco, il country e il R&B
in un nuovo codice musicale e culturale.6
IL REPERTORIO INGLESE
Il saccheggio compiuto dal rock‘n’roll nel campo del blues, del
R&B, del country e del gospel fu un fenomeno piuttosto ristretto anche negli Stati Uniti, ma in Inghilterra non ebbe
nemmeno inizio. I musicisti rock‘n’roll della prima generazione provenivano tutti dagli Stati rurali del sud e, in un clima
di profonde tensioni causate da culture razziste e segregazioniste, avevano assimilato una molteplicità di influenze musicali
transculturali. Le loro controparti britanniche di formazione
urbana - Tommy Steele, Marty Wilde, Terry Dene, e, più
tardi, Cliff Richard, Adam Faith e Bill Fury - non erano consapevoli della miscela esplosiva su cui si fondava il rock‘n’roll ,
e, in quanto alle armonie “da strada” del doo-wop e alla musica nera di Fats Domino, Little Richard, Bo Diddley e Chuck
Berry, queste risultavano totalmente estranee alla loro cultura. La scoperta del rock‘n’roll attraverso dischi e film come
Blackboard Jungle (Il seme della violenza), Rock around the
Clock, e in seguito attraverso i concerti dal vivo, rappresentò
per il pubblico non tanto l’avvento di specifiche realtà culturali, quanto semplicemente l’“americanità”, per fare uso di
un neologismo di Barthes.
Più tardi, la scoperta di ciò che stava dietro al rock‘n’roll
doveva avere conseguenze assai profonde sul pop inglese, ma
verso la metà degli anni Cinquanta si offrivano ben poche possibilità, oltre all’imitazione .di uno stile americano per giunta
mal compreso. Del resto i dischi di rock’droll che giungevano
ai primi posti delle classifiche inglesi continuavano essere
quelli di Presley, Little Richard, Jerry Lee Lewis e Chuck
33
Berry. I cantanti inglesi, a parte un paio di escursioni nel
rock‘n’roll che sconfinavano nel “pastiche” come nel caso di
Rock with the Caveman di Tommy Steele, o più riuscite come
Move It di Cliff Richard, tornarono prontamente alle canzoncine per teenager in tempo a levare.7 Il pop inglese,
nonostante lo shock del rock‘n’roll e la scoperta del teenager,
continuò a muoversi sui binari del mondo dello spettacolo tradizionale e commerciale. A questo proposito, sulle orme di Elvis, i divi del pop inglese - Tommy Steele, Cliff Richard,
Adam Faith, Billy Fury - furono tutti protagonisti di film: The
Tommy Steele Story, Espresso Bongo, Beat Girl, Play It Cool,
The Young Ones. Tommy Steele avviò infine la sua carriera
nel campo dello show business. Il carattere dell’industria musicale popolare, insieme con una limitata accettazione da parte
della radio (Saturday Club, Easy Beat) e della televisione (Oh
Boy; 6.5 Special, Juke Box Jury, Thank Your Lucky Stars, contribuirono a spingere la musica pop nell’orbita di quella che
David Jacobs, il patriarca di Juke Box Jury, definiva “un’eccellente forma di intrattenimento per tutta la famiglia”. Dopo la
fugace irruzione del rock‘n’roll , un rapido ritorno al conformismo musicale e culturale opportunamente aggiornato sembrava inevitabile: “Prima ero un cantante rock‘n’roll e piacevo
solo ai ragazzini. Con “Living Doll” ho raggiunto un altro pubblico, sono riuscito a richiamare mamme e papà” (Cliff Richard). Ma i segni premonitori erano già chiari nel 1956, quando
John Kennedy, il manager di Tommy Steele, ancor prima
dello stesso Colonnello Parker, manager di Presley, aveva deciso che il rock‘n’roll necessitava di una “rinfrescata’ e di un
“tocco di classe” in più, allo scopo di attirare un pubblico più
ampio.
Il rock‘n’roll aveva segnato un importante cambiamento nella
musica leggera, ma per il momento rimaneva una potenzialità, una rivoluzione musicale periferica. Nonostante il clamore
sollevato al momento e alcuni esempi come Bill Haley and the
Comets, che guidò la classifica per due mesi di seguito con
Rock around the Clock, dal novembre 1955 al gennaio 1956, il
rock‘n’roll non riuscì a invadere la Hit Parade inglese. Durante tutto questo periodo, il nucleo fondamentale della musica leggera inglese si ispirava agli esempi americani più assimilabili. Ne risultava un sound per adolescenti, composto
per lo più da ballate sentimentali, brani svelti in levare e musiche strumentali.
La presenza degli americani nelle classifiche inglesi, che fu ampia e decisamente importante, si può dividere in più aree.
Prima ci fu il rock‘n’roll con Bill Haley, Elvis, Chuck Berry e
gli altri. Poi, negli anni 1957-1958, segui il genere che spesso
viene chiamato High School (Scuola superiore). High School è
un termine onnicomprensivo che sta a indicare tutta una serie
di diversi filoni musicali, compresi gli ultimi sviluppi del
rock‘n’roll . Sulla scia del successo di Presley si formò una
scuola di “gorgheggiatori” orientati verso il pubblico giovanile,
che si ispiravano al suo stile più facilmente imitabile, il genere
melodico: Fabian, Tommy Sands, Paul Anka, Ricky Nelson. In
ogni caso l’America rurale che aveva prodotto il rockabilly, Elvis e la prima ondata del rock n’roll bianco non scomparve del
tutto. Con la sua tendenza più accentuata verso la country mu34
sic, e perciò più attenuata nel tono, la musica degli Everly
Brothers, di Buddy Holly and the Crickets, e di Eddie Cochran
continuò a raffinare e ampliare la tradizione del rock‘n’roll. Altrove si propagava con successo il sound dei gruppi neri di
R&B e doo wop come Frankie Lymon and the Teenagers, i
Coasters e i Drifters. A questi si aggiungevano, come importante estensione “da sala d’incisione” del pop nero urbano, i
numerosi gruppi femminili creati da produttori fantasiosi: le
Chiffons, le Ronettes, le Crystals.8 Infine c’erano i gruppi strumentali (Duane Eddy, Johnny and the Hurricanes) e gli autori
di dischi da ballo (Chubby Checker, Little Eva, Rufus Thomas).
La “morte” del rock‘n’roll e l’avvento del genere High School
sono considerati generalmente come la sostituzione di una musica “scatenata”, che si richiamava in modo inquietante al
corpo e alla sessualità, con un innocuo sentimentalismo adolescenziale. Questa operazione di pulizia segna il momento in
cui l’industria della musica leggera americana mette finalmente le briglie all’incontrollato veicolo dei suoni giovanili, e
lo dirige entro confini più docili. In parte questo è vero, anche
se il sentimentalismo ha sempre avuto un ruolo importante
nel pop: era presente fin dall’inizio in Elvis (“Love Me Tender”), in Jerry Lee Lewis e altri cantanti di rock‘n’roll . Ma
nello stesso tempo il genere della High School era al suo interno assai differenziato: pur essendoci un filo comune tra i
vari sottogeneri, caratterizzato da una certa enfasi sull’angoscia adolescenziale, questo genere non era affatto omogeneo. Inoltre, con l’esplorazione sempre più approfondita delle
tecniche produttive della sala d’incisione, per opera di importanti produttori come Phil Spector, Ahmet Ertegun e Bert
Berns, tale genere rappresentò un nuovo capitolo nella storia
di una musica che si faceva sempre più urbana.
Nessuno di questi stili particolari fu segnato cronologicamente da rotture radicali, anche se il genere della High School
dominò certamente i tardi anni Cinquanta. Ma al tempo
stesso, l’immediatezza musicale e il ritmo enfatico del
rock‘n’roll non andarono perduti, ma si perpetuavano nei
brani più veloci di Cliff Richard e Adam Faith, nella musica di
Buddy Holly e Eddie Cochran, nei gruppi strumentali e nelle
armonie dei gruppi neri di R&B, la cui matrice si sarebbe poi
modulata nella tradizione del soul urbano degli anni Sessanta
(cfr. Discografia). Queste varie tendenze portarono, sia direttamente sia attraverso i loro effetti a lungo termine, alla formazione di un repertorio di base del pop inglese, che si distingueva
nettamente dalla precedente musica di consumo. E gran parte
di questo repertorio era sostenuto da una domanda costante
di musica da ballo per un pubblico di teenager.
SULLA PISTA DA BALLO
Nell’effimera libertà del sabato sera, bere e ballare, sesso e
moda, divertimento e immaginazione, si legano tra loro in una
complessa catena di significati. La musica pop arriva ad amalgamare questa romantica sintassi dei piaceri giovanili che
emerge da queste trasformazioni. È nei balli, nei locali giova35
nili, nelle sale parrocchiali e nei centri delle comunità rurali
che la musica pop, presente solo in scarsa misura nelle radio,
trovò uno spazio privilegiato.
Mentre le sale da ballo servivano da palcoscenico pubblico per
l’esibizione di atteggiamenti maschili, erano poi le ragazze, col
ballo vero e proprio, a tradurre i suoni del pop in un nuovo
comportamento sociale. Il ballo comportava regole di base
piuttosto rigide, che erano state formulate altrove, fuori dalle
pareti delle sale da ballo o dei locali giovanili. Di conseguenza
le ragazze arrivavano per lo piu in gruppi o in coppia e danzavano tra loro, mentre la maggioranza dei ragazzi stava appoggiata alle pareti, chiacchierava e fumava, guardava in cagnesco
gli altri maschi intrusi e manifestava in questo modo la propria mascolinità.
Sparsi per la sala vi sono gruppi di ragazzi in posizioni stranamente aggressive: il capo teso in avanti, la schiena inarcata, le braccia conserte
davanti al corpo. Guarderanno le ragazze ma raramente chiederanno
loro di ballare. Di tanto in tanto qualcuno accennerà qualche rapido
movimento, poi, insoddisfatto, si sposterà a lunghi balzi in un’altra posizione sulla pista. Simultaneamente altri tre o quattro si alzeranno
come uno stormo di uccelli e lo seguiranno (Mabey 1969, p. 67).
Dietro all’atteggiamento scandalizzato suscitato negli adulti e
nei genitori dal rock‘n’roll e dalle coppiette che si agitavano
nei corridoi dei cinematografi nella tarda estate del 1956,
quando Rock around the Clock Rock veniva bandito regolarmente dalle sale da ballo inglesi, c’era la paura degli istinti liberati dalla licenziosità sessuale. I riferimenti espliciti al corpo,
contenuti in quella musica, furono confermati dall’esplosione
ginnica del ballo.
In realtà la frenesia delle coppie che ballavano il rock‘n’roll
non incontrava i favori dei gestori delle sale da ballo. La rispettabilità e il buon nome di questi locali erano infatti custoditi
gelosamente, e il ballo e l’abbigliamento dovevano conformarsi a un preciso rispetto per la decenza. La spontaneità
veniva vista solo come “la potenziale ancella della ribellione”
(Mungham 1976, p. 86). Lo stesso autore prosegue notando
che il progetto di imporre questo senso di decoro nei locali per
i giovani consistette nel trasformare i buttafuori davanti all’ingresso in guardiani, nel mentre il locale si trasformava in
un’autentica sala da ballo o in “salotto”. Non che, si deve aggiungere, tali sviluppi e aspirazioni “raffinate” fossero necessariamente antitetiche ai gusti giovatali, soprattutto quelli esistenti all’interno delle ristrette prospettive del mondo operaio.
La sessualità impressa nei sentimenti e nei comportamenti
pubblici del rock‘n’roll era prevalentemente di stampo
maschile. Erano poche le ragazze in grado di partecipare alla
sfacciata iconografia “da strada” e alla grossolana immediatezza associate a quella musica, sperando di sfuggire alla rigida censura imposta dalla famiglia, dagli amici, dal vicinato e
dalla scuola. Se da parte dei ragazzi erano prevedibili gli atteggiamenti “duri” e “bollenti”, per quanto riguardava le ragazze
queste attività extradomestiche potevano significare solo una
cosa: sfacelo morale, con tutte le connotazioni negative che accompagnano la presenza femminile nella “vita di strada”.
36
Tuttavia le ragazze furono profondamente coinvolte nella musica pop, così come lo erano state nella musica leggera precedente: dalle “ragazzine con i calzini corti” di Frank Sinatra agli
atteggiamenti quasi isterici delle fan di Johnny Ray e all’impero giovanile che fu costituito da Elvis, la presenza femminile
è stata spesso determinante. Scoraggiate o escluse da altre possibilità, le fan venivano stimolate a manifestare la loro devozione verso il divo con uno spirito romantico. La conseguenza
era che per la maggioranza delle ragazze i suoni del pop erano
profondamente associati a una “cultura da camera da letto”
piuttosto segreta, esclusivamente femminile, espressa con
poster e giradischi. Per le ragazze il ballo proponeva l’estensione pubblica di una cultura dove, avvolta nelle romantiche
sonorità del pop, “la vera sessualità era raggiunta solo nell’ambito del matrimonio”.9 Era questo spazio domestico che era
loro consentito, anziché gli spazi pubblici delle strade, dei
club, dei bar e delle sale da gioco (McRobbie & Gerber 1976).
È interessante notare come fossero più numerose le donne
cantanti di pop negli anni Cinquanta e nei primi anni Sessanta
di quante ce ne sarebbero state nei due decenni successivi. In
ogni caso, sia che si trattasse di qualche affascinante personalità da show business con accenni contenuti di sessualità (Shirley Bassey, Cleo Laine), o, meglio ancora, della “ragazza della
porta accanto” (Susan Maughan, Helen Shapiro, Brenda Lee),
o, più semplicemente, delle fan e delle ballerine del sabato
sera, le donne erano ancora considerate per lo più come ornamenti marginali in una musica che era apparentemente dominata da una cultura pubblica di stampo maschile.
AI MARGINI DEL POP
La risposta dell’industria discografica inglese al rock‘n’roll e al
successo del pop americano, cioè il lancio di qualsiasi nuovo
cantante con l’etichetta di “risposta inglese a Elvis”, fu l’aspetto più evidente degli effetti pedagogici che l’influenza
americana esercitò sulla musica leggera. L’altro aspetto furono i collegamenti con la cultura americana nell’ambito della
realtà giovanile operaia di quel periodo che, insieme con
vicende complementari sviluppate altrove, facevano parte di
un percorso esplorativo verso il cuore della musica popolare
americana. Per “vicende complementari” si intendono i piccoli
ma significativi legami che furono stabiliti durante gli anni
Cinquanta nel jazz tradizionale revivalista, nel movimento
della canzone folk (gran parte del materiale fu reimportato
dalle regioni degli Appalachi degli Stati Uniti) e un crescente
interesse per il blues rurale e urbano. In gran parte, questi interessi avevano origine da un conservatorismo nostalgico nei
confronti della musica folk o autentica appartenente a un passato immaginario. Eppure fu questa miscela finale di sonorità
americane più esotiche con il rock‘n’roll e il pop che condusse
finalmente la sua versione inglese alla soglia della maggiore
età e alla scoperta di una propria “voce interiore” (Hall &
Whannell 1964) nel decennio a venire.
Tra la musica pop, le Hit Parade e il minoritario jazz tradizionale si stabilì per un breve periodo un significativo ponte di
comunicazione: lo skiffle. In un certo senso lo skiffle fu il
primo importante tentativo di appropriarsi di settori della musica popolare americana che non derivassero direttamente.
37
dalle classifiche o dallo show business. Il rock‘n’roll aveva
comunicato dimensioni sconosciute nel panorama musicale. Il
revival inglese del jazz di New Orleans (1885-1914), iniziato
negli anni Quaranta e ancora in auge dieci anni dopo, anche
se minoritario, offriva un’altra prospettiva, anche se rivolta al
passato e per lo più statica. In modo analogo, il fiorente movimento della canzone folk, sebbene sempre più attento alla
purezza dell’eredità nazionale, stimolò agli inizi un vasto interesse per la musica folk americana, e non solo quella bianca.
Fu lo skiffle che contribuì chiaramente a trasformare queste
variegate possibilità musicali in una forma più popolare e accessibile. II suo stile canoro si rifaceva da vicino agli accenti
d’oltre Atlantico. Le canzoni trattavano del “Cumberland Gap”
(Lonnie Donegan, The Vipers), del gioco d’azzardo nel Maine,
della battaglia di New Orleans (Lonnie Donegan) e dei treni
merci (Chas McDevitt e Nancey Whiskey).
La strumentazione dello skiffle, che prevedeva una chitarra acustica e una
sezione ritmica piuttosto casalinga fatta di assi per lavare e
basso a cassa di tè, con l’aggiunta opzionale di chitarre, kazoo,
banjo e piano, era un duplicato delle “Spasm Bands” di New
Orleans a cavallo del secolo e delle orchestrine di musicisti
neri della Memphis degli anni Trenta (The Memphis Jug
Band, The Mississippi Sheiks). Tra il 1956 e il 1958 lo skiffle
rese per la prima volta popolari in Inghilterra molti degli elementi della musica americana bianca e nera.
Soprattutto lo skiffle indicava una notevole via di democratizzazione della comunicazione musicale: con pochi soldi e con
capacità musicali limitate diventava possibile partecipare di-
rettamente alla musica popolare. Nel 1957 si svolsero in Inghilterra, un po’ ovunque, numerosi concorsi di skiffle aperti ai dilettanti che videro la partecipazione di migliaia di gruppi. Singoli membri di complessi così eterogenei come gli Shadows
(Hank Marvin e Jet Harris nei Vipers) e i Beades (John Lennon e Paul McCartney nei Quarrymen) ebbero qui il loro battesimo musicale. Il lento apprendistato musicale e l’addestramento professionale nel mondo dello spettacolo o la “dea bendata» che bacia il giovane sulla fronte non rappresentavano,
più due modi opposti per accedere al mondo del pop. Lo skiffle aveva reso possibile una terza via.
Il primo successo skiffle di Lonnie Donegan, “Rock Island
Line”, era una canzone folk del repertorio di Huddie Ledbetter, cantante di colore. Ledbetter, o “Leadbelly”, nell’ultima
fase della sua carriera si era accostato al movimento post bellico della canzone folk che comprendeva tra gli altri Woody
Guthrie e Pete Seeger. In gioventù “Leadbelly” aveva accompagnato il cieco bluesman itinerante “Blind” Lemon Jefferson.
Il retro di “Rock Island Line” era “John Henry”, una ballata
comune alle tradizioni folk dei bianchi e dei neri. A modo suo,
questa miscela americana di folk bianco e nero rappresentò,
nella sua versione skiflle inglese, una specie di debole ma significativa controparte alla più importante e contemporanea nascita del rock‘n’roll negli Stati Uniti del Sud. Lo skiffle inglese
emerse in realtà dalle pieghe del jazz tradizionalista. Rock Island Line e John Henry furono incisi ambedue in una sessione
del Chris Barber Group, in cui Donegan suonava il banjo.
38
Il trad jazz, la musica tradizionale della New Orleans
dell’inizio del secolo, suonata all’unisono da un complesso che
impiegava tempi di marcia e non conteneva assoli strumentali, ebbe il suo massimo sacerdote in Ken Colyer, la cui jazz
band cominciò l’attività nel 1949. Il trad jazz ebbe origine da
una profonda avversione per lo swing e la sua “decadente commercialità”. Il jazz moderno, quello apparso nei tardi anni
Quaranta a Kansas City e a New York, con gli innovativi suoni
di Charlie Parker, Thelonius Monk, Dizzy Gillespie e Charlie
Christian, non fu preso in considerazione. Tra l’altro, questo
avrebbe comportato l’imbarazzo di confrontarsi con una
nuova coscienza musicale nera e politicizzata, qualcosa che
era più conveniente ignorare mentre si evocava con nostalgia
una mitica New Orleans a cavallo del secolo. I dibattiti e le aspre dispute che si accesero nel jazz inglese negli anni Cinquanta escludevano totalmente qualsiasi tendenza modernista. La disputa riguardava trad jazz e jazz revivalista; quest’ultimo era il jazz degli anni Venti, dopo la sua migrazione nel
nord a Chicago, ed era associato in particolar modo alla musica di Louis Armstrong e dei suoi Hot Five. In ambedue i casi,
un rigido moralismo disdegnava l’avvenuta commercializzazione di quella che un tempo era una musica “popolare” e insisteva sull’“autenticità” delle musiche rispettivamente rappresentate.
Analogamente, lo skiffle era per Lonnie Donegan “una genuina evoluzione della musica folk” che occupava “una posizione
legittima nell’ambito del movimento jazz” ed era “la musica
della gente” (Bird 1958). Naturalmente tutte queste musiche
venivano frequentemente contrapposte alle presunte manipolazioni commerciali del rock‘n’roll. Ma se nel movimento della
folk song era possibile imporre i criteri dell’“autenticità”, al
punto che Ewan McColl insisteva affinché i cantanti usassero
solo materiale proveniente dal loro repertorio nazionale, il
paradosso di uomini bianchi che cercano di riprodurre fedelmente una musica folk nera, cioè di musicisti inglesi che imitavano pedissequamente una forma culturale afroamericana ormai largamente estinta, non poteva certo mirare a un tale artificioso purismo. Per di più, quali che potessero essere i desideri privati dei singoli musicisti, la politica musicale dei vari
complessi jazz restava abbastanza elastica. Fuori dai circoli
del jazz, erano poi questi complessi che fornivano gran parte
della musica richiesta nelle sale da ballo di tutta l’Inghilterra
nella prima metà degli anni Cinquanta.10
Tutti questi stili musicali - skiflle, trad jazz, folk song - erano
anche, in differente misura, segni culturali di un’espansione
della musica popolare come mezzo di comunicazione di
massa del dopoguerra. Fu in gran parte per la disponibilità dei
dischi e per il successo della musica popolare americana che
furono conosciute le ulteriori diversità dell’America musicale.
Questo, a sua volta, rivelò altri modelli e stili sui quali poterono innestarsi gusti e interessi specificamente inglesi. L’accanita azione di retroguardia di coloro che erano impegnati a
difendere le “autentiche” musiche folk contro le macchinazioni commerciali di Tin Pan Alley e contro quelle “mode”
americane come il rock‘n’roll, era il sintomo più indicativo di
un mutamento irreversibile avvenuto nella musica leggera in39
glese. Per ironia della sorte, tali reazioni, costruite in gran
parte sulla musica afroamericana presa a prestito, dovevano
stimolare quella spinta musicale che avrebbe tradotto il tradizionalismo degli anni Cinquanta nelle “mode” degli anni Sessanta (Nuttall 1970).
L’estrema ironia fu che il colpo di grazia al trad jazz arrivò proprio dal breve boom commerciale di cui esso godette all’inizio
degli anni Sessanta. Fu in quella breve stagione che, secondo
le parole di George Melly, “un rumore sempre più monotono”
si incontrò col music hall di stampo edwardiano nella persona
di Acker Bilk (“Stranger on the Shore”), e tutto insieme venne
inchiodato alla croce del suo passato immaginario, osannato
frettolosamente e poi sepolto. A quel punto, ormai, nei locali
che avevano formato il circuito del jazz, venivano introdotti ed
esplorati altri suoni provenienti dall’America.
I suoni della nebbiosa “Città della Mezzaluna”, New Orleans,
di mezzo secolo prima stavano per cedere il passo ai timbri
più attuali di un ambiente urbano più duro ed esuberante: il
R&B e la musica soul. Il primo R&B bianco in Inghilterra fu in
larga parte stimolato da Alexis Korner e dai suoi Blues Incorporated (fra i suoi protetti c’erano Cyril Davis, Charlie Watts,
Mick Jagger, Davey Graham e John Mayall). La loro musica e
quella dei giovani gruppi di R&B, come i Rolling Stones e gli
Yardbirds, fu all’inizio un intervento “anticommerciale” nella
scena del jazz londinese, così come la musica che essi stavano
soppiantando: “Spero non pensino che siamo un gruppo di
rock‘n’roll ” (Mick Jagger, “Jazz News”).
A questo punto la rete degli scambi musicali si complica ulteriormente poiché gli effetti del rock‘n’roll e del pop americano
in generale si sovrappongono alle pratiche musicati più esoteriche diffuse nel mondo del trad jazz e nei suoi dintorni. Fu
questa combinazione, brevemente anticipata dallo skiffle, che
doveva fornire gran parte delle basi su cui il pop inglese
avrebbe elaborato i suoi timbri particolari nel decennio a venire.
NOTE
1 Steve Race in “Melody Maker”, 5 May 1956. L’intero articolo è costruito intorno alla “mostruosa minaccia” rappresentata dal rock‘n’roll .
2 Questo titolo è preso a prestito da un articolo, apparso su un numero
del «Melody Maker” di allora, il quale criticava il rock‘n’roll . Vale la
pena di riportare la frase completa per ricordarci oggi di quanto alti
fossero considerati allora i rischi di questa collisione culturale. “Il fatto
che questa sia l’era dell’uomo comune è uno dei motivi di imbarazzo
della democrazia. Oggi il raggiungimento della fama nella popolar music richiede una tecnica di istigazione della massa” (Tony Brown,
«Melody Maker”, 21 July 1956). Ancora una volta era la voce della plebaglia indisciplinata quella che veniva identificata con disappunto.
3 Nel luglio del 1954 venne approvato il disegno di legge sulla televisione (Television Act) che dava origine alla televisione commerciale. Nel
settembre del 1955 le nuove compagnie regionali di programmazione
cominciarono a trasmettere. La rigida e inflessibile politica della BBC
subì un notevole trauma con l’avvento della ITV Quest’ultima, che
dipendeva dalla pubblicità per il suo finanziamento, e quindi doveva
assicurarsi un folto pubblico, cominciò a produrre una nuova immagine di «intrattenimento popolare”. Variando dai telefilm d’azione
40
americani come Dragnet e Highway Patrol ai drammi a episodi autoprodotti quali Emergency Ward 10, dai varietà come Sunday Night at
the London Palladium al “serial” Coronation Street (che ebbe inizio
nel 1960 ed è tuttora in programmazione), fu introdotta attraverso i media una accezione più flessibile di ciò che era “popolare”.
4 Il “New Musical Express”, rivale del «Melody Maker” riportava
queste classifiche fin dal suo primo numero, nel 1952. La differenza fra
i due giornali, su questo punto, può essere spiegata dal fatto che
«Melody Maker” si considerava molto più un giornale per musicisti
(con un ampio seguito nel mondo del jazz) rispetto al “NME”.
5 Nel periodo 1950-1969 si verificò in America una serie di scandali per
corruzione. Più di duecento disc jockey, compreso Alan Freed, il padre
del rock‘n’roll, furono condannati per aver accettato denaro in cambio
della messa in onda di certi dischi: lo scandalo delle “bustarelle”. Con
gli alti cosci e le incerte prospettive future cui andava incontro ogni prodotto discografico, il ruolo del disc jockey poteva diventare di nevralgica importanza nel determinare il successo di un disco.
6 In un modo o nell’altro tutti i commenti su Elvis Presley riguardano
un mito epico. In un brillante saggio, Preslaid, il giornalista americano
Greil Marcus ha sottolineato i carattere essenzialmente americani”
delle eterogenee componenti e della conseguente formazione della personalità di Elvis Presley (cfr. Marcus 1977). Richard Middleton, in
un’interessante analisi dei vari stili musicali di Presley, ha proposto un
correttivo all’ipotesi del “declino” lineare della traiettoria musicalebiografica di Presley (da audace innovatore a statico divo dello spettacolo) che Marcus, suo malgrado, tende a suggerire (Middleton 1980).
Ma è Albert Goldmann (1982) che fornisce il resoconto più esauriente e
venato di malinconia dell’epopea di Presley. Egli delinea l’ascesa del
nostro eroe da una povera famiglia bianca del sud, fino a diventare il
giovane. proprietario di una flotta di Cadillac, e determina una serie di
precedenti nella tradizione del rock‘n’roll (“Ritratto dell’artista come
giovane punk”). Dopodiché, imprigionato in una dieta sempre più a
base di pillole, in produzioni hollywoodiane di bassa qualità, in uno
splendido isolamento e negli show di Las Vegas, Elvis diviene prigioniero del “sogno americano”: un tossicomane recluso che raramente
si avventura al di fuori delle pareti domestiche di Graceland, Memphis,
che ha il mondo ai suoi piedi pronto ad assecondarlo ed è raggirato da
un manager che ha la lungimiranza di un mercante da fiera.
7 Probabilmente l’unico disco significativo del rockn’roll inglese fu
“Shakin’All Over “di Johnny Kid and the Pirates, uscito nel 1960.
8 Per un approfondimento dell’importante incontro tra la musica nera
urbana e le produzioni di studio negli ultimi anni Cinquanta, spesso associata al lavoro di Ahmet Ertegun, Jerry Wexler, il ragazzo prodigio
Phil Spector, il duo Leiber e Stoller, paroliere e compositore, e la fondazione della Tamla Motown, cfr. Minar 1971.
9 Cfr. Birmingham Feminist History Group 1979. Seguendo questa
logica le ragazze andavano a ballare per essere abbordate, corteggiate e
poi, dopo aver trovato marito, era previsto che abbandonassero la pista
da ballo. “Il ballo è etremamente popolare fra le ragazze fino al matrimonio, quando poi è abbandonato di colpo. A volte Marian, ventidue
anni, è invidiosa quando vede sua sorella che si prepara per andare a
ballare (...). Anche Marian era appassionata al ballo, ma lei e suo
marito, ora che sono sposati, non vanno mai a ballare” (M. Kerr, in
Mungham 1976, p. 85).
10 Per un utile e divertente resoconto sul mondo del jazz e della vita on
the road tra le sale da ballo inglesi nella prima meta degli anni Cinquanta, cfr. Melly 1970.
41
C HAPTER 3
Voci
britanniche
1963-1966
Uno strano pandemonio si stava diffondendo e non aveva niente a che
fare con qualcosa di già conosciuto.
Lonnie Donegan
Agli inizi degli anni Sessanta, il pop americano continuava a
proporre modelli musicali. Nonostante il parere contrario dei
medici che avvertivano del pericolo di slogature e di distorsioni muscolari, l’ultimo modello di ballo, il twist, era in pieno
boom. Chubby Checker, un corpulento cantante negro di Filadelfia era il pezzo forte, ma Sam Cooke (Twistin’ the Night
Away), Joey Dee and the Starliters, e una serie di dischi di
twist simili di Frankie Vaughan, Bert Weedon e Susan
Maughan, ebbero tutti un certo successo nella Hit Parade.1 L’8
dicembre 1962, compreso tra Lovesick Blues di Frank Ifield e
Swiss Maid di Del Shannon, Elvis Aaron Presley, “The King”,
entrava nelle classifiche per la quindicesima volta nella sua
carriera con Returrz to Sender. Raggiunse subito il secondo
posto e la settimana dopo era primo.
Nella stessa settimana era diciannovesimo Love Me Do, il
primo disco dei Beatles. Nell’arco di sei mesi, accompagnato
da titoli in prima pagina, da un fanatismo crescente e da un
interesse commerciale senza precedenti, questo gruppo di Liverpool conquistava la corona del pop inglese. Cliff Richard sopravviveva come primo cantante solista, ma non era più la
prima pop star inglese. Comunque si trattava di una rara eccezione. Lonnie Donegan, che era stato uno dei cantanti inglesi di maggior successo, ovviamente commentava con risentimento, dall’altra parte: “Se avessero saputo [i Beatles] quali
sarebbero state le conseguenze, mi domando se si sarebbero
comportati nello stesso modo. Ammiro la loro integrità musicale, ma allora ero risentito per il cambiamento. Tutto lo show
business provava lo stesso sentimento” (Palmer 1977, p. 231).
Nel frattempo la pubblicità propagandavi le giacche senza
colletto del Beatles e i Mersey boots con i tacchi alti “costruiti
apposta per essere alla moda con le tendenze beat”. L’angloamericana Chewing Gum Company lanciava la gomma Beat
Mint.
L’interesse e il fermento suscitati dai Beatles e dalla musica
beat furono senza precedenti nel pop inglese. Essi rappresentavano l’avanguardia di un processo di rinnovamento interno
alla musica pop inglese che era stato ignorato dall’industria
discografica e dagli organizzatori di concerti. Di frequente,
come nel caso dei Beatles, si trattava di un’esperienza musicale maturata lentamente, che risaliva ai tempi dello skiflle:
John Lennon e Paul McCartney, più tardi raggiunti da George
Harrison, avevano formato i Quarrymen nel 1956. A Londra,
quei giovincelli bianchi, tutti coinvolti dall’ambiente
bohémien delle cantine in cui si suonava jazz metropolitano,
avevano forse visto Muddy Waters nel suo tour inglese del
1958 che suonava blues elettrico urbano di Chicago. Sicuramente conoscevano le All Stars e l’Alexis Korner’s Blues Incorporated. Tutto ciò, insieme con una cultura discografica sotterranea fatta di blues e alimentata da soldati, marinai e studenti
americani e da negozi di dischi specializzati che si era ampiamente diffusa soprattutto nelle scuole superiori e spesso incentivata da un iniziale entusiasmo per il rock’n’roll e lo skiflle,
alla fine ebbe come risultato una proposta musicale sicura di
43
sé e perlopiù sconosciuta alla musica pop americana contemporanea.
Nel corso del 1963, il formidabile impatto dei Beatles e la continua espansione del beat furono la causa di una riorganizzazione musicale e culturale del pop inglese. Fin dagli esordi,
questo inaspettato trionfo apparve destinato a riproporre la
classica simbologia del successo che caratterizza il mondo
dello spettacolo in Gran Bretagna. Nel novembre del 1963 i
Beatles apparivano nell’avvenimento più prestigioso dell’annuario dello show business, il Royal Variety Show. L’anno successivo, il loro film A Hard Day’s Night (Tutti per uno) fu presentato in anteprima ai reali d’Inghilterra. Poi, nel 1965, il
primo ministro Harold Wilson, autoproclamatosi artefice
della Nuova Gran Bretagna, conferì loro il titolo di baronetti.
Ma queste tradizionali conferme del successo pubblico, pur essendo molto apprezzate dal manager dei Beatles, Brian Epstein, dicono poco sulla vera storia del pop inglese in quegli
anni, del suo successo e delle sue energie innovative.
Quando i Beatles e il beat cominciarono a monopolizzare l’attenzione del pubblico, agli inizi del 1963, si manifestarono, a
dire il vero, ben pochi segni di turbamento nella stampa inglese. Non avvenne nessuna ripetizione del 1956. Le case discografiche si buttarono presto a pesce nei club e nelle discoteche di Liverpool, ansiose di estrarre da quella apparentemente inesauribile miniera d’oro che era il Mersey Sound
(cfr. Discografia). Nove mesi dopo, quando la “Beatlemania”
era al suo apice, le recensioni che anticipavano l’uscita del
nuovo 45 giri dei Beatles si preoccupavano soltanto di verifi-
care se il fenomeno avesse o no esaurito il suo corso. Il beat
era stato accolto pienamente. Lo “scandalo” della critica e il
rifiuto che avevano precedentemente circondato la misteriosa
minaccia del rock’n’roll non erano più di attualità. Solo ai confini col rhythm and blues, il lontano parente del pop e del jazz,
si percepiva ancora feto di questa situazione. Ma il beat fu
presto assimilato come una versione condensata dello show
business popolare. C’erano i divi, gli stili e le mode effimere,
tutti naturalmente soggetti a una breve vita e, con rare eccezioni, come Elvis, Cliff and the Shadows, a cambiamenti repentini.
Il dibattito sul pop nelle riviste musicali non utilizzava più termini come “gusto” e “musicalità” (che tuttavia ritornarono
ben presto alla ribalta quando il pop trovò una nuova rispettabilità sulle orme dei Beatles). La capitolazione nei confronti di
una logica di mercato era completa. Ciò che aveva importanza
era il grado di commerciabilità e di durata sul mercato. La Hit
Parade, e non i canoni estetici, dominava incontrastata sulla
fruizione della pop music. Ora, separata nettamente dal resto
della musica leggera, dall’universo delle ballate, del folk e del
jazz e ridotta alla presunta innocuità di un semplice fenomeno
consumistico (la scelta della televisione, della lavatrice e del
giradischi era ed è un segno indifferente in questo ordine di
logica), il pop servì apparentemente ad alimentare i frenetici
entusiasmi dei teenager e del mercato dilagante.
44
OPULENZA E MODERNIZZAZIONE
Era come se stessimo impadronendoci del paese
Un mod diciottenne (Hamblett-Deverson 1964)
Una strombazzata per una “miss” e uno squillo di tromba per
il disco destinato a essere un prossimo successo. Intorno a
questi due rigidi motivi fu organizzato Juke Box Jury, (appuntamento settimanale con la pop music che la BBC organizzò
nei primi anni Sessanta ogni sabato pomeriggio. Ad eccezione
del Thank Your Lucky Stars, spettacolo della rete privata ITV,
la musica dal vivo non era trasmessa alla televisione inglese.2
Talvolta compariva qualche cantante di cui si potevano seguire le reazioni di disappunto mentre una giuria composta da
tre membri, ignari della sua presenza nella stanza accanto, discuteva i meriti del disco. All’incirca dopo venti secondi di ascolto era emesso il verdetto che riguardava il grado di commerciabilità della canzone. Il sorrisetto compiaciuto sul volto del
presidente della giuria David Jacob, nel momento in cui schiacciava il campanello, era sempre un segnale piuttosto inquietante che anticipava il prevedibile “no” pronunciato da una
persona adulta e responsabile, vestita in modo appropriato e
con i capelli tagliati corti.
L’“assoluta obiettività del mercato” (Laing 1969, p. 27) era ciò
che apparentemente regolava lo spettacolo di Juke Box Jury,
ed era lo stesso meccanismo che si rivelava nella fiduciosa manipolazione della musica pop nei film di Cliff Richards, per
esempio Wonderful Life o Summer Holiday. Dietro a queste
ben orchestrate operazioni commerciali stavano anche quegli
ottimistici argomenti con cui il governo conservatore di allora
celebrava in altra sede i benefici dell’“opulenza”. Nel contempo, al Partito laburista non rimaneva che il tentativo di riformulare, non senza traumi, la questione dei suoi destinatari,
ora che quella prosperità economica minacciava di diventare
una caratteristica permanente della Gran Bretagna d’allora.
Era un periodo ancora molto confuso, che poteva essere male
interpretato dai suoi protagonisti. Quando Harold Macmillan
diede le dimissioni da primo ministro nel 1963, la politica interna del partito conservatore si rivela stranamente scollegata
dalle più ampie correnti che attraversavano il paese. Nel
mondo pubblicizzato dalla musica beat, dalla Pop Art, dai Concordes, dagli Hovercraft e dalla “tecnologia rampante”, il quattordicesimo conte di Home, nuovo leader dei conservatori che
si dilettava di caccia alla pernice, doveva apparire una pericolosa involuzione, una doccia fredda dopo lo stile esuberante di
“Supermac”, una nota stonata nella crescita costante della
meritocrazia.
Dopo il suo ritorno al potere “dopo tredici anni di malgoverno
tory”, quel reale senso di fermento e di ottimismo che accompagna inizialmente il nuovo governo laburista nel 1964 scema
rapidamente a causa della politica camaleontica del nuovo
primo ministro (un uomo che fumava modestamente la pipa
in pubblico, ma in realtà preferiva i sigari) e del comportamento deferente che la leadership laburista osserva nel governo in carica. Tuttavia, per un breve periodo di tempo, mentre Harold Wilson si impegnava nel tentativo di tagliare i
“rami secchi” della nazione e di smantellare la gerarchia della
45
società tory, i suoi florilegi retorici generarono feto insospettata di un “perverso nazionalismo” (Jeff Nuttall), che andava
dalla campagna ufficiale di I’m Backing Britain (Sto sostenendo (Inghilterra) alla Union Jack che diventava ben presto
un’icona della cultura pop. Rimaneva comunque vago, in ambedue i casi, quale fosse l”`Inghilterra” che era sostenuta.
grammi specializzati che arrivavano a coprire tutta la gamma
musicale e culturale del pop. Il programma di John Peel trasmesso da Radio Londra, The Perfumed Garden, con il suo
cocktail di poesia, pop, musica classica e folk, fu un’importante anticipazione di quello che attorno al 1966-1967 sarebbe
diventato il pop underground.
Se la “modernizzazione” era simbolo di crescita economica, allora era destinata ad avere uno sviluppo paradossale nella vita
del paese. Nell’aprile del 1964, pur essendo illegale secondo le
leggi inglesi, Radio Caroline si librò nell’etere. Il suo promotore, Ronan 0’Rahilly, già direttore del club “The Scene” a
Soho, un famoso ritrovo dei mod, colse sinteticamente lo spirito del momento: “I giovani stanno esplodendo dappertutto.
C’è da farsi un sacco di soldi”. (Frith 1978, p. 104). Radio Caroline, finanziata per il valore di cinquecentomila sterline dagli
uomini d’affari della City, fu la prima di molte radio pirata che
trasmettevano da arrugginiti ponti di navi situate in varie località nebbiose del Mare del Nord. Fu un successo straordinario. È stato calcolato che nel breve periodo di tempo (19641967), le radio pirata richiamarono all’incirca venti milioni di
ascoltatori al giorno.
Altrove, nel business musicale “modernità” significava mantenersi al passo con le tendenze, in particolare con quelle che
erano dilagate dopo (esplosione del Mersey Sound. Dal punto
di vista della tecnica, non c’erano molte novità. La stereofonia
era ancora agli albori e gli LP stereofonici erano venduti come
un “optional” di lusso. Solo con un drastico cambiamento di
rotta nei confronti del formato LP, accompagnato da una notevole crescita delle vendite e dalla disponibilità di sistemi HiFi a basso prezzo, lo stereo soppiantò con successo i dischi
tuono verso la fine del decennio.3 Inoltre, non si deve dimenticare che l’onnipresente parola d’ordine “autenticità” era sempre un principio estremamente influente sia per quanto riguardava la musica, il folk, il blues e il jazz “autentici”, sia per
(ideologia dello studio di registrazione.4 Nel loro primo LP,
registrato su un apparecchio a due piste, i Beatles non si stancarono di sottolineare le rare occasioni in cui avevano sfruttato la doppia pista delle loro voci, ovvero la loro esaltazione
“artificiale” in studio. Fu soprattutto il design “curvilineo”
delle chitarre americane, o da queste ispirato nei tardi anni
Cinquanta, che si estendeva palesemente verso un futurismo
ormai smaccato. Le “aerodinamiche” chitarre Vox Phantom, le
Fender Stratocaster, le Guild Thunderbird e le Hofner Futu-
Mentre la BBC era presente entro il suo limitato “needle time”
(fora della puntina) e con programmisti che dedicavano brevissimo spazio alla musica pop, le radio pirata offrivano una razione ininterrotta di pop, che non era limitata soltanto alle Hit
Parade del momento. Queste stazioni non solo erano molto
più in sintonia con i gusti dei club e delle sale da ballo (almeno quelle di Londra), ma andavano oltre, allestendo pro-
46
rama - che presto avrebbero arricchito in modo mai sperimentato le loro sonorità elettriche grazie alle casse dei distorsori e
ai pedali detti wah-wah - furono inequivocabilmente introdotte nel filone della modernità.5
L’“opulenza” rappresentava un tema ben più ampio e complesso. Mentre si manifestavano preoccupanti sintomi che la
povertà, quella degli “inglesi dimenticati”, non era mai
davvero scomparsa, questa si trovava per il momento nascosta
fra le pagine dei contratti delle vendite rateali ed era messa in
ombra dall’abbagliante fascino del consumismo. Il mito di una
società opulenta e senza classi era ormai diventato estremamente convincente. Per un certo periodo, l’iconografia
dell’“opulenza”, proposta quotidianamente dalla televisione,
dalla pubblicità e dalla stampa, divenne nell’ambito della pubblica rappresentazione una realtà più potente di quella di
segno contrario che essa regolarmente oscurava. Questo mito
coesisteva con altre realtà, con le quali si intrecciava. Dopo le
risse fra mod e rocker sulle spiagge dell’Inghilterra meridionale nel 1964, quando un mod si offri di pagare la multa di 75
sterline ai magistrati della corte di Margate con un assegno, il
fatto che egli non avesse neppure un conto in banca e non
avesse mai firmato un assegno in vita sua non aveva alcuna importanza: quel gesto aveva segnato l’ingresso in un altro universo simbolico, i mod erano ovviamente “orde opulente che
le multe non potevano scalfire” (Cohen 1973, p. 33). Il gesto di
sfida di un mod o il comportamento scandaloso dei Rolling
Stones e del loro manager Andrew Loog Oldham, che presentavano copertine di LP volutamente offensive (Rolling Stones
2), che erano cacciati da alberghi e ristoranti perché non portavano la cravatta, che erano multati per aver orinato contro il
muro di un garage, che si rifiutavano di rivolgere il rituale saluto al pubblico al termine dello spettacolo televisivo Sunday
Night at the London Palladium rappresentavano nuove e provocatorie forme di devianza. La delinquenza della classe operaia o le lotte fra bande erano una cosa, ma questo sdegnoso
rifiuto non dei frutti della società dei consumi, ma dei mezzi
tradizionali, il lavoro, l’obbedienza servile, il sacrificio e la dedizione necessari per ottenerli, era qualcos’altro. Il modo di
fare sgarbato e volgare era in un certo senso prevedibile, di
tanto in tanto, ma la diffusa disaffezione ideologica era qualcosa di più grave.
La società opulenta aveva apparentemente superato i precedenti confini tra sforzo individuale e retribuzione, posizione di
classe e posizione sociale. La facciata tradizionale era stata
messa in crisi dallo scandalo Profumo, da voci di orgie che
avrebbero coinvolto otto giudici della Corte suprema, e da Kenneth Tynan che nel programma televisivo BBC 3 aveva freddamente dichiarato: “Dubito che esistano persone razionali per
le quali la parola ‘cazzo’ risulti particolarmente diabolica, rivoltante e assolutamente proibita” (Wheen 1982, p. 95). Il limbo
dell’opulenza apriva in apparenza nuove possibilità. Tuttavia,
le “facce” che infine emersero erano solo in rari casi esempi di
un successo conquistato dalla gavetta. Dietro la rumorosa comparsa dei Beatles, di Michael Caine, di Twiggy e Terence
Stamp, aleggiava un diffuso senso di rinnovata imprenditorialità. Fu questa dinamica ad alimentare direttamente il mito
47
della “società senza classi” sebbene questa fosse, più precisamente, una prova evidente di una trasformazione che comportava nuove pratiche, più rapide e necessariamente più drastiche. Questo era vero sia per quanto riguardava il nuovo e aggressivo stile manageriale dell’industria discografica (Brian
Epstein, Andrew Loog Oldham, Kit Lambert, Tony Secunda),
sia in altri settori imprenditoriali più noti. In ultima analisi,
comunque, come scopri il tipico dirigente pubblicitario inglese
“MidAtlantic” descritto da Toni Wolfe, il fascino “modernistico” di stampo “newyorkese” non offriva una reale alternativa
all’ordine stabilito nell’ambiente degli affari londinese: la vecchia gerarchia inglese - “classe, per chiamarla col suo vero
nome” (Wolfe 1972) -non venne affatto scalfita, anche se, per
un breve periodo il notevole entusiasmo che suscitò i nuovo
governo laburista di Harold Wilson sembrava indicare altre
mete.
Tra il 1964 e il 1965 si verificò un decisivo cambiamento
nell’immagine pubblica che circondava la musica pop. Il pop
cessò di essere un avvenimento straordinario ma periferico,
conosciuto soprattutto per i suoi legami con i gusti della classe
lavoratrice giovanile, per diventare il simbolo fondamentale
della cultura metropolitana inglese alla moda. Da affare commerciale qual era, divento il simbolo di uno stile. In club “in”
quali lo Scotch of St. James, l’Ad Lib, il Cromwellian, una sgargiante brigata, immortalata dalle foto di David Bailey e Terence Donovan, vestita da Mary Quant, Ossie Clark e Angela
Cash, pettinata da Vidal Sassoon (“Camus è il mio scrittore
preferito (...) sono pochi quelli che mi stimolano come lui”),
ballava gomito a gomito con John Lennon, Jean Shrimpton,
Mick Jagger, Dusty Springfield, Roger Daltrey e Twiggy, e inseguiva un proprio stile di vita da copertina secondo i ritmi imperanti del pop. Per quanto illusoria e limitata fosse questa immagine di una progenie di “nuovi aristocratici” senza classi,
sicuramente impressionò l’insaziabile occhio della stampa, offrendo agli inglesi la possibilità di gettare una rapida occhiata
voyeuristica dentro l’immagine concentrata di un mutamento
recente, rapido e confuso.
Lo spettacolo del “denaro facile” e di una amoralità senza
classi fornì anche uno stimolo per i nuovi supplementi a colori
dei giornali domenicali. Il primo numero del “Sunday Times”
a colori apparve il 4 febbraio 1962.6 In copertina compariva
una serie di fotografie di David Bailey di una modella, Jean
Shrimpton, che indossava un vestito grigio di Mary Quant.
Due anni dopo il boom del beat di Liverpool veniva definito
“una tempestosa musica amplificata (...), piena di insidiose,
selvagge armonie”, suonata dai Fourmost, Mindbenders, Undertakers, che “la notte straripavano nei rigidi maestrali che
infuriano dalla baia di Liverpool” (Booker 1970, p. 210). L’idillio tra la pop music e la stampa domenicale “di qualità” era ormai avviato. Le immagini patinate e la fraseologia cosmopolita dei supplementi a colori fornivano uno specchio appropriato alle esibizioni dei giovani “attori e attrici” di questo carosello internazionale “senza classi”.
Mentre le conseguenze dei crescenti problemi economici e l’esaurimento di adeguate risposte politiche erano state temporaneamente accantonate dal linguaggio spavaldo della nuova am48
ministrazione laburista, tutto ciò non era più sufficiente per
impedire il manifestarsi di sintomi più morbosi. Una rapida
successione di scandali che coinvolsero l’edilizia, il racket degli affitti, le spie e la moralità pubblica aveva già stimolato l’immaginazione scandalistica degli inglesi.
Questo crollo dei valori si collegava ai fasti del consumismo celebrati dal governo conservatore alla fine degli anni Cinquanta
e nei primi anni Sessanta. Il famoso detto di Macmillan iniziò
a sgretolarsi nel momento in cui il “Times” e altri pontefici
della pubblica moralità insinuarono che l’Inghilterra “se l’era
passata fin troppo bene”. Sbandierando le sue ricette e profezie e il suo minaccioso pessimismo, una crociata morale lanciata dalla signora Mary Whitehouse e dal signor Malcom
Muggeridge (“il Savonarola degli anni Sessanta”, secondo la
concisa definizione di Bernard Levin), si mise in moto in uno
spietato pellegrinaggio attraverso gli sprechi “permissivi” di
un’Inghilterra ossessionata dal consumo. Nell’incestuosa
sovrapposizione di gioventù, consumismo e sesso, questo esercito della reazione era sempre più convinto di aver scoperto il
vero cancro che stava alla base del recente mutamento sociale.
Per il momento, comunque, si trattava solo di vaghe avvisaglie. L’opinione pubblica era apparentemente da tutt’altra
parte. Nel novembre del 1963, il “Daily Mirror” pubblicò un
editoriale che esordiva così: “Bisogna essere proprio un tipo
scorbutico per non amare quei matti, fracassoni, felici e bellissimi Beatles”. Cinque mesi più tardi persino il “Daily Telegraph”, un giornale ben lontano da tendenze progressiste,
iniziò a pubblicare la classifica settimanale dei primi dieci dis-
chi venduti (Top Ten). Gli isolati segnali dei capelloni, l’invasione delle spiagge inglesi da parte di mod e cocker, l’“equipaggiamento da weekend, le anfetamine e i contraccettivi” usati
dai teenager (capo della polizia di Margate, cit. in Cohen 1973,
p. 56) non erano ancora passati attraverso il catalizzatore
della “swinging London”, dal quale sarebbero emersi in una
luce assai diversa, in un alone di minaccia ormai maturo per
trasformarsi in una sorta di “panico morale”.
IL SOUND INGLESE
Abbiamo iniziato imitando Elvis, Buddy Holly, Chuck Berry, Carl
Perkins, Gene Vincent... i Coasters, i Drifters. Abbiamo semplicemente
copiato quello che facevano.
Paul McCartney
Nel 1958, quando Cliff Richard registrò a diciassette anni il
suo primo disco di successo, era di un anno più giovane di
John Lennon. Cliff e molti componenti di gruppi come gli
Shadows o i Tornadoes erano praticamente della stessa generazione dei Beatles e dei Rolling Stones, ma naturalmente il
paragone termina qui. La differenza tra gli Shads e gli Stones
non era semplicemente un fatto di successione storica, ma soprattutto una chiara e netta divisione fra due culture musicali
assai differenti. È vero che tutti e due i gruppi cercavano nella
musica americana ispirazione e stile, ma in un caso questa tendenza era in gran parte limitata a ciò che il pop americano
49
aveva legittimato, nell’altro si cercava una connessione con aspetti diversi e “non autorizzati”. Il primo percorso conduceva
all’asettica accettazione di una musica pop per teenager
(nonostante l’originaria anticipazione del rock’n’roll) da parte
dello show business inglese; l’altro, inutile a dirsi, conduceva
altrove.
I Beatles e l’ondata di gruppi beat maschili che emersero sulla
loro scia, rappresentarono qualcosa di radicalmente nuovo. II
richiamo della musica da ballo, pur non essendo necessariamente importante per la Hit Parade, era un imperativo per le
folle del sabato sera che riempivano i club e i locali pubblici in
cerca di emozioni. La musica doveva avere un andamento ritmico costante, doveva essere suonata ad alto volume e verso la
fine della serata doveva riservare alcuni brani lenti per i “pomicioni”. La sua energia cercava costantemente di ritrovare
quell’eccitazione iniziale che il rock’n’roll aveva un tempo rappresentato. Lo skiflle aveva inoltre fatto capire a molti giovani
inglesi che non era più necessario essere americani, né avere
l’appoggio dell’industria discografica inglese per ricreare quel
clima di esaltazione musicale in un locale da ballo. Il cameratismo maschile, formatosi a scuola, agli angoli delle strade, nel
college o in una banda di quartiere, veniva frequentemente tradotto in un’espressione musicale.7 Non sembra certo casuale il
fatto che il boom della musica beat avesse una componente di
partecipazione femminile inferiore a quella di qualsiasi altro
periodo precedente e successivo.
Nei club come l’Iron Door, il Mardi Gras, il Cavern di Liverpool, l’Oasis, il Three Coins, il Twisted Wheel, il Kingfisher di
Manchester; il Club A Go Go, il Guys and. Dolls di Newcastle,
il Discs-a-Gogo di Cardiff, il Lindella, il La Cave di Glasgow, la
produzione settimanale e talvolta quotidiana di musica da
ballo era fornita da musicisti locali. Fuori Liverpool, che vantava anche un proprio giornale musicale, il “Mersey Beat”, si
era ampiamente diffuso un nuovo stile musicale inglese, profondamente americano nella sua ispirazione. A Newcastle c’erano i futuri Animals, e poi l’Alan Price Combo; a Manchester
erano presenti Wayne Fontana, gli Hollies, gli Statesmen,
Freddie e i Dreamers; Dave Berry and the Cruisers, gli Sheffields, i Debonaires erano a Sheffield; i Beachcombers, Carl
and the Cheetahs, Mike Sheridan and the Night Riders, e i
Rockin’ Berries si esibivano a Birmingham. Le innumerevoli
sale da ballo come la Mecca, il Top Rank e il Locarno, spuntate in tutto il paese, ospitavano le tournée nazionali dei divi
della Hit Parade, ma per quanto riguardava il ballo del sabato
sera, i ragazzi si disarticolavano al suono dei gruppi locali e
dei loro ritmi indiavolati in sale come l’Hully Gully, il Madison, il Mashed Potato e il Twist.
Ascoltando le canzoni del primo album dei Beatles si può avere un’idea del repertorio dei gruppi delle sale da ballo e dei
locali nel nord Inghilterra durante i primi anni Sessanta. In
questo caso, c’è un particolare importante da registrare: i Beatles erano praticamente il primo gruppo che avesse iniziato a
inserire propri brani originali nel suo repertorio. Ancora oggi,
ascoltando le loro canzoni, non è difficile rintracciarne le
origini nel più ampio contesto del beat.
50
Tra il maggio 1963 e il dicembre 1964, i Beatles incisero quattro LP: Please Please Me, With the Beatles, A Hard Day’s
Night, Beatles for Sale. La maggior parte delle canzoni era
composta da Paul McCartney e John Lennon, ma fra i materiali di altri autori, c’erano ‘Twist and Shout’ (registrata in precedenza dagli Isley Brothers), ‘Please Mr. Postman’ (scritta da
Berry Gordy, leader della Tamla Motown, e incisa dalle Marvelettes), ‘You Really Got a Hold on Me’ (registrata dai Miracles), ‘Roll over Beethoven’ e ‘Rock‘n’roll Music’ (ambedue
scritte da Chuck Berry) e ‘Money’ (scritta ancora da Berry
Gordy e registrata da Barrett Strong, un’altra futura colonna
della Tamla Motown). Tutte queste canzoni evidenziano il
debito fondamentale dei Beatles, più tardi riaffermato da
John Lennon nel suo LP Rock‘n’Roll (1975), nei confronti
della musica pop nera contemporanea.
Con le loro esibizioni alla presenza della famiglia reale e con la
nomina a membri dell’Impero britannico (MBE), i Beatles
sembravano essere contemporaneamente entrati nella rassicurante categoria dello “spettacolo per famiglie”. In seguito,
col movimento dei “figli dei fiori”, le droghe e il misticismo
che circondava la loro musica, questa adozione di comodo fu
in parte riveduta, ma mai del tutto abbandonata. Per qualcuno che aveva idee profondamente radicate nei “valori” musicali, i Beatles possono aver costituito una minaccia per così
dire estetica, ma difficilmente di tipo morale. Lo stesso non si
può dire per quei raffazzonati gruppi di R&B o per quelle associazioni perlopiù oscure tra la nuova sottocultura mod e certe
musiche esotiche dell’America nera (“i mod non erano fan dei
Beatles” afferma Richard Barnes): era una distinzione importante.
Il durevole successo dei Beatles ha un valore simbolico quanto
musicale. La “mitologia.” che etichettava il gruppo (quattro
zazzeruti giovanotti di Liverpool di estrazione operaia, che sfidavano le grigie prospettive future di una città portuale del
nord per comporre le musiche di maggior successo nella storia
del pop) assorbe in modo quasi esclusivo ogni altro aspetto
della loro storia. Il loro impatto sull’immaginario del pubblico
e il successo che essi aprirono anche ad altri gruppi inglesi
(particolarmente in America), ritornano a dominare ogni volta
la discussione sulla loro importanza musicale e sui loro effetti
sulla cultura. Il continuo revival delle loro canzoni, costruite
magistralmente ma raramente innovative, fornisce probabilmente la spiegazione più sicura. Il successo dei Beatles, pur
non slegato dal loro rapido assorbimento entro i canoni estetici del momento, fu costruito su un parziale sconvolgimento
dei modelli musicali. I Beatles non provocarono alcuna rottura radicale con la precedente musica leggera: la loro musica
era considerata fresca ed emozionante ma non “estranea”, né
offensiva. Operando magistralmente sulle tradizioni della musica pop bianca e nera, i Beatles offrirono una nuova sintesi:
un mutamento di prospettiva, ma non orizzonti sconosciuti.
La nuova musica non era né un anonimo ritmo da ballo né
semplicemente una copia del sound nero. Tra gli imperativi
del primo e l’esempio del secondo, era emersa una nuova sintesi musicale, dal registro tipicamente inglese: ‘I Wanna Hold
Your Hand’, ‘Can’t Buy Me Love’, ‘Day Tripper’. E questo fat51
tore che pone la prima registrazione piuttosto grossolana dei
Beatles, ‘Love Me Do’ (1962), in un contesto completamente
diverso da quello sdolcinato e sofisticato del sound di The
Young Ones che Cliff Richard aveva registrato poco prima.
Le fonti musicali dei Beatles, come abbiamo già osservato, erano l’allora emergente sound della Tamla Motown e quello dei
gruppi femminili neri, prodotti da Phil Spector, come le Ronettes o le Crystals. A questi si mescolavano il rock‘n’roll e
parte del pop bianco, con Elvis, Little Richard, Carl Perkins,
Chuck Berry, Eddie Cochran, Buddy Holly, the Everly Brothers. L’adozione e la rielaborazione di queste influenze d’oltreoceano, sia nere sia quelle filtrate attraverso la musica Country
& Western e il rock‘n’roll, produsse una significativa tensione
fra questi due mondi musicali. L’armonia classica di tradizione europea, per quanto semplificata, rimaneva sempre al centro della musica bianca, e richiamava l’attenzione su uno sviluppo orizzontale della musica: un motivo riconoscibile, una
melodia accattivante. La musica nera, invece, concentrava le
sue potenzialità sonore altrove, sulle strutture verticali della
canzone, variandone il timbro, gli acuti, l’intensità e il ritmo.
Come un ponte gettato tra questi due continenti musicali, la
musica beat dimostrava, con accentuazioni diverse, di aver
attinto da tutte e due le tradizioni. Così, i suoni della chitarra
erano “pieni” (spesso sottolineati ulteriormente dall’uso
dell’organo) e utilizzavano accordi molto “coloriti” che si orientavano verso livelli e timbri mai sperimentati prima d’allora.
Tuttavia queste tecniche non erano state quasi mai sviluppate
al livello della complessità ritmica espressa dai musicisti neri.
L’assolo di chitarra in una canzone come Can’t Buy Me Love,
per esempio, ha un gusto indiscutibilmente blues, ma rimane
disciplinato dalla forma melodica e dalla logica di sviluppo
lineare della canzone tradizionale. Di fatto, non erano consentiti l’esplorazione e lo smembramento armonico propri del
blues urbano e del soul.
Il tipico stile vocale rilassato dei Beatles, a volte controbilanciato dalla voce roca di John Lennon, insieme con le armonie
e i cori talvolta quasi all’unisono (‘From Me to You’, ‘She
Loves You’), anche se di derivazione americana, rivelava anche stilemi che erano più vicini alla cultura locale dei suoni
più estranei del soul e del blues. L’utilizzo delle voce come strumento ritmico (“Yeah, Yeah, Yeah”), i moduli di botta e risposta tra il cantante solista e gli altri membri che armonizzavano sullo sfondo, tutti di recente riproposti nel pop nero
delle Ronettes, degli Isley Brothers e dei Miracles, possono
essere collegati direttamente al cosiddetto doowop, lo stile da
strada tipico dei gruppi neri dei primi anni Cinquanta: the Orioles, the Ravens, the Dominoes (con Clyde McPhatter), the
Penguins e più tardi gli influenti Coasters. In questo contesto
più familiare, i timbri cupi del blues erano ammorbiditi dalla
più innocenti e sentimentale tonalità della musica pop giovanile. Tuttavia, le armonie e le melodie più dolci e scorrevoli di
quest’ultima non abbandonarono completamente le ambiguità più complesse della musica afroamericana, che emergevano particolarmente nei glissandi della voce, nelle legature e
nei salti, ove era meno latente la presenza della “illegittima”
armonia blues. Il culmine della musica dei Beatles e il cuore
52
delle sonorità afroamericane erano collegati in ultima analisi a
questo inconsueto spostamento del “centro” musicale, a un
“senso” della canzone come se fosse “stonata” e ritmicamente
irregolare. Questo fattore, e il conseguente contrasto con i linguaggi musicali ufficiali “legittimi” (il do re mi... della scala
diatonica europea, per esempio), erano il naturale prodotto di
uno scambio “proibito”.
Questo rinnovato assemblaggio pubblico delle culture subalterne della musica nera e dei toni ribelli del pop bianco, un
tempo associato al rock‘n’roll, fu in gran parte dovuto al successo senza precedenti dei Beatles in Inghilterra e negli Usa.
Le illimitate possibilità riproduttive della registrazione discografica, che permettevano ai giovani bianchi di assorbire direttamente il blues, il R&B e il soul, avevano reso possibile
questa iniziativa, ma furono i Beatles e i gruppi che vennero
dopo di loro a tradurre con successo questa possibilità in
un’autentica forma culturale.
Poco dopo i Beatles e il beat settentrionale, emerse un clima
musicale più teso, più nevrotico, associato con la musica dei
Rolling Stones, degli Animals, degli Yardbirds, dei Pretty
Things e di altri gruppi inglesi che suonavano R&B. Se si può
dire che i Beatles provenivano in un certo senso dalle ceneri
ormai fredde dello skifile, gli Stones sfidavano in modo più immediato le tradizioni del jazz classico per conquistare il trono
di una musica nera “autentica” suonata da musicisti bianchi.
Fu qui che nacque la vera polemica contro la musica beat. I
musicisti jazz, dopo aver visto restringersi gran parte del loro
circuito di provincia a causa della popolarità della musica
beat, si vedevano ora sfidati sul proprio terreno. Giovani
gruppi di R&B bianco incalzavano alle porte delle loro tradizionali roccaforti londinesi. “Il Rhythm and blues? Non è altro
che un rock‘n’roll senza i movimenti” lo definì Micky Ashman,
leader di una jazz band. (“Melody Maker” 2 febbraio 1963).
I Rolling Stones e i Beatles avevano in comune l’interesse per
il rock‘n’roll, in particolare per i suoi protagonisti Chuck Berry
e Buddy Holly, come testimoniano la loro versione in stile
molto “Holly” che gli Stones hanno fatto di ‘I Wanna Be Your
Man’ e ‘It’s All over Now’ di Bobby Womack, insieme con la
loro incisione di ‘Not Fade Away’ di Buddy Holly. Ma gli
Stones scavavano molto più profondamente e più direttamente nel blues urbano e nel soul contemporaneo. Il gruppo
si ispirava anche al pop nero del momento, con ‘Under the
Boardwalk’ dei Drifters, e ‘Poison Ivy’ dei Coasters. Ma gli
esempi più influenti che si trovano un po’ dappertutto nella
loro produzione iniziale furono il blues urbano di Muddy Waters e di Howlin’ Wolf, e il nascente soul di Memphis e Detroit
di Solomon Burke, Marvin Gaye e Otis Redding. Il modo a
volte quasi frenetico usato dagli Stones nel suonare questa musica nera urbana (si ascolti la loro versione di Muddy Waters,
‘Just Want to Make Love to You’ nel loro primo LP, The Rolling Stones), rivelava alcuni problemi che la traduzione comportava. Inizialmente non compensato da materiale di loro
produzione, l’“eccesso” che questa appropriazione musicale
implicava, in seguito reso molto meglio nella struttura delle
loro canzoni, faceva contrasto con l’“equilibrio” musicale sempre più accentuato dei Beatles.
53
La musica dei gruppi inglesi di R&B era considerata, secondo i
canoni attuali del pop, troppo estrema e non fu accolta facilmente come quella dei Beatles. L’abbigliamento di gran parte
di questi gruppi bianchi - capelli lunghi, abiti trasandati, un
aspetto molto “vissuto” e disordinato - fu interpretato come
manifestazione di sentimenti bohémien. Fu allora che la retorica di una cerchia fino a quel momento ristretta e il
suo malcontento sociale, morale e politico, cominciò a
penetrare nella cultura di massa. L’espressione di questa cerchia ristretta veniva ora trasferita su un più grande schermo,
dove i suoi effetti sarebbero stati amplificati. I media elettronici riproducevano il gesto individuale in migliaia di possibilità,
dilatandone il senso, stimolando processi imitativi ed estendendoli a dismisura, contribuendo così al consolidamento pubblico di uno stile deliberatamente anticonformista.8 Lo
sguardo provocatorio degli Who, colti dall’occhio di un fotografo, e le risposte a monosillabi di Mick Jagger e degli altri
Stones, quando si presentavano provocatoriamente al Juke
Box Jury confermavano queste legittime paure.
Lo sguardo rivolto su se stessi, l’immagine di indipendenza di
questi gruppi, apparentemente alimentati dalla loro aggressiva fedeltà al blues, avevano rapidamente incontrato i favore
dello spirito di rivolta maschile. Più esplicitamente, il sound
degli Stones, così indebitato nei confronti del blues, esibizionismo socialmente provocatorio e l’immagine pubblica di Mick
Jagger e Brian Jones segnarono un importante punto di rottura con le tradizioni che dominavano il pop e la musica leggera in generale, e tendevano a esprimersi riducendo l’ironia
del blues a una plateale esibizione di sessualità maschile.
Questa era l’essenza della provocazione musicale e culturale
rappresentata da un gruppo come i Rolling Stones, e in un
certo senso costituiva un ostacolo ancora maggiore per quelle
cantanti bianche che erano ansiose di abbandonare i ruoli sentimentali che il pop aveva loro attribuito da sempre. Soltanto
la voce soul di Dusty Springfield riuscì in qualche modo a sottrarsi a questa ulteriore emarginazione. Lulu, con ‘Shout’
(1964), ci riuscì solo grazie a una certa esuberanza giovanile,
ma fu poi assorbita nei canoni dello show business e della televisione. L’esibizione pubblica della sessualità femminile nel
mondo della musica era ancora circoscritta ai margini per lo
più oscuri di musiche come il jazz e il cabaret. Tuttavia,
quando si propagò l’effetto traumatico causato dalla vistosa
esibizione della sessualità maschile (per quanto frequentemente contaminata da segni contraddittori come i capelli
lunghi e gli abiti “effeminati”), le convenzioni di allora furono
un po’ dappertutto intaccate. Proponendo la musica come diretta estensione della sessualità fisica, il R&B bianco era divenuto un potenziale strumento di rivolta culturale. La traslazione del R&B e del soul nero nel pop bianco coinvolse perciò soprattutto nel caso degli Stones - un’esplicita strategia sessuale rivolta a smantellare quei vincoli sentimentali e romantici
che dominavano il mondo del pop e dell’industria discografica.
Il rifiuto dei riferimenti culturali di base della musica pop è
sempre stato il primo segno di ribellione. Così era stato per il
rock‘n’roll e così sarebbe stato per il punk. In tutti e tre i casi,
54
l’antisentimentalismo si accompagnava a pronunciate componenti di misoginia, e con gli Stones questo era particolarmente
evidente. I titoli delle loro canzoni sono in questo senso eloquenti: ‘The Last Time’ (L’ultima volta), ‘(I Can’t Get No) Satisfaction’ (Non posso provare piacere), ‘Get off My Cloud’ (Togliti di torno), ‘Under my Thumb’ (Alla mia mercé), ‘Stupid
Girl’ (Stupida ragazza). Se i Beatles avevano esordito sperimentando la tradizione della canzone popolare, mostrando
uno spirito di tono recriminatorio, nella musica e nei film, che
lasciava tuttavia spazio al sentimentalismo (‘Michelle’, ‘Yesterday’, ‘Eleanor Rigby’), gli Stones, nella migliore tradizione del
blues, biascicavano testi decisamente sgradevoli su ritmi nevrotici e su un sound stridente che non prevedeva alcun compromesso con la musica pop. Non mancavano le eccezioni,
come ‘As Tears Go by’, o ‘Ruby Tuesday’, ma erano assai rare.9
Con una posta in gioco potenzialmente così alta, la distinzione
fra Beatles e Rolling Stones - i due principali gruppi musicali
inglesi alla fine del 1963 - si trasformò in una vera battaglia
culturale combattuta da due schieramenti opposti. Si presentavano, come vedremo, anche altre importanti alternative, ma
questa rimaneva la scelta più significativa. La rapida adozione
del gruppo di Liverpool come simbolo vivente della sana, spensierata ed esuberante gioventù inglese, da parte della stampa
nazionale, dei genitori, del primo ministro Harold Wilson e
dell’establishment in generale, poteva significare solo una
cosa per molti giovani. La contraddittoria provocazione musicale e culturale rappresentata dagli Stones era destinata a tras-
formarli, prima in Inghilterra e poi negli Stati Uniti, nella metafora sonora della rivolta giovanile di quel decennio.
“TUTTI A BORDO... SUL TRENO DELLA NOTTE”
Ha preso la mia musica. Ma mi ha dato un nome.
Muddy Waters, a proposito di Mick Jagger
Il secco, onomatopeico, stridulo ritmo “choo-choo” è messo in
moto dagli ottoni, e James Brown, Soul Brother No. 1, è in viaggio, lanciato lungo i binari dell’America notturna: “Miami,
Florida... Atlanta, Georgia... Raleigh, North Carolina... il treno
della notte, il treno della notte”. Inciso da James Brown e dai
Famous Flames nel 1962, ‘Night Train’ faceva parte di una selezione di sound neri prodotta dallo stesso Brown, e da Solomon Burke, Marvin Gaye, Rufus Thomas, Martha and The
Vandellas, che echeggiava tutte le notti sulle piste da ballo dei
locali cittadini. La penuria di dischi ballabili nella Hit Parade
ufficiale, e di conseguenza alla radio, non solo diede l’opportunità a molti gruppi di riempire con la loro musica le sale da
ballo e i club locali, ma favorì anche una più stretta relazione
tra il pop inglese e la musica nera.
All’inizio il blues, il R&B e la musica soul contemporanea trovarono il loro primo pubblico nelle frange del folk e, in modo
più significativo, nei circuiti del jazz. Questi interessi musicali
erano spesso coltivati nei circoli anticonformisti degli studenti
55
d’arte, un’area, questa, che era particolarmente importante
nella conservazione dell’esotismo musicale del blues in Inghilterra, dopo il collasso del trad jazz.10 La guerra di fazioni che
agitò il mondo del jazz inglese nel decennio precedente (tra i
“tradizionalisti” di New Orleans e i “revivalisti” di Chicago),
per affermare la paternità dell’“autentica” musica nera si trasmise in quello spirito missionario con il quale i giovani bianchi seguivano ora il R&B. Verso la fine del 1963 le pagine delle
varie riviste musicali erano occupate dal dibattito sul R&B,
sulla sua vera natura e sulla questione se i bianchi erano in
grado di suonare il blues.
Nello stesso tempo, il successo di un gruppo come i Rolling
Stones, e la successiva estensione dei legami con la musica
soul, indirettamente stimolata dalla contemporanea nascita
negli States di case discografiche indipendenti (Tamia Motown, Atlantic, Stax, Volt) specializzate nella musica nera,
comportarono una riorganizzazione radicale sulla scena dei
club londinesi. I vecchi ritrovi jazz come il Marquee, il Flamingo e l’Eel-Pie Island ridussero drasticamente le loro serate
di jazz dal vivo, sostituendole con gruppi di R&B.
In una qualsiasi serata nel 1964, gli Yardbirds erano presenti
al Crawdaddy Club di Richmond; Georgie Fame e i Blue
Flames, Zoot Money, Chris Farlowe al Flamingo Club, Wardour Street; Graham Bond al Klooks Kleek; John Mayall al
Scene di Great Windmill Street. Il locale più importante di
Londra per i concerti dal vivo era comunque il Marquee Club,
trasferito dopo il 1963 al 90 di Wardour Street. Il Marquee
fece da trampolino di lancio per molti gruppi: promettendo un
minimo di celebrità e magari anche qualche gratificazione
commerciale, questo club rappresenta un richiamo per tutti
gli aspiranti gruppi inglesi. C’era anche il 100 Club, che una
volta, per ironia della sorte, era la sede del London Jazz Club.
Come discoteca, il 100 Club offriva anche un ambiente narcisistico, con boutique e specchi annessi, alla cultura mod
dell’ora di pranzo diventando “l’underground del mezzogiorno
londinese” (Wolfe 1972).
Sia il Marquee sia il Flamingo adottarono politiche musicali
assai rigide ed esclusive. Il Marquee era orientato verso il R&B
“puristà’ di Chicago (Muddy Waters, Howlin’ Wolf, Junior
Wells, Willie Dixon), mentre il Flamingo tendeva alla musica
urbana più contemporanea di Ray Charles, del primo soul e
della Tamia Motown.11 Nel 1964 tutti e due i club erano già arrivati a ospitare con regolarità le session di ska giamaicano
con Syko and The Caribs, gli Exotics e Mickey Finn. Questa esperienza musicale di tipo più esoterico non era circoscritta
solo a Soho. Le canzoni ska di Prince Buster come ‘Thirty
Pieces of Silver’ e ‘Madness’ fecero furore anche nelle sale da
ballo del sud londinese, assumendo decisiva importanza, insieme con lo stile di danza ska, più tardi trasformato nello
shake o nel jerk, nello sviluppo estetico del mondo esclusivo
dei mod.
Fu nei club, nelle notti fonde che diventavano alba, che si costruì progressivamente quella profonda interazione tra la musica afroamericana e la cultura di massa inglese. È in questo
momento che le radici fondamentalmente nere del rock‘n’roll,
quella misconosciuta eredità americana degli anni Quaranta e
56
Cinquanta, vengono assorbite direttamente e su sempre più
larga scala. La triade musicale di trad jazz/skiffile/folk music,
aveva fornito vari stimoli ai giovani inglesi, per spingerli al di
là delle più manifeste apparenze della musica popolare americana. Queste esperienze, talvolta isolate, ma poi incoraggiate
reciprocamente - dall’introduzione della chitarra blues nei
folk-club di Soho (Davey Graham, Bert Jansch) e attraverso le
frange del mondo del jazz, fino al pop - portarono a un’appropriazione irreversibile. Fu in particolare all’interno degli ambienti più anticonformisti, retaggio dei locali jazz, che si stabilirono inizialmente questi scambi musicali, ma i club e le discoteche, aperte da poco, offrivano sempre più possibilità simili.12
Altrove, fuori dalla capitale, i locali e le sale da ballo vigilate
più severamente, con scritte come “Vietato il jive e il
rock‘n’roll”, non erano altrettanto accomodanti.13 Ma la musica nera continuò ugualmente ad aumentare il proprio indice
di ascolto.
Verso la fine del 1963, con il successo dei Rolling Stones, degli
Animals e di altri gruppi R&B, il termine “rhythm and blues”
stava diventando ormai familiare e tendeva a integrarsi talmente nel sound e nello spirito del soul americano o dello ska
giamaicano - di quando in quando integrati da un nuovo
gruppo mod indigeno, come gli Who, o più tardi gli Small
Faces - che molti giovani bianchi avevano finalmente trovato
gli appigli sonori su cui appendere la loro selettiva e disinvolta
“coolness”. Ansioso di scoprire un’alternativa alle sbiadite
“americanate” proposte dal pop inglese dominante, il ben educato “negro tutto bianco della Soho notturna (...) che vive con
i ritmi della città” (Pere Meaden, in Barnes 1979, p. 14) fu irresistibilmente attirato dalle prospettive del soul e dello ska, due
generi di musica che offrivano simultaneamente una retorica
carica di simboli e un’immagine esclusiva.
Lo stile esclusivo dei jazzisti neri Charlie Parker, Thelonius
Monk e Miles Davis, che si aggiravano nelle notti newyorkesi
dei tardi anni Quaranta con berretti di lana, occhiali neri,
barbe caprine e giubbotti a doppio petto, offrendo un’immagine che era venerata dai bianchi bohémien o beat degli anni
Cinquanta, veniva ora trasferito su un altro ritmo. Una musica
“funky”, selvaggia, ispirata al blues e al gospel e preannunciata in modi diversi da Charlie Mingus, Bobby Timmons, Horace Silver, Cannonball Adderley, aveva lanciato i primi segnali
del cambiamento. Questo territorio musicale fu in seguito ulteriormente esplorato dal free jazz, la musica sperimentale di
John Coltrane, Ornette Coleman, Archie Shepp, Albert Ayler e
altri giovani jazzisti neri degli anni Sessanta. Ma fu soprattutto nella musica nera “popolare” che il fuoco del gospel e le
radici secolari del blues si intersecarono in modo clamoroso.
Il risultato fu la musica soul.
Cantanti come Ray Charles (‘I Gotta Woman’, 1955, ‘What’d l
Say’, 1959) e James Brown (‘Please, Please, Please’, 1956; ‘Try
Me’, 1958), introdussero le urla, gli strilli, i singhiozzi e i brontolii del cantante predicatore e dei testimoni. Il “coro” del gospel fu sostituito dagli ottoni, la “chiesa” dagli accordi a pedale
del piano o dell’organo. Il ciclo incessante del blues fu spezzato in brevi ritmi e frasi staccate, con un ritornello strumen57
tale che rispondeva alle implorazioni insinuanti e alla “predicazione laica” del cantante.
tavia una sintomatica quantità di impegno e attenzione,
quando si cerca di definire la loro controparte “bianca”.
Ma era nell’apparente accessibilità di questa musica, nella sua
evidente esaltazione e nei suoi ritmi di danza, che si nascondeva la sua vera natura. Le impennate verticali dei brontolii e
dei falsetti, gli strappi degli ottoni, il fervore religioso tradotto
in laica esaltazione musicale, tutto questo rappresentò un superamento della stoica rassegnazione del blues in direzione di
una sua affermazione attiva. La musica, come il cantante,
come la canzone, non era più controllata ma continuava a
evolversi consapevolmente. La musica soul era un sistema di
comunicazione autocontrollato tra i “fratelli” e le “sorelle” del
soul; la potenziale frammentazione delle sue componenti più
instabili era disciplinata e ordinata da quel processo di costruzione di un’identità nera, e dalla distillazione di questo lavoro risultò uno stile irreprimibile.14 Per quanto frenetico
fosse il ritmo, per quanto sfrenata la voce, la musica era patrimonio della “comunità soul”, era definitivamente “cool”.
Quello stretto rapporto tra il cantante e l’esperienza più ampia
del razzismo, la vita del ghetto e la discriminazione economica
e politica, sintetizzato ed esplicitato nel gergo del ghetto e
nell’adozione dei più recenti balli neri proposti negli spettacoli, voleva dire, per esempio, che un cantante come James
Brown rappresentava “il suo pubblico in generale” (Haralambos 1974, p. 106). “Tutto questo” come disse un disc jockey
nero “è il soul” (ibidem). “Coolness” e “soul” sono termini difficili da definire, e se sembrano così “naturali” negli atteggiamenti della persona di colore che vive in città, richiedono tut-
Lo ska, che fu altrettanto popolare nei club londinesi, in particolare nel Roaring Twenties Club di Carnaby Street, rappresentava una scelta ancora più esoterica, anche se aveva già un suo
pubblico rappresentato dalle comunità caraibiche di Londra.
Era conosciuto soprattutto come Blue Beat, dal nome della
casa di produzione che lo distribuiva in Inghilterra, e rappresentava un’appropriazione giamaicana del R&B nero americano. Fu in tal modo modificato con inflessioni giamaicane:
attraverso un pizzico di “mento” (la variante giamaicana del
calipso), un tocco di “Pocomanian” (un culto religioso fondamentalista), danze e ritmi percussivi. Nei primi anni Sessanta
era conosciuto in Inghilterra soprattutto attraverso i dischi di
Prince Buster e Laurei Aitken. Una vasta partecipazione da
parte del pubblico nero, in club quali il Flamingo, portò lo ska
e il suo stile di ballo all’attenzione dei “soul boys” bianchi.
Fu a Londra che gli Animals di Newcastle, lo Spencer Davis
Group di Birmingham, i Them di Belfast e altri innumerevoli
gruppi emigrarono tra il 1963 e il 1965. Le sedi delle case discografiche londinesi, ora attente ai nuovi sviluppi associati a
quell’invasione dal nord, diventarono naturalmente un punto
di riferimento cruciale. Ma ciò che aveva maggiore importanza immediata per la quotidiana sopravvivenza musicale era
il vasto ed eclettico circuito dei club londinesi (che stavano
conoscendo una rotazione senza precedenti dei gruppi musicali, grazie al successo del pop inglese che aumentava a livello
nazionale e internazionale), una vasta area di attrazione per i
58
giovani anticonformisti, che avevano adottato il blues ed erano anche legati all’ambiente delle scuole superiori, e infine
l’ostentata, fantasiosa adesione al R&B e al soul da parte della
sottocultura mod. L’aggregazione di questi elementi fece sì
che Londra diventasse nuovamente il centro della musica pop
inglese e, per un breve periodo, anche di quella del resto del
mondo industriale.
DAI MODERNISTI AL CICLO DELLA MODA
Le strade di Londra si dichiarano massicciamente contro l’establishment ogni sabato sera.
Pete Townshend, 1965
La vita è sicuramente il più bel film, se si riesce a vederla
come un film.
Colin MacInnes, Absolute Beginners
Ready Steady Go! (“Il weekend inizia qui”), il programma televisivo dedicato alla musica pop ogni venerdì sera iniziò le trasmissioni nell’agosto del 1963. Tra questo e le altre versioni del
pop televisivo come Juke Box Jury, Thank Your Lucky Stars
c’era ovviamente un abisso. Ready Steady Go! si presentava
come un club popolato da teenager vestiti in modo appropriato che ballavano la musica alla moda. Era presentato da
un’ansimante Cathy MacGowan, il cui entusiasmo per i gruppi
ospitati nel programmala rivelava come un’autentica fan. Il sapore della “diretta” di questo programma, il suo apparente
amalgama di spontaneità e stile, ne fece l’appuntamento settimanale della cultura pop inglese.15 Era possibile vedere
suonare non solo gli Stones, gli Animals, gli Who e i Kinks, ma
anche i loro progenitori musicali e culturali, spesso poco
conosciuti e sicuramente mai comparsi in televisione, come
John Lee Hooker, Solomon Burke, James Brown. Quando fu
annunciato che si cercavano nuovi ballerini da aggiungere a
quelli selezionati con cura ogni venerdì pomeriggio, gli aspiranti giovani modernisti accorsero cosa numerosi da scatenare un vero putiferio negli studi di Wembly. Soprannominato la “Mecca dei mod”, RSG! sembrava l’unico programma
televisivo che sentisse il polso della situazione in un’importante settore della gioventù inglese. Il grigiore del mondo
adulto, che così chiaramente controllava Juke Box Jury, fu
temporaneamente accantonato dall’imposizione di gusti giovanili, come le scenografie Pop Art, una tecnica più immediata
nella ripresa televisiva, le esibizioni sfrenate di ballerini scatenati.
Per quella massa selezionata che erano i mod, RSG! fu una
passerella della sottocultura da loro proposta, quanto della
moda di Carnaby Street e della pubblicità delle “camicie mod”
pubblicata sul “New Musical Express”. Ma cos’altro c’era per
coloro che non potevano andare al 100 Club all’ora di pranzo,
o al Marquee ogni mercoledì e al Flamingo la domenica? Gli
aspiranti mod che erano tagliati fuori geograficamente dalla
scena della grande città e non avevano le pillole di anfe59
tamina, né le energie né la compagnia adatta per trasformare
“Welwyn Garden City (...) in Piccadilly Circus” (Hebdige
1976, p. 90), per i quali era un sogno irrealizzabile persino la
possibilità materiale più a portata di mano, quell’icona mod
che era lo scooter, potevano ancora lottare per trovare i loro
simbolici legami. Da RSG! essi ricavavano l’immagine del
mitico mondo del mod metropolitano, così come il programma si ispirava a sua volta ai giovani londinesi che dettavano legge nello stile.16
La musica dei mod era rigidamente nera come ispirazione:
rhythm & blues, il soul delle origini, i dischi della Tamia e lo
ska giamaicano. Erano questi i ritmi sincronizzati con i passi
del block, dello ska e di altri balli alla moda che si alternavano
con scadenza settimanale. Quando non erano programmati da
un disc jockey, nelle discoteche che stavano allora aprendo,
come La Discothèque in Wardour Street, i sound selezionati di
James Brown, dei Miracles, di Prince Buster, di Mary Wells,
di John Lee Hooker, venivano riproposti da Georgie Fame and
the Blue Flames, da Chris Farlowe and the Thunderbirds, da
Long John Baldry and the Hoochie Coochie Men, da Ronnie
Jones and the Night Timers. Non molto tempo più tardi fu proposto un sound più tipicamente londinese, influenzato anch’esso dal R&B e dal soul originario. Gli Who furono probabilmente il gruppo che più si avvicinava allo spirito mod. Il loro
primo disco, registrato quando si chiamavano ancora High
Numbers, si intitolava opportunamente ‘I’m the Face’,
facendo riferimento a un termine, “faccia”, che connota la cultura mod. La musica era nell’insieme più spigolosa e nervosa,
più chiaramente bianca e inglese di quella di tutti i primi
gruppi inglesi di R&B. Gli accordi di chitarra stoppati di Pete
Townshend, la batteria ossessiva di Keith Moon, e la voce
tremolante di Roger Daltrey, consapevolmente o per semplice
assonanza, coglievano alla perfezione il clima dell’“anfetaminizzata” vita notturna londinese che alimentava la mitologia
mod, in una serie di veri e propri inni come ‘My Generation’,
‘Can’t Explain’, ‘Anyhow Anywhere’.
Tuttavia, mentre il gusto musicale dei mod spesso serviva a introdurre nuovi stili, per quanto riguardava l’abbigliamento
esso aveva sostanzialmente una funzione stabilizzante. Uno
stile d’abbigliamento cosmopolita, come sostiene Colin MacInnes (1959, 1961), era gin diffuso alcuni anni prima dell’apparizione ufficiale di uno stile mod chiaramente identificabile.
Questi primi “modernisti” o “stilisti” erano di estrazione operaia e prevalentemente maschi, ossessionati dall’abbigliamento e in particolare dall’“adattamento anglicizzato degli
stili dell’Europa continentale (in particolare, quello francese e
quello italiano) e dell’America” (MacInnes 1961, p. 153).17
L’ambito geografico dei mod, come si conviene alla loro appariscente e fluttuante mitologia, non è altrettanto chiaro. Secondo molte ricostruzioni, questa moda ebbe inizio a Stepney,
nell’East londinese, oppure nelle zone di Shepherds Bush del
West London. Fu tra l’estate e l’autunno del 1963 che un distintivo stile mod si diffuse rapidamente nelle metropoli.
Un comune modo di vestirsi, l’abitudine di frequentare particolari club e luoghi di ritrovo, l’acquisto di certi dischi: tutte
queste caratteristiche facevano parte di un’unica entità inscin60
dibile, di un mondo all’interno di un mondo. Ballare al ritmo
persistente del R&B, del soul e dello ska neri, fare la spola tra
il sarto e il negozio di dischi a bordo di scooter italiani e imbottirsi di anfetamine (chiamate “Purple Hearts”, “Trench Blues”,
o “dexedrine”) questa frenetica attività, che fosse reale o no,
dilatava i weekend e le notti dei mod fino a quel punto immaginario in cui prendeva forma la “realtà” senza tempo di uno
stile perpetuo. Nella realtà congelata della mitologia, il cappello “blue beat” portato esattamente in quella data posizione,
la giacca con tre bottoni e due spacchi e i pantaloni a zampa
d’elefante, insieme con gli scarponcini di finto coccodrillo con
la punta rotonda, rimasero fissati per sempre, immortalati e
immuni dalle monotone ore di lavoro o di studio trascorse
sotto il controllo degli adulti.18
Anche se si nutrivano dubbi sui cosiddetti benefici della “società opulenta”, e in certi ambienti addirittura sulla sua reale
esistenza, la sua iconografia pubblica dilagava ovunque. La
televisione, il cinema, la pubblicità e la stampa continuavano a
esibire un luccicante collage di immagini di grande successo
commerciale: James Bond e le boutique di Carnaby Street, le
bianche Jaguar modello E, i programmi televisivi “The Avengers” e “The Man From UNCLE”, il modello di giovani e intraprendenti imprenditori, i supplementi domenicali a colori,
tutto ciò confermava autorevolmente che il potere dell’“opulenza” era ben lontano dall’essere esaurito.
Nessuno se ne rendeva conto meglio dei mod. Spesso legati a
lavori umili, costretti a pagare a rate i loro vestiti e i loro
scooter, quando l’avevano, essi nondimeno fecero del “con-
sumo frenetico” (Richard Barnes) la ragione più cospicua del
loro modo di vivere, che acquistava una dimensione ulteriore,
insospettata, nell’ossessiva impronta del loro stile fondato sul
flusso del consumismo, mentre reinterpretavano a loro immagine le superfici dei suoni, dell’abbigliamento e dei mezzi
di trasporto. Crearono se stessi come mod, conducendo la loro
vita nel più pubblico dei teatri, il mercato delle merci, autoproclamandosi “artisti” o “attori”. Il mondo degli adulti era escluso non tanto da una moda che era un “pugno nell’occhio”
(Tom Wolfe), quanto dall’esagerata cura della loro persona e
da un consumismo che gli adulti comprendevano solo confusamente, sospeso com’era ai margini della parodia’.19 Il riconoscibile bric-à-brac dell’“opulenza” basato sulla moda continentale, su dischi, locali pubblici e scooter, evidenziato da
segnali segreti (dovevano essere due gli spacchi nella giacca, il
locale doveva essere The Scene a Soho, la musica il soul americano e lo ska giamaicano, la moto una Lambretta TV 175 personalizzata) fu trasformato nell’imperscrutabile immagine del
mod. Alla fine, però, questa stilizzata “arroganza giovanile” divenne eccessiva, essendo stata costruita su suggestioni di seconda mano. La manifesta devozione nei confronti del continente e di un’America mitizzata, che raggiungeva il suo aspetto più evidente nell’estrema “differenza” dell’atteggiamento “cool” dei neri, coinvolse il mod in una battaglia perdente.
La magica “diversità” dello stile nero urbano, perfettamente
tradotta nel sound dello ska e del soul, aveva offerto ai mod
una realtà tangibile, ma “proibita”. Ma questa affermazione
61
radicalmente simbolica da parte di una frangia di giovani bianchi della classe operaia in fondo sottintendeva una distanza
culturale che nessuna dose di anfetamina avrebbe mai potuto
colmare.20 L’eccessiva attenzione che il mod dedicava a questo
sforzo stilistico poteva portare solamente alla cristallizzazione
finale dell’aspetto narcisistico. Perduto nello specchio e perseguendo una «diversità» che non sarebbe mai potuta essere
sua, la cui esperienza egli poteva a stento comprendere, il mod
minacciava di diventare una vacua icona della moda.
Nel 1964 i mod erano balzati alla ribalta dell’opinione pubblica per una serie di battaglie che avevano ingaggiato durante
i giorni festivi sulle spiagge di Margate e di Brighton con opposti gruppi di rocker (una variante motociclistica dei primi
teddy boy).21 Nel loro simbolico gioco contro le costrizioni del
tempo e del luogo, i mod erano portati a vedere nei rocker, imbalsamati nella loro brillantina e negli abiti di pelle così nostalgicamente associati a un altro decennio, una simbolica provocazione al loro stesso senso del possibile. Quando infine il momento dei mod cominciò a passare, un’alternativa fu quella di
riconoscere ancora più vividamente i limiti della realtà quotidiana. Questo fu il percorso che, attraverso il guardaroba
“proletario” (stivali e bretelle, capelli quasi rasati) dello stile
“hard mod”, arrivò fino allo skinhead. Un’altra possibilità,
adottata a sua volta dai seguaci metropolitani di questa moda
consisteva nell’insistere ancora di più sulla via dell’immaginazione, rifuggendo dall’anfetamina, dalla musica soul e dalla
sua rumorosa relazione con il quotidiano, a favore della “realtà” ancora più esclusiva dell’LSD e del “viaggio” nella musica
psichedelica.22 Naturalmente, non mancavano anche le più
probabili conclusioni fatte di confusi compromessi: lavoro
fisso, responsabilità, una famiglia.
Ma per un breve periodo (1964-1966) quel diffondersi di tensioni produttive, così nettamente delineate dallo stile mod, divenne il fulcro di una configurazione culturale ben più ampia,
tale da imprimere sinteticamente l’immagine del suo clamoroso successo sulla pop music inglese: la “swinging London”.
L’esaltazione del narcisismo maschile compiuta dai mod lasciò una complessa eredità alla cultura pop inglese, verso la
metà degli anni Sessanta. Lo stile dei mod, codificato e santificato dall’ossessione maschilista, parlava “con l’accento del suo
sesso” (McRobbie 1980). Il maschio che si esibiva in pubblico
non costituiva certo una novità, ma ora le dimensioni e gli effetti di tale gesto sembravano oltrepassare le codificazioni più
tradizionali, in particolare proprie della classe operaia, della
sessualità maschile. Il fatto che Mick Jagger potesse lanciare
“una nuova visione della bellezza maschile” (Cohn 1970), arrivando a diventare una “star senza connotazioni di classe, androgina e infine sociale” (Hoskyns 1982), rappresentava una
notevole estensione in quella che era allora l’immagine pubblica del “virile” e della mascolinità.
Il profilo generalmente più indistinto della ragazza mod, in
contrasto col il suo ragazzo ben vestito e con la sua più diffusa
rivale, la “dolly” (bambola), rimase un po’ indietro rispetto
alle più precise definizioni maschili. Tuttavia, la tradizionale
posizione statica della donna, nel panorama dello stile pub62
blico, iniziò a manifestare qualche segno di movimento. Le ragazze mod mescolavano i loro stili, e l’apparizione contraddittoria della minigonna (per richiamare lo sguardo del maschio,
per il piacere dell’affermazione femminile?), insieme con la
nuova valorizzazione della figura femminile come modella,
con Jean Shrimpton e Twiggy, faceva presagire un mutamento
nella produzione sociale della sessualità femminile. Se la musica pop rimaneva per il momento refrattaria a questo nuovo
protagonismo femminile, il successo commerciale della moda
mod di Mary Quant, di Biba e delle innumerevoli boutique di
Londra e della provincia, introdusse quanto meno un nuovo
aspetto nel riconoscimento pubblico delf ”io” femminile.23
La scelta di particolari generi di vestiario, di cosmetici, riviste
e acconciature, anche se era spesso meno complicata rispetto
all’esigente programma di consumo dei mod maschi, rappresentò comunque una possibile edificazione sociale di un’effettiva relazione immaginaria con la vita quotidiana, in questo
caso attraverso un’accresciuta insistenza sulla produzione attiva di sessualità femminile. Come ha sottolineato Janice Winship, fu nella produzione di beni di consumo enormemente allargata degli anni Cinquanta e Sessanta che la sessualità femminile “determina le ragioni di quel tipo di consumo che è costruito e stimolato da quel consumo stesso (Winship 1981,
p.23). Questo contradditorio “ampliamento” delle merci,
verso il riconoscimento del femminile, insieme con la diffusione di forme più efficaci di contraccettivi “apri più seriamente la possibilità di incorporare fattiva sessualità delle
donne, anche se definita da un punto di vista maschile, nel rep-
ertorio degli argomenti dibattuti pubblicamente” (Weeks
1981, p. 260).24
La conseguente “erotizzazione della cultura moderna” di impronta maschile (Weeks) ci richiama alla superficiale metafora della “swinging London”, alle mode “stravaganti” e ai rapporti tra pop, cultura di massa e all’emergente tema del “permissivismo”. Entro il 1966 la sempre maggiore raffinatezza
compositiva dei Beatles (testimoniata negli album Rubber
Soul e Revolver) aveva fatto del pop l’oggetto di attenti commenti sulla stampa. Mentre certi giornali della domenica e i
loro supplementi a colori indulgevano in iperboli, le pop star
riempivano però i giornali popolari con le loro facce e le loro
“avventure”, allorché uscivano dai confini ristretti, antiquati e
indesiderati del banale show business per entrare nella frenetica attività sociale di quello che era in quel momento il temporaneo centro mondiale della moda.
Nel fugace turbinio della “swinging London”, fra i bistrot e le
boutique appena aperte, fra i Mini-Mokes e le minigonne che
sfidavano il clima di austerità inglese, avvenivano incontri inattesi ma non casuali. In un locale di Soho, l’Ad Lib, di fronte
all’enorme vetrata che guarda sul centro di Londra, i reduci
delle scuole d’arte dispersi tra gruppi pop, disegnatori di
moda, pittori, si incontravano con quelli che più semplicemente avevano fatto fortuna: divi del cinema, come Terence
Stamp e Michael Caine, fotografi come David Bailey e Terence
Donovan, che celebravano insieme la conquista della capitale.
Gli interessi esclusivi dell’ambiente “artistico” e dell’ambiente
mod si stavano ora estendendo in un prosaico miscuglio di mu63
sica, moda e arti visive. Il gesto dell’artista Pop americano Jasper Johns, che esponeva dipinti di bandiere nelle gallerie
d’arte, fu tradotto nell’effetto pubblicitario di una giacca ispirata alla Union Jack appesa sulle spalle ossute di Pete
Townshend degli Who. Le vecchie gerarchie di valori furono
sconvolte e disgregate dalle immagini prese dalla vita quotidiana. L’“arte” fu assorbita entro i linguaggi profani dei mass
media. Le insegne da barbiere di Derek Boshier e i bersagli di
Peter Blake fornivano la scenografia settimanale di Ready
Steady Go! La lezione della Pop Art, secondo cui il “sintetico”
e 1 “artificiale” sono reali e hanno un proprio valore, iniziava a
penetrare nella cultura di massa e nella musica pop (un momento colto acutamente nel peana degli Who alle interscambiabili potenzialità della “plastica”, in ‘Substitute’).
Ma la crescente mondanità del pop inglese, i primi sintomi di
una frattura indotta dal successo, in Inghilterra e sempre più
diffusamente negli Stati Uniti, e gli accenni di una realtà più
cupa, segnata dalla droga, dalla decadenza e dalla crisi, insinuarono anche l’esistenza di una colpevole relazione fra la prosperità pubblica e i segnali di un collasso morale e sociale.25
Quando lo stile non sostituì più i conflitti generazionali ma li
mise soltanto in evidenza, quando gli spiriti giovanili apparentemente passarono all’abuso morale e al disprezzo esplicito
per i vecchi valori, quando si diffusero troppo tempo libero e
denaro, e quando una preoccupante sensazione di noia si insinuò attraverso i pori della società inglese, la metafora politica del “permissivismo” iniziò ad acquistare un profilo più
marcato.
Una anticipazione in chiave cospiratoria del crescente declino
morale era gin stata prefigurata dall’affare Vassal del 1962: un
processo di spionaggio avvolto in una situazione di ricatto
omosessuale. L’anno seguente, un melodramma composto da
ragazze squillo, da un diplomatico sovietico, da un osteologo,
dal ministro della Difesa John Profumo, da un racket immobiliare, in un ambiente di ville di campagna, fu allestito in uno
scandalo pubblico che fece crollare il governo conservatore di
Macmillan. Questa drammatica denuncia della scarsa moralità della vita pubblica, e di ciò che sembrava la controproducente “liberalizzazione” legislativa in materie così delicate
quali la prostituzione e l’omosessualità, iniziò a fermentare in
un flusso profondo di reazione. Erano molti quelli che si sentivano estranei allo spirito della riforma liberale e che cominciavano a esprimere l’opinione che i costi negativi dell’“opulenza”
stavano diventando un prezzo troppo alto da pagare.
Il rapporto fra questi temi e il mondo apparentemente
“frivolo” della musica pop e della vita notturna londinese non
era ancora completamente chiaro. Ma l’insediamento sul
trono del pop inglese di un gruppo anticonformista come i
Rolling Stones, i cui più celebri membri dovevano la loro popolarità a un deliberato comportamento provocatorio, stava a significare che il pop sarebbe stato sempre più probabilmente incluso tra le possibili cause di un panico morale. Fu necessaria
un’ulteriore svolta nella scena culturale prima che quella sacrilega alleanza tra pop, polarizzazione pubblica e collasso morale si configurasse infine in una minaccia riconoscibile. Al-
64
lora, e solo allora, quelli che erano i “matti chiassosi” di ieri si
sarebbero trasformati nei “demoni della folla” di domani.
5 E, anche, naturalmente, nell’intero discorso del design industriale.
Cfr. Hebdige 1981, pp. 48-50.
6 L’“Observer” e il “Sunday Telegraph” lanciarono i loro supplementi
settimanali a colori nell’autunno del 1964.
NOTE
1 II twist, ricavato da schemi di danza nera, fu insegnato alla gioventù
americana da Chubby Checker dagli studi di American Bandstand a
Philadelphia. Sotto (occhio vigile di Dick Clark, il maestro di cerimonie
di questo spettacolo televisivo trasmesso in tutta l’America, questo
ballo, malgrado il dimenare dei fondischiena e lo stantuffare delle anche, in breve tempo divenne stranamente asessuato, ed esuberante piuttosto che lascivo.
2 Presentata da Brian Mathew, la trasmissione Thank Your Lucky
Stars era certo consapevole della logica commerciale di fondo della musica pop, ma in una forma meno accondiscendente rispetto a Juke Box
Jury. Una breve parte dello spettacolo veniva regolarmente affidata a
una giuria, che era però palesemente formata dal giovane pubblico presente in studio. I dischi non erano mai semplicemente un “successo” o
un “fiasco”, ma veniva loro assegnato un punteggio motivato da frasi
tipo “Mi piace”, “Va bene per ballare”. A parte questo evidente taglio
giovanile, il TYLS era uno spettacolo di musica. Gruppi e cantanti
suonavano (o meglio mimavano) e la canzone veniva ascoltata interamente, non solo un accenno.
3 Un’indicazione significativa della situazione é che la rivista “New Musical Express”, decisamente orientata verso la musica pop cominciò
solo nel luglio del 1964 a riportare una classifica degli LP
4 L’idea dell’incisione a “due piste”, anziché essere considerata come
un mezzo per estendere le possibilità sonore, era ancora largamente
considerata uno stratagemma per mascherare i difetti e nascondere l’inesperienza (“New Musical Express”, 26 February 1965).
7 È importante l’osservazione di Colin Fletcher sulla trasformazione
delle bande giovanili di Liverpool in potenziali gruppi beat alla fine degli anni Cinquanta e all’inizio del decennio successivo (Wheen 1982, p.
20). Fletcher sottolinea come la musica divenne un nuovo “totem” per
la cultura di strada giovanile, con la conseguente trasformazione degli
scontri di quartieri in lotta per una nuova gestione del tempo libero, occupando le sale da ballo con i loro corpi e con la loro musica, e stimolando l’apertura di nuovi locali per giovani.
8 La diffusione tollerata dell’“anticonformismo” rivelò una circolazione
a doppio senso con conseguenze impreviste. In una direzione essa arrivò a legittimare aspetti della cultura di massa che acquistavano nuovamente importanza, soprattutto il mondo della musica pop, fatto di vesti
sgargianti, di droga e di sesso. Nella direzione opposta essa apri alcuni
aspetti della cultura tradizionale (la cultura con la C maiuscola) alle
contaminazioni popolari. Molto di tutto questo può essere semplicemente un esempio di ciò che Tom Wolfe preferisce definire “radicai
chic”. Ma gli effetti a lunga scadenza di tale interscambio nelle veloci e
ludiche traiettorie della vita urbana possono scoprire orizzonti insospettati. Per il momento può essere sufficiente una osservazione recente di
Jon Savage: “Se Andy Warhol portò con sé nei quartieri alti ragazzi intrippati di acido, travestiti e prostitute, allora i Rolling Stones portarono la tradizione anticonformista e spontaneista che avevano assimilato nei jazz club a un pubblico giovanile di massa le cui dimensioni e
la cui immediatezza erano fino ad allora sconosciute e impensate” (Savage 1982).
9 II trauma ambiguo generato dalla musica dei Rolling Stones è colto
in un dibattito del 1968 tra Alan Beckett e Richard Merton. Beckett sostiene che, sebbene non fossero “grandi innovatori”, la fortunata adozi65
one del “narcisismo erotico” del blues nella loro musica, permise ai
Rolling Stones di rompere con il languido intimismo del romanticismo
sentimentale (Beckett 1968). Merton replica dicendo che è esattamente
questo il motivo per cui i Rolling Stones sono un gruppo decisamente
innovatore nel pop. Gli Stones hanno rivelato un tabù centrale - la disuguaglianza sessuale - e lo hanno fatto nel modo più radicale e inaccettabile: esaltandolo (Merton 1968, p. 30).
10 Un elenco di musicisti pop inglesi di questo periodo associati con le
Art Schools includerebbe Keith Richards, John Lennon, Pete
Townshend, Ray Davies e Eric Clapton.
11 II long-playing dal vivo Rhythm and Blues at the Flamingo (1964) di
George Fame dà una buona idea della musica suonata in un club del
genere: ‘Night Train’ di James Brown, ‘Shop Around’ dei Miracles,
‘Humpty Dumpty’ di Prince Buster e classici del rhythm and blues
quali ‘Baby Please Don’t Go’ e ‘Let The Good Times Roll’.
12 È difficile dire in quale misura il breve periodo delle radio-pirata
contribuì a create questa situazione. Certamente le emittenti pirata offrivano una gamma più vasta e intelligente di musica pop, molto più
vicina alla realtà dei club londinesi di quanto faceva la BBC.
13 Questa affermazione è riportata in Melly 1970. Cfr. anche Mungham
1976 circa le restrizioni culturali delle sale da ballo di provincia.
14 In una delle sue canzoni ‘There mas a Time’ (1967), James Brown
annuncia alla lettera che sta “facendo il James Brown”.
15 Il 2 aprile 1965, dopo che il sindacato musicisti pose fine al play
back in televisione, RSG andò in onda dal vivo. Ciò non costituì una difficoltà, ma suggerl semplicemente un’opportuna enfatizzazione dello
spirito del programma.
16 George Melly fa un’interessante osservazione circa l’effetto provocato dal pop televisivo sulla moda giovanile a livello nazionale:
“Quando viaggiavo negli anni Cinquanta, le mode impiegavano moltissimo tempo per diffondersi. Perfino nei grandi centri di provincia come
Liverpool e Manchester erano indietro almeno di’ sei mesi, mentre
nelle piccole comunità minerarie dello Yorkshire era ancora possibile
fino al 1960 trovare abiti da teddy boy e non solo questi. Erano confezionati in tessuti color rosso rubino o nel verde dei tavoli da biliardo. Per
quanto riguarda i confini estremi della Scozia, gli abiti femminili non
erano praticamente cambiati dalla meta degli anni Trenta. RSG cambiò
tutto questo, allargò i confini del pop su scala veramente nazionale”
(Melly 1972, p. 170).
17 Nel febbraio 1963 Maureen Cleave rilevò sull’“Evening Standard”
uno “stile continentale” nelle acconciature dei Beatles, un taglio di
“stile francese” adottato mentre si trovavano in Germania, che sostituì i
ciuffi stile rock’n’roll.
18 Questa descrizione del guardaroba mod, 1963-1964 circa, è contenuta in Hamblett-Deverson 1964. Cfr. anche il film degli Who Quadrophenia (1979), per trovare un’accurata descrizione del panorama
dell’abbigliamento nel 1964.
19 “Quando Jerry Rubin e Abbie Hoffman fecero la loro apparizione al
Dick Cavett Show con il corpo dipinto, forse un limite estremo era stato
raggiunto. Ma andare nella direzione opposta e portare all’estremo le
formalità può diventare scandaloso e la gente ne rimane confusa. Pensano: sì, quello indossa giacca e cravatta, ma non riescono a capire ciò
che vi è di trasgressivo in questo atteggiamento” (Wolfe 1982).
20 Per un’analisi estremamente acuta e affascinante della tentata appropriazione di questa “realtà” nera da parte delle sottoculture
maschili bianche in Gran Bretagna, cfr. Hebdige 1979, pp. 46-70. Nel
caso dei mod si dovrebbe rilevare che il loro stile mondano costituiva
qualcosa di più che una relazione casuale con l’altra comunità emarginata, quella dei bassifondi criminali di Londra.
66
21 Un importante studio su questo scontro si può trovare in Cohen
1973.
22 Mentre le anfetamine tendono a intensificare il rapporto con la realtà, producendo una sorta di “iperrealtà”, l’LSD distorce e rielabora il
referente originale (“la realtà”), spesso fino al punto di cancellarlo e di
imporre un ordine alternativo di sensazioni.
23 Le classiche responsabilità sociali della donna come moglie e come
madre, che erano state costantemente sottolineate da riviste quali
“Woman” e “Woman’s Own” negli anni Cinquanta, erano ora integrate
della divulgazione dell’individualità e del piacere femminile in riviste
più recenti come “Honey” e “Cosmopolitan”. Cfr. l’importante analisi di
Janice Winship circa questo cambiamento (Winship 1980).
24 Janice Winship ha sottolineato l’importanza potenziale benché contradditoria dell’intervento femminile attivo nel mondo dei beni di consumo. “Mentre le merci hanno invaso la sfera privata, esse hanno anche reso pubblica quella stessa sfera (...) in modo tale che almeno per
alcuni versi la costruzione ‘maschile’ della femminilità può essere rinfacciata agli uomini da parte delle donne stesse: dimostrando che si
tratta appunto di una costruzione maschile” (Winship 1981, p. 29).
25 Naturalmente sono i Rolling Stones a fornite il paradigma del momento. Si ascolti ‘Play with Fire’, ‘19th Nervous Breakdown’, ‘Paint It
Black’, ‘Have You Seen Your Mother Baby’. Un’altra prospettiva è
quella indicata dal regista italiano Michelangelo Antonioni. Il suo film
Blow Up (1966), che narra la vicenda di un giovane fotografo di moda
che si imbatte involontariamente sulle tracce di un delitto, ruota finemente attorno a quelle traiettorie schizoidi sospese fra le abbaglianti
superfici della “swinging London” e l’ostentata frivolezza dei suoi passatempi alla moda.
67
C HAPTER 4
Il sogno
esplode
1966-1971
La gente che parla di rivoluzione e di lotta di classe senza alcun riferimento esplicito alla vita quotidiana, senza capire che cosa c’è di sovversivo nell’amore e di positivo nel rifiuto delle costrizioni, questa gente
ha in bocca un cadavere.
Comité Enragés. L’Internazionale situazionista
dispersa in mezzo a vicende culturali poco conosciute. Questo
argomento sarà comunque trattato a parte in un capitolo successivo. Per il momento ci troviamo di fronte a vicende separate, culture differenti, musiche particolari.
Una volta considerato semplicemente come una rozza manifestazione di giovani di estrazione operaia che tiravano tardi nei
bar alle prese con sgargianti juke-boxes, verso la fine degli
anni Sessanta, il pop doveva diffondersi anche nelle eleganti
abitazioni dei quartieri residenziali attraverso le trasmissioni
di “BBC 2”. Mentre l’opinione pubblica, nella seconda metà
del decennio, era spesso interessata alla funzione di rottura
che la musica svolgeva tra le inquietanti manifestazioni della
“rivolta giovanile”, il pop veniva anche assorbito gradualmente in alcuni aspetti della cultura ufficiale, o in altre parole
“rispettabile”. Un anticonformismo, dapprima associato con il
mondo crespuscolare del beat e del jazz (capelli lunghi per gli
uomini, promiscuità sessuale, vestiti stravaganti, “erba” da fumare) fu tradotto nello stile “radicai chic” di una musica per
persone “pensanti”.
Questa importante svolta del pop inglese e americano, che va
sotto l’etichetta di rock progressivo, incise profondamente nel
pop, separando il rock da tutto il resto. Gli effetti di questa operazione si sarebbero protratti per buona parte del decennio. I
principali sintomi di questa nuova fase erano, da un lato, la
crescente sofisticazione del pop inglese, per lo più evidenziata
in una serie di LP dei Beatles (Rubber Soul, Revolver, Sergeant Pepper), ma fondamentalmente alimentata dall’“underground” londinese. L’altro aspetto, altrettanto importante, fu
la profonda influenza esercitata da Bob Dylan e dalla musica
rock della West Coast. Il generale mutamento di tono fu manifestato esplicitamente attraverso i modelli di uno stile di vita
alternativo “controculturale”, e più precisamente rappresentato dall’utopistica figura dell’hippy. Come vedremo, i tratti peculiarmente inglesi non scomparvero, ma questa evoluzione
ha un sapore e uri ispirazione fondamentalmente americane.
Parallelamente a questi sviluppi, le contratte ed eterogenee energie del primo beat e del R&B iniziarono a percorrere strade
diverse. Entro il 1970 si erano costituiti diversi tipi di pubblico
ben distinti e spesso ermeticamente impenetrabili fra loro. La
prova più evidente di questo cambiamento fu lo scioglimento
di quello che un tempo era un rapporto cruciale fra il pop bianco e le varie forme di musica afroamericana. La musica nera
fu esiliata nelle estreme propaggini del rock bianco, dove andò
ORIZZONTI AMERICANI
Dopo un intervallo di tre anni, segnato dal primato del beat inglese, il centro di gravità culturale del pop ritorna palesemente negli Stati Uniti. In Inghilterra continuavano a emerg69
ere nuovi gruppi (Spencer Davis, Small Faces, Move) e gli esperimenti dell’underground londinese rappresentavano significativi passi avanti, ma le “voci” inglesi erano ora coinvolte sempre più in una spettacolarità di ispirazione americana. La California era diventata il centro di formazione delle nuove energie del pop americano: in particolare la “surf music” di Jan &
Dean e dei Beach Boys. Successivamente trasformata in un Eldorado pubblicizzato dal vistoso stile di vita degli hippy, la
California - nell’occupare uno spazio mitico nell’immaginazione europea - divenne il polo intorno al quale iniziò a ruotare
una fetta consistente del pop inglese. Dopo il 1964, il successo
internazionale dei gruppi inglesi, le promesse della cultura
americana e il denaro, incoraggiarono uno spostamento culturale verso ovest.1 Nel frattempo il pop americano, stimolato
dalla cosiddetta “British Invasion” a ricercare le proprie radici
musicali, si imbarca nell’impresa, proclamata orgogliosamente nel titolo di un album di Bob Dylan, di “riportare
tutto quanto a casa” (Bringing It All Back Home).
È, sempre sorprendente la misura in cui una singola voce riesce in un momento particolare a riassumere la complessità di
un mutamento musicale. E tuttavia è questo che è successo
nel caso di quella costellazione musicale che così chiaramente
orbita attorno al tono, al timbro e all’enunciazione vocale di
Elvis Presley verso la metà degli anni Cinquanta e a quella di
Mick Jagger dopo meno di dieci anni. Per Dylan si può dire altrettanto. L’ingresso di Dylan nella Hit Parade inglese del
1965, con la profetica ‘The Times They Are A-Changin’ fu un
evento sensazionale. Una monotona voce nasale, modellata
sullo stile del canto rurale della musica folk americana, con in
più qualche accenno di blues, associata a canzoni dai testi assai espliciti, produsse una miscela corrosiva. A confronto con
il pop commerciale e le sue derivazioni afroamericane del beat
inglese, questo era un sound decisamente diverso. Sostenuto
da una chitarra appena strimpellata e da un’esile armonica a
bocca, lo stile vocale di Dylan, quasi recitato, metteva in evidenza il contenuto lirico della canzone. Il registro nasale della
sua voce e il “messaggio” veicolato dai suoi testi, cattura la nostra attenzione in maniera molto diversa, pur con pari intensità, dai versi di ‘Satisfaction’ degli Stones (1965).
La struttura di The Times They Are A-Changin’ è presa a prestito dalla tradizione folk angloamericana, ma i suoi toni biblici
e le sue metafore apocalittiche determinano alla fine un distacco dalla forma narrativa di quella tradizione. Liberata dai
vincoli di una storia da raccontare, la canzone entra in una dimensione più propriamente poetica. Sicuramente Dylan e gli
altri cantanti folk, come Joan Baez e Donovan, che godettero
di grande popolarità in questo periodo, espressero in una direzione piuttosto particolare il loro modo di intendere la canzone, ritornando a una scrittura studiata quasi con un senso
di rivalsa dopo i vari urli, singhiozzi, strilli e glissandi del
rock’n’roll, del beat e del R&B. Dylan, che si dichiarava
“artista da trapezio”, rimase comunque un esempio complesso. Le ampie possibilità della sua voce, che avevano assorbito i timbri del R&B e del pop, e il suo tono spesso confuso,
una volta associato ai regolari ritmi elettrici di un gruppo rock
- Highway 61 Rivisited (1965), Blonde on Blonde (1966) - tras70
formò la spontaneità della canzone folk in uno stile più distaccato, garbato e metropolitano. Nel frattempo il brillante collage di metafore letterarie, allitterazioni e immagini, ben illustrato in ‘Mr. Tambourine Man’ di Dylan (il primo successo
folk-rock dei Byrds, nel 1965), ebbe un notevole effetto sul
pop inglese e americano. Un nuovo clima culturale aveva così
piantato le sue radici.
L’idea di valorizzare la parola nella canzone popolare e nella
musica folk aveva un precedente importante. Negli anni
Trenta e Quaranta, i radicali americani avevano tentato di riappropriarsi della propria cultura orale nella loro protesta contro la depressione, la povertà, il razzismo e le ingiustizie sociali. Questa tradizione prosegua, formando negli anni Cinquanta la spina dorsale del revival del folk song, celebrato dai
festival folk e dagli “hootenannys”, le feste popolari in cui il
pubblico partecipa agli eventi canori, da riviste quali “Broadside” e “Sing Out!”, e da cantanti quali Woody Guthríe, Leadbelly e Pete Seeger. I temi comuni che stavano alla base di
questo revival postbellico erano la “verità”, la “sincerità” e la
“autenticità”: cioè l’appello universale lanciato a tutti i critici
della società industriale di massa del tempo. Quella musica
aveva origine dalla convinzione che esisteva da qualche parte
una “comunità” perduta che aspettava di essere ricondotta
alla sua natura americana, genuina, popolare e organica. La
vaghezza di simili sentimenti e quell’aura di nostalgia per il
mondo rurale che li circondava, erano naturalmente aperte a
molte interpretazioni. Ma negli anni Sessanta, sotto lo stimolo
di nuovi e incalzanti avvenimenti, le prospettive della musica
folk furono incanalate in una direzione precisa.
Verso i primi anni Sessanta, lo sviluppo delle lotte per i diritti
civili da parte dei neri del Sud e i primi vagiti del radicalismo
studentesco (il “Manifesto studentesco di Port Huron” per una
società democratica è del 1962) avevano esteso enormemente
la risonanza politica del movimento della canzone folk. Il folk
entrò nelle università, nei circoli anticonformisti e nei caffè
del Greenwich Village a New York, formando un circuito di dimensioni assai più ampie. Le rivolte nere per i diritti civili
negli stati del Sud coinvolsero anche gli studenti bianchi nelle
marce per la libertà, nella protesta e in un generale movimento di solidarietà. Questo fece sì che, soprattutto dopo l’iniziale mediazione del R&B inglese, i giovani bianchi della classe
media ascoltassero le radio dei neri e assorbissero il blues, il
R&B e il soul. Il legame che si era stabilito fra la protesta e i
movimenti radicali attraverso la canzone (in particolare We
Shall Overcome), sembrava un processo che poteva essere ancor più facilmente attuato mediante i suoni di altre realtà subalterne: attraverso la “verità” del blues (che “dice come stanno
le cose”) e i radicati valori americani della country music bianca. Furono questi elementi, insieme con la nozione chiave
di “autenticità” e gli echi del populismo rurale, che si opponeva ai “vuoti” sentimenti della musica di consumo (sia bianca che nera), a costituire l’ossatura del rock americano e
della sua ideologia, nella seconda metà degli anni Sessanta.
L’apparizione della musica “folk di protesta” nelle classifiche
inglesi e americane del 1965, con Dylan, Joan Baez, Donovan,
71
Barry McGuire, fu in realtà solo un’anticipazione di una tendenza ben più ampia. La scena della musica folk in America, e
in particolare nel Greenwich Village di New York, mentre coagulava vari elementi di musiche indigene con determinate influenze pop (R&B, beat inglese), si mescolò con atteggiamenti
anticonformisti marginali e in particolar modo letterari: gli
eredi degli hipster e della beat generation degli anni Cinquanta. In Inghilterra il beat originario e le frange radicali del
CND (Comitato per il disarmo nucleare) stavano contemporaneamente confluendo nella formazione di una cultura “underground” britannica.
ali e studenteschi nei campus delle università americane,
sarebbero confluiti nella nascita della “società alternativa” e
della sua controcultura. L’“autenticità” musicale suggeriva a
questo punto un nuovo progetto, che fosse nello stesso tempo
politico e artistico. Voleva dire che il rock era destinato a distinguersi coscientemente dalle altre sfere della musica pop.
Il passo era breve dal poeta beat Allen Ginsberg al cantante
Bob Dylan, o dai romanzi “on the road” di Jack Kerouac all`acid rock” dei Grateful Dead.2 Questo clima di creatività radicale doveva rivelarsi di cruciale importanza nella cultura rock.
Quella “sincerità”, espressa in precedenza nelle canzoni di Dylan e nel linguaggio della canzone folk, si rivelava ora più complessa e meno palese. È a questo punto che avviene il passaggio da una presunta “autenticità”, condivisa a livello di comunità, a un’autenticità individuale, personale; da un registro “sociale” a uno “poetico”. Era così preannunciato il successivo
avvento di un orientamento estetico autocosciente nella musica rock.
Sognando utopie dove tutti sono amanti vedo San Francisco dalla mia
finestra.
La “protesta’ si trasforma così in “prosaicità” e le “verità” del
singolo artista sostituiscono e affinano i vaghi sentimenti
populistici. Questo tardo radicalismo esistenziale, questo
“inesplorato viaggio negli imperativi di rivolta del sé” (Norman Mailer), così come il brusco impatto dei movimenti razzi-
“SOGNANDO LA CALIFORNIA”
Lawrence Ferlinghetti
Nel 1964 Timothy Leary, Ralph Metzner e Richard Alpert pubblicarono L’esperienza psichedelica: un manuale basato sul Libro tibetano dei Morti. Leary, che sarebbe stato presto largamente associato allo slogan “Turn on, tune in, drop out” (Fatti
di droga, sincronizzati, vivi ai margini), e i suoi amici vennero
espulsi dall’università di Harvard e successivamente perseguiti dalle autorità americane e messicane per aver incoraggiato pubblicamente l’uso dell’LSD (Lysergic Acid Diethylamide). Contemporaneamente a questi avvenimenti, al Longshoresman’s Wharf e all’Avalon Ballroom di San Francisco si
svolgevano concerti che mescolavano musica, spettacoli di
luci, danza e poesia in un potente infuso che sarebbe stato
presto battezzato “acid rock”. Traducendo gli effetti allucinatori in uno spettacolo che disorientava il pubblico, questi
72
eventi multimediali costituivano temporaneamente delle teste
di ponte per un altro ordine di esperienze, considerato in qualche modo più vero e genuino, rispetto alla superficiale razionalità della vita quotidiana in America. Musica elettronica
suonata a tutto volume e luci stroboscopiche distorcevano la
normale percezione acustica e visiva (“che sconvolgeva la
mente”) modificando le forme e i colori proiettati su grandi
schermi. Sottratto alle censure e alle mete restrittive della
“buona” società, il pubblico si ritrovava di colpo “sconvolto”,
con la mente “da un’altra parte”, proiettato in una “realtà alternativa”.
Negli agglomerati urbani della West Coast, a San Francisco e
Los Angeles, musiche considerate decisamente lontane dallo
screditato centro del pop americano ed esenti dalle sue invadenti seduzioni commerciali, furono ben accolte e introdotte nel repertorio dei Grateful Dead, dei Jefferson Airplane,
di Country Joe and The Fish, di Big Brother and the Holding
Company. I suoni più autentici del folk bianco (e più tardi del
country), e del blues rurale e urbano, filtrati attraverso l’esempio dei gruppi inglesi, spesso con l’aggiunta di una vena letteraria ispirata da Dylan, formarono la principale struttura musicale di quella che stava per essere definita “controculturà’.
Il frequente ricorso a metafore cerebrali, che chiamavano in
causa la droga e anche effetti culturali, non era affatto accidentale. La ricerca di una “ragione” più profonda, fosse attraverso
la nuova musica californiana, l’LSD o uno stile di vita alternativo - tutti profondamente intrecciati, se non compresi in
un unico gesto - rivelò un forte esistenzialismo intellettuale
che seduceva i giovani bianchi americani del ceto medio. La
cultura ufficiale, soffocata dai simboli passivi di uno status rispettabile, era rifiutata con sempre maggiore vigore perché regolarmente trasformava forme non rispettabili (come la musica pop, i vestiti anticonformisti, le droghe) in un’imitazione
di alternativa. La cultura di massa, e in particolare la cultura
musicale giovanile e lo stile generazionale, conobbe una nuova
e importante fase che ebbe sviluppi diversi in America e in
Inghilterra, anche se il modello più convincente era quello
originale americano.
All’inizio, la musica nera americana fu fondamentale per la
costituzione di questo nuovo round della West Coast. Richiamandosi all’esempio dei Beach Boys, che utilizzarono alcuni
riffs di Chuck Berry, era il blues che forniva la base per le interminabili canzoni e i lunghi arsoli di chitarra che accompagnavano il diffuso stato di eccitazione della gente che ballava. Ma
il contesto contradditorio della “controcultura”, la sua svolta
decisiva, intorno al 1967, dalla protesta diretta allo stile di vita
alternativo, dal folk e dal blues alla musica psichedelica o
all’acid-rock, dall’ambiente studentesco di Berkeley all’ambiente “bohemieri di Haight Ashbury, dovevano influenzare profondamente anche la natura della musica. I ritmi di danza divennero un fattore meno indispensabile, il corpo aveva
scoperto altri modi per farsi “trasportare” e l’effetto della musica si concentrava sempre di più nella “testa”, nelle sensazioni mentali. I ritmi erano assorbiti in un flusso senza fine, il
senso del beat fu sostituito da quello delle “vibrazioni”. La mu73
sica, afroamericana fu sempre più sommersa da un dilagante
ed eclettico spettro musicale.
In ‘San Franciscan Nights’ (1967), Eric Burdon, già cantante
degli Animals di Newcastle, esalta una realtà fatta di hippy,
LSD, Hell’s Angels, pellirossa e poliziotti chiamati “porci”,
tutti colti nel caldo riverbero di un nuovo “sogno americano”.
Durante gli anni Cinquanta, gli scrittori e i poeti bianchi della
beat generation avevano elaborato un’esotica cosmologia fatta
di jazz, droghe e buddhismo Zen per guidare la loro frenetica
ricerca verso la liberazione dei sensi e la promessa americana.
Questo genere di viaggio elitario e anticonformista ai margini
della vita americana veniva ora superato e assorbito da uno
“stravolgimento” di massa, da un “trip” collettivo verso “qualcosa di più folle e misterioso on the road” (Tom Wolfe).
L’arrivo degli hippy nel mezzo dell’opulenza californiana, e i
loro tentativi simbolici, attraverso la droga, il misticismo, la
musica rock e la vita in comune, di riscoprire l’onesta povertà
di un’America più semplice, più autentica, aprirono una ferita
drammatica nel corpo della cultura giovanile americana. La
ribellione non era una novità per la musica pop americana e
per le culture giovanili. Ma il breve scandalo del rock’n’roll,
l’influenza dell’iconografia di Marlon Brando e James Dean,
l’irruzione delle bande di quartiere e dei motociclisti vestiti di
pelle o i bizzarri culti esoterici della West Coast che costruivano altari al surf e alle auto personalizzate, perdono d’importanza di fronte al rifiuto consapevole e articolato dello
“status quo” che gli hippy e la controcultura rappresentavano.
La dimensione esplicitamente politica ed estetica di questa
controcultura esistevano in una complessa simbiosi per cui
l’una era soggetta a ridefinizione da parte dell’altra e
viceversa. La politica più tradizionale degli inizi, sviluppatasi
sotto la paternità della “New Left”, formò il nucleo centrale
delle lotte universitarie a favore delle libertà intellettuali, del
movimento contro la guerra in Vietnam e dei tentativi di un’alleanza tra i bianchi radicali e una nuova, autonoma, militanza
politica nera. Dopo il 1967-1968, comunque, tutto ciò fu
messo in ombra da una metamorfosi di ampie proporzioni. Il
dichiarato ideale hippy di costruire una società alternativa che
comprendesse, secondo il poeta beat Gary Snyder, un tentativo di “uccidere l’uomo bianco, l’americano che è in me”, proponeva un’utopia molto più drammatica di quella normalmente contenuta nella politica.
Fu un paradosso storico il fatto che il rifiuto categorico della
società industriale americana e del sistema che essa esprimeva, scopri l’alternativa nel più americano di tutti i temi:
quello del West. La ricerca di una comunità “perduta”, americana e rurale, com’era rappresentata nella musica folk dei
primi radicali, diede corpo alla mitologia di una nuova frontiera. Ecco dunque emergere questa figura di uomo bianco, di
volta in volta rappresentata dal cowboy, dal beat, dall’hipster,
dall’hippy o dal surrogato di un pellerossa (tutti modi di
vestire di questa controcultura, popolari nei tardi anni Sessanta) che esce “non solo dall’Europa, ma anche dal West europeizzato, in un’America originaria e arcaica” (Fiedler 1972, p.
23). Al di là dei personaggi hipster di Kerouac (On the Road,
1957) e del loro modo di essere “cool” preso in prestito dai
74
neri, si ricercava ora fidentificazione con un’alternativa assai
più vasta: l’anima “autentica’ del “vero americano”.3
cietà industriale contemporanea: l’Oriente, i ritmi della “Madre Terrà , gli spazi interiori e talvolta quelli esterni.4
La città venne abbandonata, anche se solo simbolicamente
(mentre era solitamente conservata la sua tecnologia, giradischi e chitarre elettriche) per rivolgersi agli orizzonti più naturali della campagna, mentre l’LSD offriva una “finestra aperta
sullo Zen eterno”, “una scorciatoia per ritornare alla vita organica” (Nuttall 1972, p. 190). Gli americani medi erano sedotti dal “viaggio”. La cultura hippy, o più precisamente una
cultura “di testa”, giocava con una nuova serie di simboli che
deridevano la logica utilitaristica della società “normale” e la
sostituivano con un comportamento “freak” che disorientava e
poteva andare dai referenti centrali del rock psichedelico e
della droga alla più esotica dimensione del misticismo (in
Inghilterra si manifestò un rinnovato interesse per l’atmosfera
magica che circondava Glastonbury e Stonehenge) fino alla dimensione extraterrestre della fantascienza (un tema dominante in Jimi Hendrix come nei Pink Floyd) e persino alla stregoneria. Questa “rivoluzione” spirituale, culturale e politica
era “totale”, doveva essere vissuta per essere fatta; la rivoluzione divenne così uno stile di vita. Ma anche il tessuto sperimentale di questo “vissuto” era estremamente cerebrale. “La
prima rivoluzione (ma non certo l’ultima) è nella tua testa”
(Tuli Kupferberg dei Fugs). Le sensazioni fisiche stimolate
della musica, dal sesso e dalla droga erano valutate nell’ottica
di un nuovo ordine intellettuale. L”`autenticità” di queste esperienze veniva scoperta attraverso l’uso di altre mappe, che si
riferivano a territori estranei alla coscienza entropica della so-
Sul mitico palcoscenico di queste nuove frontiere si rappresentava una metafora capovolta dell’opulenza americana e dei
suoi imperativi economici. L’alternativa assoluta veniva ricercata in uno “stato di cose non ordinarie” (Carlos Castaneda).
L’LSD e le droghe del Nuovo Mondo (marijuana, peyote, messalina e cocaina) venivano sempre più associate a un nuovo
stile di vita e, attraverso l’onniprésenza del rock, fornivano gli
strumenti simbolici coi quali distruggere l’“American way of
life”. Sulla West Coast, Ken Kesey e i Merry Pranksters si misero in viaggio con un seguito motorizzato allo scopo di “sconvolgere” l’America con la musica, gli happening e l’LSD, mentre le migliori menti delle università americane venivano ovunque sedotte dal rock e rivolgevano la loro attenzione alla
controcultura.5 La giovane promessa di una arcadia americana, echeggiata nella musica folk e country e nel loro passaggio al rock americano, era continuamente messa in scena con
collanine di perle, giacconi di camoscio, fasce intorno al capo
e mocassini ai piedi dai pionieri della società alternativa, accampati nei campus universitari e nei quartieri artistici delle
metropoli americane.
I massicci bombardamenti del Vietnam, iniziati nel 1965, la
successiva chiamata alle armi e le immagini televisive che riprendevano in diretta la guerra provocarono nuove ondate di
protesta contro la presenza militare degli Usa nel Sud-Est asiatico. Questa situazione - aggiunta ai disordini razziali che
avvenivano nelle maggiori città americane con gli incendi di
75
Watts, Los Angeles, avvenuti nel 1965, a una nuova militanza
nera ribelle, scatenata dalla droga, e alla conseguente brutalità
della polizia contro le manifestazioni di dissenso in generale, e
in particolare contro la dimostrazione alla Convenzione democratica di Chicago nel 1968, e alla caccia all’uomo condotta
contro le Pantere nere - mise ancora più in rilievo alcuni aspetti della controcultura. Gli yippie (lo Youth International
Party) capovolsero l’ideale hippy di dissociarsi dall”Amerika”:
“Drogati, inciamparono all’indietro nella politica’ (Neville
1971, p. 32), e intervenirono con ironia nelle pubbliche arene
della società americana - distribuendo denaro gratis nella
Borsa di New York, per esempio - nel tentativo “di stabilire un
nuovo quadro di riferimento” e “mettere in viaggio il paese
con una dose di acido” (Jerry Rubin, in Neville 1971, p. 116).
In questo clima, un importante settore del rock della West
Coast - i Jefferson Airplane, Country Joe and the Fish, i Doors
- oscillava fra gli aspri estremi della politica americana e i
gesti utopistici di un “America alternativa”. Gli slogan politici
- “loro hanno i fucili ma noi abbiamo la gente” (Doors) - che
accompagnavano i ritmi del rock bianco erano comunque soltanto la superficie di quella che sarebbe stata una trasformazione ben più profonda. Mettendo in dubbio la riconosciuta “dissociazione tra politico e non politico” (Henri Lefebvre), l’anticonformismo dei giovani intellettuali bianchi minacciava il tessuto apparentemente intatto delle relazioni culturali e politiche, proprio a partire dal grembo dell’abbondanza e del benessere.
Dopo questo passo iniziale, l’“introduzione dell’estetico nel politico”, attraverso l’adozione e il patrocinio della musica rock
da parte della controcultura, certi stili di vita, determinati comportamenti sessuali e sociali, presero l’idea di rivoluzione e la
collocarono nella “sua autentica dimensione: quella della liberazione” (Marcuse 1972, p. 11). Il personale era diventato politico. Che cosa potesse significare tutto ciò, lo si sarebbe lentamente compreso solo quando la prima ondata di entusiasmo
si fu lentamente placata. Fu soltanto più tardi che la politica
sessuale del Movimento di liberazione delle donne riuscì a
rivalutare la decantata liberazione sessuale della controcultura e a scoprire in essa una libertà per lo più limitata ai bisogni maschili. Ma il profondo significato dello slogan “il personale è politico”, e di nuovo l’esempio del Movimento delle
donne è il più pertinente, rimane l’eredità più duratura e indubbiamente più radicale dei movimenti politici giovanili dei
tardi anni Sessanta.6
Tra il 1966 e il 1969, quando furono fondate le riviste rock
americane “Crawdaddy”, “Creem”, “Fusion” e “Rolling Storie”,
la situazione restava estremamente fluida, le indicazioni erano
molteplici, anche se spesso confuse e contraddittorie. Si manifestava nella nuova politica degli yippie, “surrealistica” e d’intervento, l’inventiva grafica e giornalistica della stampa underground, e nella presenza diffusa della musica rock. All’altro estremo si opponeva l’immobilismo dei freak che si occupavano
solo di se stessi, per i quali tutto ciò che andava al di là della
gratificazione personale era semplicemente “troppo pesante”.
76
Comprese tra questi due poli, un’ampia gamma di opzioni politiche, culturali e spirituali trasudavano vitalità e ottimismo.
La proposta degli hippy, che rappresentava l’“estrema variante dell’individualismo americano” (Hall 1969), filtrò attraverso la controcultura sin dietro le pratiche musicali della West
Coast e nel rock in generale, fornendo un importante lasciapassare (“fai quello che ti va”) per la fioritura di innumerevoli esperimenti musicali. La mordente incisività della chitarra elettrica rimaneva essenziale, ma era intesa in modo diverso, più
come punto di partenza che di arrivo, e altri linguaggi musicali si facevano rapidamente avanti, molti del tutto estranei
alla precedente tradizione del pop. La musica di Frank Zappa
e delle Mothers of Invention può essere considerata una sintesi estremamente personale, ma decisiva di questa nuova sensibilità musicale. Le esperte elaborazioni di Zappa degli stili
tradizionali del pop (il “doo-wop” di Reuben and the Jets,
1966 e la parodia dei Beatles in We’re Only in It for the
Money, 1967), integrate dalle composizioni di ispirazione jazzistica e classica come Lumpy Gravy (1968) e Hot Rats
(1970), rappresentano alcuni dei più importanti confini musicali della sperimentazione controculturale. Zappa, che in alcuni ambienti era considerato una sorta di guru musicale, associava l’eclettismo con la padronanza della musica e l’ironia,
producendo collage di citazioni musicali che, attingendo indiscriminatamente dal jazz, dal rock‘n’roll e dalla musica contemporanea d’avanguardia, ridicolizzavano gli imperativi commerciali dei dischi che egli stesso produceva, “rispecchiando la cultura contemporanea - da Sinatra a Varèse - come un gigan-
tesco cumulo di rifiuti a perdere” (Paddison 1982, p.215).7 Al
tempo stesso gli accentuati accenni nei confronti del jazz e
della musica classica, ulteriormente sottolineati dall’introduzione di lunghe composizioni strumentali e dall’insistenza sulle
sue capacità di improvvisazione, in quanto dimostrazione importante di “autenticità” musicale, erano segni distintivi di
uno stile musicale e culturale sofisticato ed eterogeneo, ben
diverso dal resto del pop e dalle precedenti connotazioni sociali della musica.
Dal primo festival pop di Monterey del 1967 al mastodontico
festival di Woodstock dell’agosto 1969, il rock non fu mai né
un semplice “sottofondo” né musica da ballo. Era diventato
un’esperienza centrale della controcultura, che rifletteva le
sue più profonde contraddizioni e investimenti. La varietà
delle musiche prodotte in questo periodo - dal country dell’ultimo Dylan al blues un po’ bizzarro di Captain Beeflieart e al
jazz-rock dei Blood, Sweat and Tears - richiedeva particolare
concentrazione e ascolto, non erano semplici suoni, ma “testi”
culturali, ricchi e profondi quanto un libro.
Non è possibile ignorare le alterazioni qui avvenute in seno ai
riferimenti culturali, né nutrire dubbi sulle loro complesse
origini. Anche se il dibattito in America spesso tace su questo
aspetto, le specificità di classe, di razza e persino di sesso interne al progetto musicale controculturale non erano un mistero per nessuno. Questo progetto aveva connotazioni colte,
bianche, “middle class” e decisamente maschili. In superficie,
fu probabilmente inevitabile che il diffondersi dei negozi specializzati in droghe e cibi naturali, delle botteghe artigianati, e
77
le vendite sempre crescenti di album rock e di Woodstock
(con il film e l’album triplo) al resto del mondo, produssero
una nuova variante stilizzata di consumismo. Alla fine gran
parte del panorama controculturale scivolò di nuovo, nei
primi anni Settanta, nella normalità della vita universitaria e
nello status postuniversitario di “hip”, portandosi dietro
buona parte del rock, i capelli lunghi, un po’ di droga e l’accomodante rivista “Rolling Storie”.8 Questi sviluppi non erano
affatto, naturalmente, la fase finale della proclamata “rivoluzione” controculturale. Le sue spinte contraddittorie non furono
necessariamente assorbite in maniera così semplice.
Per un altro aspetto il rock e la controcultura dei tardi anni
Sessanta possono essere compresi a posteriori come una particolare scelta culturale che sollevava dubbi provocatori sulle
tradizionali distinzioni tra musica e vita quotidiana, fra politica ed esperienza. Gli stilizzati momenti di libertà immaginativa che i mod avevano un tempo strappato alla settimana lavorativa, venivano ora superati da ambizioni più ampie che pensavano ingenuamente di fondare un modo di vivere completamente nuovo. La controcultura si proponeva di abolire l’assodata e presunta distinzione fra tempo libero e lavorativo, tra
piacere e routine quotidiana. Al suo posto veniva offerto il programma, l’iconografia e i suoni di una “esperienza totale”, una
radicale reintegrazione di “cultura” e “società”. Il rock e la controcultura estesero gli orizzonti della musica pop e delle sue
circostanti culture giovanili. Quegli orizzonti erano destinati a
restare un costante punto di riferimento sotto quei cieli più
vasti.
NEL FRATTEMPO IN TOTTENHAM COURT ROAD...
Gli hipster neri si drogavano per eccitarsi. L’underground lo faceva per
sperimentare qualcosa in cui trovare fede e convinzione.
Jeff Nuttall 1970, p. 164
In Inghilterra la convergenza fra pop e controcultura locale,
favorita dallo spettacolo americano, fu inoltre stimolata assiduamente dal nuovo giornale underground “International
Times” (chiamato in seguito IT) e dalla recente apertura di
club come l’UFO in Tottenham Court Road. Fu lo spettacolo di
beneficenza dell“International Times” - il Twenty-Four Hour
Technicolour Dream, svoltosi all’Alexandra Palace nell’estate
del 1967, il sintomo più evidente che il seme americano aveva
messo radici. Poco dopo si svolse il primo festival pop inglese
a Woburn Abbey, nel Bedfordshire. Woburn non era certamente Monterey né l’Avalon Ballroom di San Francisco; tuttavia l’immagine pubblica di questi avvenimenti musicali era
molto simile. L’“estate dell’amore” del 1967 e la diffusione dei
“figli dei fiori” sembravano avere liberato la prospettiva di una
controcultura transnazionale, un “villaggio globale” elettronico (Marshall McLuhan) dell’età dell’Acquario.
Il senso più profondo di una corrente culturale alternativa in
seno al pop inglese dopo il 1966 si produsse nell’underground
con una base soprattutto londinese, dove i legami tra il pop e
l’avanguardia letteraria alla deriva si facevano sempre più
stretti. Era stato ovviamente Dylan a innescare questo processo, a rendere più chiari gli ancora vaghi legami tra arte e musica pop.
78
Il filone iniziale di questafi ricostruzione del pop inglese ebbe
comunque una risonanza più pubblica. Consisteva in una serie
di esperimenti che erano stati condotti utilizzando forme e timbri già esistenti, come per esempio da parte degli Yardbirds
(da notare l’uso indianeggiante che Jeff Beck fa della chitarra
in ‘Still I’m Sad’, 1965). Questi nuovi elementi vennero successivamente resi popolari e ripuliti dalla produzione dei Beatles
tra il 1965 ed il 1967. II periodo di ‘Strawberry Fields’ e dell’LP
Sergeant Pepper (1967), vede fuso di strutture armoniche
elaborate, di nuove tessiture timbriche e linguistiche talvolta
create elettronicamente, “una poesia del luogo comune, profondamente misteriosa” (Mellers 1976, p. 82), che avevano
esteso al massimo molte delle convenzioni del pop.
Mentre i Beatles forzavano i limiti del pop e i canoni della musica leggera, una parte sostanziosa dell’underground si
muoveva al di là di quelli. In locali come l’UFO, l’Electric Garden e la Roundhouse in Camdem Town, iniziò a emergere una
serie di sintesi musicali assolutamente sorprendenti. In tutte
era presente un senso di sperimentazione, d’improvvisazione
e di libero interscambio tra le categorie del pop e del non-pop.
Una struttura musicale spesso “libera”, generalmente controllata da un ritornello o da un tema di introduzione e di chiusura, avviava altre parti più o meno improvvisate che spesso
utilizzavano suoni elettrici sperimentali. La musica dei Pink
Floyd (come nel loro secondo LP A Saucerful of Secrets,
1968), ne è un chiaro esempio. Ma è un panorama che spazia
dalle tendenze più d’avanguardia, come i contemporanei Soft
Machine, di estrazione jazz (da notare che il nome del gruppo
deriva da un romanzo di William Burroughs, un indicativo
segno dei tempi) fino all’infuocato blues di Jimi Hendrix.
Nel frattempo, dopo il successo dei primi gruppi di R&B, il riferimento al blues era ancora una realtà. Eric Clapton, Peter
Green, Mick Taylor e molti altri musicisti passarono attraverso l’esperienza dei Bluesbreakers di John Mayall. Ma dopo il
1966, sia il blues elettrico sia il pop sofisticato tendevano a
essere assorbiti dalla “musica psichedelica” che arrivava dalla
West Coast.9 Il legame più importante tra la tradizione della
chitarra blues, la musica psichedelica e gli esperimenti elettronici va ricercato nella musica dell’americano nero espatriato Jimi Hendrix. La sua musica e il suo stile chitarristico, i
più influenti del decennio se non della storia del pop, affondavano le radici nel blues, nelle esperienze acquisite durante le
tournée con Little Richard e gli Isley Brothers prima di arrivare in Inghilterra nel settembre del 1966. Si trattava però di
un blues setacciato attraverso le trame elettroniche del momento e le controllate estensioni dell’amplificazione elettrica.
Tale era quel cupo senso di vuoto catturato dalla sua straordinaria chitarra che emetteva suoni onomatopeici - Loneliness
is such a draggggg / wah wah wah wah / wah wah wah / wah
wah wah / wah vivah wah / wah wah wah / - suonata con il
pedale wah-wah in ‘Burning of the Midnight Lamp’ (1967).
La distorsione, la presenza/assenza del “wah-wah” e i prolungati lamenti, urli e guaiti delle note tirate e del feedback permisero a Hendrix di tradurre il blues in un frenetico metalinguaggio elettronico. Era una sintesi pregnante che parlava
non solo il prevedibile lessico del sesso e della droga, ma
79
aveva anche pronunciate implicazioni razziali e culturali. Jimi
Hendrix era infatti un protagonista nero della chitarra in un
mondo di bianchi; e non a caso un personaggio ricorrente
nelle sue canzoni era lo zingaro.10 Come ha osservato Richard
Middleton, “il fatto che gran parte della sua musica abbia
tutta l’apparenza di un ‘brutto viaggio’ conferma che non è
solo, e nemmeno in modo predominante, una ricerca culturale
autonoma, ma anche un tentativo di catarsi e di fuga.” (Middleton 1972, p. 232). L’urlo elettrico della chitarra di Hendrix,
come l’amaro e ironico silenzio di There’s A Riot Going On di
Sly Storie, era un’angosciante promemoria di quanto la musica nera fosse stata sistematicamente espulsa dalle nuove gerarchie culturali del rock progressivo. Quando qualche artista
come Hendrix o Sly Storie veniva accettato, egli era anche divinizzato e tenuto a religiosa distanza, autorizzato a suonare
come un “spirito congelato” (Eldrige Cleaver).
L’atteggiamento derisorio nei confronti della società “normale”, implicito nell’alternativa degli hippy americani, e poi la
minaccia più diretta dei movimenti studenteschi emersi in un
secondo momento in Inghilterra, puntavano a qualcosa che andava al di là del precedente e sconcertante dandysmo operaio
dei mods, o della sporadica violenza dei rockers. Questa complessa disaffiliazione, annunciata in modo simbolico dal rock
psichedelico, dai capelli lunghi, dalle droghe, dall’abbigliamento ornamentale e dai ritiri spirituali degli hippy, e in seguito manifestata drammaticamente dalla protesta giovanile
contro la guerra del Vietnam e contro il sistema universitario,
ebbe un effetto doppiamente traumatico. II collasso istituzion-
ale dell’istruzione superiore, questa crisi del “cervello sociale”,
questo attacco alla “città pietrificata” (Tom Nairn) della vita
borghese, alla sua evidente alienazione, al suo tedio ufficializzato e a sua cultura del rispetto, fu guidato proprio dai figli di
coloro che erano soliti partecipare alla definizione, al controllo
e alla repressione di tale conflittualità sociale. Lo spettacolo
della progenie allevata con tanta cura, che si emarginava dal
proprio ambiente d’origine, al centro cioè della società inglese
e, avvolta in giacconi afghani, in uno stato di grazia artificiale,
si metteva in viaggio per Katmandu o, più modestamente, per
il festival pop del fine settimana, era profondamente inquietante. Questi ribelli di periferia, con i loro amori, la loro musica, la droga e il loro esasperato individualismo, osavano mettere in dubbio le basi stesse della realtà del resto della società:
l’etica del lavoro, la famiglia nucleare, gli obblighi reciproci tra
il “cittadino” e lo Stato; in altre parole le regole “razionali” e
“normali” del vivere quotidiano. Fu un’irruzione particolarmente malvista, che giungeva precisamente nel momento in
cui il boom del dopoguerra e la retorica dell’“opulenza.” stavano iniziando la fase calante. Quando il rifiuto culturale si innestò nella politica attiva alla fine degli anni Sessanta, diventò
un vero “tradimento”, destinato a inasprire la reazione
dell’opinione pubblica.
Tra i dischi psichedelici, i caffetani, i romanzi di Herman
Hesse e il fumo delle marijuana che riempivano i monolocali
dei quartieri alternativi e i ritrovi dei campus universitari, i
“covi” della controcultura, qualcosa stava fermentando, anche
se all’osservatore esterno quel qualcosa non era molto chiaro.
80
Furono condotte inchieste, ovunque si parlava di libertà sessuale, di droga, di agitazione politica. Londra si era risvegliata
nell’alba grigiastra di un acido permissivismo. La sede della
“IT” era regolarmente soggetta a perquisizioni della polizia,
Mick Jagger e Keith Richard furono arrestati con l’accusa di
uso di stupefacenti nel 1967, e condannati a pene detentive
(anche se la sentenza fu in seguito cancellata). Fu costituita la
Squadra regionale antidroga, e Jagger inviò il testo di Street
Fighting Man (1968) al giornale rivoluzionario marxista
“Black Dwarf ”.
I tentativi della polizia e della magistratura di punire severamente droga e pornografia e di “mandare all’aria” questo progetto di trasformazione culturale, si rivelarono nient’altro che
il preludio a una più attiva politicizzazione di quest’area assai
sensibile. L’Inghilterra non era però la California. La protesta
degli studenti a favore di una maggiore democrazia all’interno
delle università e contro la guerra nel Sud-Est asiatico,non sfiorò mai il clima raggiunto nelle università americane, né l’intensità del Maggio parigino 1968. Tuttavia le reazioni ufficiali
ai disordini e ai sit-in davanti alla London School of Economics, a Warwick, a Cambridge, a Keele, a Essex e in altre università erano sintomatiche nella loro severità: gli studenti erano
considerati “sporcaccioni che fanno l’amore (se questo è il termine giusto) per la strada”, secondo John Sparrow, rettore
dell’All Souls College di Oxford. A questo punto i nebulosi fermenti della controcultura avevano assunto una forma più
minacciosa. Era giunto il momento in cui “l’unione
dell’erotico e del politico” (Henri Lefebvre), la musica, le
droghe, gli stili di vita e le alternative politiche si erano apparentemente coalizzate per sferrare un attacco congiunto contro
i vecchi baluardi del potere politico e culturale.
Naturalmente fu un periodo molto elettrizzante, che produsse
una serie di reazioni ufficiali dettate per lo più da un eccesso
di nervosismo. I rettori delle università, la polizia e la stampa
inglese, incoraggiati da un’analoga iniziativa dal primo ministro Harold Wilson davanti agli intransigenti scioperi dei marittimi (1966), dichiararono di aver individuato il diabolico virus
sociale del comportamento “antibritannico” tra quegli studenti “agitatori”, tra le idee “giunte dall’estero” e nel loro contesto controculturale. Settori della gioventù bianca della middle- class e la sua stampa “provocatoria” - “IT”, “OZ”, “Black
Dwarf ”, “Ink”, “7 Days” - non solo sferravano una critica radicale contro la società inglese, ma nello stesso tempo dimostravano praticamente (attaccati per il loro abbigliamento, la loro
musica, la droga, la stampa e la politica del personale) che l’oppressione da loro contestata non era circoscritta alla loro posizione nell’ambito dei mezzi di produzione; e che, rivolgendo
la sua attenzione alla realtà psichica e sessuale, quell’oppressione era anche di “più di un semplice sfruttamento economico”(Juliet Mitchell). Sintomi disparati ma inquietanti come le
agitazioni studentesche, i festival pop, la droga, le occupazioni
di case, il movimento femminista - tutte filiazioni della controcultura - stavano estendendosi rapidamente, imponendo
con prepotenza la spirale del loro significato. A quel punto
questi fenomeni potevano essere pubblicamente additati come
81
i pericolosi sintomi, se non addirittura come causa diretta
della preoccupante decadenza della Gran Bretagna.
LA FINE DEL VIAGGIO
La musica pop inglese si sta ormai muovendo ai bordi dell’arte.
George Melly
Alla fine del film di Antonioni Zabriskie Point (1969), esplode
una casa lussuosa nel mezzo del deserto americano. Questa
simbolica rappresentazione della disintegrazione del materialismo del1`American Way of Life" era in realtà crudelmente
parodiata altrove. Proprio quelle stesse forze che dovevano accendere la miccia per provocare l’esplosione stavano andando
incontro a loro volta alla frammentazione. Tanto a livello di
scelta simbolica e di alternativa, quanto nella sua applicazione
letterale (col programma del gruppo bianco di guerriglia urbana dei Weathermen); il tentativo controculturale di "far saltare il continuum della storia" (Walter Benjamin) stava
fallendo.
Il "momento americano" (Stuart Hall), lanciato dagli hippy
verso la mete degli anni Sessanta, e da allora esteso a una controcultura internazionale, si stava malinconicamente piegando su se stesso. Nella fredda penombra di un concerto gratuito dei Rolling Stones all’Altamont Speedway, in California,
nel dicembre 1969, appena quattro mesi dopo Woodstock, la
society alternativa inizia ad affondare nelle proprie contraddizioni. Gli Hell’s Angels - da poco elevati al rango di eroi fuorilegge in motocicletta da tali autorità californiane quali Ken
Kesey, Allen Ginsberg e i Grateful Dead - irruppero con furia
omicida tra la folla, uccidendo uno dei pochi cittadini di colore della “Woodstock del West”. Un anno dopo l’atavistica
tribù di Charles Manson sbuca fuori dal deserto della California del sud e, massacrando diabolicamente l’attrice Sharon
Tate, sferrò un colpo mortale alla precaria simbologia e alle aspirazioni libertine della “società alternativa”.11 Il viaggio attraverso la droga, la musica, la vita comunitaria e altri referenti
esotici che “prefiguravano un nuovo tipo di soggettività” (Hall
1969) si stava tramutando in una spaventosa parodia, in un incubo apocalittico, in un “viaggio terrificante”.
I mass media inglesi colsero rapidamente l’occasione per imprimere nell’opinione pubblica cupe immagini giunte da oltre
oceano, in aggiunta a quelle dei disordini razziali e dell’aumento della criminalità in generale. L’effetto di queste immagini fu ulteriormente amplificato quando il fermento del
mutamento inizia ad affiorare all’interno del paese e quando i
fragili pilastri di una ricchezza e di un consenso solo apparenti
cominciarono a vacillare. Le perenni crisi economiche
dell’Inghilterra erano divenute una realtà a partire dai primi
anni Sessanta, ma ebbe maggior peso, a breve termine, la risoluta indignazione di coloro che si sentivano imbrogliati, trascurati o semplicemente accantonati dalle disordinate tendenze
di una society dei consumi dominata dall’inflazione. Enoch
Powell, leader del Partito nazionalista inglese, faceva sinistre
82
allusioni a un “nemico all’interno” che, con la servile connivenza dell’establishment illuminato, aveva avuto la possibilità
di mettere radici. La nuova sottocultura degli skinhead riaffermava con violenza una radicata mitologia proletaria di natura
etnica (essere bianchi e britannici), concentrata intorno a un
ferreo campanilismo e ai feroci attacchi contro gli stranieri
“provocatori” come i pakistani, i gay e gli hippy. La signora
Whitehouse, esponente dell’Associazione osservatori e ascoltatori, e Lord Longford, rappresentante del “Festival della luce”,
parlavano di una “Inghilterra pornografica” e sostennero che i
valori morali del paese erano ormai corrosi dal cancro della
permissività.
Un ritorno a restrizioni morali e l’appello a procedimenti disciplinari adeguati erano ormai generali. I gemelli gangster Kray,
i simpatici “mascalzoni” della “swinging London”, che facevano da spalla a Mick Jagger e Terence Stamp in Box of Pin
Ups (1965) di David Bailey, vennero vergognosamente messi
in prigione nel 1969.12 Nello stesso anno, le moderate misure a
favore della liberalizzazione della droga proposte nel rapporto
della baronessa Wooton furono bollate dalla stampa come “la
Carta del Tossicomane” (The Junkie’s Charter). Nel frattempo, perseguito legalmente per uso di droga e atti osceni,
l’edonismo insulare era sempre più posto di fronte a una ben
più triste realtà politica a causa della continua pressione esercitata dalla polizia.
Come pratica culturale influenzata e rafforzata dalla controcultura, la musica rock inglese risentiva di questo mutamento di
clima. La musica, come molti esponenti della controcultura,
iniziò a “firmare compromessi per sopravvivere in termini puramente personali” (Thompson 1980, p. 416). Si sciolse quel
complesso legame tra il rock progressivo e un ricco ed eterogeneo momento culturale, il concetto di “progressivo” fu sempre
più identificato con la manifestazione di più limitati criteri musicali e col successivo riconoscimento di meriti estetici puramente formali.
Forse il modo migliore per cogliere questo sviluppo e le alterazioni che si verificarono nella natura della musica progressiva
tra i tardi anni Sessanta e i primi anni Settanta, è quello di
guardare a due distinti esempi: ‘Astral Weeks’ di Van Morrison (1968) e ‘The Knife’ dei Genesis (1972). La canzone di Van
Morrison inizia con un ritmo languido sostenuto da un contrabbasso, maracas e chitarra acustica. L’atmosféra pastorale
e il tono sono ancorati ai ritmi che questi strumenti intrecciano fra loro. Poi subentra la voce di Van Morrison, che accarezzando e stuzzicando ogni parola, sillaba e suono, con il suo
stile lancia questo impasto sonoro verso una serie di voli improvvisati. La presenza del R&B e della musica soul è inconfondibile. Questa presenza, insieme coi i versi “poetici” (“Se mi
avventuro nel flusso, dietro i viadotti dei tuoi sogni (...)”) si estende nel tipico canto “scat” e nei timbri jazzistici. L’assenza
di batteria sottolinea ulteriormente la mancanza di un ritmo
regolare in stile pop, e favorisce una struttura più “libera”, un
continuum poliritmico, dove in ogni frangente viene proposto
qualcosa di nuovo, di improvvisato – l’inflessione della voce,
la movimentata linea di basso, le interferenze blues della chitarra nel ritmo.
83
Con ‘The Knife’ scopriamo un modello di costruzione musicale
molto diverso. Sia ‘Astral Weeks’ sia ‘The Knife’ superano i
sette minuti di durata, ma mentre il brano di Morrison sfrutta
cambiamenti di timbro, ritmo e accento, per esplorare le molteplici possibilità dello schema di base della canzone - strofa/
ritornello/coda - ‘The Knife’ si snoda attraverso la successione
calcolata di differenti cellule musicali una sull’altra, in un tipo
di “minisuite”. Preceduto da un ritornello che riecheggia musica classica russa del primo Novecento, il normale arrangiamento verso-e-coro dà il via a una sequenza lineare di variazioni e arsoli strumentali altamente strutturati. I dettagli musicali interni non sono particolarmente interessanti, ma la
forma complessiva del brano è estremamente significativa. Si
può dire che l’esempio di ‘The Knífe’ ha offerto un paradigma
musicale per la musica progressiva che arrivò dopo il 1970 quella dei Jethro Tull, di Frank Zappa, di Emerson Lake and
Palmer e dei Van Der Graaf Generator.
Scrivendo sulla rivista marxista “New Left Review” in quel
periodo, Andrew Chester s’imbatté quasi per caso nel mutamento ideologico che si stava delineando. Chester stava tentando di identificare le basi musicali per una “estetica
autonoma” della musica rock. Egli sosteneva che la specificità
della musica rock, dovuta al suo consistente patrimonio
afroamericano, era da ricercarsi nella sua costruzione musicale “interna”, cioè nella sua esplorazione delle sonorità verticali e delle possibilità ritmiche della forma musicale (Chester
1970). Questa strategia veniva contrapposta a quella della tradizione classica europea che, con la sua insistenza sulle strut-
ture armoniche consequenziali, sacrificava le sottigliezze ritmiche a favore della forma melodica, la ricchezza verticale e le
ambiguità armoniche per un chiaro sviluppo lineare. L’involontaria ironia è evidente: proprio nel momento in cui Chester
cercava esplicitamente di fondare l’“autonomia estetica” del
rock su tali basi, la musica progressiva stava in pratica abbandonando quei criteri per altri che erano diametralmente opposti come formazione musicale e culturale. È l’addizione
sequenziale di unità musicali che rende ‘The Knife’ musicalmente “complesso” (nel senso considerato “classico”) in un
modo molto differente rispetto alla ricchezza di ‘Astral
Weeks’.
Questa successiva manipolazione del concetto di musica “progressiva” fu, in parte, ulteriormente stimolata dalle possibilità
tecnologiche che ora si offrivano nello studio di registrazione.
Lo studio era diventato rapidamente lo spazio privilegiato, se
non addirittura l’unico, per la composizione del pop. I fattori
tecnologici, in quanto essenziali per la produzione musicale
(eco, sovraincisione, phasing, montaggio, eccetera), non sono
mai stati elementi esterni, ma sempre “interni” alla storia
della musica pop, là “dove interagiscono le economie del capitale e della libido” (Wollen 1982, p. 176). In effetti, l’esplosione del rock progressivo alla fine degli anni Sessanta fu direttamente coinvolta nella seconda grande svolta nella storia
della registrazione sonora del dopoguerra. Dopo l’introduzione del nastro magnetico, che apri tutta una serie di nuovi sviluppi sempre più sfruttati dal pop degli anni Cinquanta e dei
primi anni Sessanta, fu l’introduzione del registratore a piste
84
multiple che portò un’altra rivoluzione nell’incisione in generale e nella produzione di musica pop in particolare. Le piste di
queste nuove macchine erano inizialmente quattro ma divennero ben presto otto, dodici, sedici e un po’ più tardi ventiquattro.
In equilibrio fra un hardware elettronico sempre più sofisticato e una spinta culturale che determinò l’ascesa dell’LP 33
giri al culmine del pop, lo studio di registrazione aumentò ancor più la sua importanza nella produzione musicale. Produttori discografici e tecnici del suono, come Jimmy Miller, Shel
Talmy e Glyn Johns, diventarono a pieno diritto gli equivalenti dei divi della canzone. Persino le peculiari caratteristiche
sonore di certi studi acquistarono una loro personale celebrità
e una loro clientela. Tutto ciò era sensibilmente stimolato
dalla sempre più diffusa possibilità di acquistare un complesso hi-fi a prezzi relativamente bassi e dall’adozione universale dell’LP stereo verso la fine degli anni Sessanta.
Utilizzando uno studio di registrazione a sedici piste, un
gruppo di quattro persone aveva la possibilità di produrre l’equivalente musicale di sedici musicisti singoli assemblati insieme in un suono simultaneo. Chiaramente le idee musicali e
la loro realizzazione potevano diventare più ambiziose e complesse. Se risultava un errore durante un passaggio difficile
era possibile montare una buona incisione dello stesso passaggio effettuata in precedenza, oppure registrarlo ex novo in seguito. La complessità verticale - l’utilizzo di tutte le sedici
piste - poteva essere associata a sviluppi orizzontali più articolati, in particolare se si trattava di seguire e sviluppare sedici
“voci”. Era possibile far scorrere insieme singoli segmenti e poteva essere esplorata una vastissima gamma di combinazioni.
L’apparizione degli album “concettuali”, delle opere pop e di
estese “suite” strumentali, fu pressoché inevitabile. Ma, come
sempre, non fu solo per una questione di semplici esperimenti
tecnologici che tali forme e idee musicali furono assimilate nel
pop. Isolate da tutto il resto, molte delle opzioni musicali che
le possibilità di registrazione offrivano non sarebbero mai
state compiute. Fu un particolare contesto culturale che alla
fine indicò e stimolò queste scelte.
Alla fine del decennio si era creato nel pop un notevole e influente raggruppamento di musicisti, col loro relativo pubblico,
che rifiutavano esplicitamente i limiti “artistici” del singolo
brano destinato alla Hit Parade contenuto entro i tre minuti.
Il rigido e spesso rigato e abusato 45 giri fu messo in crisi dal
punto di vista commerciale e culturale dal più delicato e protetto LP stereo ad alta fedeltà. Il pop come indiscriminata colonna sonora, che accompagna il tempo libero e rivela ovunque significati imprevisti, dal ballo del sabato alle pareti di
una camera da letto ricoperte di poster, era ora sostituito
dall’attenzione concentrata dell’ascoltatore rock “selettivo”.
Verso la metà degli anni Sessanta gli Animals con ‘The House
of the Rising Sun’, ‘Story of Bo Diddley’ e i Rolling Stones col
loro pezzo di undici minuti ‘Goin’ Home’, avevano già fatto
trasparire la possibilità di registrazioni più lunghe. Anche le
allusive canzoni narrative di Bob Dylan, come ‘Like a Rolling
Stone’ (1965) e ‘Positively 4th Street’ (1965) che univano l’impeto della lunga composizione letteraria a una corrispondente
85
estensione musicale, enfatizzarono ulteriormente questa tendenza.
presentava anche la rimozione della musica in una fortuna e
un successo privo di ambiguità.
Ma questi più vaghi referenti furono gradatamente superati e
raffinati. L’attenzione si orientava verso il più preciso centro
focale della musicalità, e tendeva spessa ai canoni ufficiali
dell’“arte” europea, o della musica classica. Furono persino
compiuti tentativi di orchestrare il rock, con i Deep Purple e
Procol Harum. In queste fasi successive, i nomi di musicisti
jazz e compositori classici non solo cominciarono a comparire
regolarmente negli scritti dei critici pop, ma anche nei commenti e nella pratica di molti musicisti pop desiderosi di
essere associati a questo processo di legittimazione estetica.13
I frutti economici della musica progressiva si rivelarono allorché le vendite degli LP superarono ampiamente quelle del 45
giri “commerciale”. Questa trasformazione fu poi registrata
nell’accresciuto investimento di capitale destinato allo studio
e alla tecnologia, alle tournée e alla promozione necessari per
riprodurre la posizione che il rock progressivo aveva conquistato nel campo istituzionale della musica pop. Il rock, infatti,
era profondamente interessato a massimizzare i profitti, solo
che nel suo caso questo processo avveniva attraverso mezzi
espressivi/estetici/ideologici diversi da quelli utilizzati nel
pop. Come è stato recentemente osservato, il rock non è un genere, ma una categoria ideologica (Taylor-Laing 1979). Una
volta dispersi o abbandonati i grandi ricordi culturali e politici
degli ultimi anni Sessanta, la musica progressiva si trasferì
quasi inevitabilmente nella sicurezza di una “politica” dell’estetica. Ma come poteva essere altrimenti, quando questa musica di grande successo pretendeva di basarsi sull’“autenticità”
artistica in contrasto con la volgarità commerciale del pop?
Dietro le lunghissime improvvisazioni, come in ‘Spoonful’ dei
Cream (nell’album Wheels of Fire), c’è il tema della spontaneità individuale, dell’esplorazione e dell’estensione. Le basi musicali del pop ora erano saldamente padroneggiate e il rock
sembrava pronto per fare un salto di qualità. La sua “autenticità” doveva essere scoperta nell’espressione di un’autonomia
artistica libera da ogni costrizione commerciale. Il progetto
controculturale aveva un tempo fornito le basi per questa e altre prospettive future del rock. Ma non appena questo progetto si ridusse, la musica tese a cercare una sua collocazione
nell’astratto rifugio dell’artista intento a separare la sua espressione artistica dal “volgare commercio”. Le confuse ma fertili
energie che circondavano il rock nei tardi anni Sessanta furono trasformate nelle acque stagnanti, ma altamente commerciali, dell”`arte”.14 Paradossalmente, per quanto riguardava le
sue dichiarate pretese estetiche, questa nuova situazione rap-
NOTE
1 In prima fila, ancora i Rolling Stones, riconosciuti come tra i più
“americani” dei gruppi inglesi: da Beggars Banquet (1968) al culto statunitense di Exile on Main Street (1972).
86
2 Nel “Merry Pranksters” - l’“happening” californiano ambulante organizzato da Ken Kesey, con il quale suonarono i Grateful Dead - era presente anche Neal Cassady, il mitico “Dean” di On the Road di Kerouac.
3 Qui siamo a livello di scelte metaforiche. Le scelte sono tanto fantasiose quanto materiali, i “paesaggi” sono fondamentalmente psichici, la
geografia interna spesso vaga e mutevole. L’“indiano”, il mitico “outsider” incontaminato dalla società industriale e dalla vita urbana,
potrebbe probabilmente risultare tanto un “guru” del subcontinente asiatico, quanto un aborigeno delle pianure, dei deserti e delle foreste del
nord America. Per chi abita sulla costa del Pacifico, andare verso il
West significa andare verso oriente, andare a est.
4 Esaminando gli assai diffusi riferimenti all’oriente (I-Ching, buddhismo, meditazione trascendentale) insiti nella mitologia hippy - dal
momento che pochi di fatto vi si sono trasferiti fisicamente - vale la
pena di ricordare la posizione di Roland Barthes nei confronti
dell’“est”: “Io non ho un rapporto d’amore con l’Oriente. Sono indifferente all’est, che mi fornisce soltanto una serie di spunti che, organizzati e ordinati, in un certo senso, mi permettono di accarezzare l’idea di
un nuovo sistema simbolico, completamente separato dal nostro” (Barthes 1970).
5 Ken Kesey, l’organizzazione dei Pranksters e autore di Qualcuno volò
sul nido del cuculo, fu un beat dell’ultima ora: con la musica rock e l’“acido” che sostituivano il be-bop e l’“erba”. Per ulteriori notizie su
queste contaminazioni culturali nell’ambiente “bohèmien” americano
degli anni Sessanta cfr. il classico testo di Tom Wolfe, The ElectricKool Aid Acid Test (1968).
6 Questa attenzione alla dimensione personale e culturale è stata ripetutamente osservata nei successivi commenti politici. Una delle prime
analisi di questo tipo si trova in Hall 1969. Un tale bagaglio di pensiero
determinò un’importante modifica del modo in cui si concepiva la possibile trasformazione della società. L’azione della controcultura nel tessuto della società contemporanea indicò la necessità di una compren-
sione politica più articolata dei rapporti sociali e delle realtà culturali
nei paesi capitalisti avanzati. Se la controcultura non riuscì mai a realizzare del tutto gli scopi che si prefiggeva, tuttavia pose una serie di quesiti decisivi nei confronti di una trasformazione così complessa come la
“rivoluzione”.
7 Mentre in California Frank Zappa stava “decostruendo” l’esperienza
musicale con i suoi collage, in una New York allora esclusa dalle mode
musicali, anche i Velvet Underground incominciavano a “decostruire”
in modo radicale l’esistente panorama dei suoni. Tuttavia, mentre
Zappa ricorreva a vari generi musicali, molti completamente estranei
all’esperienza del pop, il gruppo di New York rimase fermamente attestato entro i confini della pop song. Mobilitando gli sconcertanti personaggi e l’allucinante «rumore» delle strade di New York, ne scaturiva
una massa spinta ai limiti estremi e al di là delle facili definizioni. L’importanza di questo esempio non andò perduta in importanti settori del
pop del decennio successivo. Infatti, questa strategia diede i suoi frutti
nei gesti artificiali di David Bowie e dei Roxy Music, e più tardi nel caso
anche più significativo del punk. I Velvet Underground saranno esaminati nel prossimo capitolo, quando, negli anni Settanta, il loro effetto
ritardato sul pop comincia infine a essere notato su scala più ampia.
8 “Rolling Stone” fondato a San Francisco, apparve per la prima volta
nel novembre del 1967 come quindicinale dedicato ai suoni e all’etica
della controcultura e della sua “rivoluzione”. Fini col diventare il simbolo dell’editoria “alternativa”. Una crescente diffusione e le conseguenti pressioni commerciali del music business lo spinsero a cambiare impostazione e politica durante il periodo 1968-1973. Verso i primi
anni Settanta era ormai conosciuto come la principale rivista rock
americana. Ma adesso era la rivista “di mode per un pubblico bianco
middle-class ben più vasto e indefinito di quanto il termine controcultura possa far pensare. Oggi vende in media più di tre milioni di copie
per numero. Per ulteriori notizie cfr. Frith 1978, pp. 144-146.
87
9 Per esempio, il suono da locale R&B della Big Roll Band di Zoot
Money si trasformò nello spazio di una notte nell’abbagliante luce
stroboscopica dei Dandelion’s Chariot, Eric Burdon divenne un evangelista della West Coast che predicava acido e amore, e l’ex ragazzo prodigio degli Spencer Davis, Steve Winwood, si ritirò temporaneamente col
suo nuovo gruppo dei Traffic in un cottage di campagna, nel Berkshire
per “vederci un po’ più chiaro”.
10 Anche Hendrix sfoggiava un guardaroba da nero-pellerossa-zingaro,
fatto di capigliatura “afro”, amuleti, benda per capelli, frange, bigiotteria, fazzoletto colorato, stivali e ciondoli orientali. Insieme col suono
distorto della sua chitarra, anche questo abbigliamento alludeva a una
serie di riferimenti oscuri e marginali. Sembrava perciò quasi inevitabile che questa isolata superstar nera dovesse diventare un simbolico
crocefisso della controcultura bianca.
11 Per quanto riguarda i traumatici effetti provocati dall’eccidio di Manson sulla controcultura americana, cfr. Ewen 1972. Jeff Nuttall rilevò
un simile effetto raggelante sull’ambiente dell’avanguardia inglese, che
allora contemplava eventi quali “sventrare pubblicamente un cadavere
umano e lanciarne le budella al pubblico” (Nuttall 1972, p. 129),
quando fu colpito dai delitti di Moors del 1965. Ian Brady e Moira Hindley erano una coppia di “libettini” della classe operaia che tradussero
le loro sadiche fantasie nell’omicidio di due bambini e di un’adolescente. Essi registrarono su nastro le torture e l’omicidio finale della
giovane vittima. Due anni dopo Pamela Hansford Johnson (Lady
Snow) pubblicò On Iniquity, un libro che si proponeva di dimostrare
che Brady e Hindley erano gli inevitabili prodotti di una società permissiva.
12 Un anno dopo apparve il film Performance, con la presenza di Mick
Jagger e di James Fox. Diretto da Donald Cammell e Nicolas Roeg, il
film delineava i complessi legami tra il mondo di un prigioniero dell’universo del pop e di un deliquente londinese perseguitato dalle ritorsioni della malavita. Giocando con le identità, il film rappresentò un
interessante commento alla stilizzata amoralità che collegava profondamente le vite, a prima vista così dissimili, ma ugualmente consapevoli
della loro immagine, di una pop star e di un gangster.
13 Queste fasi particolari del rock progressivo fanno parte di un contesto del tutto differenziato da ciò che potrebbe essere definito il pop
“intelligente” degli anni Sessanta. Quest’ultima categoria spazia dal famoso Wall of Sound di Phil Spector, attraverso molte incisioni dei Beatles, degli Who, degli Zombies, eccetera, fino a gruppi americani come i
Vanilla Fudge. Queste musiche rimasero fortemente ancorate a un beat
insistente e a un suono “premeditato”, costruito dall’interno, piuttosto
che attraverso un classico sviluppo lineare (cfr. Chester 1970). Sono riconoscente a Simon Frith per avermi indicato questa distinzione.
14 Non tutti si accorsero di questi cambiamenti. Parte della critica ufficiale angloamericana fece un passo indietro rispetto alle rivendicazioni
“artistiche” più stravaganti e alla volgarizzazione dei tradizionali ideali
associati con la musica rock. Ma in genere ciò servi a poco. Mentre Van
Mortison poteva anche rappresentare una scelta critica, erano i Jethro
Tull, gli ELP, i Genesis, eccetera, che attiravano le folle più numerose e
alzavano il livello commerciale della musica progressiva. In Europa la
delusione per questi sviluppi fu spesso estrema. Molti critici europei
avevano preteso di più dal rock, avendo attribuito un profondo significato politico alla musica della West Coast della stagione 1965-1968: “la
pop music e il rock sono morti intorno al 1968-1969. Probabilmente a
Chicago (Agosto 1968)!” (Daufouy-Sarton 1972). Da parte di quegli
osservatori, le forze culturali e le intenzioni politiche del periodo 19651968 furono considerate sufficienti per consentire al rock di oltrepassare i limiti della musica commerciale, non tanto per esplorare le libertà dell’“arte”, quanto per porsi come avanguardia in quanto alternativa alla musica “capitalistica”. Ma le contraddizioni implicite in una
posizione del genere sono alla fine insostenibili. Com’era possibile che
la musica rock, con il suo modo di produzione e distribuzione, si sottraesse improvvisamente al restante mondo istituzionalizzato e capitalizzato del pop? Questo insistere su una alternativa puramente politica
88
significava che il rock successivo era semplicemente condannato a alternativa puramente politica significava che il rock successivo era semplicemente condannato a fungere da veicolo pubblicitario per i consumi più volubili.
89
C HAPTER 5
Tra i
frammenti
1971-1976
Sulla copertina dell’LP Space Oddity (1973), un terrestre
David Bowie lievemente allucinato, solleva gli occhi dalle sue
ciocche arancioni, per fissare lo sguardo nel vuoto. Sul retro si
vede l’esile figura del cantante con una tuta color argento aperta fino alla cintola. Il cantante ci osserva con sguardo interrogativo, il mento sollevato e le sopracciglia inarcate. Al collo è
appesa una collana con un grande ciondolo scintillante appoggiato sul suo petto color avorio. Seduto, con le mani strette tra
le cosce, le gambe divaricate, che si assottigliano verso il basso
dentro un paio di lucidi stivali rossi, Bowie si offre all’occhio
della macchina fotografica come immagine artificiale e inquietante. I suoi atteggiamenti femminili e il suo “look” stravagante parlano un linguaggio indeterminato, un codice androgino. Mala narcisistica atmosfera che quest’immagine
evoca è a sua volta assai ambigua. Oggetto del nostro sguardo
sconcertato, Bowie è nello stesso momento l’artefice dell’“immagine traumatica”. Una tale esibizione allude alla possibilità
di sciogliere il soggetto sessuale di genere maschile dai suoi
precedenti e più prevedibili vincoli.
L’irruzione del “glam rock”, il rock “scintillante”, o “glitter
rock”, nella rappresentazione della sessualità maschile, in cui
la camaleontica figura di David Bowie aveva una parte fondamentale, sembrò infrangere una fragile immagine repressa.
Tuttavia vari critici ribadivano che tutto ciò era soltanto una
manipolazione commerciale dell’ambiguità sessuale, un vacuo
travisamento. Visto in questa chiave il rock spettacolare diviene semplicemente un aspetto cospicuo di quella ritirata generale della musica pop dalle questioni più impegnate, una riti-
rata dalle più vaste aspirazioni della controcultura o dalle istintive affermazioni dei gusti e delle abitudini della classe operaia. Ciò che questa interpretazione non riesce a cogliere è
che all’interno del contesto culturale del pop nel suo rapporto
col sesso e con l’immaginazione erotica - le sue rappresentazioni e i suoi significati possibili - questa non può essere considerata una ritirata, caso mai si tratta di un ritorno ai referenti
sociali centrali di questa musica. Essa evidenziava “lo sviluppo
che aveva fatto delle caratteristiche sessuali un elemento fortemente agglutinante nella nostra cultura” (Weeks 1981, p. 287).
Ma questa è una valutazione del glam rock che è accettata solitamente con parecchie riserve. Era in altri contesti che questo
genere era considerato più innovatore. Nelle sue manifestazioni più sofisticate (Bowie, Roxy Music, Lou Reed), il glam
rock offriva una prospettiva estetica che era sensibilmente
diversa da quella della musica progressiva. La sua “qualità artistica” andava oltre i canoni estetici tradizionali, e come la
Pop Art era interessata agli aspetti appariscenti e superficiali
della moderna vita industriale e alla sua continua riproducibilità. L’atteggiamento retorico del rock progressivo che aveva
tentato di separare le esigenze di mercato dalle sue aspirazioni
artistiche fu bruscamente abbandonato. I due aspetti
venivano ora indiscriminatamente mescolati tra loro. In
questo modo, gli oggetti della vita quotidiana - il senso della
musica, del sesso, dell’arte e del piacere - venivano rielaborati
in modi poco ortodossi, da cui potevano uscire insospettati
suggerimenti. All’interno di questo processo, il “buono” e “cattivo” gusto furono soppiantati dalla confusione del kitsch e da
91
un viaggio verso le frontiere dell’eccesso: là dove un “ragazzo
matto”, “a-lad-insane” (David Bowie, Alladin Sane), poteva
continuare una perversa ricerca verso nuovi confini. La ricezione di questa musica non era basata sull’appello di un’estetica
astratta. La sua immagine avveniristica - un’esagerazione del
presente come anticipazione del futuro - esaltava contemporaneamente una tecnologia tangibile, la celebrità, e le prospettive commerciali. L’invasione dello spazio psichico e sociale da parte di queste realtà non fu respinta, come nel caso
della controcultura e del rock progressivo, ma fu accettata, assimilata ed esplorata.
Gli inizi degli anni Settanta erano tuttavia interessati ad altre
prospettive. Erano l’ante e la musicalità, piuttosto che il richiamo esplicito alla sessualità, i piaceri del kitsch e le distruttive teorie d’avanguardia, che davano il polso della situazione.
Fu l’astratta chimera dell’“arte” che permeava la musica di
gruppi quali gli Yes, i Jethro Tull, i Generis, Emerson, Lake &
Palmer e i Moody Blues, che continuò a esercitare una sproporzionata influenza sulla direzione e il senso di gran parte
della pop music, diffondendo canoni di giudizio e dividendo il
campo musicale in settori, spesso molto rigidi. Fino al trionfo
crepuscolare dell’ideale della musica progressiva, con Tubular
Bells di Mike Oldfield, questo rimase il settore privilegiato
dall’attenzione dei critici.1 Tra le intenzioni peculiari del rock
progressivo e il glam sofisticato, gli elementi più prevedibili
del pop continuavano a riprodursi. Nei primi anni Settanta
godettero persino di un
piccolo revival alcune varianti del blues elettrico. Alla musica
già consolidata dei Rolling Stones seguirono altre proposte
nella stessa vena blues, come quelle di Rod Stewart, dei Faces
o dei Free. Ma furono il sonoro, pulsante beat e le vistose
stravaganze della chitarra heavy metal che occuparono prevalentemente la scena del blues. Insieme con l’heavy metal e il
blues elettrico ci fu un ritorno di stili pop che esistevano
prima dei mutamenti dei tardi anni Sessanta: l’euforia da sabato sera del rock’n’roll dei Creedence Clearwater Revival, e il
malinconico lirismo pop di Elton John.
Ciò che appare più evidente in questo momento è la nuova
situazione all’interno del pop. Sotto l’ombrello della musica
progressiva tutti gli stili sopra menzionati formavano un consenso musicale (mainstream rock) che si considerava indipendente dal resto del pop. Nonostante i confini fossero spesso decisamente confusi, il rock in generale si considerava separato
dal mondo dello spettacolo televisivo. Questo significava che
mentre i divi del glam rock come Marc Bolan, o addirittura
Bowie, potevano anche rimanere casi ambigui, i Deep Purple
erano “in” e Tom Jones definitivamente “out”.
La musica rock si occupava sempre più dei suoi problemi interni. L’atmosfera più aperta e sperimentale degli anni Sessanta era scomparsa. Il rock stava ora prendendosi “sul serio”.
Uno dei prodotti più sintomatici di questa realtà fu la nascita
del critico rock professionista: il giornalista che lavorava non
solo nella stampa musicale, ma anche su riviste alternative
(“Time Out”, “Rolling Storie”) ed era pagato per esporre punti
di vista e teorie sul rock come un settore artistico particolare.
92
“ARTE”, “AUTENCITÀ” E “RADICI”
Mentre il beat e il R&B inglesi si erano ispirati a un contesto
particolare fatto di sale da ballo, club cittadini e scuole d’arte,
il rock progressivo con la sua base “underground” aveva le sue
radici fermamente saldate in una controcultura cosmopolita,
bianca, angloamericana, dagli obiettivi più globali e astratti.
In un omaggio a quest’ultima tendenza, The Age of Rock (sottotitolo: “Suoni della rivoluzione culturale americana”), il curatore Jonathan Eisen tratta la questione in termini decisamente teleologici. “Nell’insieme gli anni Cinquanta furono
musicalmente l’età della pietra la musica si ascoltava soltanto,
non si era ‘catturati’. Non era un’esperienza ‘totale’”. Verso il
1969, questa realtà era stata sostituita dal trionfale avvento
del rock: “Nato come ibrido tra il blues e il country-western è
divenuto ora una scuola che assorbe ogni tipo di musica, dal
blues al classico raga indiano, da Bach a Stockhausen” (Eisen
1969, p. XI). Evidentemente, era avvenuta una nuova e definitiva legittimazione del fenomeno.
Nell’ottobre 1970 comparve il primo numero di “Sounds”, un
settimanale di musica che si proponeva esplicitamente come
piattaforma della musica progressiva. Questa rivista avrebbe
poi influenzato sia “Melody Maker” sia il “New Musical Express”. Quest’ultima rivista assunse in seguito giornalisti della
stampa underground, e al pari del “Melody Maker” abbandonò la linea della musica pop della “via di mezzo”. Questa
trasformazione avvenne nonostante il fatto che molti artisti
dello show business e del pop tradizionale, come Tom Jones,
Peter and Lee, Engelbert Humperdinck, Perry Como, i Carpen-
ters, erano ancora ai vertici delle classifiche di vendita nella
prima metà degli anni Settanta. Un’attenzione così focalizzata
da parte dei giornalisti di queste riviste segnò, dal punto di
vista semantico, la graduale scomparsa del termine “pop” e l’adozione dell’etichetta “rock” o musica “progressiva”. Alla radio, la BBC continuava a offrire ben pochi spunti che riflettessero questo cambiamento, con la notevole eccezione della trasmissione del sabato pomeriggio di John Peel, Top Gear, che
veniva trasmessa a notte inoltrata durante la settimana. La
televisione, invece, riservava con Old Grey Whistle Test un
programma settimanale al rock progressivo sul più “serio” secondo canale televisivo.
Questo riconoscimento di una particolare area del pop era estremamente indicativo poiché sanciva l’ingresso di un nuovo
pubblico che sosteneva la musica rock, e sottintendeva che
l’area della musica pop era stata riorganizzata in campi e gusti
ben distinti. Da ciò derivò una serie di conseguenze ancora più
vaste. In primo luogo, a causa di questo orientamento “estetico”, vasti settori dell’esperienza musicale erano messi in
disparte dai critici della musica progressiva. Questo era vero
soprattutto per gli sviluppi contemporanei della musica nera
urbana. Era una tendenza ancora più sorprendente se si considera che la musica afroamericana di quel periodo non era interesse esclusivo di una ristretta minoranza, né era commercialmente irrilevante per un pubblico prevalentemente di estrazione operaia. Nel 1969, durante la fase trionfale della musica
progressiva, il soul e il reggae erano costantemente presenti
nelle classifiche inglesi e, più significativamente, nella musica
93
da ballo; tuttavia erano destinati a essere esclusi quasi totalmente dagli interessi della critica.2 La significativa assenza
della musica nera dall’area del rock progressivo fu a quel
tempo rilevata da Dave Morse: “I musicisti neri sono ora implicitamente considerati come i precursori che, avendo insegnato ai bianchi tutto ciò che sapevano, devono gradualmente
recedere, mentre la musica progressiva bianca, una volta imparata la lezione, avanza irresistibilmente verso il futuro”
(Morse 1971, p. 108). Opposto al talento “naturale”, ma tecnicamente limitato, della musica nera, il rock progressivo “deve
essere considerato come una forma d’arte” (Eisen 1969, p.
XII).
A questo punto si potrebbe essere tentati di affermare che
questo orientamento rappresentava la precipua prerogativa
del programma della musica progressiva: separare la sua
“arte” dalle esigenze del mercato. Questa tendenza sembrerebbe in parte confermata dal modo in cui i suoi sostenitori
tentavano di recuperare certi musicisti bianchi che erano rimasti vicini a un sound afroamericano. Con l’accusa di essere
“commerciali”, i musicisti neri erano sfavorevolmente confrontati con quelli che erano chiamati i “cantanti soul bianchi dagli
occhi azzurri”: “Perché il soul di oggi, la vera musica», è cantata dai bianchi. L’essenza del funk e del feeling arriva dai
bianchi.3 Era il soul e il R&B di Janis Joplin, Rod Stewart, Joe
Cocker e Van Morrison che veniva esaltato, mentre Ray Charles e Aretha Franklin, per non parlare dell’irrecuperabile scuderia della Tamla Motown, (con la sola eccezione del “progres-
sivo” Stevie Wonder) erano accusati di marcire ormai negli acquitrini della giungla commerciale.
La musica progressiva era intanto diventata un’importante opzione culturale per un pubblico orientato verso un futuro che
non aveva niente in comune con i gusti e le abitudini che avevano precedentemente caratterizato il pop. Le alterne fortune
della musica da ballo illustrano eloquentemente la situazione.
L’emarginazione della musica nera aveva comportato anche
l’esclusione di una danza stilizzata ad essa associata. La dance
music, naturalmente, non scomparve completamente. In
molti casi, l’emarginazione di questa musica servi a intensificare il suo significato e successivamente ad approfondire ulteriormente il suo rapporto con la musica nera in modi imprevedibili, per esempio col “Northern Soul”, con gli skinhead e il
reggae. Altrove, però, la musica progressiva esisteva in un contesto distinto dai più tradizionali luoghi del pop, le sale da
ballo, i coffee bar e i club cittadini. La musica progressiva era
usata prevalentemente in privato, chiusa tra le pareti di un
monolocale o fra un paio di cuffie, oppure in pubblico, nei
megaconcerti e nei festival. La musica pop, una volta rifiutata
dalla maggioranza degli studenti bianchi delle superiori, era
stata ripresa e trasformata nel nuovo universo simbolico della
cultura rock. L’attenzione rivolta al circuito universitario per i
concerti rock verso la fine degli anni Sessanta, qualcosa di impensabile solo cinque anni prima, era un fatto assai sintomatico di questo cambiamento. Questo fenomeno, la risonanza
internazionale dei festival rock estivi sempre più numerosi, e
la tendenza da parte della critica di parlare della musica pro94
gressiva attraverso “seriosi” criteri artistici, stavano a dimostrare che l’area del pop era stata occupata da nuove forze
culturali. Tale musica continuò a gestire il consenso su ciò che
era considerato “significativo” nel pop inglese, fino a quando il
“clamore” sconcertante del punk non venne a sconvolgere
questa situazione.
La musica “vera” o “autentica”, opposta a quell’impasto commerciale che era il pop, teneva in vita, anche se solo all’interno
di un’estetica astratta, i temi della musica e delle società alternative dei tardi anni Sessanta. Tutte le musiche che potevano
confluire in questa corrente, fosse per la loro “sincerità” artistica o per le loro radici culturali, erano accolte favorevolmente. Fu sotto questi auspici che il country, il country-rock e
i cantautori vennero alla ribalta nei primi anni Settanta. Sia
che si trattasse della calcolata maestria artistica dei Genesis,
del pulsante “Southern boogie” degli Allman Brothers, o dei
ruvidi toni country di Kris Kristofferson, tutti apparentemente
coesistevano nello stesso universo. “Arte”, “radici” o “autenticità”, facevano tutte fronte comune contro la “musica di consumo”. Questo era il denominatore comune di un fronte musicale altrimenti assai diversificato, che poteva includere Merle
Haggard, Robert Johnson e Bach, tutti uniti contro la Tamia
Motown. Nell’esprimere criteri estremamente astratti (che erano oggettivamente in aperta contraddizione con il ruolo centrale della musica progressiva nella strategia commerciale
dell’industria discografica di quegli anni), questa sembrava
un’obiezione intellettuale piuttosto sterile contro i piaceri viscerali da scoprire in altri settori del pop.
Se da un lato rimanevano saldamente all’interno del rock, sia i
cantautori sia le varie tendenze del country mostravano tuttavia di prendere le distanze dalla potenziale magniloquenza degli aspetti più elaborati che avrebbero caratterizzato molta musica progressiva posteriore. Ambedue continuavano tuttavia a
essere legali all’“unità estetica” progressiva personificata dal
“singolo musicista” (Christgau 1973, p. 232). Nel frattempo, la
musica propriamente country - il genere musicale più diffuso
e notoriamente più conservatore degli Stati Uniti - stava anch’essa sperimentando alcuni radicali mutamenti interni.4 L’emergere di una nuova generazione di cantanti country, come
Kris Kristofferson, Willie Nelson, Waylon Jennings, che erano
influenzati da certe idee della controcultura, e la vicinanza di
Bob Dylan e di numerosi altri gruppi rock alla musica country
dei tardi anni Sessanta, ebbero l’effetto di legare la musica
country al rock sotto diversi aspetti. I “fuorilegge” e gli eroi
dell’“honky tonk” che cantavano le nuove canzoni country indirizzavano il tradizionale “senso comune” di questo genere
verso orizzonti un po’ meno limitati e più illuminati, nei quali
si scioglieva in parte quell’immobilismo tipico delle “abitudini
del sud” (questi nuovi accenti sono bene in evidenza nel primo
LP di Kristofferson, Me and Bobby Mc Ghee).
La mitologia del cantante country lo dipinge come un giovane
che ha viaggiato molto, ha conosciuto la vita di città nei suoi
alti e bassi, ne ha assaggiato le droghe, ma in fondo è rimasto
fedele alle semplici virtù, come un osservatore di campagna
che esprime le sue contrastanti emozioni sul filo di una voce
rauca. A parte Dylan (John Wesley Harding, 1968, Nashville
95
Skyline, 1969), un altro importante contributo, anche se in
quel momento non fu molto notato, fu Sweetheart of the Rodeo (1968) dei Byrds. Dopo questo lavoro Gram Parsons lasciò
i Byrds, e cercò di orientare il country come “soul bianco”,
prima con i Flying Burrito Brothers e poi da solo, prima della
sua prematura e tragica morte. Mori infatti secondo la tradizione del musicista country ribelle (come Hank Williams), pieno di alcoolici e droghe nel deserto americano. A volte si
tratta di uno strano e contraddittorio panorama composo di
elementi insoliti. Sia il seguace autentico del “Grand Ole
Opry” di Nashville sia l’hippy irriducibile condividevano il
tema fondamentale di un populismo rurale indivualistico e la
speranza nella natura come rifugio dalla vita di città: era forse
un contraddittorio conservatorismo culturale dell’“anima bianca” americana?
La musica di Dylan, della Band e di numerosi gruppi californiani, come i Byrds, i Grateful Dead e Crosby, Stills, Nash and
Young, senza parlare della componente country nella musica
dei Flying Burrito Brothers, dei Poco e degli Eagles, era profondamente caratterizzata da chitarre rustiche e da armonie
canore. Una versione più vibrante del country rock usci dalle
viscere dello stesso Sud. Solitamente denominato “Southern
boogie”, questo genere fondeva insieme la musica country e la
musica nera in un sound elettrico senza pretese. Gli Allman
Brothers, i Lynyrd Skynyrd e la Marshall Tucker Band erano i
suoi più noti esponenti. Questi gruppi conservavano intatto il
“realismo” della musica country su ritmi rock, refrattario alla
sempre più asettica scuola della West Coast degli Eagles e di
Linda Ronstadt, che stavano conquistando il cuore del pop
americano bianco e un vasto pubblico attirato da un “facile ascolto” alla moda.
L’altra musica che aveva una profonda eco nell’“autenticità”
folk della musica country era quella dei cantautori. Non sorprende infatti che, quando non erano cantanti country, questi
cantautori venivano per la maggior parte dal movimento della
canzone folk degli anni Sessanta. Mentre in un certo senso
facevano parte del riflusso di quei giganteschi spettacoli elettronici lanciati sull’esempio di Woodstock, questi “poeti del
momento” (Graham Nash), come Neil Young, Cat Stevens,
Joni Mitchell, James Taylor, tuttavia partecipavano pienamente all’atmosfera culturale e all’“unità” della musica rock.
Le liriche personali e le insicurezze del maschio solitario, un
uomo e una chitarra, vennero a occupare certe posizioni più
spesso associate alla figura della cantante donna (il dubbio e
fautocompassione). Questa situazione estese anche le possibilità che si offrivano alle cantanti donne di elaborare un proprio
stile personale. Dai primi esperimenti di Judy Collins della
musica folk (In My Life, 1967), attraverso le biografie acustiche di Joni Mitchell fino alle sonorità urbane di Carol King,
Laura Nyro e ai lavori più tardi della stessa Joni Mitchell, la
vocalità femminile bianca iniziò a scrollarsi di dosso vecchi
stereotipi. L’immagine del cantautore, modesta e senza pretese, immersa nelle consolatorie nebbie dell’“arte”, si rivelò un
nuovo spazio particolarmente circoscritto alle cantanti desiderose di esprimere nuovi suoni e sentimenti. Ma una forma letteraria e spesso altamente sofisticata di musica femminile
96
iniziò a penetrare gradualmente nel pop proprio attraverso
questa via, come appariva evidente persino agli osservatori
maschi. Come ha osservato Robert Christgau a proposito della
ricorrente base autobiografica delle canzoni di Joni Mitchell:
“In un musicista maschio un’attenzione così intensa verso se
stesso sarebbe un’esibizione egoistica. In una donna è un atto
di sfida’ (Christgau 1973, p. 217).
iniziali. Nella successiva ricomposizione e nel riflusso, la musica pop emerse nel suo insieme sostanzialmente trasformata:
assai più ampia nella sua eterogeneità musicale, ma per il momento più esclusiva nelle sue divisioni interne.
È soprattutto nel contesto delle precise proposte artistiche e
musicali del rock progressivo - che si stava trasformando in
una nuova ortodossia nei primi anni Settanta - che si possono
meglio definire gli sviluppi del pop inglese. Alcuni di questi
ultimi continuavano a intrattenere un’ambigua relazione con
lo status e le regole artistiche del mondo del rock progressivo,
altri ne prendono decisamente le distanze. Tuttavia, sia che coinvolgesse l’esaltazione puberale del pop per giovanissimi (teenybopper), o la “sfera” caricaturale di un Gary Glitter o di un
Alvin Stardust, la cruda ossessività dell’heavy metal oppure le
sofisticate pretese di David Bowie e dei Roxy Music, tutto ciò
può essere visto come parte di una forte opposizione contro le
ambizioni più eteree della musica progressiva. Tuttavia,
questa musica continuò a influenzare molte di queste tendenze: insegnò indirettamente a David Bowie e ai Roxy Music,
per esempio, come associare il successo commerciale con una
ben pubblicizzata “scelta artistica”, stimolò il pop a incorporare i suoni “autentici” e i sentimenti della musica country, e
suggerì le formule iniziali per il rozzo populismo dell’heavy
metal. Ma oltre a ciò, spostò tutta la musica pop, compresa la
sua corrente principale, al di là dei suoi punti di riferimento
IL RIFLUSSO. 1: GLI HEAVY METAL
Profondamente endemico tra gli hippy e gli stili di vita della
controcultura si era rivelato un particolare aspetto del romanticismo maschile, ispirato all’iconografia dell’America ribelle
di Kerouac e Dylan, di James Dean e Jim Morrison. La strada
era la sua metafora centrale, e quelli “nati per essere selvaggi”
(Steppenwolf) si addobbavano con la tipica divisa da strada:
tessuti jeans e movenze ciondolanti, “erba” e gergo da marciapiede. Questa era “la cultura di strada che affascinava i
giovani di periferia, una versione romantica della cultura dei
gruppi giovanili della classe operaia” (Frith 1981, p. 167).
Quasi tutte le opzioni che si raccoglievano intorno alla musica
progressiva parteciparono a questo spirito romantico e alle
sue sfumature provocatorie. Lungo le autostrade del sogno e
nella gelida oscurità di bar immaginari, il country-rock “rilassato” degli Eagles o la musica muscolare dei Led Zeppelin, riconoscevano le donne (chicks, squinzie) solo come cartelli indicatori verso una malcelata misoginia. Ma fu l’heavy metal
che finalmente gettò la maschera ed eliminò tutte le ambiguità. Dal momento che erano necessarie le “palle” per
97
suonare questa musica, come ricordavano continuamente le
riviste musicali, furono poi definiti i riti celebratori di quello
che qualche osservatore aveva brutalmente denominato “cock
rock” (rock coi coglioni).5 Annunciato dal successo dei Led
Zeppelin verso la fine degli anni Sessanta e propagandato da
una grande quantità di gruppi dal sound più o meno simile,
agli inizi del decennio successivo, l’heavy metal, nonostante le
proteste di molti critici rock, fu senza dubbio un prodotto “mutante” della musica progressiva. Partendo dall’estetica di
quest’ultima, largamente fondata sulla chitarra (tecnica strumentale + pretese sofisticate = arte), l’heavy metal la trasformò con successo in un rumoroso e immediato populismo
musicale. La formazione classica di un gruppo di heavy metal,
derivata dal blues urbano, consisteva in una combinazione basilare di basso elettrico e batteria che produceva un martellante beat nel quale la voce e la chitarra solista si intrecciavano in un gioco narcisistico e rispecchiava un’aggressività
musicale e sessuale (cfr. Discografia). L’heavy metal aveva
inoltre rielaborato alcuni aspetti del primo movimento hippy
in una chiave più diretta. Per quelli che non potevano o non
volevano abbandonarsi alle utopie rievocate dalla “California”
o da “Katmandu”, questo stile proponeva un modo di vita più
concreto, strettamente legato alle emozioni immediate della
musica ad alto volume, alla birra e alle compagnie esclusivamente maschili. La sua rozza ed elementare poetica esaltava
senza pudori le qualità fondamentali della sessualità maschile.
Come notò il critico americano Robert Christgau, questa musica non era “sexy”, ma semplicemente aggressiva. Ai festival
di Reading, di Knebworth, e di altre località, si potevano vedere orde di maschi in jeans e capelli lunghi che consumavano
grandi quantità di birra e suonavano immaginarie chitarre in
un servile omaggio ai propri alter ego che si esibivano sul
palco. Il pubblico del’heavy metal era (ed è) composto da una
alleanza “popolare” tra studenti e operai trasandati, una sorta
di inaspettato connubio fra la cultura dei rocker e quella degli
hippy. Dal 1970, questa musica e il suo pubblico sono arrivati
a occupare uno spazio prominente e permanente nei gusti
della provincia. Il suo suono da “terra desolata.”, apparentemente immune dai rapidi sviluppi e dai continui mutamenti
che avvenivano nella metropoli, ha continuato a reclutare seguaci ovunque fino agli anni Ottanta. In questo senso non
sarebbe inesatto parlare del’heavy metal come di un’autentica
“corrente principale” della recente cultura rock.
Per molti critici, svezzati dalla musica progressiva e ora fedeli
alla sua causa, l’heavy metal rappresentò un importante punto
di rottura. Per costoro l’arte della chitarra, la ricerca estetica
del rock progressivo e l’impegno comunitario dei tardi anni
Sessanta erano stati evidentemente scambiati per l’ostentazione “insensata” di una tecnica incandescente e di un populismo di bassa lega. Ma la popolarità dell’heavy metal era innegabile. Il suo successo, più di qualsiasi altra cosa, frantuma
quelle illusorie barriere che il rock aveva professato di mantenere fra qualità artistiche e imperativi commerciali; e lasciò
gli ideologi della musica progressiva invischiati in un dubbio
irrisolvibile.6
98
Lo stile musicale e culturale dei Led Zeppelin e dei gruppi
heavy metal che apparvero con ininterrotta regolarità durante
gli anni Settanta ero stato forgiato, dopo tutto, proprio all’interno della musica progressiva. In particolare, questo successo
era basato sul trionfo del protagonista maschile con la chitarra. L’apprendistato di Jimmy Page negli Yardbirds insieme
con Jeff Beck, l’autorevole modello rappresentato dai Cream e
dal loro blues elettrico ad altissimo volume, organizzato intorno al virtuosismo chitarristico di Eric Clapton, per quanto
potessero diventare “volgarizzati”, erano troppo evidenti perché la comunità del rock progressivo potesse disconoscerli facilmente. L’heavy metal non era, come a qualcuno piaceva credere, uno sviluppo estraneo, ma semplicemente un esito.
IL RIFLUSSO. 2: IL “TEENYBOPPER POP’
Una volta mi innamoravo delle pop star, adesso mi innamoro della
gente. Quando si è innamorati, non c’è problema.
Una teenager (Cowie & Lees 1981)
Un nuovo segno della mutata geografia del pop inglese nei
primi anni Settanta fu il “teenybopper” pop. Questa musica,
ampiamente associata ai gusti delle ragazzine ancora adolescenti, aveva naturalmente dei precedenti. Negli anni Cinquanta lo spettacolo televisivo American Bandstand, trasmesso da Filadelfia, aveva imposto due ragazzi del posto, Fabian e Frankie Avalon, ai cuori delle americane giovanissime.
Verso la metà degli anni Sessanta, Hollywood aveva lanciato i
Monkees. Il gruppo era stato costituito, attraverso una calcolata operazione commerciale, come risposta ai Beatles, per
trarre profitto dai febbrili entusiasmi giovanili che il gruppo
inglese aveva generato. Dopo il loro esordio nel 1966 con uno
show televisivo trasmesso in Inghilterra dalla BBC, tutti i sabati sera i Monkees richiamavano un vasto pubblico, che si distingueva per la sua tenera età. Lo show era rivolto alle tipiche
reazioni delle ragazzine nei confronti del pop. Si rivolgeva a
loro come gruppo specifico e, seppur inavvertitamente, contribuì a far sì che esse si considerassero protagoniste che imponevano attivamente i loro gusti nel mondo della musica leggera. Questo era sempre accaduto, ma ora, con la decisiva
frammentazione che il rock progressivo stava imponendo sul
pop nel suo insieme, assumeva un tono più accentuato.
Mentre i ragazzi, soprattutto quelli della classe operaia, bighellonavano nelle strade, nei club e nei pub e a volte facevano musica assieme, le loro sorelle si trovavano da tutt’altra parte. In
particolare, le ragazze della classe operaia trascorrevano gran
parte del loro tempo libero entro le pareti domestiche, per lo
meno fino al breve momento del “corteggiamento”, quel “rapporto fisso” con qualcuno che è il preludio alla vita matrimoniale. In questo caso, il pop sembra sospeso in un transitorio
stato di liberti, fra la giovinezza e l’incombente futuro di mogli, madri e adulti “responsabili”. “Il matrimonio era qualcosa
in cui ci si trovava dopo aver vissuto” (citato in Cowie-Lees
1981). Il pathos implicito del romanticismo del teenybopper ha origine dalla consapevolezza che questo non può
99
essere eterno, ma è soltanto un momento di transizione verso
la sessualità adulta. Questa particolare esperienza, anche se
non corrisponde necessariamente a quella di tutte le adolescenti, resta comunque un modello di molte storie personali.
In questa situazione si manifestano forme di piacere e di fantasia femminile costruite in un clima di costrizione e in una realtà molto diversa da quella vissuta dai ragazzi. Questo non vuole dire che i “piaceri” femminili siano a questo punto automatici, come se la musica tennybopper fosse solo uno strumento
clandestino per insegnare alle ragazzine i requisiti culturali
della “femminilità”. Quale fosse il piacere che le ragazzine scoprivano in David Cassidy o negli Osmonds vedendoli a Top of
the Pops o su riviste come “Jackie”, questa resta una questione aperta. Non c’è bisogno di ricordare che l’impatto del
pop si nutre di ambiguità. Comunque, in questo caso particolare, esisteva un’importante interazione di propositi culturali
e rappresentativi tra il pop adolescenziale e la sua immagine
settimanale offerta da rotocalchi per le ragazzine quali
“Jackie”, “Mirabelle”, “Rave” e “Fabulous 208”. Un concordato tentativo di espellere queste ambiguità dal pop e dalla cultura femminile in generale è ben evidenziato nelle rubriche
dei consigli, nelle caute indicazioni sulla moda e nelle interviste a pop star maschili che inevitabilmente si concludono
sottolineando la loro implicita “normalità” morale. Per non
parlare delle esemplari censure imposte ai racconti “rosa” che
costituiscono l’ossatura centrale di queste pubblicazioni a
sfondo paternalistico.7 Negli occhi azzurri di David Soul una
ragazza poteva vedere una sicura indicazione verso una “nor-
male” sessualità femminile (cioè l’amore e il matrimonio), e
con questa la realizzazione di una tranquilla feliciti domestica,
in un quadro che rivela un ben preciso insieme di condizionamenti. Tali condizionamenti si rivolgevano in una direzione
molto diversa da quella indicata, per esempio, dalle ambiguità
maschili del glitter rock, o dal contradditorio, ma esplicito
gioco dell’indipendenza sessuale femminile rivelata nel soul e
più tardi nella disco music.
L’Olimpo musicale del teenybop consisteva di star maschili
spesso assai giovani: i Jackson 5, gli Osmonds, David Cassidy,
i Bay City Rollers e in un modo più indiretto, T Rex, Gary Glitter, gli Sweet. C’era scarsa unità di stile tra loro, a parte la ridondanza dei costumi di scena coperti di lustrini. I Jackson 5
erano indubbiamente “Motown”, un eccitante sound da ballo;
i Rollers (“Surf music scozzese”, secondo Gary Glitter) e gli
Sweet erano pop contemporaneo; gli altri tendevano manifestamente verso un genere nostalgico. Talvolta era semplicemente un recupero delle ballate di un’epoca precedente, più
legato allo show business, con le sue tranquille connotazioni
“romantiche”. Donny Osmond scavò approfonditamente in
questa direzione con una versione di ‘The Twelth of Never’, un
successo di Johnny Mathis degli anni Cinquanta; con ‘Young
Lover’ un successo di Tab Hunter del 1957; e con ‘When I Fall
in Love Again’, un successo di Nat King Cole dello stesso
anno. Anche se provenivano chiaramente da un’epoca precedente al pop, cioè dal mondo della musica leggera, queste canzoni non intendevano rappresentare un revival. Quello che
proponevano erano alcuni “momenti” sospesi al di fuori del
100
tempo, al di là del richiamo della storia: ‘The Twelth of Never’
non richiama il passato del pop, ma solo l’eterna attualità del
filone romantico.
Il concetto di “romantico” è ovviamente centrale nell’intera
struttura culturale del pop. È importante constatarlo e osservare che la passione romantica delle ragazzine per il pop teenybop in questo senso non è un’eccezione. Rappresenta un caso
particolare fra i tanti, in cui sono i ragazzi a essere altrettanto
coinvolti. In tutti questi casi, il romanticismo designa un complesso universo immaginario. Le prospettive che si offrivano a
molte ragazze della classe operaia rimanevano chiuse entro i
limitati orizzonti materiali e simbolici di una cultura locale,
che consisteva nella scuola del quartiere, nella convivenza con
i genitori, nella realtà della zona in cui abitavano e, tutt’al più,
in qualche club giovanile locale (McRobbie 1978b). Inevitabilmente intrappolato tra la brutalità sessuale dei ragazzi loro coetanei e l’apparente ineluttabilità di un futuro casalingo, il
periodo dell’adolescenza femminile considera le trascendentali possibilità dell’idillio romantico come suo territorio privilegiato in un modo specifico e unico. È questa dimensione
“magica’, insieme al rapporto con le amiche, la galleria iconografica delle star e la colonna sonora del pop romantico che accompagnano molte ragazze nel loro cammino verso la sola “legittima espressione della sessualità: il matrimonio” (McRobbie 1978b). È qui che le ragazze trovano un appuntamento
fisso tra i piatti da lavare e il bambino da accudire, nei ritmi
monotoni di Radio One. In qualche modo le altre possibilità
del pop sembrano essere andate perdute.
In questa situazione estrema ma diffusa, mentre in altri contesti, soprattutto in quello dell’educazione superiore, le donne
spesso riescono a esplorare possibilità più flessibili, il contradditorio processo di costruzione del piacere femminile rimane
in ultima analisi estremamente circoscritto. I richiami esterni
delle rappresentazioni sociali si uniscono per affermarsi prepotentemente, chiudendo il cerchio di una tradizionale identificazione sessuale e culturale. Infatti non si deve dimenticare che
una volta fatti i conti, presa visione dei compromessi e delle
vittorie parziali, le scelte e le possibilità più ampie - da quella
del chitarrista macho heavy metal allo scintillante stile androgino del glitter fino alla star gay della disco music - rimanevano sempre saldamente riservate ai ragazzi.
IL RIFLUSSO. 3: IL GLAM ROCK
Al centro dello spazio sociale si trova il corpo. Su di esso è inscritto l’ordine sociale in termini di rappresentazione della mascolinità/
femminilità, in termini di lavoro e di tempo libero controllato, e in termini di oggetti di desiderio istituzionalizzati.
Jonathan Miles, 1981
Attorno al 1970-1971, mentre il nucleo principale del rock progressivo continuava a gonfiarsi, arrivò il glitter o glam rock a
proporre una sensazionalistica estetica della “stranezza”. Dietro la sua conturbante teatralità, le maschere, il make-up, la
tintura per capelli, i tacchi altissimi e i costumi sempre di101
versi, il glam rock esibiva una gamma di motivi culturali assolutamente contraddittoria. Sfacciatamente vincolato alle pastoie dell’industria musicale, questo genere si dimostrò d’altronde una pungente e ironica risposta alle illusioni del rock
progressivo, e sollevò inoltre provocatori interrogativi sulla
sessualità e sullo stile maschile predominante. Ostentatamente sedotto dal suo stesso narcisismo, il glam rock sofisticato reclamizzava sapientemente l’artificio e la costruzione
della star. Con tutte queste intenzioni, il glam rock divenne
l’espressione più autocosciente del pop: tendeva a frammentare i vecchi modelli ricettivi, sia quelli semplicemente associati al “divertimento”, sia quelli recentemente acquisiti dal
regno dell’“arte”. Nello stesso tempo, gran parte del glam rock
era contemporaneamente popolare e tuttavia, nel suo stile
sofisticato, spesso faticosamente “artistico”. In questo modo il
glam rock accolse una varietà di influenze e un pubblico molto
eterogeneo. Forse il suo significato di fondo risiede nella sua
ricca e suggestiva “confusione dei livelli” (Ben Gerson).
Per molti, il glam rock rappresentò semplicemente una nuova
svolta stilistica e strategica nel pop: era soltanto l’ultima moda
che incoraggiava la fuga dai problemi immediati e da un facile
tipo di impegno. Dietro questa facciata, i vecchi ritmi musicali
e culturali sembravano continuare apparentemente imperturbati. In questo senso il glitter s’interseca frequentemente con
il più specializzato teenybopper pop. È vero che molti musicisti insistevano sui fondamenti della musica pop, sul suo
ritmo (Slade), sulla sua eredità R&B e soul (Rod Stewart) e sul
suo lirismo (Elton John). Talvolta, si trattava di un malcelato
revival, una scintillante parodia del rock’n’roll e del beat (Gary
Glitter, Alvin Stardust), altrove la sintesi era più sottile.
Quando il cantante Marc Bolan, ex mod, ex underground, si
presentò nel 1970 con uno stile elettrico lanciando i T Rex,
nella sua chitarra risuonavano gli echi dell’immediata eredità
di Jimi Hendrix, ma i suoi ritornelli provenivano direttamente
dal pop americano degli anni Cinquanta: quelli di Chuck
Berty, Eddie Cochran e Ricky Nelson. Dietro le quinte, comunque, fra i costumi e i macchinari dello spettacolo, c’era anche
un altro filone, un filone che rinviava la superficie del glam
rock a una vicenda più significativa.
Già nel 1966, New York - sempre più il simbolo della moderna
città in crisi minacciata dal tracollo - offriva, con la musica dei
Velvet Underground, una cupa alternativa all’aperto ottimismo della fiorente controcultura californiana.8 Come una
voce oscena, isolata, immemore di liberazioni utopistiche, la
musica del gruppo di New York sembrava destinata a percepire solo i fragili progetti di sfida e i piccoli piaceri agguantati
sulle “strade del vizio” della metropoli newyorkese. Se l’LSD e
la sua promessa di più vasti orizzonti era la droga della West
Coast, New York era l’habitat delle prospettive ultime dell’eroina. Era appena il 1965 quando i valori “di plastica” e l’estetica
“da buttare”, collegata a una visione catastrofica delle città
americane, fecero uscire il loro manifesto. L’Andy Warhol’s
Plastic Exploding Inevitable fu inaugurato a New York nel novembre di quell’anno: un evento multimediale che associava i
Velvet Underground, le luci stroboscopiche, la cantante Nico,
e i film di Warhol quali Eat, Sleep, Banana e Blow job. Non
102
esisteva il “pubblico”. Chiunque entrasse dalla strada si trovava istantaneamente e far parte dello spettacolo, ognuno diventava per un momento una star.
essere stata introdotta dal glam rock sofisticato.9 L’insegnamento era più o meno questo: è il gesto, la prospettiva del momento che può essere originale, non tanto l’oggetto.
Warhol e dietro di lui la Pop Art divennero un punto di riferimento di grande importanza per una ristretta ma significativa
area del pop. In quel periodo, l’influenza di Warhol su quella
musica era minima, a parte una breve e piuttosto oscura cooperazione coni Velvet Underground nel loro primo LP (completo della celebre banana di Warhol in copertina). Ma l’esplorazione delle possibilità ironiche ed espressive dei mass media
e della cultura di massa che il movimento della Pop Art americano e inglese avevano iniziato nel campo dell’arte figurativa e
iconografica avrebbe avuto indirettamente una profonda influenza. La riproduzione di riproduzioni - le serigrafie warholiane delle lattine Campbell o di Marilyn Monroe prodotte in serie - era un’esaltazione dell’artista come “ladro”, che rubava e
prendeva a prestito tecniche, suggestioni e immagini in ogni
campo della cultura contemporanea. Ma si trattava di un
“furto” produttivo e profondamente istruttivo. Si appropriava
dei sistemi semiotici della cultura di massa (pubblicità, cinema, fumetto, fotografia) e ne trasformava il significato, producendo messaggi trasversali che parlavano di essi stessi e
della loro collocazione nel mondo moderno: una lattina di
minestra riprodotta in un certo ambiente diventava così un’opera d’arte. Questa idea, insieme con un’altra profondamente
connessa, quella dell’individuo che costruisce se stesso quale
“oggetto autoreferenziale della sua arte” (Graham 1981), divenne un’importante tendenza prosaica del pop inglese dopo
La musica dei Velvet Underground era parte di questa “realistica” verifica urbana. Era una musica essenziale, ridotta ai
ritmi metallici delle chitarre, al “rumore” elettrico e a voci che
non avevano niente di umano. Il pericolo costante di cadere
nella cacofonia era controbilanciato dalle aspre monotonie e
dalle insolite associazioni di molte delle canzoni: ‘I’m Waiting
For The Man’, ‘Heroin’, ‘Sister Ray’. Questi tenebrosi oracoli
furono più tardi completati dalla violenza teatrale di Iggy Pop
and The Stooges di Detroit (‘No Fun’), e dai travestiti New
York Dolls (‘Personality Crisis,’ ‘Trash’, ‘Pills’). L’effetto
globale era quello di un suono “sporco”, East Coast, urbano;
un sovversivo sarcasmo musicale che gettava provocatoriamente un’ombra di dubbio sull’“autenticità” delle confessioni
dei cantautori e sulla “sincerità” dell’“arte” del rock progressivo.
In un clima crepuscolare di immaginazione alla deriva e di
crollo dei valori morali, l’estetica della spazzatura delle metropoli americane rivelò importanti punti di contatto con la “decadenza” europea in particolare, con il fascino morboso dei suoi
gesti stilizzati portati all’estremp. Alle vivide scene di canzoni
che parlavano di “vita da strada” americana, Bowie aggiunse
la fredda drammaticità di un futuro disumanizzato, mentre i
Roxy Music proponevano immagini patinate, icone seducenti,
come si vede nella musica e nella copertina dell’LP For Your
Pleasure (1973), che ironicamente non riflettevano altro che
103
loro stessi. La piattezza dell’artificio era paradossalmente la
sua espressione più profonda: la costruzione era svelata, i prestiti esplicitati e derisi, lo stile reso evidente.
Era soprattutto Bowie (per ammissione dello stesso) il capo di
questa banda di “ladri”. Le sue canzoni erano come film in
miniatura, dove “la macchina da presa è l’occhio di un avvoltoio in cerca di preda” (William Burroughs), come strisce piene di immagini sconcertanti che sembravano voler associare
i fumetti della “Marvel” e le escatologiche visioni dello scrittore americano William Burroughs. Nei primi anni Settanta le
canzoni e le maschere di Bowie furono diffuse attraverso una
serie di personaggi sessualmente ambigui, come Ziggy Stardust, Alladin Sane, i Diamond Dogs, che si muovevano attraverso flash temporali e immagini disparate e urtanti, come le
bande di giovani guerrieri omosessuali del futuro che scorrazzano nel romanzo di Burroughs The Wild Boys (1973). Queste
canzoni emergono come un inquietante montaggio che accompagna la musica di Bowie dal primo Man of Words, Man of
Music del 1969 (titolo originale di Space Oddity, ripubblicato
nel 1973) fino al momento in cui chiude questo periodo della
sua carriera di mannequin con Diamond Dogs (1974) e lascia
un futuro fantascientifico per indossare l’uniforme del White
Soul Boy, del nevrotico funkster e di un dandismo malinconico.
Sia con Bowie sia con il suo protetto Lou Reed (Bowie produsse Transformer nel 1972), un miscuglio musicale di luoghi
comuni - le strutture ortodosse della canzone pop, i timbri e la
strumentazione spesso tipica dell’hard rock - e di insolito (im-
magini suggestive prese dagli angoli più bui della notte cittadina) si focalizzava provocatoriamente sulle ambiguità della
sessualità maschile. Bowie, Lou Reed e l’immagine androide
di Brian Eno dei Roxy Music rappresentavano abitudini e
modi di vita del tutto estranei all’immaginazione comune, erano “extraterrestri” in tutti i sensi. Nel fare proprie le ambiguità dell’ermafrodito, del travestito, del bisessuale e dell’omosessuale, essi apparivano come “eroi proibiti” la cui “passeggiata nella zona malfamata” (Reed) confrontava il normale
panorama del pop con le suggestioni sovversive di una incerta
sessualità maschile. Anche se era stata già suggerita dalla gestualità di Jagger e dallo stile più rilassato e sommesso degli
hippy, furono Bowie e Reed che raffinarono e articolarono
questa possibilità a un livello così acuto e sconcertante. La rassegnata malinconia della Berlino di Weimar, o i freddi splendori di una futuribile New York decadente, costituivano lo
sfondo che stimolava l’apparizione di quello che in precedenza
non era stato detto. Le culture giovanili di stampo maschile
venivano messe di fronte a ciò che più poteva minacciarle: i
segni mutanti e inafferrabili, ma concreti (nella musica, nei
vestiti, nel corpo), di un’incerta “mascolinità” proiettata da
quegli umanoidi androgini che “erano caduti sulla terrà”.10
Quello che era un muto romanticismo maschile iniziò ora a
parlare con toni confusi e contraddittori. La stabilità di una
sicurezza sessuale da sempre rispettata era minacciata da un
futuro ambiguo.
Il glam rock era dopotutto un autoreclamizzato rifiuto della
“realtà” una luccicante facciata che continuamente sfuggiva a
104
un esplicito contesto. Eppure, al suo interno, sepolto nel suo
ricercato solipsismo, nelle sue maschere fugaci e nella studiata vacuità, si può rintracciare la presenza tangibile di forze
più ampie. È significativo il fatto che i radicati stili sessuali
della controcultura metropolitana e lo stile glam rock condividessero un terreno comune nel momento in cui un narcisismo apparentemente “privato” si trasformava in una rappresentazione pubblica e si rivolgeva a un palcoscenico più vasto.
La rappresentazione pubblica della sessualità - dalla pubblicità al cinema - aveva fatto passi da gigante nei “swinging sixties”. Era stata accompagnata, o incoraggiata secondo giudizi
maliziosi, da una serie di riforme illuminate che riducevano i
controlli sulla condotta sessuale privata e sulla moralità
pubblica.11 Questi sviluppi stavano ora incontrando una crescente resistenza. Nel clima di rigore che caratterizzava il governo Heath (1970-1974), e grazie al giro di vite della moralità che accompagna invariabilmente l’incombere di una
crisi, le esaltazioni pubbliche dell’edonismo sessuale furono
decisamente contestate. Si affermò che il “permissivismo” si
era spinto troppo oltre. Il “prezzo” per riprodurre la società inglese, che comprendeva anche la libertà del cittadino di
muoversi non solo fra i beni di consumo ma anche tra quelli
morali, si stava dimostrando troppo alto. Di fronte a una crisi
economica internazionale che si ripercuoteva su un’Inghilterra ovviamente impreparata, gli spazi per gli esperimenti sociali iniziarono a restringersi, i confini precedenti vennero
respinti indietro e le prospettive ridotte, mentre i solidi valori
della “tradizione” serravano le fila.
Davanti a queste minacciose prospettive, le “frivole” proposte
di Bowie, Reed e Roxy Music, non sono semplicemente una
facile evasione, ma fanno presagire una “pericolosa affermazione” (David Bowie). La straordinaria attenzione che questi musicisti del glam rock dedicano “alle apparenze esteriori del ruolo implica che i ruoli, e, in particolare, quelli sessuali, sono
superficiali, una questione di stile” (Dyer 1979a, p. 67). Era
questo aspetto apparentemente sotterraneo che indicava un
possibile senso più profondo del glam rock. Proporre ambiguità sessuali, e quindi indirizzare l’attenzione pubblica verso
aspetti dettagliati della sessualità è un fatto che merita qualche commento, proprio quando una nuova, autoritaria moralità si diffondeva nei vari settori della cultura inglese: processando per oscenità, “facendo pulizia” alla televisione;
promuovendo campagne contro l’aborto, riaffermando una visione tradizionale della sessualità, e producendo quindi un’enorme ondata di riarmo morale. In una maniera tangenziale e
confusa, il glam rock intendeva dimostrare che la presunta
“privacy” della questione sessuale, era soltanto un’illusione.
La sessualità era parte della sfera pubblica nello stesso modo
della politica, delle classi sociali e delle sottoculture. Questa
realtà si dimostrò assai scomoda da accettare anche da parte
di molti radicali, oltre che dai crociati della moralità.
Fu Bowie, soprattutto, che guidò la trasformazione delle immagini di insubordinazione e di resistenza in uno sfoggio delle
ambiguità sessuali maschili: nella musica rock (Ziggy Stardust and The Spiders from Mars, 1972) e poi con la disco music di Young Americans (1975), prima di passare agli esperi105
menti col funk. Per i critici più accaniti di Bowie e del glam
rock, era difficile riconoscere il fatto che il loro pubblico era
costituito soprattutto da teenager bianchi appartenenti alla
classe operaia. Il glam rock era un “culto centrale” nella cultura dei giovani di estrazione operaia (Taylor-Wall 1976, p.
106). Gli stessi commentatori ammisero inoltre che la fantasiosa “vita notturna” che Bowie e i suoi simili avevano prospettato, “offriva alla gioventù operaia in generale, e ai ragazzi in
particolare, un modo di consumare il tempo libero che non rientrava affatto nelle tradizionali istituzioni di classe” (ivi, p.
109). Per quanto possa sembrare strano a prima vista, il prodotto in vendita e il glam rock rappresentavano vistosamente
un “sound commerciale”, che spesso offriva potenziali espressivi e immaginativi più ampi rispetto a quelli contenuti all’interno degli angusti percorsi culturali e delle ristrette prospettive dei suoi diversi tipi di pubblico.12
Nella vita quotidiana, la mappa culturale del glam rock era
destinata a rimanere limitata per lo più alla geografia interna
della musica pop. I tentativi fatti per tradurre i suoi gesti fantasiosi nelle più rigide rappresentazioni della cultura quotidiana
spesso incontravano la risentita reazione maschile:
Una sera al “Wall” di Monmouth Estate arrivò Tommy che sembrava
David Bowie, con tanto di make-up e capelli striati. Coro di fischi, ululati e beffe dalla banda del “Wall”. Poi Mick, che era un caro amico di
Tommy, ma adesso è più affezionato alla sua motocicletta, comincia a
provocarlo: “Dove hai lasciato la tua borsetta, cara?”, “Esci col tuo
uomo allora?” (Robins-Cohen 1978, p. 81).
La tendenza a giocare con la “mascolinità” era ancora destinata a rimanere una scelta più immaginaria che reale per la
maggioranza dei ragazzi, “presi dalle loro motociclette”.13 Tale
proposta aveva comunque allargato la sfera dell’immaginazione pubblica diventando una presenza costante nel futuro del
pop.
A questo nuovo senso di instabilità contribuivano le continue
metamorfosi pubbliche di Bowie: Ziggy Stardust, Alladin
Sane, il White Soul Boy, l’emigrato berlinese. Questi personaggi evidenziavano quella possibilità prefigurata da Warhol,
secondo la quale ognuno poteva essere una star per quindici
minuti, “un eroe solo per un giorno”. Se tutto è “falso”, “un’illusione” di immagini costruite dai media, allora questa diventa,
a sua volta, la base di una nuova “realtà”. Certe volte questa
iconografia sembrava prendere direzioni allarmanti: i Roxy
Music in uniforme nazista, oppure “Hitler fu la prima superstar. Lo faceva proprio bene” (David Bowie). Ma i travestimenti continuavano a mutare, e le loro più ampie connotazioni storiche erano quindi ostinatamente ignorate. Non erano
affermazioni sul mondo, quanto momentanei gesti di provocazione. Non “rappresentavano” nulla al di là di se stessi, poiché
tutto era concentrato nella possibilità dell’immagine: un’accurata costruzione rivelata nell’autocosciente abilità dei personaggi di David Bowie e di Brian Ferry. Bowie, con i suoi capelli
tinti, il make-up e la calzamaglia “da marziano”, Ferry con un
ardito abito da sera e un atteggiamento da tardi anni Quaranta, Reed, il poeta della spazzatura, col suo volto cinereo dietro gli occhiali scuri, e con i capelli ossigenati: questi erano gli
106
artisti che costruivano l’immaginq pubblica di sé. La loro definitiva profanazione della star era ostentata ironicamente attraverso la pura e semplice esagerazione dell’immagine costruita.
Nella sua musica, questa corrente del glam rock rifuggiva dai
semplici nessi logici e dallo spirito di revival del più ordinario
glitter rock, a favore di un fragile, mutevole collage di ricercati
effetti musicali. Sia Bowie sia i Roxy Music ripulirono il terreno musicale postprogressivo con un’impressionante serie di
composizioni che si ponevano come commenti ironici nel momento in cui producevano ad arte i loro personali itinerari musicali. Bowie proponeva un’estetica della frammentazione musicale e culturale che andava dai suoni hard rock di The Man
Who Sold the World (1972) al “plastic soul” (sua definizione)
di Young Americans (1975), fino ai tormentati esperimenti
funk di Station to Station (1976). In un modo meno intenso
ma più stravagante, i Roxy Music esplorarono l’eredità degli
anni Sessanta. Essi produssero un frenetico bricolage di
suoni, timbri e stili assimilai da fonti diverse. La novità, abilmente sintetizzata ed evidenziata nei loro primi album, consisteva precisamente nella insolita giustapposizione e attenuazione di elementi già esistenti. Il fascino dell’immagine e della
potenziale metamorfosi dell’artista che si esercitava sul glam
rock era una sorta di ossessione in perfetta sintonia con la sua
musica.
Ironia e immagine sono temi molto familiari. La loro innegabile centralità, nella sofisticata estetica bianca del glam rock,
alludeva in ultima analisi ad altri spazi culturali e altre so-
norità. Nonostante fosse stato bandito dall’attenzione critica
della musica progressiva, il soul moderno aveva continuato a
proseguire la sua strada per conto proprio all’interno del pop
fra i tardi anni Sessanta e i primi anni Settanta. Verso il 19741975 il giovane lettore, solitamente bianco, di “Record Mirror”, scopriva la disco music nelle pagine scritte come sulle
piste da ballo. Nel frattempo gli stilisti di club come il Crackers, il Global Village e altri posti di Londra, ballavano al suono
più “hot” dei ritmi importati dagli Stati Uniti. Nel nord, questa
musica era il sound per antonomasia del sabato sera (e della
domenica mattina per i nottambuli) e dappertutto, in una variante o nell’altra - Tamla, Stax, “Philly Sound”, “Northern
Soul”, disco music - era la musica per ballare.
Accanto alla meticolosa gestualità di Bowie e alla sua gelida,
estrema stilizzazione, l’abbagliante frenesia del soul e della
disco music americana sembrava far parte di un altro mondo.
Ma la comparsa di Young Americans, l’album di “disco music
d’avanguardia” di Bowie (Peter York), rivelò nel 1975, in modo
sensazionale, un legame insospettato. L’LP, registrato nei
Sigma Studios di Philadelphia - il quartier generale del “Philly
Sound” - fu determinante nel portare la disco music al pubblico prevalentemente bianco di Bowie. Occupando una posizione intermedia fra un atteggiamento artistico ricercato e un
mitizzato “cool” associato all’immagine del nero di città, David
Bowie fu uno dei primi artisti bianchi ad aprire un importante
spazio fra gli esperimenti della musica bianca e i timbri delle
musiche nere contemporanee. Questo segnò il riconoscimento
107
del ritorno dell’esclusa e sepolta musica “esotica” alla legittima attenzione del pop bianco.
quello migliore, perché dà voce a tutte e due le facce del populismo:
quella democratica e quella fascista” (Christgau 1973, p. 202). È indubbiamente il più vecchio e celebre tra i vari generi della musica popolare
bianca negli Usa. Per ulteriori particolari, cfr. B. Malone, Country Music Usa (1968) e per una visione molto diversa il film di Robert Altman
Nashville.
NOTE
5 Cfr. McRobbie-Frith 1978 e la risposta di Taylor-Laing 1979. Tra i
primi a essersi soffermati su questa dimensione nella musica rock è
Christgau 1973, pp. 113-118.
1 Sebbene uscito nel 1973, Tubular Bells rimase tra gli LP più venduti
in Inghilterra nel 1974 e nel 1975. Composto unicamente da Oldfield, il
disco è una summa di molti degli ideali artistici e tecnologici della musica progressiva. Questo LP fece la fortuna della Virgin Records, da
poco fondata.
2 Tra i principali sound neri del 1969 vi furono i classici I Heard It
Through the Grapevine e Too Busy Thinking about My Baby di Marvin
Gaye. Nel frattempo dalla Giamaica venivano i successi di Desmond
Dekker con The Israelites e It Mek, degli Upsetters con Return of
Django e di Harry J and the All Stars con The Liquidator.
3 Royston Eldridge sul primo numero di “Sounds”, 10 ottobre 1970.
4 La capitale della musica country è Nashville, Tennessee. Bakersfield,
il luogo natio di Merle Haggard e di Buck Owens è il centro della musica country californiana. Non è questa la sede per addentrarci nell’intricato territorio della musica country americana, se non per sottolineare la sua persistente influenza sullo sviluppo del pop bianco americano: dalla nascita del rock’n’roll fino agli anni Ottanta e alla rassegnata nostalgia e solitudine del “Country boy” di Bruce Springsteen in
Nebraska (1982). Collocata in una subalterna cultura del Sud bianco,
la musica country si propone di essere “jeffersoniana”, ovvero di esaltare l’individualismo democratico. Tuttavia essa si rivelò più di una
volta “jacksoniana - intensamente sciovinista, razzista, schierata dalla
parte della maggioranza e antiaristocratica, nel senso peggiore come in
6. Quando erano anche quelli di maggior successo commerciale (i
Cream, per esempio), la distinzione era irrilevante. Ma l’enorme successo commerciale degli Zeppelin, nonostante una critica sfavorevole,
rivelò una profonda divisione in un pubblico che un tempo era considerato omogeneo. Questa distinzione è ora diventata una divisione tra
un gusto di massa ben definito e un gusto elitario altrettanto ben definito.” (citato in Shepherd et al. 1977, p. 189). Limitando agli LP, secondo la migliore tradizione del rock progressivo, la loro produzione discografica, ciascuno dei primi sei album dei Led Zeppelin vendette più
di due milioni di copie. Nel 1972, anno in cui non produssero nessun
materiale nuovo, gli Zeppelin rappresentarono il diciotto per cento
delle entrate della Atlantic Records (cifre tratte da Palmer 1977, p.
276).
7 A questo proposito attingo direttamente dagli argomenti e dalle ricerche di Angela McRobbie sulle riviste femminili delle teenager inglesi
(McRobbie 1978a).
8 Esiste un’importante rete di collegamenti stilistici qui con il romanticismo straziato di Patti Smith e la poetica “di strada” di Bruce Springsteen.
9 Questi concetti autoreferenti erano le volubili immagini di David
Bowie e di Lou Reed, le ironiche e patinate confezioni dei Roxy Music
e, in modo più indiretto, le successive maschere facciali e il caleido108
scopico abbigliamento del punk e di quelle manifestazioni postpunk
come i new romantics, “tre volte rimossi dalla finzione» (Steve
Strange).
10 Diretto da Nicolas Roeg, il film L’uomo che cadde sulla terra rappresenta efficacemente David Bowie come un umanoide extraterrestre
privo d’espressione, che si muove in una sceneggiatura di fantascienza.
11 Tra le riforme liberali introdotte dal governo laburista del tempo ci
furono la legge sull’aborto del 1967, la legge sui reati sessuali dello
stesso anno, che depenalizzava le attività omosessuali maschili compiute in privato, l’abolizione della censura sul teatro nel 1968 e la riforma del divorzio nel 1969.
12 Non è un caso se molte delle più approfondite ricerche sulla trasformazione dei beni di consumo in segni ed espressioni culturali ricchi di
significato sono state quelle che esaminavano le particolari condizioni
ed esperienze di coloro che sono generalmente considerati i più “passivi” nel loro uso, le donne. (Cfr. Winship 1981). Dal momento che la
commercializzazione della cultura di massa è in atto da almeno un secolo o più in Inghilterra, il vero problema non è stabilire se questa tendenza esiste, ma in quale modo essa esiste.
13 Sulla costruzione della “mascolinità” nell’esperienza scolastica dei
ragazzi della classe operaia, cfr. il significativo libro di Willis (1977),
che dovrebbe essere letto parallelamente all’importante critica di Angela McRobbie sull’orientamento maschile degli studi sulle sottoculture (McRobbie 1980).
109
C HAPTER 6
La
liberazione
dall’oscurità:
le musiche
nere
1966-1976
Africa? Africa? Africa? Basta che l’accenni, amico, ed è come se chiamassi il mio nome.
Dennis Brown
... non ci sono altre storie da raccontare, è l’unica luce che illumina la
nostra oscurità.
James Baldwin
Storie separate e dimensioni frammentarie: persino oggi,
dopo più di un decennio di alterne vicende nel mondo del pop
bianco, sembra giustificato parlare della musica reggae in
questi termini. Ma che dire della musica soul? Fin dagli anni
Sessanta, il soul ha sempre fornito la base per la musica da
ballo in Gran Bretagna ed ha riscosso una serie continuativa
di successi commerciali ora con questo, ora con quell’altro genere. Eppure, intrecciato nel tessuto storico di queste musiche, del soul in un modo, del reggae in tutt’altro, c’è un senso
semantico culturale nascosto che sfuggiva costantemente
all’occhio superficiale intento solo a percepire l’evidenza. La
musica soul in Gran Bretagna ha sempre mostrato una molteplicità di aspetti - dal successo commerciale della Tamia Motown e del Philadelphia Sound a un culto regionale in gran
parte ignorato. Dalle Supremes, i Jackson 5 e gli O’Jays, attraverso Millie Jackson e Bobby Womack, fino ai suoni sofisticati
del Northern Soul dei Prophets o di Richard Tempie, la musica soul ha rappresentato un persistente e oscuro contrappunto agli sviluppi che si verificavano in altri ambiti del pop
britannico. Sebbene spesso offuscato dal fastoso e scintillante
spettacolo del pop bianco (progressive music, glam rock,
heavy metal), nel decennio 1966-1976 fu il soul che monopolizzò i ritmi del ballo, soppiantando quel precedente fenomeno di breve durata che fu il twist e anticipando la successiva esplosione della disco music.
L’immaginazione “oscura” del soul e le allettanti seduzioni offerte dalle strade al neon che illuminano le notti e i divertimenti in America, riempivano le sale da ballo dei vari Mecca,
Locarno e Top Rank, e ampliavano le prospettive del fine settimana. Era in questi spazi e queste abitudini, diffuse in ogni
città inglese e inevitabilmente connessi a una settimana lavorativa faticosa e spersonalizzante, che la musica progressiva riusciva raramente a penetrare. Una singolare coincidenza a migliaia di chilometri dai ghetti settentrionali degli Stati Uniti: la
torrida zona dove si produce l’odierna cultura popolare nera
americana e la musica soul.
Per un breve periodo i mod avevano già tracciato un viaggio
simbolico che sembrava ingegnosamente condurli più vicino
alla realtà chiaramente diversa dell’America nera. Ma il loro
stile “cool”, tipicamente bianco, impeccabile e meticoloso, necessario a quelle attitudini in cui le aspre dissonanze si armonizzano quasi per magia, alla fine risultò troppo arduo. Tuttavia,
aveva stabilito un importante precedente, che non andò perduto per un pubblico più vasto.
Largamente limitata al campo musicale, al collezionismo di
dischi rari e al ballo, la tradizione dei mod fu continuata soprattutto nei club e nelle sale da ballo del Nord. I “duri” successori diretti dei mod, gli skinhead, fecero una esperienza simile
111
con il reggae giamaicano alla fine degli anni Sessanta. Tuttavia, per ragioni interne, il reggae delle comunità nere della
Gran Bretagna si trasforma ben presto in ritmi più profondamente neri, lasciando gli skin prematuramente isolati nella
loro rabbia di bianchi rimasti senza voce. Nel frattempo il soul
aveva oltrepassato i fragili confini della precedente sottocultura mod per raggiungere le discoteche della Gran Bretagna e
divenire finalmente l’indiscussa dance music di ogni locale
pubblico. Se il rock progressivo era facilmente identificabile
con un particolare gruppo sociale, altrettanto poteva dirsi per
il soul. Alle feste studentesche i ragazzi soli o in coppie, si
muovevano lentamente, un po’ “fatti” e con gesti spesso impacciati, al suono degli Stones o dei Santana. Sulle piste da ballo
dei locali pubblici erano invece il passo veloce ma cadenzato
della classe operaia e il movimento misurato in precise figure
di danza, che sperimentavano gli inesauribili ritmi di ‘Ain’t No
Soul Left in These Old Shoes’ di Major Lance o di ‘Here I Go
Again’ di Archie Bell and the Drells.
La musica soul e, ancora più evidentemente, i testi indecifrabili e i ritmi decentrati del reggae, venivano da “altrove”. In
ciò consiste parte dell’attrazione che sercitava sui suoi appassionati di razza bianca. Sebbene apparentemente legata all’abbigliamento sgargiante e alla febbre da ballo dell’Highland
Room, della Mecca di Blackpool o del Countdown Club di Londra, la forza culturale della musica soul era anche la prova che
esisteva un”`altrà cultura che non era stata completamente
soffocata, quella del primo continente del soul, l’America
nera.
I DUE CONTINENTI DEL SOUL
A volte mi sento tosi bello e simpatico. Buon Dio! Faccio un salto all’indietro.
Mi darei quasi un bacio.
Ho un’anima
E sono super cattivo.
James Brown, ‘Superbad’
Non volevamo avere niente a che fare con la musica progressiva. Così
ci attaccavamo al soul. E il tipo di soul che volevamo erano balli veloci.
Lavoriamo sodo, maledettamente sodo e vogliamo lavorare sodo sulla
pista da ballo. Più è veloce, meglio è.
Citato in Cummings 1975a
Il persistere della musica soul durante gli anni Sessanta e nel
decennio successivo (considerando la disco music come legittimo prodotto del soul) è un avvenimento così importante che
quasi sfugge a un tentativo di analisi. Questa non dev’essere
però intesa come una monotona produzione musicale. Una frenetica miscela di diversi generi di soul regionale americano durante gli anni Sessanta, l’incentivo a espandere le possibilità
tecniche nello studio di registrazione e i fondamentali cambiamenti avvenuti nell’“ideologia” del soul (Charles Keil), si combinarono per dar luogo a un complesso e mobile panorama sonoro in via di sviluppo. Dietro ai collaudati stili musicali della
Tamia Motown, Stax, Atlantic, Philadelphia e delle centinaia
di piccole case di produzione indipendenti nere che sorsero
negli anni Sessanta,vi era il ricco intrecciarsi dell’anima sacra
e profana dell’America nera. La solidarietà e la forza culturale
dei neri contenuta nella musica gospel della chiesa e della
112
comunità nera furono raccolte e trapiantate su ritmi “profani”,
dando origine alla “comunità del soul”. Molti cantanti R&B e
soul avevano fatto in gioventù l’esperienza diretta del gospel.
Ray Charles prese spunto da un gospel come ‘When I’m
Lonely I Talk to Jesus’ per trasformarlo in ‘I Got a Woman
over Town’ e secondo le stesse parole di Big Bill Broonzy, egli
cantava i blues “come se fossero santificati”. Solomon Burke
cantava ma anche predicava ‘Everybody Needs Somebody to
Love’, mentre gli Staple Singers declamavano il gospel “profano” ‘Respect Yourself’.
Così il soul celebra il connubio tra le due grandi tradizioni musicali afroamericane: il blues e il gospel. Dal gospel la musica
soul prese l’uso di uno schema armonico ripetitivo, che
spesso ricorreva soltanto a un paio di accordi, il cosiddetto armonico “ostinato”. Sulla canzone incombeva continuamente
una conclusione che non giungeva mai, gli accordi arrivavano
a un punto di massima tensione per poi ricadere nuovamente.
Tutto ciò produceva spesso una struttura apparentemente
“senza tempo”, disciplinata più da una diffusa pulsione che da
un evidente senso del “beat”. Allo stesso tempo, la tendenza
afroamericana di “diffondere” la musica verticalmente, venne
ulteriormente accentuata dalla pratica di ridurre più note in
un’unica sillaba cantata, il cosiddetto “melisma”. La conseguenza di questi vari prestiti fu che la tradizionale e rigida nevrosi armonica delle dodici battute del blues e la compatta struttura del R&B tendevano ad allentarsi. Si introduce così una
più aperta e incalzante pulsione musicale. Entro questa strut-
tura il cantante scopriva nuove possibilità di esplorare la propria voce.
Nel 1956, il giovane James Brown and the Famous Flames incisero ‘Please, Please, Please’. Fu il loro primo successo, e consisteva quasi interamente nella ripetizione della parola
“please” cantata da Brown. Vent’anni dopo, la parte vocale
della versione disco music di ‘I’ve Got You under My Skin’, interpretata da Gloria Gaynor, si basava principalmente sulla
frase “I’ve got you”. In ambedue i casi, l’esplicita ripetizione
della parola è subordinata al carattere fisico e personale della
voce, nonché alla presenza evidentemente celebrativa che il
cantante esibisce nella canzone. Si tratta di quello che una
volta il critico francese Roland Barthes definì la “grana” potenziale della voce: “la ‘grana’ è il corpo della voce quando
canta” (Barthes 1977, p. 188). Ma la specificità deriva dal fatto
che le musiche afroamericane sono per definizione “vocalizzate”: voce, batteria, chitarra, pianoforte, basso, sassofono,
sono tutti trattati come estensioni sonore del corpo. E questo
rivela un approccio “orale” alla produzione musicale, dimostrando inconsciamente una profonda conservazione del
retaggio africano e della cultura orale “nera”. La sua caratteristica è quella di evidenziare “un approccio personalizzato al
tono e al timbro musicale” (Vulliamy-Lee 1982, p. 25).
I suoni quasi umani che Jimi Hendrix strappava dalla sua chitarra, la batteria “parlante” e le “risposte” del sassofono di
Rashied Ali e John Coltrane (Interstellar Space, 1974), i brontolii e le urla di Ray Charles o di Millie Jackson, il falsetto
senza parole di Al Green attirano l’attenzione sul corpo rappre113
sentandolo entro le trame musicali. Il corpo, in quanto principale produttore di suono, di vibrazione e di ritmo, non viene
percepito come una semplice cassa di risonanza per stimoli
musicali elaborati altrove. Al contrario, esso è ora contemporaneamente nella situazione di fonte e destinazione finale della
musica, e i due momenti si uniscono significativamente nella
tensione creativa del ballo.
Dalla metà degli anni Sessanta in poi, la musica soul continuò
ad occupare in Inghilterra un posto sempre più importante
nelle classifiche e nell’uso del tempo libero.1 Tra il 1964 e
l’inizio degli anni Settanta, i dischi della Tamia Motown richiamarono un’impressionante massa di consumatori in Inghilterra, e a questi si affiancavano spesso le produzioni soul provenienti da altre case discografiche, quali la Stax (Otis Redding, Sam e Dave, Arthur Conley) e l’Atlantic (Wilson Pickett,
Aretha Franklin). Con i loro abiti fasciati e ricoperti di lustrini,
Diana Ross e le Supremes, i Four Tops, i Temptations, Junior
Walker e gli Ali Stars, proposero al pubblico britannico il
fascino e le emozioni del Detroit Sound (Tamia Motown), ottenendo una sorprendente regolarità di presenza nel programma televisivo Top of the Pops della BBC. I loro sgargianti
costumi di scena e il loro scatenato modo di ballare revocavano la tradizione da tempo dimenticata degli artisti neri
che gareggiavano per avere un posto al sole entro i rigidi confini del ghetto. Alcuni di loro riuscivano a imporsi nel mondo
esterno, ma la loro gestualità scenica rimaneva indelebilmente
segnata dai caratteri dell’“entertainment” e dalla loro sfacciata
aspirazione al successo.
L’ambiguità sessuale ed emotiva (il “compiacimento” della
voce nel comunicare il dolore) delle voci tenorili e in falsetto,
la profonda e incalzante voce del basso e l’avvolgente scorrere
della pulsazione erano in forte contrasto con i sentimenti e le
tendenze generalmente più evidenti del pop bianco. L’immensa popolarità riscossa dal soul come musica da ballo sottolineò ulteriormente la seducente natura del suo linguaggio corporale. Era come se ci fosse un “dio smarrito nella carne”
(Paul Valéry). Nel vasto panorama del soul era il Detroit
Sound che tendeva a imporsi sui gusti del pubblico inglese: di
solito erano i successi della Tamia Motown a capeggiare la Hit
Parade, mentre le piccole case discografiche di Detroit, come
la Mirwood, la Ric-Tic e la Revilot, richiamavano inaspettatamente l’attenzione degli appassionati del “Northern Soul”.
Il “Northern Soul” era una cultura dominata in gran parte da
valori maschili e orientata verso il ballo, legata insieme da una
comune filosofia della musica soul. Una cultura che esisteva e
continua a esistere come un’eredità dell’influenza esercitata
dalla musica soul sulla cultura di massa britannica. Il soul era
la musica adatta agli adolescenti della classe operaia bianca, i
quali rifiutavano l’accettazione passiva e il rituale pomposo
del concerto rock. Era una cultura autonoma, quasi regionale,
dotata di una propria musica, di un proprio modo di ballare,
di un proprio gergo e di proprie norme di abbigliamento.2 Organizzata attorno a lunghe maratone di ballo e al culto del collezionismo di dischi soul americani quasi introvabili, i suoi criteri musicali avevano poco a che fare con quelli che allora erano i dischi soul di successo, in Gran Bretagna come negli
114
Stati Uniti. Nel dare un significato nuovo, sulla pista da ballo,
a pezzi americani piuttosto rari, questi giovani bianchi
creavano una loro gerarchia di “star”.
Nella loro città natale, New York, gli Exciters non sono nessuno, dimenticati da tutti tranne che dalla vecchia confraternita incartapecorita che
ancora si ricorda del 1962, quando erano un gruppo di tre ragazze e un
ragazzo ed eseguivano logore canzoncine come ‘Tell Him’ e ‘He’s Got
the Power’. Qui, in mezzo alla folla sudata e palpitante del Casino di Wigan, gli Exciters sono “superstars”, sono qui per riportare in vita il loro
strepitoso successo Northern Soul del 1972 ‘Blowing up My Mind’ e il
loro incredibile sound del 1975 con ‘Reaching for the Best’ (Cummings
1975b).
Questa particolare cultura musicale del Nord racchiudeva al
suo interno diverse varianti regionali che andavano dall’“ultra
sofisticato purista della Mecca di Blackpool” fino alla “euforica
scatenata massa dello Wìgan Casino” (ibidem). I suoi gusti
specializzati erano circoscritti a particolari locali, anche se il
club più importante cambiava continuamente sede. Una volta
era il Twisted Wheel di Manchester, un’altra The Torch a Tunstall, e poi il Dungeon a Nottingham.3
Altrove, gli sviluppi della musica soul più popolare cambiavano direzione. In alcuni casi, i timbri musicali diventavano
ancora più “neri”, più “funky”, mentre altri artisti cercavano
un sound originale che, seguendo l’esempio di Sly e dei Family
Storie, prendesse ispirazione da certi temi sviluppati nella musica progressiva bianca. Se James Brown e gruppi musicali di
“street funk” come Kool and the Gang rappresentavano la
prima tendenza, furono i Temptations, prodotti da Norman
Whitfield (si ascolti ‘Papa Was a Rolling Stone’, 1972) e il can-
tautore Stevie Wonder a guidare la seconda. Ma ambedue le
correnti dell’eterogeneo movimento soul rimanevano unite
nella convinzione che “è finito il tempo del blues” (Jean
Genet). Alla rassegnazione individuale era subentrata la fiducia collettiva della “comunità del soul”.
Le rivolte urbane dei neri ad Harlem nel 1964, a Watts (Los
Angeles) fanno seguente, a Detroit e Newark nel 1967, caratterizzarono le “lunghe estati calde” in cui la tensione creatasi nei
ghetti neri si trasmise irreversibilmente nei violenti carnevali
degli oppressi. Alla fine del decennio, l’adozione generalizzata
del più brutale aggettivo “nero”, al posto dell’espressione
eufemistica “di colore”, segnò una trasformazione di valori
drammaticamente accelerata.4 Sotto gli occhi diffidenti
dell’America bianca, la formazione repressa di una cultura popolare nera generava modi espressivi carichi di nuovi significati. All’inizio degli anni Settanta, lunghe esercitazioni “funk”
di Isaac Hayes, Curtis Mayfield e Bobby Womack accompagnavano, con le minacciose tonalità ritmiche della chitarra “wahwah” e i rabbiosi ritornelli dei fiati, i nuovi protagonisti neri
aggressivamente maschi sugli schermi del nuovo cinema nero
americano in film
Shaft, Superfly, Across 110th Street. La “Ultra Skin Tone
Cream”, una crema che prometteva di schiarire le carnagioni
scure, risenti negli Stati Uniti di un calo nelle vendite; anche i
capelli stirati cominciarono a scomparire, per lasciar posto al
naturale “look” afro. James Brown nel 1968 cantava ‘Say It
Loud, I’m Black and I’m Proud’ (“Lo dico forte, sono nero e ne
sono fiero”).
115
Fu dalla metà degli anni Sessanta in poi, mentre la musica
soul cominciava a entrare a pieno diritto nel pop inglese, che
cominciò ad affiorare questo senso d’innovazione culturale da
parte dei neri. Il termine “soul”, infatti, si riferisce sia a una serie di linguaggi musicali afroamericani in evoluzione, sia a un
potente metalinguaggio culturale. Per i bianchi, e in particolare per le orecchie di alcuni inglesi, la sola parola “soul”
rievoca una profonda “mistica nera.”, un potenziale “altro” culturale fatto di associazioni fisiche e metafisiche. II “soul” allude alle intime profondità, alle energie concentrate e sublimanti di una cultura nera autonoma che si stava aprendo orgogliosamente la strada tra le correnti razziste dell’America bianca. Comprendeva contemporaneamente la gastronomia
nera (cibo “soul”) e il grido angosciato del sassofono di Albert
Ayler, i movimenti ancheggianti dei Jackson 5 e l’articolato
programma delle Black Panthers. Il “soul” era permeato
dell’indefinibile ma stilizzato senso della vita e della sopravvivenza nei ghetti neri urbani. L’idea del soul, racchiusa nella
musica nera, letteralmente “s’impadronì del tempo” (Bobby
Seale), caratterizzò cioè una grossa parte di quella che fu
l’esperienza dei neri americani negli anni Sessanta.
In Gran Bretagna ovviamente la musica soul si presentò in
modo diverso, di gran lunga più mediato. James Brown che
cercava di dar voce all’inarticolata, la malinconica atmosfera
di sofferenza creata da Otis Redding, i sentimenti sofferti di
Diana Ross: furono queste le dimensioni che per prime furono
notate e seguite. Il contesto afroamericano che spesso dava
vita a questi suoni fu ampiamente rimosso dall’esperienza bi-
anca in Inghilterra. O, quanto meno così sembrava. Infatti, tornando alla centralità del ballo, quest’imprevisto scambio culturale faceva scattare una serie più profonda di connessioni,
raramente percepite ma assorbite inconsciamente.
Distillato nel metalinguaggio del soul e nella segreta liberazione culturale che questa musica rappresentava, era l’impiego
costante delle varie possibilità polivalenti di un discorso sessuale. James Brown, Wilson Pickett, Joe Tex, e altri “fratelli del
soul” erano tutti neri, fieri, e anche sessisti. D’altra parte, cantanti come Aretha Franklin, Tina Turner, Betty Wright, Laura
Lee e Millie Jackson, affermavano una presenza e una voce
femminili in un modo del tutto sconosciuto al resto del pop.
Gli echi culturali nelle voci di queste donne erano profondamente ambigui: sessuali in un modo tradizionale e remissivo,
ma anche indipendenti in un modo aggressivo; tuttavia queste
contraddizioni, invece di essere represse dietro alla canzone,
venivano addirittura esibite.5
A giudizio di molti, un atteggiamento cosi esplicito sulle questioni sessuali non faceva che confermare ciò che essi avevano
sempre pensato: cioè che la musica soul (e la musica popolare
afroamericana in genere) forniva semplicemente un brivido
fisico, sensuale alla musica d’ispirazione europei alla quale
mancava questa dimensione corporea. La consueta riduzione
della musica soul a una versione musicale del fallocentrismo
significa ignorarne l’interiore complessità. La musica soul
sostituisce la spinta trainante e concentrata della musica rock
con un’espansione fisica nelle sue profondità verticali, distendendo il corpo su ritmi intrecciati e timbri mutevoli. Richard
116
Dyer ha osservato, a proposito della sinuosa sottigliezza ritmica del soul e della disco music, che la musica ha lo scopo di
ristabilire “l’erotismo all’intero corpo per ambedue i sessi, non
limitandolo soltanto al pene” (Dyer 1979, p. 22).6
La tendenza afroamericana a estendere il corpo in termini musicali significa, nel caso della musica soul e disco, continua
Dyer, un’importante convergenza tra il romanticismo del pop
e le possibilità materiali e contraddittorie della vita quotidiana
nel mondo di oggi. “L’erotismo [della disco music] ci permette
di riscoprire i nostri corpi come parte di quest’esperienza materiale e anche la possibilità di cambiare” (ivi, p. 23). Dyer si
propone di spiegare così la centralità assunta dalla disco music nella cultura gay degli anni Settanta. Ma le sue acute osservazioni si riferiscono anche alla più ampia influenza esercitata
dalla musica soul e disco entro i confini della musica pop bianca in genere, cioè a un’apertura, prima inaspettata, verso
possibilità culturali che ruotano intorno alla centralità del
soul sulle piste da ballo d’Inghilterra.
La musica soul tuttavia non libera magicamente i giovani proletari bianchi che ballavano al Corn Exchange di Bristol o al
Lacey Lady di Ilford dai pregiudizi radicati, dallo sciovinismo
sessuale, o, nel caso specifico, dal razzismo. Ma la sua ambigua risonanza e la sua apparente capacità di assorbire un’infinita serie di specifici interessi culturali dalla sottocultura dei
mod, al fanatismo del “Northern Soul”, alla cultura gay, rimanendo pur sempre la principale musica da ballo dell’Inghilterra, costituiscono un fenomeno senza dubbio sorprendente.
Quello che la cultura gay attinse chiaramente dalla musica, im-
prontando una particolare sessualità maschile sulle sue superfici sonore, può anche servire a spiegare la popolarità del soul
in altri contesti. Infatti, mentre la musica soul trova sfogo nei
piaceri sensuali e sessuali, nei toni confidenziali e nei suoni estatici, le sue connotazioni corporali sono raramente esclusive,
nel senso che anche le ragazze, oltre ai ragazzi, possono impossessarsene.
Avvolta nella sensualità, la sessualità non scompare, ma si
diffonde ovunque, in una temporanea esaltazione dei
sensi: nella studiata concentrazione dei passi di danza, nella
scelta dell’abbigliamento, dell’atteggiamento e del prossimo
disco, il tutto adeguatamente riflesso e amplificato nello specchio della discoteca. Parallelamente al rapporto che si era stabilito fra disco music e le culture gay americane e inglesi, anche il glam rock aveva offerto un’altra forma di stilizzato intervento maschile nelle ambiguità sessuali e spesso, in un secondo momento, con David Bowie e i Roxy Music, anche una
personalizzata interpretazione della musica soul. Il febbrile atteggiamento maschile che il pop britannico aveva adottato dal
R&B nero all’inizio degli anni Sessanta, veniva ora messo in
crisi da un più ricco e ambiguo discorso centrato sul senso del
“corpo” nella musica. Attraverso il ballo, e l’ininterrotta continuità della musica soul suggeriva un’importante connessione,
anche se raramente riconosciuta, tra i bianchi inglesi e l’“altro” afroamericano, l’eterna ossessione del pop britannico.
È giunto ora il momento di rivolgere la nostra attenzione a
una musica nera meno accessibile, il reggae, analizzando la
117
sua storia e la sua obliqua ma incisiva presenza nella cultura
britannica.
UN’ISÒLA A BABILONIA
E l’onesto uomo nero deve alzarsi in piedi.
Big Youth, ‘Marcus Garvey Dread’
Il reggae, la musica della Giamaica nera, non era destinato ad
avere facile accesso nel mondo del pop britannico e nell’ambito della musica rock bianca. In molti ambienti circolava il sospetto, puramente intuitivo, che il reggae comportasse una diversità che era troppo “differente”, troppo lontana dai modi e
dalle abitudini inglesi.
Esistono due modi principali di ballare: ognuno per sé, a diversi passi
di distanza, distaccati e indifferenti: oppure insieme, coscia contro
coscia, dondolandosi dolcemente, a volte quasi senza muoversi, in un
atteggiamento manifestamente sessuale. Tutti e due i modi scandalizzano alcuni bianchi, soprattutto il secondo: ‘È disgustoso’ ha esclamato
un’insegnante durante una festa scolastica ‘lì dentro si stanno masturbando.’ (McGlashan 1973, p. 20).
Un modo di ballare così palese non era che una vaga eco di
cose che avvenivano altrove, nei lontani Caraibi. O almeno
così sembrava all’inizio. Nessuno pensava a quel tempo che
quelle forme esotiche avessero preso dimora permanente proprio a due passi da casa nostra, a poche strade di distanza, ol-
tre il muro di cinta di un giardino inglese. In Gran Bretagna, il
reggae fu una miccia alquanto lenta, che continua a bruciare
per tutti gli anni Settanta, producendo di tanto in tanto piccole esplosioni e crepitii su un raggio più ampio, fondamentalmente intenta a forgiare l’anatomia musicale delle comunità
nere d’Inghilterra.
Alla fine degli anni Sessanta una serie di successi da Hit Parade, capeggiata da Desmond Dekker e dai suoi “The Israelites”, fecero salire sensibilmente, anche se per una breve stagione, la popolarità del reggae. Tuttavia la reazione generale,
in parte stimolata dal fatto che allora il reggae veniva associato ai bianchi bovver boys (skinhead, teppisti violenti), fu
senza dubbio fredda. L’insistenza ritmica e le rade strutture di
questo “grado zero della musica” suscitavano evidentemente
scarsa attenzione in coloro che erano interessati alle ricerche
sofisticate della musica progressiva.7 John Gee, manager del
Marquee Club, il tempio del pop inglese negli anni Sessanta,
non aveva tempo da dedicare al reggae: “Non è utile agli affari
ed è offensivo per quelli che dovrebbero intendersene” (“Melody Maker”, 10 January 1970).
In altri tempi, meno sofisticati, il diretto predecessore musicale del reggae (lo ska o blue beat) aveva già suonato per il
pubblico del Marquee. Nel 1961, in Gran Bretagna, la Melodisc Records, aveva creato la firma Blue Beat per lanciare la
musica giamaicana, tenendo d’occhio naturalmente agli immigrati nostalgici. Fu presto affiancata dalla B&C Records, che
operava sotto la direzione di Lee Goptal. La più importante
casa di produzione reggae - la Trojan Records - fu fondata nel
118
1968 da Goptal e da Chris Blackwell, un bianco originario dei
Caraibi e proprietario della Island Records. Nel frattempo lo
ska era diventato rock steady che, a sua volta, si sarebbe trasformato nel reggae. Ma le vicissitudini cui il reggae andò incontro in Gran Bretagna ci mettono di fronte a una storia abbastanza complessa. Per capirne l’effetto sotterraneo dobbiamo considerare tutta quella instabile eredità storica e
quella memoria carica di esperienza popolare che è depositata
nelle sonorità dei Caraibi.
LE BARACCOPOLI
Puoi trovare le tue radici se penetri al loro interno.
Un batterista rasta nel film documentario, Reggae Sunsplash, 1979
In qualunque modo si preferisca parlare del reggae, come condensato musicale dell’esperienza della schiavitù, della vita
nelle piantagioni, del razzismo e dell’imperialismo, oppure
come del casuale miscuglio di popoli (mandingo, spagnolo, yoruba, inglese, hausa, scozzese, akan, indiano, cinese), non si
può evitare il riferimento alla ricca mescolanza culturale tra
Indie occidentali ed Europa occidentale. Tutte le musiche
caraibiche si accordano sugli accenti di quest’unione forzata.
Oggi, l’unica traccia che rimane in Giamaica dei suoi aborigeni
- gli indiani Arawak - è il nome che essi diedero all’isola: “Xaymaca”, Terra delle Sorgenti. La stragrande maggioranza della
popolazione dell’isola è costituita dai diretti discendenti di
quegli abitanti dell’Africa occidentale ridotti in schiavitù per
lavorare nelle gigantesche piantagioni sulle quali si basava il
proficuo commercio della canna da zucchero. C’erano anche
professionisti (tecnici, medici, avvocati) provenienti dal paese
coloniale d’origine, insieme con una massa di emigrati più o
meno forzati (contadini scozzesi deportati dalle loro case
nell’Highland) e con avventurieri e filibustieri che sono sempre presenti in simili situazioni. Si trattava di una complessa
eredità culturale, un retagno che ha senza dubbio contribuito
alla realtà contemporanea della Giamaica, che sembra eludere
continuamente il motto nazionale: “Da molti popoli, uno
solo”. Le tracce di questo passato ricco di eventi si possono trovare anche nel profondo dell’attuale cultura popolare giamaicana: nella sua lingua, la sua musica, la sua religione e la sua
vita di tutti i giorni.
Nella colonia della Giamaica, l’unione tra Africa ed Europa era
controllata da una casta dominante di bianchi, successivamente affiancata dalla “missione civilizzatrice” del cristianesimo. Eppure il cristianesimo, così come la lingua inglese e le
melodie europee, si rivela notevolmente flessibile in un processo di ricostruzione interna pressoché impercettibile, operata
dagli schiavi e dai loro discendenti. Le misteriose e proibite
ombre dell’Africa occidentale passarono nella cultura popolare giamaicana attraverso un sotterraneo processo d’osmosi.
Un fervente fondamentalismo “preannunziato sull’identificazione del male” (Cashmore 1979, p. 13), univa le credenze derivate dal folklore e dal ritualismo dell’Africa occidentale, con le
119
esperienze quotidiane della Giamaica, il senso comune e una
millenaria mitologia cristiana. Il cristianesimo si fuse così con
elementi di derivazione africana, gli inni metodisti si accordarono col ritmo dell’Africa. I proibiti culti myal e obeah (che
controllava i duppies: gli spiriti dei morti) riapparvero sotto
un sottile trasvestimento. La flessibilità dottrinaria delle missioni anabattista e wesleyana e, in particolar modo della Chiesa pentecostale con il suo insistere su interventi soprannaturali, incoraggiò un processo di assimilazione della religione,
della lingua e della musica ufficiali, alla precedente cultura degli schiavi.
Con l’abolizione della schiavitù, nel 1834, l’identità culturale
dei neri giamaicani e il significato di “Giamaica.”, confluirono
in queste correnti populiste nere. La Giamaica divenne indipendente il 6 agosto 1962. La ricerca di un”identità nazionale” in una società etnicamente variegata e contesa tra la “melodia dell’Europa» e il “ritmo dell’Africa’ (Nettleford 1972, p.
173), divenne sempre più urgente e stimolò un rinnovato
interesse per le “radici” della Giamaica. Tutto ciò determinò
inevitabilmente una deleteria reazione schizofrenica. Infatti,
anche se più del novanta per cento della popolazione è interamente o parzialmente di sangue africano, “In Giamaica le persone di colore non sono considerate come un auspicabile simbolo di identità nazionale” (Nettleford ivi, p. 36). Ciò spiega,
nel contesto di una cultura popolare nera indipendente segnata dai rigidi confini della povertà e della razza, la rapida traslazione delle tradizioni orali della Giamaica in una religiosità
e in un millenarismo molto radicati.
Negli anni Venti il nero giamaicano Marcus Garvey e il suo
movimento per il ritorno all’Africa (“Back to Africa”) avevano
profondamente eccitato i sentimenti dei neri emarginati, negli
Stati Uniti come in Giamaica. La sua visione dell’Africa come
simbolo di emancipazione mentale e spirituale per il popolo
nero - costretto a subire le strutture e le tradizioni dell’Europa
bianca sulle proprie spalle e nella propria mente - fu in seguito trasformata in un più concreto messaggio dai successivi
seguaci, tra i quali vi era il movimento Ras Tafani. Contrari a
rimandare nell’Aldilà la salvezza dei neri, i rasta predicavano
un realismo concreto. Acquistarono notorietà pubblica alla
fine degli anni Quaranta, in seguito all’inevitabile conflitto con
le autorità. I rasta sopportarono di buon grado la loro successiva esclusione sociale, perché a quel punto si apprestavano a
capovolgere il mondo simbolico della società bianca. L’Etiopia
fu dichiarata la vera patria dell’esiliato nero e la strada di
“Jah” (“Jehovah”) fu indicata come la giusta via che invertiva
l’esodo forzato verso la schiavitù fisica, spirituale e culturale.
Lo scontro che scoppiò alla fine degli anni Quaranta e negli
anni Cinquanta tra le forze dell’ordine di “Babilonia.” e i rasta
univa simbolicamente rifiuto, sovversione e criminalità. Si trattava di una miscela esplosiva, destinata ad avere profonda risonanza nei ghetti che rapidamente stavano diffondendosi a
Kingston. Lo storico intreccio di religione popolare e sofferenza terrena che costituiva il fertile substrato della memoria
popolare giamaicana, trovò la sua più viva espressione nei
gerghi e nella musica della cultura orale del rasta.
120
I marcati accenti del gergo e l’intenso suono africano della
grancassa condensarono religione, lingua e musica in un’indivisibile, nera unità giamaicana. Il leggendario batterista rastafariano Count Ossie aveva proposto i ritmi alla comunità rasta
delle Wareika Hills, il trombonista ska Don Drummond intitolò le sue composizioni ispirandosi a temi rasta, come Marcus Garvey Junior, o Addis Abeba. Con il movimento rastafariario, che “forniva la spinta iniziale e creativa a questi sviluppi
della musica e della danza popolare giamaicana” (Nettleford
1972, p. 97), la musica che ne derivò divenne parte integrante
del complesso panorama culturale che comunicava solo in
modo trasversale con il mondo esterno di “Babilonia”.8 È
certo che agli inizi degli anni Sessanta, l’allora membro del
governo e futuro primo ministro, Edward Seaga, cercò di lanciare una versione “soft” dello ska, utilizzando lo sdolcinato complessino per turisti di Byron Lee e dei Dragonaires, proponendolo come musica “nazionale” giamaicana, ma i ritmi erano
troppo pesanti, gli accenti troppo particolari per propagandane così facilmente questa musica.
Lo ska rappresentava un incrocio musicale tra un’orgogliosa
cultura indigena e la musica nera degli Stati Uniti. Dalle occasionali radio nelle baracche e nei “letamai” di Trench Town,
Back O’Wall e Greenwich Farm nella parte occidentale di Kingston, le baraccopoli nelle quali ogni anno la popolazione si accresceva di nuovi emigrati dalla campagna, arrivavano i suoni
del R&B nordamericano e della musica soul trasmessi dalla
vicina Florida. Ma più che la radio, o il costoso disco, era la discoteca viaggiante, conosciuta come “sound system” (sistema
di suono) che portava gli ultimissimi sound americani da una
baraccopoli all’altra, fino a raggiungere i paesi e i villaggi di
campagna.
Come i proprietari di questi sound systems itineranti, i disc
jockey come Duke Reid, Sir Coxsone, Clement Dodd (noto anche come “Downbeat”), King Tubbys, V Rocket e Prince
Buster, gareggiavano in questa competizione musicale per conquistarsi pubblico e fama. Variazioni idiosincratiche e riconoscibili marchi di fabbrica venivano liberaménte usati in
questa competizione per il “sound vincente” dell’isola. Le limitate importazioni di dischi americani e la scarsa diffusione di
quella musica attraverso la radio giamaicana, avevano fatto
del disc jockey qualcosa di più di un semplice diffusore di quel
tipo di musica. Sembrava quindi conveniente, dal punto di
vista commerciale come da quello artistico, risalire fino al
processo iniziale della produzione discografica: spesso era sufficiente cancellare i nomi sulla copertina del disco e rivendicare come “proprio” quel sound. Inizialmente tutto ciò comportava soltanto leggere modifiche: lo stile del disc jockey era
una combinazione tra le sue scelte musicali, il suo rimbombante sound system, le sue invocazioni al pubblico danzante, i
suoi nobili attribuiti e il suo stravagante guardaroba. Sicuramente stimolato dall’enfasi che il sound system, spesso utilizzato all’aperto, doveva porre sul ritmo e sul beat per farli percepire ai ballerini, ben presto il passo fu breve per creare un
proprio stile disc jockey, basato sui ritmi locali del basso elettrico e sugli interventi della voce.
121
Il modello più vicino era lo stile scat del R&B americano, che
consisteva nell’assemblare parole in rima e verbalizzazioni melodiche e distenderle nei ritmi. Lo stile del disc jockey giamaicano tendeva ad avere uno sviluppo più immediato. Modelli di
vocalità per metà cantati e per metà gridati, più espliciti
nell’aspetto strumentale che in quello verbale, si intrecciavano
con ritmi ad altissimo volume. Denis Alcapone parlava, gridava e urlava tra i ritornelli dell’organo e il coro orecchiabile
di ‘Ripe Cherry’, ricordando che egli è “più grande di Cassius
Clay” e “più dolce di Sugar Ray”. Con l’aumento delle importazioni di dischi americani, le parti ritmiche furono ben presto
incise negli Studio One e Federai Recording Studios di Kingston appena aperti. Queste fornirono ai disc jockey la base essenziale per le loro esibizioni, e queste, a loro volta, si impegnarono direttamente nella produzione di dischi, accentrando
l’intero processo nelle proprie mani e divenendo così il principale punto di forza dell’industria discografica giamaicana. Produttori come Leslie King, Lee “Scratch” Perry e Clement “Coxsone” Dodd, prendevano i cantanti e gli strumentisti dalle
strade, davano loro qualche misero compenso, per farli poi ritornare spesso alla loro miseria, mentre essi lanciavano quello
che era diventato il loro sound ai primi posti delle classifiche
giamaicane.9
La tecnica di questi disc jockey dava allora ai ritmi locali un’inconfondibile impronta giamaicana. Il gergo jazzista di Prince
Buster e Count Machouki, il dialetto impregnato di “rastafarismo” proprio di U Roy e Big Youth, non sprigionavano soltanto nuovi ritmi vocali, ma servivano anche a sottolineare le
inflessioni e i problemi locali. La musica divenne immediatamente più sensibile all’impatto di quello che stava accadendo
altrove, nelle comunità dialettali di Kingston, e nelle zone di
campagna. Ciò fu chiaramente confermato alla fine degli anni
Sessanta con la comparsa del rude boy (ragazzaccio) giamaicano. I rudie, con i loro atteggiamenti ribelli, divennero i principali protagonisti dello ska e del rock steady giamaicano. Rovistando nell’iconografia hollywoodiana dei “duri”, i giovani
neri dei ghetti di Kingston adottarono soprannomi come Bogart, Widmark, Eastwood e Alan Ladd. Erano ragazzi che vivevano di un’economia da marciapiede, fatta di aggressioni, furtarelli e smercio di “ganja” (marijuana), mentre cercavano continuamente di trasformare il cinema americano in un dramma
di strada, ed il male dei bianchi in eroismo dei neri. L’espressione musicale di questi giovani teppisti fu un brano di Prince
Buster, Judge Dread, un giudice che condannava i rudie a
quattrocento anni di reclusione, mentre quella cinematografica, The Harder They Come (1972), ripercorreva l’ascesa
di Ivan (Jimmy Cliff) dall’oscurità della campagna alla gloria
della grande città, in una carriera fatta di reggae, “ganja” e
lauti compensi.
Secondo Prince Buster, i musicisti giamaicani che incidevano
le basi per i disc jockey locali ispiravano i loro ritmi alla “pocomania” (letteralmente, “piccola follia.”). La “pocomania.” è un
culto giamaicano afrocristiano che comporta fenomeni quali
la trance e il dominio degli spiriti. Le sue danze, i suoi stili
strumentali e i suoi ritmi sono indubbiamente entrati a far
parte della musica popolare giamaicana. La religione “myal”
122
dei Maroon - comunità di schiavi fuggiaschi che avevano preservato una lunga tradizione di indipendenza nera - fu anche
tradotta nella famosa “kumina” e divenne il nucleo spirituale
della cultura popolare giamaicana, analogamente al ruolo acquisito dal “voodoo” a Haiti. Ancora una volta, la sua strumentazione musicale, che a parte l’onnipresente batteria, per la
percussione faceva uso di scraper, gong e sonagli, i suoi poliritmi e i suoi schemi vocali, e la subordinazione di tutti questi
elementi al movimento della danza e alla partecipazione collettiva, penetravano nei suoni che i musicisti registravano negli
studi a un passo dalle strade che ospitavano tali eventi. Di
grande importanza furono anche i ritmi e le musiche più profani, associati ai festival di strada “jokkunnu” e ai “buru
ridims” (i ritmi buru). Il buru ebbe un’importanza centrale per
la musica tasta, nella quale infatti la batteria è conosciuta
come “buru set”.10
Così in Giamaica, i linguaggi popolari religiosi e quelli musicali interagiscono continuamente, originando una profonda
simbiosi tra sacro e profano. Possiamo ascoltare Clancy Eccles
che, sulla base di un pesante ritmo di rock steady, esorta Dio a
“bruciarli come Sodoma e Gomorra” e “a percuoterli con la
verga della punizione” (‘The Rod of Correction’). Alla fine degli anni Sessanta, quando i cantanti di reggae cominciarono a
interpretare nei propri brani i sentimenti del Ras Tafari,
questa continua interazione laico-religiosa e afrocaraibica, si
fece ancora più profonda e più esplicita. Così, l’interpretazione
di Prince Buster, pur sembrando all’inizio un po’ fantasiosa,
era orientata correttamente.
Al di là dei continui tentativi di imitare il R&B americano (ancor oggi in voga a Kingston), si profilava la possibilità che le
oscure forze musicali locali si affermassero pubblicamente.
Così è nato lo ska. È, stato spesso osservato che lo ska, il rock
steady e il reggae sono musiche strutturate “dalla fine
all’inizio” rispetto al R&B e al soul americano. In generale, con
il R&B e il soul, l’enfasi e i cambiamenti ritmici che si sviluppano dentro e intorno alla vibrazione musicale, tendono a concentrarsi sulla prima e la terza battuta di una struttura a quattro battute o di un “tempo 4/4”. Con lo ska, e in seguito anche
con il rock steady e il reggae, l’enfasi ritmica viene “rovesciata”. Col suo incedere sincopato, lo ska giamaicano produceva
una vibrazione incerta e spezzata, mentre i colpi della batteria
venivano a incrociarsi con i vibranti accenti fuori battuta della
chitarra.11 Il senso della vibrazione giamaicana è un rullio incerto, che produce una specie di effetto chuck-a/chuck-a. Su
questa struttura poliritmica. si sovrappongono altri strati - la
voce, i fiati, i ritornelli della chitarra e percussioni varie.
È difficile rintracciare con precisione l’origine di queste trasformazioni musicali. Le spiegazioni di tipo causale risultano
spesso erronee. Si tratta infatti di un tessuto musicale assai
ricco e complesso. A parte la simbiosi tra le suddette correnti
religiose e laiche, anche il mento (un parente del calipso di
Trinidad) col suo caratteristico passo strascicato ha avuto un
suo ruolo. Lo si può sentire nella musica di Toots and the Maytals, in canzoni come ‘It’s You’ e ‘Monkey Man’. Ma si sono
verificate anche associazioni più imprevedibili. Il sax tenore
Tommy McCook iniziò con il jazz, poi, alla fine degli anni
123
Quaranta, fece coppia con il grande batterista “buru” Count
Ossie nei concerti rasta detti “Nyabingi” o “grounations”; poi
all’inizio degli anni Sessanta registrava per “Coxsone” Dodd
prima di entrare a far parte del leggendario gruppo ska degli
Skatalites. È sintomatico della fluidità della situazione musicale giamaicana il fatto che musicisti esperti come McCook, il
quasi mitico Don Drummond e Rico Rodriquez, dovessero
essere profondamente influenzati dal movimento rastafariano
e dalle tradizioni afrocaraibiche che esso portava con sé. Al
tempo stesso, questi musicisti introdussero anche nuove
strutture nella costruzione dell’universo ska-rock steadyreggae. In particolare il loro modo di suonare gli ottoni e l’uso
dell’accordo di sesta e settima maggiore “aperto” ottenevano
un suono fluttuante, molto arioso, del tutto diverso da quello
prodotto in quel periodo dai gruppi di R&B. Questo senso di
spaziosità, che rende flessibili i confini della struttura musicale ed evoca una presenza che riempie gli spazi vuoti tra le
note, rimase anche quando il ritmo alquanto frenetico dello
ska fu rallentato e questa musica trapassò nel rock steady.
“Se i ritornelli degli ottoni avevano dominato i ritmi dello ska,
nel rock steady gli ottoni erano presenti solo nei pezzi strumentali, il tempo del disco era rallentato ed era la linea del
basso a sostenere il ritmo” (Gayle 1973, p. 678). Con il rallentare della musica trovarono eco in Giamaica alcuni degli stili
vocali più rilassati e più dolci del soul statunitense. Lo si può
riscontrare, per esempio, nelle canzoni di Alton Ellis, Ken
Boothe, Delroy Wilson e nelle prime incisioni dei Wailers, la
cui ‘Soul Almighty’ si richiama direttamente a Wicked Pickett.
Ma il rock steady introdusse anche una decisiva svolta locale:
l’emergere a pieno titolo della linea del basso come fondamento e anticipazione di ciò che in seguito sarebbe divenuto il
reggae. Il rock steady, e poi il reggae, portarono alla ribalta il
rimbombante basso elettrico, affidandogli il ruolo di voce principale, e in questo modo rovesciarono completamente il precedente schema musicale. Soprattutto il reggae, con il suo accorto uso di pause e fraseggi insoliti, esplorò appieno il senso
di questa posizione di guida assunta dal basso. Un esempio significativo è il brano ‘Concrete jungle’ dei Wailers (si può ascoltare sull’LP Catch a Fire, 1973). La centralità della “voce” del
basso, con le sue pause, spesso riempite da percussioni improvvisate, sta a significare che la “musicalità e il ritmo di un
motivo vengono mantenuti solo in una forma estremamente
mimetizzata e concisa” (Clarke 1980, p. 133). Il centro di gravitazione della musica si è ora spostato molto più in profondo,
fino alle “radici”, rimosso dalle più superficiali caratteristiche
della melodia facile e del ritmo scontato.12 Come ci ricorda Linton Kwesi Johnson: “La storia del basso è una storia nera che
commuove e ferisce”.
DIALOGHI ETNICI: GLI SKINHEAD
Nel frattempo in Gran Bretagna, Lee Goptal aveva fondato la
B&C Records per la distribuzione della musica giamaicana.
Ciò avvenniva nel 1964, anno in cui Millie Small ottenne in
124
Gran Bretagna un successo ska con ‘My Boy Lollipop’. La B&C
apri ben presto una serie di punti di vendita nei principali
quartieri delle comunità giamaicane di Londra. Vari club
come il Roaring Twenties in Carnaby Street, il Four Aces nel
North London, lo 007 nell’East End e il Ram Jam Club a Brixton, divennero importanti luoghi di ritrovo per la gioventù
nera, intenta ad assorbire gli ultimissimi sound provenienti
dalla Giamaica. Cominciavano a comparire i primi sound system locali, con i loro enormi altoparlanti per i bassi e i loro
sistemi di amplificazione “fatti in casa’.
Fu a questo punto che il rude boy giamaicano e il suo compatriota britannico di colore incontrarono nei ritmi frenetici
dello ska un altro settore di gioventù insoddisfatta. Erano
giovani bianchi provenienti dalla classe operaia. Il secco rifiuto degli skinhead di accettare la visione utopistica proposta
dalla musica progressiva era uno sgradito richiamo ad alcuni
dei limiti più evidenti delle ambizioni della controcultura.
Così George Melly descrive questo scontro, verso la fine degli
anni Sessanta.
Ai concerti all’aperto, gruppi di quindicenni sbandati camminavano
con un fare aggressivo ai margini dell’enorme folla capelluta. Erano meticolosamente puliti, con i capelli rasati a zero, indossavano stivali marroni e jeans a mezza gamba con le bretelle. Erano in cerca di “guai” e
sembravano essersi resi conto che la musica pop, che una volta distruggeva qualsiasi barriera di classe, apparteneva ora a un’intellighenzia
(per quanto ancora a livello embrionale), a potenziali “altri” (Melly
1972, p. 122).
Alcuni anni prima i mod avevano cercato stile e ispirazione
nel R&B nero, nella musica soul e nella figura del nero americano di città. Ora, intorno agli anni 1967-1968, mentre Derrick Morgan cantava ‘Tougher Than Tough’ e Dandy Livingstone metteva in guardia i miscredenti neri nella sua ‘Rudy a
Message to You’, gli skinhead stipulavano un breve accordo
con il reggae giamaicano e con lo stile del rude boy.
Il gergo della gioventù nera era attentamente studiato, il loro
modo di vestire, con quei pantaloni a mezza gamba, e la rasatura dei capelli detta “skiflle” erano oggetto di imitazione. Poi,
con l’aggiunta di altri orpelli tremendamente antiquati come
gli stivali e le bretelle da proletario, il tutto fu confezionato in
un caratteristico stile “skin”. Tuttavia, come fa notare Carl
Gayle, fu soprattutto la musica che all’inizio unificò questa turbolenta alleanza.
(...) nella seconda meta del 1968, quando “Neville, l’incantatore musicale” poteva affermare di essere il “capo”, egli si esibiva quasi ovunque
nei dintorni di Londra indipendentemente dalla distanza. I suoi fan aumentavano sempre più, ed erano esaltati, sconvolti (...). La maggior
parte delle zone in cui egli suonava erano quartieri bianchi, e non era
sorprendente che molti bianchi andassero ad ascoltare la sua musica
(Gayle 1973, p. 678).
In questo periodo nacquero gli “inni” degli skinhead, come
per esempio ‘Long Shot (Kick De Bucket)’ dei Pioneers, ‘The
Israelites’, ‘It Mek’ di Desmond Dekker e ‘Return of Django’
degli Upsetters. Il successo del reggae fu tale che da allora non
ha mai più raggiunto i livelli conseguiti nel 1969 nelle classifiche inglesi.
125
Quella stilizzata forma di “devianza” impersonificata dal reggae per alcune frange della gioventù britannica bianca e di colore (prevalentemente maschile) trovava il suo punto focale nel
linguaggio apparentemente comune dei ritmi giamaicani nello
stile del rude boy di Kingston. L’incurabile maschilismo degli
skin tendeva spesso a manifestarsi ai danni di qualsiasi malcapitato pakistano, hippy o gay che si trovasse sulla loro
strada. Le bande degli skinhead, chiamate crews (ciurme) erano molto diffuse nell’East End londinese e nelle Midlands.
Controllavano una zona ristretta con una prospettiva altrettanto ristretta, unificata non solo dai vincoli di classe e della
vita urbana in un contesto di crescente disoccupazione e di
scarse opportunità in generale, ma anche da un più preciso attaccamento simbolico al provincialismo e allo sciovinismo
razziale delle “radici bianche”. La cultura degli skinhead,
sebbene condannata per il suo estremismo, non fu affatto bandita per i suoi sentimenti. Essa esibiva con orgoglio una rigida
cristallizzazione di opinioni che altrove venivano tranquillamente approvate e applicate con buon senso nella manifestazione quotidiana di “essere britannici”.13
Non sorprende che questo idillio tra il “rudy” e lo “skin” sia
stato di così breve durata (1969-1971). Dopo tutto, la sottocultura skinhead rappresentava una manifestazione disperata e
si riferiva alle prospettive più marginali per il proprio futuro.
Era inevitabile che questa impossibile fusione di estremi opposti si spezzasse rapidamente e che gli skinhead si ritirassero
nel loro ultimo baluardo, rappresentato dall’“etnicità bianca”
(Hebdige 1982). La rottura tra gli skinhead e il reggae fu affret-
tata dagli effetti delle trasformazioni culturali che avvenivano
in Giamaica. Tali effetti si rifletterono sulle particolari condizioni di vita della gioventù nera d’Inghilterra, e sul significato
del reggae all’interno della loro cultura, con il risultato che
quel breve dialogo era ormai concluso.
Ai bianchi rudie non restava altro che aggrapparsi disperatamente agli ultimi simboli di una supposta “autenticità”: le
deprimenti strade del loro territorio “bianco”.
BIGHELLONANDO PER LADBROKE GROVE
Mentre in Giamaica lo spirito di Marcus Garvey, il fumo della
marijuana e il movimento Ras Tafiri avevano permeato l’atmosfera del reggae fino dal suo primo periodo ska, in Gran
Bretagna tutto ciò era meno evidente, molto più lontano. Durante gli anni Cinquanta e Sessanta, l’esodo delle comunità
provenienti dalle Indie occidentali in un altro paese, questa
volta la “madrepatria.” coloniale, minacciò anche di allargare
il divario tra l’esperienza della cultura popolare afrocaraibica
e le ottimistiche speranze che questi immigrati neri riponevano nelle opportunità offerte dall’Inghilterra. Ma negli anni
Settanta molte di quelle speranze erano ormai svanite. Se i giamaicani della vecchia generazione avevano adottato uno
stoico atteggiamento di difesa, i giovani neri erano sempre più
esasperati. Costretti a ripiegare sulle loro risorse, le comunità
delle Indie Occidentali riscoprirono la tempra tenace del loro
126
passato caraibico. Quello che una volta era l’esclusivo potere
del Ras Tafari cominciò a essere tradotto in un più ampio
populismo politico e culturale. I giovani della seconda generazione, tra cui molti nati e cresciuti in Gran Bretagna, cominciarono ad abbandonare i tentativi spesso vani dei loro genitori
per entrare nella corrente della società britannica. Questa reazione si basava su un realismo conseguente al diffuso malumore che serpeggiava alla fine degli anni Sessanta e negli anni
Settanta. Era ormai chiaro che il razzismo e la discriminazione
razziale non erano una questione né personale né casuale,
bensì un problema strutturale. La gioventù nera divenne sempre più consapevole del suo profondo dilemma, quello di
essere chiusa tra una eredità coloniale frammentata e un presente che le era quotidianamente negato.
Si doveva trovare una nuova risposta, una risposta più efficace
di quella della rassegnazione. Naturalmente, la tendenza fu
all’inizio quella di vagare un po’ alla deriva e in particolare
verso quegli spazi in cui fosse ancora possibile compiere azioni significative e non subire più quell’autoannullamento imposto quotidianamente nella scuola e sul lavoro (Pryce 1979).
Abbandonare la casa e la famiglia significava trasferirsi di
giorno sulle strade e di notte nei caffi sempre aperti. L’ambiente crepuscolare dello spaccio di narcotici e della piccola
criminalità offriva una possibilità. L’economia sommersa della
strada, fatta di marijuana, merce rubata, prostituzione, divenne ancora più allettante dopo aver assunto un’immagine
più stilizzata e giovanile, presa a prestito dagli appariscenti
rudy giamaicani, un’immagine ben diversa da quella sgargi-
ante e volgare propria del nero americano spacciatore o
protettore di prostitute. Come provarono i fatti, questa ostentata vita di strada era malvista in Inghilterra, dove il fenomeno era stato opportunamente etichettato come “piccola
delinquenzà , così come era avvenuto in Giamaica.
Nel frattempo, già dal 1968, col suo ben noto discorso sui “fiumi di sangue”, Enoch Powell aveva ripreso l’argomento
molto scottante del tema razziale. La sua teoria, secondo la
quale i germi della crisi e del potenziale crollo della Gran Bretagna andavano ricercati nelle tensioni razziali originate
dall’immigrazione nera, doveva divenire nel decennio seguente uno dei temi più ricorrenti e drammatici del dibattito
politico, una questione a cui molti sudditi britannici di razza
bianca rispondevano emotivamente.
Mentre nei cinema affollati di Brixton era proiettato il film
The Harder They Come, la persistente crisi economica del
paese si andava aggravando. Lentamente, ma irreversibilmente l’intero equilibrio politico del dopoguerra, fondato
sull’assistenza pubblica e la piena occupazione, cominciava a
sgretolarsi. I giovani neri ne furono doppiamente colpiti.
Questi giovani, essendo i primi a perdere il posto di lavoro o a
non trovarlo, scoprirono ben presto l’aspetto razzista della
crescente crisi. Additata come esempio per spiegare le cause
di quella situazione, la gioventù nera si ritrovò nell’occhio del
ciclone razzista. La presenza costante di giovani neri disoccupati che vagabondavano per le strade dei quartieri degradati
del centro era un segno troppo lampante per sfuggire all’attenzione degli osservatori.
127
In un clima come questo, il passo fu breve verso una più rigida
sorveglianza. La questione della “legge e dell’ordine”, aveva
già una sua lunga e nevrotica storia nei congressi del Partito
conservatore negli anni Cinquanta e Sessanta (Gamble 1974).
Ma ora, mentre le diverse manifestazioni d’inquietudine sociale erano sbrigativamente liquidate attraverso una crescente
serie di definizioni e sottoposte alla suprema autorità della
legge, il problema divenne di pertinenza di tutti i partiti. All’interno di questa ben orchestrata resurrezione dell’autorità governativa, erano ormai maturati i semi che negli anni Sessanta
Enoch Powell e altri avevano gettato nel loro fervore missionario. Razza., legge e ordine divennero ben presto un ricco serbatoio politico, per i governi conservatori come per quelli laburisti, messi ora di fronte a un aggravarsi della crisi dell’autorità e costretti a cercare un consenso popolare che legittimasse
il loro potere. Coloro che erano sospettati di ignorare quel rispetto sempre maggiore richiesto da questa circoscritta autorità, cioè gli scioperanti, gli occupanti abusivi di stabili, i militanti neri, i fumatori di marijuana, gli studenti di sinistra, furono presi di mira per il loro comportamento “antisociale” in
modi e momenti differenti. I giovani neri, essendo i più
esposti dal punto di vista strutturale, pubblico e razziale, furono tra i primi a essere colpiti da questo generale clima di ostilità. Mentre in settori più particolari, impegnati nella ricerca
di nuovi modelli di vita, le reazioni furono inizialmente più
sporadiche, nei settori più esposti dell’economia e nei bui meandri della disoccupazione urbana, esse furono immediate e
quasi inevitabilmente brutali.14 La reazione sociale colpì anzitutto loro, i giovani, che furono i primi a subire la rigida disci-
plina di quei tempi mutati. Davanti a sé, la gioventù nera trovava i rigori della polizia, della magistratura e della stampa, e
la formulazione, dopo il panico del “dilagante teppismo” diffuso nel 1972-1973, dell’insidiosa equazione: gioventù nera =
disoccupazione = criminalità di strada”.15
Attraverso un crescente confronto con il braccio della legge,
non appena vennero individuati e verificati come “sintomi”
della crisi inglese, i giovani neri erano ammoniti che sarebbe
stato meglio per loro “pensare al proprio futuro, altrimenti
sarebbero finiti in galera” (Dandy Livingstone, ‘Rudy a Message to You’). In effetti, molte canzoni dei rude boy erano
rivolte contro se stessi e piene di cupi avvertimenti per coloro
che continuavano a seguire le strade del male. Sia Prince
Buster che Dandy Livingstone esprimevano nelle loro canzoni
un senso di sgomento per i tumulti avvenuti nelle comunità
nere a causa della violenza esercitata dai rude boy sugli altri
abitanti delle baraccopoli. Per sopravvivere nella giungla urbana, era necessario trovare una strategia alternativa più duttile e allo stesso tempo più globale. Ancora una volta una cultura nera assediata si rivolse ai codici segreti e ai poteri sotterranei della sua musica. Fu nel rastafarianesimo, nella sua musica, nella sua simbologia e nel suo messaggio culturale, che la
gioventù nera dell’Inghilterra riscoprì una “realtà” diversa
dalle facili offerte di un’integrazione illusoria o dalle circoscritte vittorie di una vanagloriosa ribellione dei rude boy.
128
“RASTAMAN VIBRATION”
Dal giorno in cui il primo africano venne catturato e battezzato da qualche arrogante ecclesiastico portoghese del XV secolo e quindi destinato
a una terribile traversata oltre Atlantico, sono sempre esistite due Afriche, l’Africa geografica, con le sue innumerevoli realtà sociali, e
l’Africa mentale del negro in esilio, un’Africa fatta di ricordi secolari
che svaniscono e di speranze sconfitte che si sono tradotte in mito.
David Jenkins 1975
La figura del rude boy giamaicano fornì per breve tempo, ad
alcune frange della gioventù nera britannica, un modello di “ribelle” che venne successivamente rafforzato dalla pressione di
una vita senza prospettive di lavoro, trascinata lungo le strade
di quartieri urbani sempre più sottoposti alla sorveglianza
della polizia. Il rasta, il cui stile di vita aveva influenzato anche
i rudy giamaicani, proponeva di superare i limiti di quella
situazione mediante una strategia globale, la cui logica interna
sarebbe diventata la misura del mondo. Mentre i rudy si erano
convinti di essere “troppo cattivi” nei loro rapporti con la società, i rasta rifiutarono questi prevalenti punti di riferimento
con l’esterno e a essi opposero un loro peculiare sistema. Il
rude boy aveva cercato di distorcere le definizioni del buon
senso, nella speranza di poter negoziare un proprio ruolo entro gli spazi del ghetto, mentre i rasta decisero un totale rifiuto
di quella realtà.
L’estrema miseria e l’abietto sfruttamento coloniale e postcoloniale dei paesi del Terzo Mondo sono alle origini del Ras Tafari e del gravido simbolismo di Garvey. La società di navigazione di Garvey, la Black Star Line - fondata negli anni Venti e
commemorata cinquant’anni dopo nella canzone di Fred Lock
‘Black Star Liner’ - doveva riportare i neri deportati nella loro
patria africana. A un livello più duraturo e metaforico, fu a
Marcus Garvey che si attribuì il merito di aver identificato
l’Etiopia con la terra promessa di questa diaspora nera. Ma al
di là di queste identificazioni pubbliche, il substrato culturale
della Giamaica popolare nascondeva altre tracce di origine
afrocaraibica - le tradizioni Maroon, il kumina, i rituali buru che s’intrecciavano tutte intorno al centro focale del Ras Tafari. Il Ras Tafari trasforma il retaggio di questa onnipresente
“spiritualità nera” in una lotta materiale contro l’oppressione
razziale, culturale e sociale. A questo punto viene ormai a cadere la distinzione tra livelli religiosi e laici, per essere sostituita da un movimento indirizzato verso un populismo panafricano di natura politica.
Uno studio strategico della Bibbia, come chiave per scoprire la
“ragione della sofferenza”, ha fatto divenire il rasta una nuova
autorità su questo testo di primaria importanza nella cultura
popolare giamaicana. La Bibbia, insieme all’uso del dialetto e
al tramite della musica, ha dato origine a una “comunità” nera
capace di rovesciare completamente le principali forme della
cultura bianca. Lo schiavo di un tempo esprime ora la sua ribellione attraverso i libri e il patrimonio culturale che una
volta appartenevano al suo padrone: la sua lingua, la sua religione, la sua musica. I rasta guardano all’Africa e all’Etiopia
come alla loro Sion. Da questo ricavano i mezzi simbolici per
tracciare le linee culturali del passato, del presente e del futuro della Giamaica nera. Questa mappa culturale rappresenta
129
il momento in cui i rasta, e potenzialmente tutta la gente di colore che sceglie di seguire la filosofia del Ras Tafari si “liberano
della propria oscurità” (Nettleford 1972, p. 47). I manifesti
segni di devozione dei rasta - le lunghe ciocche di capelli intrecciate (un omaggio simbolico allo stile delle tribù
dell’Africa orientale) o più semplicemente, la “naturale”
crescita dei capelli, i berretti di lana (“tams”) nei colori rosso,
verde e oro dell’Etiopia, le rigide norme dietetiche dei cibi “Ital”, e l’importanza attribuita al fumo della marijuana, detta
“ganja” o “erba saggia”, vennero gradualmente trasferiti da un
piccolo gruppo di eccentrici religiosi (come erano visti
all’inizio) in una vasta e influente corrente popolare.
Questa drammatica rappresentazione del popolo nero, espropriato della propria cultura e della propria identità, doveva anche fornire un importante stimolo escatologico al modo in cui
quei giovani originari delle Indie Occidentali, residenti in
Gran Bretagna vivevano il loro “esilio a Babilonia”. Per alcuni
la crescente minaccia di una cronica disoccupazione si trasformava simbolicamente nelle sante stigmate di coloro che avevano deciso di non sostenere più con il proprio lavoro il
sistema “babilonese”. In un senso più ampio, con il “Jah” presente in ognuno - “Io sono Io” - e per mezzo della sacra erba
“ganja” che è uno nell”`Io”, l’esilio forzato veniva vissuto fiduciosamente come fase di passaggio verso la redenzione del popolo nero. Verso la metà degli anni Settanta, quando alla “pressione” esercitata sulla gioventù nera d’Inghilterra si unì in
misura sempre maggiore quello stile “sacro” (se non proprio
l’adesione totale al rastafarianesimo), fu come se una
“purezza” nera facesse mostra di sé tra i crescenti cumuli di
immondizie prodotti da una nazione in decadenza.
Sul fronte razziale, mentre “l’esercito industriale di riserva.”
(composto per la maggior parte da neri, donne e giovani)
stava per essere spinto in un cronico stato di disoccupazione,
un movimento di opinione popolare stava prendendo forma
attraverso una serie di messaggi lanciati dai politici e dalla
stampa. Questi messaggi andavano dalla competitività per un
sempre minor numero di posti di lavoro all’amplificazione
dell’idea del “modo di vivere britannico” (British way of life).
La drastica semplificazione di questioni complesse e una distorta mentalità imperiale scivolarono ben presto nella facile
retorica del razzismo, “proprio perché i discorsi della nazione
britannica e del popolo britannico sono, dal punto di vista
della razza, esclusivi” (Gilroy 1982, p. 278). Erano questi precisi slogan razzisti a fornire la semplice spiegazione della disoccupazione, del degrado urbano, della crisi dei servizi sociali e
dell’identità britannica in generale. Erano slogan che collegavano le esperienze più immediate e concrete ai grandi e rassicuranti temi della “nazione e della razza” (Green 1979).
Questa febbrile mitologia trovò una grottesca conferma
quando i rasta si riversarono sulle strade delle città inglesi con
le loro bizzarre capigliature, la loro strana lingua e i loro ritmi
incomprensibili.16 Un tale diretto affronto al buon senso britannico era destinato a divenire oggetto d’incredulità; una
forma di “pazzia.” per coloro, neri e bianchi, che rifiutavano la
sua logica, ma che per molti giamaicani neri era l’unica chiave
per raggiungere un equilibrio interno.17
130
Ed è in questo contesto complessivo che riappaiono, in forma
approfondita, i segreti linguaggi del reggae. La reazione della
gioventù nera all’arcigna espressione dell’Inghilterra bianca e
il rapporto che si stabili tra quella reazione e i contenuti del
movimento Ras Tafari, furono in definitiva efficacemente
saldati dal ritmo e dallo spazio comuni del reggae. Il reggae è
rimasto la più efficace forza culturale in un clima di controllo
e di vigilanza poliziesca e di reazioni immediate. Il cambiamento di direzione in seno alla gioventù nera, dalle limitate
prospettive offerte dalla strada a una promessa millenaria,
avvenne in gran parte sotto la bandiera del reggae e grazie alla
figura catalizzatrice di Bob Marley. Fu nel trionfo culturale di
Marley e attorno a esso, che “suoni” e “pressione” si fusero in
modo sempre più evidente.
Nel 1973, fu lanciato in Gran Bretagna l’ambizioso LP Catch a
Fire, che compensava la musica più direttamente originaria di
Burning (anch’esso del 1973). Due anni dopo, Bob Marley usci
da una tournée inglese come l’“archetipica minaccia rastafariana, saldamente trincerata nel filone della mitologia anglogiamaicana”(Cashmore 1979, p. 119). Riunendo nelle vibrazioni
del reggae il passato di schiavitù della Giamaica (‘Catch a
Fire’), il suo presente (‘400 Years’, scritto da Peter Tosh, che
allora faceva parte dei Wailers) e il suo futuro (‘Rasta Man
Chant’), questa musica tendeva verso l’inesorabile sospensione di temporalità immediate, “portando così i suoi partecipanti in una dimensione atemporale e forse a una comprensione del divino” (Middleton 1972, p. 41). Marley non ottenne
solo un successo commerciale con la Island Records, ma an-
che un trionfo culturale. Questo suo successo è chiarito molto
bene nella descrizione che Ernest Cashmore fa della personalità di Marley:
Non sarebbe esagerato affermare che Bob Marley fu per i rasta inglesi
degli anni Settanta quello che Marcus Garvey rappresentò per i suoi
primi seguaci giamaicani degli anni Trenta. Egli attrasse l’attenzione,
suscitò uno straordinario interesse e propagò idee di cui, con tutta probabilità, molti giovani delle Indie occidentali non avevano mai sentito
parlare prima della sua scalata al successo” (Cashmore 1979, p. 108).
Tuttavia, nonostante l’innegabile successo di Marley e i contratti che le case discografiche inglesi stipularono con numerosi interpreti del reggae (i Maytals, i Burning Spear, gli Heptones, Peter Tosh, Keith Hudson, Third World, U Roy, i
Mighty Diamonds, che firmarono quasi tutti per la Island o
per la Virgin), l’alone rastafariano che ora avvolgeva la musica
reggae probabilmente aumentò la distanza tra sé e il resto del
pop inglese. L’esplicita e orgogliosa negritudine del movimento Ras Tafari escluse decisamente i bianchi aspiranti “rasta.”. Come conseguenza, anche se alcuni musicisti bianchi si
occuparono un po’ di reggae ed Eric Clapton dimostrò i poteri
della distribuzione culturale vendendo in Giamaica più di Bob
Marley con la canzone dello stesso Marley ‘I Shot the Sheriff’,
e gli Stones incisero il brano di Clancy Eccles ‘Ripe Cherry’, il
contatto fra le due culture rimase sporadico. La significativa
eccezione doveva essere anche la più geniale fonte d’ispirazione che la cultura musicale reggae forni a quei futuri “esuli”
bianchi che erano i punk. È solo dopo l’avvento del punk, alla
fine del decennio, che il reggae inizia a mostrarsi in modo più
insistente in altre aree del pop.
131
Così, alla metà degli anni Settanta la grande maggioranza dei
suoni reggae, che non appartenevano alla categoria “superstar” di un Bob Marley o di un Peter Tosh, continuarono a rimanere chiusi all’interno della cultura della gioventù inglese
di colore. La maggioranza dei negozi di dischi in Inghilterra
non accettava volentieri l’idea di servire come posti d’ascolto
per i neri espropriati durante i pomeriggi di pioggia. I negozi
di High Street erano raramente provvisti di musica reggae, e
quindi la gioventù nera andava a cercare la propria musica in
altri posti. A metà decennio frequentavano l’Estate Club di Tottenham, accolti dal disc jockey Sir Biggs, o si dimenavano ai
ritmi di Sir Nyah del Cobweb Club a Hornsey, del disc jockey
Jah Suffera al Metro Club a Ladbroke Grove, o di Mr Bees a
Peckenham. I dischi reggae si trovavano solo nei negozi delle
comunità caraibiche, specializzati esclusivamente in quel genere. Questi negozi, con gli altoparlanti diretti all’esterno,
sulla strada, trasmettevano alle orecchie delle “vittime” nere
della Babilonia inglese gli ultimi sound di Big Youth, Dillinger,
Denis Brown, Fred Locks e Sugar Minott.
Al di sotto del flusso di interesse che circondava la musica di
Bob Marley, si svilupparono i canali più sotterranei di una
scena reggae inglese che sfuggiva in gran parte al pubblico bianco ed era completamente estranea alle maggiori case
discografiche.18 Questo fatto ci ricorda come la forza e la resistenza culturale del reggae siano stati formati e mantenuti attraverso i temi interdipendenti della razza e del razzismo. Certamente, il progressivo inasprimento degli scontri razziali che
caratterizza gli anni Settanta svolse un ruolo significativo
nella formazione di una scuola inglese di reggae. La drammatizzazione dello spettro della criminalità nera, orchestrata
dalla polizia e dalla stampa, all’inizio degli anni Settanta attorno alla paura del teppismo, favori l’aumento della febbre
razzista e allo stesso tempo alimentò ulteriormente le sanguinose profezie che Enoch Powell aveva formulato circa una
guerra razziale in Gran Bretagna. La piattaforma esplicitamente razzista del partito fascista National Front e una crescente acquiescenza nell’accettare queste tendenze, se non la
più intemperante retorica dei suoi argomenti, all’interno e fuori dal Parlamento, erano un severo monito per il futuro della
comunità nera.
Oltre a tutto ciò, proprio ai confini dei quartieri occupati dalla
comunità nera, le più tradizionali procedure poliziesche furono sostituite dai bruschi e irrazionali comportamenti delle
squadre speciali (Special Patrol Group; SPG) e da un metodo
di sorveglianza molto più severo, e inevitabilmente provocatorio. La “legge sulle persone sospette” (Suspected Persons Act,
SUS) fu applicata indiscriminatamente per arrestare i giovani
di colore e, implicitamente, per spazzare via dalle strade, ossia
dal loro unico punto di riferimento, i poveri disoccupati neri e
i potenziali scippatori. I duri scontri tra i giovani di colore e la
polizia, che conclusero il carnevale di Notting Hill del 1976, e i
diffusi tumulti razziali, che quattro anni dopo divamparono
nel distretto di St. Paul a Bristol, furono le prevedibili conseguenze di quell’“interminabile oppressione”.
Fu proprio in quest’atmosfera estremamente carica di tensione che, con il progredire degli anni Settanta, cominciò ad
132
acquisire una forma sempre più definita una lunga serie di
club neri, feste del sabato sera (i cosiddetti “shebeens”), sound
system locali, piccole case discografiche indipendenti e sotterranei successi di dischi giamaicani importati. Operando fuori
Londra, a Birmingham e in altri centri urbani, case di produzione quali la Pam, Daddy Kool, Ethnic Flight e la Black Wax,
rinnovarono il precedente successo della Trojan (dichiarata
fallita nel 1975) e gestirono nella regione qualcosa come il venticinque per cento delle vendite di tutto il reggae britannico.
Gruppi reggae inglesi come i Misty, gli Aswad e gli Steel Pulse
cominciarono a integrare le musiche già affermate dei Cimarons e dei Matumbi. Senza dubbio incoraggiato dal successo di Bob Marley e dalla problematica dimensione culturale che il razzismo da fuori e il rastafarianesimo da dentro
avevano portato a questa musica il reggae inglese cominciò a
emergere da club come il Bouncing Ball di Peckenham, da
zone urbane depresse come Handsworth a Birmingham, e da
sconosciuti studi di registrazione come i Gooseberry Studios a
Gerrard Street, Soho e, successivamente, gli Easy End Studios
nell’East End.
Pur generalmente rifiutato da un pubblico più vasto, il reggae
continuò a espandere le sue basi musicali dalla originaria
linea del basso. L’apparente divisione tra l’edonismo dei “lovers rock” e un serio e impegnato stile etnico, avvenuta a metà
degli anni Settanta, venne effettivamente smentita dall’onnipresente vibrazione del basso e dalla confluenza degli stili addolciti e radicali del reggae nell’interazione musicale rappresentata dal dub (Gilroy 1982). Il dub nasce da un modo estre-
mamente inventivo di usare i moderni impianti di registrazione che era stato indicato dai primi disc jockey di reggae,
molti dei quali erano divenuti in seguito produttori. Dalla pratica del “toasting” inciso sopra le basi puramente strumentali,
si passò, per una sorta di logica evoluzione interna, a “toccare”
il suono a ogni livello, lasciando le proprie impronte digitali
dovunque sul nastro. Il produttore discografico, spesso ispirandosi al modo in cui i disc jockey usavano la musica nelle
discoteche, cominciò a intervenire e a “tagliare” il suono,
cominciando con le versioni strumentali sulla facciata B delle
canzoni che occupavano la facciata A del disco. La canzone
originale era così messa da parte e trasformata in una nuova
esperienza sonora, un’efficace dimostrazione di come il reggae
“decostruiva” continuamente le forme musicali e i modi ereditati di produrre musica.
Sfruttando gli studi dotati di impianti di registrazione a piste
multiple, oltre che un intero arsenale di effetti elettronici (eco,
riverbero, phaser, eccetera), i produttori Joe Gibbs, King Tubbys, Herman Chin-Loy, Clement Dodd e Augustus Pablo
cominciarono a sfornare una serie di dub arabescati (vedi Discografia). Basso, batteria, chitarre e fiati venivano mixati insieme in turbinanti schemi sonori, le “voci” erano continuamente inserite ed eliminate, i ritmi troncati, intensificati,
sospesi e prolungati. Questo stile di registrazione molto inventivo, che in seguito influenzò il rap newyorkese e la musica
soul dei primi anni Ottanta, dimostrò ancora una volta che un
particolare insieme di relazioni culturali poteva piegare e disciplinare con successo in una precisa strumentazione musicale
133
una tecnologia della produzione apparentemente refrattaria.
L’inevitabile tensione che si creò dopo il successo di Marley
tra il reggae giamaicano, quello delle “origini”, e la sua graduale partecipazione alle strutture commerciali internazionali, è
giustamente integrata dalla miscela di suoni naturali e artificiali che, nel processo del dub, si rinviano gli uni agli altri. Se
inizialmente il dub e le produzioni di Prince Far I, Dr. Alimantado e Augustus Pablo non incontrarono i favori della musica
pop bianca, né trovarono spazio alla radio (una rara eccezione
fu, alla fine del 1974, ‘Ire Feelings’ di Rupie Edwards), ben
diversa era la situazione nei club neri. inglesi. Qui, in un’atmosfera satura di “africanità”, con quel rovesciamento che il
movimento Ras Tafari aveva apportato nel tempo, nell’ordine
e nella storia dei bianchi, dove il senso del reggae, della razza
e dell’imminente riscatto erano talmente intrecciati da divenire indistinguibili, trovava il suo ambiente naturale il sound
dai molteplici tessuti del dub (Hebdige 1979, pp. 37-39).
Al di là della portata immediata del dub e della cultura dei
giovani inglesi di colore, possiamo metterci in cammino su un
percorso che, col senno di poi, ci condurrà fino al paesaggio
postpunk dei tardi anni Settanta. Il dub bianco dei Public Image Ltd, il “toasting” dei Beat e degli UB 40 di Birmingham, il
revival ska dell’etichetta 2-Tone proposto dagli Specials e dai
Selecter, il reggae “candeggiato” dei Police, e la musica di quei
rudy bianchi che erano i Clash, rappresentano finalmente il riconoscimento dell’importante ruolo che il reggae giamaicano
ha avuto nella periferia del pop bianco inglese.
NOTE
1 È durante la metà degli anni Sessanta che si stabili un ponte diretto
tra la musica nera americana e il pop bianco inglese. I primi esempi isolati di musicisti neri come Fats Domino, Little Richard, Chuck Berry,
furono sostituiti da sound ed etichette identificabili come “neri”: soul
music, “Stax”, “Tamia”.
2 Il look maschile esigeva un tempo pantaloni esageratamente scampanati in fondo e cintole alte una dozzina di centimetri, magliette a
mezze maniche firmate o canottiere e capelli generalmente corti. Un
ricambio di vestiti per sostituire quelli madidi di sudore dopo una
notte trascorsa all’insegna di balli scatenati, veniva portato in una
borsa sportiva tappezzata di adesivi e slogan di club del Northern Soul.
3 Tali trasferimenti erano regolarmente provocati dalle incursioni delle
squadre antinarcotici. Come già per i mod un decennio prima, le anfetamine, chiamate gear (marcia, ma anche roba) nel gergo del Nord, sono
associate con il culto notturno del ballo e del soul. II Wigan Casino - il
principale tempio del Northern Soul - chiuse infine i battenti
nell’autunno del 1981. Ma l’entusiasmo per il soul e le “creature della
notte” continua ancora.
4 La variazione della terminologia, da “persona di colore” (o “negro”) a
“nero”, fu soltanto il risultato più evidente della pratica diffusa nella
cultura nera di trasformare la semantica della lingua inglese. A parte la
particolare morfologia dei ritmi e della sintassi del discorso, un idioletto nero si può rintracciare anche nelle trasformazioni semantiche di
tipiche espressioni repressive. Le connotazioni negative e temute del
termine “nero” sono adottate con orgoglio, e aggettivi come cattivo, volgare, eccetera, vennero usate come termini di apprezzamento. II linguaggio, come primo medium della coscienza quotidiana, è stato affinato nella cultura popolare dei neri americani fino a diventare una pratica comunicativa (in segano ben evidenziata nel rap), che comprende
134
contemporaneamente tutti i suoi potenziali utenti, escludendo la partecipazione dei bianchi.
5 Si potrebbe dire anche la stessa cosa delle nuove protagoniste nel cinema nero di allora; per esempio le donne forte interpretate da Pam
Grier, recentemente ripresa in un tributo al quel momento da Quentin
Tarantino, Jackie Brown.
6 Il senso corporeo della disco music è ulteriormente accentuato in
molte discoteche con l’uso del “Boom Box”, uno strumento che riproduce le note basse un’ottava sotto il livello in cui sono registrate. La musica colpisce letteralmente i corpi dei ballerini come una serie di onde
fisiche/sonore.
7 È abbastanza significativo che il vero interesse per Bob Marley in
Inghilterra si sia prodotto dopo lo scioglimento dei Wailers e quando
questo sound fu gestito da Chris Blackwell e dalla Island Records. Non
fu tanto il particolare suono giamaicano di Burning (1973), quanto il
“contaminato” LP Catch a Fire, distribuito quello stesso anno, a incontrare il maggior successo. Alla voce caratteristica di Marley e ai suoi
testi furono aggiunti gli effetti della sala d’incisione londinese. Il risultato fu un LP di reggae dal sapore rock o reggae “progressivo”.
8 Per ulteriori particolari su questi aspetti della cultura giamaicana,
cfr. l’eccellente saggio di Rex Nettleford sull identità nazionale della
Giamaica, in Nettleford 1972. Sul reggae e la cultura popolare giamaicana, cfr. Davis-Simon 1972, Johnson-Pines 1982 e il romanzo di Michael Thelwell The Harder They Come (1980).
9 Questa pratica è ben documentata in una scena memorabile del film
giamaicano The Harder They Come (1972) di Perry Henzell. Il romanzo sopra menzionato di Michael Thelwell è un approfondito omaggio letterario alla vitalità del film originario.
10 Per una lucida trattazione sul contesto afrocaraibico delle influenze
e delle tracce africane nelle musica popolare giamaicana, cfr. JohnsonPines 1982, pp.12-35.
11 Secondo la descrizione di Garth White “il piano o la chitarra ritmica
accentuavano l’and nel ritmo one-and-two-and-three-and-four-andeccetera. Il batterista suonava nel frattempo i quattro quarti convenzionali in batterie sulla cassa, e il contro-beat sul rullante” (JohnsonPines 1982, p. 49).
12 Garth White fornisce ancora un’utile descrizione della struttura di
base del reggae: “Una nota di durata inferiore viene aggiunta al classico
`after-beat’ dello ska/rock steady, in modo da ottenere un andamento
del genere: One-anda-two-anda-three-anda-four, eccetera.” White
osserva poi che il batterista continua a intervenire in mezzo alle battute, ma in modo che ne risulta “un ritmo più sinuoso e meno saltellante” (Johnson-Pines 1982, p. 61).
13 Le visioni da incubo degli skinhead furono ricreate per la lettura dei
pacifici cittadini che sfogliavano libri e giornali da W .H. Smith in
quella serie di rapporti dal fronte giovanile che erano i romanzi di Richard Allen (Skinhead, Skinhead Farewell, Boot Boys, Skinhead Girls). Il
legame tra gli skinhead e le correnti popolari del provincialismo culturale spiega forse anche perché questa sia l’unica sottocultura il cui
carattere conservatore le ha permesso di ritornare in scena con successo. Per quanto riguarda il “ritorno” degli skinhead nei tardi anni Settanta, in questo caso ostentatamente organizzati attorno alla rabbia bianca della musica Oi, si veda il capitolo seguente.
14 Già verso la fine degli anni Sessanta, vari rapporti ufficiali rivelavano che la gioventù nera era fortemente discriminata sul mercato del
lavoro inglese.
15 Gli autori di Policing the Crisis osservano: “La sorveglianza poliziesca dei neri minacciava di portare con sé il problema di sorvegliare anche poveri e disoccupati: tutti e tre erano concentrati esattamente nelle
135
stesse zone, un fattore che naturalmente forni quell’elemento di omogeneità geografica che facilita la nascita di una coscienza militante. Il dilagante problema di sorvegliare i neri era diventato praticamente sinonimo del più vasto problema di sorvegliare la crisi” (Hall et al. 1978,
p. 332).
16 La limitata tolleranza e rispettabilità che i rasta si sono conquistate
in Giamaica, un giusto riconoscimento della loro discendenza quasi diretta da Marcus Garvey, l’eroe nazionale giamaicano, non ha trovato
eco nella vita pubblica inglese.
calipso dei Mighty Sparrow e di Lord Kitchener sono probabilmente gli
esempi più conosciuti di questo genere. A parte il calipso, vi sono anche la soca e lo spooge (un incrocio tra soul e reggae). Per ulteriori notizie sulla presenza e la popolarità di queste musiche in Inghilterra, cfr.
le interviste in Invisible Hits: The Carribean Connectivn (“Collusion”,
4, 1983).
17 Si deve dire che il senso comune non era provocato ovunque così efficacemente. La predominante componente maschile della cultura di
strada dei neri di gran parte della musica reggae si è concentrata sull’equivalente reggae della mitica figura blues di “Staggerlee”. “Naddy
Dread” è un eroe caraibico che può sconfiggere e ridicolizzare tutti i rivali maschi. Fino a poco tempo fa le “sorelle” o “regine” del movimento
Ras Tafari hanno sempre considerato la liberazione della donna e il
femminismo come una “sciocchezza”: per loro la conservazione della
virilità del rasta è una condizione intrinseca per isolarlo dalle forze di
Babilonia. Nella filosofia rasta del recupero della sua dignità perduta e
della sua virilità ottomessa, anche l’omosessualità è ritenuta qualcosa
di innaturale ed “empio”. Quanto al controllo delle nascite, la risposta è
stata spesso drastica: “Vogliono trasformare le nostre regine in cimiteri” (Nettleford 1972, p. 93). Il “ragionamento” ontologico significava
presumibilmente che il ruolo e la collocazione naturali delle donne costituiscono un’entità in cui tale logica rifiuta di assimilare le forze
storiche e le realtà contemporanee. Comunque, si sono manifestati
segni, sia in Giamaica sia nella comunità nera d’Inghilterra, che indicano un possibile cambiamento di queste posizioni (cfr. Gilroy 1982).
18 Non si deve dimenticare che il reggae non è l’unica musica dei
Caraibi che è stata “tenuta nascosta” in questo modo. Anche altre musiche popolari della Giamaica e dei Caraibi hanno avuto un largo pubblico soprattutto tra le più vecchie generazioni delle Indie occidentali. I
136
C HAPTER 7
Paesaggi
sonori urbani
1976-1983
Tra l’autunno del 1976 e l’estate del 1977, una musica particolare, uno stile sottoculturale molto vistoso e una crisi nazionale sempre più incalzante sembrarono per un momento
fondersi insieme. Il punk fece irruzione in una Londra colta di
sorpresa e acquistò ben presto quei sinistri connotati che ne
fecero un nuovo spauracchio popolare, una dimostrazione
drammatica del preoccupante aggravarsi dello stato di
malessere in cui versava la Gran Bretagna. Irreggimentati
dalla stampa popolare, dalla televisione e dalla radio, e sottoposti a una censura generale, i punk furono posti sotto i riflettori di una squallida scenografia che preannunciava inequivocabilmente la rovina sociale: “la selvaggia musica pop della
gioventù ribelle” (“Sunday Mirror”), “il rock dei disoccupati”
(“New Society”), “lo sfruttamento commerciale del sesso e
della depravazione” (Marcus Lipton, membro del parlamento), “la negazione della cultura” (Brooks-Patridge, presidente dell’Art Committee del Consiglio municipale di Londra.
Molti vedevano nel punk un fenomeno fin troppo ovvio, altri
cercavano di scoprire in esso un senso politico al di là dei simboli violenti e provocatori che circondavano quella sottocultura, e si domandavano se fosse un fenomeno fascista o anarchico. Nonostante tanto interesse, i segnali erano contraddittori, i segni stranamente piatti e refrattari a ogni interpretazione. La svastica che si intravedeva sotto le magliette con la figura di Kart Marx; il corpo emaciato del punk perforato da
spille da balia, avvolto nella plastica e serrato in un collare per
cani; quegli occhi vitrei e sbarrati dalle anfetamine sotto le
ciocche arruffate di capelli tinti con colori appariscenti: erano
questi i segni sconvolgenti che per un momento inorridirono e
affascinarono insieme il mondo esterno. Ma erano segni che si
rifiutavano di parlare una lingua riconoscibile. L’esasperante
“mutismo” del punk, quei volti “inespressivi” fissati sulle foto
dei giornali, escludevano qualsiasi termine di riferimento disponibile. Il punk poteva essere definito solo in modo negativo,
come un’assenza, un vuoto perverso; la sua semantica interna
rimaneva sconosciuta.
Questo è solo uno, anche se il più appariscente, degli eventi
che si sono intrecciati nella recente storia del pop. Molti effetti, contaminazioni e propositi confluirono nelle mutevoli direzioni indicate dal punk e dai suoi fenomeni collaterali. Il suo
rifiuto di adattarsi a definizioni precostituite, la sua deliberata
scelta di qualcosa al di fuori della realtà circostante, possono
essere considerati i legami di una catena che doveva successivamente connettere le musiche e i protagonisti più disparati.
Punk e “neoromantici”, “electrodandies” e “decostruttivisti”
musicali (dub, rap, postpunk, “rumoristi”) sono tutti aspetti di
una differenziata rielaborazione dell’eredità culturale del pop
in Gran Bretagna che, attraverso una mescolanza di linguaggi
- musicali, sessuali, estetici - stava a indicare un drastico mutamento di prospettive. L’ideologia “della strada”, il populismo
musicale e l’“avanguardia” coesistevano indiscriminatamente
dentro l’involucro della città. Esperienze e realtà che un
tempo erano considerate definitivamente separate erano ora
assorbite dentro un’accelerata espansione delle immagini e
dei codici urbani.1
138
LA LIBERAZIONE DELL’INDICIBILE
A questo punto entrano in scena le intonazioni, il particolare modo di
pronunciare una parola. A questo punto, accanto al linguaggio acustico
dei suoni, entra in campo anche il linguaggio visuale degli oggetti, dei
movimenti, degli atteggiamenti, tale da prolungare il significato, la
fisionomia e le combinazioni, finché questi diventano segni, e da fare di
questi segni un tipo di alfabeto.
Antonin Arcaud, Primo manifesto del Teatro della crudeltà
Il “provocatorio” suono punk dei Sex Pistols, appropriatamente intitolato ‘Anarchy in the UK’, venne lanciato dalla EMI
il 26 novembre 1976. A quasi un anno esatto di distanza, la Virgin Records produsse l’LP, Never Mind the Bollocks. Here’s
the Sex Pistols. Nel tempo intercorso tra questi due avvenimenti, il manifesto musicale del punk era divenuto di patrimonio pubblico. Intanto, sia la BBC sia la Capitai Radio di Londra proibirono la trasmissione di tutti i singoli dei Sex Pistols,
con l’unica eccezione di ‘Pretty Vacant’. Nonostante ciò, ‘Anarchy in the UK’, ‘God Save the Queen’ e ‘Holidays in the Sun’
divennero tutti brani di successo. Nel frattempo le autorità di
polizia intentavano giudizio, ma senza successo, per fuso della
parola “bollocks” (coglioni), scritta sulla copertina dell’LP
Tuttavia al di sotto di tutto questo scompiglio istituzionale,
era nato nel cuore di Londra un nuovo circuito musicale. Al
100 Club di Oxford Street, al Roxy di Covent Garden, e al
Nashville di Kensington, gruppi di giovani bianchi, uniti assieme dal sudore e dal frastuono, venivano iniziati ai suoni dei
Pistols, dei Clash, dei Damned, dei Buzzcocks, di Siouxsie and
the Banshees, delle Slits e del X-Ray Spex.
Attraverso i ritmi frenetici e aspri della chitarra, le voci deliberatamente “non educate”, testi spesso politici, e il beat “robotico” (accompagnati dal ballo in stile “zombie” del pogo),
questi gruppi proponevano la lacerante cacofonia della “città
traumatizzante” nella sua fase terminale. La possibilità di discutere di qualità artistiche e musicali fu brutalmente soffocata. Nella semplicità quasi anonima del punk il senso della
musica si trasformò bruscamente in un “nonsenso”. La diffidenza dell’establishment nei confronti del pop fu ulteriormente intensificata dalle ripetute dichiarazioni dei punk a favore di una tecnica musicale populista: “Questo è un accordo.
Questo è un altro. Questo è un terzo. Ora formate un gruppo”
(Mark Perry, “Sniffin’ Glue”, 7, February 1977).
Il punk, così come il rock’n’roll e lo skiflle negli anni Cinquanta, il beat e il R&B agli inizi degli anni Sessanta generò
ben presto una rivolta nel mondo della musica. E da una settimana all’altra, da un’esibizione all’altra, lo scambio tra la musica e il suo pubblico venne favorito e diffuso dalle cosiddette
“fanzine”. Queste -“Sniffin’ Glue”, “Ripped & Torn”, ‘Live
Wire”, “Chainsaw”, “Gun Rubber” - erano fogli prodotti in
casa, fotocopiati e legati con una cucitrice, sui quali si riportavano recensioni di dischi e concerti, testi di canzoni e interviste. Dopo Londra, anche nei quartieri residenziali, nelle
scuole e nei club di città diverse come Belfast e Birmingham,
Edimburgo e Bristol, cominciavano a emergere una musica e
un giornalismo punk di carattere locale.
La genealogia musicale dei punk - i timbri londinesi dei primi
Stones, degli Who e dei Kinks, insieme alla tenebrosa America
139
dei Velvet Underground, di Iggy Pop, e dei New York Dolls e
dei Ramones - si esprimeva nelle brusche tonalità di un suono
diretto e aggressivo, semplice nell’esecuzione e deliberatamente “polarizzante” negli effetti. Ma gli accenti e i temi locali
del punk non erano l’ultima risposta a una precedente esperienza inglese, né alla nascita di una nuova tendenza
americana.2 Evidenziando deliberatamente la sua collocazione
nella metropoli inglese, il punk cercava una intensità nuova. Il
modo di cantare di Mick Jagger, Rod Stewart o Stevie Winwood fu sostituito dall’“imbiancata” laringe di quello che è
stato giustamente definito “anticanto” di Johnny Rotten o Joe
Strummer.
Il punk era una musica decisamente “etnica”. Il suo crudo
suono locale produceva un “rumore” bianco che risultava offensivo per il pop normale quanto l’indecifrabile “monotonia.”
del reggae, col suo basso rintronante e i suoi ritmi stoppati, risultava misteriosa. Come ha dimostrato Dick Hebdige, l’eventuale dialogo tra questi due estremi non fu affatto accidentale
(Hebdige 1979). Cercando ai margini della società una provocazione culturale e una stigmatizzazione sociale, i punk riattivarono inevitabilmente quel perenne contatto tra la cultura
nera e gli stili della gioventù bianca: i punk erano “negri”
(Richard Hell), e la loro musica “reggae bianco” (Johnny Rotten). L’orgogliosa insistenza del reggae sull’etnicità nera e la
sua concreta sintassi della “sofferenza” erano una prospettiva
particolarmente attraente per i punk, che volevano evitare il
sentimentalismo di gran parte del pop o l’altra trappola, la
nebulosa “artisticità” del rock progressivo.
Durante l’estate del 1976, l’esangue corpo del punk, vestito di
stracci tenuti insieme da catene, spille e nastro adesivo, divenne il temporaneo testimone della crisi e il suo peculiare abbigliamento lo specchio apparente di un decadimento morale.
Ma l’attenzione che il punk poneva sulla struttura corporea,
singolarmente concentrata nel suo corrosivo incontro vocale e
fisico con le forme musicali, provocò un significativo ritorno
di una parte del pop bianco verso le ambiguità del corpo:
quella zona “proibita.” che tende a essere associata alla musica
nera. A parte il reggae, l’altro principale interlocutore fu la
disco music, ma mentre il richiamo di quest’ultima era diretto, quello del punk era tipicamente trasversale. Il corpo
non era tanto accettato, quanto continuamente rimosso, diventava un attaccapanni per vari stili, un oggetto deliberatamente
sfruttato e trascurato, una fonte priva di sesso e sentimenti. I
soli titoli delle canzoni esprimono gin il senso di questa idea:
‘Career Opportunities’, ‘Oh, Bondage! Up Yours’; ‘Pretty Yacant’, ‘Rip Off’, ‘High Rise Living’. Esagerando una stilizzata
identità sessuale, con tutta quella plastica, quelle catene e
quelle immagini sadomasochistiche, i punk trascurarono temporaneamente il tradizionale romanticismo del pop per acquisirne uno proprio, singolarmente asessuato, un romanticismo
da “strada” che provocò una certa confusione tra i ruoli sessuali.
Il sessismo però non scomparve. Il punk continuava a presentarsi in un profilo maschilista. Tuttavia il suo stile reattivo, operante su un’amalgama insospettata di ambiguità glam rock,
di diversità stilizzate e di echi lontani del Movimento di libera140
zione delle donne, favorì l’affermazione di una nuova e contradditoria immagine femminile nella musica pop bianca. Da
un mucchio di impermeabili sporchi, di vecchie uniformi scolastiche, di gonne ricavate da sacchi dell’immondizia, di tacchi
a spillo, di maschere di cosmetici e di voci provocanti emerse
uno spazio riservato per le donne come protagoniste attive
della scena musicale. Lo scompiglio creato dalle voci “innaturali” di Siouxsie Sue, di Poly Styrene, e delle Slits, frantuma il
modello di canto femminile del pop di allora. L’esempio di
poco precedente e piuttosto isolato dell’americana Patti Smith
fu sostituito da una ricostruzione più collettiva della vocalità
femminile bianca.3 Questa nuova figura non si inseriva facilmente nella tradizionale iconografia del pop. Come ha osservato Laura Mulvey, si trattava di una transizione verso la possibilità che le donne divenissero pubbliche “produttrici di significato” (Mulvey 1975).
Nel frattempo per la stampa musicale era praticamente impossibile ignorare la provocatoria presenza del punk nel circuito
musicale londinese e il crescente interesse nazionale per il fenomeno. Lo shock culturale, che anticipava alcune delle rotture che sarebbero state prodotte dal punk in altri ambiti del
pop, fu allora sintomaticamente espresso da un articolo di
“Melody Maker”:
Ciò che appare assolutamente riprovevole è l’irresponsabile enfasi
posta sulla violenza e sul nichilismo pratico, perfettamente espressi dai
Sex Pistols con Anarchy in the UK. Un artista come Kevin Coyne, per
esempio, che con canzoni come Turpentine (un duro commento sulla
violenza suburbana repressa) e come House on the Hill (su una clinica
per malati mentali), ha esplorato temi non meno stimolanti o rilevanti,
ma il suo lavoro è stato raffinato da eloquenza e sensibilità.4
Tuttavia la reazione iniziale delle tre principali riviste musicali
fu difforme. La violenta immediatezza del punk ricordava anche l’effetto dirompente del rock’n’roll. A questa osservazione
seguiva spesso una certa approvazione da parte della critica
che produsse inevitabilmente un proprio codice giornalistico
di parte:
Glen Matlock e Steve Jones inseriscono la spina e Paul Cook si siede
dietro alla sua batteria, mentre Rotten si limita a penzolare dall’asta
del microfono, apre una lattina di birra e sfida la folla con il suo
sguardo vitreo, provocante e cinico. Capelli tinti di rosso, arruffati, un
viso bianco cadaverico, pezzi di metallo appesi alle orecchie, lunghi pantaloni sulle gambe ossute, panciotto rosso, cravatta nera e spille da
balia: sembra uno di quei cadaveri imbottiti d’anfetamine che popolano le fantasie della stampa popolare. Qualcosa lanciato dal pubblico
lo colpisce in pieno viso. Rotten getta uno sguardo gelido verso quella
persona, con le labbra socchiuse sui denti cariati. “Non tirarmi la tua
merda” ringhia lui. “Non siamo qui per fare casino... Il primo pezzo è
dedicato a un membro del consiglio di Leeds, Bill Grundy, e alla regina.
Andate a farvi fottere.5
Questo modo di scrivere, con la sua acuta attenzione per il
particolare, il suo reportage impassibile sulle maniere provocatorie del punk e la sua voluta omissione di dove finisce lo spettacolo e dove inizia il “pubblico”, rivela una nuova gamma di
sfumature culturali.
141
IL SOGNO DELL’INGHILTERRA
In effetti, non siamo dentro la musica. In che cosa, allora? Siamo nel
caos.
Uno dei Sex Pistols
All’inizio, ciò che richiamò l’attenzione nei confronti del punk
non furono tanto gli aspetti musicali quanto i sensazionali
comportamenti esibiti in pubblico. Di primaria importanza
nel punk fu l’incrocio tra uno stile maschile della classe operaia e i comportamenti anticonformisti tipici delle scuole superiori; una convivenza che già si era rivelata centrale negli atteggiamenti distaccati e un po’ snob dei mod (ma era significativamente assente nei proletari skinhead e nelle appariscenti
idiosincrasie dei ted). In questo caso, però, quel sottile interscambio era sostituito da una caotica sovrapposizione.
Quando il punk volle esibire le sue credenziali di classe, evitò
accuratamente tutti i connotati appiattiti del rispettabile proletariato bianco. Con i suoi vestiti stracciati, le sue bestemmie e
i suoi sputi in pubblico, il punk scelse l’abbigliamento emarginato dei dannati della città: il “lumpen-proletariat”.
Questi atteggiamenti e le analogie ricercate dal punk nel rastafarianesimo e nel reggae non cancellarono l’elemento di classe
nella composizione di questa musica. Ma quella produzione
simbolica comportava un’attenzione particolare per una
nuova complessità, per una rielaborazione radicale dei concetti di cultura e classe. Orgoglioso del suo “mutismo”, il punk
rappresentò tuttavia la più articolata delle sottoculture: antiartistico nelle intenzioni, esso adottò una strategia della provoca-
zione estetica; negando il significato comune di classe e di politica, espresse un radicalismo sociale assai esplicito.
Ma se il punk non aveva dirette connotazioni sonore di classe,
esso non fu neppure un semplice espediente commerciale,
una volgare truffa ideata dal manager dei Sex Pistols, Malcolm
McLaren. L’ispirata direzione di McLaren del principale
gruppo punk è stata spesso collegata alla logica di ispirazione
dadaista dell’Internazionale situazionista, in un’immagine rafforzata in seguito dallo stesso McLaren nella necrologia cinematografica dei Pistols: The Great RocknRoll Swindle (1980)6
Ma Malcolm McLaren (Cash from Chaos, Soldi del chaos) fu
solo uno degli autori del punk. Tra questa sottocultura e i
situazionisti esistevano legami meno personalizzati che si ritrovavano nel programma comune di sovvertire la passiva “società della noia”. Nei limiti degli esistenti legami sociali poteva
anche non esserci “alcun futuro”, ma rimaneva sempre la possibilità del gesto perverso; il momento in cui si afferma l’immaginazione, per rivelare “un’oasi di orrore in un deserto di
noia” (Baudelaire).7
Ma il marcato dadaismo dei punk andava ricercato, oltre che
nelle consapevoli affermazioni di Malcolm McLaren e di Bernie Rhodes, l’allora manager dei Clash, nel ridondante e
caotico stile quotidiano dei punk. In questo caso, gli slogan sottolineavano le tendenze culturali del punk nella parola d’ordine “Distruggi. Anarchia”’. Qui, un pubblico passivo veniva
spazzato via da coloro che avevano costruito una “situazione”.
Qui coloro che volevano vivere cercavano di spezzare le invisibili catene di un sistema di vita fondato sull’autocompiaci142
mento. La logica dadaista di assorbire tutte le banalità, la sporcizia e gli scarti del mondo per poi imprimere un nuovo significato a quel caotico assemblaggio era presente nella musica e
nel modo di vestire del punk, che “tagliava”, mescolava e reinterpretava precedenti stili sottoculturali, così come precedenti
tipi di musica. Ricorrendo a elementi diversi presi dal guardaroba dei ted, dei mod e degli skinhead, il punk trasformava la
rigidità di quegli stili in scelte nuove e flessibili: ciuffi imbrillantinati accanto a teste rasate, minigonne e calze con giarettiere, stivali da lavoro e scarpe a punta, le cosiddette winklepickers (Hebdige 1979, p.26). Era proprio questa sintesi innaturale, questo collage “inautentico” che veniva ostentato.
Nel frattempo, gli aspetti provocatori del punk non deludevano le aspettative dei media. Il caso dei Sex Pistols che bestemmiavano durante un varietà televisivo, il Bill Grundy
Show, della Thames Television (“Grande scandalo, mentre gli
spettatori intasano le linee telefoniche”, scriveva il “Daily Mirror”) fu solo il primo di una serie di analoghi incidenti ben
pubblicizzati. Gli operai addetti all’imballaggio dei dischi nello
stabilimento della EMI di Hayes si rifiutarono di maneggiare
il primo disco dei Pistols, ‘Anarchy in the UK’. In seguito la
stampa cercò di inscenare una battaglia fra punk e ted, come
revival degli.scontri avvenuti tredici anni prima tra i mod e i
rocker. Durante un concerto punk una ragazza venne accecata
a un occhio con un pezzo di vetro rotto. In questo clima di reazioni ostili nei confronti del punk, persino le case discografiche cominciarono ad avere paura. Prima la EMI e poi la
A&M annullarono il contratto con i Sex Pistols, e dovettero
sborsare migliaia di sterline come indennità per la rottura degli accordi.8
Il risultato fu che il punk si trovò immerso nella violenza e circondato da un clima di pubblica indignazione. Come tutte le
precedenti sottoculture, il punk fu inevitabilmente oggetto di
scandalo e di recriminazione, ma nel suo caso le invettive non
erano rivolte tutte in una sola direzione. Spezzando il ciclo di
provocazione e di condanne, il punk non solo accettò il pubblico ostracismo (“i punk amano essere odiati”, ha detto un
punk), ma lo restituì ai “media.”, sotto forma di insulti visivi e
musicali, e nelle aberrazioni sessuali cui il guardaroba feticista
fatto di gomma, plastica e abiti sado-maso si richiamava. L’universo punk riecheggiava in modo perverso le denuncie ufficiali della “crisi”, nel mentre accentuava le forme sinistre di stili
urbani devastati che univano i temi dirompenti del sesso e
della violenza come sintetizzava con provocatoria evidenza il
nome stesso dei “Sex Pistols”.
Un “futuro punk” è ciò che un editoriale del “Daily Mirror” del
giugno 1977 preannunciava a quel folto gruppo di ragazzi che
lasciavano la scuola per entrare nel mondo della disoccupazione, una generazione “che si inacidisce sotto i nostri stessi occhi”: il punk come simbolo della crisi. Mentre la situazione
stava manifestatamente disgregandosi, c’era il pericolo dell’anarchia, o di qualcosa di peggio. Per un breve momento i volti
imbiancati e i distaccati profili dei punk londinesi furono visti
come truppe d’assalto di una prorompente ondata di caos.
Mentre da un lato gli inglesi venivano chiamati a duri sacrifici
per affrontare una crisi che si profilava lunga e difficile, era
143
chiaro che non si poteva permettere a questa nuova minaccia
di passare incontrastata. Nel mezzo delle celebrazioni del Giubileo reale, quando si scoprì che l’Anarchy Tour dei Sex Pistols
e dei Clash era partito in tournée, molti consigli comunali e
autorità universitarie negarono a questa massa di alieni l’accesso nei loro locali. Il linguaggio ufficiale andava acquistando
toni più aspri e l’opinione pubblica, sempre più sensibilizzata
nei confronti di un cambiamento indesiderato, assunse prontamente comportamenti rigidi e inflessibili.
La perversa insularità del conservatorismo popolare - un particolare “senso comune” o “anglicità” - si aggrappa tenacemente
a istituzioni e prospettive che sembravano pronte per essere
imbalsamate già un secolo prima. Incoraggiato, ringiovanito
ed esteso durante gli ultimi vent’anni attorno a punti di mobilitazione quali la “razza”, la “legge” e l’“ordine”, questo humus
popolare è stato di recente rinfrescato sotto la direzione della
signora Thatcher. Una supremazia della destra, caratterizzata
da un forte idealismo e da una visione globale, radicata nelle
istituzioni e nelle esperienze della vita quotidiana, ha spezzato
via il gretto pragmatismo dei precedenti governi conservatori,
ma anche di quelli laburisti, sostituendolo con la prospettiva
dell’“anglicità”. Nella sua drastica baldanza, essa appare “moderna” e piacevolmente corroborante, pur traendo ispirazione
dal più profondo e tradizionale dei sentimenti, quello della
nazione.9 La rinvigorita eredità della “razza isolana” (Winston
Churchill), ha trovato un’ulteriore conferma storica nel revival
popolare della Corona britannica, coi festeggiamenti del Giubileo reale (1977), e delle nozze reali (1981), e nel trionfo dei
principi nazionalistici, con la spettacolare epopea militare
della guerra nelle Falklands crudelmente messa in scena nella
primavera del 1982.
In questo rigido scenario il fenomeno del punk con i suoi effetti dirompenti potrebbe sembrare solo uno spettacolo secondario e transitorio. Tuttavia, per ritornare al 1976, i punk avevano iniziato a modo loro a porre in questione il contesto esistente. Attraverso la loro musica e il loro stile di vita suggerivano e allargavano gli spazi per un sovversivo “gioco culturale” entro i confini apparentemente banali della vita quotidiana. La miseria del presente non fu tanto rifiutata, quanto
rigenerata. Il punk proclamava la necessità di violare il monotono copione quotidiano del senso comune, proponendo
una macabra parodia dell’idealismo sul quale si fondava il concetto di “anglicità”, quel severo pragmatismo che non vede alcun futuro al di là del presente, e nessun presente oltre a
quello, apparentemente immutato, che è ereditato dal passato. Lo stile punk era l’amalgama di tutte le precedenti sottoculture, la sua musica era la somma di tutti i “rumori” giovanili ribelli, il suo comportamento sociale il perverso opposto
di quello “normale” (“Ce la metto tutta per essere carino”,
Johnny Rotten), e così, esasperando quei legami fino a spezzarli, riuscì momentaneamente a scuotere la loro intrinseca inerzia in un movimento locale. Più di questo il movimento
punk non ottenne, né poteva ottenere. Rimase comunque un
manifesto provocatorio, che ha spesso illuminato con la sua
vitalità gran parte della musica pop bianca successiva. Rovesciando le ortodossie circostanti, quali erano, il punk mise in
144
luce crudamente, ma efflcamente, che un ordine arbitrario,
ma ampiamente diffuso, era suscettibile di critiche e trasformazioni.
sic sia debitrice verso le culture afroamericane e afrocaraibiche. Ne sono un’ulteriore conferma la disco music, il reggae e
il rap dei tardi anni Settanta. Ma queste influenze si sono
estese anche al di là della dance music, del soul bianco, del
funk e della riscoperta dello ska, fino alle sperimentazioni
nella musica pop d’avanguardia.
LA VIBRAZIONE DELL’AFRICA NEL CORPO ELETTRICO
Nell’anno 1975, Bobby Womack lanciò l’LP Safety Zone. È un
disco che, come qualsiasi altro uscito a metà del decennio, ci è
utile per capire le origini della disco music nera. (Altri esempi
importanti furono ‘Rock your Baby’, di George McRae, del
1974, e ‘The Hustle’ di Van McCoy, del 1975). Lo stile vocale di
Womack, un miscuglio di sermone evangelico, soul vellutato,
rap parlati e falsetti striduli, era accompagnato da un coro e
da arrangiamenti particolari che si servivano di sporadici ma
efficaci fraseggi di ottoni su una base di batteria, basso e chitarra wah-wah. In particolare è con la canzone finale dell’LP,
‘I Feel a Groove Coming On’, che si svela il futuro della disco
music per il soul. Dopo un’introduzione parlata, questa canzone di otto minuti si adagia su un avvolgente ritmo regolare
interrotto dalla voce di Womack e da un assolo del pianista
Herbie Hancock verso la metà. In questo consiste l’espediente
innovativo della disco music: l’impulso musicale viene liberato dagli ambienti claustrofobici del blues e dalla rigida impalcatura del R&B e del primo soul. Un attacco più libero,
esplicitamente poliritmico, spinge il patrimonio del blues, del
gospel e del soul in un ciclo apparentemente senza fine, in cui
non esiste inizio o fine ma solo un onnipresente “adesso”. La
disco music non si arresta in un punto preciso, ma semplice-
Harvey Fuqua, ex cantante dei Moonglows, un gruppo doowop degli anni Cinquanta, e ora noto produttore discografico,
oltre che manager di Sylvester, una star gay di colore della
disco music, ha ricordato i vecchi tempi in un’intervista a
“Black Music & Jazz Review”:
Abbiamo incominciato registrando circa dodici canzoni per la Chess, e
su una sola pista, badate bene. Non era come oggi, quando si hanno 32
e 64 piste per suonare. Si metteva il microfono in mezzo alla stanza e
tutti si sistemavano lì intorno, l’orchestra, i cantanti, tutti quanti. Se si
voleva far sentire uno strumento o un cantante, si doveva spingersi
avanti o indietro. E non era necessario usate la batteria: si poteva usare
l’elenco telefonico e agitarla. C’era da impazzire.10
Sono passati venticinque anni dalla semplice registrazione di
doowop alle tecnologie sofisticate della disco music e del dub.
In quell’arco di tempo, suoni e ritmi neri, che una volta “sembravano occulti, incomprensibili all’esperienza dell’Europa occidentale” (Joseph Conrad), hanno continuamente accompagnato la musica pop bianca inglese, intervenendovi e aprendo
nuove prospettive. Abbiamo visto più volte come la dance mu-
145
mente svanisce a poco a poco dall’udito. Limitata a un pezzo
singolo di tre minuti, questa musica non avrebbe senso. La
forza della disco music - che ben presto doveva essere favorita
tecnologicamente con l’introduzione dei lunghi disco-mix singoli - sta proprio nel saturare con la sua incessante, esplosiva
presenza, la pista da ballo e i ballerini.
e i vari incroci tra ritmi afroamericani e ritmi ispanici provenienti da Cuba e Porto Rico.11 Infine, prima che gli studi di New
York realizzassero quella sintesi cosmopolita di musica da discoteca, il Philly Sound dei Sigma Studios di Philadelphia
aveva già fatto importanti passi avanti nel fondere insieme
molti di questi elementi.
A metà degli anni Settanta, la disco music conobbe a New
York un successo strepitoso. Il suo boom fu consacrato in locali come Studio 54, Xenon, Infinity, Les Mouches, e in migliaia di altri situati anche fuori dall’elegante Manhattan. Fra i
raggi laser e i movimenti riflessi da specchi, ognuno diventava
una star, un “eroe del sabato sera”. Ma se da un lato la disco
music offriva la possibilità di uno spettacolo “democratico”,
restituendo la notte al ballo, e riproponendo il corpo come protagonista culturale, dall’altro incise profondamente sulla conseguente economia sonora del pop. L’apparente semplicità ipnotica della disco music, una vibrazione circolare su un “beat”
regolare, era in effetti il risultato di una lunga distillazione, un
complesso incrocio fra diversi percorsi musicali. Con “il suo
basso spezzato, i ritmi soffocati e gli ottoni stoppati” (Ian
Hoare), il gospel profano di James Brown era stato una presenza centrale in dischi come ‘Cold Sweat’ (1967), ‘Mother
Pop-corn’ (1969), e ‘Superbad’ (1970). Questo fatto e l’estensione del soul in film neri di cassetta portarono a un maggiore allargamento dei timbri e a un’ampliamento della
struttura. Ulteriori contributi furono l’eclettismo di Sly Storie, l’influente eredità chitarristica di Jimi Hendrix, il poliritmico muro sonoro elaborato dal trombettista jazz Miles Davis,
L’accusa di essere “commerciale”, rivolta alla disco music, per
cui il sound più popolare del decennio, la “musica della gente”
(Peter York), rimase largamente ignorato da considerevoli settori della stampa musicale inglese fino al termine degli anni
Settanta, non serve a spiegare l’entità del suo successo. Il rapporto immediato che si era stabilito fra la disco music e il
vasto pubblico delle discoteche alimentò certamente un
grande interesse commerciale. Il film La febbre del sabato
sera (1978), in particolar modo, sembrò confermare il giudizio
dei critici della disco music. In questo caso, si trattava di una
storia ben nota: un bianco, italoamericano (con vaghi riferimenti a Fabian, Frankie Avalon e altri), esibendosi come il protagonista sociale di una musica che indubbiamente era di origine afroamericana, trasforma la disco music in uno spettacolo
accettabile per un pubblico bianco.12
Ma anche la disco music aveva le sue “radici”. Anch’essa,
aveva iniziato come musica “dal basso”: un divertimento notturno da quattro soldi, a base di dischi sul sovrapposti, inseriti
e disinseriti continuamente per soddisfare il bisogno di ballare, i desideri romantici e l’evasione. Fu soprattutto fra la cultura delle minoranze gay e di colore di New York che la disco
music ebbe il suo battesimo, nei club gay come Haven, Sanctu146
ary, e a Harlem in locali come Betterdays e This and That Gallery. Secondo Tony Cummings, fu attorno al 1972 che queste
due culture iniziarono a incontrarsi negli stessi locali da ballo,
e un anno dopo “Billboard” introdusse il termine “disco hit”.13
L’incontro tra la cultura gay e quella nera attorno alla centralità erotica del corpo nel ballo era un parallelo importante, a
quel tempo praticamente ignorato, con quella confusione più
fredda e intellettuale che il glam rock stava contemporaneamente generando nel mondo degli stereotipi sessuali
maschili.14
In Inghilterra è sempre stato il ballo, e non la radio o altri media a fornire l’accesso principale a musiche e culture
afroamericane. Negli anni Settanta, è stato ancora nei club e
nelle sale da ballo inglesi che la musica dei BT Express, Disco
Tex, The Fatback Band, di Carol Douglas e Gloria Gaynor è
stata fatta propria sia dalla cultura gay sia dal più vasto pubblico dei frequentatori di locali da ballo. Le discoteche sono
state di fondamentale importanza per una maggiore accoglienza della musica nera in Gran Bretagna. Forse la radio
avrebbe diffuso il soul anche senza le discoteche. Ma certamente le discoteche hanno ampliato il boom del soul negli
anni Settanta. Innanzi tutto, esistono numerosi dischi di musica nera realizzati in primo luogo e principalmente per le discoteche, e non sono trasmessi per radio nemmeno se hanno
enorme successo nei locali inglesi.15
Il fatto che la disco music sia divenuta una musica commerciale di enorme successo non vuol dire che il mercato fosse in
grado di dirigerne e determinarne la ricezione e l’uso.
Nemmeno si poteva prevedere l’impatto che la disco music
ebbe su altre aree del pop, sul reggae, su una scuola inglese di
funk nero (Linx, Junior Giscombe), su varie correnti di quasifunk (Haircut 100, Funkapolitan, Rip Rag and Panic) e sulla
dance music bianca, elettronica, degli anni Ottanta.16 Come si
è già visto in precedenza, persino le operazioni commerciali
più attentamente controllate sono alla fine incapaci di prevedere gli eventuali esiti finali. La disco musìc, con il suo flusso
settimanale di dischi, il suo predominio del ballo, le sue mode
e i suoi film, era fondamentalmente un’industria di per sé, ma
non faceva eccezione alle incerte regole del consumo culturale.
E allora rimane da scoprire l’altra faccia della disco music:
nella frenesia del ballo, diverse musiche afroamericane (disco,
reggae e rap) continuano ad appropriarsi delle moderne tecniche di riproduzione e in questo processo riaffermano le culture orali di strada all’interno di un mezzo di comunicazione
elettronico. Sia il disc jockey che costruisce strati di suoni sui
piatti del giradischi, sia gli esperti del dub reggae alla “console”, sia le brillanti chiacchierate al microfono dei rapper,
tutti e tre illustrano il potenziale insito nella tecnologia moderna nel ripresentare, simulare le radici che hanno generato la
musica urbana contemporanea.
Il rap si trova all’estremo opposto rispetto alluso sofisticato di
effetti da studio impiegati nella disco music e nel reggae. A
New York, verso la fine degli anni Settanta, giovani di colore
permeati della stessa cultura che generò i grafftisti con la bomboletta spray e gli acrobati della “break-dancing”, utilizzarono
147
gli apparecchi più semplici e più diffusi nell’ambito dell’incisione sonora - piatti e microfoni - e li trasformarono in strumenti musicali veri e propri. Il rap è il sound system di New
York: la cultura dei giovani neri di Harlem e del Bronx che
trasforma con successo la tecnologia in una nuova forma culturale. Il rap è il graffito sonoro, uno spruzzo musicale che
fonde i ritmi neri e la ginnastica verbale del gergo di strada col
flusso di parole che un funambolico disc jockey sforna mentre
manipola il piatto del giradischi. Introdotto in Inghilterra
dalla Sugar Hill Gang, con ‘Rapper’s Delight’ (1979), e da successi come ‘The Breaks’ di Kurtis Blow, il rap è oggi associato
probabilmente con il successo di Grandmaster Flash and the
Furious Five (‘The Message’, 1982). Su un paio di piatti, dischi
di ogni tempo (compresa la musica classica) vengono mescolati, accelerati, spezzati e contrappuntati per creare un’idiosincratica base sonora fatta di trascinanti ritmi di danza, sui
quali Grandmaster Flash, J. Walter Negro, i Trouble Funk, i
Treacherous Three e gli Zulu Nation mettono alla prova il linguaggio inglese, riproponendolo secondo rime, ritmi e motivi
tipici del ghetto.
Tornando all’Inghilterra, con l’eccezione di Bob Marley e della
precedente parentesi degli skinhead, il reggae era rimasto nel
frattempo un suono estraneo. I suoi passi di danza e l’accento
ritmico irregolare (off-beat) non hanno mai avuto una grande
popolarità. Ma, ancora una volta, fu la musica punk a funzionare come importante catalizzatore. I punk videro nel’“esilio” del rastafarianesimo, nei toni millenaristici del reggae e
nel deciso rifiuto della gioventù inglese di colore di ri-
conoscere l’autorità un tipo di reazione vicina alle loro aspirazioni stilistiche. Il legame, ostacolato da ragioni di razza, esperienze e prospettive, era per lo più simbolico, ma ebbe effetti
rilevanti sul successivo corso della musica pop bianca.
Alla conoscenza di Johnny Rotten aveva del reggae, come rivelano le interviste a Capital Radio di Londra e al giornale del
movimento Rock Against Racism “Temporary Hoarding”, e ai
Clash, che includevano regolamente materiale reggae nel loro
repertorio, si aggiunse la diffusione di musica reggae durante i
concerti da vivo nei locali punk. Il rastafariano Don Letts era il
disc jockey del Roxy durante il culmine del punk, e la girò il
film a 8 mm The Original Punk Movie. In veste di uno dei promotori di Rock Against Racism, così descrisse questo tipo di
scambio: “Il reggae è una musica assolutamente rilassata e in
certo modo calcolata, mentre il punk è selvaggio ed energetico. Va benessimo nei concerti quando si vuole riposare un
attimo per poi riprendere a tutta forza.”17
Grazie a questa rivelazione, il reggae e i musicisti indigeni di
colore riuscirono ad allargare il loro pubblico anche tra i bianchi. Gruppi come i Matumbi riuscirono a passare da una piccola casa discografica come la Rama alla EMI; gli Steel Pulse
di Birmingham fecero un contratto con la Island e pubblicarano l’importante album Handsworth Revolution (1978). Ma
nemmeno questi cambiamenti diedero al reggae inglese e al
reggae in generale una grande fama al di fuori delle comunità
nere giamaicane. I gruppi reggae si sforzano tuttora, in genere
senza successo, per essere riconsciuti al di fuori del loro pubblico di colore. La loro musica gode di molto più rispetto di
148
prima, ha anche una grande influenza sul pop, ma i profondi
significati culturali, le sue origini nere e in particolare modo
l’accento fondamentalista del credo Ras Tafari tendono a mantenerla in disparte. L’unica eccezione parziale è rappresentata
dal poeta di colore Linton Kwesi Johnson, il quale scrive in un
dialetto inglese parlato dai neri che fonde duri accenni politici
con i sorprendenti effetti del dub. Sotto la guida di Denis
“Blackbeard” Bovell dei Matumbi (un pionere del dub inglese), Johnson ha prodotto alcuni fra i dischi reggae più importanti dei tardi anni Settanta (cfr. Discografia).
Nonostante il lento progresso del reggae, la musica nera
d’oggi domina più che mai il pop bianco.18 Utilizzata inizialmente allo scopo di aggiungere “colore” – i Rolling Stones,
Rod Stewart, Blondie ne sono alcuni esempi – essa condusse
anche a proposte originali, come il “reggae bianco” dei Police.
Ma la convergenza più significativa di bianco e nero, indicata
nell’avvicinamento culturale tra reggae e punk (Bob Marley incise ‘Punky Reggae Party’ nel 1977) si espresse in un sound d’avanguardia postpunk (PIL, Gang of Four, The Pop Group), e
nella dimensione del revival. Si trattava di gruppi etnici misti
di ska, come The Specials, The Selecter, ambedue di Coventry
e i Madness da Camden Town, Londra, che costituirono il
ponte più accessibile tra le musiche di colore e il pop inglese
bianco. Poco dopo apparve l’interrazziale Brum bear degli UB
40 e dei Beat di Birmingham. Questa musica modellata sullo
ska, sul reggae e poi su altri nuovi orientamenti musicali (per
esempio, What Happen? Dei Beat, 1981), ha effettivamente
reso pubblico l’eterno debito del pop bianco nei confronti
della musica nera, sullo sfondo di una crescente retorica razziale e di reazione politica.
UN ALTRO BEAT, UN ALTRO CUORE ROCK‘N’ROLL
Il nuovo importante schieramento delle forze culturali, lungo
lo spartiacque tra i territori della musica afroamericana e del
pop bianco, fu accompagnato anche da alcune importanti traformazioni complementari. Sopravvivendo tra gli affetti colaterali e i ricordi stantii della “Woodstock Nation”, il pub rock
londinese rimaneva come traccia importante di una precedente filosofia underground. Fin dai suoi inizi, nei primi anni
Settanta, il pub rock rappresentò un esplicito rifiuto delle pompose apparenze che il rock progressivo aveva assunto in
quell’epoca. Sottolineando l’immediatezza musicale, spesso
raggiunta incrociando il rock con la country music e rispolverando i classici R&B, la scena del pub rock londinese si
sviluppò per lo più nei quartieri periferici della città. Si poteva
trovarlo a Camden Town, nel Greyhound a Fulham Road,
all’Hope and Anchor all’Islington, e alle Nashville Rooms nel
West Kensington, quasi tutte divenute poi sedi del punk. Da
fuori Londra, da Canvey Island e Southend, arrivava il frenetico R&B di Dr Feelgood, dei Kursal Flyers, e il protopunk
di Eddie and the Hot Rods. Il R&B lo suonavano anche
Kokomo, i Dogs e The 101ers (dove suonava Joe Strummer dei
futuri Clash), mentre una variante più personale era proposta
149
da Kilburn and the High Roads. Nel 1975 l’ondata del R&B
aveva praticamente travolto il precedente country rock dei
Bees Make Honey, dei Ducks Deluxe e di Brinsley Schwarz. I
piccoli ritrovi dei pub servivano come terreno preparatorio
per gran parte di ciò che in seguito sarebbe diventata la “new
wave”. Venivano da qui Nick Lowe e Brinsley Schwarz, entrambi membri dell’ultimo gruppo citato. Lowe si unì poi a
Dave Edmunds nei Rockpile e produsse Elvis Costello.
Schwarz si unì ai Rumour, il gruppo di Graham Parker. Nel
frattempo, Ian Dury lasciò Kilburn and the High Roads per
proporre una sua originale vena di stramberie musicali.
fermò il classico atteggiamento ribelle che ora era però impregnato di un malinconico romanticismo maschile. I toni ottimisti del R&B bianco del decennio precedente erano ormai
temperati da una saggezza che derivava da un certo cinismo
nei confronti della vita. Il cantante americano Bruce Springsteen, “il futuro del rock‘n’roll” (Jon Landau), era considerato
il Messia di questo nuovo risveglio. La sua “poetica di strada”
offriva la desolata visione di un’America ferita, vista da motociclette e auto che sfrecciavano veloci sotto crepuscolari orizzonti metropolitani verso autostrade abbandonate, “inseguendo qualcosa nella notte”.
Questa musica di derivazione R&B, anche se riscuoteva raramente un largo favore di pubblico, rappresentò una forza importante nel pop inglese alla metà degli anni Settanta, prima e
dopo il punk. Riprendendo molti dei timbri e dei sentimenti
espressi nella contemporanea “musica di strada” della East
Coast americana (Patti Smith, Bruce Springsteen), i suoi chiaroscuri musicali offrirono un tenebroso contrasto alla “bianca” densità del punk. Pur non abbracciando la dimensione
più ampia di quest’ultimo genere, esso tuttavia non fu un revival puro e semplice del rock‘n’roll. Mentre imparava dal
punk ad attaccare l’autocompiacimento della musica rock, i riferimenti del pub rock erano più schiettamente musicali e ruotavano intorno all’idea di “autenticità”: musica diretta e nuda
emotività.
Le varianti inglesi non raggiungevano i livelli di questa angoscia esistenziale, oppure conservavano un distacco ironico.
Se Ian Dury suonava in chiave umoristica e i Jam offrivano un
beat dal sapore molto inglese, Elvis Costello arrivò a produrre
un ironico catalogo della storia della musica pop. Muovendo
da una revisione decentrata del rock‘n’roll, senza però la spacconeria sessuale (My Aim Is True), attraverso una musica
beat cinica e distaccata (This Year’s Model), per arrivare infine alle incursioni eclettiche di oul stile stax, ska e country, la
sua musica riuscì a riunire un’impressionante varietà di tendenze e tensioni proprie del pop inglese, in una mezza dozzina
di album prodotti tra il 1977 e il 1981 (cfr. Discografia). Un livello così elevato di consapevolezza trovò un’eco anche nel giornalismo musicale. “Melody Maker” e “New Musical Express”
cominciarono a sfornare articoli sugli aspetti dimenticati del
passato, rimestando soprattutto nel calderone musicale degli
anni Cinquanta. La miscela di tutte queste tendenze (pub
Accompagnando i suoi versi con un aggiornato ritmo di R&B
(per esempio Graham Parker con ‘Heat Treatment’, 1976; ‘Discovering Japan’, 1979), gran parte di questa musica ricon-
150
rock, R&B rivitalizzato, una new wave consapevole, retrospettive giornalistiche) preparò inoltre quel terreno che sarebbe
stato presto occupato da correnti di revival più precise:
rock‘n’roll (The Straycats, Matchbox, The Polecats), pop anni
Cinquanta (Darts), mod music (Chords, Secret Affair, e una
nuova rivista mod: “Maximum Speed”), soul della metà anni
Sessanta (Dexy’s Midnight Runners) e infine ska. Palesi differenze di pubblico e di esecuzione impedirono a queste musiche, in questa loro rinascita, di essere una ripetizione trasparente dei loro illustri precedenti. Talvolta sfioravano il
grottesco e offrivano solo una trita e reazionaria sensazione di
nostalgia; più spesso generarono stimoli importanti per nuovi
inizi. La convivenza nei tardi anni Settanta di quasi tutti gli
stili musicali più importanti che avevano partecipato alla formazione del pop inglese - dal rockabilly allo ska, dal sound al
beat, dal punk al country - è un fenomeno degno di riflessione, che segna la fine di qualsiasi tentativo di concepire il pop
come movimento lineare di nuove forme musicali sempre più
complesse che sostituiscono e superano le forme più semplici
e sorpassate. Questa idea, che una volta era alla base della musica progressiva, ora è andata perduta tra le molteplici direzioni di un presente eterogeneo.
PALLIDI PROTAGONISTI DI UN FUNK ELETTRONICO
Contemporaneamente agli sforzi compiuti per ricatturare la
passione e l’impeto associali ai primi momenti del pop - la
Londra dei mod, nel 1964 circa, nel caso dei Jam, la tradizione
R&B e soul e l’esempio di un cantante come Van Morrison nel
caso di Graham Parker e Kevin Rowlands dei Dexy’s Midnight
Runners - prese forma un’altra proposta musicale decisamente più distaccata. Si trattava di una sovrapposizione di
ritmi funk e disco music, di sintetizzatori ed elettronica con
una particolare attenzione ai codici della sintassi musicale.
Gli esperimenti degli anni Settanta con i ritmi afroamericani e
le sonorità del soul e della disco music devono molto al precoce interesse di David Bowie in quest’area. Dopo la musica
soul di Young Americans (1975), Bowie era andato avanti, collaborando a volte con Brian Eno e Robert Fripp, nello sviluppare le possibilità di una musica funk bianca con Station to
Station (1976), Low (1977), Heroes (1977). Analogamente si
era interessato ad aspetti della musica di avanguardia (per
esempio Philip Glass) e al rock elettronico tedesco dei primi
anni Settanta. Quest’ultimo, che ebbe un grosso impatto sulla
musica post-punk dei Public Image Ltd (PIL), per esempio,
aveva dato un suggestivo contributo alla formazione degli insistenti ritmi della disco music. Questa complessa genealogia
di funk-disco music-avanguardismo, rock teutonico - Bowie,
doveva svolgere ancora un suo ruolo, di nuovo con l’apporto
di Brian Eno, nella produzione del nevrotico funk bianco dei
newyorkesi Talking Heads.
151
Dopo non molto tempo, il rifiuto dei punk di cristallizzarsi provocò la spaccatura della momentanea espressione dei suoi
volubili elementi. Dopo il 1977 si produsse infatti una spaccatura tra la sua ala avanguardista e quella populista. Gruppi
come il PIL (formato da Johnny Rotten dopo lo scioglimento
dei Sex Pistols) i Gang of Four, il Pop Group e altri cercarono,
con una miscela di linguaggi musicali precedentemente separati, intersecando il punk con il reggae, i timbri del dub e i
ritmi disco music e funk, di proseguire gli esperimenti musicali punk con il rumore e la ripetizione in una nuova chiave.
L’alternativa a questa tendenza sembrava proseguire imperturbabile quella vena radicale e populista più accessibile che
era più aderente allo stile originario del punk. Questa fu la
strada scelta dai Clash, anche se aggiungevano spesso il reggae e accenni di rock‘n’roll a questa base musicale.19 In effetti,
la retorica musicale populista coltivata dai punk si è tramandata fino agli anni Ottanta, riscuotendo comunque maggiori
successi commerciali di quelli conseguiti nel 1976. I Crass, il
gruppo anarcoide di Epping, insieme con l’Anti-Nowhere
League, i Vice Squad, i Discharge e gli Exploited (Punk’s not
Dead, 1981) hanno continuato la tradizione più intransigente
dei punk.20
Il PIL, il Pop Group e i Gang of Four si discostarono invece
dall’immediatezza dei populisti, abbandonando l’effetto
dell’espressione cruda per sostituirla con l’effetto dirompente
di un montaggio musicale che alienava i linguaggi musicali
esistenti nel mentre li esplorava. Se ascoltiamo le prime registrazioni dei PIL, per esempio ‘Death Disco’, dal titolo provoca-
torio (1978), o la loro musica successiva, nel secondo LP,
Metal Box (1978), è evidente l’adozione di diversi linguaggi
musicali e il loro inserimento in una nuova rete di rapporti insospettati. In ‘Albatross’ e ‘Poptones’, la vibrazione viene costruita sulle oscure figurazioni del basso e su un’insistente percussione. Su questa base punk/ reggae, i ritornelli ripetitivi
della chitarra interagiscono con le “innaturali” tessiture della
voce di Lyndon. Il tutto è soggetto poi alla puntualizzazione
dei sintetizzatori, del phasing e dell’eco.
Questo ardito rimescolamento di elementi musicali comuni
sottintendeva un tentativo di ricostruire la musica pop e di
darle un nuovo significato. Esperimenti analoghi stavano avvenendo anche a New York. I Theoretical Girls, i DNA e la “No
wave” esploravano un paesaggio sonoro postpunk che comportava la sovrapposizione di un suono sull’altro per produrre
una musica rumoristica e abolire quelle barriere (musica/
rumore) che il punk aveva inizialmente messo in crisi. In
questo nuovo contesto, la “ripetizione” dell’impulso afroamericano s’incrocia con la ricercata ripetitività dell’avanguardia
classica (Eric Satie, Terry Riley, Steve Reich e Philip Glass).
Abbandonando quell’atteggiamento di rifiuto globale che il
punk aveva espresso originariamente, questi gruppi avevano
ripiegato su una strategia più trasversale. Interrompendo, disgregando ed estraniando le convenzioni del pop, la musica
stessa diventava un momento “politico”, una sovversione intenzionale delle aspettative prevalenti. Rinunciando all’ambiziosa idea di produrre condizioni più ampie per la fruizione
della musica, questa strategia cercava di rivelare le condizioni
152
interne del lavoro musicale. Con fuso di sintesi frequentemente frammentate - ritornelli di chitarra e basso, rumori elettronici, ossessivi ritmi di percussione, strampalate “insalate di
parole” - la nuda impalcatura musicale diventa così spettacolo. La sovrapposizione e l’accostamento inusuale di idee
musicali così diverse non offrono facili soluzioni; la musica
che ne deriva non è diretta verso una riconciliazione ma rimane aperta, e in ultima analisi irrisolta. L’ascoltatore può
essere attratto dal rapporto produttivo della costruzione, cosi
come può rifiutare le crude e stridenti associazioni del collage.
Quale che sia il giudizio sui suoni finali, tale musica “decostruita” insiste su una rivelazione sconcertante. Non è più possibile concepire il pop come semplice risultato di ispirazioni musicali, stili e influenze fortuite, visti come elementi che regolarmente vengono assorbiti dal potere mummificante della tecnologia e del mercato. Ora è chiaramente dimostrato che i linguaggi del pop e i suoi toni epidermici sono un particolare
tipo di costruzione, una specifica forma di produzione. Nell’allontanarsi dallo sterile limbo in cui sembravano arenarsi gli
sforzi iniziali del punk, i “decostruzionisti” hanno lavorato per
una sospensione del significato nel presente per “vibrare con i
riflessi del futuro” (André Breton). Interrompendo e interrogando il modo “normale” di fruizione del pop, essi hanno cercato di catturare il senso di quei “rapporti sotterranei fra elementi dissimili” che colpiscono il pubblico “come una pallottola” (Walter Benjamin). Connettendo forme musicali, stili vocali e testi assolutamente incongrui la presunta fissità semantica del pop come entertainment viene scossa bruscamente ed
è almeno provvisoriamente sostituita da un’espressione paradossale che, attraverso la sua sola presenza, mette in dubbio le
aspettative musicali e culturali esistenti.
È, stato proprio verso quella soglia che un importante frammento di musica postpunk si è orientato. Pur scostandosi da
soluzioni ovvie, questo pop d’avanguardia continua a occupare un suo spazio all’interno delle strutture commerciali
dell’industria musicale. È rimasto fermamente ancorato alla
musica pop dal suo interno, senza pretendere quella “legittimazione” che il rock progressivo aveva tanto ricercato nei
primi anni Settanta.
Rimanendo parte integrante della cultura di massa, questa musica ha anche dato luogo a proposte meno radicali. La conseguenza più immediata, a parte una popolarità insospettata
della disco music (cfr. Trans Europe Express dei Krakwerk),
fu il fatto che un’intera ondata di dance music a base di sintetizzatori elettronici (Gary Numan, Human League, Heaven
17, Depeche Mode) aveva assimilato questi esperimenti per
produrre ciò che Paul Tickell, in “New Musical Express” definisce “elettro pop”, un’integrazione di moderno e tradizionale (elettronica e ballo), di avanguardia e pop. Questo genere
esiste come testimonianza di una complessa eredità culturale:
“È suono (microcomputer, sintetizzatori, nastri e macchine intelligenti) o sensibilità (precisione, discoteche e club, tempo
libero come tempo di sogno)?” (Paul Tickell, “New Musical Express”, 13 December 1981).
153
I PARADOSSI DELLA CRISI
Le crisi hanno molteplici aspetti, alcuni positivi, altri negativi
e molti semplicemente ambigui. Gli ultimi anni Settanta sono
stati un periodo di crisi per il pop inglese, tanto nei suoi linguaggi musicali quanto nelle sue istituzioni. È stato anche un
periodo in cui un vasto conflitto sociale e una crescente instabilità politica sembravano premere sull’economia del pop
spesso in modo molto diretto. Dai provocatori slogan del punk
e dall’apocalittica soluzione rastafariana del reggae, attraverso
svolte ideologiche che si potevano cogliere nel giornalismo musicale e nel successo della campagna Rock Against Racism,
fino all’estrema etnicità bianca coagulata attorno alla musica
Oi, il pop inglese veniva regolarmente investito dai simboli del
fermento politico. Svastiche e movimenti per il disarmo nucleare, questioni razziali e giovanili, mercato e anticapitalismo, sessismo e crescita della musica femminile, tutto ciò era
assorbito nella contraddittoria sequenza degli stili del pop.
In tutto questo, il punk è stato il principale movimento propulsore, ritenuto responsabile sia di una rivoluzione interna al
pop sia di una traduzione della crisi sociale nella retorica musicale e sottoculturale. Eppure, un importante aspetto del punk,
sospeso tra narcisismo e nichilismo, era stato proprio il suo
disprezzo per l’“ovvio”, per il “senso”. Il suo populismo incipiente contraddiceva la sua riluttanza a comunicare col mondo
esterno. A questa seconda tendenza, accompagnata da un crescente ricorso a mezzi tecnici per riprodurre l’immaginario, segui una serie di proposte che sembravano ignorare l’esistenza
stessa di un mondo esterno. Maschere e costumi fuori dall’or-
dinario, circondati da batterie elettroniche e sintetizzatori programmati, sostituirono i precedenti legami con la “strada.” e
la sua presunta “autenticità” con il rifiuto di considerare la necessità stessa di una “autenticità”. La logica delle “origini”, le
spiegazioni a essa conseguenti e l’attaccamento romantico che
esse generavano erano totalmente ignorate. Stili musicali e culturali sono stati tolti dal loro contesto, perdendo così i loro referenti iniziali, e in questo modo non rappresentano nient’altro
che la loro effimera presenza. Adam and the Ants che prendono un ritmo di percussione dal Burundi e poi un rap da Harlem, i languidi miscugli dei Culture Club, o il “minestrone” musicale (duck soup) del “maestro” in persona, Malcom
McLaren, sfocia in un continuo collage di inaspettati incontri
ravvicinati. La pedante razionalità del “buon gusto” è sostituita dal pluralismo dei piaceri.
Si può dire che le prospettive e le aspettative precedenti, legate alla particolare conoscenza di una unica monumentale storia, sono state abbandonate per fare emergere storie orizzontali da un patrimonio di esperienze sociali e di vita quotidiana.
In questo senso, il femminismo è stato il protagonista assoluto, anche se spesso non riconosciuto. La presunta omogeneità del presente, la “metanarratività” Jean François Lyotard)
della storia, vengono frammentate in contesti diversi che cambiano prospettive e possibilità. In questo mondo postmoderno, in apparenza dispersivo, ma in realtà più specifico, e dettagliato, l’“artificiale”, l’“imitazione”, la “plastica” non creano
più imbarazzo. Anch’essi hanno le loro storie particolari; anch’essi sono “reali”.21
154
Fin da quando la rabbia minimalista dei punk sembrò invertire il corso della musica, la breve, ma ricca storia del pop è tornata sempre più alla sua identità iniziale, come “passaporto
per il territorio dell’adesso” (George Melly). Il passato del pop
cessa di funzionare come un mausoleo di reliquie e si rivela un
serbatoio di possibilità musicali immediate. I cosiddetti revival dello ska, del rockabilly, del R&B bianco e del soul (per
molti non sono mai morti, sono semplicemente scomparsi
dall’attenzione del grosso pubblico), e la grande crescita di
contaminazioni musicali fra passato e presente, e spesso diversi presenti, sono i segni inconfondibili di questo cambiamento. Parecchi anni dopo l’esplosione del punk, e ormai
negli anni Ottanta, esiste una considerevole gamma di stili musicali, dal funk bianco e dal rap nero alle superfici ribollenti
del juju (Nigeria), della soca (Trinidad), e alla riscoperta della
salsa (Cuba/Porto Rico/New York), oltre a tutte le miscele che
si possono ottenere fra loro. Questa situazione, attribuibile
alla rottura iniziale del punk, promette una “proliferazione di
margini” (Rosetta Brooks) piuttosto che un prevedibile ritorno a un rinnovato filone centrale e alla sua alternativa subalterna.
Una versione lineare della storia del pop è stata trasgredita,
violata. Le spiegazioni causali sono state eluse da una serie di
trasgressioni culturali, dai revival, dal ciclico ritorno di musiche e stili del passato. Un’indifferenza per le prospettive teleologiche ha anche favorito una serie di approcci trasversali che
hanno cancellato i precedenti confini musicali ed estetici. Il
gesto dadaista nei confronti degli oggetti quotidiani, insieme
col suo modo aleatorio d’espressione, e il gesto della pop art
negli anni Sessanta nei confronti delle forme, strutture e gusti
della cultura di massa, sono stati sussunti in un bricolage contemporaneo. In una serie di storie sovrapposte - di cultura urbana, di avanguardia, di musica pop - si riscoprono oggetti
e rapporti che credevamo di conoscere fin troppo bene. Ci
troviamo in un mix o in un dub culturale insospettato, in un
viaggio nomade tra “objets trouvés”. Nel frattempo, le distinzioni tra il “privato” e il “pubblico” diventano sempre più confuse. Gli spazi pubblici vengono invasi da un numero crescente di apparati musicali privati. La radio transistor a bassa
fedeltà (introdotta dalla Sony nel 1955) è stata sostituita dal
registratore portatile a cassette ad alta fedeltà, i negozi reggae
rivolgono i loro sound system verso la strada, le autoradio stereo e il Sony Walkman creano una ulteriore mobilità. Il paesaggio sonoro urbano va incontro a un radicale rifacimento, mentre il pubblico, immerso in un “suono avvolgente” (Murray
Schafer), “recepisce, ma in modo distratto” (Walter Benjamin).
In questa situazione, dove la massima riproducibilità è la
norma, cioè il terreno comune per gli sviluppi culturali, per
una nuova estesa eterogeneità, il senso della musica si trasforma profondamente. Eventi passati e presenti - da una registrazione originale Sun di Roy Orbison a un video promozionale degli Human League - diventano parte di un significativo
“adesso”, un’apparizione/sparizione momentanea che viene a
costituire un “sapere di tipo trasversale” (Alberto Abruzzese).
155
Il rifiuto del passato e la trasformazione dei suoi resti in una
sorta di deposito vivente per scelte attuali non sono limitati
solo al campo musicale. Un intero campionario di manie di abbigliamento in continua trasformazione ha attraversato le
piste da ballo, i locali notturni e negli ultimi anni anche i
risorti cocktail bar delle città inglesi più importanti. Il punk
aveva saccheggiato spietatamente i “magazzini di roba usata”
della storia e aveva parodiato stili sottoculturali fino ad allora
rispettati, confondendo in modo blasfemo i loro guardaroba
un tempo distintivi. Gli stili successivi hanno trasformato
quell’ironia nel fascino del travestimento. L’insistenza del
punk sull’artificio dello spettacolo si è accentuato ulteriormente. La stagione “new romantic” degli anni Ottanta, modellata da Adam Ant in Top of the Pops, sullo stile pellerossa, pirata, bandito di strada, offriva uno spettacolo continuo di
manichini interscambiabili. Hipster in pantaloni attillati a vita
alta, costumi spaziali, gauchos, gentildonne e turchi, vagavano
avanti e indietro nel tempo, passando da una cultura all’altra...
Il dandy, “il damerino”, il “sex symbol” femminile, diventano
nuove icone di cui appropriarsi. Imitando Bryan Ferry, Debbie Harry o Siouxsie Sue, la “narcisistica conoscenza di sé”
(Krystina Kitsis), implicita nell’appropriazione di un’immagine, conduce a un gioco potenzialmente critico tra finzione
spettacolare e normalità. La messinscena è a tempo pieno,
non si tratta più di un gesto isolato ma di una realtà parallela
a una realtà convenzionale. Così il camp, un tempo ai margini
della cultura, entra ora a far parte di un repertorio di immag-
ini quotidiane. Johnny Rotten dei Sex Pistols o Boy George
O’Dowd dei Culture Club, come molti altri nel circuito della
vita notturna londinese, si esibivano in pubblico ancor prima
di diventare star.
Dietro questi orizzonti spettacolari, ci sono i contributi anonimi dei giovani metropolitani, alla moda, quelli che si “nascondono nella luce” (Dick Hebdige). Per i nuovi “maestri del
travestimento” (Peter York) che popolano uno scenario apparentemente privo di referenti - “La moda dà sicurezza” (Sandy,
“New Musical Express”, 19 dicembre 1981) - c’era un intero
corredo a portata di mano. Locali come il Cabaret Futura
(Wardour Street), Le Beat Route (Greek Street), la Ultratheque (Glasgow) e il Rum Runner (Birmingham) erano i
luoghi deputati dove farsi vedere, mentre per chi voleva controllare la propria immagine e il proprio stile di vita c’erano (e
ci sono) le riviste “I-D” e “The Face”. Il punk e i suoi postumi
incombono come una cappa di fumo sulla fine degli anni Settanta e il principio degli anni Ottanta, e ciò è evidente soprattutto nelle mode, negli stili e nei volti del pop di questi anni:
dagli sconcertanti accostamenti dei punk ai travestimenti
delle varie tendenze, fino alla smorfia rabbiosa di uno skinhead, con la scritta “Made in London” tatuata sulla fronte, che
mostra due dita in segno di saluto verso la macchina fotografica. Eppure è il grande revival degli skinhead all’inizio degli anni Ottanta che ci distoglie da questa storia interna al pop
e ci riporta indietro ai più ampi temi del generale fermento.
Riunendosi nelle vicinanze di Petticoat Lane, nell’East End di
London, o attorno al negozio dal nome appropriato “The Last
156
Resort” (l’Ultima Spiaggia), gli skin rappresentavano una dura
estremizzazione del punk. Tuttavia a differenza di molti punk,
essi non usavano davvero mezze misure. Irrigidita in uno stile
brutale, rigoroso, maschile, questa ritrovata sottocultura proliferava con i suoi stivali, i jeans rimboccati, gli scalpi rasati, i
tatuaggi e il loro esasperato nazionalismo, portando tutto
questo oltre la soglia dell’“accettabilità”. La sua musica, i Cockney Rejects, gli Angelic Upstarts, i Cocksparrer, The 4 Skins e
altri gruppi Oi, era un’amalgama di suoni proletari frustrati,
in precedenza associati agli Sham 69 e alla “Sham Army”: slogan rabbiosi e canti da stadio, la musica degli “irrispettabili”,
della “classe operaia andata a male” (Hebdige 1982). L’economia di quartiere un tempo elastica, fatta di lavoro occasionale
e di impieghi stagionali, che sosteneva economicamente la
scelta degli skinhead, è andata sempre più razionalizzandosi,
sfuggendo perciò alla portata dei giovani privi di una specializzazione. Impreparato a un simile destino, lo skinhead rimane
un attore disperato, ridotto a vivere ai margini della società
dei bianchi e a trascorrere le sue giornate in un’ottica di decadenza urbana, di disoccupazione, razzismo, teppismo e violenza di strada. Ma nonostante le apparenze, il rapporto tra
particolari settori del pop inglese e il dramma di una crisi sociale in generale resta fondamentalmente ambiguo anche
quando promette chiarezza. L’apparente intesa tra punk e
populismo di sinistra nel periodo 1976-1978, nella quale si organizzò con successo la campagna Rock Against
Racism, o l’associazione tra razzismo, nazionalismo e rinascita
degli skinhead, che culminò nell’incendio del pub Hambrough
Tavern, dopo un concerto Oi, e la rivolta razziale a Southall
nel luglio del 1981, sembrarono esempi evidenti di una sintonia fra musica e realtà. Anche molte canzoni punk, i ritmi di
ispirazione giamaicana degli UB 40, dei Beat e dei Fun Boy
Three, i testi “impegnati” dei Clash e dei Jam, e, per altri versi,
il richiamo a una etnicità bianca dell’Oi, rimandavano tutti
alla “politica”. Questo radicalismo, spesso autentico, può tuttavia rivelarsi in ultima analisi un segnale fuorviante. Il fatto
che una parte del pop sia diventata sensibile a questioni esplicitamente politiche dà un po’ la misura della situazione attuale,
ma d’altro canto, i sentimenti investiti nella musica, nati da
un realismo che è prodotto nella concretezza di un luogo specifico, di un momento e di una pratica particolari, nel caso migliore stentano ad adattarsi allo scenario politico esistente, e
nel caso peggiore sono in dichiarato antagonismo con esso.
L’importanza di un impegno politico apertamente dichiarato
non può sostituire i significati più ampi del pop inglese e le
sue realtà interne.
È su questo aspetto finale che voglio soffermarmi nelle conclusioni che seguono.
NOTE
1 Il regista americano Jon Jost offre una suggestiva interpretazione di
tale possibilità nel suo film Chameleon (1978). Terry è un trafficante di
Los Angeles, dedito soprattutto allo smercio di cocaina, ma anche di
falsi d’arte. Lo seguiamo mentre si aggira e traffica per le infinite strade
157
della metropoli americana parlando da solo nella notte. Si tiene a galla
nel mondo radicai-chic dell’arte, quello così spietatamente descritto da
Toni Wolfe in The Painted Word (1976). Ma egli sopravvive grazie alla
logica della “strada”, arrangiandosi. Terry è una lucertola che cambia
sempre pelle, vive ai margini della città, e scivolando attraverso le sue
viscide consuetudini, si muove tra i vaghi confini di un “iperrealismo”
artistico e di un’istantanea del mondo sotto l’effetto della cocaina: tra
le finzioni dell’arte e farce di fingere la vita. Una metafora cinematografica più esplicita è quella di Fuga da New York (1981) di John Carpenter.
2 Mentre il punk inglese rappresentò un brutale rifiuto del suo presente e dell’immediato passato musicale, il punk di New York operò
una distillazione assai più sofisticata, per quanto nevrotica, delle
oscure “vette” della musica rock americana, da Chuck Berry ai Doors,
da Jimi Hendrix ai Velvet Underground. Un’estetica della spazzatura,
liberamente disseminata da riferimenti letterari - Wilson Pickett mescolato con Rimbaud, Genet con Van Morrison - il tutto in un contesto culturale assai diverso dalla provocante nudità culturale e dal rozzo linguaggio del punk inglese. L’immagine da ragazzi di strada dei Ramones
fu l’unica importante eccezione.
3 I dischi di Patti Smith (Horses, 1975; Radio Ethiopia, 1976), sebbene
profondamente influenzati dall’olimpo dei romantici del rock (Keith
Richards, Brian Jones, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Van Morrison),
rappresentarono un importante passo in avanti della voce femminile.
Patti Smith fissò un preciso stile vocale femminile e tuttavia originale
all’interno del pop bianco.
4 “Melody Maker”, 7 agosto 1976. Questa difesa piuttosto prevedibile
delle qualità “artistiche” (eloquenza e sensibilità) fu inconsciamente
un’ironica riproposta di un analogo attacco sferrato da Steve Race contro il rock‘n’roll e pubblicato sul “Melody Maker” vent’anni prima (cfr.
capitolo Un momento formativo, 1956-1963, in questo volume).
5 Tony Parson, che doveva diventare presto coautore con Julie Burchill
di The Boy Looked at Johnny. The Obituary of Rock‘n’Roll “New Musical Express”, 11 dicembre 1978.
6 II gruppo dell’Internazionale situazionista nacque intorno alla metà
degli anni Cinquanta. Forse il loro più famoso manifesto pubblico fu la
critica globale di Guy Debord nei confronti del feticizzato spettacolo del
capitalismo avanzato, La società dello spettacolo (1968). Ma è piuttosto con gli immediati progenitori dell’Internationale situationniste, l’Internationale lettriste, una ramificazione del movimento dadaista
parigino, che si può trovare una certa affinità. I “lettristi” erano specializzati nel dipingere slogan sui pantaloni, sulle cravatte e sulle scarpe.
Incoraggiavano la pratica della “deriva” urbana e della “psicogeografia”: “Lo studio e la correlazione del materiale ottenuto dalla deriva”. Fu usato, da una parte, per tentare di costruire nuove mappe
“emozionali” delle aree esistenti e, dall’altra per delineare piani per
“situazioni” (Grey 1974, p. 5). Malcolm McLaren era collegato al
gruppo situazionista di Notting Hill, conosciuto come King Mob. La
fama di questo gruppo è legata a una loro invasione natalizia dei grandi
magazzini Harrods, durante la quale distribuirono gratuitamente le
merci ai clienti sorpresi finché non arrivò la polizia.
7 Talvolta, naturalmente, i fomentatori di miti allarmanti ne diventano
le vittime più clamorose. La fine dei Sex Pistols, avvenuta dopo una
caotica tournée negli Stati Uniti nel gennaio del 1978, rispecchia pressapoco questo copione. Mentre Johnny Rotten abbandonava il gruppo, il
chitarrista Steve Jones e il batterista Paul Cook volavano verso Rio de
Janeiro per incidere con Ronnie Biggs, uno degli artefici della “grande
rapina al treno”. Sid Vicious e la sua ragazza Nanry Spugen nel frattempo davano inizio al loro fumetto dell’orrore ambientato a New
York. Nanry fu uccisa a coltellate e Sid, accusato dell’omicidio, uscì infine di scena con un’overdose di eroina.
8 Due contratti annullati, la parziale distribuzione di ‘Anarchy in the
UK’ (subito ritirato dopo che la EMI interruppe il loro contratto) e 125
158
mila sterline sborsate al gruppo come indennizzo: erano questi i precedenti dei Pistols prima che firmassero per la terza volta in meno di un
anno per la Virgin Records, nel maggio del 1976, e prima che uscisse
‘God Save the Queen’.
studi americani. Verso i tardi anni Settanta, le radio private aprirono
ampi spazi al soul e alla disco music con programmi come Soul Spectrum di Greg Edwards (Capitai Radio) e Soul Train di Andy Peeble (Piccadilly Radio, Manchester).
9 Sull’“ideologia inglese”, il “thatcherismo” e il buon senso conservatore, cfr. Hall (1979) e Nairn (1981).
16 Il successo della disco music esercitò un’influenza anche su alcuni
settori del reggae. Certi gruppi e singoli .musicisti come Bob Marley,
Third World, Inner Circle, Peter Tosh, Big Youl ridussero il tipico “offbeat” del reggae e si avvicinarono alla regolarità dei ritmi della disco
music, talvolta passando direttamente ai “disco mix”. Il famoso connubio basso/percussioni formato da Robbie Shakespeare e Sly Dunbar divenne una componente costante del successo della disco music di
Grace Jones: si ascolti per esempio Night Clubbing.
10 “Black Music & Jazz Review” (un tempo “Black Music”), novembre
1978.
11 Hendrix aveva anche esercitato un’influenza diretta sulla musica
jazz-elettrica di Davis. Un articolo interessante sulle radici cubane
della salsa è quella di Nestor Figueras, A Gozà in “Collusion”, 1, 1981.
12 Con il bianco John Travolta, gli australiani Bee Gees e (organizzazione di Robert Stigwood la “congiura” commerciale della disco music
sembra essere completa. Male apparenze possono trarre in inganno. E
anche se si rivelassero reali, nessuno pub prevedere il tipo di diversi
piaceri che esse possono suscitare.
13 Ho fatto ampi riferimenti all’articolo di Tony Cummings, Gloria
Gaynor and the Disco Boom, “Black Music”, giugno 1975, per questi
particolari.
14 La disco music è saldamente legata al soul, una tradizione musicale
che aveva già partecipato a sua volta a stili diversi che minavano gli
stereotipi dominanti della mascolinità: le voci in falsetto, il “vamp” ostentato di Little Richard, le assurde stravaganze della James Brown Revue, eccetera.
15 Chi parla qui è il disc jockey del Northern Soul Ian Levine in “Black
Music & Jazz Review”, maggio 1977. Nei loro locali i disc jockey cercavano continuamente nuovi sound per consolidare e allargare la loro
fama. In alcuni casi si arrivò a livelli tali che Ian Levine, di Manchester,
parti per gli Stati Uniti per produrre dischi in stile Norrhern Soul negli
17 Da un’intervista ai membri del collettivo di “Temporary Hoarding”
di Londra, nel settembre 1978.
18 La quantità di pubblicazioni dedicate alla musica nera in Inghilterra
è considerevole, soprattutto se paragonata alla situazione negli Stati
Uniti, dove non esistono riviste specializzate esclusivamente in musica
nera. In Gran Bretagna, “Blues and Soul”, “Black Music” (in seguito
“Black Music & Jazz Review”), “Black Echoes”, e una pubblicazione più
irregolare come “Pressure Drop”, specializzata in reggae, insieme con
una schiera di fantine (“Hot Buttered Soul», “Black Wax”, “Soul to Inspect”), hanno rivelato (esistenza di un pubblico sostanzioso per pubblicazioni che trattano soltanto di musica nera, e nel quale sono compresi
anche molti lettori bianchi.
19 A cominciare da ‘Police and Thieves’ di Junior Murvin, ripreso nel
loro primo LP (1977), il reggae era diventato parte integrante del sound
dei Clash all’epoca del loro quarto album Sandinista (1980). In questa
fase il giamaicano Mickey Dread si era già insediato nei loro studi di
registrazione come tecnico del suono e Don Letts stava realizzando i
loro video promozionali.
159
20 Nella provincia si continuavano a vedere i pantaloni attillati e i
ciuffi di capelli colorati molto tempo dopo che questa moda si era ormai completamente esaurita a Londra o si era trasformata in qualcos’altro. Nel 1982 un giornalista osservò: “Il punk è passato dalla moda
della capitale alle manie della provincia” (“New Musical Express”, 1
maggio 1982).
21 Il termine “postmoderno” iniziò a diffondersi con la crisi del modernismo nell’architettura e nelle arti visive americane, e come iniziativa
della critica letteraria statunitense. In Europa La condizione postmoderna (1979) di Jean-François Lyotard è probabilmente il documento
più noto di questo discorso.
160
C HAPTER 8
Conclusioni
Nel regno del
possibile
Un oggetto di lusso é sempre di questo mondo, richiama sempre, anche
se in un modo prezioso, la sua origine, minerale o animale, il tema naturale del quale non è che una delle espressioni. La plastica è interamente inghiottita nell’uso: alla fine, gli oggetti saranno inventati per il
solo piacere di usarli.
Roland Barthes, 1957
In un senso profondo, la cultura di massa contemporanea è di
“plastica”. Come nella definizione di Barthes, essa è prodotta
in serie, è elastica e flessibile, duttile e conveniente. Anche se
è regolarmente criticata per tali attributi, “falsità” e “artificialità” sono le qualità più significative della cultura di massa,
“l’idea stessa della sua trasformazione infinita”, dell’“ubiquità
resa visibile” (Barthes 1973). E come la plastica, la cultura di
massa si è depositata a mo’ di una pellicola flessibile sulle superfici e le azioni della nostra vita quotidiana, fondendole in
modelli apparentemente prosaici.
In certi momenti e in situazioni particolari, la musica pop inglese è stata la partitura più adatta per una spettacolare esibizione sottoculturale; qui come supporto all’esagerata “perfezione” dei mod, là come ritornello assordante della disgregazione punk. Nelle comunità nere dei Caraibi, nel caso del reggae, è diventata un elemento fondamentale della resistenza
culturale. In altre circostanze, il pop ha costantemente fornito
una garanzia per il ballo, per le fantasie sentimentali e per
l’amore romantico, o più semplicemente ha incoraggiato il superamento dell’abitudine, indicando le possibilità di una realizzazione personale che sfida le abitudini costituite.
Tuttavia, mentre l’evidente struttura commerciale e l’organizzazione urbana della cultura di massa potrebbero imprimere
un marchio riconoscibile su queste diverse possibilità, le
stesse possono anche facilmente distogliere la nostra attenzione dalle loro potenzialità immaginative. Oggi, tuttavia, abitudini, gusti e piaceri che una volta venivano mascherati dalla
storia, stanno venendo sempre di più alla ribalta, imponendo
un cambiamento irreversibile nella nostra concezione di “cultura”. La continua polemica sui termini cultura “popolare” o
cultura “di massa”, da sempre una malcelata lotta per il giudizio e la custodia della cultura in generale, adesso può essere
messa a nudo e rivelare sotto pelle ciò che Raymond Williams
ha una volta definito una “lunga rivoluzione”. La cultura che
emerge da tale processo è il risultato di uno scontro condotto
attraverso la produzione e gli usi contraddittori del presente
per una cultura che, nonostante la sua evidente organizzazione commerciale, è più dinamica e potenzialmente più democratica delle superate prospettive conservatrici che essa invade e soppianta.1
L’AMORE, IL CORPO E LA CITTÀ
“Ehi, la mia silhouette è a posto?”.
Dal film Subway Riders di Amos Poe, 1981
162
È attraverso i1 sentimentalismo, lo spirito romantico, che la
musica pop viene generalmente usata e suscita reazioni. Nel
romanticismo la musica pop acquisisce la sua piena dimensione fantastica. Quando si parla di romanticismo, si pensa subito alle adolescenti che costruiscono fantasie attorno ai
poster e ai dischi dei cantanti idolatrati. Ma questo non è che
un esempio, perché in realtà tale romanticismo è presente in
ogni aspetto del pop.2 Gli oscuri contorni di un romanticismo
decisamente più aspro, di segno prevalentemente maschile,
fatto di strade notturne e di scene viste attraverso lo specchietto retrovisore di motociclette e macchine, di gruppi di ragazzi che guardano le ragazze, percorre tutto l’universo simbolico della musica pop da Elvis ai Clash. Questo romanticismo acquista per la sua universalità un’aria “naturale” che lo
rende pressoché invisibile, ed è perciò ancor più insidioso, poiché tende a circoscrivere lo slancio romantico che pervade il
pop solo alle proiezioni “irrazionali” della psiche femminile.
Nel contempo, quel romanticismo maschile perde le sue caratteristiche e passa inosservato nell’ambito della “realtà”:
“essere uomo non vuol dire possedere attribuiti maschili,
bensì partecipare a una sog gettività non condizionata dal
sesso” (Black-Coward 1981).3
Abbandonando le nozioni tradizionali dell’amore romantico e
seguendone l’evoluzione nell’ambito della musica pop, ci rendiamo conto ben presto della necessità di spaziare oltre i limiti
del “senso comune”. Le forme attuali del tempo libero e dei
suoi piaceri sono più complesse e intricate di quanto non credessimo inizialmente. Diventa quindi necessario ampliare gli
orizzonti, dato che è sulle superfici sociali degli eventi quotidiani - dove l’ordinario e l’eccezionale si fondono - che noi scopriamo la prosa del mondo (Lefebvre 1978). La presentazione
del rock‘n’roll come un insulto al “buon gusto”, o della disco
music come un invito alla lobotomia, è stata sovvertita
nell’uso e nelle abitudini quotidiane e col tempo ufficialmente
abbandonata. Nello stesso modo, il mutevole scenario delle
“vite private” delle adolescenti, della cultura dei giovani neri,
delle sottoculture bianche, e un complicato intreccio di romanticismo urbano, coinvolgono una serie di investimenti culturali le cui intense diramazioni passano regolarmente inosservate. Anche se a volte rumoroso e provocatorio, come nel caso
del punk, ma di solito assai meno invadente, è il complesso
rapporto tra la musica e questi spazi particolari che connette e
scioglie continuamente le divisioni tra pubblico e privato in
una serie di rielaborazioni immaginarie.
La musica può essere considerata un importante “spazio alternativo” (Henri Lefebvre) nella nostra vita quotidiana. La sua
forza consiste nel sospendere temporaneamente la divisione
tra “pubblico” e “privato”, tra l’immaginazione e la routine, tra
i ruoli e le relazioni sociali in cui ci troviamo regolarmente intrappolati. Come tale, la musica non è una “evasione dalla realtà”, ma un modo di esplorare le categorie che la organizzano. Immaginazione e realtà sono mescolate tra loro, in un
significativo rapporto di attriti e scambi, e il principale luogo
di questa interazione è quel territorio cosi spesso represso che
è il corpo.
163
L’intensità corporea delle sonorità elettroniche, insieme con i
sentimenti urlati del soul, l’angoscia allucinata del punk, le
grida del rhythm and blues, il dialetto del reggae e le contorsioni verbali del rap, pongono il corpo al centro del pop. Concentrato nella danza e nella visceralità di un’esibizione musicale è proprio questo senso di immediatezza musicale che risulta fondamentale nella cultura pop. È il corpo che in definitiva produce la musica, ne fruisce e reagisce ad essa; ed è il
corpo che connette suoni, ballo, mode e stili con il riferimento
inconscio della sessualità e dell’erotismo. Qui, dove fantasia e
realtà formano un tutt’uno, il senso comune è spesso ridicólizzato, disgregato e distorto.
Se il romanticismo è lo strumento centrale del pop, e il corpo
la sua principale cassa di risonanza, è la città che ne dispone il
palcoscenico. La città è il “corpo” urbano, il luogo dell’immaginazione contemporanea; e attraverso la riproduzione tecnologica dell’immaginario, le strutture della metropoli - sotto
forma di copie e di variazioni locali - penetrano in ogni angolo
della nostra vita. Nella città notturna, dopo che uffici, negozi e
strade vengono svuotate dalla forza lavoro, il centro viene consegnato a una nottambula: l’altra faccia del grigio lavoro quotidiano. Queste creature della notte fanno sosta nelle discoteche, nei club, nelle sale di ritrovo e nei bar. L’“annullamento
tecnologico della distanza’ (Oscar Handlin), dovuto a un
sistema di trasporto veloce e (fino a poco fa) economico, stimola la città a cambiare aspetto ogni dodici ore. Per il turno di
notte, perfino i limiti cronometrici del tempo libero si possono
allungare assimilando gli stimolanti adatti, in particolare lo
speed (velocità/anfetamina), un nome particolarmente appropriato.
L’epicentro della cultura di massa britannica è stato la metropoli che, fatte rare eccezioni, vuol dire Londra. Tuttavia
sarebbe un errore trascurare gli effetti che da altre aree urbane si sono spesso riflessi sulla capitale con un linguaggio
riveduto e a volte addirittura nuovo. Il caso clamoroso del Mersey sound rimane stampato a caratteri indelebili nella mitologia del pop inglese. In realtà il circuito del Northern Soul e il
continuo fermento sotterraneo del reggae giamaicano e inglese durante gli anni Settanta, si sono rivelati fenomeni anche più duraturi. Nessuna di queste musiche, che si sono formate alle confluenze della cultura popolare urbana e all’ombra
di un’industria musicale accentrata a Londra può dire di
essere sfuggita all’impronta metropolitana. Ma alcune di esse
ne hanno forzato i confini. In particolare, dopo l’irruzione del
punk nell’universo pop, siamo stati stimolati a cercare nuove
sonorità al di fuori di Londra, in altri centri urbani quali Coventry, Birmingham, Glasgow, Manchester e Liverpool.
Sebbene soffocati dalla moda londinese, appaiono tuttavia
segni evidenti di forme e varianti regionali che emergono un
po’ ovunque. E in qualche modo, la musica di un venerdì sera
al Rock City di Nottingham, ha un suono diverso da quella del
Le Beat Route di Londra. La stessa musica, lo stesso disco possono essere oggetto di pressioni culturali, esigenze e piaceri
diversi. La battaglia culturale per l’uso e il senso della musica
pop è una battaglia che coinvolge anche il suo potenziale
democratico e la sua delega culturale. In altre parole, essa co164
involge il suo potenziale sintonizzarsi con la vita “palpabile e
concreta”... una vita il cui interesse si concentra su ciò che è
intimo, sensoriale, sul particolare e sul personale (Hoggart
1958, p. 81).
La cultura di massa contemporanea è vissuta direttamente attraverso le superfici immediate della vita quotidiana: una radio, un disco, un paio di cuffie, gli annunci pubblicitari, lo
schermo televisivo. Immersi ogni giorno nel suo flusso, ne abbiamo una “percezione distratta” (Benjamin 1973). Criticato a
torto da molti osservatori per una sua presunta passività, è
proprio questo modo distratto di percepire i prodotti culturali,
favorito dalla riproduzione elettronica dei vari linguaggi visivi
e sonori esistenti, che fa presagire un mutamento nelle “regole
del gioco”, un “rafforzamento” della “nostra capacità di sopportare l’incommensurabile” (Lyotard 1979), e una situazione in
cui tutti noi diventiamo degli “esperti” (Benjamin).
Nella musica pop, nel suo romanticismo, nei suoi gusti, stili e
piaceri c’è un uso individualizzato e un dialogo aperto con i linguaggi della cultura urbana contemporanea: linguaggi che in
apparenza ci mettono in una condizione di esserne simultaneamente “soggetto” e “oggetto”. Sono questi interrogativi concreti, spesso “privati”, in territori di pubblico dominio - quale
un’esibizione di break dancing o la scelta di colore del rossetto
- che trasformano l’apparente “ovvietà” della cultura di massa
in una conquista immaginaria della vita quotidiana. A questo
punto, ci troviamo all’interno di un altro “sapere”, molto
diverso dalle ristrette prospettive della “cultura” con la C maiuscola, dalla sua razionalità e dal suo formalismo estetico.
Questa trasfigurazione delle realtà ufficiali, del loro modo di
spiegare l’esperienza sociale, rappresenta una vittoria sull’ineluttabile, e allo stesso tempo svela la prospettiva insospettata
della cultura di massa: la possibilità di cambiamento in un realtà modificabile attraverso la continua fusione dell’immaginazione e del vissuto.
NOTE
1 Davanti agli elastici contorni dell’odierna cultura di massa, la relativa
staticità della “tradizione” fa muro attorno a una “autenticità” assediata. Per i tradizionalisti rimane solo una via d’uscita: “L.’idea di libertà
recede dalla teoria sociale all’esteticà (Fekete 1977, p. 6). La presunta
unità di un sapere o cultura totalizzante è vanificata e frammentata
dalle eterogenee pressioni di diversi saperi e culture.
2 Lasciando in disparte per un momento queste considerazioni generali, sarebbe possibile entrare più approfonditamente nei particolari ed
esaminare, per esempio, i cambiamenti avvenuti all’interno del giornalismo musicale - dall’insistenza su un certo tipo di “autenticità” musicale nei tardi anni Sessanta all’allineamento con la cultura di “strada”
del decennio successivo - come segnali importanti di unamutevole retorica di un più generale romanticismo urbano.
3 Spinto al di là dei propri limiti da eventi più importanti e dall’insistente richiesta del “nuovo”, il romanticismo maschile ha incominciato
negli ultimi anni a riscoprire una vistosa identificazione con il proprio
sesso: David Bowie, Michael Jackson, Boy George. Ma la bellezza e il
narcisismo maschile, giocando col sé e con le ambiguità sessuali,
spesso sotto l’angolazione del “camp”, sono ancora indicative di un
165
privilegio maschile nella vita sociale. I poteri legati alla divisione dei
sessi mantengono anche qui i limiti di ciò che è sessualmente lecito. Il
pop accetta i segni della cultura gay, ma non c’è ancora un accenno di
un’autonomia sessuale da parte femminile, cioè sul versante del lesbismo.
166
Discografia
I dischi qui indicati sono prevalentemente limitati a registrazioni di
cantanti solisti e gruppi menzionati nel testo. Essi rappresentano l’immediato contesto sonoro delle descrizioni e delle questioni trattate nei
precedenti capitoli. Il loro ordine di successione segue pertanto questa
logica.
Vivere nel mondo moderno
Per comprendere le influenze americane sulla musica leggera dopo gli
anni Venti in termini di sound, l’album doppio Kings of Swing (RCA) e
Million Sellers of the Fifties (Embassy) permettono di fare un tuffo nel
vasto mare della musica popolare statunitense, da Benny Goodman a
Frankie Laine. Questo ascolto può essere accompagnato da quello dei
primi esempi di folk urbano inglese rintracciabili in The Iron Muse
(Topic) e dei residui del music hall, con la sua trasformazione in varietà: On tbc Halls (EMI).
Le differenze tra tutti questi stili popolari e i suoni della tradizione
afroamericana possono essere verificati con una scelta dei toni lugubri
e intensi del blues rurale d’anteguerra di Robert Johnson in King of tbc
Delta Blues Singers (CBS) e poi della forza oscura del blues urbano del
dopoguerra. In quest’ultimo caso, si può ascoltare meglio Muddy Waters in Chess Blues Masters (Chess); Howlin’ Wolf in Howlin’ Wolf
(Chess), Elmore James in The Best of Elmore James (SUE), fosse solo
per l’immortale ‘Dust My Broom’, B.B. King in Live at tbc Regal (ABC);
John Lee Hooker, con il suo tono idiosincratico e la sua voce malinconica in Dimples (DJM) e Bobby Bland nello splendido Two Steps from
tbc Blues (Duke).
Ritornando alla musica leggera inglese degli anni tra le due guerre e immediatamente successivi, quando le piccole orchestre dominavano le
frequenze radiofoniche con la musica da ballo, la Decca dedica la serie
The Bands that Matter ai dischi di Roy Fox, Lew Storie e Ambrose. Per
avere un’idea dello stile confidenziale americano è sufficiente qualsiasi
disco di Bing Crosby o di Frank Sinatra, per esempio The Very Best of
Frank Sinatra (EMI). II grande debito nei confronti della musica
afroamericana, in particolare quella jazz, si può trovare tra le sue note
e i suoi versi.
“Il nastro magnetico è stato introdotto verso la fine del 1948, il lavoro
neccesario per montarlo terrorizzava tutti quanti”(Tom Dowd, produttore discografico americano, in un’intervista alla prima rete radiofonica
BBC, 3 gennaio 1982). Il rapporto tra le possibilità offerte dal nastro
alla recente scoperta dell’immediatezza della musica nera da patte del
gusto popolate bianco e l’importanza di tutto ciò per la successiva musica pop può essere apprezzato appieno ascoltanto le registrazioni di
studio di Little Richard, ‘Keep A-Knockin’ o di altri classici come ‘Tutti
Frutti’, o come ‘Lawdy Miss Clawdy’ di Lloyd Price. Queste registrazioni e altre ancora, si possono trovare sul secondo volume di This Is
How It All Began (Speciality).
Un momento formativo. 1956-1963
Altri esempi di registrazioni di musica popolare americana di questo
periodo sono contenuti in Juke-Box Hits of the ‘50s (RCA). L’ultimo
disco offre una selezione che va da ‘Just Walking in the Rain’ di Johnny
Ray a ‘Crying in the Chapel’ degli Orioles, o a ‘The Great Pretender’ dei
Platters. 40 Greatest (RCA), contiene inoltre molti successi di Elvis tra
il 1956 e la fine degli anni Sessanta. Ma per avventurarsi nel Presley
epico e nei mitici inizi del rock’n’roll, e in quello che era, per i britannici di razza bianca, una nuova “America’”, è essenziale ascoltare The
Sun Collection (RCA), che contiene quasi tutti i brani registrati a Memphis tra il 1954 e il 1956 sotto la supervisione di Sam Phillips prima del
passaggio di Elvis alla RCA e del suo successo mondiale. Insieme con le
prime registrazioni di Presley è necessario citare altro materiale uscito
dagli studi della Sun tra il 1955 e il 1957. Alcuni dei più oscuri suoni
rockabilly, compresa la memorabile ‘Domino’ di Roy Orbison, possono
essere trovati in That Rockabilly Craze (Charly). Sono anche da ricordare Jerry Lee Lewis con The Original Jerry Lee Lewis e Carl Perkins
con Rocking Guitarsman (entrambi su Charly). Tutte queste registrazioni mostrano senza ombra di dubbio un’eco di country bianco. Vale
quindi la pena di ascoltare A Legendary Performer (RCA) di Jimmy
Rodgers, 40 Greatest Hits di Hank Williams (MGM) e The Bob Willis
Anthology di Bob Willis e dei suoi Texas Cowboys (CBS), per avere
qualche ulteriore dato del country round che, con il gospel bianco del
sud, si è incrociato con il blues per formare il southern rockabilly.
Il country è contenuto anche in Bill Haley and The Comets, storicamente importante, sebbene musicalmente più debole. I loro successi
anticipatori della metà degli anni Cinquanta sono rintracciabili in
Golden Hits (MCA). Proveniente da un’altra direzione fu estremamente importante Chuck Berry. Basterebbe pensare al debito degli
Stones nei suoi confronti o ai rifacimenti di ‘Johnny B. Goode’ dei vari
gruppi bianchi negli anni Sessanta. Caso strano per un artista nero, influenze country sono chiare anche in questo caso: “Aggiungendo toni
tipicamente blues a veloci brani country e unendo al tutto un beat
rhythm & blues, egli ha creato uno stile strumentale con un forte richiamo birazziale”(Christgau 1973, p. 144). I classici brani di Berry possono essere trovati in Motivatin’ (Chess): ‘Carol’, ‘Bye Bye Johnny’,
‘Back in the USA’, ‘Brown Eyed Handsome Man’.
Chi volesse approfondite maggiormente il primo periodo del pop può
rivolgersi a Louis Jordan in The Best of Louis Jordan, con il miglior
“jump” R&B degli anni Quaranta. Doowop Doowop (DJM) esemplifica
i gruppi vocali neri da strada degli anni Cinquanta. II rilassato stile
R&B di New Orleans dei 20 Greatest Hits di Fats Domino (United Artists) e la chitarra borbottante di Golden Decade (Chess) di Bo Diddley
sono altri contributi da tenere presenti. L’importanza della chitarra elettrica per il caratteristico sound del pop negli anni Cinquanta e Sessanta
è bene evidenziata nei dischi su menzionati, in particolar modo quelli
di Berry. Il delicato, sofisticato stile chitarristico texano di T Bone
Walker ha influenzato un’intera scuola di artisti neri (B.B. King, Amos
Milburn, Albert King) degli anni Cinquanta che, a sua volta, forni un
modello per un’infinita schiera di chitarristi bianchi degli anni Sessanta. Lo stile di Walker è apprezzabile in T-Bone Blues (Atlantic). Nel
country, la figura chiave fu Merle Travis che nel 1957 registrò ‘Merle’s
Boogíe’, impiegando il “trucco di rallentare la velocità di registrazione
mentre incideva le parti di chitarra° (David Toop, “Finger Picking”and
Double Talking” , “Collusion”, 4, London 1982). Travis fu importante
per lo stile di Chet Atkins, sempre presente nelle prime incisioni di
Presley per la RCA, e attraverso lui al Nashville Sound della decade seguente. Si può ascoltarlo in The Best of Merle Travis (Capitol).
Il sound della chitarra elettrica nei ritmi metallici degli Shadows può
essere seguito in 20 Golden Greats (EMI), mentre Duane Eddy si trova
in Legend of Rock (London). L’estensione del R&B attraverso l’ampliamento delle sfumature timbriche consentita dall’aggiunta degli archi,
può essere rilevata in 24 Originai Hits (Atlantic). La spinta di queste
tendenze nell’orchestrazione di Phil Spector e del suo “muro del
suono’”, associata a gruppi di ragazze nere come The Ronettes e The
Crystals e culminata con ‘River Deep-Mountain High’ di Ike e Tina
Turner si trova in Phil Spector’s 20 Greatest Hits (Phil Spector International).
Il sentimentalismo dei teenager domina il pop che segui la prima ondata del rock’n’roll. È testimoniato in From Bobby Sox To Stockíngs
(MGM). Ma per un’antologia che copra la maggior parte degli spazi del
pop britannico nei tardi anni Cinquanta e primi anni Sessanta si raccomanda The Roots of Britúh Rock (SIRE). Le forme inglesi delle ballate
per teenager sono rintracciabili in 40 Golden Greats di Cliff Richard
(EMI), in Tbe Billy Fury Story (Decca) di Billy Fury e in The Best of
Adam Faith (Sterline) di Adam Faith.
La musica americana dei tardi anni Cinquanta, eccezion fatta per la dolciastra vacuità di Fabian e Tommy Sands, vanta anche personaggi
come Buddy Holly and che Crickets, gli Everly Brothers e Eddie Cochran. Holly, nativo di Lubbock, Texas, uni nelle sue ballate e nei suoi
energici rock il country con il blues, solitamente accompagnato da uno
schieramento di due chitarre, basso e batteria. Nonostante la precoce
morte che lo colse non ancora ventitreenne, egli produsse una miscela
musicale a cui il pop si è spesso ispirato (gli Stones di ‘Not Fade Away’
o Elvis Costello con My Aim Is True, Stiff). Una fondamentale selezione del suo lavoro si può trovare in Legend (MCA). Gli Everly Brothers
attingono da una tradizione country di famiglia: dopo aver sentito lo
stile chitarristico del loro padre alla radio, Merle Travis abbandonò il
banjo per la chitarra. Sono stati tra i pionieri. del canto a più voci del
pop bianco. I loro successori in questo campo furono i Beatles, ma è importante notare che gli Everly non sono stati molto influenzati dalla musica nera. I loro successi negli anni Cinquanta si trovano in Don and
Phil’s Fabulous Fifties Treasury (Janus). Eddie Cochran, il ribelle,
rockeggiante ragazzo bianco di ‘Summertime Blues’, fu estremamente
popolare in Gran Bretagna, dove trovò morte prematura in un incidente automobilistico. Tutti i suoi dischi più significativi, eccetto
‘Three Steps To Heaven’, si trovano in Legendary Masters (United Artists).
Il sound del pop nero di questo periodo può essere trovato nei già menzionati dischi dei Drifters, di Phil Spector o su 20 Great Originals dei
Coasters (Atlantic). I dischi da ballo americani, che di nuovo si richiamavano ai suoni della musica nera, ricevettero un ulteriore incentivo
con il successo di Chubby Checker con ‘The Twist’ (Columbia), seguiti
da Little Eva con ‘The Locomotion’ (London). Lo skiffle inglese, a parte
i pezzi inclusi in The Roots of British Rock (Sire), si può trovare in
forma più concentrata in The Donegan File (Pye) di Lonnie Donegan.
Gli stili del folk blues a cui lo skiffle attinse e che più tardi servirono da
incentivo, possono essere ascoltati in Leadbelly’s Last Session (Folkways).
Voci inglesi. 1963-1966
Agli album pop menzionati alla fine dell’ultimo capitolo (soprattutto
The Roots of British Rock, Sire) fornisce un più ampio contesto nelle
classifiche inglesi tra il 1962 e il 1964 (aggiunta di musica d’importazione americana, come The Golden Age of Sam Cooke (RCA), la voce di
“Little Miss Dynamite’”, The Brenda Lee Story (MCA), The Best of Del
Shannon (Contempo), All Time Greatest Hits di Roy Orbison (Monument), i macabri melodrammi per adolescenti delle Shangri-La in
Golden Hits of Shangri-Las (Philips), senza dimenticare Elvis di Blue
Hawaii (RCA), per avere un idea di Presley come cantante romantico
di ballate di stampo hollywoodiano.
Mersey Beat ‘62-‘64 (United Artists) è un’utile collezione permeata
dalla eccitazione di Johnny Sandon and the Remo Four, The Escorts,
The Undertakers e molti altri gruppi di Liverpool che non conobbero
mai l’ebbrezza del successo dei Beatles o di Gerry and the Pacemakers.
Un’altra collezione, The Beat Merchants (United Artists), testimonia la
variegata diffusione musicale e geografica del sound britannico, in
particolare quello del R&B bianco.
Tutte le registrazioni dei Beatles, incluse rarità in cui è Pete Best e non
Ringo a suonare la batteria e Stu Sutdiffe il basso nei loro tempi di Amburgo nei primi anni Sessanta, sono facilmente reperibili. Dopo l’incisione di ‘Love Me Do’ nel 1962, i loro LP sono in ordine cronologico:
Please, Please Me, With The Beatles, A Hard Day’s Night, Beatles for
Sale, Help, Rubber Soul e Revolver, tutti su Parlophone. Queste registrazioni esauriscono la loro carriera fino al termine del 1966.
Le inglesi Helen Shapiro (‘Don’t Treat Me Like a Child’, ‘Walking Back
to Happiness’) e Dusty Springfield (A Girl Called Dusty, e Golden
Hits), entrambi su Philips, rappresentano due voci diverse nella prima
metà degli anni Sessanta, poi seguite da Cilla Black, Cilla (Parlophone)
e Sandy Shaw, Sandy Shaw (Pye).
Il R&B britannico conobbe i suoi primi successi di pubblico con i Rolling Stones, e la loro musica su The Rolling Stones (Decca) rappresenta
chiaramente un vivido aspetto delle tendenze principali di quel mondo:
il blues elettrico di Chicago mescolato con un’arrogante sensualità
maschile. La loro musica è successivamente dispiegata, particolarmente grazie ai prestiti del soul nero, nei due album seguenti, Rolling
Stones 2 (Decca) e Out of Our Heads (Decca), prima di sbocciare nell’originale stile londinese e mondano di Aftermath (Decca). Un’altra tendenza del R&B britannico è rappresentata da Georgie Fame and the
Blues Flames in Rhythm and Blues at the Flamingo (Columbia). A
questo dovrebbero essere aggiunti Five Live Yardhirds (Columbia) e
The Animals (EMI). La leggenda di Eric Clapton, insieme con la crociata blues di John Mayall si può rintracciare in Blues Breakers (Decca).
Il primo album doppio di James Brown Solid Gold (Polydor) presenta
molti degli autorevoli suoni di Soul Brother n. I da ‘Night Train
‘(reperibile anche sull’LP di Georgie Fame) attraverso la frenesia controllata di ‘Out of Sight’ e al declamatorio ‘Papa’s Got A Brand New
Bag’, Il primo soul di Marvin Gaye (di cui ‘Can I Get a Witness’ e ‘Hitch
Hiker’ appaiono sui primi dischi degli Stones) è rintracciabile in Anthology (Tamla Motown). Dietro questi artisti si trova Ray Charles, un’in-
fluenza riconosciuta dalla quasi totalità degli artisti di soul bianco degli
anni Sessanta. Da ascoltare il suo A 25th Anniversary in Show Business Salute (Atlantic).
Quando Georgie Fame registrò il suo disco nel 1963, una delle canzoni
incluse era ‘Shop Around’ del gruppo dei Miracles. Il brano fu un successo della Tarala Motown nel 1960. I momenti più salienti della Motown del primo periodo e di quello di mezzo sono rintracciabili in Anthology, l’album triplo dei Mirades, in 20 Golden Hits di Diana Ross
and The Supremes, in Greatest Hits di Stevie Wonder. A questi si aggiungeranno in seguito Mary Wells, The Contours, The Marvellettes, Martha and The Vandellas: suoni e ispirazioni che più in là faranno la loro
comparsa sugli album dei Beatles, degli Who e degli Stones (‘Street
Fighting Man’ del 1968 fu un rifacimento cinicamente sofisticato di
‘Dancing in the Streets di Martha and The Vandellas), tutti rintracciabili sul quintuplo The Motown Story (Motown).
L’aspetto più oscuro e difficile della musica soul proveniente dal Sud, e
rappresentata in particolare dalle case discografiche di Memphis Stax e
Volt, ebbe un’enorme ricezione nei club britannici e nella sottocultura
mod. I dischi chiave sono The Best of Otis Redding (Atlantic), Greatest
Hits (Atlantic) di Wilson Pickett, Best of Sam and Dave (Atlantic),
senza dimenticare Booker T and the MGs con l’organo in crescendo di
Booker T e le chitarre taglienti come la lama di un coltello di Steve
Cropper in ‘Green Onions’, che ipnotizzarono le piste da ballo inglesi
tra il 1961-1964. Si può trovare in Best of Booker T and the MGs (Atlantic).
L’LP del 1979 Intensified1 Originai Ska 1962-66 (Island) ripresenta
molti dei suoni ska allora popolari nei locali. Può essere integrato con
Fabulous Greatest Hits (Fab) di Prince Buster.
Un tipo di sperimentazione molto diversa che convogliava blues, folk e
chitarre acustiche, stava intanto affermandosi a Soho. È, bene rappresentato dai seguenti tre dischi. Folk, Blues and Beyond (Decca) di
Davey Graham è una notevole sintesi di blues, funky jazz (Charlie Min-
gus e Bobby Timmons), folk britannico e armonie modali di ispirazione
araba. Un altro importante disco destinato a influenzare lo stile dei
cantanti-chitarristi fu Bert Jansch (Transatlantic), mentre il punto più
alto dello stile folk-barocco è da ricercarsi nella collaborazione tra
Jansch e John Renboum testimoniata da Bert and John (Transatlantic). Queste incisioni costituiscono uno dei raccordi più significativi tra
le basi gettate dallo skiflle, il posteriore folk elettrico e la musica progressiva.
La seconda ondata dei gruppi su essivi ai Beatles e agli Stones, spesso
associata con il movimento mod, è ottimamente rappresentata dagli
Who di Meaty, Beaty, Big and Bouncy (Track) o di The Story of The
Who (Polydor), e dai Kinks di Kink File (Pye). Altri suoni della “swinging London’”, quelli di The Small Faces e The Zombies, sono reperibili
su Hard Up Heroes (Decca), mentre due prodigiose voci stavano emergendo: quella di Stevie Winwood con lo Spencer Davis Group, Best of
Spencer Davis (Island) e quella di Van Morrison con i Them, The
World of Them (Decca).
Il sogno esplode. 1966-1971
Poco è stato detto sul surfing sound californiano dei primi anni Sessanta. Un incrocio di armonie vocali bianche ispirate al doo-wop e di
ritmi alla Chuck Berry, la surf music fu all’inizio una musica principalmente strumentale, con The Ventures e The Safaris (‘Wipe Out’), fino a
quando Jan and Dean e poi i Beach Boys aggiunsero testi che si riferivano ai due principali miti giovanili californiani: il surf e le automobili. Il primo è testimoniato da Golden Summer(United Artists), il secondo da 20 Golden Hits (Capitol) dei Beach Boys, e da qualsiasi album
di Jan and Dean intorno al 1964.
Gli LP di Dylan sono stati tutti importanti in modi differenti: il suo
periodo folk è meglio rappresentato in The Times they Are A-Changin’
(CBS), mentre Bringing it All Back Home (CBS), inciso dopo la “British invasion”, è indirizzato verso una prospettiva folk-rock. Da questo
disco i Byrds ripresero ‘Mr Tambourine Man’. I successivi due lavori,
Highway 61 Revisited e Blonde on Blonde (entrambi CBS) segnano il
passaggio della voce di Dylan verso un mosaico di parole sempre più
complesso (‘Like a Rolling Stone’, ‘Desolation Row’) e del suo sound in
una dimensione elettrica dovuta all’accompagnamento della Band (‘Visions of Johanna’, ‘Just Like a Woman’, eccetera).
Il revival del folk americano e i suoi immediati antedecenti si possono
ascol tare in Leadbelly’s Last Session (Folkways), in Dust Bowl Ballads
di Woody Guthrie (sempre Folkways) e in Broadside Ballads (Folkways) di Pete Seeger. Tra i più importanti contemporanei di Dylan si
deve ricordare Joan Baez. The First Ten Years (Vanguard) offre un’utile panoramica del suo stile vocale puro su materiale tradizionale e
contemporaneo. Le canzoni di impegno politico di Phil Och possono
essere ascoltate sul suo doppio album retrospettivo (dopo il suo suicidio nel 1977) Chords of Fame (A&M). La sofisticata suggestione musicale di Judy Collins può essere ascoltata su In My Life (Elektra), un importante disco di transizione per questa cantante e per il movimento
folk. A parte la scena folk dei locali londinesi, l’antologia in quattro dischi The Electric Muse (Island) ricostruisce gran parte della storia del
folk inglese degli anni Sessanta. Dei Pentangle il documento migliore è
Sweet Child (Transatlantic), dei Fairport Convention l’importante lavoro folk elettrico Leige and Lief (Island), di Donovan è da ascoltare il
suo terzo disco Sunshine Superman (Pye). Meno folk dei due album
precedenti, il disco rispecchia le influenze dell’acido, del folk-rock e
della controcultura della metà degli anni Sessanta, particolarmente
nell’atmosfera freak di ‘Hampstead Incident’ e ‘Season of the Witch’.
Nel frattempo il folk-rock statunitense si spingeva in avanti. I Byrds erano sicuramente il gruppo principale. Ma questa musica, che attingeva
anche a influenze country col trascorrere degli anni Sessanta, era rin-
tracciabile un po’ovunque: Mr. Tambourine Man (CBS) dei Byrds, The
Band (Capitol), The Lovin’ Spoonful File (Pye) dei Lovin’ Spoonful,
Workingman’s Dead (Warner Brothers) dei Grateful Dead, Retrospettive dei Buffalo Springfield (Atlantic), e così via.
L’acid-rock più duro della West Coast si può ascoltare con buoni effetti
su Live Dead dei Grateful Dead (Warner Brothers), e in classici come
‘Dark Star’ e ‘St. Stephen’. Il secondo album dei Jefferson Airplane, Surrealistic Píllow (RCA) mette in mostra la voce di Grate Slick particolarmente nella riscritrura LSD di Alice nel Paese delle Meraviglie in
‘White Rabbit’ e nel potente ‘Somebody to Love’. Il loro manifesto musicale contro l’“Amerika” è Volunteers (RCA). Country Joe and The Fish
nel loro periodo più importante, quello di Berkeley, del movimento contro la guerra in Vietnam, dell’LSD e della controcultura, sono testimoniati in I Feel Like I’m Fixin’ to Die (Vanguard). Cheap Thrills (CBS) è il
miglior documento di Janis Joplin, mentre Happy Trails (Capitol) dei
Quicksilver Messenger Service offre un altra idea del feeling musicale
di San Francisco intorno al 1966-1967. Da Los Angeles provenivano i
“politici dell’erotico”, The Doors (Elektra) e Forever Changes (Elektra)
dei Love. Lo storico incontro di questi vari stili musicali avvenne nella
celebrazione pubblica della contro cultura a Woodstock, nella regione
settentrionale dello Stato di New York nel 1969. Il triplo Woodstock (Atlantic) offre una selezione di alcune di queste esibizioni: Jimi Hendrix,
Sly and The Family Stone, Joe Cocker, The Who, Ten Years After,
Ritchie Havens.
L’abbandono della Newcastle Brown da parte di Eric Burdon, a favore
del Nirvana di San Francisco è attestata in Winds of Change (MCA),
mentre i lati sperimentali meno forzati del periodo sono brillantemente
esplorati da un altro britannico espatriato, Van Morrison, in Astrai
Weeks e in Moondance (entrambi Warner Brothers) e da Tim Buckley
con il suo Goodbye and Hello (Elektra)
I dischi di Zappa menzionati in questo capitolo furono realizzati per la
Verve e per la Bizarre, mentre una retrospettiva del primo materiale
dei Mothers, Mothermania, che copre il periodo 1965-1967, si può trovare su Polydor. A questo punto sarebbe appropriato menzionare l’inconsueta, spesso assolutamente bizzarra produzione di Captain Beefheart e della sua Magic Band: The Captain Beefheart File (Pye) e per
quelli più esigenti Trout Mask Replica (Straight) e Clear Spot (Reprise).
Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Parlophone) dei Beatles
ha avuto un enorme influenza sul pop in generale, come indicazione
del suo sofisticato potenziale. Dietro ciò si trova tutto il variegato underground britannico. Proveniente dai folk club, The Incredibile String
Band utilizzava sitar, rumori di barattoli, chitarre e cimbali per produrre una musica esoterica il cui tessuto si può ricostruire in 5000 Spiriti or the Layers of the Onion (Elektra) e in The Hangsman’s Beautiful
Daughter (Elektra). I primi due album dei Pink Floyd, The Piper at the
Gates of Dawn e A Saucerful of Secrets, sono stati ristampaci insieme
nel doppio album A Nice Pair (Harvest). Altri sound significacivi del
periodo sono Family Entertainment (Reprise) dei Family e la ristampa
dei primi due dischi dei Soft Machine Volume One and Two (Probe).
Tra l’underground londinese e il successo pubblico, la presenza elettrizzante di Jimi Hendrix può essere apprezzata appieno mettendo in relazione (effetto esplosivo del suo primo LP Are You Fxperienced? (Track)
con i tessuti elettronici pluristratificati del doppio Electric Ladyland
(Polydor). I gruppi di blues elettrico del periodo sono capeggiati dei
Cream, Disraeli Gears (RSO), seguiti dai Fleetwood Mac di Fleetwood
Mac (CBS) e dai successivi Free, The Free Story (Island). I Traffic
hanno seguito un tragitto più orientato verso il soul: basti ascoltare
Best of Traffic (Island). I Rolling Stones, dopo il loro imbarazzante incontro con il flower-power, Their Satanic Majesties Request (Decca),
sono ritornati sui loro passi, cioè al blues urbano, con Beggars’ Banquet (Decca). Gli inizi del rock progressivo britannico, una volta concluso il periodo di gestazione underground, possono essere ascoltati in
Living in the Past (Chrysalis) dei Jethro Tull, In the Court of the Crimson King (Island) dei King Crimson e in Tresspass (Charisma) dei
Genesis in cui è contenuto ‘The Knife’.
Mentre alcuni gruppi di rock progressivo guardavano ai motivi classici
e alle strutture armoniche, altri si rivolgevano al jazz. Negli Stati Uniti
il primo gruppo che si presentò al pubblico con una miscela jazz-rock
fu il Blood, Sweat and Tears. Il loro primo LP Child Is Father to Man
(CBS) venne inciso nel 1968. Un anno dopo i Chicago registrarono Chicago Transit Authority (CBS), mentre Santana introduceva ritmi latini
nel rock della West Coast, con Abraxas (CBS). Esistevano anche gruppi
jazz-rock britannici come gli If e i Nucleus, ma fu il chitarrista John
McLaughlin, dopo aver suonato con Miles Davis, a spingere questa musica verso la fervente intensità di Birds of Fire (CBS), insieme ai
Weather Report di I Sing the Body Electric (CBS), anch’esso realizzato
nel 1973.
Tra i frammenti. 1971-1976
Ulteriori sviluppi della musica progressiva inglese verso il territorio
consacrato dell’arte si possono trovare in Pictures at an Exhibition
(Manticore) di Emerson, Lake e Palmer; In Search of the Lost Chord
(Deram) dei Moody Blues, Close to the Edge (Atlantic) degli Yes, Pawn
Hearts (Charisma) dei Van Der Graaf Generator e Foxtrot (Charisma)
dei Genesis. È qui compresa anche l’eccezione “progressiva” della
Tamla Motown, con Innervisions di Stevie Wonder. The Dark Side of
the Moon (Harvest) dei Pink Floyd è da segnalare tra i più interessanti
del periodo. Tuttavia, come ho cercato di indicare, la sintesi più completa dei temi “progressivi” in un’espressione artistica prodotta indipendentemente è l’opera strumentale Tubular Bells (Virgin) di Mike Oldfeld. All’interno di questo tipo di musica troviamo Terry Riley con il
suo A Rainbow in Curved Air (CBS). Realizzato nel 1969, si trattava di
un approccio musicale, con un regolare battito elettronico accompagnato da strutture cicliche e da figure ritmiche ripetute, che, affiancato
dalle analoghe proposte di LaMonte e Philip Glass, troverà poi spazio
negli esperimenti di David Bowie, assumendo una diversa rilevanza nel
contesto elettro-funk del decennio successivo.
Nel frattempo il blues elettrico inglese procedeva. Preceduto dai Rolling Stones con Exile on Main Street (Rolling Stones Records), Rod
Stewart con Every Picture Tells a Story (Mercury) introduceva un
diverso modo di rielaborare la tradizione. Altrove troviamo il sound revivalistico dei Credente Clearwater Revival, Chronicle The 20 Greatest
Hits (Fantasy), le astute melodie di Elton John, Elton John e Tumbleweed Connection (entrambe DJM) e l’heavy metal, su cui si ritornerà
in seguito.
La cosiddetta autenticità della musica country garanti a questo genere
un ingresso nell’area progressiva. Questo movimento fu evidenziato soprattutto dal Dylan di John Wesley Harding (CBS) e di Nashville Skyline (CBS). I suoi contemporanei nel campo della musica country sono
rappresentati nel modo migliore da Kris Kristofferson con Me and
Bobby McGhce (Monument), Willie Nelson con Shotgun Willie (Atlantic) e Waylon Jennings con Dreaming My Dreams (RCA). Un altra
voce importante fu quella di Merle Haggani, particolarmente influente
nell’arca country-rock di cui è consigliabile Songs I’ll Always Sing
(Capitol).
Il country-rock fu in gran parte stimolato da Sweetheart of the Rodeo,
(album inciso dai Byrds nel 1968 (CBS). Ma furono probabilmente i Flying Burrito Brothers a offrire la più valida fusione di country, e rock in
Tbe Gilded Palace of Sín (A&M), mentre la voce sofferta di Gram Parson, sottolineata dall’armonia di Emmylou Harris, può essere ascoltata
in Grievous Angel (Reprise). Il gruppo che continuò a conseguire un
successo internazionale grazie a questa miscela musicale fu quello degli
Eagles. La loro opera migliore è probabilmente contenuta in Desperado (Asylum) con tramonti desolati, tequila, cowboy e cuori infranti.
Altrettanto lacrimosi, ma meno direttamente indebitati con il country
furono Crosby, Stills, Nash and Young, il punto di arrivo degli esperimenti musicali californiani. L’album 4 Way Street (Atlantic) offre un
quadro esauriente dei loro stili fatti di suoni elettrici e acustici.
Una più robusta versione del country-rock fu sviluppata da una serie di
gruppi emergenti dagli Stati del wud degli Usa. Spesso conosciuta
come southern boogie, gli esponenti più conosciuti di questa scuola
sono probabilmente gli Allman Brorhers, tragicamente segnati dal
destino (Brothers and Sisters, Capricorn) e gli altrettanto sfortunati
Lynyrd Skynyrd (First and Last, MCA). Ambedue i gruppi hanno perduto i loro membri più importanti in incidenti automobilistici e in disastri aerei. A proposito degli Allman Brothers, ritorna alla mente anche
la connessione, attraverso Duane Allman, con la metamorfosi americana di Eric Clapton come Derek and The Dominoes, con Layla (Polydor).
Da questi incroci tra beat e blues, country e rock, virtuosismi di chitarra e successo commerciale, emerse in quegli anni gran parte della
spinta verso il filone principale del rock statunitense degli anni Settanta: esecuzioni impeccabili, produzioni levigate e facilità di ascolto.
Certo ci sono state eccezioni, come Alice Cooper (Greatest Hits, Warner Brothers), tendenze verso l’heavy metal con i Boston (Boston,
Epic), ma le sonorità più usuali sono rappresentate dalla serie di LP dei
Chicago registrati per la CBS, da Fleetwood Mac con Rumours (Warner
Brothers), The Doobie Brothers con Captain and Me (Warner Brothers), Steely Dan con Greatest Hits (ABC), Peter Frampton con Frampton Comes Alive (MM).
Nel frattempo i cantautori si trovavano al punto d’incontro di diversi
percorsi musicali: l’autenticità country e folk, la sincerità artistica e le
ceneri ancora ardenti della conttocultura. Tutto ciò è percepibile in After the Goldrush (Reprise) di Neil Young e ancora più evidentemente
in Sweet Baby James (Warner Brothers) di James Taylor e, in una
diversa chiave, nelle canzoni di isolata alienazione intrise di malinconia
di Leonard Cohen, in Songs from a Room (CBS). Il Regno Unito proponeva Cat Stevens, ritmicamente più vivace, con Tea for the Tillerman (Island), mentre un po’ più tardi compariva un distinto stile californiano con For Everyman (Asylum) di Jackson Browne. In quel
periodo Paul Simon otteneva un successo commerciale di enormi di-
mensioni con Still Crazy alter All These Years (CBS), e in seguito
un’analisi introspettiva completamente diversa che emergeva nei tardi
anni Settanta con le immagini urbane di Tom Waits in Small Change
(Asylum).
Tapestry di Carole King fu incisa in quel periodo per la A&M, e New
York Tendaberry di Laura Nyro per la CBS. Le prime registrazioni di
Joni Mitchell - Ladies of the Canyon, Blue - sono della Reprise, le seguenti dell’Asylum.
L’heavy metal ebbe inizio con il successo dei Led Zeppelin. L’ascolto di
Wheels of Fire (Polydor) del 1968 dei Cream o di Truth del Jeff Beck
Group (con Rod Stewart alla voce) realizzati nello stesso anno, rivela
molte delle radici del successivo heavy metal. Led Zeppelin I e Led Zeppelin II (entrambi su Atlantic) furono presentati al pubblico mentre gli
anni Sessanta trapassavano nei Settanta. II loro esempio di riff di chitarre ad alto volume fu presto seguito dai Deep Purple con In Rock, Machine Head (entrambi su EMI), dai Black Sabbath la cui selezione di
brani in Greatest Hits (NEMS) dà una chiara idea del loro repertorio, e
da una miriade di altri gruppi. Negli Stati Uniti c’erano i Grand Funk
Railroad e i Blue Oyster Cult (Blue Oyster Cult, Columbia). L’heavy
metal britannico che segna il passaggio dagli anni Settanta agli anni Ottanta è rappresentato dai Motorhead con l’appropriato titolo Overkill
(Bronze), da Judas Priest con Killing Machine (CBS), dai Saxon con
Wheels of Steel (Carrere). Esiste anche un’antologia dei festival di Reading del 1979 e 1980 - una data importante nel calendario degli heavy
metal - con la partecipazione di Whitesnake, Michael Shenker, Budgie,
eccetera, compresa in Reading Rock (Mean).
Per una selezione di musica teenybopper è da ricordare David Cassidy
con Greatest Hits (Bell), The Osmonds con Greatest Hiys (Polydor),
the Bay City Rollers con Once Upon a Time (Bell). Nell’area del rock
teenybopper/glitter, dove il beat bianco si incrocia con le sonorità
Tamla, ci sono Gary Glitter con Greatest Hits (Bell), The Slade con
Sladest (Polydor) e T Rex con Electric Warrior (Fly). I Jackson 5 appar-
tengono soltanto in parte a quest’area, essendo anche tra i principali interpreti del nuovo sound nero degli anni Settanta, e possono
essere ascoltati in Greatest Hits (Motown). Un altro caso periferico
è rappresentato dai Mott The Hoople (‘All the Young Dudes)’ che si
possono ascoltare in Greatest Hits (CBS). L’aspra musica urbana
americana che passò inosservata negli anni Sessanta, ma fu più
tardi ampiamente rivalutata, si può ascoltare in The Velvet Underground and Nico (MGM), il disco presumibilmente prodotto da
Andy Warhol, e in Loaded (MGM), oltre che in Kick out the Jams
(Elektra) degli MC5 e in Fun House (Elektra) di Iggy Pop and the
Stooges. I New York Dolls si possono ascoltare in New York Dolls,
Volumes One and Two (Mercury). For Your Pleasure (Polydor) dei
Roxy Music fu probabilmente il loro prodotto più ricco di stile,
dalla copertina con scena notturna all’edonismo vuoto di ‘In Every
Dream Home a Heartache’. La musica successiva può essere ascoltata in Greatest Hits (Polydor) e il loro seguente contributo al dandysmo elettro-pop degli anni Ottanta in Avalon (Polydor). I menzionati dischi di Bowie sono tutti RCA, cosl come Transformer e Berlin di Lou Reed.
La liberazione dall’oscurità: le musiche nere. 1966-1976
Solid Gold (Polydor) di James Brown e Anthology (Motown) di
Marvin Gaye costituiscono due significativi punti di partenza. Il
sound Motown dei tardi anni Sessanta è ben evidenziato in Anthology dei Temptations, mentre un’altra influenza determinante è
quella di Sly and The Family Stone: da ascoltare il loro Greatest
Hits (Epic). Una musica nera più deliberatamente militante è quella
di His Early Years with tbe Impressions (Probe) di Curtis Mayfìeld,
nonostante segnali di questo tipo non fossero assenti in James
Brown (‘Say it Loud I’m Black and I’m Proud’), in Marvin Gaye
(‘What’s Going on?’) e in Sly Storie.
L’intreccio fra il blues e il gospel nei differenti toni del soul può essere
seguito nel doppio LP di Ray Charles A 25th Anniversary in Show Business Salute (Atlantic), che, nonostante il titolo poco promettente, unisce in un flusso produttivo tutti gli elementi: blues, gospel, punte di
jazz, strumenti ad archi, echi country. ‘I’ve Got a Woman,’ ‘Hallelujah,
I Love Her So’ e molti apri brani che hanno influenzato le generazioni
seguenti sono ascoltabili qui. Aretha Franklin, figlia di un noto predicatore battista mescola gospel e soul in Ten Years of Gold (Atlantic). I’incalzante messaggio di The Staple Singers in Be What You Are (Stax) illustra bene la trasformazione successiva del quartetto gospel in un soul
contemporaneo. II levigato falsetto di Al Green offre una tonalità di gospel più morbida in Greatest Hits (London).
La più estesa sfera musicale del soul, dove i generi scivolano in un generale abbraccio della “comunità nera”, può essere esplorata ascoltando
le sonorità sviluppate dai musicisti di colore di musica jazz degli anni
Cinquanta e Sessanta. Anche la musica di John Coltrane rappresenta
una magistrale estensione dell’universo della malinconia. Gli esempi si
trovano ovunque, da Blue Train (Impulse), attraverso la sua importante collaborazione con Miles Davis in Kind of Blue (CBS), ai “sheets
of sound” sviluppati in A Love Supreme (Impulse) e Meditations (Impulse). Sempre dell’Impulse è il duo John Coltrane-Rashied Ali, di Interstellar Space. Ornette Coleman con Free Jazz (Atlantic), Archie
Shepp con Mama Too Tight (Impulse) e Albert Ayler con Ghosts (Fontana), hanno tutti scavato nei tessuti della musica afroamericana ed
esteso le possibilità del soul. Questi suoni costituiscono un’importante
parte della comunità soul di colore e della sua crescente militanza culturale nel corso degli anni Sessanta.
La musica nera che ha tenuto occupate le piste da ballo inglesi in
questo periodo è validamente rappresentata nei vari album della Motown Chartbuster incisi verso la fine degli anni Sessanta. Nei primi
anni Settanta, il sound Motown venne contrastato in Gran Bretagna
dai prodotti delle case discografiche Philadelphia, Gamble, Huff e Bell
e dal sorgere dei gruppi di street-funk che riprendevano ed estende-
vano il lavoro di James Brown e Sly and The Family Storie. Il Philly
Sound, che comprendeva ‘Back Stabbers’ e ‘Love Train’ degli O’Jays, le
profonde ballate soul di Harold Melvin e i Blue Notes con ‘If You Don’t
Know Me by Now’, si può ascoltare in Phillybusters: The Sound of
Philadelphia (Philadelphia International).
Lo street-funk introdusse un feel più jazzistico e puntato verso certe
parti che verranno riprese in seguito dalla disco music. Differenti versioni possono essere apprezzate ascoltando Greatest Hits (Polydor) di
Kool and The Gang, Open Our Eyes (Columbia) degli Earth, Wind and
Fire, Thc World Is a Ghetto (United Artists) dei War, e The Best of The
Crusaders (Anchor) dei Crusaders. Vale inoltre la pena di ascoltare i
trucchi del vecchio maestro James Brown sul disco dal vivo Superbad
(Polydor). Esercizi più articolati furono introdotti per primi da Isaac
Hayes con il disco registrato nel 1969 Hot Buttered Soul (Stax), ma fondamentalmente incoraggiati dalle colonne sonore scritte per il cinema
nero. ‘Theme from Shaft’ di Hayes si trova in Chronicle (Stax) mentre il
soundtrack di Superfly di Curtis Mayfield è della Curtom.
La rarità esclusiva del Northern soul - quasi tutto importato e circoscritto a rapidamente dimenticati, saldamente legato a particolari
sale da ballo - lo rende difficilmente reperibile a causa dei prezzi esorbitanti (quasi centomila lire per il raro suono della casa discografica di
Detroit Ric-Tic del 1982). Dovrebbe essere possibile tracciare un
quadro dei dischi e dei musicisti presenti nel ventaglio dei negozi specializzati in musica soul. Un ulteriore elenco è stato recentemente proposto in”‘Out on the Floor” di Neil Rushton, su “The Face’”, 29, settembre 1982, dove viene presentato un catalogo dei dischi dance realizzati
da case discografiche statunitensi e inglesi. Tra queste è da segnalare
l’ottima antologia Sold on Soul della United Artists. Un’altra antologia
che vale la pena di rintracciare è Solid Soul Sensation (Pye).
Nel terzo capitolo sono suggerite alcune registrazioni ska. A queste
sarebbe bene aggiungere Best of the Skatalites (Studio One) degli Skatalites. Il reggae edulcorato di Byron Lee and the Dragonaires si può
ascoltare in Regay Splash Down (Trojan), mentre Better Must Come di
Delroy Wilson bene esprime i più immediati ma incalzanti sentimenti
che stavano bollendo nei quartieri poveri. Version Galore (Virgin) di U
Roy offre un’ottima idea del “toasting” del disc jockey giamaicano. Uno
stile in seguito ripreso dai Big Youth, Dreadlocks Dread (Virgin) e da I
Roy, Presenting I Roy (Trojan). Sfortunatamente, molti dei precedenti
“toaster” non sono rintracciabili su vinile eccezion fatta per Denis Alcapone, il cui toast ‘Ripe Cherry’ può essere ascoltato in Tighten Up Volume 5 (Trojan). Nello stesso disco è contenuto ‘Rod of Correction’ di
Clancy Eccles, già menzionato in questo capitolo.
Dietro questi sviluppi si intrecciano i filoni più persistenti della musica
popolare nera giamaicana. Esempi di musica Kumina possono essere
trovati in Bongo, Backra and Coolie (Folkways). I ritmi Buru suonati
dai leggendari Count Ossie and The Mystic Revelations of Ras Talari, si
possono trovare sul triplo Grounatíon (Ashanti).
La collezione Tighten Up (Trojan) in otto volumi contiene quasi tutti i
sound fondamentali presenti durante la transizione dal tardo rock
steady al primo reggae. Un’altra utile antologia che include classici del
rock steady come ‘Stop That Train’ (o ‘Draw Your Brakes’) è la colonna
sonora di The Harder They Come (Island), con le importanti presenze
di Jimmy Cliff, Desmond Dekker and the Slickers. La collezione prodotta da Duke Reid, Hottest Hits (Virgin), On Top (Studio One) degli
Heptones, Long Shot (Trojan) dei Pioneers e Early Days (Total Sound)
di Slim Smith sono essenziali da ascoltate in questo contesto.
Studio One Presents Burning Spear (Studio One) e African Herbsman
(Ttojan) sono due dischi importanti per rivelare la situazione del reggae giamaicano nei primi anni Settanta, prima che questa musica attirasse l’attenzione di tutto il mondo musicale. Le successive incisioni di
Bob Marley and the Wailers menzionate in questo capitolo sono tutte
per la Island britannica.
L’effimero interesse degli skinhead per il reggae nei tardi anni Sessanta
è documentato da una discografia in Knight 1982, pp. 48-51. Molti dei
dischi menzionati in quel contesto sono reperibili nei già menzionati
LP della Trojan, insieme con Fabulous Greatest Hits (Fab) di Prince
Buster a cui ci si riferisce nel terzo capitolo.
Verso la metà degli anni Settanta, il reggae allargò enormemente la sua
influenza e anche la sua sfera d’azione all’interno. I timbri più ricchi
che fanno la loro comparsa nel reggae di quel periodo si possono ascoltare in Marcus Garvey (Island) dei Burnmg Spear, in Two Sevens
Clash (Joe Gibbs) del Culture con Harder than the Rest (Virgin), in
Right Time (Virgin) dei Mighry Diamonds e in Extra Classic (Conflict)
di Gregory Isaac. La linea tradizionale di basso e batteria si estese man
mano che l’elaborato uso del rock nella batteria di Sly Dunbar diveniva
popolare. Tutto ciò forniva un’efficace matrice per le robuste parti vocali poi regolarmente utilizzate nelle tematiche Ras Tafani.
In Giamaica faceva la sua comparsa il dub che rappresentava la trasformazione più radicale verso una nuova direzione del reggae. I primi
passi su questa nuova strada, divenuta poi più sofisticata verso la fine
degli anni Settanta, sono documentati in African Dub Almighty. Chapter 1 (Lightning) di Joe Gibb, inciso nel 1973, insieme con This Is
Augustus Pablo (Randy) del 1970. Tutti raccomandabili sono King
Tubby Meets Rockers Uptown (Yard), Ital Dub (Virgin) e Cry Tuff Dub
Encounters, Part 2/Prince Far I In Dub (Virgin), mentre Vital Dub
(Virgin) di Joseph Hoo Kim rielabora molte delle canzoni associate al
trio vocale giamaicano The Mighry Diamonds in un esemplare dispiegamento di ritmi e timbri ricostruiti. I successivi sviluppi del toasting possono essere ascoltati in Best Dressed Chickrn In Town (Greensleeves)
di Dr. Alimantado, molto apprezzato dai punk, in Bionic Dread (Black
Swan) di Dillenger, e in MPLA (Virgin) di Tapper Zukie.
Un’occhiata in un qualunque negozio specializzato di reggae rivelerà
un’enorme quantità di musica trascurata o persa sotto l’aura militante
Ras Tafani che questo suono genera. Ma nella vita della comunità nera
il reggae “dolce” di “lover’s rock” ha chiaramente un posto importante.
Alcuni esempi potrebbero essere Lots of Love (Sky Note) di Bob Andy,
To Be a Lover (Island) di George Faith e Live Loving (Studio One) di
Sugar Minott.
Paesaggi sonori urbani. 1976-1983
I due LP essenziali del punk sono Never Mind the Bollocks (Virgin) dei
Sex Pistols - contenente tutti i loro singoli – e The Clash (CBS) dei
Clash. Per l’emozione dal vivo di un concerto punk nell’ancora violenta
primavera del 1977 è da ricordare The Roxy London WC2 (Harvest),
che contiene materiale dal vivo dei Buzzcocks e X Ray Spex, insieme
agli ormai quasi dimenticati Slaughter and the Dogs, Johnny Moped e
altri ancora.
The Scream (Polydor) di Siouxsie and the Banshees, registrato nel
1978, Cut (Island) delle Slits, prodotto da Dennis Bowell e inciso nel
1979 e The Story So Far (Deram) delle Mo-dettes, pubblicato l’anno seguente, rappresentano un’angolazione femminile importante del punk,
anche se i successivi eventi hanno dimostrato la difficoltà di mantenere
quelle promesse. È anche necessario menzionare l’artista americana
Patti Smith. Il suo LP Horses (Arista), comparso nel 1976, è un importante documento musicale, che pone la tradizione del pop in una
nuova, insistente versione femminile. Ma il disco che si deve soprattutto ricercare è il suo primo 45 giri, ‘Hey Joe/Piss Factory’. Hey Joe
inizia con un monologo indirizzato a Patry Hearst e alla sua esperienza
con la Symbionese Liberation Army, quindi si trasforma in una versione per piano e chitarre in sordina del brano reso famoso da Jimi
Hendrix. Questi consapevoli riferimenti incrociati illustrano inoltre il
deliberato atteggiamento di gran parte del punk americano. Prima
della comparsa, verso la fine degli anni Settanta, dei gruppi punk americani “privi di gusto”(per esempio i Dead Kennedys), l’unica importante
eccezione era costituita dagli inni monosillabici da marciapiede dei Ramones come Rocket to Russia (Sire).
Per rendersi conto della situazione della Hit Parade britannica e del
sound che andava per la maggiore, suggerirei un rapido ascolto di
Greatest Hits (Epic) degli Abba, insieme con Wings at the Speed of
Sound (EMI) e Horizon (A&M) dei Carpenters.
Safery Zone di Bobby Womack è prodotto dalla United Artists. Il complesso retaggio nero del sound disco può essere ricercato nei già menzionati LP di James Brown, Stand (CBS) di Sly Stone e Bitches Brew
(CBS) di Miles Davis. Ritmi latini sono già in evidenza nello street funk
citato nel precedente capitolo e anche i dischi chiave del “Philly
sound”sono già stati indicati.
La colonna sonora di Saturday Night Fever (RSO) che, oltre ai Bee
Gees, vede la partecipazione di Kool and the Gang e dei Trammps tra i
molti, è essenziale per apprezzare l’esplosione della disco music nei
tardi anni Settanta. Ma a quest’ultima si deve aggiungere Love Tracks
(Polydor) di Gloria Gaynor. C’est Chic (Atlantic) degli Chic, Makossa
Music (Creole) di Manu Dibango, Nightclubbing (Island) di Grace
Jones, e l’antologia Souled Out (K-Tel). Con questi dischi è possibile
toccare con mano la varietà di suoni e le diverse correnti musicali di
quella che viene frettolosamente liquidata con etichette erronee come
la “monotonia” della disco music.
Il leggero, raffinato funk britannico dei primi anni Ottanta è rintracciabile in Go Ahead (Chrysalis) dei Lynx, mentre le versioni bianche sono
numerose, per esempio il sound degli Spandau Ballet. La musica di ex
membri di Pop Group, che si trova in I Am Gold (Virgin) di Rip Rig and
Panic, con l’apporto dell’ex partner di Omette Coleman Don Cherry, è
un interessante esperimento di incrocio culturale in musica. Lend an
Ear (Y Records) di Pig Bag offre spunti più leggeri.
La migliore introduzione al rap è costituita dal doppio album Rapped
Uptight (Sugarhill), che comprende quasi tutti i sound che contano: da
‘Rapper’s Delight’ della Sugarhill Gang e dai contributi di Trouble
Funk, di The Treacherous Three, delle Sequence, tutti eseguiti da
donne, fino a Grandmaster Flash and The Furious Five con ‘The Message’.
Handsworth Revolution dei Steel Pulse è stata prodotta dalla Island. I
Matumbi suonavano il reggae (con The Cimarons) ben prima della comparsa dei gruppi come i Steel Pulse nei tardi anni Settanta. Points of
New (EMI) offre un buon esempio del loro stile musicale. Dennis Bovell dei Matumbi è anche il gran maestro del dub in Gran Bretagna: è
sufficiente ascoltare il suo LP Brain Damage (Fontana). Linton Kwesi
Johnson ha realizzato il suo primo LP Dread, Beat and Blood per la Virgin, mentre Forces of Victory e Bass Culture sono della Island.
Il reggae bianco dei Police è consigliabile nel loro secondo LP Reggatta
De Blanc (A&M). Il revival ska è invece contenuto in The Specials
(Chrysalis), in Too Much Pressure (Chrysalis) dei Selecter e in I Just
Can’t Stop It (Arista) dei Beat. Il dub di Birmingham si può ascoltare in
Signing Off (Graduate) degli UB 40. I Clash sono cresciuti con il reggae
fin dai giorni in cui hanno inciso una canzone di Junior Murvin, ‘Police
and Thieve’, sul loro primo LP. London Calling (CBS), oltre che illustrare il loro uso di trame e ritmi reggae, è probabilmente anche il loro
disco più conosciuto, e insieme con Pretenders (Sire) dei Pretender e
all’antologia dei Jam Dig The New Breed (Polydor) sintetizza molto del
ringiovanimento del pop inglese della fine degli anni Settanta.
I primi vagiti del pub rock possono essere ascoltati in Before the Flood
(RCA) dei Ducks Deluxe. Verso la metà degli anni Settanta, il circuito
fu sconvolto soprattutto per opera del R&B di Dr. Feelgood, Stupidity
(United Artists) e di Eddie and the Hot Rods, Teenage Depression (Island). L’angoscia di strada americana, oltre che da Patti Smith, è ben
descritta da Brute Springsteen in Darkness on thc Edge of Town e in
The River (entrambi CBS), e sfociò più tardi nella bucolica depressione
di Nebraska (CBS).
Di Ian Dury è da ascoltare New Boots and Panties (Stiff). ‘Heat Treatment’ di Graham Parker si trova in Heat Treatment (Vertigo), mentre
‘Discovering Japan’ è in Squeezing Out Sparks (Vertigo). My Aim is
True di Costello è della Stiff, This Year’s Model è della Radar, Get
Happy; Trust e Imperial Bedroom sono della F Beat, una sussidiaria
della CBS. Altro artista da menzionare in questo contesto è Joe Jackson con Look Sharp! (A&M). Nei successivi lavori Jackson è ritornato
al sound R&B di Louis Jordan.
I dischi di Bowie qui menzionati - Young Americans, Station To Station, Low e Heroes - sono prodotti dalla RCA.
A mantenere vivo il punk negli anni Ottanta sono stati gruppi come i
Crass, 4 Stations of The Crass (Crass Records), e i Discharge, Hear
Nothing, See Nothing, Say Nothing (Clay). Una selezione di gruppi
dell’animata scena punk dell’ultima ora, con la partecipazione di The
Exploited, UK Subs, Angelic Upstarts, e altri, si può trovare in Punk
and Disorderly 111 (Gram). Alcune fonti di questa tradizione della
linea dura con la sua miscela punk e skinhead, come l’ultimo LP degli
Oi, Oi! Oi! that’s yer lot (Secret), con una facciata “ubriacà e una
“punk’”, sono già in evidenza su Tell us the Truth (Polydor) degli Sham
69.
L’album dei PIL Metal Box fu stampato in un numero limitato di copie,
per essere poi ristampato con il titolo Second Edition dalla Virgin. L’opera della Gang of Four è reperibile su Solid Gold (EMI). I Theoretical
Girls si sono ormai sciolte, ma un recente esempio di musica “rumorista” newyorkese si può trovare in Ascension (99) di Glenn Branca.
Alcuni elementi della musica elettro-dance avevano precedentemente
fatto patte del sound dei Kraftwerk in Trans Europe Express. A questo
punto si deve anche ricordare il battito elettronico insistente di alcuni
gruppi tedeschi dei primi anni Settanta, come I Tangerine Dream,
Phaedra (Virgin), gli Amori Duul II, Dante of the Lemmings (United
Artists), e i Can. Questi gruppi influenzarono sia le avanguardie postpunk come i PIL, sia la più popolare musica elettro-dance. Gary Numan con The Pleasure Principle (Beggars Banquet), John Foxx con
Metamatic (Virgin), The Human League con Dare (Virgin) e i Duran
Duran con Rio (EMI) hanno tutti movimentato le piste da ballo con sintetizzatori e drum macchine.
La scoperta della musica “juju” potrebbe cominciare con il noto LP di
King Sunny Ade Juju Music (Island) e continuare con Juju Music of
the Eighties (SALPS) sempre di Ade. Per quanto riguarda soca, calypso
e mento giamaicano suggerirei una visita a un negozio specializzato
come Sonny Robett’s Orbitone Records (2 Station Offices, Station
Road, London N.W 10). Lo stesso dicasi per quanto riguarda i ritmi
latini, tra i quali vale la pena di cercare l’LP Latin Roots (Carino).
Music For Airports (Polydor) di Brian Eno è stato il primo di una serie
di dischi appropriatamente intitolata Ambient. Uno dei più recenti è
stato Ambient # 4 On Land (EG Records). Nel tempo intercorso tra
questi due album, Eno ha realizzato altri esperimenti sonori: Music for
Film (Polydor), Before and after Science (Polydor).
Al lato diametralmente opposto dello spettro musicale, la musica più
amara Oi è stata presentata al pubblico in una confezione di quattro dischi dalla casa discografica Secret. The 4 Skins, che hanno avuto una
vasta notorietà dopo aver suonato alla Hambrough Tavern la notte in
cui il locale fu bruciato, hanno inciso un LP con un titolo opportunamente ambiguo, The Good, Tbe Bad & The Four Skins (Secret).
Per concludere con una nota più ottimistica, di sintesi anziché distruttiva, si può ascoltare Michael Jackson in Thriller (CBS), per scoprire
come l’heavy metal si può incrociate con la dance music nera (‘Beat It’),
indistinti sentimenti con voci stupendamente soffocate (‘Billie Jean’), il
tutto ammantato da ambiguità sessuale e da eccitazione fisica (‘Wanna
Be Startin’ Somethin’’).
Riferimenti bibliografici
Barthes R, ‘The Grain of the Voice’, in Image Music-Text London, Fontana, 1977 (trad. it. in R. Barthes, L’ovvio e l’ottuso, Torino, Einaudi,
1975).
Beckett A., ‘Stones’, “New Left Review”, 47, London 1968.
Benjamin W, Das Kunstwerk im Zeitaltes seintr technischen
Reprnduzíerbarkeit, Frankfurt, Suhrltamp Verlag, 1955 (trad. it. L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducíbilitd tecnica, Torino, Einaudi,
1966).
Bird B., Skiffle, London, Hale,1958.
Birmingham Feminist History Group, Feminism and Femininity in the
Nineteen-Fifties, “Feminist Review”, 3, London 1979.
Abrams M., The Teenage Consumer, London, London Press Exchange,
1959.
Attali J., Bruits, Paris, Presses Universitaires de Frante, 1977 (trad. it.
Rumori, Milano, Mazzotta, 1978).
Barnes R., Coronation Cups and Jam Jars, London, Ceriterprise Publications, 1976.
Barnes R, Mods, London, Eel Pie, 1979.
Barthes R, L’empire de signes, Genève, Skira, 1970 (trad. it. L’impero
dei segni, Torino, Einaudi, 1984).
Barthes R, Mythologies, Paris, Seuil, 1973 (trad. it. Miti d ‘oggi, Torino,
Einaudi, 1974).
Black M., Coward R, ‘Linguistic, Social and Sexual Relations. A Review
of Dale Spender’s Man-Made Language’, “Screen Education”, 39, London 1981.
Booker C., The Neophiliacs, London, Fontana, 1970.
Brooks R, Everything You Want... and a Little Bit More, “ZG”, 7, London 1982.
Burchill J., Parsons T, The Boy Looked at Johnny, in The Obituary of
Rock and Roll London, Pluto, 1978.
Burroughs W .S., The Wild Boys, London, Corgi, 1973 (trad. it. Ragazzi
selvaggi, Milano, Sugarco, 1979).
Cardiff D., Scannell E, ‘Radio in World War II’, Unit 8 of the Open University Popular Culture Course, U203, Milton Keynes, The Open University Press, 1981.
Cashmore E., Rastaman, London, Allen & Unwin, 1979.
Chambers I, ‘Some Critical Tracks’, “Popular Music”, Cambridge Universiry Press, 1982.
Chester A., ‘Second Thoughts on a Rock Aesthetic: The Band’, “New
Left Review”, 62, London 1970.
Christgau R., Any Old Way You Choose It, Baltimore, Penguin, 1973.
Clarke S., Jah Music, London, Heinemann, 1980.
Dyer R., ‘In Defence of Disco’, “Gay Left”, 8, London 1979b.
Eisen J., The Age of Rock, New York, Vintage Books, 1969.
Ewen S., ‘Charlie Manson and tbe Family’, “Working Paper in Cultural
Studies”, 3, Birmingham, Centre for Contemporary Cultural Studies,
1972.
Cohen S., Folk Devils and Moral panics, London, Paladin, 1973.
Cohn N., AwopBopaLooBopAlopBamBoom, London, Paladin, 1970.
Cowie C., Lees S., ‘Slages or Drags’, “Feminist Review”, 9, London
1981.
Cummings T, The Northern Discos, in C. Gillett, S. Frith (eds.), Rock
File 3, London, Panther, 1975a.
Cummings T., ‘Northern Soul’, “Black Music”, London, November
19756.
Cunningham H., Leisure in the Industrial Revolusion, London, Croom
Helm, 1980.
Daufouy P, Sarton J.P, Pop music/rock, Paris, Editions Champ Libre,
1972.
Davis S., Simon E, Reggae Bloodlines, New York, Anchor-Doubleday,
1979.
Fekete J., The Criticai Twilight, London, Routledge & Kegan Paul,
1977.
Fiedler L., The Return of the Vanishing American, London, Paladin,
1972.
Frith S., The Sociohgy of Rock, London, Constable, 1978 (trad. it. La
sociologia del rock, Milano, Feltrinelli, 1982).
Frith S., ‘The Magic That Can Set You Free: The Ideology of Folk and
tbc Myth of the Rock Community’, “Popular Music”, 1, Cambridge,
Cambridge University Press, 1981.
Gamble A., The Conservative Nation, London, Routledge & Kegan
Paul, 1974.
Gayle C., ‘Reggae: Soul of Jamaica’, in The Story of Pop, Leeds, Phoebus Publications, 1973.
Debord G., La societé du spectacle, Paris 1968 (trad. it. La società dello
spettacolo, Firenze, Vallecchi, 1980).
Gilroy P, ‘Steppin’ out of Babyhn-Race, Class and Autonomy’, in P Gilroy, E. Lawrence, H. Carby et al., The Empire Strikes Back. Race and
Racúm in 70s Britain, London, Hutchinson, 1982.
Dyer R, Stars, London, British Film Institore, 1979a.
Goldmann A., Elvis, Harmondsworth, Penguin, 1982.
Graham D., ‘The End of Liberalism’, “ZG”, 2, London 1981.
Green A., ‘On the Political Economy of Black Lahour and the Racial
Structuring of the Working Class in England’, Stencilled Occasionai
Paper”, 62, Birmingham, Centre for Contemporary Cultural Studies,
1979.
Grey C., Leaving the 20th Century, London, Free Fall Pubblications,
1974.
Guralnick P, Feel Like Going Home, London, Omnibus Press, 1978.
Hall S., ‘The Hippies: An American Moment’, in J. Nagel (ed.), Student
power, London, Merlin, 1969.
Hall S., ‘The Great Moving Right Show’, “Marxism Today”, London,
January, 1979.
Hall S., Whannell P, The Popolar Arts, London, Hutchinson, 1964
(trad. it. Le arti popolari, Roma, Officina Ed.,1973).
Hebdige D., Subculture: Tbc Meaning of Style, London, Methuen,
1979 (trad. it. Sottocultura. Il fascino di uno stile innaturale, Genova,
Costa & Nolan, 1983).
Hebdige D., ‘Towards a Cartography of Taste, 1935-62,’ “Block”, 4, Middlesex Polytechnic, 1981 (ristampato in versione ridotta in WaitesBennett-Martin 1982).
Hebdige D., ‘This is England And They Don’t Live Here’, in Knight
1982.
Hoare L, ‘Mighty Mighty Spade and Whitey: Soul Lyrics and BlackWhite Crosscurrents’, in I. Hoare, C. Anderson, T Cummings, S. Frith,
The Soul Book, London, Methuen, 1975.
Hoggart R, The Uses of Literacy, Harmondsworth, Penguin, 1958
(trad. it. Proletariato e industria culturale, Roma, Officina, 1970).
Hoskyins B., ‘As Years Go By’, “New Musical Express”, 9, London, January 1982.
Hall S., Jefferson T, (eds.), Resistance Through Rituals, London,
Hutchinson, 1976.
Jackson B., Working Class Community, London, Routledge & Kegan
Paul, 1968.
Hall S., Critcher C., Jefferson T., Clarke J., Roberts B., Policing the Crisis, London, Macmillan, 1978.
Jasper T, British Record Charts 1955-1979, London, MacdonaldFutura, 1978.
Hamblett C., Deverson J., Generation X, London, Tandem, 1964.
Jenkins D., Black Zion: the Return of Afro Amerícans and West Indians to Africa, London, Wildwood, 1975.
Haralambos M., Right On: From Blues to Soul in Black America, London, Eddison, 1974.
Hebdige D., ‘The Meaníng of Mod’ in Hall-Jefferson 1976.
Johnson H., Pines J., Reggae Deep Root Music, New York-London,
Proteus, 1982.
Johnson L.K., Dread Beat and Blood, London, Bogle-I:Ouverture,
1975.
Kerouac J., On the Road, London, Deutsch, 1958 (trad. it. Sulla strada,
Milano, Mondadori, 1959).
MacInnes C., England, Half English, London, MacGibbon & Kee, 1961.
MacInnes C., Sweet Saturday Night, London, Panther, 1969.
Knight N., Skinhead, London, Omnibus Press, 1982.
McRobbie A., ‘Jackie: An Ideology of Adolescent Femininity’, “Stencilled Occasional Paper”, 53, Birmingham, Centre for Contemporary
Cultural Studies, 1978a.
Laing.D., The Sound of Our Time, London, Sheed & Ward, 1969.
McRobbie A., ‘Working Class Girls and the Culture of Femininity’, in
Women’s Study Group, Women Take Issue, London, Hutchinson,
1978b.
Lefebvre H., Critique de la vie quotidienne, 2. Fondemenn d une sociologie de la quotídiennité, Paris, (Arche Editeur, 1961 (trad. it. Critica
della vita quotidiana, Bari, Dedalo, 1977).
Lefebvre H., The Explosion, New York-London, Monthly Review Press,
1969.
Lyotard J-F, La condition postmtoderne, Paris, Editions de Minuit,
1979 (trad. it. La condizione postmoderna, Milano, Feltrinelli, 1981).
Mabey R., The Pop Process, London, Hutchinson, 1969.
Malone B., Country Music Usa, Austin, University of Texas Press,
1969.
McRobbie A., ‘Settling Accounts with Subcultures’, “Screen Education”, 34, London 1980.
McRobbie A., Gerber J., ‘Girls and Subcultures’, in Hall-Jefferson 1976.
McRobbie A., Frith S., ‘Rock and Sexuality’, “Screen Education”, 29,
London 1978.
Meller H.E., Leisure and the Changing City, London, Routledge & Kegan Paul; 1976.
Mellers W , Twilight of Gods, London, Faber & Faber, 1976.
Melly G., Owning-up, Harmondsworth, Penguin, 1970.
Marcus G., Mystery Train, London, Omnibus Press, 1977.
Melly G., Revolt into Style, Hardmondsworth, Penguin, 1972.
Marcuse H., An Essay on Liberation, Harmondsworth, Penguin, 1972
(trad. fit. Saggio sulla liberazione, Torino, Einaudi, 1974).
Merton R., ‘Comment’, “New Left Review”, 47, London 1968.
McArthur C., Underworld USA, London, Secker & Warburg, 1972.
McGlashan C., ‘The Sound System’, “Sunday Times Colour Magazine”,
London, 4 February 1973.
MacInnes C., Absolute Beginners, London, MacGibbon & Kee, 1959.
Middleton R., Pop Music and the Blues, London, Gollancz, 1972.
Middleton R., ‘All Shook Up’, in J.L. Tharpe (ed.), Elvis: Image and
Fantasy, Jackson, Universiry Press of Mississippi, 1980.
Miles J., ‘Terrorism in Disneyland’, “ZG”, 2, London 1981.
Millar B., The Drifters, London, Studio Vista, 1971.
Mitchell J., Woman’s Estate, Harmondsworth, Penguin, 1971.
Palmer T., All You Need Is Love, London, Future, 1977.
Morin E., L’ésprit du temps, Paris, Grasset, 1962 (trad. it. L’industria
culturale, Bologna, Il Mulino, 1963).
Pryce K., Endless Pressure, Harmondsworth, Penguin, 1979.
Morse D., Motown, London, Studio Vista, 1971.
Mulvey L., ‘Visual Pleasure and Narrative Cinema’, “Screen”, 16/3, London 1975.
Mungham G., ‘Youth in Pursuit of Itself’, in Mungham-Pearson 1976.
Mungham G., Pearson G. (eds.), Working Class Youth Culture, London, Routledge & Kegan Paul, 1976.
Nairn T., ‘The Future of Britain’s Crisis’; “New Left Review”, 113-114,
London 1979.
Nairn T., The Break-up of Britain, London, Verso/NLB, 1981.
Nettleford N., Identity, Race and Protest in Jamaica, New York, Morrow, 1972.
Neville R., Playpower, London, Paladin, 1971.
Nuttall J., Bomb Culture, London, Paladin, 1970.
Quattrocchi A., Nairn T, The Beginning of the End, London, Panther,
1968.
Robins D., Cohen P, Knuckle Sandwich, Harmondsworth, Penguin,
1978.
Russell J., Gablik S., Pop Art Redefined, London, Thames & Hudson,
1969.
Savage J., ‘Is This The End?’, “ZG”, 8, London 1982.
Scannell P, Cardiff D., ‘Serving the Nation: Public Service Broadcasting
Before the War’, in Waites-Bennett-Martin 1982.
Shepherd J. et al., Whose Music, London, Latimer, 1977.
Stedman-Jones G., ‘Working Class Culture and Working Class Politics
in London, 1870-1900: Notes on the Remaking of a Workíng Class’,
“Journal of Social History”, VII, 4, 1974 (ripubblicato in una versione riveduta in Waites-Bennett-Martin 1982).
Orwell G., Collected Essays, vol. II, 1940-43, Harmondsworth, Penguin, 1970.
Taylor J., Wall D., ‘Beyond the Skinheads’, in Mungham-Pearson 1976.
Paddison M., ‘The Critique Criticised: Adorno and Popular Music’,
“Popular Music”, 2, Cambridge, Cambridge University Press, 1982.
Taylor J., Laing D., ‘Disco-Pleasure-Discourse’, “Screen Education’, 31,
London 1979.
Thelwell M., The Harder They Come, London, Pluto, 1980.
Thompson H.S., The Great Shark Hunt, London, Picador, 1980.
Vulliamy G., Lee E., Popular Music. A Teacher’s Guide, London, Routledge & Kegan Paul, 1982.
Waites B., ‘The Music Hal’l, Unit 5 of the Open Universiry Popular Culture Course, U203, Milton Keynes, The Open Universiry Press, 1981.
Waites B., Bennett T, Martin G. (eds.), Popular Culture: Past and Present, London, Croom Helm, 1982..
Wale M., Vox Pop, London, Harrap, 1972.
Weeks J., Sex, Politics and Society, London, Longman, 1982.
Wheen E, The Sixties, London, Century, 1982.
Williams R., Culture and Society 1780-1950, Harmondworth, Penguin,
1963 (trad. it. Cultura e rivoluzione industriale, Torino, Einaudi,
1968).
Willis P, Learning To Labour, Farnborough, Saxon House, 1977.
Willis P, Profane Culture, London, Routledge & Kegan Paul, 1978.
Winship J., ‘Sexuality For Sale’, in S. Hall, D. Hobson, A. Lowe, P Willis (eds.), Culture, Media, Language, London, Hutchinson, 1980.
Winship J., ‘Woman Becomes an Individuale - Femininity and Consumption in Women’s Magazines, 1954-69’, “Stencilied Occasional Paper”, 65, Birmingham, Centre for Contemporary Cultural Studies, 1981.
Wolfe T, The Electric Kool-Aid Acid Test, New York, Bantam, 1969.
Wolfe T, The Pump House Gang, New York, Bantam, 1972.
Wolfe T, The Painted Word, New York, Bantam, 1976.
Wolfe T, Wolfe in Chic Clothing,,”New Musical Express”, 6, London,
February 1982.
Wollen P, Readings and Writings, London, Verso/NLB, 1982.
York P, Style Wars, London, Sidgwick & Jackson, 1980.