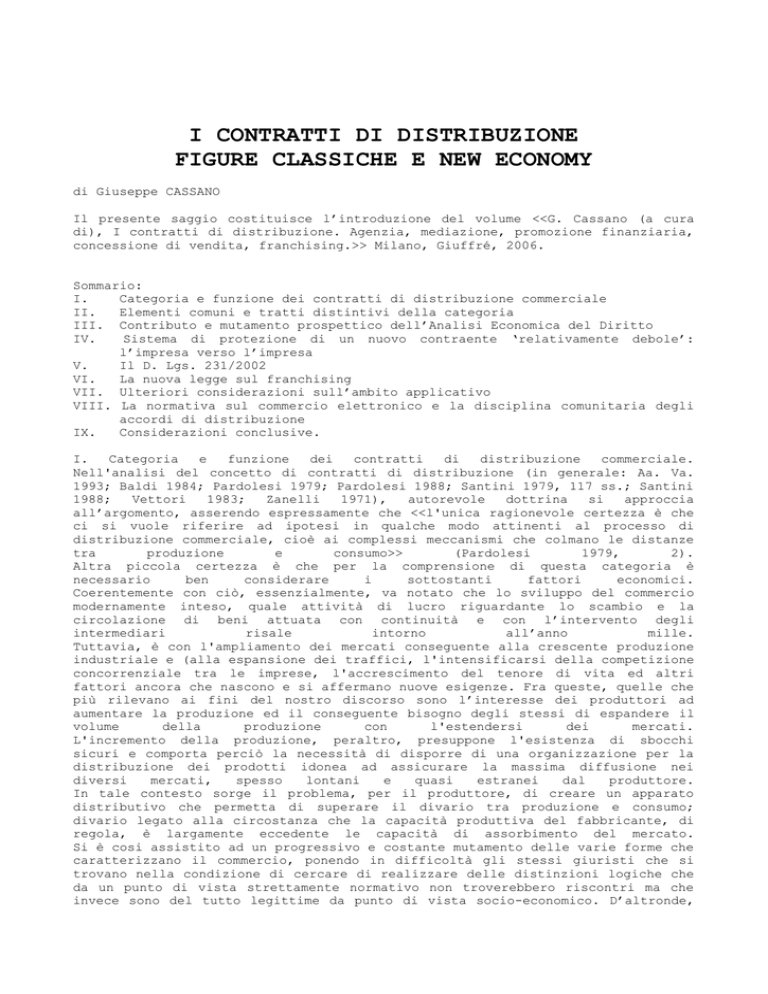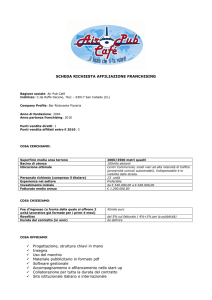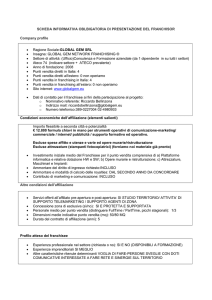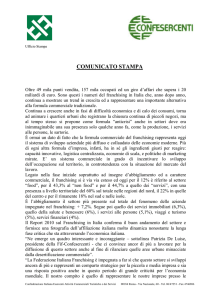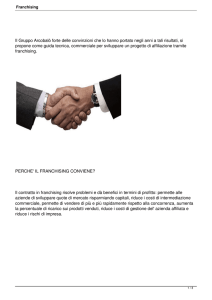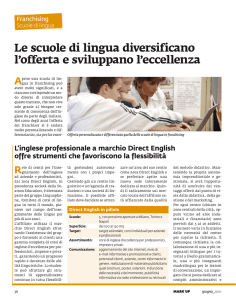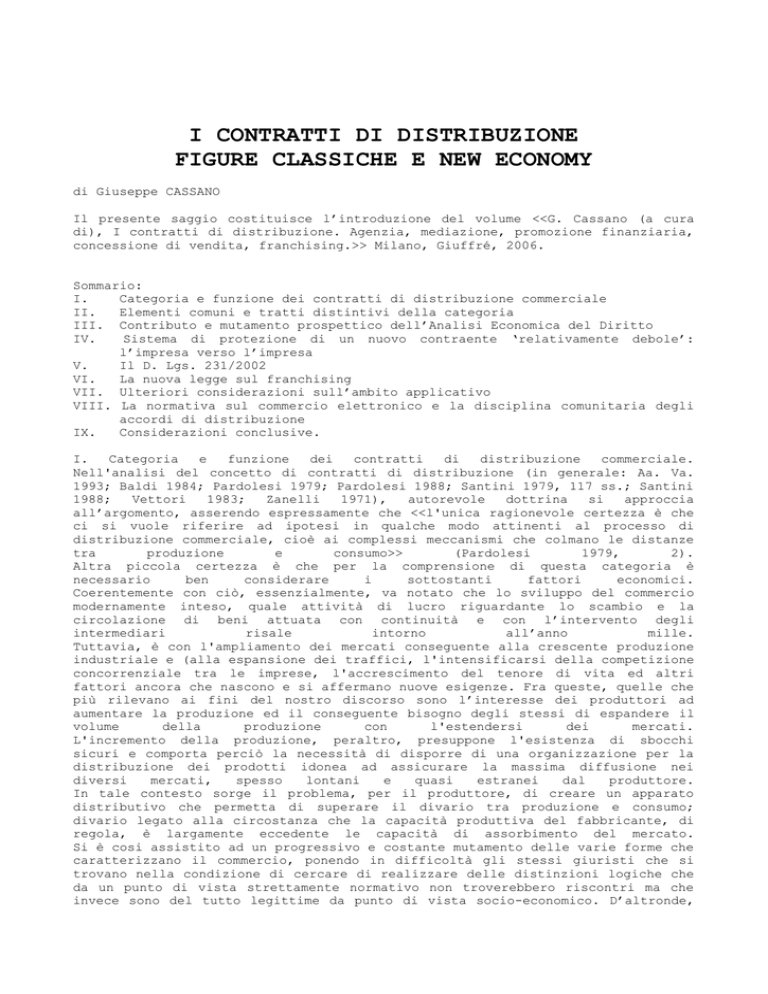
I CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE
FIGURE CLASSICHE E NEW ECONOMY
di Giuseppe CASSANO
Il presente saggio costituisce l’introduzione del volume <<G. Cassano (a cura
di), I contratti di distribuzione. Agenzia, mediazione, promozione finanziaria,
concessione di vendita, franchising.>> Milano, Giuffré, 2006.
Sommario:
I.
Categoria e funzione dei contratti di distribuzione commerciale
II.
Elementi comuni e tratti distintivi della categoria
III. Contributo e mutamento prospettico dell’Analisi Economica del Diritto
IV.
Sistema di protezione di un nuovo contraente ‘relativamente debole’:
l’impresa verso l’impresa
V.
Il D. Lgs. 231/2002
VI.
La nuova legge sul franchising
VII. Ulteriori considerazioni sull’ambito applicativo
VIII. La normativa sul commercio elettronico e la disciplina comunitaria degli
accordi di distribuzione
IX.
Considerazioni conclusive.
I.
Categoria
e
funzione
dei
contratti
di
distribuzione
commerciale.
Nell'analisi del concetto di contratti di distribuzione (in generale: Aa. Va.
1993; Baldi 1984; Pardolesi 1979; Pardolesi 1988; Santini 1979, 117 ss.; Santini
1988;
Vettori
1983;
Zanelli
1971),
autorevole
dottrina
si
approccia
all’argomento, asserendo espressamente che <<l'unica ragionevole certezza è che
ci si vuole riferire ad ipotesi in qualche modo attinenti al processo di
distribuzione commerciale, cioè ai complessi meccanismi che colmano le distanze
tra
produzione
e
consumo>>
(Pardolesi
1979,
2).
Altra piccola certezza è che per la comprensione di questa categoria è
necessario
ben
considerare
i
sottostanti
fattori
economici.
Coerentemente con ciò, essenzialmente, va notato che lo sviluppo del commercio
modernamente inteso, quale attività di lucro riguardante lo scambio e la
circolazione di beni attuata con continuità e con l’intervento degli
intermediari
risale
intorno
all’anno
mille.
Tuttavia, è con l'ampliamento dei mercati conseguente alla crescente produzione
industriale e (alla espansione dei traffici, l'intensificarsi della competizione
concorrenziale tra le imprese, l'accrescimento del tenore di vita ed altri
fattori ancora che nascono e si affermano nuove esigenze. Fra queste, quelle che
più rilevano ai fini del nostro discorso sono l’interesse dei produttori ad
aumentare la produzione ed il conseguente bisogno degli stessi di espandere il
volume
della
produzione
con
l'estendersi
dei
mercati.
L'incremento della produzione, peraltro, presuppone l'esistenza di sbocchi
sicuri e comporta perciò la necessità di disporre di una organizzazione per la
distribuzione dei prodotti idonea ad assicurare la massima diffusione nei
diversi
mercati,
spesso
lontani
e
quasi
estranei
dal
produttore.
In tale contesto sorge il problema, per il produttore, di creare un apparato
distributivo che permetta di superare il divario tra produzione e consumo;
divario legato alla circostanza che la capacità produttiva del fabbricante, di
regola, è largamente eccedente le capacità di assorbimento del mercato.
Si è cosi assistito ad un progressivo e costante mutamento delle varie forme che
caratterizzano il commercio, ponendo in difficoltà gli stessi giuristi che si
trovano nella condizione di cercare di realizzare delle distinzioni logiche che
da un punto di vista strettamente normativo non troverebbero riscontri ma che
invece sono del tutto legittime da punto di vista socio-economico. D’altronde,
lo scopo del diritto è regolare i rapporti all’interno della società cercandosi
di adeguarsi alle mutevoli esigenze espresse dalla stessa.
Attualmente, con lo sviluppo di sempre nuove forme di manifestazione
dell’autonomia privata assieme all’evolversi e al variegarsi delle modalità di
realizzazione degli scambi, viene messa in crisi l’unitarietà e l’organicità
della fattispecie della vendita, accanto alla quale si creano nuove categorie,
tra
queste
quella
dei
contratti
di
distribuzione.
Si è avuto anche un mutamento radicale nelle modalità di organizzazione
strutturale del processo di distribuzione, in quanto in base a delle semplici
considerazioni economiche, la produzione di un bene e la prestazione di un
servizio sono giustificati solo in quanto vige la legge della domanda, anche se
potenziale, di quel bene e di quel servizio, che a sua volta da senso
all’attività produttiva. Di conseguenza, per ogni impresa produttrice la fase di
distribuzione diventa l’oggetto principale di studio approfondimento volto al
miglioramento della stessa in quanto rappresenta il canale principale per
aumentare la redditività dell’impresa.
Altresì, al contempo, va rilevato un importante mutamento strutturale
all’interno della categoria dei rapporti di distribuzione: <<Con l'evolversi
delle tecniche di marketing e delle prassi contrattuali, tuttavia, il centro di
gravita delle figure in discorso è venuto progressivamente a spostarsi dal patto
di esclusiva di (ri)vendita (che ha perso sempre più il connotato di elemento
essenziale del rapporto tra produttore e distributore, per divenire una
pattuizione eventuale ed accessoria) alla clausola che pone a carico di
quest'ultimo non solo l'impegno di acquistare le merci ma anche di promuoverne
la commercializzazione secondo modalità stabilite dal produttore; clausola che
ha finito col diventare - come meglio vedremo più avanti - il vero tratto
fisionomico
di
questi
contratti>>
(Luminoso
1995,
257).
Secondo un schema tendenzialmente riduttivo (Bacchini 1999, XI), due sono le
principali forme di organizzazione per la distribuzione di un bene e di un
servizio.
Da una parte, nella c.d. distribuzione diretta, la merce passa dalle mani del
suo produttore direttamente nella mani del consumatore finale e il produttore
realizza un’integrazione di tipo verticale tramite la quale può curare
direttamente tutte le fasi attinenti alla messa in commercio di quel prodotto,
avvalendosi di soggetti appartenenti alla stessa struttura e come tali
configurabili come lavoratori dipendenti; ciò permette al produttore di avere il
potere decisionale e di controllo sull’attività dei suoi sottoposti addetti alle
varie fasi dalla commercializzazione.
In dottrina, si è precisato che questo tipo di distribuzione è diretta sia
perché la vendita si attua direttamente nella sede dell'impresa, sia perché
l'impresa stessa assume su di se tutte le funzioni attinenti alla messa in
commercio
del
prodotto
(Bacchini
XI,
1999).
Invece, nella distribuzione indiretta, che si realizza quando il produttore
concentra ogni suo sforzo e attenzione sull’efficienza e funzionalità
dell’attività di produzione rinunciando alla costituzione di una propria
organizzazione distributiva, avvalendosi di una catena di operatori commerciali
giuridicamente autonomi, che operano su diversi livelli, esemplificati dalle
figure del grossista e del dettagliante.
Viene a realizzarsi una sorta di integrazione verticale pattizia che si basa
sugli
accordi
e
contratti
posti
in
essere
dalle
parti
interessate.
La recente dottrina ha osservato che il produttore però, si è costruito una
terza via, né diretta, né indiretta, all’interno del tradizionale contesto
contrattuale distributivo che va sotto il nome di distribuzione <<coordinata>>
in base alla quale è possibile coordinare le fasi di produzione e distribuzione
attraverso la stipulazioni di una variegata gamma di contratti, fra operatori
formalmente indipendenti, che saltano i vari stadi della commercializzazione.
Fra la distribuzione indiretta e la distribuzione diretta è possibile, quindi,
<<concepire tutta una sfumata gamma di pattuizioni che permettono, in qualche
misura, di coordinare la fase produttiva con quella distributiva, senza per
questo elidere l'autonomia dei partners; si arriva cioè a definire, in negativo
un'area contrassegnata dall'integrazione verticale convenzionale>> (Pardolesi
1988, 1-2).
ovvero dall'integrazione, formalizzata con specifico strumento negoziale, a
causa della consentita ingerenza del produttore sul distributore coordinato,
soggetti
distinti
operanti
a
diversi
livelli
di
mercato.
In questo senso, infatti, il fenomeno della segmentazione del processo
produttivo, altrimenti detto <<outsourcing>> attuato mediante la cooperazione
fra imprese diverse, non e assicurato necessariamente da un contratto di
scambio, ma può costituirsi anche sulla base di contratti di collaborazione più
o meno stretta, senza che sia pregiudicata la reciproca autonomia dei soggetti.
Oggi si impongono all’evidenza le nuove tecnologie informatiche e telematiche e
le nuove tecniche di organizzazione, sicché, in concreto, risultano possibili
svariate forme di coordinamento.
Perciò, l’interazione tra i fattori produttivi può essere perseguita con una
gamma di strumenti diversi, potendo, ad esempio, costituire integrazione
produttiva fra più distinte imprese, il medesimo marchio, know-how, o modello
industriale, come per la concessione di vendita o per il franchising.
Così, nella c.d. <<impresa di rete>>, vengono esternalizzate le varie fasi del
processo produttivo, prima unitario, ciò comportando lo scorporamento della
stessa struttura imprenditoriale. Si pensi all’autonomizzazione <<del servizio
di riscossione dei crediti mediante il contratto di factoring, del servizio di
marketing, del servizio di revisione e verifica del bilancio mediante il
contratto di auditing, del servizio di progettazione mediante il contratto di
engineering, del servizio di magazzino, del servizio di selezione del personale
o, nel nostro caso di studio, della rete di vendita mediante, contratti di
integrazione distributiva autonoma come il contratto di franchising, fino ad
arrivare,
con
il
contratto
di
subfornitura>>
(Bacchini
1999,
XIII).
Soprattutto, va evidenziato che il produttore, con la distribuzione coordinata,
si garantisce uno sbocco fisso per la sua produzione ed una migliore
programmazione
delle
vendite
e
delle
altre
attività
di
marketing
Tali contratti possono andare da quello di semplice scambio a quello di
collaborazione più o mena stretta, ma tale però da non ledere l’autonomia delle
parti, in larga parte non suscettibili di essere ricondotti ai modelli
tradizionali di rapporto gerarchico e transazione.
Ne consegue che nell’equilibrio sinallagmatico del negozio assumono posizione
centrale quelle particolari clausole caratterizzanti lo stesso, che prevedono
per il concessionario degli oneri di commercializzazione di contro ad una
posizione di privilegio nella rete distributiva che gli garantisce una parte di
potere di mercato del concedente (Pardolesi 1988, 3). Siffatta ricostruzione
trova conferma nella più recente giurisprudenza di legittimità. La Suprema
Corte, infatti, riconosce che <<la parziale dismissione della propria autonomia
imprenditoriale da parte del concessionario, viene operata in corrispettivo di
una posizione di privilegio nel mercato accordatagli dal concedente, che
consiste tra l’altro nella licenza d’uso del marchio della stessa concedente,
marchio che solitamente è caratterizzato da particolare prestigio sociale>>
(Cass. 22.2.99, n. 1469, Lex - Giur. Mass. 2003).
L’emersione di questi profili ha confermato le elaborazioni della dottrina che è
giunta a creare la categoria dei contratti di distribuzione, cioè, quei rapporti
commerciali che con i quali intermediari professionisti collaborano in forma
stabile e continuativa con l’industriale costituendo l’anello di congiunzione
tra produttore e consumatore. (Baldi 1998, 963).
Tale classificazione ricomprende l’ampia gamma delle forme di distribuzione
indiretta dei beni accomunati però <<dalla stabilità e continuità (…) si
determina quella ripetizione continua di prestazioni e obbligazioni che è tipica
appunto della categoria in questione>> (App. Bologna 3.5.93, n. 668, LexGiur.Mass. 2003).
Si aggiunge (Baldassarri 1995, 1999) che per tali contratti, caratterizzati
dalla stabilità e continuità delle relazioni, debba prevedersi l’obbligo
dell’esercizio dell’attività di promozione delle vendite da parte del
distributore. Ma la stessa dottrina si è trovata in difficoltà circa la natura
giuridica di questi contratti, giungendo ad una nuova elaborazione che porta
alla distinzione tra contratti di distribuzione e contratti in materia di
distribuzione.
Per i contratti di distribuzione soccorre la definizione fornitaci da Pardolesi:
<<Sono quei contratti quadro in forza dei quali un operatore economico assume,
verso contropartita consistente nelle opportunità di guadagno che si legano alla
commercializzazione delle merci contrattuali, l’obbligo di promuovere la
rivendita dei prodotti forniti dalla controparte; obbligo il cui adempimento
postula la stipulazione di singoli contratti per l’acquisto, a condizioni
predeterminate, dei prodotti da rivendere>> (Pardolesi 1979, 297).
I contratti in materia di distribuzione, nei quali troviamo l’agenzia, la
commissione e la mediazione o il franchising recentemente positivizzato dalla
legge 129 del 2004, pur avendo come oggetto la commercializzazione dei prodotti,
non comportano l’integrazione tra i soggetti che si assumono in proprio i
relativi rischi.
Basta mettere a confronto l’agente e il distributore. Nel primo caso ci troviamo
in una situazione in cui il soggetto è legato alla ditta mandante da un rapporto
di dipendenza e non si assume nessun rischio; nel secondo caso troviamo lo
stesso un rapporto di dipendenza ma il distributore assume su di se tutti i
rischi connessi all’attività. Manifestando in tal modo un’autonomia giuridica ed
economica che invece manca all’agente.
In giurisprudenza interessante è la definizione fornitaci dal Tribunale di
Catania, secondo il quale <<Il contratto di distribuzione non sarebbe una nuova
figura contrattuale ma piuttosto un genus sotto il quale andrebbero riunite le
fattispecie negoziali attinenti in qualche modo al processo di distribuzione
commerciale, cioè ai complessi meccanismi che colmano la distanza tra produzione
e consumo>> (Trib. Catania 29.2.88, NGCC,1989, I,14 ).
II. Elementi comuni e tratti distintivi della categoria.
In via di approssimazione, possiamo quindi giungere alla conclusione che sotto
il nome di distribuzione commerciale, generalmente intesa, possono essere fatti
rientrare tutta una serie di attività che, a diverso titolo, contribuiscono a
creare una relazione diretta tra la produzione di un bene e la sua fase finale,
cioè
quando
viene
acquistato
dal
consumatore,
contribuendo
a
rendere
realizzabili
gli
obiettivi
dei
produttori
e
dei
consumatori.
Quindi, sono sussumibili alla categoria di contratti di distribuzione
commerciale tutti gli accordi che hanno come oggetto il coordinamento e
l’intermediazione economica, mediante le quali viene soddisfatta l’esigenza
delle imprese di non disinteressarsi della commercializzazione dei propri
prodotti, pur senza sopportarne costi e rischi.
Questi accordi che si traducono in una serie di schemi contrattuali consentono
al produttore di poter realizzare sia una penetrante ingerenza nella sfera
decisionale dei propri rivenditori ed un coordinamento unitario della rete
distributiva, configurando quindi la totale subordinazione di questi e sia che
tale ingerenza sia ridotta al minimo.
Da un’indagine superficiale si capisce subito che non è chiaro il senso e il
relativo peso da attribuire a tali forme contrattuali.
Una parte della dottrina ha cercato di creare una categoria giuridica, potremmo
dire, non unica, ma comunque unitaria, pensando di individuare dei tratti comuni
che caratterizzano i diversi e i variegati assetti negoziali (ex pluribus,
Pardolesi 1988, 5 ss.), per altri Autori, invece, le differenziazioni tra le
figure viste siano tali da non consentire una reductio ad unitatem (Santini
1988, 2).
Le
caratteristiche
costanti
sono
rinvenibili:
a) nell’agire dell’intermediario in proprio nome e per proprio conto;
b)
nell’obbligo
di
promuovere
la
vendita
dei
prodotti;
c)
nella
continuità
e
stabilità
nel
tempo
del
rapporto;
d)
nella
tendenziale
dipendenza
economica
del
distributore.
In base ad una seconda impostazione, invece, il termine contratto di
distribuzione è configurato alla stregua di una etichetta da attaccare alle
diverse ipotesi che in qualche modo sono attinenti al processo di distribuzione
commerciale, cioè ai complessi meccanismi che vanno a colmare le distanze tra
produzione e consumo (Pardolesi 1979, 2).
Sotto tale configurazione, possono essere fatte rientrare ipotesi in cui
l’intermediario assume su di sè il rischio della commercializzazione dei
prodotti ed ipotesi in cui invece lo stesso prospetta il mercato per conto
altrui.
L’uso disinvolto di tali etichette potrebbe far pensare ad una nitidezza di
distinzioni, cosa che invece non si realizza in quanto molteplici clausole
possono divenire obbligo nascente dal contratto a carico di entrambi le parti.
Come ben sappiamo, i soggetti, in attuazione del fondamentale principio
dell’autonomia privata ex art. 1372 c.c., sono liberi di determinare il
contenuto dei contratti ed anche di elaborare schemi negoziali atipici, purché
finalizzati a perseguire interessi meritevoli di interessi, e conseguentemente,
ci troviamo di fronte ad una miriade di sottogruppi della categoria dei
contratti di distribuzione.
Naturalmente, vi sono degli obblighi che nella prassi commerciale si ripetono
con una certa frequenza. Innanzitutto la necessità di attuare un’efficace
coordinazione tra la fase di produzione e quella di commercializzazione porta ad
uno scambio continuo e sistematico tra le parti di informazioni che risultano
determinanti per ben coordinare e programmare la distribuzione del prodotto.
Inoltre, possono essere fissati nel momento della collaborazione delle parti
ulteriori obblighi gravanti sull’attività di rivendita e condizionanti, in via
direttamente proporzionale alla loro intensità, il grado di integrazione.
I benefici connessi all’integrazione sono diversi. Anzitutto, essa riduce i
costi di esercizio commerciale a carico del concessionario, dato che lo stretto
rapporto
di
collaborazione
con
il
concedente
permette
una
migliore
programmazione della rotazione delle scorte, limitando, al contempo, il rischio
di incorrere nell’invenduto. Inoltre, il concessionario beneficia del ritorno di
immagine derivatagli dalla sua appartenenza alla catena di distribuzione e ha
diritto di utilizzare i segni distintivi del concedente, beneficiando della
forza attrattiva del marchio.
Tale posizione di privilegio del distributore è rinvenibile anche in una
sentenza
di
Cassazione
che
esprime
l’orientamento
giurisprudenziale
predominante: <<È connaturato con le caratteristiche proprie della concessione
di vendita, che rientra nel novero delle figure contrattuali di distribuzione
commerciale, l’obbligo per il concedente (…) di non pregiudicare il prestigio
del proprio marchio al fine di evitare che il concessionario possa subire danni
economici>>. (Cass. 22.2.99, n. 1469, Lex - Giur.Mass. 2003).
Ma può anche realizzarsi un più alto grado di integrazione che si traduce per il
distributore in un diritto di esclusiva per la distribuzione dei beni in una
determinata zona territoriale, costringendo il concedente a rifornire unicamente
il distributore organizzato ma in cambio gli può essere inibito il commercio di
prodotti concorrenti o possono essere poste in essere dal concedente altre
misure fortemente limitative dell’autonomia privata del concessionario. Abbiamo
anche accennato alla possibilità per l’intermediario di rapportarsi al mercato
per conto del produttore, in questo caso spetterà al distributore alla fine del
rapporto un compenso o un’indennità per la clientela che è riuscito a creare a
favore del produttore ma anche per quella che ha perduto per risoluzione del
contratto da parte di quest’ultima, unitamente al rimborso per gli oneri e i
danni che ha subito nel corso della sua attività. Secondo tale visione
dottrinale, rientrano nella categoria dei contratti di distribuzione figure
classiche come l’agenzia, la mediazione, la concessione di vendita ma anche il
franchising (Baldassarri 1995, 1999) ed anche altre figure contrattuali
caratterizzate dal fatto che si occupano di accompagnare il prodotto verso il
consumatore finale.
Così, emerge anche qui la diffusa realtà dei <<distributori integrati>>, che
hanno contrattualmente alienato una frazione del proprio potere decisionale
rispetto alle modalità di gestione dell'impresa (Pardolesi 1990, 66 ss.), ma
che, al contempo, dall'altro, ricevono, per così dire “in cambio”, dal
produttore <<opportunità di guadagno sufficienti a compensare gli svantaggi che
derivano dalla rinunzia ad una piena indipendenza gestionale>> (Pardolesi 1990,
66-67).
In tal modo,a nulla rilevando il contratto e il nome che l'intermediario può
assumere (esclusivista, rivenditore autorizzato, concessionario, franchisee),il
produttore allontana da sé ì rischi della vendita diretta addossandoli al
distributore, al quale offre, quale allettante contropartita, una <<posizione
privilegiata>>, pur variabile, nel mercato (Luminoso 1995, 258).
III. Contributo e mutamento prospettico dell’Analisi Economica del Diritto.
Tale discorso va necessariamente traslato in termini di analisi economica del
diritto (Analisi Economica del Diritto - fra le maggiori opere in materia:
Pareto 1906, 579; Cheung 1969, 23 ss.; Bessone 1972, 882; Baker 1975; Crawford
1988, 485 ss.; Posner 1988; Wiggins 1990), e, in tale prospettiva, per quanto
già si è detto riguardo a caratteristiche e funzione, può dirsi che i contratti
di distribuzione, se coerentemente e opportunamente utilizzati, garantiscono un
maggiore efficienza del processo distributivo ed una migliore ottimizzazione
degli investimenti.
Ma specifichiamo meglio l’opportunità-necessità del contributo dell’Analisi
Economica del Diritto.
È evidente che, lungi dall’essere una vana o futile elucubrazione mentale, lo
studio delle norme giuridiche con l’ausilio di strumenti di analisi
quantitativa, rappresenta un valido strumento col quale comprendere, nel miglio
modo, la realtà socioeconomica che sottende ed ispira il diritto.
Del resto, lo scopo principalmente perseguito dell'Analisi Economica del
Diritto, in riferimento alla materia contrattuale è perseguire il raggiungimento
dell'efficienza, attraverso le norme che governano i contratti (Mattei e
Pulitini 1994). Al contempo, non si deve pensare al concetto di <<efficienza>>
come ad un paradigma astratto ed aprioristico, bensì ad una categoria più
elastica
e
duttile,
affidata,
di
volta
in
volta,
alla
valutazione
dell’interprete. E' infatti quasi impossibile risolvere simultaneamente le varie
problematiche che si affrontano nell'ottimizzare l'output generato da un negozio
contrattuale. In verità, come sancito nel celebre Teorema di Coase, pilastro
della teorica dell’Analisi Economica del Diritto, solo in un mondo privo di
costi negoziali, a prescindere da chi detiene il diritto, sarebbe possibile
acquisire un assetto totalmente efficiente: <<Più precisamente, appartiene a R.
Coase l’intuizione che ha condotto a rifondare le basi su cui si fondava la
teoria
dell’impresa
neoclassica
e,
che
ha
riformulato
il
problema
dell’organizzazione
del
sistema
economico
in
termini
di
comparazione
istituzionale. L’obiettivo di Coase consiste nel colmare il vuoto tra l’idea che
l’allocazione delle risorse venga effettuata tramite il meccanismo dei prezzi e
quella, di sapore schumpeteriano, secondo cui essa si realizza attraverso
l’attività coordinatrice di un imprenditore, che produce un’organizzazione
alternativa rispetto al mercato, l’impresa. Si tratta quindi di raccogliere
elementi sufficienti per poter giudicare se le due prospettive dovessero
intendersi come alternative o piuttosto complementari, ovvero di identificare i
motivi che portano al sorgere dell’impresa ed al suo sostituirsi al mercato. La
prima ragione, che costituisce il nucleo del contributo di Coase, è individuata
nei costi di transazione associati al meccanismo di mercato, che possono essere
ampiamente ridotti facendo ricorso ad un’organizzazione alternativa come
risposta al problema posto dalla necessità di negoziare un contratto separato
per ciascuna transazione. I contratti non vengono del tutto eliminati, ma
largamente ridotti: se un gruppo di fattori produttivi collabora in modo
continuativo all’interno di un’impresa, può scegliere di stipulare un unico
contratto a lungo termine destinato a sfociare nella forma-impresa, piuttosto
che affidarsi al mercato con una serie di contratti a breve. I1 secondo cardine
è il ruolo dell’incertezza, messo in evidenza già da Knight nel 1921. La
necessità di operare in un mondo in cui l’informazione è scarsa e costosa,
richiede un apparato in grado di assicurare i flussi informativi in modo più
efficiente rispetto al mercato.
Queste considerazioni pongono un ulteriore interrogativo, cioè se sia possibile
individuare i fattori che intervengono a determinare la dimensione di un’impresa
e, se l’impresa nasce come risposta all’esistenza di costi di transazione,
perché si continui comunque a ricorrere al mercato; perché, in altre parole, non
si faccia ricorso ad un’unica grande impresa, capace di surrogare completamente
il mercato. La risposta di Coase poggia sui rendimenti decrescenti attribuibili
all’attività manageriale (o genericamente organizzativa, dal momento che la
distinzione tra proprietà e controllo è ancora al di fuori dell’analisi).
’andamento decrescente è ascrivibile, da un lato, al costo marginale crescente
associato a ciascuna transazione aggiuntiva compiuta all’interno dell’impresa,
fino a raggiungere quel punto in cui esso è pari al costo della stessa
transazione condotta sul mercato; dall’altro, è da addebitarsi ad una
diminuzione delle capacità dell’imprenditore al crescere del numero delle
transazioni. Il risultato di questo processo è che la perdita dovuta ad
un’allocazione delle risorse sempre più inefficiente è tale da annullare il
vantaggio acquisito trasferendo la transazione dal mercato all’impresa >>
(Williamson 1975).
Essendo quindi, purtroppo, il nostro un mondo tutt'altro che perfetto, il
problema essenziale per l'interprete, chiamato a rapportarsi ad un determinato
assetto contrattuale, quindi anche ad un contratto di distribuzione, è di capire
ciò: fino a che punto è opportuno rendere vincolante fra le parti un contratto
che, per l’Analisi Economica del Diritto, oltre a costituire diritti e obblighi,
comporta un costo per l’intera economia, cioè per la Società civile, a vario
livello
regionale,
nazionale,
o
internazionale
?
Ovvero, al contrario, quando sarà consigliabile sciogliere o ritenere
inesistente il vincolo, liberando i contraenti dalle proprie rispettive
obbligazioni (ad es. per eccessiva onerosità sopravvenuta, per errore, per
l'avverarsi di una condizione risolutiva ecc. ecc.)? Ulteriori questioni e
problemi concernono, poi, il metodo di coercizione e di tutela del vincolo
contrattuale: allorché si sia giunti alla conclusione che, nella circostanza
presa
in
esame,
sarebbe
inefficiente permettere lo scioglimento del contratto, come punire il contraente
inadempiente ? con un'azione in forma specifica ? con i danni da aspettativa ?
con quelli da affidamento ? o ancora con i punitive damages ?
È facile notare che le prospettive cui l’Analisi Economica del Diritto ci porta
sono estese, tanto da coinvolgere il sistema giuridico di mercato, imprese e
consumatori, ma anche quello economico-finanziario di stati e popoli, quindi di
aree e zone.
Ancor di più, in questa sede, preme sottolineare come fondamentale obiettivo
dell’Analisi Economica del Diritto sia individuare la scelta della giusta
strategia per l'agire di uno Stato, di un’Impresa o di un Cittadino, al fine di
creare valore. L’attività di <<creazione di valore>> va misurata in termini di
<<interrelazione>>,
cioè
di
interscambio,
con
l'ambiente
circostante;
conseguentemente, se adottato a rango di <<metodo del Sistema>>, esso determina
un complessivo aumento del valore dell'intero contesto di pertinenza economica.
In quest’ottica, pare potersi dire l’impresa distributrice, o comunque
contraente con un’altra, è <<un portatore di interessi>> nei confronti
dell’impresa con cui si è accordata, cioè è un vero e proprio stakeholder, al
pari del <<socio di diritto>>, anzitutto in quanto essa è significativo
parametro di efficacia ed efficienza dell'Impresa, e, inoltre, in quanto le
imprese coprogettano, forniscono reciproche garanzie e/o finanziamenti.
Peraltro, osservando dall’angolo visuale dell’Analisi Economica del Diritto, si
nota che la legislazione italiana, compresa quella dei contratti di
distribuzione, si può in generale affermare che le norme si muovono, anche se
con alcune significative differenze, in un ottica generalmente paretiana, cioè
della c.d. teoria della <<normale imperfezione dei contratti>> (Pareto 1906,
579).
Volendo fare un esempio, basti pensare all'articolo 1372 c.c., che afferma che
il contratto ha <<forza di legge fra le parti>>. La norma è particolarmente
significativa per illustrare detta teoria: difatti, nell'ottica del <<contratto
perfetto>> (cioè, di quel contratto che rende lo scambio ottimizzato anche per
ogni circostanza eventuale o futura la norma non avrebbe alcuna ragione di
esistere, poiché non vi sarebbe alcun motivo di apprestare una forza legale al
vincolo negoziale. Essendo state preventivamente regolate tutte le ipotesi e le
ipotesi possibili, cioè, non ci dovrebbero essere attriti o contrasti, riguardo
l’esecuzione del contratto.
Tuttavia, come noto, nel mondo reale i contratti non sono mai <<perfetti>> e
pertanto possono verificarsi dei contrasti, sicché se la legge non prevedesse
una normativa sul contratto (in primo luogo, di tipo generale come il principio
che il contratto <<ha forza di legge fra le parti>>, in secondo luogo una
disciplina positiva specifica, almeno nelle sue linee fondamentali, per gli
elementi fondamentali della fattispecie costitutiva, per i singoli contratti in
rilievo), una delle parti si potrebbe impunemente sottrarre all'accordo.
Ciò dal punto di vista giuseconomico verrebbe a creare due differenti effetti
negativi: in primis disincentiverebbe gli investimenti idiosincratici (o
specifici); in secondo luogo, creerebbe un problema di avversione al rischio che
finirebbe con l'influire negativamente sull'aumento dei costi negoziali (le
parti infatti sarebbero costrette a regolare autonomamente e specificamente
tutte le sanzioni da associare ad ogni singola possibile eventualità) (Arrow
1969, 59).
Soprattutto, non bisogna trascurare che, dalla formulazione del codice del ’42,
la visione dell’impresa è mutata davvero molto dato che nel frattempo, per dirla
alla Arrow, è mutata la stessa percezione del rischio, non più possibilità di
perdita, meramente subita dall’individuo, come era concepito inizialmente, ma,
ben diversamente, opportunità da cogliere, scelta consapevole ed attiva del
soggetto, anzi momento strategico, sia nella vita di impresa, sia di un Paese.
IV. Sistema di protezione di un nuovo contraente ‘relativamente debole’:
l’impresa verso l’impresa.
Il legislatore, stretto fra l’esigenza di promuovere lo sviluppo della piccola
impresa e quella- spesso contrapposta- di garantire la libertà d’impresa e la
sua autonomia organizzativa, ha fornito all’imprenditore, similmente al
consumatore, una prima rete di protezione con la L. 192 del 1998 (ex pluribus:
Bortolotti 1999; Alpa e Clarizia 1999; Coccia e Sposato 1999; Bertolotti 2000);
limitata, però, ai soli rapporti di subfornitura, (Padovini 1999), certo –
evidentemente – molto lontana, per quantità e gravità, dalla minuziosa congerie
di provvedimenti e norme favorevoli al consumatore (Cassano 2000, 587).
In particolare, l’art. 1, co. 1, L. 192 del 1998, definendo il campo applicativo
della subfornitura, stabilisce che con questo contratto <<un imprenditore si
impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su
prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o
si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere
incorporati o comunque a essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica
del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a
progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi
forniti dall’impresa committente>>.
Il 2° comma del medesimo articolo, invece, esclude dal campo applicativo di
questa legge <<i contratti aventi ad oggetto la fornitura di materie prime, di
servizi di pubblica utilità e di beni strumentali non riconducibili ad
attrezzature>>.
<<Ma è altrettanto evidente che, man mano, stia sempre più emergendo una
disciplina
civilistica
sempre
più
segmentata
e
Invero, però, in dottrina si rileva l’assenza di elementi sufficienti a
giustificare il sistema normativo ad hoc per queste categorie (essenzialmente
consumatori e imprese) e, quindi, la dicotomia fra diritto generale dei
contratti e diritto dei consumatori, così come fra diritto generale e diritto
d’impresa (Amato 2003, 20).
Si afferma che, in tal senso, non può bastare di per sé l’introduzione della
disciplina relativa ai contratti dei consumatori, quindi a fortori il predetto
ragionamento varrebbe per la PMI, rispetto alla quale non si può ravvisare una
disciplina generale dei contratti d’impresa, ma solo una normativa, di varia
fonte, direttamente o indirettamente concernente la PMI.
Si sottolinea, poi, che - anche nei considerando della direttiva 1993/13/CE in
materia di consumatori - la tutela di questi ultimi pare strumentalizzata al
fine della creazione dell’unico mercato comunitario; che la nozione di
consumatore, così come - in un certo qual modo - quella di imprenditore, non è
uniforme nella legislazione europea e nelle normative dei singoli Stati e la
relativa categoria non è sufficientemente delimitabile, considerata l’estrema
eterogeneità dei soggetti ricomprensibili, quanto ad estrazione (socioeconomica, culturale, professionale, geografica …) ed interessi coinvolti (Reich
1995, 292; Amato 2003, 2 ss.)
Ancora all’individuabilità di uno specifico status di consumatore o di
imprenditore osterebbero il carattere variegato del suo ruolo e la sua non
appartenenza ad una collettività o a un gruppo organizzato (Falzone-Calvisi
2000, 453-454). Soprattutto, però, si evidenzia che la specialità della
disciplina di status crea disuguaglianze (fra le parti contraenti), ma anche
duplicazioni di principi e regole (Amato 2003, 24), e, quindi, problemi di
coordinamento normativo e di individuazione della disciplina applicabile al caso
di specie.
Peraltro, la ragionevolezza delle dette dicotomie entrerebbe in crisi, a causa
del carattere frammentario della legislazione comunitaria, che interviene su
materie disparate e dello stesso strumento di intervento, la direttiva, che, per
quanto dettagliata, rimane esposta ad adattamenti disomogenei scoordinati da
parte degli Stati membri (Amato 2003, 21). Si considera, poi, che la
compresenza, in ambito comunitario, di due diversi modelli di diritto dei
contratti si pone in contrasto con gli obiettivi dell’analisi economica del
diritto, nella cui ottica essa ostacola l’agilità e la celerità degli scambi,
causando ‘inefficienza economica.’
Così, mentre Zeno Zencovich pare favorevole al binomio diritto dei consumatori diritto delle imprese (Zeno Zencovich 1994, 1287; 1983, 57 ss.), opinione
altrettanto autorevole, invece, si preoccupa di evidenziare il prioritario
obiettivo comunitario di creazione di un mercato efficiente, e, in quest’ottica,
rileva che <<dato che non esiste un mercato separato per i consumatori (domanda)
e per i produttori (offerta), il diritto dei contratti deve affrontare il
problema di come regolamentare domanda e offerta in un unico mercato>> (Mattei
1999, 611).
Analogamente, va detto che il fine preminente del legislatore del 1998,
intervenendo in materia di subfornitura, non è o, più in generale, agevolare la
iniziativa economica individuale, ma garantire l’efficiente funzionamento del
mercato (Maugeri 2002, 457).
Non si è voluto realizzare un principio di protezione sociale o di giustizia
distributiva, ma garantire la concorrenza del mercato, in stretto collegamento
con la ratio della L. 87/1990, istitutiva dell’Autorità Garante della
concorrenza del mercato (Pardolesi 1993, 1; Osti 1994, 76).
Così, ad esito del contemperamento tra contrapposte, la tutela fornita
all’impresa debole risulta disorganica, disordinata, contraddittoria, e priva
peraltro di utili criteri di prevalenza dell’interesse tutelato.
Può considerarsi a tutela della piccola impresa anche la direttiva 2000/35/CE
(ex pluribus: Fauceglia 2001, 307 ss., Mengoni 2001, 74 ss.; Zaccaria 2001, 259
ss.; De Marzo 2002, 628 ss.), adottata per la lotta contro i ritardi dei
pagamenti nelle <<transazioni>> commerciali, e dal relativo D. Lgs. 231/2002,
attuativo della stessa.
In verità, anche qui, si dichiarano e perseguono in via diretta precisi
obiettivi, esposti nei Considerando della direttiva 2000/35/CE, diversi dalla
tutela della PMI.
Difatti, tale direttiva sottolinea che, in vari Stati membri, i termini
contrattuali di pagamento divergono eccessivamente dalla media comunitaria
(Considerando 8) e che le differenze, tra le normative in materia di pagamento e
le prassi seguite negli Stati membri, ostacolano il buon funzionamento del
mercato interno (Considerando 9).
Essa, poi, chiarisce, che i ritardi di pagamento costituiscono una violazione
contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori a causa del basso
livello dei tassi degli interessi di mora e della lentezza delle procedure di
recupero dei crediti (Considerando 16).
Questa situazione, a sua volta, contrasta col disposto dell’art. 14 Trattato UE
secondo cui <<gli operatori economici dovrebbero essere in grado di svolgere le
proprie attività in tutto il mercato interno in condizioni che garantiscano che
le operazioni transfrontaliere non comportino rischi maggiori di quelle interne.
’applicazione di norme sostanzialmente diverse alle operazioni interne e a
quelle transfrontaliere comporterebbe la creazione di distorsioni alla
concorrenza>>
Solo in via ulteriore e, potrebbe dirsi, secondaria, la direttiva de qua si
preoccupa di evidenziare anche: 1 - che i periodi di pagamento eccessivamente
dilatati e i ritardi nei pagamenti impongono pesanti oneri amministrativi e
finanziari alle imprese, in particolare, a quelle di piccole e medie dimensioni
(Considerando 7) e 2 - tali problemi spesso sono causa di insolvenza
dell’impresa e determinano la perdita di numerosi posti di lavoro (Considerando
cit.).
Per contro, deve notarsi l’ampiezza della norma dell’art. 1 della direttiva
(pressoché letteralmente trasposto, nell’ordinamento italiano, mediante l’art. 1
D. Lgs. 231/2002), destinato a definire l’ambito di applicazione di questa
normativa comunitaria, stabilendo che la direttiva si applica ad ogni pagamento
effettuato a titolo di corrispettivo nell’ambito di una transazione commerciale.
V. Il D. Lgs. 231/2002
L’art. 2 del detto decreto (contenente la descrizione di vari termini e concetti
rilevanti ai fini della direttiva) contribuisce ad ampliarne il campo operativo.
Ciò, in quanto adotta definizioni molto ampie: ad esempio, le ‘transazioni
commerciali’ sono intese come <<i contratti, comunque denominati, tra imprese
ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano, in via esclusiva
o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro pagamento
di un prezzo>>.
Vi è compresa, così, anche quell’estrema varietà organizzativa e funzionale
costituita dalle pubbliche amministrazioni, soggette anch’esse, dunque, alle
misure di lotta contro i ritardi nei pagamenti.
Ma esteso è anche il concetto di ‘imprenditore’, definito come <<ogni soggetto
esercente un’attività economica organizzata o una libera professione>> (art. 2 ,
co. 1 lett. c, D. Lgs. 231/2002) e tale da comprendere, pur ai soli fini di
questa direttiva (Considerando 14), anche la diffusa figura del libero
professionista, anche se agente da solo e, parrebbe, a prescindere, dalle
dimensioni e dalle caratteristiche della sua organizzazione.
Tuttavia,
complessivamente,
il
piccolo
imprenditore
risulta
protetto
essenzialmente nelle sue ragioni creditorie (Natali 2004, 739). In particolare,
va
segnalato
che
il
legislatore,
con
il
D.
Lgs.
231/2002:
a) istituisce, nei rapporti tra imprese, la mora ex re, automatica, che non
necessita di atti di intimazione scritta (art. 4, co.1, D. Lgs. 231/2002);
b) disciplina, in modo tendenzialmente completo, i termini d’adempimento, con
precisi criteri legali, pronti a subentrare se nel contratto non è previsto
alcun termine di riferimento o se il termine contrattuale risulta gravemente
iniquo
per
il
creditore
(art.
4,
co.
2,
D.
Lgs.
231/2002);
c) stabilisce un saggio d’interessi ‘legale’ aggravato rispetto al saggio legale
ordinario, dato che <<Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli
interessi, ai fini del presente decreto, e' determinato in misura pari al saggio
d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale
europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale
effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato
di sette punti percentuali>> (art. 5, co. 1, D. Lgs. 231/2002).
Nella direttiva il diritto del creditore agli interessi di mora è subordinato,
ex lett. c) par. 1, a due soli presupposti: 1- che il creditore abbia adempiuto
ai suoi obblighi e 2- che il ritardo nel pagamento sia imputabile al debitore,
e, similmente nel detto decreto attuativo, ma con un maggiore favore verso il
creditore, il debitore può sottrarsi alla responsabilità per ritardo solo se
dimostri che il ritardo nel pagamento è dipeso dall’impossibilità della
prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
V’è poi da segnalare l’art. 6, co. 1, in base a cui il creditore ha il diritto
di esigere dal debitore un risarcimento (definito <<ragionevole>> nella
direttiva) per i costi di recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento da
parte del debitore. A completamento di tale norma e garanzia della sua
effettività, si pone il par. 4 della direttiva: <<Gli Stati membri assicurano
che, nell’interesse dei creditori…, esistano mezzi efficaci ed idonei per
impedire il continuo ricorso a condizioni gravemente inique nel senso di cui al
paragrafo 3>> cioè nell’ambito di eventuali accordi sulle conseguenze
dell’inadempimento.
A testimoniare ancor di più il favor creditoris, v’è l’art. 6 della direttiva
2000/35/CE, secondo cui <<Gli Stati membri possono lasciare in vigore od emanare
norme che siano più favorevoli al creditore di quelle necessarie per conformarsi
alla presente direttiva>> prontamente recepito dalla normativa interna, in base
a cui <<Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi
speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.>> (art.
11, co. 2, D. Lgs. 231/2002).
Con finalità simili, la normativa sul ritardo nei pagamenti contempla anche
disposizioni di natura processuale, fra cui quelle dell’art. 8 e dell’art. 9.
La prima prevede che: <<1. Le associazioni di categoria degli imprenditori
presenti
nel
Consiglio
nazionale
dell'economia
e
del
lavoro
(CNEL),
prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i
settori produttivi e degli artigiani, sono legittimate ad agire, a tutela degli
interessi
collettivi,
richiedendo
al
giudice
competente:
a) di accertare la grave iniquità, ai sensi dell'articolo 7, delle condizioni
generali concernenti la data del pagamento o le conseguenze del relativo ritardo
e di inibirne l'uso;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi
delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a
diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del
provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle
violazioni accertate.>> (art. 8, D.Lgs. 231/2002).
La seconda, invece, completa il disposto dell’art. 648, co. 1, c.p.c.,
prevedendo che <<Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del
decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che
l'opposizione sia proposta per vizi procedurali>> (art. 9, co. 3, D. Lgs.
231/2002).
Sorge comunque un interrogativo: l’impresa creditrice è sempre impresa ‘debole’,
dunque meritevole di tutela? Al riguardo, va detto che il legislatore
comunitario (e quello nazionale che ne è ispirato col D. Lgs. 231/2002) pare
tutelare l’impresa creditrice in quanto tale, senza preoccuparsi della posizione
economica
concretamente
sottesa
alla
posizione
di
credito.
2001.
In un’ottica analogamente limitata, il legislatore della subfornitura considera
anche il contenuto giuridico ed economico dei contratti stipulati fra imprese,
ma il controllo su questo contenuto si incentra su ipotesi di grave sproporzione
del rapporto sinallagmatico, come nel caso dell’art. 9 sul divieto di ‘abuso di
dipendenza economica’, laddove per <<dipendenza economica>> si intende la
situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti
commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di
obblighi.
Il contenuto negoziale dei contratti d’impresa è sostanzialmente lasciato
all’autonomia privata, quale dimensione riflessa della libertà d’impresa.
Inoltre, emergono ancora significativi vuoti di tutela. Ad esempio, quid iuris
quando il regolamento contrattuale sia iniquo verso un’impresa che non rientri
nel
campo
applicativo
dell’art.
1
L.192/1998?
Soprattutto, pare opportuno, anche ‘de iure condendo’, adottare un concetto di
contraente debole che prescinda dalla formale qualifica di consumatore e dalla
relativa definizione, ed eleggerlo a imprescindibile obiettivo di tutela,
considerando soprattutto la situazione sostanziale facente capo all’operatore
economico. In quest’ottica si è recentemente sostenuto che <<Ai fini della
protezione ordinamentale, dunque, pare imprescindibile un concetto di impresa
‘debole’ a carattere ‘sostanziale’ (concreto) e ‘relativo’, cioè strettamente
legato alla singola vicenda contrattuale, alla prassi eventualmente instaurata
fra le parti e all’area di mercato coinvolta, ma ancor più ai fondamentali
momenti della stipula del contratto e della sua esecuzione, e alle
caratteristiche socio-economiche della controparte>> (Natali 2004, 740).
VI. La nuova legge sul franchising.
Recentemente, i contratti d’impresa hanno avuto un importante momento di
positivizzazione con la legge 6 maggio 2004 n. 129 intitolata <<Norme per la
disciplina dell’affiliazione commerciale>>, che ha reso contratto tipico lo
strumento atipico, ma sempre più diffuso (già dal caso Buffetti: Barbuto 2004,
18), e rilevante socioeconomicamente, cioè il franchising.
Già nel corso dei lavori preparatori alla legge, si sottolineava come lo scopo
della redazione di un apposito testo normativo fosse quella di contemperare e,
al contempo, salvaguardare, l’esigenza di trasparenza nei rapporti di
franchising, attraverso l’introduzione di norme a carattere generale, con il
principio dell’autonomia privata, e la connessa sfera d’azione.
Orbene, l’obiettivo di trasparenza (<<disclosure law>>) della legge è perseguito
attraverso l’inserimento di specifici obblighi informativi precontrattuali tra
le
parti;
parallelamente,
emerge
la
previsione
di
clausole
negoziali
obbligatorie, destinate a incidere sul contenuto normativo, e di riflesso, anche
su quello sostanzialmente economico, del contratto: la volontà negoziale dei
privati è così soggetta ad una ‘discreta’, ‘prudente’ eterodirezione, con
l’intento, ammirevole almeno in astratto e fino a risultanze diverse nel momento
della verifica operativa - cioè dell’applicazione concreta della legge già nella
prassi commerciale e poi, soprattutto, nella prassi dei Tribunali - di
armonizzare fra loro i contrapposti interessi in gioco, in vista di un possibile
effettivo equilibrio.
Del resto, natura e funzione dei limiti dell’autonomia privata, meglio si
comprendono se, in via più generale, si consideri che all’attività dei privati
si affianca, in funzione integrativa, ma anche contrappositiva, l’attività
eteronoma dell’ordinamento giuridico, mediante <<regole eteronome al potere di
autoregolazione privata, non costituenti emanazione del potere medesimo, ma
miranti… a disciplinarne … il valido esercizio>> (Grisi 1999, 12).
che si esprime, sia attraverso predeterminati comandi normativi, sia attraverso
la pronuncia resa a posteriori dal giudice (Gazzoni 1970, 189; Belvedere 2001,
VII).
In particolare, essi, a prescindere dalla loro peculiarità, paiono tutti, più o
meno direttamente, trarre origine o giustificazione, nel limite costituzionale
dell’ ‘utilità sociale’ (Ferri 1966, 177).
Quest’ultima comprende, ma non si esaurisce nell’esigenza di <<strutturazione
del mercato>>, peraltro, attenersi alla distinzione fra norme disponibili e
norme imperative, dunque sottratte al potere normativo dei privati (Messineo
1973,
42),
sarebbe
ugualmente
parziale
e,
pertanto,
scorretto.
Nell’utilità sociale sembrano potersi includere anche altre esigenze, tra cui
quella di tutela del contraente ‘debole’, tra cui spesso rientrano i
consumatori, ma anche le piccole imprese fornitrici o subfornitrici.
Questa asserzione, però, è più esatta se sufficientemente contestualizzata e
relativizzata, rilevando che tali imprese, nell’ambito delle relazioni
commerciali con grandi imprese nazionali o straniere, si trovano in una
situazione di notevole soggezione economica, pronta a tradursi in gravi
squilibri del regolamento contrattuale - quali modesti corrispettivi o tassi di
interessi moratori, esoneri o limitazioni della responsabilità del creditore,
deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria - oppure in gravi patologie
del momento esecutivo, come – si è gia visto nel par. precedente - ritardi
eccessivi e ingiustificati dei pagamenti e notevoli costi per il recupero dei
crediti.
Pertanto, ai limiti ‘negativi’, quali l’ordine pubblico, la morale, la norma
imperativa,
sanciti
dal
codice
civile
(artt.
1343
ss.;
1418
c.c.),
sostanzialmente tesi ad arginare l’autonomia privata, si aggiungono limiti
‘positivi’, comportanti, cioè, <<l’invasione della sfera dell’autonomia con
statuizioni che attengono allo stesso modo d’essere del rapporto interprivato.>>
(Barcellona 1969, 143 ss.). In quest’ottica, vanno rilevati l’obbligo legale di
contrarre (artt. 1679 - 2597 c.c.), il meccanismo di inserzione automatica di
clausole (art. 1339 c.c.) e, soprattutto, i sempre più frequenti interventi del
legislatore speciale, spesso in attuazione della normativa comunitaria, al fine
di proteggere interessi e diritti del contraente debole, che, se non sottratto
alla logica del mercato, rischia di non trovare risposta ai propri bisogni, nei
rapporti di locazione; di lavoro subordinato; di credito; di commercio, fra cui
quelli aventi oggetto i beni di consumo.
Ebbene, in questa stessa prospettiva di tutela, si inserisce anche la recente
legge sul franchising.
Tornando a discorrere di questo contratto, molte cose meriterebbero di essere
annotate già in queste pagine introduttive, ma sembra non potersi pretermettere
ad un dato di assoluto rilievo: la legge n. 129/04 ha tipizzato la <<causa
complessa sommatoria di tante cause semplici>> che caratterizzava il rapporto
atipico del franchising prima dell’intervento legislativo. In particolare, si
segnalava che <<Il detto contratto ricomprende al suo interno diversi elementi
causali tipici, quali quelli della vendita, o meglio, della somministrazione, se
il franchisor si impegna a vendere, ed il franchisee ad acquistare, certi beni;
quello della licenza di beni immateriali (soprattutto segni distintivi e knowhow; peraltro, la licenza di know-how è essa stessa un contratto atipico);
quello del mandato, se si considerano gli obblighi di coordinamento tra il
franchisor e il franchisee sul piano dello svolgimento delle rispettive attività
d’impresa (e quindi gli obblighi di informazione a carico del franchisee, oltre
che di sottoporsi ai controlli ed
1999, 47; 1996, 248).
Il legislatore del franchising ha
via cristallizzatasi, spesso in via
processo romano, nella prassi dei
contratto socialmente <<tipico>>.
alle verifiche del franchisor)>> (Frignani
così recepito la struttura contrattuale via
tralaticia, come già le formule delle antico
rapporti commerciali, e tale da rendere il
Invero, il legislatore, prima ancora dell’inserimento del franchising tra i
contratti nominati del nostro ordinamento, aveva dato già sufficiente rilevanza
del franchising, riconoscendo ad esso la sua importanza socioeconomica,
arrivando già a definire il contenuto giuridico dell’accordo sottostante al
franchising, anche se solo al fine del riconoscimento di agevolazioni
finanziarie a favore delle imprese. <<In particolare, se la stessa legge 488/92
in materia di finanziamenti a favore delle imprese riconosce le agevolazioni
anche ai <<programmi di investimento promossi da imprese aderenti a catene
commerciali anche in forma di franchising>>, il decreto ministeriale n. 295 del
28 maggio 2001, recante criteri e modalità di concessione degli incentivi a
favore dell’autoimpiego, conteneva una definizione del contratto di franchising,
come (art. 1, lett. g) un accordo che comporta la licenza di un insieme di
diritti di proprietà immateriale che riguardano in particolare marchi o insegne
e know-how, per l'uso e la distribuzione di beni o servizi. Oltre alla licenza
dei diritti di proprietà immateriale, l'affiliante (<<franchisor>>) fornisce
all'affiliato (<<franchisee>>), durante il periodo di vigenza dell'accordo,
un'assistenza tecnica o commerciale: licenza e assistenza formano parte
integrante della formula commerciale oggetto del franchising>> (Gaballo 2004,
30).
È poi indispensabile accennare all’ambito applicativo previsto dalla legge per
questo nuovo contratto tipico. Le parti (essenzialmente «franchisor» e
«franchisee») devono essere «soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente
indipendenti» (art. 1.1 L. 2004/129).
Secondo l’opinione di autorevole dottrina (De Nova 2004, 761-762) ‘Soggetti
giuridici’: come dire, pare, non persone fisiche (ma l’imprenditore individuale
può certamente essere un franchisee). «Economicamente e giuridicamente
indipendenti»: come dire, pare, che il rapporto di franchising non può essere di
lavoro
subordinato>>
Il franchisor giova il franchisee di un «package» <<inserendo l’affiliato in un
sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio,
allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi>> (art. 1.1, L.
2004/129).
Va precisato che il «package» è <<un insieme di diritti di proprietà industriale
o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli
di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o
consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito
da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di
commercializzare determinati beni o servizi>> (art. 1.1, L. 2004/129).
Ma subito sorge un interrogativo fondamentale: v’è un contenuto necessario per
il package e, nel caso di risposta positiva, quale e come può essere
individuato?
<<Non è chiaro se il «package» debba necessariamente comprendere tutti gli
elementi ivi indicati. Credo di no. Ma è essenziale che il «package» comprenda
il know-how, come si è detto>> (De Nova 2004, 762).
Peraltro, il contratto di franchising può essere utilizzato in ogni settore di
attività economica (art. 1, co. 2), coerentemente con uno dei massimi principi
vigenti in materia civilistica, l’autonomia privata di cui all’art. 1322 c.c.
L’ampia portata di tale norma deve però confrontarsi, all’interno della medesima
legge, con gli elementi previsti dal legislatore per il franchising.
In questa prospettiva, in armonia la definizione comunitaria del contratto, non
rientra il franchising industriale (o di produzione), fattispecie in cui il
franchisee produce sulla base delle istruzioni del franchisor e si avvale dei
suoi
segni
distintivi.
Infatti,
le
intese
di
franchising
industriale
<<disciplinando i rapporti tra produttori, integrano un’ipotesi di intese
orizzontali (tradizionalmente considerate di gran lunga più pericolose di quelle
verticali, intercorrenti cioè tra operatori situati a livelli diversi della
scala produttivo-distributiva, data la diminuzione di concorrenza <<interbrand>>
che esse determinano)>>(Frignani 1999, 47).
La nuova disciplina, invece, si preoccupa di regolare solo il franchising di
distribuzione
o
di
servizi,
stabilendo
gli
effetti
dell’inserimento
dell’affiliato <<in un sistema costituito da una pluralità di affiliati
distribuiti sul territorio>>, inserimento che così caratterizzato è peculiare
del franchising distributivo rispetto al franchising industriale (art. 1.l;
Venezia 2004, 160) .
Non a caso, nella descrizione del contenuto del contratto, emergono le
royalties, <<tipiche>> del franchising di distribuzione, e, invece, generalmente
assenti nel franchising industriale, rispetto al quale il compenso del
franchisor è componente non autonoma, ma generalmente assorbita nella
quantificazione complessiva del prezzo del prodotto.
In proposito, va detto che, in mancanza di punti di disciplina o anche di meri
riferimenti espliciti al franchising industriale, tale figura contrattuale è
capace di venir in rilievo, e, dunque, trovare applicazione, solo attraverso la
<<scorciatoia>> dell’analogia con il franchising distributivo, l’unico contratto
tipizzato dal legislatore.
L’analogia si renderebbe utile, ad esempio, rispetto alla questione della durata
del contratto:in tal caso, infatti, rileva primariamente l’esigenza di
salvaguardare gli investimenti del franchisee in caso di recesso dal contratto
da parte dell’affiliante, poiché sottesa, a sua volta, vi è l’esigenza di
tutelare il legittimo affidamento del franchisee alla prosecuzione del
contratto. Nel medesimo tempo, si tenga conto del carattere, spesso ingente,
degli
investimenti
del
franchisee
industriale,
costretto
ad
adeguare
stabilimenti, macchinari e/o manodopera impiegati alle richieste produttive
dell’affiliante, ed della frequente contestuale previsione di una clausola di
non concorrenza destinata ad essere efficace dopo l’avvenuta conclusione del
contratto.
Il carattere generico e aperto dell’espressione <<ogni settore di attività
economica>> pare poter legittimare, sostanzialmente, anche contratti di
franchising di servizi nell’ambito delle attività professionali, compresa
pertanto la professione forense. Infatti, l’ambito di applicazione della norma
pare confuso, in ragione di una formulazione che evoca l’estensione del
franchising anche all’esercizio delle attività professionali, fenomeno non
inedito come mostra l’esperienza statunitense del ricorso a vere e proprie forme
di affiliazione commerciale anche nell’ambito delle tradizionali libere
professioni e, peraltro, già in atto da tempo in forma strisciante anche nel
nostro Paese.
Tale possibilità di stipulazione non è però scontata, se sol si guardi alla
lettera della legge, e in particolare, alla previsione del know-how, quale
elemento costitutivo indefettibile del contratto de quo, e della sua necessaria
individuabilità
perché
possa
essere
trasmesso
al
franchisee.
Il valore economico del know-how è tale e sussiste se può essere riprodotto in
dati ed informazioni, che, a loro volta, possono essere trasmessi a terzi; in
mancanza, il know-how non può più definirsi così e coincide con la mera
esperienza professionale.
Quest’ultima non può costituire oggetto di autonomi atti di commercio, perché è
elemento inseparabile dalle persone (Gaballo 2004, 39; Scaglione Sandri 1990,
55).
VII. Ulteriori considerazioni sull’ambito applicativo.
La normativa relativa al contratto di franchising si applica, per espressa
disposizione dell’art. 2 della legge, anche al c.d. master franchising e al c.d.
corner franchising, due particolari figure contrattuali affermatesi nella prassi
commerciale e che contribuiscono alla varietà e alla rilevanza socio-economica
dei contratti di distribuzione, quali strumenti sempre più identificativi
dell’autonomia privata delle imprese.
Il Master franchising è un contratto di affiliazione commerciale principale, in
virtù del quale un’impresa concede all’altra, giuridicamente ed economicamente
indipendente dalla prima, dietro corrispettivo, diretto o indiretto, il diritto
di sfruttare un’affiliazione commerciale per stipulare accordi di affiliazione
con terzi.
Esso emerge nella nuova legge, nel momento in cui essa prevede che il
franchisor, nell’ambito di una determinata area territoriale, possa concedere la
possibilità al franchisee di stipulare altri contratti (c.d. sub-franchising).
Si parla anche di <<franchising internazionale>>, in quanto è di più frequente
applicazione nei rapporti internazionali, perché capace di soddisfare l’esigenza
del franchisor di espandere, senza sopportare i relativi rischi imprenditoriali,
la distribuzione dei prodotti o servizi anche in mercati esteri in cui è scarsa
la penetrazione commerciale della propria impresa, avvalendosi di un subfranchisor che si propone come migliore conoscitore del territorio.
Il sub-franchisor, a sua volta, deve rispettare tutti gli obblighi che la legge
impone al franchisor, nel rapporto di affiliazione principale, compresi gli
obblighi informativi precontrattuali che dovrà fornire ai propri affiliati.
Accenniamo poi al Corner franchising, ossia al contratto con il quale
l’affiliato, in un’area di sua disponibilità, allestisce uno spazio dedicato
esclusivamente allo svolgimento dell’attività commerciale con i prodotti o i
servizi propri del rapporto di affiliazione.
La norma dell’art. 2 individua il c.d. corner franchising (o <<franchising
parziale>>) particolarmente diffuso nei grandi centri commerciali, nel punto e
nel momento in cui l’affiliante concede la possibilità ad un franchisee di
creare nel proprio esercizio di vendita uno spazio autonomo dove distribuire i
prodotti o i servizi del franchisor, offrendo in pratica la possibilità di dar
vita ad <<un negozio nel negozio>>, dedicato ai prodotti e servizi del
franchisor (Gaballo 2004, 40-41).
La definizione legislativa non chiarisce la reale portata del corner franchising
in relazione alla costituzione del rapporto tra le parti. Più precisamente, si è
detto che <<il testo della legge ove si riferisce al corner franchising potrebbe
essere causa di dubbi interpretativi: non è chiaro se l’affiliato che concede lo
spazio acquista la qualifica di franchisee mediante tale concessione, ovvero
doveva ricoprire tale ruolo anche prima della concessione dello spazio>> (Fulco
2004, 25).
In conclusione, è evidente che molteplici possono essere le forme di
cooperazione imprenditoriale in un rapporto di franchising che, pur in assenza
di una automa considerazione normativa, sono destinate ad avere come necessario
punto di riferimento la nuova legge.
E, al contempo, non può trascurarsi di evidenziare anche le lacune di questa
legge che si preoccupa di regolare più gli obblighi di disclosure, cioè di
informazione, soprattutto in chiave precontrattuale, e la fase di formazione del
contratto, e si occupa meno della vita e della cessazione dello stesso, <<e ciò
perché il legislatore ha ritenuto principale l’esigenza di evitare che aspiranti
affiliati stipulino contratti, impegnando tempo e risorse, a fronte di un quasi
inesistente know-how ed avviamento, di un marchio non forte o di prodotti non
apprezzati sul mercato e di un superficiale impegno di formazione, assistenza e
consulenza>> (Leo 2004, 963).
È dunque una legge palesemente monca, così notando, senz’altro può darsi
condividere l’autorevole opinione di chi osserva che <<se per legislatore dei
contratti intendiamo il legislatore che ordina e regola in modo organico la
prassi
contrattuale,
il
legislatore
italiano
dei
contratti
è
morto>>
(De Nova 2004, 764; 2002, 5-9).
Analogamente si esprime Tripodi, secondo cui: <<La nuova disciplina, nell’ambito
di un approccio improntato al «minimo impatto», è piuttosto scarna e, nei nove
articoli che la compongono, viene secondata l’esigenza di tutelare la
trasparenza dei rapporti tra affiliante ed affiliato, ricongiungendosi
idealmente ad una linea di pensiero legislativo che porta a riequilibrare la
vicende contrattuali non solo quando la controparte sia, per definizione,
bisognosa di tutela, come nel caso delle numerose prescrizioni a tutela dei
consumatori, ma anche quando sia ravvisabile un indizio di «debolezza» in
imprenditori (almeno formalmente) autonomi.>> (Tripodi 2004, 511 e 512).
Va comunque osservato che, data la prevalente ratio dell’intervento legislativo:
ossia la tutela dell’imprenditore ‘debole’, le norme della legge sul franchising
devono considerarsi a carattere imperativo (De Nova 2004, 761), e, dunque,
indisponibili
da
parte
dell’autonomia
privata.
Ciò sulla base di più e diverse argomentazioni.
1) una previsione espressa (l’art. 3.1 dice nullo il contratto verbale);
2) una norma transitoria dell’art. 9, che impone l’adeguamento dei vecchi
contratti;
3) una formulazione (ex art. 1.1: «l’affiliazione commerciale franchising è il
contratto, comunque denominato…») che ha senso solo in un’ottica antielusiva.
Va precisato, però, che la conseguenza, in caso di violazione delle norme
previste dalla nuova legge, non sarà sempre la stessa, e soprattutto, data
l’assenza di riferimenti espressi, dall’esito ermeneutico e applicativo incerto
(De Nova 2004, 761).
Così, se vengono violate le norme che pongono obblighi di informazione, il
franchisor risponderà per danni, salvo che siano fornite informazioni false, nel
qual caso il contratto sarà annullabile; se non si osserva la forma prescritta,
il contratto sarà nullo.
E se, invece, il franchisor infrange la norma che impone di aver sperimentato la
propria formula commerciale, o l’obbligo implicito di fornire un know-how, quid
iuris? In tal caso, il contratto dovrebbe ritenersi nullo, perché il package non
può essere vuoto (De Nova 2004, 761).
VIII. La normativa sul commercio elettronico e la disciplina comunitaria degli
accordi di distribuzione
Nell’attuale considerazione della disciplina sui rapporti tra imprese, bisogna
poi tener conto che il 14 Aprile 2003, con il Decreto Legislativo n° 70 del
2003, è stata attuata nel nostro ordinamento la Direttiva CE 31/00, tesa a
disciplinare i servizi della società dell’informazione, quindi, in sostanza,
anche
il
commercio
elettronico
(e-commerce).
È questa una tappa decisiva nella creazione a livello comunitario e nazionale di
un quadro organico, specifico e chiaro di regole giuridiche per un fenomeno,
quello del commercio elettronico, nato e cresciuto a ritmi vertiginosi negli
ultimi anni (Antonucci 2001; Cassano e Cimino 2002, 870 ss.).
A prescindere dalle singole specificazioni normative, tra cui le norme
antispamming o quelle inerenti alla tutela della sicurezza e della riservatezza
delle comunicazioni e alla protezione dei dati sul traffico, sull’identità e
sull’ubicazione fisica, l’obiettivo generale e fondamentale della nuova
normativa è favorire la libera circolazione e lo sviluppo di queste attività e,
pertanto, di questo strategico settore dell’economia, stabilendo con precisione
gli obblighi, i diritti e le responsabilità delle parti coinvolte nel processo
di informazione-conoscenza, di acquisto e di erogazione dei <<servizi della
società dell’informazione>>, cioè delle <<attività economiche svolte in linea
(on line)>> mediante la connessione di accesso alla rete globale Internet e la
presenza stabile in essa degli operatori economici per mezzo di un sito web
(art. 2 D. lgs. 70/2003) (Visconti 2003).
Più precisamente, il legislatore europeo non ha inteso disciplinare direttamente
i rapporti (spesso conflittuali) tra la normativa attinente agli accordi di
distribuzione
e
quella
riguardante
il
commercio
elettronico.
Tale lacuna deve, pertanto, essere colmata avuto riguardo ai principi generali
del diritto comunitario.
A tal proposito si possono rammentare le indicazioni contenute all’interno delle
voluminose guidelines (“Linee direttrici sulle restrizioni verticali” - COM
291/01, in GUCE C del 13.10.2000. pag. 1) relative alla applicazione del già
citato Regolamento n. 2790/1999.
Al riguardo, in tale documento, si afferma il basilare principio di diritto che
consente a ciascun distributore affiliato alla rete del produttore la facoltà di
vendere anche attraverso Internet; dovendosi egli unicamente astenere dalla
“promozione attiva” (si tornerà diffusamente sul concetto nel prosieguo del
presente lavoro, per il momento basti aver chiaro il principio) al di fuori del
proprio territorio contrattualmente assegnato.
Il problema - in gran parte irrisolto dalle guidelines - deriva dall’evidente
anacronismo insito nell’allacciare a criteri di territorialità la disciplina
antitrust degli accordi di distribuzione, con riguardo ad un fenomeno (Internet)
che tali limiti territoriali rifugge per antonomasia.
Ciò dovrà, verosimilmente in un prossimo futuro, portare ad un ripensamento dei
termini di riferimento sulla regolamentazione europea relativa agli accordi di
distribuzione. Molto probabilmente ci si trova, difatti, alla vigilia
dell’introduzione di nuovi e più articolati strumenti giuridici che dovranno
salvaguardare le legittime aspettative dei consumatori ed al contempo,
preservare gli investimenti effettuati dai produttori.
Per una analisi dell’argomento sarà comunque opportuno muovere dall’esame delle
disposizioni generalmente contenute negli accordi di distribuzione, formulando
due ipotesi base e tra di loro alternative.
La prima. Quando in un contratto di distribuzione manchino specifici termini
contrattuali che proibiscano la vendita per corrispondenza oppure on line da
parte del distributore, residua comunque per il produttore la possibilità di
trovare altri argomenti a sostegno, nelle pieghe dell’accordo, per negare la
liceità di una tale condotta.
La mancanza di prestigio del sito web realizzato dal distributore (come, ad
esempio, la scarsa qualità delle fotografie) può, difatti, assai spesso rilevare
quale inadempimento al contratto di distribuzione per fatto e colpa del
distributore; impedendosi, così, a quest’ultimo di ricorre al mezzo telematico
per la commercializzazione dei prodotti.
La seconda. Il contratto di distribuzione prevede una clausola che proibisce
espressamente
la
vendita
per
corrispondenza
della
merce
ricevuta
dal
distributore (si rammenta che la vendita per corrispondenza presuppone l’invio
di un catalogo o brochure al consumatore).
A questo proposito occorre anticipare due sub-ipotesi, che dipendono dal tipo di
vendita on line (attiva o passiva) realizzata mediante il mezzo telematico.
Qualora, infatti, il distributore si limiti ad offrire sul web la propria merce
e non tenti di attirare “attivamente” i consumatori al proprio sito - per
esempio spedendo loro informazioni commerciali attraverso le e-mail - ma siano,
invece, quest’ultimi ad accedere, senza particolare sollecitazione, al sito del
distributore, sembra non potersi interpretare tale forma di commercializzazione
come vendita per corrispondenza (tuttavia contra Bensoussan, 1998). La vendita
per corrispondenza si attua, difatti, mediante l’invio ad personam del catalogo
di prodotti del commerciante, mentre l’offerta on line è attuata ad incertam
personam.
Di contro, se il distributore opera una “strategia attiva” per attirare i
consumatori al proprio sito (inviando loro e-mail, ovvero pubblicizzando
diffusamente il sito stesso con banner ipertestuali destinati in prevalenza a
determinati gruppi di consumatori), pare lecito interpretare tale vendita quale
vendita per corrispondenza.
Occorre a questo punto domandarsi se sia possibile per il produttore inibire
tout-court contrattualmente ai propri distributori la possibilità stessa di
ricorrere al commercio elettronico.
La risposta negativa a tale interrogativo deriva dal fato che la Commissione
europea ha espressamente disposto che i contratti di distribuzione selettiva non
possono a priori escludere il ricorso da parte del distributore alle forme
moderne di commercializzazione, prima tra tutte l’e-commerce, salvo che esse si
concretino in “vendite attive”.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, lettera b) del Regolamento n.
2790/1999 di esenzione per categoria, la Commissione intende per “vendite
attive” quelle derivanti dal contatto diretto e deliberato con singoli clienti,
ad esempio per posta elettronica, oppure il contatto diretto con uno specifico
gruppo di clienti, o con clienti situati in uno specifico territorio attribuito
in esclusiva ad un altro distributore, attraverso inserzioni pubblicitarie sui
media o altre promozioni specificamente indirizzate a quel gruppo di clienti
ovvero ai clienti residenti in quel territorio.
Sono, di contro, da considerasi “vendite passive”: la risposta ad ordini non
sollecitati di singoli clienti - incluse la consegna di beni o la prestazione di
servizi a tali clienti, le azioni pubblicitarie o promozionali di portata
generale realizzate attraverso i media o via Internet - anche qualora
raggiungano clienti all’interno del territorio esclusivo o del gruppo di clienti
esclusivo di un altro distributore, ma purché, in questo caso, costituiscano
comunque un modo ragionevole per raggiungere clienti nei territori non concessi
in esclusiva o residenti all’interno del proprio territorio di competenza.
Alla stregua di tali principi può dunque affermarsi che qualsiasi distributore
deve poter essere libero di utilizzare Internet per pubblicizzare o vendere i
propri prodotti.
Giova a questo punto precisare che la nozione di “vendita passiva”, nonostante
l’analogia semantica, pare ben poco riecheggiare quella elaborata dalla
giurisprudenza nord-americana di “sito passivo” (per una analisi approfondita
del concetto di “sito passivo” si rinvia alle considerazioni di Draetta, 2001).
Ad ogni modo, alla luce di quanto sopra esposto, la restrizione negoziale
all’uso di Internet da parte dei distributori potrebbe essere compatibile con il
citato Regolamento solo qualora la promozione o la vendita via Internet dessero
vita ad una “vendita attiva” in territori, ovvero ai gruppi di clienti, concessi
in esclusiva ad altri distributori.
Giova peraltro ribadire che - salvo i casi sopra indicati ed altri analoghi che
possono ipotizzarsi - l’uso di Internet non è generalmente assimilabile ad una
forma di “vendita attiva”, trattandosi, per lo più, di un modo ragionevole per
raggiungere la clientela attribuita al distributore affiliato ad una rete di
vendita.
La circostanza che l’uso di Internet da parte di un distributore possa produrre
alcuni effetti anche al di fuori del territorio o del gruppo di clienti
assegnatogli è una conseguenza inevitabile della tecnologia, che consente un
facile
accesso
alle
negoziazioni
da
qualsiasi
luogo
della
terra.
Tuttavia discutibile appare, al riguardo, la previsione contenuta nelle
guidelines circa la normale irrilevanza della lingua adottata dal distributore
per il proprio sito. Va infatti considerato che l’impiego di una lingua diversa
da quella del Paese di stabilimento del distributore, denota, quasi in tutti i
casi, la evidente finalità di penetrare in un determinato territorio
appartenente (in ipotesi) ad altro distributore. Nonostante la marcata
incongruenza occorre, tuttavia, prendere atto che le suddette guidelines
espressamente dispongono che “la lingua utilizzata sul sito o nella
comunicazione non svolge, di norma, alcun ruolo”.
In ogni caso, nella misura in cui un sito non è specificamente destinato a
raggiungere clienti siti principalmente all’interno di un territorio o di una
cerchia di clienti attribuiti in esclusiva ad un altro distributore, ad esempio
mediante banner o link in pagine specificamente dirette a tali clienti, il sito
in questione non può essere considerato alla stregua di uno strumento riducibile
all’ipotesi di “vendita attiva”.
Come invece già detto, i messaggi di posta elettronica non sollecitati (c.d.
spam) inviati a singoli clienti, o a specifici gruppi di clienti, sono sempre da
considerarsi
alla
stregua
di
forme
di
“vendita
attiva”.
Infine, prescindendo pure da quanto sopra affermato, il produttore (come già
accennato) può esigere dal distributore il rispetto di standard qualitativi in
relazione all’uso dei siti Internet per la rivendita dei beni negli stessi casi
in cui può farlo anche in relazione ad un punto vendita o all’attività
pubblicitaria e promozionale in generale.
Quest’ultimo aspetto può essere importante in particolare per la distribuzione
selettiva. Un divieto assoluto di vendere via Internet o su catalogo è
astrattamente possibile solo se vi sia una rilevante giustificazione oggettiva
in tal senso.
Per quanto riguarda l’individuazione dei motivi legittimanti l’opposizione alla
vendita on line da parte del produttore (titolare di marchio) essi riguarderanno
qualsiasi azione che comprometta gravemente il valore, l’attrattiva o l'immagine
del marchio o dei prodotti recanti il marchio, ma non comprenderanno invece
azioni o circostanze che non pregiudichino i diritti costituenti l’interesse
specifico di tutela e la funzione essenziale del marchio. Il limite può essere
offerto, ad esempio, da determinati beni di lusso, quali gioielli o prodotti
dell’alta moda, che potrebbero essere gravemente sviliti qualora fossero
commercializzati on line.
Per concludere sul punto è opportuno, infine, rammentare come le guidelines
escludano espressamente che il fornitore possa riservarsi in esclusiva la
possibilità di utilizzare Internet ai fini di vendita o pubblicitari.
IX. Considerazioni conclusive.
L’attuale contesto economico risente profondamente di alcune elementi costanti,
quali la globalizzazione di mezzi materiali, capitali, cose e persone;
l’evoluzione tecnologica, fra cui l’enorme sviluppo e diffusione del web, la sua
rapidità ed il suo essere alla portata di tutti; la dimensione e la
strutturazione del sistema organizzativo e distributivo dell’impresa (che ha un
perno fondamentale nei contratti di distribuzione).
Ebbene, oggi, alla luce della continua interazione di tali fattori, peraltro,
in reciproco rapporto di causa-effetto ed quindi, poter prospettare dei criteriguida, di carattere normativo, positivizzati od ermeneutici che siano, anche
magari in termini di Analisi Economica del Diritto, rispetto alle scelte da
compiersi, vuol dire prospettare vere e proprie chiavi di lettura della realtà,
ed assicurarsi, al contempo, un’imprescindibile funzione per orientarsi nel
Mercato.
Il che vuol dire andare al di là, e probabilmente, ‘progredire’ rispetto alle
tradizionali dispute sulla formazione e la validità del contratto e del vincolo
conseguentemente nascente.
Da qui tutto l’interesse a soffermare l’attenzione sui contratti di
distribuzione, capirne le peculiarità, la possibile disciplina e, soprattutto,
l’effettiva applicabilità nel concreto mondo economico, magari attraverso il
filtro autorevole ed affidabile della giurisprudenza.