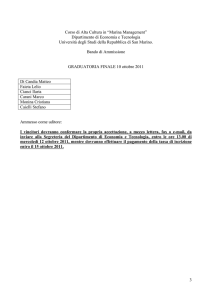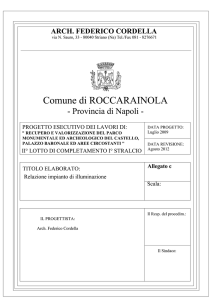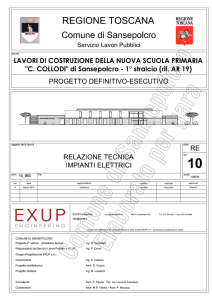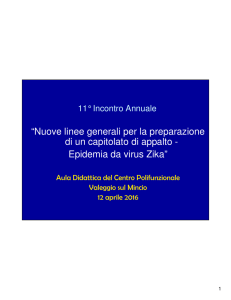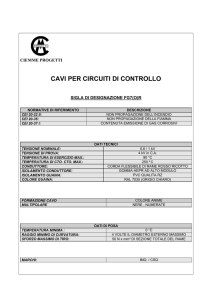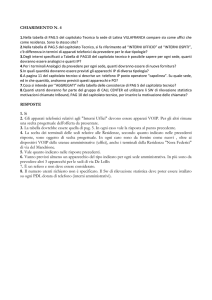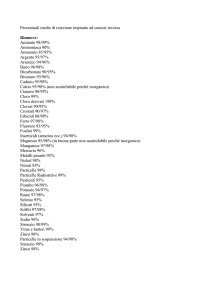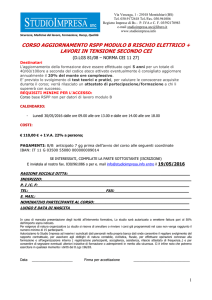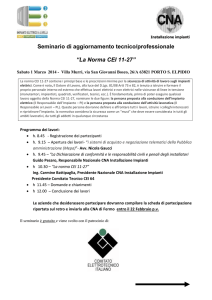Regione del Veneto
Azienda Unità Locale
Socio Sanitaria
OVEST
VICENTINO
CONTRATTO APERTO DI MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA
DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ E DI USO AZIENDALE
ANNI 2010-2011
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
[NORME TECNICHE]
U.O.C. Risorse Tecniche e Tecnologiche - Via Trento n. 4 - 36071 Arzignano (VI)
P.IVA 00913220240 Tel. 0444/459791 - Fax 0444/459794
INDICE
OPERE EDILI ......................................................................................................... 4
QUALITÀ DEI MATERIALI E COMPONENTI.................................................................................. 5
MATERIALI IN GENERE ........................................................................................................................................................... 5
ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI .......................................................................................................... 5
Acqua...................................................................................................................................................................................................... 5
Calci........................................................................................................................................................................................................ 5
Cementi e agglomerati cementizi................................................................................................................................................................ 6
MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE .......................................................................................... 6
ELEMENTI IN LATERIZIO E CALCESTRUZZO............................................................................................................................. 6
ARMATURE PER CALCESTRUZZO ............................................................................................................................................. 7
PRODOTTI DI PIETRE NATURALI O RICOSTRUITE.................................................................................................................... 7
PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONI ........................................................................................................................................... 7
Prodotti in gomma .................................................................................................................................................................................... 7
Masselli di calcestruzzo.............................................................................................................................................................................. 8
PRODOTTI PER COPERTURE E TAMPONATURE LOCALI TECNICI ............................................................................................... 8
PRODOTTI DI VETRO.............................................................................................................................................................. 9
PRODOTTI DIVERSI (SIGILLANTI, ADESIVI)............................................................................................................................. 9
INFISSI ................................................................................................................................................................................ 10
PRODOTTI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI ............................................................................................................ 10
Prodotti rigidi ......................................................................................................................................................................................... 10
Prodotti fluidi od in pasta......................................................................................................................................................................... 11
PRODOTTI PER ISOLAMENTO TERMICO................................................................................................................................. 11
Materiali fabbricati in stabilimento: (blocchi, pannelli, lastre, feltri ecc)......................................................................................................... 11
Materiali iniettati, stampati o applicati in sito mediante spruzzatura ............................................................................................................. 12
PRODOTTI PER PARETI ESTERNE E PARTIZIONI INTERNE ..................................................................................................... 13
MODALITÀ DI ESECUZIONE ...................................................................................................... 14
RILEVATI E REINTERRI ......................................................................................................................................................... 14
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI.................................................................................................................................................. 14
OPERE E STRUTTURE DI MURATURA ..................................................................................................................................... 15
Malte per murature ................................................................................................................................................................................. 15
Murature in genere: criteri generali per l’esecuzione................................................................................................................................... 15
OPERE E STRUTTURE DI CALCESTRUZZO .............................................................................................................................. 16
Impasti di conglomerato cementizio ......................................................................................................................................................... 16
Controlli sul conglomerato cementizio ....................................................................................................................................................... 16
Norme di esecuzione per il cemento armato normale. ................................................................................................................................ 16
Norme di esecuzione per il cemento armato precompresso ......................................................................................................................... 17
Responsabilità per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso................................................................................ 17
SOLAI .................................................................................................................................................................................. 18
Generalità .............................................................................................................................................................................................. 18
Solai su travi e travetti di legno ................................................................................................................................................................ 18
Solai su travi di ferro a doppio T (putrelle) con voltine di mattoni (pieni o forati) o con elementi laterizi interposti ............................................ 18
Solai di cemento armato o misti: generalità e classificazione ....................................................................................................................... 18
Solai misti di calcestruzzo armato o calcestruzzo armato precompresso e blocchi forati di laterizio. ................................................................. 19
Caratteristiche dei blocchi........................................................................................................................................................................ 19
Solai prefabbricati................................................................................................................................................................................... 20
Solai misti di calcestruzzo armato o calcestruzzo armato precompresso e blocchi diversi dal laterizio............................................................... 20
Solai realizzati con l’associazione di elementi di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso prefabbricati .................................... 20
STRUTTURE IN ACCIAIO ....................................................................................................................................................... 21
Collaudo tecnologico dei materiali ............................................................................................................................................................ 21
Controlli in corso di lavorazione................................................................................................................................................................ 21
Montaggio ............................................................................................................................................................................................. 21
Prove di carico e collaudo statico.............................................................................................................................................................. 22
Varie ..................................................................................................................................................................................................... 22
RIVESTIMENTI INTERNI E TINTEGGIATURE........................................................................................................................... 22
Sistemi realizzati con prodotti resilienti...................................................................................................................................................... 22
Sistemi realizzati con prodotti fluidi........................................................................................................................................................... 23
VETRI E SERRAMENTI........................................................................................................................................................... 24
PARETI ESTERNE E PARTIZIONI INTERNE ............................................................................................................................. 25
INTONACI ............................................................................................................................................................................ 26
Intonaco comune o civile......................................................................................................................................................................... 26
PAVIMENTAZIONI ................................................................................................................................................................. 27
CONTROSOFFITTI................................................................................................................................................................. 27
FINITuRE ED ESECUZIONI PARTICOLARI ............................................................................................................................... 27
Attraversamento di setti taglia fuoco da impianti........................................................................................................................................ 27
Fascia paracolpi...................................................................................................................................................................................... 28
IMPIANTI MECCANICI ........................................................................................ 29
SPECIFICHE DELLE APPARECCHIATURE ............................................................................................... 30
Canalizzazioni in lamiera ........................................................................................................................................................ 30
Progetto meccanico ................................................................................................................................................................................ 30
Installazione........................................................................................................................................................................................... 31
Tubazioni in acciaio ............................................................................................................................................................... 32
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 1
Tubazioni in rame per fluidi termovettori ................................................................................................................................ 33
Tubazioni precoibentate .......................................................................................................................................................................... 34
Tubazioni in PEHD e PP per linee in pressione......................................................................................................................... 34
Opere di protezione............................................................................................................................................................... 34
Preparazione delle superfici ..................................................................................................................................................................... 35
Applicazione delle vernici......................................................................................................................................................................... 35
Coibentazione ....................................................................................................................................................................... 35
Identificazione degli isolamenti ................................................................................................................................................................ 36
Finiture: benda in PVC ............................................................................................................................................................................ 38
Valvolame ed accessori per tubazioni ..................................................................................................................................... 38
Valvole .................................................................................................................................................................................................. 38
Valvole a sfera ....................................................................................................................................................................................... 39
Valvole di sicurezza................................................................................................................................................................................. 40
Termometri ed idrometri........................................................................................................................................................ 41
Termometri a quadrante ......................................................................................................................................................................... 41
Termometri a colonna ............................................................................................................................................................................. 41
Idrometri a quadrante............................................................................................................................................................................. 41
Bocchettame ed accessori per canalizzazioni........................................................................................................................... 42
Condizioni di progetto ............................................................................................................................................................................. 42
Regolazione automatica elettronica ........................................................................................................................................ 44
Generalità .............................................................................................................................................................................................. 44
Montaggio ............................................................................................................................................................................................. 44
Valvole servocomandate per acqua calda e fredda ..................................................................................................................................... 45
Valvole di regolazione in ghisa per alte temperature (max 180°C) ............................................................................................................... 45
Valvole di regolazione in acciaio PN 25...................................................................................................................................................... 46
Dispositivo di regolazione valvole ............................................................................................................................................................. 46
Servomotori ........................................................................................................................................................................................... 46
Sistema di supervisione impianto meccanico ........................................................................................................................... 46
Controllori periferici ................................................................................................................................................................................ 46
Unità a microprocessore .......................................................................................................................................................................... 46
Moduli di funzione .................................................................................................................................................................................. 47
Stazione centralizzata di controllo............................................................................................................................................................. 48
Caratteristiche tecniche ........................................................................................................................................................................... 49
Stampante sistema (protocolli)................................................................................................................................................................. 50
Stampante Sistema (allarmi) .................................................................................................................................................................... 50
Collettori .............................................................................................................................................................................. 50
Ubicazione ............................................................................................................................................................................................. 50
Collettori in tubo di acciaio nero ............................................................................................................................................................... 50
Collettori in tubo di acciaio zincato ........................................................................................................................................................... 51
Collettori in rame .................................................................................................................................................................................... 51
Tubazioni di scarico in PEHD.................................................................................................................................................................... 51
Montaggio ............................................................................................................................................................................................. 51
Ispezioni................................................................................................................................................................................................ 51
Vasi di espansione .................................................................................................................................................................................. 52
Vasi di espansione chiusi ......................................................................................................................................................................... 52
Vasi di espansione di tipo aperto .............................................................................................................................................................. 53
Setti tagliafiamma................................................................................................................................................................................... 53
Centrali di trattamento aria.................................................................................................................................................... 54
Generalità .............................................................................................................................................................................................. 54
Progetto meccanico ................................................................................................................................................................................ 54
Involucro ............................................................................................................................................................................................... 54
Serrande................................................................................................................................................................................................ 54
Camere di miscela .................................................................................................................................................................................. 54
Filtri ...................................................................................................................................................................................................... 54
Modalità di installazione .......................................................................................................................................................................... 57
Impianto gas medicali ........................................................................................................................................................... 57
Reti di distribuzione: gruppo di riduzione 2 ° stadio.................................................................................................................................... 57
IMPIANTI ELETTRICI.......................................................................................... 59
GENERALITA’ ............................................................................................................................ 60
PRESCRIZIONI...................................................................................................................................................................... 60
MATERIALI IMPIANTISTICI ................................................................................................................................................... 60
VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI ........................................................................................................................................ 60
COLLAUDI ............................................................................................................................................................................ 61
DOCUMENTAZIONE............................................................................................................................................................... 62
GARANZIA ............................................................................................................................................................................ 63
CERTIFICAZIONI................................................................................................................................................................... 63
SMALTIMENTO RIFIUTI......................................................................................................................................................... 63
MISURAZIONE E VALUTAZIONE LAVORI ................................................................................................................................ 64
SMANTELLAMENTI ................................................................................................................................................................ 64
NORME DI RIFERIMENTO...................................................................................................................................................... 64
SPECIFICHE DELLE APPARECCHIATURE ............................................................................................... 68
QUADRI ELETTRICI............................................................................................................................................................... 68
Criteri di dimensionamento ed alimentazione dei quadri elettrici .................................................................................................................. 68
Caratteristiche costruttive ........................................................................................................................................................................ 69
Caratteristiche elettriche.......................................................................................................................................................................... 70
INTERRUTTORI AUTOMATICI DI BASSA TENSIONE ................................................................................................................ 71
Interruttori magneto termici .................................................................................................................................................................... 72
Interruttori magnetotermici differenziali .................................................................................................................................................... 73
TUBAZIONI E CANALI PORTACAVI. ........................................................................................................................................ 73
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 2
Canale portacavi..................................................................................................................................................................................... 74
Tubazioni incassate................................................................................................................................................................................. 74
Tubazioni in vista.................................................................................................................................................................................... 75
Cassette di derivazione............................................................................................................................................................................ 75
CAVI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA .................................................................................................................................... 75
Cavi e conduttori di bassa tensione .......................................................................................................................................................... 75
Modalità di installazione delle linee elettriche............................................................................................................................................. 76
Morsetti di connessione ........................................................................................................................................................................... 76
APPARECCHI DI COMANDO E PRESE ELETTRICHE.................................................................................................................. 77
Apparecchi di comando ........................................................................................................................................................................... 77
Prese di corrente .................................................................................................................................................................................... 77
Prese di corrente per uso industriale......................................................................................................................................................... 78
APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE........................................................................................................................................... 78
Caratteristiche degli apparecchi................................................................................................................................................................ 79
Apparecchio compatto per controsoffitto ................................................................................................................................................... 79
APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA.................................................................................................................. 79
Caratteristiche degli apparecchi................................................................................................................................................................ 80
IMPIANTO DI PROTEZIONE ED EQUIPOTENZIALIZZAZIONE.................................................................................................... 80
Conduttore di protezione ......................................................................................................................................................................... 81
Collettore o nodo di terra ........................................................................................................................................................................ 81
Conduttori equipotenziali ......................................................................................................................................................................... 81
Equalizzazione del potenziale ................................................................................................................................................................... 81
IMPIANTI SPECIALI ED A BASSISSIMA TENSIONE .................................................................................................................. 81
Impianto cablaggio strutturato ................................................................................................................................................................. 81
Apparati ................................................................................................................................................................................................ 82
Impianto Interfonico ............................................................................................................................................................................... 82
Impianto rivelazione fumi ........................................................................................................................................................................ 83
Impianto diffusione sonora ...................................................................................................................................................................... 85
Impianto di chiamata .............................................................................................................................................................................. 86
Impianto di televisione a circuito chiuso .................................................................................................................................................... 86
BARRIERE TAGLIA FIAMMA ................................................................................................................................................... 87
Diaframma resistente al fuoco in sacchetti ................................................................................................................................................ 87
Diaframma resistente al fuoco in materiale intuminescente ......................................................................................................................... 87
ELENCO MARCHE.................................................................................................................................................................. 88
ALLEGATO 1 ......................................................................................................................................................................... 89
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 3
OPERE EDILI
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 4
QUALITÀ DEI MATERIALI E COMPONENTI
MATERIALI IN GENERE
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la realizzazione delle opere, dovranno essere scelti e selezionati dalla ditta Appaltatrice, secondo criteri di sua convenienza,
purché rispondenti alle caratteristiche di qualità e prestazione conformi, in ordine di priorità, ai seguenti criteri:
• Indicazioni e prescrizioni contenute negli elaborati progettuali, con la seguente linea di prevalenza;
• Disciplinare tecnico;
• Tavole grafiche;
• Elenco prezzi;
• Per quanto non espressamente citato in relazione alla qualità dei materiali e dei componenti, si farà
riferimento, anche se non allegato materialmente al presente capitolato di appalto, al “Capitolato
Speciale Tipo per Lavori Edili”, approvato dall’Assemblea Generale dei Lavori Pubblici nel 14 dicembre 1990, così come aggiornato e integrato;
• Normativa UNI-EN;
• Schede tecniche di applicazione dei prodotti;
• Norme di buona tecnica.
Tutti i materiali impiegati, sia per le opere civili che per gli impianti meccanici e elettrici, dovranno rispondere
alle norme UNI, CNR, CEI di prova e di accettazione, ed alle tabelle UNEL in vigore; nonché alle altre norme
e prescrizioni richiamate nella descrizione dei lavori e nelle specifiche tecniche. Resta comunque stabilito che
tutti i materiali, componenti e le loro parti, opere e manufatti, dovranno risultare rispondenti alle norme emanate dai vari organi, enti e associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento dell’aggiudicazione
dei lavori o che vengano emanate prima dell’ultimazione dei lavori stessi.
Ogni approvazione rilasciata dalla Direzione Lavori non costituisce implicita autorizzazione in deroga alle specifiche tecniche facenti parte degli elaborati contrattuali, a meno che tale eventualità non venga espressamente citata e motivata negli atti approvativi.
L’Appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o a fare eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato Speciale o espressamente ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere. Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del C.N.R., verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.
Tutti i materiali, le apparecchiature i componenti e quanto altro l’Appaltatore intenda utilizzare deve, tuttavia, essere sottoposto alla preventiva approvazione del Direttore dei Lavori, corredato da schede tecniche,
certificazioni, campioni e quanto altro occorra per dimostrarne la conformità e la accettabilità. Le forniture
non accettate, ad insindacabile giudizio, dalla Direzione Lavori dovranno essere immediatamente allontanate
dal cantiere, a cura e spese dell’Appaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
L’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in
ogni caso, non pregiudica i diritti che il Committente si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.
ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI
Tutti i leganti dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno ben riparati dall’umidità o
in sili. Per la misurazione, sia a peso che a volume, il legante dovrà essere perfettamente asciutto.
Acqua
L’acqua per l’impasto con leganti idraulici dovrà essere dolce, limpida priva di sostanze organiche o grassi e
priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante. Nel caso in cui si rendesse necessario, dovrà essere trattata per permettere un grado di
purità adatto all’intervento da eseguire, oppure additivata per evitare l’insorgere di reazioni chimico/fisiche
con produzione di sostanze pericolose. In merito si veda l’allegato I del D.M. 9 gennaio 1996.
Calci
Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R.D. 2231/1939; le calci
idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 595/1965 “Caratteristiche tecni__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 5
che e requisiti dei leganti idraulici” nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972
“Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche”.
In particolare si prescrive che:
• la calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura di colore
uniforme, non bruciata, né vitrea né pigra ad idratarsi ed infine di qualità tale che, mescolata con la
sola quantità d’acqua dolce necessaria all’estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a
grassetto tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, siliciose od altrimenti inerti;
• la calce viva, al momento dell’estinzione, dovrà essere perfettamente anidra; sarà rifiutata quella ridotta in polvere o sfiorita, e perciò si dovrà provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla comunque in luoghi asciutti e ben riparati dall’umidità;
• l’estinzione della calce viva dovrà farsi con i migliori sistemi conosciuti ed, a seconda delle prescrizioni della direzione dei lavori, in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura. La calce grassa destinata agli intonaci dovrà essere spenta almeno sei mesi prima dell’impiego.
Cementi e agglomerati cementizi
I cementi devono rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 595/1965 e nel D.M. 03.06.1968
“Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi” e successive modifiche. Gli agglomerati cementizi devono rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 595/1965 e nel D.M.
31.08.1972 e successive modifiche.
A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Industria 126/1988 (Regolamento del Servizio di
Controllo e certificazione di qualità dei cementi), i cementi di cui all’arti lettera A) della legge 595/1965 (e
cioè i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d’alto forno), se utilizzati per confezionare
il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di
cui all’art. 6 della legge 595/1965 e all’art. 20 della legge 1086/1971.
I cementi devono essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall’umidità da altri agenti capaci di
degradarli prima dell’impiego.
MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE
Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi
non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc, in proporzioni non nocive all’indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed
all’ingombro delle armature. La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.
Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti aeranti; fluidificanti ritardanti; fluidificanti acceleranti; antigelo super fluidificanti. Per le
modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potrà far eseguire prove od accettare
l’attestazione di conformità alle norme secondo i criteri di cui al precedente art. 1.
I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al
D.M. 09.01.1996 “Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in E.A. normale e
precompresso e delle strutture metalliche”, le relative circolari esplicative e le eventuali successive modifiche
e/o integrazioni.
ELEMENTI IN LATERIZIO E CALCESTRUZZO
Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio o in calcestruzzo) possono
essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.
Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute
nel D.M. 20.11.1987 “Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e
per il loro consolidamento”.
Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a
quelle della norma UNI 8942/2.
Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni
del succitato D.M. 20.11.1987.
La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 6
delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel
D.M. di cui sopra.
E’ facoltà del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli
elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.
ARMATURE PER CALCESTRUZZO
Gli acciai per l’armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente
D.M. in data 09.01.1996 attuativo della legge 1086/1971 e relative circolari esplicative.
E’ fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all’origine. I campioni verranno prelevati in contraddittorio
con l’Impresa ed inviati a cura della D.L. ed a spese dell’Impresa ad un Laboratorio Ufficiale; di tale operazione dovrà essere redatto apposito verbale controfirmato dalle parti. La D.L. darà benestare per la posa in
opera delle partite sottoposte all’ulteriore controllo in cantiere soltanto dopo che avrà ricevuto il relativo certificato di prova e ne avrà constatato l’esito positivo. Nel caso di esito negativo si procederà come indicato
nel D.M. min. LL. PP. 9.1.1996.
Gli acciai per le armature metalliche delle opere in cemento armato saranno usati in barre tonde lisce oppure
ad aderenza migliorata.
PRODOTTI DI PIETRE NATURALI O RICOSTRUITE
Le pietre naturali da impiegarsi per qualsiasi lavoro dovranno corrispondere alle norme in vigore e dovranno
essere a grana compatta ed ognuna monda da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro
impiego ed offrire una resistenza proporzionata all’entità della sollecitazione cui devono essere assoggettate.
Saranno escluse le pietre alterabili all’azione degli agenti atmosferici e dell’acqua corrente. Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere sonore alla percussione,
immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilità.
La terminologia utilizza ha il significato di seguito riportato, le denominazioni commerciali devono essere riferite a campioni, atlanti, ecc.
PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONI
Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell’intero
sistema di pavimentazione.
Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all’articolo sulla esecuzione delle pavimentazioni.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro
accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
Prodotti in gomma
I prodotti di gomma per pavimentazione sotto forma di piastrelle e rotoli devono rispondere alle prescrizioni
date dal progetto e in mancanza e/o a complemento, devono rispondere alle prescrizioni seguenti:
• essere esenti da difetti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle superfici destinate a restare in
vista;
• avere costanza di colore tra i prodotti della stessa fornitura; in caso di contestazione deve risultare
entro il contrasto dell’elemento n. 4 della scala dei grigi di cui alla norma UNI 8272-2. Per piastrelle
di forniture diverse ed in caso di contestazione vale il. contrasto dell’elenco n. 3 della scala dei grigi;
sulle dimensioni nominali ed ortogonalità dei bordi sono ammesse le tolleranze seguenti:
- piastrelle: lunghezza e larghezza +0,3% spessore +0,2 mm;
- rotoli: lunghezza +1%, larghezza +0,3%, spessore +0,2 mm;
- piastrelle: scostamento dal lato teorico (in millimetri) non maggiore del prodotto tra dimensione del
lato (in millimetri) e 0,0012;
- rotoli: scostamento dal lato teorico non maggiore di 1,5 mm;
• la durezza deve essere tra 75 e 85 punti di durezza Shore A;
• la resistenza all’abrasione deve essere non maggiore di 300 mm3;
• la stabilità dimensionale a caldo deve essere non maggiore dello 0,3% per le piastrelle e dello 0,4%
per i rotoli;
• la classe di reazione al fuoco deve essere la prima secondo il D.M. 26.06.1984 allegato A3.1);
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 7
•
la resistenza alla bruciatura da sigaretta, inteso come alterazioni di colore prodotte dalla combustione, non deve originare contrasto di colore uguale o minore al n. 2 della scala dei grigi di cui alla
norma UNI 8272-2. Non sono inoltre ammessi affioramenti o rigonfiamenti;
• iI potere macchiante, inteso come cessione di sostanze che sporcano gli oggetti che vengono a contatto con il rivestimento, per i prodotti colorati non deve dare origine ad un contrasto di colore maggiore di quello dell’elemento n. 3 della scala dei grigi di cui alla UNI 8272-2. Per i prodotti neri il contrasto di colore non deve essere maggiore dell’elemento n. 2;
• il controllo delle caratteristiche di cui ai comma a) ad i) si intende effettuato secondo i criteri indicati
utilizzando la norma UNI 8272 (varie parti);
• i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
Il foglio di accompagnamento indicherà oltre al nome del fornitore almeno le informazioni di cui ai commi da
a) ad i).
Masselli di calcestruzzo
Per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla loro forma, dimensioni, colore e resistenza caratteristica; per la terminologia delle parti componenti il massello e delle geometrie di posa ottenibili si rinvia
alla documentazione tecnica. Essi devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza ,od a loro
completamento devono rispondere a quanto segue:
a.
essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superino le tolleranze dimensionali ammesse. Sulle dimensioni nominali è ammessa la tolleranza di 3 mm per un
singolo elemento e 2 mm quale media delle misure sul campione prelevato;
b.
le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza ±15% per il singolo massello e ±10% sulle medie;
c.
la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) non più del
15% per il singolo massello e non più del 10% per le medie;
d.
il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato dal fabbricanti;
e.
il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con tolleranza ±5%
per un singolo elemento e ±3 % per la media;
f.
la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm2 per il singolo
elemento e maggiore di 60 N/mm2 per la media.
I prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti dall’azione di
sostanze sporcanti. Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, almeno le caratteristiche di cui
sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa.
PRODOTTI PER COPERTURE E TAMPONATURE LOCALI TECNICI
Si definiscono prodotti per le coperture e tamponature quelli utilizzati per realizzare locali tecnici.
Per la realizzazione dei locali tecnici nel loro insieme si rinvia all’articolo sull’esecuzione dei locali tecnici.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori ai fini della loro
accettazione può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
Nel caso di contestazione si intende che le procedure di prelievo dei campioni, i metodi di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI citate di seguito.
Le lastre di metallo ed i loro pezzi speciali si intendono denominati secondo la usuale terminologia commerciale. Essi dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza ad a completamento alle seguenti caratteristiche:
a)
i prodotti completamente supportati: tolleranze di dimensioni e di spessore; resistenza al punzonamento, resistenza al piegamento a 360°; resistenza alla corrosione; resistenza a trazione; le
caratteristiche predette saranno quelle riferite al prodotto in lamina prima della lavorazione. Gli
effetti estetici e difetti saranno valutati in relazione alla collocazione dell’edificio;
b)
i prodotti autoportanti (compresi i pannelli, le lastre grecate, ecc.) oltre a rispondere alle prescrizioni predette dovranno soddisfare la resistenza a flessione secondo i carichi di progetto e la distanza tra gli appoggi. La fornitura dovrà essere accompagnata da foglio informativo riportante il
nome del fornitore e la rispondenza alle caratteristiche richieste.
Le lastre in alluminio Lega 5754 HI8 ed i loro pezzi speciali si intendono denominati secondo la usuale terminologia commerciale. Essi dovranno corrispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza a completamento delle seguenti caratteristiche: le lastre in alluminio indicate, devono essere corrispondenti alla norma-
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 8
tiva europea; le lastre verranno fornite in lastre piane, altrimenti verranno prodotte direttamente in cantiere
con una profilatrice attrezzata allo scopo, larghezza delle lastre compresa fra 500 mm e 650 mm; densità
compresa tra 2 e 3 g/cm3, temperatura di fusione circa 650°; coefficiente di dilatazione termica circa
0,000024 1/C°; allungamento massimo 5%; carico di rottura a trazione circa 300 N/mm; durezza BRMNEL
HB90.
Le caratteristiche predette saranno riferite al prodotto in lamina prima della lavorazione. Gli effetti estetici e
difetti saranno valutati in relazione alla loro collocazione.
La fornitura dovrà essere accompagnata da foglio informativo riportante il nome del fornitore e la rispondenza alle caratteristiche richieste.
Il fissaggio delle lastre dovrà essere eseguito mediante gruppi composti da staffe in poliammide PA6 30%
rinforzato vetro e viti mordenti in acciaio zincato.
PRODOTTI DI VETRO
Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro. Essi si
dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti di seconda lavorazione.
Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni, nonché
per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alle norme UNI EN 572-177’.
Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni
della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura.
PRODOTTI DIVERSI (SIGILLANTI, ADESIVI)
Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei lavori, ai
fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate. Per il campionamento dei
prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.
Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi
edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta
all’aria, all’acqua, ecc.
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, si intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche: compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati:
• diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al quale sono destinati;
• durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con decadimento delle
caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalità;
• durabilità alle azioni chimico/fisiche di agenti aggressivi presenti nell’atmosfera o nell’ambiente di
destinazione.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto
od alle norme UNI 9610 e UNI 9611 e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.
Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente,
resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all’ambiente ed alla destinazione d’uso.
Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi
e per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc). Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di
prodotti o componenti.
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, si intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:
• compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati;
• durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un decadimento
delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità);
• durabilità alle azioni chimico - fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell’atmosfera o
nell’ambiente di destinazione;
• caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l’uso.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una
norma UNI e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati
dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori.
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 9
INFISSI
Per la terminologia specifica dei singoli elementi costituenti gli infissi e delle loro parti funzionali in caso di
dubbio verrà fatto riferimento alla norma UNI 8369 (varie parti).
Le modalità di posa sono sviluppate nell’articolo relativo alle vetrazioni ed ai serramenti.
Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, potrà procedere ai controlli (anche parziali) su campioni
della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nei disegni di
progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche
dovute all’azione del vento od agli urti, garantire la tenuta all’aria, all’acqua e la resistenza al vento.
Quanto richiesto dovrà garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico, comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose, atti vandalici, ecc.
Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo.
I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati seguendo le
prescrizioni indicate nei disegni costruttivi da predisporre a cura della Ditta Appaltatrice, conformemente a
quanto previsto nella parte grafica e nell’elenco prezzi di progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque nel loro insieme devono essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e contribuire, per la parte di loro spettanza, al
mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc; lo svolgimento delle funzioni predette deve essere mantenuto nel tempo.
Il Direttore dei lavori potrà procedere all’accettazione dei serramenti mediante il controllo dei materiali che
costituiscono l’anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti mediante il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori, e mediante il controllo delle sue caratteristiche
costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) e per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all’acqua, all’aria, al vento, e sulle
altre prestazioni richieste. Le modalità di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme
UNI in vigore per i serramenti.
Il Direttore dei lavori potrà altresì procedere all’accettazione dell’attestazione di conformità della fornitura alle
prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche. Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dal Direttore dei Lavori.
L’attestazione dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.
PRODOTTI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI
Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali (pareti facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell’edificio.
I prodotti si distinguono:
• a seconda del loro stato fisico rigidi (rivestimenti in pietra, ceramica, vetro, alluminio, gesso ecc);
flessibili (carte da parati, tessuti da parati, ecc); fluidi o pastosi (intonaci, vernicianti, rivestimenti
plastici, ecc);
• a seconda della loro collocazione per esterno; per interno;
• a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento di fondo; intermedi; di finitura.
Tutti i prodotti di seguito descritti in 19.2, 19.3 e 19.4 vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della
fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.
Prodotti rigidi
Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto. Le loro prestazioni meccaniche (resistenza all’urto, abrasione, incisione), di reazione e resistenza al fuoco, di resistenza agli agenti
chimici (detergenti, inquinanti aggressivi, ecc.) ed alle azioni termoigrometriche saranno quelle prescritte in
norme UNI, in relazione all’ambiente (interno/esterno) nel quale saranno collocati ed alla loro quota dal pavimento (o suolo), oppure in loro mancanza valgono quelle dichiarate dal fabbricante ed accettate dalla direzione dei lavori.
Saranno inoltre predisposti per il fissaggio in opera con opportuni fori, incavi, ecc.
Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc, le caratteristiche di resistenza all’usura, ai viraggi di colore, ecc. saranno riferite ai materiali di rivestimento.
La forma e costituzione dell’elemento saranno tali da ridurre al minimo fenomeni di vibrazione, produzione di
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 10
rumore tenuto anche conto dei criteri di fissaggio.
Per le lastre di cartongesso si rinvia all’articolo su prodotti per pareti esterne e partizioni interne.
Nota: In via orientativa valgono le prescrizioni della norma UNI 8981, (varie parti). Per gli elementi piccoli e
medi fino a 1,2 m come dimensione massima si debbono realizzare opportuni punti di fissaggio ed aggancio.
Per gli elementi grandi (pannelli prefabbricati) valgono per quanto applicabili e/o in via orientativa le prescrizioni dell’articolo sulle strutture prefabbricate di calcestruzzo.
Prodotti fluidi od in pasta
Gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legante (calce cemento gesso)
da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed eventualmente da pigmenti o terre coloranti, additivi e rinforzanti.
Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche seguenti:
• capacità di riempimento delle cavità ed eguagliamento delle superfici;
• reazione al fuoco e/o resistenza all’incendio adeguata;
• impermeabilità all’acqua e/o funzione di barriera all’acqua;
• effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;
• adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.
Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI è sinonimo di conformità alle prescrizioni predette; per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla direzione dei lavori.
I prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un legante (naturale o sintetico), da
una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo stato solido, formano una pellicola o uno
strato non pellicolare sulla superficie. Si distinguono in:
• tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie;
• impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosità del supporto;
• pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio;
• vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;
• rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm circa),
hanno colore proprio e disegno superficiale più o meno accentuato.
I prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione delle prestazioni loro richieste:
• dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;
• avere funzione impermeabilizzante;
• essere traspiranti al vapore d’acqua;
• impedire il passaggio dei raggi U.V.;
• ridurre il passaggio della CO2;
• avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto);
• avere funzione passivante del ferro (quando richiesto);
• resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);
• resistere (quando richiesto) all’usura.
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli dichiarati dal fabbricante
ed accettati dalla direzione dei lavori.
I dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova sono quelli definiti nelle norme UNI.
PRODOTTI PER ISOLAMENTO TERMICO
Si definiscono materiali isolanti termici quelli atti a diminuire in forma sensibile il flusso termico attraverso le
superfici sulle quali sono applicati (vedi classificazione tab. 1). Per la realizzazione dell’isolamento termico si
rinvia agli articoli relativi alle parti dell’edificio o impianti.
I materiali vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro
accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione per le caratteristiche si intende che la procedura di prelievo dei campioni, delle prove e della valutazione dei risultati sia
quella indicata nelle norme UNI EN 822, UNI EN 823, UNI EN 824, UNI EN 825 ed in loro mancanza quelli
della letteratura tecnica. I materiali isolanti si classificano come segue.
Materiali fabbricati in stabilimento: (blocchi, pannelli, lastre, feltri ecc)
Materiali cellulari:
• composizione chimica organica: plastici alveolari;
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 11
• composizione chimica inorganica: vetro cellulare, calcestruzzo alveolare autoclavato;
• composizione chimica mista: plastici cellulari con perle di vetro espanso.
Materiali fibrosi:
• composizione chimica organica: fibre di legno;
• composizione chimica inorganica: fibre minerali.
Materiali compatti:
• composizione chimica organica: plastici compatti;
• composizione chimica inorganica: calcestruzzo;
• composizione chimica mista: agglomerati di legno.
Combinazione di materiali di diversa struttura:
• composizione chimica inorganica: composti “fibre minerali-perlite”, calcestruzzi leggeri;
• composizione chimica mista: composti perlite-fibre di cellulosa, calcestruzzi di perle di polistirene.
Materiali multistrato:
• composizione chimica organica: plastici alveolari con parametri organici;
• composizione chimica inorganica: argille espanse con parametri di calcestruzzo, lastre di gesso associate a strato di fibre minerali;
• composizione chimica mista: plastici alveolari rivestiti di calcestruzzo.
I prodotti stratificati devono essere classificati nel gruppo A5. Tuttavia, se il contributo alle proprietà di isolamento termico apportato da un rivestimento è minimo e se il rivestimento stesso è necessario per la manipolazione del prodotto, questo è da classificare nei gruppi Al ad A4.
Materiali iniettati, stampati o applicati in sito mediante spruzzatura
Materiali cellulari applicati sotto forma di liquido o di pasta:
• composizione chimica organica: schiume poliuretaniche, schiume di ureaformaldeide;
• composizione chimica inorganica: calcestruzzo cellulare.
Materiali fibrosi applicati sotto forma di liquido o di pasta:
• composizione chimica inorganica: fibre minerali proiettate in opera.
Materiali pieni applicati sotto forma di liquido o di pasta:
• composizione chimica organica: plastici compatti;
• composizione chimica inorganica: calcestruzzo;
• composizione chimica mista: asfalto.
Combinazione di materiali di diversa struttura:
• composizione chimica inorganica: calcestruzzo di aggregati leggeri;
• composizione chimica mista: calcestruzzo con inclusione di perle di polistirene espanso.
Materiali alla rinfusa:
• composizione chimica organica: perle di polistirene espanso;
• composizione chimica inorganica: lana minerale in fiocchi, perlite;
• composizione chimica mista: perlite bitumata.
Per tutti i materiali isolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali:
a)
dimensioni: lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori;
b)
spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri
documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori;
c)
massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nelle norme UNI o negli altri documenti
progettuali; in assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua
documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori;
d)
resistenza termica specifica: deve essere entro i limiti previsti da documenti progettuali
(calcolo
in
base
alla legge 9 gennaio 1991 n. 10) ed espressi secondo i criteri indicati nella norma UNI
7357 e suoi FA 83-79 e 3-89).
Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto le seguenti caratteristiche:
• reazione o comportamento al fuoco;
• limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;
• compatibilità chimico - fisica con altri materiali.
Per i materiali isolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le stesse caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. Il Direttore dei Lavori può inoltre
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 12
attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera, ricorrendo ove necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito.
I metodi di controllo sono quelli definiti nelle norme UNI. Per le caratteristiche possedute intrinsecamente dal
materiale non sono necessari controlli.
PRODOTTI PER PARETI ESTERNE E PARTIZIONI INTERNE
Si definiscono prodotti per pareti esterne e partizioni interne quelli utilizzati per realizzare i principali strati
funzionali di queste parti di edificio.
Per la realizzazione delle pareti esterne e partizioni interne si rinvia all’articolo che tratta queste opere. I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato
di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione si intende che la
procedura di prelievo dei campioni, le modalità di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle
norme UNI ed in mancanza di questi quelli descritti nella letteratura tecnica ed indicati nelle norme UNI
7959, UNI 8201, UNI 8326, UNI 8327, UNI 8369/2 e 5 UNI 8979 ed UNI 9269 (provvisoria).
I prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale (vedere articolo murature)
ma unicamente di chiusura nelle pareti esterne e partizioni, devono rispondere alle prescrizioni del progetto
ed, a loro completamento, alle seguenti prescrizioni:
• gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante trafilatura o pressatura con materiale normale od alleggerito devono rispondere alla norma UNI 8942 parte 2°.;
• gli elementi di calcestruzzo dovranno rispettare le stesse caratteristiche indicate nella norma UNI
8942 (ad esclusione delle caratteristiche di inclusione calcarea), i limiti di accettazione saranno quelli
indicati nel progetto ed in loro mancanza quelli dichiarati dal produttore ed approvati dalla direzione
dei lavori;
• gli elementi di calcio silicato, pietra ricostruita, pietra naturale, saranno accettati in base alle loro caratteristiche dimensionali e relative tolleranze; caratteristiche di forma e massa volumica (foratura,
smussi, ecc); caratteristiche meccaniche a compressione, taglio e flessione; caratteristiche di comportamento all’acqua ed al gelo (imbibizione, assorbimento d’acqua, ecc).
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto ed in loro mancanza saranno quelli dichiarati dal
fornitore ed approvati dalla direzione dei lavori.
I prodotti ed i componenti per partizioni interne prefabbricate che vengono assemblate in opera (con piccoli
lavori di adattamento o meno) devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza, alle prescrizioni indicate al punto precedente.
I prodotti a base di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed, in mancanza, alle prescrizioni seguenti: avere spessore con tolleranze ± 0,5 mm, lunghezza e larghezza con tolleranza ± 2 mm,
resistenza all’impronta, all’urto, alle sollecitazioni localizzate (punti di fissaggio) ed, a seconda della destinazione d’uso, con basso assorbimento d’acqua, con bassa permeabilità al vapore (prodotto abbinato a barriera
al vapore), con resistenza all’incendio dichiarata, con isolamento acustico dichiarato.
I limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto ed, in loro mancanza, quelli dichiarati dal produttore ed approvati dalla direzione dei lavori.
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 13
MODALITÀ DI ESECUZIONE
RILEVATI E REINTERRI
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli
scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla direzione dei lavori, si
impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati.
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti
ovunque l’Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione
dei lavori.
Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose,
restando vietato in modo assoluto l’impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con
l’assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro
esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene
sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su
tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.
Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate
direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell’opera per essere riprese poi al
momento della formazione dei suddetti rinterri.
Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo
le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei lavori.
E’ vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell’Appaltatore. E’ obbligo dell’Appaltatore,
escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall’assestamento delle terre, affinché all’epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.
L’Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati
e compiendo a sue spese, durante l’esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la
ripresa e la sistemazione delle scarpate e l’espurgo dei fossi.
La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente scorticata, ove occorra,
e se inclinata sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte.
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Le demolizioni e/o rimozioni di murature, calcestruzzi, tavolati in cartongesso, ecc, sia parziali che complete,
dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue
pareti, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo; in particolare
la Ditta Appaltatrice dovrà prestare la massima cura e gli adeguati accorgimenti onde limitare al minimo indispensabile polvere, rumori e disagi ai servizi sanitari attivi. Per le opere che coinvolgano porzioni esterne alle
aree di intervento quali, ad esempio, i cavedi, l’Appaltatore dovrà predisporre un programma dettagliato, che
determini i tempi e le aree interessate, oltre a prevedere gli approntamenti provvisori che si intendono adottare per limitare al minimo il disturbo e l’interferenza con l’attività del reparto.
Per qualunque intervento rimane, comunque, vietato gettare dall’alto i materiali in genere, che invece dovranno essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature, che i calcestruzzi, quanto i materiali di risulta, dovranno essere opportunamente bagnati.
Nelle demolizioni e rimozioni la Ditta Appaltatrice dovrà inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che dovranno restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i
quali potranno ancora essere impiegati nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa
di danni a favore dell’Ente Appaltante.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, dovranno pure a cura e spese della Ditta Appaltatrice, senza alcun compenso, essere ricostruite e rimesse in ripristino le
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 14
parti indebitamente demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, dovranno essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione
stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento per
evitarne la dispersione. In particolare, per quanto riguarda gli infissi che verranno smontati e di cui non è
previsto il riutilizzo, l’Appaltatore dovrà provvedere a depositare nel luogo indicato dalla Direzione dei Lavori,
posto all’interno dell’area dell’Ospedale, quelli che l’Amministrazione intenderà conservare, mentre provvederà ad allontanare tutti gli altri.
Detti materiali resteranno tutti di proprietà dell’Ente Appaltante il quale potrà ordinare alla Ditta Appaltatrice
di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni dovranno sempre, dalla Ditta Appaltatrice, essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche, incluso l’onere del loro carico,
trasporto e scarico.
OPERE E STRUTTURE DI MURATURA
Malte per murature
L’acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche
di cui all’art. 2.
L’impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte è consentito, purché ogni fornitura sia accompagnata
da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantità dei leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il fornitore dovrà certificare con
prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa.
Le modalità per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel D. min. Ind.
Co min. art. 13.09.1993.
I tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte di diverse proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentate, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media a compressione risulti non inferiore ai
valori di cui al D.M. LL.PP. 20 novembre 1987, n. 103.
Murature in genere: criteri generali per l’esecuzione
Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle volte, piattabande, archi, e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per:
• ricevere le chiavi ed i capichiavi delle volte: gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T; le testate delle travi (di legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la formazione delle murature;
• il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell’acqua potabile, canne di stufe e camini,
scarico acqua usata, immondizie, ecc);
• per il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione; le imposte delle volte e degli archi;
• gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, ecc.
Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite.
La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le parti di esse. I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione.
Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rifluisca all’ingiro e riempia tutte le connessure.
La larghezza dei giunti non dovrà essere maggiore di 8 mm né minore di 5 mm.
I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all’intonaco od alla stuccatura col ferro.
Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per evitare che
i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.
Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente collegate
con la parte interna.
Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista (cortina) si dovrà avere cura di scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più uniforme, disponendoli con perfetta
regolarità e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 15
In questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente compressi e
lisciate con apposito ferro, senza sbavatura.
Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre
disposti in direzione normale alla curva dell’intradosso e la larghezza dei giunti non dovrà mai eccedere i 5
mm all’intradosso e 10 mm all’estradosso.
All’innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in
relazione al materiale impiegato.
I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi disgelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.
Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.
Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli addentellati
d’uso, sia col costruire l’origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite sagome, secondo quanto
verrà prescritto.
La Direzione dei lavori stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani e di porte e finestre siano collocati
degli architravi (cemento armato, acciaio) delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani,
allo spessore del muro ed al sovraccarico.
Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sarà eseguito un opportuno strato
(impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capillarità.
Si precisa che, per la formazione delle compartimentazioni REI, saranno impiegati i seguenti sistemi, a seconda delle circostanze, secondo quanto previsto dal progetto:
• nuove pareti REI 120;
• pareti esistenti da rendere REI 120.
Dei materiali che saranno impiegati la Ditta Appaltatrice dovrà consegnare al Direttore dei Lavori, al momento di ciascuna fornitura, la certificazione di omologazione sotto l’aspetto antincendio.
In corrispondenza di tracce, vani per cassette impianti, ecc, eseguite sulle murature di compartimentazione
antincendio, dovranno essere realizzati adeguati fazzoletti protettivi di intonaco antincendio.
OPERE E STRUTTURE DI CALCESTRUZZO
Impasti di conglomerato cementizio
Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità di quanto previsto
nell’allegato 1 del D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996.
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell’impasto, devono essere
adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.
Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato tenendo conto anche dell’acqua contenuta negli inerti.
Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovrà essere
scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.
L’impiego degli additivi dovrà essere subordinato all’accertamento della assenza di ogni pericolo di aggressività.
L’impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.
Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 9858 che precisa le specifiche tecniche dei
materiali costituenti il calcestruzzo, la sua composizione e le proprietà del calcestruzzo fresco e indurito. Fissa inoltre i metodi per la verifica, la produzione, il trasporto, consegna, getto e stagionatura del calcestruzzo
e le procedure di controllo della sua qualità.
Controlli sul conglomerato cementizio
Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto dall’allegato 2 del D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996.
Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto specificato nel suddetto allegato 2 del D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996.
La resistenza caratteristica del conglomerato dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal progetto.
Norme di esecuzione per il cemento armato normale.
Nelle esecuzione delle opere di cemento armato normale l’appaltatore dovrà attenersi alle norme contenute
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 16
nella legge 1086/1971, e nelle relative norme tecniche del D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996. In particolare:
a)
Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione
dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto. Il getto deve essere
convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno
tre giorni. Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0°C, salvo il ricorso ad opportune cautele.
b)
Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate.
Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:
- saldature eseguite in conformità delle norme in vigore sulle saldature;
- manicotto filettato;
- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l’ancoraggio di ciascuna barra, in ogni caso
la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la
prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compressa. La distanza
mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro.
c)
Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore
di 6 volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto 5.3.3 del
D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996. Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo.
d)
La superficie dell’armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure devono essere aumentate, e al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a
4 per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina ed altri agenti aggressivi. Copriferri
maggiori richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio reti). Le
superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potrà derogare a
quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le
coppie ad almeno 4 cm. Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del
cerchio circoscritto.
e)
II disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all’impiego della struttura all’atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze
progettuali e costruttive; la decisione è lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.
Norme di esecuzione per il cemento armato precompresso
Nella esecuzione delle opere di cemento armato precompresso l’appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni
contenute nelle attuali norme tecniche del D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996. In particolare:
• il getto deve essere costipato per mezzo di vibratori ad ago od a lamina, ovvero con vibratori esterni,
facendo particolare attenzione a non deteriorare le guaine dei cavi;
• le superfici esterne dei cavi post-tesi devono distare dalla superficie del conglomerato non meno di
25 mm nei casi normali, e non meno di 35 mm in caso di strutture site all’esterno o in ambiente aggressivo. Il ricoprimento delle armature pre-tese non deve essere inferiore a 15 mm o al diametro
massimo dell’inerte impiegato, e non meno di 25 mm in caso di strutture site all’esterno o in ambiente aggressivo;
• nel corso dell’operazione di posa si deve evitare, con particolare cura, di danneggiare l’acciaio con
intagli, pieghe, ecc.;
• si deve altresì prendere ogni precauzione per evitare che i fili subiscano danni di corrosione sia nei
depositi di approvvigionamento sia in opera, fino ultimazione della struttura. All’atto della messa in
tiro si debbono misurare contemporaneamente lo sforzo applicato e l’allungamento conseguito; i due
lati debbono essere confrontati tenendo presente la forma del diagramma “sforzi, allungamenti” a
scopo di controllo delle perdite per attrito. Per le operazioni di tiro, ci si atterrà a quanto previsto al
punto 6.2.4.1 del succitato D.M.
L’esecuzione delle guaine, le caratteristiche della malta, le modalità delle iniezioni devono egualmente rispettare le suddette norme.
Responsabilità per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso
Nella esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l’appaltatore dovrà attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nella legge 1086/1971.
Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza della legge 64/1974, e del D.M. 16 gennaio
1996.
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 17
Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell’opera, appaltata saranno eseguiti in base ai calcoli di stabilità accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un tecnico abilitato iscritto all’Albo, e che l’appaltatore dovrà presentare alla Direzione dei lavori entro il termine che
gli verrà prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle
norme che gli verranno impartite, a sua richiesta, all’atto della consegna dei lavori.
L’esame e verifica da parte della Direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non
esonera in alcun modo l’appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilità loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto.
SOLAI
Generalità
Le coperture degli ambienti e dei vani e le suddivisioni orizzontali tra gli stessi potranno essere eseguite a
seconda delle indicazioni di progetto, con solai di uno dei tipi descritti negli articoli successivi. I solai di partizione orizzontale (interpiano) e quelli di copertura dovranno essere previsti per sopportare, a seconda della
destinazione prevista per i locali relativi, i carichi comprensivi degli effetti dinamici ordinari, previsti ai punti 5
e 6 dell’allegato al D.M. LL.PP. 16 gennaio 1996 “Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di
sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”.
Solai su travi e travetti di legno
Le travi principali di legno avranno le dimensioni e le distanze che saranno indicate in relazione alla luce ed
al sovraccarico.
I travetti (secondari) saranno collocati alla distanza, fra asse e asse, corrispondente alla lunghezza delle tavelle che devono essere collocate su di essi e sull’estradosso delle tavelle deve essere disteso uno strato di
calcestruzzo magro di calce idraulica formato con ghiaietto fino o altro materiale inerte.
Solai su travi di ferro a doppio T (putrelle) con voltine di mattoni (pieni o forati) o con elementi
laterizi interposti
Questi solai saranno composti dalle travi, dai copriferri, dalle voltine di mattoni (pieni o forati) o dai tavelloni
o dalle volterrane ed infine dal riempimento.
Le travi saranno delle dimensioni previste nel progetto o collocate alla distanza prescritta; in ogni caso tale
distanza non sarà superiore ad 1 m. Prima del loro collocamento in opera dovranno essere protette con trattamento anticorrosivo e forate per l’applicazione delle chiavi, dei tiranti e dei tondini di armatura delle piattabande.
Le chiavi saranno applicate agli estremi delle travi alternativamente (e cioè una con le chiavi e la successiva
senza), ed i tiranti trasversali, per le travi lunghe più di 5 m, a distanza non maggiore di 2,50 m.
Le voltine di mattoni pieni o forati saranno eseguite ad una testa in malta comune od in foglio con malta di
cemento a rapida presa, con una freccia variabile fra cinque e dieci centimetri.
Quando la freccia è superiore ai 5 cm dovranno intercalarsi fra i mattoni delle voltine delle grappe di ferro
per meglio assicurare l’aderenza della malta di riempimento dell’intradosso.
I tavelloni e le volterrane saranno appoggiati alle travi con l’interposizione di copriferri.
Le voltine di mattoni, le volterrane ed i tavelloni, saranno poi ricoperti sino all’altezza dell’ala superiore della
trave e dell’estradosso delle voltine e volterrane, se più alto, con scoria leggera di fornace o pietra pomice o
altri inerti leggeri impastati con malta magra fino ad intasamento completo.
Quando la faccia inferiore dei tavelloni o volterrane debba essere intonacata sarà opportuno applicarvi preventivamente uno strato di malta cementizia ad evitare eventuali distacchi dall’intonaco stesso.
Solai di cemento armato o misti: generalità e classificazione
Nei successivi punti sono trattati i solai realizzati esclusivamente in calcestruzzo armato o calcestruzzo armato precompresso o misti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi in laterizio od in altri materiali.
Vengono considerati sia i solai eseguiti in opera che quelli formati dall’associazione di elementi prefabbricati.
Per tutti i solai valgono le prescrizioni già date per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato
precompresso, ed in particolare valgono le prescrizioni contenute nel D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996 “Norme
tecniche per l’esecuzione delle opere in calcestruzzo armato normale e precompresso ed a struttura metallica”.
I solai di calcestruzzo armato o misti sono così classificati:
1) solai con getto pieno: di calcestruzzo armato o di calcestruzzo armato precompresso; solai misti di calcestruzzo armato o calcestruzzo armato precompresso e blocchi interposti di alleggerimento collaboranti e
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 18
non, di laterizio od altro materiale; solai realizzati dall’associazione di elementi di calcestruzzo armato o
calcestruzzo armato precompresso prefabbricati con unioni e/o getti di completamento.
Per i solai del tipo 1) valgono integralmente le prescrizioni dell’articolo “Opere e Prescrizioni in calcestruzzo”,
i solai del tipo 2) e 3) sono soggetti anche alle norme complementari riportate nei successivi punti.
Solai misti di calcestruzzo armato o calcestruzzo armato precompresso e blocchi forati di laterizio.
I solai misti di cemento armato normale o precompresso e blocchi forati di laterizio si distinguono nelle seguenti categorie: solai con blocchi aventi funzione principale di alleggerimento; solai con blocchi aventi funzione statica in collaborazione con il conglomerato. I blocchi di cui al punto 2), devono essere conformati in
modo che, nel solaio in opera sia assicurata con continuità la trasmissione degli sforzi dall’uno all’altro elemento. Nel caso si richieda al laterizio il concorso alla resistenza agli sforzi tangenziali, si devono usare elementi monoblocco disposti in modo che nelle file adiacenti, comprendenti una nervatura di conglomerato, i
giunti risultino sfalsati tra loro. In ogni caso, ove sia prevista una soletta di conglomerato staticamente
integrativa di altra di laterizio, quest’ultima deve avere forma e finitura tali da assicurare la solidarietà ai fini
della trasmissione degli sforzi tangenziali. Per entrambe le categorie il profilo dei blocchi delimitante la nervatura di conglomerato da gettarsi in opera non deve presentare risvolti che ostacolino il deflusso di calcestruzzo e restringano la sezione delle nervature stesse.
La larghezza minima delle nervature di calcestruzzo per solai con nervature gettate o completate in opera
non deve essere minore di 1/8 dell’interasse e comunque non inferiore a 8 cm. Nel caso di produzione di serie in stabilimento di pannelli di solaio completi, il limite minimo predetto potrà scendere a 5 cm. L’interasse
delle nervature non deve in ogni caso essere maggiore di 15 volte lo spessore medio della soletta. Il blocco
interposto deve avere dimensione massima inferiore a 52 cm.
Caratteristiche dei blocchi
Spessore delle pareti e dei setti dei blocchi.
Lo spessore delle pareti orizzontali compresse non deve essere minore di 8 min, quello delle pareti perimetrali non minore di 8 mm, quello dei setti non minore di 7 mm. Tutte le intersezioni dovranno essere raccordate con raggio di curvatura, al netto delle tolleranze, maggiore di 3 mm.
Si devono adottare forme semplici, caratterizzate da setti rettilinei ed allineati, particolarmente in direzione
orizzontale, con setti con rapporto spessore lunghezza il più possibile uniforme. Il rapporto fra l’area complessiva dei fori e l’area lorda delimitata dal perimetro della sezione del blocco non deve risultare superiore a
0,670-^625 h, ove h è l’altezza del blocco in metri.
Caratteristiche fisico/meccaniche.
La resistenza caratteristica a compressione, riferita alla sezione netta delle pareti e delle costolature deve risultare non minore di:
• 30 N/mm2 nella direzione dei fori; 15 N/mm2 nella direzione trasversale ai fori; per i blocchi di cui alla categoria a2);
• 15 N/mm2 nella direzione dei fori; 5 N/mm2 nella direzione trasversale ai fori; per i blocchi di cui alla
categoria a1).
La resistenza caratteristica a trazione per flessione dovrà essere non minore di 10 N/mm2 per i blocchi di tipo
a2) e di: 7 N/mm2 per i blocchi di tipo a1).
Speciale cura deve essere rivolta al controllo dell’integrità dei blocchi con particolare riferimento alla eventuale presenza di fessurazioni.
Spessore minimo dei solai.
Lo spessore dei solai a portanza unidirezionale che non siano di semplice copertura non deve essere minore
di 1/25 della luce di calcolo ed in nessun caso minore di 12 cm. Per i solai costituiti da travetti precompressi
e blocchi interposti il predetto limite può scendere ad 1/30. Le deformazioni devono risultare compatibili con
le condizioni di esercizio del solaio e degli elementi costruttivi ed impiantistici ad esso collegati.
Spessore minimo della soletta.
Nei solai del tipo a1) lo spessore minimo del calcestruzzo della soletta di conglomerato non deve essere minore di 4 cm.
Nei solai del tipo a2), può essere omessa la soletta di calcestruzzo e la zona rinforzata di laterizio, per altro
sempre rasata con calcestruzzo, può essere considerata collaborante e deve soddisfare i seguenti requisiti:
possedere spessore non minore di 1/5 dell’altezza, per solai con altezza fino a 25 cm, non minore di 5 cm
per solai con altezza maggiore; avere area effettiva dei setti e delle pareti, misurata in qualunque sezione
normale alla direzione dello sforzo di compressione, non minore del 50 % della superficie lorda.
Protezione delle armature.
Nei solai, la cui armatura è collocata entro scanalature, qualunque superficie metallica deve risultare conformata in ogni direzione da uno spessore minimo di 5 mm di malta cementizia Per armatura collocata entro
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 19
nervatura, le dimensioni di questa devono essere tali da consentire il rispetto dei seguenti limiti, distanza
netta tra armatura e blocco 8 mm; distanza netta tra armatura ed armatura 10 mm. Per quanto attiene la
distribuzione delle armature trasversali, longitudinali, per taglio, si fa riferimento alle citate norme contenute
nel D.M. del 9 gennaio 1996.
In fase di esecuzione, prima di procedere ai getti, i laterizi devono essere convenientemente bagnati.
Gli elementi con rilevanti difetti di origine o danneggiati durante la movimentazione dovranno essere eliminati.
Conglomerati per i getti in opera.
Si dovrà studiare la composizione del getto in modo da evitare rischi di segregazione o la formazione di nidi
di ghiaia e per ridurre l’entità delle deformazioni differite. Il diametro massimo degli inerti impiegati non dovrà superare 1/5 dello spessore minimo delle nervature né la distanza netta minima tra le armature. Il getto
deve essere costipato in modo da garantire l’avvolgimento delle armature e l’aderenza sia con i blocchi sia
con eventuali altri elementi prefabbricati.
Solai prefabbricati
Tutti gli elementi prefabbricati di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso destinati alla formazione di solai privi di armatura resistente al taglio o con spessori, anche locali, inferiori ai 4 cm, devono
essere prodotti in serie controllata. Tale prescrizione è obbligatoria anche per tutti gli elementi realizzati con
calcestruzzo di inerte leggero o calcestruzzo speciale.
Per gli orizzontamenti in zona sismica, gli elementi prefabbricati devono avere almeno un vincolo che sia in
grado di trasmettere le forze orizzontali a prescindere dalle resistenze di attrito. Non sono comunque ammessi vincoli a comportamento fragile.
Quando si assuma l’ipotesi di comportamento a diaframma dell’intero orizzontamento, gli elementi dovranno
essere adeguatamente collegati tra di loro e con le travi o i cordoli di testata laterali.
Solai misti di calcestruzzo armato o calcestruzzo armato precompresso e blocchi diversi dal laterizio
Classificazioni.
I blocchi con funzione principale di alleggerimento, possono essere realizzati anche con materiale diversi dal
laterizio (calcestruzzo leggero di argilla espansa, calcestruzzo normale sagomato, materie plastiche, elementi
organici mineralizzati, ecc).
Il materiale dei blocchi deve essere stabile dimensionalmente. Ai fini statici si distinguono due categorie di
blocchi per solai: a1) blocchi collaboranti; a2) blocchi non collaboranti.
Blocchi collaboranti:
• devono avere modulo elastico superiore a 8 kN/mm2 ed inferiore a 25 kN/mm2;
• devono essere totalmente compatibili con il conglomerato con cui collaborano sulla base di dati e caratteristiche dichiarate dal produttore e verificate dalla Direzione dei lavori. Devono soddisfare a tutte le caratteristiche fissate per i blocchi di laterizio della categoria a2).
Blocchi non collaboranti:
• devono avere modulo elastico inferiore ad 8 kN/mm2 e svolgere funzioni di solo alleggerimento. Solai con blocchi non collaboranti richiedono necessariamente una soletta di ripartizione, dello spessore
minimo di 4 cm, armata opportunamente e dimensionata per la flessione trasversale. Il profilo e le
dimensioni dei blocchi devono essere tali da soddisfare le prescrizioni dimensionali imposte per i
blocchi di laterizio non collaboranti.
Spessori minimi.
Per tutti i solai, così come per i componenti collaboranti, lo spessore delle singole parti di calcestruzzo contenenti armature di acciaio non potrà essere minore di 4 cm.
Solai realizzati con l’associazione di elementi di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso prefabbricati
Oltre le prescrizioni indicate nei punti precedenti, in quanto applicabili, sono da tenere presenti le seguenti
prescrizioni.
a)
L’altezza minima non può essere minore di 8 cm. Nel caso di solaio vincolato in semplice appoggio monodirezionale, il rapporto tra luce di calcolo del solaio e spessore del solaio stesso non
deve essere superiore a 25. Per solai costituiti da pannelli piani, pieni od alleggeriti, prefabbricati
precompressi (tipo 3) senza soletta integrativa, in deroga alla precedente limitazione, il rapporto
sopra indicato può essere portato a 35. Per i solai continui, in relazione al grado di incastro o di
continuità realizzato agli estremi, tali rapporti possono essere incrementati fino ad un massimo
del 20%. E’ ammessa deroga alle prescrizioni di cui sopra qualora i calcoli condotti con riferi__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 20
b)
c)
mento al reale comportamento della struttura (messa in conto dei comportamenti non lineari,
fessurazione, affidabili modelli di previsione viscosa, ecc.) anche eventualmente integrati da idonee sperimentazioni su prototipi, non superino i limiti indicati nel D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996. Le
deformazioni devono risultare in ogni caso compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e
degli elementi costruttivi ed impiantistici ad esso collegati.
Per i solai alveolari, per elementi privi di armatura passiva d’appoggio, il getto integrativo deve
estendersi all’interno degli alveoli interessati dalla armatura aggiuntiva per un tratto almeno pari
alla lunghezza di trasferimento della precompressione.
Solai con getto di completamento: la soletta gettata in opera deve avere uno spessore non inferiore a 4 cm ed essere dotata di una armatura di ripartizione a maglia incrociata.
STRUTTURE IN ACCIAIO
Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dalla legge
1086/1971, “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”, dalla legge 64/1974, “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni
per le zone sismiche”, dalle Circolari e dai Decreti Ministeriali in vigore attuativi delle leggi citate.
L’impresa sarà tenuta a presentare in tempo utile, prima dell’approvvigionamento dei materiali, all’esame ed
all’approvazione della Direzione dei lavori: gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina, sui quali dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualità,
dimensioni, grado di finitura e peso teorici di ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualità degli acciai da impiegare; tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche
sulle opere di fondazione. I suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell’Appaltatore.
Collaudo tecnologico dei materiali
Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio pervengono dagli stabilimenti per la
successiva lavorazione, l’Impresa darà comunicazione alla Direzione dei lavori specificando, per ciascuna colata, la distinta dei pezzi ed il relativo peso, la destinazione costruttiva e la documentazione di accompagnamento della ferriera costituita da:
• attestato di controllo;
• dichiarazione che il prodotto è “qualificato” secondo le norme vigenti.
La Direzione dei lavori si riserva la facoltà di prelevare campioni di prodotto qualificato da sottoporre a prova
presso laboratori di sua scelta ogni volta che lo ritenga opportuno, per verificarne la rispondenza alle norme
di accettazione ed ai requisiti di progetto. Per i prodotti non qualificati la Direzione dei lavori deve effettuare
presso laboratori ufficiali tutte le prove meccaniche e chimiche in numero atto a fornire idonea conoscenza
delle proprietà di ogni lotto di fornitura. Tutti gli oneri relativi alle prove sono a carico dell’impresa.
Le prove e le modalità di esecuzione sono quelle prescritte dal D.M. 9 gennaio 1996 ed altri eventuali a seconda del tipo di metallo in esame.
Controlli in corso di lavorazione
L’Impresa dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei materiali
impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovrà esibire la
copia a richiesta della Direzione dei lavori.
Alla Direzione dei lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i
controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture
siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d’arte. Ogni volta che le
strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo l’impresa informerà la Direzione dei lavori, la
quale darà risposta entro 8 giorni fissando la data del collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la
spedizione delle strutture stesse in cantiere.
Montaggio
Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato in conformità a quanto, a tale riguardo, è previsto nella relazione di calcolo. Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito
ed il montaggio, si dovrà porre la massima cura per evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate.
Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette. Il
montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, nel
rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo.
In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovrà controllare che la controfreccia ed il posi-
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 21
zionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze
previste.
La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo quando essi risulteranno staticamente
superflui.
Nei collegamenti con bulloni si dovrà procedere alla alesatura di quei fori che non risultino centrati e nei quali
i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro sopraccitato, si dovrà procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore. E’ ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questo venga controllato con chiave dinamometrica, la cui taratura dovrà risultare da certificato rilasciato da laboratorio ufficiale in data non anteriore ad un
mese.
Per le unioni con bulloni, l’impresa effettuerà, alla presenza della Direzione dei lavori, un controllo di serraggio su un numero adeguato di bulloni.
L’assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovrà essere effettuato senza che venga interrotto il
traffico di cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo brevi interruzioni durante le operazioni di
sollevamento, da concordare con la Direzione dei lavori.
Nella progettazione e nell’impiego delle attrezzature di montaggio, l’impresa è tenuta a rispettare le norme,
le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo
alla zona interessata, ed in particolare: per l’ingombro degli alvei dei corsi d’acqua;
per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie, ecc: per
le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo.
Prove di carico e collaudo statico
Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e, di regola,
prima che siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verrà eseguita da parte della Direzione
dei lavori una accurata visita preliminare di tutte le membrature per constatare che le strutture siano state
eseguite in conformità ai relativi disegni di progetto, alle buone regole d’arte ed a tutte le prescrizioni di contratto.
Ove nulla osti, si procederà quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture; operazioni che
verranno condotte, a cura e spese dell’impresa, secondo le prescrizioni contenute nei decreti Ministeriali,
emanati in applicazione della Legge 1071/1971.
In particolare le strutture in acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto
dalla legge 1086/1971, dalla legge 64/1974 e dalle circolari e decreti ministeriali in vigore attuativi delle leggi
citate.
Varie
I basamenti metallici di sostegno degli impianti, ad esempio quelli della U.T.A. e quanto altro, dovranno essere realizzati con profilati di dimensioni adeguate, estesi oltre gli impianti da sostenere della lunghezza necessaria per trasmettere sollecitazioni compatibili con la struttura muraria, anche col ricorso a traverse o ripartitori; saranno assemblati preferibilmente fuori opera, con saldatura continua e successivamente zincati a
caldo per immersione; sono ammesse giunzioni bullonate solo nel caso non sia possibile, per questioni di ingombro, procedere diversamente; per la posa in opera si dovrà prevedere uno strato di compensazione di
materiale adeguato da interporre tra la struttura muraria ed i basamenti, oltre ad idonei sistemi di fissaggio,
meccanici o chimici.
Per tutte le strutture metalliche, prima della fornitura l’Appaltatore dovrà consegnare al Direttore dei Lavori
tutta la necessaria documentazione tecnica consistente nei piani di costruzione e nelle certificazioni, per le
verifiche di idoneità; dopo l’approvazione del Direttore dei Lavori e prima della posa in opera dovrà essere
depositata la prescritta documentazione agli organi di controllo, ove necessaria per legge.
RIVESTIMENTI INTERNI E TINTEGGIATURE
Questi dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni del progetto, conformemente alle normative UNI,
EN, ecc. di riferimento, a completamento del progetto sulla base delle seguenti indicazioni.
Sistemi realizzati con prodotti resilienti
Per la stesura dei teli del rivestimento resiliente si dovrà procedere alla posa su supporto esistente o su letto
di malta, o prodotto livellante avente adeguate caratteristiche di resistenza meccanica, planarità, ecc. in modo da applicare successivamente uno strato di collegamento (od ancoraggio) costituito da adesivi aventi adeguate compatibilità chimica e termica con lo strato ripartitore e con il rivestimento. Durante la posa del ri-
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 22
vestimento si dovrà curare l’esecuzione dei giunti, il loro allineamento, la saldatura termica, la planarità della
superficie risultante ed il pieno rispetto di eventuali motivi ornamentali. Durante la posa del rivestimento
quando è previsto il raccordo tra la superficie orizzontale con quella verticale dovrà essere posta una sguscia
preformata a sostegno del risvolto del pavimento. La posa del rivestimento in parete si intende oltre il controsoffitto, altrimenti dovrà essere previsto un cordolo di finitura da apporre alla linea di stacco tra la parete
rivestita e quella tinteggiata. Tale cordolo dovrà essere sagomato in maniera tale da non permettere il deposito di sudicio e/o annidamento di organismi animali. Per quanto riguarda il sistema di messa in opera del
rivestimento murale per la protezione dei muri interni, consistente in un tessuto in puro cotone protetto da
un laminato ottenuto per polimerizzazione di monomeri vinilici e spalmatura di pigmenti micronizzati, biologicamente inerte e non tossico, con superficie protetta da una pellicola di fluoruro di polivinile di spessore non
inferiore a 25 micron, si dovranno seguire le indicazioni segnalate sulle relative scheda Tecnica fornita dalla
stessa casa produttrice.
In particolare per annullare il gradino tra la zoccolatura a parete (spessore 2 mm) e il rivestimento murario
(spessore 0,55 mm), dovrà essere realizzato un raccordo mediante riempimento con stucco, che a partire
allo spessore della zoccolatura procederà per l’altezza di almeno 15 cm sulla parete, sino ad annullare completamente lo spessore. La superficie verticale finale dovrà essere complanare, senza gradini che possano
formare pericolosi ricettacoli di sporco.
Il rivestimento a parete dovrà essere applicato sovrapponendolo per almeno 1 cm sulla zoccolatura e raccordandolo indissolubilmente ad essa tramite saldatura.
Sistemi realizzati con prodotti fluidi
Tali sistemi dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto (con prodotti costituiti da pitture, vernici impregnanti, resine liquide, ecc.) aventi le caratteristiche riportate nell’articolo loro applicabile
ed a completamento del progetto dovranno rispondere alle indicazioni seguenti: su pietre naturali ed artificiali impregnazione della superficie con siliconi o oli fluorurati, non pellicolanti, resistenti agli U.V., al dilavamento, agli agenti corrosivi presenti nell’atmosfera. su intonaci esterni: tinteggiatura della superficie con tinte alla calce o ai silicati inorganici; pitturazione della superficie con pitture organiche;
La tinteggiatura degli intonaci interni sarà realizzata secondo i seguenti criteri:
1. A tempera:
• su tutti i soffitti ove non sia previsto il controsoffitto; sui controsoffitti in cartongesso;
• sulle porzioni di parete tra il rivestimento ed il soffitto, nei vani rivestiti con piastrelle;
• in tutti gli altri locali se espressamente specificati.
2. A resina acrilica:
• su tutte le rimanenti pareti.
La tinteggiatura degli intonaci interni dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:
1. Preparazione del supporto:
• Su intonaci nuovi: lisciatura e stuccatura del supporto, fino alla perfetta planarità, all’esame della luce
radente;
• Su intonaci vecchi: bruschinatura, raschiatura e lavaggio per l’eliminazione delle vecchie pitture e
successiva stuccatura del supporto per la eliminazione di imperfezioni, fino alla perfetta planarità,
all’esame della luce radente;
2. Primer:
• Mano di primer fissativo a base di resine acriliche in dispersione acquosa, pigmentato a base di biossido di titanio rutilio, cariche minerali, additivi atti a facilitare l’applicazione e la filmazione, applicato a
pennello o rullo;
3. Pitturazione:
• Tinteggiatura a tempera: applicazione di tinteggiatura a tempera, in due mani successive;
• Tinteggiatura con pittura lavabile a base acrilica: realizzata con pittura murale a base di resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti organici, inorganici e speciali additivi atti a facilitare
l’applicazione e la filmazione. Il prodotto deve essere autodilatante, antigraffio, sanificante e resistente alle abrasioni, con ottima resistenza agli alcali (soluzioni ammoniacali e sodiche), agli alcoli e ai detergenti chimici; conforme alle norme DIN 53 778 S-W-M o simili; inodore, non tossico, non infiammabile, esente da sostanze nocive, componenti contenenti metalli pesanti, solventi tossici, aromatici,
clorurati. L’applicazione deve essere eseguita in due mani successive, nella diluizione prevista dalla
scheda tecnica del prodotto.
La scelta dei colori sarà effettuata dal Direttore dei Lavori, sia tramite le cartelle colori che le prove in sito; le
pareti ed i soffitti saranno realizzati o con colorazione uniforme, anche se diverse per pareti e soffitti o il Direttore dei Lavori potrà richiedere la esecuzione di fasce od altre caratterizzazioni cromatiche a più colori, su
prodotti di legno e di acciaio.
I sistemi dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed in loro mancanza (od a loro inte__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 23
grazione) secondo le indicazioni date dal produttore ed accettate dalla Direzione dei Lavori; le informazioni
dovranno essere fornite secondo le norme UNI 8758 o UNI 8760 e riguarderanno:
• criteri e materiali di preparazione del supporto;
• criteri e materiali per realizzare l’eventuale strato di fondo, ivi comprese le condizioni ambientali
(temperatura, umidità) del momento della realizzazione e del periodo di maturazione, condizioni per
la successiva operazione; criteri e materiali per realizzare l’eventuale strato intermedio, ivi comprese
le condizioni citate al punto precedente per la realizzazione e maturazione; criteri e materiali per lo
strato di finiture, ivi comprese le condizioni citate al secondo punto.
Durante l’esecuzione, per tutti i tipi predetti, si dovrà curare per ogni operazione la completa esecuzione degli strati, la realizzazione dei punti particolari, le condizioni ambientali (temperatura, umidità) e la corretta
condizione dello strato precedente (essiccazione, maturazione, assenza di bolle, ecc), nonché le prescrizioni
relative alle norme di igiene e sicurezza.
Il Direttore dei Lavori per la realizzazione del sistema di rivestimento opererà come segue:
1.
Nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà continuamente che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed
inoltre almeno per gli strati più significativi verificherà che il risultato delle operazioni predette
sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione che è attribuita
all’elemento o strato realizzato. In particolare verificherà: per i rivestimenti rigidi le modalità di
fissaggio, la corretta esecuzione dei giunti e quanto riportato delle prescrizioni di progetto o concordate come detto nel punto a) verificando la loro completezza, ecc, specialmente delle parti
difficilmente controllabili al termine dei lavori.
2.
A conclusione dei lavori eseguirà prove (anche solo localizzate) e con facili mezzi da cantiere
creando sollecitazioni compatibili con quelle previste dal progetto o comunque simulanti le
sollecitazioni dovute all’ambiente, agli utenti futuri, ecc.
Per i rivestimenti rigidi verificherà, in particolare, il fissaggio e l’aspetto delle superfici risultanti, mentre per
quelli fluidi la completezza, l’assenza di difetti locali, l’aderenza al supporto.
VETRI E SERRAMENTI
I vetri dovranno corrispondere alle indicazioni, caratteristiche e modalità previste nel progetto; ove questo
non sia sufficientemente dettagliato valgono le prescrizioni seguenti:
a)
Le lastre di vetro, in relazione al loro comportamento meccanico, dovranno essere scelte tenendo conto delle loro dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico di vento e neve, alle
sollecitazioni dovute ad eventuali sbattimenti ed alle deformazioni prevedibili del serramento.
Dovranno inoltre essere considerate per la loro scelta le esigenze di isolamento termico, acustico, di trasmissione luminosa, di trasparenza o traslucidità, di sicurezza sia ai fini antinfortunistici
che di resistenza alle effrazioni, atti vandalici, ecc. Per la valutazione dell’adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di prescrizioni nel progetto si dovranno adottare i criteri stabiliti nelle norme UNI per l’isolamento termico ed acustico, la sicurezza, ecc. (UNI 7143,
UNI 7144, UNI 7170 e UNI 7097); gli smussi ai bordi e negli angoli dovranno prevenire possibili
scagliature. Tutte le lastre che verranno utilizzate, sia per la formazione di vetro-camera che per
vetrate semplici, negli spessori previsti in progetto, dovranno essere del tipo stratificato antisfondamento. Gli spessori riportati negli elaborati di progetto costituiscono minimi inderogabili.
b)
I materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, dovranno essere scelti in relazione alla conformazione e dimensioni delle scanalature (o battente aperto con ferma vetro) per quanto riguarda lo spessore e dimensioni in genere, capacità di adattarsi alle deformazioni elastiche dei
telai fissi ed ante apribili, resistenza alle sollecitazioni dovute ai cicli termoigrometrici tenuto conto delle condizioni microlocali che si creano all’esterno rispetto all’interno, ecc. e tenuto conto del
numero, posizione e caratteristiche dei tasselli di appoggio, periferici e spaziatori. Nel caso di lastre posate senza serramento gli elementi di fissaggio (squadrette, tiranti, ecc.) dovranno avere
adeguata resistenza meccanica, essere preferibilmente di metallo non ferroso o comunque protetto dalla corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la lastra dovrà essere interposto materiale
elastico e resistente alle azioni climatiche.
c)
La posa in opera dovrà avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi alle lastre,
serramenti, ecc. e collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere correttamente il
peso della lastra al serramento; i tasselli di fissaggio dovranno servire a mantenere la lastra nella
posizione prefissata. Le lastre che possono essere urtate dovranno essere rese visibili con opportuni segnali (motivi ornamentali, maniglie, ecc). La sigillatura dei giunti tra lastra e serramento
dovrà essere continua in modo da eliminare ponti termici ed acustici. Per i sigillanti e gli adesivi
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 24
si dovranno rispettare le prescrizioni previste dal fabbricante per la preparazione, le condizioni
ambientali di posa e di manutenzione. Comunque la sigillatura dovrà essere conforme a quella
richiesta dal progetto od effettuata sui prodotti utilizzati per qualificare il serramento nel suo insieme. L’esecuzione effettuata secondo la norma UNI 6534 potrà essere considerata conforme
alla richiesta del presente Capitolato nei limiti di validità della norma stessa.
d)
Gli infissi interni saranno quasi tutti di nuova fornitura. La posa dei serramenti dovrà essere effettuata come indicato nel progetto e quando non precisato dovrà avvenire secondo le prescrizioni seguenti:
A)
Le finestre dovranno essere collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti
dal progetto e comunque in modo da evitare sollecitazioni localizzate. Il giunto tra controtelaio e telaio fisso, se non progettato in dettaglio onde mantenere le prestazioni richieste al serramento, dovrà essere eseguito con le seguenti attenzioni: assicurare tenuta all’aria ed isolamento acustico; li interspazi dovranno essere sigillati con materiale
comprimibile che resti elastico nel tempo; se ciò non fosse sufficiente (giunti larghi più
di 8 mm) si sigillerà anche con apposito sigillante capace di mantenere l’elasticità nel
tempo e di aderire al materiale dei serramenti; il fissaggio dovrà resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto l’azione del vento odi carichi dovuti all’utenza
(comprese le false manovre).
B)
La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria o parete in cartongesso dovrà avvenire assicurando il fissaggio con l’ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli
ad espansione, ecc); sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di elementi separatori quale non tessuti, fogli, ecc; curando l’immediata pulizia
delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrose, ecc.) dal contatto con
la malta.
C)
Le porte dovranno essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre; inoltre si dovranno curare le altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito
ed i fermi in gomma a pavimento, qualora le porte, nell’apertura, possano sbattere su
qualunque superficie rigida. Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione), acustiche, termiche, scorrevoli, a tenuta o di comportamento al fuoco, si dovranno
inoltre rispettare le istruzioni per la posa (date dal fabbricante ed accettate dalla Direzione dei lavori).
In particolare le porte antincendio, siano esse ad un battente o a due battenti su misura e/o standard, dovranno essere omologate secondo la norma UNI 9273 e dovranno essere correlate di relativa certificazione.
Per la loro posa in opera dovrà essere particolarmente curato il loro perfetto ancoraggio alla parete, verificando la compatibilità delle sollecitazioni trasmesse ed eventualmente inserendo telai metallici di rinforzo e
ripartizione, ove necessari.
Il Direttore dei Lavori per la realizzazione delle opere di cui sopra opererà come segue.
Nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà continuamente
che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte. In particolare verificherà
la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi ed i controtelai; la esecuzione dei
fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetto delle prescrizioni di progetto, del capitolato e del produttore
per i serramenti con alte prestazioni.
A conclusione dei lavori eseguirà verifiche visive della corretta messa in opera e della completezza dei giunti,
sigillature, ecc. Eseguirà controlli orientativi circa la forza di apertura e chiusura dei serramenti (stimandole
con la forza corporea necessaria), l’assenza di punti di attrito non previsti, e prove orientative di tenuta
all’acqua, con spruzzatori a pioggia, ed all’aria, con l’uso di fumogeni, ecc. controlli predetti potranno avere,
a discrezione del Direttore dei Lavori, carattere solo casuale e/o statistico.
Direttore dei Lavori avrà anche cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più significativi, predisposti a cura della Ditta Appaltatrice, unitamente alla descrizione e/o alle schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.
PARETI ESTERNE E PARTIZIONI INTERNE
Le pareti esterne o partizioni interne realizzate a base di elementi di laterizio, calcestruzzo, calcio silicato, laterogesso, pietra naturale o ricostruita e prodotti similari dovranno essere realizzate con le modalità richiamate nel precedente articolo relativo alle “Opere e strutture di muratura”, tenendo conto delle modalità di
esecuzione particolari (giunti, sovrapposizioni, ammorsature, ecc.) richieste quando la muratura ha compiti di
isolamento termico, acustico, resistenza al fuoco, ecc. Per gli intonaci ed i rivestimenti in genere si rinvia
all’articolo successivo, comunque, in relazione alle funzioni attribuite alle pareti ed al livello di prestazione ri-
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 25
chiesto, si dovrà curare la realizzazione dei giunti, la connessione tra gli strati e le compatibilità meccaniche e
chimiche.
Nel corso dell’esecuzione si dovrà curare la completa realizzazione dell’opera, con attenzione alle interferenze
con altri elementi (impianti), all’esecuzione dei vani di porte e finestre, alla realizzazione delle camere d’aria
o di strati interni, curando che non subiscano schiacciamenti, discontinuità, ecc. non coerenti con la funzione
dello strato.
Le partizioni interne dovranno essere realizzate in conformità alla specifica normativa tecnica in materia, con
particolare riferimento alle norme UNI, quali, ad esempio, la UNI 7960- Edilizia residenziale - Partizioni interne - Terminologia; la UNI 8087- Edilizia residenziale - Partizioni interne verticali - Analisi dei requisiti, ecc; i
nuovi tramezzi trasversali, rispetto alle facciate, debbono, di norma essere centrati sui montanti degli infissi,
salvo diversa disposizione, e realizzati in modo tale da assicurare, comunque, la possibilità di apertura delle
finestre; i particolari di attacco tra gli infissi e le pareti debbono essere realizzati come previsto in progetto,
assicurando la perfetta sigillatura e separazione dei vani contigui.
Nella realizzazione delle pareti con caratteristiche di resistenza al fuoco la classificazione richiesta è da intendersi come requisito minimo di accettabilità, in relazione alle certificazioni che l’Appaltatore dovrà produrre.
Le partizioni interne costituite da elementi predisposti per essere assemblati in sito (con o senza piccole opere di adeguamento nelle zone di connessione con le altre pareti o con il soffitto) dovranno essere realizzate
con prodotti rispondenti alle prescrizioni delle precedenti definizioni.
Le partizioni interne costituite da elementi a lastre preformate da installare su struttura metallica dovranno
essere assemblati in sito (con o senza piccole opere di adeguamento nelle zone di connessione con le altre
pareti o con il soffitto) dovranno essere realizzate con prodotti rispondenti alle prescrizioni delle precedenti
definizioni, e finite con opere alle giunzioni di protezione e finitura tali da garantire la perfetta continuità del
piano finito.
Nell’esecuzione si dovranno seguire le modalità previste dal produttore (ivi incluso l’utilizzo di appositi attrezzi) e comunque approvate dalla Direzione dei Lavori.
Si dovrà curare la corretta predisposizione degli elementi che svolgono anche funzione di supporto in modo
da rispettare le dimensioni, tolleranze ed i giochi previsti o comunque necessari ai fini del successivo assemblaggio degli altri elementi; si dovrà anche curare che gli elementi di collegamento e di fissaggio vengano
posizionati ed installati in modo da garantire l’adeguata trasmissione delle sollecitazioni meccaniche.
Il posizionamento di pannelli, vetri, elementi di completamento, ecc. dovrà essere realizzato con
l’interposizione di guarnizioni, distanziatori, ecc. che garantiscano il raggiungimento dei livelli di prestazione
previsti ed essere completati con sigillature, ecc.
Il sistema di giunzione nel suo insieme dovrà completare il comportamento della parete e dovrà essere eseguito secondo gli schemi di montaggio previsti; analogamente si dovranno eseguire secondo gli schemi previsti e con accuratezza le connessioni con le pareti murarie, con i soffitti, ecc.
INTONACI
Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in condizioni di ambiente opportune, dopo aver rimosso dai
giunti delle murature la malta poco aderente, ripulita ed inumidita la superficie della parete stessa.
Gli intonaci, di qualunque specie siano, non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarità negli allineamenti e negli spigoli od altri difetti. Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere demoliti e rifatti dalla Ditta Appaltatrice a sue spese. Ad opera finita
l’intonaco dovrà avere uno spessore non inferiore a 15 mm.
Gli spigoli sporgenti o rientranti dovranno essere eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento, a seconda degli ordini che in proposito impartirà la Direzione dei Lavori. Per ciascun tipo di intonaco
si prescrive principalmente quanto appresso: Intonaco grezzo o arricciatura
Predisposte le fasce verticali, sotto regolo di guida, in numero sufficiente, verrà applicato alle murature un
primo strato di malta cementizia detto rinzaffo, gettato con forza in modo che possa penetrare nei giunti e
riempirli.
Dopo che questo strato sarà alquanto asciutto, si applicherà su di esso un secondo strato della medesima
malta che si stenderà con la cazzuola o con il frattone, stuccando ogni fessura e togliendo ogni asprezza,
sicché le pareti riescano quanto più possibile regolari.
Intonaco comune o civile
Appena l’intonaco grezzo avrà preso consistenza si stenderà su di esso un terzo strato di malta fina che si
conguaglierà con le fasce di guida per modo che l’intera superficie piana ed uniforme, senza ondeggiamenti
e disposta a perfetto piano verticale o secondo le superfici degli intradossi. La rifinitura finale dovrà essere
effettuata con malta pronta data con il frattazzo e regolarizzata con attrezzatura adeguata allo scopo.
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 26
PAVIMENTAZIONI
I pavimenti in gomma interni saranno realizzati con teli o piastrelle delle dimensioni di cm. 60x60, poste in
opera tramite incollaggio sul supporto e saldate con filo continuo, secondo le metodiche specifiche del materiale, risultanti dalle schede tecniche; il materiale dovrà essere certificato antiscivolo e di classe 1, secondo le
norme UNI; l’incollaggio potrà avvenire su massetto nuovo piallettato o su preesistente pavimento in piastrelle; in ambedue i casi si dovrà provvedere alla preparazione del sottofondo tramite levigatura con prodotti aggrappanti autolivellanti o stesi a spatola, previo trattamento del supporto per assicurare la perfetta adesione; in presenza di tali pavimenti verrà posto in opera uno zoccolino avente le stesse caratteristiche meccaniche ed estetiche, del tipo a sguscio, con raccordi preformati per angoli o spigoli, perfettamente saldato al
pavimento, per impedire ogni possibile penetrazione e ristagno di liquidi.
Il pavimento in gomma delle sale operatorie avrà spessore di 2mm, dovrà presentare le stesse caratteristiche di classificazione del precedente, e dovrà essere del tipo antistactico, sarà posto in opera con le stesse
modalità, curando la perfetta asciugatura del supporto.
Eventuali linee di attacco tra pavimenti di diverso tipo dovranno essere realizzati in corrispondenza del filo
parete sul quale verrà montata la porta e dovrà essere protetto da un apposito profilo metallico, saldamente
fissato ai pavimenti e perfettamente sigillato, per impedire ogni possibile penetrazione e ristagno di liquidi.
CONTROSOFFITTI
Nel corrispondente prezzo di elenco si intendono compresi tutti gli oneri per le opere provvisionali di sostegno e protezione, l’adozione di tutti gli accorgimenti strutturali atti a garantire una corretta sospensione degli
elementi.
La Ditta appaltatrice dovrà assicurare, a lavoro finito, la perfetta complanarità del controsoffitto e pulizia,
precisando che in caso di imperfezioni di sorta la Ditta stessa dovrà provvedere a sua spesa ai necessari ripristini. Detti controsoffitti dovranno essere tali da soddisfare le particolari esigenze di clinicità, con particolare riferimento a quelli a tenuta alla polvere che saranno in acciaio verniciato 6/10 con orditura nascosta. Dovranno, in particolare: essere lavabili, resistenti all’umidità, allo sporco, al grasso, ai fumi, alla polvere ed ai
microbi; essere facilmente smontabili e resistenti agli urti, avere un’alta prestazione acustica ed essere in
grado di evitare il prodursi di risonanze; avere una buona estetica ed un buon isolamento termico, consentire l’inserimento di servizi integrativi, quali corpi illuminanti, bocchette e/o anemostati, parti traslucide, griglie
e tutto quanto è previsto, senza doverne alterare la struttura.
I controsoffitti dovranno essere certificati ed omologati rispetto alle seguenti caratteristiche tecniche minime:
• Comportamento acustico: isolamento di almeno 30 dB;
• Assorbimento acustico: almeno 0,3 per ogni frequenza compresa tra 250 e 2.000Hz.;
• Comportamento al fuoco: Classe 1, (Con omologazione ministeriale);
• Riflessione della luce: > 90%; Conduttività termica;
La tenuta alla polvere dovrà essere realizzata, ove previsto, mediante una speciale sagomatura del bordo dei
pannelli, adatta alla posa di una guarnizione di tenuta, oppure mediante fissaggio continuo dei pannelli lungo
tutto il perimetro. Nei prezzi di elenco si intendono compensati tutti gli oneri per l’esecuzione di eventuali forature per l’inserimento di anemostati, bocchette dell’aria, faretti, corpi illuminanti, griglie, elementi in traslucido, ecc.
FINITURE ED ESECUZIONI PARTICOLARI
Attraversamento di setti taglia fuoco da impianti
Tutti gli attraversamenti di impianti sia elettrici che idrici e meccanici di setti taglia fuoco, dovranno essere
tamponati mediante adeguato corredo REI 60-120 costituito da materiale intumescente o da sistemi alternativi che garantiscono la continuità REI della parete attraversata.
Per opere richiedenti materiali di particolari caratteristiche e lavorazioni in stabilimento e/o particolari accorgimenti costruttivi in cantiere per i quali il presente Disciplinare Tecnico non fornisce specifici riferimenti sulle
loro tecnologie di produzione e sulle modalità di posa in opera, si rimanda a quanto descritto e/o fissato nelle
voci dei corrispondenti prezzi unitari di elenco o comunque a quanto fissato dalla normativa vigente e dalle
regole della buona arte e/o a quanto stabilito nelle specifiche tecniche di qualificazione ed accettazione dei
singoli materiali e/o nelle istruzioni di posa in opera fornite dal produttore dei materiali più significativi.
Si richiama tra le esecuzioni e gli oneri particolari l’obbligo di provvedere al trattamento dei materiali comprendenti amianto con le procedure previste dal Piano della Sicurezza al loro conferimento in discarica autorizzata. Tale trattamento avverrà nelle modalità di legge e in specie si dovrà essere provvedere a:
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 27
•
•
•
compartimentare tramite opere provvisionali i locali nel corso del trattamento per impedire il rilascio
in ambiente delle particelle dovute alla lavorazione;
confezionare i residui in appositi teli o sacchi opportunamente sigillati, per il trasporto;
pulire e bonificare gli ambienti da residui dispersi.
Fascia paracolpi
In genere si può considerare che nei locali oggetto di intervento la maggior parte degli urti sarà causata dal
passaggio delle barelle. Per le protezioni da urto accidentale sono state previste agli spigoli vivi delle strutture in muratura e sulla fascia delle pareti, dispositivi atti a proteggere l’area di massima probabilità d’urto, situabile tra cm 80-100 dalla quota del pavimento finito.
I paraurti dovranno essere istallati con un ancoraggio meccanico alla parete e presentare, oltre che caratteristiche meccaniche idonee, una superficie di facile pulizia, una giunzione tra elementi tale da non permettere
nessun tipo di incidente ed una elasticità tale da assorbire in parte l’urto.
Dovrà essere in acciaio inox spessore 12/10 mm con finitura spazzolata e comunque di forma e tipologia uguali a quello esistente nel comparto operatorio.
Per motivi estetici sarà necessario inoltre mantenere le stesse quote di installazione, in particolare modo nei
locali e corridoi con facce contrapposte.
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 28
IMPIANTI MECCANICI
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 29
SPECIFICHE DELLE APPARECCHIATURE
CANALIZZAZIONI IN LAMIERA
Le canalizzazioni in lamiera servono al convogliamento dell’aria trattata, dell’aria esterna e dell’aria di espulsione; oltre all’installazione delle canalizzazioni metalliche, saranno forniti ed installati gli accessori indicati sui
disegni o comunque necessari per collegare tra loro tutte le apparecchiature di trattamento dell’aria, le prese
dell’aria esterna, gli eventuali cassoni di contenimento, i pezzi speciali di raccordo ai diffusori ed alle bocchette di mandata e di ripresa, nonché tutti i collegamenti flessibili tra le aspirazioni e la mandata dei ventilatori
e dei canali.
In corrispondenza all’attraversamento di pavimenti, solai, pareti o tramezzi, attorno alle canalizzazioni sarà
prevista una guida fissa nella muratura che permetta il passaggio del canale; la guida sarà riempita poi con
lana di roccia per impedire ponti acustici tra i singoli locali.
All’attraversamento di pareti tagliafuoco dovranno essere sempre installate serrande tagliafuoco di idonee
caratteristiche, di tipo omologato.
Progetto meccanico
La costruzione delle canalizzazioni sarà progettata conformemente alle norme ASHRAE e SMACNA ed in modo da rispettare le specifiche tecniche che seguono.
Le canalizzazioni, i condotti di contenimento di batterie, filtri o ventilatori, le prese di aria esterna e di espulsione, le cappe di qualsiasi tipo saranno costruite in lamiera zincata con gli spessori, tipi di giunto e rinforzi,
indicati nelle allegate tavole di progetto rispettivamente per canali a sezione rettangolare a bassa velocità
(pressione) e per canali a sezione circolare.
Le lamiere avranno la zincatura su entrambi i lati; la zincatura avrà una consistenza totale di 215 g/mq di
lamiera e verrà applicata secondo il metodo Sendzimir.
Le lamiere impiegate risponderanno alle norme UNI relative.
Canalizzazioni a sezione quadrangolare
Le canalizzazioni e quantaltro elencato al precedente paragrafo saranno costruite secondo quanto prescritto
nella tabella seguente che riporta gli spessori, nonché i rinforzi previsti in funzione della dimensione massima
del canale.
DIMENSIONI
SPESSORE DELLA LAMIERA
RINFORZI
Lato Maggiore (mm)
Acciaio Zincato
Alluminio
Dimensioni dell’Angolare
/Dist.
Fino a 300
6/10
8/10
Da 350 a 450
8/10
10/10
Da 500 a 750
8/10
10/10
25x25x3/1500
Da 800 a 1050
10/10
Da 1100 a 1400
10/10
Da 1450 a 1550
12/10
Da 1600 a 2150
12/10
Da 2200 a 2450
14/10
Oltre 2500
14/10
Gli angolari ed i ferri di rinforzo saranno zincati a caldo e potranno essere ancorati al canale mediante rivetti,
bulloni, viti o saldatura a punti in modo da evitare le vibrazioni.
Ove necessario i canali saranno rinforzati mediante Croci di Sant’Andrea in modo da non subire deformazioni
apprezzabili per effetto della pressione dell’aria.
I canali saranno dotati di curve tali da ridurre al minimo le perdite di carico; dove necessario, le curve saranno provviste di deflettori interni, secondo le indicazioni riportate nei disegni allegati.
I canali posti all’esterno dell’edificio, nonché quelli per i quali vi sono espresse indicazioni nei disegni allegati,
saranno eseguiti con lamiera maggiorata di 2/10 rispetto ai valori di tav. 1 e quindi protetti esternamente
con doppia mano di bitume.
Anche i canali di estrazione dalle cappe delle cucine avranno uno spessore maggiorato di 2/10 rispetto ai valori di tav. 1 ed inoltre saranno completamente flangiati con profilati di acciaio zincati fissati al canale mediante rivettatura; fra i profilati sarà interposta una guarnizione che impedisca nel tempo la fuoriuscita di
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 30
fumi e grassi.
Nelle posizioni indicate nei disegni saranno previste portine di ispezione per la pulizia in caso di necessità.
Canalizzazioni a sezione circolare
I canali a sezione circolare potranno essere costruiti così come indicato nella tabella seguente ove sono riportati gli spessori delle lamiere e le connessioni perimetrali da impiegare.
DIAMETRO DEL
SPESSORE LAMIERA
SPESSORE PERIMETRALI
CONGIUNZIONI
CANALE
Fino a 200/250/350
6/10
Giunto a Nipplo Lungh. 50
mm.
450 - 650
8/10
Giunto a Nipplo Lungh. 50
mm.
700 - 900
10/10
Giunto a Nipplo Lungh. 50
mm.
950 - 1250
12/10
Giunto a Flangia con Angolare
40x40x3
1300-1500
14/10
Giunto a Flangia con Angolare
40x40x3
1550-2150
14/10
Giunto a Flangia con Angolare
40x40x3
Nella costruzione dei canali circolari la zincatura eventualmente bruciata verrà ripristinata con vernice “zinc
coat”.
Le curve ed i gomiti verranno costruiti ove possibile in maniera da risultare lisci (stampati) e di un solo pezzo
con raggio uguale 1,5 volte il rispettivo diametro; le curve ed i gomiti a più pieghe verranno costruiti come
segue:
Angolo
n. delle pieghe
fino a 36 g.
2
36-70 g.
3
70-90 g.
5
Per quanto riguarda la costruzione delle derivazioni e le riduzioni si rimanda alle prescrizioni
ASHRAE.
Qualsiasi tipo di staffa, rinforzo o accessorio in profilato di ferro verrà zincato a caldo dopo la lavorazione.
Installazione
Il percorso delle canalizzazioni è chiaramente indicato nelle planimetrie di progetto; nella fase di installazione
si cercherà di rispettare il più possibile tale percorso, salvo eventuali diverse disposizioni da parte della
Committente e/o della D.L. in conseguenza alle necessità che dovessero emergere lungo il corso dei lavori.
La procedura di installazione prevede che una volta sia stato verificato il corretto allineamento dello staffaggio e che non ci siano interferenze con altre opere, si proceda al montaggio dei canali sulle staffe ed alla loro
congiunzione secondo quanto previsto nelle tavole allegate; i canali saranno quindi fissati alle staffe mediante viti autofilettanti, rivetti o bulloni che ne impediscano il distacco in condizioni di esercizio.
Per tutti i tipi di giunzione sarà assicurata la continuità metallica mediante treccia di rame munita di capicorda fissati al canale con bulloni o viti autofilettanti.
Ad installazione avvenuta si provvederà alla sigillatura dei canali ad evitare perdite di aria lungo il loro percorso.
I sigillanti a supporto liquido volatile, potranno essere impiegati unicamente per finiture o per sigillare giunzioni che presentino aperture di modesta entità.
I sigillanti semisolidi saranno applicati a spatola o mediante pistola a pressione possibilmente dall’interno dei
canali di mandata ( a pressione statica positiva )in modo che la pressione dell’aria tenda a spingere il materiale all’interno del giunto, mentre per la stessa ragione saranno applicati all’esterno dei canali di aspirazione
( a pressione statica negativa ); non saranno impiegati sigillanti semisolidi a base oleosa.
Nel caso di giunzioni flangiate si provvederà all’inserzione fra le flange di guarnizioni di neoprene, o materiale plastico che saranno fissate alle flange stesse mediante mastice adeguato.
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 31
Nell’unione dei canali alle apparecchiature occorrerà predisporre un giunto antivibrante in tela olona che
renda completamente indipendente il canale dalla apparecchiatura.
TUBAZIONI IN ACCIAIO
Le tubazioni per il convogliamento dei vari fluidi impiegati negli impianti dovranno essere dei seguenti tipi:
• Tubo di acciaio nero tipo gas serie media s.s., Mannesmann, fino al diametro nominale di 1 ½” e tipo liscio commerciale a partire dal diametro 54/60. Le tubazioni sopra indicate possono essere impiegate per: convogliamento acqua, a qualsiasi temperatura in circuiti di tipo chiuso; perdita di carico da 15-^25 mm. c.a. per ogni metro lineare di tubazione rettilinea; per quanto concerne la velocità dell’acqua nelle stesse occorre usare i seguenti valori: tubazioni aventi d. 2” da 0,6 a 1,2 m/sec. tubazioni maggiori di d. 2” da 1,2 a 1,7 m/sec.
• Tubo di acciaio nero, tipo gas serie media s.s., Mannesmann, API 5L Sch. 40 per tubazioni vapore fino a d. 2”, Sch. 80 per diametri superiori.
• Tubo in acciaio zincato, tipo gas serie media, con estremità filettabili per: convogliamento di acqua a
qualunque temperatura nei circuiti a ciclo aperto e nelle reti di distribuzione eventualmente esposte
alle intemperie; formazione della rete degli scarichi di condensa.
Prima di essere posti in opera tutti i tubi dovranno essere accuratamente puliti ed inoltre in fase di montaggio le loro estremità libere dovranno essere protette per evitare l’intromissione accidentale di materiali che
possano in seguito provocarne l’ostruzione.
Tutte le tubazioni dovranno essere montate in maniera da permettere la libera dilatazione senza il pericolo
che possano lesionarsi o danneggiare le strutture di ancoraggio prevedendo, nel caso, l’interposizione di idonei giunti di dilatazione atti ad assorbire le sollecitazioni termiche.
Nei tratti orizzontali le tubazioni dovranno avere un’adeguata pendenza verso i punti di spurgo.
Tutti i punti della rete di distribuzione dell’acqua che non possano sfogare l’aria direttamente nell’atmosfera,
dovranno essere dotati di barilotti a fondi bombati, realizzati con tronchi di tubo delle medesime caratteristiche di quelli impiegati per la costruzione della corrispondente rete, muniti in alto di valvola a sfera, oppure di
valvola automatica sempre con relativa intercettazione.
I tubi in acciaio nero saranno giuntati fra loro mediante saldatura elettrica, mentre saranno da utilizzare le
giunzioni a flangia o raccordi a vite o manicotto per il collegamento dei tubi alle valvole, alle macchine ed ai
collettori.
Le saldature dopo la loro esecuzione, dovranno essere martellate e spazzolate con spazzola di ferro.
Le flange dovranno essere dimensionate per una pressione di esercizio non inferiore ad una volta e mezzo la
pressione di esercizio dell’impianto.
Le giunzioni fra tubi di differente diametro dovranno essere effettuate mediante idonei raccordi conici, non
essendo permesso l’innesto diretto di un tubo di diametro inferiore entro quello di diametro maggiore. Le
giunzioni saranno eseguite con raccordi normalmente a saldare oppure a filettare od a flangia.
Le tubazioni verticali potranno avere raccordi assiali o, nel caso si voglia evitare un troppo accentuato distacco dei tubi dalle strutture di sostegno, raccordi eccentrici con allineamento su una generatrice. I raccordi per
le tubazioni orizzontali saranno sempre del tipo eccentrico con allineamento sulla generatrice superiore per
evitare la formazione di sacche d’aria.
I tubi zincati saranno giuntati mediante raccordi a vite e manicotto, oppure mediante flange.
Per i cambiamenti di direzione verranno utilizzate curve prefabbricate, normalmente a saldare oppure montate mediante raccordi a vite e manicotto o mediante flange, dove espressamente indicato dalla D.L.
Per i piccoli diametri, inferiori ad 1”1/2, saranno ammesse curve ottenute mediante piegatura a freddo.
Le derivazioni verranno eseguite utilizzando raccordi a T filettati oppure a saldare. Per tubazioni API verranno utilizzati pezzi speciali prefabbricati, forgiati.
Nelle derivazioni in cui i tubi vengano giuntati mediante saldatura, non sarà comunque ammesso per nessuna ragione l’infilaggio del tubo di diametro minore entro quello di diametro maggiore.
Le tubazioni che debbano essere collegate ad apparecchiature che possano trasmettere vibrazioni
all’impianto dovranno essere montate con l’interposizione di idonei giunti elastici antivibranti.
I supporti per le tubazioni saranno realizzati utilizzando componenti di staffaggi prefabbricati delle marche
elencate in Elenco Marche.
La distanza fra i supporti dovrà essere calcolata sia in funzione del diametro della tubazione sostenuta che
dalla sua pendenza al fine di evitare la formazione di sacche dovute all’inflessione della tubazione stessa.
Nel caso che venisse espressamente richiesto nelle descrizioni impianti e nel computo metrico, tutte le tubazioni sia verticali che orizzontali, di qualsiasi diametro e per ogni circuito installato, verranno staffate singolarmente e tramite sostegni a collare con tiranti a snodo, regolabili, dotati di particolari giunti antivibranti in
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 32
gomma.
I collari di sostegno delle tubazioni dovranno essere dotati di appositi profili in gomma sagomata con funzione di isolamento anticondensa e fonoassorbente.
L’interasse dei sostegni, siano essi singoli o per più tubazioni contemporaneamente, dovrà essere secondo la
seguente tabella in modo da evitare qualunque deformazione dei tubi.
Diametro esterno tubo
Interrasse appoggi
damm 17,2 a mm 21,3
cm 180
da mm 26,9 a mm 33,7
cm 230
da mm 42,4 a mm 48,3
cm 270
da mm 60,3 a mm 88,9
cm 300
da mm 101,6 a mm 114,3
cm 350
da mm 139,7 a mm 168,3
cm 400
damm219,1 a mm 273
cm 450
oltre mm 323,9
cm 500
Tutte le tubazioni in ferro nero, compresi gli staffaggi, dovranno essere pulite, dopo il montaggio e prima
dell’eventuale rivestimento isolante, con spazzola metallica in modo da preparare le superfici per la successiva verniciatura di protezione antiruggine, la quale dovrà essere seguita da due mani di vernice a smalto adatta alle temperature idi linea, di differente colore.
Tutte le tubazioni non isolate ed in vista saranno verniciate con due mani di vernice a smalto di colore a scelta della D.L.
Tutte le tubazioni installate all’esterno saranno staffate mediante carpenteria zincata a bagno dopo la lavorazione.
L’eventuale bulloneria utilizzata per l’assemblaggio dovrà essere in acciaio inox.
Tutte le tubazioni dovranno essere contraddistinte da apposite targhette che indichino il circuito di appartenenza, la natura del fluido convogliato e la direzione del flusso.
I colori distintivi saranno quelli indicati nella seguente tabella:
Acqua fredda
verde
Acqua calda
rosso
Acqua fredda o calda alternativamente
verde-rosso
Vapore acqueo
grigio
Diverse tonalità dello stesso colore dovranno indicare diverse temperature di uno stesso fluido.
Il senso del flusso del fluido trasportato sarà indicato mediante una freccia situata in prossimità del colore
distintivo di base.
TUBAZIONI IN RAME PER FLUIDI TERMOVETTORI
I tubi saranno del tipo senza saldatura fabbricati con rame Cu-DHP; se non altrimenti disposto, non verrà
fatto uso di tubi di spessore inferiore a 0,8 mm.
I raccordi saranno di rame, fabbricati partendo dal tubo, oppure in ottone o bronzo e saranno sottoposti alle
stesse prove indicate dalla UNI 5649 per i tubi di rame.
I raccordi misti, a saldare e a filettare, saranno impiegati per collegare tubazioni di rame con tubazioni di acciaio oppure con le rubinetterie, valvolame e loro accessori.
I raccordi a saldare saranno impiegati nelle giunzioni fisse.
Nel caso che il raccordo necessario non fosse reperibile in commercio, previa autorizzazione della D.L., verranno eseguite derivazioni dirette senza l’impiego dei raccordi; in tal caso la derivazione sarà realizzata con
saldobrasatura forte.
Nell’eseguire le derivazioni saranno impiegate le speciali attrezzature per preparare le parti da collegare, seguendo le particolari istruzioni di corretto impiego.
I tubi di diametro superiore a 20 mm. saranno curvati con macchine curvatrici automatiche; in presenza di
tubo allo stato crudo il tratto di tubo da curvare sarà preventivamente riscaldato.
Le giunzioni del tipo smontabile saranno del tipo a cartella, e la cartellatura del tubo dovrà essere effettuata
impiegando l’apposita cartellatrice, oppure con tenute del tipo ad anello conico e ghiera di serraggio.
Le giunzioni a brasare saranno effettuate utilizzando leghe per brasatura forte all’argento con l’impiego di
adatti disossidanti.
Il fissaggio ed il sostegno dei tubi verrà effettuato mediante supporti, staffe, piastre a muro, collari e simili in
materia plastica, evitando l’uso di leghe metalliche in grado di poter provocare una coppia fotovoltaica con il
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 33
rame stesso.
La conformazione di tali pezzi speciali sarà tale da non deformare il tubo e da consntirne la rimozione senza
dover smurare il pezzo.
Nel collegamento in opera delle tubazioni in rame dovranno essere rispettate le seguenti norme:
nei circuiti aperti i tubi di rame non precederanno mai i tubi di acciaio, l’acqua dovrà scorrere sempre
dall’acciaio al rame così da evitare la possibilità di corrosione dell’acciaio da parte di eventuali particelle di
rame trasportate dall’acqua;
le giunzioni fra tubi di ferro e tubi di rame dovranno essere realizzate mediante raccordi in ottone o bronzo
evitando il contatto diretto rame-ferro.
le giunzioni incassate saranno protette con rivestimenti tali da consentire alle tubazioni stesse liberi movimenti;
le tubazioni installate in vista saranno di tipo incrudito, sostenute con adatti pezzi speciali posti a distanza
non maggiore di cm.150 per tubi di diametro fino a 25 mm., e non maggiore di 250 mm. per i diametri superiori.
Tubazioni precoibentate
Le tubazioni per convogliamento di fluido termovettore caldo saranno del tipo con precoibentazione a norma
DPR412 mediante guaina in polietilene espanso a cellule chiuse e con guaina in polietilene compatto dotata
dei seguenti requisiti:
dim.(mm)
diam. esterno, (mm)
peso (g/m)
10x1
21
252
12x1
23
308
14x1
27
363
16x1
31
420
18x1
35
475
22x1
52
587
È ammesso l’uso di tubazioni un rame per circuiti caldo-freddo purché la coibentazione, oltre ai requisiti di
cui alla tabella precedente, sia di tipo idoneo a detto tipo di utilizzo e quindi tale da garantire temperature
superficiali al di sopra della temperatura di rugiada in qualsiasi condizione di utilizzo da realizzare barriera al
vapore. Differentemente dovranno essere utilizzate guaine isolanti conformi alla relativa specifica.
La posa delle tubazioni avverrà mediante i criteri sopra esposti, mentre la ripresa della coibentazione sarà
effettuata mediante le prescrizioni generali presenti in questa raccolta.
TUBAZIONI IN PEHD E PP PER LINEE IN PRESSIONE
Per fluidi in pressione, tipo 312 (acqua potabile e fluidi alimentari) secondo UNI 7611/76 PN 6-10-16 secondo necessità e/o richieste.
La raccorderia per questi tipi di tubazioni sarà conforme alle Norme UNI 7612/76: essa sarà del tipo a compressione con coni e ghiere filettate in ottone. Questo tipo di giunzione sarà utilizzato per diametri fino a 4”
(110 mm). Per diametri superiori sia i pezzi speciali (curve, ecc.) che le giunzioni fra tratti di tubazioni diritti
saranno del tipo a saldare; la saldatura dovrà essere del tipo a specchio, eseguita con apposita attrezzatura
elettrica seguendo scrupolosamente le istruzioni del costruttore. Per le diramazioni a T potranno usarsi anche prese a staffa, per qualsiasi diametro della tubazione principale.
Per il collegamento di tubazioni di PEHD o PP a tubazioni metalliche si useranno giunti a vite e manicotto,
metallici, quando la tubazione in acciaio sia filettabile e comunque non oltre i 4”. Per i diametri superiori si
useranno giunzioni a flange (libere o fisse sul tubo di plastica).
Il costo degli staffaggi, pezzi speciali ed accessori (sfiati, scarichi, raccordi, ispezioni, ecc.) sarà compreso nel
prezzo in opera della tubazione.
OPERE DI PROTEZIONE
Saranno protette con apposite vernici e con le modalità che qui di seguito vengono descritte tutte le seguenti
apparecchiature:
• Tubazioni, escluse quelle zincate, ma comprese quelle che successivamente verranno isolate.
• Strutture di sostegno e carpenteria metallica in genere.
Per le tubazioni che dovranno percorrere tratti interrati e per le strutture di sostegno che dovranno rimanere
esposte all’atmosfera esterna, è prevista, una protezione aggiuntiva mediante vernice bituminosa, quando
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 34
non zincate.
Per le tubazioni in vista l’ultima mano di verniciatura sarà di un colore a scelta della Committente.
Preparazione delle superfici
Si provvederà ad una pulizia accurata delle superfici da sottoporre a ciclo di verniciatura onde togliere scorie
di saldatura, ruggine, sporcizia, grassi, untuosità mediante raschiatura e spazzolatura a mano o meccanica,
usando il sistema più adatto o la combinazione di essi.
Applicazione delle vernici
Su tutte quelle parti ove si è eseguito la pulizia verrà applicato immediatamente una prima mano di fondo a
base di minio di piombo (spessore a secco 50 microns).
Preferibilmente la seconda mano verrà applicata sui materiali in opera previ i necessari ritocchi della prima
mano.
Le strutture di sostegno, compreso quelle delle torri evaporative, saranno protette con tre mani di preparato
antiruggine; le strutture di sostegno che dovranno rimanere esposte all’atmosfera saranno ulteriormente
protette con vernice bituminosa, se non zincate.
Le tubazioni zincate non rivestite che rimarranno in vista saranno verniciate con due mani di smalto di un colore a scelta della Committente.
Per le tubazioni che dovranno percorrere tratti interrati per le opere di protezione verranno impiegati i seguenti materiali:
1. Vernice bituminosa (Primer);
2. Bitume speciale polimerizzato ad alto punto di rammollimento e bassa penetrazione;
3. Velo di fibra di vetro peso minimo 50 gr/mq;
4. Tessuto di fibra di vetro peso minimo 150 gr/mq.
L’applicazione dei vari strati di materiale avverrà nel modo seguente:
• Una mano di vernice bituminosa di sottofondo (Primer);
• Uno strato a caldo di bitume polimerizzato;
• Uno strato di velo di fibra di vetro impregnato di bitume a caldo eseguito come lo strato precedente;
• Uno strato a caldo di bitume polimerizzato;
• Una mano finale di latte di calce.
La superficie esterna si presenterà uniforme e priva di difetti.
In luogo di feltro e tessuto di vetro, potranno essere impiegate due fasciature di tessuto di vetro impregnate
di bitume a caldo ed eliche invertite ed a lembi sovrapposti.
Gli spessori totali risulteranno i seguenti:
sino a 12”
6 mm
14”-20”
7 mm
22”-30”
9 mm
32” ed oltre
10 mm
COIBENTAZIONE
L’isolamento coibente di tutte le tubazioni/canalizzazioni calde deve rispondere ai requisiti richiesti dal regolamento di esecuzione delle legge 10/1991. Il rivestimento coibente deve essere eseguito solo dopo le prove
di tenuta e l’approvazione della campionatura. Dovrà essere garantita la massima continuità dell’isolamento
e della relativa barriera al vapore ed a tal scopo l’interasse di posa delle tubazioni/canalizzazioni e la tipologia
dello staffaggio dovranno essere adeguatamente valutati in fase di esecuzione e sottoposti a campionatura.
In presenza di apparecchiature di sicurezza, targhe identificatrici, dispositivi di regolazione e misura,
l’isolamento lascerà scoperte le sole superfici minime necessarie a garantire l’accessibilità e l’ispezionabilità.
Verranno coibentati:
• Tutte le tubazioni, i serbatoi e le apparecchiature contenenti acqua refrigerata e calda o vapore/condensa, comprese valvole e flange.
• Tutte le tubazioni, serbatoi ed apparecchiature di cui si voglia evitare il congelamento quando la
temperatura esterna scende al di sotto della temperatura di congelamento del fluido trasportato.
• Tutte le tubazioni, serbatoi ed apparecchiature la cui temperatura di esercizio sia al di sotto della
temperatura media atmosferica e su cui si voglia evitare la condensazione dell’umidità.
• Tutte le canalizzazioni di presa aria esterna realizzate in sottocentrali chiuse.
• Le canalizzazioni di mandata aria a valle dei gruppi di condizionamento e quelle di ripresa.
• Le canalizzazioni di espulsione facenti capo a recuperatoli di calore, a monte dei medesimi.
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 35
•
Qualsiasi attacco di passerelle, scale, valvole di dreno, sfiato, scaricatori di condensa, filtri e tutte le
tubazioni per cui si desidera evitare perdita di calore.
Non verranno coibentati:
• Le canalizzazioni di espulsione non facenti capo a recuperatoli di calore e quelle a valle dei medesimi.
• Le canalizzazioni di presa aria esterna in sottocentrali all’aperto. Gonne, selle e gambe di supporto
dei serbatoi.
Identificazione degli isolamenti
Nelle documentazioni di progetto ed in tutta la documentazione che l’installatore produrrà verrà introdotta
per ogni linea l’identificazione dell’isolamento secondo il seguente codice di lettura:
1° carattere: identifica la funzione dell’isolamento:
A – Anticondensa
C - Caldo
F – Freddo
I – Interrato
P - Protezione
D – Condotti Aria
S - Scarichi
2° carattere: identifica il materiale da utilizzare:
A - guaine espanse Cll per caldo
B - guaine espanse Cll per freddo, permeabilità >5.000
C - fibra di vetro
D - vetro cellulare espanso
M - materassino in lana di vetro su carta alluminata
F - fonoassorbente per condotti aria: poliuretano antierosione
I - fonoisolante: bilamina in sandwich PU/Pb
3° carattere: identifica il tipo di finitura esterna:
0 - senza finitura
1 - lamierino alluminio
2 - gusci PVC Cll
3 - lamierino inox
4 - benda PVC
5 - rete zincata
6 - lamierino zincato
Materiali isolanti: guaine espanse
Le guaine isolanti saranno realizzate in speciali elastomeri espansi o in schiuma di resina sintetica. Dovranno
essere certificate Classe 1 di resistenza al fuoco e, nel caso di utilizzo per fluidi freddi o refrigerati, dovranno
essere dotate di permeabilità al vapore superiore a 5.000.
La posa dovrà essere eseguita conformemente alle istruzioni del produttore dell’isolamento, dotandosi di
strumenti di taglio e mastici adeguati. Per i casi in cui sia richiesta la barriera al vapore si dovranno prevedere i sormonti delle giunzioni a mezzo di nastro del medesimo materiale dell’isolante. Sempre in questi casi si
dovranno installare le apposite coppelle speciali per appoggio tubazione allo staffaggio in modo da garantire
lo spessore e la continuità dell’isolamento e della barriera al vapore.
Lo spessore dell’isolamento per tubazioni/canalizzazioni calde è legato alle prescrizioni del DPR 412; per le
tubazioni convoglianti acqua fredda sanitaria lo spessore antistillicidio da considerare è pari a 9 mm min, per
le tubazioni convoglianti acqua refrigerata e per la protezione antigelo si deve considerare lo spessore minimo di 30 mm.
Materiali isolanti: isolamento in fibra di vetro di tubazioni calde
Verranno utilizzate coppelle in lana di vetro con densità non inferiore a 60 kg/mc, rif. Isover TEL o equivalente, applicate a giunti sfalsati e strettamente accostati fra loro, con legatura in filo di ferro zincato ogni 30 cm.
Spessori per acqua calda conformi DPR 412; per vapore e condensa:
• sp. minimo 50 mm fino a DN40 (incluso);
• sp. minimo 60 mm fino a DN 80 (incluso);
• sp. minimo 80 mm oltre DN 80 e per serbatoi caldi e scambiatori.
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 36
Materiali isolanti: isolamento in fibra di vetro di tubazioni fredde
Verranno utilizzate coppelle in lana di vetro con densità non inferiore a 60 kg/mc, rif. Isover TEL o equivalente, applicate a giunti sfalsati e strettamente accostati fra loro, con legatura in filo
di ferro zincato ogni 30 cm. Successiva sigillatura di tutte le giunzioni mediante impasto di emulsione bituminosa con creazione di barriera al vapore mediante spalmatura su tutta la superficie dell’emulsione bituminosa. Avvolgimento con velo di vetro da pressare sulle superfici in modo da rimanere completamente annegato
nell’impasto. Ulteriore applicazione di impasto bituminoso (lkg/mq) fino alla copertura del velo e rivestimento
esterno di protezione in cartone cannettato. Spessori isolamento:
• sp. minimo 30 mm fino a DN50 (incluso);
• sp. minimo 50 mm fino a DN 150 (incluso);
• sp. minimo 60 mm fino a DN 250 (incluso);
• sp. minimo 80 mm oltre DN 250 e per serbatoi e scambiatori.
Materiali isolanti: isolamento in fibra di vetro di serbatoi e scambiatori di calore
Verranno utilizzati feltri in fibra di vetro trapuntato con filato di vetro su rete zincata, densità 65 kg/mc, rif.
Isover Tellsol 65 FV o equivalente. Spessore isolamento 80 mm.
Materiali isolanti: isolamento in fibra di vetro di canali rettangolari esterni
Verranno utilizzati materassini in lana di vetro sp 50 mm con densità non inferiore a 60 kg/mc, trapuntato su
cartone, applicato a mezzo collante e legato con rete di filo di ferro zincato all’esterno della canalizzazione.
Realizzazione di barriera al vapore mediante spalmatura su tutta la superficie di emulsione bituminosa. Avvolgimento con velo di vetro da pressare sulle superfici in modo da rimanere completamente annegato
nell’impasto. Ulteriore applicazione di impasto bituminoso (kg/mq) fino alla copertura del velo.
Materiali isolanti: isolamento in fibra di vetro di canali rettangolari interni
Verranno utilizzati materassini in lana di vetro sp. 25 mm con densità non inferiore a 60 kg/mc, trapuntato
su carta alluminata, applicato a mezzo collante e legato con rete di filo di ferro zincato all’esterno della canalizzazione previa sigillatura con astro in alluminio adesivo dei giunti.
Materiali isolanti: vetro cellulare espanso
Coibentazione in coppelle di vetro-cellulare espanso con resistenza alla compressione di almeno 500 KPa.
Temperatura di esercizio fino a 120°C e conducibilità termica in condizioni normali non inferiore a 0,03
W7mq°C. Protezione esterna in PEAD. Giunzioni a tenuta con guaine termorestringenti. Modalità di installazione e posa come da specifiche del produttore.
Materiali isolanti: materassino fonoassorbente in PU per canali aria
Materassino fonoassorbente per montaggio interno alle canalizzazioni aria in espanso di PU densità 30-34
kg/mc- adatto per temperature da -40 ad 80°C, trattato superficialmente per non manifestare rischi di erosione per velocità dell’aria fino a 20 m/sec. Classe 1 di resistenza al fuoco. Rif. Cofermetal Acustifilm o equivalente, sp. 13 mm. Da installare conformemente alle prescrizioni del costruttore con mastici di caratteristiche idonee al mantenimento della Cll, con l’aggiunta di reggette metalliche zincate, rivettate nei punti di
giunzione.
Materiali isolanti: materassino fonoisolante bilamina
Da utilizzare esternamente a tubazioni e canalizzazioni, sarà realizzato in materassino di PU densità 30-34
kg/mc- adatto per temperature da -40 ad 80°C, in sandwich con doppio strato in lamina di piombo Spessore
19 mm. Peso lastre di piombo 3 kg/mq. Finitura esterna in film impermeabile all’acqua e resistente ad agenti
chimici, oli, ad abrasione. Posa con sormonto giunti e fissaggio tramite mastici con accurata sigillatura dei
ponti acustici.
Finiture: lamierino alluminio
Per i tratti di tubazione in vista il materiale di finitura consisterà in lamierino di alluminio, titolo di purezza in
Al 99,5% minimo di spessore 6/10 mm per tubazioni e di 8/10 per collettori, apparecchiature recipienti e
serbatoi, 10/10 per scatole valvolame. Sui giunti longitudinali il lamierino sarà aggraffato e sovrapposto, lungo la circonferenza è sufficiente la semplice sovrapposizione di almeno 50 mm. Viti autofilettanti tipo Parker
in acciaio inossidabile verranno impiegate per il fissaggio del lamierino.
Le giunzioni installate all’esterno dell’edificio avranno sigillatura con mastice siliconico a perfetta tenuta. La
testa dei collettori di DN fino a 200 sarà conica, per diametri superiori, come per i coperchi di serbatoi e tutte
le altre superfici semisferiche, la finitura sarà a spicchi, semisferica anch’essa.
Poiché dovranno essere isolati tutti i pezzi speciali, incluse valvole, saracinesche, ritegni, filtri, ecc, i quali richiedono periodiche manutenzioni, si dovrà prevedere sui medesimi gusci in alluminio atti a contenere la
coibentazione. I gusci saranno privi di vuoti, da riempire con isolante opportunamente sagomato, e realizzati
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 37
in due metà con chiusura mediante cerniera a scatto facilmente smontabili.
Finiture: gusci in PVC
Rivestimento con guaina di materiale plastico autoestinguente (tipo okapac o isogenopak o simile). Sigillato
lungo le giunzioni con apposito collante fornito dalla stessa casa costruttrice (oppure con il bordo da sovrapporre, già adesivo all’origine).
Tutte le curve, T, etc. dovranno essere rivestite con i pezzi speciali gi disponibili in commercio, posti in opera
con le stesse modalità.
Nelle testate saranno usati collarini di alluminio.
Finiture: benda in PVC
La bendatura avverrà in modo elicoidale, ben stretta, con sormonto del 50% delle singole spire. Si eseguiranno sempre fasciature in doppia passata, con accurata chiusura delle terminazioni.
Isolamento valvolame e pezzi speciali
Devono essere isolati tutti i pezzi speciali, incluse valvole, saracinesche, ritegni, filtri, ecc. sia soggetti a dispersione termica che a condensazione atmosferica. L’isolamento deve essere conforme alle specifiche di linea, con finitura in alluminio.
Isolamento elettropompe
Le coclee delle elettropompe acqua calda, condensa e acqua refrigerata dovranno essere isolate con sistema
analogo al valvolame relativo. Finitura in alluminio, con scatole apribili.
Isolamento serbatoi e scambiatori di calore
Serbatoi caldi e scambiatori di calore dovranno essere isolati a mezzo di feltri in fibra di vetro trapuntato
(c.f.r.). Finitura esterna in allumino.
VALVOLAME ED ACCESSORI PER TUBAZIONI
Si provvederà a completare le tubazioni ed il loro allacciamento alle apparecchiature con valvole, raccordi,
ecc. secondo gli schemi allegati.
In ogni caso, anche se non espressamente indicato dai predetti schemi, ogni corpo scaldante condizionatore
da ambiente o valvola motorizzata, sarà dotato di organi di intercettazione e/o regolazione.
La Ditta costruttrice dovrà disporre della certificazione per la garanzia della qualità in accordo alla norma
UNI-EN 29001 o documento equivalente prodotto da un istituto di certificazione secondo ISO 9001, BC5750,
NFX50.131, o equivalente
Valvole
Tutte le valvole, dopo la posa in opera, saranno opportunamente isolate con materiale e finitura dello stesso
tipo delle tubazioni su cui sono installate.
Tutte le valvole saranno scelte per una pressione normale minima PN10.
Tutti gli organi di intercettazione e/o regolazione potranno essere sottoposti a prove di tenuta per il corpo
(consistenti nell’assoggettarlo ad una pressione pari a 1,5 volte quella di esercizio) e per l’otturatore (consistente nel sottoporre alla pressione di esercizio la parte a monte dell’otturatore); in tutti e due i casi la prova
risulterà positiva se per ventiquattro ore non si noteranno perdite apprezzabili.
Le valvole potranno avere corpo in bronzo o ottone per piccoli diametri (DN < 50 mm); il corpo sarà invece
in ghisa per diametri superiori limitatamente a fluidi quali l’acqua, oli e gas freddi.
Per il vapore, le valvole avranno corpi in acciaio fuso al carbonio per piccoli diametri e in acciaio legato per
diametri superiori.
Per piccoli diametri e comunque in impieghi non critici (bassa pressione e/o bassa temperatura) le valvole
avranno il coperchio di tipo filettato o saldato; per dimensioni superiori e per servizi critici il coperchio sarà
bullonato. In quest’ultimo caso la faccia della flangia di accoppiamento sarà a gradino e la guarnizione di tipo
metallo - plasto.
Per i servizi moderati i seggi delle valvole potranno essere filettati; per valvole in bronzo ed acciaio i seggi
saranno integrali.
Per valvole a saracinesca l’otturatore sarà del tipo a cuneo; solo per condizioni di esercizio moderate e per
diametri superiori a 100 mm verrà fatto uso di valvole con otturatore a dischi.
Per le valvole di ritegno a battente l’otturatore sarà integrale. Le valvole possono essere di vari tipi:
Valvole a farfalla
Saranno utilizzate in tutti i circuiti per i quali è prevista la sola intercettazione. In caso di utilizzo per circuiti
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 38
antincendio, dovranno essere dotate di indicatore di posizione.
Di tipo wafer o full lug, saranno a doppia pressione di esercizio di 10 bar con temperatura di esercizio da 15°C a 130°C. Il corpo sarà in ghisa completo di base di fissaggio per organi di manovra secondo unificazione 150; la farfalla, di forma lenticolare, sarà costruita senza appendici o spinotti e la centratura dell’asse di
rotazione permetterà flusso bidirezionale. La sede di tenuta sarà in elastomero rimovibile EPDM; la leva di
comando di tipo a cremagliera. Per i diametri del DN150 compreso in poi dovrà essere previsto un riduttore
di comando con azionamento a volantino, se non altrimenti indicato dagli elaborati di progetto.
Valvole a saracinesca
Saranno utilizzate in tutti i circuiti per i quali è prevista la sola intercettazione.
Di tipo in ghisa, flangiate PN10, delle seguenti caratteristiche:
• corpo e cappello in ghisa gg 25,
• stelo in acciaio inox AISI416,
• tenuta sull’albero in grafite esente da manutenzione,
• tenuta tra il cappello ed il corpo in grafite,
• tenuta a mezzo cuneo gommato.
Valvole a sfera
Saranno costruite con corpo in ottone ricavato da barra trafilata, sfera in acciaio inox oppure in ottone cromata a spessore, guarnizioni in PTFE leva in duralluminio plastificato, serie PN10 minimo.
Detto tipo di valvola potrà essere impiegato per diametri dal 3/8” al 1” compreso. Per diametri superiori ad
1”, le valvole a sfera saranno con corpo in acciaio al carbonio e, per diametri sopra 2” di tipo wafer, con attacco flangiato, sfera in acciaio inox, seggi in PTFE.
Le valvole a servizio di fluidi refrigerati, avranno asse leva prolungato, per permettere la coibentazione.
Valvole a flusso avviato
Per l’utilizzo su linee vapore e, per acqua calda e refrigerata, in tutti i circuiti per cui è prevista, oltre alla
possibile intercettazione, anche la necessità di effettuare una regolazione della portata, saranno installate
valvole di regolazione del tipo a flusso avviato.
Le valvole per vapore saranno in acciaio, a flusso avviato con tenuta a soffietto in acciaio inox e con premistoppa. Asta, sedi di tenuta a soffietto in acciaio inox. Attacchi flangiati. PN 25 e risalto UNI 2229. Se richiesto, esecuzione a squadra.
Per acqua calda e refrigerata verranno adottate valvole a flusso avviato con tenuta morbida di chiusura e di
regolazione con attacchi flangiati PN 16 e risalto UNI 2229 delle seguenti caratteristiche: corpo e cappello in
ghisa gg 25 stelo in acciaio inox AISI 416 tenuta sull’albero in grafite esente da manutenzione tenuta tra il
cappello ed il corpo in grafite sede di tenuta dell’otturatore sul corpo in acciaio inox AISI 304 otturatore in
acciaio, guarnizione di tenuta dell’otturatore sulla sede in teflon intercambiabile. Se richiesto, esecuzione a
squadra.
Gruppo di riduzione pressione per vapore II gruppo di riduzione pressione sarà costituito da:
• riduttore di tipo autoazionato con soffietto di equilibratura, completa di gruppo di regolazione; PN
16; corpo in ghisa; otturatore, stelo, soffietto e sede in acciaio inox; attacchi flangiati,
• filtro a monte c.s.,
• valvole intercettazione a monte e valle (di diverso diametro) tubazione di by-pass completa di valvola intercettazione 2 manometri con ricciolo e rubinetto di prova,
• valvola di sicurezza in ghisa ad alzata totale, di diametro adeguato alla max portata che può passare,
nelle condizioni di esercizio, attraverso il by-pass oppure attraverso la valvola di riduzione completamente aperta,
• eliminatore d’aria.
Gruppo di scarico condensa a galleggiante II gruppo sarà costituito da:
• scaricatore di condensa a galleggiante con dispositivo termostatico per l’espulsione aria, corpo in
ghisa, galleggiante e congegni interni in acciaio inox, adatto alla pressione differenziale di esercizio,
• indicatore di passaggio, corpo in ghisa, spia in vetro temperato filtro in ghisa con elemento filtrante
inox 2 valvole di intercettazione, 1 di bypass rompi vuoto,
• accessori vari di collegamento.
Gruppo di scarico condensa a secchiello rovesciato II gruppo sarà costituito da:
• scaricatore di condensa a secchiello rovesciato completamente automatico, secchiello e congegni interni in acciaio inox, adatto alla pressione differenziale di esercizio (max 8 bar),
• indicatore di passaggio, corpo in ghisa, spia in vetro temperato filtro in ghisa con elemento filtrante
inox 2 valvole di intercettazione, 1 di bypass rompi vuoto eliminatore d’aria accessori vari di collegamento.
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 39
Valvola a doppia regolazione
Le valvole a doppia regolazione potranno essere tipo diritto o angolo e saranno in bronzo con attacchi filettati di costruzione robusta PN10 e complete di volantino.
Valvole a detentore
Le valvole a detentore saranno in bronzo con attacchi filettati di costruzione robusta PN10 e completi di vite
di chiusura coperta da cappuccio filettato.
Valvole di ritegno
Le valvole di ritegno del tipo a via diretta o a flusso avviato risponderanno alle caratteristiche costruttive appresso indicate:
• valvole a pistone (vapore) e corpo in ghisa UNI 668 G22 sedi di bronzo;
• molle di acciaio inossidabile otturatore a profilo idrodinamico guarnizioni di tenuta in idoneo materiale plastico attacchi a flangia max diametro di impiego 150 mm circuiti acqua calda e refrigerata per
diametri uguali o inferiori a 1 ¼” attacchi filettati;
Valvole di ritegno a battente clapet, serie PN 16 adatti per circuiti verticali e/o orizzontali delle seguenti caratteristiche:
• corpo e otturatore in bronzo;
• guarnizioni di tenuta sull’otturatore in gomma;
• attacchi a manicotto filettati gas;
Circuiti acqua calda e refrigerata per diametri uguali o superiori a DN 40 attacchi flangiati PN 16 con rialzo
UNI 2229.
Valvole di ritegno di tipo verticale delle seguenti caratteristiche:
• corpo in ghisa 20-22;
• otturatore in ghisa G 20-22;
• sede di tenuta sul corpo in ottone;
• guarnizione di tenuta sull’otturatore in gomma intercambiabile.
Valvole di ritegno a battente clapet PN 16 per circuiti verticali e/o orizzontali delle seguenti caratteristiche:
• corpo e coperchio in ghisa G 20-22;
• otturatore in ghisa G 20-22;
• sede di tenuta sull’otturatore in ottone;
• guarnizione di tenuta sull’otturatore in gomma dura.
Filtri
Circuiti acqua calda o refrigerata per diametri uguali o inferiori 1 ¼” attacchi filettati.
Filtri raccoglitori di impurità delle seguenti caratteristiche:
• corpo e coperchio in ottone;
• cestello in acciaio inox.
Circuiti acqua calda o refrigerata per diametri uguali o superiori al DN 40 attacchi flangiati.
Filtri raccoglitori di impurità delle seguenti caratteristiche:
• corpo in ghisa G 20-22;
• coperchio in ghisa G 20-22;
• cestello in acciaio inox 18/8 AISI 304 con, minimo, n. 9;
• fori del diametro di 2 mm per cmq.
Valvole di sicurezza
Le valvole di sicurezza saranno del tipo a molla.
Il corpo valvola potrà essere in ghisa o in bronzo a seconda del tipo di valvola impiegato. In ogni caso saranno omologate ISPESL.
Le sedi delle valvole saranno a perfetta tenuta fino a pressioni molto prossime a quelle di apertura; gli scarichi saranno ben visibili e saranno collegati mediante tubazioni in acciaio zincato al pozzetto di scarico.
Valvole di scarico termico
Saranno costruite in ottone con molle in acciaio di tipo qualificato ISPESL con attacchi a manicotto filettati,
elemento sensibile a grande alzata, microinterruttore con pulsante di riarmo manuale, segnalatore di apertura valvola.
Valvole di sfogo automatico dell’aria
Per norma lo sfogo dell’aria di sfiato sarà manuale, realizzato mediante barilotto di raccolta e valvola a sfera.
Ove concordato con la D.L., in ciascuno punto alto delle tubazioni sarà installata una valvola di sfogo
dell’aria; la valvola sarà di tipo a galleggiante in ottone completa di attacco filettato; ciascuna valvola sarà
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 40
completa di maschio di esclusione.
Quelle per lo sfogo dell’aria dai radiatori saranno costruite con corpo in ottone ricavato da barra trafilata, tenuta a spillo, dispositivo di manovra a cacciavite.
Flange
Le flange potranno essere dei seguenti due tipi: a saldare per sovrapposizione, a tasca da saldare.
Le flange a tasca saranno impiegate per piccoli diametri (DN 50mm), in circuiti di acqua calda fino a 95 °C o
refrigerata.
La faccia di accoppiamento delle flange, sarà del tipo a gradino o a risalto con l’esclusione di quei casi dove
l’attacco ad apparecchiature che abbiano bocchelli flangiati prefabbricati obblighi all’impiego di flange a faccia piana o ad anello.
Guarnizioni
Saranno usate guarnizioni del tipo piano non metallico con gomma sintetica ed altri eventuali leganti. Per le
guarnizioni relative a linee fluidi potabili usare materiale certificato atossico.
Filtri per acqua
Saranno del tipo a Y con corpo in ghisa (o in ottone), attacchi flangiati (o filettati) adatti per le temperature
di esercizio previste.
L’elemento filettante sarà in lamiera di acciaio inossidabile 18/8 di spessore non inferiore a 0,5 mm forata
con fori di diametro non superiore a 0,6 mm.
Rubinetti per gas metano
I rubinetti di intercettazione del gas metano saranno del tipo a sfera o a farfalla, con comando a leva, colore
giallo, omologati per il servizio con gas a norme UNI - CIG.
TERMOMETRI ED IDROMETRI
Termometri a quadrante
I termometri da installare dovranno rispondere alle Norme UNI ed alle Norme vigenti in materia.
Essi dovranno essere del tipo a quadrante, completi di indice rosso con vite di fissaggio onde indicare il punto ottimale di lavoro e di temperatura dell’impianto.
I termometri dovranno essere del tipo ad immersione a quadrante, a dilatazione di mercurio e vite di taratura; dovranno consentire la lettura con la precisione di 1°C per l’acqua calda e 0,5°C per l’acqua refrigerata.
I termometri per l’acqua saranno completi di manicotto e di pozzetto in ottone d’immersione, con la lunghezza minima di 100 mm; i termometri per l’aria saranno completi di flangia di fissaggio alla lamiera con il bulbo
avente una lunghezza minima di 250 mm.
II quadrante avrà diametro 80 mm.
Termometri a colonna
I termometri a colonna saranno a squadra del tipo a bulbo con custodia in ottone, lunghezza della scala 200
mm, campo 0-80 C, per l’acqua di torre,-20-+40 C per l’acqua refrigerata, 0-120 C per l’acqua calda; precisione 1°C.
Idrometri a quadrante
Gli idrometri da installare dovranno rispondere alle norme UNI ed alle Norme vigenti in materia.
Essi dovranno essere del tipo a quadrante, completi di indice rosso con vite di fissaggio onde indicare il punto ottimale di lavoro e di pressione dell’impianto.
Gli idrometri dovranno essere dotati di rubinetto di prova del tipo a tre vie e flangia di attacco dell’idrometro
campione e ricciolo in rame; la precisione di lettura non dovrà essere +/- 1,5% secondo UNI 4656. La scala
dovrà essere espressa in kPa. Per il controllo di pressioni differenziali su macchine ed apparecchiature potrà
essere prevista l’installazione di un unico idrometro in deviazione.
In tal caso, per il montaggio, questo sarà dotato di:
• Rubinetto deviatore a tre vie,
• tubo in rame a ricciolo per assorbimento vibrazioni,
• rubinetto di prova a tre vie deviatore con flangia porta manometro campione.
Il quadrante avrà diametro 80 mm.
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 41
BOCCHETTAME ED ACCESSORI PER CANALIZZAZIONI
Le griglie, le bocchette ed i diffusori di mandata, ripresa, transito, aria esterna, espulsione e in generale tutti
gli accessori per le canalizzazioni, avranno le caratteristiche sotto riportate e saranno installati nelle posizioni
necessarie ad ottenere una perfetta distribuzione dell’aria.
Condizioni di progetto
La velocità dell’aria nella zona occupata dalle persone non risulterà superiore a 0,16 m/sec a livello uomo;
pertanto sarà opportuno che il lancio e la velocità di uscita dalle bocchette non eccedano i limiti più sotto riportati.
La velocità dell’aria in uscita dalle bocchette di mandata misurata mediante anemometro sarà limitata a 2-3
m/sec per le bocchette poste in prossimità delle persone, ed a 6-7 m/sec per le bocchette poste in zona lontana dalle persone.
La velocità frontale dell’aria alle bocchette della ripresa sarà limitata a 2-3 m/sec.
I diffusori circolari o quadrati a soffitto saranno dimensionati con una velocità nel collo non superiore a 5-6
m/sec.
Per le bocchette di transito la velocità dell’aria non sarà superiore a 2-3 m/sec ed in ogni caso la velocità non
darà luogo a rumorosità ed a correnti.
La velocità dell’aria misurata sulle griglie di presa dell’aria esterna non supererà i 5 m/sec.
La scelta dei materiali ed i criteri di costruzione e di installazione delle varie apparecchiature saranno tali da
assicurare in ogni ambiente condizionato riscaldato e/o ventilato, durante il funzionamento degli impianti e
nelle proprie normali condizioni di vita un livello di pressione sonora non superiore di 3dB (A) al livello di
fondo esistente nel punto di misura quando l’impianto non funziona.
Queste condizioni potranno essere verificate in più punti dell’ambiente (distribuiti in particolare nelle zone
ove sono normalmente presenti le persone ) in normali condizioni di abitabilità e di attività dell’ambiente
stesso.
Il rilievo fonometrico tendente a stabilire il valore del rumore di fondo ambientale potrà essere e seguito
mediante più misurazioni alle varie ore di attività dell’ambiente in prova; verrà assunto come valore del livello di pressione sonora del rumore di fondo la media aritmetica delle Gli strumenti di misura utilizzati nelle
prove saranno conformi alle norme IEC n. 128, 179, 225.
Diffusori quadrangolari ad effetto elicoidale
I diffusori del tipo quadrangolare ad effetto elicoidale in esecuzione quadrata, sezione libera, livello sonoro e
perdita di carico invariate in tutte le posizioni delle alette. Costituito da pannello frontale con guarnizioni in
PU completo di alette regolabili in materiale sintetico disposte radialmente. Completo di camera di raccordo
in lamiera di acciaio zincato con lamiera forata raddrizzatrice. Rif. Schako DQJ-SQ o equivalente.
Griglie di transito
Le bocchette di transito saranno in alluminio o in lamiera di acciaio fosfatizzata e verniciata a fuoco in colore
alluminio, secondo le indicazioni del progetto, del tipo a labirinto con alette a “V” complete di cornice e contro cornice per applicazione su porte o pareti.
Griglie di ripresa
Le bocchette di ripresa dell’aria saranno del tipo quadrangolare ad unico ordine di alette orizzontali fisse inclinate, costruite in alluminio estruso e complete di serranda di taratura ad alette contrapposte comandabili
dall’esterno con apposita chiave e facilmente smontabili senza danni alle opere murarie; preferibilmente verrà impiegato il fissaggio a scatto.
Valvole di estrazione
Per l’estrazione dell’aria viziata dai servizi potranno essere impiegate le valvole del tipo a diffusore circolare
con cono centrale regolabile per la taratura della portata dell’aria. Saranno costruite in lamiera d’acciaio fosfatizzata e verniciata a fuoco, o in PVC.
Griglie esterne
Le bocchette di presa aria esterna ed espulsione saranno costruite in lamiera d’acciaio zincata di forte spessore con alette inclinate per impedire l’ingresso della pioggia; le bocchette saranno complete di rete antivolatile e di tegolo rompigocce.
Serrande di taratura e regolazione
Le serrande sia di taratura che di regolazione del tipo quadrangolare, saranno costruite totalmente in lamiera
di acciaio zincata, con assi di rotazione delle alette alloggiati in bussole di nylon (o ottone).
Le alette, a movimento contrapposto, saranno collegate fra loro mediante levismi di sincronismo posti in posizione laterale e facilmente accessibili; esse saranno profilate in modo tale da assicurare una elevata resi__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 42
stenza alla flessione ed alla torsione. La tenta, nelle serrande di intercettazione, sarà garantita da apposite
guarnizioni in gomma poste sulle alette. La guarnizione sarà di elastomero.
L’accoppiamento asse di rotazione-alette sarà realizzato tramite bullone passante.
Ciascuna serranda sarà dotata di dispositivo che ne permetta l’azionamento manuale e di indicatore di posizione chiaramente visibile dall’esterno.
Le serrande sia di taratura che di regolazione del tipo circolare avranno involucro ed unica aletta in lamiera
d’acciaio zincata. La tenta, nelle serrande di intercettazione, sarà garantita da apposite guarnizioni in gomma
poste sulle alette. La guarnizione sarà di elastomero.
Serrande tagliafuoco
Le serrande tagliafuoco saranno della stessa forma (circolare o rettangolare) e dimensioni del canale in cui
vanno inserite.
Dovranno essere di tipo omologato ed approvato dal M.I., REI 120, oppure secondo quanto richiesto nel
punto di installazione se di caratteristiche superiori.
Saranno realizzate in robusta lamiera di acciaio zincato, collegate al canale con sistema a flangia, con interposizione di adeguata guarnizione tale da garantire perfetta tenuta del giunto.
L’aletta sarà in lamiera zincata a doppia parete, con interposizione di idoneo materiale di tenuta non contenente amianto (minimo 20 mm) e l’intervento avverrà a mezzo di fusibile e molla, tarato a 67-71°C.
La serranda sarà inoltre dotata di portello d’ispezione, vite di regolazione e microinterruttore di segnalazione
dello scatto.
Se richiesto, la serranda tagliafuoco dovrà essere del tipo con dispositivo di sgancio elettrico adatto ad essere azionato dall’impianto di rilevazione fumi: naturalmente rimarrà il fusibile e lo sgancio dovrà poter avvenire sia per intervento del fusibile che, indipendentemente, per intervento del dispositivo elettrico. In altre parole, l’intervento di uno qualsiasi dei due meccanismi dovrà provocare la chiusura della serranda.
Qualora le canalizzazioni dell’aria nelle quali inserita la serranda non siano in lamiera zincata, la serranda dovrà essere costruita nello stesso materiale (ad esempio alluminio o acciaio inox) con cui sono costruiti i canali.
Se richiesto, la serranda dovrà essere dotata di servocomando elettrico o pneumatico per l’apertura. In ogni
caso sia la serranda che tutti gli automatismi dovranno essere omologati ed approvati dal M.I. nel loro insieme.
La serranda dovrà essere posta in opera “a cavallo” della parete tagliafuoco, lasciando libero il comando di
riarmo manuale.
Captatori
I captatori d’aria saranno del tipo regolabile costruiti in serie, in lamiera di acciaio zincata.
La struttura mobile, composta da astine di collegamento e rango di alette curve a 90 g. garantirà una deflessione sempre ortogonale indipendentemente dalla posizione assunta dal captatore.
II movimento sarà a compasso con centri di rotazione su apposita basetta da fissare alla diramazione.
La regolazione avverrà a mezzo di apposita asta di manovra che consentirà di posizionare il captatore in
qualsiasi angolazione da “tutto aperto” a “tutto chiuso”.
Silenziatori per canali quadrangolari
I silenziatori a sezione rettangolare dovranno essere del tipo rettilineo a settori.
La cassa dovrà essere realizzata in lamiera d’acciaio zincata, di spessore minimo 10/10, con opportuni rinforzi che ne garantiranno una perfetta solidità; alle estremità dovranno essere predisposte flange, guarnizioni e
bulloni per il collegamento delle canalizzazioni.
II materiale fonoassorbente utilizzato dovrà essere costituito da speciali pannelli in fibra di vetro ad altissima
densità (100 kg/mc) ininfiammabili apprettati sulla superficie a contatto con l’aria con uno strato di neoprene
perfettamente permeabile alle onde sonore che dovrà assicurare una notevole resistenza superficiale
all’erosione dovuta al flusso dell’aria. Il materiale fonoassorbente non dovrà essere igroscopico, non dovrà
favorire lo sviluppo e la formazione di batteri, né dovrà essere soggetto a corrosione da parte degli agenti
atmosferici. I settori, costruiti col materiale fonoassorbente sopra descritto, dovranno avere uno spessore
minimo di 150 mm. e dovranno essere racchiusi entro apposite cornici di acciaio zincato, dovranno essere
solidamente inseriti e fissati alla cassa di contenimento.
Le parti laterali dei silenziatori dovranno essere rivestite interamente con settori di spessore di 100 mm. onde impedire le fughe laterali di rumore.
Il silenziatore dovrà avere come minimo le seguenti caratteristiche di abbattimento complessivo (tenuto conto anche della rigenerazione) per banda di ottava:
HZ
63
125
250
500
1000
2000
4000
dB
7
12
16
28
35
35
28
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 43
Tali prestazioni dovranno essere rese con una perdita di carico, valutata alla portata di esercizio, non superiore a 50 Pa.
Il silenziatore sarà raccordato al canale con appositi tronchi conici, con conicità non superiore a 15 gradi.
Le prestazioni su esposte devono intendersi come dei minimi, nel senso che se la rumorosità nei locali superasse, a causa di rumori provenienti dalle canalizzazioni, i livelli NC consigliati, la
Ditta dovrà, senza alcun onere per la S.A., sostituire o modificare i silenziatori, in modo da far rientrare la
rumorosità entro livelli accettabili.
Qualora i canali d’aria entro cui inserito il silenziatore non siano in acciaio zincato, il silenziatore sarà realizzato nello stesso materiale (ad esempio alluminio o acciaio inox) dei canali.
Silenziatori per canali circolari Saranno in analogia con quelli quadrangolari:
• involucro esterno in lamiera zincata da almeno 10/10, con flange, bulloni e guarnizioni per il collegamento ai canali;
• rivestimento interno in materiale fonoassorbente, e lamierino forato, o simile;
• per i diametri interni da 300 mm in poi: ogiva interna in materiale fonoassorbente, rivestito c.p.d.
Il silenziatore dovrà avere come minimo le seguenti caratteristiche di abbattimento complessivo (tenuto conto anche della rigenerazione) per banda di ottava:
HZ
63
125
250
500
1000
2000
4000
SENZA OGIVA dB
2
5
10
14
14
11
8
CON OGIVA dB
6
9
14
22
22
17
15
Altre caratteristiche come indicato per i canali quadrangolari.
REGOLAZIONE AUTOMATICA ELETTRONICA
Generalità
Tutti gli impianti saranno dotati, di regolazione automatica per il mantenimento delle condizioni termoigrometriche di progetto; la regolazione sarà elettronica, gestita da un sistema centralizzato.
L’impianto di regolazione sarà fornito completo di tutti gli accessori necessari per il suo funzionamento e perfettamente tarato.
Sonde di temperatura Le sonde trasmettitrici delle grandezze rilevate, dovranno:
• essere scelte nei campi di misura appropriati;
• essere complete di eventuali guaine e staffe per fissaggio.
Non saranno ammesse sonde di temperatura a contatto.
Le sonde di temperatura per canali dovranno:
• essere di lunghezza tale da rilevare sempre la temperatura media dell’aria;
• non essere a contatto con le pareti del canale.
Sonde di umidità relativa
Le sonde di umidità relativa saranno sia del tipo da ambiente che del tipo da canale e potranno essere dotate di potenziometro incorporato.
Montaggio
Le sonde ambiente verranno installate possibilmente ad una altezza di ca. m 1,5 a parete, su di una scatola
incassata. È però possibile anche il montaggio esterno. Sono da evitare posizioni che risentano di fonti di calore o di umidità, come presso porte, finestre, camini, ecc. È anche da evitare l’installazione presso angoli,
nicchie o posizioni in cui non vi sia libera circolazione dell’aria.
Le sonde da canale dovranno essere posizionate in prossimità del centro del canale stesso, quando si impieghi la sonda con flessibile, questo dovrà interessare l’intera sezione del canale e non venire in contatto con
le pareti del canale stesso. La sonda dovrà essere piegata in modo tale che sia disposta sulla diagonale del
canale oppure formi delle spire equidistanziate per tutta le sezione del canale.
Per le sonde di umidità dovrà essere assicurata una distanza di almeno tre metri da eventuali umidificatori a
vapore.
La sonda da immersione su tubazioni dovrà essere montata, ove possibile, in una curva in modo da opporsi
al senso di circolazione del fluido. In caso di impianti con valvola miscelatrice, l’acqua deve risultare ben miscelata nel punto di installazione della sonda e comunque non dovrà essere ad una distanza inferiore a 1,5
metri dalla valvola stessa.
La sonda climatica da esterno dovrà essere installata preferibilmente sulla parete dell’edificio esposta a nord
e comunque non esposta ai raggi del sole. L’altezza da terra dovrà essere minimo 2,5 metri.
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 44
Dovranno essere evitate installazioni sopra finestre, porte, correnti d’aria o altre sorgenti di calore, ed in corrispondenza di balconi o gronde. Il tubo dei conduttori in corrispondenza della sonda dovrà essere isolato
per evitare errori di misura. La sonda non dovrà essere verniciata.
Le sonde di pressione non dovranno essere installate su parti soggette a vibrazioni o su tubazioni sottoposte
a pressioni “pulsanti”. La testa della sonda dovrà essere sempre rivolta verso l’alto per evitare introduzione di
sporcizia o altro nell’elemento sensore.
Servocomandi per serrande per regolazione proporzionale
Per la regolazione proporzionale di serrande per aria, verranno impiegati servocomandi proporzionali a variazione di tensione con shut off in caso di non utilizzo della zona.
Funzionamento:
Un relè elettronico di regolazione con circuiti di comando integrati sarà integrato nel servocomando. Il potenziometro di bilanciamento verrà collegato direttamente su questo circuito. Ad ogni tensione tra 2...10V
corrisponderà uno spostamento proporzionale a questo segnale.
Costruzione:
Il servocomando sarà costituito da una cassa di contenimento in lega di alluminio presso fusa nella quale è
alloggiato lo stelo di azionamento delle serrande; il movimento rotatorio del motore sincrono reversibile, protetto contro i sovraccarichi, viene trasformato in un movimento assiale dello stelo.
Il servocomando sarà completo di attacco elettrico e staffa di montaggio. Il servocomando sarà protetto contro lo stillicidio.
Montaggio:
Sarà possibile il montaggio direttamente sulle serrande in qualsiasi posizione.
Servocomandi per serrande con molle di ritorno
I servocomandi per serrande con molla di ritorno vengono impiegati per il comando a due posizioni oppure
per la regolazione proporzionale di serrande di sicurezza (per esempio serrande antincendio o antigelo).
Funzionamento:
II motore reversibile del servocomando viene comandato a due posizioni oppure regolato proporzionalmente.
In caso di caduta di tensione o di entrata in azione di un elemento di sicurezza (per esempio il termostato
antigelo), la serranda aperta viene chiusa mediante la molla dell’apparecchio di emergenza.
I servocomandi saranno cablati fissi con i circuiti di relè a potenziale zero senza interruttori ausiliari.
All’esterno verranno collegate solo le tensioni di comando, e rispettivamente di alimentazione e di comando.
Costruzione:
Il servocomando sarà costruito c.s.
Montaggio:
Sarà possibile il montaggio direttamente sulle serrande in qualsiasi posizione.
Valvole servocomandate per acqua calda e fredda
Tutte le valvole, se non altrimenti prescritto, saranno di tipo proporzionale, di funzionamento silenzioso e saranno disposte normalmente aperta o normalmente chiusa in modo da non recara danno in caso di mancanza di corrente.
La posizione di apertura e di chiusura sarà specificata in conformità alle esigenze delle condizioni di lavoro.
Tutte le valvole saranno in grado di funzionare a velocità variabile, per corrispondere esattamente al segnale
dell’organo di controllo e alle esigenze per variazione di carico.
Le valvole che operano in sequenza, con altri servocomandi di valvole o serrande, dovranno avere campi di
lavoro e punti di intervento aggiustabili in modo da avere la massima flessibilità nelle sequenze e nella banda
proporzionale.
Tutti i corpi di valvola avranno le stesse caratteristiche di resistenza alla pressione dei tubi sui quali vengono
installati.
Le valvole per acqua refrigerata e calda saranno:
• per diametri inferiori a 2” corpo in bronzo PN 10/16 con attacchi filettati e con bocchettoni, otturatore e stelo in acciaio inox, adatte per acqua fredda e calda max 110°C;
• per diametri uguali o superiori a 2” corpo in ghisa PN 16 flangiate; sede, otturatore e stelo in acciaio
inox, adatte per il tipo di fluido regolato; temp. max 110°C;
• per uniformità, in una stessa centrale, le valvole di regolazione dovranno essere dello stesso tipo del
valvolame impiegato (bronzo o ghisa).
Valvole di regolazione in ghisa per alte temperature (max 180°C)
Il corpo sarà in ghisa PN16, stelo ed otturatore in acciaio inox, attacchi flangiati, complete di controflange,
guarnizioni e bulloni.
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 45
Le valvole saranno NC o NA secondo la sicurezza che devono garantire.
Le valvole avranno un sistema di protezione del servocomando elettrico onde evitare il superamento della
temperatura di esercizio dello stesso.
Valvole di regolazione in acciaio PN 25
Il corpo sarà in acciaio al carbonio PN25, stelo ed otturatore in acciaio inox, attacchi flangiati, complete di
controflange, guarnizioni e bulloni.
Le valvole saranno NC o NA secondo la sicurezza che devono garantire.
Le valvole avranno un sistema di protezione del servocomando elettrico onde evitare il superamento della
temperatura di esercizio dello stesso.
Dispositivo di regolazione valvole
Il dispositivo di regolazione sarà meccanicamente semplice, robusto e tale da non richiedere manutenzione.
Ogni minimo movimento verrà trasmesso dal sistema rigido all’otturatore, cosicché anche il passaggio di
quantità minime d’acqua attraverso la valvola può essere regolato in modo progressivo.
Le valvole saranno autocompensate dal punto di vista della pressione. Valvole per mobiletti a tre vie con bypass incorporato.
Per il controllo di radiatori e batterie riscaldanti con modesto carico termico (fino a 14 kW), verranno impiegate valvole a tre vie con by-pass incorporato.
La valvola proporzionale a tre vie miscelatrice con by-pass incorporato sarà comandato dal regolatore. Dimensionando in modo corretto la valvola (perdita di carico attraverso la valvola uguale a quella della batteria
di scambio termico), la portata rimane costante attraverso tutto il suo campo di regolazione.
Essendo il by-pass già incorporato non occorre il by-pass esterno. L’attacco avviene mediante nipple filettato
G ½” o ¾”. Guarnizioni piatte potranno garantire la tenuta del collegamento tra valvole e tubi.
Servomotori
I servocomandi dovranno essere idonei a comando di tipo proporzionale (non sono ammessi servomotori per
comando a tre punti) avere principio di azionamento magnetico, elettromeccanico, elettroidraulico.
Non sono ammessi servomotori di tipo termico essere esenti da manutenzione, essere completi di staffa per
accoppiamento ai corpi valvola e dispositivo di indicazione di apertura, avere la possibilità di un comando
manuale avere un dispositivo di ritorno (una molla) in mancanza di tensione, che potrà essere in chiusura o
in apertura della valvola secondo la sicurezza che si dovrà garantire.
I servocomandi dovranno avere una forza di azione tale da superare di almeno il 30% la pressione differenziale dell’impianto. Ove necessario vi dovrà essere un contatto di fine corsa.
I servocomandi dovranno essere completi dei necessari dispositivi di montaggio e, quando da impiegare su
valvole funzionanti per alte temperature, dovranno avere una protezione affinché l’alta temperatura non li
danneggi.
SISTEMA DI SUPERVISIONE IMPIANTO MECCANICO
Controllori periferici
I controllori dovranno essere realizzati interamente con sistema modulare. Essi dovranno essere costituiti da
Unità intelligenti a microprocessore (controllori periferici) in grado di gestire le grandezze controllate, sia direttamente attraverso una sezione (preferibilmente separata dall’Unità stessa e ad essa collegata tramite apposito BUS di trasmissione dati) costituita da moduli di funzione a cui risultano collegati i “punti di informazione” prelevati dall’impianto, sia indirettamente attraverso dei regolatori ambiente DDC nel caso di impianti
a terminali (ventilconvettori, cassette VAV-CAV). Il collegamento fra Unità a microprocessore e moduli di
funzione e fra Unità a microprocessore e regolatori DDC dovrà essere effettuato tramite opportuni cavi di
trasmissione dati in modo da ottimizzare la configurazione del sistema semplificando così l’installazione elettrica iniziale e rendendo più’ agevole eventuali ampliamenti futuri. L’accesso al sistema dovrà poter essere
protetto tramite apposite password. Le apparecchiature dovranno essere alimentate in bassa tensione (24
Vca).
Unità a microprocessore
Questa dovrà essere dotata di un sistema operativo adatto per controlli di processo (real time, multi-tasking,
multi-user) avente cioè la possibilità di eseguire in tempo reale più programmi contemporaneamente, e consentire diverse possibilità di accesso e scambio contemporaneo di dati. Su questa dovranno essere inoltre
residenti tutti i programmi applicativi per la gestione dei punti controllati dall’unità stessa in modo da garanti-
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 46
re la completa autonomia del controllore. Ovvero, anche nel caso che esista un sistema gerarchicamente superiore a cui il controllore risulti collegato, quest’ultimo deve garantire un funzionamento non degradato della parte di impianto da esso controllata anche in assenza di tale sistema. A tale scopo tutta la memoria di sistema, programmabile e non, deve risiedere sull’unità stessa ed avere dimensioni adeguate al numero di
punti controllati sia in termini di complessità di programmazione che di elaborazione e storicizzazione dei dati. L’Unità dovrà essere inoltre provvista di un sistema di watchdog interno e di funzioni di diagnostica atte
ad assicurare sia la corretta esecuzione dei programmi in corso che la supervisione della rete di comunicazione. L’Unità a microprocessore dovrà essere inoltre dotata di batteria tampone che consenta, anche in assenza di alimentazione di rete, il mantenimento della data, ora, dei programmi e delle configurazioni in modo
tale che al ritorno dell’alimentazione l’Unità stessa sia in grado di effettuare un restart automatico. Ogni unità
dovrà inoltre essere dotata di un proprio terminale locale, preferibilmente integrato nell’unità stessa ed in
ogni caso stabilmente presente sul quadro elettrico di contenimento del controllore, attraverso il quale
l’Operatore possa essere in grado di accedere a tutte le informazioni ed a tutti i dati relativi ai punti da essa
controllati. Il terminale locale dovrà essere costituito da un display digitale multiriga per la presentazione dei
dati e da una tastiera per la modifica degli stessi. Ogni dato dovrà essere accompagnato da un testo in chiaro che ne consenta la precisa interpretazione senza la necessità di ricorrere a codici di identificazione e tabelle esterne; a tale scopo i testi dei punti/funzione dovranno essere liberamente definibili in modo da poter essere concordati con gli Operatori e/o la Direzione lavori prima della loro implementazione. L’unità a microprocessore dovrà consentire, se richiesto e compatibilmente con la memoria disponibile per l’applicazione
corrente, di:
• essere equipaggiata di interfaccia seriale per il collegamento con altre sottostazioni analoghe (ampliamento del sistema) con gestione autonoma della rete di comunicazione (comunicazione Peer to
Peer);
• essere equipaggiata di interfaccia seriale per il collegamento con una eventuale Postazione Centrale
di supervisione e controllo che fa riferimento alla stessa rete di trasmissione dati di cui al punto precedente con standard di comunicazione di tipo full-duplex su anello SDLC (Synchronous Data Link
Contrai);
• essere equipaggiata di interfacce per il collegamento locale con altri terminali di dialogo (stampante,
modem di comunicazione remota su linea commutata, Personal Computer portatile);
• essere equipaggiata con interfacce per il collegamento ai BUS di trasmissione dati locale dedicati ai
moduli di funzione e/o ad eventuali sistemi di regolazione ambiente per impianti a terminali;
• essere equipaggiata con interfacce per il collegamento seriale con unità a microprocessore di altri
Costruttori; in questo caso dovrà essere noto e documentato il protocollo di trasmissione dell’unità
da interfacciare.
Il trasferimento dei dati con la Postazione Centrale dovrà essere di tipo bidirezionale (trasmissione fullduplex su anello SDLC) e dovrà avvenire con rilevamento delle variazioni di stato dei punti controllati da parte della Unità Centrale o con trasferimento spontaneo dal controllore verso la Postazione stessa (comunicazione orientata agli eventi). La stessa linea di trasmissione consentirà il trasferimento dati fra i singoli controllori e l’accessibilità a tutte le informazioni da essi trattate da un qualsiasi terminale locale di cui ciascuno
di essi dovrà essere dotato. A tale scopo l’Unità dovrà essere in grado di gestire autonomamente tale rete di
comunicazione anche in assenza della Postazione Centrale. La scansione invece dei punti controllati collegati
ai moduli di funzione dovrà avvenire con cicli di interrogazione periodici da parte dell’Unità a microprocessore
inferiori a 0,3 secondi per consentire un immagine in tempo reale del processo controllato. Il collegamento
infine con un eventuale sistema di regolazione ambiente per impianti a terminali dovrà consentire:
• impostazione manuale dei valori prescritti di gruppi o singoli regolatori sia nel funzionamento normale che nel funzionamento a regime ridotto;
• impostazione dei valori di banda proporzionale, tempo di integrazione ed eventuale zona morta di
gruppi o singoli regolatori;
• taratura del programma di compensazione della temperatura ambiente controllata in base alla temperatura esterna;
• assegnazione di un programma temporale di funzionamento regime normale/regime ridotto nell’arco
dell’anno per gruppi o per regolatori singoli;
• letture su display numerico di tutti i valori impostati e del valore istantaneo di tutte le variabili in entrata ed in uscita dei regolatori (temperatura ambiente, segnali agli organi finali) commutazione del
senso d’azione dei regolatori (commutazione Estate/Inverno).
Moduli di funzione
I dati di processo in un sistema DDC devono necessariamente essere convertiti e digitalizzati con l’esatto valore e la corretta dimensione fisica. A questo scopo deve essere prevista una sezione costituita da opportuni
moduli di interfaccia con l’impianto dotati di proprie morsettiere integrate a cui poter collegare direttamente i
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 47
punti di informazione dell’impianto controllato. Sono tecnicamente preferibili soluzioni in cui tale sezione è
fisicamente separata dall’Unità a microprocessore e ad essa collegata tramite un BUS di trasmissione dati, in
quanto, oltre a permettere una ottimizzazione dell’installazione elettrica iniziale, tale soluzione consentirà una
maggiore libertà per eventuali ampliamenti futuri. Sempre per le stesse ragioni è opportuno che tale sezione
possa essere costruita attraverso la libera combinazione di tante unità modulari (moduli di funzione), diverse
a seconda del tipo di punto di controllo da trattare, in grado ciascuna di trattare un numero limitato di punti
(due, quattro) in modo da avere la massima libertà di configurazione del controllore stesso (il numero e tipo
dei moduli necessari a formare un controllore viene determinato in funzione delle grandezze da gestire). Sono cioè da evitarsi soluzioni che prevedano una combinazione fissa di ingressi/uscite del controllore in quanto non sufficientemente adattabili alle diverse tipologie di impianti da controllare. I moduli dovranno presentare una geometria tale da consentire la eventuale sostituzione dell’elettronica in caso di guasto senza per
questo dover richiedere la rimozione del cablaggio elettrico sia del/i punto/i controllato che del BUS di trasmissione; ciò per limitare i tempi di manutenzione ed evitare possibili errori di collegamento in fasi successive al primo avviamento dell’impianto. Tipiche geometrie consigliate sono costituite da elettronica su scheda
ad innesto su morsettiera oppure da elettronica su frutti alloggiati in custodie precablate. Per il riconoscimento del punto controllato ogni modulo dovrà recare una etichetta con riportato il testo in chiaro descrittivo
del punto, specie nel caso in cui i richiesti comandi manuali (selettori e manuali (selettori e potenziometri) e
relative indicazioni luminose dei punti di controllo siano a bordo del modulo stesso. I moduli di funzione (ingresso/uscita) dovranno svolgere le seguenti funzioni base:
Ingressi digitali (segnalazioni di stato)
I moduli relativi dovranno poter accettare segnali provenienti da contatti liberi da potenziale (NA o NC) o da
contatti in tensione. I moduli dovranno essere completi di LED di indicazione; in mancanza di ciò tali indicazioni dovranno comunque essere predisposte sul quadro elettrico di contenimento del/i controllore/i.
Ingressi digitali (totalizzazione)
I moduli dovranno poter accettare segnali ad impulso da contatti liberi da potenziale. Ad ogni impulso corrisponderà una unità della grandezza da conteggiare liberamente predefinibile.
Ingressi analogici (misure)
I moduli dovranno accettare segnali provenienti da trasduttori attivi (0-10V,0-25 o 4-20 mA) o passivi (Ni
1000,Pt 100, Pt 1000 ohm o potenziometrici 0-2500 ohm).
Uscite digitali (comandi)
I moduli dovranno effettuare comandi semplici, doppi o tripli in funzione del tipo di utenza da controllare.
Dovranno essere completi di LED di indicazione dello stato del comando; in mancanza di questi tali indicazioni dovranno comunque essere predisposte sul quadro elettrico di contenimento del/i controllore/i. Tali moduli
dovranno essere completi di selettori per il comando manuale delle utenze. In mancanza di tali dispositivi
dovranno essere previsti, sui quadri elettrici di contenimento del/i controllore/i, dei selettori esterni per il
comando manuale delle utenze ed il sistema dovrà acquisire, sottoforma di ingressi digitali, le posizioni di
ciascun selettore (aut/spento/man).
Uscite analogiche/digitali (posizionamenti)
I moduli relativi dovranno poter effettuare il posizionamento di organi attuatori con comandi di tipo analogico (0/10V,4/20mA) o digitale (a tre punti). Dovranno essere completi di LED di indicazione del segnale di uscita e di potenziometri per il posizionamento manuale dell’organo controllato. In mancanza di questi sia le
indicazioni del segnale di uscita che i potenziometri di posizionamento manuale dovranno essere predisposti
separatamente sul quadro elettrico di contenimento del/i controllore/i; dovranno inoltre essere previsti sempre sul quadro elettrico, dei selettori esterni (aut/man) per abilitare il funzionamento dei potenziometri di posizionamento manuale ed il sistema dovrà acquisire, sottoforma di ingressi digitali, le posizioni di ciascun selettore.
Stazione centralizzata di controllo
Attraverso la postazione centralizzata dovrà essere possibile accedere al sistema e a tutte le sue funzioni in
modo grafico attraverso l’uso di mouse e schemistica interattiva. Si compone di: Workstation grafica per gestione dati e comunicazione, Monitor a colori, Stampanti
Workstation grafica per gestione dati e comunicazione
La Workstation avrà la funzione di gestore del traffico dati e di controllore / gestore della comunicazione e
trasmissione degli stessi. Tale stazione grafica dovrà inoltre svolgere le funzioni di interfaccia utente con accesso a tutte le funzionalità di impianto e dovrà avere capacita di esemplificazione grafica di comandi, funzioni, trend, analisi statistiche e quantaltro richiesto per una gestione user friendly degli impianti.
La Workstation dovrà essere in grado di monitorare e controllare i sottosistemi gestiti, valutando i dati ricevuti e generando, nel caso siano richiesti, i relativi comandi. Dovrà essere in grado di interloquire con la
workstation in modo da rendere disponibili all’utente le informazioni operative e di sistema.
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 48
Nella fattispecie, alla Workstation sono demandate le seguenti funzioni:
• gestione delle funzioni di comunicazione di rete. I sottosistemi gestiti dovranno rispondere ad ogni
sua richiesta ed eseguire i comandi da esso inviati;
• coordinamento del traffico dati con aggiornamento continuo degli stati di funzionamento degli impianti, degli eventi e delle variazioni;
La configurazione hardware della postazione centralizzata sarà costituita dai seguenti componenti:
• Workstation grafica per gestione dati e comunicazione;
• Monitor a colori;
• Stampanti.
Attraverso la postazione centralizzata dovrà essere possibile accedere al sistema e a tutte le sue funzioni in
modo grafico attraverso l’uso di mouse e schemistica interattiva.
Workstation grafica per gestione dati e comunicazione
La Workstation avrà la funzione di gestore del traffico dati e di controllore / gestore della comunicazione e
trasmissione degli stessi. Tale stazione grafica dovrà inoltre svolgere le funzioni di interfaccia utente con accesso a tutte le funzionalità di impianto e dovrà avere capacità di esemplificazione grafica di comandi, funzioni, trend, analisi statistiche e quantaltro richiesto per una gestione user friendly degli impianti.
La Workstation dovrà essere in grado di monitorare e controllare i sottosistemi gestiti, valutando i dati ricevuti e generando, nel caso siano richiesti, i relativi comandi. Dovrà essere in grado di interloquire con la
workstation in modo da rendere disponibili all’utente le informazioni operative e di sistema.
Nella fattispecie, alla Workstation sono demandate le seguenti funzioni:
• gestione delle funzioni di comunicazione di rete. I sottosistemi gestiti dovranno rispondere ad ogni
sua richiesta ed eseguire i comandi da esso inviati;
• coordinamento del traffico dati con aggiornamento continuo degli stati di funzionamento degli impianti, degli eventi e delle variazioni;
• aggiornamento e mantenimento delle configurazioni di funzionamento del processo mediante la trasmissione di immagine istantanea. Tale operatività dovrà essere realizzata in modalità multitasking
ed in real time essendo il server previsto per l’esecuzione contemporanea delle funzioni di BMS.
Mediante l’uso di specifici applicativi e l’adozione di un MMI grafica e di facile uso dovrà essere possibile gestire e configurare le funzioni di BMS secondo i desideri dell’utente; in particolare sono richieste le seguenti
funzionalità:
• Log in, Log out e Chiave elettronica differenziabile per competenza.
• Messaggistica in chiaro.
• Reazioni generate da differenti cause (data, ora, processo, ore funzionamento ecc.).
• Statistica guasti.
• Avviamento strutturato dopo mancanza rete.
• Optimal start/stop (OSTP).
• Funzioni e algoritmi entalpici.
• Controllo punte di carico elettrico.
Tutti i dati reali o calcolati inerenti alla gestione del risparmio energetico (ad es. rendimenti, consumi ecc. )
dovranno poter essere rappresentati sotto forma grafica facilmente intelligibile. La workstation dovrà essere
in grado di storicizzare i dati di impianto nelle memorie di massa; tali dati dovranno essere accessibili per eventuali elaborazioni da altri pacchetti applicativi.
Caratteristiche tecniche
Processore
Pentium 75 o superiore
Memoria RAM
32Mb o superiore
Hard disk
530 Mb o superiore
Floppy disk
1.44 Mb
Comunicazione System bus controller per 2 anelli con comunicazione sincrona SDLC/FSK.
Immagazzinamento messaggi
5.000 entrate
Immagazzinamento statistiche
5.000 entrate
Immagazzinamento data process
100.000 valori
Immagini grafiche
150 immagini con max 60 canali/immagine
Suddivisione dati immagazzinati
Max. su 250 files
II server dovrà essere predisposto per le seguenti opzioni:
• n. 2 interfacce parallele e N. 2 interfacce V.24;
• Unita a disco asportabile per aggiornamenti e back-up in linea;
• CD – ROM;
• N°2 hard disk da 1200 Mb in configurazione Shadow;
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 49
• Drive magneto – ottico.
Dovrà essere possibile predisporre la comunicazione attraverso apposito modem telefonico agente su linea
dedicata. La workstation sarà completa di Video ad alta risoluzione Super Vga, dimensione 20” (Monitor a
colori).
Stampante sistema (protocolli)
Dovrà essere presente una stampante di sistema atta a fornire la registrazione permanente dei dati. Tale
stampante dovrà avere le seguenti caratteristiche:
• connessione seriale
• velocità di stampa 180 cps su 80 colonne alimentazione 220 V / 50 Hz Tale stampante dovrà prevedere
la stampa automatica e/o su richiesta dei seguenti eventi:
• protocollo stato macchine e misure per un’intera sezione di impianto protocollo stato macchine e misure per ogni singolo punto,
• protocollo statistico in arco di tempo determinato (stati, allarmi, variabili ecc.) per ogni singolo punto
o per sezioni di impianto,
• protocollo giornaliero, settimanale o mensile degli apparati da porre in manutenzione protocollo di
informazione su avviamento / fermata ottimizzati,
• protocollo informazione su controllo picchi elettrici di carico,
• protocollo di definizione dei punti e delle relative funzionalità (variabili, azione/reazione, ecc).
Sui tabulati deve essere indicata l’ora e la data.
Stampante Sistema (allarmi)
Dovrà essere presente una stampante di sistema atta a fornire la registrazione permanente degli allarmi in
tempo reale. Tale stampante dovrà avere le seguenti caratteristiche:
• connessione seriale;
• velocità di stampa 180 cps su 80 colonne;
• alimentazione 220 V / 50 Hz.
Tale stampante dovrà prevedere la stampa automatica dei seguenti eventi:
• data completa e numerazione progressiva allarmi su evento con stampa dell’indirizzo punto con stato
e unità di misura;
• su richiesta: protocollo allarmi e loro classificazione.
La programmazione necessaria del server dovrà permettere la gestione tanto dei punti controllati di nuova
fornitura, quanto di quelli già operanti.
Il minimo numero delle pagine grafiche da prevedere, consultatali dalla unità centrale è di 50 pagine.
COLLETTORI
Per il collegamento in parallelo delle apparecchiature e per la distribuzione dei fluidi ai vari servizi, verranno
installati nelle posizioni di progetto collettori di opportuno diametro, completi di attacchi flangiati, con flangia
uguale a quella dell’organo di intercettazione della diramazione relativa.
Ubicazione
I collettori verranno installati ad una altezza tale da consentire l’agevole manovra degli organi
d’intercettazione e regolazione, saranno collocati in opera su mensole di sostegno in profilato di acciaio.
Collettori in tubo di acciaio nero
Saranno in tubo di acciaio nero, conformemente alle tubazioni che da essi vi dipartano, i collettori di distribuzione e di raccolta acqua calda, refrigerata, di raffreddamento, reintegro, sfiato, vapore e condensa.
I collettori avranno forma cilindrica, fondi bombati ed attacchi per le diramazioni di tipo flangiato forate UNI.
La sezione trasversale di ciascun collettore sarà tale da garantire una velocità dell’acqua non superiore a 0,50,6 m/sec alla massima portata di progetto.
L’interasse fra i vari attacchi sarà tale che tra due flange consecutive esista una spaziatura di almeno 50 mm.
e comunque adeguata agli organi di comando delle intercettazioni: volantini o leve devono poter essere agevolmente comandati.
Per ogni collettore verranno previsti un numero adeguato di attacchi di riserva ciascuno completo di valvole
di sezionamento o di flangia cieca di chiusura conformemente agli schemi di progetto.
Tutte le tubazioni che fanno capo ai collettori saranno munite di valvole e di targhette indicatrici con indicazioni del fluido, circuito, senso di circolazione, eventuali note.
Tutte le tubazioni che fanno capo al collettore distributore saranno dotate di termometro a colonnetta a cari-
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 50
ca di mercurio o e quadrante secondo quanto richiesto. Saranno inoltre montati su ciascun collettore un manometro, ed un rubinetto di scarico.
Di norma sul collettore ricevitore, quindi sul lato di aspirazione delle pompe, verrà inserito l’attacco per la linea di reintegro e riempimento. A tale scopo ciascun collettore sarà provvisto, secondo le necessità, di opportuni attacchi a manicotto saldati.
I collettori per i quali non sia richiesta la zincatura saranno protetti con verniciatura conformemente alle specifiche allegate.
L’isolamento termico sarà del tipo e dello spessore conforme a quanto utilizzato per le altre tubazioni delle
reti facenti capo al collettore medesimo. La finitura esterna verrà eseguita con lamierino di alluminio.
Collettori in tubo di acciaio zincato
I collettori per la distribuzione dell’acqua fredda, dell’aria compressa, e quanti altri richiesti, saranno zincati a
bagno a lavorazione ultimata.
I collettori, se necessario, saranno rivestiti con un adeguato spessore di materiale coibente atto ad evitare
fenomeni di condensa superficiale, con finitura c.s.
Collettori in rame
I collettori in rame saranno impiegati secondo le indicazioni di progetto per la raccolta e la distribuzione
dell’acqua calda e refrigerata a radiatori, a fan-coils nonché per la raccolta e la distribuzione dell’acqua calda
sanitaria nei servizi igienici.
I collettori saranno provvisti di attacchi filettati e saranno installati in apposite cassette di contenimento da
incasso a parete.
Tubazioni di scarico in PEHD
Le tubazioni di scarico delle acque bianche e nere a partire dai sifoni degli apparecchi fino ai punti di allacciamento alla rete fognante esterna, e comunque secondo le indicazioni del progetto esecutivo, dovranno
essere realizzate in tubo di polietilene ad alta densità fabbricato per estrusione, delle seguenti caratteristiche :
densità : 0,95 g/cmc
campo di applicazione : -40 ‘C ./. +100 ‘C
coefficiente di dilatazione : 0,2 mm./mt. ‘C
pezzi speciali realizzati per inietto fusione dello stesso materiale delle tubazioni e lavorati con apposite attrezzature sia per saldatura testa a testa con termoelemento sia con manicotto elettrico.
Montaggio
Colonne di scarico: posate con manicotto di dilatazione ad ogni piano.
Collettori di scarico: per tratti inferiori a mt. 6 montaggio con punti fissi; per tratti superiori montaggio con
manicotto lungo di dilatazione adatto per installazione orizzontale.
Giunzioni tra tubazioni orizzontali eseguite a mezzo di:
• saldatura,
• manicotti per saldatura elettrica,
• manicotti lunghi di dilatazione.
È vietato l’uso di manicotti d’innesto con guarnizione che possono essere usati solo per giunzioni verticali.
Ispezioni
Deve intendersi compreso nel prezzo delle tubazioni di scarico quota parte dovuta all’onere per fornitura e
posa di ispezioni alle linee di scarico.
Ove previsto dagli schemi di progetto, ed in ogni caso di percorso suborizzontale di sviluppo superiore a 2 m
dovranno essere previste ispezioni per manutenzione delle linee di scarico, ad interasse adeguato, secondo
le situazioni di installazione, alle operazioni di intervento. I pozzetti per ispezioni in controsoffitto saranno costituiti, alla base della montante, da braca con tappo di chiusura apribile; lungo il percorso suborizzontale da
apposito pezzo speciale con tappo superiore di chiusura. Il pozzetto di ispezione per scarichi a terra sarà realizzato in polietilene ad alta densità, di spessore non inferiore a 5 mm, di forma cilindrica, con diametro di
almeno 40 cm. Sarà provvisto di:
• fondo saldato, pure in polietilene;
• n. 4 attacchi radiali, da 110 oppure da 125 (secondo quanto necessario) posti in prossimità del fondo;
• coperchio pure in polietilene di elevato spessore, resistente ai carichi accidentali, oppure in ghisa. Il
coperchio dovrà essere a perfetta tenuta.
L’altezza del pozzetto dovrà essere tale da sporgere leggermente dal terreno; gli attacchi non utilizzati do__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 51
vranno essere chiusi con fondelli in polietilene saldati.
Vasi di espansione
I vasi di espansione saranno generalmente di tipo pressurizzato, qualora particolari esigenze lo giustifichino,
potranno essere costruiti ed installati vasi aperti.
Tutti i vasi pressurizzati risulteranno conformi alle Specificazioni tecniche del titolo II del D.M. 1.12.1975, ed
alla circ. n. 32875 del 20.08.76 della A.N.C.C.
Vasi di espansione chiusi
Il vaso di espansione chiuso sarà installato in centrale termica in prossimità delle caldaie, a monte delle
pompe di circolazione.
La tubazione di collegamento del vaso all’impianto sarà possibilmente ad andamento verticale; gli eventuali
tratti orizzontali avranno pendenza almeno del 2% in modo che non si creino sacche di aria. Tale tubazione
non avrà alcun organo di intercettazione, o sarà dotata di rubinetto a tre vie ISPESL.
Per lunghezze orizzontali superiori a 2 metri di diametro, in detto tratto, sarà opportunamente maggiorato.
Vasi di espansione a membrana
Ciascun impianto di espansione del tipo a membrana, sarà con precarica di azoto e costruito in lamiera di acciaio ordinario di spessore adeguato alla pressione di bollo, secondo quanto richiesto dalle vigenti norme.
Per i vasi da 4 a 24 litri, che per le loro caratteristiche costruttive non sono soggetti al collaudo individuale
ISPESL, tuttavia ci si uniformerà al detto della raccolta R ( R.3.C 3.7, 3.8, 3,9).
La membrana potrà essere in gomma naturale o sintetica e le semicalotte, per pressioni di bollo inferiori a 5
Ate potranno essere assemblate meccanicamente mediante aggraffatura. Per pressioni di bollo di 6 Ate e superiori le due semicalotte saranno saldate.
Tutti i vasi anche quelli esenti da collaudo ISPESL, saranno muniti di targa comprovante l’avvenuta prova idraulica.
Gruppi di riempimento automatico
Ciascun impianto di espansione sarà provvisto di un’apparecchiatura di riempimento e reintegro acqua costituita da una valvola automatica atta a ridurre la pressione del fluido operante alla pressione di alimentazione
dell’impianto.
Ciascuna valvola sarà essenzialmente costituita dai seguenti elementi:
• corpo, coperchio e dado in ottone forgiato,
• otturatore in ottone lavorato OT58,
• molle per riduzione a ritegno in acciaio inox 18/8,
• membrana per riduzione guarnizioni,
• manometro con scala espressa in Kg/cmq (fondo scala 6Kg/cmq),
• filtro in bronzo sinterizzato,
• attacchi a manicotto
Sarà sempre possibile operare in campo la taratura della valvola su pressioni di funzionamento diverse da
quelle prefissate in stabilimento.
Vasi di sicurezza di tipo senza membrana per impianti ad acqua calda a temp. < 100°C
Ove previsto dal progetto si adotteranno vasi di tipo basato su serbatoio in fasciame di acciaio di costruzione
conforme ISPESL per pressioni di utilizzo compatibili con quelle dei dispositivi di sicurezza dell’impianto.
Lo spessore minimo, al netto del sovraspessore di corrosione, sarà di 3 mm per il mantello e di 4 mm per i
fondi. Le saldature longitudinali e circonferenziali, per quanto possibile, non intersecheranno le saldature delle connessioni e di quanto altro saldato al recipiente.
Il mantello sarà ottenuto da un unica virola ottenuta da lamiera di acciaio calandrata e saldata longitudinalmente di testa a piena penetrazione, con ripresa a rovescio (ove possibile).
I fondi, ricavati da lamiera di acciaio FÉ 410 - 1 KW UNI 5869-75 mediante stampaggio, saranno bombati
con profilo semisferico.
I fondi avranno colletto cilindrico di altezza non inferiore a 0,015 DE + S (dove DE è il
diametro esterno della virola ed S lo spessore della lamiera) e comunque non inferiore a 25 mm e
non superiore a 100 mm.
Ciascun serbatoio sarà provvisto delle seguenti connessioni:
• attacchi elettrosaldati per entrata/uscita acqua;
• attacco a manicotto per il collegamento al tubo di scarico di fondo;
• attacchi per pressostato, livellostati, valvola di sicurezza;
• attacchi a manicotto per carico/scarico aria compressa;
• attacchi a manicotto per manometro, indicatore visivo di livello.Apparecchiature di controllo e sicu__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 52
rezza.
Le apparecchiature di controllo e sicurezza comprenderanno:
• livello stato di allarme alto/basso livello e comando elettrovalvola di carico;
• presso stato di comando aria e di blocco, a riarmo manuale;
• elettrovalvola di carico impianto;
• elettrovalvole di sfiato e carico aria compressa;
• manometro a quadrante con sifoncino e rubinetto di prova;
• indicatore di livello in vetro in più pezzi, completo di rubinetti di prova e paralivello;
• valvole/a di sicurezza regolamentare;
• rubinetto di scarico di fondo.
Il cuscinetto pressurizzante sarà realizzato mediante aria compressa prodotta da apposita stazione di produzione.
Dispositivi di sicurezza
L’impianto con vaso di espansione chiuso sarà munito di valvole di sicurezza ad alzata con molla non a contatto con acqua, a taratura fissa.
L’otturatore della valvola sarà servoazionato da un diaframma di grande sezione; la guarnizione sarà del tipo
soffice per garantire, oltre la perfetta tenuta, il sicuro intervento alla pressione prefissata anche dopo lunghi
periodi di inattività.
La valvola potrà anche essere comandata manualmente senza l’uso di attrezzi e sarà dotata di dispositivo
rompivuoto.
Lo scarico dell’acqua della valvola di sicurezza sarà a vista; con protezione per gli operatori. L’acqua affluirà
ad appositi pozzetti e quindi verrà convogliata nella fognatura.
L’impianto con vaso di espansione chiuso sarà munito di un pressostato che possa interrompere il flusso del
combustibile al bruciatore in caso di sovrapressione.
Il collegamento, se elettrico, sarà in serie al termostato di sicurezza della caldaia. E
Vasi di espansione di tipo aperto
Gli impianti con vaso di espansione aperto saranno sempre dotati di tubazioni di sicurezza, le cui estremità
inferiori saranno collegate direttamente alla parte superiore delle caldaie; la estremità superiore sarà prolungata al di sopra del livello massimo dell’acqua nel vaso di espansione.
Lo sfogo sarà realizzato in modo da risultare assolutamente non ostruibile.
L’impianto idrico di alimentazione del vaso sarà di portata sufficiente a rifornire di acqua la caldaia di un
quantitativo almeno pari a quello del vapore che la caldaia è capace di produrre.
Lungo la tubazione di sicurezza non saranno mai inseriti organi di intercettazione, e le tubazioni non presenteranno diminuizioni di sezione né contropendenze.
Il diametro interno minimo della tubazione del circuito di sicurezza non sarà inferiore ai valori risultanti dalla
tabella del decreto ministeriale 1.12.1975.
Setti tagliafiamma
Gli attraversamenti e le pareti con resistenza al fuoco REI predeterminata e gli attraversamenti di solai dovranno essere isolati con setti di materiale in classe 1 atti ad impedire la propagazione della fiamma e del
fumo (provvisti di certificazione del MINISTERO DELL’INTERNO e/o laboratorio riconosciuto), da entrambi i
lati nel caso di pareti o da un solo lato (inferiore) nel caso di solai, secondo le caratteristiche dettagliate a
seguire:
Attraversamento con tubazioni
Uso di manicotto tagliafiamma costituito da due calotte metalliche che si chiudono attorno al tubo, all’interno
delle quali viene posto un riempimento che espandendosi forma una massa sigillante.
Attraversamento con canalette Nel punto di separazione saranno posti:
• inserti piatti, fissati con viti ed atti ad eliminare le irregolarità della parete;
• flangia di fissaggio per permetterà la stabilità delle resine intumescenti;
• riempimento con spugne e resine intumescenti.
Particolare cura sarà osservata nell’attraversamento delle pareti dei locali tecnologici, dei cavedi e dei vani
scale, oltre agli ingressi dalle linee provenienti dall’esterno dei fabbricati.
DATI E DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE A SEGUITO DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE IL PROGETTO
ESECUTIVO DI CANTIERE E DELLA DOCUMENTAZIONE DI FINE LAVORI:
• certificati del ministero dell’interno inerenti la resistenza al fuoco;
• schemi planimetrici con indicata la posizione dei setti tagliafiamma e tipici di realizzazione;
• manuale di installazione e manutenzione.
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 53
CENTRALI DI TRATTAMENTO ARIA
Generalità
Le centrali di trattamento di norma saranno del tipo a sezioni componibili, predisposte per l’installazione
all’interno o all’esterno e saranno composte secondo le indicazioni di progetto. In ogni caso il tipo, la composizione, la portata dell’aria, la potenzialità termica e frigorifera delle singole centrali saranno riportate negli
schemi allegati.
Progetto meccanico
Le centrali di trattamento saranno progettate in conformità alle normative vigenti; in particolare saranno costruite per una perfetta tenuta sia nelle sezioni a pressione statica positiva che a pressione statica negativa:
non risulteranno perdite o infiltrazioni superiori al 5% della portata totale nella sezione di centrale considerata. Il progetto terrà conto che la centrale non dovrà subire deformazioni permanenti con sovraccarico di 70
Kg/mq uniformemente distribuito.
Involucro
L’involucro di ciascuna sezione, costruito in maniera da poter essere facilmente accoppiato alle altre sezioni,
sarà in grado di contenere agevolmente le apparecchiature di detta sezione in modo che ne risulti facile la
manutenzione ordinaria e straordinaria.
L’involucro sarà, se non diversamente specificato, costituito da doppia pannellatura di lamiera di acciaio zincata dello spessore minimo interno di 10/10 mm, esterno 6/10 plastificato, unificata Sendzimir, nella quale
sarà interposto uno strato di lana di roccia dello spessore minimo di 48 mm.
Le varie sezioni termineranno con un profilato atto a permettere l’accoppiamento sia con bulloni che con profilati scorrevoli; la perfetta tenuta sarà assicurata mediante guarnizioni in gomma o neoprene.
I pannelli anteriori delle sezioni ventilanti, di umidificazione, filtri e batterie saranno completamente asportabili in modo da consentire lo sfilaggio delle apparecchiature in esse contenute.
I pannelli della sezione ventilante, filtrante e di umidificazione saranno completi di portelli a tenuta ermetica
(che permettano l’ingresso del personale all’interno della centrale) e pannelli di chiusura.
Le vasche di raccolta, previste sotto le batterie di raffreddamento e la sezione di umidificazione, saranno in
acciaio inox complete di attacchi per il reintegro, lo scarico di fondo e lo scarico di troppo pieno.
Serrande
Le serrande sia di taratura che di regolazione saranno del tipo ad alette multiple a rotazione contraria; le alette realizzate con profilatura alare, saranno contenute in un involucro ad “U” in lamiera di acciaio zincata
dello spessore minimo di 1,2 mm.
Gli assi di rotazione saranno alloggiati in bussole di bronzo o di nylon; i levismi che collegano le alette della
serranda saranno provvisti di dispositivi che ne permettano con attrito ridotto l’azionamento manuale o mediante servocomando.
Camere di miscela
La camera di miscela sarà costituita da un cassone con due serrande per miscelare aria di ricircolo e aria esterna.
Le due serrande saranno della stessa dimensione per la massima portata.
Le pale delle serrande saranno costruite in doppia lamiera zincata per evitare torsioni ed avranno movimento
parallelo.
Lo spessore della lamiera impiegata per l’esecuzione delle alette sarà di 0,8-1,2 mm in relazione alla lunghezza delle alette stesse.
I cuscinetti saranno in fibra di vetro con rinforzo in nylon o in ottone.
Le serrande saranno taratali separatamente, per permettere di preselezionare i rapporti di miscela.
Le serrande saranno collegate esternamente tra loro e la loro posizione risulterà indicata esternamente.
Filtri
Nella sezione filtri potranno essere installati i seguenti tipi di filtro: Filtri a celle piane o pieghettate
I filtri, del tipo a celle piane o pieghettate, saranno costituiti da un telaio di acciaio zincato dello spessore di
0,8 mm, completo di guarnizioni per la tenuta d’aria, doppia rete elettrosaldata e zincata con maglia di 12 x
12 mm. e di un setto filtrante rigenerabile composto di fibre sintetiche legate con apposite resine perfettamente calibrate ed espanse nelle tre dimensioni in modo da evitare zone di passaggio preferenziale ed assicurare la massima compattezza, alta resistenza meccanica ed elevata elasticità.
II setto filtrante sintetico risulterà altresì insensibile agli agenti atmosferici ed alla maggior parte dei compo-
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 54
sti organici; in alternativa potrà essere adottato materiale filtrante in filo di acciaio zincato piatto.
I dati tecnici di progettazione sono i seguenti:
• massima temperatura di esercizio 60°C;
• massima umidità relativa % 60;
• efficienza di filtrazione secondo ASHRAE STANDARD 52-76 % 85;
• perdita carico iniziale Pa 50.;
• perdita carico finale Pa 150
I filtri saranno alloggiati in guide in lamiera di acciaio zincata e disposti normalmente al flusso dell’aria o a V
in una sezione dotata di portello di ispezione.
Filtri a tasche
I filtri a tasche saranno costituiti da una serie di elementi filtranti a forma di tasca ciascuno fissato ad un telaio di lamiera di acciaio zincata.
Ciascuna tasca sarà costituita da un unico foglio di materiale filtrante in fibra di vetro flessibile, resiliente, di
tipo poroso con elevate dosi di resistenza, di stabilità ed uniformità dimensionale, chimicamente inerte, non
igroscopico, non infiammabile, di massima resistenza agli agenti atmosferici ed all’umidità; il materiale filtrante ripiegato nella parte posteriore e sigillato lungo i bordi, avrà una forma aerodinamica tale da garantire
la configurazione iniziale.
I dati tecnici di progettazione saranno i seguenti:
• massima temperatura di esercizio 60°C;
• massima umidità relativa % 90;
• efficienza di filtrazione secondo ASHRAE 52-68 colorimetrico % 95;
• massima velocità frontale dell’aria m/sec 1,3;
• perdita carico iniziale Pa 70;
• perdita carico finale Pa 200.
Gli elementi filtranti saranno sistemati in telai di lamiera di acciaio zincata che ne permattano la facile estrazione per la manutenzione, completi di guarnizione di tenuta d’aria.
Filtri assoluti
I filtri assoluti saranno costituiti da un elemento filtrante costituito da un unico materiale filtrante in fibra di
vetro flessibile, resiliente, di tipo poroso con elevate dosi di resistenza, di stabilità ed uniformità dimensionale, chimicamente inerte, non igroscopico, non infiammabile, di massima resistenza agli agenti atmosferici ed
all’umidità.
I dati tecnici di progettazione saranno i seguenti:
• massima temperatura di esercizio 60°C;
• massima umidità relativa % 90;
• efficienza di filtrazione a fiamma di sodio % 99,99;
• massima velocità frontale dell’aria m/sec 1,3.
Gli elementi filtranti saranno sistemati in telai di lamiera di acciaio zincata che ne permettano la facile estrazione per la manutenzione, completi di guarnizione di tenuta d’aria.
Batterie di scambio termico
Le batterie di scambio termico saranno costituite essenzialmente da tubi di rame disposti perpendicolarmente al moto dell’aria, opportunamente alettati con alettatura di alluminio di tipo a pacco; il pacco alettato sarà
contenuto in un involucro di acciaio zincato di forte spessore che permetterà il libero scorrimento dei tubi
dovuto alle dilatazioni termiche.
Passo alette 2,5 mm se non diversamente specificato.
La disposizione dei tubi sarà tale da prevedere il non allineamento dei tubi stessi in due ranghi successivi (disposizione romboidale o quadrangolare), i circuiti saranno realizzati collegando fra loro i vari tubi mediante
curvette saldate o ricavate direttamente per piegatura.
Le alette possono essere di tipo continuo per tutto il fascio tubiero o di tipo discontinuo ( una aletta per ciascuno rango ) con superficie corrugata in maniera da assicurare il massimo della turbolenza dell’aria; le alettature saranno dotate altresì di collare trafilato per il fissaggio meccanico al tubo e l’autodistanziamento a
2,5 mm. I materiali di cui sono costituite le batterie saranno rispondenti alle seguenti norme:
diametro
spessore
tubi di rame 16 mm.
0,5
alette in alluminio
mm. 0.3
Le batterie alimentate ad acqua (sia calda che refrigerata) saranno complete di collettori di entrata e di uscita. Tali collettori, per qualsiasi numero di ranghi, si troveranno dallo stesso lato della batteria e saranno costruiti in tubo di acciaio trattato con vernice anticorrosiva e completi di attacchi filettati gas, spurghi filettati
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 55
per lo sfogo dell’aria e lo svuotamento della batteria. Le batterie saranno collaudate a 12 Ate con aria compressa immerse in acqua.
La velocità dell’acqua nei tubi non supererà 1,5 m/sec, mentre la velocità dell’aria sarà tale da non trovare
trascinamento di gocce per le batterie alimentate con acqua refrigerata e comunque inferiore a 3,5 m/sec
per le batterie alimentate ad acqua calda.
All’altezza dei collettori delle batterie alimentate con acqua refrigerata sarà prevista una bacinella inox di raccolta dell’eventuale condensa proveniente dalle tubazioni di alimentazione.
Umidificatore con vapore di rete
Sarà costituito da un distributore di vapore in acciaio inox, di tipo ad intercapedine, per produzione di vapore
secco, corredato da un gruppo separatore di condensa, una valvola di regolazione del flusso di vapore completa di servomotore, uno scaricatore di condensa di tipo adatto (secondo le indicazioni del costruttore
dell’umidificatore), con filtro (eventualmente incorporato) e indicatore di passaggio. Dimensionamento della
rampa adeguato alla sezione di inserimento in modo da garantire omogenea distribuzione.
Separatore di gocce
A valle della sezione di umidificazione, se necessario, verrà installato un separatore di gocce inox.
Il separatore sarà del tipo completamente smontabile e costituito da lamelle ad almeno 3 pieghe fissate a
pressione sul telaio di contenimento; la parte inferiore del separatore scaricherà l’acqua direttamente nella
vasca di raccolta, anch’essa in lamiera inox.
Ventilatori
I ventilatori saranno del tipo centrifugo a doppia aspirazione, accoppiati mediante cinghie trapezoidali al motore elettrico di azionamento.
Ciascun ventilatore sarà costituito da coclea in robusta lamiera d’acciaio rinforzata da opportuni angolari, con
girante a pale multiple staticamente e dinamicamente equilibrata calettata su albero in acciaio rettificato di
un sol pezzo; le pale potranno essere del tipo curvato in avanti o rovesce con profilo piano o alare, secondo
le condizioni d’uso e nel rispetto di valori del rendimento e del livello di pressione sonora prodotto, da contenere sempre il più’ possibile e sempre entro i limiti di progetto.
Gli alberi saranno dimensionati e costruiti in moda tale da non attraversare le loro prime velocità critiche
mentre i ventilatori si avvicinano alle rispettive velocità di regime.
Le bocche di mandata dei ventilatori saranno collegate all’involucro della sezione mediante un giunto flessibile di fibra di vetro ricoperto di PVC.
I ventilatori saranno selezionati in una zona della curva caratteristica prescelta nella quale per differenze di
pressione dell’ordine del 40% la differenza di portata non superi il 20%.
Salvo diversa indicazione nella scelta dei ventilatori saranno rispettati i seguenti valori limite:
Tipo a pale rovesce
Tipo a pale in avanti
Livello di pressione
> 600 Pa
< 600 Pa
Rendimento minimo
75%
65%
Motori
I motori saranno a 4 poli del tipo protetto con raffreddamento esterno, adatti per avviamento in corto circuito sino ad una potenza di 7,5 kW e con avviamento stella-triangolo per potenze superiori.
Motore e ventilatore saranno assemblati su unico basamento completo di slitta tendicinghia e di supporti antivibranti a molla o in gomma in grado comunque di assicurare un isolamento minimo del 90% a tutte le frequenze.
I motori saranno dimensionati per una potenza maggiore del 25% rispetto alla potenza assorbita all’asse del
ventilatore alla temperatura ed alla portata di esercizio.
Trasmissioni
La trasmissione consisterà in pulegge e cinghie; le cinghie del tipo trapezoidale, saranno dimensionate per
trasmettere una potenza pari ad 1,5 volte quella installata e si avrà un minimo di due cinghie per motori di
potenza superiore ad 1 kW. Per agevolare la regolazione della trasmissione saranno previste pulegge a diametro variabile per motori di potenza inferiore ad 1 kW.
I dati tecnici di progettazione faranno riferimento alle seguenti norme:
Pulegge:
diametro ISO/R 450
bilanciamento
ISO/R 254
Cinghie: costruzione
ISO/R 460
Trasmis.: dimensionamento
DIN 7753, sez.l
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 56
Rumorosità
Un livello di pressione sonora misurato sugli assi geometrici del ventilatore ad una distanza di 1,5 m. e nelle
condizioni di rendimento prefissate, non risulterà superiore ai 70 db normalizzati con strumenti di misura
conformi alle norme IEC n.123, 179, 225.
Nel caso le centrali fossero poste all’interno degli ambienti condizionati il livello di pressione sonora, misurato
nelle stesse condizioni e con gli stessi strumenti sopra ricordati, non dovrà risultare superiore a 65 dBA.
Modalità di installazione
Per carico e trasporto devono essere accuratamente seguite le istruzioni del costruttore utilizzando in maniera corretta golfari e asole predisposte.
L’appoggio dell’unità dovrà avvenire su basi livellate ed in piano tramite l’interposizione di mattoncini antivibranti appositamente dimensionati o supporti a molla. Se non diversamente prescritto dal costruttore
l’interasse massimo ammesso per gli appoggi è di 1,5 m. È vietato il fissaggio diretto dell’unità alla base, dovranno essere previsti fermi perimetrali con interposizione di gomma per evitare spostamenti dell’unità.
L’assemblamento delle sezioni dovrà essere eseguito con montaggio delle guarnizioni e delle stuccature necessarie alla perfetta tenuta. Nel collegamento delle tubazioni agli attacchi delle batterie dovrà essere applicata una coppia contraria a quella di serraggio per evitare il danneggiamento dei collettori delle batterie medesime.
L’altezza del sifone dello scarico condensa dovrà superare di almeno 20 min la pressione massima statica
all’interno dell’unità.
L’allacciamento dei canali alle unità di trattamento potrà avvenire esclusivamente a mezzo di giunti antivibranti in tela olona di larghezza minima di 140 mm. In caso di installazioni critiche dal punto di vista acustico
deve essere prevista la fasciatura del giunto mediante bilamina PU/Pb/PU.
IMPIANTO GAS MEDICALI
Reti di distribuzione: gruppo di riduzione 2 ° stadio
II gruppo di riduzione sarà costituito da:
• 1 riduttore di pressione a membrana in ottone,
• valvola di sicurezza,
• capocorda per la messa a terra,
• manometro cromato scala 0-10 bar, per la lettura della pressione nella tubazione secondaria (dal riduttore di secondo stadio alle prese),
• valvola filtro installata a monte del riduttore che deve consentire l’esclusione del gruppo dalla rete
primaria, e fungere da filtro per la rete secondaria,
• fondello a muro in allumino predisposto per il contenimento del riduttore,
• pannello di copertura in plexiglas, riportante la dicitura del gas.
La pressione in uscita sarà regolabile a mezzo di apposita chiave fino ad un massimo di 5 bar, la porta max
del riduttore sarà di 18 mc/h ad una pressione di 3 bar
Valvole di intercettazione e sezionamento Le valvole saranno costituite da:
• valvola a sfera a chiusura rapida o del tipo a membrana con volantino,
• raccordi a tre pezzi in ottone per l’installazione della valvola,
• fondello a muro in lamiera verniciata predisposto per il contenimento della valvola,
• pannello di copertura in plexiglas con indicata la dicitura del gas in transito.
Prese di utilizzo
Tutte le prese rapide da installarsi dovranno essere di tipo unificato, provviste di dispositivo automatico antiritorno, atto a permettere l’immediato arresto del flusso del gas all’atto del disinserimento degli apparecchi di
utilizzazione. Le prese dovranno essere complete di dispositivo atto al filtraggio dei gas, ogni presa deve essere in grado di erogare almeno 30 N L/min deve portare ben visibile il nome del gas, ed essere realizzata in
modo da evitare il rischio di intercambiabilità tra i diversi gas, secondo i criteri stabiliti dalle norme internazionali di unificazione.
Le prese da prevedersi potranno essere dei seguenti tipi:
• prese rapide in bocchette a muro, da incasso, con portello in acciaio inox, sia le bocchette che i portelli dovranno interamente essere realizzati in acciaio inossidabile satinato.
• prese rapide in bocchette a muro da incasso con placca a filo parete e presa in vista, cui si possano
collegare gli apparecchi utilizzatoli senza aprire il portello. Il tutto sarà in ottone cromato.
L’utilizzo di bocchette a muro e di portelli o placche costruiti con materiali diversi dall’inox (ottone cromato,
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 57
alluminio, plastica od altro) dovrà essere espressamente autorizzato dalla D.L.
Le prese dovranno essere dotate di targhetta circolare del colore distintivo del gas, da fissarsi in modo inamovibile al pannello, e riportante la dicitura del gas stesso.
Tubazioni e raccorderia
Tutte le tubazioni dovranno essere realizzate in tubo di rame, e dovranno venire garantiti contro ogni difetto
di trafila o porosità. Le tubazioni dovranno essere esenti da polvere, grassi e materiali estranei.
Le giunzioni dovranno essere effettuate mediante adatta raccorderia in rame, con saldobrasatura eseguita
per capillarità con materiale d’apporto in lega d’argento, effettuata a perfetta regola d’arte.
Le tubazioni in rame, secondo le prescrizioni UNI, devono avere pareti lisce e disossidate, ed essere preventivamente controllate con prova pneumatica a valori di pressione proporzionali ai diametri, fino ad un valore
di 50 kg/cmq per il tubo più piccolo.
Lo staffaggio, per le tubazioni non incassate, avverrà tramite particolari staffe costituite da un profilato in
ferro zincato atto a ricevere idonei morsetti di plastica per il bloccaggio delle tubazioni.
Quadro multiplo
Ove occorrente saranno previsti dei quadri di contenimento apparecchiature multiple, come riduttori e/o valvole. Il quadro sarà completo c.s.
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 58
IMPIANTI ELETTRICI
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 59
GENERALITA’
Salvo preventive prescrizioni del Committente, la Ditta ha facoltà di svolgere l’esecuzione dei lavori nel modo
che riterrà opportuno per darli nel termine contrattuale. Per quanto riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna al collaudo, si fa riferimento alle disposizioni dettate a riguardo dal Capitolato generale.
Per quanto riguarda la condotta e svolgimento dei lavori l’Appaltatore ha obbligo di affidare la direzione tecnica del cantiere, agli effetti delle leggi e regolamenti vigenti, a persona di provata esperienza nel campo elettrico e avente i requisiti previsti dalla legge 46/90 ed assicurare la presenza sul luogo dei lavori di un assistente dei lavori, adibito esclusivamente a mansioni tecnico-amministrative e di sorveglianza, al fine di redigere i documenti contabili necessari alla conduzione del cantiere e alla misurazione delle partite dei lavori.
L’Appaltatore deve eseguire le verniciature di protezione con due mani di antiruggine a pennello di tutte le
parti ferrose, tubazioni, staffe, mensole, ecc.
L’Appaltatore deve inoltre identificare con targhette o fascette o altri mezzi le varie tubazioni, apparecchiature, circuiti, ecc, con numeri o diciture corrispondenti poi agli schemi.
Tutte le parti di impianto che presentano per la loro stessa natura pericolo per gli addetti alla manutenzione,
devono essere dotate di cartelli monitori, a norme ISPESL, disposti in punti ben visibili, solidamente fissati e
con diciture indelebili.
In particolare devono essere indicati con opportuni cartelli: le passerelle ed i condotti dei cavi con
l’indicazione del valore di tensione; i quadri elettrici in tensione con l’indicazione del valore di tensione; le
porte di accesso dei cavedi contenenti montanti elettrici.
PRESCRIZIONI
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali
e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere in appalto, dovranno provenire da
quelle località che la Ditta Appaltatrice riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, rispondano tutti alle caratteristiche e prestazioni di seguito indicate.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza al presente Disciplinare Tecnico dovrà risultare da un attestato
di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
Per materiali di particolare produzione e di previsto impiego per i quali il presente Disciplinare Tecnico non
fornisce specifici riferimenti di accettazione in merito alla loro qualità, alla loro tecnologia ed alla loro provenienza, si rimanda a quanto descritto e/o fissato nelle voci dei corrispondenti prezzi unitari di elenco ed anche alle indicazioni specifiche tecniche vigenti in materia. In ogni caso tutti i materiali forniti, con particolare
riguardo a quelli relativi ad esecuzioni speciali e/o a tutte le finiture interne, dovranno essere preventivamente sottoposti all’esame del Direttore dei Lavori ed alla sua accettazione.
MATERIALI IMPIANTISTICI
Tutti i materiali e le apparecchiature, dovranno essere scelti in modo tale che risultino adatti all’ambiente,
alle caratteristiche elettriche (tensione, corrente, ecc.) ed alle condizioni di funzionamento previste. Essi dovranno inoltre resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche e quelle dovute all’umidità, alle quali possono essere soggetti durante il trasporto, il magazzinaggio, l’installazione e l’esercizio.
Tutti i materiali e gli apparecchi saranno costruiti in conformità con le norme e la documentazione di riferimento, in particolare dovranno rispondere ai requisiti imposti dalla legge 626/96 ed al D.L. 277/97. In particolare dovranno essere in possesso della marcatura CE.
I materiali di consumo e gli accessori di montaggio, anche se non esplicitamente specificati, sono parte integrante della fornitura.
L’approvazione delle marche utilizzate dovrà essere autorizzata per iscritto dalla direzione dei lavori secondo
la scheda riportati in allegato 1. Alcune configurazioni d’ingombro ed i disegni del progetto esecutivo in genere sono stati valutati tenendo conto delle stesse; nell’ipotesi che vengano indicati più produttori dello stesso componente od apparecchiatura, le dimensioni riportate potranno variare in funzione della scelta effettuata tra i costruttori indicati. I materiali si devono intendere originali della casa costruttrice.
VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI
Tutte le forniture oggetto delle presenti specifiche potranno essere soggetti a verifiche, collaudi e prove in
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 60
corso d’opera e finali allo scopo di verificare:
a. la corrispondenza delle forniture agli impegni contrattuali;
b. la corretta esecuzione nel rispetto delle prescrizioni e, in mancanza di queste, secondo le regole
dell’arte;
c. lo stato di funzionamento delle varie apparecchiature a livello delle singole prestazioni;
d. la rispondenza al corretto funzionamento degli impianti come risultato conseguente l’inserimento delle apparecchiature in contemporaneo funzionamento secondo quanto previsto per i singoli sistemi o
impianti;
e. gli schemi di tutti i quadri elettrici (di potenza e funzionali) quotati e la cui identificazione dovrà essere riportata sulle planimetrie secondo quanto indicato ed i disegni costruttivi delle relative carpenterie.
In particolare, in accordo al programma lavori contrattuale, l’Appaltatore è tenuto ad avviare e rendere funzionanti le varie macchine, impianti, sistemi, etc. procedendo alle opportune tarature, bilanciamenti, e verifiche per ottenere alla fine le condizioni di progetto.
Sono quindi necessarie le seguenti verifiche (elenco minimo) in accordo alle necessità funzionali dei vari impianti:
• il controllo delle tensioni sui quadri elettrici, siano essi di distribuzione principale siano essi di distribuzione secondaria o terminale;
• la taratura della selettività delle correnti differenziali impostate fra interruttori in serie;
• la verifica delle prestazioni di tutti i componenti;
• la verifica del corretto funzionamento della regolazione automatica in tutti i modi operativi;
• la verifica delle prestazioni dell’impianto nel suo complesso;
la verifica del funzionamento degli impianti di sicurezza attiva e passiva quali: impianto di illuminazione di
sicurezza, impianto rivelazione fumi, impianto di chiamata infermieri;
• la verifica della rumorosità prodotta dal funzionamento dei vari impianti, con particolare attenzione al
trasformatore ed al gruppo elettrogeno;
• le verifiche di cui alla Legge 46/90 e della norma CEI 64-8/7:2003-05.
Pertanto l’Appaltatore provvederà affinché tutte le apparecchiature siano fatte funzionare per tutto il tempo
necessario per eseguire le tarature e siano verificate tutte le portate controllando che le sicurezze intervengano senza ritardi e le sequenze logiche siano rispettate.
Queste verifiche dovranno essere puntuali e dettagliate al fine di dimostrare l’effettiva verifica di tutte le parti degli impianti.
Tutti gli impianti dovranno essere fatti funzionare, per quanto possibile, alle effettive condizioni di esercizio e
si dovrà verificare che gli scostamenti delle variabili controllate siano contenuti nelle tolleranze ammesse.
Tutte le verifiche sopra indicate saranno raccolte in apposito dossier e controfirmate da tecnici abilitati a garanzia della loro validità.
COLLAUDI
La consegna degli impianti alla Committente dovrà avvenire secondo le prescrizioni riportate nel Capitolato
Speciale d’Appalto parte prima “Disposizioni generali ed amministrative” e comunque entro 60 (sessanta)
giorni consecutivi dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.
Nel caso in cui si proceda a consegne parziali di reparti od unità funzionali entro 10 giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori dovranno essere consegnate tutte le certificazioni degli impianti relative al reparto ultimato. In particolare dovranno essere consegnate le dichiarazioni di conformità degli impianti complete delle certificazioni delle apparecchiature installate e delle prove di prima installazione degli impianti. Inoltre dovranno essere consegnate tutte le certificazioni e dichiarazioni collegate alla pratica di prevenzione
incendi. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari allo uno per mille dell’importo contrattuale relativo al reparto o unità funzionale
completata.
Si ricorda che la dichiarazione di conformità, con l’entrata in vigore del D.P.R. 462/01, costituisce omologazione d’impianto.
Alla fine delle tarature, prove e collaudi in corso d’opera dovrà essere responsabile di una prova di affidabilità e rispondenza dell’intero impianto installato.
I collaudi definitivi delle opere non menomano però la responsabilità dell’appaltatore sancita delle vigenti disposizioni di Legge.
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 61
DOCUMENTAZIONE
Questa documentazione, indicata più semplicemente come Manuali di Uso e Manutenzione, deve essere approntata con grande cura e tempestività dall’Appaltatore, rispettando scrupolosamente quanto sotto indicato:
• i Manuali di Uso e Manutenzione saranno strutturati utilizzando robusti registratori in plastica cartonata (dimensioni 34x28,5 cm) con custodia in cartone rivestito. Questi registratori, adatti per documenti preforati o per buste in plastica trasparente a foratura universale, saranno dotati di meccanismo di apertura con azionamento a leva, 3 o 4 anelli in acciaio nichelato, e dispositivo di pressatura.
Sul dorso sarà presente un porta etichette a fogli mobili.
• Un set completo dei soli disegni sarà raccolto invece in scatole d’archivio in polipropilene (dimensioni
35x25 cm), con chiusura con bottone a pressione. Sul dorso sarà presente un porta etichette a fogli
mobili. Il grado di riempimento di questi supporti non dovrà superare l’80% degli stessi.
L’approntamento dei Manuali di Uso e Manutenzione, seguirà parallelamente l’avanzamento del progetto costruttivo e di officina, e l’andamento del cantiere, secondo la seguente tempistica:
a. disegni e schemi in accordo emissione progetto esecutivo e costruttivo di officina;
b. documentazione macchine (trasformatore, quadro di media tensione, quadri elettrici etc.) e
componenti in accordo emissione ordini e ispezioni;
c. aggiornamento disegni e schemi in accordo avanzamento cantiere, compreso certificati e
collaudi in corso d’opera. Nota: Tutti i percorsi degli impianti invisibili a opere finite (tubi interrati, impianti nei controsoffitti etc.) devono essere aggiornati immediatamente
dall’Appaltatore;
d. documentazione completa dopo le operazioni di start-up;
e. documentazione finale aggiornata.
In particolare i Manuali
cumenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
di Uso e Manutenzione conterranno, suddivisi nei capitoli sotto indicati, i seguenti doPagina di guardia (da ripetere per ogni registratore utilizzato).
Indice generale, in particolare per ogni registratore utilizzato.
Cap. 1 Premessa e descrizione generale degli impianti.
Cap. 2 Dati di calcolo e condizioni da garantire.
Schemi unifilari.
Calcoli e dimensionamenti.
Cap. 3 Elenco apparecchiature.
Cap. 4 Documentazione specifiche delle varie apparecchiature o componenti con individuazione evidenziata del tipo o modello prescelto, item di riferimento, certificati
di collaudo, prove, disegni di ingombro, caratteristiche elettriche, etc. Questa documentazione sarà ordinata in sottocapitoli secondo l’elenco apparecchiature (item A B - C etc). La strumentazione ed il controllo saranno raggruppati in un unico sottocapitolo.
Cap. 5 Dossier operativo di controllo, conduzione e manutenzione impianti: operazioni generali di routine. Idem c.s. ma con riferimento agli specifici interventi su impianti e componenti particolari.
Cap. 6 Elenco parti di ricambio critiche.
Cap. 7 Elenco fornitori dei vari componenti con indirizzi, numero telefax, telefono.
Cap. 8 Documentazione di start-up (portate, assorbimenti, certificati di prove elettriche, età).
Cap. 9 Documentazione di collaudo impianti con le varie relazioni di verifica e controllo redatte dai Collaudatori.
Cap. 10 Documentazione per verifiche ufficiali (ISPESL, USSL, etc.) ordinata per apparecchio od impianto. Nota: i certificati originali attinenti a tale capitolo, ordinati
come sopra, saranno forniti in raccoglitore separato.
Cap. 11 Elenco disegni e relativa serie dei disegni del progetto esecutivo e costruttivo di officina in edizione “As-built”. Note: il numero degli esemplari dei Manuali di
Uso e Manutenzione che l’Appaltatore deve fornire è di tre.
Il personale di conduzione degli impianti, nominato dal Committente dovrebbe essere presente, come osservatore, durante lo start-up dei vari impianti e sistemi.
I Manuali di Uso e Manutenzione devono essere forniti dall’Appaltatore al Committente 15 giorni prima
dell’inizio del training del personale di conduzione impianti.
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 62
In particolare l’Appaltatore deve effettuare un esauriente addestramento di questo personale; tale addestramento deve riguardare tutti gli impianti e la relativa componentistica con particolare enfasi rivolta a:
• ai contenuti dei Manuali di Uso e Manutenzione;
• all’uso da farsi di detti manuali;
• alle procedure da attuare per far funzionare gli impianti in ognuna delle modalità che per ciascuno di
essi sono state previste in fase di progetto;
• ai livelli di tolleranza accettabili per quanto riguarda la taratura degli impianti installati;
• alle procedure che occorre applicare per la gestione di eventuali situazioni d’emergenza;
• allo sviluppo della metodologia necessaria per registrare ogni inconveniente che riguardi il funzionamento di questi impianti e l’analisi per effettuare gli interventi correttivi tendenti ad eliminare le cause che hanno provocato questi malfunzionamenti.
GARANZIA
La Ditta Appaltatrice resterà garante di ciascun settore d’intervento relativo alle opere civili ed impiantistiche
nei termini riportati nel Capitolato Speciale d’Appalto parte prima “Disposizioni generali ed amministrative”.
S’intende per garanzia delle opere anzidette, entro il termine precitato, l’obbligo che incombe alla Ditta Appaltatrice di riparare tempestivamente, a sua totale cura e spesa, tutti i guasti e/o le imperfezioni che si potranno manifestare per effetto della non buona qualità dei materiali impiegati e/o per difetti di esecuzione.
CERTIFICAZIONI
La Ditta Appaltatrice, al termine dei lavori, dovrà presentare tutte le certificazioni, le omologazioni e gli attestati di conformità dei materiali impiegati, siano essi edili che impiantistici, rilasciati dai produttori dei materiali stessi.
La ditta Appaltatrice avrà altresì l’onere di certificare tutte quelle opere appaltate composte da più lavorazioni
elementari e formanti opere composite, con resistenza al fuoco REI come richiesto negli elaborati di progetto.
Al termine dei lavori le imprese installataci, siano esse appaltataci che subappaltatoci, sono tenute a rilasciare al Committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati (art. 9 L. 46/90).
L’entrata in vigore del D.P.R. 462/01 ha reso la dichiarazione di conformità, rilasciata dall’installatore, atto di
omologazione dell’impianto.
Di tale dichiarazione faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati e dal
progetto e dovrà essere sottoscritta sia dal titolare che dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
SMALTIMENTO RIFIUTI
La Ditta Appaltatrice dovrà prestare particolare attenzione allo smaltimento dei rifiuti provenienti dagli scavi,
dalle demolizioni delle opere edili, dalla rimozione di impianti tecnologici, infissi, ecc, attuando una raccolta
ed una cernita dei rifiuti precisa e costante. Con la rimozione dei componenti dell’impianto elettrico preesistente all’interno dei locali oggetto di intervento è compreso lo smontaggio di tutti i componenti, la cernita
dei materiali, il loro eventuale accantonamento in deposito indicato dalla D.L. o lo smaltimento in discarica
autorizzata dei materiali di risulta.
E’ compreso lo sfilamento dei conduttori di alimentazione fino alle scatole di derivazione che si trovano al perimetro della zona di intervento. E’ compreso anche il ripristino di eventuali parti di impianti elettrici che si
trovino all’interno dei locali oggetto degli interventi e funzionanti per altre utenze non presenti all’interno degli stessi o non considerati in tale appalto.
Per i rifiuti non riutilizzabili, come enunciato dal D.Lgs. 22/1997, si applicheranno le norme vigenti per lo
smaltimento dei rifiuti industriali in particolare il D.P.R. 915/1982 e successive modifiche ed integrazioni. Si
ricorda che i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, i macchinari e le apparecchiature deteriorate ed obsolete sono considerati come rifiuti speciali.
Nel caso di presenza di rifiuti classificati tossici lo smaltimento dovrà essere condotto da ditta autorizzata al
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi, compreso il rilascio della documentazione di
avvenuto smaltimento presso centro autorizzato.
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 63
MISURAZIONE E VALUTAZIONE LAVORI
I prezzi contrattuali al netto del ribasso d’asta contrattuale sono comprensivi di tutti gli oneri generali e speciali specificati negli atti contrattuali e nel presente capitolato ed ogni altro onere che, pur se non esplicitamente richiamato, deve intendersi consequenziale e necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola
d’arte. Nei prezzi contrattuali sono, dunque, compensate tutte le spese principali ed accessorie, le forniture, i
consumi, la mano d’opera, il carico, il trasporto, lo scarico, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori ultimati nel modo prescritto, le spese generali e l’utile per l’appaltatore. I lavori saranno pagati in base alle misure fissate dal progetto anche se le stesse, all’atto della misurazione, dovessero risultare superiori; potrà
tenersi conto di maggiori dimensioni soltanto nel caso che le stesse siano state ordinate per iscritto dalla direzione dei lavori. Per tutte le opere oggetto dell’appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con
misure geometriche o a numero o a peso in relazione a quanto previsto nell’elenco prezzi.
In particolare per le lavorazioni da computarsi a misura si avrà:
• le canale portacavi della distribuzione principale saranno valutate al metro lineare misurando
l’effettivo sviluppo lineare in opera. Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i pezzi speciali per
gli spostamenti, raccordi, supporti, staffe, mensole e morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a
parete con tasselli ad espansione;
• i cavi multipolari od unipolari saranno valutati al metro lineare misurando l’effettivo sviluppo lineare
in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale sono attestati. Nei cavi unipolari o multipolari
sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capo corda ed i marca cavi;
Tutte le lavorazioni da computarsi a corpo saranno valutate, dopo la verifica dell’effettiva esecuzione, in percentuale di lavoro eseguito rispetto alla percentuale di incidenza della categoria di lavorazione in relazione
all’importo complessivo dei lavori.
SMANTELLAMENTI
Per la realizzazione degli interventi devono essere preliminarmente smantellati gli impianti tecnologici attualmente a servizio delle aree oggetto di intervento.
Tutti gli smantellamenti in questione sono completi di rimozione e di trasporto a discarica, previa differenziazione con smaltimento secondo Legge, di qualunque tipo di materiale: cavi di alimentazione, quadri, canale,
apparecchi illuminanti, ecc. e della rimozione di ogni accessorio o complemento la cui necessità sia venuta
meno, insistente in zone nelle quali non vi è al momento necessità di utilizzo. Come i cavi elettrici, così tutte
le canale inutilizzate devono essere rimosse fino al punto di origine evitando la permanenza di rami morti.
Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d’arte e le prescrizioni della Direzione dei Lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale
d’Appalto ed al progetto. L’esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori o con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere
affidate ad altre ditte. La Ditta è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e
dei propri dipendenti, alle opere esistenti.
NORME DI RIFERIMENTO
Per la realizzazione degli impianti dovranno essere seguite tutte le disposizioni legislative applicabili per
l’esecuzione degli impianti elettrici e le norme CEI, CEI-UNEL in vigore al momento del progetto. Eventuali
varianti a disposizioni di legge o norme impiantistiche dovranno essere segnalate alla Direzione Lavori che, in
base ai propri riscontri tecnici e previo accordo con il R.U.P., attuerà le misure necessarie affinché i lavori ultimati siano conformi ai disposti legislativi e normativi in vigore all’atto del Collaudo tecnico-amministrativo.
Di seguito si riportano le principali disposizioni legislative e normative in vigore.
• Legge n. 186 del 1° marzo 1968
• Legge n. 46 05 marzo 1990 Norme per la sicurezza degli impianti
• D.P.R. n. 447 6 dicembre 1991 Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990n. 46 in materia di sicurezza degli impianti
• D.P.R. n. 392 18 aprile 1994 Regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza
• Legge n. 626 25 novembre 1996 Attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE
del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione
• D.L. n. 277 31 luglio 1997 Modificazioni al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, recante
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 64
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcature CE del materiale elettrico destinato ad
essere utilizzato entro taluni limiti di tensione
D.P.R. n. 380 6 giugno 2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia
D.P.R. n. 462 22 ottobre 2001 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia
di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a
terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi
Legge n. 818 7 dicembre 1984 Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative
dell’ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
D.M. 8 marzo 1985 Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del
rilascio del nulla osta provvisorio di cui alla legge 7-12-84, n. 818
D.M.I. 18 settembre 2002 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private
UNI 9795 Sistemi fissi automatici di rivelazione e segnalazione manuale d’incendio
CEI 11-17 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo
CEI 11-48 Esercizio degli impianti
CEI 16-1 Individuazione dei conduttori isolati
CEI 16-4 Principi base e di sicurezza per l’interfaccia uomo-macchina, marcatura ed identificazione.
Individuazione dei conduttori tramite colori o codici numerici
CEI 16-7 Elementi per identificare i morsetti e la terminazione dei cavi
CEI EN 60947-2 (CEI 17-5) Apparecchiatura a bassa tensione. Parte 2: interruttori automatici
CEI EN 60947-3 (CEI 17-11) Apparecchiatura a bassa tensione. Parte 3: Interruttori di manovra,
sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili
CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1) Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa
tensione (quadri BT). Parte 1: apparecchiature di serie soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature non di serie parzialmente soggette a prove di tipo (ANS)
CEI EN 60439-3 (CEI 17-13/3) Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa
tensione (quadri BT). Parte 3: prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e
di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove il personale non addestrato ha accesso al loro uso quadri di distribuzione (ASD)
CEI17-43 Metodo per la determinazione delle sovrattemperature, mediante estrapolazione, per le
apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) non di serie
(ANS)
CEI 17-70 Guida all’applicazione delle norme dei quadri di bassa tensione
CEI 17-71 Involucri vuoti per apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione. Prescrizioni generali
CEI 20-20/2 Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V. Parte 2: metodi di prova
CEI 20-20/3 Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V. Parte 3: cavi senza guaina per posa fissa
CEI 20-20/4 Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V. Parte 4: cavi con guaina per posa fissa
CEI 20-22/1 Prove d’incendio su cavi elettrici. Parte 1: generalità e scopo
CEI 20-22/2 Prove d’incendio su cavi elettrici. Parte 2: prova di non propagazione dell’incendio
CEI 20-22/3 Prove d’incendio su cavi elettrici. Parte 3: prove su fili o cavi disposti a fascio
CEI 20-22/4 Prove d’incendio su cavi elettrici. Parte 4: metodo per la misura dell’indice di ossigeno
per componenti non metallici
CEI 20-24 Giunzioni e terminazioni per cavi d’energia
CEI 20-27 Cavi per energia e per segnalamento. Sistema di designazione
CEI 20-33 Giunzioni e terminazioni per cavi d’energia a tensione Uo/U non superiore a 600/1.000 in
corrente alternata e 750 V in corrente continua
CEI EN 50265-1 (CEI 20-35/1) Metodo di prova comuni per cavi in condizioni di incendio. Prova
di non propagazione verticale della fiamma su un singolo conduttore o cavo isolato. Parte 1 : apparecchiature di prova
CEI EN 50265-2-1 (CEI 20-35/1-1) Metodo di prova comuni per cavi in condizioni di incendio.
Prova di non propagazione verticale della fiamma su un singolo conduttore o cavo isolato. Parte 2-1:
procedure di prova - fiamma di 1 kW premiscelata
CEI EN 50265-2-2 (CEI 20-35/1-2) Metodo di prova comuni per cavi in condizioni di incendio.
Prova di non propagazione verticale della fiamma su un singolo conduttore o cavo isolato. Parte 2-2:
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 65
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
procedure di prova - fiamma diffusa
CEI EN 50267-1 (CEI 20-37/2-0) Metodo di prova comuni per cavi in condizioni di incendio.
Prova sui gas emessi durante la combustione dei materiali prelevati dai cavi. Parte 1 : apparecchiatura di prova
CEI EN 50267-2-1 (CEI 20-37/2-1) Metodo di prova comuni per cavi in condizioni di incendio.
Prova sui gas emessi durante la combustione dei materiali prelevati dai cavi. Parte 2-1: procedure di
prova. Determinazione della quantità di acido alogenidrico gassoso
CEI EN 50267-2-2 (CEI 20-37/2-2) Metodo di prova comuni per cavi in condizioni di incendio.
Prova sui gas emessi durante la combustione dei materiali prelevati dai cavi. Parte 2-2: procedure di
prova. Determinazione del grado di acidità (corrosività) dei gas dei materiali mediante la misura del
pH e della conduttività
CEI EN 50267-2-3 (CEI 20-37/2-3) Metodo di prova comuni per cavi in condizioni di incendio.
Prova sui gas emessi durante la combustione dei materiali prelevati dai cavi. Parte 2-3: procedure di
prova. Determinazione del grado di acidità (corrosività) dei gas dei materiali mediante il calcolo della
media ponderata del pH e della conduttività
CEI 20-37/4 Prove sui gas emessi durante la combustione di cavi elettrici e dei materiali dei cavi.
Parte 4: misura della densità del fumo emesso dai cavi elettrici sottoposti a combustione in condizioni definite: Sezione 1: apparecchiatura di prova
CEI 20-37/5 Prove sui gas emessi durante la combustione di cavi elettrici e dei materiali dei cavi.
Parte 5: misura della densità del fumo emesso dai cavi elettrici sottoposti a combustione in condizioni definite: Sezione 2: procedura di prova e prescrizioni
CEI 20-40 Guida per l’uso di cavi a bassa tensione
CEI EN 60898 (CEI 23-3) Interruttori automatici per la protezione dalle sovraccorrenti per impianti domestici e similari
CEI 23-5 Prese a spina per usi domestici o similari
CEIEN 60669-1 (CEI23-9) Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa
per uso domestico e similare. Parte 1 : prescrizioni generali
CEIEN 60309-1 (CEI23-12/1) Spine e prese per uso industriale. Parte 1 : prescrizioni generali
CEI EN 60309-2 (CEI 23-12/2) Spine e prese per uso industriale. Parte 1: prescrizioni per intercambiabilità dimensionale per apparecchi con spinotti ad alveoli cilindrici
CEI 23-16 Prese a spina di tipi complementari per usi domestici e similari
CEI 23-19 Canali portacavi in materiale plastico e loro accessori ad uso battiscopa
CEI 23-20 Dispositivi di connessione per circuiti a bassa tensione per uso domestico e similare. Parte 1: prescrizioni generali
CEI 23-21 Dispositivi di connessione per circuiti a bassa tensione per uso domestico e similare. Parte 2-1: prescrizioni particolari per i dispositivi di connessione come parti separate con unità di serraggio di tipo a vite
CEI EN 60423 (CEI 23-26) Tubi per installazioni elettriche. Diametri esterni dei tubi per installazioni elettriche e filettature per tubi e accessori
CEI 23-31 Sistemi di canali metallici e loro accessori ad uso portacavi e porta apparecchi
CEI 23-32 Sistemi di canali di materiale plastico isolante e loro accessori ad uso portacavi e porta
apparecchi per soffitto e parete
CEI EN 50086-1 (CEI 23-39) Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Parte 1 :
prescrizioni generali
CEI EN 61008-1 (CEI 23-42) Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche o similari. Parte 1: prescrizioni generali
CEIEN61008-2-1 (CEI23-43) Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche o similari. Parte 2-1: applicabilità delle prescrizioni generali agli interruttori differenziali con funzionamento indipendente dalla tensione di rete
CEI EN 61009-1 (CEI 23-44) Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati
per installazioni domestiche o similari. Parte 1 : prescrizioni generali
CEIEN 61009-2-1 (CEI23-45) Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche o similari. Parte 2-1: applicabilità delle prescrizioni generali agli interruttori differenziali con funzionamento indipendente dalla tensione di rete
CEI EN 50086-2-4 (CEI 23-46) Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Parte 2-4:
prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati; CEI 23-48 Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari. Parte 1: prescrizioni generali
CEI 23-49 Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari. Parte 2: prescrizioni particolari per involucri destinati a contenere dispositivi di protezione ed apparecchi
che nell’uso ordinario dissipano una potenza non trascurabile
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 66
•
CEI 23-50 Prese a spina di tipi complementari per usi domestici e similari. Parte 1: prescrizioni generali
• CEI 23-51 Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico o similare
• CEI EN 50086-2-1 (CEI 23-54) Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Parte 2-1:
prescrizioni particolari per sistemi di tubi rigidi e accessori
• CEI EN 50086-2-2 (CEI 23-55) Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Parte 2-2:
prescrizioni particolari per sistemi di tubi pieghevoli e accessori
• CEI EN 50086-2-3 (CEI 23-56) Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Parte 2-3:
prescrizioni particolari per sistemi di tubi flessibili e accessori
• CEI EN 61543 (CEI 23-53) Interruttori differenziali (RCD) per usi domestici e similari. Compatibilità elettromagnetica
• CEI EN 50085-2-3 (CEI 23-67) Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche. Parte 23: prescrizioni particolari per sistemi di canali con feritoie laterali per installazione all’interno dei quadri elettrici
• CEI EN 60081 (CEI 34-3) Lampade fluorescenti tubolari per illuminazione generale
• CEI EN 60598-1 (CEI 34-21) Apparecchi di illuminazione. Parte 1 : prescrizioni generali e prove
• CEI EN 60598-2-22 (CEI 34-22) Apparecchi di illuminazione. Parte 2-22: prescrizioni particolari.
Apparecchi di emergenza
• CEIEN 60598-2-1 (CEI 34-23) Apparecchi di illuminazione. Parte 2: prescrizioni particolari. Apparecchi fissi per uso generale
• CEI EN 60598-2-2 (CEI 34-31) Apparecchi di illuminazione. Parte 2: prescrizioni particolari. Sezione 2: apparecchi di illuminazione da incasso
• CEI EN 60901 (CEI 34-56) Lampade fluorescenti monoattacco. Prescrizioni di prestazione
• CEI EN 61195 (CEI 34-72) Lampade fluorescenti a doppio attacco. Prescrizioni di sicurezza
• CEI EN 61199 (CEI 34-73) Lampade fluorescenti con attacco singolo. Prescrizioni di sicurezza
• CEI EN 61547 (CEI 34-75) Apparecchi per illuminazione generale. Prescrizioni di immunità EMC
• CEI EN 60598-2-25 (CEI 34-76) Apparecchi di illuminazione. Parte 2: prescrizioni particolari. Sezione 25: apparecchi di illuminazione per gli ambienti clinici degli ospedali e delle unità sanitarie
• CEI R023-001 Raccomandazioni per il coordinamento dimensionale tra involucri e dispositivi da incorporare per fissaggio su guide per installazioni domestiche e similari; Involucri per apparecchi per
installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari. Parte 1 : prescrizioni generali;
• CEI 64-8:2003-05 Impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua. Parte 1 : oggetto, scopo e principi fondamentali; Parte 2: definizioni; Parte 3: Caratteristiche generali; Parte 4: prescrizioni per la sicurezza; Parte 5: scelta ed installazione dei componenti elettrici; Parte 6: verifiche; Parte 7: ambienti ed applicazioni particolari
• CEI 70-1 Grado di protezione degli involucri
• CEI EN 60065 (CEI 92-1) Apparecchi audio, video e apparecchi elettronici similari. Requisiti di sicurezza
• CEI-UNEL 00721 Colori della guaina dei cavi elettrici
• CEI 60146-4: UPS – Prestazioni
• CEI 62040-1 e EN 62040-1: UPS – Sicurezza
• CEI 62040-2 e EN 62040-2 livello B: UPS - Compatibilità elettromagnetica
• CEI 62040-3 e EN 62040-3: UPS – Prestazioni
• CEI60950 / EN 60950: sicurezza delle apparecchiature elaborazione dati
• CEI61000-2-2: compatibilità elettromagnetica: livelli di compatibilità
• CEI 61000-3-4:
limiti d’emissione di correnti armoniche per apparecchiature con corrente
d’ingresso > 16 A/fase
• CEI 61000-4:compatibilità elettromagnetica: test d’immunità
• EN 55011 e EN 55022: interferenze elettromagnetiche degli apparecchi industriali scientifici - Livello B,
emissioni condotte e irradiate
CEI 439: sicurezza delle apparecchiature a bassa tensione
CEI 60529: livello di protezione delle apparecchiature (codice IP)
ISO 3746: misura del rumore acustico
IEC norma 439 IEC norma 157-1 IEC norma 898
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 67
SPECIFICHE DELLE APPARECCHIATURE
QUADRI ELETTRICI
Nella fornitura è prevista la realizzazione del nuovo elettrico generale di smistamento del blocco operatorio e
dei quadri elettrici secondari per consentire la protezione delle nuove linee elettriche di alimentazione degli
utilizzatori e degli apparecchi illuminanti sia per illuminazione normale che di sicurezza. La fornitura avrà inizio ai terminali d’ingresso di ciascun quadro e si completerà con il perfetto funzionamento a regola d’arte,
comprese l’attestazione dei conduttori afferenti sia in ingresso che in uscita.
Sono compresi nella fornitura i quadri elettrici evidenziati nelle tavole di progetto i cui schemi di potenza e
funzionali saranno riportati sugli elaborati allegati al progetto esecutivo. Ciascun quadro deve essere completo e pronto al funzionamento entro i seguenti limiti meccanici ed elettrici: Lamiere di chiusura laterali e per
chiusura, passaggio cavi comprese; Attacchi per collegamento cavi di potenza compresi; Morsetti per collegamento cavi ausiliari esterni compresa; Devono essere fornite le seguenti opere e prestazioni: Trasporto;
Posa in opera; Esecuzione di opere civili minori necessarie per la posa in opera.
Tutti i quadri elettrici potranno essere approvvigionati in cantiere e posati in opera solo dopo che sia stata
consegnata, alla D.L., la certificazione di conformità del quadro elettrico. Per quanto concerne il quadro elettrico generale del blocco operatorio, tav. E-04, la D.L. dovrà poter assistere alle prove di accettazione del
quadro elettrico stesso.
Criteri di dimensionamento ed alimentazione dei quadri elettrici
Tutti i quadri sono alimentati dalla rete privilegiata.
Per quanto riguarda gli impianti dei locali sale operatorie, risveglio e preparazione, è stato previsto di predisporre su di essi un ulteriore alimentazione di sicurezza (Art. 710.562 Norma CEI 64-8:2003-05) realizzata
prelevando l’alimentazione di tali circuiti sotto UPS. Per il dimensionamento dei circuiti elettrici, e quindi degli
interruttori, si è adottato la seguente procedura: i circuiti elettrici alimentanti una singola utenza sono dimensionati per la potenza nominale dell’utenza stessa; i circuiti elettrici alimentanti più utenze sono dimensionati considerando la potenza nominale (Pn) dell’utilizzatore a cui è applicato un coefficiente di contemporaneità (Kc), come da tabella seguente. Quindi si è calcolato il carico convenzionale del circuito (numero degli
utilizzatori x potenza nominale x coefficiente di contemporaneità), al risultato ottenuto viene applicato il coefficiente di utilizzazione (Ku) che fornisce la potenza per cui è stato dimensionato e calcolato il circuito.
Nella tabella seguente sono riportati: la tipologia dell’utilizzatore, la rispettiva potenza nominale, il coefficiente di contemporaneità applicato ed il coefficiente di utilizzazione applicato, inoltre si evidenziano i fattori di
potenza (cos cp) applicati per il calcolo della caduta di tensione.
Utilizzatore
Potenza nominale coeff. di uti- Potenza utilizzatore coeff. di con
Fattore di
(Pn) (W)
lizzazione
(Pu) (W)
temporaneità
potenza
(Ku)
(Kc)
(cos cp)
Luci
Presa 10°
Presa 10/16°
Presa UNEL 16°
Prese 32° 2p+t CEE
Porte motorizzate
Lampada scialitica
Pensile attrezzato
Parete attrezzata SO
Quadro prese S.O.
1,00
2.000
3.200
2.000
6.000
500
600
1.700
300
1.200
0,10
0,05
0,20
1
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
200
150
400
6.000
500
600
1.700
300
1.200
1,00
0,90
0,80
0,60
0,80
0,50
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
1,00
0,90
0,90
0,90
Le apparecchiature devono essere previste per essere utilizzate nelle seguenti condizioni di servizio:
DATI AMBIENTALI (riferiti al locale ove è installato il quadro)
• Temperatura ambiente max +40 ° min. -5 °C
• Umidità relativa 30-60%
DATI ELETTRICI (comuni a tutti i quadri elettrici)
• Tensione di isolamento: 1.000V
• Tensione esercizio: 380V
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 68
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Numero delle fasi 3+N
Stato del Neutro: distribuito
Tensione di tenuta a frequenza industriale per un minuto
3,5 kV circuiti di potenza
0,5 kV circuiti ausiliari
Frequenza nominale: 50 Hz
Corrente nominale sbarre come a schemi
Corrente nominale derivazioni come a schemi
Corrente di breve durata nominale ammissibile 15 kA per 1”
Durata nominale del corto circuito: 1”
Potere di interruzione degli interruttori: come a schemi
Tensione nominale di alimentazione dei dispositivi di apertura e chiusura e dei circuiti ausiliari: come da
schemi. Tutte le parti metalliche accessibili degli apparecchi, dei quadri e delle altre parti dell’impianto
elettrico, non appartenenti a circuiti a bassissima tensione di sicurezza devono essere protette contro le
tensioni di contatto. La protezione è attuata mediante messa a terra delle parti metalliche accessibili o
con isolamento speciale.
Caratteristiche costruttive
I quadri risponderanno alle caratteristiche dettate dalle normative CEI EN 60439-1, CEI EN 60439-3 e
D.P.R. 547/55 in esecuzione IP40, dotati di pannellatura di servizio e porta trasparente, saranno completamente chiusi su tutti i lati e con le apparecchiature così predisposte:
• unità di arrivo: interruttore generale e/o sezionatore generale di barra o sezione, in apposito cubicolo segregato, accessibile solo dopo che l’interruttore si trova in posizione di aperto, interblocco
meccanico;
• gruppi di comando: assieme degli interruttori magnetotermici, magnetotermici differenziali, ausiliari;
• unità di uscita: assieme delle morsettiere atte al collegamento delle apparecchiature alle linee ad
esse in derivazione disposte in appositi cubicoli segregati dalle altre apparecchiature. Le sezioni afferenti a reti di alimentazione distinte devono essere completamente segregate ciascuna in un cubicolo
proprio.
La disposizione delle apparecchiature deve essere scelta in modo da rendere facile l’individuazione dei circuiti
e la loro manutenzione; a questo scopo i pannelli frontali devono essere dotati di targhette con iscrizioni recanti la destinazione delle apparecchiature corrispondenti a quanto riportato negli schemi. Deve essere indicato, con idoneo sinottico, il percorso del flusso di distribuzione dell’energia indicante ogni singola diversa
sezione con colori diversi, da concordare con la Direzione tecnica dell’Ospedale.
Indicativamente potremmo avere:
• Nero = sezione ordinaria;
• Rosso = sezione preferenziale;
• Blu = sezione di continuità.
Alle apparecchiature stesse devono essere applicate, nella parte interna, etichette adesive con sigla alfanumerica relativa all’identificazione del quadro di appartenenza e del numero d’ordine riferito allo schema unifilare che dovrà essere allegato ad opera compiuta. Tutti i quadri sono provvisti di collegamento equipotenziale al circuito di terra e di protezione, tramite barra di rame (non sono ammessi i supporti delle morsettiere
quali conduttori di equipotenzialità). La rimozione dei ripari deve essere possibile solo con apposita attrezzatura, e le eventuali morsettiere, che per necessità devono rimanere in tensione anche a quadro aperto, devono essere provviste di apposite protezioni in materiale isolante.
Le apparecchiature sono derivate da barre o morsetti omnibus e l’assemblaggio deve essere realizzato in
modo da garantire un grado di protezione IP2x min. con pannelli asportati a tale scopo si precisa che: la barre ed i morsetti omnibus sono in rame elettrolitico dimensionate per una corrente superiore del 50% rispetto
al valore nominale dell’interruttore posto a monte; la barre ed i morsetti omnibus devono essere segregati su
tutti i lati ed accessibili solo dopo aver rimosso i pannelli in plexiglas fissati alla struttura tramite viti con teste
ad esagono incassato (brugola) ed in acciaio inox; la barra di terra, per tutta la lunghezza e/o altezza del
quadro, deve essere posta in prossimità delle morsettiere.
DESIGNAZIONE
IDENTIFICAZ.
DESIGNAZIONE
IDENTIFICAZ.
CONDUTTORI
CONDUTTORI
LINEA ALIMENTAZIONE c.a.
Fase 1
Fase 2
LINEA ALIMENTAZIONE c.c.
L1
L2
Positivo
Negativo
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
L+
L-
__________
pag. 69
Fase 3
Neutro
LINEE DERIVATE IN c.a.
Fase 1
Fase 2
Fase 3
L3
N
Ri/Xi/ Ili
Si/Yi A/i
Ti /Zi /Wi
Mediano
Conduttore di protezione
(Sistemi TT-TNS)
(Sistemi TNC)
(Dispersore)
Terra senza disturbi
M
PE
PEN
E
TE
Le morsettiere di allacciamento delle linee in partenza devono essere installate ad una distanza minima di
12,5 mm dal pannello superiore, inferiore o laterale del quadro, inclinate di circa 45° dalla verticale onde facilitare il collegamento in cantiere delle linee derivate. L’ingresso dei conduttori attraverso l’involucro esterno
del quadro deve avvenire senza che ciò pregiudichi le caratteristiche di tenuta richieste; a tale scopo saranno
impiegati passacavi a tenuta o sistemi equipollenti.
Nel caso di conduttori unipolari deve essere posta particolare cura nell’impedire campi magnetici, per correnti indotte, sulle carpenterie metalliche del quadro.
Sul fronte di ciascuno scomparto devono essere presenti i seguenti cartelli:
a) Targa indicante il nome del costruttore, il tipo dell’unità l’anno di fabbricazione, la tensione nominale, la corrente nominale e la corrente di breve durata nominale;
b) Indicazioni del senso delle manovre;
c) Targa monitoria.
I quadri di distribuzione secondaria, o quadri di zona, previsti in progetto sono di tipo a FORMA 2 rispondente alle norme CEI17-13/3 (quadro ASD), sono addossati a parete ed accessibili dal fronte. Questa tipologia di
quadro è adatto per posa diretta a pavimento, con struttura di tipo modulare e costituita da un colonna indipendente la lamiera sarà di prima scelta di acciaio, laminate a freddo e bordi rifilati. Tutto il quadro elettrico,
barre, supporti e cavi deve poter sopportare un corrente di cortocircuito almeno 1,5 volte la ICc nominale ipotizzata sulle barre. La carpenteria metallica del quadro deve essere costituita essenzialmente da:
a) basamento, montanti, pannelli di chiusura laterali, pannelli di chiusura posteriori e pannelli di chiusura superiori in profilato di lamiera di spessore adeguato;
b) porta anteriore in lamiera bordata provvista di vetro e di maniglie con chiusura a chiave tipo”YALE”;
c) pannelli frontali per apparecchi di tipo con cerniera, pannelli frontali di chiusura del vano morsettiera
con vite;
d) colore a scelta della Direzione dei Lavori;
e) sbarre di terra di sezione non inferiore alla minima sezione in arrivo e comunque non inferiore a 25
mm2.
All’interno delle apparecchiature devono essere installati tutti gli apparati necessari alla razionale suddivisione dei circuiti di alimentazione degli utilizzatori, onde consentire la semplice e sicura gestione dell’impianto e
la massima sicurezza da parte degli utenti. Ogni quadro raggruppa al suo interno le apparecchiature di protezione e sezionamento relative ad un gruppo funzionale di utenze ubicate nelle sue vicinanze; il coordinamento delle protezioni, come meglio specificato, deve garantire la selettività degli interventi in caso di guasto
e permettere la continuità di esercizio dei servizi essenziali Gli interruttori installati devono rispettare le seguenti caratteristiche:
- interruttori fino a 63°: tipo modulare (modulo 17,5 mm) per installazione su profilato DIN;
- interruttori da 63 a 100°: tipo modulare o scatolati compatti a discrezione secondo il potere
di interruzione richiesto;
- interruttori oltre 100°: tipo scatolati compatti.
Le connessioni devono essere accessibili solo dopo la rimozione dei pannelli anteriori. Tutti gli interruttori devono essere derivati da barra o morsetti omnibus, non sono ammessi cavallotti fra i poli degli interruttori ad
eccezione di barre collettrici adatte allo scopo. Tutti i quadri nei quali sono presenti sia l’energia ordinaria
che la privilegiata e la sicurezza sotto UPS dovranno essere divisi in zone tra di loro separate e segregate,
anche a mezzo di setti metallici interni e tutte le utenze (interruttori, morsettiere, cablaggi, ecc.) soggette ai
diversi sistemi di alimentazione devono essere alloggiate esclusivamente nel relativo scomparto.
L’accoppiamento dei vari elementi delle strutture è realizzato con viti speciali senza taglio a cacciavite opportunamente trattate (cadmiatura eccetera). All’interno i quadri sono provvisti di opportuni telai completi di
profilati tipo DIN e piastre di fondo. Le dimensioni di ingombro esterne di ogni quadro riportate negli schemi
elettrici sono da intendersi come tipiche.
I quadri devono essere ancorati alle opere murarie tramite bulloni tirafondi a terra e tasselli ad espansione
alla parete di appoggio.
Caratteristiche elettriche
Per tutti i quadri suddetti oltre alle prescrizioni specifiche per ciascuno di essi, sono da rispettare le seguenti
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 70
indicazioni.
• le linee di alimentazione devono attestarsi direttamente ai morsetti dei relativi interruttori, per corrente nominale fino In=100 A e sezione del cavo fino a 16 mm2, per corrente nominale In>100 A e
sezione del cavo fino a 16 mm2 l’attestazione del cavo deve avvenire su apposite barrature o codoli;
• le linee di distribuzione devono attestarsi ad apposite morsettiere di potenza numerate previste nella
parte inferiore del quadro;
• i circuiti funzionali di ciascun quadro devono essere posati in apposito vano segregato sia verticalmente che orizzontalmente, non è ammesso il montaggio di apparecchiature e/o il cablaggio delle
stesse all’interno dei vani di risalita cavi, all’interno dei vani barre e/o cubicoli interruttori;
• tutte le connessioni interne per correnti nominali sino a 100 A devono essere eseguite con cavi e/o
conduttori di sezione adeguata alloggiati entro canale in materiale plastico autoestinguente disposte
in modo ordinato, e devono essere attestati, sia in morsettiera sia sull’apparecchio, con capocorda a
pressione preisolati. Oltre tale limite si devono impiegare barre di rame preformate;
• i conduttori, di tipo N07VK, sono posati all’interno di canale di cablaggio in PVC autoestinguente, dotati di apposite asole, opportunamente fissate ai montanti ed ai pannelli interni del quadro stesso;
• la colorazione dei conduttori deve permettere l’immediata identificazione delle caratteristiche di funzionamento del circuito (protezione, potenza, ausiliari, ausiliari in BTS, interblocchi). Confrontare anche la tabella CEI-UNEL 00721;
• i conduttori devono portare, a ciascuno dei capi (sia a monte, sia a valle degli interruttori ed in morsettiera), tramite anelli o fascette di siglatura, l’identificazione alfanumerica del circuito con riferimento alla fase ed al numero caratteristico dell’apparecchiatura etc.) come da tabella ed i terminali
saranno dotati di capicorda a compressione preisolati con caratteristiche consone al tipo di connessione. A tale scopo sarà onere del Costruttore aggiornare lo schema elettrico dell’apparecchiatura
costruita con l’identificazione alfanumerica adottata;
• nei cablaggi di circuiti funzionali i conduttori devono portare la numerazione alfanumerica che identifichi il numero di riferimento della colonna all’interno della pagina dello schema elettrico relativo;
• i conduttori che collegano eventuali apparecchiature installate sui pannelli frontali devono essere
protetti con spirale flessibile e non devono trasmettere sollecitazioni ai morsetti;
• la sezione minima ammessa per i conduttori dei circuiti ausiliari sarà di 1,5 mm2;
• per i circuiti principali sarà di 2,5 mm2;
• tutti i conduttori interni ai quadri devono essere di tipo non propagante la fiamma, a bassa emissione di gas tossici ed assoluta assenza di gas corrosivi;
• tutti i cavi in ingresso ed in uscita dal quadro elettrico devono essere siglati alle estremità con le apposite targhette di siglatura che ne identificano in maniera univoca il quadro di provenienza, il servizio ed il tipo di macchina (o utenza) alimentata;
• le varie sigle devono essere riportate sullo schema elettrico del quadro stesso;
• tutte le apparecchiature elettriche, così come la realizzazione del quadro, sono previste per un clima
corrispondente a quanto indicato precedentemente;
• in particolare si deve tenere conto: della distanza tra le parti in tensione e del livello di isolamento;
del trattamento superficiale della bulloneria che è zincopassivata e di classe 8.8;
• del trattamento e protezione delle parti metalliche come specificato ai punti successivi.
INTERRUTTORI AUTOMATICI DI BASSA TENSIONE
Nel presente articolo si fa riferimento agli interruttori automatici (compresi quelli di tipo differenziale) installati a bordo dei quadri elettrici. Sono quindi esclusi i piccoli interruttori installati a bordo di “scatole porta
frutto” (comando e/o FM).
L’installazione degli interruttori automatici è dettata dall’esigenza di proteggere le linee elettriche contro il
sovraccarico ed il cortocircuito; è prevista l’installazione di interruttori automatici con protezione magnetotermica opportunamente dimensionata secondo le modalità indicate dalle normative CEI 64-8, in pratica dovrà risultare verificata la relazione
IB2 < IN2 < Iz
dove:
IB = corrente di impiego dell’utilizzatore,
IN = corrente nominale dell’interruttore di protezione.
Iz = portata del conduttore secondo tabelle UNEL, in funzione del tipo di posa e del numero di conduttori attivi disposti nella stessa canalizzazione e della temperatura ambiente e di esercizio. Per quanto riguarda la
protezione in caso di C.to C.to le CEI 64-8 ed IEC 364-4-43 stabiliscono che il dispositivo di protezione della
condutture deve avere un potere di interruzione almeno uguale alla Icc presunta nel punto di installazione e
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 71
deve intervenire con una rapidità tale da non far superare alla conduttura la massima temperatura ammessa
ottenuta tramite la relazione:
(I2t)<K2S2
dove:
(I2t) = energia specifica passante per la durata del C.to C.to
K= fattore dipendente dal tipo di isolamento e di conduttore
S= sezione del conduttore.
Per garantire, in caso di corto circuito, il coordinamento tra l’interruttore magnetotermico e la relativa conduttura protetta, l’Appaltatore dovrà installare interruttori aventi curva di energia specifica passante massima
(I2t) adeguata a quella analoga della conduttura protetta. Quindi, sia per il corto circuito con potenza minima
che per il corto circuito con potenza massima, la curva I2t della conduttura sarà superiore a quella relativa
all’interruttore (riferita al relè termico montato a bordo dell’interruttore).
In ogni caso il valore dell’energia specifica passante dell’interruttore, corrispondente al tempo di intervento
del relè termico pari a 5 s, sarà tale da garantire la protezione contro i contatti indiretti. Tutti gli interruttori
sui quadri devono rispettare le seguenti caratteristiche:
• protezione termica e magnetica per ogni polo protetto; di tipo omnipolare, ovvero non sono ammessi interruttori unipolari su linee bipolari ed interruttori tripolari su linee tetrapolari;
• tutti gli interruttori di tipo scatolato devono avere la regolazione del relè magnetico e del relè termico;
• tutti gli interruttori automatici conformi alla norma CEI 17-5 l’idoneità a svolgere la funzione di sezionamento deve essere esplicitamente dichiarata dal costruttore. Per i circuiti ausiliari non sono
ammessi autotrasformatori;
• i trasformatori dovranno rispondere alle norme CEI in vigore, avere protezione termomagnetica ed
un sovradimensionamento di almeno il 25% della potenza necessari. Tutte le linee per i circuiti di distribuzione principale secondaria che alimentano impianti di illuminazione e prese a spina sono dotate di interruttori automatici con protezione differenziale, sensibilità IAn = 0,030 A, quale protezione
aggiuntiva per contatti diretti e indiretti;
• tale installazione non deve prescindere dalla realizzazione di tutti quegli accorgimenti previsti dalle
norme e dalla buona tecnica. Gli interruttori monofasi devono essere distribuiti sulle tre fasi, in modo
da equilibrare, per quanto possibile, il carico totale con uno scarto massimo tra la fase più carica e la
fase più scarica pari al 20%.
Gli interruttori magnetotermici e magnetotermici differenziali, devono avere il potere di interruzione adeguato alla corrente di corto circuito presunta nei punti interessati, da verificare prima dell’installazione con misure appropriate sul quadro.
Gli interruttori sono del tipo in esecuzione fissa e devono potere essere dotati di blocchi atti a ricevere le
connessioni degli eventuali ausiliari. Al fine di diminuire i tempi per eventuali disservizi dovuti a guasti su interruttori generali di sezione questi ultimi saranno di tipo sezionabile.
Il comando degli interruttori, la loro caratteristica, la corrente nominale ed il potere di interruzione si evincono dagli schemi elettrici.
Interruttori magneto termici
Tutti gli interruttori in argomento, di tipo automatico magnetotermico, costituiscono organo di protezione e
di sezionamento delle relative linee di alimentazione ed utilizzatori. I citati interruttori hanno le seguenti caratteristiche generali qualitative:
a) tipo compatto, modulare o scatolato, adatto sia per montaggio su profilato di supporto normalizzato
sia per installazione su pannello;
b) tutti i poli protetti simultaneamente per i tipi bipolari tripolari e tetrapolari;
c) curva caratteristica normalizzata secondo le caratteristiche tecniche dell’utenza da alimentare, prestazioni riferite ad una temperatura ambiente (quello all’interno del quadro elettrico) di 40°C; questo
indipendentemente dai valori a cui fanno riferimento le norme CEI (20°C per le CEI 23-3 e 40°C per
le CEI 17-5);
d) potere di interruzione minimo di corto circuito nominale (Icn) in funzione della corrente di corto circuito presunta nel quadro e comunque mai inferiore a 10 kA con fattore di potenza pari a 0,7-0,8
(secondo norme CEI EN 60898) e, per gli interruttori di tipo scatolato (CEI EN 60947-2) potere
d’interruzione limite minimo di corto circuito (leu) non inferiore a 20 kA, e potere d’interruzione diservizio (Ics) pari al 50% di leu.;
e) salvo specifica diversa indicazione, grado di protezione minimo IP 20.
Per gli interruttori domestici e similari è richiesto il marchio dell’Istituto Italiano Marchio di Qualità, mentre
per gli interruttori industriali (norma CEI 17-5) è richiesto il marchio CEI che attesti la rispondenza alla nor__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 72
ma di riferimento.
Per gli interruttori installati in serie si richiede:
• il coordinamento amperometrico (diversità di calibro) tra l’interruttore a monte e quello immediatamente a valle, al fine di realizzare la selettività di intervento alle correnti di sovraccarico; inoltre, gli
interruttori di tipo industriale dovranno risultare totalmente selettivi (coordinamento amperometrico
e cronometrico) rispetto agli interruttori a valle;
• la selettività totale per le correnti di corto circuito, ove le caratteristiche degli interruttori lo
consentono (fornite dalla Casa costruttrice degli stessi).
I seguenti dati di targa dovranno essere impressi sull’interruttore stesso:
• Interruttore ad uso civile (CEI EN 60898): nome del costruttore o marchio di fabbrica, con sigla identificativa del tipo di interruttore; corrente nominale “In” (A); tensione nominale (V); tipo di corrente
(alternata);
• - Interruttore ad uso industriale (CEI EN 60947-2): nome del costruttore o marchio di fabbrica, con
sigla identificativa del tipo di interruttore; tensione di impiego (V); categoria prestazione (P2) su corto circuito; corrente termica nominale o corrente ininterrotta (Im); frequenza d’uso (50 Hz); potere di
interruzione nominale di corto circuito (A oppure kA); potere di chiusura in corto circuito nominale
(solo se diverso da quello che la norma CEI EN 60947-25 fa corrispondere al potere di interruzione
nominale di corto circuito); tensione di isolamento (se maggiore della tensione di impiego nominale).
Interruttori magnetotermici differenziali
La protezione differenziale (il cui sgancio deve avvenire senza necessità di energia ausiliaria), ove prevista, è
realizzata esclusivamente a mezzo di interruttori automatici differenziali con sganciatori di sovracorrente
(magnetotermici) incorporati, così come stabilito dalle norme CEI EN 61008-1, CEI EN 61008-2-1, CEI EN
61009-1 e CEI EN 61009-2-1.
L’apparecchiatura predetta, costituente un unico sistema monoblocco non separabile (salvo manomissione),
ha tutte le caratteristiche precedentemente indicate per i semplici interruttori magnetotermici automatici.
Al fine di garantire la massima continuità di servizio, due interruttori differenziali posti in serie, l’uno all’altro,
devono risultare selettivi, per cui quello a monte deve avere (rispetto a quello a valle) ritardo di intervento
e/o valore della corrente differenziale nominale di intervento relativamente maggiori e tali da garantire la
non sovrapposizione delle azioni in condizioni di intervento pari a quelli nominali dell’interruttore a valle.
Ad integrazione di quanto riportato per gli interruttori magnetotermici in merito alle tipologie di interruttori
(in funzione della portata nominale) si precisa che per portate nominale (In) non inferiori a 63° potranno essere installati interruttori differenziali selettivi, con curva di intervento fissa. Per quanto evidente, si precisa
che gli interruttori differenziali devono garantire una protezione totale ai contatti indiretti e costituire solo
protezione addizionale ai contatti diretti.
Si precisa che i dispositivi differenziali a protezione dei circuiti prese od apparecchiature dei locali di gruppo 1
e gruppo 2, cosi come definito dalla vigente normativa CEI (art. 710.413.1.5 norma CEI 64-8/7:2003-05),
devono essere di “tipo A” per garantire la protezione da correnti di guasto alternate con componenti pulsanti
unidirezionali.
I seguenti dati di targa dovranno essere impressi sull’interruttore stesso:
• Corrente nominale (A);
• Tensione nominale (V);
• Tipo di corrente (alternata e alternata/pulsante);
• Corrente differenziale nominale di intervento IA (mA);
• Grado di protezione (se diverso da IP 20);
• Potere di interruzione nominale di corto circuito (A oppure kA).
TUBAZIONI E CANALI PORTACAVI.
I conduttori, a meno che non si tratti di installazioni provvisorie volanti per le quali occorre seguire idonee
procedure di installazione, devono sempre essere protetti e salvaguardati meccanicamente mediante posa in
tubazioni, canale porta cavi, passerelle, condotti o cunicoli ricavati nella struttura edile, ecc. Quando una
conduttura attraversa elementi costruttivi, quali pavimenti, muri, tetti, soffitti o parete, che devono conservare, per un tempo determinato, la resistenza meccanica ®, la tenuta alle fiamme ed ai gas (E), l’isolamento
termico (I) deve essere previsto il ripristino di tale condizione mediante l’installazione di opportune barriere
tagliafiamma trattate di seguito.
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 73
Canale portacavi
Le canale porta cavi per la distribuzione principale sono realizzate in acciaio elettrozincato conforme alle
norme DIN 50961, mentre per la distribuzione secondaria sono in PVC; entrambe le tipologie sono installate
a parete del corridoio od all’interno del controsoffitto sempre del corridoio. Nel caso di posa in controsoffitto
le scatole di derivazione devono comunque essere posate in posizione facilmente accessibile senza per questo dover rimuovere il controsoffitto.
Le giunzioni delle canale devono essere eseguite in modo tale da evitare il pericolo di abrasione della guaina
dei cavi durante la posa.
Le canale devono essere fissate direttamente a parete; altre situazioni in cui non sia possibile tale soluzione
prevedono l’utilizzo di mensole di sostegno; l’interasse di dette mensole deve essere calcolato in funzione del
carico; la freccia non deve comunque superare 1/150 della luce libera.
Dovendo posare le canale direttamente a parete si rende necessario l’impiego delle traverse reggicavo, che,
inoltre, hanno la funzione di impedire la rimozione del coperchio senza l’ausilio di attrezzi. Le canale devono
comunque essere comprensive di:
• coperchi;
• giunti d’unione; curve; derivazioni a “T”;
• derivazioni a croce;
• riduzioni;
• mensole varie di sostegno;
• bulloneria;
• setti separatori;
• e tutto quantaltro necessario a una perfetta installazione.
Le canale porta cavi devono potere essere suddivise in scomparti per consentire la separazione dei conduttori dei vari sistemi elettrici presenti nell’impianto. Per l’agevole accesso dei cavi, la distanza minima libera
ammessa tra due canale sovrapposte o tra le canale e/o i canali e tubazioni degli altri impianti (CDZ, fluidi,
ecc.) non deve essere inferiore a 200 mm, qualora per ragione di spazio si rendesse necessario diminuire
detta distanza, l’approvazione dovrà essere data dalla D.L., inoltre, come prescritto dalla norma CEI 23-32, si
deve applicare un coefficiente di riempimento delle canale pari al 50%, relativamente agli scomparti destinati
ad ospitare cavi per energia.
Per agevolare il riconoscimento del percorso delle canale, oltre a riportarlo nelle tavole di progetto, si deve
provvedere ad identificare le stesse con opportune targhette identificatrici indicanti la tipologia di impianto
posata all’interno del canale.
Canale portacavi in acciaio zincato
Le canale portacavi in acciaio zincato del tipo a griglia con bordi arrotondati antitaglio, devono essere dotate
di dispositivo di messa a terra che garantisca la continuità elettrica di tutti i componenti costituito
dall’elemento di giunzione. La canala deve presentare grado di protezione minimo pari ad IP 20. Il coperchio,
con innesto a scatto sulla base, deve essere smontabile solo con l’ausilio di attrezzo.
Canale portacavi in PVC
I canali portacavi e porta apparecchi e pareti divisorie mobili devono essere in PVC rigido resistente al calore
anormale ed alla propagazione della fiamma con temperatura limite di esercizio pari a 65°C e resistenti alla
prova di infiammabilità UL94 in classe V-0. Il materiale deve essere resistente all’azione della maggior parte
degli agenti chimici, all’umidità, alle muffe, all’atmosfera marina.
La canala deve presentare grado di protezione minimo pari ad IP 40.
Il coperchio, quando previsto deve essere con innesto a scatto sulla base e smontabile solo con l’ausilio di
attrezzo.
Tubazioni incassate
Le derivazioni d’impianto agli apparati utilizzatori, siano essi elettrici siano appartenenti agli impianti speciali,
sono previste in tubo flessibile posato sotto intonaco e devono presentare un grado di protezione minimo pari a IP > 40. Le tubazioni, che devono collegare senza interruzioni e giunzioni la scatola di derivazione con
l’utilizzatore finale, sono in materiale termoplastico a base di cloruro di polivinile (PVC), con resistenza allo
schiacciamento pari a 750 N (serie pesante) di tipo flessibile come definito nella norma CEI EN 50086-2-3, e
devono essere dotate di marcatura CE. Si deve prestare particolare attenzione, nella posa, ai raggi di curvatura imposti alla tubazione come richiesto dalla norma CEI 11-17 (art. 2.3.03).
Le tubazioni, al fine di consentire un agevole passaggio dei conduttori, devono presentare un diametro maggiorato del 30% rispetto al diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi, con un minimo di 20 mm. Le
tubazioni devono seguire percorsi perpendicolari od orizzontali evitando accuratamente percorsi obliqui nella
parete.
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 74
Tubazioni in vista
Le derivazioni d’impianto agli apparati utilizzatori posati nel controsoffitto, siano essi elettrici siano appartenenti agli impianti speciali, sono previste in tubo rigido posato a vista con gli appositi sostegni ferma tubo; il
grado di protezione minimo da rispettare è pari a IP 44, o secondo quanto previsto dai disegni di progetto.
Le tubazioni, che devono collegare la scatola di derivazione con l’utilizzatore finale, sono in materiale termoplastico a base di cloruro di polivinile (PVC), con resistenza allo schiacciamento pari a 750 N (serie pesante)
di tipo flessibile come definito nella norma CEI EN 50086-2-1, e devono essere dotate di marcatura CE; è
consentito l’impiego di appositi manicotti flessibili protetti (IP > 44).
Si deve prestare particolare attenzione, nella posa, ai raggi di curvatura imposti alla tubazione come richiesto
dalla norma CEI 11-17 (art. 2.3.03).
Le tubazioni, al fine di consentire un agevole passaggio dei conduttori, devono presentare un diametro maggiorato del 30% rispetto al diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi, con un minimo di 20 mm.
Cassette di derivazione
Tutte le canalizzazioni principali devono essere collegate tra di loro e con le canalizzazioni derivate, tramite
interposizione di idonee cassette di derivazione ispezionabili. Ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalla
struttura muraria dei locali, ad ogni derivazione da linea principale, o dorsale, a linea secondaria ed in ogni
locale servito, la tubazione deve essere interrotta con cassette di derivazione. Le scatole e le cassette di derivazione saranno dei seguenti tipi:
• cassette da incasso in materiale isolante con coperchio liscio a filo muro munite di viti di fissaggio,
da utilizzare per derivazioni e come rompitratta in tutti gli impianti incassati in pareti tradizionali; per
scatole di dimensione superiore a 196x162x70 mm devono essere dotabili di separatori per la suddivisione di circuiti a tensione diversa;
• cassette per posa a parete da esterno per tubi rigidi di industriale in PVC pesante antiurto con bordi
rinforzati con coperchio fissato con viti, munite di pressatubi o passacavi agli imbocchi con grado di
protezione minimo IP 44;
• tipo per canale a vista, in resina stampata con coperchio fissato con viti, in tutti quei casi in cui
l’impianto sarà eseguito a vista, con grado di protezione minimo pari a IP 40.
Per agevolare il riconoscimento dell’utenza servita dalla cassetta di derivazione, si deve provvedere ad identificare e codificare la stessa con opportuna targhetta di identificazione indicante la tipologia di impianto posata all’interno. La codifica assegnata dovrà essere riportata sul disegno AS-BUILT.
CAVI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA
Il collegamento fra la fonte di alimentazione, in questo caso il quadro elettrico di zona o di reparto, è realizzato con conduttori in rame con caratteristiche di isolamento diverse a seconda dell’impiego. Tutti i cavi elettrici impiegati nella realizzazione degli impianti elettrici dovranno essere rispondenti alle norme di riferimento
sopraccitate e dovranno portare impresso sul rivestimento il marchio IMQ attestante le caratteristiche costruttive e il superamento delle prove relative alle norme di seguito citate.
I circuiti sono dimensionati considerando le massime cadute di tensione ammesse e il coordinamento con le
protezioni contro i sovraccarichi ed i corto circuiti. La sezione dei conduttori adottati è stata determinata sulla
base delle correnti convenzionali di impiego, ricavate sulla base delle tabelle dei carichi precedentemente riportate, dei fattori di potenza ipotizzati e dei coefficienti di riduzione dipendenti dal tipo di posa, dalla temperatura ambiente e dalla temperatura massima che può raggiungere il cavo senza che vi siano danneggiamenti dell’isolante stesso, secondo i dettami delle UNEL 35024 e IEC 448. Il dimensionamento, è stato eseguito considerando un aumento della potenza disponibile all’utenza pari a circa il 10% rispetto alle potenze
sopra indicate.
Per tensioni fino a 400 V i cavi e conduttori avranno una tensione nominale Uo/U non inferiore a 450/750 V.
I cavi posati in vista, aerei, volanti, in cunicoli o condotto, su passerella, saranno provvisti di guaina esterna
di protezione.
Se non diversamente indicato i cavi o conduttori avranno le seguenti sezioni minime:
• cavi per montanti di distribuzione: 4 mm2;
• cavi potenza in genere: 2,5 mm2;
• cavi per comando e illuminazione: 1,5 mm2;
• conduttore di protezione (PE) separato da conduttore di fase: 16 mm2;
• conduttore di protezione per collegamenti equipotenziali: 6 mm2.
Cavi e conduttori di bassa tensione
Salvo diversa prescrizione degli elaborati progettuali, tenuto conto delle condizioni di posa (norma CEI 11__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 75
17) che prevedono sempre una protezione meccanica del cavo costituita da tubo o canaletta, è prevista
l’installazione di cavi per energia isolati (con o senza guaina) in gomma e in PVC nelle seguenti composizioni:
a) Cavi unipolari in rame, flessibili, isolati con PVC di qualità R2, tensione nominale Uo/U: 450/750V, di
tipo non propagante la fiamma ed a bassa emissione di gas corrosivi, rispondenti ai requisiti delle
norme CEI 20-22/2, 20-35 20-37/2 e tabelle CEI-UNEL 35375/35376/35377, da impiegare per le linee di distribuzione secondarie di energia derivate dai quadri elettrici per l’alimentazione dei circuiti
di illuminazione di sicurezza e cablaggi dei quadri elettrici.
b) Cavi uni/multipolari flessibili in rame ricotto stagnato con barriera ignifuga isolati con elastomero reticolato di qualità HEPR, tipo FG7(O)R/4 di tipo non propagante la fiamma, a ridotta emissione di gas
corrosivi, perciò rispondenti alle norme CEI 20-22/2, 20-35, 20-37, e secondo tabella CEI- UNEL
35368; l’impiego di tali cavi è previsto per le alimentazioni principali, per i servizi tecnologici e per i
circuiti isolati.
c) Cavi uni/multipolari flessibili in rame ricotto stagnato con barriera ignifuga isolati con elastomero reticolato di qualità HEPR, tipo FG7(O)M1 di tipo non propagante l’incendio a basso sviluppo di fumi e
gas corrosivi, perciò rispondenti alle norme CEI 20-22/2, 20-35, 20-37, 20-38, e secondo tabella CEIUNEL 35368; l’impiego di tali cavi è previsto per le alimentazioni principali, per i servizi tecnologici e
per i circuiti isolati.
d) Cavi uni/multipolari flessibili in rame ricotto stagnato con barriera ignifuga isolati con elastomero reticolato di qualità G10, tipo FTG710(O)Ml di tipo resistente all’incendio non propagante l’incendio a
basso sviluppo di fumi e gas corrosivi, perciò rispondenti alle norme CEI 20-22/2, 20-35, 20-36, 2037, 20-38, e secondo tabella CEI-UNEL 35368; l’impiego di tali cavi è previsto per le alimentazioni
principali, per i servizi tecnologici e per i circuiti isolati.
Devono essere installati cavi aventi portata adeguata all’uso a cui sono destinati (in particolare secondo le
indicazioni delle tabelle UNEL inerenti), tenuto conto della temperatura dell’ambiente di posa (usualmente
30°C), della caduta di tensione globale ammissibile e del numero di conduttori/cavi attivi posati all’interno
dello stesso tubo/canala. Inoltre la sezione di ogni cavo deve essere coordinata, secondo le disposizioni delle
norme CEI64-8, all’organo di protezione corrispondente.
In ogni caso la caduta di tensione dovrà essere inferiore a quella fissata dalle Norme CEI.
La colorazione delle guaine dei cavi e dei conduttori deve rispondente alla norma CEI 64-8:2003-05.
I terminali di partenza e di arrivo di ogni cavo devono essere opportunamente numerati ed identificati in
modo univoco, secondo quanto specificato dalle norme CEI 16-1 e 16-4.
Per gli impianti di segnalazione realizzati con sistema a bassissima tensione (categoria -0- SELV) tutti i conduttori che seguiranno un percorso indipendente dai conduttori di alimentazione saranno isolati in polietilene
reticolato non propagante l’incendio (CEI 20-22) con tensione di esercizio 300/500V; in caso contrario dovranno avere identica classe di isolamento dei conduttori facenti parte dell’impianto in categoria 1.
I conduttori facenti parte di impianti di segnalazione con sistema categoria -0- SELV-PELV dovranno avere
caratteristiche identiche ai conduttori dei circuiti in categoria -1-.
Modalità di installazione delle linee elettriche
Tutti i cavi ed i conduttori devono essere posti in opera a regola d’arte, nel rispetto delle normative di riferimento a secondo quanto indicato nella presente specifica e nella descrizione degli impianti.
I cavi da posare nelle canale devono essere posati in modo ordinato, ed affiancati, in modo da formare un
semplice strato; qualora per ragioni di ingombri non sia possibile adottare il semplice strato, è ammesso il
doppio strato a condizione che il coefficiente di contenimento della canala e/o passerella risulti uguale a
quanto prescritto all’art. 7.1.
I cavi da posare nei tratti verticali devono essere fissati alle canale e/o passerelle a mezzo di legature tipo
Colson e le stesse devono essere provviste di coperchio.
Lungo tutto il percorso, i cavi devono essere identificati con opportune targhette in PVC, indicante il numero
di cavo, il tipo di impianto ecc.
Deve essere garantita un’agevole rimozione dei cavi e conduttori, a tale scopo il raggio di curvatura dei tubi
e dei condotti dovrà essere tale da soddisfare le prescrizioni per le curvature dei cavi indicato nella norma
CEI 11-17 (Art. 2.3.03).
Morsetti di connessione
Le connessioni elettriche fra i circuiti di distribuzione ed i circuiti utilizzatori devono essere effettuate
all’interno delle cassette di derivazione descritte all’art. 7.4 ed eseguite con appositi dispositivi di connessione aventi grado di protezione minimo IP 20, quindi non sono ammesse giunzioni e/o derivazioni eseguite con
semplice attorcigliamento e nastratura. E’ altresì vietato eseguire giunzioni all’interno delle canalizzazioni.
Per raggiungere lo scopo prefissato è previsto l’impiego di morsetti volanti, conformi alle norme CEI 23-20 e
23-21, costruiti in policarbonato autoestinguente V0, dotati di elevata resistenza meccanica, resistenza al ca__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 76
lore (130°C), resistenza alla fiamma ed all’accensione, idoneità alla prova del filo incandescente a 850°C, elevata rigidità dielettrica. Il materiale di contatto deve essere realizzato in ottone OT58, viti o grani di ferro
zincato.
APPARECCHI DI COMANDO E PRESE ELETTRICHE
Tutti gli apparecchi di comando e le prese di corrente previste nel realizzazione del complesso si possono dividere in due grandi famiglie, la prima di tipo definito civile, la seconda definito di tipo industriale, grado di
protezione minimo IP44, a sua volta la prima famiglia si può suddividere in altre due sottofamiglie, con grado
di protezione minimo IP40 la prima, e di tipo protetto la seconda cioè con grado di protezione minimo IP44.
L’installazione della serie civile non protetta è prevista in tutti quei locali dove non è prevista la presenza eccessiva di polveri o umidità, ad esempio le camere di degenza gli uffici e locali similari; tale serie è costituita,
sia per gli apparecchi di comando sia per le prese, da apparecchio di tipo modulare componibile, delle dimensioni indicative di 20x45 mm, installato su supporto in resina, con vite, di tipo modulare per tre apparecchi installato su scatola da incasso in resina.
A finitura dell’apparecchio deve essere installata la placca, di colore a scelta della Direzione Lavori, del tipo in
resina a scatto. Per i locali soggetti al facile accumulo di polveri e/o ad un elevato grado di umidità, o a
spruzzi di acqua, è previsto l’impiego di apparecchi protetti, grado di protezione minimo IP55; tale realizzazione prevede l’impiego dei medesimi apparecchi prima descritti, ma installati su placca in resina di tipo autoportante, con sportello di chiusura e membrana plastica trasparente, dotata di guarnizione in grado di garantire il grado di protezione richiesto. La placca autoportante, a tre moduli, è destinata all’installazione su
scatola di incasso.
Nei casi in cui sia previsto un impiego gravoso delle prese elettriche è previsto l’impiego di prese di corrente
di tipo industriale con grado di protezione minimo IP55. Queste sono installate a semi incasso, incassando la
parte fissa del corpo della presa.
In considerazione che si tratta di un completamento delle opere di ristrutturazione già avviate con le sale
operatorie 5 e 6 tutti gli apparecchi di comando dovranno essere di tipo omogeneo a quanto già installato
nell’area ristrutturata. Eventuali modifiche dovranno essere sottoposte all’approvazione sia della Direzione
dei Lavori sia dell’Ufficio tecnico.
Poiché è previsto che nel medesimo ambiente coesistano forme di energia diversa, ordinaria, preferenziale, e
continuità, le prese devono essere di tipo non intercambiabile (art. 710.55.3 norma CEI 64-8/7:2003-05). Per
evitare difficoltà di interconnessione fra le apparecchiature e le prese elettriche si adotterà una colorazione
delle prese in accordo con la Direzione Tecnica dell’Ospedale.
Tutti gli apparecchi devono avere la marcatura CE ed il marchio IMQ e non devono costituire pericolo
d’innesco o di propagazione dell’incendio.
Apparecchi di comando
Gli apparecchi di comando, quali interruttori, deviatori, pulsanti e similari, devono appartenere a serie civili di
tipo modulare componibile delle dimensioni, indicative di 20x45 mm, installatali su supporto modulare a tre
posti in resina da posare su scatola da incasso, idonea al contenimento fino a tre apparecchi.
L’apparecchio deve avere comando basculante bilanciato idoneo al comando di carichi ohmico/induttivi, con i
seguenti dati elettrici:
• tensione nominale 250 V 50 Hz;
• corrente nominale 16°;
• resistenza d’isolamento > 5 M(l; rigidità dielettrica 2.000 V; vita elettrica minima, in condizioni di uso
normale, pari a circa 40.000 manovre;
• morsetti posizionati a tergo;
• sezione massima dei conduttori allacciabili 2x4 mm2.
L’apparecchio di comando deve essere installato ad altezza di 90 cm da quota del pavimento finito, e, se unipolare, deve interrompere la fase di alimentazione dell’utilizzatore; non è ammessa l’interruzione del neutro
se non tramite l’impiego di interruttori bipolari.
Prese di corrente
Le prese elettriche per il prelievo di energia, sia con corrente nominale da 10° sia con corrente nominale da
16°, per uniformità con gli apparecchi di comando, devono appartenere a serie civili di tipo modulare componibile delle dimensioni, indicative di 20x45 mm, installabili su supporto modulare a tre posti in resina da
posare su scatola da incasso, idonea al contenimento fino a tre apparecchi.
Tutte le prese, salvo quanto diversamente indicato nelle tavole di progetto, sono del tipo ad alveoli allineati,
e devono possedere i seguenti dati elettrici:
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 77
• tensione nominale 250 V 50 Hz;
• corrente nominale 10° o 16°;
• alveoli attivi schermati -grado di protezione 2.1-;
• resistenza d’isolamento > 5 MH;
• rigidità dielettrica 2.000 V;
• vita elettrica minima, in condizioni di uso normale, pari a circa 5.000 manovre;
• morsetti posizionati a tergo;
• sezione massima dei conduttori allacciabili 2x4 mm2 ;
• alveoli elastici con priorità di contatto su alveolo o contatto di terra.
Le prese di corrente devono essere installate ad altezza di 30 cm da quota del pavimento finito; le prese elettriche installate in prossimità dei lavabi o in presenza di banchi di lavoro devono essere installate ad altezza di 110 cm nella medesima scatola dell’apparecchio di comando; le prese elettriche destinate ad alimentare
gli apparecchi televisivi nelle camere di degenza devono essere installate al altezza 250 cm; fatta salva diversa prescrizione riportata sulla tavola di progetto.
Prese di corrente per uso industriale
Le prese di corrente da impiegare per carichi elevati, prossimi a 16° o superiori, sono di tipo CEE monofase o
trifase rispondenti alle norme CEIEN 60309-le CEIEN 60309-2.
Le prese sono complete di interruttore di blocco (atto a permettere l’inserimento ed il disinserimento della
spina solo in mancanza di tensione nella presa), con a corredo dell’interruttore di blocco.
Presa, interruttore di blocco e organo di protezione sono installati entro custodie di materiale termoplastico
autoestinguente di tipo sporgente, complete di coperchio di protezione a molla con ghiera e pressatubo.
Le prese di corrente interbloccate devono rispondere ai seguenti requisiti elettrici:
• impossibilità di accoppiare prese e spine con differenti caratteristiche nominali di impiego - corrente,
tensione, frequenza;
• correnti nominali pari a 16°, 32°, 63° e 125°;
• numero dei poli 2P+T, 3P+T, 3P+N+T;
• grado di protezione IP44, prese con coperchio a molla spine senza ghiera;
• grado di protezione IP55, prese con coperchio a molla con ghiera, IP67 prese e spine con ghiera;
• materiale isolante termoplastico resistenza al filo incandescente a 850°C per le prese fino 32 A, materiale isolante in termoplastico con resistenza al filo incandescente a 960°C per portate superiori a
32 A;
• interblocco con manovra di chiusura dell’interruttore possibile solamente a spina inserita e coperchio
chiuso, estrazione della spina solo a interruttore aperto; interruttore conforme alle norme CEI EN
60947-3; basi portafusibili per cartucce a tappo tipo D.
APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
L’illuminazione naturale dei locali è integrata dall’illuminazione artificiale, che è impiegata quando quella naturale non è sufficiente a garantire un buon confort visivo all’interno del locale.
L’illuminazione artificiale è di tipo generale, apparecchi a soffitto, o di tipo locale, apparecchi su lavabi.
L’illuminazione generale è ottenuta con apparecchi illuminanti, da esterno o da controsoffitto, dotati di lampada fluorescente che permette una buona illuminazione con bassi costi energetici in considerazione
dell’elevato tempo di accensione dell’apparecchio.
Altra suddivisione che si presenta nell’impiego degli apparecchi illuminanti è dovuta alla classificazione del
locale, infatti è previsto l’impiego di apparecchi con grado di protezione minimo IP 40 nei locali destinati a
corridoi, nelle camere di degenza e simili, IP 65 nei locali destinati a depositi o locali umidi, ed IP 65 di tipo
asettico nei locali sale operatorie, anestesia e risveglio. Gli apparecchi illuminanti destinati all’impiego nei locali che non richiedono un particolare grado di protezione sono scelti fra quelli con schermo lamellare di alluminio. Nei corridoi, dove l’unico orizzonte del paziente è il soffitto, per evitare l’effetto flicker, è previsto
l’impiego di apparecchi dove no sia possibile la visione diretta della fonte luminosa.
La posizione e la tipologia degli apparecchi illuminanti da impiegare nella realizzazione dell’opera sono riportati nelle tavole di progetto.
Tutti gli apparecchi si intendono completi di ogni accessorio elettrico di funzionamento e meccanico di fissaggio quali: lampade, starter a basse perdite, fusibile di protezione, reattore di tipo elettronico, morsettiera
d’ingresso, staffe, tiranti, ed ogni altro accessori d’installazione; tali devono avere approvazione EVIQ di rispondenza alle norme CEI, certificazione di conformità europea ENEC e marcatura CE.
Per la determinazione del numero degli apparecchi illuminanti, della relativa tonalità di colore delle lampade
e della resa di colore, sono presi a base di calcolo i dati caratteristici indicati dalle norme EN 12464-1:2002
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 78
con particolare riferimento ai valori dell’illuminamento medio su un piano a 0,8 m dal suolo.
I coefficienti di riflessione degli ambienti, riferiti alle condizioni locali, considerati nell’elaborazione computerizzata dei valori dell’illuminamento medio sono in linea di massima: soffitti 60%; pareti 40%; posto di lavoro
20%. I valori di illuminamento medio di esercizio da raggiungere sono quelli riportati, come valore centrale,
nel prospetto I delle norme EN 12464-1:2002; il coordinamento effettuato tra il valore dell’illuminamento
medio di esercizio ed il compito visivo si riferisce a persone con capacità visive normali.
I valori di illuminamento medio di esercizio calcolati tengono conto di un fattore di deprezzamento relativo
all’invecchiamento ed all’insudiciamento dei materiali pari a 0,8; tale coefficiente corrisponde ad una manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione. Per ciò che riguarda la qualità della luce emessa dalla lampada si è previsto l’impiego di lampade con temperatura di colore minore di 3.300 K; e con indice di resa
cromatica, Ra, in conformità all’art. 5. Sempre in applicazione dell’art. 5 si è prestato attenzione a rispondere
al limite del grado unificato di abbagliamento fornito dal costruttore dell’apparecchio illuminante.
Caratteristiche degli apparecchi
La descrizione delle caratteristiche elettriche degli apparecchi illuminanti, per illuminazione generale, è valida
sia per apparecchi a plafone sia per apparecchi da incasso.
Apparecchi con ottica in alluminio satinata rigata
Apparecchio con corpo in lamiera di acciaio verniciata ad immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, previo trattamento di fosfatizzazione; portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso; ottica
in alluminio satinato anodizzato, spessore 2\a, a bassa luminanza con traversini rigati, fissaggio a scatto con
cordine anticaduta; cablaggio per alimentazione 220V/50Hz con cavo in rame isolato in PVC-HT, morsettiera
2P+T con fusibile 6.3°; grado di protezione IP 20. Installazione nei locali ad uso generico, locali comuni e
corridoi.
Apparecchi a luce schermata
Apparecchio con corpo in lamiera di acciaio verniciata con polvere in poliestere colore bianco antingiallimento, previo trattamento di fosfatizzazione; portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso; riflettore in alluminio bianco opaco, antiriflesso a bassa luminanza; diffusore con lastra microforata di acciaio
completo di lastra opale in plexiglass antiabbagliamento; cablaggio per alimentazione 220V/50Hz con cavo in
rame isolato in PVC-HT, morsettiera 2P+T con fusibile 6.3°; grado di protezione IP 40. Installazione corridoio
pulito.
Apparecchi stagni IP > 44
Apparecchio con corpo in policarbonato infrangibile autoestinguente; riflettore in acciaio laminato a freddo,
zincato a caldo; diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato internamente;
portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso; cablaggio per alimentazione 220V/50Hz con
cavo in rame isolato in PVC-HT, morsettiera 2P+T con fusibile 3,15 A; grado di protezione IP65. Installazione
in locali umidi quali, nei depositi, sterilizzazione e locali similari.
Apparecchi per ambienti asettici
Apparecchio con corpo in lamiera di acciaio verniciata per anaforesi acrilica, colore bianco stabilizzato ai raggi UV; portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso; ottica lamellare in alluminio satinato anodizzato, spessore 2|i, a bassa luminanza, vetro di protezione temperato spessore 4 mm; cornice portavetro in alluminio estruso verniciata per anaforesi acrilica, colore bianco; cablaggio per alimentazione
220V/50Hz con cavo in rame isolato in PVC-HT, morsettiera 2P+T; grado di protezione IP 65.
Installazione nei locali sala operatoria, anestesia e risveglio.
Apparecchio compatto per controsoffitto
Apparecchio per illuminazione costituito da: corpo in lamiera d’acciaio stampato; riflettore in policarbonato
metallizzato con polveri di alluminio purissimo in alto vuoto, con prismatura sfaccettata per un elevato rendimento luminoso; diffusore in vetro; portalampada in policarbonato; cablaggio per alimentazione
220V/50Hz con cavo in rame isolato in PVC-HT, morsettiera 2P+T; grado di protezione IP 43. Installazione
deposito.
APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
Nei locali, lungo i corridoi e sulle uscite l’illuminazione di sicurezza è ottenuta mediante l’installazione di lampade autoalimentate del tipo S.E. (solo emergenza) o del tipo S.A. (sempre accesa). Tutti i componenti di
nuova installazione dovranno essere compatibili con la centrale di controllo; infatti per una razionale manutenzione degli apparecchi di emergenza e sicurezza è prevista l’installazione di una centrale che sia in grado,
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 79
dialogando con i singoli apparecchi, di eseguire dei test periodici funzionali e di autonomia.
La ricarica del dispositivo di alimentazione dell’apparecchio, avviene tramite la tensione di rete e da una linea
autonoma; gli apparecchi sono in numero e potenza tali da garantire una facile individuazione delle vie di
esodo; la sorgente di energia interna al corpo illuminante è ottenuta con accumulatori ermetici in grado di
garantire alle lampade del circuito di illuminazione di emergenza una autonomia di circa due ore.
In genere sono installati apparecchi illuminanti autonomi in tutti i percorsi di esodo e nei locali tecnici. Tutti
gli apparecchi devono essere dotati in origine di dispositivo elettronico in grado di verificare costantemente
l’efficienza dell’apparecchio e comunicarne i dati, a mezzo di linea di segnalazione distinta, ad apparecchi di
supervisione secondari ed all’apparecchio di supervisione generale; il sistema di controllo della illuminazione
di sicurezza basato su microprocessore, sarà in grado di gestire le segnalazioni di anomalia, le fasi di carica e
scarica periodica, controllare ed abilitare le funzioni di illuminazione ordinaria ed emergenza, interagire con
gli altri sistemi di supervisione; dovrà inoltre fornire segnalazione delle varie fasi a mezzo di segnalatori ottici, ed a richiesta o periodicamente fornire lo stato generale o parziale dell’impianto su supporto cartaceo;
dovrà essere comunque garantita la normale funzione di accensione in black out totale in caso di blocco della centrale di gestione.
Come accennato il sistema dovrà operare su linea indipendente da quella di alimentazione, utilizzando reti
che consentano comunque facilità di ampliamento e modifica. L’architettura della rete deve essere divisa in
zone, mentre le singole plafoniere devono essere identificabili singolarmente. La posizione e la tipologia degli
apparecchi illuminanti da impiegare nella realizzazione dell’opera sono riportati nelle tavole di progetto. Tutti
gli apparecchi si intendono completi di ogni accessorio elettrico di funzionamento e meccanico di fissaggio
quali: lampade, starter a basse perdite, fusibile di protezione, reattore, morsettiera d’ingresso, staffe, tiranti,
ed ogni altro accessori d’installazione.
Gli apparecchi devono avere approvazione IMQ di rispondenza alle norme CEI e certificazione di conformità
europea ENEC.
Caratteristiche degli apparecchi
Apparecchi per illuminazione di sicurezza
L’illuminazione permanente delle vie di uscita è realizzata con apparecchi con custodia in materiale plastico
autoestinguente 94V2, a doppio isolamento, con grado di protezione IP40/65, completo di lampada con flusso luminoso emesso pari a 400 lumen, dispositivo per autodiagnosi con supervisione centralizzata, dotati di
modo riposo (CEI EN 60598-2-22), alimentazione 230V 50 Hz, ricarica completa in dodici ore, autonomia minima pari a due ore. Compreso l’idoneo pittogramma indicante la via d’esodo.
L’illuminazione non permanente degli ambienti comuni realizzata con apparecchi con custodia in materiale
plastico autoestinguente 94V2, a doppio isolamento, con grado di protezione IP 40/65, dispositivo per autodiagnosi con supervisione centralizzata, dotati di modo riposo (CEI EN 60598-2-22), alimentazione 230V 50
Hz, ricarica completa in dodici ore, autonomia minima pari a due ore, visibilità pari a 32 m.
IMPIANTO DI PROTEZIONE ED EQUIPOTENZIALIZZAZIONE
L’intervento consiste nella realizzazione dell’impianto di protezione contro i contatti indiretti nei locali non adibiti ad uso medico e nell’equalizzazione del potenziale nei locali ad uso medico di tutte le parti metalliche
accessibili degli apparecchi, dei quadri e delle altre parti dell’impianto elettrico, non appartenenti a circuiti a
bassissima tensione di sicurezza. La protezione è attuata mediante messa a terra delle parti metalliche accessibili o con isolamento speciale.
Il collegamento all’impianto di terra deve essere realizzato mediante appositi conduttori di protezione (PE). Il
conduttore di protezione deve essere separato dal conduttore di neutro.
La protezione contro i contatti indiretti, trattandosi di sistema TN-S è generalmente assicurata nel sistema di
distribuzione principale (dai quadri principali ai quadri di zona) dal coordinamento interruttore di protezione
(magnetotermico, o magnetotermico differenziale) ed impedenza di guasto in modo tale da assicurare la
tempestiva interruzione del circuito guasto se la tensione di contatto assume valori pericolosi, superiori a
quelli previsti nelle norme di riferimento secondo la relazione la < Zs /U0 dove Zs è l’impedenza dell’anello di
guasto la è la corrente di intervento dell’interruttore secondo le norme CEI 64-8 (Sistemi TN) U0 è la tensione nominale in valore efficace tra fase e terra (in ambiente ospedaliero non deve superare 25 V).
La distribuzione delle terre nelle aree oggetto di intervento è sintetizzabile in: conduttori secondari di terra
realizzati con corda in rame e guaina in PVC giallo/verde per l’allacciamento dei singoli quadri con il conduttore principale di terra; distribuzione del conduttore di protezione realizzata con corda di rame da 16 mm2
posata all’interno delle canale.
Le giunzioni dei vari conduttori di terra devono essere realizzate con giunti a compressione con ampia superficie di contatto posti in opera con apposita pinza.
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 80
Conduttore di protezione
Conduttore prescritto per il collegamento al nodo, o collettore principale, delle parti che in caso di anomalia
possono procurare contatti indiretti quali: masse, masse estranee, collettori secondari. La sezione del conduttore di protezione deve rispondere a quanto prescritto dalla norma CEI 64-8/5:2003-05 art. 543.1.
I conduttori di protezione devono essere protetti contro il danneggiamento meccanico, chimico e contro le
sollecitazioni elettrodinamiche; le connessioni devono essere accessibili per ispezioni e prove; sui conduttori
di protezione non devono essere interposti organi di interruzione, ma possono essere installati dispositivi apribili con attrezzo ai fini delle verifiche; le masse dei componenti non devono costituire tratti del conduttore
di protezione, in particolare non è ammesso il ponticello fra infissi.
Collettore o nodo di terra
E’ l’elemento previsto il collegamento per il collegamento al dispersore dei conduttori di protezione, inclusi i
conduttori equipotenziali e di terra.
Il collettore è costituito dalla barra di rame installata all’interno del quadro generale di reparto, nel caso esista la necessità di collettori secondari, derivati dal precedente, questi devono essere alloggiati all’interno di
cassette di derivazione predisposte per lo scopo.
Conduttori equipotenziali
E’ il conduttore di protezione destinato ad assicurare il collegamento equipotenziale tra diverse masse e
masse estranee in modo da portarle allo stesso potenziale.
I conduttori equipotenziali principali, o supplementari, devono rispondere alle prescrizioni riportate agli artt.
547.1.1 e 547.1.2 delle norme CEI 64-8/5:2003-05.
Equalizzazione del potenziale
Nei locali dove il paziente è più esposto al pericolo di microschok, deve essere realizzato l’impianto di equalizzazione del potenziale di tutte le masse e masse estranee presenti nel locale, che in qualunque condizione
d’uso si trovino ad un’altezza inferiore a 2,5 m dal piano di calpestio.
Questo impianto deve essere realizzato con installazione di una cassetta di derivazione da semi incasso con
coperchio trasparente al cui interno deve essere collocata la barra di rame, installata su appositi isolatori.
A questa sono attestati i conduttori equipotenziali delle masse e masse estranee. Le masse devono essere
collegate al nodo con conduttore in rame isolato in PVC di qualità N07V-K avente sezione minima pari a 2,5
mm2 ; le masse estranee devono essere collegate al nodo con conduttore in rame isolato in PVC di qualità
N07V-K avente sezione minima pari a 6 mm2. I conduttori equipotenziali devono essere provvisti di connettori ad occhiello di tipo preisolato pressati all’anima del conduttore e collegati sulla barra di rame con bullone,
dado e rondella anti allentamento.
Inoltre tutti i conduttori devono essere chiaramente identificati alle due estremità, quindi sia sulla massa sia
sul nodo, con fascette segnafilo riportanti l’identificazione univoca del collegamento; quest’ultima deve essere poi riportata sul disegno esecutivo.
Ad impianto eseguito in tutti i locali di gruppo 2, così come richiamati nella norma CEI 64-8/7:2003-05, deve
essere eseguita la verifica della continuità dei conduttori.
IMPIANTI SPECIALI ED A BASSISSIMA TENSIONE
La predisposizione degli altri impianti prevede la realizzazione di tutte le canalizzazioni necessarie al collegamento dei punti utilizzatori con le montanti poste nei cavedi verticali posizionati nel corpo scale sia a Nord sia
a Sud dell’edificio.
Questa è realizzata seguendo le prescrizioni generali indicate all’art. 7 “Tubazioni e canali portacavi”. La posizione degli utilizzatori componenti gli impianti sono riportate sulle tavole di progetto.
Impianto cablaggio strutturato
L’impianto di comunicazione e trasmissione dati è realizzato come cablaggio strutturato quindi ogni singola
presa terminale, secondo il collegamento eseguito nell’armadio, può essere ugualmente utilizzata sia per la
fonia sia per la trasmissione dati.
L’impianto prevede la realizzazione delle canalizzazioni di collegamento, fra il punto di utilizzazione e
l’armadio concentratore è realizzato con canalizzazioni in PVC sotto traccia attestate a scatola da incasso per
apparecchi modulari componibili fino a tre moduli, all’interno del locale, e con cassetta di derivazione collegata alla canala in PVC posizionata nel corridoio. La scatola porta apparecchio deve essere completata con
supporto in resina, tasti copriforo, frutto RJ45 e placca di finitura in resina con colore a scelta della direzione
dei lavori.
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 81
La rete cavi è costituita con cavo per trasmissione dati ad alta velocità per frequenze fino a 100 MHz, nei sistemi di cablaggio strutturato degli edifici. Il cavo è costituito da conduttore a 4 coppie twistate a filo unico
con isolante in polietilene; la guaina esterna è in termoplastico a bassa emissione di alogeni.
Apparati
Armadio di distribuzione rack 19” a pavimento
L’armadio è formato da una struttura metallica con zoccolo H 100 mm, porta in vetro temperato completa di
serratura con chiave, coppia di montanti rack 19”, ed è dimensionato per garantire un’espansione minima
del 50% per numero di prese di telecomunicazione e numero di porte degli apparati di rete. La fornitura
comprende:
• posizionamento e montaggio meccanico dell’armadio;
• accessori vari di complemento;
• ogni onere ed accessorio per l’esecuzione del lavoro a regola d’arte.
Patch panel con prese RJ45 per cablaggio orizzontale
Patch panel 1 unità, con 24 prese RJ45 UTP cat. 5° Enhanced (tipo AMP 406330-1) per la terminazione dei
cavi UTP del cablaggio orizzontale, completo di dadi e viti a gabbia per il fissaggio ai montanti rack 19” e
comprensivo del montaggio meccanico all’interno dell’armadio di distribuzione.
Patch panel per cablaggio ottico di dorsale
Patch panel 1 unità (tipo AMP 1206138-8) con 12 posizioni vuote per bussole SC Duplex, per la terminazione
dei cavi ottici relativi al cablaggio di dorsale, completo di dadi e viti a gabbia per il fissaggio ai montanti rack
19” e comprensivo del montaggio meccanico all’interno dell’armadio di distribuzione.
Connettore ottico SC duplex con bussola da pannello
Connettore ottico SC Duplex per Fibra Ottica multimodale, per la terminazione dei cavi ottici relativi al cablaggio di dorsale, composto da due connettori SC (tipo AMP 503692-1) ed una bussola SC Duplex da pannello (tipo AMP 504640-1) e comprensivo di: terminazione di due Fibre Ottiche multimodali sui connettori;
certificazione del Link Ottico con Power meter per verificarne la rispondenza alla norma EN50173 Link ottico;
stampa, per ogni link UTP, del report di tutte le misure effettuate dal reflettometro, con evidenziata la conformità alla norma sopracitata.
Pannello di alimentazione elettrico
Pannello di alimentazione elettrica rack 19”, con sei prese UNEL ed interruttore luminoso, completo di dadi e
viti a gabbia per il fissaggio ai montanti rack 19” e comprensivo del montaggio meccanico all’interno
dell’armadio di distribuzione.
Posto di lavoro fonia/dati
Posto di lavoro fonia/dati, composto da una o più prese di telecomunicazione RJ45 cat. 5° Enhanced (presa
RJ45 tipo AMP 406372-1 e placca 503 autoportante AMP), esclusa la fornitura e posa del cavo UTP e comprensiva di:
• terminazione dei cavi UTP sulle prese di telecomunicazione e sul patch panel all’interno dell’armadio
di distribuzione;
• etichettatura delle prese di telecomunicazione e del pannello precaricato all’interno dell’armadio di
distribuzione;
• certificazione di ogni link UTP con reflettometro in base alla norma EN50173 Link Classe D;
• stampa, per ogni link UTP, del report di tutte le misure effettuate dal reflettometro, con evidenziata
la conformità alla norma sopracitata;
• accessori di montaggio, esclusa la fornitura della scatola 503.
Impianto Interfonico
L’impianto consente il collegamento tra un punto di chiamata esterno ed un punto di chiamata interno. La
stazione esterna, posizionata di norma nel corridoio pulito, può essere installata a filo muro e permette di selezionare tutti gli utenti del sistema e di accedere a tutte le sue funzioni. Il pannello frontale in alluminio anodizzato è dotato, oltre al LED indicante comunicazione in corso, del commutatore “Private/Open” per la
scelta del segreto di conversazione o meno. La stazione è dotata di microfono electrect che si adatta automaticamente al livello audio dell’ambiente.
La stazione interna, posizionata di norma nell’ambiente controllato, è del tipo per installazione ad incasso. La
stazione interna vista la necessità di asetticità dell’ambiente deve avere caratteristiche idonee ad un impiego
in sale operatorie o in ambienti sterili, in particolare la superficie esterna dovrà essere priva di porosità ed
impermeabile per una facile pulizia.
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 82
Postazione esterna
Costituito da scatola da incasso per il contenimento delle apparecchiature della stazione esterna.
Dimensioni della stazione circa mm 125x280x53.
La stazione è alimentata dalla centrale e collegata con cavi di tipo 22 AWG.
Campo di temperatura di funzionamento: da 0 °C a + 40 °C con umidità relativa compresa fra 10% e 85%.
Altoparlante 1w con impedenza di 63 ohm, banda di frequenza 300-5.000 Hz, livello di compressione suono
altoparlante 75 dB con cavo 0,5 mmq e lunghezza massima 100 m, tensione di uscita microfono 100-300 ,
preamplificatore microfonico impedenza uscita 600 Ohm.
Postazione interna
Costituito da scatola da incasso idonea al contenimento delle apparecchiature del posto interno. Frontale in
alluminio ricoperto da mylar, altoparlante e microfono protetti da schermi; microfono: 100/300 mV uscita, 65dBA, 1 kHz di sensibilità; altoparlante diam. 76 mm, 63 ohm, 1,6 w, sensibilità 88 dB; frequenza: banda
da 300 a 5.000 Hz; comandi: tasti ricoperti da mylar, tasti e LED per indicazione della chiamata,; collegamento con cavo tipo 22 AWG.
Canalizzazioni e linee
Per quanto è oggetto della realizzazione delle canalizzazioni e delle linee dell’impianto citofonico si fa riferimento a quanto prescritto agli artt. 7 e 8.
Impianto rivelazione fumi
E’ prevista la realizzazione dell’impianto di rilevazione incendi con l’inserimento di rilevatori di fumo automatici nei corridoi e nei locali non presidiati ed il loro collegamento con la centrale di allarme e supervisione esistente nel reparto di terapia intensiva, previa verifica della capienza.
La posa dei cavi di collegamento fra i vari apparati in campo e la centrale di allarme avverrà all’interno di canala metallica a griglia con setto separatore, per la distribuzione principale, ed in apposita canalizzazione per
quanto riguarda la derivazione all’apparato.
I sensori saranno dislocati a protezione di tutti gli ambienti a soffitto, fatta eccezione per i locali ove transitano all’interno del controsoffitto le canalizzazioni elettriche o siano presenti impianti con pericolo d’incendio
elevato: in tali locali è stata prevista l’installazione di rilevatori anche all’interno del controsoffitto.
All’interno delle canale di trattamento aria è prevista l’installazione di rivelatori, all’interno di apposite custodie, all’interno della canala, sia essa di mandata che di ripresa dell’aria trattata.
II numero e la posizione dei componenti dell’impianto è rilevabile dalle tavole di progetto e dallo schema
funzionale.
Le normative di installazione e progettazione a cui far riferimento sono dettate dalla norma UNI 9795 “Sistemi fissi automatici di rivelazione e segnalazione manuale d’incendio”, che prende come riferimento le indicazioni contenute nelle norme Europee EN 54 per i componenti dei sistemi. All’interno della norma UNI 9795
si esplicita come eseguire il dimensionamento di un sistema tenendo in considerazione molteplici parametri
quali: geometria dei locali, fattori ambientali a carattere variabile come ad esempio la presenza nei locali interessati di impianti per il trattamento dell’aria.
Il sistema di rivelazione automatica sarà composto dai seguenti componenti:
• centrale di rivelazione, gestione e segnalazione allarmi;
• stampante su carta per registrazione degli eventi;
• rivelatori automatici d’incendio;
• pulsanti di allarme;
• ripetitori ottici di allarme;
• targhe ottico-acustiche;
• sirene di allarme, elettromagneti per porte taglia fuoco alimentatori;
• linee di collegamento.
Il sistema di rivelazione incendio sarà del tipo analogico autoindirizzante al fine di garantire:
• identificazione puntuale del rivelatore;
• segnalazione di manutenzione sensore;
• continuità di servizio anche in caso di taglio e/o cortocircuito della linea, tramite loop ad anello con
isolatori; comando delle porte taglia fuoco, dispositivi di evacuazione fumi, targhe e sirene mediante
relè programmabili posti in campo.
I componenti in campo saranno collegati in linee ad anello (loop) a due conduttori con cavi non propaganti
la fiamma secondo la norma CEI20/22 II, contenuti in canale e/o tubazioni separate.
L’impianto sarà gestito da una centrale d’allarme, di tipo modulare per garantire che l’eventuale fuori servizio
di un area non pregiudichi il buon funzionamento del resto dell’impianto.
A tale scopo ogni linea ad anello sarà alimentata e gestita da propria scheda elettronica.
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 83
Centrale di allarme
La centrale è esistente del tipo a microprocessore. Dovrà essere verificata la capienza della centrale per
l’integrazione del loop esistente per le sale operatorie 5 e 6.
Rivelatore automatico
Il rivelatore da abbinare alla centrale descritta dovrà essere del tipo definito “intelligente” cioè dovrà essere
in grado di autoindirizzarsi secondo i canoni standard di comunicazione con la centrale. Dovrà essere in grado di trasmettere messaggi “finiti” quali: fumo, allarme calore, guasto, richiesta manutenzione ecc.
La presenza del microprocessore farà si che dal rivelatore si possano ottenere prestazioni superiori a quelli
“standard” come ad esempio: rivelazioni combinate con più tecnologie all’interno dello stesso rivelatore, autoindirizzamento del punto di rivelazione, gestione di uscite programmabili in campo, memoria degli eventi
residente nel rivelatore.
Il rivelatore previsto è di tipo a tripla tecnologia, cioè incorporerà in un unico rivelatore le caratteristiche del
rivelatore ottico ad effetto Tyndall, del termovelocimetrico e del termostatico. Il rivelatore dovrà assimilare i
segnali provenienti dai tre sistemi di rivelazione in esso incorporati, li dovrà compensare alle condizioni ambientali e confrontare con le mappature tipiche residenti in memoria.
Le principali caratteristiche elettriche che dovrà presentare il rivelatore sono:
• indicatore di allarme (LED rosso);
• capacità di memoria di allarme e dati operativi;
• controllo automatico della sensibilità;
• tensione nominale di alimentazione (Vdc) 19V;
• assorbimento corrente a riposo 45 µA;
• assorbimento corrente in allarme impulsiva 9 mA;
• temperatura di esercizio da -20°C a + 70°C;
• grado di protezione IP40.
I rivelatori sopra descritti dovranno potere essere installati su zoccoli di tipo standard, su zoccoli con relè
programmabile, o su zoccoli con isolatore di loop. Gli zoccoli con relè programmabile si renderanno necessari
quando nel caso in cui si preveda l’attuazione di apparecchiature in campo, o nel caso di comando dei ripetitori ottici necessari all’identificazione dello stato di allarme di rivelatori non univocamente individuabili.
In osservanza del D.M.I. 18 settembre 2002 tutti i rivelatori installati in locali non sorvegliati ed in aree non
direttamente visibili, ad esempio nel corridoio all’interno del controsoffitto, fanno capo a dispositivi ottici di
allarme installati lungo i corridoi.
Le principali caratteristiche che distinguono il ripetitore ottico sono:
• tensione di alimentazione dal loop;
• assorbimento medio in allarme 150 \aA, LED quattro,;
• frequenza 1,5 Hz;
• tipo di connessione a morsettiera; materiale in ABS; colore bianco; dimensioni 82x82x27; grado di
protezione IP 50.
Pulsanti manuali di allarme
Ad integrazione dei rivelatori automatici d’incendio è previsto l’impiego dei pulsanti manuali di allarme idonei
a fornire alla centrale una segnalazione di assoluta emergenza incendio. Una volta rotto il vetro di protezione
il pulsante fornisce al sistema un segnale di allarme generale di massima priorità, anche questi dispositivi in
campo saranno del tipo ad autoindirizzamento.
Le principali caratteristiche che dovrà presentare sono:
• materiale di contenimento in ABS rosso RAL 3000;
• Tensione nominale di alimentazione (Vdc) 19V;
• assorbimento corrente a riposo 45 µiA;
• assorbimento corrente in allarme impulsiva 9 mA;
• temperatura di esercizio da -30°C a + 70°C;
• grado di protezione IP 42;
• led rosso di identificazione stato di allarme;
• copertura in vetro frangibile trasparente.
Targa ottico-acustica
La segnalazione di allarme incendio in corso ad ogni singola zona funzionale sarà dato da una targa di allarme incendio dotata di lampade ad incandescenza ed un buzzer piezoelettrico da 90 dB.
La linea di alimentazione della targa ottico acustica sarà del tipo resistente all’incendio così come previsto
dalle norme UNI 9795.
La targa presenterà i seguenti dati caratteristici:
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 84
•
•
•
•
•
•
materiale di costruzione polistirolo metacrilato;
tensione di alimentazione 12 o 24 Vdc;
assorbimento in allarme 75 mA a 24 V;
grado di protezione IP 54;
buzzer 90 dB ad 1 m;
5 LED ad alta luminosità.
Alimentatore 24 Vdc
Per l’alimentazione degli apparati in campo quali elettromagneti, attuatori elettrici degli infissi di evacuazione
dei fumi e simili, è previsto l’impiego di alimentatori soccorritori separati per ogni singolo piano, questo al fine di diminuire gli eventuali disservizi.
Ogni alimentatore, della capacità riportata nelle singole tavole, dovrà rispondere ai seguenti requisiti minimi:
• tensione primaria 230 Vac;
• tensione secondaria 27,5 Vdc;
• corrente nominale di uscita secondo la richiesta del carico;
• protezione di corto circuito;
• protezione da sovratemperatura;
• batteria di auto alimentazione.
Transponder
II transponder non è altro che l’interfaccia fra la centrale ed i vari apparati in campo: infatti il transponder
previsto è un concentratore a dodici uscite relè liberamente programmabili e sarà installato sulla medesima
linea loop ad anello dei rivelatori. Il microprocessore installato sul transponder autoindirizzerà l’unità stessa
secondo le logiche standard della centrale.
Dati caratteristici a cui dovrà rispondere la fornitura sono:
• tensione di alimentazione del loop 19 Vdc;
• 12 relè programmabili NA o NC;
• assorbimento a riposo 50 µA;
• temperatura di funzionamento da -20°C a + 70°C.
I transponder saranno installati in prossimità degli alimentatori in apposita scatola.
Al fine di garantire il corretto funzionamento dell’impianto anche in caso di corto circuito di tratti di linea e
per far si che non si perda la funzionalità di più di una zona logica saranno installati dispositivi isolatori di loop che garantiranno la perdita della sola zona logica interessata dal guasto.
E’ previsto che le canalizzazioni relative all’impianto di rivelazione incendi, oltre a collegare i sensori ed i pulsanti manuali di allarme, devono collegare gli apparati in campo quali elettromagneti, sirene ottico acustiche
di allarme in corso, attuatori elettrici per infissi. Anche in questo caso la predisposizione delle canalizzazioni è
realizzata con tubazioni in PVC sottotraccia attestate a scatola da incasso per apparecchi modulari componibili fino a tre moduli, all’interno del locale, e con cassetta di derivazione collegata alla canala in PVC posizionata nel corridoio.
Nel caso di installazione dell’apparato nel controsoffitto si deve predisporre una scatola di collegamento da
esterno.
Viste le tecnologie attuali maggiormente in uso si è prevista la realizzazione di una linea di collegamento dei
rivelatori e dei pulsanti manuali di allarme del tipo a loop.
Per quanto è oggetto dell’alimentazione degli apparati in campo è prevista la posa di canalizzazioni separate
rispetto a quelle dell’impianto di rivelazione. E’ ammesso il transito nel medesimo scomparto della canala
principale di distribuzione.
Impianto diffusione sonora
Tra le procedure di allarme descritte al punto e) dell’allegato IV al D.M. 10 marzo 1998 “criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” è suggerito, per ambienti con notevole presenza di pubblico, l’impiego di un impianto per la diffusione di messaggi preregistrati attivato dal
sistema di allarme antincendio.
Tale è richiamato anche dal D.M. 18 settembre 2002 al punto 8. Quindi è stata prevista la realizzazione
dell’impianto di diffusione sonora che la squadra di emergenza potrà utilizzare per facilitare l’esodo in caso
d’incendio.
L’impianto proposto prevede la realizzazione, delle linee di collegamento ai diffusori sonori del tipo resistenti
al fuoco (FG10OM1) e dai diffusori sonori del tipo a parete, per i locali, e del tipo a contro soffitto per i corridoi.
La centrale con tutti gli apparati attivi del sistema sono esclusi dalla presente progettazione.
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 85
Diffusore sonoro a controsoffitto
Diffusore sonoro a controsoffitto per la sonorizzazione degli ambienti comuni dove è presente il contro soffitto, principalmente i corridoi, realizzato in materiale plastico di colore bianco RAL 9003, altoparlante a gamma
estesa da 200 mm di diametro.
Dati caratteristici a cui dovrà rispondere la fornitura sono:
• tipo a plafoniera con trasformatore;
• sistema di fissaggio a incasso;
• potenza nominale/massima 6/10W, impedenza 4 ohm;
• risposta in frequenza 80/10.000 Hz;
• sensibilità 94 dB;
• massima pressione sonora 104 dB;
• angolo di copertura 4.000 Hz 40°;
• angolo di dispersione del diffusore sonoro pari a 110°.
Impianto di chiamata
La realizzazione delle canalizzazioni di collegamento fra i punti di chiamata, ed il centralino, posto nei locali di
lavoro infermieri, ricalca quanto descritto per gli impianti a bassissima tensione, quindi è previsto l’impiego di
canalizzazioni in PVC sotto traccia all’interno dei locali e l’impiego di un apposito scomparto nella canala posizionata nel corridoio. La posizione dei punti di chiamata è riportata nelle tavole di progetto.
Le terminazioni locali devono essere eseguite con scatola da incasso tonda diam. 80 mm completa di coperchio di chiusura a vite. Per le apparecchiature di chiamata che verranno posizionate sul testaletto si deve
prevedere il collegamento, con tubo in PVC incassato nella struttura, tra questo ed il terminale di stanza. Le
linee elettriche di collegamento devono rispondere ai requisiti generali descritti al capitolo 8.
Alimentatore stabilizzato
L’alimentazione elettrica dell’impianto di chiamata è derivata da apposito alimentatore stabilizzato monofase
esistente in quanto parte dell’impianto è già esistente per le sale operatorie 5 e 6. A seguito di quanto sopra
tutte le apparecchiature costituenti l’impianto dovranno essere omogenee a quanto già presente. Indicativamente l’impianto derivato dovrà avere le seguenti caratteristiche.
Pulsantiera di chiamata da posto letto
Ogni singolo posto letto è dotato di pulsantiera di chiamata in materiale isolante bianco, con spina a 7 poli,
dotata di: tasto di chiamata rosso con simbolo “infermiere”, lampada di rassicurazione led rosso, tasto luminoso per accensione luce. Completa di sistema di disinserimento “a strappo” e cavo di collegamento di m 2,
ripiegabile ad anello.
Pulsante di annullamento chiamata
Il sistema di annullamento chiamata, per camera o bagno, è costituito da modulo di riconoscimento del tipo
di chiamata in corso dotato di: led rosso di rassicurazione, led verde di segnalazione presenza infermiere,
segnalatore acustico.
Modulo elettronico di chiamata camera pazienti
Il modulo elettronico di controllo per la camera pazienti, a tre campi luminosi, deve essere idoneo alla segnalazione di: chiamata medico, chiamata diagnostica, chiamata bagno/WC, chiamata paziente (normale e
d’emergenza); completo dei circuiti di annullamento di tutte le chiamate e della segnalazione di presenza infermiera (verde), eventuali annullamenti separati bagno/WC.
Impianto ricezione per locale presidiato
L’impianto di chiamata è gestito e controllato dall’impianto di ricezione chiamata per locale presidiato, già esistente quindi escluso dall’appalto
Impianto di televisione a circuito chiuso
E’ prevista la possibilità di poter inviare immagini, sia a scopo didattico sia a scopo di documentazione
dell’operazione, dalla sala operatoria ad uno o più punti di visualizzazione. Tali punti sono attualmente individuati sul pensile chirurgo ed a parete in prossimità del quadro prese. La predisposizione del punto per uscita di impianto di sorveglianza a monitor comprende, oltre alla presa coassiale anche il cavo coassiale per radio frequenza e tubazione in PVC diametro 25mm.
Presa connettore BNC per cavo RG 58 a crimpare
La presa per il collegamento delle apparecchiature di ripresa o visione è costituita da connettore BNC 50
Ohm per cavo RG 58 B/U. Il collegamento fra cavo e presa BNC è del tipo a crimpare. L’apparecchio deve
essere del tipo modulare componibile per alloggiamento entro scatola da incasso modulare a tre posti e
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 86
completo di placca di finitura omogenea a quanto installato per gli apparecchi di comando.
Cavo coassiale per radiofrequenza tipo RG 58 B/U
Cavo coassiale per radiofrequenza con dielettrico compatto o a spirale di polietilene per reti trasmissione dati
e per radiofrequenza costituito da:
• Anima in filo unico di rame ricotto rosso o stagnato o a cordina o stagnato copperweld;
• Isolante in polietilene compatto;
• Schermatura con conduttore esterno a treccia di rame rosso o stagnato;
• Guaina in PVC colore nero.
E’ compensato l’onere di siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei
materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte.
BARRIERE TAGLIA FIAMMA
Nei percorsi principali dei cavi, raggruppati in canale, in attraversamenti di pareti e di solette che delimitano
“compartimenti”, come definito al secondo capoverso dell’art. 7 sono poste opportune barriere al fine di prevenire la propagazione degli incendi e dei fumi.
Le barriere tagliafiamma possono essere di vari tipi a secondo dei vari passaggi da sigillare; in generale è data preferenza all’impiego di diaframmi resistenti al fuoco REI 120 del tipo a sacchetto in tessuto minerale incombustibile, riempito con una miscela di fibre inorganiche e barre termoespandenti, per la sigillatura di canale, mentre per la sigillatura di varchi costituiti da tubazioni sarà data preferenza all’impiego di mastici intumescenti per sigillature REI 120.
Dette barriere devono comunque avere grado di resistenza al fuoco (REI) almeno uguale o superiore a quelle della parete e/o solette in cui vengono impiegate.
Tutti i materiali, comunque dovranno essere corredati di certificato di omologazione del Ministero degli interni, C.S.I. o equivalente.
Diaframma resistente al fuoco in sacchetti
Per la chiusura degli attraversamenti di vie elettriche costituite da canale principali è data preferenza a diaframmi resistenti al fuoco costituiti da sacchetti in quanto facilmente rimuovibili per eventuali ampliamenti.
Tali sacchetti, costituiti da tessuto minerale al cui interno contengono una miscela di fibre inorganiche e barre termoespandenti, permettono di ridurre drasticamente la trasmissione della temperatura nel varco tramite
l’intervento delle fibre inorganiche, mentre l’espansione delle barre intumescenti, associata alla perdita
dell’acqua di cristallizzazione, contribuisce ad abbassare ulteriormente la temperatura e consente la completa
sigillatura del varco e delle eventuali fessurazioni, conseguenti alla fusione dei cavi elettrici ed alla loro riduzione di volume.
Diaframma resistente al fuoco in materiale intumescente
Per la chiusura degli attraversamenti di vie elettriche costituite da tubazioni è data preferenza all’impiego di
mastice intumescente costituito da materiali inorganici autoespandenti ad elevata elasticità ed applicabile,
tramite apposite pistole, su qualsiasi tipo di supporto. Durante l’esposizione al fuoco il mastice si deve espandere formando una schiuma adattabile a qualsiasi forma, in grado di sigillare il varco ed impedire la
propagazione di fumi e gas.
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 87
ELENCO MARCHE
Di seguito sono elencate le marche di riferimento che definiscono il livello qualitativo e degli equipaggiamenti
da utilizzare per l’installazione degli impianti di cui all’oggetto, con riferimento alla produzione standard, o a
fuori standard specificati nel precedente articolo e/o negli elaborati di progetto.
Devono comunque essere previsti tutti gli accessori e complementi necessari per l’ottenimento delle finalità
di buona e corretta manutenzione, completezza e buon funzionamento del sistema.
La richiesta di approvazione dei materiali da adottare dovrà essere sottoposta alla D.L. esclusivamente tramite la scheda riportata nel seguente “allegato 1”
Eventuali variazioni alle marche devono essere sottoposte all’accettazione da parte della D.L.. Possono essere accettate, in variante, solo Ditte costruttrici che dispongano della certificazione per la garanzia della qualità in accordo alla norma UNI-EN 29001 o documento equivalente prodotto da un istituto di certificazione secondo ISO 9001, BC5750, NFX50.131, o equivalente.
Per la specifica delle procedure di approvazione dei materiali da approvvigionare si rimanda al corrispondente articolo della parte generale del C.S.A.
Contenitori metallici per quadri elettri- BTICINO serie HD, ABB serie ArTu, Grupe Schneider serie Prisma,
ci
LUME serie Quadro
Interruttori scatolati
BTICINO serie Megatiker, ABB serie Isomax S, Grupe Schneider
serie Compact, HAGER serie HN
Interruttori modulari
BTICINO serie BTDin, ABB serie prò M, Grupe Schneider serie Multi
9, HAGER serie N
Passerelle a griglia
LEGRAND; Arnocanali; FEMI
Tubazioni
RomanPlastic, Dielectrix, InSet
Cassette di derivazione
Gewiss, BTICINO, Vimar, Ave, Palazzoli, Ilme
Morsetti di connessione
Cabur, Eleco, Arnocanali, 3M
Conduttori
Pirelli, Manuli, CentralCavi, AlcatelCavi
Apparecchi di comando e prese elet- BTICINO Serie LIVING, Ave serie Blanc, Vimar Serie 8000, Legrand
triche civili e similari
serie Cross
Prese di corrente di tipo industriale
Palazzoli, Ilme, Schyller
Impianto interfonico
Terraneo, Urmet, Farfisa, ELCA ACS
Apparecchi illuminanti
DISANO, 3F FILIPPI, PRISMA, TARGETTI, ESSE-CI, NOVALUX o
equivalente approvato
Apparecchi illuminanti di sicurezza
OVA Bargellini, Beghelli; Menvier
Lampade
OSRAM, PHILIPS, LEUCI, GENERAL ELECTRIC
Impianto di chiamata infermieri
ZETTLER, TAICO, ABBCLINOS, EFE
Rivelazione fumi
ZETTLER, NOTIFIER, ESSER
Diffusione sonora
RCF, Paso o equivalente approvato
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 88
ALLEGATO 1
Impresa:
Scheda n.:
DITTA INSTALLATRICE :
Data di presentazione
IMPIANTO :
Data di approvazione
Riferimento E.P.U.
DESCRIZIONE
DESCRIZIONE DELLA FORNITURA / CAMPIONATURA
MARCA :
MODELLO :
ALLEGATI :
CAMPIONATURA :
SI
NO
PARERE:
LA DITTA
LA DIREZIONI LAVORI
__________
Contratto aperto di Manutenzione 2010-2011 – DOC 05 - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
__________
pag. 89