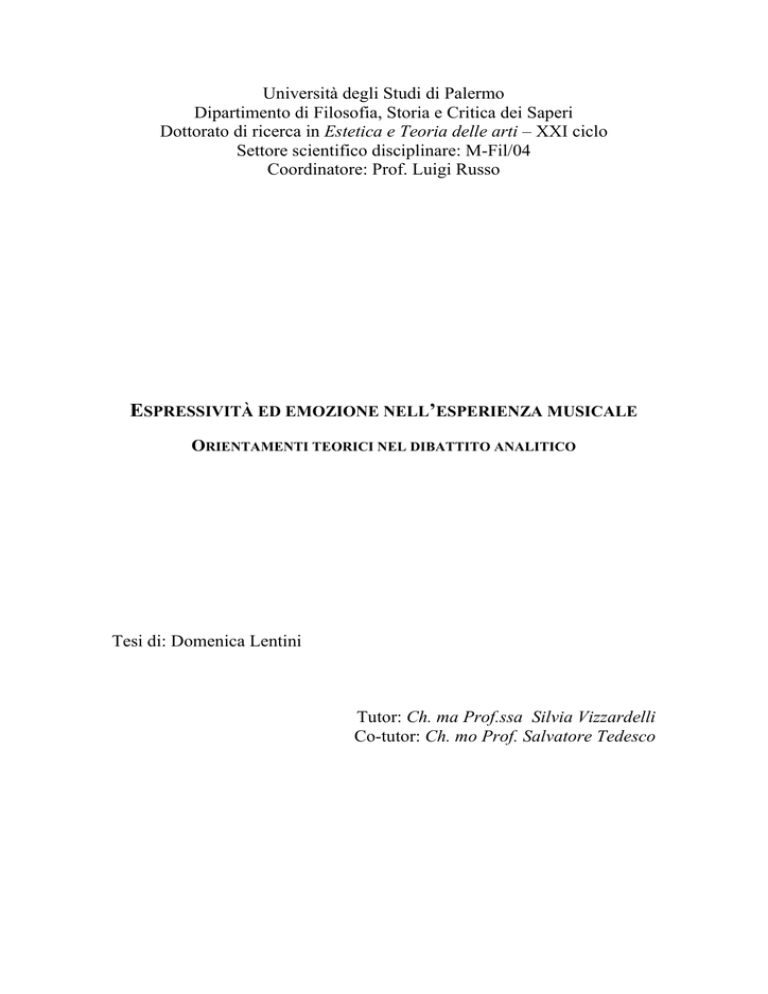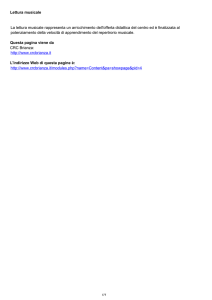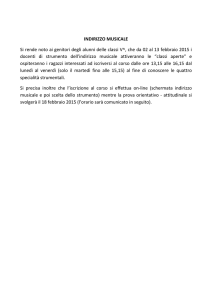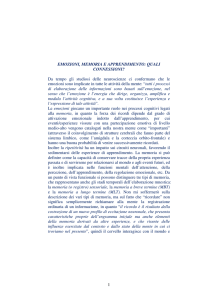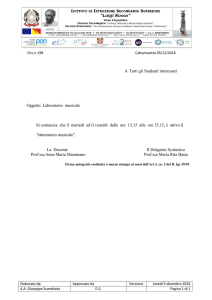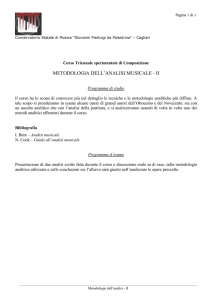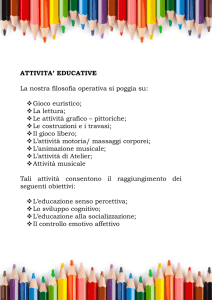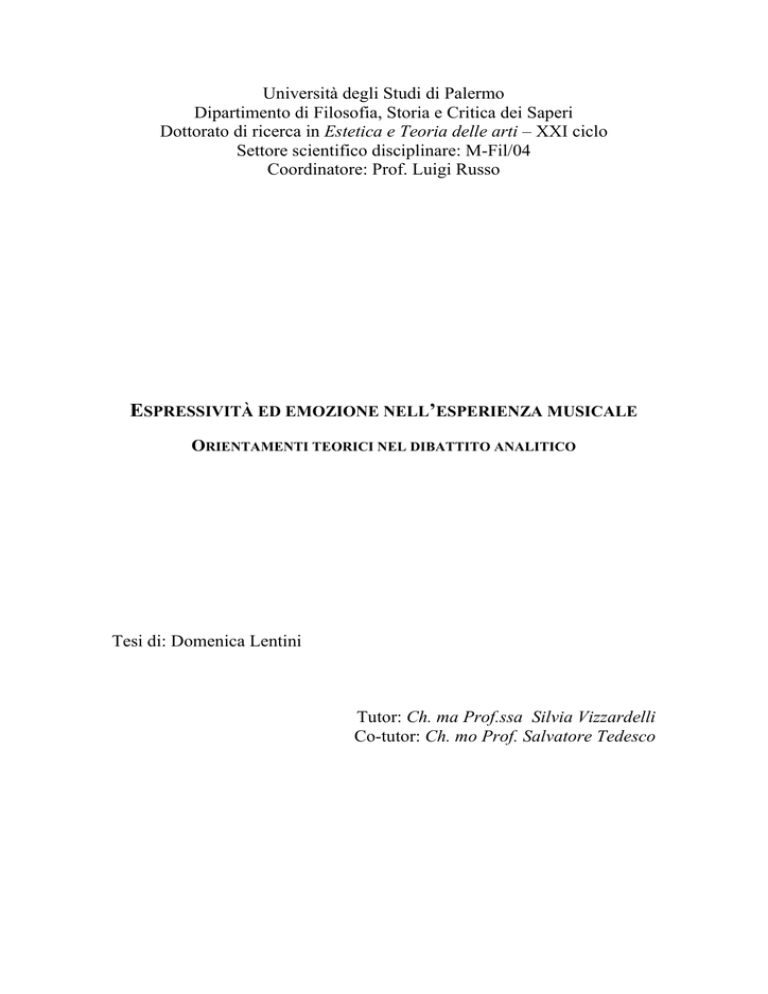
Università degli Studi di Palermo
Dipartimento di Filosofia, Storia e Critica dei Saperi
Dottorato di ricerca in Estetica e Teoria delle arti – XXI ciclo
Settore scientifico disciplinare: M-Fil/04
Coordinatore: Prof. Luigi Russo
ESPRESSIVITÀ ED EMOZIONE NELL’ESPERIENZA MUSICALE
ORIENTAMENTI TEORICI NEL DIBATTITO ANALITICO
Tesi di: Domenica Lentini
Tutor: Ch. ma Prof.ssa Silvia Vizzardelli
Co-tutor: Ch. mo Prof. Salvatore Tedesco
INDICE
INTRODUZIONE..................................................................................... P.
1
CAPITOLO PRIMO
Prospettive di ricerca e testi seminali
1.
Il rapporto musica-emozioni al centro del dibattito .................................... p.
14
2.
Premesse storiche ........................................................................................ p.
23
2. 1 Arthur Schopenhauer ............................................................................ p.
26
2. 2 Eduard Hanslick .................................................................................... p.
29
2. 3 Susanne K. Langer ............................................................................... p.
34
Externality claim vs Arousal theory ............................................................ p.
39
3.
CAPITOLO SECONDO
Musica e forma
1.
Musica assoluta: superficie o profondità? La proposta di Peter Kivy ......... p.
47
2.
Per una teoria dell’espressione musicale ..................................................... p.
57
3.
L’espressività musicale: una breve storia .................................................. p.
71
4. Kivy dialoga con Levinson e Davies ........................................................... p.
77
5.
Formalismo e formalismo arricchito ............................................................ p.
84
6.
La risposta disposizionale di Derek Matravers ............................................ p.
94
I
CAPITOLO TERZO
Musica, metafora e isomorfismo
1.
Introduzione al dibattito sulla metafora ....................................................... p. 113
2.
I testi seminali ............................................................................................. p. 115
2. 1 Il bello musicale di Hanslick ............................................................... p. 115
2. 2 Metaphor di Max Black ........................................................................ p. 119
2. 3 Che cosa significano le metafore di Donald Davidson ......................... p. 124
2. 4 Metafora come luce della luna di Nelson Goodman ............................ p. 127
3.
Nick Zangwill: musica, metafora ed emozione ............................................ p. 132
4.
Roger Scruton: immaginazione e metafora .................................................. p. 144
4.1 Suoni e note .......................................................................................... p. 147
4. 2 Metafora ................................................................................................ p. 153
4. 3 Metafora e similitudine ......................................................................... p. 156
4. 4 Un’appropriata trasgressione ................................................................ p. 159
4. 5 Musica e metafora ................................................................................. p. 162
5.
Malcolm Budd: metafora e isomorfismo ...................................................... p. 165
6.
Stephen Davies: le caratteristiche esteriori delle emozioni .......................... p. 197
7.
Jerrold Levinson: isomorfismo dell’esperienza vs isomorfismo descrittivo ....... p. 214
BIBLIOGRAFIA ................................................................................................. p. 233
II
Gli avversari passionali hanno fantasticato di una mia polemica contro tutto ciò che sia sentimento, mentre ogni lettore imparziale e attento non farà difficoltà a riconoscere
che io protesto solo contro la falsa ingerenza dei sentimenti
nella scienza, ossia io combatto contro quei visionari
dell’estetica che con la pretesa di insegnare qualcosa al
musicista, non fanno che interpretare i loro sogni da fumatori di oppio sonoro. Io sono completamente d’accordo con
l’opinione che il valore ultimo del bello si trova all’interno
dell’immediata evidenza del sentimento. Ma sono altrettanto sicuro che il richiamo al sentimento come spesso accade,
non consente di ricavare leggi musicali.
La musica ha un contenuto, sebbene sia musicale, in quanto scintilla del fuoco divino non inferiore alla bellezza di
ogni altra arte. Ma solo negando inesorabilmente alla musica ogni altro “contenuto”, se ne salva il contenuto spirituale. Infatti non con il ricorrere a un sentimento indefinito
– in cui, nel migliore dei casi, consiste il contenuto – si può
attribuirle un significato spirituale, ma riconoscendo la
bella e ben definita forma sonora come creazione dello spirito, compiuta su un materiale atto a essere spiritualizzato.
EDUARD HANSLICK
INTRODUZIONE
Quando si esamina il problema della relazione tra la musica e le emozioni da un
punto di vista storico, si resta inevitabilmente colpiti dal fatto che l’estetica musicale
sembra avere oscillato, fin dall’antichità, fra concezioni che privilegiano l’autonomia
della musica nelle sue soluzioni formali, e concezioni che invece considerano
quest’arte inscindibilmente legata alle dinamiche emotive. Il più delle volte, una di
queste due concezioni sembra dominare. Vi è una sorta di alternanza nel corso della
storia della musica e delle teorie musicali. Talvolta esse coesistono in uno stesso periodo storico.
È innegabile che quella del rapporto musica-emozioni è un’annosa questione
che ha affascinato e allo stesso tempo impegnato i filosofi quasi dall’inizio della filosofia stessa. Una questione che ci interpella ancora oggi, riaffermandosi nella recente discussione degli estetologi analitici di area anglo-americana, i quali danno oramai da diverso tempo, e in particolare con una ricca fioritura negli ultimi trent’anni, un contributo teoretico di notevole importanza, colmando così anche quel vuoto che si registra purtroppo ancora nella tradizione estetologica continentale. Nell’attuale dibattito analitico,
la tradizionale questione del rapporto tra musica ed emozioni riceve sempre maggiore
attenzione, come testimoniano peraltro le dense conversazioni, i dialoghi intrecciati, le
analisi punto-per-punto. Senza poi trascurare il fatto che numerose sono le tesi in campo e altrettanto numerose le pubblicazioni di vario genere centrate esclusivamente sulla
questione. Una trattazione ricca del tema dell’espressività e del rapporto musica-vita
emotiva la troviamo nelle due principali riviste di area anglo-americana, il “British
Journal of Aesthetics” e il “Journal of Aesthetics and Art Criticism”. Possiamo
senz’altro dire che la musica, e segnatamente il rapporto musica-emozioni, è la forma
d’arte che ha più stimolato il dibattito analitico se teniamo conto della quantità ed estrema varietà dei contributi ad essa dedicati.
Pensando alla fecondità di tale ricerca ma anche alla modesta attenzione che essa riceve nella nostra tradizione, il presente lavoro nasce con l’intenzione di colmare
una lacuna, dando la giusta rilevanza al dibattito che negli ultimi anni è venuto sviluppandosi. Diciamo subito che l’idea, nello specifico, è quella di ricostruire, a partire da
un orientamento tematico, le conversazioni, i dialoghi teorici che si stanno svolgendo,
dando particolare rilievo a quei filosofi le cui singole teoriche sono paradigmatiche di
1
una certa tendenza. D’altronde entro la straordinaria moltitudine di proposte che animano la discussione, ci è parso opportuno ricercare un “criterio” orientativo, una sorta
di guida rossa che consentisse di intraprendere il viaggio senza smarrirci tra i percorsi
laterali che, pure, si aprono ad ogni crocicchio.
Abbiamo scelto dunque innanzitutto un criterio tematico. In questo senso, per
ciascun punto o problema che ci siamo impegnati a trattare, il nostro obiettivo non è
stato – compito che sarebbe stato peraltro infruttuoso se non impossibile – quello di
presentare l’insieme delle teorie o dei punti di vista che lo hanno affrontato, ma al contrario, di fare appello per la trattazione di ciascun tema a una sola voce, spesso più significativa rispetto al tipo di problematica in questione o significativa in relazione alla
vicendevole corrispondenza creatasi tra quanti dialogano sulla medesima problematica.
Abbiamo dunque preferito affrancarci da ogni pretesa, diciamo così, di “completezza”,
per descrivere quelle che ci sembrano una serie di questioni importanti (musica-forma,
musica-metafora, musica-isomorfismo) ed esemplificarle attraverso il riferimento ad
alcuni dei numerosi autori che ne trattano (Kivy, Davies, Levinson, Matravers, Goodman, Zangwill, Scruton, Budd e Davies).
Seguendo questi criteri metodologici, abbiamo così iniziato il nostro percorso di
ricerca, cercando di penetrare quanto più possibile nel cuore di questa discussione, per
capire quali ancora sono i problemi, gli interrogativi e dunque anche le soluzioni più
significative a quella che, dicevamo, si è sempre dimostrata essere una problematica
scivolosa. Un punto va chiarito: come nel passato, non è in discussione l’idea che tra la
musica e le emozioni vi sia una qualche speciale relazione, dato pressoché inamovibile,
ma ancora una volta tutte le complessità sono legate alla difficoltà di stabilire in che
termini è possibile giustificare questa relazione, in che senso essa possa sussistere, quali le motivazioni profonde.
L’attenzione, precisiamo, nell’attuale dibattito, nella maggior parte dei casi, è
diretta in particolar modo alla musica assoluta, cioè alla musica strumentale senza testo, titolo o programma. È rispetto ad essa infatti, che è certamente più problematico
giustificare l’idea che vi sia una relazione con le emozioni, visto che, diversamente dalle arti a vario titolo rappresentative (si pensi alla pittura figurativa, al teatro, letteratura,
ecc.) la musica pura non è un’arte contenutistica che intrattiene legami evidenti con il
nostro mondo rappresentativo.
Dal nostro approfondimento è emerso che due sono le concezioni dominanti nel
dibattito analitico. In un primo momento ha riscosso consenso soprattutto l’idea di chi,
2
in antitesi con le affermazioni scettiche di Hanslick, ritiene che è certamente sensato
parlare della musica in termini espressivi, perché essa possiede le emozioni e le possiede come proprietà percettive della sua struttura. In aperta polemica con tale posizione,
si è successivamente affermata invece l’idea di quanti ritengono che le proprietà emotive stiano alla musica piuttosto che come proprietà percettive, come proprietà disposizionali. Secondo tale idea, la musica è cioè espressiva delle stesse emozioni che essa
normalmente desta o suscita nell’ascoltatore. Peter Kivy, che è uno dei più illustri e attivi rappresentati del dibattito, ci informa non a caso di come l’antica querelle concernente il problema del rapporto della musica con le emozioni il più delle volte, nella recente discussione, sfoci in una accesa diatriba tra queste due posizioni, rispettivamente
ribattezzate come cognitivismo ed emotivismo. E come Kivy, anche Derek Matravers,
si riferisce alla stessa diatriba caratterizzandola nei termini dell’opposizione tra sostenitori del requisito dell’esternalità (externality requirement) e teorici della teoria eccitazionistica (Arousal Theory). Gli stessi Kivy e Matravers sono tra i principali protagonisti di questa querelle, essendo il primo il più estremo sostenitore della tesi cognitivista
e il secondo il più estremo sostenitore di una teoria eccitazionistica. Proprio Kivy e
Matravers sono infatti i due veri contendenti, perché hanno radicalizzato rispettivamente le loro tesi e di conseguenza accentuato il loro dissidio teorico. Più sfumate sono invece le tesi di altri autori, visto che tra quanti si fanno sostenitori dell’idea che la musica è espressiva perché le emozioni sono una sua proprietà, si riscontra, il più delle volte, anche una parziale convergenza con una teoria eccitazionistica o Arousal Theory. Ci
è parso questo nello specifico il caso di Malcolm Budd ma anche di Jerrold Levinson e
Stephen Davies, i quali infatti pur muovendo da quel presupposto fondamentale, diciamo pure, cognitivista, non negano comunque il potere che la musica ha di suscitare
emozioni in chi ascolta. Naturalmente, essendo il punto di partenza quello di una tesi
anti-emotivista, non è ridondante precisare che questo riconoscimento non ha come
conseguenza la conclusione – come invece spesso accade con gli emotivisti – che sia
anche questa la ragione per cui si può spiegare la portata o capacità espressiva della
musica.
Sulla scorta quindi di queste premesse generali è doveroso sottolineare che per
chi ha voluto dimostrare la tesi che la musica è espressiva in quanto “incarna” le emozioni nella sua struttura, la questione dell’espressività si dimostra certamente più complessa e articolata, dal momento che diverse sono le questioni da dover fronteggiare.
Primo fra tutti vi è il problema di come, ovvero secondo quale processo, la musica sia
3
capace di incarnare le emozioni ordinarie. In secondo luogo, occorre spiegare quale
ruolo giocano queste proprietà espressive nella struttura musicale alla quale appartengono. Infine, l’ultima questione: dato che le emozioni ordinarie risiedono, in quanto
proprietà espressive, nella musica, e non nell’ascoltatore, cosa significa dire che una
persona è emotivamente colpita dalla musica.
Come può dunque la musica ‘incarnare’ le emozioni ordinarie? Per ragioni di
ordine e di chiarezza abbiamo individuato due tipi di risposta a questa domanda: una
risposta “dal basso” e una risposta “dall’alto”.
La risposta “dal basso” è quella secondo cui il problema espressivo è da ricondurre sul piano di una risposta immediata, a partire soprattutto dalla riabilitazione di
una tesi isomorfica. L’idea è che proprio sulla soglia dei nostri decorsi percettivi si rivelino somiglianze, similarità, tra le dinamiche della musica e quelle del comportamento espressivo umano. Il senso dei decorsi percettivi è cioè una proiezione che si radica
in una struttura. Le nostre percezioni, come del resto la fenomenologia ha ben mostrato, non sono delle esperienze puntuali ed isolate, ma disegnano una trama. Questa trama, fatta di ritenzioni e protensioni, rappresenta quello che qui chiamiamo ‘struttura’.
Ed è proprio grazie a questa nozione che possiamo arrivare a concepire le proprietà
emotive come analogicamente ancorate alla struttura musicale.
L’orizzonte dell’affettività da una parte e l’insieme delle strutture percettive
dall’altra non sono due dimensioni che stanno in un qualche rapporto tra loro, ma due
aspetti di un’unica realtà, strutturalmente isomorfici. Secondo questa lettura,
l’isomorfismo si presenta con il suo massimo di necessità, ogni qualvolta si voglia fuggire da ipotesi riduzionistiche che, ispirate all’autorità della logica scientifica tendono a
riaffermare il principio secondo cui la musica non può provare emozioni né può essere
triste, a meno che tali attribuzioni non si dicano poetiche o metaforiche, per la circostanza che l’esperienza (la possibilità) di sentire emozioni dentro di sé è propria solo
degli esseri senzienti.
Una risposta “dal basso” è quella che abbiamo facilmente riconosciuto nella cosiddetta teoria del profilo (Contour Theory) di Peter Kivy, ma anche nella tesi espressiva (Emotion-characteristics-in-appearances Theory) di Stephen Davies. Nel caso specifico, Kivy sostiene che certamente deve esservi una somiglianza tra la struttura, il
profilo, il contorno della musica e le manifestazioni acustiche e visive dell’espressione
emotiva umana. Kivy precisa che, nonostante l’apparenza, non si tratta di una teoria
rappresentazionale, perché le emozioni non sono percepite come rappresentate, vale a
4
dire in maniera mediata, ma in modo immediato: l’analogia tra la musica e gli aspetti
acustici o visivi delle emozioni umane è in altri termini subliminale, dobbiamo cioè
trovarci in uno stato di inconsapevolezza rispetto all’esistenza dell’analogia stessa, non
dobbiamo in alcun modo presupporla. A seguito delle obiezioni ricevute, Kivy recentemente ha anche seriamente messo in discussione la validità della teoria del profilo,
seppure arrivando alla conclusione che attualmente siffatta teoria non ha, diciamo così,
una degna sostituta, anzi – egli precisa – resta ancora la più attraente. Quale soluzione
adottare, in ultima analisi, Kivy non ce lo dice. Si ferma solo a constatare che attualmente c’è un accordo generale sul fatto che la musica esprima le qualità emotive come
qualità percettive, e che quindi la cosa migliore da fare, stabilite così le cose, è di attendere fiduciosi che nel futuro si trovi una spiegazione più convincente. Muovendosi da
questa acquisita consapevolezza egli infatti ha preferito spostare l’attenzione alle altre
due questioni dell’espressività, al ruolo cioè che tali qualità giocano nella struttura e
nell’esperienza musicale.
Come per Kivy, anche per Davies l’espressività della musica dipende prevalentemente da una somiglianza che si può cogliere percettivamente nell’immediatezza.
Una somiglianza che percepiamo tra il carattere dinamico della musica e il movimento,
l’andatura, il comportamento o l’atteggiamento dell’uomo. Se la musica è espressiva,
non lo è perché essa possiede le emozioni, nel senso in cui un essere senziente le possiede: alla musica mancano i pensieri, le attitudini, e i desideri che sono caratteristici
dell’esperienza emotiva e che contribuiscono a far sì che esse siano le emozioni che
sono. Ciò che la musica invece presenta in quanto arte espressiva sono le caratteristiche
esteriori delle emozioni, vale a dire: la nostra esperienza dei brani musicali e, in particolare, del movimento in musica è simile alla nostra esperienza di quelle forme di
comportamento che, negli esseri umani, sfociano nelle caratteristiche esteriori delle
emozioni. L’analogia risiede nella maniera in cui queste cose sono esperite, piuttosto
che essere fondata su una qualche inferenza che cerchi di stabilire una relazione simbolica tra alcune componenti specifiche della musica e alcuni particolari del comportamento umano. Un’analogia che possiamo per l’appunto cogliere subito, in quanto sostiene Davies, l’emozione è immediatamente, non mediatamente, presentata nella musica.
Inoltre, una risposta “dal basso” è anche quella che abbiamo potuto rintracciare
nella spiegazione di Malcolm Budd e Jerrold Levinson; sebbene sia necessario precisare che nell’uno e nell’altro caso la spiegazione del problema espressivo della musica
5
non passa da un’unica e precisa soluzione, ma da una serie di categorie concettuali ugualmente adottabili (nel caso di Budd), e da una serie di requisiti (nel caso di Levinson) che un’adeguata spiegazione dell’espressività deve soddisfare. Tra queste categorie concettuali/requisiti, vi è appunto quello dell’analogia che possiamo cogliere tra la
musica e il comportamento espressivo umano. Muovendosi da un’ottica possibilista,
entrambi giungono poi a declinare il problema espressivo della musica a partire dal coinvolgimento immaginativo che vi è nella nostra esperienza di essa come espressiva.
Significativa è in tal senso l’adesione da parte di Budd ad una tesi finzionale, e altrettanto significativa la teoria della persona di Levinson.
In questo nostro tentativo di individuare delle linee esemplificative di lettura,
abbiamo anche parlato di una risposta “dall’alto” che è quella di chi riporta il problema
espressivo della musica ad un tipo di risposta che non è immediata come quella che si
rivela in una dinamica percettiva, ma mediata dalla incidenza della nostra componente
immaginativa nell’esperienza della musica. Emblematica in tal senso la prospettiva teorica di Roger Scruton, filosofo di chiara ascendenza kantiana le cui tesi non potrebbero
intendersi se non entro una teoria dell’intenzionalità e dell’immaginazione. Per quanto
concerne nello specifico la musica, Scruton separa il fenomeno dei suoni fisici
dall’esperienza della musica; la differenza non risiede in una semplice variazione di
grado e la musica non sarebbe il risultato di una sequenza organizzata di note e accordi,
ma suoni e musica sono entità di genere differente che agiscono nell’ambito delle rispettive sfere d’appartenenza: i primi fanno parte del mondo fenomenico degli esseri di
natura e in esso vengono ascoltati concettualmente come suoni naturali semplici, mentre la musica chiama in causa unicamente la sfera intenzionale del solo essere di natura
(l’uomo) capace di relazionarsi contemporaneamente con la propria facoltà immaginativa per trascendere la sua condizione materiale del qui e ora. L’esperienza musicale è
propriamente il tentativo razionale dell’uomo di evolversi da se stesso, dalla propria
condizione di finitezza naturale per dislocarsi su un piano di intenzionalità immaginativa che rappresenta l’antitesi di quella relazione analogica che ogni altro essere di natura
intrattiene attraverso l’apparato sensoriale con il proprio ambiente di riferimento.
Questa spiegazione è la stessa che confluisce nella tesi principale di Scruton,
secondo la quale la nostra esperienza della musica coinvolge un elaborato sistema di
metafore – metafore di spazio, movimento e di animazione. Già nel nostro apprendimento musicale di base è in gioco un complesso sistema di metafore, il quale non è la
descrizione veritiera di un qualche fatto materiale, o di qualcosa che riguardi sempli6
cemente il mondo fisico dei suoni. La metafora non può essere eliminata dalla descrizione della musica, poiché essa definisce l’oggetto intenzionale dell’esperienza musicale. Esplicitamente dichiara: «togliete di mezzo le metafore, e non potrete più descrivere
l’esperienza della musica» 1 .
Questa affermazione – che l’esperienza della musica è irriducibilmente metaforica – è stata rifiutata, tra gli altri, da Malcolm Budd, il quale sostiene che fino a quando non sarà stato compreso lo scopo che sta alla base della metafora, la caratterizzazione di tale esperienza come metaforica è del tutto irrilevante. Detto in altri termini, Budd
afferma che ciò che si dà nell’esperienza musicale di una determinata persona, e che
quindi viene colto in essa, è, in quanto irreducibilmente percettivo (anziché metaforico), impossibile da specificare senza fare riferimento all’oggetto di quell’esperienza,
vale a dire, senza fare riferimento alla musica stessa.
A questa critica si è aggiunta anche quella di Davies, il quale, in accordo con
Budd, è dell’idea che quando la musica viene descritta come ‘triste’, la parola ‘triste’ è
usata proprio nel senso in cui è normalmente riferita ai discorsi ordinari del sentimento,
ovvero letteralmente. Nello specifico, egli precisa che i termini che denotano emozioni
utilizzati per descrivere determinati aspetti (o modi di apparire) sia delle persone che
degli oggetti naturali o delle opere d’arte, sono parassitari rispetto all’uso che di tali
termini si fa per riferirsi alle emozioni che vengono vissute; essi rappresentano cioè un
uso secondario. I termini che denotano emozioni descrivono per l’appunto quella apparenza acustica, quelle caratteristiche esteriori dell’emozione che sono alla base della
stessa spiegazione dell’espressività nella teoria di Davies.
Dialogo questo cui abbiamo dato rilevanza nell’ultimo capitolo del nostro lavoro, nel quale spesso si sfiora anche l'altra questione legata al problema del rapporto musica-emozioni, e cioè quella della natura linguistica della musica, il problema della sua
semanticità. Problematica questa che il tema musica-emozioni si porta dietro come fosse la sua ombra, e che come tutta la storia stessa della musica lascia intravedere, pone
sul tappeto l’ipotesi di una prossimità tra musica e linguaggio. Un’ipotesi che
nell’attuale dibattito, abbiamo però potuto constatare, non trova facilmente adesioni.
Non si è cioè propensi a considerare l’idea che la musica possa essere semplicemente
un linguaggio tra i linguaggi. Si ripensa così alla concezione langeriana della musica
come simbolo inconsumato e si riflette allo stesso modo sulla concezione simbolica
goodmaniana delle arti. Nello specifico, ci si interroga su quanto ancora si possa parla1
R. Scruton, Understanding music, in “Ratio”, 25 (2), 1983, pag. 106.
7
re di linguaggio in presenza di siffatte concezioni simboliche e quanto la musica in ultimo possa avere affinità tali da poter essere ricondotta al linguaggio. Abbiamo così visto che in alcuni casi, particolarmente chiaro quello di Stephen Davies, muovendo dal
rifiuto di quelle tesi che prospettano l’idea della musica come simbolica, ci si sposta sul
versante di altre questioni, quali: qual è l’esatto modo di definire una metafora, e quale
la sua funzione illuminante all’interno delle descrizioni emotive della musica? E a seguire come intendere tali descrizioni? Si tratta di descrizioni metaforiche o letterali?
Altrettanto marcate e diversificate poi ci sono parse anche le soluzioni date sul
versante dell’altra problematica, quelle cioè di come giustificare il potere meraviglioso
che la musica ha di commuoverci. È questa certamente l’altra importante questione che
debbono fronteggiare quanti negano una teoria eccitazionistica e difendono invece
l’idea che le emozioni “musicali” siano quelle che riconosciamo nella musica, piuttosto
che nella dinamica emotiva dell’ascoltatore. Interessante a tal proposito è stato per noi
seguire il dibattito serrato tra Kivy, Levinson e Davies, i quali si trovano in sintonia
tanto in relazione all’idea che le proprietà emotive siano proprietà percettive della musica stessa, quanto nel rifiutare perentoriamente una teoria eccitazionistica. Il maggior
punto di dissenso sta invece nel fatto che mentre per Kivy la musica ci commuove emotivamente per la sua bellezza, per Davies e Levinson la musica ci colpisce emotivamente in virtù del potere che le qualità espressive hanno di suscitare in noi delle emozioni ad esse corrispondenti. In altre parole, stando alle spiegazioni proposte da Davies
e Levinson, il meccanismo di stimolazione delle emozioni è attivo quando la musica è
espressiva di tristezza, di felicità, o di qualcos’altro, sia o meno essa una buona musica,
ovvero una musica bella. Secondo la teoria di Davies, l’espressività è infatti di per se
stessa contagiosa (teoria della tendenza o del contagio), sia o meno essa incarnata in
un’opera d’arte di alto livello o in qualcosa che non è affatto un’opera d’arte:
l’espressività provoca direttamente le emozioni. Secondo la teoria di Levinson, tutto
ciò che è necessario affinché la musica stimoli un’emozione è che vi sia un’empatia nei
confronti di un personaggio musicale che immaginiamo esprime tale emozione (teoria
della persona). Per Kivy invece la musica, affinché commuova, deve essere bella, ovvero musicalmente riuscita. Inoltre, una diversa concezione è anche quella che tali autori manifestano rispetto a come si debbono intendere le emozioni che la musica ha destato: per Kivy, si tratta di emozioni pure, nude e crude, emozioni che, egli precisa, avvalendosi della teoria di Brentano, hanno un oggetto, una credenza e un feeling. Mentre
nel caso di Davies e Levinson le emozioni stimolate dalla musica non sono emozioni
8
vere e proprie, che hanno cioè una precisa componente cognitiva e intenzionale, ma
quasi-emozioni o emozioni sbiadite.
In aperta polemica con i teorici cognitivisti o teorici dell’esternalità, dunque in
netta rottura con quello che ci è parso essere l’orientamento dominante nel dibattito analitico, troviamo i teorici dell’Arousal. Declinata infatti in forme certamente più singolari e sofisticate, anche nell’attuale dibattito viene a rivivere la teoria disposizionale
(qui ribattezzata Arousal Theory) che tanta fortuna ha avuto da Platone fino al XVIII
secolo. Da questo punto di vista, come avevamo anticipato, si ritiene che le proprietà
emotive appartengono alla musica piuttosto che come proprietà percettive come proprietà disposizionali, vale a dire: la musica esprime le sue distinte emozioni per la sua
predisposizione a causarle nell’ascoltatore. Uno dei più illustri rappresentanti di questa
tendenza, anzi probabilmente il primo a riaffermare polemicamente un’idea di tipo disposizionale per la comprensione del problema espressivo, è Derek Matravers. Egli sostiene infatti che sebbene l’esperienza musicale causi uno stato mentale caratteristico
che non è un’emozione vera e propria, dotata cioè di una componente cognitiva, bensì
una sensazione, possiamo descrivere un brano musicale come triste soltanto perché esso suscita in noi quelle sensazioni che nella vita reale sono parte dell’esperienza della
tristezza. Certamente anche in quest’orientamento non possiamo esimerci di evidenziare come numerose siano le varianti teoriche in gioco, ma le nostre scelte ci hanno portato infine a un approfondimento esclusivo della tesi di Matravers, soprattutto in vista,
avevamo anticipato, del dibattito serrato che egli intrattiene con Kivy.
Innegabile comunque è, in tal senso, la difficoltà che emerge ogni qualvolta si
voglia dare, anche se approssimativamente, una classificazione delle teorie esaminate,
poiché diverse sono le sfaccettature che le caratterizzano e con le quali bisogna necessariamente confrontarsi. Per questa ragione fuorviante è, dal nostro punto di vista, il
tentativo di categorizzazione proposto da Jerrold Levinson nell’opera The Pleasures of
Aesthetics. Si tratta infatti di un percorso espositivo all’insegna della parzialità dove infine prevale la logica strumentale di far venire fuori quegli aspetti delle varie teorie che
per qualche misura non pervengono ad una spiegazione dell’espressività esaustiva rispetto all’elenco dei desiderata dallo stesso stilato. Un elenco di esigenze cui, in ultimo,
solo la sua teoria sembra soddisfare pienamente. Ma Levinson non è l’unico a muoversi
seguendo una logica di questo tipo. Aspetto questo il più delle volte imbarazzante ma
soprattutto dicevamo fuorviante perché ciò che infine sembra affermarsi come obiettivo
9
primario non è più quello di guardare al problema in esame ma controbattere nel modo
più efficace e convincente le argomentazioni altrui.
Ad ogni modo, questo è dunque il quadro sintetico delle posizioni in gioco, che
come si è detto animano il dibattito analitico contemporaneo intorno al problema del
rapporto tra musica ed emozioni. Mi sembra opportuno anticipare ora l’ordine secondo
cui tali posizioni saranno esposte e analizzate nel corso della nostra ricerca.
Nel primo capitolo, abbiamo voluto dar spazio ad un’introduzione di carattere
generale del dibattito, esaminando i percorsi storici che hanno favorito la rinascita di
questa particolare attenzione alla questione del rapporto musica-emozioni e disegnando
anche i percorsi metodologici caratteristici della ricerca analitica. Fino poi a ricostruire
in un percorso rapido e sintetico le premesse storiche che sono alla base del dibattito.
Nel secondo capitolo, dedicato al tema musica-forma, un’attenzione particolare
è stata destinata alla concezione di Peter Kivy. L’idea è stata quella di seguire attentamente le tappe più significative della sua indagine sul problema espressivo, fino ad arrivare all’approdo al formalismo arricchito (enhanced). Nell’ambito di questo percorso
interessante è anche stato per noi seguire il dialogo che Kivy intrattiene con i filosofi
contemporanei Levinson e Davies, in relazione al problema di come intendere il potere
della musica di commuoverci e al tipo di emozioni che la musica è in grado di destare.
Il passo successivo è stato poi quello di prendere in esame la teoria di Derek Matravers,
sia in vista dell’aspra polemica con Kivy sia in considerazione del fatto che egli, anticipavamo, è uno dei più illustri rappresentati dell’altra tendenza riattivatasi nel dibattito.
Infine nel terzo e ultimo capitolo abbiamo rivolto una particolare attenzione al
tema dell’uso delle metafore nelle descrizioni musicali e a quello ad esso connesso
dell’isomorfismo. Nello specifico, dopo aver dedicato una primissima parte ai testi seminali che sono alla base della discussione, interessante è stato per noi seguire il dialogo tra coloro che, come Zangwill e Scruton, sostengono, seppure per ragioni diverse,
una concezione metaforica delle descrizioni della musica in termini emotivi e coloro
che invece, come Budd e Davies, vogliono riaffermare la letteralità di siffatte descrizioni.
Il nostro è stato un lavoro di esposizione e di analisi, e piuttosto che schierarci
da una parte o dall’altra, abbiamo preferito invece il più delle volte portarci fuori dalle
nette opposizioni e dalle polemiche, spesso sterili, derivate nella maggior parte dei casi
da sottili distinzioni terminologiche e da etichette di vario genere. In tal senso, impor10
tante per noi è stato soprattutto rilevare invece quelle puntuali convergenze che di volta
in volta emergono sotterraneamente, malgrado cioè i tentativi di dissimularle. La più
significativa di queste convergenze è quella che abbiamo intravisto nell’idea dei teorici
cognitivisti, i quali, pur muovendosi da posizioni che sembrano inconciliabili, quelle
cioè di una risposta “dal basso” che riporta l’isomorfismo al suo massimo di necessità e
di una risposta “dall’alto” che guarda invece a dinamiche intenzionali, hanno in ultimo
sempre e comunque dovuto riconoscere il ruolo dei processi immaginativi in atto
nell’esperienza musicale.
Dimensione quella immaginativa decisiva, come emergerà nell’ultimo capitolo
del nostro lavoro, tanto nelle teorie incentrate sulla metafora, tanto in quelle che, al
contrario, vi rinunciano optando per una descrizione letterale dei termini implicati, che
si pone come candidato principale a rivestire una funzione trans-categoriale, capace di
stabilire cioè connessioni che favoriscono il passaggio da un dominio di riferimento
concettuale ad un altro. Da questo punto di vista sembrerebbe infatti che la musica crei
delle forze immaginative che favoriscono e orientano le nostre possibili associazioni.
Inoltre, per quanto possa sembrare un azzardo una simile ipotesi, ci è parso infine che le distanze non siano nemmeno così accentuate, come invece potrebbe rivelarsi
ad un analisi superficiale, tra i teorici cognitivisti e i teorici disposizionalisti, dal momento che la spiegazione dell’espressività musicale nell’uno e nell’altro caso deve
sempre fare i conti tanto con le proprietà della musica quanto con l’incidenza soggettiva di chi fa esperienza di essa. Anche per il cognitivista Kivy questo è un dato con cui
dover confrontarsi, e noi crediamo che egli stesso ne sia consapevole quando afferma
che in realtà nella sua concezione emozione e cognizione non si diano come separate. E
come Kivy anche Matravers riteniamo non possa fare a meno di riportarsi infine a delle
proprietà che la musica comunque possiede e che ci predispongono ad un’emozione.
Pensando soprattutto alla più aspra controversia che vi è tra i due, e d’accordo con
quanto scrive Giovanni Piana sosteniamo che: «quanto più si esaspera il tema
dell’oggettività e della sintassi, quanto più si sottolinea l’essere in sé dell’opera come
un essere in sé che si separa da ogni legame con il mondo, tanto più nettamente
l’impostazione del problema tende ad un completo ribaltamento non appena si avanza
nuovamente la pretesa dell’espressione» 2 .
Sembra dunque che quando ci si occupa del problema musica-emozioni non si
possa venir fuori da quell’oscillazione cui accennavamo sopra, tra concezioni della mu2
G. Piana, Filosofia della musica, Guerini e Associati, Milano 1991, pag. 271.
11
sica che difendono la sua autonomia e concezioni che la vedono vincolata inscindibilmente alla nostra esperienza. Eppure, come abbiamo voluto far emergere, tirandoci
fuori dalle polemiche, dalle obiezioni e contro-obiezioni che caratterizzano la ricerca
analitica, il più delle volte quelle due concezioni possono semplicemente coesistere.
Anzi è proprio nel segno di questa integrazione, di questo riportare le cose ad unità che
riteniamo si possa gettare adeguatamente luce sul problema del rapporto tra la musica e
le emozioni. Più significativa in questo senso ci è parsa la sfida ardua intrapresa dal
gruppo dei teorici cognitivisti o sostenitori dell’esternalità, i quali, certamente consapevoli del limite in seno alla concezione formalista della musica come ‘universo chiuso’,
hanno voluto aprire questo stesso universo al legame negato.
Altrettanto interessante per noi è stato riscontrare come entro questo stesso ordine di idee l’ipotesi isomorfica, nella maggior parte dei casi, resti ancora, dopo cioè i
precedenti significativi di Pratt e Langer, l’ipotesi più accreditata. Per quanto osteggiata e malvista, ad essa si ritorna, talvolta anche carsicamente. Secondo questa lettura, la
relazione specifica della musica con le emozioni è una relazione primitiva, prevalutativa. Sentire questo rapporto non è cioè una conseguenza di un atto di adesione, di apprezzamento estetico, di valutazione; non ci sentiamo coinvolti emotivamente dalla
musica perché ne riconosciamo il valore estetico, si tratta piuttosto di un legame originario che può confluire nell’apprezzamento di un valore, oppure no (Kivy, Budd, Davies, Levinson).
Al contrario chi nega l’ipotesi isomorfica, esemplare in questo senso la teoria di
Scruton, lo fa proprio in vista della presunta coincidenza di espressività e valore estetico. Una posizione questa, noi sosteniamo, d’accordo con quanto suggerisce Silvia Vizzardelli, «che fa circuitare pericolosamente la nozione di espressività con il riconoscimento del valore estetico, al punto che anche processi almeno all’origine d’impatto
immediato, come la danza, vengono subito riassorbiti in esperienze più complesse e,
potremmo dire, privati già in partenza della loro natura» 3 .
3
S. Vizzardelli, Musica, in Le arti nell’estetica analitica, (a cura di) Paolo D’Angelo, Quodlibet, Macerata, pag. 100.
12
CAPITOLO PRIMO
Prospettive di ricerca e testi seminali
1. Il rapporto musica-emozioni al centro del dibattito
Obiettivo del nostro lavoro è quello di volgere l’attenzione al rinnovato interesse del dibattito analitico per il tema musica-emozioni. Ci soffermeremo in particolare
su tre questioni specifiche fondamentali, l’espressività della musica, il ruolo delle emozioni nell’esperienza musicale e l’incidenza delle allusioni emotive nelle descrizioni
musicali. Tali questioni saranno esplorate alla luce di quelle che ad oggi possiamo considerare le più significative proposte teoriche degli studiosi di area angloamericana.
Poiché, tuttavia, in Italia l’attenzione per questo tema specifico dell’estetica analitica è ancora modesta 4 , riteniamo opportuno, almeno in questa prima parte, dare
spazio ad una presentazione generale del dibattito, ricostruendo i percorsi che hanno
favorito e, allo stesso tempo, accompagnato la nascita di una nuova attenzione per la
tradizionale questione del ruolo del sentimento nella musica (sappiamo infatti che la discussione su questo tema è centrale nel pensiero musicale sin dagli albori della riflessione filosofica), ma anche e soprattutto analizzando quali sono i percorsi metodologici
che definiscono e insieme strutturano l’identità della ricerca estetica analitica.
Tra la seconda metà del XIX sec. e buona parte del XX, la riflessione filosofica
sulla musica non occupava più una posizione significativa nemmeno nell’ambito delle
filosofie orientate verso tematiche di ordine estetico. Il tributo di Susanne Langer a
quest’arte intesa come simbolo presentazionale o incompiuto che possiede proprietà
formali simili a quelle del feeling umano, sancisce un vero e proprio momento di svol-
4
In realtà, come riferiscono Giovanni Matteucci e Paolo D’Angelo nel fascicolo monografico di «Discipline filosofiche», Elementi di estetica analitica, in Italia, purtroppo, si registra ancora una scarsa attenzione rispetto all’intero settore della recente filosofia analitica dell’arte. Se pure, possiamo constatare che
dall’uscita di quel saggio, nel 2005, ad oggi la situazione è visibilmente mutata. “Discipline filosofiche”
XV 2005, Elementi di estetica analitica, a cura di Giovanni Matteucci, Quodlibet, Macerata, 2005. (Avvertenza del curatore, pag. 5, Analitici e Continentali, in estetica, pp. 7-23). A conferma di quanto detto
ecco alcuni testi di riferimento: Introduzione all’estetica analitica (a cura di) Paolo D’Angelo, Laterza,
Roma, 2008; Estetica e Filosofia Analitica, (a cura di Pietro Kobau, Giovanni Matteucci e Stefano Velotti), Il Mulino, Bologna, 2007; S. Chiodo, Che cosa è arte. La filosofia analitica e l’estetica, Utet Università, Torino, 2007; A. Ottobre, Sulle proprietà estetiche, in «Rivista di Estetica», XLIII, 23, 2003, pp.
84-106; A. Ottobre, L’abuso delle proprietà estetiche, in «Rivista di Estetica», XLVII, 35, 2007, pp.
293-310. S. Velotti, L’opera d’arte: una nozione classificatoria o normativa? Note su Goodman, Danto
e Dickie, in «Studi di Estetica», III serie, 31, 1, 2003; S. Velotti, La scelta di Danto, in «Rivista di Estetica», III serie, 35, 2, 2007; S. Velotti, Estetica analitica: un breviario critico, Aesthetica Preprint, Palermo, 2008; S. Velotti e A. Ottobre, Le proprietà estetiche, in A. Coliva, Filosofia analitica. Temi e
problemi, Carocci, Roma, 2007, pp. 307-330. P. Kobau, Ontologie analitiche dell’arte, Milano, AlboVersorio, 2005; Estetica analitica/1 (a cura di) Fernando Bollino, in «Studi di Estetica», 27, CLUEB,
Bologna, 2007; Estetica analitica/2, Id., in «Studi di Estetica», 28, CLUEB, Bologna, 2007; Le arti
nell’estetica analitica, (a cura di) P. D’Angelo, cit.
14
ta 5 . Interessante, a tale proposito, riportare qualche testimonianza. In quella di Peter
Kivy ad esempio, uno dei più eminenti filosofi contemporanei della musica di area angloamericana, facilmente rinveniamo il segno di questo attestato riconoscimento al lavoro di Langer, la quale – egli evidenzia – con la pubblicazione nel 1941 di Philosophy
in a New Key, è riuscita a rompere il silenzio in cui era caduta la riflessione filosofica
sulla musica dopo la pubblicazione de Il bello musicale di Eduard Hanslick (1854).
Queste le sue parole a riguardo:
Per la restante parte del diciannovesimo secolo e per buona parte del
ventesimo, la speculazione filosofica relativa alla musica è rimasta in
ombra. L’Inghilterra ha prodotto, nel 1880, un capolavoro, The
Power of Sound di Edmund Gurney, ingiustamente trascurato per via
della sua prosa ampollosa e delle sue dimensioni ingombranti. Il resto
è silenzio, fino a che, nel 1941 Susanne K. Langer risuscitò, da sola,
la filosofia della musica nel suo libro, Philosophy in a New Key. Il
fatto che tale libro avrebbe avuto un grande impatto è qualcosa di veramente notevole, dato che solo uno dei suoi dieci capitoli ha a che
fare con la musica. Ma il titolo del libro, dopo tutto, faceva riferimento alla musica, e suggeriva quindi che la musica era al cuore del progetto. Ad ogni modo, è ciò che la Langer scrisse sulla musica in quel
libro che ebbe profonde conseguenze, e che lo ha consegnato alla
memoria 6 .
In realtà, come spiega opportunamente Kivy in questa stessa citazione, in quel
periodo di stasi, in Inghilterra nel 1880 fu pubblicato il capolavoro di Edmund Gurney,
The Power of Sound, il quale però fu ingiustamente trascurato a causa della sua ridondante prosa e delle voluminose dimensioni. Non ottenne quindi il rimarchevole effetto
sortito dall’opera di Langer. Un effetto secondo Kivy tanto sorprendente quanto più si
tiene conto del fatto che solo uno dei dieci capitoli che compongono quell’opera è interamente dedicato alla musica. Ciò nonostante – egli tiene a sottolineare – esso è sufficiente a renderci testimonianza del fatto che la musica sta al centro della sua impresa.
Quanto Langer ha detto della musica in quel libro ha avuto un effetto molto profondo,
ed è questa la ragione per cui merita di essere ricordata. Poco più avanti aggiunge:
5
Cfr. Giovanni Piana, Intorno alla filosofia della musica di Susanne Langer, materiali di lavoro per un
corso sul tema “Fenomenologia dell’espressione e filosofia della musica” tenuto nel 1986 (Università di
Milano, Insegnamento di Filosofia teoretica I), pag. 2; Cfr. S. Vizzardelli, Filosofia della musica, Laterza, Roma, 2007, pag. 77.
6
Peter Kivy, New Essays on Musical Understanding, Clarendon Press, Oxford, 2001, pag. 96. Traduzione mia. D’ora in poi, dove non diversamente indicato, le traduzione sono mie.
15
Per quel che mi riguarda, il suo negare che la musica potrebbe incarnare la particolare emozione che identifichiamo senza difficoltà in essa, inficia automaticamente il suo lavoro di ricerca, ma non dirò
nient’altro al riguardo, se non ribadire che la Langer ha fatto sì che la
musica tornasse ad essere un significativo oggetto d’indagine per il
mondo filosofico anglo-americano, e ha preservato l’intuizione di
Schopenhauer secondo cui l’espressività musicale si trova nella musica e non nell’ascoltatore. Per questi motivi a lei va il mio encomio e
la mia gratitudine 7 .
Anche qui possiamo cogliere più manifestamente i segni di questo tributo di
Kivy a Langer, nella misura in cui le riconosce esplicitamente il doppio merito di avere
reintrodotto la musica nel mondo della filosofia angloamericana come privilegiato oggetto di esame e di avere saputo valorizzare la teoria schopenhaueriana della musica
secondo la quale l’espressività della musica risiederebbe non più nella capacità
dell’ascoltatore di coglierla, ma nella musica stessa.
Non è diversa la posizione di Stephen Davies – altro esponente di primo piano
nell’ambito della filosofia analitica della musica – il quale anch’egli, nell’opera
Musical Meaning and Expression 8 , non ha potuto fare a meno di evidenziare la rilevante influenza del pensiero di Langer, seppur limitandola soprattutto al ruolo che essa ha
svolto nell’ambito degli studi di ermeneutica.
La posizione della Langer ha sempre attirato sostenitori. L’ “estetica
semiotica ,” di cui la teoria di Langer è un esempio imprescindibile,
ha avuto il suo apice tra il 1940 e il 1950. Questo tipo di teoria non è
molto più in voga tra i filosofi analitici anglo-americani dell’arte (si
veda, tuttavia, Tarasti 1987), ma il fantasma della teoria langeriana
sopravvive nell’ermeneutica europea 9 .
Innegabile quindi il fatto che è proprio a partire dal lavoro di Langer che il tema
del rapporto musica-emozioni è diventato protagonista – con una ricca fioritura soprattutto negli ultimi trenta anni – della riflessione filosofica sulla musica in area angloamericana. Come avremo modo di verificare in un secondo tempo, tutti coloro che si sono occupati di questo tema hanno dovuto fare i conti con le sue tesi, a volte anche tentandone il superamento. Quello di Langer, di fatto, è un merito riconosciuto anche da
7
Ibidem, pag. 97.
S. Davies, Musical Meaning and Expression, Cornell University Press, Ithaca, 1994.
9
Ivi, pag. 124. L’immagine di questa teoria come fantasma che sopravvive in Europa pensiamo sia massimamente esplicativa dell’importanza che essa ha avuto e, aggiungiamo, ha ancora oggi. Anticipiamo,
se pure prematuramente, che tale presenza è tangibile tanto quanto il fatto che ad oggi dall’impostazione
langeriana della relazione della musica con le emozioni come una relazione di tipo isomorfico quasi nessuno degli studiosi è realmente riuscito a prendere le distanze.
8
16
chi ha poi sviluppato metodi e prospettive diverse e dunque si è allontanato dalle sue
tesi 10 .
La musica torna così ad assumere all’interno del pensiero novecentesco un ruolo centrale, se non di primo piano, e sappiamo anche, adesso, che l’humus di questa
rinnovata attenzione alla musica ed ai problemi estetici che ad essa si legano è quello
dell’eredità tramandataci da Langer. Questo anche e soprattutto a dispetto di certe poetiche musicali novecentesche che hanno invece preferito dedicare la propria energia ed
attenzione ai problemi della tecnica e della forma, con un non trascurabile sospetto per
chiunque tentasse di indagare esteticamente o psicologicamente la portata emotiva della musica.
Il segno più manifesto di questa apertura si può cogliere nell’ambito di una vastissima produzione di scritti (articoli, monografie) interamente centrati sul nostro tema. Più precisamente, partendo dal riconoscimento che tra la musica (assoluta) e le
emozioni certamente deve esserci una qualche relazione, ci si interroga su questioni del
tipo:
1. In che modo è possibile giustificare tale relazione? In che senso può sussistere?
2. La musica ha una propria dimensione espressiva oppure la sua portata emotiva è inevitabilmente vincolata alla nostra risposta emotiva?
3. E, se la musica incarna le emozioni nella propria struttura ci si chiede ancora: in che modo la musica può esprimere le emozioni nella varietà delle loro
sfumature?
4. Qual è il ruolo delle proprietà espressive e quale il loro legame con la struttura musicale cui appartengono?
5. Che cosa significa essere profondamente commosso o impressionato dalla
musica?
10
Vedi, ad esempio, L. Addis, Of Mind and Music, Cornell University Press, New York, 1999, p. IX:
«Molti anni fa, quando ero studente universitario in musica e prima di intraprendere uno studio formale
della filosofia, lessi il libro di Susanne Langer, Philosophy in a New Key. Allora ero già stato colpito dal
potere della musica, e perciò il libro esercitò su di me un forte impatto, in quanto sembrava che contenesse una spiegazione plausibile del perché la musica è così importante per la vita di così tante persone e
ha una certa importanza nella vita di pressoché ciascun individuo. […] Sto raccontando questi dettagli
autobiografici non perché essi hanno qualcosa a che fare con la verità o con la plausibilità della teoria
della Langer o della mia, ma per individuare da subito quello che è il singolo e principale riferimento per
le riflessioni che seguono. La mia teoria è uno sviluppo e una estensione della sua, e, pur distinguendosi
per alcuni dettagli e soprattutto per lo scopo e per i fondamenti, non sarebbe stata possibile senza di essa».
17
6. Come intendere la nostra risposta emotiva alla musica?
7. Inoltre, altro problema nodale: la musica assoluta in quanto arte priva di testo, titolo o programma, ha una sua profondità, può essere in qualche modo
vincolata a contenuti rappresentativi determinati, oppure si tratta di un’arte
esclusivamente formale?
8. La musica può essere paragonata a un sistema simbolico simile a quello della lingua?
9. La relazione della musica con le emozioni è una relazione di tipo causaeffetto?
Ora, la possibilità di dare una descrizione adeguata di quelli che potremmo definire gli aspetti costitutivi dell’identità di questo dibattito su un tema e un’arte specifici, passa dall’individuazione dei “tratti comuni” che interessano e insieme strutturano
l’intero ambito della ricerca analitica 11 . Uno di questi “tratti comuni” è rintracciabile
nella tendenza a prediligere una scansione dei contenuti filosofici per problemi e soluzioni (cosa significa rappresentare un oggetto in pittura? La musica può rappresentare
qualcosa? Che cosa significa per un’immagine esemplificare qualcosa? Che tipo di piacere procura l’ascolto musicale? In che senso il tempo entra nella nostra percezione
della pittura? In che misura la storia della produzione di un’opera d’arte è rilevante per
il suo apprezzamento?). Interessante per noi è che quasi sempre il problema tende ad
essere affrontato con particolare attenzione ad una singola forma artistica (ci si interroga sull’ontologia dell’opera musicale, sulla rappresentazione nella pittura): esiste, per
così dire, un’attenzione particolare per le cosiddette “estetiche speciali” 12 .
Inoltre, tratto caratterizzante dell’impostazione analitica è quella che potremo
chiamare la “circolarità” della discussione. Mi riferisco al fatto che ciascuno degli aderenti al dibattito realizza, quasi sempre, l’opportunità di pervenire all’individuazione di
una propria chiave interpretativa o di aderire ad una determinata prospettiva, confrontandosi non solo con quelle teorie che hanno segnato la riflessione filosofica sulla mu11
Un’utile informazione a tale riguardo è quella di Paolo D’Angelo, il quale seguendo le indicazioni di
Franca D’Agostini, ripropone le quattro definizioni, mediante le quali si può tentare di dare risposta alla
domanda “Cos’è la filosofia analitica?”, (nella quale egli evidenzia rientra anche quella specifica
sull’estetica analitica): definizione storica (riferimenti ad autori e scuole), filosofica (assunzioni fondamentali e premesse metodologiche caratterizzanti), stilistica (forma del discorso e sviluppo argomentativo), metafilosofica (concezione della filosofia e dei suoi compiti). Cfr. F. D’Agostini, Che cos’è la filosofia analitica?, in F. D’Agostini e N. Vassallo, a cura di, Storia della filosofia analitica, Einaudi, Torino, 2002, pp. 3 sgg.
12
Per ulteriori approfondimenti cfr. Le arti nell’estetica analitica (a cura di) P. D’Angelo, cit., pag. 7-12,
49.
18
sica (tra queste, quella di Hanslick, Schopenhauer, Langer, Pratt, Meyer, Gurney, Cooke, Wittgenstein), ma anche e soprattutto creando una sorta di dialogo intrecciato, mediante il quale ognuno può rinviare costantemente alle posizioni teoriche dell’altro.
Nessuno di loro, infatti, rinuncia ad un continuo e reciproco scambio; quasi come se
questa conversazione si svolgesse attorno ad una tavola rotonda, nella quale le opinioni
rimbalzano continuamente da un punto all’altro senza uscire mai al di fuori di essa. Gli
esempi migliori a tale proposito sono quelli ricavati dall’esperienza diretta della lettura
di alcuni di questi saggi, per esempio quello di Malcolm Budd, il quale nella prefazione
a Music and the Emotions 13 , dopo avere introdotto il tema di questa sua opera, motiva
la scelta personale di costruire l’indagine proprio a partire da un attento esame delle
principali teorie del rapporto musica-emozioni, evidenziando il fatto che l’intento non è
certamente quello di fornire una ricostruzione di tipo storiografico, bensì di investigare
sulla possibilità o meno che esistano dinamiche relazionali tra suoni ed emozioni, per
approdare così ad una personale soluzione del problema. Ne consegue la scelta di operare secondo questo particolare metodo di confronto, vale a dire: valutando attentamente e portando all’esame critico quelle teorie che a parer suo rappresentano il contributo
più significativo sull’argomento, Budd tenta di creare le premesse necessarie ad un superamento di limiti e incongruenze riscontrate. L’applicazione di simile procedimento
favorisce l’individuazione di due linee teoriche generali, emblematiche: nella prima
colloca quel gruppo di studiosi (Hanslick, Pratt e Gurney) che ha cercato di dissolvere
qualsiasi tentativo di subordinazione della musica alle emozioni, siano esse
dell’ascoltatore, dell’esecutore o del compositore, mentre nella seconda prende in considerazione le teorie di coloro (Schopenhauer, Langer e Cooke) che per diverse ragioni
hanno invece pensato di subordinare il valore estetico della musica alla significante relazione con i sentimenti. Da questo tipo di suddivisione resta fuori invece la teoria di
Leonard Meyer, poiché – precisa Budd – si tratta di una teoria ibrida che cerca di conciliare i due opposti punti di vista, quello del “formalismo” e dell’“espressionismo”.
Se in questo caso specifico, come si è evidenziato, il percorso d’indagine si
struttura mediante l’unico canale dei riferimenti prelevati, molto selettivamente a dire il
vero, dalla tradizione del pensiero estetico, essendo questa un’opera del 1985, cioè di
un periodo in cui il dibattito cominciava a prender piede, esistono invece altri esempi 14
13
M. Budd, Music and the Emotions. The Philosophical Theories, Routledge and Kegan Paul, London,
1985, Prefazione, pp. x, xi, xii.
14
Cfr. ad esempio, Peter Kivy, New Essays on Musical Understanding, cit.; Id., Introduction to a Philosophy of Music, Oxford University Press, New York, 2002; trad. it. Filosofia della musica.
19
di opere nelle quali il riferimento alla tradizione filosofica viaggia accanto al dialogo
serrato con quelli che potremmo chiamare i compagni di viaggio, con quella comunità
di studiosi ed interpreti che si muove intorno allo stesso problema. È il caso anche di
dire che spesso questi due piani vengono ad intersecarsi strutturando così un campo di
tensione nel quale le varie posizioni gravitano, o come dicevamo poc’anzi, circolano
tutte in un’area comune che è quella di questa rinnovata attenzione alla musica e alla
relazione di essa con il sentimento.
Riassumendo, possiamo dunque dire che l’impronta circolare del dibattito definisce un metodo e incide anche sul piano propriamente stilistico dell’argomentazione
che è quello, parafrasando ancora una volta D’Angelo, nel quale forse si fa massima la
tensione fra analitici e continentali, in estetica, vale a dire: il relativo chiudersi degli estetici analitici nella propria tradizione che si incrocia peraltro e coesiste con l’altra
“chiusura alla storia dell’estetica”. Nella tavola rotonda attorno cui siedono questi studiosi, potremmo dire, che non tutti gli ospiti sono ben accetti. La tendenza degli analitici è infatti quella di fare cerchio non solo attorno ai problemi specifici inerenti le singole arti ma anche attorno ad una tradizione filosofica selezionata secondo criteri stabili.
In questo senso, la circolarità del dibattito è quindi da noi identificata come una
chiusura, che è pur vero, non sempre è del tutto ermetica. In effetti, come in parte abbiamo già evidenziato, non è difficile individuare quali sono i capisaldi teorici su cui
poggia la riflessione degli analitici sul tema qui in questione, vista la ricorrenza degli
stessi autori e delle stesse tesi come presupposti comuni della discussione. Potrei quindi come in uno schema così evidenziarli:
— l’impostazione langeriana del rapporto musica-emozioni;
— la concezione formalista di Eduard Hanslick;
— la teoria schopenhaueriana della musica;
— l’idea (Wittgenstein e Cooke) di una possibile analogia tra simbolismo musicale e simbolismo linguistico;
— il motto di Pratt “music sounds the way the emotion feel”, alla base delle tesi
isomorfiche;
Questo almeno per quanto concerne strictiori sensu le premesse storiche, mentre per
quello che riguarda da vicino il dibattito vivo, possiamo senz’altro individuare anche
qui come in uno schema le teorie più importanti:
Un’introduzione, Einaudi, Torino, 2007. Malcolm Budd, Music and the Emotions: The Philosophical
Theories, cit.; Stephen Davies, Musical Meaning and Expression, cit.
20
— La teoria cognitivista (Peter Kivy);
— La teoria metaforica (Nick Zangwill, Roger Scruton);
— La teoria della persona (Jerrold Levinson);
— La teoria della tendenza o del contagio (Stephen Davies);
— La teoria sintomatica delle emozioni o modello disposizionale (Derek Matravers);
— La teoria finzionale (Malcolm Budd)
In realtà, sappiamo anche che negli ultimi anni la ricerca analitica sta iniziando
a muoversi in una nuova direzione, cercando di colmare lo “spazio vuoto” derivato da
questa secchezza di riferimenti alla tradizione, e allo stesso tempo, lo abbiamo detto,
dalla circoscrizione dello spettro d’indagine alle tesi degli autori a loro prossimi. Viene
meno, per così dire, sul piano argomentativo quella copiositas, quella densità che scaturisce inevitabilmente dal reperimento dei loci communes o luoghi comuni, cioè degli
argomenti che l’esperienza ha accumulato relativamente a qualsivoglia soggetto di discussione. Si tratterebbe quindi, secondo l’insegnamento di Vico nella più celebre delle
sue sette orazioni inaugurali, la De nostri temporis studiorum ratione, di arricchire con
la topica il repertorio di argomenti 15 , per evitare che la ricerca si sclerotizzi intorno a
nodi problematici ripetitivi. Crediamo quindi che, come anche in questo caso ha saputo
bene evidenziare D’Angelo, il relativo chiudersi degli estetici analitici nella propria
tradizione è insieme un punto di forza e un elemento di debolezza:
Un punto di forza, perché il fatto che si parta da un numero limitato
di autori, prossimi nel tempo e omogenei (un po’come se si passa il
paragone, nei sistemi di common low vige il principio dello stare decisis), rende la discussione molto più intensa di quanto non appaia
nella nostra tradizione filosofica, dove le varie tradizioni spesso si
sovrappongono senza incontrarsi o, se si incontrano, non riescono a
dialogare veramente. Chi segua attraverso gli anni le due maggiori riviste dell’estetica analitica, il «Journal of Aesthetics and Art Criticism» americano e il «British Journal of Aesthetics» inglese, non può
non restare colpito dalla frequenza delle riprese dei medesimi temi o
problemi, e dal numero di saggi che dialogano con altri saggi. Questa
forza è però pronta a rovesciarsi in una debolezza. L’orientamento
quasi esclusivo verso autori di lingua inglese (parlo sempre
dell’estetica, questo vale meno per altra filosofia analitica) e recenti
non solo fa correre continuamente il rischio di cadere nella fallacia
della ignoratio elenchi (cioè nel lasciarsi sfuggire qualche soluzione o
15
Cfr. G. Vico, De nostri temporis studiorum ratione, Armando, Roma, 1974, pag. 25. Sappiamo che il
termine topica o inventio indica la prima delle cinque parti della retorica, quella concernente, appunto, il
reperimento dei topoi ovvero di tutti quegli aspetti sotto i quali è possibile considerare una questione.
21
proposta decisiva, solo perché formulata troppo tempo fa o in una
lingua diversa dall’inglese) ma affida una drammatica responsabilità,
diciamo così al capostipite della discussione 16 .
Ogni scelta è tale, definisce e allo stesso tempo struttura sempre un campo
d’azione, il prezzo da pagare è che tutto quello che in questo non rientra resta inevitabilmente ai margini, e forse è anche naturale le cose stiano così; è pur sempre vero però
che questo riconoscimento non dovrebbe nemmeno esimerci dal ponderare responsabilmente e accuratamente i pro e contro della scelta operata poiché è solo muovendosi
da tale consapevolezza che il cammino di ogni ricerca, di qualsiasi tipo essa sia, può
crescere, migliorarsi e arricchirsi. È in questo che riconosciamo meglio anche il segno
distintivo di ogni possibile percorso di ricerca. Di questa nostra invece vogliamo ripercorrere i momenti più significativi, se pur anche noi operando delle scelte nel ventaglio
molto ampio delle innumerevoli posizioni e spaziando nella complessità delle sottili
sfumature di certe proposte teoriche, soprattutto di quelle che rappresentano il maggiore contributo all’argomento. Ma di questo renderemo conto più avanti con maggiore
precisione. Per ora ci preme sottolineare, prima di concludere questa panoramica introduttiva, che un altro dei compiti fondamentali che speriamo di portare a termine in questa ricerca è quello di combattere contro il pregiudizio negativo che oramai da tempo si
registra in Italia nei confronti della ricerca analitica 17 .
C’è chi ci aiuta in questo. È stata appena edita da Einaudi la traduzione italiana
del testo di Peter Kivy, Introduction to a Philosophy of Music 18 . È una goccia d’acqua
nel deserto, ne pioveranno forse di nuove. Noi ce lo auguriamo, figurandoci nel pensiero che anche questo lavoro sul problema del rapporto musica-emozioni possa servire a
riscattare l’estetica analitica dalla dimensione marginale in cui è stata relegata fino a
non molto tempo fa. Ancora una volta, come ha saputo sottolineare D’Angelo, nel saggio al quale abbiamo più volte fatto riferimento in questo primo paragrafo, Analitici e
continentali, in estetica, e come vogliamo sottolineare anche noi:
Benedetto Croce diceva dei metodi della critica letteraria che sono
tutti buoni quando sono buoni. La stessa cosa si potrebbe ripetere a
16
P. D’Angelo, Analitici e Continentali, in estetica, cit., pp. 20-21.
Le ragioni di questa scarsa fortuna dell’estetica analitica presso di noi sono diverse. Anche in questo
caso preferiamo rinviare al breve, ma denso saggio di introduzione di Paolo D’Angelo, il quale fornisce
tutta una serie di valide indicazioni a tale proposito.
18
P. Kivy, Filosofia della musica. Un’introduzione, cit. In realtà, per completezza d’informazione, è anche giusto precisare che esistono traduzioni di altri saggi di filosofi angloamericani, dei quali solo alcuni
riguardano specificamente la musica.
17
22
proposito dei metodi filosofici. Per chi è interessato a discutere problemi, non ad attaccare etichette a questo o quel pensatore, le diatribe
sulle appartenenze, le scuole o gli orientamenti non possono che apparire oziose, quello che conta essendo quanto ognuno, dal proprio
punto di vista, può apportare alla chiarificazione del punto di cui si
discute. Se è in giuoco un problema identificabile, diventa subito manifestamente assurdo non prendere in considerazione quello che molti
altri hanno fatto per risolverlo19 .
E la filosofia della musica molto ci aiuta in questo cammino, se è vero quanto
Giovanni Piana ha affermato nel suo breve saggio Intorno alla filosofia della musica di
Susanne Langer:
Ad una filosofia della musica noi chiederemmo ciò che chiediamo alla
filosofia in genere: che aguzzi la nostra capacità di distinguere; che attiri la nostra attenzione su questo e quello, che ci fornisca strumenti
svariati e criteri, guide ed orientamenti per discutere problemi che sorgono sul terreno, e soprattutto che sappia insegnarci la complessità e ci
fornisca alcune tracce per penetrarla20 .
2. Premesse storiche
Ricostruiremo ora le premesse storiche del dibattito, tenendo conto del fatto che
gli autori di cui ci occuperemo sono autori complessi che in nessun modo abbiamo intenzione di affrontare, per così dire di petto, poiché scopo di questo primo capitolo è
quello di portare in chiaro solo i centri di interesse per il dibattito analitico. Nostro
compito sarà quello quindi di enucleare soltanto quanto della loro riflessione interessa
specificatamente il problema qui affrontato, la relazione tra la musica e le emozioni,
creando così un apparato teorico funzionale a quello che sarà il lavoro successivo. Lavoro mediante il quale, mettendo insieme i pezzi, perverremo ad una visione d’insieme.
Quello che intendo dire è che, una volta compiuto questo primo passo a ritroso, più facilmente potremo avvicinarci, ad esempio, alla concezione metaforica di Zangwill, vedere in che modo egli riprende la tesi hanslickiana, oppure capire quali differenze in19
20
P. D’Angelo, Analitici e continentali, in estetica, cit., pag. 23.
G. Piana, Intorno alla filosofia della musica di Susanne Langer, cit., pag. 14.
23
tercorrono, se differenze poi realmente sussistono, tra il formalismo arricchito (enhanced) di Peter Kivy e il formalismo, ancora una volta, di Hanslick. Si potrà inoltre far
emergere la straordinaria variabilità dei modi di intendere il sentimento, talora concepito come tonalità emotiva di fondo (pensiamo alla nozione langeriana di feeling,
nell’accezione più ampia di qualsiasi cosa possa essere sentito), o, ancora prima, come
sentimento in abstracto (Schopenhauer), e alla opposta concezione hanslickiana del
sentimento sempre determinato dal contesto d’esperienza. Nozione, quella del sentimento, sulla quale inevitabilmente si gioca la partita per gli estetici analitici, ma anche
per noi che tenteremo di orientarci, chiarendo le diverse prospettive teoriche, sia di
quelle che guardano al sentimento come prodotto di un’esperienza particolare, la quale
definisce l’intenzionalità del sentimento stesso, e negano quindi alla musica la capacità
di rinviare ad un simile contesto (presupposto sul quale, possiamo sin da ora anticipare,
si basa la cosiddetta teoria metaforica delle emozioni), sia di quelle che, spostando
l’oggetto intenzionale dal piano della vita a quello del suono, ritengono si possa parlare
di un vero e proprio sentimento della musica (la tesi in questo caso è quella alla base
della cosiddetta teoria cognitivista). Tenteremo, inoltre, di esplorare quelle teorie che ci
offrono una concezione anemica dell’emozione musicale, la teoria della persona e la
teoria del contagio, senza trascurare il riferimento alla tesi più osteggiata, quasi fosse
l’unico nemico da combattere, la cosiddetta teoria sintomatica delle emozioni o modello disposizionale.
Dalle tracce di questa parziale ed estremamente selettiva ricostruzione storiografica delle tesi di Schopenhauer, Hanslick e Langer, risaliremo quindi alle posizioni
teoriche degli autori che qui ci interessano, che sono poi gli stessi, come avevamo già
preannunciato, le cui teorie costituiscono il più significativo contributo all’indagine sul
tema musica-emozioni in area angloamericana. È su queste proposte teoriche, siamo
certi oramai, che s’innesta la discussione degli estetici analitici. Dalla nostra panoramica storica resteranno fuori, ma solo temporaneamente, altre tesi di autori – come Pratt,
Gurney, Cooke, Meyer e Wittgenstein – che occupano anch’essi un ruolo significativo
nell’ambito di questa indagine.
Faremo quindi con una rapida, ma intensa incursione, un percorso a ritroso
all’interno di quelle teorie che per diverse ragioni sono state elette da alcuni degli aderenti al dibattito come le più rappresentative della riflessione filosofica sul rapporto tra
musica ed emozioni, a partire dal diciannovesimo secolo: periodo nel quale, sappiamo,
affonda le radici se non tutta, almeno una buona parte, della discussione degli estetici
24
analitici su questa specifica problematica. A tale proposito, non ci sembra nemmeno
scontato segnalare il fatto che la loro decisione di operare destinando una maggiore attenzione a quel periodo storico in particolare, non è una decisione di per sé casuale,
bensì essa ci appare motivata e parallelamente guidata dal fatto che quello fu il momento in cui si realizzò per la prima volta una significativa e decisiva svolta rispetto al tradizionale modo di intendere l’espressività musicale 21 . Ad essere felicemente archiviato,
secondo Kivy, è proprio il modello disposizionale, che a partire dalla filosofia platonica, attraverso la camerata fiorentina nel XVI secolo, giunge ai nostri giorni con la cosiddetta “arousal theory of emotions”. La ‘convinzione’ che supporta tali teorie è che la
musica è triste o felice perché ha il potere di suscitare tali emozioni nell’ascoltatore. A
tale proposito, lo stesso Kivy, sostiene che la teoria schopenhaueriana delle emozioni
musicali è la prima delle due rivoluzioni che il diciannovesimo secolo produsse. La seconda avvenne nel 1854, nella forma di un libricino del musicista e critico musicale
viennese Eduard Hanslick 22 .
A queste due rivoluzioni, seguì un altro punto di rottura cui abbiamo già accennato. L’artefice questa volta fu Susanne Katherina Langer, la quale riuscì ad interrompere con la pubblicazione nel 1942 di Philosophy in a New Key, il silenzio che si determinò dopo l’uscita del trattato di Hanslick, favorendo così una vera e propria rinascita degli studi filosofici sulla musica. Una rinascita che continua ancora oggi. Interpelliamo ancora una volta Kivy, il quale così dispiega questi passaggi nell’itinerario di “una breve storia”, a partire dalla quale ripercorre, talvolta praticando voli pindarici, i risultati più significativi conseguiti dalla storia dell’estetica musicale sul tema musicaemozione 23 . Queste le sue parole a riguardo:
Più o meno sessanta sterili anni nella filosofia della musica, almeno
nel mondo anglofono, separano la maggiore opera di Gurney da quello che è considerato l’evento inaugurale, anche se un po’ prematuro,
della vera e propria rinascita delle discussioni filosofiche su queste
questioni negli Stati Uniti e in Inghilterra, rinascita che continua mentre sto scrivendo. Fu nel 1942 che Susanne K. Langer (1895-1985)
pubblicò la Philosophy in a New Key, un’opera che doveva avere una
21
Cfr. P. Kivy, New Essays on Musical Understanding, cit., pp. 92-97; Filosofia della musica.
Un’introduzione, cit., pp. 19-38.
22
P. Kivy, Filosofia della musica. Un’introduzione, cit., pag. 28.
23
Il riferimento è al secondo capitolo dell’opera Filosofia della musica. Un’introduzione, cit., pp. 19-38.
Avvertiamo che la scelta di ricorrere, per la spiegazione di alcuni passaggi (soprattutto in questa fase,
che è una fase, teniamo a precisare, preliminare del lavoro), alle tesi di un autore particolare, è dettata
semplicemente dalla semplificazione che l’attuazione di questo procedimento può favorire. Attuabile,
nella misura in cui, come avevamo precedentemente annunciato, uno dei presupposti accomunanti la discussione degli estetologi analitici è quello di ricorrere frequentemente agli stessi autori e alle stesse tesi.
25
profonda ripercussione sul pensiero musicale e che ricordò ai filosofi
dell’arte che la musica aveva fortemente bisogno della loro attenzione. In particolare la Langer ridiede slancio al dibattito sulla relazione
tra la musica e le emozioni.
Nonostante il suo titolo «musicale», Philosophy in a New Key non è
un libro di filosofia della musica; infatti, soltanto uno dei suoi capitoli, On significance in Music, è un diretto contributo a questo tema.
Tuttavia, ciò che la Langer sostiene qui a proposito del problema del
significato della musica, che ella crede sia in potenza un simbolo emotivo, toccò una corda ricettiva, dopo quasi cent’anni di scetticismo, particolarmente fra quei teorici e filosofi della musica che stavano forse cominciando a diventare anch’essi un po’ scettici riguardo
allo scetticismo emotivo di Hanslick, e stavano cercando una via
d’uscita 24 .
Prima di passare dunque al dibattito vivo degli estetici analitici, mi soffermerei
sulle premesse storiche che hanno sorretto e animato la discussione, isolando per ora
solo i nodi teorici che mi paiono più presenti in quel dibattito.
2. 1 ARTHUR SCHOPENHAUER
«L’arte, nodo cruciale in cui per Arthur Schopenhauer (1788-1860) si annodano
fino a confondersi il momento estetico, l’istanza etica e l’afflato mistico, è la prima via
della liberazione dall’illusione e dal dolore. Come desiderio sempre insoddisfatto la vita è pena e lo stesso piacere non vi costituisce che un momento negativo, una pausa nel
soffrire ininterrotto. Superato in maniera definitiva solo con l’ascetica estinzione della
volontà, il dolore cosmico (Weltschmerz) può essere almeno momentaneamente mitigato dall’azione, insieme rivelatrice e catartica, delle arti»25 .
Per iniziare, ci siamo serviti di questa citazione – tratta dall’Estetica musicale di
Giovanni Guanti – poiché riteniamo che in essa si trovino, rapidamente condensate, le
premesse fondanti la teoria dell’arte di Schopenhauer, al cuore della quale troviamo gerarchicamente collocata, in primo piano, la musica:
Dopo avere fin qui considerato, in quella forma generale che è adeguata al nostro punto di vista, tutte le arti belle, a cominciare
dall’architettura, il cui fine in quanto tale è di rendere chiara
24
25
Ivi, pp. 34, 35.
G. Guanti, Estetica musicale, La Nuova Italia, Firenze, 1999, pag. 324.
26
l’oggettivazione della volontà nel grado più basso delle sua visibilità,
dove essa appare come cupo premere della massa, automatico e privo
di conoscenza e tuttavia rivela già un’interna divisione e lotta, ossia
tra la gravità e la solidità; - per chiudere poi la nostra trattazione con
la tragedia, che, nel più alto grado di oggettivazione della volontà, ci
mette davanti agli occhi, con terribile grandezza e chiarezza, appunto
quel suo dissidio con se stessa; - troviamo che un’arte bella è rimasta
tuttavia, e doveva rimanere, esclusa dalla nostra trattazione, in quanto
nell’ordine sistematico della nostra esposizione nessun luogo era ad
esso adatto: è la musica. Essa se ne sta affatto isolata da tutte le altre.
In essa noi non riconosciamo l’imitazione, la riproduzione di una
qualche idea degli esseri del mondo; tuttavia essa è un’arte così grande e straordinaria e magnifica, agisce così potentemente sull’intimo
dell’uomo, viene qui così completamente e così profondamente da lui
compresa, come una lingua universalissima la cui chiarezza sorpassa
finanche quella dello stesso mondo intuitivo […] 26 .
Tra le arti, nella considerazione di Schopenhauer, la musica è certamente la
forma più alta: la ragione di questo privilegio accordato alla musica è la relazione di
essa con il principio metafisico, con la “cosa in sé” creatrice dell’universo, la Volontà
noumenica. Dal suo punto di vista, infatti, la musica è immagine della Volontà, anzi,
oggettivazione diretta della Volontà noumenica. Il mondo che ad essa appartiene è
quello delle Idee e non quello fenomenico della realtà sensibile cui sono vincolate invece le altre arti. Essa è libera dal mondo greve della materia sensibile, non è riflesso di
esso, né imitazione. Le altre arti oggettivano la volontà quindi solo mediatamente, per
mezzo delle idee, mentre la musica gode di un rapporto immediato con l’essenza, la
Volontà pura, vive al di là del mondo fenomenico, anzi
lo ignora e potrebbe in certo modo sussistere anche se il mondo non
fosse affatto: ciò che non si può dire delle altre arti; La musica è cioè
una oggettivazione e immagine di tutta la volontà, tanto immediata
quanto lo è il mondo stesso, anzi quanto lo sono le idee, la cui manifestazione moltiplicata costituisce il mondo delle cose particolari. La
musica non è dunque affatto, come le altre arti, immagine delle idee,
bensì immagine della volontà stessa, di cui anche le idee sono
l’oggettità. Perciò appunto l’azione della musica è tanto più potente e
penetrante di quella delle altre arti: queste, infatti, parlano solo
dell’ombra, quella invece dell’essenza 27 .
Ecco perché Schopenhauer pensa all’arte dei suoni come ad un’arte che agisce
potentemente sull’intimo dell’uomo e che intrattiene quindi un rapporto più intenso con
26
27
A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, Bompiani, Milano, 2006, pp. 509, 511.
Ivi, pag. 513.
27
la profonda interiorità del nostro essere. Raggiunge rapidamente la nostra anima con il
linguaggio universale del sentimento, esprimendo non «questa o quella gioia particolare e determinata, questo o quell’affanno o dolore o terrore o giubilo o allegria o tranquillità d’animo; bensì la gioia, l’affanno, il dolore, il terrore, il giubilo, l’allegria, la
tranquillità di spirito stessi, per così dire in abstracto, ciò che in essi è essenziale,
senz’alcun accessorio, e dunque anche senza i relativi motivi» 28 . Essa evoca quindi il
dolore senza il dolore, la gioia senza la gioia, la malinconia senza la malinconia, vale a
dire: può universalmente inglobare il mondo della vita senza dover però essere sintomo
di affezioni particolari. Questo è il carattere tanto eccezionale che alla musica Schopenhauer riconosce, quello di vincere la determinatezza dei sentimenti umani esprimendo solo la quintessenza della vita e dei suoi eventi. Viene così a determinarsi in
questa prospettiva una diversa concezione del sentimento della musica. Tale sentimento non è più quello dell’ascoltatore competente, ma è quello universale e indeterminato
della musica: il sentimento come tonalità emotiva (Fühlen) piuttosto che un sentimento
determinato (Gefühl). Da questo punto di vista si capisce quindi come la teoria schopenhaueriana rappresenti un momento significativo di svolta rispetto alla tradizionale
concezione dell’espressività musicale, la stessa che inaugurata da Platone è sopravvissuta pressoché invariata fino alla fine del XVIII secolo. Una concezione cosiddetta sintomatica delle emozioni musicali, vale a dire: la musica è triste, felice, malinconica
perché capace di suscitare tali sentimenti nell’ascoltatore. Questo non è più vero nella
prospettiva schopenhaueriana, è vero invece che l’espressività della musica appartiene
ad essa stessa, in essa soltanto si localizza e non nelle singole affezioni suscitate
dall’ascolto di una melodia, qualunque essa sia. È giusto anche sottolineare che localizzando così l’espressività della musica nella musica stessa, Schopenhauer non sta negando l’impatto emotivo della musica sull’ascoltatore, semplicemente vuole precisare
che non è in quell’impatto che possiamo rinvenire l’autentica essenza del sentimento
della musica quale dinamica tensiva di un sentimento in abstracto. Di fatto, come recentemente ha saputo bene evidenziare Silvia Vizzardelli nella sua Filosofia della musica:
La musica [nella considerazione di Schopenhauer] non ci racconta
una storia, non è espressione della vita e dei suoi eventi, non svela
motivi, ma fa risuonare un mondo di spiriti invisibile e dinamicamente mosso; non rivela la motivazione determinata del sentimento, la
28
Ivi, pag. 521.
28
sua storia, la sua particolare occasione, piuttosto riveste di carne ed
ossa un’invisibile dinamica 29 .
Fissiamo per ora l’attenzione su questi due aspetti della riflessione schopenhaueriana sulla musica, perché è proprio intorno a questi nodi tematici che si svilupperà
il dibattito analitico:
- L’espressività della musica non è una qualità che emerge nell’ascolto, ma è una proprietà della musica stessa;
- l’emozione musicale non gode di alcuna determinatezza o contestualità, non si ancora
ad alcuna esperienza determinata, perché è piuttosto un’archetipica dimensione tensiva,
l’anima del desiderio, un sentimento in abstracto appunto.
Su questi punti torneremo più di una volta quando si tratterà di rintracciare la
loro presenza nel dibattito vivo dell’estetica analitica.
2.2 EDUARD HANSLICK
Fino a oggi il modo in cui è stata considerata l’estetica musicale si è
basato su un grosso equivoco; cioè essa non cerca di conoscere cosa
sia il bello nella musica [Musik], ma fa una descrizione dei sentimenti
che questa suscita in noi. Queste ricerche corrispondono in tutto al
punto di vista di quegli antichi sistemi estetici che consideravano il
bello solo in relazione alle sensazioni [Empfindungen] che esso risveglia e che, come è noto, tenevano a battesimo anche la filosofia del
bello figli della sensazione (αίσθησις).
L’applicazione di queste estetiche, in sé e per sé non filosofiche, alla più eterea delle arti le attribuisce senza dubbio un qualcosa
di sentimentale che, se rallegra le anime belle, offre pochi chiarimenti
a colui che desidera apprendere. Chi cerca di sapere qualcosa
sull’essenza della musica desidera uscire dall’oscuro dominio del
sentimento e non esservi continuamente rimandato, come accade con
la maggior parte dei manuali.
L’impulso verso una conoscenza il più possibile oggettiva delle
cose, che nella nostra epoca muove tutti i campi del sapere, deve toccare necessariamente anche l’indagine sul bello. Questa potrà seguirlo soltanto se abbandona un metodo che parte dal sentimento soggettivo per ritornare di nuovo al sentimento, dopo una poetica passeggiata lungo tutta la periferia dell’oggetto. Se non vuol divenire affatto illusoria, l’indagine sul bello dovrà avvicinarsi al metodo delle scienze
naturali quel tanto da provare a sciogliere le cose stesse in carne e os29
S. Vizzardelli, Filosofia della musica, cit., pag. 31.
29
sa e di ricercare che cosa vi sia in esse di permanente e oggettivo,
prescindendo dalle mille diverse e mutevoli impressioni 30 .
Sostenuto da una formazione nella quale confluiscono istanze filosofiche di diversa provenienza, Hanslick realizza, con la pubblicazione nel 1854 de Il bello musicale, la necessità di opporsi alla diffusa concezione romantica della musica come “linguaggio dei sentimenti”. Idea antica, ma caricata di accenti particolari in quel periodo
storico e imperante nella concezione wagneriana della musica. A questa necessità egli
lega contemporaneamente quella di riportare in vita un metodo d’indagine attraverso il
quale far valere un’analisi il più possibile oggettiva dell’arte dei suoni. Un’indagine è
tale, nella considerazione di Hanslick, se riesce a distanziarsi dalle contaminazioni a
cui essa è esposta se assoggettata alle mutevoli impressioni dello spirito umano. Pur
consapevole, Hanslick, che certamente quello è il punto di partenza di ogni attività umana, la quale da quello spirito si diparte, si svolge, e vi ritorna.
Assunzione, quest’ultima, nella quale rinveniamo il crocevia di certe complessità che ancora si registrano rispetto ad alcuni ambiti teorici della riflessione hanslickiana
sulla musica, evidentemente pregnanti, ma ancora insoluti, vale a dire: come meglio
potremo evidenziare più avanti, diverse sono le occasioni in cui gli studiosi angloamericani interrogano la cosiddetta tesi formalista di Hanslick, secondo la quale la musica,
nuda e cruda, esibisce – se un contenuto la musica deve esibire – solo «forme sonore in
movimento». Tesi, questa, che pur non lasciando spazio, almeno apparentemente, a
fraintendimenti di alcun genere, si rivela spesso contraddittoria e pressoché paradossale
quando – come alcuni di questi autori fanno notare (tra questi Kivy, Budd, etc.) – accade che Hanslick per “descrivere” la musica, per “indicarci” la musica, per “spiegarcela”, così come per “informarci” del fatto che ad essa non appartengono i nostri stati
d’animo, qualunque essi siano, si trova a doverlo fare in termini emotivi. Ecco la ragione per cui Kivy, ad esempio, lo definisce ‘emotivista’ malgrè lui. Se questo accade,
osserva infatti Kivy, è perché evidentemente c’è qualcosa nella musica che solo questi
termini possono letteralmente descrivere, e perché le proprietà emotive della musica
non possono essere negate: «non possono non essere sentite, e Hanslick ha l’orecchio
per sentirle» 31 .
Prima di Kivy, anche Budd, si è soffermato – nel secondo capitolo di Music and
the Emotions dedicato interamente al problema del radicale ripudio delle emozioni da
30
31
E. Hanslick, Il bello musicale, Aesthetica Edizioni, Palermo, 2001, pag. 37.
P. Kivy, New Essays on Musical Understanding, cit., pag. 43.
30
parte di Hanslick – ad evidenziare con un’analisi piuttosto dettagliata e minuziosa i limiti riscontrati in seno a questa concezione.
Non vi è dubbio alcuno infatti, possiamo qui anticipare, che per questi ed altri
autori che potremmo definire, diciamo pure, post-formalisti, la concezione hanslickiana
può preservarsi integralmente per quanto concerne, diciamo così, la salvaguardia
dell’autonomia formale della musica, deve invece emanciparsi dalla negazione che
questa impostazione formale porta con sé, vale a dire dall’esclusione delle potenzialità
espressive della musica. Al centro dell’attenzione e della discussione degli studiosi angloamericani troviamo quindi le due tesi da cui prende le mosse la ricerca di Hanslick,
vale a dire:
a) tesi negativa, nella quale si afferma che la musica non deve “esibire sentimenti”;
b) tesi positiva, mediante la quale invece si stabilisce che «la bellezza di un brano
è specificamente musicale, essa cioè è insita nei suoni senza relazione con una
cerchia di pensieri esterni alla musica» 32 .
La teoria hanslickiana è certamente una di quelle teorie che ha tentato di liberare la musica da ogni implicazione possibile con i sentimenti. Di fatto, Hanslick partendo dal presupposto che l’ascolto musicale non deve essere necessariamente influente
sui sentimenti, poiché «l’effetto della musica sul sentimento non possiede né la necessità, né l’esclusività, né la costanza che un fenomeno dovrebbe presentare per poter costituire la base di un principio estetico» 33 , arriva anche a spiegare il fatto che nemmeno
l’espressione dei sentimenti è in potere della musica. Alla base di questa ulteriore e
quanto mai perentoria affermazione troviamo la concezione hanslickiana del sentimento. Una concezione, possiamo già anticipare, diametralmente opposta a quella di Schopenhauer, in quanto non può accogliere l’idea di una necessaria astrazione del sentire.
Prospettiva che si ribalta nella considerazione di Hanslick, secondo il quale ciò che ‘intenziona’ un sentimento è sempre un’esperienza particolare:
I sentimenti non esistono isolati nell’anima, pronti per poter essere estratti attraverso un’arte alla quale sarebbe negata l’esibizione delle
altre attività spirituali. Al contrario, essi dipendono da presupposti fisiologici e patologici, sono condizionati da rappresentazioni, giudizi,
ossia da tutto l’insieme del pensiero intellettuale e razionale, a cui si
contrappone volentieri il sentimento. Cos’è dunque che del sentimento in generale fa un sentimento determinato? Il desiderio, la speranza,
32
33
E. Hanslick, Il bello musicale, cit., pag. 34
Ivi, pag. 42.
31
o l’amore? O forse la semplice intensità o debolezza, o l’ondeggiare
di un movimento interiore? No di certo. L’intensità può essere uguale
in sentimenti diversi, ma può anche essere diversa nello stesso sentimento in individui e in epoche diverse. Solo in base a una certa quantità di rappresentazioni e giudizi – che nel momento di una forte
commozione forse sono inconsci – il nostro stato d’animo può concentrarsi in quel determinato sentimento. Il sentimento della speranza
è inseparabile dalla rappresentazione di uno stato futuro più felice rispetto a quello presente. La malinconia confronta una felicità passata
con il presente. Queste sono rappresentazioni determinate, concetti:
senza di essi, senza questo apparato concettuale l’affettività presente
non si può chiamare “speranza” o “malinconia”, è tale apparato concettuale che la determina. Se si astrae da esso rimane un vago moto
dell’animo o tutt’al più la sensazione di un generico benessere o malessere […] Un sentimento determinato (una passione, un’affezione)
non esiste come tale senza un reale contenuto storico, il quale può essere esposto soltanto mediante concetti» 34 .
È chiaro quindi che per Hanslick l’esibizione di un determinato sentimento o affezione non è assolutamente in potere della musica, poiché i sentimenti, egli sostiene,
sono introdotti esclusivamente dal nostro cuore: «questa può sussurrare, infuriare,
mormorare; ma l’amore o la collera sono introdotti solo dal nostro cuore» 35 . La musica
non ha il potere di raccontare un’esperienza determinata, di esibire sentimenti ancorati
ad un particolare contesto d’esperienza, e poiché il sentimento è sempre determinato
per Hanslick, allora dovrà dirsi che la musica non ha il potere di esibire emozioni. Che
cosa resta allora alla musica nella dimensione in cui Hanslick l’ha pensata, privandola
completamente del sentimento? Restano la serie di suoni, di forme sonore che hanno
contenuto solo in se stesse. Il contenuto di un brano musicale, spiega Hanslick, non è
altro se non le forme sonore udite, perché i suoni non solo sono ciò con cui la musica si
esprime, ma anche sono l’unica cosa espressa. La presenza di una certa affinità delle
strutture musicali a certi moduli dell’esperienza non deve perciò indurci a pensare erroneamente ai medesimi moduli come possibile contenuto della musica 36 . Non solo.
Hanslick ha anche chiarito che se si vuole decidere in merito al problema se la musica
possiede un suo proprio carattere, quali siano la sua natura e le sue proprietà, e quali i
suoi limiti e le sue tendenze, non si può prendere in considerazione altra musica che
quella strumentale, perché solo la musica strumentale è simpliciter musica. Esibire brani vocali o pezzi d’opera a riprova che tale connessione esiste è perfettamente inutile,
34
E. Hanslick, Il bello musicale, cit., pag. 46
Ibidem.
36
Come vedremo meglio in seguito questo è invece il nucleo teorico centrale su cui poggia la tesi della
metafora estetica di Nick Zangwill.
35
32
perché nella musica vocale o operistica è impossibile tracciare una distinzione così comoda tra gli effetti della musica e quelli delle parole, e “una definizione esatta della
parte che essi hanno nella produzione del tutto diventa impossibile”.
Ciò che la musica strumentale non può fare, non deve essere considerato possibile per la musica in quanto tale; infatti essa soltanto è musica pura e assoluta. Se si intende prediligere, per valore o effetto, la
musica vocale o quella strumentale – procedimento in cui domina per
lo più una dilettantesca ristrettezze di idee – si dovrà sempre ammettere che il concetto di “musica” non si adatta del tutto a un brano musicale composto sulle parole di un testo. In una composizione musicale l’efficacia dei suoni non è mai puntualmente separabile da quella
delle parole, dell’azione e dello scenario, da poter valutare esattamente la portata delle singole arti. Dobbiamo rifiutare anche pezzi con determinati titoli o programmi quando si tratta del “contenuto” della
musica. L’unione con la poesia allarga il potere della musica, ma non
i suoi limiti» 37 .
A partire da queste premesse Hanslick realizza l’obiettivo finale, quello esposto
nella tesi positiva, nella quale si afferma che l’autentico valore estetico della musica è
un “bello specificamente musicale”, vale a dire:
un bello che senza dipendere e senza abbisognare di alcun contenuto
esteriore, consiste unicamente nei suoni e nella loro artistica connessione. Le ingegnose combinazioni di suoni belli, il loro concordare e
opporsi, il loro sfuggirsi e raggiungersi, il loro crescere e morire, questo è ciò che in libere forme si presenta all’intuizione del nostro spirito
e che piace come bello 38 .
Ecco dunque i perni della riflessione hanslickiana che dovremo portarci dietro per
comprendere le principali articolazione del dibattito analitico:
- Il sentimento è sempre ancorato a esperienze determinate, non esiste una gioia in astratto, esiste solo una gioia che intenziona una particolare situazione d’esperienza;
- la musica, in quanto è essenzialmente musica pura, strumentale, o assoluta se vogliamo utilizzare un’espressione di Dahlhaus, non può vincolarsi a contenuti rappresentativi determinati;
- da ciò discende che la musica non può esprimere o esibire sentimenti.
37
38
Ivi, pag. 52.
Ivi, pag. 63.
33
2. 3 SUSANNE K. LANGER
Sappiamo già quanta e quale importanza abbia avuto la concezione langeriana
della musica. Facevamo notare infatti come sia stato proprio a partire dalla sua attenzione alla tematica musicale, che si è venuta a determinare nel dibattito analitico una
nuova tensione teorica intorno al tema del rapporto musica-emozioni. Langer è certamente artefice di questa apertura e di questo cambiamento di scena, grazie ai quali i riflettori si accendono nuovamente sulla musica. Tutti gli studiosi angloamericani, qualcuno direttamente qualcun altro implicitamente, sono concordi nel riconoscerle questo
merito, anche quando, come dicevamo in apertura, le loro convinzioni non hanno saputo trovare convergenza nella teoria della musica di Langer quale simbolo presentazionale o inconsumato. Teoria questa che senz’altro fagocita al suo interno, per riflesso,
l’intera teoria langeriana dell’arte. La significatività dell’arte, spiega infatti Langer, si
può esemplificare al meglio nella significatività distintiva della musica, sebbene questo
non equivalga a dire che la musica sia l’arte più alta, più espressiva o più universale, o
a voler comunque aprirsi a frettolose generalizzazioni. In Feeling and Form così scrive
a tale proposito 39 :
Nel libro cui il presente volume fa seguito c’è un capitolo intitolato
“On Significance in Music” [Sulla significanza nella musica]. La teoria della significanza ivi elaborata è una teoria particolare che non aspira ad altra applicazione oltre quella che ne è data nel suo ambito
originario, cioè appunto la musica. Tuttavia, più si riflette sulla significanza dell’arte in generale, e più la musica sembra fornire indizi
[…] Il giusto modo di costruire una teoria generale è, per generalizzazione, partire da una teoria particolare; e io ritengo che l’analisi
della significanza data in Philosophy in a New Key sia passibile di
una siffatta generalizzazione, e capace di fornire una teoria della significanza valida per l’intero Parnaso 40 .
Al centro di questa teoria troviamo la nozione chiave di simbolo, sulla quale si
struttura l’intero edificio della filosofia dell’arte di Langer. È questo infatti il piano su
cui poggia la giustificazione teorica del riconoscimento di un simbolismo diverso da
quello proprio della lingua, il cosiddetto simbolismo presentazionale: il simbolismo
della fantasia, del mito, del rito, dei sogni, dell’arte e di tutte quelle sfere dell’umana
39
A tale proposito, vogliamo evidenziare, che alcuni studiosi hanno manifestato un certo scetticismo rispetto alla possibilità intravista da Langer, di estendere la riflessione sulle altre arti, traendo così una teoria generale dalle osservazioni su un’arte particolare.
40
S. K. Langer, Feeling and Form: A theory of Art, New York, Scribner’s Sons, 1953; Sentimento e
forma, trad. it. a cura di Lia Fomigari, Feltrinelli, Milano, 1975, pp. 40-41.
34
esperienza che non possono essere adeguatamente simboleggiate dalle regole sintattiche e grammaticali proprie del simbolismo discorsivo. Il progetto langeriano è un progetto ampio e complesso 41 , nel quale confluiscono e convivono istanze filosofiche di
diversa provenienza, tra queste: vi è innanzitutto il riferimento, se pur polemico, al neoempirismo, ma anche l’avvicinamento, già dalla metà degli anni Trenta, al trascendentalismo neokantiano di Ernst Cassirer, alla psicologia della Gestalt ed all’impostazione
pragmatista di William James, la cui rilevante influenza si manifesta soprattutto a proposito della nozione di “feeling”. La nozione di simbolo è quella nella quale si riflette
maggiormente la coesistenza di questi diversi indirizzi teorici, ma anche la volontà di
Langer di operarne una revisione. Tale revisione si esplica nell’ambito di quella ricerca
intrapresa da Langer in Philosophy in a New Key 42 (1942) e proseguita in Feeling and
Form (1953). Nello specifico, nella prima opera Langer riesce a reperire la nuova chiave della teoria simbolica di cui si avvarrà in un secondo momento per affrontare l’altra
importante questione del rapporto dell’arte con il sentimento. Vediamo ora quindi in
che modo si struttura questo percorso di ricerca di Langer e quali sono gli esiti conseguiti, soprattutto per quanto concerne da vicino la teoria della musica.
Il primo passo in questa direzione è quello che si realizza sul fronte del confronto e della polemica con i filosofi neopositivisti, i quali, secondo Langer, hanno limitato
l’estensione del campo semantico a quello meramente linguistico, sostenendo che (1) il
linguaggio è il solo mezzo di articolare il pensiero e che (2) ogni cosa che non sia pensiero dicibile è sentimento 43 .
In realtà, dietro questa considerazione dei neopositivisti (il riferimento è, in particolare, alla teoria di Russell e Carnap, ma anche al Wittgenstein del Tractatus LogicoPhilosophicus) si cela, o per meglio dire, Langer vede celarsi un’angusta considerazio41
Come bene evidenzia Lucia Demartis, nel saggio L’estetica simbolica di Susanne Katherina Langer, si
tratta di un progetto articolato nel quale si può cogliere come «l’attenzione per il simbolismo e la strutturazione formale dell’esperienza, iniziata secondo una prospettiva logico-simbolica (A Logical Analysis of
Meaning, 1926; The Practise of Philosophy, 1930; An introduction to Symbolic Logic, 1937) e proseguita nell’esame di quegli aspetti dell’esperienza che da questa restano esclusi (Philosophy in a New Key: A
study in the Symbolism of Reason, Rite, and Art, 1942; Feeling and Form, 1953; Problems of Art, 1957;
Reflections on Art, 1958; Philosophical Sketches, 1962) giunge in Mind a interrogare la radice della simbolizzazione secondo un percorso antropologico e filogenetico che coglie nella funzione simbolizzatrice
ciò che caratterizza la relazione propriamente umana con la realtà. In Mind l’analisi del simbolismo viene inverata e portata a compimento attraverso il superamento della distinzione tra simbolicità discorsiva
e presentazionale, al fine di indagare l’ambito comune ad ogni produzione umana: l’articolazione formale dell’esperienza vissuta». L. Demartis, L’estetica simbolica di Susanne Katherina Langer, Aesthetica
Preprint, Palermo, 2004, pag. 8.
42
S. K. Langer, Philosophy in a New Key: A study in the Symbolism of Reason, Rite, and Art, Harward
University Press, Cambridge, Mass. 1942; Filosofia in una nuova chiave, trad. it. di G. Pettenati, Armando, Roma, 1972.
43
Ivi, pp. 122-123.
35
ne della razionalità umana, che risulta così essere relegata nei ristretti meandri della
simbolicità discorsiva. Intenzione di Langer è quella quindi di riscattarla, sottraendola
ai confini attribuitigli e restituendola agli ambiti ineffabili che sfuggono a quel tipo di
forma simbolica (quella della lingua, per l’appunto), ma non si negano alla forma simbolica presentazionale.
Esistono differenti sistemi simbolici quindi, ai quali Langer riconosce la possibilità di articolare la ricchezza e la complessità dell’umano sentire44 . Si tratta di
un’ipotesi, questa, che Langer ha formulato combinando i risultati conseguiti da Cassirer e dagli psicologi della Gestalt. Le conclusioni cui è pervenuta a seguito di questa
sintesi possono essere così semplificati:
a) La significazione avviene mediante simboli;
b) L’attribuzione di significati precede la sfera della concettualizzazione
logico-discorsiva.
Sono questi gli assunti, peraltro, mediante i quali si è presentata a Langer l’opportunità
di provvedere:
c) All’estensione della nozione di “simbolo”;
d) Alla revisione della nozione di “astrazione”.
L’attività di trasformazione simbolica è per Langer un’attività naturale e caratteristica dell’uomo, che precede l’ambito della simbolizzazione discorsiva, in quanto il
primo processo di organizzazione simbolica della realtà è quello che si realizza sul piano della nostra esperienza percettiva. In altri termini, ancor prima del pensiero esiste la
nostra costituzione fisiologica pura e semplice, e la nostra esperienza più puramente
sensoriale, dice Langer, è già un processo di formulazione, là dove i nostri occhi, le nostre orecchie, in una parola i nostri organi di senso, sono il primo accesso al mondo:
Già la nostra esperienza più puramente sensoriale è un processo di
formulazione: il mondo che in realtà colpisce i nostri sensi non è un
mondo di “cose”, circa le quali siamo invitati a scoprire fatti non appena si sia codificato il necessario linguaggio logico che permetta di
farlo; il mondo della pura sensazione è così complesso, così fluido e
pieno, che la pura sensibilità agli stimoli andrebbe incontro solo a ciò
che W. James ha chiamato con una frase caratteristica, “una florida e
rumorosa confusione”. Da essa i nostri organi di senso debbono sele44
Anche in questo caso, si rivela preziosa l’indicazione della Demartis, la quale ha evidenziato: «La distinzione tra i due sistemi simbolici esprime la contrapposizione tra due modi di intendere la razionalità:
una razionalità che opera attraverso simboli dalla denotazione più univoca possibile, risultanti da convezioni codificate e collegati mediante successione e calcolo; e una razionalità concepita come insight, intuizione di una relazione tra più elementi, che si esprime nella forma pregnante di una significanza polisemica. L. Demartis, L’estetica simbolica …, cit. pag. 7.
36
zionare certe forme predominanti, se debbono riuscire a registrare cose e non puri “sentiti” confusi […] Un oggetto non è un dato, ma una
forma costruita dall’organo sensitivo e intelligente, e che è, al contempo, una cosa individuale esperita e un simbolo del suo concetto45 .
La razionalità umana, in quanto capacità di organizzazione formale della realtà,
individuazione di schemi ordinativi, viene da Langer fatta confluire in ambiti che sino
ad allora erano stati considerati prerazionali: il processo di astrazione simbolica, di fatto, si realizza già a livello di insight sensoriale. È chiaro quindi che da questo punto di
vista l’articolazione formale della realtà in cui viviamo è, a parere di Langer, prerogativa della nostra percezione ancor prima che della razionalità discorsiva. Da questa acquisizione si apre la strada per un simbolismo diverso, presentazionale, adatto ad articolare e a costeggiare l’ineffabile: si tratta dell’articolazione dell’umano sentire, di
quella sfera, teniamo a sottolineare, che la filosofia neopositivistica aveva confinato
nell’ambito del sentimento incomposto. La mente secondo questa prospettiva langeriana ha un raggio d’azione più ampio perché ogni simbolo ha il suo significato, non esistono simboli che restano esclusi dall’ambito della significazione.
La teoria langeriana dell’arte s’impianta su questo terreno, fondandosi sulla
considerazione che la significatività dell’arte si dispiega nell’articolazione simbolica
del sentimento. È il caso di aggiungere, prima di passare alla discussione di Langer
sull’espressività, o come lei ha preferito definirla, sulla significatività della musica, che
il sentimento nella sua concezione è di più di quello che comunemente associamo a
questo termine. Tale nozione, oltre che essere scevra da qualsiasi tipo di connotazione
romantica, rinvia infatti alla definizione di “feeling” che William James ha introdotto e
sviluppato nei Principi di Psicologia 46 , dove il termine “feeling” viene utilizzato sia in
riferimento alla coscienza (feeling of relations, feeling of tendency, the feeling of rational sequence), sia al sé (self feeling), allo spazio (the feeling of crude extensity), alle
emozioni. In altri termini, “feeling” nel senso più ampio di qualsiasi cosa possa essere
sentita 47 . Per Langer l’opera d’arte ha infatti una “portata” che è «la struttura della vita
stessa com’è sentita e direttamente conosciuta» 48 .
45
S. K. Langer, Filosofia in una nuova chiave, cit., pag. 126.
W. James, The Principles of Psychology, London, Macmillan & Co, 1901; 1ª ediz. H. Holt, v. I, 1980.
47
Cfr. S. K. Langer, Problems of Art, New York, Charle’s Scribner’s Sons, 1957; tr. it. di M. Attardo
Magrini, Problemi dell’arte, Milano, Il Saggiatore, 1962, pag. 28.
48
S. K. Langer, Sentimento e forma, cit., pag. 48.
46
37
Alla luce di quanto sinora esposto, veniamo ora ad occuparci della concezione
langeriana della musica come simbolo incompiuto e degli esiti fondamentali di questa
sua concezione.
La musica sostiene Langer si avvale della possibilità di esser “vera” rispetto alla
vita del sentimento, di rivelare là dove le parole oscurano, di veicolare simboli capaci
di sempre nuove significanze, di essere quindi: simbolo inconsumato. Ma se la musica
ha una qualche significatività, tiene a precisare Langer, questa è semantica non sintomatica: «si tratta di un “significato” non tale da funger da stimolo per evocare emozioni, né da segnale che le annunzi; se la musica ha un contenuto emotivo, lo “ha” nello
stesso senso che il linguaggio “ha” il suo contenuto concettuale; cioè simbolicamente.
La musica non è causa o terapia di sentimenti, ma la loro espressione logica» 49 .
In tal senso, appare dunque evidente il fatto che Langer rifiuti una considerazione della musica basata sul doppio punto di vista: quello del compositore e
dell’ascoltatore. La musica cioè, così come le altre arti, non è spiegabile né nella prospettiva dell’autoespressione né in quella dell’impressione: una teoria dell’arte che fornisca una tale interpretazione della musica non è infatti una teoria apprezzabile. Nulla
ci dice del problema che per eccellenza alla musica pertiene, un problema di tipo logico. La soluzione a questo problema Langer l’ha individuata impostando la relazione
della musica con le emozioni come una relazione di tipo isomorfico. La musica ha sì
una relazione con la nostra vita emotiva – Langer non nega certo questa possibilità –
ma si tratta di una relazione di tipo analogico che s’instaura, appunto, per via della similarità che esiste tra le proprietà strutturali formali proprie della musica e quelle del
“feeling”. A conferma di quanto detto, Langer si è così espressa:
le strutture tonali che noi chiamiamo “musica” hanno una stretta somiglianza logica con le forme del sentimento umano: forme di sviluppo e decrescenza, di flusso e di accumulo, di conflitto e di soluzione, di rapidità, arresto, somma eccitazione, calma, o attivazione
sottile e cadute nella sfera del sogno; non gioia e dolore, forse, ma il
mordente dell’una o dell’altra o di entrambi; la grandezza e la brevità
e l’eterno trascorrere di tutto ciò che è vitalmente sentito. Questo lo
schema, o la forma logica, del sentire; e lo schema della musica è
quella forma stessa, elaborata nella purezza e nel metro del suono e
del silenzio. La musica è un corrispondente tonale della vita emotiva 50 . Una tale analogia formale, o congruenza di strutture logiche, è
la condizione prima per una relazione fra un simbolo e tutto ciò che
49
50
S. K. Langer, Filosofia in una nuova chiave, cit., pag. 281.
Corsivo mio.
38
questo deve significare. Il simbolo e l’oggetto simbolizzato devono
avere una qualche forma logica in comune» 51 .
La musica per Langer può riflettere quindi solo la morfologia dei sentimenti,
avvalendosi di simboli impliciti anziché di simboli trasparenti quali sono quelli di cui
invece si avvale il linguaggio: l’articolazione è la sua vita, non l’asserzione;
l’espressività lo è, non l’espressione 52 .
Isoliamo quindi anche in questo caso le nozioni-chiave che ci accompagneranno nel
corso della nostra ricerca:
- La musica intrattiene una relazione intima con la vita emotiva.
- La musica non esprime sintomaticamente le emozioni, ma esprime simbolicamente le
forme del sentire.
- Esiste dunque un rapporto isomorfico tra musica ed emozioni.
Concezione, in particolare, quest’ultima, come emergerà con chiarezza in un
secondo tempo, che, a nostro avviso, opera sotterraneamente anche laddove viene dichiarata inutilizzabile. Si tratta di quella tesi che abbiamo qui voluto caratterizzare come una risposta “dal basso”, secondo la quale per l’appunto l’espressività della musica
risiede in una somiglianza tra la musica e il comportamento espressivo umano. Una
somiglianza che si dà nell’immediatezza della nostra esperienza percettiva.
3. Externality claim vs Arousal theory
Buona parte della comunità degli estetologi analitici, partendo dal comune riconoscimento che esista una speciale connessione tra la musica e le emozioni, si trova oramai da tempo impegnata a spiegare in che termini tale relazione possa sussistere,
quali ne siano le motivazioni profonde. Da una parte troviamo la musica dall’altra invece le emozioni. Si tratta, come bene evidenziato da Martha Nussbaum 53 nel libro
L’intelligenza delle emozioni (2001), di due mondi apparentemente diversi:
quello delle emozioni dell’ascoltatore, e quello delle qualità espressive della musica. Da un lato, ci chiediamo come dobbiamo intendere
51
S. K. Langer, Sentimento e forma, cit., pag. 43.
Ricordiamo che Langer rifiuta la possibilità di parlare della musica come linguaggio dei sentimenti.
53
M. Nussbaum, L’intelligenza delle emozioni, Il Mulino, Bologna 2004.
52
39
le emozioni che proviamo quando ascoltiamo musica: sono emozioni
«reali» o no? Che tipo di emozioni sono? A chi appartengono? Qual
è il loro oggetto intenzionale e il loro contenuto? Dall’altra, ci interroghiamo sulle nostre attribuzioni di qualità emotive alla musica
stessa: cosa stiamo effettivamente facendo quando diciamo che
l’ultimo movimento del Concerto per violino di Beethoven è gioioso?
Che nell’Ouverture delle Ebridi di Mendelssohn c’è un’espressione
di speranza? Che lo scherzo della Seconda sinfonia di Mahler esprime un sardonico disgusto nei confronti della vita quotidiana? Formuliamo questi giudizi certi che tali attribuzioni ci dicano qualcosa a
proposito della musica stessa. E facciamo anche delle distinzioni più
sottili, attribuendo diverse sottospecie di una singola emozione. Per
esempio, sento di essere arrivata a cogliere qualcosa a proposito della
musica, e non solo delle mie reazioni private, allorché, paragonando i
movimenti conclusivi dei concerti per violino di Dvořák e Beethoven,
affermo che entrambi esprimono una forma di intensa ed esuberante
gioia, ma che quella del primo è più riflessiva, più solida e in un certo
senso più attiva, e quella del secondo è una vertiginosa euforia, fuggevole e capricciosa. E ancora, se paragoniamo il Liebestod del finale
del Tristano di Wagner con il duetto complessivo «Pur ti miro pur ti
godo» di L’incoronazione di Poppea di Monteverdi […], possiamo
dire che entrambi esprimono la passione sessuale, e il trionfo della
passione sulle norme morali – ma in modi molto diversi. Il Liebestod
esprime un tragico struggersi infinito, irrisolto, in cui la felicità fisica
è costantemente lontana; il duetto di Monteverdi esprime un completo
immergersi nella gioia dei sensi, ed è in effetti una straordinaria rappresentazione musicale del rapporto sessuale. Il problema è, dunque:
che cosa significa tutto questo? Stiamo realmente dicendo qualcosa
di valido sulla musica, quando diciamo cose del genere? 54 ».
Senza prendere in esame la teoria delle emozioni della Nussbaum, che non può
a rigore essere inquadrata all’interno della cornice in senso stretto analitica 55 , diamo
tuttavia uno sguardo rapido alle domande contenute nel passo che abbiamo appena citato. Affiora infatti in esso tutta la portata problematica di una questione sempre ricorrente nella storia del pensiero musicale. La sfida è quella di capire come le emozioni possano essere in qualche modo vincolate alla struttura musicale, poiché ogni qualvolta si
tenta di spiegare il nesso della musica con le emozioni ci si trova poi nella difficoltà di
stabilire quale emozione associare alla musica. In altri termini, quando diciamo che un
passaggio musicale è doloroso, gioioso, malinconico, ecc., stiamo parlando della capa54
Ivi, pp. 306-307. Corsivo mio.
La teoria di Martha Nussbaum può essere considerata come una teoria cognitiva dell’emozione, che
rivolge particolare attenzione alla condizione dell’ascoltatore, e della soggettività nell’atto creativo piuttosto che all’espressività come proprietà estetica della musica stessa. Il sentimento, in questo quadro, resta strettamente vincolato ad esperienze particolari di vita, che possiamo senz’altro considerare come il
contenuto intenzionale che appartiene all’emozione stessa. Come si vede, si tratta di una tesi assimilabile
perciò a quella hanslickiana, secondo la quale un sentimento determinato non esiste come tale senza un
reale contenuto storico.
55
40
cità della musica di suscitare un’emozione in noi oppure stiamo attribuendo una tale
emozione alla musica stessa, come una proprietà che percepiamo in essa? Se scegliamo
la seconda ipotesi, dobbiamo ancora domandarci come un’emozione possa appartenere
alla musica?
Anticipiamo sin da ora che questo è il problema certamente più dibattuto negli
ultimi cinquant’anni dall’estetica analitica; occorre cioè stabilire in quali termini è possibile giustificare una descrizione della musica in termini espressivi, posto che per i filosofi analitici una simile descrizione risulta essere perfettamente sensata.
In realtà le cose non sono poi così semplici come appaiono a prima vista, poiché
se è vero che quasi tutti gli studiosi si trovano in sintonia rispetto a questo riconoscimento, non sono poi altrettanto d’accordo sul tipo di soluzione proposta. Esistono delle
divergenze marcate soprattutto tra quei filosofi della musica che sostengono la tesi secondo cui l’espressività della musica possa e debba essere ricercata nella musica, come
ad essa appartenente, e coloro invece che credono di potere rendere conto di una spiegazione della musica in termini espressivi guardando piuttosto alle emozioni generate
dall’ascolto musicale. La prima tesi è portata avanti dai teorici cosiddetti cognitivisti o
sostenitori dell’externality claim, requisito dell’esternalità – definizione coniata da Jerrold Levinson nell’opera The Pleasures of Aesthetics 56 per identificare questa concezione particolare dell’espressività musicale –, mentre la seconda è sostenuta dai teorici
della nota e controversa Arousal Theory, teoria disposizionale.
In generale l’impegno del primo gruppo di filosofi è quello di stabilire come
un’emozione possa essere nella musica. E, più precisamente, in conflitto con l’istanza
formalistica hanslickiana, di difendere l’idea che l’espressività della musica sia inequivocabilmente vincolata alla struttura musicale, come una sua proprietà o un aspetto di
essa, piuttosto che vincolata all’esperienza emotiva, percettiva, di chi ascolta, compone, esegue. Riecheggia, notavamo, ancora una volta, in questa ipotesi interpretativa il
riferimento alla teoria paradigmatica per eccellenza nel contesto analitico, la teoria
hanslickiana quale teoria a cui guardare ma da cui dover poi velocemente rifuggire.
Con Hanslick, di fatto, i teorici analitici sostenitori del requisito dell’esternalità si trovano in perfetta sintonia quando egli spiega che non è nelle nostre attribuzioni di qualità emotive alla musica che possiamo rinvenire il reale valore estetico di essa (teoria
metaforica delle emozioni in musica). Non hanno quindi nulla da obiettare quando egli
s’impegna risolutamente a sgomberare il mondo della musica dalle affezioni particolari
56
J. Levinson, “Musical Expressiveness,” in The Pleasures of Aesthetics, Cornell University Press,
Ithaca and London, 1996, pag. 91
41
suscitate dall’ascolto, da quel dominio del patologico che impediva la possibilità di
guardare alla musica come mondo a se stante, libero dalle proiezioni della nostra vita
emotiva. Torna certamente utile ricordare quanto Hanslick ha affermato a tale proposito:
L’ascoltatore gode attraverso una pura contemplazione [Anschaung]
il pezzo musicale eseguito e ogni interesse per il contenuto deve essergli lontano. Tuttavia un interesse per il contenuto è la tendenza a
lasciar eccitare in se stessi le affezioni. Se il bello interessa esclusivamente l’intelletto, siamo nel campo della logica, non dell’estetica;
se esercita un effetto dominante sul sentimento, si ha un fatto ancora
più preoccupante, vale a dire un fatto patologico. Tutto ciò, sviluppato già da tempo dall’estetica generale, vale altrettanto riguardo al bello di ogni arte. Se dunque si considera la musica come arte bisogna
riconoscere come sua istanza estetica la fantasia e non il sentimento.
Questa breve premessa ci sembra opportuna, perché in maniera indefessa si ritiene che con la musica si ottenga un’influenza calmante
sulle passioni umane, finendo spesso col non sapere più se si parli
della musica come di una norma di polizia, di pedagogia o di medicina 57 .
In realtà è ben noto il fatto che questo riconoscimento spinse Hanslick a negare
qualsiasi possibilità di dare descrizioni della musica in termini espressivi, poiché
l’unico significato estetico che egli riconosce alla musica è quello della sua bellezza
formale, delle forme sonore in movimento, nient’altro. Le cose non stanno così invece
per i sostenitori del requisito dell’esternalità i quali manifestano uno scetticismo pressoché radicale rispetto a questa istanza teorica. Urge infatti, dal loro punto di vista, il
bisogno di ripensare il problema dell’espressività musicale all’interno di una prospettiva che accetta, è vero, i presupposti di un’impostazione formalistica, ma non ne condivide gli esiti. È possibile cioè salvare l’espressività musicale a partire da premesse formalistiche. Ma a questo punto, preannunciavamo, sorge il problema di stabilire come si
possa vincolare un’emozione alla struttura musicale.
Una prima conferma a quanto sinora esposto è quella che ci viene da Kivy, il
quale così ci informa della mutata condizione:
Fra i filosofi della musica è andato crescendo il consenso sul fatto
che, contrariamente alla affermazioni scettiche di Hanslick, sia perfettamente sensato descrivere la musica in termini espressivi e che,
ancora contrariamente alla affermazioni scettiche di Hanslick, fra gli
57
E. Hanslick, Il bello musicale, cit., pag. 40.
42
ascoltatori qualificati l’accordo relativo a ciò che la musica esprime
in ogni singolo caso, qualora essa sia espressiva di qualcosa (cosa che
non è necessariamente sempre vera), sia più o meno generale. Più
precisamente è cresciuto il consenso relativamente al fatto che la musica possa essere, e spesso è, espressiva delle emozioni comuni, come
il dolore, la gioia, la paura, la speranza e poche altre emozioni fondamentali come queste. C’è un consenso generale anche sul fatto che,
quando diciamo che un passaggio musicale è doloroso, pauroso, o
simili, non stiamo descrivendo una disposizione della musica di suscitare un’emozione in noi, ma stiamo attribuendo una tale emozione
alla musica stessa, come una proprietà che percepiamo in essa 58 .
Fra quei filosofi della musica, siamo certi, Kivy riconoscerebbe anche se stesso.
Anch’egli in disaccordo con l’idea di Hanslick che nega il valore espressivo della musica si muove oramai da tempo nella direzione opposta. Kivy è infatti dell’opinione che
dietro quella negazione si celi una vera e propria contraddizione, dal momento che è
Hanslick stesso il primo a dare una descrizione della musica in termini emotivi quando
si trova impegnato nella sua attività di critico. Questo dimostrerebbe il fatto che c’è
qualcosa nella musica che solo in quei termini può essere descritto e per Kivy questo
qualcosa sono le sue proprietà emotive. La musica, egli sostiene, pur essendo un mero
gioco formale ha a che fare con le emozioni (formalismo enhanced, “arricchito”). E,
più precisamente, le emozioni appartengono alla musica come sua qualità percettiva.
Da questo punto di vista, capiamo bene, che una musica è triste, allegra, malinconica,
ecc., non per la sua capacità di destare, stimolare in noi questi sentimenti o, in quanto
proprietà rappresentazionale, cioè in quanto rappresentazione di un’emozione particolare, bensì perché essa stessa possiede questa emozione nelle sue proprietà acustiche. Esiste, per così dire, un sentimento del suono che può essere un sentimento altro da quello che proviamo direttamente nell’ascolto. Vale la pena riportare il passo in cui troviamo chiaramente esplicata questa concezione di Kivy:
A non essere contemplata era la possibilità che la musica sia triste in
virtù del fatto di possedere la tristezza come una proprietà acustica,
allo stesso modo in cui una palla da biliardo possiede la rotondità e
l’essere-rossa come una sua proprietà visiva. Ma, una volta concepita
la possibilità delle proprietà emotive come proprietà acustiche della
musica, diviene allora immediatamente evidente che le descrizioni
emotive della musica sono compatibili con il «formalismo», inteso
ampiamente come la dottrina, delineata nel capitolo precedente, secondo cui la musica è una struttura di eventi sonori senza contenuto
semantico o rappresentazionale. Infatti, se le proprietà emotive come
58
P. Kivy, Filosofia della musica. Un’introduzione, cit., pag. 39.
43
la tristezza sono proprietà acustiche della musica, sono semplicemente proprietà della struttura musicale; pertanto dire che un passaggio
musicale è triste o allegro non significa descriverlo in termini semantici o rappresentazionali più che descriverlo come turbolento o tranquillo. Un passaggio musicale tranquillo non rappresenta la tranquillità né significa «tranquillo». Esso è semplicemente tranquillo. E lo
stesso vale per un passaggio malinconico. Non significa la «malinconia» né rappresenta la malinconia. È semplicemente malinconico, è
questo è tutto 59 .
È in questi termini quindi che Kivy spiega l’espressività musicale, vale a dire:
pensando all’emozione musicale come percepita in quanto presente nella musica. Questo modo di comprendere le emozioni musicali, come bene evidenziato da Kivy, fu ben
compreso dallo scomparso filosofo americano Oets. K. Bouwsma 60 , il quale sosteneva
che la relazione tra l’emozione e la musica assomiglia più alla relazione tra il rosso e la
mela, che a quella tra il rutto e il sidro. Bouwsma intendeva qui vincolare l’espressività
musicale alle qualità strutturali della musica per fuggire all’idea che essa potesse assumere un mero valore sintomatico. Si tratta di una spiegazione dell’espressività musicale
rispetto alla quale però Kivy si trova d’accordo sino a metà strada, e cioè fino a quando
l’emozione viene collocata nella musica come sua qualità piuttosto che in noi in quanto
da essa causata, ma che non è più valida nei modi in cui questa possibilità viene descritta.
C’è poi chi, come Roger Scruton 61 , individua la possibilità di dare una descrizione dell’espressività musicale come qualità terziaria. L’emozione, infatti, sostiene
Scruton, non può appartenere alla musica né come sua qualità primaria, cioè una proprietà fisica di un oggetto, né come sua qualità secondaria, poiché in tal caso qualunque
creatura dotata di capacità percettiva potrebbe riconoscerla; capacità che sappiamo appartiene tanto agli animali umani quanto a quelli non-umani. Questi ultimi però possono avere la percezione dei colori, ma non quella di un’emozione, qualunque essa sia,
dal momento che l’emozione non implica solo il coinvolgimento della nostra capacità
sensoriale, ma anche il concorso di intelletto e immaginazione. In questo Scruton rivela
la sua ascendenza kantiana poiché il sostegno scelto a convalida di questa sua teoria è
quello che ricava direttamente dalla teoria kantiana del libero gioco delle facoltà. In
59
P. Kivy, Filosofia della musica. Un’introduzione, cit., pp. 108-109.
O. K. Bouwsma, “The Expression Theory of Art”, in Id., Philosophical Essays, Lincoln, University of
Nebraska Press, 1969, p. 49.
61
R. Scruton, The Aesthetics of Music, Oxford University Press, New York, 1997.
60
44
un’ottica cognitivista, si annoverano, come vedremo, anche le tesi di Levinson, Davies,
Budd.
In netta rottura, avevamo anticipato, con la spiegazione che i teorici del requisito dell’esternalità danno dell’espressività musicale troviamo i teorici disposizionalisti,
o sostenitori dell’Arousal Theory. È loro convinzione infatti che la musica possa esprimere le distinte emozioni per la sua predisposizione a causarle nell’ascoltatore. Si
tratta quindi di una tesi diametralmente opposta a quella di chi, abbiamo potuto constatare, vuole decisamente prendere le distanze da una descrizione del rapporto tra musica-emozioni tutta sbilanciata dalla parte della reazione emotiva dell’ascoltatore, ritenendo che questo modo di vedere finisca per caratterizzare l’esperienza musicale alla
stregua di esperienze ordinarie della vita quotidiana. Questo invece non costituisce un
problema per chi come Derek Matravers 62 riabilita versioni più o meno forti
dell’Arousal Theory, poiché per poter dare un’adeguata descrizione della musica in
termini espressivi – egli sostiene – è necessario ricondurre l’esperienza emotiva musicale all’esperienza comune dell’emozione. La tristezza, la malinconia, o qualsiasi altra
emozione quindi, non risiede nella musica, bensì nella sensazione che quella musica ha
eccitato nell’ascoltatore. Dal suo punto di vista in effetti, ciò che la musica eccita in noi
non è un’emozione vera e propria, bensì una sensazione. Ragione per cui possiamo descrivere un brano musicale come triste soltanto perché esso suscita in noi quelle sensazioni che nella vita reale sono parte dell’esperienza della tristezza. Secondo tale teoria
la musica sarebbe quindi espressiva di tristezza in virtù del fatto che essa suscita tristezza negli ascoltatori, espressiva di gioia perché suscita gioia negli ascoltatori e così
via. In altri termini, essa possiede le proprietà emotive come disposizioni a suscitare
emozioni negli ascoltatori nello stesso modo in cui l’oppio ha la proprietà disposizionale di indurre il sonno. Sarebbe qui in gioco un rapporto che metterebbe tra parentesi,
almeno provvisoriamente, qualsiasi riferimento alle mediazioni formali e stilistiche, alla dimensione estetica come regno della virtualità e della simulazione.
Costeggiata così la conflittuale dinamica teorico-concettuale che attraversa il
recente dibattito sul tema musica-emozioni in ambito analitico, il passo successivo sarà
quello di iniziare ad occuparci approfonditamente delle teorie sopra esposte.
62
D. Matravers, Art and Emotion, Clarendon Press, Oxford, 1998; Id., The Experience of Emotion in
Music, in “The Journal of Aesthetics and Art Criticism”, 61, pp. 353-63.
45
CAPITOLO SECONDO
Musica e forma
1. La musica assoluta: superficie o profondità? La proposta di Peter Kivy
Abbiamo visto come uno dei tratti metodologici caratterizzanti la ricerca analitica sia quello di prediligere una scansione dei contenuti filosofici per problemi specifici. Per questa ragione rispettando il taglio particolare di questa impostazione, la presente analisi e quella del capitolo successivo si svolgerà seguendo un ordine tematico.
In questo capitolo, nello specifico, ci soffermeremo sulle questioni inerenti al
tema musica-forma. Negli ultimi anni, di fatto, in ambito analitico, tale tematica è stata
ampiamente ripresa e sviluppata partendo da una riformulazione della teoria formalista
di Hanslick che non escluda completamente il riferimento all’espressività dai tentativi
di descrivere la musica. Sappiamo infatti che il testo seminale che inaugura questo tipo
di discussione e nel quale peraltro affonda le radici tutto il dibattito analitico sulla musica è Il bello musicale. E, in effetti, come è stato recentemente evidenziato da
D’Angelo nell’Introduzione all’estetica analitica 63 «accade sempre nella filosofia di
tradizione analitica [che], la persistenza di un problema e il suo sviluppo sono legati alla discussione di alcuni testi precisi, che ricorrono nelle trattazioni della questione e
vengono a formare una sorta di catena» 64 .
Il problema di fondo intorno al quale viene a costruirsi questa catena è quello
relativo alla seguente domanda: la musica assoluta, la musica strumentale senza testo,
titolo o programma, ha una sua profondità, può essere in qualche modo vincolata a
contenuti rappresentativi determinati, oppure si tratta di un’arte esclusivamente formale, il cui apprezzamento si deve limitare a degli aspetti, per così dire, di superficie o
morfologici?
Uno dei principali protagonisti di questa discussione è lo studioso cui abbiamo
già più volte fatto riferimento nel corso di questo scritto, Peter Kivy 65 . Al centro della
rinascita che ha caratterizzato la filosofia della musica negli ultimi trent’anni troviamo,
63
P. D’Angelo, Introduzione all’estetica analitica, Laterza, Roma, 2008.
Ivi, pag. 5.
65
Peter Kivy è uno degli esponenti più autorevoli dell’estetica analitica, di quell’estetica analitica che ha
tra i suoi più insigni rappresentanti Nelson Goodman, Monroe Beardsley, Richard Wollheim, George
Dickie, Arthur Danto ed oggi anche Jerrold Levinson e Noel Carroll. Il suo campo di specializzazione è
l’estetica e la filosofia dell’arte. Uno dei suoi primi lavori in quest’area si è incentrato sull’estetica britannica del diciottesimo secolo, e, in particolare su Francis Hutcheson. All’inizio degli anni Settanta dirige la sua attenzione all’estetica analitica angloamericana ed in particolare ai problemi inerenti
all’ultimo saggio di Frank Sibley, “Aesthetic Concepts”. Ma è solo alla fine degli anni Settanta che inizia
ad interessarsi al problema filosofico delle emozioni in musica, diventando così uno dei più apprezzati
filosofi della musica in area anglosassone. La filosofia della musica, infatti, a partire da quel momento,
diventa il suo interesse principale, occupandosi nello specifico di questioni quali: il carattere artistico
specifico della musica, il linguaggio musicale, l’espressività della musica e il ruolo delle emozioni
nell’esperienza musicale, l’ontologia dell’opera musicale, la fenomenologia della performance.
64
47
di fatto, l’autorevole presenza di questo filosofo, protagonista instancabile del dibattito
sul tema musica-emozioni, artefice, peraltro, di una proposta teorica di particolare rilievo. Si tratta di una teoria formalista alternativa che guadagna, senza contravvenire
ai suoi presupposti, la possibilità di giustificare una relazione della musica con le emozioni. È in questo senso che Kivy preferisce presentare la sua proposta nella chiave
di un formalismo arricchito, enhanced appunto.
Kivy inizia ad interessarsi al problema dell’espressione musicale verso la fine
degli anni Settanta, e nel 1980 pubblica The Corded Shell 66 . Il titolo dell’opera (letteralmente: La conchiglia accordata) è tratto da un verso del poema di John Dryden del
1687 A Song for St. Cecilia’s Day, dedicato appunto al personaggio biblico che si suppone sia il fondatore della musica. Nel 1989 l’opera è stata ristampata con alcuni ampliamenti con il titolo di Sound Sentiment. Come ha bene evidenziato Bertinetto,
l’espressione contiene un gioco di parole difficilmente traducibile. Sound Sentiment significa «sentimento ragionevole (sicuro, brillante)», ma sound significa anche suono,
rumore, rumoroso e quindi l’espressione può rimandare anche al «sentimento del suono». In questa seconda edizione, Kivy torna a meditare sulle tesi esposte in quella prima versione, tenendo conto delle obiezioni che gli erano state mosse. Si tratta di un atteggiamento frequente e tutto interno al dibattito analitico, se è vero che la tendenza a
ripensare e riformulare le proprie tesi è un tratto caratteristico di chi non resta impermeabile alle eventuali obiezioni ed anzi ne trae spunto per ulteriori approfondimenti.
Siamo peraltro convinti che nel caso di Kivy questo work in progress non comporti
l’abbandono delle posizioni precedentemente sostenute. La conferma ci viene dalle parole di Kivy stesso, il quale nella Prefazione a Sound Sentiment dice: «Niente di quanto
ho scritto in The Corded Shell mi fa arrossire, ma dal 1980 ad oggi ho appreso un po’
di cose. L’opportunità di condurre una seconda edizione del libro mi rende acutamente
consapevole di come molte questioni sono state lasciate irrisolte e di come molte delle
cose dette oggi potrebbero dirsi differentemente … Nonostante ci siano stati dei ripensamenti riguardo ad alcuni temi trattati, la verità è che resto comunque ostinato su determinate affermazioni, e questo, non per il gusto di perseverare nell’errore, quanto
perché son forte delle mie convinzioni e ansioso di persuadere con il potere di
un’argomentazione razionale che bene può dimostrare le mie tesi» 67 . In effetti, come
66
P. Kivy, The Corded Shell. Reflections on Musical Expression, Princeton University Press, Princeton,
1980.
67
P. Kivy, Sound Sentiment: An Essay on the musical Emotions. Including the complete text of The
Corded Shell, Temple University Press, Philadelphia, 1989, pag. xv.
48
evidenziato dall’editore di questa seconda edizione, Joseph Margolis, il messaggio di
Sound Sentiment resta molto vicino a quello di The Corded Shell: occorre spogliarsi di
qualsiasi forma di scetticismo in merito al tema dell’espressività musicale, ed opporre
all’“emotivismo musicale” il “cognitivismo musicale”, vale a dire, all’idea che le attribuzioni espressive siano dovute all’eccitazione di emozioni nell’ascoltatore, la tesi, assai più feconda, che vede le qualità espressive o emotive strettamente ancorate alle
strutture musicali.
In The Corded Shell, Kivy cerca per la prima volta di chiarire come la musica
possa essere espressiva delle emozioni comuni (garden-variety of emotions), quali ad
esempio: amore, tristezza, gioia, ecc. Soprattutto, si pone il problema di come «alcuni
predicati emotivi possano essere comprensibilmente applicati alla musica, e perché
possano essere applicati intersoggettivamente» 68 , operando così in una direzione opposta a quella dei puristi musicali, i quali sostengono invece l’esatto contrario, vale a dire:
1) le descrizioni emotive della musica sono incomprensibili, o meglio non condivisibili; 2) esse sono congenitamente “soggettive” 69 . I puristi musicali, in effetti, sono per
Kivy i sostenitori di un formalismo tout court che si sottrae a qualsiasi possibilità di
“arricchimento” emotivo. Alla base di questa concezione troviamo l’idea che le descrizioni emotive siano “descrizioni” solo nel nome. Ci si chiede, infatti, come qualcosa
possa definirsi correttamente una “descrizione” se non abbiamo criteri condivisi attraverso i quali poter distinguere una descrizione pertinente da una non pertinente. Le descrizioni emotive della musica sono infatti, a giudizio dei puristi, descrizioni puramente
soggettive, impantanate tra gli individualismi di una psicologia male intesa. Lapidario,
fa notare Kivy, risulta quanto è stato detto a tale proposito da Gurney nell’opera The
Power of Sound. Egli scrisse: «spesso troviamo che la musica che per una persona
sembra possedere una certa espressione emotiva, non la possiede, o ne possiede una diversa, per un’altra persona, sebbene potrebbe tranquillamente darsi che entrambe le
persone apprezzano la stessa musica» 70 .
Inoltre, da questo particolare punto di vista, dare letteralmente una descrizione
della musica in termini emotivi pare del tutto infondato, perché solo esseri senzienti
possono letteralmente essere tristi, allegri e così via. È un’obiezione che vien fatta
spesso a coloro che tentano di salvare una qualche idea di espressività per la musica
pura e che, dico subito, sorprende per la sua apparente banalità. Torneremo su questo
68
Ivi, pag. 11.
Ibidem.
70
E. Gurney, The Power of Sound, Smith, Elder, London, 1880, p. 339.
69
49
problema per evidenziare come una simile affermazione nasconda una sostanziale incomprensione della tesi isomorfica.
Secondo Kivy sono queste le obiezioni ricorrenti nelle teorie che negano la possibilità di dare una descrizione della musica in termini espressivi e il nodo gordiano da
sciogliere, o per utilizzare la sua stessa terminologia, il “paradosso” della descrizione
musicale da risolvere si annida in queste stesse obiezioni. È chiaro infatti che il sospetto nei confronti della descrivibilità della musica poggia su una cattiva interpretazione di
quel che intendiamo quando parliamo di descrizione. Tali descrizioni possono infatti
oscillare tra due estremi: possono essere comprensibili solo all’esperto musicale; oppure accessibili ai non addetti ai lavori, a chi in altre parole, esperto non è, a costo di essere però descrizioni prive di alcun senso, o semplicemente una mera fantasia soggettiva.
In altre parole, le descrizioni possono essere troppo tecniche per le persone comuni
(prive quindi di contenuto emotivo), oppure sovraccariche di termini che denotano emozioni (prive quindi di referenze tecniche) 71 . Interessante, a tale proposito, proporre i
quattro esempi di descrizione musicale 72 che Kivy ha selezionato come rilevanti per illustrare questo peculiare stato delle cose, questo “paradosso” delle descrizioni musicali:
1) descrizione biografica;
2) descrizione autobiografica;
3) descrizione emotiva;
4) descrizione tecnica;
Kivy definisce biografica quella descrizione nella quale l’autore mette in primo
piano la personalità del compositore, anziché la musica. L’esempio cui attinge per illustrare questo tipo di descrizione è tratto dagli scritti di Robert Schumann, e più precisamente da quelli dedicati agli studi di Berger 73 . Si tratta di un esempio quanto mai e71
Cfr. Cap. I, pag. 3, di The Corded Shell, cit., interamente dedicato al paradosso della descrizione musicale, e Cap. XII, How to Emote over Music (Without Losing Your Respectability), pag. 132.
72
Kivy chiarisce che la sua analisi si limita a queste quattro tipologie di descrizione musicale, ma che
questo naturalmente non deve indurci a credere che sia una tipologia esaustiva.
73
Queste le parole di Schumann: «Tra gli artisti più vecchi, [Ludwig] Berger, come pure Moscheles, non
si è rivolto in maniera oziosa ai nuovi impulsi che venivano dati alla musica per pianoforte. Se i vecchi
ricordi talvolta lo sopraffanno, egli se li lascia alle spalle, ed è ancora attivo finché la luce del giorno
splende. Dopo un lungo silenzio di questo artista ormai anziano, che gode di una fama assai ampia, considerato il numero esiguo delle sue composizioni, ci saremmo dovuti aspettare qualcosa di molto diverso
da questi studi [Fifteen Etudes, Opus 22]. Ci saremmo piuttosto dovuti aspettare di trovarlo a fluttuare
incessantemente sui torrenti armonici, e a crogiolarsi nel ricordo del suo lungo e fruttuoso lavoro. Invece, egli ha messo di fronte ai nostri occhi una vita profondamente agitata, che cerca, con energico impe-
50
loquente di abuso di termini emotivi, romanticamente riferiti ai presunti stati mentali
del compositore. Osserva infatti Kivy:
Schumann ci vuole far credere che intende descrivere gli studi di
Berger, e forse, indirettamente, posso supporre che lo faccia. Ma in
realtà la maggior parte del suo discorso è su Berger, non sulla musica.
Quando apprendiamo, a proposito degli studi di Berger, che “noi possiamo contemplare una vita profondamente agitata, che cerca, con
energico impegno, di arrivare alla fine del giorno”, quando apprendiamo che questa musica scaturisce “da un cuore profondamente poetico, e da “un’artistica consapevolezza” che qualche volta “viene
sommersa dalla sua stessa impetuosità”, a noi sembra di sentire molte
cose su Ludwig Berger, ma poche sulla sua musica 74 .
Una descrizione di questo tipo è del tutto inattendibile poiché in essa, spiega Kivy, non
è certamente la musica ad essere tenuta in considerazione, ad essere protagonista ed
oggetto dell’analisi. La musica risulta fuori fuoco e la descrizione non pertinente.
La situazione non cambia di molto nemmeno nel caso del secondo esempio,
quello della descrizione autobiografica. Tale è una descrizione quando chi scrive racconta la propria esperienza dell’ascolto. Estratto come esplicativo a tale proposito un
passo dei Memoirs 75 di Hector Berlioz. Si tratta, con precisione, del passo in cui Berlioz si sofferma a dare una descrizione delle emozioni destategli dall’ascolto
dell’Armide di Gluck 76 . La musica anche in questo caso riveste un ruolo marginale, anzi essa funziona semplicemente come stimolo per la fantasia di Berlioz. Ironicamente,
Kivy commenta, «egli avrebbe potuto benissimo prendere tanto una dose di laudanum,
quanto una dose di Gluck»; e poco più avanti aggiunge: «Il fatto che Berlioz fosse una
mente supremamente interessante rende le sue peregrinazioni autobiografiche supremamente interessanti. Ma non le rende delle descrizioni della musica. Il loro soggetto è
gno di arrivare alla fine del giorno. In vari punti di questi studi troviamo espressioni tetre, cenni misteriosi, e subito dopo un’improvvisa concentrazione di forze, un sentimento di trionfo che si avvicina − e
tutto ciò è emanato, tuttavia, da un cuore profondamente poetico, ed è accompagnato dalla consapevolezza artistica fino al momento in cui esso non viene sopraffatto dalla sua stessa impetuosità»Robert
Schumann, Music and Musicians: First Series, tr. by Fanny Raymond Ritter (8th ed.; London: William
Reeves, n. d.), pp. 264-265.
74
P. Kivy, The Corded Shell …, cit., pag. 4. Trad. mia.
75
E. Berlioz, Memoirs, tr. by Ernest Newman, New York, Tudor, 1932.
76
Berlioz riferisce: «Ho chiuso i miei occhi, e, mentre ascoltavo la divina gavotta [nell’Armide di
Gluck], con la sua melodia carezzevole e con la sua monotona armonia che sussurra sofficemente, e
(mentre ascoltavo) il coro, Jamais dans ces beaux lieux, così squisitamente grazioso nel suo esprimere
gioia, mi sembrava di essere circondato da tutti i lati da braccia avvolgenti, da piedi adorabili che si intrecciavano, da capelli fluttuanti, da occhi risplendenti, e da sorrisi contagiosi. Il fiore del piacere, scosso
con gentilezza dalla brezza melodica, si espandeva, e un concerto di suoni e colori si riversò dalla sua
incantevole corolla». E. Berlioz, Memoirs, cit., p. 321.
51
Berlioz» 77 . Alla base di queste giocose considerazioni, vi è l’idea che non si possa associare la qualità espressiva della musica all’effetto emotivo che una certa melodia può
stimolare in chi ascolta. Non è sul piano della dinamica stimolo-reazione che possiamo
trovare un’adeguata descrizione della musica in termini espressivi.
Se Schumann ha quindi commesso l’errore di parlare del compositore, Berlioz
invece ha commesso l’errore di parlare dell’ascoltatore, di se stesso in questo caso. Così facendo, nessuno dei due ha tenuto adeguatamente in considerazione la musica, la
quale resta come sfondo in entrambe le descrizioni.
Lontana invece dalle effusioni romantiche di Schumann e Berlioz, e quindi in
un certo senso più rispettabile, sarebbe invece per Kivy la cosiddetta descrizione emotiva. In questo terzo tipo di descrizione le emozioni sono ascritte direttamente alla musica come se essa realmente fosse attraversata da quelle stesse emozioni. Un esempio di
tal genere è secondo Kivy quello che si trova in una delle più ammirate opere di esegesi
musicale, Essays in Musical Analysis di Tovey 78 . In effetti, Tovey parla della musica
(di Beethoven e Brahms) come se realmente fosse “distrutta dal dolore” oppure
dall’ira. Mi preme sottolineare sin da ora che è esattamente questo il tipo di descrizione
che più di ogni altra convince Kivy, una descrizione cioè dove le qualità emotive vengono ascritte alla musica stessa, poiché, e spiegheremo meglio in seguito per quali ragioni egli arriva a questo convincimento, la musica ha un proprio sentimento, che non è
né quello del compositore, né quello dell’esecutore, né tantomeno quello
dell’ascoltatore. Non è nelle indipendenti dinamiche emotive dell’umano sentire che
dobbiamo ricercare il legame della musica con le emozioni, bensì nella musica stessa
quale pura forma che possiede però l’emozione come parte percettiva della sua struttura. Una tesi tanto singolare quindi che certamente si presta a tutta una serie di obiezioni quanto più, e anche in questo caso diamo un’anticipazione di un tema che svilupperemo a parte, una tale concezione rifiuta l’idea che le nostre attribuzioni di qualità
emotive alla musica siano da considerarsi metaforicamente. Kivy infatti contravvenen77
P. Kivy, The Corded Shell …, cit., pag. 5.
Tovey scrive: «Il primo episodio [del secondo movimento dell’Eroica] è un normale trio in tonalità
maggiore, che inizia in un’atmosfera di consolazione e per due volte esplode nel trionfo. Dopo, la luce si
spegne e il tema lugubre fa ritorno … Successivamente fa il suo ingresso, finalmente, l’inizio di un nuovo messaggio di consolazione, ma esso svanisce e il movimento si conclude con un’ultima enunciazione
del tema principale, i cui ritmi e i cui accenti sono completamente distrutto dall’angoscia. Qui segue [nel
primo movimento della Prima Sinfonia di Brahms] un bellissimo passaggio preparatorio al secondo soggetto; un commovente diminuendo, che inizia rabbiosamente … e si ammorbidisce (nel mentre passa rapidamente attraverso delle tonalità molto distanti) verso toni di profonda tenerezza e pietà ….». D. F.
Tovey, Essays in Musical Analysis: Volume I, Symphonies, Oxford University Press, London, 1935, pp.
32 e 86.
78
52
do, almeno in questo caso, pienamente alla teoria metaforica delle emozioni sostenuta
da Hanslick, ribadisce che una struttura musicale possiede realmente le emozioni come
qualità percettive. È in questo senso che egli chiarisce: «Tovey, è chiaro, sa bene quale
sia l’oggetto di cui egli presumibilmente sta parlando: non Beethoven, non Brahms, e
nemmeno Tovey, ma la musica. Se si volesse contestargli qualcosa, di certo non sarebbe ciò di cui egli sta parlando, ma come egli ne sta parlando. Non è né Beethoven né
Tovey ad essere consolato, trionfante, lugubre, completamente distrutto dall’angoscia.
Solo la musica lo è. Non è né Brahms né Tovey ad essere commovente, arrabbiato, tenero, caritatevole. Solo la musica lo è» 79 .
Una musica può essere dunque distrutta dal dolore? In che senso usiamo come
ponte tra musica ed emotività l’aggettivo ‘distrutta’? C’è una motivazione sottile che
spinge Kivy, e noi con lui, a ritenere che una simile descrizione accolga in sé le istanze
di un formalismo illuminato e nello stesso tempo l’esigenza di salvaguardare la componente espressiva. ‘Distrutto’ è un aggettivo che può evocare molto bene sia il singhiozzo di un sentimento tormentato, sia la discontinuità, frammentazione della sintassi
musicale. Vale a dire: ascoltiamo un brano musicale e lo descriviamo come “spezzato
dal dolore”, perché la sua struttura ci suggerisce una sintesi percettiva che trova in
quella particolare declinazione emotiva la sua identità.
Chiariamo subito che per quanto Kivy riconosca la validità di una posizione
come questa, senta cioè la fertilità di una concezione che presuppone sostanzialmente
un rapporto isomorfico, avverte anche tuttavia il peso delle obiezioni mossegli dagli
anti-emotivisti.
Il musicologo oppure il filosofo scettico potrebbero sollevare obiezioni come
queste, vale a dire: come possono questi predicati emotivi essere realmente applicati
alla musica? Se la musica fosse realmente distrutta dal dolore, qualcuno potrebbe anche
suggerirci di provare a risollevare la povera musica oppure addolcirla? Risollevarla dal
dolore e addolcirla dall’ira. Chi si oppone infatti a una descrizione emotiva della musica accoglie sarcasticamente la possibilità che si possa parlare di essa in termini emotivi,
come se ci si riferisse a un essere senziente capace di provare emozioni. In realtà, anche
in questo caso direbbero gli scettici, molto probabilmente, non è della musica che si sta
parlando, ma ancora una volta, se pur indirettamente, degli stati d’animo del compositore e dell’ascoltatore. Se le cose stessero così, osserva Kivy, tanto varrebbe allora ritornare al punto di partenza, e cioè alla descrizione biografica e autobiografica. En79
P. Kivy, The Corded Shell …, cit., pag. 6.
53
trambe sono state considerate inaccettabili, perché sia nell’uno che nell’altro caso abbiamo potuto constatare che parlare delle emozioni in musica sembra sempre coincidere con il parlare delle emozioni del compositore oppure dell’ascoltatore.
L’ovvia conclusione di chi mostra scetticismo nei confronti di qualsiasi forma
di ammiccamento all’espressività, sembrerebbe quindi essere: una descrizione emotiva
della musica è impossibile. Se non altro questa è la conclusione cui perviene il purista,
il quale pur mettendo in gioco l’ipotesi che una simile descrizione possa avere qualche
senso, giunge poi alla conclusione che mancano in essa criteri intersoggettivi, pubblicamente condivisi, di applicazione. E il fatto che ci sia disaccordo su come le descrizioni emotive possano correttamente caratterizzare alcuni temi o composizioni musicali
è, dal punto di vista dei puristi, il segnale più tangibile del carattere puramente soggettivo di tali descrizioni. La musica, in altre parole, può sortire effetti emotivi diversi a
seconda delle persone in ascolto, pur restando invariato il grado di apprezzamento estetico.
Infine, troviamo la descrizione tecnica della musica 80 . Tale descrizione è accreditata dal purista, poiché essa è scientifica, oggettiva, distante dalle sciocchezze emotive (emotive flapdoodle) di molti discorsi sulla musica. Non a caso, Kivy scrive a tale
proposito: «qui, finalmente, il purista raggiunge la sua meta: nella descrizione oggettiva, sensata, scientifica, scevra di qualsiasi contaminazione soggettivistica o di eccesso
romantico. Un ritmo o è giambico o non lo è. Un accordo o è un accordo di quinta o
non lo è. Tutti gli ascoltatori dotati di una certa conoscenza sono più o meno d’accordo
su come queste questioni devono essere risolte» 81 . Le questioni che entrano in gioco
quindi in una simile descrizione appaiono rigorosamente tecniche: la musica ha oppure
non ha un ritmo giambico, un accordo è o non è un accordo di quinta, e via dicendo.
Tali descrizioni, evidenzia Kivy, per molti aspetti convincono (anzi riconosce che per
formazione e inclinazione personale egli non intende essere cieco ad esse), ma al tempo
stesso egli non può non evidenziare però il problema che a queste stesse descrizioni inevitabilmente si lega, ovvero il fatto che restano inaccessibili, impenetrabili a tutte
80
Due sono gli esempi di descrizione tecnica riportati da Kivy, il primo è tratto dall’opera di Cooper e
Meyer, The Rhythmic Structure of Music, il secondo invece dal lavoro di Kerman, The Beethoven Quartets. Per esemplificare riporteremo solo il primo esempio: «Il ritmo del tema dell’ultimo movimento della “Surprise” Symphony di Haydn … mostra assai più palesemente un profilo giambico. In questo caso i
gruppi iniziali, sebbene siano entrambi anfibrachi, sono assai diversi dal punto di vista melodico e temporale, sono assai vicini l’un l’altro, e sono tenuti insieme da una potente progressione armonica (I-V-I).
Perciò queste due unità tendono a formare un gruppo trocaico su un secondo livello ritmico e costituiscono una singola e unificata anacrusi a un terzo livello ritmico». G. Cooper e L. B. Meyer, The Rhythmic Structure of Music, University of Chicago Press, 1960, pag. 65. J. Kerman, The Beethoven Quartets,
Alfred Knopf, New York, pp. 175-176.
81
P. Kivy, The Corded Shell …, cit., pag. 8.
54
quelle persone che non hanno una conoscenza di tipo tecnico della musica. Queste le
sue parole a riguardo: «questo tipo di descrizione, se da un lato è assai invitante per chi
ha una competenza musicale, dall’altro lato taglia fuori un’ampia e importante comunità musicale. La musica, dopo tutto, non è solo per i musicisti o per gli studiosi, così
come la pittura non è solo per gli storici dell’arte e la poesia non è solo per i poeti» 82 .
Dunque, si appresta a concludere Kivy, la strada da imboccare per giungere a una possibile soluzione del “paradosso” dell’espressività musicale non può passare né da una
totale negazione della descrizione tecnica né da una totale chiusura nei confronti della
descrizione emotiva. Egli ha infatti a cuore l’obiettivo di dare un fondamento razionale
alla critica emotiva della musica, vale a dire: fornire sostegno ad una descrizione emotiva della musica che sia rispettabile agli occhi dell’esperto e che possa stare a fianco
delle descrizioni tecniche come un valido strumento analitico. Se questo è l’obiettivo, il
problema sarà allora quello di stabilire in che modo è possibile conseguire un simile risultato.
Una nota strategia filosofica adottata spesso nella storia del pensiero, ma non
condivisa da Kivy, per uscire fuori da questa apparente situazione di inconciliabilità
delle descrizioni tecniche con le descrizioni emotive, è quella che denuncia sia il nonsenso (meaninglessness) sia il soggettivismo psicologico implicito nella descrizione
emotiva, ma al contempo riconosce che tale “descrizione” possa tuttavia risultare utile
al lavoro del critico: ci permette di percepire qualcos’altro nell’opera che è lì realmente
per essere da noi colto. Kivy sta pensando alle conclusioni di Isenberg, in un saggio
molto influente sulla teoria della critica: «il critico sta pensando un’altra qualità, della
quale non ci fornisce alcuna idea attraverso il linguaggio da lui utilizzato, una qualità
che però egli vede e che riesce a farci vedere tramite l’uso che egli fa del linguaggio» 83 . Da una simile posizione si potrebbe allora sostenere che le descrizioni emotive
sono nello stesso tempo prive di senso e rispettabili. Esse colmerebbero un vuoto lasciato dal linguaggio, si sostituirebbero ad una mancanza linguistica allo scopo di evocare metaforicamente un senso altrimenti non afferrabile, non dicibile. Quel “qualcos’altro” di cui ci parla Isenberg.
Anche questo modo di impostare il problema rimanda a quell’atteggiamento di
fuga dallo specifico musicale che da sempre Kivy combatte. Il fatto che la descrizione
emotiva della musica ci conduca a percepire una qualità attraverso il discorso su qual82
Ibidem.
A. Isenberg, “Critical Communication,” Aesthetic and Theory of Criticism: Selected Essays of Arnold
Isenberg, University of Chicago Press, Chicago and London, 1973, pag. 162.
83
55
cos’altro è implicito anche nella descrizione biografica ed autobiografica. Di fatto, in
entrambe le descrizioni, come abbiamo avuto modo di constatare, si realizza qualcosa
di simile, vale a dire: nella descrizione biografica, il critico parla di qualcos’altro, del
compositore, facendoci in tal modo sentire l’espressività della musica; così, anche nella
descrizione autobiografica succede che il critico parla di qualcos’altro, cioè di se stesso, per raggiungere sempre e comunque lo stesso risultato. Ma è esattamente questo il
modo di intendere la descrizione al quale Kivy vuole energicamente opporsi. Non è accettabile infatti, dal suo punto di vista, che una descrizione della musica debba sempre
svolgersi mediante un discorso per via indiretta (by “indirection”), né tantomeno si
può accettare l’idea che noi siamo nelle mani del critico, in balia di una sua cospirazione, e che egli quindi abbia il potere di decidere se introdurci o meno dentro l’ascolto di
ciò che egli ha a sua volta sentito, e cosa ancora peggiore, mediante un discorso che è
un nonsenso, come se noi non fossimo pronti per la terribile verità, o, non fossimo comunque capaci di seguire un’argomentazione critica autentica. In altri termini, la descrizione emotiva della musica per Kivy non è certamente interpretabile nell’ottica di
una complessa mistificazione.
Veniamo quindi al punto che qui più ci interessa evidenziare. Secondo Kivy il
critico musicale può senz’altro condurci a farci sentire qualcos’altro nella musica, ma
non si tratta di sentimenti soggettivi, bensì di quello che egli descrive come le proprietà espressive della musica. E, qui, ritorna la descrizione di Tovey quale modello esemplare di quello che Kivy riconosce essere una valida descrizione emotiva, una descrizione cioè nella quale l’emozione è vincolata, aderente alle caratteristiche strutturali
dell’oggetto descritto. Infatti, dice chiaramente Kivy, l’efficacia di un’espressione come quella di Tovey, “la musica è distrutta dal dolore”, consiste nel fatto che quella descrizione non ci allontana dalla musica, ma ce la fa sentire come capace di evocare
strutturalmente quella qualità. Le sue stesse qualità, poiché, come avevamo anticipato,
la concezione espressiva di Kivy contempla la possibilità che la musica possieda le
proprietà emotive come proprietà acustiche. È anche questa la ragione per cui – egli
precisa – le descrizioni emotive della musica sono compatibili con il «formalismo», inteso come la dottrina secondo cui la musica è una struttura di eventi sonori senza contenuto semantico o rappresentazionale. Scrive infatti a riguardo che: «se le proprietà
emotive come la tristezza sono proprietà acustiche della musica, sono semplicemente
proprietà della struttura musicale, dire che un passaggio musicale è triste o allegro non
significa descriverlo in termini semantici o rappresentazionali più che descriverlo come
56
turbolento o tranquillo. Un passaggio musicale tranquillo non rappresenta la tranquillità
né significa «tranquillo». Esso è semplicemente tranquillo. E lo stesso vale per un passaggio musicale malinconico. Non significa la «malinconia» né rappresenta la malinconia. È semplicemente melanconico, e questo è tutto» 84 . Questo spiega anche perché,
precisa ancora Kivy, la musica assoluta, sebbene sia una forma artistica pura, astratta,
formale, non ha niente a che vedere con uno “stato freddo”. Essa ha «calore» umano,
così si esprime piuttosto semplicisticamente Kivy; perché le emozioni sono una parte
percettiva della sua struttura.
È proprio a questo punto che si definisce così l’obiettivo di salvare
l’espressività della musica senza aver nessuna intenzione di rinunciare ad una prospettiva di matrice formalistica.
Ma procediamo per gradi e cerchiamo di capire con quali tesi e argomenti Kivy
sostiene la sua teoria cosiddetta cognitiva delle emozioni in musica e giustifichi così
l’approdo al formalismo arricchito.
2. Per una teoria dell’espressione musicale
Risulta evidente quindi che la musica, nella prospettiva di Kivy, può essere descritta in termini espressivi. È possibile infatti spiegare come le emozioni siano vincolate alla struttura musicale, come la musica possegga le emozioni e sia espressiva di
esse nella varietà delle loro sfumature. Poiché, ed ecco il punto, la musica possiede
l’emozione come una sua qualità percettiva.
Per quanto prematuro possa apparire affermarlo, la tesi centrale che Kivy mette
avanti sin dalla primissima fase della sua ricerca sul problema delle emozioni musicali
è proprio questa. A mio avviso, si tratta di una vera e propria tesi guida della sua riflessione, visto che dalla pubblicazione di The Corded Shell all’ultima opera scritta, Introduction to a Philosophy of Music, sono trascorsi ventidue anni, ma il suo punto di vista
resta pressoché invariato. Certamente, alcuni tra i percorsi teorici seguiti nel tentativo
di dimostrare questa tesi nodale sono stati messi in discussione, spesso anche a seguito
di critiche ricevute. Per questa ragione ritengo opportuno seguire, almeno nelle sue linee generali, tale percorso evolutivo della ricerca di Kivy prima di approdare alla que84
P. Kivy, Filosofia della musica. Un’introduzione, cit., pp. 108-109.
57
stione che qui più ci interessa del formalismo musicale nella sua nuova veste emotiva.
D’altronde, una tale questione, a mio avviso, non nasce isolata e completamente autonoma rispetto alle altre, ma è problematicamente presupposta in esse. Tuttavia, sappiamo, che è proprio questa una delle tendenze metodologiche privilegiate dagli analitici, i quali tengono per lo più separate le diverse problematiche. Kivy, in particolare,
nell’opera Philosophies of Art. Essay in Differences, suffraga questo modo di orientarsi
come uno dei punti di forza dell’estetica analitica. L’idea sarebbe la stessa che riecheggia nel motto di Bertrand Russell, secondo il quale il miglior modo di dominare una
questione è proprio quella di dividerla, di guardarla isolandola dalle altre: divide et impera, sarebbe infatti secondo Kivy la regola da rispettare anche in estetica85 .
A fondamento, quindi, della teoria dell’espressione cui Kivy inizia a lavorare
già in The Corded Shell troviamo questo acquisito modo di guardare al problema della
relazione tra musica ed emozione. Dico acquisito, perché, come in parte avevamo già
rilevato nel primo capitolo, l’idea che l’emozione appartenga alla musica come qualità
percettiva era già sufficientemente diffusa in ambito analitico. Kivy stesso non fa mistero alcuno del fatto che l’orizzonte teorico da cui si diparte il proprio percorso di ricerca è proprio quello dell’analisi contemporanea sul tema musica-emozioni. Diversi,
anzi, sono i contesti in cui non manca di evidenziarlo apertamente. In un articolo del
1999, Feeling the musical emotions, scrive:
Io avevo il vantaggio, rispetto ai miei predecessori, di poter contare
sui passi in avanti compiuti dalla filosofia analitica, i quali mi hanno
fornito più opzioni, oltre a quelle basate sulla semplice rappresentazione o sul contenuto simbolico, per creare un’alternativa alla concezione disposizionale dell’espressività musicale. Sempre di più, i filosofi dell’arte stavano per rendersi conto che ha più senso – da un punto di vista metafisico – concepire le proprietà emotive nella musica
come proprietà percettive pure e semplici 86 .
E, così, anche in Filosofia della musica. Un’introduzione:
L’analisi contemporanea, comunque, considera ora una seconda possibilità, più vicina alla maniera in cui sembra che noi esperiamo le
emozioni nella musica, cioè in quanto proprietà percettive come colori o gusti. La nostra attenzione deve dunque ora volgersi questo nuo-
85
P. Kivy, Philosophies of Art. An Essay in Differences, Cambridge U. P., Cambridge, 1997. Si veda anche, Introduction: Aesthetics Today, in Id., The Blackwell Guide to Aesthetics, Blackwell, New York –
Oxford, 2004, pp. 4-5.
86
P. Kivy, Feeling the musical emotions, “The British Journal of Aesthetics”, 39, 1, 1999, pag. 1.
58
vo approccio al problema delle emozioni musicali, che è a mio modo
di vedere quello vincente 87 .
Tra i sostenitori di questa “nuova” concezione dell’espressività musicale, due
sono in realtà i filosofi cui Kivy è solito fare riferimento, Charles Hartshorne e Oets. K.
Bouwsma. Hartshorne in particolare, secondo Kivy, fu uno dei primi a sostenere che le
proprietà emotive, o qualità affettive, sono parte del nostro campo percettivo. Quando,
infatti, il problema delle cosiddette proprietà emotive non era ancora emerso come decisivo per la contemporanea filosofia della musica, Hartshorne, nell’opera Philosophy
and Psychology of Sensation (1934), scriveva che «l’ “allegria” del giallo (quella particolare e specifica allegria) è la giallezza del giallo» 88 . L’idea di Hartshorne è che
l’allegria non appartiene al giallo perché esso ci rende allegri, bensì perché l’allegria è
parte della sua qualità percettiva, è inseparabile dal suo «essere-giallo». Si tratta, in altre parole, semplicemente del modo in cui noi percepiamo questo colore. Stessa cosa,
sosteneva Hartshorne, si può dire degli altri colori, della musica, e, in generale, anche
di altri aspetti visuali del mondo. Il fenomeno sarebbe quindi legato all’esperienza percettiva umana in generale e, non riguarderebbe dunque in particolare la musica o i colori.
Viste così le cose, spiega Kivy, diventa meno problematica e anche meno imbarazzante una spiegazione di come le emozioni «sarebbero inerenti» alla musica. Scoprire infatti nella nostra esperienza ordinaria casi in cui comunemente accettiamo come
logica conseguenza che la nozione di proprietà emotiva appartenga anche ad altri oggetti non senzienti, secondo Kivy, dovrebbe farci sentire meno a disagio anche rispetto
al fenomeno musicale. L’esempio del colore giallo di Hartshorne sotto questo punto di
vista funziona benissimo, perché egli sposta la nostra attenzione da quello che Kivy, a
quanto pare, considera un caso problematico da spiegare, e cioè il fenomeno musicale,
ad un caso che problematico non è, (quantomeno, non per il comune modo di vedere),
quello della tonalità emotiva del colore giallo 89 . Dal nostro punto di vista sostenere,
come fa Kivy, che ci sono oggetti nella nostra esperienza ordinaria rispetto ai quali, più
facilmente, riusciamo a metabolizzare l’idea che ad essi ineriscano emozioni, in realtà
non ci aiuta affatto a comprendere meglio il fenomeno musicale. Perché dovrebbe aiu87
P. Kivy, Filosofia della musica. Un’introduzione, cit., pag. 38.
C. Hartshorne, The Philosophy and Psychology of Sensation, The University of Chicago Press, Chicago, 1934, pag. 7.
89
Cfr. Filosofia della musica. Un’introduzione, cit. pp. 40-41. Kivy scrive: «Uno dei modi tradizionali
utilizzati dai filosofi per occuparsi di tali casi consiste nel provare a costruire un’analogia tra il caso problematico e un caso non problematico ch vi assomiglia in modo rilevante».
88
59
tarci, ci chiediamo? Non è assolutamente detto che il colore giallo sia in rapporto con
l’allegria, almeno non più di quanto una certa musica lo sia in rapporto ad una certa
emozione. Quello che genera una certa perplessità ai nostri occhi è soprattutto il fatto
che egli in qualche modo, e per ragioni a noi poco chiare, tenda a dare per scontato che
le cose per la logica comune debbano funzionare in questi termini. Possiamo comprendere che tra le diverse tonalità emotive che siamo soliti attribuire al giallo, l’allegria è
forse quella predominante, anche se non l’unica, non possiamo invece altrettanto facilmente ammettere che un esempio come questo sia meno problematico di quello della
musica. Quali sono i presupposti teorici che giustificherebbero questa credenza? Chi
assicura a Kivy che è più facile per noi accettare il fatto che un’emozione x appartenga
al colore y e che invece sia più complesso accettare che un’emozione appartiene alla
musica? Che l’allegria del giallo non sia un caso problematico, e che l’allegria della
musica invece lo sia?
Lo stesso Kivy, seppure tenendosi a margine, nota che una simile replica potrebbe venire dallo scettico, il quale comodamente potrebbe evidenziare che il problema non è stato assolutamente risolto, se mai esacerbato. Sembrerebbe inoltre che una
simile ipotesi interprativa non goda di nessun credito nemmeno nel pensiero analitico
contemporaneo. Opinione diffusa in questo contesto è infatti che la filosofia di Hartshorne sia una sorta di «panpsichismo»: una filosofia cioè che attribuisce alla realtà fisica caratteristiche e dinamismi propri della vita psichica. Se seguiamo questa particolare concezione filosofica, di fatto, anche gli oggetti non senzienti possiederebbero un
certo grado di sensibilità, allo stesso modo degli esseri senzienti (persone o animali).
Così facendo si corre il rischio di perdere di vista la distinzione tra, per l’appunto, “esseri senzienti” e “oggetti non senzienti”. Per Kivy invece, una tale distinzione ha la sua
importanza, per quali ragioni lo capiremo meglio a breve, parlando della teoria del profilo (contour theory). Ne consegue una critica ad Hartshorne, il quale, sostiene Kivy,
non è stato capace infine di spiegare quello che a suo avviso è invece il problema fondamentale da risolvere, vale a dire: come sostanze non senzienti possano pervenire a
possedere proprietà emotive. Perché, è il caso di evidenziarlo, per Kivy la musica certamente non è un essere senziente pur possedendo le emozioni come sue qualità percettive, mentre nel caso di Hartshorne, se ci fidiamo delle informazioni dateci da Kivy,
anche gli oggetti non senzienti in qualche modo sarebbero senzienti.
Anche nel caso di queste ultime riflessioni vorremmo aprire una breve parentesi
critica. Kivy, abbiamo visto, sottolinea che il merito della spiegazione di Hartshorne è
60
quello di aiutarci a comprendere come un’emozione può inerire ad un oggetto non senziente estendendo il fenomeno al nostro campo percettivo, evidenziando cioè che le
proprietà emotive fanno parte del nostro campo percettivo. Semplicemente si tratta del
modo in cui percepiamo. Fino a questo punto niente da evidenziare. La nostra perplessità nasce invece quando dopo aver detto questo, portandoci così a credere che nella
spiegazione di Hartshorne potevamo trovare un plausibile modo di comprendere il fenomeno musicale, Kivy arriva a sostenere, facendo anche leva sulle critiche della contemporanea filosofia analitica, che Hartshorne non è stato in grado di penetrare la misteriosa questione di come l’emozione possa vincolarsi a strutture che non sono senzienti. Non riusciamo, nel caso specifico, a capire per quali ragioni Hartshorne avrebbe
dovuto porsi questo problema, dal momento che egli ha sottolineato che in realtà è
all’esperienza percettiva umana in generale che dobbiamo guardare e non solo agli oggetti, poiché un’emozione ad essi inerisce nel momento in cui la percepiamo.
L’emozione musicale è legata al modo in cui noi la percepiamo.
Abbiamo il sospetto che dietro questa faticosa argomentazione, oscillante cioè
tra il polo noetico e quello noematico della nostra esperienza del mondo, vale a dire tra
l’accento posto sull’elemento soggettivo dell’esperienza percettiva e quello oggettivo,
si nasconda un mancato approfondimento della nozione di sintesi passiva maturata ed
elaborata in ambito fenomenologico 90 . Se cioè consideriamo il fatto che i materiali percettivi hanno facoltà di autoorganizzarsi e di suggerire percorsi sintetici e direzioni
immaginative, allora non ci sembrerà più né un cedimento al panpsichismo né
un’indebita accentuazione delle componenti soggettive il fatto di concepire le qualità
espressive come una proprietà strutturale della musica.
Per il momento, dobbiamo accontentarci soltanto di queste brevi notazioni, anche perché mancano al nostro attivo altre tesi fondamentali che per esigenze di ordine
espositivo non abbiamo ancora potuto esplorare, attraverso le quali guadagneremo certamente maggiore chiarezza.
Ora, la tesi che le proprietà emotive appartengono alla musica come qualità percettive era stata sostenuta anche da un altro filosofo americano cui Kivy spesso fa riferimento nelle sue opere. Si tratta del wittgensteiniano Bouwsma, secondo il quale la tristezza è in relazione alla musica non perché la musica ha il potere di renderci tristi, di
disporci a un’emozione, bensì perché l’emozione è una sua qualità percettiva. Bouwsma sosteneva in particolare che la tristezza sta alla musica più come “il rossore sta
90
Cfr. E. Husserl, Lezioni sulla sintesi passiva, trad. it. di V. Costa, a cura di P. Spinicci, Guerini e Associati, Milano 1993.
61
alla mela, che come il rutto sta al sidro”. Tale analogia per Kivy rivela con chiarezza
l’esigenza di ancorare le qualità emotive alle strutture musicali, ma non spiega, allo
stesso modo dell’esempio di Hartshorne, come la musica possa possedere l’emozione
come sua qualità percettiva: il problema – egli aggiunge – è relativo al fatto che pur avendo una buona idea di come il rossore «sia inerente» alla mela e ad altre cose rosse,
non abbiamo un’idea altrettanto chiara di come le emozioni «siano inerenti» alla musica 91 .
Parte dell’attenzione di Kivy nella sua ricerca è diretta su quel come. Come
l’emozione stia «dentro» la musica. Per Kivy è un fatto che la musica possiede le emozioni. È un fatto cioè che una musica in tonalità maggiore, con un tempo rapido e sincopato e temi vivaci e galoppanti sia percepita come allegra, così come una musica in
tonalità minore con un tempo lento e pesante, con una dinamica sommessa, i temi esitanti e calanti, sia percepita come melanconica, triste. Perché però, si chiede, ascoltiamo allegria e non soltanto la tonalità maggiore, il tempo rapido, etc., oppure, perché
non ascoltiamo la tonalità minore di un brano, la sua dinamica sommessa, la melodia
cadente ed esitante, e ascoltiamo invece la malinconia? Questo è il problema. Scrive
Kivy:
L’approccio più seducente al problema concernente le emozioni
«dentro» la musica mi è intimamente familiare, perché è un approccio
che ha sedotto anche me. Esso prende le mosse dall’idea che non possa essere una semplice coincidenza il fatto che la musica triste abbia
un tempo lento e incerto, una dinamica sommessa e melodie esitanti e
calanti, e che le persone tristi camminano con passo lento e incerto,
con il corpo chino, e parlino sottovoce in modo esitante. Non può essere neppure una semplice coincidenza il fatto che le opere musicali
allegre e le persone allegre si muovano rapidamente, parlino forte e
persino saltellino, la musica melodicamente, le persone con il corpo 92 .
Ci deve essere, da questo punto di vista, una qualche analogia tra l’andatura, il
contegno il portamento delle persone quando esprimono le emozioni comuni e il modo
91
In generale, sottolinea Kivy, l’intera comunità dei filosofi britannici e americani interessata alla questione dell’espressività ha accettato al fatto che la musica sia espressiva delle emozioni comuni in virtù
del suo possederle come proprietà percettive. Ma, una volta assodato questo restano tre importanti questioni, sulle quali c’è un sostanziale disaccordo, da risolvere, vale a dire: 1) Come, attraverso quale processo, la musica è capace di esprimere le emozioni nella varietà delle loro sfumature? 2) Qual è il ruolo
che le proprietà espressive giocano nella struttura musicale cui appartengono? Dato che le emozioni comuni sono, come proprietà espressive, nella musica e non nell’ascoltatore, che cosa significa essere profondamente commosso dalla musica?
92
P. Kivy, Filosofia della musica. Un’introduzione, cit., pp. 45-46.
62
in cui la musica suona o è descritta quando è percepita come espressiva di quelle stesse
emozioni. Kivy è certo che una simile analogia esista, anzi, è proprio basandosi su di
essa che ha tentato di spiegare il problema dell’espressività musicale già a partire da
The Corded Shell. Com’è possibile però, ammesso che possibile sia, avvicinare
l’espressione umana delle emozioni con l’espressione delle emozioni nella musica?
L’emozione è uno stato di coscienza e sembrerebbe che soltanto esseri viventi dispongano di stati di coscienza 93 . Secondo Kivy, è necessario, a tale proposito fare una distinzione tra “esprimere qualcosa” e “essere espressivo di qualcosa”, poiché per potere
esprimere qualcosa bisogna sentire l’emozione espressa, mentre per essere espressivi di
un’emozione non è necessario che qualcuno o qualcosa provi realmente
quell’emozione. L’esempio che egli propone è il seguente:
Se, nelle circostanze appropriate, sono spinto dalla rabbia a urlare e a
stringere i pugni, è corretto dire che io ho espresso la mia emozione;
ed è corretto dire che l’urlare e lo stringere i pugni esprimono o sono
l’espressione della mia emozione. È estremamente importante notare
che una condizione necessaria affinché l’urlare e lo stringere i pugni
siano l’espressione della mia rabbia è che io sia realmente arrabbiato;
e fino a che io non sono veramente arrabbiato, non è corretto dire che
io ho espresso la mia rabbia o che il mio urlare e il mio stringere i
pugni sono espressioni di tale rabbia. Si consideri questo come il paradigma dell’espressione emotiva.
Ma si confronti questo caso con quest’altro. Il San Bernardo ha
una faccia triste. Con ciò non vogliamo dire che la faccia del San
Bernardo esprime tristezza. Poiché di certo il San Bernardo non è
sempre triste. E affinché la sua faccia possa essere possa essere sempre appropriatamente descritta come esprimente tristezza, dovrebbe
verificarsi il seguente caso: la povera creatura dovrebbe trovarsi in un
perenne stato di tristezza. Pertanto, quando descriviamo la faccia del
San Bernardo come una faccia triste, non stiamo dicendo che esso esprime tristezza, ma, piuttosto, che esso è espressivo di tristezza. Si
consideri questo come il paradigma dell’essere espressivo di φ, dove
“φ” è il nome di un’emozione o di uno stato d’animo (come “rabbia”
o “malinconia”) 94 .
Dunque, perché un essere umano esprima un’emozione, condizione necessaria è
che realmente senta quell’emozione (paradigma dell’espressione emotiva). Le cose non
93
Cfr. il recente contributo di A. Bertinetto, Bach e il San Bernardo. La filosofia della musica di Peter
Kivy, «Estetica», I (2006), pag. 92.
94
P. Kivy, The Corded Shell …, cit., Cap. II, To Express and To Be Expressive, pag. 12. Questa distinzione ci informa Kivy la si ritrova nel libro di Alan Tormey, The Concept of Expression: A Study in Philosophical Psychology and Aesthetics (Princeton University Press, Princeton, 1971, Cap. II). Sembrerebbe che sia stato proprio il libro di Tormey a trasmettere a Kivy una visione chiara riguardo al concetto di
espressione.
63
stanno così invece nell’altro caso, la tristezza del muso del San Bernardo, ma anche in
altri casi analoghi a questo, come, ad esempio, quello del salice piangente. Il muso del
San Bernardo non esprime tristezza, ma è espressivo di essa. La tristezza del muso del
San Bernardo esiste – evidenzia Kivy – in virtù del nostro vederla come una sorta di
caricatura del volto umano quando esprime tristezza. Inoltre, possiamo affermare che
se il San Bernardo ci appare triste è anche per via di altri suoi tratti fisici, gli occhi umidi, la fronte aggrottata, la bocca ricurva e le orecchie afflosciate; caratteristiche, queste, che rimandano tutte alle caratteristiche di un volto umano quando esprime tristezza.
La tristezza sarebbe quindi una qualità del muso nella stessa maniera in cui l’allegria è
una qualità del giallo. Stessa cosa dicesi del salice piangente, esso non è così definito
perché realmente sta provando la tristezza, bensì perché è espressivo di tristezza (paradigma dell’essere espressivo di φ, dove “φ” è il nome di un’emozione oppure di un
umore, come la rabbia, la malinconia, etc.). Il problema ora è questo: a quale dei due
paradigmi
dobbiamo
ricondurre
l’espressività
della
musica?
Al
paradigma
dell’esprimere un’emozione? Oppure al paradigma dell’essere espressivo di?
Noi tutti, evidenzia Kivy, abbiamo tentato, chi in un modo chi nell’altro, di descrivere una canzone, una melodia, un tema oppure una sinfonia in termini emotivi:
abbiamo detto di una canzone che è triste, di una melodia che è allegra, di un tema che
è minaccioso, di una sinfonia che è malinconica. Leggiamo questo tipo di descrizioni
della musica dappertutto, nella più “alta” e consapevole così come nella più “bassa” e
inconsapevole forma di critica musicale. Compositori grandi e meno grandi hanno descritto la loro musica in termini emotivi, e così anche i musicologi. Ma, quando noi,
oppure i compositori, i critici, i musicologi, diciamo che una melodia è triste, stiamo
dicendo che essa esprime tristezza o che è espressiva di questa emozione? Applicato
agli esempi visti: stiamo parlando del pugno chiuso di un uomo arrabbiato o del muso
del San Bernardo?
Dal punto di vista di Kivy c’è una buona ragione per accantonare l’idea che
quando diciamo di un brano musicale che è triste ciò equivalga a dire che “la musica
esprime tristezza”. Perché se la musica esprimesse tristezza, questo vorrebbe dire che la
sua tristezza starebbe in stretta relazione con la tristezza di qualcuno, così come l’aver
alzato la voce e il pugno chiuso stanno alla rabbia quando correttamente dico di esprimere rabbia, nel paradigma dell’espressione emotiva. Solitamente, l’ovvio candidato è
il compositore, la cui tristezza si suppone la musica debba esprimere. Una tesi simile,
nota Kivy, è quella sostenuta dal biografo di Beethoven, J. W. N. Sullivan.
64
Per Sullivan infatti la musica di Beethoven è lo specchio dell’uomo, l’espressione delle
sue passioni. Egli scrive così:
Il coraggio e la risolutezza che troviamo nel primo movimento [della
Hammerclavier sonata] sono curiosamente austeri …. Quelle armonie
fredde, così tipiche degli ultimi lavori di Beethoven, non trasmettono
più quella fiducia calorosa e umana di un uomo che sa che la vittoria
sta alla fine. Qui viene espressa una risolutezza arida e spoglia, non
priva di coraggio, ma che non è toccata da nessuna delle gioie che si
possono provare al termine di un conflitto … L’uomo che ha scritto
questa musica è già di per se un gran solitario. Il suo coraggio non si
è affatto affievolito, ma è diventato più torvo. Sembrerebbe che la
sofferenza lo abbia indurito; verrebbe da pensare che quest’uomo non
potrà mai più provare emozioni … Il movimento lento è l’espressione
deliberata, da parte di un uomo che non ha alcun riserbo, di una sofferenza fredda e senza eguali, che sembrerebbe trascinarci in un baratro
dove nulla di ciò che chiamiamo vita potrebbe durare più di un istante 95 .
Quello che emerge chiaramente dalla descrizione di Sullivan non è altro che la
diffusa concezione che la musica non sia espressiva, ma che esprima le emozioni, allo
stesso modo, abbiamo visto, di un essere senziente: che la musica stia insomma alle
emozioni come il pugno chiuso sta alla rabbia, non come la tristezza sta al muso del
San Bernardo. Sullivan, scrive Kivy, impassibilmente usa “espressione” piuttosto che
“espressivo di”. Inoltre, da questo esempio si evidenzia anche che le qualità emotive
della musica sono viste come inerenti allo stato mentale del compositore. La musica di
Beethoven in Hammerclavier non esprime più entusiasmo e fiducia, perché è Beethoven che non ha più fiducia e entusiasmo, e che è diventato un “grande solitario”. Così
descritta la funzione della musica sarebbe quindi quella di comunicare gli stati mentali
del compositore, e, questi stati testimonierebbero la profondità della natura dell’artista
e la qualità delle sue esperienze di vita.
La teoria dell’espressione cui invece pensa Kivy, non c’è ombra di dubbio, rifiuta l’idea che la musica possa esprimere le emozioni piuttosto che essere espressiva
di esse. Una teoria che sgombra il campo quindi dalle facili suggestioni di una critica
intrisa di psicologismi o condotta sulla cattiva strada da una monotona teoria
dell’espressività. Il pericolo è sempre lo stesso: quello di descrivere la musica emotivamente anche quando è perfettamente chiaro che essa non esprime le emozioni che le
ascriviamo; la descriviamo così infatti anche quando non abbiamo modo di sapere se
95
J. W. N., Sullivan, Beethoven: His Spiritual Development, Vintage Books, New York, 1960, pp. 13839.
65
esprime quelle emozioni perché non abbiamo modo di conoscere quali erano gli stati
emotivi del compositore quando l’ha scritta. Questo ci deve far molto pensare, osserva
Kivy, perché accade di fatto che la maggior parte delle nostre descrizioni emotive della
musica sono logicamente indipendenti dagli stati della mente del compositore, mentre
se il mio pugno chiuso è o non è un’espressione della mia rabbia è logicamente dipendente dal fatto di essere o non essere arrabbiato. L’espressività della musica rientra
quindi nel paradigma dell’essere espressivo di φ.
A questo punto dobbiamo capire in che senso la musica espressiva ha la stessa
relazione con le emozioni che il muso del San Bernardo ha con l’emozione della tristezza. Kivy distingue tre caratteristiche espressive 96 :
1. In primo luogo ci sono le caratteristiche della musica di cui si può dire che
«suonano come» i suoni emessi dagli esseri umani nell’esprimere le loro emozioni: pensiamo all’esempio più ovvio del linguaggio parlato. Una musica è
percepita come allegra quando è brillante, forte e nel registro alto, perché le
persone allegre si esprimono con toni brillanti, forti, a volte persino rumorosi.
2. In secondo luogo ci sono quelle caratteristiche della musica di cui si può dire
che rassomiglino, nel loro suono, ad aspetti visibili del comportamento espressivo umano: per esempio il ritmo della gestualità, il movimento del corpo. La
musica in questo caso è comunemente descritta in termini molto simili a quelli
che usiamo per descrivere il movimento del corpo umano sotto l’influsso di
emozioni.
3. In terzo luogo ci sono alcune caratteristiche musicali, in particolare gli accordi
di maggiore, minore e diminuito, che, per la maggior parte delle persone, possiedono rispettivamente i toni emotivi dell’allegria, della malinconia e
dell’angoscia, ma che non sembrano rassomigliare né al suono dell’espressione
umana né al suo aspetto visibile, perché – come il giallo e la sua allegria – sono
semplici qualità percettive.
Nei primi due punti troviamo delineata quella che Kivy in The Corded Shell definì «teoria del profilo» (contour theory or model) 97 dell’espressività musicale. Tale
teoria è stata così definita perché essa spiega l’espressività della musica mediante la
congruenza, l’analogia, del “contorno” o “profilo” della struttura musicale con le manifestazioni acustiche e visive dell’espressione emotiva umana. Kivy tiene a precisare
96
P. Kivy, Filosofia della musica. Un’introduzione, cit., pag. 47.
Cfr. The Corded Shell …, cit., cap. VIII, pp. 71-83; Cfr. anche Filosofia della musica …, cit., pp. 4853.
97
66
che la teoria del profilo non è da considerarsi una teoria rappresentazionale, una teoria
cioè secondo cui la musica rappresenta la voce e la gestualità dell’espressione umana.
Da questo punto di vista infatti noi non udiamo le emozioni della musica, nella musica,
come rappresentate, in maniera mediata, bensì in maniera immediata. L’analogia tra la
musica e il comportamento espressivo umano infatti, secondo Kivy, la si può cogliere a
livello subliminale, vale a dire: dobbiamo trovarci in uno stato di inconsapevolezza rispetto all’esistenza dell’analogia stessa, non dobbiamo in alcun modo presupporla. Il
problema è comprendere però perché dovremmo udire emozioni nella musica a causa
di questa percezione subliminale, e non udire invece qualcos’altro. Questo dipenderebbe dall’evoluzione che ci struttura in un certo modo per selezione naturale. Kivy spiega
infatti che la tendenza generale di noi esseri umani è quella di vedere le figure ambigue
come forme animate anziché come forme inanimate: come esseri viventi, piuttosto che
non-viventi. Vediamo forme viventi nelle nuvole, nelle macchie sui muri, così come
nelle cose che si celano ombrose nei boschi. Se vediamo un bastone, facilmente siamo
portati a pensare che si tratti di un serpente ed è meglio che le cose stiano così, perché
se fuggiamo da un bastone il massimo rischio che possiamo correre è quello di sprecare
inutilmente un po’ delle nostre energie, farci venire il fiatone, mentre se fuggiamo da
un serpente siamo al riparo da un potenziale pericolo. L’evoluzione insomma dice:
«Meglio sicuri che sofferenti. Meglio errare che essere mangiati» 98 . La stessa cosa sostiene Kivy accade con i suoni, accade cioè che li percepiamo come animati, come espressivi di emozioni. Tuttavia, nel caso dei fenomeni visivi ambigui siamo coscienti di
quello che stiamo vedendo, mentre nel caso della musica le cose funzionano diversamente: per quanto possiamo essere consapevoli delle proprietà espressive, non siamo
altrettanto consapevoli del fatto che prendiamo il profilo musicale per un enunciato espressivo. Se questo accade, spiega Kivy, è perché il senso dell’udito ha meno importanza nella lotta per la sopravvivenza, a differenza del senso della vista che è invece il
senso primario degli esseri umani e anche di altri primati superiori. È probabile quindi
che quella che originariamente era una tendenza consapevole, udire cioè i suoni ambigui come animati e come potenzialmente minacciosi, con il tempo, a causa di ragioni
evolutive, sia divenuta inconsapevole.
A nostro modo di vedere la teoria del profilo richiama alla mente la tesi isomorfica sostenuta da Langer, la quale forte delle acquisizioni degli psicologi gestaltisti 99
98
P. Kivy, Filosofia della musica, cit., pag. 51.
La teoria dell’isomorfismo viene presentata da Köhler in un saggio del 1920, Die Physischen Gestalten in Ruhe und im stationärem Zustand [Le forme fisiche in quiete e nello stato stazionario], come teo99
67
spiegava che in realtà esisterebbe un’analogia formale tra le proprietà strutturali proprie
della musica e le proprietà formali del feeling umano 100 . Kivy stesso non manca di evidenziare tale affinità, anche se tiene rilevare le differenze che intercorrono tra la sua
concezione e quella della Langer. Mi sembra utile riportare quanto egli scrive a tale
proposito:
Credo che sarebbe utile, a questo punto, contrapporre alla concezione
qui sostenuta quella della Langer, con la quale ha qualche affinità;
poiché si potrebbe pensare che ciò che qui si sta sostenendo è semplicemente un rimaneggiamento delle sue ben note obiezioni. Sia Langer che io affermiamo che la musica possiede qualche somiglianza
con la “vita emotiva”, e che, in un modo o nell’altro, è proprio qui
che possiamo trovare la spiegazione della sua espressività. Ma da qui
iniziano le differenze. La Langer afferma, diversamente da me, che
l’“isomorfismo” (un suo termine) della musica con la vita emotiva fa
sì che la musica sia un simbolo di tale vita. Io affermo invece che la
musica è espressiva di emozioni singole e specificabili, per lo meno
entro certi limiti, laddove lei nega questo punto, sostenendo solo che
la musica è un simbolo della vita emotiva considerata come un insieme unico, e che non può essere simbolica – e quindi non può essere
ria generale delle strutture fisiche (per esempio un magnete avvicinato ad altri magneti ne altera la configurazione spaziale complessiva): il suo uso in psicologia non è che un’applicazione particolare. Tale teoria nasce da una riconsiderazione da parte di Köhler, ma anche degli altri gestaltisti berlinesi, del ruolo
delle sensazioni. Nello specifico viene criticato – a seguito di una serie di esperimenti, condotti da Wertheimer nel 1910, sulla percezione del movimento apparente o movimento-phi – uno dei paradigmi della
psicologia associazionista, l’ipotesi della costanza, secondo cui si deve assumere una corrispondenza
puntuale tra lo stimolo e la percezione. Per Köhler invece una simile corrispondenza non esiste, esiste
invece una più generale somiglianza strutturale tra complessi gestaltici di stimoli da un lato e fenomeni
psichici globali dall’altro. Il processo percettivo non è pertanto una forma di interpretazione a partire da
stimoli indipendenti collegati in seguito da processi inferenziali e associativi, ma è caratterizzato fin dal
principio da una tendenza alla globalità. Le Gestalten psicologiche, come le Gestalten fisiche, obbediscono a leggi di organizzazione (di somiglianza, contiguità, proseguimento naturale, ecc.).
Per quanto concerne da vicino il riferimento alla dinamica musicale, nell’altra importantissima opera del
1929, Gestalt Psychology, Köhler così scriveva: «In modo affatto generale, i processi interiori, vuoi emotivi, vuoi intellettuali, mostrano tipi di sviluppo che si possono terminizzare con elementi comuni nella terminologia musicale, quali crescendo e diminuendo, accelerando e ritardando. Come queste qualità
occorrono nel mondo delle esperienze acustiche, occorrono anche nel mondo di quelle visive, per cui
possono esprimere caratteristiche dinamiche simili della vita interiore nell’attività direttamente osservabile … Al tempo interiore in accelerazione e al suo livello dinamico corrisponde un crescendo e un accelerando nel movimento visibile. Naturalmente, lo stesso sviluppo interiore può esprimersi in via acustica,
come, per esempio, nell’accelerando e crescendo del parlato …». W. Köhler, Gestalt Psychology, Berlino, 1929, pp. 248-249.
100
Nell’opera Sentimento e forma a tale proposito Langer scriveva: «Le strutture tonali che noi chiamiamo “musica” hanno una stretta somiglianza logica con le forme del sentimento umano: forme di sviluppo e decrescenza, di flusso e di accumulo, di conflitto e di soluzione, di rapidità, arresto, somma eccitazione, calma o attivazione sottile e cadute nella sfera del sogno; non gioia e dolore, forse, ma il mordente dell’una o dell’altra o di entrambi; la grandezza e la brevità e l’eterno trascorrere di tutto ciò che è
vitalmente sentito. Questo lo schema, o la forma logica, del sentire; e lo schema della musica è quella
forma stessa, elaborata nella purezza e nel metro del suono e del silenzio. La music è un corrispondente
tonale della vita emotiva. Una tale analogia formale, o congruenza di strutture logiche, è la condizione
prima per una relazione fra un simbolo e tutto ciò che questo deve significare. Il simbolo e l’oggetto
simbolizzato devono avere una qualche forma logica in comune». S. K. Langer, Sentimento e forma, cit.,
pag. 43.
68
espressiva – di emozioni singole, dal momento che ciò vorrebbe dire
che essa sarebbe un “linguaggio” delle emozioni, il che ovviamente
non corrisponde al vero. Come è stato evidenziato dalla letteratura
precedente, il passaggio dall’ “isomorfismo” al “simbolo” è fallace.
Dal fatto che la musica è isomorfica con la vita emotiva, non segue
che essa simbolizza la vita emotiva, sebbene l’essere isomorfica con
la vita emotiva potrebbe essere una condizione necessaria (ma non
sufficiente) affinché qualcosa sia un certo tipo di simbolo della vita
emotiva. Questa particolare critica non può essere rivolta contro la
posizione qui difesa; poiché io non sostengo che la somiglianza della
musica col comportamento espressivo renda la musica simbolica di
alcunché 101 .
Con tutte le differenze del caso, a parte cioè la non condivisibilità da parte di
Kivy della teoria langeriana del simbolo, ritenuta una indebita associazione alla nozione di isomorfismo, ciò che si evidenzia in entrambe le teorie è l’esistenza di questa analogia tra le proprietà strutturali-formali della musica e la vita emotiva degli esseri umani, ma anche il fatto che è proprio sulla base di questa somiglianza che sussiste la possibilità di spiegare e quindi comprendere l’espressività musicale.
Resta ora da chiarire il discorso sulla terza proprietà espressiva, quella relativa
cioè agli accordi espressivi, maggiori, minori, diminuiti. In questo caso ci troviamo dinanzi
alla
cosiddetta
teoria
convenzionale
(convention
theory
or
model)
dell’espressività musicale; essa spiega l’espressività della musica come una funzione,
semplicemente, della consueta 102 associazione di alcune caratteristiche musicali a quelle delle nostre risposte emotive. Si tratta di caratteristiche però la cui associazione non
chiama in causa nessun tipo di relazione analogica. È il caso degli accordi espressivi, i
quali sono percepiti dalla maggior parte delle persone rispettivamente come allegri,
malinconici e angosciosi, non perché presentino una qualche analogia con i tratti del
comportamento umano, ma solo perché sarebbero qui in gioco qualità percettive semplici 103 .
Come a giusta ragione, crediamo, ha sottolineato Bertinetto «non basta, come fa
Kivy, affermare che recenti teorie di psicologi, biologi evoluzionisti, filosofi analitici
(di cui Kivy non fornisce le generalità) sostengono che le emozioni fondamentali sono
universali e che il sistema tonale è quello che meglio ha incorporato l’espressione di ta-
101
P. Kivy, The Corded Shell …, cit., pp. 60-61.
Questa tendenza di Kivy di appellarsi continuamente al senso comune, al consueto modo di vedere,
percepire, ascoltare – come avevamo già evidenziato – desta in noi non poche perplessità. Crediamo infatti che siano formule utilizzate con una certa superficialità e vaghezza.
103
Per un approfondimento in merito alla distinzione di Kivy tra qualità semplici e complesse rinviamo
al terzo capitolo di Filosofia della musica …, cit., pp. 42-45.
102
69
li emozioni. Occorrerebbe fornire qualche argomentazione e documentare tale affermazione. Peraltro non sembra ovvio che le emozioni fondamentali (in che senso poi si può
distinguere se un’emozione è fondamentale o meno?), e tanto meno le loro espressioni,
siano le stesse in ogni tempo e cultura. Tanto meno è ovvio che la tonalità maggiore
esprima sempre emozioni positive e viceversa la tonalità minore emozioni negative: isolare l’aspetto armonico dalla struttura ritmica e dalla melodia ostacola la comprensione del complesso rapporto tra la musica e le emozioni. Kivy non dice nulla (per
quanto io ne sappia) sull’espressione di emozioni nel jazz, dove non è affatto raro che,
in rapporto al ritmo e alla melodia, una tonalità minore possa essere espressiva di gioia.
Peraltro i dubbi che affiorano nei più recenti scritti di Kivy intorno alla capacità espressiva della musica sono sintomo del fatto che la teoria naturalistica di The Corded Shell
non è sorretta da convincenti argomentazioni» 104 .
In effetti, oramai da un po’ di tempo a questa parte 105 , Kivy ha seriamente messo in discussione l’intero impianto della teoria del profilo. Non è più certo infatti, questo forse anche per via di alcune critiche ricevute106 , che ci siano analogie riconoscibili
tra il profilo musicale e l’espressione umana, non è nemmeno sicuro che il fenomeno
delle figure visive ambigue possa essere applicato ai suoni e a ciò che ascoltiamo in essi, né tantomeno quindi che la spiegazione evoluzionistica possa a questo punto essere
di qualche utilità. Tuttavia, Kivy è giunto alla conclusione che, per quanto buffo possa
apparire, la teoria del profilo, non avendo ancora trovato, per così dire, una degna sostituta, resta attualmente la più attraente. Semplicemente – egli dice – si rifiuta di morire,
104
A. Bertinetto, Bach e il San Bernard. La filosofia della musica di Peter Kivy, cit., 100-101.
Cfr. New Essays on Musical Understanding, cit.; Filosofia della musica …, cit.
106
Tra queste le più significative sono quelle che gli sono state mosse da Jerrold Levinson e Stephen Davies. Entrambi sono sostenitori di una teoria non eccitazionistica dell’espressività musicale. Tanto per
Kivy quanto per Levinson e Davies è valido infatti il principio dell’externality claim, secondo cui
l’espressività della musica è vincolata alla struttura musicale stessa. Questo è sicuramente il tratto comune delle loro teorie. Anche se poi ciascuno spiega diversamente questa appartenenza. Secondo Davies (il
quale è molto vicino all’impostazione cognitivista di Kivy) l’esperienza che abbiamo della musica è
quella di caratteristiche emotive il cui aspetto è associato con un’emozione. Ma la capacità di riconoscere
un certo brano o passaggio musicale come espressivo di una certa emozione può dipendere non soltanto
da fattori naturali, ma piuttosto dall’ambiente socio-culturale. A tale proposito cfr. S. Davies, Musical
Meaning and Expression, cit.; S. Davies, Themes in Philosophy of Music, Oxford University Press, Oxford 2003, pp. 119-91, in particolare pag. 185. Sulla convenzionalità dei sentimenti e della loro espressione musicale insiste anche David Carr, il quale, sostiene da un punto di vista wittgensteiniano che la
musica ha il suo proprio carattere emotivo. Cfr. D. Carr, Music, Meaning, Emotion, in «The Journal of
Aesthetics and Art Criticism», 63, 2004, pp. 225-34.
Per Levinson invece un passaggio musicale è espressivo di una certa emozione soltanto se tale passaggio
è ascoltato, da una persona esperta di quel genere musicale, come espressione di quella data emozione. E
poiché l’espressione di un’emozione richiede l’esistenza di un soggetto che esprime l’emozione, ascoltare un’emozione in musica significa ascoltare – magari in modo subliminale – un agente nella musica,
una «persona» musicale. Cfr. J. Levinson, Musical Expressiveness, in The Pleasures of Aesthetics, cit.,
pp. 20-125; Id., Musical Expressiveness as Hearability as Expression, in M. Kieran (a cura di), Contemporary debates in Aesthetics and the Philosophy of Art, Blackwell, Oxford 2006, pp. 192-204.
105
70
nonostante le sue numerose difficoltà. Quale soluzione adottare allora? Kivy non ce lo
dice. Si ferma solo a constatare che attualmente c’è un accordo generale sul fatto che la
musica esprima le qualità emotive come qualità percettive, e che quindi la cosa migliore da fare, stando così le cose, è di attendere fiduciosi che nel futuro si trovi un spiegazione più convincente. Ritiene, infatti, che sia un errore rimanere impantanati nel problema di come la musica riesca a contenere le emozioni comuni come qualità percettive; ne consegue la scelta di dirigere l’attenzione al ruolo che tali qualità giocano nella
struttura e nell’esperienza musicale. Interessante a tale proposito riportare una immagine molto significativa che Kivy utilizza per spiegare il fenomeno dell’espressività musicale, quella della musica come una scatola nera:
Consideriamo dunque la musica, sotto questo rispetto, come una
«scatola nera», come dicono gli scienziati: vale a dire, come una
macchina di cui ci è ignoto il funzionamento interno. Sappiamo che
cosa vi entra e che cosa ne esce. Rispetto al modo in cui la musica
riesce a esibire le emozioni comuni come qualità percettive, essa è
per noi una scatola nera. Sappiamo che cosa vi entra: le qualità musicali che, per tre secoli, sono state associate con le emozioni particolari di cui la musica è espressiva. E sappiamo che cosa ne esce: le qualità espressive che sono udite come espresse dalla musica. E piuttosto
che farci prendere dall’ossessione di penetrare dentro questa scatola
nera, dovremmo, o per lo meno alcuni di noi dovrebbero, tenere presenti le implicazioni che questo nuovo modo di considerare le qualità
espressive della musica (infatti è davvero un modo nuovo) ha per la
nostra comprensione complessiva della musica 107 .
3. L’espressività musicale: una breve storia
Chiarito dunque che la musica assoluta 108 , secondo Kivy, non esprime letteralmente le emozioni, ma è espressiva di esse, sarà necessario entrare meglio nel merito
107
P. Kivy, Filosofia della musica …, cit., pag. 59.
Non dobbiamo dimenticare che al centro dell’indagine di Kivy troviamo la musica assoluta, la cui rapida affermazione verso la seconda metà del diciottesimo secolo segna un momento di svolta radicale di
quella tradizione che fino ad allora pensando alla musica pensava principalmente alla musica vocale. Per
quanto infatti evidenzia Kivy la musica strumentale non fosse sconosciuta in epoca pre-moderna ed esistevano comunque splendide composizioni, essa non godeva, diciamo così, della stessa considerazione
della musica vocale. Questa situazione notavamo però che ad un certo punto muta radicalmente, visto
che la produzione di musica strumentale aumenta notevolmente, e, ancor di più, essa diventa il centro
dell’attenzione di intellettuali e filosofi. La musica non deve più necessariamente farsi imitazione o rappresentazione della voce umana parlante come aveva voluto la tradizione inaugurata da Platone e sopravvissuta anche nelle idee degli esponenti della Camerata Fiorentina, ma può essere concepita come un
108
71
della questione di come tali emozioni possano essere vincolate alla struttura musicale,
capire quindi in che termini egli intenda questo rapporto, in che senso cioè esso possa
sussistere e debba essere interpretato. Interessante per noi, da questo punto di vista, dare una rapida lettura del percorso storico-teorico tracciato e seguito da Kivy, in alcune
sue opere in particolare 109 , entro il quale, avremo modo di verificare a breve, una tale
concezione viene a chiarirsi. Kivy si confronta sempre con un oggetto ben selezionato;
anche quando si propone di dare uno sguardo rapido alla storia del pensiero musicale,
egli dirige l’attenzione in modo quasi esclusivo alla musica assoluta occidentale e ai
modi in cui essa è stata interpretata. Una scelta questa che ha fatto molto discutere e
che è stata oggetto di critiche aspre, soprattutto da parte di chi ha visto tale restrizione
del campo d’indagine come un ostacolo per qualsiasi tentativo di guadagnare un respiro
universale 110 . Vale a dire non si può parlare di Musica, quando tutto il discorso è rivolto ad una tradizione musicale ben determinata storicamente e geograficamente. Il percorso nella storia dell’estetica musicale compiuto da Kivy si snoda lungo due direttrici
principali: da un lato troviamo il riferimento ai classici del pensiero filosofico che hanno dedicato particolare attenzione all’arte dei suoni, dall’altro invece il confronto con le
tesi di filosofia della musica attualmente più discusse in ambito analitico (Susanne
Langer, Leonard Meyer).
Apriamo una breve parentesi per evidenziare come anche in questo caso si possa rilevare la piena sintonia di Kivy con l’altra tendenza diffusa tra gli analitici che è
qualcosa che è dotato d’un potere espressivo autonomo: essa è capace di veicolare emozioni e significati,
grazie alle capacità semantiche che le sono state riconosciute anteriormente, all’epoca della sua stretta
unione con il linguaggio verbale. Scrive Kivy a tal proposito, «Per la stragrande maggioranza della popolazione mondiale, «musica» significa musica cantata. Per la stragrande maggioranza delle persone della
storia dell’umanità, «musica» ha significato musica cantata. Il moderno «problema della musica» è figlio
della musica strumentale pura: musica assoluta, sola musica». Cfr. Filosofia della musica …, cit., pag.
61.
109
Cfr. P: Kivy, The Corded Shell …, cit.; Filosofia della musica …, cit.; Queste per lo meno sono le opere dove troviamo organicamente dispiegato tale percorso, ma potremmo in generale segnalare un po’
tutte le sue opere, poiché Kivy costantemente non rinuncia a questo confronto, a volte anche muovendosi
senza seguire un preciso ordine di comparizione delle diverse teorie. Ad ogni modo, il lettore, sicuramente, avrà già constatato che sono quelli i due testi di Kivy cui siamo soliti riferirci, e questo non a caso. Alla base di questa decisione c’è infatti una ragione precisa, poiché il The Corded Shell è la prima
opera in cui Kivy getta le basi di tutta la successiva speculazione filosofica sulla musica ed è anche il
luogo dove prende forma per la prima volta la teoria del formalismo emotivo, e Filosofia della musica,
oltre che essere la più recente opera scritta, è invece il testo nel quale troviamo una summa delle principali tesi filosofiche sulla musica esposte da Kivy nelle sue precedenti pubblicazioni. Si tratta, inoltre di
un’opera, nella quale, evidenziavamo, egli, alla luce dell’esperienza acquisita, valuta criticamente alcune
delle proposte teoriche avanzate che filosofi a lui contemporanei hanno seriamente messo in discussione.
110
Un altro importante aspetto da tenere in considerazione è proprio questo, e cioè, l’interesse di Kivy è
tutto direzionato verso la musica classica occidentale. Nel The Corded Shell chiaramente si evidenzia
questo dato quando Kivy scrive: « … E fintantoché la mia spiegazione sarà storica, basata su certi fatti
relativi alla musica e alla sua evoluzione nell’Occidente, questa monografia sarà filosofica non in senso
stretto». P. Kivy, The Corded Shell …, cit., pag. 16. Tutti gli esempi musicali di Kivy attingono dal repertorio della musica classica occidentale.
72
quella, ricordiamo, di avanzare le personali proposte a seguito di un’esplorazione delle
teorie che hanno inciso profondamente nella riflessione filosofica, se pure ritagliando
in maniera estremamente selettiva i riferimenti ad essa.
In che modo quindi è stata intesa l’espressività musicale nella storia del pensiero estetico? Viste in uno schema, le teorie più rappresentative sembrano riassumersi così:
a) teoria dello eccitazionistica o modello disposizionale;
b) teoria rappresentazionale;
c) teoria metaforica;
d) una teoria simbolica.
Per quanto concerne specificatamente il primo punto, iniziamo subito ad evidenziare che l’idea fondamentale delle teorie disposizionali è che la musica ha il potere
di suscitare emozioni nell’ascoltatore, ed è triste, gioiosa, malinconica, ecc. proprio in
virtù del fatto che essa suscita tali emozioni in chi ascolta. E, di fatto, nell’ottica delle
teorie disposizionali, dire che un passaggio musicale è malinconico altro significato
non ha se non quello di riconoscergli la proprietà di rendere malinconico l’ascoltatore.
La tradizione del modello disposizionale, avverte Kivy, è una delle tradizioni
che maggiormente ha resistito nel tempo, basti pensare al fatto che essa ha avuto inizio
con la teoria platonica della musica e delle emozioni, è stata ripresa a vario titolo dalle
teorie del diciassettesimo e diciottesimo secolo 111 (tra queste vi è quella più rilevante
della Camerata fiorentina, ma anche la teoria psicologica e fisiologica delle emozioni di
Descartes – sotto influsso della quale si diffuse in Germania la cosiddetta «dottrina de111
Le teorie del diciassettesimo e diciottesimo secolo, ci sembra opportuno evidenziare, rivestono un
ruolo particolarmente significativo nella ricerca filosofica sulla musica di Kivy, in quanto egli sostiene
che se appropriatamente investigate e rivisitate da tali teorie si possono ricavare degli utili spunti per edificare una migliore spiegazione dell’espressione musicale. A tale proposito nella Prefazione a The Corded Shell scrive: «L’argomento di questo libro, così come le sue fonti, rivelano il lungo e imperituro interesse dell’autore per il diciassettesimo e il diciottesimo secolo, e la sua convinzione che sebbene coloro
che in quei periodi hanno scritto sull’espressività musicale si sbagliavano su molte cose, essi avevano
profondamente ragione su qualcosa di importante, e sulla cui base si potrebbe costruire una soddisfacente teoria dell’espressione musicale. È mia intenzione qui portare alla luce tale profondità, e costruire tale
teoria. Spero comunque che il mio debito verso i filosofi del diciassettesimo e il diciottesimo secolo non
comporterà che i capitolo iniziali vengano letti come una storia delle teorie dell’espressione musicale
dell’Illuminismo. Non è questo il mio scopo. La mia selezione delle teorie è alquanto parziale, e si basa
non su un giudizio storico ma semplicemente su ciò che mi potrebbe essere utile per costruire la mia teoria»; The Corded Shell, cit., pag. xiii. Una precisazione simile si ritrova anche in Filosofia della musica,
dove egli precisa: «Per raccontare la storia che sono tenuto a riferire devo ora saltare quasi duemila anni
per giungere alla fine del sedicesimo secolo. Non perché nel frattempo non sia stata compiuta nessuna
riflessione sulla musica e le emozioni. Tuttavia c’è un continuità speciale tra la storia che comincia con
Platone e Aristotele e il revival delle loro teorie delle emozioni in musica nel tardo Rinascimento. Tale
storia ininterrotta è quella più pertinente al nostro progetto ed anche quella che risulta più proficua da
percorrere»; Filosofia della musica …, cit., pp. 21-22.
73
gli affetti» (Affektenlehre) – e la nuova teoria delle emozioni che nacque in Gran Bretagna, verso la fine del diciottesimo secolo, sulla base della psicologia associazionistica
112
), e si è protratta in maniera incisiva fino ai nostri giorni con la cosiddetta “arousal
theory of emotions” (teoria eccitazionistica delle emozioni) 113 .
Kivy si oppone decisamente al modello disposizionale delle teorie eccitazionistiche. Le
principali obiezioni mosse sono le seguenti 114 :
112
La teoria della Camerata fiorentina, così come la teoria cartesiana delle emozioni a cui molti teorici
verso la metà del diciottesimo secolo aderirono, e la teoria di chi invece scelse di spiegare la relazione
musica-emozioni seguendo il modello della psicologia associazionistica, secondo Kivy sono tutte teorie
che hanno in comune il fatto di essere teorie disposizionali che accettano la spiegazione secondo la quale
X (la musica) è triste se X eccita tristezza. Sotto questo aspetto, naturalmente, egli preferisce rifiutarle.
Tuttavia, in comune hanno anche la concezione secondo cui il maggiore operatore nell’espressività musicale – o comunque uno dei maggiori operatori – è una somiglianza della musica con alcuni aspetti
dell’umana espressione. Da questo punto di vista, non è difficile a questo punto capire, tali teorie sono da
recuperare. Kivy lo ha fatto. Se pensiamo, ad esempio, alla teoria sostenuta dai membri della camerata
fiorentina - i quali pensavano che il modo di eccitare un’emozione nell’ascoltatore è quello di creare una
somiglianza della linea musicale con la voce umana parlante appassionata (per questa ragione tale teoria
è denominata da Kivy “speech theory”, teoria della parola) – subito potremmo accorgerci come essa riviva nella teoria del profilo. Certo Kivy estende l’analogia della musica in generale al comportamento
espressivo umano, ma il tono della voce rientra pienamente nella sua descrizione. Ma anche la teoria
dell’espressività spiegata secondo la teoria cartesiana rivela questa somiglianza; l’idea ricordiamo era
che la musica può suscitare emozioni in virtù della somiglianza che essa presenta con gli spiriti vitali.
Così se un compositore avesse desiderato scrivere per esempio musica triste, ciò che egli avrebbe dovuto
fare sarebbe stato scrivere musica la cui configurazione generale somigliasse alla configurazione degli
spiriti vitali appropriata per suscitare una tale emozione. Nella teoria dell’espressività ricondotta alla teoria psicologica associazionista troviamo invece la descrizione di quel fenomeno che Kivy chiama della
“nostra canzone”. La teoria dell’espressione musicale, spiegata secondo l’associazione delle idee nello
specifico, si fonda sulla considerazione che è mediante le associazioni per l’appunto che un individuo
può fare (in relazione a quello che è lo stato emotivo di quel momento e in base alle particolari esperienze di vita vissute), durante l’ascolto che la musica può eccitare una particolare emozione. (Sul fenomeno
della nostra canzone però ritorneremo più avanti). Sulle spiegazioni associazionistiche dell’espressività
musicale sviluppate nel Diciottesimo secolo, si veda Maria Semi (a cura di), Il suono eloquente. Musica
tra imitazione, espressione e simpatia, Aesthetica Preprint, Palermo 2008.
113
Come avevamo già rilevato sono numerosi i teorici contemporanei che riabilitano nuove versioni, o
varianti, dell’Arousal Theory. Ecco alcuni testi di riferimento a testimonianza della vivacità del dibattito:
S. Speck, “Arousal Theory” reconsidered, in “The British Journal of Aesthetics”, 28, 1991, pp. 40-47;
M. Budd, Music and Communication of Emotions, in “The Journal of Aesthetics and Art Criticism”, 53,
1989, pp. 129-138; R. T. Allen, The Arousal and Expression of Emotion by Music, in “The British Journal of Aesthetics”, 30, 1990, pp. 57-61; J. Robinsoon, The Expression and Arousal of Emotion in Music,
in “The Journal of Aesthetics and Art Criticism”, 52, 1994, pp. 13-22; A. Ridley, Musical Sympathies:
The Experience of Expressive Music, in “The Journal of Aesthetics and Art Criticism”, 53, 1995, pp. 4958; A. Goldman, Emotion in Music (A Postscript), in “The Journal of Aesthetics and Art Criticism”, 53,
1995, pp. 59-69; J. E. Mackinnon, Artistic Expression and the Claims of Arousal Theory, in “The British
Journal of Aesthetics”, 36, 1996, pp. 278-289; D. Matravers, Art and Emotion, cit.; Id., The Experience
of Emotion in Music, cit.; A. Beever, Arousal Theory Again?, in “The British Journal of Aesthetics”, 38,
1998, pp. 82-90; J. Kingsbury, Matravers on Musical Expressiveness, in “The British Journal of Aesthetics”, 42, 2002, pp. 13-19.
114
Per un approfondimento rinviamo all’opera New Essays on Musical Understanding, nella quale troviamo un capitolo, precisamente il settimo, interamente dedicato alla “Arousal Theory”, capitolo nel
quale muovendosi dalle critiche che Derek Matravers (uno dei principali sostenitori della teoria eccitazionistica in ambito analitico) ha mosso in una recente opera, Art and Emotion, alla sua teoria cognitivista dell’espressività musicale, giunge a dare una spiegazione delle principali motivazioni per cui una teoria eccitazionistica non può essere accettata. Cfr. D. Matravers, Art and Emotion, cit.. pag. 114-144. Una
puntuale disamina critica nei confronti dell’Arousal Theory è anche quella proposta da Kivy in The Corded Shell, cit., nel capitolo and Nevertheless it’s sad, pag. 153-157.
74
1. La prima è quella che si viene ad evidenziare nel cosiddetto “argomento del
comportamento”, vale a dire: quando diciamo che un brano musicale esprime rabbia, perché ci fa sentire rabbia, noi in realtà stiamo descrivendo in
maniera errata le emozioni che proviamo ascoltando il brano, in quanto
mancano tutte le componenti comportamentali presenti quando noi siamo
realmente arrabbiati;
2. la seconda obiezione è invece quella che troviamo esplicata nel cosiddetto
“argomento delle emozioni negative” 115 : se una musica è triste perché causa
tristezza nell’ascoltatore, soltanto un masochista continuerebbe ad ascoltare
musica triste. Non si comprende perché ci si dovrebbe esporre alla tortura di
ascoltare un brano musicale che, nonostante la sua bellezza, rende tristi, pur
avendo a disposizione moltissima musica allegra e di ottima qualità 116 .
3. Terza obiezione: il modello disposizionale riesce infine a spiegare solo casi
di personali idiosincrasie o occasionali e soggettive reazioni; casi irrilevanti
per la comprensione della musica in sé. È vero che una determinata opera
musicale, per es. la Settima di Beethoven, può suscitare tristezza in qualcuno, per il fatto di essere associata a un periodo o a un episodio triste della vita di un particolare ascoltatore. È chiaro che in circostanze speciali – che
coinvolgono le esperienze individuali dell’ascoltatore o il suo particolare
stato emotivo – un brano musicale può provocare emozioni reali
nell’ascoltatore. Si tratta del fenomeno da Kivy chiamato della “nostra canzone” 117 . Tale fenomeno è però del tutto irrilevante per la comprensione estetica della musica, perché dipende unicamente dalla situazione psicologica
individuale dell’ascoltatore, mentre il compito del filosofo della musica è la
comprensione del carattere emotivo della musica a partire dall’analisi delle
sue qualità estetico - strutturali.
115
Per un approfondimento del discorso sulle emozioni negative interessante è il saggio di Jerrold Levinson dedicato interamente alla questione del perché ci esponiamo consapevolmente anche all’ascolto di
quella musica che incide sul nostro stato d’animo negativamente. J. Levinson, Music, Art, and Metaphysics: Essays in Philosophical Aesthetics, Cornell University Press, Ithaca, 1990, pp. 306-335.
116
All’ovvia replica, secondo cui allora non si comprenderebbe perché, nel caso di opere letterarie o cinematografiche, il genere tragico sia così apprezzato, Kivy risponde che il piacere derivante da una tragedia può sorgere dall’esplorazione delle emozioni e dei sentimenti negativi, cosa questa che invece non
accade nell’ascolto della musica, dato che questa non è un’arte rappresentativa, e, ancora più importante,
evidenzia Kivy, non è un’arte linguistica.
117
L’espressione è tratta dal film di M. Curtiz Casablanca (USA, 1942) dove, com’è noto, Rick proibisce a Sam, il pianista di suonare “As time goes by”, la canzone preferita di Rick e del suo perduto amore,
Ilsa, perché questa canzone lo rende triste, in quanto gli ricorda la fine della storia d’amore.
75
All’Arousal Theory si contrappone il secondo modello di spiegazione delle relazioni tra la musica e le emozioni, vale a dire, il modello rappresentazionale, la cui
storia ha inizio con Aristotele. Secondo questa teoria, la musica non rappresenta
un’espressione fisica delle emozioni umane, ma l’emozione umana stessa. Le emozioni
non sono così più legate alle reazioni dell’ascoltatore, come accadeva nell’Arousal
Theory, ma si trasferiscono, per così dire, dall’ascoltatore alla musica stessa. Un brano
musicale è percepito e può essere descritto come triste, gioioso, malinconico, ecc., perché è la musica in se stessa a rappresentare la tristezza, la gioia, la malinconia, non
perché suscita tali emozioni negli ascoltatori.
Tale teoria è quella che viene a riaffiorare in maniera incisiva nella filosofia
della musica di Schopenhauer, grazie al quale, evidenzia Kivy, si ruppe per la prima
volta il monopolio asfissiante che la teoria eccitazionistica aveva avuto, per oltre due
secoli, sul tentativo di spiegare il fenomeno dell’espressività musicale. Infatti, considerando la musica come una manifestazione della volontà, Schopenhauer suggerì allo
stesso tempo che essa potesse essere anche una rappresentazione delle emozioni umane. Fu così che le emozioni della musica furono sottratte in un sol colpo all’esperienza
esclusiva dell’ascoltatore, per essere collocate dentro la musica. Tuttavia Kivy non aderisce nemmeno alla teoria rappresentazionale di Schopenhauer, poiché egli sostiene
che per quanto perfettamente condivisibile sia il punto di vista che le emozioni appartengono alla musica e non all’ascoltatore, non è altrettanto opportuno spiegare tale aderenza delle emozioni alle proprietà strutturali della musica mediante, per l’appunto, una
relazione di tipo rappresentativo.
Proseguendo nell’analisi, scopriamo che Kivy prende le distanze anche dalla
teoria metaforica dell’emozione, secondo la quale descrivere emotivamente la musica è
solo una possibilità tra le tante disponibili per avvicinarsi allo specifico musicale, se è
vero che si possono scegliere caratterizzazioni che non chiamano in causa la vita emotiva, come quando diciamo, ad esempio, che una musica è bilanciata o delicata. Primo
sostenitore di una teoria metaforica delle emozioni in musica è stato Hanslick, il quale
però, secondo l’opinione di Kivy, ne ha fin da subito evidenziato le contraddizioni. Il
problema di Hanslick è quello di essere un ‘emotivista’ malgrè lui, poiché pur sostenendo sul piano teorico il carattere puramente metaforico delle descrizioni sentimentali,
nella sua concreta attività critica, quando cioè si trova a dover raccontare la musica,
spiegarne forme e dinamiche, non può che descriverla in termini emotivi.
76
L’ultimo modello che incontriamo in questo viaggio attraverso le diverse teorie
dell’espressione musicale è quello del simbolismo langeriano, secondo il quale la musica è iconicamente simbolica della vita emotiva in generale, e lo è sulla base di una relazione «isomorfica» con essa. Sappiamo però da quanto abbiamo illustrato nel precedente paragrafo quali sono le ragioni per cui Kivy prende parzialmente le distanze anche da questo modello. Un approfondimento non è quindi necessario.
4. Kivy dialoga con Levinson e Davies
Alla luce di quanto detto finora, continuiamo adesso ad esaminare il percorso di
Kivy riportandoci questa volta al dialogo che egli intrattiene con i contemporanei filosofi della musica. Diciamo subito che i suoi due referenti preferiti sono Stephen Davies
e Jerrold Levinson, con i quali intrattiene un intenso e serrato dialogo soprattutto in relazione al problema di come la musica possa commuoverci emotivamente, sul come e il
perché di questo effetto emotivo 118 . Problema questo che si pone principalmente a chi
rifiuta una teoria eccitazionistica e preferisce invece aderire alla concezione che le proprietà emotive siano proprietà della stessa struttura musicale, a chi, in altre parole, riconosce valido il requisito dell’externality claim. Spiega infatti Kivy che nella semplice
teoria eccitazionistica una tale questione non affiora, in quanto in essa il problema
dell’espressività musicale viene a fondersi con la questione del potere emotivo che la
musica ha su di noi. La situazione è diversa quando anziché riconoscere le emozioni in
noi, le riconosciamo nella musica.
Levinson e Davies sostengono che quantunque sia errato affermare che la musica è triste perché provoca la tristezza nell’ascoltatore, può darsi che la musica susciti
comunque tale emozione nell’ascoltatore e da questo dipende anche il fatto che essa ci
commuova. In Musical Meaning and Expression scrive Davies a tale proposito: «la
musica triste potrebbe spingere alcuni ascoltatori a sentirsi tristi, anche se l’espressività
della musica non va spiegata in funzione del suo potere di risvegliare tale risposta» 119 .
118
Cfr. P. Kivy, ‘How Music Moves’, in Philip Alperson (ed.), What is music? An Introduction to the
Philosophy of Music, Haven, New York, 1987; lo stesso articolo è stato successivamente ristampato a
seguito di un lavoro di revisione in P. Kivy, Music Alone: Philosophical Reflections on the Purely Musicla Experience, Cornell University Press, Ithaca, 1990, (ottavo capitolo). Feeling the musical emotions,
cit.. Cfr. Filosofia della musica …, cit., VII capitolo, Le emozioni in noi.
119
S. Davies, Musical Meaning and Expression, cit., pag. 279
77
Anche Levinson si pone sulla stessa linea argomentativa quando ribadisce che
l’espressività della musica debba considerarsi inequivocabilmente appartenente alla
musica, come una proprietà o una aspetto di essa, piuttosto che all’ascoltatore, ma nello
stesso tempo insiste anche sull’idea che «l’espressività musicale dovrebbe essere tale
che, quando viene percepita o rilevata da un ascoltatore, l’evocazione di un sentimento
o di uno stato affettivo, oppure l’immaginazione di un sentimento, naturalmente, se non
inevitabilmente, ne deriva (requisito dell’ “affettività”)» 120 .
Per Kivy la posizione di Davies e Levinson può essere condivisa sul piano generale: hanno ragione quando rilevano che la musica è espressiva delle emozioni comuni in virtù delle qualità emotive che riconosciamo in essa, quando cioè vincolano
l’espressività alle strutture musicali. Non appare tuttavia a Kivy condivisibile la spiegazione che entrambi forniscono del modo in cui la musica può commuoverci, può cioè
sortire in noi un certo effetto emotivo, e allo stesso tempo non appare altrettanto condivisibile il tipo di caratterizzazione che danno dell’emozione musicale.
Stephen Davies, in particolare, ritiene che le manifestazioni comportamentali
delle emozioni comuni siano assenti nella musica: se sei felice perché la musica ti ha
reso felice, apparentemente non fai le stesse cose che fanno le persone felici quando
provano queste emozioni; stessa cosa se sei triste perché la musica ti ha suscitato questa emozione, certamente non ti comporterai come si comportano le persone quando
sono tristi; semplicemente – egli spiega – resti seduto assorto nell’ascolto. Non bisogna
quindi trascurare, secondo Davies, questa assenza della risposta comportamentale
quando vogliamo parlare di come la musica può commuoverci. Nei casi non-musicali
accade, scrive Davies, che «Se mi sento triste perché credo che la situazione sia sfortunata e deplorevole, cercherò di modificare la situazione per far sì che essa non sia più
sfortunata e deplorevole» 121 . Nei casi musicali invece «Non solo la risposta emotiva è
priva di molte delle credenze che, normalmente, condurrebbero all’azione, ma essa è
anche priva delle credenze che conferiscono intensità a quei sentimenti» 122 . Dopotutto,
l’oggetto intenzionale della tristezza musicale, secondo Davies, non è una situazione
sfortunata e spiacevole, ma è semplicemente la qualità espressiva della tristezza che la
musica possiede. Da questo particolare punto di vista quindi, accade che durante
l’ascolto di una musica triste si faccia esperienza di un modo di sentire analogo a quello reale ma drasticamente indebolito, al punto che a variare sono proprio le forme com120
J. Levinson, “Musical Expressiveness”, cit., pp. 91-92.
S. Davies, Musical Meaning and Expression, cit., pp. 305-306.
122
Ivi, pag. 307.
121
78
portamentali associate all’ascolto. Insomma, nella situazione musicale, come Davies
mette in evidenza, ai nostri sentimenti «mancano gli elementi intenzionali che donano
loro forza e intensità» 123 .
La teoria cui Davies aderisce per illustrare la sua concezione di come la musica
ci commuova è la cosiddetta teoria della tendenza o del contagio, della quale egli è, insieme a Colin Radford 124 , certamente uno dei maggiori sostenitori. L’idea difesa è che
una musica triste ha la tendenza a causare la tristezza nell’ascoltatore, così come la vivacità gioiosa del colore giallo avrebbe la tendenza a suscitare allegria e la cupezza del
nero la tendenza a suscitare malinconia. Detto in altri termini, le proprietà espressive
della musica hanno la tendenza a produrre in chi percepisce le emozioni di cui sono espressive. Davies illustra la teoria del contagio mediante l’esempio dell’operaio che lavora in una fabbrica di maschere tragiche. L’operaio inevitabilmente, egli spiega, dopo
aver trascorso giorni e giorni a diretto contatto con quelle maschere, la cui espressione
si sa è quella di un viso corrucciato, certamente avrà la tendenza a deprimersi. La malinconia delle maschere deve inevitabilmente influenzare il suo stato d’animo. La tendenza della maschera a produrre malinconia potrebbe alla fine avere la meglio su di lui.
La stessa cosa può accadere con la musica malinconica.
Una delle obiezioni di Kivy alla teoria di Davies è che una tendenza è appunto
solo una tendenza; non è detto quindi che susciti effetti reali. Inoltre, affinché l’operaio
si deprima per la sua situazione dovrà vedere le maschere tutti i giorni durante un tempo piuttosto lungo, e precisamente per otto ore al giorno, per cinque giorni alla settimana. Ma nessuno ascolta la musica in questo modo, non sono queste le circostanze normali cui è sottoposto il pubblico di un concerto che normalmente non dura più di tre
ore: normalmente le condizioni di chi ascolta un brano musicale non sono tali da poter
trasformare la tendenza in un fatto reale. Peraltro ciò che accade con una musica triste,
ma bella, è esattamente il contrario: essa non suscita in noi tristezza, quantunque ci
commuova profondamente. «Più spesso che mai, [precisa infatti Kivy], se si è amanti
della musica e l’esecuzione è stata buona, si vive [invece] una sorta di esaltazione 125 . È
chiaro che se una persona trascorresse molto tempo ascoltando musica triste, alla fine si
intristirebbe. Questa però non è una condizione che possa interessare il filosofo, perché
non è la situazione di cui egli deve tener conto nell’analisi dell’emozione musicale: egli
123
Ibidem.
Cfr. C. Radford, Emotions and Music: A reply to the Cognitivists, in “The Journal of Aesthetics and
Art Criticism”, 47, 1989; Id., Muddy Waters, in “The Journal of Aesthetics and Art Criticism”, 49, 1991.
125
P. Kivy, Filosofia della musica …, cit., pp. 147-148.
124
79
deve considerare il caso normale della musica ascoltata in una sala da concerto. Soprattutto Kivy non può esimersi dall’evidenziare l’aspetto della teoria che più confligge
con la sua concezione musicale (capiremo a breve per quali ragioni), e cioè il fatto che
le emozioni di cui parla Davies sono anemiche in quanto il contagio ci rende tristi o allegri, ma in modo soft, pallido: l’emozione che la musica suscita è sì la tristezza, ma
solo in una forma indebolita, incapace di attivare qualsivoglia delle risposte comportamentali ordinariamente associate a quella emozione. Qualsiasi cosa essa sia, non è esattamente la tristezza, in un senso ordinario.
Analogamente a Davies, anche Jerrold Levinson 126 si sofferma ad evidenziare
questo indebolimento della componente cognitiva e della nostra risposta comportamentale per quanto concerne specificamente le emozioni musicali. Ecco le sue parole a riguardo:
È giunto il momento di dire chiaramente che la riposte emotive standard a un brano musicale – ad esempio, quella che io ho chiamato
una reazione triste – non sono in verità delle emozioni piene. Ciò dipende principalmente dal fatto che la musica né fornisce un oggetto
appropriato verso al quale l’emozione possa essere diretta, né produce i desideri, le credenze, o le attitudini relative a un oggetto e che
sono essenziali affinché un’emozione sia ciò che è. Quando un adagio
di una sinfonia mi “intristisce”, non sono né triste in riferimento alla
musica, né considero l’adagio come un qualcosa che vorrei che fosse
diverso da quello che è. Inoltre, questo indebolimento della componente cognitiva nella risposta emozionale alla musica in genere sfocia
nell’inibizione della maggior parte dei comportamenti caratteristici e
in una significativa diminuzione delle tendenze comportamentali 127 .
Diversamente dalle emozioni della vita reale, le emozioni musicali non sono emozioni
piene. Secondo Levinson, infatti, l’emozione che si prova nell’ascolto di un brano musicale manca dell’aspetto cognitivo (non ci interessa l’oggetto che produce o verso il
quale è indirizzato il sentimento, ovvero la musica in quanto causa efficiente o finale) e
126
Jerrold Levinson è senza dubbio uno dei massimi filosofi contemporanei di area analitica. Il suo ambito di studio principale è l’estetica (sebbene egli si sia occupato anche di filosofia morale e di filosofia
della mente). Levinson ha fornito dei contributi fondamentali, in particolare, ai problemi (molto dibattuti
all’interno dell’area anglo-americana) della definizione dell’arte (proponendo una definizione di tipo storico-intenzionale), delle proprietà estetiche (scrivendo tra gli altri un seminale saggio intitolato ‘Aesthetic Supervenience’) e della filosofia della musica (introducendo anche qui una propria proposta teorica
originale e altamente qualificata, che va sotto il nome di ‘teoria della persona musicale’). I suoi principali scritti di estetica e di filosofia della musica sono contenuti in tre volumi, intitolati Music, Art and Metaphysics (1990), The Pleasures of Aesthetics (1996) e Contemplating Art (2006). Alcuni dei suoi saggi
sono stati tradotti in italiano, ed altri suoi saggi saranno tradotti e pubblicati in un testo a lui interamente
dedicato per la casa editrice Aesthetica di Palermo. Attualmente Levinson è titolare di una cattedra di
Estetica all’Università del Maryland (USA).
127
J. Levinson, ‘Music and Negative Emotion’, in Music, Art, and Metaphysics, cit., pp. 313-314.
80
comportamentale, ma presenta un accentuato e caratteristico (in quanto non accompagnato dalla componente cognitiva) aspetto affettivo e fisiologico (ovvero la componente fenomenologica dell’emozione, ciò che uno sente internamente, il feeling specifico).
La descrizione del modo in cui la musica ci commuove passa, nel caso di Levinson, attraverso una teoria empatica, la cosiddetta teoria della persona, della quale
egli non solo è uno dei maggiori sostenitori, ma anche uno dei principali artefici. Secondo tale teoria ogni brano musicale viene ascoltato come un enunciato umano. Possiamo, per esempio, immaginare una sinfonia come incarnazione di un agente, una
“persona musicale”, il quale va inteso come il soggetto delle emozioni che tale sinfonia
esprime (ciò non vuol comunque dire – precisa Kivy – che tale “persona” sia la rappresentazione musicale dell’autore).
Ascoltando la sinfonia, proveremmo cioè le emozioni che immaginiamo che
stia provando la persona musicale, proprio così come empatizziamo con una persona
reale quando esprime le sue emozioni. È proprio in questo senso che la relazione tra la
musica e le emozioni viene vista come una relazione di tipo empatico: l’ascoltatore può
condividere, tramite immedesimazione, le stesse emozioni che la musica “sta provando”, in quel particolare momento. Non è importante il fatto che la persona musicale sia
un prodotto immaginario, dal momento che l’opportunità di immedesimarsi in taluni
sentimenti non deve necessariamente essere subordinata all’esistenza materiale del
soggetto con cui noi empatizziamo; d’altronde la stessa cosa accade con i personaggi di
un racconto, di un film, ecc. (sebbene altra cosa sia comprendere perché ciò accada).
Kivy muove anche in questo caso tutta una serie di obiezioni. Eccone alcune tra le più
significative:
1. La musica mi commuove profondamente anche senza che io percepisca affatto
personae musicali esprimenti i loro stati emotivi;
2. L’analogia tra la persona musicale e i personaggi di finzione della narrativa non
regge. Kivy obietta che a tale ‘persona’ mancano proprio le caratteristiche che
fanno apparire un personaggio immaginario come una persona reale.
3. È complicato spiegare la relazione tra i personaggi immaginari e le emozioni
che proviamo. Nella vita reale per determinare la reazione emotiva di una persona al cospetto dell’espressione emotiva di un’altra persona occorre conoscere
le circostanze della relazione tra le due persone, chi sono, ecc. È semplicemente
falso che la reazione emotiva delle persone di fronte all’espressione di tristezza
di qualcuno sia sempre la tristezza: se la persona triste è una persona cara può
81
succedere che empatizziamo con il suo sentimento, mentre se a provare tristezza è un nostro nemico verosimilmente e crudelmente ci sentiremo felici. Questo
accade anche nel caso della letteratura, del cinema, del teatro, accade cioè che
l’allegria di un personaggio malvagio possa provocare spesso rabbia, non certo
gioia. Se una teoria come quella basata sull’identificazione con i personaggi e
sul sentire le loro emozioni non funziona nel caso della narrativa di finzione –
spiega Kivy – ciò vale a maggior ragione nel caso della musica assoluta.
Dunque la teoria secondo cui proviamo un’emozione perché ci identifichiamo empaticamente con il personaggio immaginario è falsa. Il difensore della teoria delle persona
a questo punto, sostiene Kivy, ha due opzioni:
1. Può affermare che, diversamente dalla vita reale, nel caso della musica empatizziamo sempre con la “persona musicale”, e sempre proviamo l’emozione
che essa esprime – ma allora occorrerebbe spiegare perché questo accade soltanto nel caso della musica e non nella vita reale.
2. O può affermare che, esattamente come nella vita reale e nella finzione narrativa, può accadere che la musica triste provochi allegria e viceversa; però il nostro problema era quello di spiegare precisamente com’è possibile che la musica triste commuova e sia riconosciuta come espressiva di tristezza.
Dunque la teoria della persona musicale non funziona.
In breve, le emozioni suscitate dall’espressività della musica – sottolinea Kivy –
sono, nella tesi sostenuta da Davies, emozioni anemiche (anaemic emotions), e in quella sostenuta da Levinson, quasi-emozioni (quasi-emotions) o emozioni del ‘come se’
(emotion-like). Si tratta semplicemente di surrogati emotivi che ci restituiscono una
pallida immagine di quelle emozioni che nella vita si presentano in modo nitido.
A questa sorta di riflesso della tensione sentimentale nelle forme musicale, a
questa idea di un’emotività sdoppiata e pallida, Kivy invece contrappone la sua teoria
delle emozioni musicali piene, tali perché intenzionano la bellezza della musica stessa.
Riprendendo la teoria cognitiva di Brentano, Kivy evidenzia che l’emozione è un fatto
complesso composto di tre elementi: un oggetto intenzionale, una credenza e un feeling
(sensazione/sentimento). Quando ho paura di qualcosa, per esempio di una tigre, ho
una credenza o una serie di credenze relative a questo oggetto (credo che la tigre sia un
animale feroce e dunque credo che sia troppo pericoloso starle vicino), e un feeling, associato a tale credenza (per esempio un brivido). Tale teoria è la stessa che Kivy rico-
82
nosce valida per le emozioni musicali, le quali anch’esse hanno evidentemente un oggetto, una credenza e un sentimento:
1) L’oggetto dell’emozione musicale è la musica, o, più esattamente, l’insieme
delle caratteristiche della musica che l’ascoltatore crede siano belle, magnifiche,
portatrici di un valore estetico. In una parola, l’oggetto dell’emozione musicale
è la bellezza della musica.
2) La credenza dell’emozione musicale è la credenza dell’ascoltatore che la musica che sta ascoltando, o un suo aspetto, sia bella, magnifica, o possegga comunque proprietà estetiche in modo molto accentuato.
3) Il sentimento è il tipo di eccitazione o di euforia o di stupore o di meraviglia che
una tale bellezza comunemente suscita.
Assistiamo quindi ad una vera e propria virata dell’intenzionalità dal piano
dell’esperienza umana al piano della bellezza della musica, delle sue strutture, che ci
riporta ad un sentimento del suono la cui specificità, a questo punto, nulla ha più a che
spartire con le emozioni della vita reale (pur trattandosi di un sentimento che ha la stessa pienezza delle emozioni ordinarie, diversamente da quanto sostenuto da Davies e
Levinson). Per Kivy infatti se la musica ha il potere di commuoverci, dato che egli non
mette in discussione, non siamo mossi a queste emozioni ma da queste emozioni. Siamo mossi dalla loro bellezza musicale. Se si tratta di malinconia, siamo mossi da quanto la musica è stupendamente malinconica. Detto in altri termini, se dunque la musica
può commuoverci profondamente non è per la tristezza, la malinconia o l’allegria che
può trasmettere, bensì per la sua bellezza. Ciò che apprezziamo della musica sono dunque le sue qualità estetiche. Mi riservo a tale proposito di evidenziare che, ancora una
volta in accordo con l’osservazione di Bertinetto, Kivy si appropria della nozione di
bellezza, centrale come sappiamo nel dibattito estetico per spiegare la virata
dell’emozione verso i processi della sua messa in forma, senza però approfondire i motivi di questa scelta, né richiamare, anche solo per cenni, i luoghi della riflessione tradizionale sul tema. Kivy, forse, non ha dato la giusta importanza al fatto che l’estetica sin
dalla sua nascita come disciplina autonoma non fa che interrogarsi sul problema del
bello e del gusto, per cui il fatto di dare per scontato il significato del termine rende tutto il discorso, almeno per ciò che riguarda questo aspetto, poco persuasivo.
83
5. Formalismo e formalismo arricchito
Secondo il paradigma formalistico, la musica strumentale non possiede contenuto semantico o rappresentazionale, non si riferisce a nulla, non rappresenta oggetti,
non racconta storie, non fornisce argomentazioni, non espone alcuna filosofia, ma è
semplicemente una pura struttura sonora; contenuti e significati sono strettamente limitati ai casi in cui essa sia accompagnata da testi, titoli o rappresentazioni. In virtù del
suo essere pura struttura di suoni essa possiede una sua trama, ma è una trama del tutto
particolare che non eccede mai gli stessi eventi sonori, i quali accadono, come sosteneva Hanslick, con una loro logica e con un loro senso. La musica assoluta è dunque la
bella arte della ripetizione.
Leonard Meyer, in Emotions and Meaning in Music 128 (1956), mutua dalla teoria dell’informazione l’idea secondo cui la pratica dell’ascolto musicale risponde a un
preciso gioco di regole relazionali che si instaurano tra l’ascoltatore e certe caratteristiche della musica. Poiché Kivy ritiene tale teoria fondamentale per la comprensione del
formalismo, ne analizziamo il senso alla ricerca di una prima risposta all’interrogativo:
perché la musica pura suscita il nostro gradimento estetico, dal momento che pare distinguersi dalle altre forme d’arte in virtù delle sue ‘manchevolezze’?
Nella narrativa, sostiene Leonard Meyer, gli eventi, nella trama del loro svolgimento costituiscono un continuum, tanto nel loro essere attesi quanto nel loro essere inattesi. Se si volesse applicare questa teoria alla musica, gli eventi sonori musicali sarebbero valutati in ragione del loro maggiore o minore grado di prevedibilità, laddove
un determinato evento è massimamente informativo quanto più imprevedibilmente si
manifesti, mentre un evento atteso è poco informativo, ma allo stesso modo del primo
contribuisce alla particolare comprensione della trama musicale. La musica che piace,
secondo Meyer, deve perciò collocarsi in un regime tensivo intermedio: non deve concedere troppo alla sorpresa e deludere le aspettative, né essere sempre e immancabilmente una conferma: se gli eventi fossero tutti disattesi, sarebbero certamente sorprendenti e dunque altamente informativi, ma la comprensione del decorso musicale sarebbe quasi nulla, al contrario se fossero tutti attesi, cioè prevedibili, essi soddisferebbero
certamente le attese dell’ascoltatore, senza però essere mai significativi. Il grado di informatività di un determinato evento sonoro è cioè inversamente proporzionale alla
prefigurazione di ciò che accadrà della trama di quell’avvenimento.
128
L. Meyer, Emozione e significato nella musica, Il Mulino, Bologna, 1992.
84
La teoria di Meyer quindi si presta perfettamente a spiegare il tipo di rapporto
che un lettore intrattiene con una certa opera di narrativa finzionale, ma nel caso della
musica il problema nasce quando bisogna capire di che tipo di eventi stiamo parlando,
poiché un evento sonoro, non è certamente un evento in senso stretto. Kivy, nello specifico, distingue tra due generi di eventi musicali: gli eventi sintattici e gli eventi formali.
I primi regolano la struttura musicale, avendo a che fare con le sequenze degli
accordi, con le linee melodiche e con le combinazioni di melodie, rappresentano cioè la
struttura minima di un avvenimento musicale, laddove gli eventi formali, concernono
invece l’organizzazione temporale dell’opera nel suo sviluppo complessivo. Eventi sintattici, dunque, ed eventi formali, guidano l’ascoltatore attraverso lo svolgersi della
trama musicale, originando una serie di aspettative che possono genericamente essere
articolate in esterne e interne: le prime sono costituite dal patrimonio esperienziale
dell’ascoltatore, e che dunque egli per così dire immette nella formulazione delle sue
aspettative in ordine allo sviluppo armonico dell’ascolto in atto; le seconde sono invece
generate direttamente ed esclusivamente dall’ascolto contingente di un particolare brano musicale, sono cioè immanenti a quel brano.
Risulta evidente come nell’ascolto musicale le aspettative generate dalla propria
esperienza entrino in relazione col modo in cui ci disponiamo all’ascolto di ogni nuova
musica nel gioco delle conferme e delle sorprese.
In tutti i casi, conferme e sorprese accresceranno la nostra esperienza d’ascolto
che consisterà dunque nel piacere di lasciarci coinvolgere in questo gioco per trovare
una strada che possa condurci, per un verso, abbastanza lontano dalle consuete abitudini (in tal modo amplieremo la nostra cultura musicale) ma che, al contempo, non ci allontani troppo da quello sfondo di abitudini e di attese che è il portato culturale di tutti
gli ascolti pregressi e che determina la nostra peculiare forma di familiarità musicale.
La teoria di Meyer, nella sua applicazione alle pratiche musicali, dà luogo a una
serie di considerazioni che possono infine essere ricondotte a due grandi domande: la
prima riguarda le modalità attraverso le quali si innesca nell’ascoltatore quel meccanismo in grado di favorire la serie di sorprese e conferme di cui parlavamo prima; si tratta di un’azione cosciente, oppure essa fa capo a un meccanismo che opera al di sotto
della soglia cognitiva? La seconda domanda concerne il modo o i modi in cui tale processo possa perpetrarsi senza consumarsi, in presenza di una medesima opera musicale,
anche a seguito di successivi ascolti.
85
Kivy ritiene che il livello della coscienza cognitiva, così come quello che opera
indipendentemente da esso, siano entrambi ugualmente responsabili di quelle aspettative formulate dall’ascoltatore nei confronti dello svolgersi degli avvenimenti musicali,
ma tuttavia abbandona l’aspetto inconscio della questione per sviluppare la sua analisi
in ordine a ciò cha accade nella coscienza di colui che gioca consapevolmente con la
musica, avanzando una serie di congetture cognitive per formulare previsioni relativamente a ciò che nell’ascolto sta per accadere.
Si tratta quindi di un ascolto attento, il cui ambiente ideale è costituito dalla sala
da concerto, nel cui spazio l’esecuzione risulta evidentemente decontestualizzata, condizione questa indispensabile per l’apprezzamento delle sue qualità formali. Questo,
ovviamente, non significa che la musica non abbia un suo ruolo anche in ambiti sociali
diversi, cerimonie religiose, feste da ballo e altri svariati contesti, è evidente che il suo
ascolto non si riduca a quello che ha luogo nelle sale da concerto.
Tuttavia, sostiene Kivy, il filosofo della musica deve occuparsi del caso paradigmatico della musica eseguita e ascoltata nelle sale da concerto. Il ruolo
dell’attenzione così conseguita, risulta essenziale per la formulazione di quelle ipotesi
che si rivelano più o meno in linea con le aspettative, a seconda del maggiore o minore
grado di informatività della musica che si sta ascoltando e che derivano come già abbiamo visto dall’interazione delle precedenti esperienze d’ascolto con l’evento musicale attuale. Ne consegue che un ascoltatore attento e competente sarà fornito di un apparato concettuale più vasto rispetto a un neofita, nella misura in cui riuscirà a contestualizzare e organizzare più coerentemente il suo personale gioco di ipotesi, aprendosi a
sempre nuove opportunità di ascolto.
Non sfugge a Kivy come tale circostanza possa prefigurare il rischio di una sorta di intellettualizzazione del processo che presiede alla comprensione della musica: il
vero ascolto è quello competente, consapevole, capace di esplicitare in termini concettuali le dinamiche dell’esperienza che si sta compiendo a contatto con un brano musicale. D’altra parte, un certo grado di esclusività dell’ascolto ci sembra fortemente rivendicato da parte di Kivy.
Il secondo problema che essa solleva è relativo invece a come sia possibile che
il gioco dell’attesa si rinnovi ogni volta anche in presenza di ripetuti ascolti della medesima opera. In questo caso il gioco potrebbe perdere ogni sua ragion d’essere e con essa il piacere dell’ascoltatore di formulare ipotesi: che senso avrebbe tale gioco se il
modo in cui la melodia si svilupperà ci è noto dall’inizio? In altri termini sembrerebbe
86
rispondere al senso comune l’idea che non avrebbe più pregio verificare se quel certo
sviluppo melodico conforterà o meno le nostre aspettative dal momento che una conoscenza precedentemente acquisita destituirebbe di fatto quell’attesa da ogni incertezza.
La teoria della persistenza dell’illusione costituisce lo sfondo teorico attraverso
cui Kivy espone la tesi secondo la quale un ascoltatore, per quanto attento e competente, pur conservando un ricordo abbastanza preciso di una certa musica, non potrà comunque avere mai una memoria fotografica della successione degli accordi e dello sviluppo temporale di quell’opera, in grado di invalidare quella disponibilità ogni volta
rinnovata a lasciarsi nuovamente coinvolgere da essa. Inoltre ogni nuovo ascolto rivelerebbe particolari sfuggiti in precedenza, quei particolari che con molta probabilità non
costituivano ancora oggetti intenzionali dell’ascoltatore.
Parallelamente alla persistenza dell’illusione si colloca il fenomeno del nascondi e cerca: le forme della musica assoluta sono pure trame senza contenuto, ma in analogia isomorfica con quanto accade nelle opere di narrativa finzionale esse instaurano
con l’ascoltatore una relazione (non semantica in questo caso) in cui egli è mosso alla
ricerca di quei temi che, pur immanenti alla trama della struttura musicale, non risultano immediatamente visibili perché opportunamente occultati dal compositore. La scoperta di tali temi, rappresentati dai motivi centrali della melodia che si susseguono nella
struttura temporale complessiva dell’opera, risulta essere una parte importante del godimento musicale traducendosi in una sorta di autoconferma della personale abilità e
dunque della propria competenza musicale. La musica diventa cioè l’oggetto intenzionale dell’attenzione dell’ascoltatore, in tal modo una consolidata conoscenza tecnica
della sintassi e della struttura musicale tenderà ad aumentare la nostra consapevolezza e
dunque il nostro gradimento musicale nella misura in cui contribuirà ad ampliare il nostro oggetto intenzionale, ovvero quella competenza formale che consente di relazionarsi sapientemente con il bel gioco della ripetizione della trama musicale, con
quell’inseguimento di passaggi e frammenti melodici che costituiscono le figure del
suono, quasi fossero forme grafico-decorative che si ripetono periodicamente per essere
ricomprese in disegni più ampi e che costituiscono, secondo Kivy, il materiale da costruzione essenziale della maggior parte delle forme musicali prodotte durante gli ultimi trecento anni.
Un primo problema si profila, già a partire da queste considerazioni. Il meccanismo sopra descritto, per intendersi la dialettica di attese e conferme che sostiene
l’ascolto, si applica con una certa agilità a contesti musicali molto circoscritti, vale a
87
dire alla musica classica occidentale e tonale. Tale circostanza introduce evidentemente
una prima difficoltà nella struttura teorica del formalismo e si traduce di fatto in un ridimensionamento di quelle qualità strutturali: private di una autentica esistenza indipendente e di qualsiasi pretesa di universalità, esse andrebbero dunque ripensate e contestualizzate.
L’introduzione nel formalismo di una teoria che in qualche modo apre al mondo
dell’esperienza anticipa quello che sarà il tentativo di Kivy di rompere
quell’isolamento che aveva costituito la forza ma forse anche la debolezza del formalismo di Hanslick, ma introduce fatalmente il problema dei problemi: definire cioè in che
modo le proprietà percettive della forma sonora interagiscono con la coscienza
dell’ascoltatore, o ancora quanta parte di essa sia direttamente o indirettamente responsabile dell’effettiva fecondità di quelle proprietà. La riflessione che si aprirebbe sarebbe tanto ampia da non poter essere contemplata nel contesto del presente scritto, ci
chiediamo semplicemente, prima di proseguire, se le strutture di cui si occupa il formalismo avrebbero ancora senso al di fuori del flusso che le collega al vissuto della coscienza. Kivy sente questo problema, e da qui nasce il suo progetto di revisione del
formalismo.
Il formalismo di Hanslick e sostanzialmente anche quello di Gurney avevano
rigorosamente tenuto il contesto musicale separato da quello emozionale, pur ammettendo (Gurney) un certo grado di coinvolgimento emotivo nell’esperienza musicale che
comunque non valicava mai la semplice accidentalità. Tale atteggiamento era funzionale, spiega Kivy, alla necessità da parte dei formalisti della prima ora di contrapporsi decisamente alla tradizione romantica dominante, radicalizzando lo scontro fino a negare
alla musica qualsiasi tipo di rapporto significativo con l’universo delle emozioni. Inoltre, sostiene ancora Kivy, Hanslick non disponeva di una teoria in grado di aprire il
formalismo al mondo extramusicale, senza snaturarne l’essenza.
È proprio a questa apertura che Kivy mira, proponendo la teoria del ‘formalismo arricchito’, espressione che egli mutua dal filosofo Philip Alperson, e che rappresenta il tentativo di liberare il formalismo dal suo stato di isolamento, per riformarlo alla luce di ciò che evidentemente appariva come un fatto incontestabile, e cioè che la
musica e le emozioni di cui essa è espressiva intrattengono necessariamente un qualche
tipo di rapporto. Un’analisi formalista quindi, dal suo particolare punto di vista, non
doveva e non poteva in alcun modo trascurare gli aspetti emotivi dell’esperienza musicale; l’impegno maggiore sarà dunque quello di arricchire il formalismo con una teoria
88
delle emozioni, senza però snaturarne il senso, per non ricadere su posizioni contenutistiche; impresa che sin da ora non ci appare priva di enormi difficoltà.
Nell’opera The Corded Shell, Kivy aveva impostato la proposta teorica del suo
formalismo arricchito. Essa si risolveva infine nella scelta di innestare direttamente le
emozioni comuni nelle proprietà acustiche della musica, una mossa che risulta pertanto
apparentemente coerente con l’anima formalista, nella misura in cui salvaguarda la pura struttura degli eventi sonori senza contenuto semantico né rappresentazionale, e considerando le proprietà emotive come una componente percettiva della musica stessa, le
vincola di fatto a quelle strutture. L’alterità dell’esperienza estetica musicale rispetto
alle altre forme artistiche rimarrebbe così preservata, come auspicava, per altro, anche
Hanslick: mentre tutte le arti contenutistiche si confrontano con i vari aspetti del mondo, la musica assoluta è al contrario l’arte pura della liberazione.
Kivy recupera i due elementi che in apertura avevamo considerato come gli oggetti prediletti da un’indagine ispirata al formalismo: la sintassi e la forma complessiva
della struttura musicale. Eventi sintattici ed eventi formali costituiscono dunque le proprietà percettive, e nello stesso tempo rappresentano il vincolo, lo schema ordinativo,
della nostra risposta emotiva ed immaginativa.
Le emozioni comuni sarebbero in altri termini parte costitutiva dei motivi melodici che si alternano ritmicamente nella struttura formale; non avendo significato e
non sottintendendo rappresentazioni, esse vanno comprese e apprezzate esteticamente
come una sorta di disegno di suoni. Ma in che senso possiamo dire che le strutture formali e le qualità emotive sono delle proprietà percettive?
Nell’ascolto riusciamo a cogliere le successive alternanze di tensioni e risoluzioni, ma non nella misura in cui, avverte Kivy, un determinato passaggio ci fa sentire
prima in tensione, mentre poi ci concede, nella fase di risoluzione, uno stato di quiete e
di abbandono. Si tratta invece semplicemente di cose che stanno accadendo nella musica e di cui, per così dire prendiamo cognitivamente atto assegnando a esse il giusto posto nella struttura della musica “e non in qualche parte della nostra biografia psicologica” 129 , come egli sottolinea in evidente polemica con i sostenitori dell’Arousal Theory.
La musica per Kivy non esprime alcuna emozione, ciò non di meno essa è espressiva di emozioni: per esprimere un’emozione, occorre sentirla, la qual cosa è evidentemente competenza esclusiva degli esseri senzienti, mentre l’‘essere espressivo di
129
P. Kivy, Filosofia della musica …, cit., pag. 116
89
emozioni’ potrebbe essere inquadrato all’interno di un contesto di somiglianze e analogie, in cui non apparirà necessario provare realmente l’emozione. In tal modo una musica è percepita come allegra in virtù dell’esistenza di un’analogia subliminare, probabilmente sinestetica, tra, ad esempio, l’aspetto delle persone che esprimono allegria e i
modi incalzanti, rapidi e sincopati della tonalità maggiore. Il muso del San Bernardo,
secondo il celebre esempio più volte citato, è un caso paradigmatico: esso è espressivo
di tristezza senza che il cane sia effettivamente triste. Riprendiamo così brevemente in
esame i termini generali della teoria delle emozioni già ampiamente svolta nel paragrafo precedente, solo per vedere nello specifico come il profilo della struttura musicale, il
suo disegno sonoro possa essere dunque analogo a quello delle manifestazioni visive o
sonore delle principali emozioni umane, non in senso rappresentativo, bensì in maniera
immediata, diretta.
A sostegno di questo passaggio Kivy svolge tutta una serie di argomentazioni
volte a marcare, in sintonia col formalismo tradizionale, la diversità dell’esperienza
musicale rispetto ad ogni altro tipo di esperienza. Contrariamente a ciò che avviene nelle situazioni ordinarie dove un’aspettativa dà luogo ad uno stato di ansia e alle sue conseguenti manifestazioni fisiche, nell’ascolto musicale le alternanze di tensione e rilascio non provocano corrispettive alterazioni degli stati interni dell’ascoltatore, a dimostrazione del fatto che tali eventi sono ascoltati nella musica, sono, come dire, osservati
a distanza.
È in questo senso che Kivy pensa di conciliare il formalismo con il riconoscimento della componente emotiva della musica. Eppure, proprio a questo punto
dell’argomentazione, si affacciano nuovi problemi. Una volta che il formalismo si è, in
qualche modo, incrinato, almeno nella sua versione più rigorosa, e ha accettato di accogliere una sfera d’esperienza più ampia, non potrà fare a meno di confrontarsi con i
movimenti della storia, le variazioni dei gusti, le diversità culturali e di interpretare anche su questa base le dinamiche delle risposte emotive. È ad esempio opinione condivisa da molti che il discorso di Kivy a proposito dei processi di attesa, delle tensioni e
previsioni dell’ascolto musicale, non sia sufficientemente pronto ad accogliere le differenze tra le varie culture musicali, in alcune delle quali non si producono le stesse dinamiche.
È indubbio che una delle funzioni più ricorrenti nell’ambito della musica classica occidentale sia rappresentata proprio dal gioco delle tensioni armoniche e melodiche
che ne regolano la sintassi. Se quindi riconosciamo che termini come tensione, rilascio,
90
e risoluzione si riferiscono solitamente a ciò che esperiamo direttamente sotto
l’influsso di particolari situazioni emotive, dovremmo presumere che essi descrivono
altrettanto bene opere musicali che proprio su quelle dinamiche si appoggiano.
Avevamo in precedenza accennato, a proposito della teoria dell’informazione,
al pericolo che si determina a carico dell’impianto teorico formalista, quando esso si
apre ad accogliere situazioni esperienziali più ricche e complesse. La teoria formalista
nella sua accezione arricchita, è insomma costantemente esposta al rischio di una sorta
di invasività storica, che si presenta immancabilmente, ogni qualvolta si conferisce un
respiro di universalità ad osservazioni che valgono invece solo in contesti particolari.
Kivy sostanzialmente ci sembra prendere atto che le nozioni fin qui esaminate,
quelle che conferiscono alla musica il suo carattere emotivo, sono comunque frutto di
attribuzioni culturali e dunque relative ad una particolare condizione storica. Crediamo
di indovinare un certo imbarazzo nell’ammissione che certi archi melodici che oggi riconosciamo come tendenti alla distensione o alla chiusura sarebbero stati considerati
inappropriati per tale funzione da un musicista del diciannovesimo secolo. Tuttavia
Kivy pensa di sottrarsi a questo problema semplicemente ammettendo che «la chiusura
musicale sarebbe un concetto sintattico e la sintassi in musica così come nei linguaggi
naturali si trasforma con l’andare del tempo» 130 . In tal modo, chiude la questione, passando ad altro e sorvolando evidentemente sul fatto che l’affermazione sarebbe pienamente condivisibile solo se la sintassi musicale avesse una sua corrispettiva sfera semantica, poiché ci pare questo e non altro l’elemento che conferisce al linguaggio naturale la sua caratteristica di adeguarsi modificandosi, al cambiamento del mondo di cui è
segno. Non è chiaro in altri termini come una struttura formale pura e quindi indipendente possa o debba modificarsi nel tempo adeguandosi ai modi e alle mode musicali di
un determinato secolo. In ciò risiede una delle grandi difficoltà della sua teoria formalista.
Abbiamo accennato, all’inizio, come Kivy giustificasse in chiave strategica la
scelta di Hanslick di chiudere il formalismo a qualsiasi tipo di relazione esterna; le tesi
del Bello musicale rispondevano all’esigenza di compensare i parossismi sentimentalistici romantici e idealistici che, come nota il critico Massimo Mila in L’esperienza musicale 131 , finivano, sulla base del principio hegeliano dell’unità dell’arte come momento dell’esplicarsi dello spirito assoluto, col favorire una pericolosa confusione tra le arti. Hanslick ribadiva il principio secondo cui ogni arte deve essere ricondotta alla pro130
131
P. Kivy, Filosofia della musica …, cit., pag. 115.
M. Mila, L’esperienza musicale e l’estetica, Einaudi, Torino, 1965.
91
pria tecnica, poiché solo in essa manifesta la sua specificità, e in tal senso egli riteneva
di dover rispettare il carattere fondamentale della musica, il cui elemento originario è
l’eufonia ed il ritmo la sua essenza.
Ma, per Kivy, il primo formalismo era fortemente condizionato dal fatto di non
avere a disposizione una teoria che, pur non cedendo ai contenutismi e ai sentimentalismi, riconoscesse la validità delle descrizioni emotive della musica. Ci pare più plausibile che Hanslick avesse intuito perfettamente che l’essenza del formalismo poteva essere preservata come pura riflessione filosofica, solo attraverso una totale e incondizionata chiusura a qualunque tipo di esperienza extramusicale, poiché l’introduzione di
qualsiasi rapporto con un più vasto contesto d’esperienza, lo avrebbe posto di fronte al
problema di dover poi spiegare come i sentimenti, che in una certa misura risultano essere costruzioni culturali, e comunque mai completamente privi di contenuto rappresentativo, potessero coincidere con gli aspetti strutturali e formali, trasparenti invece ad
un’indagine rigorosamente formalistica.
Ci pare, dunque, di condividere l’opinione di Alessandro Bertinetto, quando afferma che il formalismo o è formalismo (come il formalismo di Hanslick) tout court o
non è formalismo 132 . Da questo punto di vista, che poi è lo stesso di alcuni critici di
Kivy, il formalismo nella sua forma arricchita (enhanced) viene considerato come un
vero e proprio escamotage utile per integrare l’analisi tecnica della musica con la nostra esperienza musicale reale. Il problema che si evidenzia è che nell’impianto formalistico di Kivy vanno ad inserirsi elementi (le emozioni) che finiscono per scardinarlo.
Ha ragione quindi chi vede nella divaricazione tra l’indagine tecnico-formalista della
musica e l’indagine emotiva, una discutibile decisione procedurale 133 .
Ad ogni modo, precisiamo che, sebbene difeso in un’accezione emotivamente
arricchita, il formalismo di Kivy si riporta in ultimo ad una negazione di qualsiasi interpretazione contenutistica, di qualunque tipo essa sia, e il serrato dibattito che Kivy
intrattiene con i cosiddetti nemici del formalismo ne è diretta testimonianza. Severo è
infatti il suo rifiuto di tutte quelle tesi antiformalistiche che difendono un qualche elemento di narratività anche per quanto riguarda la musica.
All’interno dell’articolata ed eterogenea lista di coloro che in vario modo protendono per un’interpretazione in chiave contenutistica, Kivy “sceglie” di dedicare le
sue particolari attenzioni alla musicologa americana Susan McClary e a David P.
Schroeder, anch’egli americano e musicologo. I due costituiscono i casi probabilmente
132
133
A. Bertinetto, Bach e il San Bernardo. La filosofia della musica di Peter Kivy, cit., pag. 99.
Cfr. E. Maus, Music as Drama, in J. Robinson (a cura di), Musical Meaning, cit., pp. 105-130.
92
più estremi di quella concezione contenutistica che Kivy chiama “interpretazione narrativa forte” e che consiste sostanzialmente nell’attribuire alla musica la capacità di rinviare ad una vera e propria ‘trama narrativa’, da intendersi come una sorta di messaggio
musicale. La Quarta Sinfonia di Čajkovskij assume così, nell’interpretazione della
McClary 134 , i contorni della biografia sessuale del suo autore con una dovizia di particolari che, come nota facilmente Kivy, potrebbero essere esposti solo da un’opera letteraria: la “lettura” della McClary si spinge fino a ipotizzare un conflitto interno del
compositore, tra la sua natura omosessuale e le legittime aspettative del padre; tra i due,
la figura di una donna, forse innamorata, articola ulteriormente la trama narrativa con
altri risvolti psicologici.
Analogamente, ma in chiave più prettamente filosofica, Schroeder 135 , interpreta
la Sinfonia n. 83 di Haydn come espressione dell’ideale illuministico settecentesco, che
culmina con un messaggio sociale ricco di contenuti idealistici: i conflitti di opinione
sono inevitabili, essi non vanno risolti con la repressione, bensì con la tolleranza, non
sistemi dogmatici quindi ma aperture democratiche. Kivy, ovviamente, condanna senza
appello l’infondatezza di entrambe le teorie: una storia, benché minima può essere raccontata solo per mezzo del linguaggio verbale, o entro certi limiti anche dalle rappresentazioni visive. La musica pura, assoluta non ha una simile capacità narrativa.
Osserviamo, per inciso, che ritenere che le istanze antiformaliste si esauriscano
sostanzialmente nelle teorie sopradescritte ci pare molto limitativo. Kivy in sostanza ha
buon gioco nel confutare con cognizione le idee certamente singolari di McClary e di
Schroeder, ma non sappiamo dire francamente quanto esse siano rappresentative della
teoria contenutistica in senso lato, certamente esse non hanno alla base nessun criterio
di giustificazione scientifica.
Esiste anche, osserva Kivy, un’interpretazione narrativa debole, secondo la
quale la musica, non racconterebbe alcuna storia reale, ma esporrebbe generalizzate
trame archetipiche: la Quinta sinfonia di Beethoven, per esempio, è un caso tipico della
trama archetipica “lotta contro le avversità fino al trionfo finale”.
Anche in questo caso il giudizio di Kivy è decisamente negativo: è assurdo ritenere che una sinfonia possa avere una trama archetipica senza una corrispettiva trama
vera e propria, a meno che non si intenda riferirsi alla capacità dei suoni di evocare di-
134
Cfr. S. McClary, Feminine Endings: Music, Gender and Sexuality, University of Minnesota Press,
Minneapolis, 1991.
135
Cfr. D. P. Schroeder, Haydn and the Enlightenment: The Late Symphonies and their Audience, Clarendon Press, Oxford, 1990.
93
namiche tensive originarie. In quest’ultimo caso tanto varrebbe non riconoscerle alcuna
componente narrativa.
6. La risposta disposizionale di Derek Matravers
Un’antica querelle è quella che concerne la musica e la relazione di essa con la
vita emotiva, che Kivy caratterizza come la querelle tra emotivisti e cognitivisti musicali. La stessa querelle che oggi, nel dibattito analitico, troppo spesso sfocia in una sorta
di crociata morale: da una parte ci sono coloro (gli emotivisti, critici musicali, teorici o
semplici ascoltatori) che sostengono che quando in circostanze normali descriviamo un
brano musicale “triste” è perché esso ci rende tristi, intendendo dire che è triste quella
musica che normalmente suscita tristezza nell’ascoltatore. Si tratta della crociata contro
i senza-cuore, i senza-emozione, i quali ascoltano in maniera analitica e fredda un qualcosa (la musica) che dovrebbe invece costituire un potente stimolo emotivo. Dall’altra
parte invece troviamo la crociata di coloro (i cognitivisti) i quali sostengono che sia appropriato descrivere la musica in termini espressivi (cosa ovviamente riconosciuta anche dagli emotivisti), ma diversamente dagli emotivisti, non pensano che la musica triste sia tale in virtù della capacità di suscitare quella stessa emozione negli ascoltatori,
piuttosto sostengono che la tristezza sia una proprietà di qualche tipo che noi, ascoltatori, possiamo riconoscere, ascoltare, nella musica, senza che sia necessario provare personalmente una siffatta emozione; la loro è quindi la crociata contro chi si crogiola nel
mare di melassa emotiva e rischia così di perdere di vista gli elementi musicali più significativi.
In realtà, spiega Kivy, con una buona dose di rammarico e consapevole di essere certamente annoverato tra i più importanti e fervidi sostenitori del cognitivismo, una
tale situazione di frattura sorge solo da un’errata interpretazione della teoria cognitivista cui fa riferimento. La teoria cognitiva da lui difesa non sostiene l’inconciliabilità
dell’emozione e della cognizione musicale. Per questa ragione trova infondata, e respinge, l’accusa di chi sostiene che egli altro non è se non che un freddo cognitivista.
Tale accusa, diciamo subito, sebbene lo avevamo in parte già evidenziato, è quella che
si solleva dal coro di coloro che in questi ultimi anni hanno optato per una spiegazione
del problema dell’espressività musicale attraverso una riabilitazione, in nuove e spesso
94
singolari varianti, della teoria eccitazionistica o disposizionale (Arousal Theory). In
particolare, è il caso di evidenziare – Kivy stesso ne è consapevole – che la voce che da
quel coro si erge più altisonante e muscolosa è certamente quella di Derek Matravers 136 . Tra i due, diciamo subito, vi è infatti oramai da tempo un dialogo pressoché
costante, anzi dovremmo parlare di una vera e propria pressante marcatura che l’uno
esercita nei confronti dell’altro, come si evidenzia dalle rispettive opere. Nello specifico, l’Arousal Theory è bersaglio polemico di Kivy sin dalla primissima fase della sua
ricerca. Ricordiamo infatti che il riconoscimento della validità del cognitivismo musicale si afferma parallelamente alla negazione della validità di una teoria disposizionale
quale è stata fondamentalmente quella tradizionale e in aperta contrapposizione con
quest’ultima. E, in effetti, le prime significative critiche mosse da Kivy all’Arousal
Theory le si ritrovano nell’opera Sound Sentiment, e precisamente nel capitolo significativamente intitolato And Nevertheless It Moves, critiche alle quali Matravers controbatte nella sua prima opera dedicata al problema della relazione delle emozioni con le
arti (Art and Emotion), confrontandosi con la tesi cognitivista quale essa è stata interpretata e rivisitata da Kivy e analizzando ogni singola obiezione all’Arousal alla luce di
quella che, come conosceremo a breve, è in realtà una più sofisticata versione della teoria eccitazionistica, la cui riabilitazione si manifesta in una formula certamente inedita.
La risposta, naturalmente, anche in questo caso non tarda ad arrivare; nei New Essays
on Musical Understanding, Kivy dedica infatti un nuovo capitolo, anche questo direi
dal titolo particolarmente emblematico, The Arousal Theory of Musical Expression:
Rethinking the Unthinkable, nel quale risponde alle critiche mosse da Matravers ed esamina la sua teoria. Ma interessanti a tale proposito, sono anche altri scritti di Matravers; tra questi, particolarmente significativo è ‘Unsound Sentiment: A Critique of
Kivy’s “Emotive Formalism”, ma anche ‘The Experience of Emotion in Music’. Quello
che viene ad emergere come sfondo costante è quindi, anche negli scritti di Matravers,
questa conflittualità accesa, emblematica di due differenti spiegazioni dell’espressività
136
Vale la pena fare una breve presentazione biografica di Derek Matravers, il quale si è cimentato in
diverse aree: dall’etica alla politica, dalla filosofia della mente fino ovviamente all’estetica, dove ha mostrato un particolare interesse per i problemi legati alla natura delle descrizioni estetiche, all’esperienza
estetica e al valore artistico. Tra le pubblicazioni di Matravers segnaliamo quelle che ci sembrano più
significative per il nostro filone d’indagine: Art and the Emotions: A Defence of the Arousal Theory, Oxford University Press, 1998. Paperback edition, 2001; ‘Art and the Feeling Emotions’, The British
Journal of Aesthetics, 31 (1991): 322-31; ‘Unsound Sentiment: A critique of Kivy’s “Emotive Formalism”’, Philosophical Papers 22 (1993): 135-47; ‘Once More with Feeling: A Reply to Ridley’, The British
Journal of Aesthetics, 34, 1994; ‘The experience of Expression in Music’, cit.; ‘Art and Emotion’; Routledge Companion to Aesthetics; ed. Berys Gaut and Dominic Lopez; Routledge; 2001 (seconda edizione
2005); ‘Experience and Expression’ in Philosophers on Music: Experience, Meaning, and Work’, ed.
Kathleen Stock (OUP, forthcoming, 2007).
95
che non trovano, o sembrano non poter trovare, soluzione d’accordo. Conflittualità che
egli però preferisce caratterizzare, diversamente da Kivy, come accentuato dissidio tra i
teorici disposizionalisti (tra questi, Kendall Walton e Aaron Ridley) e i teorici sostenitori dell’externality requirement (il riferimento in questo caso non poteva che essere a
Kivy, Levinson e Davies) 137 .
In considerazione quindi di questa serrata corrispondenza e tenuto conto anche
del fatto che la tesi disposizionale difesa da Matravers è una tesi particolarmente rappresentativa dell’altra principale tendenza riattivatasi nel dibattito analitico, un approfondimento ci sembra necessario. Diciamo subito infatti che Matravers è uno dei primi
a riaffermare e rivendicare la necessità di ripensare al problema della relazione tra musica ed emozioni mediante la difesa della teoria eccitazionistica in un periodo e in un
clima fortemente ostili. Nella Prefazione di Art and Emotion scrive a tale proposito:
«La mia intenzione in questo libro è quella di riabilitare un approccio alla connessione
tra l’arte e le emozioni che è stato a lungo tempo considerato come eretico» 138 . Si tratta, in effetti, come avevamo anche evidenziato, di una teoria particolarmente osteggiata
dalla comunità analitica, presso la quale per un certo periodo sembra invece avere avuto maggiori consensi una concezione dell’espressività prossima a quella cosiddetta cognitivista.
Ho sperimentato personalmente come le persone che lavorano in questo campo siano restie perfino a prendere in considerazione l’Arousal
Theory. Un filosofo in particolare, Peter Kivy, ha attaccato l’Arousal
Theory ovunque essa sia comparsa, e talvolta anche in contesti in cui
non compariva nemmeno. Kivy, tuttavia, non è il solo ad aver antipatia per questa teoria. L’attuale linea dominante ritiene che l’‘Arousal
Theory’ sia certamente falsa e che tutto ciò che viene inquadrato
all’interno di una concezione ‘cognitivista’ è corretto139 . Io sosterrò
invece che il cognitivismo è muto proprio nel momento in cui dovrebbe dire qualcosa di importante. Inoltre, pochi degli argomenti che
vengono rivolti contro l’Arousal Theory vanno presi sul serio, e nessuno di essi è decisivo. Non solo l’Arousal Theory fornisce una soluzione soddisfacente al problema dell’espressione, ma si inserisce
all’interno di una spiegazione unitaria delle nostre reazioni emotive
alle altre persone, al mondo e alle opere d’arte 140 .
137
Vedi in particolare ‘The Experience of Emotion’, cit., pag. 353.
D. Matravers, Art and Emotion, cit., pag. vii.
139
Corsivo mio.
140
D. Matravers, Art and Emotion, cit., pag. 4.
138
96
La difesa della teoria eccitazionistica viene infatti a ribaltare il piano generale
della teoria dei cosiddetti cognitivisti o teorici dell’externality, i quali non hanno certamente negato la capacità della musica di commuoverci, ma hanno invece negato perentoriamente che sia in questa dinamica, in quella cioè della risposta emotiva alla musica, che possiamo ricercare una soluzione al problema dell’espressività musicale. Non
bisogna, in altri termini, considerare le proprietà emotive della musica come proprietà
disposizionali, bensì come proprietà percettive, fenomenologiche della struttura musicale stessa. Kivy così evidenzia questo aspetto quando scrive:
A partire dalla pubblicazione di The Concept of Expression (1971) di
Alan Tormey’s, e del mio The Corded Shell (1980), si è formato un
consenso, tra i filosofi analitici, che l’Arousal Theory of musical expressiveness sia, invero, irrimediabilmente sbagliata, e che le proprietà espressive della musica non sono disposizioni che stimolano
delle normali emozioni, ma sono proprietà percepite della musica. In
altre parole, noi percepiamo la tristezza, la felicità, la rabbia o la depressione nella musica, così come in genere percepiamo proprietà
‘fenomenologiche’ come il turbamento, la tranquillità, la ‘qualità del
fluttuare’, e così via 141 .
Qualche riga più avanti aggiunge:
Fino a pochissimo tempo fa, potrei dire con una certa sicurezza che
c’era in effetti un consenso generale riguardo alle proprietà espressive
della musica: esse erano delle proprietà percepite, ovvero fenomenologiche, che si trovavano nella musica stessa, piuttosto che essere disposizioni volte a stimolare le emozioni ordinarie in un ascoltatore
qualificato. Ma ora è apparso qualcuno che ha scombinato questa
omogeneità di vedute. Si tratta, nello specifico, di Derek Matravers,
il quale nella sua recente monografia, Art and Emotion, ha elaborato
tanto una critica all’approccio cognitivo all’espressività musicale
(che è anche il nome che viene solitamente dato alla mia posizione),
quanto una propria personale spiegazione, che egli ritiene essere una
versione della ‘Arousal Theory’ 142 .
Kivy e Matravers hanno dunque messo in atto una stessa operazione, sebbene di
segno inverso: mentre Kivy ha accompagnato all’elaborazione della propria teoria
sull’espressività musicale una critica delle teorie eccitazioniste, il punto di partenza di
Matravers è invece una puntuale critica delle teorie cognitiviste, in particolare di quella
di Kivy. La concezione di base di quest’ultimo è, come abbiamo già approfondito, che
la musica, pur non essendo un essere senziente, che possa cioè provare emozioni, può
141
142
P. Kivy, New Essays on Musical Understanding, cit., pag. 120.
Ivi, pag. 121. Corsivo mio.
97
nondimeno essere descritta come ‘triste’ (ad esempio) se assomiglia all’espressione (esteriore) di un’emozione da parte di una persona (la quale espressione è possibile anche
quando non è direttamente causata dall’emozione stessa, come l’esempio
dell’espressione ‘naturalmente triste’ del cane San Bernardo dimostra). La somiglianza
della musica con l’espressione umana delle emozioni è quindi, secondo Kivy, la causa
del nostro descrivere la musica in termini emotivi; affinché però la spiegazione del significato dell’espressività sia completa, ovvero affinché si dia una spiegazione del significato dell’esperienza dell’espressività musicale e del giudizio espressivo sulla musica, è necessario aggiungere qualcosa al fattore, pur rilevante, della somiglianza. Kivy
stesso ne è consapevole, e nel corso degli anni ha fornito diverse interpretazioni del significato dell’esperienza dell’espressività musicale, interpretazioni che Matravers riassume nelle seguenti tre proposte.
La prima sostiene che l’esperienza della musica che viene descritta come (ad
esempio) triste equivale all’esperienza udibile della tristezza umana. Ora, sebbene sia
vero, riconosce Matravers, che talvolta sentiamo nella musica alcune tipiche espressioni uditive umane della tristezza, come il singhiozzare, il piangere, il gridare, e così via,
da ciò non deriva che qualsiasi musica descrivibile (in senso lato) come triste rappresenti o riproduca i suoni caratteristici delle persone tristi (tra i tanti esempi a disposizione, Matravers cita il secondo movimento della sinfonia Eroica di Beethoven, che sicuramente non contiene in sé alcuna traccia di suoni di questo tipo, pur venendo solitamente esperita come ‘triste’, ‘angosciante’, ecc.).
La seconda proposta sostiene che l’esperienza della musica che viene descritta
come (ad esempio) triste equivale all’ascoltare la musica come somigliante
all’espressione umana comportamentale della tristezza. La somiglianza alla quale i cognitivisti fanno qui riferimento è principalmente quella tra la musica e il movimento
umano (il quale è uno dei modi in cui l’uomo può manifestare esteriormente i propri
sentimenti): le successioni di note di frequenza diversa vengono percepite come spostamenti da una posizione all’altra all’interno dello ‘spazio musicale’ (non a caso si
parla di note più o meno ‘alte’ o più o meno ‘basse’). La percezione di tale aspetto, ovvero il riconoscimento dell’esistenza di una siffatta somiglianza, non rappresenta però,
osserva Matravers, un’esperienza duratura e unitaria, laddove sono proprio queste le
caratteristiche che, da un punto di vista fenomenologico, contraddistinguono
l’esperienza dell’ascolto della musica espressiva, esperienza che non può ridursi, come
vuole questa seconda proposta cognitivista, ad un accadimento momentaneo (vale a di98
re, alla percezione, in un certo istante dell’esperienza dell’ascolto, di una somiglianza
tra la musica e il movimento umano).
Rimane ancora da prendere in considerazione la terza proposta cognitivista (di
nuovo attribuibile a Kivy), secondo la quale l’esperienza dell’espressività musicale equivale all’ ‘animare’ i suoni in una certa maniera (in virtù di determinati motivi, tra i
quali la somiglianza tra la musica e il comportamento umano è quello principale), ovvero in maniera tale da percepire, nell’ascolto, l’espressione di un’emozione nella musica, o come un aspetto della musica. Questa terza soluzione si riduce sostanzialmente,
secondo Matravers, alla prima, e ricade quindi nelle stesse obiezioni.
Nessuna delle tre proposte avanzate da Kivy sembra in grado di giustificare il
nostro uso di termini emotivi per descrivere determinate musiche, in quanto non riesce
a spiegare il senso intrinseco dell’esperienza che facciamo di tali musiche. L’unico ruolo che Kivy pare poter mantenere per la proprietà della somiglianza (tra la musica e il
comportamento umano, ovvero tra la musica e l’espressione umana comportamentale
delle emozioni) è di tipo causale: tale somiglianza sarebbe il motivo per cui noi ‘animiamo’ i suoni e facciamo quindi esperienza dell’espressività musicale. Tuttavia, lo
stesso Kivy è scettico al riguardo, e riconosce che la somiglianza non è una condizione
né sufficiente − a ben vedere, la struttura musicale può somigliare anche al ‘salire’ e al
‘precipitare’ dell’indice del mercato internazionale, senza che con ciò ne sia
l’espressione − né necessaria all’espressività − la quale può essere prodotta da altre
cause (che Kivy individua principalmente in fattori di tipo convenzionale o associazionistico).
Data la provata (a suo avviso) inadeguatezza della teoria cognitivista di Kivy a
dar conto dell’espressività musicale, Matravers opera un netto cambio di direzione, e
decide di riportare l’attenzione sul versante opposto, e cioè sul fatto che non si può
mettere tra parentesi il legame che la musica espressiva ha con l’esperienza emotiva
dell’ascoltatore, come i cognitivisti vorrebbero. Piuttosto, egli insiste sul fatto che è esattamente in quella direzione che è necessario investigare qualora si voglia perseguire
un’adeguata comprensione del problema espressivo delle arti, bisogna cioè capire come
le emozioni formino il ponte tra la nostra esperienza dell’arte e della vita, capire, più
specificamente, cosa l’esperienza emotiva musicale ha in comune con l’esperienza ordinaria dell’ascoltatore. Questo non vuol dire, secondo Matravers, perdere di vista o
comunque trascurare la specificità dell’una e dell’altra esperienza, chiaramente differenti, ma comprendere proprio a partire da questa singolarità, che l’esperienza artistica
99
porta in primo piano più di altre esperienze della nostra vita, la forza e la pertinenza di
quel legame. In questo modo, Matravers vuole farci capire come sia possibile una nostra reazione emotiva nei confronti, ad esempio, di personaggi ed eventi finzionali, e in
particolare, come sia possibile spiegare questa reazione verso quelle forme artistiche
(come la musica strumentale) che, diversamente dalle arti visive e (soprattutto) da quelle narrative, sono svincolate da qualsiasi contenuto rappresentativo che giustifichi in
qualche maniera una nostra credenza. Detto in altri termini, spesso troviamo che un
particolare poema, un quadro, o un brano musicale comporti un cambiamento emotivo,
possiamo cioè esperire emozioni verso o a favore, rispettivamente, di personaggi funzionali, dei soggetti ritratti in un dipinto o di una particolare sequenza melodica. Tali
esperienze sono però filosoficamente complesse e il problema – evidenzia Matravers è proprio quello di interpretarle, poiché le loro cause sembrano essere completamente
differenti dalle cause delle nostre emozioni nel resto delle nostre vite. Ciò nondimeno
non bisogna comunque rinunciare a comprendere, dicevamo, cosa tali esperienze hanno
in comune con le altre, e cosa le lega all’espressione delle emozioni in casi nonartistici.
Scrive Matravers a tale proposito:
La grande arte ci procura alcune tra le esperienze più degne di merito
che sia possibile per noi avere. Tali esperienze coinvolgono simultaneamente molti aspetti della nostra vita mentale: esse saturano i nostri
sensi e allo stesso tempo stimolano la nostra intelligenza e chiamano
in causa le nostre simpatie e le nostre emozioni. Queste connessioni
conferiscono all’esperienza della grande arte un’importanza e una
complessità che l’esperienza del buon cibo, ad esempio, per quanto
sia apprezzabile, non possiede. In questo libro io esploro alcune di
queste connessioni: la relazione – o, meglio, le relazioni − tra l’arte e
le emozioni 143 .
Come si evince da queste prime e sommarie informazioni, naturalmente, anche
per Matravers, come per la maggior parte dei filosofi analitici, il problema della nostra
risposta emotiva alle opere d’arte si configura diversamente in relazione ad opere che
non hanno un qualche contenuto rappresentativo di riferimento. La risposta emotiva a
queste forme artistiche è complessa, soprattutto perché le strategie che, nel caso delle
forme d’arte rappresentazionale, forniscono delle spiegazioni sia del perché noi rispondiamo emotivamente ad esse, sia di che tipo siano queste risposte, non sembrano essere
143
D. Matravers, Art and Emotion, cit., pag. 1.
100
valide allorquando si passi alle forme d’arte non-rappresentazionale, come per
l’appunto la musica strumentale (e anche l’astrattismo in pittura e in scultura). Si tratta
di quello che Matravers definisce il problema della definizione (definitional problem),
vale a dire: un romanzo, un film, un paesaggio impressionista danno l’immagine di un
mondo umano, con gli elementi del quale possiamo empatizzare o identificarci, reagire
o non reagire simpateticamente, o anche riflettere l’impensabile, quasi attraverso una
sorta di contagio naturale. Ma con una sinfonia, una sonata, una scultura minimalista o
con un quadro dell’espressionismo astratto tali spiegazioni non sembrano avere nessuna validità. Gli esseri umani e le loro storie sono del tutto assenti. Quindi è inevitabile
chiedersi perché e in che modo la percezione di tali opere dovrebbe sollecitare, destare
emozioni in noi, e a cosa sono dirette tali emozioni.
È qui che il problema della definizione differisce dal secondo dei due
problemi che considererò in Art and Emotion: nel dover giustificare il
fatto che descriviamo le opere d’arte con termini che usiamo per denominare le emozioni (e che chiamerò ‘termini emotivi’), quando tale
descrizione non è spiegata, quantomeno non del tutto, dal contenuto
rappresentazionale dell’opera. Il problema del descrivere la musica
strumentale utilizzando termini emotivi è un caso particolare di questo tipo di problema 144 .
Tale problema emerge prepotentemente ed è tanto più spigoloso ovviamente in
relazione alla musica strumentale, la quale – evidenzia Matravers –, sebbene non sia
inusuale per noi descriverla in termini emotivi, non solo si presenta discontinua con il
resto delle nostre vite, ma non è nemmeno, per riprendere un’espressione di Danto, ‘a
proposito di’ (about) qualcosa che potrebbe giustificare l’applicazione di un termine
emotivo ad essa 145 . Tale è la ragione per cui diventa più difficile comprendere da dove
traiamo l’idea che l’opera stia esprimendo le emozioni, e soprattutto, risulta difficile
chiarire come e perché l’espressione delle emozioni entri a far parte dell’esperienza di
tali opere.
Matravers sostiene che un primo passo per arrivare ad una possibile soluzione
tanto del primo quanto del secondo problema, per quanto differenti siano l’uno
dall’altro, è quello di far emergere quali sostanziali differenze intercorrano tra il complesso stato mentale che è provocato da un’opera d’arte e il complesso stato mentale
che è l’esperienza delle emozioni nei casi centrali, ovvero nei casi dell’esperienza ordi144
Ivi, pag. 3.
Cfr. A. Danto, The Transfiguration of the Coomonplace: A Philosophy of Art, Cambridge Mass, Harvard University Press, 1981.
145
101
naria della vita. È necessario infatti, dal suo punto di vista, mettere in conto e comprendere il fatto che non tutti gli stati mentali, o esperienze psicologiche, possono essere
considerate e classificate allo stesso modo. Matravers nello specifico – muovendosi da
una teoria cognitiva delle emozioni, secondo la quale un’emozione è composta da un
numero di elementi includenti una o più attitudini proposizionali, e dal funzionalismo
che definisce le attitudini proposizionali nei termini della loro collocazione all’interno
di una rete causale di input, output e connessioni con altri stati mentali – sostiene che ci
sono stati psicologici, le emozioni, che hanno una precisa componente cognitiva, e altri
stati, le sensazioni (feelings) in cui tale componente viene meno, anzi è preferibile dire,
è completamente assente. Ci sembra dunque qui riproporsi quella distinzione, cui accennavamo nel primo capitolo, tra Gefühl e Fühlen, tra sentimento determinato (Hanslick) e sentimento come tonalità del sentire (Schopenhauer, Langer).
Specifica Matravers a tale proposito:
Questo dimostra che non tutte quelle che potremmo chiamare esperienze psicologiche sono dirette-verso-un-oggetto. Questa caratteristica delle attitudini proposizionali, e quindi delle emozioni che le
coinvolgono, serve a distinguere questi stati in particolare dalle esperienze che rientrano in un’altra categoria psicologica: ovvero da quelle che io chiamerò sensazioni (feelings). Nel distinguere queste due
categorie dell’esperienza psicologica, non voglio sostenere che vi
debba essere una netta distinzione nelle esperienze stesse, né voglio
sostenere che un termine emotivo non possa essere correttamente usato anche per indicare una sensazione che differisce dall’emozione solo per l’assenza della componente cognitiva di quest’ultima. Perciò in
alcuni casi potremmo voler chiamare ‘emozione’ una istanza di paura, in quanto essa ha un oggetto (essa è la paura per qualcosa), e in altri casi potremmo volerla chiamare ‘sensazione’ in quanto è priva di
oggetti […] La distinzione tra stati mentali che sono a proposito di
qualcosa e quelli che invece non lo sono, è, tuttavia, comprensibilmente evidente, e il sottolinearla rende un servizio alla chiarezza.
[…] È la presenza o l’assenza delle attitudini proposizionali più rilevanti, in particolare le credenze, che considererò come l’elemento
che distingue le emozioni dalle sensazioni. Le altre due componenti
di questi due stati psicologici, ovvero quella fenomenologica e quella
fisiologica, saranno da me considerate caratteristiche di entrambi.
Un’emozione si distingue da una sensazione, quindi, in virtù del possesso di un aspetto cognitivo 146 .
Le emozioni, quindi, sono dotate di un aspetto cognitivo (esse sono dirette verso
un qualche oggetto) che invece è assente nelle sensazioni. Queste ultime costituiscono
146
Ivi, pp. 19-20.
102
la componente fenomenologica e fisiologica delle emozioni. Ed ecco il punto che qui ci
preme evidenziare. Secondo Matravers lo stato caratteristico suscitato da un’opera
d’arte espressiva è una sensazione e non un’emozione, poiché la sensazione a differenza dell’emozione non ha una componente cognitiva.
Lo stato caratteristico suscitato da un’opera d’arte espressiva è […]
una sensazione e non un’emozione: ovvero, esso è privo della componente cognitiva. Abbiamo visto nel capitolo 2 che l’ ‘essere-direttiall’oggetto’ da parte delle emozioni è una conseguenza del loro aspetto cognitivo; l’oggetto intenzionale dello stato cognitivo è anche
l’oggetto intenzionale delle emozioni. Lo stato che è suscitato da
un’opera d’arte espressiva (per uno spettatore qualificato posto nelle
appropriate condizioni) non ha oggetto. Esso non è né ‘tristezza riguardo a qualcosa’ né ‘tristezza per il pensiero di qualcosa’ 147 .
Naturalmente, aggiunge Matravers, è possibile per le proprietà espressive di
un’opera d’arte causare uno stato mentale coinvolgente un’attitudine proposizionale,
ma se questo accade – se accade cioè che l’opera d’arte espressiva provochi
un’emozione – quell’emozione non ha l’opera come suo oggetto intenzionale; essa avrà
qualcosa di esterno all’opera; per esempio, il pensiero della morte della nonna o la perdita di un amore. Dico subito che questo tipo di considerazione costituisce un problema
per l’Arousal Theory, poiché – come Matravers stesso non trascura di evidenziare –
molti sono i filosofi d’accordo nel sostenere, e tra questi abbiamo già visto da vicino il
pensiero di Kivy a tale riguardo, che tali reazioni non sono esteticamente rilevanti.
L’idea comune è che se io sono sollecitato (triggered) da un’opera d’arte a provare
un’emozione il cui oggetto è qualcosa di esterno all’opera, una tale reazione non può
costituire la base per un giudizio estetico sull’opera. L’Arousal Theory dovrà in questo
senso trovare un modo di distinguere il primo tipo di reazione dalla seconda.
Sulla base di queste considerazioni possiamo così iniziare a comprendere in che
termini Matravers viene a reimpostare una più sofisticata versione della teoria eccitazionistica rispetto a come essa si presentava nella sua formula standard, e cioè a partire
da una precisa spiegazione di come dobbiamo intendere l’uso del termine emozione in
contesti estetici. La spiegazione comunque di come intendere l’uso che facciamo del
termine emozione in contesti estetici non è l’unico aspetto da mettere in conto nella ridefinizione da parte di Matravers della teoria eccitazionistica. È importante anche e soprattutto – come egli tiene a precisare – spiegare l’esperienza stessa dell’espressione in
147
Ivi, pp. 147-148. Corsivo mio.
103
arte, vale a dire: in cosa consiste tale esperienza, qual è il suo senso intrinseco, in che
modo le emozioni (o, meglio, le sensazioni) entrano a far parte dell’esperienza
dell’espressività musicale.
Possiamo avere già una qualche comprensione dell’esperienza espressiva delle
opere d’arte, avvalendoci semplicemente della riflessione su cosa tale esperienza ha in
comune con l’esperienza delle persone che esprimono emozioni. Sostiene Matravers
infatti che vi è un’analogia tra la nostra risposta all’arte che esprime emozioni e la nostra risposta alle persone che esprimono emozioni. Nello specifico, l’aspetto interessante di questa analogia tra la musica espressiva e le persone espressive considera il modo
in cui è appropriato reagire nell’una e nell’altra situazione. In questo senso – egli sostiene – è inappropriato, quando ci troviamo dinanzi all’espressione umana
dell’emozione, semplicemente formarsi una credenza, ovvero una convinzione relativa
alle cause dell’espressione (vale a dire, fare delle ipotesi su cosa possa aver causato la
manifestazione esteriore dell’emozione). L’appropriata reazione è piuttosto sentire un
qualche tipo di emozione in noi stessi 148 . Lo stesso è vero della nostra reazione all’arte
espressiva. Poiché è inappropriato semplicemente riconoscere che un’opera d’arte esprime un’emozione e registrare il fatto nella forma di una credenza. In circostanze ottimali, si dovrebbe apprezzare l’opera reagendo ad essa con un’esperienza emotiva appropriata.
Si evidenzia così il motivo di netto contrasto tra il punto di vista di Matravers e
quello di Kivy: delle emozioni, per Kivy, si ha cognizione, è necessario cioè poterle riconoscere, mentre Matravers sottolinea come esse vadano piuttosto sentite.
È muovendosi dalle due principali affermazioni a) che l’appropriata reazione
all’espressione artistica è una sensazione e non un’emozione e b) che tale esperienza
emotiva causata dall’opera d’arte espressiva è analoga a quella della nostra risposta
emotiva dinanzi a persone che esprimono emozioni 149 , che Matravers arriva alla seguente formula:
148
Analogamente a quanto sostiene Ridley, altro illustre sostenitore della teoria eccitazionistica, anche
Matravers è dell’idea che per descrivere la musica come espressiva delle emozioni occorre in qualche
modo rapportare l’esperienza emotiva della musica all’esperienza comune delle emozioni. Dobbiamo
cioè entrare in “simpatia” con la musica che ascoltiamo, altrimenti risulterebbe impossibile una descrizione della musica in termini emotivi. In altre parole, l’esperienza della somiglianza tra un passaggio
musicale e l’espressione reale delle emozioni dipende dal fatto che ascoltando il brano in questione “portiamo alla mente” ciò che succede in noi quando proviamo una certa emozione; pertanto il riconoscimento dell’espressione di un’emozione in musica e la descrizione emotiva di un brano musicale implicano il
sentimento di quell’emozione. (Cfr. A. Ridley, Musical Symphaties: The Experience of Expressive Music, cit.; Id., Music, Value and Passions, Cornell University Press, Ithaca, Capitolo VI).
149
La differenza tra le due esperienze sta nel fatto che, come detto, reagiamo all’espressione di emozioni
da parte di persone provando emozioni, mentre reagiamo all’espressione di emozioni da parte di opere
104
Un’opera d’arte x esprime l’emozione e se, per uno spettatore qualificato p che esperisce x in condizioni normali, x suscita in p una sensazione che costituirebbe un aspetto della reazione appropriata
all’espressione di e da parte di una persona, o a una rappresentazione
il cui contenuto sia costituito dall’espressione di e da parte di una
persona 150 .
Spostandosi dalle arti in generale e passando al caso particolare della musica strumentale, lo schema resta pressoché invariato:
Un brano musicale esprime un’emozione e se spinge l’ascoltatore a
esperire una sensazione α, dove α è la componente sensibile (the feeling component) dell’emozione che sarebbe appropriato provare (nei
casi centrali) quando ci troviamo di fronte a persone che esprimono
e 151 .
Si tratta, diciamo subito, di quella più sofisticata formula mediante la quale Matravers viene a riqualificare una spiegazione dell’espressività musicale in chiave eccitazionistica o disposizionale. Secondo tale spiegazione, sembra dunque evidente, una descrizione della musica in termini emotivi è possibile soltanto perché essa suscita in noi
quelle sensazioni che nella vita reale sono parte di quella stessa emozione. Detto in altri
termini, possiamo descrivere un brano musicale come allegro perché esso suscita in noi
quelle sensazioni che nella vita reale fanno parte dell’allegria, o meglio, che sono forme appropriate di reazione all’espressione di allegria da parte di una persona, e che
quindi ci spingono a descrivere la musica come allegra. In questo senso, possiamo adesso comprendere meglio, le proprietà espressive della musica non sono più da intendersi come proprietà percettive della musica stessa, bensì come disposizioni a suscitare
sensazioni in chi ascolta. Non si deve infatti, secondo Matravers, cadere nell’errore dei
cognitivisti in generale, e di Kivy, in particolare, di pensare che l’espressione della musica possa essere svincolata dal polo dell’esperienza soggettiva, che si possa quindi
spiegare l’espressività musicale come un fatto inerente la musica, le sue stesse proprietà. Ma, ed ecco il punto di maggiore incrinatura tra le opposte concezioni, ciò che è did’arte provando sensazioni. Matravers chiarisce anche che questo aspetto dell’Arousal Theory, e cioè che
l’appropriata reazione all’espressione artistica è una sensazione e non un’emozione, si potrebbe pensare
sia in conflitto con la fondamentale analogia tra la nostra risposta all’arte che esprime emozioni e la nostra risposta alle persone che esprimono emozioni, poiché in quest’ultimo caso è certamente appropriato
rispondere con un’emozione – cioè uno stato con una componente cognitiva. Quando ci troviamo dinanzi ad una persona triste, rispondiamo con la tristezza, o forse con la pietà. In realtà – egli spiega – le
strutture basilari (ovvero fisiologiche e fenomenologiche) delle risposte sono analoghe, anche se rimuoviamo le considerazioni riguardanti il contenuto cognitivo.
150
Ivi, pag. 146.
151
Ibidem, pag. 149.
105
stintivo riguardo al cognitivismo è proprio l’affermazione che l’espressione è una proprietà di un’opera che è descrivibile in quanto tale indipendentemente da
un’individuale reazione ad essa.
Come già anticipato, la teoria eccitazionista di Matravers è stata a sua volta il
bersaglio di numerose critiche mosse dal fronte dei cognitivisti, in particolare dal suo
esponente di punta, vale a dire Peter Kivy. In Art and Emotion, Matravers prende in esame quelle che sono le quattro principali critiche mosse da Kivy all’Arousal Theory,
rispondendo alle quali egli non solo difende la validità della propria proposta, ma ne
chiarisce alcuni aspetti importanti che possono essere rimasti ancora in ombra 152 .
La prima critica sostiene che ogni emozione da noi provata nella vita reale ha
delle implicazioni di tipo comportamentale − quando ad esempio proviamo malinconia,
di solito perdiamo l’appetito, e stiamo a testa bassa; quando siamo arrabbiati, tendiamo
ad attaccare briga; e così via − che sono assenti quando ascoltiamo la musica − di solito
infatti non osserviamo comportamenti simili nelle persone sedute in teatro che assistono a un concerto di musica classica, e nemmeno ci lasciamo andare a particolari reazioni esteriori quando ascoltiamo la musica tramite le cuffie del nostro stereo. Ciò minerebbe la presunta analogia tra le emozioni ordinarie e quelle suscitate dalla musica.
Matravers ha gioco facile nel ribattere in prima battuta a tale critica, in quanto gli è sufficiente ricordare che la sua teoria afferma che la musica espressiva suscita
nell’ascoltatore una (particolare) sensazione (la quale è priva della componente cognitiva, non è rivolta ad alcun oggetto, e che quindi non implica necessariamente delle esternazioni comportamentali specifiche) e non un’emozione. I cognitivisti replicano però a loro volta sostenendo che identificare la sensazione caratteristica di un’emozione,
in quanto scissa dalla componente cognitiva di quest’ultima, risulta essere
un’operazione pressoché impossibile; il che renderebbe la definizione dell’espressività
musicale data da Matravers del tutto inoperativa, dato che tale definizione lega
l’attribuzione di un termine emotivo a un dato brano musicale al riconoscimento
dell’analogia tra la sensazione suscitata dal brano e la componente sensitiva
dell’emozione (feeling component of emotion) corrispondente al termine, la quale componente sensitiva è quella che proveremmo se ci trovassimo di fronte a una persona che
esprime l’emozione in questione. A tale ulteriore osservazione, Matravers risponde
chiarendo innanzitutto, una volta di più, che non si tratta secondo lui di riconoscere,
ovvero di percepire, una proprietà nella musica, ma di provare internamente una certa
152
Ci riferiamo qui sempre al testo di Matravers, Art and Emotion, cit., con particolare riferimento alle
pp. 147-187. Le stesse analisi sono riassunte in Id., The Experience of Emotion in Music, cit.
106
sensazione ed esperire la somiglianza di questa con un certo tipo di reazione emotiva
che caratterizza la nostra vita comune, i nostri rapporti con le altre persone e in generale con la vita. Ad ogni modo, egli ritiene, riprendendo anche Levinson, che sia possibile identificare, attraverso un’attività di introspezione, il ‘feeling component’ delle emozioni designate dai termini emotivi attribuiti alla musica, specificandoli in termini esperienziali-fenomenologici (ovvero in termini di determinati impulsi, sensazioni interne,
sentimenti di piacere o dispiacere, stati di tensione o di rilassamento, ecc.). Tale attività
di introspezione è agevolata dal fatto (riconosciuto anche da Budd) che le emozioni espresse dalla musica − come il linguaggio della critica musicale, che attribuendo certi
termini emotivi alla musica intende portarne alla luce l’espressività, conferma − sono
designabili attraverso un numero limitato e circoscritto di termini piuttosto generali, i
quali si riferiscono ad emozioni (malinconia, gioia, tristezza, ecc.) per le quali è lecito
attendersi che sia possibile identificare, per via introspettiva, uno specifico ‘feeling
component’, almeno in riferimento ai casi centrali (ovvero alle situazioni della vita reale in cui proviamo determinate sensazioni in reazione all’espressione di tali emozioni
da parte di certe persone), ai quali l’espressività musicale è collegata da una relazione
di somiglianza (tra le sensazioni suscitate dall’ascolto di una musica che descriviamo
ad esempio come triste e le sensazioni che proviamo quando ci troviamo di fronte a una
persona che esprime tristezza; sensazioni che, come vedremo meglio più avanti, possono essere di tristezza o di pietà). Non mancano quindi a Matravers gli argomenti per respingere la prima critica mossagli da Kivy; critica che, a ben vedere, si basa su premesse tutt’altro che certe. È infatti vero, Matravers riconosce, che i sentimenti suscitati dalla musica sono solitamente moderati, e quindi privi di manifestazioni comportamentali
(essi sono simili ai sentimenti suscitati dalla lettura del giornale, le cui notizie possono
colpirci emotivamente, ma non fino al punto tale da farci mettere da parte il thè che
stavamo sorseggiando durante la lettura). Tuttavia, ciò non toglie che talvolta la musica
possa emozionarci al punto tale da farci ridere di gioia, o da farci piangere per la commozione, sebbene solitamente evitiamo di abbandonarci a tali esternazioni, soprattutto
se ci troviamo in uno spazio pubblico (come quello di un teatro o di un’arena).
La seconda critica che Kivy indirizza alla teoria di Matravers consiste nel famoso argomento delle ‘emozioni negative’, il quale, sinteticamente, pone la seguente domanda, alla quale l’Arousal Theory non sembra essere in grado di rispondere: se la musica che esprime tristezza suscita in noi emozioni (o, più precisamente, sensazioni) di
107
tristezza (e quindi spiacevoli), perché mai dovremmo desiderare di ascoltarla? Tale argomento, da molti ritenuto decisivo, è in realtà facilmente respingibile.
Restando sul piano del piacere estetico suscitato dall’ascolto della musica, Matravers osserva infatti che il fatto che l’esperienza dell’ascolto di una musica triste contenga dei sentimenti di tristezza (e quindi di per sé spiacevoli), non implica affatto che
tale esperienza non possa essere, nel suo complesso, un’esperienza piacevole (essendo
questa un’esperienza che coinvolge anche altri elementi, quali ad esempio
l’apprensione della forma musicale). Spostandosi poi sul piano più generale di una teoria del valore, Matravers sostiene (con una riflessione dal sapore nietzschiano) che non
c’è alcuna ragione di pensare che tutte le nostre attività volontarie siano finalizzate al
raggiungimento di uno stato di piacere; il fine delle nostre attività è, più in generale,
quello di “rendere la vita meritevole di essere vissuta”, e ciò può includere anche esperienze e sentimenti ‘spiacevoli’ (felicità e infelicità, diceva Nietzsche, sono sorelle gemelle; le esperienze dolorose possono contribuire, se bilanciate da esperienze di segno
opposto, alla pienezza della vita di una persona) 153 . La terza critica da parte dei cognitivisti (che stavolta comprendono, oltre a Kivy, anche Stephen Davies), sostiene che,
poiché non sappiamo né perché, né come, la musica espressiva possa provocare dei
sentimenti, di conseguenza non possiamo postulare l’esistenza di tali sentimenti (o sensazioni) e tantomeno basare su di essi una teoria dell’espressività musicale. Riguardo
alla questione del perché, l’Arousal Theory non sarebbe in grado di giustificare il sentimento provocato dalla musica, in quanto il provare un sentimento non sarebbe una reazione appropriata alla musica, nella stessa maniera in cui (ad esempio) la tristezza è
una reazione appropriata alla morte di una persona cara; ma, chiarisce Matravers,
l’Arousal Theory afferma che la musica espressiva è proprio quella musica che suscita
in noi dei sentimenti, i quali, pur non essendo giustificati, giustificano la credenza che
la musica sia espressiva dei sentimenti stessi. (In sostanza, quello che per Kivy e Davies dovrebbe essere il punto di arrivo, per Matravers è invece il punto di partenza).
Riguardo alla questione di come la musica possa suscitare dei sentimenti, la risposta
può essere fornita, secondo Matravers, solo attraverso una ricerca extra-filosofica. At153
Entrambe le repliche di Matravers a Kivy relativamente all’argomento delle emozioni negative si avvicinano ad alcune delle soluzioni che Jerrold Levinson ha a sua volta avanzato in relazione al medesimo
problema. Secondo Levinson, infatti, i principali elementi che rendono desiderabile l’ascolto di una musica che trasmette emozioni negative sono l’ “emotional resolution” − vale a dire l’apprezzamento della
finalità interna alla composizione musicale, in base alla quale anche le suddette emozioni acquistano un
significato, un senso − e l’ “expressive potency” − ovvero il senso di pienezza e di ricchezza emotiva che
acquisiamo attraverso l’ascolto empatico di una musica che esprime una vasta gamma di emozioni, comprese quelle spiacevoli. (Vedi J. Levinson, Music and Negative Emotion, cit., pp. 326 – 329).
108
tingendo ai contributi della storia, della psicologia e dell’antropologia, è plausibile ipotizzare che l’uomo abbia da sempre avuto l’esigenza di esprimere i propri sentimenti
attraverso l’arte, e abbia sfruttato tanto l’esistenza di corrispondenze naturali, quanto
l’introduzione di determinate convenzioni a livello dei vari linguaggi artistici, al fine di
produrre determinate sensazioni nelle persone che all’arte, nelle varie epoche, si sono
rivolte, e continuano a rivolgersi.
La teoria di Matravers, si è detto, afferma che una musica esprime (ad esempio)
tristezza se è tale che noi reagiamo ad essa provando le sensazioni che, nella vita reale,
proveremmo di fronte a una persona che esprime tristezza. Tali sensazioni possono essere di tristezza o di pietà. Riprendendo la terminologia introdotta da Elliott, Matravers
specifica che nel primo caso esperiamo la musica “dal di dentro”, ovvero come se la
musica fosse l’espressione di un nostro sentimento, mentre nel secondo caso la esperiamo “dal di fuori” 154 , ovvero come se la musica fosse l’espressione del sentimento
provato da un’altra persona, di fronte alla quale reagiamo provando una reazione appropriata (che nel caso specifico è identificata dalla pietà). Questa duplicità della nostra
reazione emotiva alla musica espressiva è parallela a quella che solitamente abbiamo
nella vita reale: osservando una persona (descrivibile come) triste, possiamo identificarci con essa (e allora proveremo anche noi tristezza), oppure possiamo assumere un
atteggiamento simpatetico (e allora reagiremo provando pietà per tale persona). Questa
aggiunta serve a Matravers per chiarire meglio in cosa consiste l’esperienza della musica espressiva; tuttavia, ciò non sembra sufficiente per soddisfare tale scopo. L’ultima
critica che è stata mossa all’Arousal Theory sostiene infatti che la caratterizzazione
causale dell’esperienza dell’espressività musicale, se anche fosse necessaria, non sarebbe comunque sufficiente a caratterizzare adeguatamente quest’ultima, in maniera tale cioè da distinguerla da altre esperienze che chiaramente non possiedono il requisito
dell’espressività. Il contro-esempio più forte che si può fare a Matravers è che, teoricamente, lo stato emotivo suscitato da una musica espressiva può essere provocato anche tramite l’assunzione di una certa droga; di certo, non per questo diremo che la droga è espressiva dell’emozione in questione, ma l’Arousal Theory non sembra in grado
di darne conto. A tale critica se ne accompagna un’altra, portata avanti soprattutto (inutile sorprendersi) da Kivy, il quale vede proprio in tale mancanza l’incapacità
dell’Arousal Theory di dar conto della complessità e dell’importanza, anche ai fini
dell’esperienza dell’ascolto, della comprensione di un brano musicale, il cui ruolo è ri154
Cfr. R. Elliott, ‘Aesthetic Theory and the Experience of Art’ (1967), repr. in H. Osborne, ed., Aesthetics, 1972, pp. 145-57. Oxford, Oxford University Press.
109
conosciuto dalla maggioranza dei critici e degli appassionati di musica, e senza il cui
contributo l’esperienza dell’ascolto di una musica espressiva si ridurrebbe al semplice e
passivo essere affetti da una qualche sensazione o stato emotivo.
Matravers prospetta tre possibili risposte al contro-esempio appena introdotto,
ovvero tre diversi fattori che distinguono l’assunzione di una droga dall’esperienza
dell’ascolto musicale: i sentimenti suscitati; il tipo di proprietà che stimolano i sentimenti; il modo in cui le proprietà (rispettivamente, la droga e le caratteristiche intrinseche di un brano musicale) stimolano i sentimenti. Matravers ritiene che sia il terzo fattore quello decisivo 155 . Affinché una droga ci renda tristi, è sufficiente assumerla, senza che poi si tenga sempre presente, a livello di coscienza, la rappresentazione di ciò
che ha causato il nostro sentimento. Viceversa, l’esperienza espressiva della musica
non si riduce all’esperienza del sentimento che essa suscita in noi, ma comprende anche la rappresentazione consapevole delle proprietà percettive della musica in quanto
cause del sentimento che proviamo, e dei modi in cui tali proprietà producono in noi il
sentimento in questione. Tali modalità prevedono, da parte dell’ascoltatore,
l’attenzione continua e costante alle proprietà dinamiche della musica, alla sua configurazione formale (la struttura in senso lato) e a certe caratteristiche del suono (al fatto
cioè che una musica sia scritta in tonalità maggiore piuttosto che minore). Nello specifico, è particolarmente importante prestare attenzione alle proprietà dinamiche, ovvero
alle relazioni tra i toni, in virtù dell’esistenza di un isomorfismo di base tra la musica e
le emozioni, per cui la percezione del movimento che una musica compie (ad esempio)
dalla dissonanza alla risoluzione produce nell’ascoltatore il passaggio da uno stato
d’animo di tensione o di ansia a uno di rilassamento e di soddisfazione. Fatte tali aggiunte, l’Arousal Theory è in grado di fornire una descrizione sufficientemente informativa dell’esperienza dell’espressività musicale, pur rimanendo all’interno di una cornice causale; descrizione che, al contrario di quanto sostenuto dai suoi detrattori, dà
pienamente conto dell’importanza e della complessità dell’ ‘understanding music’, fornisce una caratterizzazione fenomenologica di tale esperienza in termini di simultaneità
(nella coscienza) della causa (la musica) e dell’effetto (il sentimento) in quanto intimamente connessi tra loro, e fuga ogni dubbio circa la sua presunta affinità con esperienze extra-musicali (come quella dell’assunzione di droghe).
155
Matravers accenna al primo dei tre fattori nel citato The Experience of Emotion in Music, dove egli
sottolinea la maggiore complessità degli stati emotivi suscitati dalla musica, rispetto a quelli suscitati
dalla droga. Il terzo e decisivo fattore è invece preso in esame ancora in Art and Emotion (in particolare,
nelle pp. 164 – 184).
110
L’Arousal Theory cattura quindi, secondo Matravers, il senso primario
dell’espressività musicale; e anche quando quest’ultima deriva non tanto dai sentimenti
che una musica provoca, quanto dalle relazioni che intercorrono tra tali sentimenti
(possiamo ad esempio dire che la speranza e l’ottimismo che la Quinta Sinfonia di Beethoven nel complesso esprime siano dovuti al graduale passaggio dalle sensazioni di
angoscia alle sensazioni di gioia che sperimentiamo durante l’ascolto), è pur sempre
vero che senza le esperienze primarie dell’espressività musicale (ovvero dei vari sentimenti suscitati, durante l’ascolto, dalle proprietà, soprattutto dinamiche, della musica)
questo secondo livello di espressività non sarebbe possibile.
111
CAPITOLO TERZO
Musica, metafora e isomorfismo
1. Introduzione al dibattito sulla metafora
Fino a questo momento è emerso che due sono le principali posizioni
nell’attuale dibattito sul problema espressivo della musica. Abbiamo infatti, parafrasando Kivy, appurato che c’è in atto quasi una sorta di crociata morale tra teorici cognitivisti o sostenitori del requisito dell’esternalità e teorici disposizionalisti. Nonostante
infatti la specificità che caratterizza le singole tesi, ciascuna di esse può essere ricondotta al polo interpretativo di chi ritiene, detto in estrema sintesi, che il problema espressivo della musica si può comprendere focalizzando l’attenzione sulle proprietà espressive e percettive della musica stessa, oppure al polo interpretativo opposto che invece si fa sostenitore dell’idea più antica ed egemone nel pensiero musicale che è quella platonica, secondo cui la musica è triste, allegra e quant’altro, perché causa tali sentimenti nell’ascoltatore. Da questo punto di vista, come abbiamo visto, le proprietà emotive della musica sono considerate piuttosto che come proprietà percettive come
proprietà disposizionali. Non si tratta, cioè, di riconoscere una proprietà della musica
(come insistono per lo più i teorici cognitivisti), ma di provare internamente una certa
sensazione, sentirla, ed esperire la somiglianza di questa con un certo tipo di reazione
emotiva che caratterizza la nostra vita comune, i nostri rapporti con le altre persone e in
generale con la vita.
Due poi abbiamo visto sono anche le principali risposte al problema di come intendere e spiegare l’emozione musicale, la nostra risposta emotiva alla musica. C’è chi
insiste sulla pienezza di tali emozioni, sul fatto cioè che al pari di tutte le altre emozioni
esse abbiano una precisa componente intenzionale, e chi invece ritiene che le emozioni
musicali non siano emozioni vere e proprie, poiché in esse vi è un indebolimento della
componente cognitiva e della nostra risposta comportamentale.
La stessa dinamica conflittuale, vedremo adesso, riverbera anche a proposito
dell’altra questione al centro dell’attuale discussione sul rapporto musica-emozioni, vale a dire: come intendere le descrizioni della musica in termini emotivi. Anche in questo caso, possiamo anticipare, emergono due prospettive in conflitto tra loro: c’è chi
propende per un’ipotesi letterale delle descrizioni emotive e chi, invece, ritiene che
queste siano necessariamente metaforiche.
Una concezione di tipo letterale è quella che abbiamo già incontrato quando ci
siamo occupati della teoria espressiva di Kivy, il quale, nella sua prima opera, The
Corded Shell, iniziava l’indagine proprio a partire dall’analisi di quello che egli defini113
sce il paradosso della descrizione musicale. Ciò che è emerso è che per Kivy non c’è
bisogno infine di convocare le risorse della metafora, perché si riconosce all’oggetto,
cioè alla musica stessa, il possesso di quelle proprietà che giustificano una sua descrizione in termini emotivi.
Così, anche Matravers, sebbene a partire da altri presupposti, è disposto ad archiviare come inutile e improduttivo qualsiasi ricorso alla metafora quando si parla dei
giudizi di espressione. «La dichiarazione ‘quel brano di musica è triste’ è più vicino a
dichiarazioni inequivocabilmente letterali come ‘quel brano era lungo’, ‘quello era un
valzer’, che non alla dichiarazione inequivocabilmente metaforica ‘quella musica ha
dato fuoco alla sala’. La metafora mette a confronto la musica e il fuoco, mentre il giudizio d’espressione non fa confronti di questo tipo. Se la comunicazione è valida, chiunque ascolti il giudizio d’espressione non perverrà ad alcuna credenza relativa a una
qualche proprietà, specificabile separatamente, comune alla musica e alle persone tristi,
ma arriverà semplicemente a credere che la musica è, in effetti, triste» 156 .
Vi è qui dunque in gioco l’ipotesi che le descrizioni della musica in termini emotivi siano da intendersi come descrizioni letterali. Ipotesi questa cui dedicheremo
adesso maggiore attenzione, mediante l’approfondimento particolare delle tesi di due
esponenti aderenti, come Kivy, alla corrente cognitivista (Malcolm Budd e Stephen
Davies). Anche per loro ha valore un’idea di espressività che rivendica il carattere di
realtà delle proprietà emotive della musica e allo stesso tempo riabilita un’ipotesi isomorfica quale contraltare di una spiegazione dell’espressività capace di catturare i rapporti analogici tra la nostra esperienza e le caratteristiche proprie dell’oggetto estetico.
Su tutto un altro fronte, versus dunque un’ottica “letteralista”, troviamo i sostenitori di una tesi metaforica. Da questo punto di vista vi è l’idea che quando descriviamo un brano musicale in termini emotivi stiamo in realtà attribuendo alla musica non
proprietà reali, ma proprietà metaforiche, e che pertanto ascoltare la tristezza della musica sia una questione non di «ascoltare che», ma di «ascoltare come», e cioè in maniera immaginativa. In una prospettiva di questo tipo certamente si annoverano rispettivamente le tesi di Goodman e Scruton.
Sostenitore di una tesi metaforica è anche Nick Zangwill, per il quale le descrizioni emotive della musica sono da intendersi come descrizioni metaforiche delle proprietà estetiche della musica. In questo caso, come spiegheremo meglio in seguito, il
riconoscimento del valore metaforico delle descrizioni emotive della musica può fun156
D. Matravers, Art and Emotion, cit., pag. 110.
114
zionare come indebolimento drastico del rapporto musica-emotività, se è vero che descrivere emotivamente la musica è solo una possibilità tra le tante disponibili per avvicinarci allo specifico musicale, poiché si possono scegliere caratterizzazioni che non
chiamano in causa la vita emotiva, come quando diciamo, ad esempio, che una musica
è bilanciata o delicata.
Sullo sfondo di queste diverse posizioni strettamente connesse al discorso sulla
musica, troviamo dunque il dibattito più generale sul problema della parafrasabilità o
traducibilità della metafora. Il punto centrale della questione riguarda quindi il criterio
prettamente linguistico della parafrasabilità, e ruota intorno all’interrogativo se una certa metafora possa conservare il suo contenuto semantico pur in presenza di formulazioni linguistiche alternative, il che equivale a chiedersi sostanzialmente se una metafora
possa essere letteralmente traducibile oppure no.
La domanda è allora questa: una metafora reca in sé qualcosa che non è riconducibile (o lo è solo in parte) alla sua manifestazione letterale, è capace di apportare
una conoscenza che in qualche modo è implicita pur senza essere letteralmente presente nella formulazione linguistica che la esprime?
Ancora una volta sarà interessante a tale proposito, prima di entrare nel merito
dell’attuale discussione e di vedere anche in questo caso quali sono le posizioni teoriche di maggiore rilievo, guardare alla questione a partire da un’indagine delle tesi e dei
testi seminali che sono alla base del dibattito.
2. I testi seminali
2. 1 Il bello musicale di Hanslick
Torniamo ancora su questo testo, perché in esso è presente la tematica dell’uso
metaforico delle attribuzioni emotive alla musica, anche se, come è ovvio, non vi troviamo una vera e propria teoria della metafora. Per Hanslick, non vi è ombra di dubbio,
che le nostre descrizioni della musica in termini emotivi siano da intendersi non come
descrizioni di un’emozione reale, bensì come descrizioni metaforiche. A suffragare
questa tesi vi è, ancora prima, la confutazione dell’erroneo presupposto che il bello della musica possa consistere nell’esibizione di sentimenti, poiché il sentimento per Han115
slick è sempre determinato, vincolato cioè ad un’esperienza particolare. Il bello della
musica è invece – egli sostiene – un bello specificamente musicale, che non dipende e
non ha bisogno di alcun contenuto esteriore, ma che consiste unicamente nei suoni e
nella loro artistica connessione. Le ingegnose combinazioni di suoni belli, il loro concordare e opporsi, il loro sfuggire e raggiungersi, il loro crescere e morire, questo è ciò
che in libere forme si presenta all’intuizione del nostro spirito e che piace come bello.
L’unico contenuto che alla musica si può ascrivere è quello delle forme sonore in movimento. Tutto quello che è vincolato al nostro mondo non ha nessuna relazione, né diretta, né indiretta con la musica, in quanto il suo regno, asserisce esplicitamente Hanslick, non è di questo mondo. La musica ha un suo mondo, è un’immagine il cui oggetto non può essere racchiuso in parole ed essere esaurito in concetti. Per tale ragione, le
descrizioni che diamo di essa non possono essere che metaforiche. Interessante, a tal
proposito, riportare il passo in cui esplicitamente Hanslick dice:
È straordinariamente difficile descrivere in musica questo bello indipendente, ossia l’elemento tipicamente musicale. Poiché la musica
non ha modelli in natura e non esprime alcun contenuto concettuale si
può parlare di essa solo in aridi termini tecnici, oppure con immagine
tecniche. Effettivamente il suo regno “non è di questo mondo”. Tutte
le fantastiche descrizioni e illustrazioni di un brano musicale sono
metaforiche o erronee. Ciò che per ogni altra arte non è che descrizione, per la musica è metafora. La musica, insomma, vuol essere intesa in quanto musica e può essere compresa e gustata solo in se stessa 157 .
A conferma del fatto che le nostre descrizioni della musica in termini emotivi
sono da intendersi solo in senso figurato e che non possano avere nessun valore, diciamo così, letterale di applicazione, vi è anche il fatto, spiega Hanslick, che spesso attingiamo a descrizioni che designano il carattere espressivo della musica senza ricorrere a
concetti che richiamano la nostra vita emotiva, assumendo definizioni che appartengono a tutta un’altra cerchia di fenomeni. Possiamo cioè descrivere un brano musicale
come malinconico, ma anche con altri termini quali, ad esempio, bilanciato, delicato,
etc. In questo senso i sentimenti che utilizziamo per la designazione del carattere di una
musica sono solo fenomeni come altri che offrono somiglianze. Si può dire che la musica è triste, ma ci si guardi bene dal dire questa musica descrive tristezza. Descrivere,
spiega Hanslick, significa mostrare con chiarezza ed evidenza qualcosa, “esibirla” di
157
E. Hanslick, Il bello musicale, cit., pag. 65
116
fronte ai nostri occhi, ma la musica assoluta, lo abbiamo visto, a differenza delle altre
arti, non ha nulla da esibire.
Per caratterizzare l’espressione musicale di un motivo scegliamo
spesso concetti propri della nostra vita affettiva come “fiero, triste,
tenero, ardito, nostalgico”. Possiamo però prendere le definizioni anche da un’altra cerchia di fenomeni e chiamare una musica “vaporosa, primaverilmente fresca, nebulosa, gelida”. Per la designazione del
carattere di una musica i sentimenti sono dunque fenomeni come altri, che offrono somiglianze. Tali epiteti possono essere usati avendo
coscienza del carattere figurato, di cui non si può fare a meno, ma ci
si guardi dal dire: questa musica descrive la fierezza, ecc. 158
Anticipiamo che sono esattamente queste le stesse riflessioni che troviamo da
sfondo e che supportano la teoria metaforica sostenuta recentemente da Zangwill
nell’articolo Music, Metaphor, and Emotion 159 . In questo articolo viene in chiaro come
non sia necessario ricorrere ad una teoria della metafora vera e propria per stabilire se
la parola emozione è usata oppure non è usata metaforicamente. È sufficiente infatti dal
suo punto di vista fornire, più semplicemente, dei criteri specifici per stabilire quali sono gli usi metaforici e quelli non metaforici del termine emozione, sebbene in una nota
Zangwill ci informi che è incline ad abbracciare la teoria esposta da Donald Davidson
nell’articolo “Cosa significano le metafore” 160 . Si tratta dello stesso articolo di cui ci
occuperemo a breve e che espone una cosiddetta teoria letterale o non-cognitiva della
metafora.
È il caso infatti di specificare che oltre alla tesi hanslickiana che offre una spiegazione di come intendere le descrizioni della musica senza ricorrere a nessun tipo di
teoria metaforica vera e propria, ma basandosi più semplicemente su un’osservazione
di quella che è la natura della musica e di un’emozione, negli articoli di cui ci occuperemo a breve, avremo modo di verificare che puntualmente vi è il riferimento ad una
teoria metaforica entro cui si inquadra il tentativo di dar conto delle descrizioni emotive della musica.
158
Ivi, pag. 67.
N. Zangwill, Music, Metaphor and Emotion, “Journal of Aesthetics and Art Criticism”, 65, 2007, pp.
391- 400.
160
D. Davidson, Che cosa significano le metafore, in Id., Verità e interpretazione, trad. it. Di R. Brigati,
a cura di E. Picardi, Il Mulino, Bologna, 1994, pp. 337-360 e in Simona Chiodo (a cura di) Che cosa è
arte, la filosofia analitica e l’estetica, UTET, Torino 2007, pp. 1 35-146 (What Metaphor Mean, «Critical Inquiry» n. 5, 1978, pp. 31-47, anche in Id., Inquiries into Truth and Interpretation, Clarendon Press,
Oxford 2001).
159
117
L’orizzonte storico-teorico di riferimento è quello che vede rinnovarsi una concezione cognitiva della metafora in ambito analitico. A venire meno è la vecchia e riduttiva opinione che vede la metafora come mero abbellimento o come sostituto della
similitudine, un ornamento letterario, un congegno raro o esotico, esclusivamente decorativo. Si viene così a riaffermare l’idea che la metafora ha una capacità cognitiva importante e solidale al progresso della conoscenza e che è diversa per articolazione ma
non per funzione dagli altri strumenti discorsivi a cui va riconosciuto un vero e proprio
esercizio gnoseologico. Si riconosce così il valore cognitivo del discorso metaforico. In
passato, chi negava che la metafora avesse un contenuto cognitivo nuovo rispetto a
quello letterale voleva sovente mostrare che la metafora è fonte di confusione, ha carattere puramente emotivo, è inadatta al discorso scientifico o filosofico serio. Il primo a
rinnegare questa idea, vedremo nell’approfondimento che segue, riportando in auge
una concezione cognitiva della metafora è stato Max Black. Una conferma a tale proposito è quella che rinveniamo nelle parole di Ted Cohen nel saggio Metaphor 161 :
Dopo essere stato trattato in maniera alquanto saltuaria nella storia
della filosofia per più di 2000 anni, il tema della metafora ha cominciato a ricevere un’intensa attenzione nell’ultima parte del ventesimo
secolo. Possiamo trovare dei rilievi occasionali sulla metafora in Aristotele, Hobbes, Locke, e Nietzsche, tra gli altri, ma questo tema ha
cominciato a ricevere un’attenzione continua, in special modo da parte dei filosofi analitici, a partire dal 1950. La rilevanza della metafora
nella filosofia del linguaggio e nella filosofia dell’arte è stata ora riconosciuta, e alcuni hanno ritenuto che tale tematica sia importante
per la filosofia in generale. Jacques Derrida (Derrida 1974) ha detto
che virtualmente tutte le dichiarazioni sono, in un certo senso, metaforiche; e George Lakoff e Mark Johnson (Lakoff and Johnson 1980)
hanno sostenuto che la stessa struttura del pensiero è profondamente
metaforica. Queste tesi ardite non hanno esercitato molta influenza
sui filosofi analitici, ma sono state fatte proprie da un consistente
numero di persone che operano in altri campi. Uno dei primi testi
fondamentali, per i filosofi analitici e non solo, è stato “Metaphor” di
Max Black, sebbene tale saggio abbia goduto di un’ampia considerazione solo una dozzina di anni dopo la sua pubblicazione, quando fu
positivamente menzionato da Nelson Goodman (Goodman 1968. La
tesi di Goodman è elaborata e difesa in Scheffler 1979) 162 .
161
T. Cohen, Metaphor, in “The Oxford Handbook of Aesthetics” (a cura di) Jerrold Levinson, Oxford
University Press, Oxford, 2002, pp. 366-376.
162
Ivi, pag. 366.
118
2. 2 Metaphor di Max Black
Significativo certamente è stato il lavoro di Max Black 163 , Metaphor 164 , a cui
non mancano di far riferimento quasi tutti i saggi pubblicati sull’argomento. Black è infatti il principale sostenitore di una teoria che ha riscosso molto successo e insieme ha
rinnovato l’interesse nei confronti degli studi relativi a questa figura. Si tratta, diciamo
subito, di una teoria cognitiva della metafora secondo la quale la metafora ha un contenuto cognitivo speciale, additivo, che non può essere riducibile ad una equivalente espressione letterale. Il modello di spiegazione metaforica da cui Black attinge nel tentativo principale di difendere strenuamente il valore cognitivo del discorso metaforico è
quello della cosiddetta concezione interattiva della metafora (interaction view), proposta ancora prima da Richards (The Philosophy of Rhetoric, Oxford 1936) 165 , ma emendata della primitiva e schematica distinzione tra significato «scientifico» e significato
«emotivo». Tale concezione vede la metafora come l’interazione tra due insiemi di
luoghi comuni associati ai due termini in essa presenti che Black identifica come soggetto «principale» e soggetto «sussidiario». Nell’esempio, oramai molto banale, ‘Giulietta è il sole’, ‘Giulietta’ sarebbe il soggetto principale e il ‘sole’ il soggetto sussidiario. Tali soggetti, precisa Black, non sono da intendersi come oggetti semplici, bensì
come complessi sistemi di implicazioni.
Il successo di una metafora, secondo la spiegazione interattiva nella formula rivisitata da Black, è il risultato di una selezione che opera all’interno del sistema
d’implicazione del soggetto sussidiario sopprimendo alcuni casi ed enfatizzandone altri, per trasferirli all’interno del sistema del soggetto principale; il criterio che rende
pertinente l’operazione di scelta e successivamente quella di trasferimento poggia su un
sistema di relazioni isomorfiche, i cui centri sono costituiti da quell’insieme di luoghi
comuni e opinioni notevoli che costituiscono il contenuto di tali sistemi.
163
Max Black (1909 – 1988) è stato uno dei più importanti esponenti della filosofia analitica nella prima
metà del XX secolo. I suoi contributi hanno interessato gli ambiti della filosofia del linguaggio, della filosofia matematica, della filosofia della scienza, e della filosofia delle arti. Ha pubblicato anche saggi sui
lavori di Frege. Studiò matematica al Queens’ College di Cambridge, dove sviluppò l’interesse per la
filosofia matematica. In quel periodo Russell, Wittgenstein, George Edward Moore, e Frank Plumpton
Ramsey erano presenti contemporaneamente a Cambridge, e la loro influenza su Black fu considerevole.
Si laureò nel 1930, e vinse una borsa di studio di un anno a Göttingen. Tra i suoi lavori più rappresentativi ricordiamo: “Vagueness; An exercise in logical analysis” (1937), “Metaphor” (1954), “Models and
metaphors” (1962), “More about Metaphor” (1979).
164
M. Black, Metaphor, “Proceedings of the Aristotelian Society”, 55, 1954, pp. 273-294; trad. it. Modelli Archetipi Metafore, Pratica Editrice, Parma, 1983.
165
I. A. Richards, The Philosophy of Rhetoric, Oxford University Press, New York, 1936.
119
Come Black specifica nell’altro saggio dedicato alla metafora, More about Metaphor 166 (Ancora sulla metafora), nel quale riprende la concezione interattiva già esposta in Metaphor, apportando solo lievi modifiche, la relazione reciproca tra soggetto
principale e sussidiario è espressa dal contrasto tra il focus dell’asserzione metaforica,
il centro di essa, vale a dire, quel termine (o quei termini) direttamente responsabili del
senso metaforico della frase, e dal frame, dalla cornice letterale da cui il focus è circondato. Focus e frame sono entrambi egualmente responsabili della riuscita di una metafora per via di quel rapporto di interazione che si stabilisce tra loro, e senza il quale
qualsiasi attribuzione predicativa del soggetto sussidiario a quello primario sarebbe arbitraria e perciò priva di qualsiasi senso.
Risulta dunque chiaro, nella struttura sintattica di una metafora, come il frame
sia invariabilmente sovrapposto al soggetto sussidiario, mentre il focus è costituito dal
soggetto principale (questo almeno nelle metafore brevi), quale ad esempio: «L’uomo è
un lupo».
La concezione interattiva nella forma esposta da Black rimanda ai seguenti sette requisiti 167 :
1. Un’asserzione metaforica ha due soggetti distinti, un soggetto «principale» e
uno «sussidiario».
2. Questi soggetti sono spesso valutati meglio come «sistemi di cose» piuttosto
che come «cose».
3. La metafora funziona applicando al soggetto principale un sistema di «implicazioni associate» proprie del sistema sussidiario.
4. Queste implicazioni consistono solitamente di «luoghi comuni» riguardanti il
soggetto sussidiario, ma possono, in casi specifici, consistere di implicazioni
devianti, stabilite ad hoc dallo scrittore.
5. La metafora seleziona, enfatizza, sopprime ed organizza i tratti del soggetto
principale, implicando asserzioni di esso che normalmente vengono attribuite al
soggetto sussidiario.
6. Questo comporta spostamenti nel significato delle parole che appartengono alla
stessa famiglia o sistema dell’espressione metaforica; alcuni di questi spostamenti, anche se non tutti, possono essere traslati metaforici (le metafore subordinate devono comunque essere lette meno «enfaticamente»).
166
M. Black, More about Metaphor, in “Dialectica”, vol. 31, n. 3-4, 1977; trad. it. Modelli Archetipi Metafore, Pratiche Editrice, Parma, 1983.
167
Ivi, pag. 63.
120
7. Non c’è, in generale, nessuna «base» semplice per i necessari spostamenti di significato – nessuna ragione recondita perché una metafora funzioni e un’altra
fallisca.
Black descrive il modello dell’interazione della metafora come non riducibile
ad una parafrasi letterale. A differenza delle primitive e classiche concezioni della metafora, quella della sostituzione o della comparazione (come nella concezione aristotelica) 168 , la teoria dell’interazione identifica il contenuto cognitivo di una metafora con
la sua richiesta di percezione simultanea di due soggetti, il soggetto «principale» e il
soggetto «secondario», con i loro rispettivi sistemi di implicazione. Black ritiene infatti
che l’effettivo funzionamento della metafora si ha quando essa “seleziona, enfatizza,
sopprime, ed organizza caratteristiche del soggetto principale implicando asserzioni di
esso che normalmente attribuiamo al soggetto sussidiario”. Questo vuol dire che, il
successo di una metafora dipende da fecondi e specifici allineamenti o dis-allineamenti
tra gli insiemi di associazioni dei suoi due soggetti. Ragione per cui, semplicemente,
168
Scrive infatti Black che i meriti della concezione interattiva, che sviluppa e modifica le valide intuizioni di I. A. Richards, dovrebbero essere valutati per contrasto con quelli delle uniche alternative esistenti – le tradizionali «concezione sostitutiva» e «concezione comparativa». La concezione sostitutiva
vede «l’intera frase, che è il luogo della metafora, come sostitutiva di alcuni insiemi di frasi letterali»; la
concezione comparativa invece considera la presente parafrasi letterale come affermazione di una somiglianza o analogia, e considera di conseguenza qualunque metafora come una similitudine condensata o
ellittica. Conformemente alla concezione sostitutiva, il focus della metafora, la parola o l’espressione che
ha un chiaro uso metaforico all’interno di un contesto letterale, viene usato per comunicare un significato
che avrebbe potuto essere espresso letteralmente; così in un esempio un po’ sfortunato, «Richard è un
leone» che gli scrittori moderni hanno discusso con noiosa insistenza, il significato letterale è considerato lo stesso della frase «Richard è coraggioso». Scrive ed evidenzia Black «Quali che siano i meriti di
tali speculazioni che riguardano l’atteggiamento del lettore, esse concordano nel fare della metafora un
ornamento. Eccetto che nei casi dove una metafora è una catacresi che rimedia ad alcune temporanee
imperfezioni della lingua letterale, il proposito della metafora è di divertire e di distrarre. Da questo punto di vista, il suo uso costituisce sempre una deviazione dallo «stile piano e strettamente appropriato».
Così, se i filosofi hanno qualcosa di più importante da fare che fare piacere ai loro lettori, la metafora
non può avere un posto serio nella discussione filosofica. L’altro caso invece di spiegazione metaforica,
quella comparativa, considera il significato dell’espressione metaforica simile o analogo a quello del suo
equivalente letterale. Una volta che il lettore ha scoperto ciò che è alla base dell’analogia rappresentata o
della similitudine può risalire il sentiero percorso dall’autore e in tal modo giungere al significato originale. Scrive Black a tale proposito: «Quando Schopenhauer chiamò una dimostrazione geometrica una
trappola per topi voleva dire, in accordo con tale concezione (sebbene non esplicitamente): «Una dimostrazione geometrica è come una trappola per topi, poiché ambedue offrono una ricompensa ingannevole,
adescano a poco a poco le proprie vittime e le conducono ad una spiacevole sorpresa». Precisa inoltre:
«Si noterà che la «concezione comparativa» è un caso particolare della «concezione sostitutiva». Perché
ciò che conta è che un’asserzione metaforica possa essere sostituita da un’equivalente comparazione letterale». La differenza principale fra una concezione sostitutiva e la forma particolare di questa, che ho
chiamato concezione comparativa, può essere illustrata attraverso l’esempio standard «Richard è un leone». Nel primo caso la frase significa approssimativamente lo stesso di «Richard è coraggioso»; nel secondo è approssimativamente lo stesso di «Richard è come un leone (in quanto coraggioso)», dove le
parole aggiunte fra parentesi sono implicite, ma non affermate esplicitamente. Nella seconda traduzione,
come nella prima, si ritiene che l’asserzione metaforica occupi il posto di qualche equivalente letterale.
Ma la concezione comparativa fornisce una parafrasi più elaborata, visto che l’asserzione originale è interpretata come se parlasse tanto di leoni quanto di Richard. Cfr. M. Black, Modelli Archetipi Metafora,
cit., pp. 49-54.
121
parafrasare una metafora (nel senso della concezione comparativa) affermando ‘Giulietta è come il sole’ oppure ‘Giulietta è come… (un esaustivo elenco di proprietà del
sole) non ottiene lo stesso effetto che una semplice metafora può sortire.
I significati estesi che risultano da una metafora non possono così essere né antecedentemente predicati né successivamente parafrasati. Scrive Black a tale proposito:
«La parafrasi letterale dice inevitabilmente troppo e con l’enfasi sbagliata. Uno dei
punti su cui vorrei insistere è che la perdita, in casi simili, è una perdita di contenuto
cognitivo; la più grossa carenza della parafrasi letterale non è costituita dal fatto che
questa possa essere fastidiosamente prolissa o noiosamente esplicita o priva di qualità
stilistiche; essa non riesce come traduzione perché non riesce a dare quel tipo di intuizione che la metafora dava» 169 .
La metafora, ed ecco il punto centrale che ci preme maggiormente evidenziare,
sostiene Black, piuttosto che formulare una somiglianza la crea («la tesi della creatività
forte») 170 ; e ciò che essa è in grado di creare è una nuova visione e una nuova intuizione della realtà. È precisamente in questo che Black riconosce il potere creativo della
metafora ed è questa la ragione per cui egli considera le metafore non come un semplice ornamento ma come strumenti cognitivi veri e propri, indispensabili per instaurare
connessioni che sono veramente presenti, solo quando vengono percepite. Alla domanda “le metafore funzionano sempre da strumenti cognitivi?”, Black risponde, “Io credo
di sì”. Le metafore ci mettono in grado cioè di vedere aspetti della realtà che la creazione della metafora aiuta a costituire e dal momento in cui tali aspetti si sono dati a
vedere divengono parte integrante della realtà, come sua verità e non come semplice
allusione ad essa. E ciò ritiene Black non è poi tanto sorprendente se si crede che il
«mondo» è necessariamente un mondo che cade sotto una certa descrizione – o un
mondo visto da una certa prospettiva. Alcune metafore possono creare tale prospettiva.
L’idea di Black che le metafore abbiano un contenuto cognitivo, additivo, si
traduce quindi nella possibilità di mettere in conto il fatto che le asserzioni metaforiche
possano, cambiando i rapporti tra le cose designate (il soggetto principale e quello sussidiario), generare a volte nuove conoscenze e scoperte, suscitare nuove visioni. Una
visione però, non trascura di evidenziare Black, per quanto mediata, deve essere sempre visione di qualcosa. Il problema è quello di suggerire cosa è quel “qualcosa”, e
quanto il suo possesso possa contribuire all’intuizione di «come sono le cose». Questo
non equivale a chiedersi, come alcuni filosofi sono soliti fare, se le asserzioni metafori169
170
M. Black, Modelli Archetipi Metafore, cit., pag. 65.
Ivi, pag. 128.
122
che siano asserzioni vere, poiché una tale domanda se applicata al discorso metaforico
risulta essere solo una forzatura. La strategia di questi filosofi, scrive Black, «è fuorviante, e tale da indurre distorsioni in quanto richiama l’attenzione su quella speciale
connessione tra asserzione e realtà che noi segnaliamo mediante l’attribuzione del valore di verità» 171 . Ma l’aggettivo “vero” – egli precisa – è più appropriato in quelle situazioni in cui lo scopo principale è quello di esprimere un fatto, cioè in cui l’asserzione in
questione che «esprime il fatto» è associata ad una procedura accettata di verifica o di
conferma. In tal senso, ciò che, secondo Black, si nasconde dietro il desiderio di forzare «il vero» perché si adatti a certi casi, è il riconoscimento che una metafora non superflua non appartiene al regno della finzione e non viene usata, come pretendono certi
autori, per certi misteriosi «effetti estetici», ma realmente «dice qualcosa».
In realtà, Black sostiene che «il riconoscimento invece di ciò che può essere
chiamato l’aspetto rappresentazionale di una metafora forte può essere meglio compreso ricordando altri comuni espedienti per rappresentare «come sono le cose» che non
possono essere assimilati alle «asserzioni sui fatti». Cartine e mappe, grafici e diagrammi pittorici, fotografie e dipinti «realistici», e soprattutto i modelli sono comuni
espedienti di carattere cognitivo per mostrare «come sono le cose», espedienti che non
è necessario percepire come semplici sostituti di un insieme di asserzioni sui fatti. In
questi casi parliamo di correttezza e non correttezza, senza dover ricorrere agli epiteti
troppo sfruttati di «vero» e «falso» 172 . Secondo Black è questa l’indicazione di cui abbiamo bisogno per rendere giustizia degli aspetti cognitivi della metafora, informativi,
e ontologicamente illuminanti delle metafore forti. Tale è l’indicazione che si ricava
dalla concezione interattiva della metafora che postula delle interazioni tra due «sistemi», basate su analogie di struttura (in parte create, in parte scoperte). Gli isomorfismi
che le sono stati attribuiti possono, come abbiamo visto, essere resi espliciti e diventano così i soggetti idonei alla specificazione di appropriatezza, fedeltà, parzialità, superficialità e simili. Si può giustamente ritenere che le metafore che sopravvivono ad un
tale esame critico forniscono, in forma essenziale, profonde intuizioni circa i sistemi a
cui si riferiscono. In tal modo esse possono, e talvolta lo fanno, generare intuizioni su
«come sono le cose» in realtà.
Infine, le metafore, nella visione di Black sono, possiamo dire appropriandoci
dell’espressione usata da Goodman, il quale difende anch’egli una teoria cognitiva del
discorso metaforico, luce della luna; come la luna illuminano e rischiarano la nostra vi171
172
Ivi, pag. 133.
Ivi, pag. 135.
123
sione della realtà e non alludono come invece vuole Davidson, secondo il quale la metafora è il «lavoro del sogno» del linguaggio, la cui funzione non è quella di significare
un «senso» speciale importante da tradurre, ma è quella di sollecitare una «visione»,
cioè di alludere senza significare.
In effetti, c’è ancora da dire che, tra le varie e numerose recensioni critiche che
sono state fatte al lavoro di Black, la più significativa è proprio quella di Donald Davidson il quale, possiamo già evidenziare, oppone a una teoria cognitiva della metafora la
teoria dichiaratamente antitetica cosiddetta letterale o non-cognitiva, della quale un approfondimento sarà ora necessario.
2. 3 Che cosa significano le metafore di Donald Davidson
La tesi centrale sostenuta da Davidson 173 in Che cosa significano le metafore, è
che, strettamente parlando, le metafore non significano niente di più di ciò che significano le parole nella loro interpretazione letterale. In questo senso, se la parafrasi letterale di una metafora non è possibile, spiega Davidson, non è perché le metafore hanno
un contenuto cognitivo determinato, un ‘significato’ metaforico speciale, che non può
essere ricondotto ad una equivalente traduzione letterale, bensì perché nella metafora
non c’è nulla da parafrasare. Scrive a tale proposito: «La concezione che vede la metafora principalmente come un veicolo per trasmettere idee, quantunque inusuali, mi
sembra altrettanto errata quanto l’idea affine secondo la quale le metafore avrebbero un
significato speciale. Concordo con l’opinione che le metafore non possano essere parafrasate, ma penso che ciò sia vero non perché le metafore dicano qualcosa di troppo inconsueto per essere espresso letteralmente, bensì piuttosto perché non c’è in esse niente
da parafrasare. Possibile o no, la parafrasi attiene a quanto vien detto: nella parafrasi, si
tenta di dire lo stesso in un altro modo. Ma, se vedo giusto, una metafora non dice nulla
aldilà del suo significato letterale (né colui che la crea dice, usando la metafora, nulla
che trascenda il letterale). Con ciò, naturalmente, non si nega che una metafora abbia
uno scopo, né che tale scopo possa essere ottenuto usando altre parole» 174 . Non si nega
173
Donald Davidson (1917-2003), allievo di Whitehead e di Quine, ha insegnato in diverse Università
statunitensi, in particolare a New York, a Chicago e a Berkeley. Tra i lavori essenziali: Azioni ed eventi e
Verità e interpretazione.
174
D. Davidson, Che cosa significano le metafore, cit., pag. 137.
124
cioè, come accadeva in passato, che la metafora possa portarci a nuove e importanti
conclusioni cognitive, si nega invece che tali conclusioni appartengano ad essa come
suo contenuto cognitivo additivo, come significato speciale, in aggiunta a quello letterale. Ciò vuol dire che le metafore, a differenza del linguaggio letterale, non sono fenomeni semantici: esse piuttosto sono usate, come indicazioni o fotografie, per attirare
la nostra attenzione a certe caratteristiche del mondo di cui possiamo o non possiamo
essere precedentemente consapevoli. L’obiettivo polemico di questo suo saggio – precisa Davidson – non è infatti quello di mettere in discussione l’effetto che la metafora
può sortire su di noi, per come tale effetto è stato caratterizzato da Max Black, Paul
Henle, Nelson Goodman, Monroe Beardsley, bensì la sua critica s’innesta sul modo in
cui la metafora dovrebbe produrre tali effetti. Tale critica mette avanti invece, come
punto di maggiore incrinatura con le tesi di quei filosofi, la distinzione fra ciò che le
parole significano e ciò per cui vengono usate, poiché, sostiene Davidson, la metafora
appartiene esclusivamente all’ambito dell’uso e non ha nulla a che vedere con il significato. Se un significato alle metafore si vuole attribuire questo può essere solo quello
vincolato al significato originario, letterale delle parole, poiché sia che la metafora dipenda o no da significati nuovi o traslati, certamente essa dipende in qualche modo dai
significati originari; una spiegazione adeguata della metafora deve ammettere che i significati primari e ordinari delle parole rimangono attivi nella loro ambientazione metaforica. Una metafora infatti, sottolinea Davidson, dice solo ciò che esibisce apertamente: di solito una falsità palese o una verità assurda. E questa verità o falsità ovvia
non ha bisogno di parafrasi alcuna: il suo significato è dato dal significato letterale delle parole.
Abbiamo visto che Black sostiene, tra gli altri, che una metafora può comunicare un contenuto cognitivo non-letterale (un significato metaforico speciale) in addizione ad un significato letterale. Egli crede che la chiave per comprendere le metafore stia
nella spiegazione di come questo significato extra sia arrivato al significato letterale di
un’espressione e come si è relazionato ad essa. Davidson ritiene invece che questo progetto si basi su una fondamentale incomprensione circa la natura della metafora e della
sua funzione. Non è utile – egli sostiene – per spiegare come funzionano le parole nella
metafora postulare significati metaforici o figurativi, oppure alcun tipo speciale di verità poetica o metaforica. Idee come queste non spiegano la metafora, ma ne vengono
spiegate. Una volta compresa una metafora, possiamo chiamare «verità metaforica» ciò
che abbiamo afferrato e possiamo dire (entro un certo limite) quale sia il «significato
125
metaforico». Ma collocare semplicemente questo significato nella metafora equivale a
spiegare perché una pillola fa dormire dicendo che ha una vis dormitiva. Detto in altri
termini, analogamente a Black, Davidson è d’accordo nel sostenere che le metafore ci
permettono di arrivare a nuove e importanti conclusioni cognitive, è invece fortemente
in disaccordo con l’idea che queste conclusioni cognitive siano in qualche modo parte
della metafora stessa come qualche significato metaforico. Questo si spiega attraverso
l’archiviazione da parte di Davidson dell’intera categoria del significato metaforico:
non esistono una verità e una falsità metaforiche, poiché il significato cioè il dominio
del vero e del falso sono prerogativa esclusiva del discorso letterale e non di quello figurale. Da questo particolare punto di vista le metafore non “significano” ciò che esse
ci mostrano oppure ci forzano a notare. Esse sono piuttosto strategie della conversazione attraverso le quali queste relazioni tra cose, o aspetti del mondo, vengono messi in
evidenza. Le metafore, in questo senso, più che essere proposizioni che possiedono valore di verità, sono come indicazioni o il disegno di un diagramma. Quando chiediamo
la direzione, non rimaniamo perplessi se qualcuno ci indica la propria destra. Ma, allo
stesso tempo, non confondiamo questo ‘indicare’ con una proposizione portatrice di verità. Non penseremmo che il loro gesto sia vero o falso; piuttosto, sostiene Davidson,
penseremmo che quel gesto diriga la nostra attenzione verso qualcosa che ha un qualche significato. Siamo spinti a credere che dovremmo andare a destra. Questa credenza
può essere vera o falsa, ma il valore di verità non ha alcun legame con il gesto
dell’indicare.
Riprendendo l’esempio già fatto da Black, quando Shakespeare scrive “Giulietta è il sole”, non dovremmo, secondo la concezione di Davidson, pensare che
quest’asserzione contenga un significato extra, non-letterale, seguendo la linea di “Giulietta è come il sole” oppure “Giulietta, come il sole, è centrale, gassosa, brillante, etc.”.
Piuttosto dobbiamo assumere che le metafore ci consentono di notare aspetti di Giulietta e del sole che non avevamo notato prima. L’arrivo cognitivo a questa potenziale novità e agli aspetti sorprendenti del soggetto di Shakespeare non è una proprietà semantica della metafora stessa, ma solo un effetto pragmatico che la metafora produce in
noi. Risulta quindi che per Davidson l’aspetto interessante e importante da evidenziare
sta quindi non nella questione di cosa propriamente significa la metafora, ma nella
“questione di come la metafora è relazionata a ciò che essa ci rende capace di vedere”.
Si tratta, come a questo punto facilmente si può comprendere, di un «vedere come»,
che le metafore condividono con le immagini, e non del «vedere che» che ha invece a
126
che fare con le dichiarazioni del linguaggio letterale. La metafora ci fa dunque vedere
una cosa «come» un’altra mediante una certa asserzione letterale che ispira o stimola
l’intuizione. Allude cioè, ma senza significare, suggerisce una somiglianza che già c’è
e che non è creata con un’allusione metaforica, perché la metafora non ha alcun esercizio veritativo.
Tale concezione viene messa in discussione da Nelson Goodman nel saggio
precedentemente citato Metafora come luce della luna. Egli infatti, diversamente da
Davidson, e in piena sintonia con la tesi di Black, si fa sostenitore dell’idea che la metafora è cognitiva, perché essa dice qualcosa. Sarà interessante quindi vedere con quali
argomenti Goodman confuta la teoria di Davidson in questo breve saggio, e successivamente, sulla base di questo approfondimento, vedere come tale concezione trovi un
campo d’applicazione privilegiato nel mondo delle arti, ovvero di quelle formazioni
simboliche capaci di creare nuovi orizzonti di senso, e di suscitare una nuova visione
del mondo.
2. 4 Metafora come luce della luna di Nelson Goodman
Il breve saggio Metafora come luce della luna 175 è stato scritto da Goodman 176
con l’intento apertamente dichiarato di mettere in discussione la posizione difesa da
Davidson in Che cosa significano le metafore. Nello specifico, Goodman riafferma,
versus Davidson, il valore cognitivo delle espressioni metaforiche. Esse non funzionano come semplici indicatori, ma sono direttamente implicate nella creazione di nuovi
domini di conoscenza. La particolarità e l’importanza che Goodman infatti ascrive alla
metafora è quella di svolgere un esercizio gnoseologico, al pari di tutti gli altri strumenti discorsivi, rispetto ai quali – egli precisa – la metafora è diversa solo per articolazione ma non per funzione. Le metafore possono fornirci una nuova visione della realtà, che, per intenderci, non è la visione allusiva cui fa riferimento Davidson, il «vede175
N. Goodman, Metaphor as Moonlighting, «Critical Inquiry» n. 6, 1979, pp. 125-130 (trad. it di Simona Chiodo (a cura di) in Che cosa è arte, la filosofia analitica e l’estetica, UTET, Torino 2007, pp. 135146), poi in ELGIN C. Z. (a cura di), The Philosophy of Nelson Goodman, vol. IV: Nelson Goodman’s
Theory of Symbols and It’s Applications, Garland, New York 1997, pp. 53-58.
176
Nelson Goodman (1906-1998), interlocutore di Carnap, collega di Quine e allievo di Lewis, ha insegnato presso la Harvard University (Cambridge (Mass.), USA). Tra i suoi studi che sono essenziali per la
filosofia analitica contemporanea, quelli di interesse estetico sono, in particolare, I linguaggi dell’arte,
Vedere e costruire il mondo e Of mind and other matters.
127
re come», ma è un autentico «vedere che», che le asserzioni metaforiche condividono
con il linguaggio letterale. Analogamente ad esso, le metafore possiedono la capacità di
dire la verità.
Questa discussione testimonia la sensazione crescente che la metafora
sia importante e particolare – la sua importanza è particolare e la sua
particolarità è importante – e che la sua collocazione in una teoria generale del linguaggio e della conoscenza abbia bisogno di studio.
L’uso metaforico del linguaggio varia sensibilmente dall’uso letterale, ma rispetto all’uso letterale, non è meno comprensibile, più oscuro, meno pratico e meno vincolato alla verità e alla falsità. Lontano
dall’essere un semplice strumento ornamentale, l’uso metaforico del
linguaggio partecipa pienamente al progresso della conoscenza: nel
sostituire alcune vecchie specie «naturali» con categorie nuove e illuminanti, nel costruire fatti, nell’aggiustare una teoria e nel darci
mondi nuovi 177 .
Davidson, come abbiamo spiegato, nega il carattere veritativo della metafora
perché egli ritiene che le metafore in realtà non abbiano nessun significato additivo,
siano prive di un contenuto speciale. Non esistono, dal suo punto di vista, la verità e la
falsità metaforiche, esistono solo la verità e la falsità letterali. Goodman invece ritiene
che la verità e la falsità siano vincolate sia al «senso» letterale sia al «senso» metaforico. Anzi, precisa Goodman, la particolarità della metafora è che «la verità metaforica è
compatibile con la falsità letterale: una sentenza falsa, se intesa letteralmente, può essere vera se intesa metaforicamente, come nel caso di «il locale è in fermento» o di «il
lago è uno zaffiro». La particolarità viene compresa riconoscendo che l’applicazione
metaforica di un termine è di solito piuttosto diversa dall’applicazione letterale. Applicato letteralmente, il sostantivo «zaffiro» indica vari oggetti, compresa una particolare
pietra, ma non un lago. Applicato metaforicamente indica vari oggetti, compreso un
particolare lago, ma non una pietra. «Il lago è uno zaffiro» è quindi letteralmente falso,
ma metaforicamente vero, mentre «lo stagno fangoso è uno zaffiro» è sia letteralmente
sia metaforicamente falso. La verità e la falsità metaforiche sono distinte l’una
dall’altra – e opposte l’una all’altra – analogamente alla verità e alla falsità letterali. E
«il lago è uno zaffiro» è metaforicamente vero se e solo se «il lago è metaforicamente
uno zaffiro» è letteralmente vero» 178 .
La metafora, secondo Goodman, implica che un termine, o una struttura di termini, venga estratto da un’iniziale applicazione letterale per essere poi applicato in mo177
178
N. Goodman, Metafora come luce della luna, cit., pp. 154 e 155.
Ivi, pag. 155.
128
do nuovo, in maniera tale da produrre un effetto nuovo all’interno dello stesso o di un
diverso regno. Da questo punto di vista la negazione da parte di Davidson del fatto che
le applicazioni metaforiche possano distinguersi dalle applicazioni letterali e che una
proposizione falsa se intesa letteralmente può essere vera se intesa metaforicamente
non fa altro, sostiene Goodman, che generare una grande confusione sull’argomento.
Alla base di questa discussione critica di Goodman vi è l’intento di confutare,
insieme a Black e a chi in generale riafferma il valore cognitivo del discorso metaforico, la concezione che vede la metafora come un mero artificio letterario, un congegno
raro o esotico, esclusivamente decorativo. Non è in quest’ottica che si valorizza la metafora, ma nell’ottica di chi riesce invece a scorgere che la metafora rappresenta una via
particolarmente economica, pratica e creativa di uso dei simboli, poiché introducendo
vecchie parole in nuovi contesti possiamo risparmiare un gran numero di parole e abbiamo il vantaggio di dare il via ad abitudini linguistiche che avviano il processo di trascendimento delle parole. In questo senso egli afferma e conclude che «Nella metafora
i simboli illuminano come la luce della luna» 179 .
Interessante per noi adesso è rilevare che tale concezione della metafora (o del
simbolo) è quella che si riflette nella concezione goodmaniana delle arti, le quali funzionano come simboli veri e propri che hanno un valore gnoseologico analogo a quello
delle scienze. Dicendo qualcosa di vero, un simbolo è una «versione» vera del mondo.
Come bene evidenziato da Simona Chiodo, un simbolo dunque nella concezione di Goodman «è una versione vera di un mondo, perché, in uno scenario gnoseologico costruzionalistico, ciascuna versione vera costruisce il mondo del quale essere vera e, un oggetto d’arte, agendo da simbolo, funziona analogamente a una versione del mondo, costruendo un mondo proprio. Le arti da questo punto di vista non alludono all’esistenza,
ma dicono con saturazione la verità dell’esistenza che costruiscono» 180 .
Questo è quanto, peraltro, chiaramente emerge nell’opera più importante a tal
proposito, vale a dire in I linguaggi dell’arte. Per Goodman, il cui intento principale in
quest’opera è stato quello di impostare – come egli stesso dichiara nell’introduzione –
una teoria generale dei simboli, un quadro, una scultura, una sequenza di suoni musicali
sono simboli. Ora, una caratteristica distintiva dei simboli artistici è che essi sono tipicamente considerati come espressivi: un quadro dai toni grigi con un tema cupo è così
descritto come “triste”, così come triste dovrebbe descriversi una melodia lugubre in
179
Ivi, pag. 159.
S. Chiodo, Visione o costruzione. Nelson Goodman e la filosofia analitica contemporanea, LED, Milano, 2006, pag. 60.
180
129
una tonalità minore. Per Goodman, tale tristezza non è un attributo proprio del simbolo
è invece figurativa o metaforica: nel descrivere il quadro o la melodia come “triste”, noi
trasferiamo un sistema di concetti dal suo regno tipico (gli stati emotivi associati agli
esseri senzienti) dentro un nuovo regno. L’espressività di un’opera d’arte, di conseguenza, non è un attributo dell’opera in quanto tale, ma è semplicemente attribuita
all’opera.
Il tentativo goodmaniano di fornire una spiegazione plausibile dell’espressività
dell’opera d’arte – ed in particolare, della musica – si è incontrato con due tipi di obiezioni. La prima, e più semplice, proviene dai filosofi che hanno sostenuto che il carattere espressivo è parte fondamentale dell’opera stessa: intendendo dire che l’espressività è
una proprietà ineliminabile dell’opera musicale, ad esempio. Quando Goodman ha relegato la tristezza di una melodia al dominio del metaforico, non ha capito la cosa più importante, visto che il proposito della melodia è quello di essere espressiva di qualche
emozione. Diciamo subito che è questa l’obiezione mossa da chi (Budd, Davies, lo stesso Kivy di cui ci siamo già occupati, e per certi versi anche Levinson) riconduce la
spiegazione del problema espressivo a quella che abbiamo definito una risposta “dal
basso”, riporta cioè l’isomorfismo al suo massimo di necessità. Da questo punto di vista
infatti non c’è bisogno di convocare la metafora perché ciò che si dà nell’esperienza
musicale di una determinata persona, e che quindi viene colto in essa, è, in quanto irriducibilmente percettivo (anziché metaforico), impossibile da specificare senza fare riferimento all’oggetto di quell’esperienza, vale a dire, senza fare riferimento alla musica
stessa. Si tratta della percezione di, per avvalerci delle parole di Budd, somiglianze
trans-categoriali tra, da un lato, gli oggetti di una modalità sensoria, e dall’altro lato, gli
stati psicologici “interni” o i tratti esteriori delle manifestazioni comportamentali.
La seconda obiezione a Goodman viene dal filosofo Roger Scruton, il quale ha
notato che l’approccio di Goodman non ha dato spazio all’ambito cognitivo, perché in
realtà i simboli artistici e il valore espressivo loro attribuito sono completamente indipendenti dall’umana cognizione 181 . La teoria estetica di Scruton, nella sua interezza,
richiede invece che l’opera d’arte trovi posto nel regno complesso e mediato dei processi intenzionali. Ci si confronta cioè, in questo caso, con l’obiezione di chi riconduce
il problema espressivo alle dinamiche di una cosiddetta risposta “dall’alto”, e cioè a
complessi processi intenzionali e immaginativi che trascendono la possibilità di una risposta immediata qual è quella che si dà in una dinamica percettiva. Si comprende così
181
Cfr. R. Scruton, Art and imagination: A study in the philosophy of mind, London, Methuen & Co,
pag. 222.
130
il netto rifiuto da parte di Scruton di qualsiasi idea di somiglianza, analogia, isomorfismo tra stati interni e oggetto artistico.
Anticipiamo che si tratta di obiezioni significative a partire dalle quali vedremo
anche, in quest’ultimo capitolo, in che modo una particolare concezione espressiva
venga a influenzare e favorire anche la concezione di come intendere e spiegare le attribuzioni di qualità emotive alla musica. Sono tali descrizioni metaforiche o letterali?
A tal proposito, daremo in primis, prima cioè di prendere in esame le obiezioni sopra
indicate, un approfondimento della concezione metaforica di Nick Zangwill, il quale a
partire dalla riabilitazione pressoché integrale della concezione hanslickiana della musica, della quale è certamente un convinto sostenitore, viene a ribadire l’idea che le nostre descrizioni della musica in termini emotivi non possono essere altro che descrizioni metaforiche, anziché letterali.
131
3. Nick Zangwill: musica, metafora ed emozione
Nell’articolo “Against Emotion: Hanslick was right about music” così esordisce
Zangwill:
Dovremmo comprendere la musica in termini emotivi? Sono
d’accordo con Eduard Hanslick: la risposta è ‘No’. Lasciatemi elencare i modi in cui non si dà alcuna connessione: non è essenziale, per
la musica, il possedere emozioni, lo stimolare emozioni, l’esprimere
emozioni, o il rappresentare emozioni. La musica, in se stessa, non ha
nulla a che fare con le emozioni. Questa tesi negativa è ristretta alla
musica strumentale o assoluta. […] Dimostrerò che Hanslick aveva
ragione nel condurre la sua critica negativa alle teorie emotive letteraliste della musica 182 .
Come emerge chiaramente in questa citazione, per Zangwill 183 non è vi è dubbio che la musica assoluta non ha alcun tipo di relazione con l’emozione. Questa è
l’idea che egli viene a riaffermare, a partire, non possiamo più far finta di non notare,
da una lettura della tesi di Hanslick come una tesi che inclina e recide qualsiasi legame
della musica con le emozioni. Lettura il più delle volte accreditata nell’attuale dibattito
(eclatante è il caso di Kivy), ma che non restituisce e non tiene adeguatamente in considerazione, dal nostro punto di vista, la complessità che agisce invece al fondo della
riflessione hanslickiana sulla musica. È vero che Hanslick ha dichiarato che le nostre
descrizioni della musica in termini emotivi debbono essere intese metaforicamente, ma
tale dichiarazione dovrebbe essere inquadrata più nell’ottica di una volontà di liberare
la musica dall’ingombrante fardello delle impressioni soggettive dell’ascoltatore, che
non invece nel tentativo dissacratorio di negare tout court una dimensione espressiva
alla musica. In tal senso, ci chiediamo infatti come ci si confronta con le seguenti affermazioni di Hanslick: «la musica è spirito che si plasma interiormente» 184 , «il comporre è un lavoro dello spirito su un materiale spiritualizzabile» 185 , o ancora «la musica
ha un contenuto, sebbene sia musicale, in quanto scintilla del fuoco divino non inferio182
N. Zangwill, Against Emotion: Hanslick was right about music, “The British Journal of Aesthetics”,
Vol. 44, No. 1, 2004, pp. 29-43.
183
Nick Zangwill è un filosofo britannico contemporaneo molto attivo nel campo della filosofia analitica. Egli insegna alla University of Durham (UK), dove tiene corsi in estetica, teoria della conoscenza e
etica. In ambito estetico, egli si è occupato prevalentemente di proprietà estetiche, espressività musicale
e creatività artistica. La sua posizione su tali questioni è etichettabile, per sua stessa ammissione, come
‘formalismo moderato’. I suoi principali riferimenti ‘continentali’ sono Kant e Hanslick. Il suo pensiero
estetico è ampiamente approfondito in sue due opere principali: The Metaphysics of Beauty (Cornell
University Press, 2001) e Aesthetic Creation (Oxford UP, 2007).
184
E. Hanslick, Il bello musicale, cit., pag. 65.
185
Ivi, pag. 66.
132
re alla bellezza di ogni altra arte. Ma solo negando inesorabilmente alla musica ogni altro “contenuto”, se ne salva il contenuto spirituale. Infatti non con il ricorrere a un sentimento indefinito – in cui, nel migliore dei casi, consiste il contenuto – si può attribuirle un significato spirituale, ma riconoscendo la bella e ben definita forma sonora come
creazione dello spirito, compiuta su un materiale atto a essere spiritualizzato» 186 .
Ad ogni buon conto, muovendosi da siffatta interpretazione, Zangwill viene a
porsi in netta rottura con la posizione dei cosiddetti teorici “letteralisti”, i quali ipotizzano, al contrario, che tra la musica e le emozioni vi sia una relazione di qualche tipo.
Non esageriamo se diciamo che tutta la disamina offerta da Zangwill in questo articolo
è improntata proprio sul voler dimostrare come per l’appunto nessuna delle relazioni
ipotizzate dai “letteralisti” possa sussistere tra la musica e le emozioni. Questo è quanto
peraltro, viene fuori con maggior vigore e chiarezza in un articolo successivo, Music,
Metaphor and Emotion, che è quello cui, volgeremo l’attenzione, essendo questo il
luogo teorico in cui Zangwill affronta diffusamente la tematica di come spiegare le nostre descrizioni della musica in termini emotivi.
Punto di avvio dell’indagine in questo articolo è l’ovvia constatazione di quello
che egli definisce il “fatto inconfutabile – indiscutibile” (The Indisputable Fact), sul
quale siamo pressoché tutti d’accordo, e cioè che spesso diamo descrizioni della musica in termini emotivi. Il problema è però come comprendere questo, e cioè in che senso
diciamo, ad esempio, che un brano di musica è triste, malinconico, allegro, ecc. Sono
queste descrizioni letterali o metaforiche? Due sono qui, precisa Zangwill, le questioni
in gioco, reciprocamente connesse: da una parte quella della descrizione linguistica
della musica e dall’altra la questione che riguarda da vicino la natura della musica.
Sullo sfondo il problema centrale, stabilire cioè se tra la musica e un’emozione possa
esservi una qualche essenziale relazione.
Se si adotta un’ottica di tipo letterale tali descrizioni sono da intendersi letteralmente. Da questo punto di vista, infatti, certamente deve esservi una qualche relazione tra la musica e un’emozione reale: esempi importanti di tali teorie, riconosciute
anche come teorie dell’emozione, sono secondo Zangwill, quelli di chi ritiene che la
più importante funzione della musica deve essere quella di esprimere emozioni, eccitare emozioni, oppure rappresentare emozioni 187 . All’opposto, se si adotta una prospet186
Ivi, pag. 118.
Per quanto concerne da vicino la prima tesi, e cioè che la musica debba esprimere emozioni, il riferimento è in particolare a quanto sostenuto da Aaron Ridley, nell’opera Music, Value, and the Passions e a
Dereck Cooke, in The Language of Music; mentre per un esempio di Arousal Theory, come possiamo
facilmente comprendere oramai da quanto abbiamo appreso nel precedente capitolo, Zangwill, non può
187
133
tiva non-letterale, tali descrizioni sono invece considerate tipicamente metaforiche,
poiché la musica in se stessa non ha nulla a che vedere con un’emozione reale.
Per chi, come Zangwill, è dell’idea che le emozioni siano dimensione distintiva
dell’umano, chiaramente una prospettiva di tipo letterale non può che rivelarsi fallace,
nonché facile preda di obiezioni. Ancora prima infatti di ipotizzare la possibilità che tra
la musica e le emozioni vi sia una qualche relazione, è necessario un esame preliminare
della natura di un’emozione. Il più delle volte, sospetta Zangwill, le difficoltà e i problemi derivano tutti dal fatto che non si ha un’univoca e chiara definizione del concetto
di emozione. Un’emozione, riportandosi anche in questo caso all’ipotesi intenzionale di
Hanslick, è uno stato mentale della persona, che ha sia carattere che contenuto qualitativo, vale a dire: un’emozione è essenzialmente posseduta da una persona, è circa qualcosa, ed è sentita. Emozioni quali paura, collera e orgoglio sono possedute dalle persone, esse sono a proposito di qualcosa, sono sentite in un certo modo, e sono collegate
necessariamente ad alcune credenze. Se qualcuno quindi applica la parola emozione a
qualcosa che è privo di queste caratteristiche, allora quell’uso è probabilmente metaforico o perlomeno è un uso esteso del termine. Solo un pazzo o un illuso può pensare
che le cose stiano diversamente.
In altri termini, si può secondo Zangwill pervenire a delle soluzioni plausibili,
fermandosi a riflettere attentamente sulla natura della musica, che come molti altri hanno evidenziato, non è un essere senziente, e sulla natura delle emozioni. Questo è quanto certamente non è stato fatto dai “letteralisti”, i quali, evidenzia Zangwill, ingenuamente hanno invece trascurato il fatto che:
a) descriviamo anche la natura in termini di emozioni. Per esempio, parliamo di
rocce orgogliose, fiori timidi, nuvole minacciose, etc. Dovremmo ipotizzare allora anche in questi casi che vi sia una qualche significativa relazione tra un’emozione reale,
quale ad esempio, la malinconia, e le nuvole? Viste così le cose, spiega Zangwill, è
chiaro che non può esserci nessun legame generale tra le prevalenti descrizioni in termini emotivi e il possesso, l’espressione, oppure la rappresentazione dell’emozione,
perché le cose naturali inanimate chiaramente non possono possedere, esprimere o rappresentare emozioni. Tuttavia non si esclude la possibilità che anche la natura comunque possa suscitare emozioni. In ogni caso, egli avverte, dovremmo essere cauti nel postulare emozioni corrispondenti alle descrizioni in termini di emozioni.
che rinviare all’opera di Derek Matravers, Art and Emotion; come esempio invece di una teoria rappresentazionale cita la tesi sostenuta da Langer in Philosophy in a New Key.
134
b) Descriviamo anche altri tipi di opere d’arte, oltre che la musica, in termini di
emozioni. Siamo infatti soliti fornire descrizioni in termini emotivi anche di sculture e
di quadri astratti, possiamo cioè parlare di colori gioiosi di un quadro oppure di forme
minacciose di una scultura. A tal proposito Zangwill, come già in precedenza hanno
fatto anche Kivy e Matravers, riconosce che una cosa è parlare delle arti che non hanno
nessun contenuto rappresentativo, altra è in qualche modo parlare delle arti che hanno
qualche contenuto rappresentativo, in quanto – precisa Zangwill – nel caso delle arti
rappresentazionali, il motivo per cui le descriviamo in termini emotivi è ben diverso,
visto che in tali arti abbiamo a che fare con delle persone che sono rappresentate come
aventi un’emozione oppure con situazioni che sono rappresentate in un modo da invitare ad una risposta emotiva. Ma, ed ecco l’altro motivo per cui non c’è nessuna ovvia
ragione per sostenere le tesi letterali, ci dice Zangwill, diamo anche descrizioni in termini emotivi di quadri astratti e sculture che non dipendono dalla rappresentazione.
Dunque non è evidente che la musica si differenzi dalle altre arti sotto questo aspetto.
c) Molti presumono che sia condivisibile affermare che la musica ha proprietà
“espressive”. In linea di principio, spiega Zangwill, questo pensiero è condivisibile se
alla base vi è l’idea che la musica è appropriatamente descritta in termini di emozioni,
poiché questo non coincide già con l’asserzione perentoria che vi sia un legame tra la
musica e un’emozione reale. Il problema, ravvisa Zangwill, sta invece nel fatto che asserendo che la musica ha proprietà espressive, in realtà spesso si aspira a dire molto di
più. E, precisamente, si dice qualcosa di controverso e discutibile se la parola “espressivo” viene usata per indicare che le descrizioni in termini di emozioni si riferiscono a
stati mentali emotivi 188 . Il letteralismo è dunque un modo inadeguato di guardare al
problema. Anzi, Zangwill sostiene, è un modo ingenuo, che possiamo tollerare se viene
adottato dalle persone comuni, ma non se a pensarla così è un teorico della musica. È
assolutamente inverosimile che un esperto di musica possa spingersi a credere che
quelle descrizioni siano indicative del fatto che la musica è in relazione con
un’emozione reale.
Sarà necessario dunque portarsi oltre questa visione dimostrando che in realtà le
descrizioni della musica non sono da intendersi quali descrizioni letterali, bensì come
descrizioni metaforiche delle proprietà estetiche della musica. Anticipiamo, che è questa la cosiddetta tesi della metafora estetica difesa da Zangwill. In tal senso, Zangwill
introduce tutta una serie di argomenti con l’intento di dimostrare il valore positivo di
188
N. Zangwill, Music, Metaphor, and Emotion, cit., pag. 392.
135
un’ottica non-letterale. Uno di questi argomenti è quello che egli definisce della parità
(the parity argument) e si basa sulla considerazione che:
Diamo molte descrizioni della musica (e del modo in cui la musica
suona) che non sono descrizioni in termini di emozioni, ma che sono
anch’esse ovviamente metaforiche 189 .
Poniamo, per esempio, il caso di quando descriviamo la musica come “delicata”
o “bilanciata”. Qui, evidenzia Zangwill, nessuno si spinge a dire che le parole servono
a riferirsi a qualche emozione con la quale la musica è connessa. (Sentimenti delicati?
Sentimenti sbilanciati/non-bilanciati? Certamente no). Quasi con una punta di ironia,
egli si diverte a sottolineare che qualcosa di esteticamente delicato non deve di necessità essere a rischio di rottura, e, che qualcosa che è esteticamente bilanciato non deve di
necessità avere una eguale distribuzione di peso tra le sue parti. Perciò questi utilizzi di
“delicato” e “bilanciato” non possono, chiaramente, essere altro che metaforici. A sostegno di questa tesi, Zangwill chiama in causa Scruton 190 , il quale anch’egli, seguendo
Victor Zuckerkandl 191 , ha sottolineato il fatto che le descrizioni della musica in termini
di altezza e movimento sono metaforiche. Si tratta, anche in questo caso, si può riscontare, di descrizioni che designano comunque il carattere espressivo della musica senza
però ricorrere a concetti che chiamano in causa la nostra vita emotiva, concetti la cui
applicazione resta sempre e comunque, secondo la spiegazione di Zangwill, metaforica.
Tali descrizioni della musica in termini non-emotivi dovrebbero essere tenute in considerazione dai filosofi della musica tanto quanto le descrizioni emotive. Se pensiamo
che le descrizioni della musica in termini di “delicatezza”, “bilanciamento”, “altezza” e
di “movimento da una nota all’altra” sono chiaramente metaforiche, dobbiamo allo
stesso modo presumere che anche le principali descrizioni della musica in termini emotivi siano altrettanto metaforiche. Non si capisce invece perché tendiamo a fornire spiegazioni diverse nell’uno e nell’altro caso, quando sarebbe invece auspicabile che si
desse una spiegazione unica che valga per tutte le suddette descrizioni. Chiaramente
riusciamo a scorgere quanto, in queste affermazioni, incida con forza il pensiero di
Hanslick, il quale per dimostrare la tesi che le descrizioni emotive della musica sono
metaforiche si è appellato, diciamo così, al criterio della sostituibilità di siffatte descri-
189
Ibidem.
R. Scruton, “Understanding Music”, in The Aesthetic Understanding, Manchester: Carcanet, 1983;
The Aesthetic of Music, Oxford University Press, 1997, cap. 1, 2.
191
V. Zuckerkandl, Sound and Symbol, Prometheus, New York, 1956.
190
136
zioni: per descrivere la musica attingiamo spesso anche a concetti tratti da altre sfere
che non sono quelle del mondo emotivo dell’uomo, concetti che con facilità siamo portati a qualificare come metaforici, piuttosto che come letterali. Un’idea, quella della sostituibilità, che Zangwill condivide in pieno, dal momento che, e questo è un punto certamente importante da evidenziare, il riconoscimento del valore metaforico delle descrizioni emotive della musica funziona qui come indebolimento drastico del rapporto
musica-emotività, se è vero che descrivere emotivamente la musica è solo una possibilità tra le tante disponibili per avvicinarsi allo specifico musicale. Un indebolimento
che si può evidenziare anche se prestiamo attenzione alla cosiddetta tesi dell’intreccio o
interconnessione (the interweaving thesis), vale a dire:
Le descrizioni della musica in termini emotivi sono intimamente connesse con altre descrizioni che sono chiaramente metaforiche – in
particolare, spesso le descrizioni in termini di emozioni sono fornite
sulla base di descrizione in termini non emotivi che sono chiaramente
metaforiche, e viceversa 192 .
Per esempio, possiamo dire di un brano di musica che è sereno perché esso è
delicato. Tuttavia se queste descrizioni in termini non-emotivi non possono evidentemente che essere considerate se non come metafore, sarebbe strano considerare diversamente le descrizioni in termini emotivi. Ciò che si vuole evidenziare è che l’uso delle
metafore dell’emozione in musica è spesso strettamente connesso con l’uso di altre metafore e non può essere compreso senza di esse. L’esempio può essere: La musica arrabbiata (angry) è solitamente violenta (violent) o scabrosa (jagged).
Nell’arco di queste argomentazioni possiamo constatare come Zangwill parli di
descrizioni metaforiche rinunciando a precisare quali siano i criteri per stabilire cosa è
che consente di qualificare una descrizione come metaforica piuttosto che letterale. In
realtà, dal suo punto di vista, una spiegazione di questo tipo non è necessaria; si può infatti comodamente evitare di dare un ragguaglio generale di cosa sia una metafora,
mentre, come avevamo anticipato, è necessario fornire criteri specifici per poter distinguere gli usi metaforici e non metaforici dei termini che denotano emozioni. E il criterio cui appellarsi per stabilire se la parola emozione è usata metaforicamente senza dover dipendere da una controversa teoria generale della metafora, sappiamo, è quello che
si può reperire chiarendo cosa è un’emozione.
192
N. Zangwill, Music, Metaphor, and Emotion, cit., pag. 392.
137
Questo è quanto chiaramente potrebbe emergere confrontandosi, sostiene Zangwill, anche con una tesi dichiaratamente letterale delle descrizioni emotive della musica. Si tratta della tesi di Stephen Davies, per il quale, come meglio avremo modo di
verificare in un approfondimento successivo, le descrizioni della musica, come “triste”,
“delicato”, e “alto”, non sono metaforicamente, bensì letteralmente applicate alla musica 193 . Ciò che hanno in comune tali metafore è il fatto di essere familiari, dei veri e
propri cliché. Per tale ragione, c’è la comprensibile tentazione di pensare che esse siano
metafore morte, ovvero che esse, essendo divenute familiari, cessano di essere metafore e diventano espressioni letterali (usando a sua volta una metafora, Zangwill dice che
esse, morendo come metafore, approdano al paradiso dei termini letterali). Riprendendo i termini che abbiamo introdotto nella sezione dedicata ai testi seminali, potremmo
dire, che l’uso di tali termini ha esaurito l’originaria contraddizione fra significato letterale falso e significato metaforico vero. Nel tempo cioè quelle che originariamente riuscivamo a riconoscere distintamente come metafore sono diventate vere e proprie asserzioni letterali al pari di molte altre. Secondo Zangwill, in realtà, tale tesi non è plausibile se si tiene adeguatamente in considerazione il fatto che queste descrizioni sono
dello stesso tipo di quelle nuove che possiamo coniare per descrivere la musica, le quali – aggiunge – sono chiaramente metaforiche. Così scrive:
Ad esempio, non ricordo di aver sentito le seguenti descrizioni della
musica, ma posso pensare a una musica che vorrei chiamare “sconvolta”, “crudele”, “titubante”, “nervosa”, “insistente”, “vibrante”, e
così via 194 .
Anche questi nuovi termini in realtà sono metaforici, così come lo sono quelli
che costituiscono le cosiddette metafore morte: non vi è alcuna differenza tra le prime
descrizioni e le seconde. Per tale ragione anche in questo caso è auspicabile, secondo
Zangwill, dare una spiegazione unitaria dei due tipi di descrizione. Egli ritiene infatti
che tali ‘nuove’ metafore (nuove in quanto inedite) siano dello stesso tipo delle descrizioni cliché della musica come “triste”, “delicata”, e “alta”.
Ma soprattutto, Zangwill sottolinea una volta di più il fatto che, al di là della
questione se i termini che denotano emozioni usati per descrivere la musica siano metafore o metafore morte, tali termini comunque non descrivono stati che hanno le caratte193
S. Davies, Musical Meaning and Expression, cit, pp. 162-165; vedi anche Leo Treitler, “Language
and the Interpretation of Music”, in Music and Meaning, ed. Jenefer Robinson, Cornell University Press,
1993.
194
N. Zangwill, Music, Metaphor, and Emotion, cit., pag. 393.
138
ristiche essenziali delle emozioni. Ecco perché anche se Davies avesse ragione, e se
quindi alcune descrizioni della musica in termini di emozione fossero metafore morte,
ovvero descrizioni dotate di un senso letterale secondario, ciò non cambierebbe comunque le cose, visto che anche in questo caso le descrizioni della musica in termini di
emozioni non si riferirebbero a stati mentali realmente emotivi – ovvero, a stati che una
persona ha, che hanno un contenuto intenzionale, che hanno un carattere qualitativo, e
che sono organizzati in dei precisi modi – che le parole, considerate nel loro senso letterale primario, suggerirebbero. Da questo punto di vista Zangwill ritiene che una teoria delle descrizioni in termini di emozioni in quanto metafore morte è classificabile in
realtà più come una teoria non-letterale, visto che chiama in causa dei significati secondari non riferibili alle emozioni reali. Per tale ragione Zangwill arriva a concludere
che tutto sommato una teoria della metafora morta può bene accordarsi con la sua teoria metaforica. Egli dice:
Personalmente ammetto che un utilizzo letterale dei termini che denotano emozioni implica che essi vengano riferiti a degli stati mentali
emotivi o a qualcosa che stia in una qualche relazione con stati mentali emotivi. Il punto della questione è se le descrizioni della musica
in termini emotivi facciano effettivamente riferimento a tali stati. Fin
qui abbiamo visto che ci sono alcune ragioni per pensare che tale riferimento non sussista 195 .
Il più delle volte, spiega Zangwill, facilmente ci si può rendere conto del modo
in cui il problema delle descrizioni linguistiche della musica sia in relazione con la
questione riguardante la natura della musica. Nello specifico, il letteralismo, se è vero,
ha come implicazione, per ciò che riguarda la natura della musica, che essa sia in qualche modo collegata alle emozioni. E, in tal senso, dunque il letteralismo si connette alle
teorie dell’emozione. Al contrario, il non-letteralismo, per come è stato caratterizzato,
incoraggia fortemente una concezione non-emotiva. Se cioè le descrizioni in termini
emotivi non si riferiscono realmente alle emozioni, allora è chiaro che la natura della
musica non ha nulla a che vedere con le emozioni. Non sempre però, tiene a precisare
Zangwill, i confini sono così nitidamente delineati. Questo è infatti il dato che emerge,
diciamo così, in teorie più complesse, tali in quanto in esse sembrerebbe profilarsi la
possibilità di combinare una tesi non-letterale con una teoria delle emozioni. Si tratta di
quelle che Zangwill definisce teorie intenzionali delle emozioni, nelle quali vi è in gio-
195
Ivi, pag. 394.
139
co l’ipotesi che la musica non sia in realtà relazionata ad un’emozione quanto piuttosto
a pensieri sulle emozioni (thoughts about emotions). In una prospettiva di questo tipo
egli annovera rispettivamente le tesi di Scruton e Levinson, i quali entrambi fanno appello alle emozioni immaginate durante l’ascolto di musica. Da questo punto di vista –
egli spiega – un’emozione immaginata è un pensiero sull’emozione che non è una credenza. Sembrerebbe dunque che, sebbene non in un’accezione piena, anche in questi
casi vi sia il riferimento ad un’emozione. Eppure – evidenzia Zangwill – per Scruton le
descrizioni della musica in termini emotivi non debbono essere considerate letteralmente, piuttosto metaforicamente. Il problema destabilizzante sembra qui essere per
Zangwill quello di chiarire e stabilire se un’emozione immaginata è oppure non è
un’emozione vera e propria, poiché sono questi, e non altri, come abbiamo finora puntualmente verificato, i criteri di cui egli si avvale per stabilire quali sono i precisi confini tra teorie letterali e teorie metaforiche. Scrive infatti a tale proposito: «Non è chiaro
se queste teorie dovrebbero essere classificate come teorie emotive, dato che esse non
chiamano in causa emozioni reali, ma solo dei pensieri ad esse relativi. Non è così importante fare questa classificazione. Tuttavia, la combinazione del letteralismo con una
teoria intenzionale dell’emozione può creare confusione: se nell’esperienza della musica sono coinvolti dei pensieri relativi alle emozioni, di sicuro potremmo attenderci che
le descrizioni linguistiche della musica significhino letteralmente le emozioni a cui i
pensieri si riferiscono in tali esperienze» 196 .
Per chi come Zangwill si trova in sintonia con una concezione dichiaratamente
formalista, le descrizioni della musica in termini emotivi possono intendersi solo come
descrizioni metaforiche delle proprietà estetiche della musica 197 . Tali proprietà esteti196
Ibidem.
È il caso di specificare, seppure senza poter dare un certo approfondimento della questione, che la tesi
della metafora estetica può essere meglio compresa laddove si tiene in considerazione la concezione che
Zangwill ha delle proprietà estetiche, che è, dico subito, una concezione realista. Si tratta però di una
forma di realismo temperato. Come infatti spiega a tale proposito Matteucci, in un saggio dedicato specificamente alle proprietà estetiche, «Zangwill amplia la base di subvenienza anche alle proprietà non sensoriali senza con ciò rinunciare al rapporto di dipendenza tra estetico e percettivo, riconoscendo al tempo
stesso che il peso delle proprietà sensoriali varia nelle diverse arti. La ‘dipendenza debole’ che ne deriva
viene così formulata da Zangwill: «le proprietà sensoriali sono necessarie per le proprietà estetiche, non
sufficienti. Accettare una tesi di dipendenza debole è compatibile con l’ammettere che anche altri fattori
sono necessari. Ma la tesi debole implica comunque che senza proprietà sensoriali non ci sarebbero proprietà estetiche». Cfr. Aesthetic/Sensory Dependence, “The British Journal of Aesthetics”, 38, 1, 1998,
pp. 66-81. È quindi una tesi che vincola le proprietà estetiche alla dimensione percettiva, senza tuttavia
risolverle completamente in essa. Cfr. G. Matteucci, Le proprietà estetiche, in Introduzione all’estetica
analitica, cit. pag. 103. Detto in altri termini, la forma di realismo difesa da Zangwill vede sul tappeto
l’ipotesi che le caratteristiche (che vengono) attribuite attraverso i predicati dei giudizi estetici sono proprietà estetiche, proprietà ‘emergenti’ rintracciabili negli oggetti, proprietà che dipendono dalle proprietà
di primo-livello degli oggetti, e (sostiene) che l’apprezzamento estetico di un oggetto consiste
nell’acquisizione della conoscenza delle sue proprietà estetiche attraverso una normale attività percettiva
197
140
che comprendono la bellezza, l’eleganza, la delicatezza, e possono essere descritte solo
metaforicamente. La descrizione in termini emotivi non è dunque una descrizione che
rinvia a qualche emozione esperita o trasferita, bensì alle proprietà estetiche che appartengono alla musica stessa. A tale proposito, precisa infatti Zangwill, se la tesi della
metafora estetica è corretta, «essa suggerisce con forza che non si verifica nulla di genuinamente emozionale che sia in qualche modo rilevante, né nella creazione immediata, né nella ricezione immediata della musica. Ovviamente, le emozioni possono talvolta svolgere un ruolo se le consideriamo come le cause più remote dell’attività creative,
e le emozioni possono talvolta figurare tra i più lontani effetti dell’esperienza della musica. Ma ciò è filosoficamente poco interessante. L’esperienza musicale e la creazione
musicale primarie non comportano affatto il coinvolgimento delle emozioni. Per ‘esperienza musicale primaria’ della musica io intendo l’esperienza di una certa musica, e
per ‘creazione musicale primaria’ io intendo il pensiero creativo relativo alla musica e
che fa nascere la musica stessa 198 .
Per rafforzare l’indipendenza della musica dalle emozioni, Zangwill respinge
anche la concezione ‘moderata’ di chi, come Jenefer Robinson, sostiene che la musica
sia in grado di suscitare nell’ascoltatore solo un certo tipo di emozioni: vale a dire, le
emozioni che sono prive di un contenuto intenzionale, e che Robinson chiama “viscerali”. Una di queste emozioni è quella dell’eccitamento. Secondo Zangwill, è plausibile
usare questo termine per descrivere alcuni passaggi della Quinta Sinfonia di Shostakovich; così come è possibile che, nell’ascoltare tali passaggi, noi ci sentiamo realmente
eccitati, nel senso inteso da Robinson. Tuttavia, precisa Zangwill, la prima asserzione
non deriva dalla seconda. Noi non descriviamo la musica come ‘eccitante’ per il fatto
che il suo ascolto ci provoca la sensazione di eccitamento, ma per il fatto che “udiamo”
affiancata dall’esercizio della ‘percezione estetica’, ovvero del ‘gusto’. Ora, interessante per noi è evidenziare che in antitesi con la concezione realista delle proprietà estetiche difesa da Zangwill troviamo la
concezione antirealista di Scruton. Scruton in realtà non insiste più di tanto sulla forza persuasiva
dell’argomento antirealista che rivolge direttamente contro questa teoria, si accontenta piuttosto di sottolineare la particolare natura delle qualità emozionali (e affettive) delle opere d’arte, che egli, seguendo
una consuetudine consolidata, è lieto di descrivere come qualità ‘terziarie’. Posto che non vi siano caratteristiche di livello-inferiore e normalmente percepibili di fronte alle quali una persona che non percepisce una proprietà estetica di un certo oggetto è per tal motivo cieco, si può comprendere come Scruton
colleghi la ‘percezione’ di una proprietà estetica alla percezione delle apparenze (o aspetti), ovvero al
‘vedere-come’ (essendo le apparenze i paradigmi delle qualità terziarie). La sua posizione può essere
dunque così riassunta: sentire la tristezza della musica non è una questione che riguarda un sentire che,
ma (riguarda) un sentire come − sentire la musica come triste. Si tratta di una forma di sentire/udire immaginativo. Quello delle proprietà estetiche è un problema centrale nell’attuale discussione, e per certi
versi legato alla questione dell’espressività, cui non abbiamo dedicato una specifica attenzione per limiti
di spazio e per salvaguardare l’unità della trattazione. Per un approfondimento rinviamo in questo caso
alla lettura dell’articolo di Malcolm Budd, Aesthetic Realism and Emotional Qualities of Music, “The
British Journal of Aesthetics”, 45, 2005, pp. 111-122.
198
N. Zangwill, Music, Metaphor, and Emotion, cit., pp. 394-395.
141
l’eccitamento nella musica, ovvero percepiamo in essa la proprietà estetica
dell’eccitamento, da sola o, più probabilmente (come implicato dalla tesi
dell’intreccio), in congiunzione con altre proprietà estetiche (come l’essere ‘tumultuosa’, ‘stridente’, aggressiva’, e via dicendo). L’eccitazione di cui parla Robinson segue
tale percezione, e non la precede; inoltre essa può darsi come può non darsi (non è una
conseguenza necessaria del nostro udire la proprietà dell’eccitamento nella musica).
Con ciò Zangwill ribadisce una volta di più che le nostre descrizioni della musica in
termini emotivi dipendono dalla rilevazione di proprietà estetiche presenti nella musica, piuttosto che dal nostro provare determinati stati d’animo.
Questo tuttavia non vuol dire che Zangwill intenda l’esperienza della musica
come un’esperienza asettica, fredda e distaccata. È infatti incontestabile il fatto che la
musica, in particolare la grande musica, ci procuri un’esperienza speciale, intensa, gratificante: in una parola, piacevole. Di che tipo di piacere si tratta? Muovendosi su una
linea già tracciata da Hume e Kant, Zangwill precisa che si tratta di un tipo di piacere
particolare, sia per quanto riguarda la sua natura − il piacere che l’ascolto della grande
musica ci procura è tale da portarci in uno stato di totale assorbimento, rapito ed estatico −, sia per ciò che concerne le cause che ne sono alla base. Il piacere estetico è infatti
legato alla percezione della bellezza della musica, la quale è una proprietà superiore a
tutte le altre proprietà estetiche ‘sostanziali’ (come l’essere una musica ‘eccitante’,
‘bramosa’, ‘appassionata’, ‘arrabbiata’, e via dicendo), dalla cui combinazione (“intreccio”) deriva per l’appunto la qualità della bellezza − secondo una visione piramidale delle proprietà estetiche messa a punto dallo stesso Zangwill in The Beautiful, The
Dainty and the Dumpy 199 . Pertanto, come, dal punto di vista metafisico, la bellezza deriva dalle proprietà estetiche sostanziali, così, dal punto di vista esperienziale, il piacere
associato alla percezione della bellezza deriva dalle diverse reazioni estetiche associate
alle percezione delle suddette proprietà estetiche. Tali reazioni non sono, vale la pena
ricordarlo, necessariamente delle emozioni: quando ascoltiamo una musica descrivibile
come ‘arrabbiata’, noi non diveniamo per forza arrabbiati (mancando l’oggetto intenzionale di una siffatta emozione, come potrebbe essere qualcuno che ci sta offendendo), ma reagiamo esperienzialmente alla percezione, nella musica, di una siffatta proprietà, che descriviamo metaforicamente come ‘arrabbiata’. Se poi siamo fortunati, la
musica è meravigliosamente arrabbiata e l’ascoltarla ci procura un grande piacere. Non
si può non rilevare come qui la teoria di Zangwill ricalchi quella di Kivy, il quale in
199
Zangwill, The Beautiful, the Dainty and the Dumpy, “The British Journal of Aesthetics”, 35, 1995,
pp. 317-329. Vedi anche Id., The Metaphysics of Beauty, Cornell University Press, Ithaca, 2001.
142
maniera del tutto simile, come abbiamo già avuto modo di vedere, sostiene che la musica ci procura un particolare sentimento di eccitazione (estasi, direbbe Zangwill)
quando è, ad esempio, splendidamente malinconica, il che vuol dire che non solo possiede la proprietà della malinconia, ma la incarna in una maniera che è musicalmente
bella 200 .
200
Vedi Kivy, Feeling the musical emotions, cit. L’eccitazione di cui parla qui Kivy non è l’eccitazione
‘viscerale’ della Robinson (la quale usa tale termine per descrivere un sentimento simile a quello che
proviamo al termine di una corsa), ma è vicino all’estasi di cui parla Zangwill (Kivy afferma infatti che il
termine ‘eccitazione’ non è nemmeno adeguato a descrivere il sentimento che proviamo di fronte alla
bellezza della musica, che a ben vedere è un sentimento privo di un nome specifico).
143
4. Roger Scruton: immaginazione e metafora
Nella riflessione musicale di Roger Scruton 201 , due sono i termini fondanti e
imprescindibili: l’immaginazione che è la facoltà che rende possibile il costituirsi
dell’esperienza dell’ascolto musicale, e il regime metaforico come modalità descrittiva
della musica. Partiamo dal primo dei due termini, e vediamo in che modo esso viene
introdotto dal filosofo inglese nei suoi scritti riguardanti la filosofia della musica.
Scruton distingue nettamente il regno dei suoni fisici dal regno della musica.
Non si tratta di una differenza meramente quantitativa o di grado, bensì è in gioco un
vero e proprio salto qualitativo. I suoni sono parte del mondo naturale, sono fenomeni
‘trovati’, per così dire, mentre la musica coinvolge la sfera dell’intenzionalità e
dell’immaginazione umana.
Il dualismo prospettato da Scruton ci riporta direttamente, attraverso un approccio antropologico di stampo kantiano, alle due modalità attraverso cui si può parlare di
uomo: a) la modalità “fisiologica”, nella quale egli come essere di natura è capace di
percepire suoni grazie alla conformazione fisica del suo apparato percettivo, e (b) la
modalità “pragmatica” che, nella terminologia di Scruton, assume l’accezione di intenzionalità immaginativa, come condizione razionale che (ci) permette di proiettare il
(nostro) pensiero in un orizzonte speculativo lontano dal presente e dal luogo attuale,
attraverso i mondi del possibile e dell’impossibile.
201
Roger Scruton è un personaggio poliedrico, polemico e oggetto di polemiche. La sua formazione
culmina nel conseguimento del titolo di Philosophiæ Doctor a Cambridge, con una tesi in estetica poi
confluita nella sua prima pubblicazione, Art and Imagination. Successivamente anche la sua carriera accademica si svolge interamente nel mondo anglofono; attualmente insegna filosofia presso l’università
cattolica Institute for the Psychological Science in qualità di Research Professor, dividendosi tra Washington e Oxford. I suoi interessi filosofici sono quindi orientati verso l’estetica, la musica in particolare, ma spaziano anche nella morale e soprattutto nella politica. Oltre a essere portavoce di istanze conservatrici, è stato anche protagonista attivo, ad esempio in Repubblica Ceca come supporto ai dissidenti
del regime comunista. Naturalmente la sua posizione politica e il suo attivismo, unitamente ad altre particolarità come la sua difesa della caccia alla volpe, lo rendono un personaggio spesso al centro di dibattiti. Anche la risonanza di Scruton in Italia è incentrata soprattutto su questioni di ordine politico. «Quelli
che lo odiano, tutti politicamente corretti, lo definiscono uno dei maggiori reazionari e clerico-fascisti
europei. Quelli che lo amano lo considerano uno dei pochi maestri coraggiosi del pensiero occidentale».
Come giornalista scrive sugli argomenti più disparati, dalla religione al vino. È anche autore di romanzi
e compositore: The Minister e Violet sono le sue due opere in musica. Tra i suoi lavori più significativi
ricordiamo: Art and Imagination, cit; The Aesthetics of Music, cit; Representation in Music, “Philosophy”, 51, 1976, 273-287; Absolute Music, in “Sadie”, ed., Vol. I, 1980a, 26-27; The Natural of Musical
Expression, in “Sadie”, ed., Vol. 6, 1980b, 327-332; Programme Music, in “Sadie”, ed., Vol. 15, 1980c,
283-287; The Semiology of Music, in “The Politics of Culture and Other Essays”, Carcanet Press, Manchester, 1981, 75-79; Analytical Philosophy and the Meaning of Music, “Journal of Aesthetics and Art
Criticism”, 46, Analytic Aesthetics, 1987, 169-176.
144
L’esperienza musicale, come peraltro altre modalità di intervento e di azione
dell’uomo nel mondo, è una sorta di innalzamento, di presa di distanza dalla finitezza
naturale per dislocarsi su un piano di intenzionalità immaginativa. L’essere di ragione è
aperto al mondo come un immenso e imprevedibile teatro di eventi da interpretare e
modificare per compiere se stesso attraverso il compimento del mondo.
L’attività cognitiva quotidiana coinvolge la percezione, la credenza, e
la raccolta di informazioni. Si tratta di un’attività comune a molte
specie animali, e non è certo distintiva dell’uomo. Tuttavia gli esseri
razionali – di cui l’uomo e la divinità sono i soli esempi conosciuti –
hanno delle capacità che non possono trovarsi altrove.
L’immaginazione è una di queste 202 .
L’immaginazione estetica è un fatto della musica nella misura in cui questa sia
capace di emanciparsi dal mondo fisico dei suoni per configurarsi come tramite tra
l’essere razionale e l’universale delle realtà immateriali; rappresentando quel ponte ideale capace di instaurare una relazione cognitiva tra i due piani.
Se dunque l’immaginazione è un fatto della musica, la musica è un fatto
dell’essere razionale, e la sua caratteristica è quella di uno sdoppiamento ontologico attraverso due distinte forme di realtà: quella oggettiva esperienziale della percezione e
quella immateriale del pensiero immaginativo. Qui, e solo qui, agisce la razionalità
come caratteristica esclusivamente umana che consente di esperire l’universale attraverso la pratica conoscitiva delle arti, della cultura e del linguaggio.
Nell’esperienza estetica, l’immaginazione si avvale di un ulteriore elemento che
Scruton definisce nei termini di “competenza”. L’immaginazione razionale, informata
dalla “competenza”, consente quindi di manipolare la realtà attraverso un complesso
apparato simbolico, per dislocare in due diversi ambiti cognitivi le cose reali e le apparenze, ovvero la concettualizzazione delle apparenze che, emendate dalla necessità della credenza, restano sospese nello spazio virtuale dell’esperienza estetica accanto agli
oggetti materiali, senza alcuna aspettativa derivante dalla necessaria concatenazione
vedere = credere.
Poniamo che io veda un uomo che sta in piedi di fronte a me con atteggiamento minaccioso. Il mio istinto è di stare in guardia. Mi aspetto qualcosa e la temo; e rispondo in accordo con tale paura. Il mio
comportamento è adeguatamente spiegato dal fatto che ciò che io ve202
Roger Scruton, The Aesthetics of Music, cit., pag. 88.
145
do è anche ciò che credo che sia lì. In effetti, vedere, in questo caso, è
anche credere 203 […].
Supponiamo ora che io veda un uomo che sta in piedi con lo stesso
atteggiamento minaccioso, ma che fa parte di un dipinto. Il mio istinto è di vedere, di studiare, di apprezzare con piacere questa meditazione sul fenomeno della collera. Non mi aspetto nulla, non temo nulla, e sono interamente assorbito dal modo in cui le cose appaiono.
Qui il mio comportamento è spiegato dal fatto che ciò che io vedo è
anche ciò che io credo che non sia lì. Io sto ‘guardando senza credenza’ 204 .
Tale condizione consente uno stato di pura contemplazione, dove l’esperienza è
coscienza del sé che si proietta attraverso visioni in cui il suo oggetto è l’oggetto di un
mondo parallelo che nulla condivide con quello delle cose materiali: due mondi copresenti, ma non relazionati. L’esperienza musicale è quindi una speciale realtà dualistica in cui operano tanto un sistema progettuale organizzato di note, accordi e melodie,
quanto un parallelo ma distante sistema immaginativo capace di coglierne il senso come oggetto intenzionale, senza desumerlo dalla “forma” che la manifesta come tale nella realtà fattuale. Senza questo senso speciale, note, accordi e melodie ricadrebbero sotto il dominio indeterminato dei suoni non significativi.
Non si tratta di ascoltare, spiega Scruton, la musica come in una sorta di presente allargato in cui la ritenzione memorativa del gioco degli accordi precedenti dispone
allo sviluppo dell’ascolto in atto nei termini di uno schema combinatorio consequenziale, poiché nell’esperienza in divenire dell’ascolto, un nuovo accordo, non si aggiunge
come effetto di una gerarchia generativa, bensì nel modo in cui tutta la melodia, gestalticamente ne risulta ridefinita nell’immanenza di un’apprensione immaginifica ed estetica, che prescinde dalla somma computazionale dei suoni in essa contenuti.
In quanto razionale, l’immaginazione non è arbitraria ma anzi può rivendicare a
sé contenuti cognitivi nella misura in cui è pur sempre l’oggetto sensibile a innescare
quella relazione attraverso cui la facoltà immaginativa può concettualizzare la visione
estetica.
Ma in che misura tali visioni sono veramente nell’oggetto nel quale esse sono
udite? La loro oggettività dice Scruton è perlomeno messa in discussione dal fatto che
solo gli esseri dotati di immaginazione sono in grado di percepirle:
203
204
Corsivo mio.
Roger Scruton, The Aesthetics of Music, cit., pag. 89.
146
Come ogni oggetto della percezione immaginativa, esse sono soggette alla volontà, e sono l’oggetto di scelte consapevoli o inconsapevoli.
Questo è ciò che rende possibile la critica, qui come nel caso della
pittura. Si possono fornire delle ragioni per sentire i colpi di percussione che aprono il Concerto di Violino Op. 61 di Beethoven come
una prolungata battuta in levare, o parte della melodia; la scelta risiede nell’ascoltatore. Se guardiamo attentamente al parallelo con i dipinti, vedremo che la percezione musicale coinvolge tutte quelle caratteristiche che ho attribuito all’immaginazione, e non potrebbe esistere nella mente di una creatura incapace di avere un pensiero immaginativo 205 .
Il rischio di un radicamento dell’immaginazione all’interno di contesti individuali, sembra comunque scongiurato: Scruton è un antirelativista per eccellenza, e
l’eliminazione del rapporto causalistico strumento-suono o in altri contesti suonomusica non va inteso come precondizione liberatoria in grado di favorire il libero esercizio di suggestioni immaginative o fantasiose slegate da ogni necessità e prive di contenuto cognitivo.
La musica rimane quell’elemento unificante che si costituisce nell’esperienza
d’ascolto come condizione capace di vincolare a sé l’immaginazione di un’idea condivisa o almeno condivisibile; in quanto facoltà razionale degli esseri umani essa aggrega
il singolo in un’esperienza allargata, laddove il rapporto interno/esterno si risolve
nell’idea di ispirazione kantiana di un terreno comune costituito dalle tradizioni sociali,
religiose e culturali, intese come patrimonio storico irrinunciabile delle civiltà e dal
quale il dato sensibile riceve la sua verificazione etica nella connessione con le categorie concettuali umane.
4. 1 Suoni e note
Per meglio chiarire quanto detto fin qui a proposito del ruolo ricoperto
dall’immaginazione nel costituirsi dell’esperienza musicale, sarà opportuno fare un
passo indietro, e analizzare con attenzione quello che è il punto di partenza del pensiero
di Scruton, vale a dire la distinzione tra suoni e note 206 .
205
Ivi, pag. 94.
Usiamo qui il termine ‘nota’, anziché ‘tono’, per tradurre l’originale ‘tone’ usato da Scruton. La nostra scelta deriva dal fatto che nel linguaggio comune è decisamente più usato il primo termine, dato che
il secondo non può essere compreso senza far riferimento all’organizzazione tonale che è sottesa a gran
206
147
I “suoni” sono sensazioni causate dalla vibrazione di un corpo in movimento
che propagandosi nell’aria con diverse frequenze e intensità giungono alla percezione
sensoriale attraverso un apparato fisiologico che le trasforma in sensazioni uditive correlate alla natura della vibrazione originaria.
Per “nota”, comunemente si intendono due cose: il segno in cui si rappresentano i suoni usati nella musica e le singole occorrenze sonore a essi conformi, generate
da strumenti o dalla voce umana.
La classe dei suoni naturali risulta sovradimensionata rispetto a quella delle note che in quanto occorrenze fanno quindi riferimento a due diverse classi di entità:
quella immediata dei suoni naturali, e quella dinamica organizzata all’interno di una
certa teoria musicale. I suoni naturali non vanno intesi nell’accezione di suoni della natura, (anche un suono emesso da uno strumento rimane in primis un suono naturale),
bensì in quella più ampia di vibrazioni che producono una perturbazione di carattere
oscillatorio che si propaga attraverso un mezzo elastico.
Una “nota” produce lo stesso tipo di perturbazione fisica di un suono ordinario,
potendosi entrambi definire nei termini di numero di oscillazioni (variazioni di pressione) misurabili in cicli al secondo (hertz).
Ne consegue che nessun tipo di analisi empirica potrebbe distinguere una nota
da un suono ordinario, o per citare direttamente Scruton: “l’estensione nel mondo materiale di ciascun concetto (ciascuno dei due) è la stessa” 207 . Ciò che segna il passaggio dal mondo dei suoni al mondo delle note va quindi cercato non in determinate proprietà degli oggetti, ma nelle facoltà dei soggetti, ovvero degli ascoltatori. Ma procediamo per gradi, e cerchiamo di ripercorrere il percorso compiuto da Scruton.
Il filosofo inglese inizia constatando una vicinanza dei suoni ai colori, in quanto
entrambi dipendono dall’esercizio di un’unica modalità sensoria (rispettivamente,
l’udito e la vista): essi (i suoni) “sono oggetti dell’ascolto più o meno nella stessa maniera in cui i colori sono oggetti della vista, e sono assenti nel mondo delle persone
sorde, proprio come i colori sono assenti nel mondo delle persone cieche” 208 . I filosofi
hanno tradizionalmente classificato come secondarie le qualità che sono oggetto di
un’unica modalità sensoria, in quanto contrapposte a quelle qualità, etichettate come
primarie, le quali possono essere rilevate anche attraverso altre modalità (si pensi alla
parte della tradizione musicale classica occidentale − tradizione che rimane comunque, vale la pena ricordarlo, l’orizzonte entro cui la riflessione scrutoniana si dipana.
207
R. Scruton, The Aesthetics of Music, cit., pag. 93.
208
Ivi, pag. 1.
148
forma di una moneta, che può essere percepita anche col tatto, oltre che con la vista).
Di certo i colori sono qualità secondarie, in quanto la loro rilevazione dipende da come
gli oggetti appaiono a degli osservatori qualificati posti in condizione standard di osservazione: essi, in questo senso, costituiscono il “rivestimento fenomenico” delle cose.
Tuttavia, osserva Scruton, i suoni, a differenza dei colori, non possono essere considerati qualità secondarie, poiché non sono affatto delle qualità. I colori, infatti, vengono
percepiti in quanto appartenenti a certi oggetti: noi acquisiamo familiarità col colore
blu osservando oggetti blu, e così via. Viceversa, i suoni non appartengono agli oggetti
che li determinano causalmente, ma sono emessi da questi. Ciò significa che “sebbene
ogni suono debba avere una causa, da ciò non segue che esso debba anche essere emesso dalla sua causa, o che debba essere inteso come il suono che ha quella causa” 209 .
La separabilità del suono dalla sua causa ha secondo Scruton delle importanti
conseguenze. La principale riguarda il fatto che i suoni possono essere esperiti come
“eventi puri”, come “suoni a sé stanti”, distinti dalle cause fisiche dalle quali pure essi
dipendono − il che non accade con la nostra esperienza ordinaria, in cui normalmente
quando assistiamo a un dato evento, noi percepiamo degli oggetti che agiscono e si
modificano. Teoricamente è possibile immaginare una “stanza della musica” entrando
nella quale noi sentiamo dei suoni, ma in cui non sono rinvenibili le fonti del suono
stesso, che viene quindi esperito “acusmaticamente” 210 . Ciò significa che noi possiamo
sentire i suoni come abitanti un mondo tutto loro, e come organizzati primariamente
entro la dimensione temporale, mentre la dimensione spaziale non può che essere solo
immaginata metaforicamente.
La separazione tra i suoni e le loro sorgenti è il primo passo per comprendere la
natura della musica, che, secondo Scruton, va innanzitutto definita come “arte del suono” 211 . Tuttavia, non ogni suono è musica (si pensi al suono di una fontana, la quale sia
stata creata sotto la guida di un’intenzione estetica). Si potrebbe allora aggiungere la
seguente caratterizzazione: la musica è l’arte del “suono organizzato”. Ma anche questa
aggiunta non è sufficiente a delimitare il nostro ambito di ricerca, in quanto anche la
poesia è un’arte del suono organizzato − dalle regole della sintassi e della semantica,
come dall’intenzione del poeta e dalle aspettative del lettore. È necessario specificare
allora di che tipo di organizzazione si serve la musica. A tal fine può essere d’aiuto, di-
209
Ivi, pag. 2.
Ivi, pp. 2-3. Il termine ‘acusmatico’ è desunto dai Pitagorici, i quali ascoltavano parlare il loro maestro al di là di un telo che lo nascondeva alla vista, ed erano chiamati akousmatikoi.
211
Ivi, pag. 16.
210
149
ce Scruton, fare un parallelo con quanto accade alle parole che utilizziamo per dialogare con altre persone. Ogni suono emesso intenzionalmente dalle persone viene istintivamente interpretato come un tentativo di comunicazione. Esso rimane però un puro
suono privo di significato, fino a che non viene percepito all’interno di un campo di
forze organizzato, che nel caso del linguaggio è rappresentato dalla grammatica, la quale fa sì che il suono venga percepito come una parola con un proprio significato. Qual è
il campo di forze che trasforma un suono in una nota, e un insieme di suoni in musica?
Per stabilire ciò, è sufficiente secondo Scruton prendere in considerazione quelle che sono le opere d’arte (musicali) paradigmatiche della nostra tradizione, ovvero i
capolavori indiscussi della musica classica occidentale, tralasciando invece i casi-limiti
che si possono rinvenire nel modernismo e nel post-modernismo. Lo studio di tali opere ci dice che l’organizzazione alla quale sottostà l’arte musicale dei suoni è
l’organizzazione della musica tonale. I suoni diventano musica quando noi, in quanto
esseri razionali dotati di immaginazione, percepiamo, nell’ascolto, qualcosa in essi;
questo ‘qualcosa’ è il tono, o nota, ed è dotato di una propria forza, in virtù della quale
lo udiamo come “derivante” da altri suoni/note e “conducente” verso altri suoni/note.
Quando ascoltiamo la musica, noi udiamo le note come sottostanti a una “causalità virtuale”, ulteriore a quella fisica che regola le relazioni tra i suoni corrispondenti; in virtù
di tale causalità virtuale noi percepiamo un movimento − immaginato, metaforico − tra
le note che si succedono temporalmente 212 .
Questo modo di intendere la musica si applica a tutte e quattro le principali
forme di organizzazione musicale, vale a dire l’altezza, il ritmo, la melodia e l’armonia.
Concentriamoci sulla seconda e sulla terza delle forme appena menzionate. Per quanto
riguarda il fenomeno del ritmo, Scruton respinge le teorie che fanno capo a spiegazioni
di tipo generativo 213 in quanto rendono conto di un solo aspetto del ritmo: quello del
metro, esplicato in termini di divisione della battuta in valori a loro volta divisibili. Similmente Cooper e Meyer 214 commettono lo stesso errore, confondendo il ritmo, con
uno solo dei suoi aspetti, teorizzato attraverso il raggruppamento di una o più pulsazioni non accentate in relazione a una pulsazione accentata.
Teorie di questo tipo tendono a ricondurre il problema in termini di rapporti materiali ai quali secondo Scruton il ritmo non è mai riconducibile; affiorando da uno
212
Ivi, pp. 16-20.
Spiegazioni di questo tipo sono quelle che provengono, spiega Scruton, dalla psicologia cognitiva.
Cfr. H. C. Longuet-Higgins, Mental Processes: Studies on Cognitive Science, MIT Press, Cambridge,
1987.
214
Cfr. G. Cooper, L. B. Meyer, The Rhythmic Structure of Music, cit.
213
150
sfondo virtuale generato dall’immaginazione, esso non dipende dalla regolarità del battito, ma dalla fluidità della pulsazione vitale. Nel ritmo non cogliamo un calcolo, ma
[…] una sorta di animazione. Il ritmo coinvolge la stessa causalità
virtuale che troviamo nella melodia. I battiti non si susseguono uno
dopo l’altro; si pongono in essere l’un l’altro, si rispondono vicendevolmente e respirano animati da una stessa vita. L’organizzazione che
ho appena descritto non è una possibile organizzazione di suoni, costruiti come oggetti materiali. Ma è un’organizzazione di oggetti
mentali, che conosciamo intimamente dalla nostra esperienza interiore: l’esperienza della vita consapevole di sé in quanto vita 215 .
Non si può quindi comprendere il ritmo se non si considerano tanto la varietà di
aspetti che lo determinano − la regolarità, la pulsazione, la distinzione tra battere e levare, i raggruppamenti, gli accenti, l’enfatizzare una nota o l’altra, la stretta connessione con la melodia (ogni pulsazione è infatti associata ad un frammento melodico) −
quanto la sua natura intrinsecamente metaforica. Non si può infatti descrivere il ritmo
se non facendo ricorso a espressioni metaforiche come “pulsazione vitale”, “esperienza
della vita”, o “organismo che respira” 216 . Le stesse caratteristiche di complessità e di
metaforicità si applicano anche all’esperienza della melodia. La melodia è un tipo particolare di Gestalt musicale: essa è l’unità che si instaura tra le note che si succedono,
ma anche tra micro-unità come frasi e motivi. Da questo punto di vista, la melodia si
distingue tanto dall’armonia − la quale è una Gestalt in cui però vari elementi vengono
percepiti simultaneamente come unitari, mentre la Gestalt melodica è un’unità di elementi che si succedono nel tempo − quanto dal ritmo − in quanto la melodia, a differenza del ritmo, è percepita come un “individuo musicale”, reidentificabile e riconoscibile (da ciò deriva il frequente utilizzo, da parte dei compositori, della tecnica della variazione melodica, che senza la possibilità di riconoscere delle unità individuali melodiche che sono sottoposte a trasformazione non avrebbe alcun significato). Il riconoscere una melodia come unità organica e non come mera somma di elementi richiede
l’esercizio dell’immaginazione, attraverso la quale riconosciamo un inizio e una fine
della melodia (una stessa nota può essere sentita come la fine di una melodia o come
l’inizio di un’altra), in virtù del riconoscimento di una dinamica interna alla musica in
corrispondenza della quale ‘segmentiamo’ la melodia in parti che si ‘muovono’ ineso215
R. Scruton, The Aesthetics of Music, cit., pag. 35.
Espressioni, queste, che secondo Scruton non possono essere applicate alla musica pop, in cui il semplice battito sostituisce quell’intima connessione tra ritmo e melodia che ci fa percepire la musica stessa
non come una macchina ma come un organismo che vive e respira.
216
151
rabilmente (ovvero guidate da un’intima necessità) l’una verso l’altra all’interno di uno
spazio che non può che essere metaforico (dato che non c’è nulla, qui, che occupa letteralmente una posizione). Percepire il movimento musicale è quindi di fondamentale
importanza, poiché esso è “la realtà di sfondo su cui le melodie prendono forma” 217 .
Riassumendo, Scruton ritiene che per comprendere la musica sia necessario distinguere non solo il suono dalla sua sorgente materiale, ma anche il suono dalla nota:
solo quest’ultima è l’oggetto intenzionale dell’esperienza musicale. Non bisogna però
incorrere nell’errore di considerare suoni e note come entità individuali distinte: esse
sono piuttosto due modi diversi di concepire una medesima realtà, allo stesso modo in
cui lo sono mente e corpo per Spinoza. L’esperienza musicale è e rimane indubbiamente un dato reale nella misura in cui si dispiega in uno spazio fisico attraversato da vibrazioni che colpiscono i nostri sensi per un tempo determinato definito da un inizio e
da una fine; tuttavia è la sua comprensione nei termini di organizzazione tonale a renderla pienamente reale, vale a dire reale per noi (uomini). In noi la musica è conoscenza
e insieme movimento: movimento immaginario di suoni all’interno di uno spazio virtuale in cui le note si muovono ora verso il basso ora verso l’alto, e che non va confuso
con quello esemplificato dal diagramma musicale, dove il rapporto significatosignificante si risolve in un ordine necessitato da un sottostante codice analogico nel
quale ogni segno è conforme al suo manifestarsi come nota all’interno dell’esecuzione.
La realtà musicale acusmatica proposta da Scruton fa invece riferimento a un ben più
complesso sistema di significati in cui agisce uno sfondo etico: quando egli dice che
una nota è conseguenza di quella che la precede, lo è nella misura in cui ne è ragione
(ragione umana) e non conseguenza necessitata da rapporti causali descrivibili nei termini discorsivi delle asserzioni sui fatti. Sottratta ai parametri che guidano il criterio di
oggettività scientifica, la musica in quanto oggetto immaginario non è e non può essere
né vera né falsa, configurandosi piuttosto nei termini di una tensione morale in vista di
un “dover essere” in cui “etica ed estetica sono una cosa sola” 218 .
La nostra esperienza della musica sarà dunque esperienza di un mondo immateriale. Ha ancora senso parlare di esperienza? Che tipo di esperienza possiamo sperare
di conseguire, ovvero: in che modo e in quali ambiti possiamo parlare di musica?
Negli ultimi decenni il dibattito estetico si è spesso trovato diviso tra una serie
di alternative, una di queste riguarda il problema delle qualità che attribuiamo alla mu-
217
218
Ivi, p. 155.
R. Scruton, Art and Imagination. A study in the Philosophy of Mind, cit., pag. 249.
152
sica (comprese quelle espressive). Sono proprietà reali o vanno piuttosto intese in senso
metaforico? E se sono metaforiche, in che senso lo sono?
Potremmo togliere di mezzo la metafora e descrivere l’oggetto dell’esperienza
musicale senza che si dipenda da essa?
4. 2 Metafora
Ci sono dei contesti, sostiene Scruton,
nei quali le metafore sembrano essere indispensabili 219 : non solo in
quanto fanno parte di un’esperienza letteraria unica, ma in quanto le
stiamo utilizzando per descrivere qualcosa che è altro dal mondo materiale, in particolare in quanto stiamo cercando di descrivere come il
mondo “appare” dal punto di vista dell’immaginazione attiva. E questo è il caso di quando ascoltiamo la musica 220 .
Riprendiamo brevemente l’esempio del quadro raffigurante la figura di un uomo minaccioso, che, citando direttamente le parole del suo autore, avevamo già incontrato, per svilupparlo ora in una chiave di interpretazione più prettamente metaforica. In
quel contesto avevamo lasciato l’esperienza estetica sospesa in una dimensione puramente contemplativa nella quale al vedere non conseguiva una richiesta di verificazione oggettiva: “Ciò che io vedo, è anche ciò che io credo che non sia lì ” 221 . Si tratta di
un mondo che esiste senza esistere accanto a quello materiale nel quale invece il vedere
coincide necessariamente con la credenza di vedere per davvero.
Abbiamo appreso come i due mondi, co-presenti nella realtà, sono tuttavia separati da un’abissale distanza, la medesima che separa l’essere di ragione dall’essere di
natura o, per essere più precisi, l’essere umano nella sua dualistica e contemporanea
appartenenza a due mondi diversi.
Qui il tentativo di trovare una relazione tra il dato sensibile della necessità e
quello intellegibile dell’immaginazione, ci riporta ancora una volta al progetto kantiano
della terza critica, o meglio ad una delle sue possibili chiavi di lettura che possiamo
scorgere nel paradigma della “doppia intenzionalità” proposto da Scruton:
219
Corsivo mio.
R. Scruton, The Aesthetics of Music, cit., pag. 91.
221
Ivi, pag. 89.
220
153
Quando vedo un dipinto, e l’uomo in esso ritratto, l’intenzionalità
della percezione può sdoppiarsi, proprio in quanto non vi è conflitto
tra le immagini. Non sono diviso tra credenze rivali, come lo sarei invece di fronte a un affresco trompe l’oeil, e non devo chiedermi se ho
di fronte un dipinto o un uomo. Posso accostarmi ad esso come a uomo o come dipinto, proprio in quanto l’uomo non appartiene al mondo nel quale il dipinto è collocato. Credo che l’oggetto posto di fronte
a me sia un dipinto, e semplicemente rifletto sull’uomo che sta
all’interno di questo. Questa è la peculiare esperienza che
l’immaginazione rende possibile: l’incontro del pensiero detto e nondetto 222 .
È questo il punto centrale in chiave gnoseologica della concezione metaforica di
Scruton: la trasposizione di un’immagine in un’altra si connette con la teoria
dell’immaginazione estetica, nella misura in cui è la distanza (logica) che pareva incolmabile tra i due termini e non la loro vicinanza 223 (fisica) a consentire l’innesco
delle due differenti concettualizzazioni del pensiero: quello detto (asserito) e quello
non-detto (non-asserito), che in chiave puramente esemplificativa possiamo far corrispondere in ultima analisi a ciò che accade nella metafora tra il soggetto e il predicato.
Il “focus” della metafora (terminologia che Scruton mutua da M. Black) cioè il
predicato oggetto della trasposizione è parimenti importante, quanto il contesto letterale che lo accoglie.
Scruton tende costantemente a mantenere soggetto e predicato all’interno di un
rapporto di “appropriatezza” che li unisce e separa nello stesso tempo, nella misura in
cui il significato denotativo del predicato applicato, mantiene la sua integrità indenne
rispetto all’operazione della trasposizione, laddove invece nella concezione interattiva
di Black esso si disperdeva come abbiamo visto in un sistema connotativo molto più
instabile di “implicazioni associate” capace (almeno potenzialmente) di determinare un
effetto dòmino, a carico di tutto il linguaggio dove i nomi perderebbero progressivamente il loro significato denotativo a causa della reciproca interferenza (interattività)
tra soggetti e predicati.
Non possiamo esimerci dal ritornare se pur brevemente alla teoria interattiva
esposta in Metaphor da M. Black che rappresenta il momento stesso della trasformazione in chiave moderna della concezione della metafora, e segna l’evoluzione da concezioni definite sostitutive o comparative di derivazione storica (spesso fraintese) a
222
Ivi, pp. 89-90.
Oppure somiglianza, in tal caso dovremmo specificare cos’è una somiglianza e dovremmo farlo ricorrendo ancora una volta ad Aristotele … per il momento lasciamo quindi “vicinanza” (per non complicare
le cose) vicinanza è un termine generico che non ci costringe ad entrare nel merito, come invece saremmo obbligati a fare parlando di “somiglianza”.
223
154
concezioni cognitive che raccolgono molte delle adesioni nell’attuale dibattito filosofico intorno allo statuto del discorso metaforico. L’impressione però è che se da un lato
sembra ormai riconosciuta la valenza conoscitiva assegnata da Aristotele alla metafora,
dall’altro come sottolinea Guastini, non sempre la filosofia del Novecento si è interrogata adeguatamente intorno a quale tipo di conoscenza mette in gioco la metafora aristotelica 224 .
Senza alcune necessarie precisazioni non saremo in grado di tenere insieme, il
dato conoscitivo (cognitivo) con la concezione metaforica comparativa adottata da
Scruton (che sarebbe più utile inquadrare col termine di “appropriatezza”) 225 e che invece recupera in pieno all’intenzione aristotelica tutto il suo valore eminentemente conoscitivo riscattandolo da una progressiva delegittimazione gnoseologica, subita attraverso i secoli, a partire come nota ancora Guastini
da Cicerone prima e Quintiliano in modo ancora più sistematico poi,
[i quali] pur riprendendo spesso parola per parola le argomentazioni
esposte da Aristotele nella Poetica e nella Retorica, inseriranno ciò
che l’uno chiama translatio e l’altro propriamente metaphora
all’interno della dimensione dell’ornatus orationis, dell’ornamento
stilistico, avranno di fatto modificato in modo profondo il contesto in
cui Aristotele aveva trattato della metafora. Contesto che il filosofo
nelle due opere richiama con il termine lexis e che, seguendo
l’intendimento aristotelico, sarebbe forse più adeguato allargare
all’intero ambito del linguaggio; questo per usare una terminologia
moderna, sia al piano dell’espressione che a quello del contenuto
piuttosto che, come farà invece la retorica classica, al solo ambito, assai più delimitato, dell’elocutio e dello stile […] Quindi, almeno
all’apparenza, un contesto tassonomico, classificatorio quello recepito dalla tradizione della retorica classica, che dell’argomentazione
svolta qui da Aristotele coglierà solo questo – che pure c’è, intendiamoci – di carattere stilistico, e che tuttavia non rappresenta affatto il
centro dell’argomentazione, né nella retorica e nemmeno, malgrado
certe indecisioni, nella Poetica 226 .
Il carattere esoterico degli scritti aristotelici, unito ad alcune apparenti contraddizioni tra i due testi Poetica e Retorica, e infine la loro trasposizione in un contesto filosofico che non tiene più conto del dato referenzialistico né dell’orizzonte metafisico
224
D. Guastini, Aristotele e la metafora: ovvero un elogio dell’approssimazione. Questo contributo è il
testo di una relazione tenuta a Urbino il 7 Dicembre 2004 in occasione del seminario di studi: Vedere il
simile nel dissimile: la metafora in Aristotele e il simbolo in Kant, tenutosi presso l’istituto di filosofia
Arturo Massolo dell’Università di Urbino, pag. 2.
225
Sostitutiva è il termine adoperato in chiave riduttiva come sinonimo di superfluo, e per estensione superflua, decorativa ecc, vedi M. Black, Modelli Archetipi metafore, cit. Appropriatezza è il termine che
più si avvicina a “vicinanza prossemica” termine introdotto da Aristotele nella Poetica.
226
D. Guastini, Aristotele e la metafora …., cit., pp. 1 e 4.
155
del contesto originario, fanno sì che l’idea aristotelica si sia dispersa, dalla scolastica
fino al secolo scorso, attraverso una serie di letture, che non si configurano come interpretazioni più o meno adeguate, ma finiscono adesso per dare origine a una vera e propria dicotomia.
Ripristinare come punto centrale il carattere di “appropriatezza” dell’uso figurato del linguaggio esemplificato dalla trasposizione metaforica aristotelica, (e ugualmente dalla similitudine) è per Scruton una condizione imprescindibile ed equivale a
mostrarne tutto il suo contenuto cognitivo, contro certe interpretazioni, che (come si evince dalla breve ricostruzione che segue) celebrano invece l’arbitrarietà della trasposizione predicativa e della sua stessa connotazione come quella condizione che renderebbe eminentemente alla metafora, (contro la similitudine) l’esclusivo possesso del dato
conoscitivo gnoseologico e che l’avverbio di paragone “come” negherebbe ipso facto.
Sostiene M. Black :
Uno dei rischi di occuparsi soprattutto di ciò che ho chiamato «motivi
metaforici» è quello di postulare una risposta standard 227 a una data
asserzione metaforica, risposta determinata da convinzioni linguistiche, concettuali o d’altro genere. Un tale punto di vista è insostenibile
perché l’asserzione metaforica implica una violazione delle regole.
Non ci può essere nessuna regola per violare «creativamente» le regole 228 .
4.3 Metafora e similitudine
Le teorie metaforiche comparative e sostitutive di derivazione storica sono solitamente considerate da una larga parte del dibattito contemporaneo, come semplici casi
di similitudine implicita o, in altre versioni, come la sostituzione di un certo termine
con una forma figurata di quel termine; in entrambi i casi è sempre possibile ritornare
alla corrispondente formulazione letterale ripristinando il termine originario o facendo
emergere in superficie l’avverbio di paragone “come” che distingue una similitudine da
227
Si noti come Black adoperi il termine standard, forzando volutamente i termini della questione, poiché era perfettamente chiaro anche a lui che l’appropriatezza prospettata da Aristotele era in realtà, come
si evince dalla retorica, una appropriatezza inappropriata, vale a dire la transazione inappropriata di un
predicato appropriato (in sé), quindi tutt’altra cosa rispetto a quel meccanismo automatico che Black vorrebbe suggerire col termine standard.
228
M. Black, Modelli Archetipi Metafore, cit., pag. 107.
156
una metafora. In tal modo la metafora si configura come similitudine ellittica, nella
quale l’eliminazione (ma solo superficiale) dell’agente “come” contribuisce
all’economicità dell’espressione e le conferisce una suggestione maggiore. La netta distinzione tra linguaggio letterale e linguaggio scientifico rimane preservata poiché una
metafora così concepita non presenta nessun problema di interpretazione in quanto la
sottostante similitudine necessita e convalida la conseguente espressione metaforica.
Ne deriva un’unione che nei termini del paragone preserva l’alterità dei due
soggetti, e sacrifica il “senso metaforico” poiché la molteplicità delle somiglianze che
può essere colta tra cose dissimili è praticamente infinita così che si può affermare che
ogni cosa, sotto certi aspetti, è letteralmente come un’altra cosa.
Il secondo polo attraverso cui la retorica classica e medievale ha considerato la
metafora, è quello della concezione sostitutiva che per certi aspetti è strettamente connesso al sistema comparativo appena descritto, entrambi si definiscono infatti nei termini di concezioni deduttive necessitate.
In questo secondo caso, si assume la preesistenza di un corrispettivo termine
letterale per ogni termine metaforico sulla base di un codice in cui ogni espressione
metaforica è sostituibile con una equivalente espressione letterale; il lavoro di ricostruzione (parafrasi) consisterà quindi nell’esplicazione della figura retorica e nel ripristino
della corrispondente formulazione letterale.
In entrambi i casi il prezzo da pagare è alto e si misura nei termini di svalutazione del dato gnoseologico.
Ma siamo sicuri che le cose stiano davvero in questo modo, e che la questione
sia riconducibile in ultima analisi a una sterile contrapposizione tra contenuto cognitivo
da una parte e appropriatezza predicativa (non cognitiva) dall’altra? La questione è tanto controversa che persino I. A. Richards riconosciuto pressocché unanimemente come
il precursore delle moderne concezioni metaforiche, e a cui lo stesso Black riconosce
alcune intuizioni fondamentali, mostra ancora una malcelata nostalgia verso quelle che
definisce “caratteristiche comuni” 229 quando dice che nella trasposizione metaforica
una parola o un’espressione deve connotare solo una selezione delle caratteristiche
connotate nei suoi usi letterali, e così riducendone di fatto la discrezionalità connotativa, induce Black ad accusarlo di essere ricaduto in una delle più vecchie e meno sofisticate analisi che si tenta di superare 230 .
229
230
Ivi, pag. 56.
Ibidem.
157
Questo è il punto di snodo cruciale dell’intera questione, un nodo da sciogliere
al più presto per una corretta comprensione di ciò di cui parliamo quando parliamo di
metafora.
Per precisare ulteriormente i termini della questione, marcandone le differenze,
citiamo ancora una volta Scruton che in polemica col nominalista N. Goodman, ci fa
sapere che
Per metafora intenderò ciò che Aristotele intendeva: l’applicazione
deliberata di un termine o di una frase a qualcosa che sappiamo non
esemplificare tale termine o frase (se non vi piace questa definizione
aperta, potete semplicemente sostituire un altro termine a ‘metafora’).
Subito ci si presenta un problema. Se applicate deliberatamente un
certo predicato a un oggetto, non state forse dando per scontato che il
predicato si applica davvero all’oggetto? Qual è il significato
dell’espressione “sappiamo non applicarsi a”? Se siete dei nominalisti, e credete che non vi sia bisogno di ulteriori spiegazioni per giustificare il modo in cui classifichiamo le cose, e che l’applicazione dei
predicati sia la fase finale di tale classificazione, allora è davvero difficile distinguere un uso metaforico da altri tipi di usi. L’unica distinzione che ci potrebbe venire in mente è quella tra usi più o meno
nuovi. L’uso metaforico sarebbe allora quello al quale non ci siamo
ancora abituati. Questa è la teoria della metafora esposta dall’ipernominalista Nelson Goodman ne I linguaggi dell’arte, ed è una teoria
che convenientemente risolve la discussione. Troppo convenientemente, però. Se c’è qualcosa che può mettere a nudo l’incoerenza del
nominalismo, questo qualcosa è la metafora. Più precisamente, è la
nostra consapevolezza della metafora che ci permette di distinguere il
caso in cui qualcosa è realmente blu dal caso in cui il nostro giudicare
qualcosa come blu poggia essenzialmente sulla sua falsità. Ne siamo
così consapevoli che la parola ‘letteralmente’ ha tutto fuorché rimpiazzato le parole ‘veramente’ o ‘realmente’ nel parlare quotidiano 231 .
Seguendo Scruton, proviamo a dare un giusto ordine alle cose, cercando di
comprendere i limiti (ove ce ne fossero) e il valore (presunto) di ciò che correttamente
si intende per attribuzione appropriata di un predicato a un soggetto, all’interno di
un’asserzione metaforica.
231
R. Scruton, The Aesthetics of Music, cit., pp. 80-81.
158
4.4 Un’appropriata trasgressione
Nella referenzialità del contesto aristotelico originale, la trasgressione metaforica porta in luce qualcosa che ontologicamente preesiste, essa quindi non crea nuovi
domini di riferimento, il suo scopo va invece compreso nei termini di scoperta più che
in quelli di invenzione; la relazione semantica non può infatti in nessun caso prescindere dal rapporto ontologico originario e la metafora deve essere pertanto guidata da
un’appropriatezza che la riporta sempre ai suoi attributi naturali.
L’arbitrarietà della trasgressione si costituisce non di meno come elemento conoscitivo fondamentale, e attiene unicamente al dispositivo stesso della metafora, ovvero al trasferimento non ortodosso (trasgressivo) delle parole da un contesto a un altro,
sebbene il significato delle parole consista poi sempre nella denominazione (e non connotazione) di oggetti. Spostando così il fulcro della significazione metaforica dal contesto dei significati a quello della pragmatica, cioè del loro uso.
Lo scopo della similitudine, sostiene Scruton, è identico a quello della metafora:
esso non consiste nel descrivere un oggetto (come invece vorrebbe la
teoria interattiva) ma nel cambiarne l’aspetto in modo tale che noi rispondiamo ad esso in altro modo. Ciò è possibile perché i termini che
vengono usati metaforicamente, come quelli che sono presenti in una
similitudine, vengono usati nel senso ordinario 232 .
Sono cioè soggetti a una regola, regola che mette fuori gioco molte teorie della
descrizione estetica. Quando diciamo metaforicamente che una musica è triste, non
siamo chiamati a decidere 233 (implicitamente) quali caratteristiche veicolate dalla tristezza possono sopravvivere e quali soccombere a seguito della trasposizione predicatoria, né in che modo la musica possa presentare certe caratteristiche in grado di accoglierle.
Il termine ‘triste’ che viene utilizzato nell’asserzione metaforica ‘questa musica
è triste’ è esattamente lo stesso triste che adoperiamo nel linguaggio letterale, cioè nelle situazioni in cui ordinariamente parliamo di tristezza. (Qui Scruton cita a conferma il
noto esempio wittgensteiniano del martedì/mercoledì grasso/magro):
232
Ivi, pag. 84.
Qui decidere è usato metaforicamente, poiché non esiste un termine adeguato per descrivere la situazione, si tratta infatti di una sorta di decisione implicita.
233
159
Dati i due concetti “grasso” e “magro”, saresti disposto a dire che
mercoledì è grasso e martedì è magro, o saresti meglio disposto a dire
il contrario? (Io sono propenso a scegliere la prima alternativa). Ebbene, qui «grasso e «magro» hanno un significato diverso dal loro significato ordinario? Hanno un impiego diverso. – Dunque, per parlare
propriamente, avrei dovuto usare altre parole? Certamente no. – Qui
voglio usare queste parole (con i significati che mi sono familiari).
[…]
Se qualcuno mi chiedesse: «Che cosa intendi, propriamente, con
“grasso” e “magro”?» potrei spiegargli i significati di queste parole
soltanto nel modo assolutamente ordinario. Non potrei riferirli agli
esempi di martedì e mercoledì 234 .
L’appropriatezza dell’idea scrutoniana coincide quindi con la deliberata (e non
implicita) consapevolezza di utilizzare questa parola, qui dove essa non dovrebbe essere usata, ed è riconducibile alla nozione di “relazione prossemica” introdotta da Aristotele. Tale consapevolezza, che non deve necessariamente intendersi come implicita conoscenza letterale del meccanismo che soggiace dell’asserzione metaforica nei termini
della sottostante o esplicita similitudine, va invece compresa in Scruton come intenzione: l’intenzione di invitare qualcuno a condividere l’esperienza estetica della “trasformazione alchemica” 235 di una cosa suggerita nei termini di un’altra, e questo è anche lo
scopo di una similitudine, portare alla luce una fusione di esperienze, nei termini della
doppia intenzionalità informata dalla persistenza di due contemporanee concettualizzazioni: quella del pensiero detto (asserito) e quella del pensiero non detto, (non asserito)
dei quali ci eravamo già occupati e che qui riprendiamo alla luce delle ultime acquisizioni, con un ulteriore approfondimento, citando ancora una volta direttamente
l’autore.
Quando vedo un volto in un dipinto, in un normale contesto estetico,
non sto vedendo un dipinto e un volto; né sto vedendo una somiglianza tra il dipinto e il volto. Il volto e il dipinto sono fusi insieme nella
mia percezione. Il che non vuol dire che confondo l’uno con l’altro, o
che ne scambio la realtà. Ho di fronte due oggetti simultanei di percezione: il dipinto reale, e il volto immaginario. E la mia risposta
all’uno si fonde con la mia risposta all’altro. Ad esempio, rispondo
alle linee fluenti e al color carne con delle emozioni e delle aspettative che derivano dall’esperienza che io ho dei volti, e (rispondo) al
volto con le emozioni e le aspettative che derivano dal mio interesse
per il colore, l’armonia e l’espressività delle linea. La fusione si com-
234
L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, Einaudi, Torino 1999 (trad. it. Di R. Piovesan e M. Trinchero),
pag. 283 (parte II, § XI).
235
R. Scruton, The Aesthetics of Music, cit., pag. 82.
160
pie al più alto livello di interesse razionale, nello stesso tempo in cui
si traduce nell’atto percettivo stesso 236 .
Un’analoga esperienza si manifesta nella comprensione di una metafora: non
stiamo semplicemente pensando il soggetto nei termini letterali del predicato applicato,
non stiamo stabilendo analogie e soprattutto non stiamo confondendo gli oggetti che
sono simultaneamente immaginati.
Al contrario! Come si evince nell’esempio del dipinto, l’effetto dipende proprio dal riconoscimento dell’ineliminabile differenza metafisica tra i due oggetti della nostra visione: quello materiale e quello immaginario.
Scruton spiega la “doppia intenzionalità” come una visione simultanea che avviene nella mente quando l’attenzione si concentra sull’apparenza di una cosa (asserita)
e contemporaneamente sull’apparenza di un’altra (non asserita). In tal modo le qualità
della seconda vengono trasferite simpateticamente e appropriatamente alla prima, realizzando una connessione che è reale nell’immaginazione ma solo immaginata negli
oggetti, perché il fascino estetico che attribuiamo ad essi, in realtà risiede dentro di noi
nel modo in cui cerchiamo per tramite di essi di conoscere il mondo. Di questo mondo
gli oggetti della percezione sono pertanto da intendersi più come mezzo che non come
fine della conoscenza.
Diverso il discorso quando una metafora è utilizzata per descrivere gli avvenimenti del mondo materiale; in questi casi sostiene Scruton, al di là del valore poetico,
misurabile in termini di mera suggestione, non rimane altro e quindi possiamo anche
farne a meno (la metafora è qui interpretabile come la “versione stenografata” di una
realtà complessa, che possiamo portare alla luce estrapolando dalla metafora il suo significato 237 ); ma, quando il mondo è il mondo della musica così come di ogni altra esperienza in cui opera l’immaginazione, allora la metafore (o la similitudine) si rivelano indispensabili.
La metafora indispensabile sopraggiunge quando il modo in cui il
mondo appare dipende dal nostro coinvolgimento immaginativo con
esso, piuttosto che dai nostri normali fini conoscitivi. E questo è il caso di quando ascoltiamo la musica 238 .
236
Ivi, pag. 87.
Posso ad esempio estrapolare il significato dell’espressione metaforica homo homini lupus descrivendo i più conosciuti esempi ed episodi di aggressione dell’uomo nei confronti dei suoi simili.
238
Ivi, pag. 92.
237
161
4.5 Musica e metafora
L’altezza di un suono è paragonabile al colore di una luce, sotto questo aspetto: è una qualità secondaria, prodotta da una vibrazione […]
inoltre proprio come ogni cambiamento della frequenza delle onde
luminose produce una modificazione del colore, così ogni cambiamento della frequenza di un suono ne modifica l’altezza. […] La nostra esperienza dell’altezza come quella del colore, ci presenta un
continuo: tra due colori o due altezze qualsiasi, giace sempre un terzo, anche se le sue caratteristiche non sono per noi percettivamente
differenti da quelle dei suoni vicini 239 .
L’esperienza dell’ascolto musicale coinvolge molti sistemi metaforici, di questi
quelli fondamentali sono tre: lo spazio, il movimento e l’azione. Essi non vanno intesi
in ordine ad alcuni tipi di attribuzione che possiamo riferire alla musica attraverso
l’istituzione di rapporti isomorfici quali soggetti di riferimento espliciti, idonei a rilevare criteri di somiglianza.
Spazio movimento e azione sono in noi: la musica è movimento in quanto è vita, e in quanto è vita è azione, azione che fa vibrare il nostro spazio immaginativo la
cui “forma” è la forma 240 dello spazio fenomenico attraverso cui organizziamo concettualmente la realtà ordinaria nei termini di sotto, sopra, salire e scendere, alto e basso.
È una possibilità questa del pensiero immaginativo, di fondere 241 realtà separate
da un abisso, conseguita al patto di rinunciare al dovere di credere alle cose.
Così pure, se siamo posti di fronte a un dipinto, posso chiederti di
guardare ad esso non come al ritratto di un bambino, ma come al ritratto di un nano con gli occhi da bambino, oppure non come al ritratto di una donna, ma come al ritratto di un uomo vestito da donna. Gli
esempi familiari di figure ambigue, che possiamo vedere ora in un
modo, ora in un altro, non sono delle eccezioni: esse sono semplicemente gli esempi più chiari della libertà universale che abbiamo,
quando ciò che vediamo viene visto senza credervi. Il cambiamento
di aspetto è il cambiamento da un’esperienza ad un’altra: ma esso non
è causato da alcun cambiamento nell’informazione visiva; esso implica il passaggio da un pensiero non-detto ad un altro, ciascuno incorporato in un’immagine visuale i cui contorni sensori rimangono
gli stessi 242 .
239
Ivi, pag. 20.
“Forma” è virgolettato nell’accezione riferita allo spazio immaginativo, non è virgolettato
nell’occorrenza immediatamente successiva, poiché lo spazio fisico ha realmente una (per quanto vaga)
forma.
241
Fondere qui è usato convenzionalmente, poiché esse non sono fuse nel senso ordinario del termine,
bensì mantenute in una contemporanea sospensione estetica. Usiamo fusione solo per brevità.
242
R. Scruton, The Aesthetics of Music, cit., pag. 90.
240
162
Non possiamo fornire di questa impossibile unione ulteriori descrizioni rispetto
a quanto possa fare la metafora stessa, poiché è la combinazione di parole
dell’esperienza verbale (e non ciò che essa rappresenta o descrive) a collegare parlando
cose impossibili da collegare, e coincide con “Il mettere davanti agli occhi le cose”
dell’espressione aristotelica resa proverbiale dalla Retorica.
Rimane da rilevare ancora come la coppia spazio-tempo dell’impianto metaforico musicale di Scruton, segni un deciso scarto rispetto all’orizzonte speculativo kantiano che costituiva fino a qui un sicuro orizzonte di riferimento per le argomentazioni
del filosofo inglese. Per entrambi, ma per opposti motivi, infatti spazio e tempo costituiscono le due condizioni fondamentali della conoscenza: per Kant essi sono esibiti da
un ordine pre-concettuale secondo le “forme dell’intuizione”, prima di qualsiasi rappresentazione dell’oggetto, per Scruton invece costituiscono irrinunciabilmente un dato
pienamente concettuale, senza il quale non può darsi l’esperienza musicale (così come
nessun’altra esperienza estetica).
Scruton polemizza però non tanto con Kant, quanto con quei filosofi contemporanei (come Peacocke) che, sulla scia della dottrina kantiana, hanno avanzato l’ipotesi
che un oggetto possa presentarsi alla percezione di una persona, anche se questa persona non è in grado di identificarlo mediante concetti. Scruton è ben consapevole che la
possibilità di una percezione immediata metterebbe fuori gioco tutta la sua teoria, poiché non ci sarebbe bisogno di alcuna metafora per mostrare ciò che spontaneamente si
mostrerebbe da sé alla percezione dei sensi. Non potremmo infatti udire le melodie e le
armonie come individui musicali, senza invece che si debba udirli in termini di spazio e
movimento?
La vera questione qui, secondo Scruton, non è tanto se ci possa essere
un’organizzazione pre-concettuale esibita dalla Gestalt musicale, quanto piuttosto se
sia sufficiente sentire questa organizzazione per poter sentire la musica come musica.
Su questo punto egli ha molte riserve, espresse nel seguente esempio:
Si consideri la prima frase di ‘Baa, Baa, Black Sheep’, che inizia nella tonalità C. La frase è composta nel modo che segue: due semiminime in C, due in G, e poi quattro crome in A, B, C, e A, che conducono di nuovo a G dove riposa. È del tutto possibile che un ascoltatore senta tutto ciò come un’unità, senza che senta il movimento che
noi vi sentiamo. Per lui, come per noi, la melodia inizia in C e si ferma in G, con le note intermedie che conducono dalla prima nota
all’ultima. Ma egli potrebbe ordinare le note in questa maniera, anche
se esse non avessero, per lui, nessuna direzione: anche se egli non ri163
conoscesse alcun movimento ascensionale da C a G; anche se egli
non sentisse che le crome trascinano la melodia nella stessa direzione; anche se il ritorno a G non comportasse quindi la perdita della
spinta ‘verso l’alto’. Un caso del genere sarebbe parallelo a quello in
cui una persona riconoscesse una figura come posta in piedi contro
uno sfondo, ma non avesse alcuna conoscenza della natura di tale figura. Di certo, tuttavia, saremmo portati a dire che il nostro ascoltatore, anche se ha percepito una unità musicale, non l’ha percepita come
musica. Egli ha sentito il contorno, ma non la sostanza, e il fondamentale atto di riconoscimento, che è un riconoscimento del movimento, non è ancora avvenuto 243 .
L’esempio mostra una volta di più come, secondo Scruton, la musica sia
l’oggetto intenzionale di un’esperienza che solo gli esseri razionali possono avere, e solo attraverso l’esercizio dell’immaginazione; per descriverla dobbiamo far ricorso alle
metafore, in particolare a quelle spaziali e di movimento, non in quanto esse registrano
un’analogia della musica con altri tipi di oggetti, bensì in quanto le metafore descrivono esattamente cosa sentiamo, quando sentiamo i suoni come musica. Questo, ci rimanda al dualismo da cui eravamo partiti tra un implicito sentire del corpo e un razionale sentire della mente, a quell’insanabile distanza metafisica tra natura e razionalità
che si dà nell’esperienza estetica e che solo la metafora può, per Scruton, contribuire a
ridurre. Per quanto ci riguarda, concludiamo con un’ultima citazione, questa volta di
W. Nowottny che sottoscriveremo per la sua splendida sintesi:
La critica corrente prende spesso la metafora au grand sérieux, come
uno spiraglio sulla natura della realtà trascendentale, un mezzo primario attraverso cui l’immaginazione può vedere nella vita delle cose. Questo atteggiamento rende difficile vedere il funzionamento di
quelle metafore che deliberatamente pongono l’accento sulla loro
forma, offrendosi come deliberate fabbricazioni, come mezzi primari
per vedere non nella vita delle cose, ma in quella della coscienza umana creatrice, artefice del proprio mondo 244 .
243
244
R. Scruton, The Aesthetics of Music, cit., pag. 95.
W. Nowottny, The Language Poets Use, London, 1962, pag. 89.
164
5. Malcolm Budd: metafora e isomorfismo
Nell’attuale dibattito analitico, le ipotesi legate all’adozione di modelli isomorfici sembrano fornire una buona soluzione per affrancarsi da insoddisfacenti teorie metaforiche, e opporsi al problema rappresentato in ambito formalista dalle dicotomie logiche, contro la cui autorità abbiamo visto costantemente infrangersi molti dei tentativi
di vincolare le categorie dell’espressività alla struttura della musica, da Hanslick in poi.
Oggetti appartenenti ad ambiti disomogenei presentano, talvolta, alcune caratteristiche di somiglianza rintracciabili nel ruolo che ognuno di essi svolge all’interno del
proprio sistema di riferimento o rispetto agli altri oggetti di quella medesima struttura;
l’ordine presente nelle cose è di tipo dinamico e gli oggetti non si danno a priori ma si
fondano e ridefiniscono continuamente a partire dai dati fenomenici. Da qui la conseguente caratteristica dinamica e multiforme delle somiglianze che possono essere colte
nella realtà.
In chiave strategica, l’adozione di tali modelli sembrerebbe rivelarsi particolarmente utile per uscire dall’impasse laddove la metafora rivela le sue intrinseche contraddizioni; quelle contraddizioni che Malcolm Budd 245 segnala come casi tautologici.
La possibilità, nonché, la necessità di svincolare l’esperienza musicale dal piano
d’immanenza, le conseguenti aperture che si offrono a una dinamica trans-categoriale,
consentono al senso di evolversi dalla dimensione materiale dell’essere secondo le categorie logiche, per dispiegarsi in un campo di forze in cui i contorni dell’oggettività
stemperandosi rivelano soggiacenti similarità trasversali rispetto alle quali sembrerebbe
plausibile insinuare ipotesi alternative contro la logica del “o A o B”.
Nell’accostarsi all’isomorfismo riteniamo sia imprescindibile la rinuncia a idee
dualistiche che tendono ad opporre mente-corpo, senso-ragione, soggettivo-oggettivo,
interno-esterno e che finiscono inevitabilmente per pretendere di indagare l’uno nei
termini concettuali dell’altro, cercando poi l’impossibile sintesi in un linguaggio disincarnato e ulteriormente scisso tra letterale e non letterale, tra logica ed estetica. Se la
natura umana è una natura linguistica, il linguaggio si costituisce in un’inscindibile unità tra corpo e anima, tra ragione e senso. Nell’esperienza musicale, forse più che in ogni altro tipo di esperienza estetica, non basta seguire una logica rettilinea e deduttiva,
ma occorre invece anche un altro tipo di ragionevolezza capace di muoversi non sem245
Malcolm Budd ha insegnato filosofia alla University College of London per più di trent’anni prima
di ritirarsi dall’insegnamento e concentrarsi sui suoi scritti. Egli è stato eletto Socio della British Academy nel 1995 ed è diventato Presidente della British Society of Aesthetics nel 2004.
165
plicemente lungo una linea predefinita, ma per così dire più ampiamente e liberamente
attraverso diversi livelli di realtà, non solo per cogliere ma anche per instaurare nessi
tra le cose a partire dalla centralità del linguaggio e delle sue potenzialità estetiche.
Se esaminiamo la nota proposizione di Wittgenstein “la vocale E è gialla” ci accorgiamo immediatamente che non avrebbe senso chiedersi che tipo di cosa è rivelata
nell’affermazione, o come e perché la “giallezza” del predicato trasposto possa mantenere la sua natura 246 . Non avrebbe ugualmente senso domandarsi se ci troviamo al cospetto di una metafora, di una folgorazione sinestetica o di qualcos’altro, o peggio interrogarsi su cosa egli volesse dire dicendo … ciò che ha detto. Molto più semplicemente, Wittgenstein spiega il carattere non traslato di questa affermazione (che è del
tutto simile alla proposizione ‘questa musica è malinconica’) chiamando in causa una
sensazione primaria che conserva la sua integrità anche alla fine del processo logico
che la porta all’evidenza e che anzi diviene in essa pienamente reale e condivisibile. Si
potrebbe dire che ciò che sta alla base di affermazioni come quelle appena riportate sia,
secondo Wittgenstein, una sorta di “sensazione del pensiero” 247 : un pensiero che sfiora
la verità lasciandosi intercettare dalla realtà linguistica e che, pur sfuggendo a qualsiasi
richiesta di spiegazione, realizza non di meno quell’identità tra senso e linguaggio che
costituisce probabilmente un punto centrale dell’interpretazione per l’analisi della questione di cui qui ci occupiamo. La stessa questione che autori come Langer, Pratt e
Budd hanno variamente reinterpretato, con esiti talvolta controversi.
È importante a questo punto sottolineare quanta e quale importanza rivesta ancora oggi una tesi di tipo isomorfico, anche laddove una ripresa di essa si manifesti solo in forma talvolta trasversale, talvolta celata, e talaltra volutamente omessa, ma solo
nell’ottica forse di prendere le distanze da certe “contaminazioni” che l’isomorfismo ha
contratto. Budd in ogni caso non manifesta (almeno dal punto di vista delle intenzioni)
nessuna reticenza nel riappropriarsi della tesi isomorfica in maniera assolutamente dichiarata.
I testi cui facciamo riferimento consistono in una serie di articoli di Malcolm
Budd scritti tra il 1983 e il 2005 248 in cui l’autore passa più volte in rassegna le princi246
L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, cit., pag. 284.
S. Vizzardelli, “Musica”, in Le Arti nell’estetica analitica, cit., p. 103.
248
M. Budd, Motion and Emotion in Music: How Music Sounds, “The British Journal of Aesthetics”, 23,
1983, 209-221; Music and the Emotions: The Philosophical Theories, Rutledge & Kegan Paul, London,
1985a; Understanding Music, “Proceedings of the Aristotelian Society”, Supp. Vol. 59, 1985b, 233-248;
Music and the Communication of Emotion, “Journal of Aesthetics and Art Criticism”, 47, 1989a, 129138; Music and the Expression of Emotions, “Journal of Aesthetic Education”, 23, no. 3, 1989b; “Review of Walton’s Mimesis as Make-Believe”, “Mind”, 101, 1992, 195-198; Values of Art, The Penguin
247
166
pali questioni che animano il dibattito analitico contemporaneo attraverso la comparazione incrociata di alcuni tra gli autori contemporanei più influenti, ripartendo dalla
storica contrapposizione tra formalisti ed espressionisti/disposizionalisti. I temi della
comprensione musicale, dell’immaginazione, del realismo, del linguaggio, la questione
della metafora e della parafrasi, l’oggettività delle emozioni s’intrecciano in un dibattito serrato ma privo di direzionalità, dal quale emerge lo sforzo dell’autore di cogliere il
significato della musica come “forma d’arte” e di capire come le categorie emozionali
giocano un ruolo nella comprensione e nell’apprezzamento di essa, sia in riferimento al
suo valore intrinseco, sia in riferimento a valori esterni: la musica per Budd è un’arte
astratta in quanto non è basata sulla capacità umana di rappresentare o riferire i propri
elementi al mondo esterno, ciò nondimeno sarebbe sbagliato inferire che l’esperienza e
il valore della musica non possano essere relazionati al mondo extra-musicale.
La peculiarità della sua riflessione consiste essenzialmente proprio nella ricerca
di una sintesi in grado di dare risposta alla domanda: in che modo è possibile ascoltare
una particolare emozione nella musica? Budd si avvale dell’idea di Schopenhauer come chiave di lettura per spiegare la capacità della musica di contenere o incorporare
un’emozione. Secondo il filosofo tedesco la musica è rappresentazione diretta
dell’intima essenza del mondo, ovvero di quella “Volontà” che nell’uomo si realizza
con particolare vivacità nell’esperienza delle varie emozioni; egli riconduce a questa
relazione diretta tra musica ed esperienza emotiva la spiegazione del fascino profondo
prodotto dalla forma d’arte musicale:
[La musica] non esprime questa o quella gioia particolare e determinata, questo o quell’affanno o dolore o terrore o giubilo o allegria o
tranquillità d’animo; bensì la gioia, l’affanno, il dolore, il terrore, il
giubilo, l’allegria, la tranquillità di spirito stessi, per così dire in abstracto, ciò che in essi è essenziale, senz’alcun accessorio, e dunque
anche senza i relativi motivi 249 .
Tale affermazione equivale a dire che ciò che la musica riflette è costituito dalle
forme, infinitamente diverse, in cui il contenuto non-rappresentazionale e nonconcettuale delle emozioni − la ‘quintessenza astratta’ della soddisfazione e della insoddisfazione − può venire esperito nel tempo. Budd interpreta l’intuizione schopen-
Press, London, 1995; Aesthetic Realism and Emotional Qualities of Music, “The British Journal of Aesthetics”, 45, 2005, pp. 111-122; Musical movement and aesthetic metaphors, “The British Journal of
Aesthetics”, 43 (3), 2003, 209-223.
249
A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, cit., pag. 521.
167
haueriana concedendo un maggior grado di espressività alla musica e rimarcando
l’importanza del concetto di somiglianza tra la musica e l’esperienza emozionale, diciamo così, diretta dell’ascoltatore: se nell’idea di Schopenhauer la musica è una rappresentazione di ciò che non può essere rappresentato, nell’interpretazione di Budd, la
vita interiore di un’emozione può manifestarsi nella musica, incarnandosi nei vari aspetti dell’esperienza fenomenologica.
Budd dichiara di non essere interessato a una ricognizione storica, bensì a una
riflessione prettamente filosofica, che lo guida attraverso le diverse posizioni in campo
alla ricerca di un metodo, o di quella che egli definisce “base canonica” 250 , a partire
dal quale i giudizi sulle proprietà estetiche vengono elaborati sulla base di
un’esperienza percettiva e immaginativa capace di connettere la musica nel suo essere
pura struttura sonora, con l’innegabile fatto che essa in qualche modo è implicata nella
fenomenologia di alcuni tipi di emozioni umane: alcuni fenomeni musicali infatti non
esistono solo nella musica e la nostra familiarità con le loro istanze non-musicali può
giocare un ruolo determinante nella nostra esperienza d’ascolto, come quando la nostra
risposta riconosce una relazione isomorfica tra il ritmo e determinati movimenti corporei ad esso corrispondenti .
Le teorie metaforiche risultano incapaci nell’insieme di fornire una risposta adeguata alla questione relativa all’espressività musicale, risposta che, secondo Budd, è
invece più adeguatamente reperibile nell’adozione di un modello isomorfico o come
egli la definisce in Values of Art, di una concezione minimale di base 251 da contrapporre alle teorie metaforiche “forti” di Scruton e Goodman, che sia pure in diversi contesti
e non sempre per ragioni coincidenti o derivanti (come per altro abbiamo approfondito)
da una medesima interpretazione della metafora applicata alla spiegazione della musica, avevano ugualmente teorizzato l’imprescindibile necessità del ricorso a una teoria
metaforica per dar conto dell’attribuzione di proprietà emotive alla musica.
Budd in realtà non nega le importanti funzioni della metafora, riconoscendole
anzi, in ossequio al pensiero di Donald Davidson, il merito di segnalare un problema
laddove le lacune del linguaggio non sarebbero in grado di dar conto della complessità
del problema musica-emozioni. Ciò che Budd nega è la loro necessità, perché metafo-
250
Il riferimento è all’articolo Aesthetic Realism and Emotional Qualities of Music, cit., pag. 111.
L’aspetto centrale della “concezione minimale di base” consiste nell’idea secondo cui la percezione
dell’espressività musicale, consiste nell’esperienza di una somiglianza tra, da un lato gli oggetti di una
modalità sensoria, e dall’altro degli stati psicologici interni.
251
168
ricità ed ineliminabilità non sono per lui compatibili 252 , dal momento che una metafora, stando a quanto dice Davidson, deve sempre poter essere parafrasata, ovvero tradotta in una corrispondente locuzione letterale. Così come non si può descrivere un dipinto
senza l’uso (evidentemente letterale) del linguaggio dei colori, similmente non si può
descrivere l’esperienza dell’ascolto prescindendo dall’uso del vocabolario inerente la
teoria musicale. L’ambito della metafora è pertanto assegnato alla competenza dell’uso
e non a quella del significato, poiché essa (metafora) non spiega perché descriviamo le
opere d’arte utilizzando termini corrispondenti agli stati d’animo delle creature senzienti 253 . Il suo significato invece coincide senza residui col significato letterale, ovvero denotativo, di ciò che in essa vien detto, salvo poi decidere circa il vero o il falso
dell’asserzione espressa. La convinzione di Budd è che quando la musica viene descritta come triste, la parola «triste» è usata proprio nel senso in cui è normalmente riferita
ai discorsi ordinari del sentimento, ovvero letteralmente.
La riflessione filosofica di Budd appare a tratti un complesso sistema filosofico
ritagliato trasversalmente all’interno di teorie spesso eterogenee: muovendosi per aggiunte ed emendamenti, secondo il tipico stile degli articoli qui esaminati, a rimanere
irrimediabilmente sacrificata è una visione complessiva e unificante, dove le diatribe
polemiche tipiche della contrapposizione punto-per-punto delle sue argomentazioni
spingono costantemente in secondo piano ciò che sembrerebbe un passaggio obbligato,
ovvero il problema del riconoscimento di quel senso di profonda contiguità tra ciò che
nominiamo metafora e ciò che nominiamo analogia. Risulterebbe infatti in linea con lo
spirito del metodo isomorfico riconoscere nell’una e nell’altra una differenziazione
convenzionale più che uno status naturale, e dunque una variazione del grado di senso
all’interno di quel continuum costituito dal linguaggio, e non già l’individuazione di
“oggetti” di genere differente: superando alcune differenze terminologiche non sembre252
Cfr. Budd, Understanding Music, cit. Qui Budd attacca l’affermazione di Scruton che le metafore usate per descrivere la musica sono ineliminabili. Budd sostiene che ineliminabilità e metaforicità si escludono a vicenda. In alcuni casi (compresi quelli descritti da Scruton) i termini sono eliminabili e metaforici; in altri essi possono essere eliminabili e non metaforici; e in altri ancora essi sono ineliminabili e
quindi non possono essere metaforici. Cfr. R. Scruton, The Nature of Musical Expression, cit.
253
Questo è stato anche evidenziato da Stanley Cavell, il quale, in un articolo del 1977, affermava che
“ciò di cui abbiamo bisogno è una spiegazione del perché descriviamo le opere d’arte utilizzando termini
che sono solitamente confinati alla descrizione degli esseri senzienti (più specificatamente, delle persone). Dire che la descrizione è metaforica senza aggiungere nient’altro, equivale ad evitare di fornire
l’analisi che qui è richiesta”. L’articolo è “Music Discomposed”, in Must We Mean What We Say?,
Cambridge, Cambridge University Press, 180-212. Anche Davies sottolinea che non c’è ragione di pensare che il riferimento alla metafora possa sostituire l’analisi del fenomeno che è invece necessario spiegare: l’espressività della musica. Questa è l’accusa che può essere rivolta a Scruton, The Nature of Musical Expression, cit; D. A. Putman, Music and Metaphor of Touch, “Journal of Aesthetics and Art Criticism”, 44, 1985, 59-66; Id., Some Distinctions on the Role of Metaphor in Music, “Journal of Aesthetic
Education”, 23, 2, 1989, 103-106; M. Evans, Listening to Music, Macmillan, London, 1990.
169
rebbe, per esempio, azzardato individuare una serie di contiguità sostanziali con l’idea
metaforica del rivale Scruton certamente propenso anch’egli all’accettazione di un sistema di significazione analogico 254 . Ma è sul comune piano dell’immaginazione consapevole e informata che le distanze sembrano ulteriormente ridursi a una mera forzatura tassonomica in linea con il tipico uso di rimarcare i contrasti, sorvolando così
spesso sugli aspetti comuni sostanziali: la strategia di Budd di svincolarsi dalla metafora necessitata di Scruton è evidentemente prioritaria rispetto al rilevamento di alcune
sostanziali identità che pure si mostrerebbero evidenti. Senza contare per inciso che
molte delle teorie metaforiche moderne, (pensiamo nello specifico alla teoria interattiva
di Max Black in primis) ipotizzavano già l’esistenza di una rete sotterranea di rapporti
contrassegnata da scambi di somiglianze analogiche responsabili del venire alla luce
delle conseguenti manifestazioni metaforiche.
Se è vero, dunque, che Budd si muove con l’intento di riconoscere a tutte le idee in campo un qualche barlume di verità, è altrettanto vero che non sempre emerge
un approfondimento esaustivo delle questioni poste, e d’altra parte il sostanziale ed esplicito riconoscimento del valore del metodo isomorfico, in senso generale appare più
improntato ad un uso di tipo strategico-difensivo di quanto non sia propositivo in senso
pieno: le idee di Budd non sembrano liberarsi per esempio da un eccesso di prudenza
quando tenta di rimuovere alcuni aspetti (peraltro sostanziali) della tesi di Langer il cui
fascino, innegabilmente suscitato sin dal suo apparire negli anni 40’ sulla scena filosofica, è stato costantemente accompagnato da una latente diffidenza. L’influenza neopositivista della prima riflessione analitica e probabilmente la controversa (e spesso fraintesa) eredità della concezione linguistica wittgensteiniana continuano a rappresentare
per la scuola analitica una sorta di limite invalicabile, al di là del quale si prospetterebbero pericolose aperture metafisiche certamente non auspicabili.
In questo contesto sembra possibile inquadrare la tiepida accettazione del simbolismo langeriano da parte di Budd che a proposito dei presunti difetti di quella teoria
sostiene che l’idea secondo cui l’asserzione verbale è pressoché inutile per trasmettere
in maniera precisa delle conoscenze relative al particolare carattere della nostra vita affettiva è imputabile alla sottovalutazione della Langer delle considerevoli risorse del
linguaggio per descrivere come ci sentiamo. Budd sostiene infatti che Langer è erroneamente indotta, dall’enfasi che ella pone sui termini emotivi generici/comuni, a pensare
che il linguaggio non possa possedere una specificità quando è adoperato per descrive254
Si rimanda alla lettura del paragrafo su Scruton.
170
re i sentimenti – e questa presunta inadeguatezza viene quindi spiegata come una conseguenza della discrepanza tra la modalità di rappresentazione propria del linguaggio e
la struttura della nostra vita emotiva. Ma tale spiegazione – egli precisa – è ridondante.
Poiché non è vero che, per descrivere il modo in cui ci sentiamo, dobbiamo limitarci ad
usare le parole del linguaggio ordinario che designano i vari tipi di emozioni, tutt’al più
integrandoli facendo riferimento ad alcune delle circostanze che fanno pensare al sentimento in questione. I sentimenti del tipo al quale Langer fa riferimento nella sua discussione sul significato della musica derivano la loro articolazione e la loro complessità dai pensieri sui quali sono fondati. Di conseguenza, la descrizione di tali sentimenti
può essere effettuata con precisione, specificando i pensieri che sono integrali ad essi.
E dal momento che non vi sono pensieri il cui contenuto non possa essere rappresentato
nel linguaggio, non vi è in linea di principio alcuna difficoltà a descrivere in maniera
precisa la natura particolare di un sentimento.
Sul piano del linguaggio si articola dunque buona parte del pensiero di Budd: la
possibilità di una caratterizzazione linguistica della precisa natura degli stati interni, diventa un problema centrale.
Budd contesta con i medesimi argomenti la seguente celebre frase di Felix
Mendelssohn: “i pensieri che sono espressi da un brano musicale che amo non sono
troppo indefiniti per essere tradotti in parole, ma al contrario sono troppo definiti” 255 ;
dietro affermazioni di questo tipo, non si cela una semplice denuncia delle presunte carenze di una certa lingua, bensì un’impossibilità di principio che rimanda a una presunta incommensurabilità di tipo logico e dunque irriducibile tra il linguaggio da una parte
e le emozioni espresse da un brano musicale dall’altra. Una concezione, questa, tipicamente solipsistica, secondo cui le emozioni nella vita (oppure nella musica) appaiono
più difficilmente descrivibili di quanto non lo siano gli oggetti materiali. Budd ritiene
che tale visione delle cose non è convincente, argomentando che anche se è plausibile
ammettere che le capacità espressive della musica eccedano in qualche misura quelle
della lingua ciò non vuol dire che esse non potrebbero mai essere espresse in virtù della
presunta mancanza di corrispondenza tra la natura determinata delle emozioni e quella
indeterminata del linguaggio. Altrove afferma, ad ulteriore conferma, che anche quando, per effetto di certe carenze del linguaggio, alcuni concetti non presentino un corrispettivo significato referenziale, tali carenze potrebbero essere emendate ricorrendo exnovo ad un termine adatto.
255
F. Mendelssohn, Lettera a Marc André Souchay, Berlin, 5 October, 1842,
171
Al medesimo principio è improntato il suo rifiuto nei confronti delle teorie metaforiche che pretenderebbero di “catturare” il senso dell’indicibile traendolo da
un’originaria condizione di indeterminatezza per portarlo all’evidenza del linguaggio
positivizzando il carattere di vaghezza del discorso metaforico. Budd non riconosce valore a idee di questo tipo, poiché la concettualizzazione categoriale è per lui indipendente rispetto alla formulazione linguistica che la porta all’evidenza del linguaggio, e
in fondo la sua polemica con Goodman sembra rimandare in ultima analisi proprio al
disconoscimento di quel valore speciale della metafora che coinciderebbe con la possibilità stessa di esperire e non semplicemente nominare, etichettandoli, nuovi domini di
riferimento, altrimenti inattingibili e dunque necessariamente metaforici.
In polemica con Scruton, Budd respinge in particolare l’idea che le nozioni di
movimento e azione 256 possano essere applicate alla musica metaforicamente, pur riconoscendo che nell’ascolto musicale c’è qualcosa in più rispetto a una semplice percezione di suoni, ma qualunque sia questa cosa, non esiste ragione perché non possa essere detta secondo le regole di significazione del linguaggio ordinario. Budd ritiene insoddisfacente l’assunto secondo cui movimento e azione sono metaforici, poiché una
tale teoria non spiega ciò che dovrebbe spiegare se non è dotata di una motivazione in
grado di individuare lo scopo; motivazione della quale il pensiero di Scruton evidentemente è privo.
L’individuazione dello scopo di una metafora consiste nell’esplicazione del suo
significato; conseguentemente perché una metafora possa definirsi tale deve, sostiene
Budd, poter essere convenientemente parafrasata, ma una proposizione come “la musica è triste” non può essere parafrasata perché il suo scopo non può essere catturato
senza il riferimento al carattere emotivo dell’espressività della musica: la parola “triste” non può essere eliminata dalla descrizione della metafora della quale costituisce il
predicato trasposto, ovvero non può essere sostituita. Una parafrasi di essa non potrebbe comunque non contenerla, e dunque conclude Budd è come dire la stessa cosa con
altre parole. Budd sembra raggiungere in tal modo, con successo, lo scopo di dimostrare come quello della metafora sia in fondo un problema tautologico, ma da questo de256
M. Budd, Music and the Communication of Emotion, cit., pag. 132. «Se la funzione di una metafora è
quella di indicare una qualche somiglianza tra M e E o un’espressione corporea o vocale di E, allora
l’esperienza può essere caratterizzata come la percezione di tale somiglianza. Ma l’effetto di una siffatta
mossa è quello di abbandonare, piuttosto che risollevare, la spiegazione metaforica proposta. Poiché se è
possibile esplicitare lo scopo della metafora e utilizzarlo per fornire una caratterizzazione indipendente
dell’esperienza allora la nozione di metafora non ha un ruolo fondamentale nella specificazione della natura dell’esperienza. Pertanto la spiegazione dell’esperienza nei termini della metafora o è emendabile
oppure non è illuminante».
172
stino sembra non sfuggire la sua stessa spiegazione poiché più avanti suggerisce l’idea
che per superare questa impasse, la parafrasi potrebbe a sua volta contenere essa stessa
termini metaforici, a patto che questi non costituiscano parte della metafora alla quale
essa sta come parafrasi, e così rimandando evidentemente all’infinito la soluzione del
problema.
Per i sostenitori delle tesi metaforiche (Goodman in particolare) 257 questo non è
un metodo adatto per analizzare la questione, ma solo un punto di vista, poiché la non
parafrasabilità di tali descrizioni, piuttosto che mettere in discussione lo status di metafore, rivela invece i limiti del linguaggio letterale ai quali il ricorso alla metafora è un
tentativo di rimediare. Questo passaggio ci dà modo di ritornare ancora una volta sulla
circostanza, qui particolarmente esemplare, di come l’impossibilità di pervenire a un
accordo, sia frutto di un errore che sta alla base: quello di considerare il linguaggio metaforico e quello letterale come i campi di due domini inconciliabili di significazione
linguistica, e di come l’insistita e colpevole miopia a voler interpretare di volta in volta
l’uno nei termini concettuali dell’altro finisce inevitabilmente per determinare un cortocircuito. Lo stesso Davidson a cui Budd fa riferimento si mostra molto meno interessato alla questione della parafrasabilità di quanto non possa sembrare, limitandosi prudentemente a collocare il problema in una posizione più defilata rispetto ai problemi
sostanziali posti dalla questione metaforica 258 , e concludendo infine che la metafora
non presenta rispetto al linguaggio letterale alcun tipo di problema specifico tale da necessitare il ricorso a un trattamento speciale rispetto ai casi ordinari.
Ritornando alla questione centrale è interessante per noi soprattutto rilevare
come l’adozione di una tesi isomorfica consenta a Budd di invalidare una volta per tutte tesi metaforiche necessarie (la tesi della necessità metaforica), come ad esempio
quella già esaminata di Scruton. Nello specifico l’idea cui Budd manifesta una particolare attenzione è una delle prime tesi isomorfiche comparse nella storia della riflessione
filosofica sulla musica. Si tratta della tesi di Carroll Pratt. Ci preme precisare che
257
«L’applicazione metaforica dei termini ha l’effetto, e spesso lo scopo, di tracciare significativi confini
che agevolano il superamento di abitudini logorate dall’uso e di selezionare nuove specie importanti per
le quali non abbiamo ancora descrizioni letterali semplici e familiari». Cfr. N. Goodman, Metafora come
luce della luna, cit. pag. 156.
258
«Concordo con l’opinione che le metafore non possono essere parafrasate, ma penso che ciò sia vero
non perché le metafore dicano qualcosa di troppo inconsueto per essere espresso letteralmente, bensì
piuttosto perché non c’è in esse niente da parafrasare. Possibile o no la parafrasi attiene a quanto viene
detto, nella parafrasi si tenta di dire la stessa cosa in un altro modo. Ma, se vedo giusto, una metafora
non dice nulla al di la del suo significato letterale […] Infatti una metafora dice solo ciò che esibisce apertamente: di solito una falsità palese o una verità assurda. E questa verità o falsità ovvia non ha bisogno di parafrasi alcuna: il suo significato è dato dal significato letterale delle parole». Cfr. D. Davidson,
Che cosa significano le metafore, cit., pp. 137 e 149.
173
l’applicazione alla musica di una siffatta tesi isomorfica, derivata dagli studi prima
scientifici e successivamente psicologici, era già stata operata da Riemann il quale
nell’opera Wie hören Wir Musik? scrive: «In verità, non è affatto questione di esprimere emozioni perché … la musica solo commuove l’animo in modo analogo a quello in
cui lo commuove l’emozione, senza tuttavia pretendere in alcun modo di farla sorgere
(ed ecco perché non significa nulla il fatto che effetti del tutto eterogenei abbiano forme dinamiche simili, e possano perciò esser “espressi” dalla stessa musica, com’è già
stato osservato, e molto giustamente da Hanslick) …» 259 .
Tale teoria è quella successivamente sviluppata da Pratt, il quale (evidentemente in modo affatto indipendente da Riemann) è venuto alla conclusione che la musica
né causa, né elabora sentimenti reali, ma produce certi effetti peculiari che noi scambiamo per sentimenti. La musica ha il suo speciale carattere uditivo che, «intrinsecamente contiene certe proprietà, le quali, in grazia della loro stretta somiglianza con certe caratteristiche del dominio soggettivo, vengono frequentemente confuse con vere e
proprie emozioni» 260 , ma «queste caratteristiche uditive non sono affatto emozioni:
semplicemente, suonano come gli stati d’animo sentono 261 … Più spesso che no, queste caratteristiche della musica non hanno un nome: sono semplicemente ciò che la musica è …» 262 . È il caso di precisare che è questa la tesi di Pratt cui ancor prima di Budd
si era ispirata e aveva guardato Langer, la quale, muovendo dagli esiti particolari degli
studi gestaltici e per l’appunto dalla tesi isomorfica di Pratt, cui non manca di fare esplicita menzione nell’opera Filosofia in una nuova chiave, ripensa le funzioni
dell’isomorfismo. Esso si traduce in una somiglianza tra la morfologia del feeling umano e le proprietà strutturali-formali della musica, più che in una somiglianza tra il movimento in musica e i movimenti del e nel corpo, per come l’analogia si configura nella
concezione di Pratt. Anche per Langer infatti l’espressività della musica non è il risultato del trasferimento dei sentimenti che qualcuno ha sentito né tantomeno è da intendersi come residuo emotivo delle impressioni che ha destato in noi l’ascolto, piuttosto
evidenzia energicamente Langer: «formulazione e rappresentazione di emozioni, stati
d’animo, tensioni mentali e risoluzioni: un “ritratto logico” della vita senziente e responsiva, una fonte di intendimento, non una richiesta di simpatia. I sentimenti rivelati
dalla musica non sono essenzialmente, “la passione, l’amore o il desiderio del tale o del
259
H. Riemann, Wie Hören wir Music? (Come ascoltiamo la musica?), Leipzig, 1888, pp. 22-23.
C. C. Pratt, The Meaning of Music, New York and London, McGraw-Hill Book Co., 1931, pag. 191.
261
Corsivo mio.
262
Ivi, pag. 203.
260
174
tal altro”, un invito a metterci nei suoi panni, ma sono direttamente presentati alla nostra intellezione, sì che possiamo afferrare, realizzare, comprendere questi sentimenti
senza pretendere di averli, o imputarli a qualcun altro. Proprio come le parole possono
descrivere eventi di cui non siamo testimoni, luoghi e cose che non abbiamo visto, così
la musica può presentare emozioni e stati d’animo che non abbiamo sentito, passioni
che non avevamo prima subìto. Il suo soggetto è lo stesso che nell’autoespressione e i
suoi simboli possono addirittura esser mutuati occasionalmente, dal dominio dei sintomi espressivi; ma gli elementi suggestivi così mutuati sono formalizzati e il soggetto
“distanziato” in una prospettiva artistica» 263 . Sulla scia inoltre di quell’anima formalista di matrice hanslickiana che ha animato anche lo spirito di Pratt, e che però rivendica
la necessità di ripensare la “forma” in un’accezione più significativa, troviamo anche il
riferimento di Langer al motivo (decorativismo) come espediente organizzativo delle
opere d’arte figurativa. “I motivi – scrive Langer, tentando di dimostrare che qualsiasi
forma di arte figurativa ha in sé l’anima del decorativismo – sono espedienti organizzativi che mettono in moto l’immaginazione dell’artista e ‘motivano’ l’opera in un senso
genuino. Essi la orientano e ne guidano lo sviluppo” 264 . Come evidenziato da Vizzardelli, «I motivi, in questa visione, rispondono ad un bisogno di astrazione che, pure, resta congeniale alla nostra intuizione dello spazio essendo guidato dall’interesse per la
percezione dei ritmi e delle dinamiche emotive. Per questo la composizione grafica non
è una copia di impressioni visive dirette, ma è il modo di foggiare queste impressioni
secondo i ritmi della forma vitale, è simbolizzazione originaria. I motivi non agiscono
come immagini riproduttive della realtà, sono piuttosto delle finestre artificiali che
danno accesso ad un mondo intermediario, ad un mondo in cui si assiste ad uno scambio, ad una conversione interno-esterno, ad una intercettazione di piani distinti ma isomorfici» 265 .
263
S. Langer, Filosofia in una nuova chiave, cit., pag. 286. In Feeling and Form poi così scriveva a tale
proposito: Le strutture tonali che noi chiamiamo “musica” hanno una stretta somiglianza logica con le
forme del sentimento umano: forme di sviluppo e decrescenza, di flusso e di accumulo, di conflitto e soluzione, di rapidità, arresto, somma eccitazione, calma o attivazione sottile e cadute nella sfera del sogno; non gioia e dolore, forse, ma il mordente dell’una o dell’altro o di entrambi; la grandezza e brevità e
l’eterno trascorrere di tutto ciò che è vitalmente sentito. Questo lo schema, o la forma logica del sentire;
e lo schema della musica è quella forma stessa, elaborata nella purezza e nel metro del suono e del silenzio. La musica è un corrispondente tonale della vita emotiva. Una tale analogia formale, o congruenza di
strutture logiche, è la condizione prima per la relazione fra un simbolo e tutto ciò che questo deve significare. Il simbolo e l’oggetto simbolizzato devono avere qualche forma in comune. Cfr S. K. Langer,
Sentimento e Forma, cit., pag. 43.
264
S. Langer, Sentimento e Forma, cit., pag. 86.
265
S. Vizzardelli, Musica, cit., pag. 98.
175
Le tesi isomorfiche peraltro rappresentano il terreno di incontro per Langer e
Pratt, i quali citano reciprocamente e con approvazione i rispettivi scritti. Pratt però a
differenza di Langer non è dell’idea che la musica sia un simbolo (non-referenziale),
ma egli sostiene che essa possiede un carattere emozionale, oggettivo, dovuto alla similarità formale tra il movimento musicale e le sensazioni organiche e cinestesiche che
sono i correlati e i determinanti delle emozioni. Scrive Pratt in un articolo del 1954,
“The Design of Music” 266 : «La musica tutto al più non è simbolica … il disegno tonale
non sta per niente oltre se stesso. Esso non suggerisce emozioni e sentimenti. Esso è
emozioni e sentimenti. Le qualità della percezione uditiva non sono segni iconici, neppure essi per loro stesso tramite rappresentano o imitano oppure copiano qualcosa» 267 .
E aggiunge: «Le emozioni e la lotta della volontà e del desiderio sono incarnati nella
musica non direttamente, ma indirettamente per via di disegni tonali che somigliano
fortemente nel profilo formale al movimento interno degli spiriti … Ma qui in ultimo
potrebbe essere vero che la musica diventa simbolica, perché sembra significare ed esprimere la gioia e il dolore di tutto il genere umano» 268 . Secondo la tesi di Pratt, le
emozioni sono “soggettive” (cioè esperite, come interne al corpo): «Il materiale
dell’emozione è un processo fisico, un elaborato modello di turbamento muscolare e
viscerale» 269 . La musica non può incarnare o contenere le emozioni, ma per via del suo
carattere dinamico la musica può possedere proprietà che sono simili a quelle delle
emozioni, per tale ragione si può dire che essa possiede o presenta un carattere emozionale. La musica non può “significare” (cioè, riferirsi a) emozioni; piuttosto, essa possiede proprietà formali con un oggettivo (cioè, “esterno al corpo”) carattere fortemente
simile a quello delle emozioni: «L’agitazione è sia un sentimento organico che una
percezione uditiva ma nel primo caso essa è un’emozione e nel secondo essa è
un’impressione sensoria terziaria – due modi psicologici dell’esperienza completamente differenti, che tuttavia, per via della similarità nella forma, sono chiamati con lo stesso nome. La confusione verbale è largamente responsabile della confusione nella teoria» 270 . Gli ascoltatori possono rispondere emozionalmente alla musica, ma l’espressività
della musica è indipendente dai suoi effetti. In breve, come avevamo segnalato, Pratt è
un formalista che contesta agli altri formalisti, come Hanslick, di avere eccessivamente
266
C. C. Pratt, The Design of Music, “Journal of Aesthetics and Art Criticism”, 12, 289-300.
Ivi, pag. 290.
268
Ivi, pag. 300.
269
Ivi, pag. 291.
270
C. C. Pratt, Music as the Language of Emotion, Washington, D. C.: Library of Congress, 1952, pag.
18.
267
176
contratto la nozione di forma. La musica presenta forme che colpiscono i sensi, le quali
forme sono così simili a quelle dei sentimenti, al punto che possiamo caratterizzare la
musica come triste, felice, e così via.
Muovendosi dal riconoscimento di quanta e quale fecondità possa avere
l’intuizione di Pratt, carpita sapientemente da Langer, Budd ritorna – anche in questo
caso a dispetto della critica che Scruton ha mosso alla teoria della somiglianza in The
Aesthetics of Music annoverandola come una delle tre teorie più pericolose
dell’espressione in musica 271 – ad accogliere l’idea fondante e principale della tesi isomorfica di Pratt incapsulata nel famoso slogan “la musica suona nel modo in cui le
emozioni sono vissute”, e concentra la sua attenzione, vedremo adesso nel particolare,
sull’idea (che sta a fondamento della tesi di Pratt appena citata) che vi sia un’analogia
tra i movimenti del nostro corpo e i movimenti della musica. Secondo Budd, quella di
Pratt è una delle teorie che meglio possono aiutarci a comprendere il problema
dell’espressività nella musica, sebbene nemmeno essa sia esente da problemi, derivanti
in ultimo della particolare caratterizzazione che Pratt dà del movimento musicale.
In Music and the Emotions, Budd prende le mosse proprio dalla tesi che Pratt
sviluppa nell’opera The Meaning of Music. Si tratta di un’ipotesi prettamente dualistica
secondo la quale: ciò che una persona esperisce come esterno al suo corpo è per quella
persona oggettivo e ciò che esperisce come appartenente oppure interno al suo corpo è
invece soggettivo. Secondo questo criterio gli stati d’animo e le emozioni sono soggettivi per la persona che sente tali emozioni o stati: ciò che qualcuno prova quando egli
sente preoccupazione, ansia, disagio, paura e gioia, appartiene o è interno al suo corpo.
Un’emozione è soggettiva nel senso che ciò che viene sentito è localizzato all’interno,
piuttosto che all’esterno, del corpo del soggetto. Quando una persona esperisce
un’emozione, ella sente la contrazione della fronte, la tensione dei suoi muscoli, il san271
In ordine, tali teorie sono: a) la teoria biografica, secondo la quale un’opera d’arte esprime uno stato
della mente perché l’artista “mette nell’opera il suo stato mentale”; b) la teoria dell’evocazione: spostando l’attenzione dall’artista allo spettatore-ascoltatore, questa teoria identifica l’emozione espressa da
un’opera con l’emozione indotta nell’ascoltatore. Dobbiamo invece distinguere il significato di un’opera
dal suo significato per me. Dire che io associo ad un’opera musicale certi miei sentimenti, esperienze,
memorie è come non dire niente sul suo carattere musicale. L’espressione appartiene invece, ci suggerisce Scruton riprendendo esplicitamente la tesi crociana della sintesi intuitiva, al carattere estetico di
un’opera d’arte. Si può apprezzare l’espressività di un’opera solo prestando attenzione a essa, e ascoltando l’emozione in essa. Basta distrarsi e l’esperienza svanisce. Ma si possono apprezzare le associazioni fatte durante l’ascolto di un’opera musicale anche chiudendo la mente ad essa, anche distraendosi.
Quelle associazioni sono provocate, stimolate dall’esperienza estetica, ma si estendono molto al di là di
essa; c) la teoria della somiglianza: secondo questa teoria l’espressione in musica è fondata sull’analogia
o somiglianza tra una struttura musicale e uno stato mentale. Scruton ritiene che la teoria della somiglianza musica-emozioni sia maldestramente al centro del dibattito estetico a partire dalle tesi di S. Langer fino alle ipotesi sviluppate M. Budd e P. Kivy. Cfr. R. Scruton, The Aesthetics of Music, cit., pag.
144-148.
177
gue che pulsa, o qualche altro accadimento interno o diretto al proprio corpo. Ma talvolta parliamo degli stati d’animo e delle emozioni come se si pensasse che essi possano essere proprietà di fenomeni che sono per ciascuna persona oggettivi – in particolare, come se essi possano essere proprietà della musica. Eppure non può essere letteralmente vero che la musica incarna l’emozione, perché essa non è un corpo vivente che
sente i propri processi corporei. In che modo, allora, dobbiamo intendere la descrizione
della musica come agitata, calma, malinconica, seducente, inquieta, pomposa, appassionata, triste, trionfante o bramosa 272 ?
L’intento di Pratt, nell’ambito di questa riflessione, è quello di contrapporre
un’alternativa alla teoria secondo la quale questi sono semplicemente stati d’animo o
sentimenti che l’ascoltatore erroneamente ha trasferito da se stesso alla musica perché è
diventato vittima di quella che Ruskin ha chiamato “fallacia patetica” (the pathetic fallacy) 273 . Ruskin ha creduto infatti che le nostre emozioni possono causare una falsità
nella nostra esperienza del mondo esterno. Gli oggetti fisici possono cioè assumere false apparenze sotto l’influenza di violente emozioni, per questo motivo noi siamo portati ad attribuire a tali oggetti caratteristiche che in realtà essi non possiedono. Noi attribuiamo agli oggetti inanimati caratteristiche che sono specifiche delle cose viventi e attribuiamo ad altri tipi di cose viventi qualità che solo gli esseri umani possiedono. Sebbene sappiamo che le creature non-umane non possiedono caratteristiche specificatamente umane e che gli oggetti inanimati non sono forme di vita, le emozioni hanno il
potere di farceli apparire diversamente: questi oggetti possono cioè apparire come se
fossero caratterizzati da proprietà che essi sono incapaci di possedere. Lo stato eccitato
dei nostri sentimenti ci rende, per un certo periodo, irrazionali. Mentre la nostra ragione
è temporaneamente sconvolta, immaginiamo che gli oggetti che percepiamo abbiano
caratteristiche che sappiamo essi non possono avere.
Se qualcuno che ascolta musica è così potentemente colpito dalla musica al
punto di arrivare a pensarla come animata e a percepirla come qualcosa che è in uno
stato emotivo, allora questa falsità nella sua coscienza è un esempio di tale fallacia patetica: è stata la forza dei sentimenti che lo ha spinto a proiettare nella musica
l’emozione che egli sente. Secondo Budd, tuttavia, un’illusione che comporti la dislocazione dell’emozione vissuta da un soggetto in un oggetto inanimato, non è un qualcosa al quale siamo naturalmente portati a credere. Inoltre la descrizione della musica
in termini emotivi, così concepita, è sempre ingiustificata: un carattere è stato erronea272
273
Cfr. C. C. Pratt, The Meaning of Music, cit., 157-162.
John Ruskin, Modern Painters, Volume III, London, 1856, Cap. XII.
178
mente trasferito dall’ascoltatore alla musica, ma la descrizione della musica come
gioiosa, triste o trionfante non sempre è inappropriata.
Forse, allora, la descrizione emotiva della musica è semplicemente un modo fantasioso di parlare in cui le emozioni apparentemente attribuite alla musica dovrebbero
essere intese come emozioni che sono provate dall’ascoltatore; ciò che l’ascoltatore,
esprimendosi in questa maniera, vuole significare, può essere quindi vero, sebbene egli
si esprima in modo ingannevole. Tuttavia questa proposta è di poco migliore di quella
precedente: poiché sebbene non richieda che l’ascoltatore esperisca emozioni così violente da fargli perdere la ragione, essa invero richiede che provi l’emozione che egli
stesso apparentemente attribuisce alla musica. Eppure non è necessario che un individuo si senta trionfante, triste, allegro, affinché egli possa correttamente caratterizzare la
musica attraverso i nomi di queste emozioni. Per Budd infatti, è il caso di mettere in
chiaro con vigore, vale il concetto fondamentale secondo cui le qualità delle emozioni
sono proprietà udibili della musica: il modo più basilare in cui esperiamo la musica
quando la sentiamo come espressiva di un’emozione consiste nel sentire l’emozione, di
cui la musica è espressiva, come caratterizzante la musica stessa, come quando la sentiamo come sobria, malinconica, allegra o felice: noi sentiamo l’emozione nella musica. In che modo, allora, dobbiamo interpretare l’apparente attribuzione di stati d’animo
e di emozioni alla musica?
La soluzione che Pratt dà a questo problema è una soluzione di tipo isomorfico,
come d’altronde avevamo evidenziato, ed è una soluzione cui Budd – interessato
anch’egli a contravvenire una volta per tutte a ragionamenti come quelli insiti nella teoria della fallacia patetica che spesso, crediamo di comprendere, confluiscono anche
nell’approdo di alcune particolari caratterizzazioni metaforiche – guarda con attenzione
considerandola meritevole di ulteriori approfondimenti. L’idea di Pratt, così esposta da
Budd, è la seguente:
Ci sono movimenti sia del, che nel, corpo: il nostro corpo può muoversi ed è esso stesso un luogo di movimenti. Alcuni di questi movimenti vengono sentiti attraverso sensazioni organiche e cinestesiche.
Il fatto che possiamo sentire cinestesicamente ed organicamente i
movimenti corporei è la principale ragione per cui, per descrivere il
modo in cui ci sentiamo, utilizziamo parole che indicano il carattere
dinamico del movimento. Le parole ‘forte’, ‘debole’, ‘languido’, ‘agitato’, ‘inquieto’, ‘tranquillo’, ‘eccitato’, ‘quieto’, ‘indeciso’, ‘grazioso’, goffo’, ‘maldestro’, ‘rapido’, ‘ritmico’ e ‘fluente’, ad esempio,
possono correttamente essere usate per descrivere il modo in cui ci
sentiamo. Ma queste parole si applicano ugualmente alle qualità dei
179
movimenti corporei di cui facciamo esperienza. Perciò, se c’è un’altra
specie di movimento che possiede queste stesse caratteristiche del
movimento sentito nel nostro corpo, queste parole possono essere applicate con uguale efficacia ad altre specie di movimento. Di conseguenza non c’è nessuna fallacia patetica in questo uso delle parole.
Ed infatti il movimento musicale possiede caratteristiche del tipo richiesto. Quindi, un’affermazione come “la musica è angosciata”,
quando è vera, è letteralmente vera 274 .
L’applicazione della nozione di movimento alla musica è, come Budd non manca di evidenziare, un’operazione alquanto problematica. Tuttavia la nozione di movimento musicale sostenuta da Pratt sembra essere più convincente di quella proposta da
altri filosofi, in particolare Scruton. Entrambi prendono seriamente in considerazione la
rilevanza che, nella critica musicale, i termini indicanti determinate forme di movimento rivestono. Tuttavia, mentre per Scruton tali termini hanno una necessaria valenza
metaforica − il che, in virtù delle critiche prima ricordate all’idea scrutoniana
dell’ineliminabilità delle metafore musicali, lo condanna al fallimento 275 − Pratt spera
di risolvere il problema indicando un parallelo tra, da una parte, alcuni dei processi che
ascoltiamo nella musica e, dall’altra parte, la nostra percezione del movimento tramite
la vista (by sight) e la cinestesia. Il movimento fisico è un cambiamento di posizione
nello spazio. Se consideriamo un semplice caso di movimento di traslazione, allora
percepiremo il movimento attraverso la vista in virtù del fatto che il nostro campo visivo contiene una successione di qualità visive simili poste in differenti posizioni. Quando uno strumento musicale fa seguire, a una nota, un’altra nota avente una diversa frequenza, noi sentiamo, uno dopo l’altro, suoni simili corrispondenti a livelli di frequenza differenti. Ora, se noi accettiamo la tesi di Pratt sull’esperienza della frequenza, allora la nostra percezione uditiva della frequenza implica, fenomenologicamente,
l’esperienza di una dimensione spaziale. Quindi, quando uno strumento musicale suona, in successione, delle note di frequenza differente, il nostro campo uditivo contiene
qualità uditive tra loro simili e poste in una successione di posizioni differenti. Questo
parallelo tra l’esperienza di una serie di note di diversa frequenza e la percezione del
movimento tramite la vista è sufficiente, secondo quanto sostiene Pratt, a fornire le basi
per l’attribuzione alla musica di caratteristiche proprie del movimento. La musica può
contenere processi che possiedono proprietà simili a quelle che altri tipi di movimento
propriamente detti possiedono. In particolare, il movimento musicale è capace di ripro274
M. Budd, Music and the Emotions, cit., pag. 39.
Sulle critiche di Budd alla spiegazione del movimento musicale avanzata da Scruton, si veda M.
Budd, Musical Movement and Aesthetic Metaphors, cit.
275
180
durre la struttura formale del movimento fisico. Il movimento musicale – che è oggettivo – possiede proprietà molto simili a quelle del movimento corporeo – che è soggettivo (per la persona avente il corpo in questione). La stretta somiglianza tra le caratteristiche dei due tipi di movimento ci autorizza ad applicare ad entrambi, e nella stessa
maniera, le parole che indicano queste caratteristiche.
Secondo Budd, tuttavia, il tentativo di Pratt di risolvere il problema del movimento che verrebbe percepito nell’ascolto della musica è destinato al fallimento 276 . In
primo luogo, infatti, è sbagliato rappresentare le forme del movimento musicale come
un’illusione percettiva; e tuttavia questo è tutto ciò che si può trarre dalla somiglianza
tra l’esperienza dei suoni musicali con la percezione visiva e cinestetica del movimento. In ogni caso, l’esperienza di una serie di note di diversa frequenza non comporta
l’esperienza di una variazione continua nella frequenza del suono, laddove quando un
oggetto si muove attraverso il nostro campo visivo, la nostra esperienza comporta un
cambiamento continuo nella posizione occupata dall’oggetto che a noi appare. In secondo luogo, non è sempre vero che, nell’ascoltare una successione di note di diversa
frequenza, percepiamo un movimento verso l’alto e verso il basso. Ma la spiegazione
che Pratt dà del fenomeno del movimento musicale implica che noi, nell’ascoltare ciascuna di tali successioni, dovremmo percepire un siffatto movimento. In terzo luogo, la
spiegazione fornita da Pratt non è in grado di dar conto della possibilità del contrappunto: noi ascoltiamo due melodie e le percepiamo come se procedessero assieme, anche
quando le melodie sono prodotte da strumenti aventi un timbro identico o simile. Ma
l’evidente discontinuità del cambiamento nella frequenza di una successione di note ci
impedisce di modellare l’esperienza del contrappunto sulla percezione visiva di due
movimenti simultanei.
Lo stretto parallelo che Pratt voleva rinvenire tra il cosiddetto ‘movimento’ nella musica e il movimento reale, in realtà, dunque, stando alle analisi fatte da Budd, non
sussiste. Tuttavia, ciò non comporta la diretta dismissione dell’ipotesi di Pratt relativa
al modo in cui si dovrebbe comprendere l’apparente attribuzione di proprietà soggettive alla musica: difatti, sebbene la sua ipotesi cerchi di sfruttare tale presunto parallelo,
a ben vedere essa non necessita che la musica sia, o sia esperita come, una forma di
movimento: essa potrebbe non aver bisogno di nient’altro se non del fatto che la musica possieda un certo numero di caratteristiche di alcune forme di movimento. È perciò
necessario, secondo Budd, considerare più dettagliatamente la spiegazione che Pratt
276
Le critiche che Budd rivolge alla nozione di movimento musicale sviluppata da Pratt e che ci accingiamo ad analizzare, sono ampiamente sviluppate in M. Budd, Music and the Emotions, cit., pp. 37-51.
181
fornisce riguardo all’utilizzo dei termini che denotano emozioni per descrivere la musica.
La spiegazione si basa, come abbiamo visto, sull’affermazione secondo cui le
emozioni e gli stati d’animo sono esperienze soggettive: quando noi esperiamo
un’emozione oppure siamo soggetti ad uno stato d’animo, ciò che noi sentiamo (organicamente oppure cinestesicamente) sono processi che coinvolgono movimenti del, oppure nel, nostro corpo. Ora, se un movimento, o una propensione al movimento, è implicato in un certo stato psicologico, ci sarà un carattere, C, del movimento, che noi
sentiamo quando siamo in quello stato. E potrebbe darsi che noi diciamo di sentire C
quando ci troviamo in quello stato psicologico precisamente perché questo (carattere) è
proprio ciò che noi sentiamo quando siamo in quello stato. Ma questo carattere potrebbe essere posseduto anche da un brano musicale – nel qual caso la musica potrebbe essere propriamente descritta come C. E la descrizione della musica come C non sarebbe
figurata ma letterale. La sua forza non dipenderebbe dall’applicazione primaria del
termine ‘C’ ad un stato psicologico. Piuttosto, lo stato psicologico deriverebbe il suo
nome da una qualità del movimento che è comune al movimento musicale e a quello
fisico. Noi saremmo, e insieme sentiremmo, C; la musica non dovrebbe essere sentita
come C, ma semplicemente essere C. È precisamente questo tipo di possibilità che
Pratt propone come la corretta comprensione dell’uso dei termini che denotano emozioni per descrivere la musica.
Pratt presenta un numero di stati psicologici che a suo avviso possono illustrare
la sua spiegazione. Uno di questi stati è l’agitazione. Quando un individuo è in uno stato di agitazione egli è tende a comportarsi in modo agitato; e se egli in effetti si comporta in modo agitato, egli sente i movimenti agitati che il suo corpo produce. Ma il carattere agitato di questi movimenti può essere condiviso da molti altri tipi di fenomeni,
e in particolare dalla musica. E se un brano musicale ha questo carattere agitato, allora
la sua descrizione come agitato è letteralmente vera. Un altro stato è l’irrequietezza. Se
un individuo si sente irrequieto, egli non si sente in (uno stato di) quiete. Egli sente cose come un’incapacità a rimanere calmo e un aumento del ritmo della respirazione e del
battito cardiaco. Più o meno gli stessi tipi o aspetti del movimento possono trovarsi nella musica: «Passaggi staccati, trilli, accenti forti, crome, rapidi accelerandi e crescendo,
scosse, ampi sbalzi di frequenza – tutti questi espedienti portano alla creazione di una
struttura uditiva che è appropriatamente descritta come irrequieta»277 . Pratt sostiene
277
C. Pratt, The Meaning of Music, cit., pag. 198.
182
che la maggior parte delle parole come ‘giocoso’, ‘capriccioso’, ‘trionfante’, ‘potente’,
‘marziale’, ‘maestoso’, ‘calmo’, ‘pacifico’, ‘urgente’, ‘combattente’, ‘sconcertante’,
‘tumultuoso’, ‘incerto’, e ‘ansioso’, può essere utilizzata per indicare emozioni e stati
d'animo; e quando tali parole sono usate in questa maniera, esse «si riferiscono ad esperienze psicologiche che includono, tra i loro componenti, vari tipi di movimento. Nella
misura in cui analoghi tipi di movimento possono presentarsi sotto forma di variazioni
o relazioni di diverse tonalità, le stesse parole si applicano altrettanto bene agli effetti
musicali» 278 .
In breve: la musica può essere agitata, irrequieta, trionfante o calma poiché essa
può possedere il carattere proprio dei movimenti fisici che sono implicati negli stati
d’animo e nelle emozioni a cui vengono assegnati tali nomi − i quali nomi vengono assegnati alle emozioni e agli stati d’animo suddetti precisamente perché è proprio questo
carattere del movimento fisico (agitatezza, irrequietudine, ecc.) che viene sentito (avvertito, percepito) quando gli stati d’animo o le emozioni sono esperite. Per questo tipo
di spiegazione è essenziale che vi siano caratteristiche del movimento che possano essere percepite in due modi differenti: attraverso il sentimento organico e cinestesico
nella percezione del movimento corporeo e attraverso l’ascolto nella percezione del
movimento musicale.
L’irrequietezza e l’agitazione sono probabilmente i due esempi che forniscono
il maggiore supporto alla spiegazione di Pratt. Qualcosa è in uno stato di irrequietezza
se essa è incessantemente in uno stato di movimento. Qualcuno che è irrequieto trova
difficile starsene fermo e si muoverà nervosamente. Egli può percepire l’incessante
movimento del suo corpo tramite sensazioni corporee/fisiche, nel qual caso egli prova
irrequietezza, oppure è consapevole della sensazione di irrequietezza. E, analogamente,
la musica può essere soggetta a uno stato di incessante cambiamento. Ancora, qualcosa
è in uno stato agitato se si sta muovendo in avanti e indietro o se sta tremando. Qualcuno che è agitato si comporterà in modo agitato salvo che non reprima la sua inclinazione; ed egli può sentire/avvertire i movimenti agitati che il suo corpo compie. E la musica può riprodurre in se stessa uno stato simile all’agitazione. Tuttavia, sostiene Budd,
rilevando quella che a suo avviso rappresenta un’insormontabile difficoltà nell’ipotesi
avanzata da Pratt, il ragionamento fatto a proposito dell’irrequietezza e dell’agitazione
non sembra poter essere esteso alla maggioranza delle emozioni, degli stati d’animo, o
278
Ivi, pp. 197-198.
183
più in generale delle condizioni psicologiche in cui una persona può trovarsi, e che
vengono normalmente attribuite − nella critica musicale − determinate composizioni.
Le caratteristiche che individuano il movimento di un oggetto possono essere
costituite dal numero di movimenti che esso compie, dalle parti dell'oggetto che sono in
movimento, dalle modalità, dall’estensione, dalla velocità e dalla forza di ogni movimento e dalla resistenza con cui ogni movimento viene sostenuto. È solo la condizione
psicologica (ovvero stato d’animo o emozione) che può essere definita da un insieme di
caratteristiche di questo tipo che può accordarsi con l’ipotesi di Pratt. Ma, osserva
Budd, non vi è alcun insieme di siffatte caratteristiche che definisca (tanto per fare un
esempio piuttosto indicativo) l'emozione della tristezza, ovvero che specifichi ciò che
una persona prova quando si sente triste, ed in relazione al quale tale sentimento sia caratterizzato come tristezza. La tristezza, infatti, è una forma di infelicità, e quando
qualcuno si sente infelice non c’è nessun insieme di caratteristiche proprie del movimento corporeo che dia il suo nome a quel sentimento. Inoltre, la tristezza è un tipo
specifico di infelicità: è l’infelicità che si prova per una perdita, per una sofferenza, per
una delusione. E i movimenti corporei che sono indicativi di infelicità non sono in se
stessi sufficienti a determinare quale sia l’oggetto dell’infelicità di cui essi sono sintomo: non vi sono movimenti fisici che sono specifici della tristezza in quanto distinta
dalle altre forme di infelicità. Pertanto, la descrizione della musica come triste non può
essere compresa facendo uso del modello che Pratt propone.
Budd rileva che non sarebbe una replica adeguata all’argomento da lui sostenuto affermare che un certo tipo di movimento corporeo costituisce una parte, ma solo
una parte, di ciò che qualcuno prova quando si sente triste. Poiché anche se questo fosse vero, non sarebbe sufficiente ad autorizzare l’attribuzione di tristezza alla musica
nella maniera difesa da Pratt. Se una persona, quando si sente triste, sente o prova qualcosa in più di questo tipo di movimento, allora − in accordo col modello di Pratt − dovremmo attribuire, alla musica che incarna questo movimento, qualcosa in meno
dell’intera condizione emotiva o psicologica indicata dalla parola ‘triste’. Pratt sostiene
che certe parole, quando sono usate per le emozioni e gli stati d’animo, indicano esperienze psicologiche che includono tra i loro componenti varie forme di movimento. Ma
la conclusione che egli trae da ciò non segue necessariamente: “Nella misura in cui analoghe forme di movimento possono essere presentate tonalmente (ovvero, sotto forma di variazioni o relazioni di diverse tonalità), le stesse parole si applicano altrettanto
bene agli effetti musicali”. Se il mio petto si gonfia con orgoglio, questo fatto non rap184
presenta una base sufficiente a farmi attribuire (la proprietà del) l’orgoglio ad un brano
musicale che possiede una certa caratteristica tendenza ad espandersi/estendersi. Una
forma di movimento corporeo (secondo la spiegazione di Pratt) deve infatti costituire
tutto ciò che una persona sente quando esperisce una certa emozione – essa (ovvero la
forma del movimento) deve anche dare/prestare il proprio nome all’emozione – affinché la musica che esibisce la stessa forma (di movimento) possa essere correttamente
caratterizzata mediante il nome dell’emozione.
La proposta di Pratt non è quindi in grado, secondo Budd, di fornire una soluzione generale al problema dell’apparente attribuzione alla musica di ciò che è soggettivo. Il linguaggio della critica musicale utilizza un gran numero di termini che denotano emozioni e stati d’animo, ma il modo in cui essi vengono utilizzati non può essere
compreso basandosi sul modello che Pratt difende. Il difetto principale della teoria di
Pratt sta, secondo quanto evidenziato dalle critiche di Budd che abbiamo ora esposto,
nell’aver ristretto la base di somiglianza tra musica ed emozioni alle caratteristiche attinenti al movimento − le quali non sono fondamentali né per la prima, vista
l’impossibilità di definire con esattezza la nozione di movimento musicale (se non ricorrendo alle farraginose costruzioni metaforiche), né per le seconde, dato che i movimenti percepiti nel nostro corpo non esauriscono la componente fenomenica delle nostre emozioni e dei nostri stati d’animo. La soluzione sta quindi, secondo Budd, nel ripartire dall’idea sottesa al modello isomorfico e rielaborarla in una forma più elastica,
che sappia cioè dar conto della molteplicità di fattori e di elementi che possono costituire il terreno comune della musica da un lato e delle emozioni dall’altro, e che non si
lasciano ridurre (come voleva invece Pratt) ad aspetti relativi al movimento percepito.
Il modello isomorfico proposto da Budd trova espressione in quella che lui chiama
“concezione minimale di base” dell’espressività musicale. Vale la pena, a tal proposito,
riportare l’intero passo in cui troviamo un’esaustiva spiegazione di tale concezione:
Il concetto minimale di base dell’espressione musicale delle emozioni
risulta essere questo: quando ascoltate una certa musica come espressiva dell’emozione E − quando sentite E nella musica − voi sentite la
musica come se suonasse nel modo in cui E viene vissuta 279 ; la musica è espressiva di E se è corretto sentirla in questo modo, o se il pieno
apprezzamento della musica richiede che l’ascoltatore la senta in que279
La frase ‘quando ascoltate una certa musica come espressiva dell’emozione E − quando sentite E nella musica − voi sentite la musica come se suonasse nel modo in cui E viene vissuta’ si può anche tradurre così: ‘quando nell’ascoltare una certa musica si pensa che sia espressione dell’emozione E − quando si
sente l’emozione E nella musica −, si sente la musica risuonare nel modo in cui l’emozione E viene vissuta’ .
185
sto modo. Pertanto, il senso in cui sentite l’emozione nella musica −
il senso in cui essa è una proprietà udibile della musica − sta nel fatto
che percepite una somiglianza tra la musica e l’esperienza
dell’emozione […] La spiegazione dà ragione anche di una caratteristica sovente rimarcata dell’esperienza musicale, ovvero del fatto che
la musica può essere sentita come espressiva di diverse emozioni nello stesso lasso di tempo: ciò è possibile in quanto è possibile che vengano percepite simultaneamente delle relazioni di somiglianza tra
sentimenti diversi, se non addirittura opposti. Inoltre essa fornisce
una solida base all’idea, apparentemente paradossale, secondo cui
nell’esperienza della musica noi percepiamo direttamente ciò che
normalmente percepiamo indirettamente (attraverso cioè il suo manifestarsi nell’apparenza corporea), ovvero la ‘vita interiore’
dell’emozione. O, nella formulazione di Schopenhauer, all’idea secondo cui la musica è una rappresentazione di ciò che non può mai
essere direttamente rappresentato. Sebbene la somiglianza tra una cosa e un’altra non richieda che il soggetto che la percepisce debba essere consapevole di ciò in cui la somiglianza consiste, la percezione
(non-creativa) di una somiglianza richiede che le due cose debbano
essere simili in un aspetto che è responsabile della percezione. Pertanto l’emozione può essere propriamente sentita nella musica nel
senso sotteso alla somiglianza trans-categoriale solo nella misura in
cui la musica e l’emozione si assomigliano. Inoltre, affinché si possa
giustificare la percezione di una somiglianza tra un oggetto e un altro
identificando una proprietà comune attraverso la riflessione
sull’aspetto manifesto dei due oggetti stessi, l’essenza della somiglianza non deve trovarsi al di sotto della soglia della consapevolezza, sì da non poter essere rilevata e resa esplicita. Perciò questo tipo
di giustificazione riflessiva della percezione della somiglianza tra la
musica e le emozioni richiede che la musica e le emozioni debbano
assomigliarsi in qualche maniera (che sia) evidente. Ma l’aspetto per
cui i due oggetti sono simili, e che è responsabile dell’impressione di
somiglianza, potrebbe anche rimanere al sotto della soglia della consapevolezza, nel qual caso la sua rilevazione competerebbe più a
un’investigazione scientifica, che non a una riflessione sugli aspetti
manifesti degli oggetti» 280 .
Appare dunque risuonare forte quanto mai l’eco dello slogan di Pratt, “music
sounds the way emotions feel”. Questo spiega più che mai quindi il fatto che per Budd,
come correttamente rileva anche Bertinetto281 , l’analogia tra l’espressione musicale e
l’espressione reale non implica l’utilizzo di metafore, ma semplicemente che l’ascolto
della musica come triste è un caso reale del sentimento della tristezza. La tristezza, sarà
il caso di ricordare ancora una volta, è infatti per Budd una proprietà udibile della musica. Il modello isomorfico fin qui delineato e riassunto nella concezione minimale di
280
M. Budd, Values of Art, cit., pag. 135-137.
A. Bertinetto, “Peter Kivy e il dibattito sul «formalismo arricchito»”, in Filosofia della musica.
Un’introduzione, cit. pag. 340, nota 31.
281
186
base è piuttosto vicino a quello di Pratt; in entrambi vi è l’idea che l’espressività musicale sia ascrivibile a una somiglianza tra la musica e le emozioni; la differenza sta, come anticipato, nella base di somiglianza che per i due autori accomuna musica e emozioni. Se per Pratt tale base riguarda essenzialmente caratteristiche corporee associate
al movimento, Budd ritiene che sia un errore rappresentare il ‘feeling’ proprio di
un’emozione, come ad esempio l’ammirazione, il disgusto, la gratitudine, la timidezza
o la nostalgia, come composto unicamente da sensazioni corporee. Una tale identificazione potrà apparire credibile solo se ci concentriamo esclusivamente su un numero esiguo di casi particolari che si ritiene che siano paradigmatici − ad esempio, la paura
per un pericolo imminente. In questi casi vi sono delle evidenti manifestazioni corporee
che il soggetto dell’emozione esperisce: l’adrenalina, il battere del cuore, il drizzarsi
dei peli, il brivido lungo la spina dorsale. Ma per la maggior parte delle emozioni e degli stati d’animo, le sensazioni corporee caratteristiche, se esistono, sono poche; e per
quanto riguarda l’intero spettro delle emozioni, compresa la paura, se anche
un’emozione, nel venire esperita, fosse sempre accompagnata da sensazioni corporee
caratteristiche, queste non riuscirebbero a identificare il sentimento (feeling) proprio
dell’emozione. Piuttosto, è l’attitudine valutativa, provata dal soggetto, nei confronti
del modo in cui il mondo viene rappresentato, e non le sensazioni corporee che vengono patite, che rende la sua reazione una reazione emotiva e serve a definire l’emozione
che il soggetto prova. La verità è che le sensazioni corporee sono un elemento secondario dell’esperienza di un’emozione. I sentimenti intrinseci all’esperienza delle emozioni
sono invece, primariamente, forme percepite di desiderio e di repulsione (come per
l’invidia, il disprezzo o la vergogna), di dolore (come per la paura o per il cordoglio),
di piacere (come per la gioia, il divertimento o l’orgoglio) e dispiacere, soprattutto il
dispiacere derivante da un desiderio frustrato (come per la rabbia). Il sentimento proprio di un’emozione spesso è un fenomeno complesso, ed è costituito da più di uno solo di questi elementi. Inoltre, i sentimenti che sono coinvolti ne, ma non sono intrinseci
a, l’esperienza delle emozioni, comprendono, oltre alle sensazioni corporee, i sentimenti di energia o di spossatezza (come per la gioia o la tristezza), di movimento o di impulsi al movimento (come per il tremore corporeo legato all’ansia), di inclinazioni o di
impulsi all’azione (come per la collera), o di tensione o di rilassamento (come per
l’eccitamento e per il sollievo).
Sulla scorta di questa concezione delle emozioni, e in particolare della loro
componente esperienziale − la quale, sola, può espressa dalla musica astratta, in quanto
187
questa, come detto, può riflettere solo il carattere non-rappresentazionale e nonconcettuale delle esperienze emotive −, Budd procede ad enumerare quelle che secondo
lui sono le risorse in virtù delle quali la musica è capace di rispecchiare quegli aspetti
del sentimento che sono accessibili ad essa − i quali aspetti comprendono primariamente, lo ripetiamo, la mera realtà del desiderio e la facilità o la difficoltà con cui esso viene soddisfatto, la tensione e il rilassamento, il piacere, il dolore, la soddisfazione e il
dolore nelle loro varie gradazioni, e secondariamente, le differenze nella direzione, nella magnitudo, nella velocità e nel ritmo del movimento percepito, i livelli di energia
avvertita, e così via.
Una prima risposa è costituita dal meccanismo che regola le melodie. Già Schopenhauer aveva a suo tempo sottolineato la corrispondenza tra l’aspetto melodico della
musica (da un lato), e il processo secondo cui i desideri sorgono e vengono soddisfatti
(dall’altro). Una melodia, per come la concepiva Schopenhauer, è un processo in cui
c’è una progressione da un punto di riposo relativo a un altro punto dello stesso tipo: le
frasi che intrecciandosi compongono la melodia, formano dei processi più brevi le cui
note conclusive rappresentano il traguardo di tali frasi, ma questi traguardi sono solamente momentanei e la melodia giunge al termine solo quando essa ritorna alla nota
fondamentale in maniera definitiva. Tale processo è analogo al modo in cui, per conseguire un risultato che desideriamo e che ci siamo prefissi, noi ci impegniamo strenuamente per raggiungere un traguardo intermedio, che probabilmente raggiungeremo e
dal quale saremo momentaneamente appagati, ma solo fino a che non sorge un nuovo
desiderio che richiede di essere soddisfatto, e così via fino a che il traguardo finale viene raggiunto. Più semplicemente, possiamo dire vi è una corrispondenza naturale tra il
passaggio, che è integrale alla musica tonale, da quei suoni musicali che sono in attesa
di risoluzione a quelli che non lo sono, e il passaggio dagli stati di desiderio agli stati di
soddisfazione, ovvero dagli stati di tensione agli stati di liberazione. Un’altra corrispondenza interessante è, secondo Budd, quella tra la dimensione della frequenza e la
dimensione verticale dello spazio, e, di conseguenza, tra le successioni di note aventi
una differente frequenza (rispetto alla durata e all’intensità) e i movimenti (ritmici) verso l’alto e verso il basso aventi maggiore o minore magnitudo e velocità, sì da permettere alla musica di riflettere i movimenti che vengono percepiti e che sono integrali a
determinati tipi di emozione (come avviene per il tremore del corpo, che è intrinseco al
sentimento di una forte ansia o agitazione). Ma le corrispondenze tra musica e emozioni non finiscono qui. I livelli di energia percepita trovano degli analoghi naturali nelle
188
variazioni della forza della pulsazione musicale, del grado del movimento e della massa musicale, ad esempio. Il sentimento del fluttuare o dell’essere eccitati può essere rispecchiato dalla musica (rispettivamente) attraverso un alleggerimento della tessitura
musicale, probabilmente riducendola a un’unica, e molto acuta, linea melodica, o attraverso degli aumenti di frequenza, di volume e di ritmo.
In virtù di queste ed altre risorse Budd ritiene che non vi siano particolari difficoltà, almeno in teoria, a giustificare la nostra percezione di una somiglianza tra la musica e le emozioni, gli stati d’animo e i sentimenti: a tal fine è sufficiente indicare gli
aspetti che accomunano entrambi, e che sono stati appena elencati e analizzati. I soli
casi in cui possono sorgere delle difficoltà, sono quelli in cui la base della somiglianza
si trova al di sotto della soglia della consapevolezza (come nel caso, ad esempio, del
suono malinconico posseduto da una triade minore, in quanto opposta a una triade
maggiore). Budd riconosce che, per quanto accuratamente possiamo ragionare su come
la musica risuona e su come le emozioni vengono vissute, ci sono situazioni (di cui egli
peraltro dà pienamente conto nella sua concezione minimale, riportata in precedenza)
in cui potremmo non essere capaci di identificare una proprietà comune che sia responsabile della percezione della somiglianza − nel qual caso dovremmo accontentarci del
fatto che si hanno delle risposte comuni.
Al di là di tali casi, comunque marginali, il modello isomorfico proposto da Budd
si rivela certamente più elastico di quello Pratt, essendo la ‘base di caratteristiche comuni’ tra musica e emozioni indicata dal primo più vasta e più coerente (con la dinamica esperienziale delle emozioni) di quella individuata dal secondo. Ma la maggiore
elasticità della teoria di Budd non si misura solo sulla estensione della suddetta base,
ma anche sull’integrazione, da lui successivamente operata, della propria concezione
minimale dell’espressività musicale − secondo la quale, lo ripetiamo, la nostra esperienza del sentire la musica come emozionalmente espressiva equivale alla nostra esperienza dell’ascoltare la musica risuonare nel modo in cui un’emozione viene sentita −
con altre possibili concezioni. Egli riconosce infatti che esistono altre concezioni della
percezione dell’espressione musicale delle emozioni, le quali sono legittimamente applicabili alla musica. La mossa successiva operata da Budd consiste quindi nel vedere
in che modo tali concezioni ulteriori possono essere innestate sulla concezione minimale, la quale spiega la percezione dell’espressività musicale ricollegandola alla semplice
percezione di una somiglianza tra la musica e i sentimenti.
189
Budd guarda soprattutto alla teoria del finzionalmente vero (make-believedly) 282 ,
sostenuta da Kendall Walton, per il quale la frase posta nella forma “M è E” (laddove
M indica un brano musicale, e E indica un termine emotivo come triste, allegro, angosciato, ecc.) più che metaforicamente è da intendersi finzionalmente. Tale teoria, spiega
Budd, sembra in grado in qualche misura di approssimarsi alla sua teoria
dell’espressività musicale, sebbene egli non sposi appieno la formula del make-believe
nell’accezione integrale di Walton, un’accezione caratteristicamente coinvolgente in
modo decisivo l’immaginazione (imagination-involving). Walton esplicita la sua teoria
immaginativa dell’espressione musicale nell’articolo “What Is Abstract about the Art of
Music?” 283 nel modo che segue:
un passaggio P è espressivo di E se e solo se l’ascoltatore è propenso,
nell’ascoltare P, a immaginare o che egli sta ascoltando l’espressione
comportamentale, da parte di qualcuno, di E, oppure che egli sta
prendendo coscienza dei propri sentimenti verso E.
Con la teoria di Kendall Walton Budd condivide in linea generale l’enfasi posta
sulle emozioni immaginate in connessione con la musica ascoltata, condivide cioè in
ultima istanza l’idea di base dell’approccio del “make-believe”, vale a dire: l’idea che
la musica emozionalmente espressiva è quella musica designata per incoraggiare
l’ascoltatore ad immaginarsi il sopravvenire di esperienze emotive. Un’idea, possiamo
facilmente comprendere, analoga sotto questo aspetto anche a quella che, abbiamo già
esposto, è sostenuta da Jerrold Levinson, il quale anch’egli mette in gioco una simile
ipotesi immaginativa nella sua teoria empatica dell’ascoltare la musica immaginariamente come una persona, un agente che incarna l’emozione, con la quale appunto mediante l’immaginazione siamo portati ad immedesimarci. Ora, per quanto propenso ad
accogliere l’idea fondante della teoria del make-believe, Budd specifica, in Music and
Communication of Emotion, che esistono diversi modi in cui la nozione di verità di finzione può essere utilizzata per spiegare il concetto dell’espressione musicale delle emozioni. Nello specifico – egli spiega – si possono distinguere tre modi particolari in
282
Kendall Walton, Pictures and Make-Believe, in “Philosophical Review” LXXXII (July 1973), 298299.
283
Kendall Walton, What Is Abstract about the Art of Music?, in “Journal of Aesthetics and Art Criticism”, 46, 1988.
190
cui “M è E” potrebbe essere analizzata nei termini della nozione di verità di finzione,
ed è necessario quindi determinare quale di tali modi sia quello più credibile 284 .
1) In primo luogo: si consideri ad esempio l’emozione dell’angoscia. Secondo il
suggerimento di Walton “M è angosciato” dovrebbe probabilmente essere inteso come
“*M esprime l’angoscia (di qualcuno o di qualcosa)* (MB)” 285 . Al fondo di questa
spiegazione vi è l’idea del finzionalmente vero secondo cui la musica espressiva di
emozioni viene esperita come se essa sia, finzionalmente, l’espressione sonora
dell’emozione di un individuo. Budd rileva che questa prima ipotesi non cattura
un’importante concezione dell’espressione musicale delle emozioni, dal momento che
tale idea non si applica a molta della musica che esperiamo come espressiva di emozioni e che ha valore per noi proprio in quanto la esperiamo come espressiva di emozioni. L’idea che l’emozione venga espressa attraverso il corpo di qualcuno non rientra
nemmeno parzialmente nell’attitudine che, riflette Budd, abbiamo nei confronti di questo tipo di musica, vale a dire: quando sento un’emozione nella musica, la mia relazione con questa emozione non è mediata dall’idea che i suoni emanino dal corpo di una
persona in virtù della sua condizione emotiva. Per tale ragione egli ritiene necessario
quindi, diciamo così, invalidare questa prima variante e utilizzare in altro modo la nozione di verità di finzione – e, precisamente, in un modo che stabilisca una relazione
più stretta tra l’ascoltatore e l’emozione che viene espressa nella musica – se il risultato
finale deve essere quello di conseguire un concetto più completo dell’espressione musicale delle emozioni.
2) Un secondo modello esplicativo basato sulla nozione di finzione, un modello
che evita qualsiasi riferimento all’espressione finzionale delle emozioni, potrebbe essere questo: “M è angosciato” deve essere inteso come “*M è angosciato* (MB)”. Ma
non è chiaro come lo si dovrebbe interpretare. Se può essere letteralmente vero che
qualcosa è angosciato solo se è una creatura senziente (in breve, se è un individuo), allora la definizione suggerisce la seguente lettura: “*M è un individuo che è angosciato*
(MB)”. Budd tuttavia non è propenso ad esplorare questa possibilità, ritenendo che vi
sia una lettura ad essa strettamente imparentata ma assai più esplicativa. Secondo
quest’ultima, “M è angosciato” va inteso come “*M è un’esperienza di angoscia*
(MB)”, o (il che è lo stesso) “*M è l’esperienza che un individuo ha dell’angoscia*
(MB)”. Questa è una possibilità più invitante, poiché è più credibile, precisa Budd,
284
L’analisi di queste tre diverse modalità è svolta da Budd in, Music and the Communication of Emotion, cit., pp. 132-137.
285
“*p* (MB)” deve essere letto come “è finzionalmente vero che p”.
191
rappresentare finzionalmente la musica come l’esperienza di una persona che rappresentarla finzionalmente come una persona. Secondo questa seconda lettura
dell’interpretazione finzionale, quindi, quando ascolto una musica che descrivo come
‘angosciata’, io fingo che la mia esperienza di M sia un’esperienza di angoscia, oppure
immagino che, nell’esperire M, io stia provando un’esperienza di angoscia. Una siffatta
caratterizzazione della mia esperienza sarebbe, per Budd, invitante sotto vari aspetti.
Uno di questi è che essa spiegherebbe la nostra inclinazione tanto ad affermare, quanto
a negare, che esperiamo l’emozione che sentiamo essere espressa dalla musica: io esperisco davvero quell’emozione, ma solo finzionalmente. Un altro aspetto che rende appetibile la suddetta caratterizzazione è che essa spiegherebbe la nostra inclinazione a
rappresentare l’espressione musicale dell’emozione come intrinsecamente particolare:
il mio sentire M è un’esperienza diversa dal mio sentire qualsiasi altra cosa, sicché il
mio *esperire l’angoscia* (MB) nel sentire M è un’esperienza diversa dal mio
*esperire l’angoscia* (MB) nel sentire qualcos’altro. Un terzo fattore di attrattiva verso
questa caratterizzazione è che essa rappresenta l’apprezzamento del lato emozionalmente espressivo della musica in modo tale da non ridurre la musica a un semplice veicolo per la comunicazione delle emozioni: se apprezzo un brano musicale in virtù del
fatto che sento tale brano come espressivo di una certa emozione, ciò che sto apprezzando è la mia esperienza del sentire la musica, che equivale al mio *esperire
l’emozione* (MB). Ma, a fronte di queste attrattive, Budd è dell’avviso che non sia poi
così desiderabile rappresentare la mia esperienza del sentire M come angosciato in un
modo tale che il mio sentire M debba equivalere al mio *esperire l’angoscia* (MB),
ovvero continuare a sostenere che, quando sento M come angosciato, deve essere finzionalmente vero, relativamente a me stesso, che io sono in uno stato d’angoscia. Poiché anche se questo fosse vero, non è necessario che le cose stiano in questi termini: la
musica angosciata non sempre esige che l’ascoltatore che riconosce l’angoscia sia finzionalmente angosciato. Posso certamente immaginare che la mia esperienza di un brano musicale sia un’esperienza di angoscia, e questa esperienza immaginativa può propriamente essere descritta come un’esperienza del sentire la musica come espressiva di
angoscia. Ma essa non è l’unica esperienza di questo genere, e probabilmente non è
nemmeno la più importante.
3) Il terzo modo in cui “M è angosciato” potrebbe essere analizzato nei termini
della nozione di verità di finzione, il quale modo evita anche qualsiasi riferimento
all’espressione finzionale di emozioni, è anche quello preferibile per Budd. Posto nella
192
sua forma semplice (questo terzo modello afferma che): “M è angosciato” deve essere
inteso come “È la natura di M che fa sì che *l’angoscia viene esperita* (MB)”. In altre
parole: “È finzionalmente vero che l’angoscia viene esperita, e questa verità finzionale
è causata da M”.
Un vantaggio di questo modello esplicativo è, certamente, sostiene Budd, che esso offre una concezione più liberale dell’esperienza del sentire l’angoscia nella musica,
rispetto a quella fornita dal modello precedente (anch’esso collegato all’idea di verità
di finzione). Poiché, sebbene esso esiga che la mia esperienza della musica che io sento come espressiva dell’angoscia sia guidata dalla mia consapevolezza che è finzionalmente vero che l’angoscia viene esperita, esso non esige che debba essere finzionalmente vero che tale angoscia sia la mia, ovvero che io sia angosciato. In altre parole, chiarisce Budd in Values of Art 286 , questa terza lettura del modello finzionale
dell’espressività musicale prevede che anziché immaginare che la vostra esperienza
dell’ascolto del brano musicale sia un’esperienza del provare il sentimento, voi potreste
semplicemente immaginare che quella musica sia un’istanza di quel sentimento. Questa
terza ipotesi di tipo immaginativo richiede che voi utilizziate l’immaginazione; ma tale
immaginazione non introduce all’interno di ciò che state immaginando, e, in particolare, non esige che voi concepiate l’istanza immaginaria del sentimento come se fosse la
vostra. Se ci si immagina che un brano musicale sia l’istanza di un sentimento, ci si
immagina dunque qualcuno che stia provando tale sentimento. Il soggetto del sentimento non deve, tuttavia, essere concepito come qualcuno in particolare − il compositore o noi stessi, ad esempio, tanto per citare i due candidati più probabili −, ma può assumere la forma alquanto indefinita di ‘persona’ immaginata nella musica.
Questa terza ipotesi si innesta agilmente sul modello isomorfico rappresentato
dalla concezione minimale di base: è sufficiente riconoscere che la causa del nostro
immaginare, durante l’ascolto di un brano musicale, che esso sia un’istanza di una certa
emozione, poggia sulla percezione, più o meno consapevole, di un certo numero di somiglianze tra certe caratteristiche strutturali del brano e il feeling interno all’esperienza
dell’emozione che attribuiamo alla musica ascoltata. Ma ci sono altri due vantaggi che
rendono questa terza ipotesi di tipo immaginativo particolarmente adeguata a descrivere l’espressività musicale, e che meritano quindi di essere considerati. Il primo riguarda
l’annosa questione − per le teorie, come quella di Budd, che sostengono che le proprietà emotive sono proprietà che appartengono alla musica − di come dar conto del fatto
286
M. Budd, Values of Art, cit., pp. 147-157.
193
che, per quanto irrilevanti ai fini dell’attribuzione dei termini emotivi alla musica, le
risposte emotive suscitate dalla musica espressiva di emozioni sono una forma di interazione (dell’ascoltatore con la musica) che ricorre spesso e che è dunque assai importante.
Budd sostiene a tal proposito che ci sono fondamentalmente due modi in cui immaginarsi un’occorrenza di un’emozione può sollecitare una risposta emotiva: si può
essere o direttamente contagiati dall’emozione che si sta immaginando durante
l’ascolto di un brano, oppure si può essere colpiti da tale emozione in maniera simpatetica o antipatetica.
Se esperite una risposta simpatetica all’emozione espressa, sostiene Budd, sarete
ovviamente consapevoli del fatto che l’emozione alla quale state rispondendo non è reale, ma è finzionale: state solo immaginando un’esperienza di quella emozione, ed è
questa emozione immaginata che vi colpisce. La vostra reazione emozionale simpatetica sarà quindi diversa rispetto a una situazione di vita reale, dove la vostra reazione si
basa su una credenza relativa a un effettiva occorrenza dell’emozione in una particolare
persona; e lo sarà per più di un motivo. Poiché, nel caso nel caso dell’espressione musicale dell’emozione, l’emozione dalla quale siete colpiti non solo è immaginata (anziché reale), ma è anche astratta e, in un certo senso, disincarnata: l’emozione non riguarda nessun determinato stato di cose e non è esperita da nessuna persona avente caratteristiche definite (età, razza, sesso, e così via). Se, ad esempio, l’emozione è quella
del trionfo, si tratterà di un trionfo il cui oggetto non è specificato, così come non è
specificato l’individuo al quale attribuirlo; si tratterà infatti del sentimento trionfante
non di un particolare individuo, ma di una persona indeterminata, la quale è definita unicamente dalla natura dell’emozione che ella finzionalmente prova. L’emozione, qui,
non ha né un oggetto definito né un soggetto definito. Pertanto la vostra risposta simpatetica all’esperienza immaginata dell’emozione consisterà unicamente in un’emozione
diretta verso tale emozione astratta e disincarnata: proverete un sentimento simpatetico
verso la malinconia o la solitudine, oppure proverete piacere nel trionfo o nella gioia
immaginarie di un’altra persona.
Se la vostra risposta nei confronti dell’aspetto emozionalmente espressivo della
musica rispecchia l’emozione espressa, ovvero se venite ‘contagiati’ da tale emozione,
l’emozione espressa dalla musica verrà anche in questo caso esperita come astratta e,
nel senso appena chiarito, disincarnata. Ma non si potrà dire che immaginerete semplicemente un’occorrenza dell’emozione: voi esperirete l’emozione, e la esperirete nella
194
forma in cui essa viene espressa dalla musica. Pertanto sperimenterete come ci si sente
a provare malinconia, solitudine o trionfo, senza che ricolleghiate tale sentimento a un
pensiero che specifichi l’oggetto del sentimento stesso. Inoltre, sarete consapevoli del
fatto che questo sentimento è prodotto in voi solo dall’immaginarvi l’emozione che una
persona fittizia prova, sicché il sentimento di malinconia, solitudine o trionfo che proverete verrà da voi sperimentato non solo in una forma indefinita ovvero priva di oggetto (il che potrebbe darsi anche per i sentimenti che proviamo nella vita reale), ma
anche in una forma tale che non sarà corretto descrivervi come malinconici, soli o
trionfanti. Il fatto che sperimentiate come ci si sente a provare malinconia, solitudine o
trionfo non implica che vi sentiate malinconici, soli o trionfanti, ovvero che vi troviate
in uno stato, o condizione, di malinconia, solitudine o trionfo.
L’ultimo vantaggio del terzo modello finzionale, costruito da Budd a partire dalla
teoria di Walton e innestato sulla propria concezione minimale dell’espressività musicale, consiste nella sua capacità di dar conto, almeno in parte, del valore artistico della
musica. Se tale valore, secondo Budd, non può ridursi alla sola presenza di proprietà
espressive − in quanto, secondo lui, il potenziale artistico di un brano musicale dipende
soprattutto dalla sua struttura formale-compositiva, e quindi ‘puramente’ musicale 287 −,
è pur vero, egli aggiunge, che l’immaginazione delle emozioni che ha la sua base nella
musica, talvolta permette all’ascoltatore di sperimentare immaginariamente la natura
intima degli stati emotivi in una maniera particolarmente vivace e intensa (in virtù della
complessità della composizione musicale) e quindi soddisfacente. Inoltre, un brano
musicale può essere composto in una maniera tale da condurre l’ascoltatore dotato di
immaginazione attraverso una successione di stati d’animo le cui vicissitudini formano
un dramma dotato di una sua logica interna e che si risolve in un modo che dona una
profonda soddisfazione, in quanto concludendosi comunica probabilmente il raggiungimento di un’armonia, di una pace, di una stabilità, dell’accettazione del destino e della comprensione degli eventi. Per di più, esperendo in questo modo la musica emozionalmente espressiva, l’ascoltatore rinuncia all’autonomia della propria immaginazione
per consegnarsi nelle mani del compositore. Se la fiducia dell’ascoltatore è ripagata
dall’ascolto, il comprendere (da parte sua) che l’esperienza dell’emozione che egli im-
287
Budd cita, come esempio paradigmatico di valore artistico, il Ricercare a Sei voci di Bach. Sebbene si
tratti indubbiamente di una musica splendida, il suo fascino risiede, secondo il filosofo americano, “non
nel suo costituire l’espressione di vari tipi di stati emotivi, ma nel modo magistrale con cui Bach tratta le
voci, le quali si intrecciano armoniosamente secondo schemi sempre cangianti, sicché il mondo sonoro
dell’ascoltatore è caratterizzato da sviluppi multipli che cambiano in continuazione all’interno di una
struttura ordinata in un modo eccezionalmente chiaro e complesso” (Budd, Values of Art, cit., p. 156).
195
magina o prova (durante l’ascolto) non è unicamente la sua, ma può essere vissuta anche ad altre persone ed è stata resa possibile dall’immaginazione creativa del compositore, sviluppa in lui un senso di comunione con le altre persone che con la sua sola e
personale attività immaginativa non potrebbe raggiungere.
In conclusione, possiamo rilevare come l’incessante tentativo di Budd di opporsi
alla necessità della tesi metaforica rimanda all’idea di ribadire il principio della letteralità delle descrizioni emotive della musica e quindi la loro piena comunicabilità, così
dimostrando anche la fallacia delle tesi solipsistiche e dei linguaggi privati come si evince (pur se con qualche esitazione) dalla presa di distanza da Langer sul piano del
simbolismo presentazionale, e dal rifiuto delle riflessioni intimistiche di Mendelssohn e
di Deryck Cooke. È questo forse il maggiore merito che gli va ascritto: mantenere le
attribuzioni emotive alla musica sempre oltre la soglia normativa della referenzialità
ordinaria − compito che egli assolve elaborando un modello isomorfico, sulla scia di
quello di Pratt ma senza ricadere nelle ristrettezze di quest’ultimo. Ugualmente meritoria è la tendenza generale a mantenere un atteggiamento di cautela a fronte della consapevolezza di una realtà estremamente articolata che non sempre supporta l’univocità di
regole generali; cautela che prende forma nell’integrazione, proposta da Budd, della
sua concezione minimale ‘isomorfica’ di base, con un’ipotesi finzionale desunta da
Walton. Come contropartita, emerge forse il rischio che, in seguito a tali integrazioni,
la concezione isomorfica perda la sua specificità e quindi la sua intrinseca ricchezza di
senso.
196
6. Stephen Davies: le caratteristiche esteriori delle emozioni
La posizione di Stephen Davies 288 , nell’opera Musical Meaning and Expression, prende le mosse, come in molti altri casi che abbiamo analizzato, da una pars destruens piuttosto dettagliata e articolata. Egli infatti considera e rifiuta una alla volta:
a) le teorie descrittive della musica: l’idea cioè che la musica descriva (come il
linguaggio);
b) le teorie rappresentazionali, per le quali la musica ha un contenuto raffigurativo
nello stesso modo in cui i quadri rappresentali/figurativi lo hanno.
c) le teorie simboliche, per le quali invece la musica simbolizza (in modo distintivo) le emozioni; nel caso specifico, Davies si trova in netta rottura con la tesi
del simbolismo di Langer e di Goodman.
Ugualmente Davies resiste all’idea:
a) che l’espressività della musica possa spiegarsi solamente come libera espressione della personalità del compositore, sebbene a volte i compositori esprimano
davvero, nell’atto del comporre, le emozioni che attraversano il proprio animo.
b) che l’espressività della musica consiste nel suo potere di commuovere
l’ascoltatore, anche se gli ascoltatori qualche volta sono commossi dalla musica.
Queste teorie infatti, per Davies, collocano il significato della musica oltre i
confini del brano musicale – come se tale significato fosse un qualcosa a cui si è fatto
riferimento, o che è stato denotato, o simbolizzato, o rappresentato, o sfogato, o destato. All’opposto, egli si dichiara favorevole ad una teoria diversa, la teoria cioè che colloca il significato della musica all’interno dell’opera, in quanto risiedente nelle sue
288
Stephen Davies è Senior Lecturer in Filosofia alla University of Auckland, New Zeland. Egli si è occupato, tra le altre cose, dei problemi della definizione e della valutazione dell’arte, occidentale e non
(attestandosi su una posizione definibile come contestualista), nonché dell’interpretazione delle opere
letterarie. Tra i suoi scritti, segnaliamo: Musical Meaning and Expression, cit.; The Philosophy of Art,
Malden, Blackwell, 2006; The Expression of Emotion in Music, in “Mind”, 89, 67-86, 1980; Is Music a
Language of the Emotions, “The British Journal of Aesthetics”, 23, 222-233, 1983; Attributing Significance to Unobvious Musical Relationship, “Journal of Music Theory”, 27, 203-213, 1983; Truth-Values
and Metaphors, “Journal of Aesthetics and art Criticism”, 42, 291-302. 1984; The Expression Theory
Again, “Theoria”, 52, 146-167, 1986; The Evaluation of Music, in “Alperson”, ed., 307-325, 1987; Review of Kivy’s Music Alone, “Canadian Philosophical Review”, 10, 368-372, 1990; The Ontology of
Musical Works and the Authenticity of Their Performances, “Noûs”, 25, 21-41, 1991; Definitions of Art,
Ithaca, Cornell University Press, 1991; Review of Kivy’s Sound Sentiment, “Journal of Aesthetics and Art
Criticism”, 49, 83-85, 1991; The End of Art, “A Companion to Aesthetics”, Ed. David E. Cooper, Oxford, Blackwell, 138-142, 1992; Representation in Music, “Journal of Aesthetics Education”, 27, n. I,
15-21, 1993; Musical Understanding and Musical Kinds, “Journal of Aesthetics and Art Criticism”, 52,
69-81, 1994.
197
proprietà intrinseche. Scrive infatti Davies: «Io sostengo, nello specifico, che le emozioni espresse in musica sono proprietà del brano» 289 .
Ritenendo che l’espressività sia in qualche modo “incarnata” nella musica stessa, e comunque non riferibile, se non isomorficamente, a elementi ad essa esterni, Davies rientra a pieno titolo nella vasta schiera dei post-formalisti che hanno cercato faticosamente di affrancarsi dall’originaria asetticità dello strutturalismo hanslickiano per
aprire l’esperienza musicale all’universo delle emozioni umane, marcando nello specifico l’insostituibilità delle descrizioni emotive con quelle descrizioni sensibili o dinamiche che costituivano l’orientamento suggerito da Hanslick.
Molte sono le analogie riscontrabili quindi col pensiero di Kivy, molte le questioni riprese e sviluppate direttamente da Malcolm Budd e molte quelle insospettabilmente rintracciabili con le teorie metaforiche rivali, da noi già prese in esame, di Goodman, Scruton e di Zangwill.
Nella sostanza si ripropongono, spesso irrisolte, le difficoltà storicamente associate a tutti i reiterati tentativi di connettere, sulla base di una logica scientifica, la struttura della musica con le categorie emozionali, difficoltà accentuate dalla rinuncia alle
potenzialità offerte dalle descrizioni metaforiche e dalla continua, quasi ansiosa, riaffermazione di un problematico principio di letteralità discorsiva. In particolare, precisiamo che, il valore della concezione letterale difesa da Davies rappresenta una versione della teoria già esaminata di Budd 290 : come Budd anch’egli prende posizione infatti
contro chi propende per una concezione metaforica delle descrizioni musicali.
Davies si oppone, in particolar modo, a quelle teorie che ipotizzano l’idea secondo cui la musica conseguirebbe il proprio effetto espressivo in virtù di una propria
tipologia di simboli, rilevando la sostanziale indicibilità di tali simbolismi, tanto nel caso di Langer che in quello di Goodman. Davies si oppone pertanto a qualsiasi tipo di
sistema simbolico, più o meno ineffabile, che persegua la significazione a prescindere
dall’unico sistema legittimo e pubblico: quello del linguaggio letterale, salvo poi abbracciare alla fine una soluzione che individua nell’estensione connotativa dei termini
emozionali l’escamotage per tenere insieme, nei termini di ciò che potrebbe definirsi,
letteralmente corretto, l’oggettività della struttura musicale con i termini che adoperiamo nella descrizione delle emozioni umane. Davies sostiene, infatti, che i termini
che denotano emozioni utilizzati per descrivere determinati aspetti (o modi di apparire),
sia delle persone che degli oggetti naturali o delle opere d’arte, sono parassitari rispetto
289
290
S. Davies, Musical Meaning and Expression, cit., pag. 201.
Ivi, cit., pag. 150-151.
198
all’uso che di tali termini si fa per riferirsi alle emozioni che vengono vissute; essi rappresentano cioè un uso secondario, seppur letterale, di tali termini. In tale uso secondario, i termini che denotano emozioni descrivono le caratteristiche esteriori delle emozioni (characteristics emotion in appearances), ed è in tale uso che l’espressività musicale risiede. Così scrive a tale proposito: «L’espressività della musica consiste nel suo
presentare le caratteristiche esteriori delle emozioni […] Oltre a riconoscere che il parlare (ad esempio) della tristezza della musica implica un uso secondario e derivato della
parola “triste”, ho sostenuto che quest’uso secondario è di un tipo a noi familiare. Esso
è un uso stabilito in contesti ordinari e non-musicali in cui attribuiamo le caratteristiche
delle emozioni agli aspetti esteriori delle persone, o degli animali non-umani, o degli
oggetti inanimati. In tal senso, l’espressività attribuita alla musica non è misteriosamente confinata all’ambito musicale […] Le caratteristiche esteriori delle emozioni sono attribuite senza che si prendano in considerazione i sentimenti o i pensieri di ciò a
cui esse sono attribuite. Questi aspetti dell’espressione non sono emozioni che sono
vissute, che hanno oggetti, che implicano desideri o credenze - esse non sono affatto
emozioni che occorrono/sopraggiungono. Esse sono proprietà emergenti delle cose a
cui esse sono attribuite» 291 .
Fondamentale è infatti per Davies la distinzione tra parole che denominano le
emozioni, i sentimenti e gli stati d’animo, nel loro uso primario e le parole che denominano le emozioni nel loro uso secondario. La differenza sostanziale sta nel fatto che
le prime si riferiscono ad esperienze, mentre le seconde non riguardano in alcun modo
l’esperienza, ma riguardano quello che Davies definisce per l’appunto le “caratteristiche esteriori delle emozioni”. Un esempio, in primis, è per Davies il carattere
dell’aspetto di una persona, del suo portamento, del suo volto, o della sua voce, che a
volte viene descritto utilizzando termini che denotano emozioni. Di una persona possiamo cioè dire “egli è dall’aspetto triste” oppure “egli dà l’impressione di essere triste”. Ma in casi come questi non vogliamo dire che quella persona si sente triste; né
vogliamo dire che quella persona spesso si sente triste, o che immaginiamo finzionalmente che egli si sente triste. Il riferimento cioè in questi casi non è, infatti, a qualsivoglia emozione, ma all’aspetto esteriore della persona. Esse, insomma, le caratteristiche
esteriori delle emozioni sono mostrate “all’esterno” senza essere “esperite all’interno”.
Le caratteristiche esteriori delle emozioni sono attribuite all’aspetto delle persone e
non, come invece avviene per le emozioni, alle persone stesse. È il caso dei volti che
291
Ivi, cit., pag. 228.
199
non sentono emozioni e non pensano pensieri; essi sono non-senzienti. Le caratteristiche esteriori delle emozioni, a differenza delle emozioni vissute, non si riferiscono a
oggetti emozionali e non implicano credenze, desideri o attitudini. È in questo senso
che egli ritiene, dunque, che i termini che denotano emozioni non possano applicarsi
alla musica nel loro uso primario, quanto piuttosto nel loro uso secondario.
Dal nostro punto di vista, accreditare una estensione connotativa dei termini discorsivi equivale evidentemente a compiere un deciso passo indietro rispetto alla iniziale riaffermazione del carattere logico letterale del linguaggio e suggerisce pericolose
analogie con i presupposti fondativi delle principali concezioni metaforiche moderne.
Nel sistema interattivo di Max Black per esempio i termini discorsivi (nomi) non si applicano come etichette alle cose, ma vanno identificati come sistemi di implicazioni associate o come (detto in altre parole) estensioni connotative 292 .
Nel caso specifico, Davies sottolinea come una tale scelta non configura di per
sé una metafora, e non inficia di conseguenza la validità del linguaggio letterale, dovendosi in tal modo (letteralmente) considerare certi modi di dire, che avendo smaltito
nell’uso l’originaria intrinseca contraddittorietà, acquisiscono nel tempo la piena legittimità delle espressioni ordinarie. L’apertura concessa da Davies ci pare ispirata alla distinzione già prospettata da Davidson tra il significato (letterale) del linguaggio e il suo
uso nella prassi discorsiva, uso che consentirebbe nel caso in questione di aggirare i limiti descrittivi posti dall’univocità denotativa, ma che ci pare ispirata alla necessità di
riconoscere legittimità di diritto a ciò che si presenta già con una innegabile attestazione di fatto, allo scopo di sottrarre certe espressioni dell’uso comune dal dominio metaforico per ricondurle su un piano di letteralità.
Ma in fondo anche in questo caso la distinzione appare non necessaria, la questione sembra di forma più che di sostanza: postulare un grado di letteralità intermedio,
ovvero di secondo livello per cooptare all’interno del primo (quello letterale in senso
pieno) certi usuali modi di dire che si costituiscono nel tempo in consolidate realtà linguistiche atipiche per sottrarre spazi semantici al regno del metaforico, ci sembra
un’operazione più politica che filosofica, dettata dall’urgenza più che dalla ragione.
Urgenza di dover in qualche modo sistematizzare quelle espressioni che non rientrando
a pieno titolo nei canoni della denotazione discorsiva, costituiscono certamente motivo
di grave imbarazzo e, tuttavia, si rendono necessarie quando come nel caso specifico un
linguaggio troppo scientifico impedirebbe a causa della sua rigidità di parlare di cose
292
Rinviamo alla trattazione della suddetta teoria già esposta nelle premesse storiche del dibattito sulla
metafora.
200
inanimate nei termini propri degli esseri senzienti ovvero di estendere le categorie linguistiche da un dominio concettuale a un altro. Ma l’operazione non è priva di rischi,
poiché legittimando i casi sopradescritti, come metafore morte, Davies finisce per riconoscerne implicitamente la legittimità, almeno sotto il profilo storico.
Il problema delle metafore morte introduce una questione ampiamente dibattuta
tra gli studiosi: capovolgendo i termini della questione, potremmo considerare che
quando una metafora smaltisce la sua iniziale contraddizione, di cui l’irriflessiva appropriazione da parte della comunità dei parlanti ne è la dimostrazione, allora avrà dilatato lo spazio semantico del linguaggio, aggiustandosi progressivamente verso la sua
estrinsecazione in ragione dei modi con cui entra a far parte di quel linguaggio: nella
prima fase della sua “vita” la sua caratteristica è quell’indeterminatezza, condizione
necessaria che le permette di entrare in contatto con forme di realtà extra-semantiche,
la seconda fase è quella che consente almeno in parte di acquisire quelle nuove conoscenze, (nuovi domini di riferimento) introducendole nel linguaggio.
L’uso irriflessivo di una certa metafora potrebbe quindi non essere certificazione della sua morte, in quanto tale, ma anzi del suo compiuto passaggio dal primo stato
al secondo. In altri termini, l’uso smaltisce nel tempo la caratteristica contraddizione
interna tra significato esplicito (letterale) e significato implicito (metaforico).
Quanto più irriflessivamente viene usata, tanto più essa avrà assolto al suo
compito di estendere il confine semantico del linguaggio, nella misura in cui avrà introdotto al suo interno quelle realtà che solo nel linguaggio diventano pienamente tali,
vale a dire: reali per noi. Ma il problema in definitiva ci sembra mal posto poiché indurrebbe anche in questo caso a conseguenze paradossali come quella di dover disporre
di un determinato criterio per poter decidere se una metafora è viva o morta, e (sorvolando sulla pertinenza letterale dell’attribuzione di termini come vita o morte a cose inanimate), ipotizzare eventualmente livelli di vita intermedi o stati di morte apparente.
Più sensato sembrerebbe invece rendersi conto come in questo ennesimo caso il
confine tra metaforicità e letteralità appare ridursi ulteriormente fino ad identificarsi unicamente con le rispettive etichette. Zangwill sostiene che non esiste un criterio discriminate per identificare le metafore vive e quelle morte, salvo ipotizzare (non senza
ironia) una sorta di paradiso letterario come loro luogo di destinazione finale. Egli
spiega infatti che nei discorsi sulla musica, la valenza metaforica consiste non nel suo
stato di salute, bensì precipuamente nella sua proprietà di rappresentare un’emozione,
201
pur in mancanza di qualsiasi riferimento a un corrispettivo stato mentale in cui agisca
un’occorrenza di quel termine, quindi una sorta di immagine pura, priva di riferimento.
Centrale è dunque la nozione di immaginazione che solo attraverso la rinuncia
all’intenzionalità emozionale ci consente di parlare della musica nei termini di triste,
allegra. L’immaginazione costituisce allo stesso modo e con le medesime caratteristiche il fulcro dell’idea di Davies, e si rivela via via come quell’elemento trasversale capace di subordinare imprescindibilmente a sé concezioni che pure sembrerebbero inconciliabili tra di loro: da Kivy a Scruton, da Budd allo stesso Zangwill, a Levinson
l’immaginazione si rivela decisiva tanto nelle teorie incentrate sulla metafora, tanto in
quelle che, al contrario, vi rinunciano optando per una descrizione letterale dei termini
implicati; essa si pone come candidato principale a rivestire una funzione transcategoriale, capace di stabilire connessioni che favoriscono il passaggio da un dominio
di riferimento concettuale a un altro; variamente declinata a seconda della specificità
dei diversi contesti teorici, l’immaginazione (ci) consente di rilevare la presenza di una
data emozione in forme che non la rappresentano in quanto occorrente o intenzionale e
per le quali Kivy aveva coniato il termine di “espressivo di tristezza” contrapposto a
“esprimere tristezza” che indica invece una rappresentazione ovvero una fenomenologia motivata da un corrispondente stato interno di tristezza, accompagnato sempre da
ulteriori manifestazioni empiriche. Scelta, questa di Kivy, che Davies sottoscrive in
pieno, riconoscendo l’acutezza della distinzione colta dal collega, e rimarcando ulteriormente con una lunga spiegazione l’importanza delle manifestazioni emotive non
motivate, ovvero di una fenomenologia dell’apparenza immediata e non mediata (che
lo stesso Scruton approverebbe in pieno) 293 priva di caratteristiche riferibili a un oggetto esperito e dunque capace di declinare nei termini delle emozioni umane i discorsi
sulla struttura formale della musica, superando in questo modo i limiti delle rispettive
concettualizzazioni categoriali.
Come nota ancora Zangwill, il metodo e l’obiettivo della riflessione di Davies
non si discostano molto dai parametri tipici delle descrizioni metaforiche dei termini
emotivi, eppure Davies rigetta questa attribuzione optando, come abbiamo visto, per
una descrizione letterale, sia pure di secondo livello. L’impressione è che dietro la molteplicità delle sigle impiegate agisca una sola e unica realtà, una sola immaginazione,
indipendente e incurante dei termini usati per descriverne o catturarne il senso.
293
Si veda la nozione scrutoniana di “pensiero non detto”.
202
Nel merito, dunque, la teoria generale di Davies è che la musica sia in prima
luogo espressiva nel suo rappresentare non le istanze delle emozioni ma l’apparenza
acustica di ciò che egli chiama caratteristiche delle emozioni (emotion characteristics
in appearances): in particolare l’esperienza del movimento in musica sarebbe simile
alla nostra esperienza di quelle forme di comportamento che negli esseri umani si manifestano fenomenologicamente dando luogo ai diversi aspetti associati alle varie emozioni. L’espressività della musica dipende prevalentemente da una somiglianza che
percepiamo tra il carattere dinamico della musica e il movimento dell’uomo: andatura,
comportamento, atteggiamento.
In questa particolare caratterizzazione del principio di somiglianza, Davies,
consapevole che tale posizione può essere troppo facilmente riconducibile a quella già
sostenuta da Kivy, puntualizza che in realtà egli non è affatto propenso a considerare
l’idea, sostenuta dal collega, che la somiglianza fondamentale sia quella che la musica,
per via di elementi come la cadenza, l’intonazione, la frase, il timbro, il tono e la tessitura, intrattiene con la voce umana (considerata nel suo aspetto fenomenico, ovvero indipendentemente dal contenuto di un eventuale atto comunicativo verbale). Scrive Davies a riguardo: «dal momento che la musica è un’arte del suono, si potrebbe pensare
che la musica presenti le caratteristiche proprie delle emozioni per via della somiglianza con alcune proprietà che si manifestano nell’espressione vocale delle emozioni occorrenti. Tale concezione è difesa in Kivy (1980), e non vi è dubbio che in essa vi sia
qualche verità, sebbene io pensi che tale somiglianza spieghi solo una piccola parte
dell’espressività. Per le mie orecchie, la somiglianza tra la musica e la voce è tenue. Allo stesso modo, trovo ci sia poca somiglianza tra la musica e il volto umano, sebbene i
volti siano tra i principali elementi che presentano non solo le espressioni di emozioni
vissute ma anche di caratteristiche esteriori delle emozioni» 294 .
In realtà, secondo Davies, nell’ascoltare la musica noi percepiamo il movimento, e tale movimento presenta delle somiglianze con i movimenti che conferiscono a
una persona il suo portamento o la sua andatura, e che sono a loro volta le manifestazioni esteriori di determinati sentimenti e stati d’animo. In realtà, secondo Davies,
nell’ascoltare la musica noi percepiamo un movimento, e tale movimento presenta delle somiglianze con i movimenti che conferiscono a una persona il suo portamento o la
sua andatura, e che sono a loro volta le manifestazioni esteriori di determinati sentimenti e stati d’animo. Pertanto, l’espressività della musica dipende prevalentemente da
294
S. Davies, Musical Meaning and Expression, cit., pag. 229.
203
una somiglianza che percepiamo tra il carattere dinamico della musica e il movimento
dell’uomo − la sua andatura, il suo portamento, il suo atteggiamento, e così via. Una
siffatta definizione di espressività richiede degli ulteriori chiarimenti. In primo luogo,
ci si potrebbe chiedere: in che senso possiamo parlare di movimento nella musica? Se
non si vuole ricorrere a spiegazioni metaforiche (che, come si è visto, presentano non
pochi problemi, primo fra tutti quello di identificare cos’è che, nello spazio musicale, si
muove da una posizione a un’altra), come quella offerta da Scruton, è necessario cercare altre ipotesi esplicative. La soluzione di Davies è, in sintesi, la seguente: si può parlare di movimento non solo in riferimento a elementi che occupano posizioni nello spazio e che si spostano da una posizione all’altra, ma anche in riferimento a processi puramente temporali, in cui non c’è nessun individuo che cambia la sua posizione nello
spazio, e non c’è nulla che si muove da uno posto ad un altro. Che l’uso dei termini che
denotano movimento sia legittimo anche per tali processi, è confermato dal fatto che il
tempo stesso è frequentemente descritto in termini spaziali: c’è lo scorrere del tempo;
c’è il passare del tempo; il tempo si evolve; le cose accadono a tempo debito. Analogamente, diciamo che un fiume è in costante movimento, o che ci possono essere movimenti politici per la guerra nel Medio Oriente, o ancora, che l’indice del Dow Jones
reagisce (a un certo evento) scendendo verso il basso. Tali usi sono secondari ma del
tutto frequenti e legittimi, e, cosa importante, per nulla metaforici, in quanto legati
all’idea di processi temporali. Ora, essendo la musica un’arte del processo temporale,
ad essa possiamo applicare la stessa nozione di movimento:
Un tema è costituito dal movimento nel modo in cui il progresso
dell’indice del Dow Jones lo è. Il progresso dell’indice del Dow Jones può essere rappresentato con un grafico, ma le coordinate attraverso cui il movimento è registrato non sono nello spazio reale (anche
se la rappresentazione grafica lo è; si confronti questa rappresentazione grafica con la notazione musicale). L’indice del Dow Jones può
essere contrapposto all’indice del New Zealand di Barclay dello stesso periodo; molti processi temporali sono intrecciati tra loro in molteplici modi (si confronti questo con l’armonia e la polifonia). L’uso
dei termini relativi alla posizione e al movimento concernenti la musica è forse secondario, ma questo non implica che tali termini operano come metafore vive. Lo stesso uso secondario è comunemente diffuso al di fuori del contesto musicale, come ho indicato, e il dire che
una nota è più alta di un’altra nota non è più metaforico, a mio avviso, del dire che l’indice Dow Jones è in rialzo. Il movimento musicale
differisce dal paradigma (dello spostamento spaziale) introdotto sopra
perché il movimento è quello di un processo nel tempo, non perché il
movimento musicale è aberrante o di tipo speciale. Nei casi che riguardano la musica, è possibile negare l’appropriatezza di tale carat204
terizzazione, o negare l’oggettività del fenomeno esperito, solo rimettendo in discussione le descrizioni e le esperienze, assai diffuse e
consuete, di fenomeni non-musicali. Inoltre, la descrizione della musica in tali termini non sembra essere eliminabile; dubito che qualcuno possa parlare della tonalità, o della chiusa finale di una sinfonia di
Beethoven, ad esempio, senza far ricorso alle nozioni di spazio o di
movimento 295 .
In secondo luogo, rimane da spiegare per quale speciale criterio la somiglianza
rilevante ai fini dell’attribuzione di proprietà espressive alla musica sia quella tra il
movimento musicale e le caratteristiche esteriori del movimento umano. La tesi di Davies è che vi siano delle proprietà del movimento musicale che aiutano ad attirare la
nostra attenzione sulle somiglianze con la vita emotiva. Nello specifico, l’idea è che il
movimento musicale attira la nostra attenzione sull’espressività perché, come l’azione
e il comportamento umani (e diversamente dai processi causali), esso esibisce ordine e
finalismo. Il movimento musicale, in questo senso, è rivestito di umanità (ovvero, presenta sembianze umane) non semplicemente perché la musica è creata ed eseguita da
esseri umani, bensì perché essa fornisce un senso di unità e di conformità a scopo. Noi
riconosciamo, nel procedere della musica, una logica tale che ciò che segue deriva naturalmente, senza essere determinata, da ciò che precede; in questo, il movimento musicale è più simile all’azione umana che al movimento casuale o ai movimenti totalmente determinati di un meccanismo non-umano. Questa proprietà della musica, ritiene
Davies, deriva dal carattere degli stessi materiali musicali, e non solamente dal riconoscimento del fatto che le mani umane plasmano questi materiali − in particolare, egli
sottolinea l’importanza della tonalità nel conferire al movimento musicale il suo carattere teleologico 296 . Detto in altri termini, l’idea dell’espressività anche per Davies passa
indubbiamente, come abbiamo visto anche per Kivy, Budd, da una fenomenologia propria della struttura musicale, qui presentata come dimensione acustica dello spazio e
295
Ivi, pp. 235-6.
“Nella musica tonale, la tonica è percepita nell’ascolto come centro, ovvero come un punto di riposo.
Le note che non costituiscono la tonica sono percepite nell’ascolto come attratte verso di essa, e la forza
dell’attrazione dipende dalla posizione della nota nella scala, dalla sua “distanza” dalla tonica. Per esempio, nella scala maggiore, melodicamente la nota principale è quella più fortemente attratta verso la tonica. Gli accordi sono comparativamente tesi o rilassati (discordanti o concordanti) in relazione all’accordo
tonico; la dissonanza tende verso una risoluzione. Di conseguenza, l’andamento della musica, il suo movimento, corrisponde a un’esperienza di aumento o di diminuzione della tensione, di spinta e di trazione,
di impulso e di decadimento, ed esso giunge al termine con l’arrivo della tonica finale.” (Ivi, p. 236).
Davies riconosce tuttavia che possono esistere dei modi di organizzare i materiali musicali, diversi da
quelli tradizionalmente tonali che dominano la musica classica occidentale, e tali da poter essere usati
per creare delle strutture musicali che siano percepibili come coerenti − altrimenti gran parte della musica contemporanea occidentale (perlomeno quella atonale) e molte tradizioni musicali non-occidentali
non avrebbero alcun senso, il che è alquanto improbabile.
296
205
del movimento musicali 297 . Anzi è proprio in questa direzione – non ci sembra indebito
evidenziare – che i post-formalisti odierni cercano di conciliare i tratti di un arido formalismo con la dimensione espressiva che gli stessi hanno riconosciuto alla musica.
Vogliamo evidenziare inoltre che questa idea del movimento in relazione alla musica
ricorre frequentemente nella letteratura odierna e non, interessanti soprattutto la caratterizzazione di spazio e del movimento musicale come “ideali” (da Edmund Gurney) oppure “virtuali” (in Langer), oppure “metaforici” (in Pratt).
Un ultimo chiarimento ci preme effettuare, per completare il quadro della teoria
dell’espressività musicale delineata da Davies. Le caratteristiche esteriori delle emozioni sono, come abbiamo visto, del tutto slegate da pensieri, credenze o desideri; esse
esprimono la componente fenomenologica e non-intenzionale delle emozioni (pur non
essendo necessariamente la loro conseguenza diretta), e possiamo riconoscere tali espressioni (ad esempio la gioia) in soggetti che non conosciamo affatto (ad esempio osservando una persona che ride di gusto, pur ignorando il motivo della sua risata). Ciò
ha delle importanti conseguenze, in quanto delimita considerevolmente il campo delle
emozioni che possiedono delle manifestazioni esteriori specifiche; di certo non vi rientrano emozioni “elevate” come la speranza, l’imbarazzo, la perplessità, l’irritazione, o
l’invidia (per l’identificazione delle quali abbiamo bisogno non solo di determinate
manifestazioni esteriori, ma anche della conoscenza degli oggetti a cui esse sono rivolte). Vi rientrano invece emozioni meno raffinate come la tristezza e la felicità, considerate però genericamente e non nelle loro forme particolari (come la depressione, la malinconia, l’avvilimento da un lato, o il godimento, l’euforia, il buon umore dall’altro),
le quali sono distinguibili solo in relazione alla natura dei loro oggetti formali. Ciò significa che, tornando alla teoria dell’espressività musicale di Davies, la gamma di emozioni che la musica, quando viene ascoltata, presenta nella maniera appena esposta,
e di cui quindi può essere espressiva, è ristretta a quelle emozioni o stati d’animo aventi
espressioni comportamentali caratteristiche, ovvero la tristezza o la felicità considerate
in generale (il che si accorda, secondo Davies, in maniera piuttosto precisa con la nostra esperienza dell’espressività musicale, dal momento che tale esperienza consiste, a
suo avviso, nel trovare l’espressività all’interno del brano e nel considerare il carattere
di tale espressività solitamente come alquanto generale).
In conclusione ci preme rilevare che l’analogia avvalorata da Davies risiede nella maniera in cui queste somiglianze sono esperite, piuttosto che essere fondata su una
297
Ivi, pp. 229-240.
206
qualche inferenza che cerchi di stabilire una relazione simbolica tra alcune componenti
specifiche della musica e alcuni particolari frammenti del comportamento dell’uomo.
Somiglianze cioè che si danno percettivamente nell’immediatezza. Quando si ascolta la
musica, le emozioni cioè sono percepite come appartenenti ad essa, così come gli aspetti esteriori delle emozioni sono presenti nel comportamento, nell’atteggiamento e
nell’andatura dei nostri simili e di altre creature viventi. La tristezza della musica è una
proprietà dei suoni dei brani musicali. Ecco perché non c’è, secondo Davies, alcun bisogno di descrizione, o di rappresentazione, o di simbolizzazione, o di altri tipi di denotazione che connettano l’espressività musicale a delle emozioni occorrenti, poiché il carattere espressivo della musica risiede all’interno della sua propria natura.
In tal senso possiamo anche adesso comprendere meglio la polemica di Davies
con Goodman, per il quale ciò che è espresso da un’opera d’arte è metaforicamente esemplificato. Ciò che esprime tristezza è metaforicamente triste. E ciò che è metaforicamente triste è realmente ma non letteralmente triste, cade cioè sotto un’applicazione
trasferita di qualche etichetta coestensiva a triste. Inoltre, da questo punto di vista, dal
momento che l’espressione, come la rappresentazione, è una forma di simbolizzazione,
le proprietà espresse, non sono solo possedute metaforicamente, ma anche fatte oggetto
di riferimento, esibite, emblematizzate, indicate. In sintesi, la teoria dell’espressione di
Goodman è questa: X esprime Y se e solo se X possiede Y metaforicamente e X esemplifica Y. Sebbene X non denota realmente Y, la denotazione è presente all’interno di
questa relazione – che va da “Y” (il predicato) a X. Un’opera d’arte è espressiva quando possiede metaforicamente una proprietà che essa esemplifica. Goodman, come avevamo anticipato, propone questa analisi come un’analisi generale dell’espressione nelle
arti, che si può applicare alla pittura, per esempio, come alla musica. Un brano musicale è triste solo nel caso in cui esso ha la proprietà metaforica dell’essere triste e questa
proprietà è esemplificata.
Davies precisa che l’obiezione alla quale la teoria di Goodman va naturalmente
incontro è questa: l’esemplificazione implica l’uso di una proprietà già posseduta
dall’opera d’arte, un uso che (nella spiegazione di Goodman) garantisce la denotazione.
Ma se l’opera possiede già la proprietà dell’essere triste, ad esempio, allora
l’espressività ha a che fare con il possesso piuttosto che con l’esemplificazione. Questo
evidenzia, sostiene Davies, che la preoccupazione di Goodman è rivolta all’uso simbolico dell’espressività artistica, ovvero a un discorso che fa uso di quell’espressività, ma
l’opera potrebbe possedere la proprietà espressiva senza che venga usata per denotare
207
la proprietà che possiede (cioè, senza che la proprietà venga esemplificata).
L’espressività, infatti, non è per Davies una questione di esemplificazione;
l’esemplificazione è una condizione necessaria non per l’espressività in quanto tale ma
per il riferimento, tramite l’uso della proprietà rilevante.
Davies spiega infatti che, come a giusta ragione ha evidenziato Beardsley 298 , le
proprietà esemplificate sono degne di nota o di valore indipendentemente dal fatto che
ad esse sia stata attribuita una funzione esemplificatoria, e perciò non dobbiamo concentrarci troppo sul fatto che esse siano esemplificate; piuttosto, dovremmo focalizzarci sulle proprietà in questione, e non sul loro riferirsi ad altro; il brano musicale non ha
bisogno di denotare alcunché, poiché il semplice esibire/presentare le proprie qualità
rilevanti da un punto di vista estetico permette ad esso (ovvero al brano) di fare la propria parte nell’aiutarci a comprendere il mondo e a relazionarci con questo. Da questo
punto di vista è dunque chiaro che, l’analisi di Goodman presuppone, piuttosto che
spiegare, l’espressività nell’arte, poiché si ritiene che la sua preoccupazione è rivolta
infine piuttosto all’uso referenziale a cui l’espressività dell’arte stessa si presta.
Inoltre, Davies manifesta una certa insofferenza anche riguardo alla spiegazione
di Goodman per il quale semplicemente funzionando come carattere entro un sistema
simbolico, l’opera utilizza le proprie proprietà per conseguire la denotazione e, quindi,
l’esemplificazione. Le arti infatti secondo Goodman hanno in comune alcune proprietà
che riflettono la loro natura simbolica generale – la denotazione, in particolare – ma esse sono distinguibili da altri sistemi simbolici per il loro tendere all’opacità, dal momento che dirigono la loro funzione simbolica verso se stesse. Da questo punto di vista,
l’opera seleziona le sue proprietà per l’esemplificazione, proprio nello stesso modo in
cui possiamo dire che una superficie colorata seleziona la luce che rifletterà. L’ipotesi
qui in gioco è che la denotazione non presuppone un uso intenzionale e quindi nemmeno l’esemplificazione lo presuppone. Goodman infatti non parla degli usi che vengono
fatti delle opere d’arte; in realtà, egli non discute né di artisti né del modo in cui questi
ultimi applicano e dunque utilizzano gli schemi simbolici da lui descritti. Goodman ritiene infatti che la funzione dei simboli può essere studiata senza tener conto delle credenze o dei motivi di un qualche soggetto/agente i quali potrebbero aver provocato le
relazioni coinvolte (nel funzionamento del simbolo). Egli dice che, ad esempio, non c’è
bisogno di chiedersi chi ha lanciato la palla, o se è solo rotolata dallo scaffale, per conoscere il modo in cui la palla rimbalza. Detto in altri termini, l’ipotesi qui accreditata
298
Cfr. M. C. Beardsley, On Understanding Music, In Price, ed., 55-73, 1981.
208
da Goodman è che laddove le convenzioni di un sistema simbolico sono stabilite, esse
operano (ovvero, fanno il loro lavoro) indipendentemente dal loro essere usate intenzionalmente. Il significato emerge e viene prodotto al’interno del contesto di un sistema simbolico, indipendentemente dal fatto se ci sia o meno qualcuno che crea o dirige
intenzionalmente l’attenzione su tale portata significativa. A tale proposito, Joseph
Margolis obietta che la noncuranza, da parte di Goodman, nei confronti del ruolo
dell’artista nel processo di simbolizzazione, ha la sfortunata conseguenza di antropomorfizzare l’opera, come se essa da sola riuscisse ad esemplificare qualcuna delle sue
proprietà 299 . Un’idea pienamente condivisa da Davies, il quale per quanto d’accordo
con l’idea che le convenzioni (o, se si preferisce, i ruoli e le pratiche in cui un sistema
di simboli è strutturato) svolgono la loro funzione di conferire significato anche nei casi in cui esse non siano usate per fare questo, tuttavia non può avallare l’ipotesi che
questo giustifichi la liquidazione delle intenzioni, degli usi, o delle pratiche come irrilevanti al fine di stabilire il contesto per l’esemplificazione goodmaniana. Scrive Davies a tale proposito: «Dal fatto che in certe circostanze possiamo occuparci del contenuto simbolico senza fare riferimento alle intenzioni, non segue che potremmo sempre
agire in questa maniera. Il fatto che noi possiamo considerare un contenuto simbolico
senza far riferimento all’uso intenzionale non mostra che un sistema di simboli, come
quelli che Goodman ha in mente, potrebbe produrre un significato esemplificatorio
senza che esso (il sistema di simboli) sia mai stato usato, oppure (sia mai stato) compreso correttamente come usato, per effettuare una comunicazione. L’analogia di Goodman della palla che rimbalza è fuorviante; le palle rimbalzano indipendentemente
dall’uso che ne facciamo, mentre i sistemi simbolici goodmaniani non esisterebbero a
meno che non vi fosse una connessione tra il loro uso intenzionale e il loro significato
pubblico garantito da quell’uso. I sistemi simbolici sono stabiliti e sorretti solo attraverso il loro utilizzo intenzionale – in generale, se non in ogni occasione» 300 .
La polemica con Goodman sembra ricondurre dunque alla domanda se
nell’apprezzamento estetico di un’opera d’arte possa darsi un sistema simbolico proprio, ovvero, che nei suoi riferimenti prescinda dall’univocità normativa del linguaggio
letterale per conseguire la denotazione non per mezzo di un uso intenzionale, ma automaticamente attraverso le operazioni proprie di quel sistema, ovvero a prescindere
dall’elemento umano. Da quanto detto, è chiaro che la risposta di Davies non può quin299
J. Margolis, What Is When? When is What? Two Questions for Nelson Goodman, Journal of Aesthetics and Art Criticism, 39, 266-268.
300
S. Davies, Musical Meaning and Expression, cit., pp. 142-143.
209
di che essere negativa, poiché – egli sostiene – che i sistemi simbolici sono stabiliti e
sorretti solo attraverso il loro utilizzo intenzionale, e la circostanza (non impossibile)
che un’opera possa esemplificare per effetto della sua appartenenza a un sistema simbolico, un significato per il quale non era stata concepita, rappresenta un’eccezione rispetto all’intima connessione che lega inscindibilmente l’esemplificazione e l’uso.
In questo percorso di minuziosa analisi Davies non trascura infine di evidenziare che problematica (nonché oscura) risulta per lui anche l’idea che le proprietà esemplificate dall’opera d’arte siano metaforiche. A tale proposito, secondo Davies, Goodman ha ragione nel pensare che sia necessario fare una distinzione tra il fatto che una
proprietà musicale sia metaforica e il fatto che una proprietà musicale sia descritta metaforicamente, tuttavia non è comprensibile cosa significhi per la musica, non quindi
per le descrizioni della musica, essere metaforica, visto che, in ultimo Goodman nega
la concezione che la musica debba essere paragonata al linguaggio per ciò che concerne
il suo significato 301 .
301
Interessante aprire una parentesi qui per evidenziare, come fa Davies, che Goodman non è il primo e
l’unico ad avere avanzato l’ipotesi che la musica stessa sia metaforica. Un precedente significativo è
quello di Donald Ferguson, il quale suggeriva che la musica ha una pressoché unica predisposizione
all’espressione metaforica. Dal suo punto di vista, nello specifico, una metafora è un’inflessione (il tono
della voce nel discorso, ovvero l’espressione verbale) che aggiunge un “incremento poetico” al significato standard di una parola. In questo caso, Davies evidenzia che anche laddove ci si spingesse ad accettare
questa strana spiegazione, non è affatto certo che Ferguson possa giustificare l’affermazione secondo cui
la musica è adatta all’espressione metaforica. Le sue osservazioni secondo cui la musica riguarda per lo
più l’inflessione della voce non costituiscono delle basi solide per fondare tale affermazione, poiché non
è chiaro come tali inflessioni aggiungano un “incremento poetico” al “significato standard” di un’unita
(musicale) corrispondente alla parola. Daniel Putnam (1989) è un altro autore che ha scritto a proposito
della musica come metafora. L’altezza e la bassezza delle note, e il movimento musicale, sono caratteristiche metaforiche dei brani musicali. Egli suggerisce che, quando la musica diventa una metafora morta,
le persone iniziano ad ascoltare non la musica ma una successione di suoni. E anche in questo caso, puntuale e pertinente è l’osservazione di Davies che: nella misura in cui questi autori aderiscono a un modello che fa dipendere la metafora dalle proprietà semantiche/sintattiche proprie dei linguaggi naturali, le
loro affermazioni sulla musica rendono più confusa, anziché più chiara, la distinzione tra l’essere metaforico della musica e l’uso della metafora nella descrizione della musica, dato che non viene spiegato in
che modo le considerazioni fatte a proposito di un tipo di metafora (ovvero quella letteraria) debbono
essere interpretate quando vengono applicate all’altro tipo di metafora (ovvero quella musicale). La difficoltà che qualsiasi tentativo di caratterizzare la musica come metaforica partendo da un modello letterario della metafora si trova a dover fronteggiare è rilevata da Steven Krantz (1987), il quale proietta alcune delle più importanti teorie della metafora sul caso musicale. Le conclusioni di Krantz sono in gran
parte negative. Egli stabilisce che solo facendo capo a una teoria interattiva della metafora, e solo riguardo a quella musica che poggia su associazioni culturali che garantiscono un qualche riferimento − ad esempio, (in quei passaggi musicali) dove le trombe connotano il potere – si può rintracciare qualche somiglianza con la metafora (linguistica). La teoria interattiva descrive la metafora come derivante
dall’interazione tra i significati delle parti di una frase, come i soggetti e i predicati. Ora, anche tale descrizione per Davies non ha ragione di sussistere, poiché egli è dell’idea che gli elementi musicali non
hanno funzioni semantiche/sintattiche paragonabili (a quelle possedute dalle parti di una frase). Se si
tengono presenti queste circostanze, dire che la musica è metaforica (in quanto è simile alla metafora
linguistica) equivale semplicemente ad adoperare una metafora che non chiarisce affatto i termini della
questione. Cfr. D. Ferguson, Music as Metaphor: The Elements of Expression, University of Minnesota
Press, Minneapolis, 1960; D. A. Putnam, Some Distinctions on the Role of Metaphor in Music, Journal
210
La concezione di Davies, che identifica nell’aspetto convenzionale il valore della significazione simbolica (semantica), è convocata ugualmente contro l’altro principale modello teorico in questione: quello di Langer. Davies, appoggiando le critiche già
mosse da Budd, sostiene che Langer avrebbe frainteso la “forma logica” della teoria
wittgensteniana alla quale dichiara di ispirarsi, perché nel momento in cui pretende di
sostituire alla forma logico-discorsiva un’analoga forma presentazionale ne avrà di fatto snaturato il senso. Ma la questione è estremamente complessa. Lo stesso Wittgenstein, dopo il 1930, mostra grandi ripensamenti rispetto alla sua stessa teoria atomica
delle proposizioni semplici esposta nel Tractatus, e questo potrebbe essere variamente
interpretato tanto a favore di Langer che (all’opposto) dei suoi detrattori. Né Langer 302 ,
però, né tantomeno Davies sembrano considerare che l’apertura del secondo Wittgenstein ad un possibile orizzonte extra-linguistico è una consapevolezza che si rivela già
alla fine del Tractatus e che anticipando le Ricerche suggerisce che se da un lato i limiti del linguaggio sono i limiti del nostro mondo e pertanto di ciò di cui non si può parlare è meglio tacere, dall’altro il nostro mondo non esaurisce il confine del mondo che
si estende anche oltre i limiti imposti alla conoscenza delle nostre stesse caratterizzazioni linguistico-concettuali. E, tale svolta, vogliamo precisare, potrebbe essere interpretata come un’apertura di senso che introduce il problema dell’indicibile. Ma lo
scontro concettuale tra Davies e Langer sembra concentrarsi unicamente sui temi del
Tractatus.
L’impressione che se ne ricava è che dietro i ripetuti riferimenti all’autorità del
pensiero wittgensteniano, operi il tentativo di avvalorare le proprie tesi, a volte in modo
alquanto semplicistico senza tenere conto della complessità del suo pensiero, problematicamente in bilico tra l’atomismo delle proposizioni logiche e la referenzialità dei
giochi linguistici, tra significati denotativi e connotativi, tra logica scientifica e aperture
al mistico.
Ed è proprio sul piano dell’ineffabilità delle esperienze emozionali, e dunque
sulla presunta inadeguatezza del linguaggio che si consuma il centro della polemica,
of Aesthetic Education, 23, 2, 103-106, 1989; S. C. Krantz, Metaphor in Music, Journal of Aesthetics
and Art Criticism, 45, 351-360.
302
Garry Hagberg acutamente così riassume la posizione di Langer, catturando così il modo in cui la sua
concezione differisce da quella di Wittgenstein: su ciò di cui non si può parlare, si deve comporre, dipingere, scrivere, scolpire, e così via. Cfr. G. Hagberg, Art and Unsayable: Langer’s Tractarian Aesthetics,
“The British Journal of Aesthetics”, 24, 325-340. È certo che in questi termini si possa riassumere la
concezione di Langer, visto che, dal nostro punto di vista, la sua è un’interpretazione che potremmo dire
letterale della celebre chiusa del Tractatus. L’idea di Wittgenstein infatti non era quella di una perpetua
chiusura ai “mondi possibili”, per usare la terminologia leibniziana, ma se proprio di chiusura si vuol
parlare questa era certamente riferita alle possibilità della significazione linguistica.
211
poiché
una
simile
ammissione
invaliderebbe
la
tesi,
difesa
da
Davies,
dell’insostituibilità dei termini emotivi nelle descrizioni della musica. Se infatti il linguaggio dovesse rivelarsi insoddisfacente a dare conto della molteplicità e complessità
delle emozioni, allora si potrebbe insinuare l’idea di una incommensurabilità tra
l’universo delle emozioni e le parole usate per descriverle, e concludere conseguentemente che solo il ricorso a una teoria metaforica potrebbe gettare luce su ciò che il linguaggio non riesce ad illuminare.
Davies riconosce che un certo grado di ineffabilità è sempre presente nelle cose,
e dunque l’esperienza musicale non costituisce in tal senso un problema a sé, poiché le
esperienze che proviamo in prima persona sono sempre e necessariamente più ricche e
dense di significati di quel linguaggio che usiamo per descriverle, ma questo aspetto
non inficia in alcun modo la loro piena comunicabilità, e d’altra parte il linguaggio è un
sistema simbolico, il suo compito è quello di ridurre (per semplificare) la complessità
della realtà ovvero il nostro rapporto col mondo, e non già di riprodurla punto per punto, poiché in tal caso non sarebbe più un sistema simbolico ma copia iconica della realtà e dunque inutilizzabile per la comunicazione. Se infatti, in virtù di una qualche particolare esperienza privata o per effetto di un’ostensione fossimo in grado di superare i
limiti dell’indicibile e guardare nella natura delle cose, questa nostra conoscenza non
avrebbe alcun uso intelligibile, rimarrebbe cioè incomunicabile.
Come già rilevato in Budd, il segno più significativo della riflessione di Davies
ci sembra essere rappresentato proprio dalla difesa del valore referenziale del linguaggio: l’insostituibilità dei termini emotivi nella descrizione della musica, più volte riaffermata, è funzionale al principale compito del linguaggio di consentire l’interscambio
dei significati e delle esperienze. Un linguaggio che presentasse un’analogia punto per
punto dei molteplici aspetti e delle svariate sfumature delle emozioni connesse
all’esperienza musicale (così come a ogni altro tipo di esperienza) non sarebbe più un
linguaggio, ovvero non ci consentirebbe di maneggiare le cose del mondo e di fatto la
comunicazione risulterebbe impedita. Pertanto, il fatto di verificare o intuire alcune
eccedenze della realtà rispetto alle possibilità discorsive, non sarebbe un problema del
linguaggio, ma delle false aspettative riposte in esso. Ovvero di una fraintesa valutazione dei suoi compiti e dei suoi limiti. L’avversione di Davies per le teorie metaforiche che pretendono di sopperire alle lacune del linguaggio, va dunque intesa più proficuamente sotto questo punto di vista, e in questo senso va inteso il primato del linguag-
212
gio letterale al di là delle sterili polemiche sulla parafrasabilità o meno delle espressioni
metaforiche 303 .
Tali insistite contrapposizioni intese a definire lo schieramento di opposte fazioni e a consolidarle in quanto tali, costituiscono a nostro avviso un ostacolo alla chiarificazione delle cose. Lo stesso Davies che pur ci pare colga esattamente nel segno
riaffermando la pura convenzionalità linguistica dei discorsi sulla musica non si sottrae
alla tentazione di difendere l’insostituibilità dei termini espressivi schierandosi almeno
formalmente tra i detrattori della metafora. Avrebbe forse potuto rilevare più proficuamente come tali sostituzioni non siano in definitiva né necessarie né sufficienti e comunque non rimuoverebbero tutti i dubbi circa il significato del nome, poiché il nome
(che sia usato letteralmente o metaforicamente) non rimanda comunque ad alcun tipo di
verità o di falsità di natura, ma il suo significato dipende unicamente dal contesto e solo
all’interno di esso l’enunciato può essere considerato vero. Pertanto una descrizione
come “la musica è triste” può essere (è) vera all’interno di un discorso in cui i parlanti
siano consapevoli della referenzialità e dei modi e delle regole in cui il termine triste
viene usato.
Al di fuori della referenzialità dei discorsi sull’espressività della musica, è evidentemente insensato chiedersi se sia vero o falso che la musica è triste, ugualmente insensato sarebbe credere che un uso metaforico possa conseguire un risultato migliore.
In conclusione avanziamo la proposta che parlare di insostituibilità dei termini emotivi,
può essere fuorviante, più opportunamente si potrebbe dire che una tale operazione sarebbe superflua o non necessaria.
303
Budd, si è visto, sostiene che le metafore debbano essere parafrasabili letteralmente; Davies è un po’
più morbido, e sostiene che una metafora sia chiarificabile anche facendo ricorso ad altre metafore. Entrambi sono comunque d’accordo sulla necessità di spiegare il senso delle metafore; senso che essi non
ravvedono nelle descrizioni della musica in termini emotivi. Tali termini sono, secondo i due autori, insostituibili, ma non in quanto descrizioni metaforiche ineliminabili di una verità ineffabile, bensì in
quanto descrizioni letterali di proprietà espressive che sono nella musica, e che affondano le loro radici
in un certo tipo di isomorfismo.
213
7. Jerrold Levinson: isomorfismo dell’esperienza vs isomorfismo descrittivo
L’ultimo autore che prenderemo in esame nel nostro lavoro è Jerrold Levinson.
Non si tratta di una scelta casuale: la teoria di Levinson sull’espressività musicale, come vedremo tra poco, si presenta infatti, e ciò è evidente anche nelle intenzioni esplicite dell’autore, come una sorta di grande sintesi delle riflessioni fin qui esposte, sebbene
tale sintesi sfoci in una posizione alquanto originale e che non ha mancato di destare
perplessità in altri autori di ambito analitico. Il saggio a cui faremo principalmente riferimento è Musical Expressiveness (1996), dove Levinson porta a compimento le idee
elaborate in forma ancora sperimentale in Music and Negative Emotion (1990) e Hope
in ‘the Hebrides’ (1990) sul tema dell’espressività musicale. Egli esordisce chiarendo
che il suo obiettivo primario è quello di dire esattamente che cos’è l’espressività musicale, ovvero di fornire un’analisi compiuta di cosa significhi dire che un passaggio musicale P è espressivo di un’emozione E o di un qualche altro stato psicologico; il che
significa che poco spazio sarà dedicato allo studio delle cause o dei fondamenti
dell’espressività musicale, o del valore dell’espressività nella musica.
Per meglio chiarire che cosa egli intenda con espressività musicale, Levinson fa
i seguenti esempi “non convenzionali” di musica espressiva: “l’apertura dell’Ottavo
Quartetto di Shostakovich, la quale esprime tristezza e disperazione; l’Ottetto di Mendelssohn, il quale esprime una soave esuberanza; il finale della Musica da Camera N. 1
di Hindemith, il quale esprime una insolente impudenza; l’apertura del Don Giovanni
di Strauss, la quale esprime uno stato mentale giovanile, energico ed eroico” 304 . Questi
sono i tipi di attribuzioni di cui egli cerca di illuminare il contenuto. Lo schema seguito
da Levinson nel saggio Musical Expressiveness è abbastanza lineare, come nella tipica
tradizione analitica. Il primo passo è costituito dal presentare una lista di desiderata che
un’adeguata spiegazione dell’espressività musicale dovrebbe soddisfare. Dopodiché
l’autore passa in rassegna un numero di proposte recenti relative a come si debba concepire l’espressività musicale, evidenziando le virtù e i vizi di ciascuna, e concludendo
con quelle che sembrano essere le più adeguate. È solo a questo punto che Levinson
avanza la sua proposta, mostrando come essa soddisfi (meglio delle posizioni rivali) i
desiderata elencati all’inizio, e difendendola infine dalle obiezioni a cui essa va inevitabilmente incontro.
304
J. Levinson, Musical Expressiveness, cit., p. 90.
214
Ecco dunque quelli che, secondo Levinson, sono i desiderata che un’analisi accettabile dell’espressività musicale deve cercare di soddisfare:
L’espressività musicale dovrebbe essere vista come parallela o
analoga all’espressione nel suo senso più letterale, ovvero, dovrebbe
essere vista come il manifestarsi di stati psicologici attraverso segni
esterni, in particolare attraverso il comportamento (requisito
dell’“analogia”).
II. L’espressività musicale dovrebbe essere vista come collegata in
modo intelligibile all’espressività nelle altre arti, o perché essa è chiaramente una specie dell’espressività artistica considerata in generale,
in accordo con una qualche plausibile concezione di quest’ultima, o
perché essa è un parente stretto dell’espressività esibita nelle altre arti, laddove la divergenza è spiegabile in termini delle differenze salienti nei media utilizzati (requisito dell’“estendibilità”).
III. L’espressività musicale dovrebbe essere vista come appartenente inequivocabilmente alla musica − ovvero come un sua proprietà o
un suo aspetto − e non all’ascoltatore o all’esecutore o al compositore
(requisito dell’ “esternalità”).
IV. L’espressività musicale dovrebbe essere qualcosa che un ascoltatore sensibile esperisce o percepisce direttamente, piuttosto che
pervenirvi intellettualmente, attraverso il ragionamento o la dimostrazione, almeno nei casi principali, ovvero in quelli concernenti
l’espressione semplice (requisito dell’ “immediatezza”).
V.
L’espressività musicale può essere concepibile come relativa a
stati troppo specifici per essere tradotti in parole, ma deve comprendere anche, e principalmente, stati psicologici familiari considerati in
generale (requisito della “generalità”).
VI. L’espressività musicale dovrebbe essere tale che, quando venisse percepita o rilevata da un ascoltatore, ne deriverebbe naturalmente,
se non inevitabilmente, l’evocazione di un sentimento o di uno stato
affettivo, oppure l’immaginazione di un sentimento (requisito dell’
“affettività”).
VII. L’espressività musicale dovrebbe essere tale che l’esperienza di
essa dovrebbe accompagnarsi al riconoscimento di un valore, contribuendo ad accrescere, perlomeno di norma, il valore dei brani che la
possiedono (requisito dell’ “avere valore”) 305 .
I.
Il secondo passo, come detto, consiste nell’elencare quelle che egli identifica
come le principali posizioni che nel dibattito analitico si sono contraddistinte relativamente al tema dell’espressività musicale. Levinson traccia a tal fine la seguente “mappa”:
305
Ivi, pp. 91-92.
215
In primo luogo, vi sono le concezioni basate sull’evocazione (o
sull’eccitazione), le quali si differenziano in disposizionalista (Nolt),
dell’appropriata risposta (Matravers) e auto-espressiva (Ridley).
In secondo luogo, ci sono le concezioni basate sulla finzione, le quali
si differenziano in introspezionalista (Walton), impersonalista
(Budd), e rappresentazionalista (Callen).
In terzo luogo, ci sono le concezioni basate sulla metafora, le quali si
differenziano in esemplificazionalista (Goodman) e proiettivista
(Scruton).
In quarto luogo, ci sono le concezioni basate sul giudizio (o
sull’inferenza), le quali si differenziano in teoria della corrispondenza
(Wollheim), dell’adeguatezza (Barwell) e spiegazionista (Vermazen).
In quinto e ultimo luogo, ci sono le concezioni basate sull’aspettodell’espressione, le quali si differenziano in vocalista (Elliott), fisiognomista (Davies) e animazionista (Kivy) 306 .
Levinson anticipa che è in quest’ultimo gruppo che la sua teoria si colloca, sebbene le somiglianze e le differenze emergeranno solo in un secondo momento, ovvero
dopo la disamina delle principali teorie appena menzionate. Piuttosto che ripercorrere
per intero tale disamina, ci concentreremo qui su quelle teorie alle quali abbiamo dedicato più spazio all’interno del nostro lavoro, e che rivestono una particolare importanza
nel dibattito analitico sulla questione dell’espressività musicale. Iniziamo dalla teoria di
Malcolm Budd, la quale, come detto, può essere vista come una variante della tesi di
Walton (riletta alla luce del modello isomorfico). Ciò che Budd in sintesi propone è
questo: un passaggio P è espressivo di E se e solo se è finzionalmente vero che E viene
esperito, sebbene non necessariamente dall’ascoltatore, e questa verità è generata da P
nel modo corretto.
Budd è arrivato a questa forma più impersonale di espressività-come-emozionefinzionale in quanto egli pensa, giustamente, che “non è auspicabile rappresentare la
mia esperienza del sentire (un passaggio) come angosciato in un modo tale che il mio
ascoltare (tale passaggio) debba essere considerato come il mio esperire (finzionalmente) l’angoscia. … Poiché sebbene ciò possa essere vero, non è necessario che le cose
vadano in questa maniera: invero, la musica angosciata non sempre richiede che
l’ascoltatore che riconosce l’angoscia (nella musica) sia finzionalmente angosciato
(ovvero, si immagini di essere angosciato in virtù dell’ascolto della musica)” 307 . Ma
Budd ammette che in realtà non sa bene come l’espressione “nel modo corretto”, contenuta nella formulazione precedente, debba essere intesa, ed egli è comprensibilmente
scettico di fronte alla possibilità di delucidare tale espressione facendo ricorso a regole
306
307
Ivi, pp. 92-3.
M. Budd, Music and the Communication of Emotion, cit., p. 135.
216
convenzionali della finzione che determinino il funzionamento dell’espressione musicale. In effetti, sembra che l’unica maniera plausibile di chiarire in che modo la verità
finzionale che E viene esperito debba essere generata affinché P esprima E sia quella di
postulare che un ascoltatore è spinto, nell’ascoltare P, a percepirlo come E, il che renderebbe inutile l’attribuire un qualsivoglia ruolo più elaborato alla finzione.
In effetti, Budd sembra concludere che forse si debba conservare “solo l’idea
sottesa all’approccio finzionale”, ovvero “l’idea che la musica emozionalmente espressiva è (una musica) concepita per spronare l’ascoltatore ad immaginarsi il sopraggiungere di esperienze emotive”, il che lascia aperta la questione di come ciò realmente avvenga. Ridotta a questa idea di base, osserva Levinson, probabilmente non vi è alcun
conflitto tra l’approccio finzionale e quello da lui stesso raccomandato: secondo la sua
prospettiva, infatti, la musica espressiva è una musica che invita l’ascoltatore ad immaginare delle emozioni, ma solo e specificatamente nel senso che l’ascoltatore è propenso ad immaginare che la musica sia un particolare tipo di manifestazione esteriore di
una qualche emozione − ovvero (come vedremo meglio poi) nel senso che l’ascoltatore
è propenso a percepire la musica, nell’ascoltarla, come un’espressione personale, sui
generis, di tale emozione da parte di un non meglio specificato individuo.
Passando alla quinta classe di teorie precedentemente individuate − ovvero le
concezioni basate sull’aspetto dell’espressione −, vediamo cosa Levinson ha da dire
sulla teoria proposta da Stephen Davies, riassunta nella seguente maniera: P è espressivo di E se e solo se P presenta alcune caratteristiche sonore esteriori delle emozioni associate ad E − ovvero, presenta un aspetto sonoro analogo alle caratteristiche esteriori
comportamentali dell’emozione E. L’idea di fondo che muove la riflessione di Davies,
e su cui egli fonda la propria teoria, è che l’espressività musicale “dipende prevalentemente da una somiglianza che percepiamo tra il carattere dinamico della musica e il
movimento, l’andatura, il comportamento o l’atteggiamento dell’uomo” 308 . Pertanto,
“quando si ascolta la musica, le emozioni sono percepite come appartenenti ad essa,
proprio come gli aspetti esteriori delle emozioni sono presenti nel comportamento,
nell’atteggiamento e nell’andatura dei nostri simili e di altre creature viventi. La gamma di emozioni che la musica, quando viene ascoltata, presenta nella maniera appena
esposta, è ristretta, come pure è vero degli aspetti dell’uomo (ovvero del suo compor-
308
S. Davies, Musical Meaning and Expression, cit., p. 229.
217
tamento), a quelle emozioni o stati d’animo aventi espressioni comportamentali caratteristiche” 309 .
Secondo Levinson lo spirito di questa teoria è affine a quello della teoria che lui
stesso difende; ciò che non lo convince è tuttavia la nozione principale attorno alla quale tale teoria ruota, vale a dire la nozione di ‘caratteristica esteriore musicale’ delle emozioni. Il problema, di cui Davies è consapevole, è che l’aspetto di un passaggio musicale non è precisamente quello di una persona, o del viso o del corpo di una persona,
in qualunque condizione, o del comportamento di una persona, in qualunque momento.
Si tratta piuttosto, quando un passaggio musicale presenta un modo di apparire
dell’emozione attraverso delle sequenze di suoni, di un modo di apparire analogo (o
simile) a quello manifestato da una persona in una certa condizione. Ma allora, dato
che ogni cosa è analoga (o simile) a qualsiasi altra cosa in qualche grado, il problema
diventa quello di stabilire quanto grande deve essere l’analogia tra tale modo e quello
manifestato dal comportamento umano affinché esso possa costituire una caratteristica
esteriore sonora dell’emozione in questione, o anche quanto grande deve essere
l’analogia tra l’esperienza (come Davies stesso talvolta, più cautamente, sostiene) del
movimento musicale e quella del comportamento umano affinché il modo di apparire
di tale movimento costituisca una caratteristica esteriore sonora dell’emozione in questione.
È chiaro, secondo Levinson, che non si può rispondere a tale questione, se non
facendo appello alla nostra disposizione a percepire, nell’ascolto, tale emozione − piuttosto che un’altra, o nessuna − nella musica, ovvero, facendo appello alla nostra disposizione a interpretare la musica come un’istanza fonetica di un’espressione personale,
cioè a percepire gli aspetti umani in quelli musicali: la nostra disposizione, in breve, ad
animare i suoni in una certa maniera. Solamente se avviene ciò, la musica possiede
l’espressività in questione, indipendentemente dal grado oggettivo di analogia o somiglianza tra certi aspetti della musica e alcuni aspetti dell’uomo, come “la sua andatura,
il suo comportamento o il suo atteggiamento”, in relazione ai quali essa è in ultimo espressiva. Non vi è infatti alcuna regola che ci permetta di tradurre le caratteristiche
comportamentali esteriori in caratteristiche musicali esteriori; solamente l’atto del percepire, nella musica, i lineamenti del primo tipo di caratteristiche dà luogo alle seconde
come tali. L’accusa che Levinson fa alla concezione di Davies è che, sostanzialmente,
essa ha la colpa di mettere il carro − l’aspetto espressivo che risulta presente in un pas309
Ivi, p. 239.
218
saggio (musicale), il quale viene identificato come espressivo di E − davanti ai buoi −
l’esperienza del percepire E nel passaggio che viene ascoltato.
Sebbene sia abbastanza chiaro che Davies non vuole appoggiare la tesi secondo
cui l’espressività musicale consiste in un’analogia, o somiglianza, con il comportamento letteralmente espressivo, il suo fare appello alle caratteristiche sonore delle emozioni
in quanto poggianti su tale analogia o somiglianza ed emergenti su di essa suggerisce
perlomeno che tali caratteristiche abbiano delle identità specificabili indipendentemente dalle esperienze del percepire l’espressione delle emozioni nella musica, e che esse
probabilmente siano in ultimo ricavabili e classificabili di per se stesse, nello stesso
modo in cui lo sono le caratteristiche esteriori comportamentali delle emozioni direttamente associate con le emozioni vissute − ad esempio, il carattere tipico di una faccia
allegra, di uno sguardo triste, o di un gesto arrabbiato. Ma che ciò sia realmente possibile, ovvero che sia possibile identificare una particolare specie di aspetto caratteristico
della musica “triste”, nello stesso modo in cui è possibile individuare le caratteristiche
esteriori che le persone tristi nella vita reale normalmente manifestano, è secondo Levinson alquanto dubbio.
Detto di Davies, vediamo come Levinson considera la proposta di Roger Scruton. Innanzitutto egli chiarisce che, sebbene tale concezione sia stata dallo stesso Levinson classificata tra quelle basate sulla metafora, essa potrebbe rientrare anche
nell’ambito delle teorie basate sull’aspetto delle emozioni. Per quanto sia difficile formulare una proposta specifica sull’espressività sulla base di quanto affermato da Scruton − una delle ragioni di ciò è che egli è più interessato a dire che cosa significhi ascoltare, e penetrare in, tale espressività, piuttosto che a offrirne un’analisi −, Levinson
ritiene che si possa interpretare la posizione di Scruton traducendola nella seguente
formula: un passaggio musicale P è espressivo di un’emozione E nella misura in cui esso viene esperito come se presentasse o contenesse dei gesti caratteristici
dell’espressione di E.
Se le cose stanno in questa maniera, allora la teoria di Scruton è credibile, sebbene Levinson non possa esimersi dal confessare due riserve al riguardo. La prima riguarda il fatto che essa poggia sull’idea di metafora. Levinson, come anche altri autori
già menzionati (si pensi soprattutto a Budd), pensa che il fare appello alla metafora in
generale tende ad oscurare, piuttosto che illuminare, la questione dell’espressività. Una
seconda, anche se più piccola, riserva, riguarda il fatto che il requisito dell’esperibilità
dei gesti caratteristici di una particolare emozione, anziché dell’espressione esteriore
219
dell’emozione, in una qualche maniera, è, probabilmente, inutilmente limitante. Ma
Scruton ha sicuramente ragione, precisa Levinson, a dire che l’esperienza
dell’espressione nella musica assume principalmente la forma del percepire,
nell’ascolto del movimento musicale, i gesti compiuti da un individuo che esprime
un’emozione; su questo punto le rispettive teorie giocano sullo stesso terreno.
L’ultima spiegazione dell’espressività musicale che Levinson prende in considerazione è quella fornita da Peter Kivy in The Corded Shell. Nel testo di Kivy, Levinson rintraccia tre distinte proposte relative al tema in questione. Una è che un passaggio
musicale P è espressivo dell’emozione E se e solo se P viene interpretato come somigliante, nel suo profilo, al comportamento caratteristico di E; la seconda è che P è espressivo di E se e solo se P è collegato a E per mezzo di una somiglianza nei profili o
di un’associazione convenzionale o di entrambe le cose; e la terza è che un passaggio
musicale P è espressivo dell’emozione E se e solo se gli ascoltatori sono disposti ad ‘animare’ P attribuendogli l’emozione E.
Le prime due proposte, che il testo di Kivy (implicitamente) suggerisce, sostituiscono fatalmente una lista delle cause e dei fondamenti primari dell’espressività musicale con l’analisi del concetto dell’espressività musicale stessa. La prima proposta,
inoltre, ha l’ulteriore difetto di escludere pregiudizialmente l’elemento convenzionale
dell’espressività, il che chiaramente non è nelle intenzioni di Kivy. Ma, per ciò che riguarda la terza proposta, essa è, a giudizio di Levinson, sostanzialmente corretta.
L’unico problema è, a suo avviso, che essa rimane in qualche maniera oscura, dato che
la nozione di animazione richiede una delucidazione tanto quanto la richiede la nozione
di espressività. È proprio qui che può innestarsi la proposta di Levinson, in quanto egli
crede che l’ascoltare la musica come, o come se fosse, un’espressione personale, catturi
ciò che Kivy vuol dire con l’espressione ‘animare i suoni’. Ciò è confermato da quanto
Kivy stesso altrove esplicitamente afferma: “Noi dobbiamo vedere uno schema visivo
come un veicolo di espressione − un volto o una figura − prima di poter vedere la sua
espressività. Analogamente, noi dobbiamo ascoltare uno schema sonoro come un veicolo di espressione − una enunciazione o un gesto − prima di poter ascoltare la sua espressività” 310 .
A questo punto, Levinson è pronto a introdurre la propria concezione
dell’espressività musicale, che egli formula nella seguente maniera:
310
P. Kivy, Sound Sentiment, cit., p. 59.
220
un passaggio musicale P è espressivo di un’emozione o di un’altra
condizione psichica E se e solo se P, in un certo contesto, è prontamente e appropriatamente percepito nell’ascolto, da un ascoltatore
adeguatamente informato, come l’espressione di E, effettuata in una
maniera sui generis e “musicale” da parte di un agente indefinito, il
personaggio della musica 311 .
In questa proposta vi sono delle chiare affinità con le precedenti proposte relative all’argomento in questione; il merito che Levinson si riconosce è di aver offerto nel
modo più esplicito possibile, attraverso la formulazione appena fornita, il nucleo essenziale dell’espressività musicale − la pronta-percettibilità-come-espressione − a cui un
consistente numero di autori si è approssimato, insieme eliminando tutto ciò che è inessenziale o che risponde ad altri aspetti del fenomeno dell’espressività nell’arte, come
quello relativo a quali strutture o convenzioni servono a garantirne il funzionamento
(ovvero alle cause dell’espressività), o a quali tipi diversi di risposta ad essa potrebbero
esserci (ovvero agli effetti dell’espressività).
La formula esposta da Levinson non è però pienamente comprensibile se non si
fanno alcune precisazioni, che l’autore stesso ha esplicitato. Innanzitutto, egli specifica
che per “contesto” intende sia il contesto interno all’opera − quello costituito dai passaggi musicali tra i quali quello dato si inserisce e con i quali si relaziona − sia il contesto esterno all’opera − quello costituito dallo stile individuale e generale entro cui la
composizione data si inserisce, così come dall’ambiente che circonda i brani musicali
di tale compositore e di altri compositori. Con l’avverbio “adeguatamente”, egli sottolinea il fatto che gli ascoltatori in questione devono aver familiarità con lo stile della
musica e con la gamma espressiva ad esso inerente, con la natura e con le potenzialità
degli strumenti adoperati, con gli scopi generali dei compositori di quel periodo, con le
norme strutturali e estetiche del genere musicale a cui il brano dato appartiene, e così
via. Inoltre essi devono anche essere in grado di dar prova di possedere le abilità, le capacità discriminatorie, e le capacità di reazione comportamentale necessarie
all’elaborazione di un giudizio estetico credibile312 . Levinson chiarisce anche il perché
egli ha denominato la maniera “musicale”, utilizzando le virgolette: lo scopo è quello
di indicare che il personaggio della musica non deve essere concepito come una persona che esprime la propria emozione attraverso dei mezzi musicali. Vale a dire, non si
311
J. Levinson, Musical Expressiveness, cit., p. 107.
Il fatto che i “giudici” siano in grado di dar pubblicamente prova di tali abilità, e il riscontro di una
convergenza dei loro giudizi circa brani musicali diversi da quello in questione, fanno sì, secondo Levinson, che la sua definizione non incorra in un circolo vizioso.
312
221
sta qui suggerendo che ci immaginiamo che il personaggio in questione suoni il piano,
o la tromba, oppure canti; piuttosto, si intende dire che il personaggio, in una qualche
maniera non meglio specificata, sta manifestando l’emozione attraverso la creazione
musicale, ma non nella maniera in cui le persone dotate di abilità musicali normalmente fanno. Infine, un’ultima precisazione dovrà riguardare il fulcro della definizione
dell’espressività musicale offerta da Levinson, vale a dire “Il personaggio della musica”, il quale, spiega l’autore, dovrebbe essere inteso come il soggetto dell’atto espressivo immaginario che percepiamo immediatamente nell’ascolto. L’ascolto espressivo
di una porzione di musica piuttosto estesa, in quanto opposta a un particolare passaggio, può ovviamente coinvolgere una serie di personaggi, piuttosto che uno solo.
Levinson sostiene che sia possibile pervenire alla posizione alla quale egli è
pervenuto relativamente al problema dell’espressività musicale, non solo cercando le
affinità tra le diverse concezioni fin qui proposte da altri autori, ma anche partendo da
quella che, probabilmente, va considerata come l’idea principale di base riguardo
all’espressività nella musica, ovvero l’idea che un passaggio musicale P è espressivo di
E se, per un ascoltatore normale e dotato di una certa esperienza, esso suona come E.
Tale idea è sfociata nel famoso detto di Carroll Pratt, più volte citato anche nel corso
del nostro lavoro: “La musica suona nel modo in cui le emozioni sono provate”. Tuttavia questa idea, posta in tali termini, non è secondo Levinson accettabile, poiché non
possediamo alcuna concezione intelligibile di cosa potrebbe voler dire, in astratto, il
suonare come una qualsivoglia cosa. Si potrebbe allora perfezionare l’idea di base proponendo che, quando è espressivo, il passaggio viene piuttosto percepito come risuonante in maniera analoga all’esperienza che qualcuno ha di E. Questo è di sicuro un
miglioramento, poiché fornisce perlomeno un qualcosa di particolare e di personale al
quale il passaggio musicale può essere collegato foneticamente. Ma non siamo ancora
arrivati a una soluzione soddisfacente, poiché rimane altrettanto difficile da comprendere cosa significhi che l’esperienza personale di un’emozione suoni come una qualsivoglia cosa. Il passo successivo nel processo di perfezionamento dell’idea di base non
può che essere allora, secondo Levinson, il postulare che P viene percepito come risuonante in maniera analoga all’espressione di E da parte di un qualche individuo − un
individuo che sta manifestando esternamente la propria esperienza di E. Il fatto che la
musica debba suonare in maniera analoga ad una manifestazione esteriore di
un’emozione è perfettamente intelligibile, sostiene l’autore, ed è, in effetti, un fatto letteralmente vero, in relazione a certe espressioni comportamentali, vocali e non, delle
222
emozioni. In più, è facile e abbastanza naturale per noi immaginare l’esistenza di un
modo di esprimere le emozioni alternativo e “specificatamente” musicale. Pertanto,
riadattando il detto di Pratt alla luce di queste riflessioni, potremmo giungere ad affermare qualcosa del tipo: “La musica suona nel modo in cui una persona che esperisce e
manifesta esternamente certe emozioni è” 313 ; il che è un altro modo per affermare la
definizione dell’espressività musicale precedentemente fornita da Levinson, la quale, è
evidente, soddisfa il fondamentale requisito dell’esternalità (terzo desideratum).
Nel saggio che stiamo principalmente prendendo in esame, vale a dire Musical
Expressiveness, Levinson dichiara all’inizio, come detto, di non voler discutere né di
quelle che sono le cause dell’espressività musicale, né dei suoi possibili effetti o conseguenze sull’ascoltatore, in quanto entrambi sono elementi inessenziali rispetto alla descrizione del significato intrinseco dell’espressività stessa. Tuttavia, una volta esplicitata la sua teoria della ‘persona musicale’, egli ritiene che un esame, seppur breve, dei
suddetti elementi possa aiutarci a comprendere meglio alcuni importanti risvolti della
teoria appena menzionata. Per ciò che concerne le cause dell’espressività musicale, Levinson ritiene che la somiglianza isomorfica tra musica e emozioni sia un fattore fondamentale per l’attribuzione di proprietà emotive alla musica, ma non sia l’unica. Altri
fattori importati, che l’isomorfismo tende colpevolmente a ignorare, sono costituiti innanzitutto da quelle che lui chiama “risposte sub-emotive”, o “micro-sentimenti” − i
quali comprendono “scosse, fremiti, pelle d’oca, soffocamenti; fitte, spasimi, sussulti,
brividi; aumenti di tensione e rilassamenti, accelerazione e rallentamento del respiro,
tensione e rilassamento dei muscoli; stati di aspettativa, apprensione, eccitazione, calma, soddisfazione, frustrazione; sentimenti di sorpresa, di conclusione, di incertezza;
aumenti e cali di attenzione” 314 − che accompagnano il nostro ascolto dei brani musicali. Un’accelerazione del tempo o una suddivisione del battito può ad esempio produrre
un aumento del battito cardiaco; un aumento costante di frequenza può generare ansia;
la dolcezza di un accordo o di un vocalizzo può provocare una certa quantità di piacere;
la risoluzione di una sospensione può portare a una sensazione di carattere misto; una
dissonanza stridente può produrre un leggero dolore; una modulazione inattesa genera
disorientamento; un cambiamento di direzione particolarmente attraente di una frase
musicale suscita il desiderio che esso venga ripetuto o variato. Ora, Levinson sostiene
che, sebbene non costituiscano l’intera componente esperienziale delle emozioni ordinarie, tali reazioni intrattengono evidentemente molte relazioni di affinità con le emo313
314
Ivi, p. 116.
Ivi, p. 113.
223
zioni e con altri stati intenzionali pienamente sviluppati; esse sono gli ingredienti di tali
stati, e sono evocativi degli stessi, sebbene di per se stesse tali reazioni non siano in
grado di indicare in maniera univoca nessuno di questi stati 315 .
Non bisogna poi dimenticare il ruolo giocato da fattori di carattere convenzionale − pensiamo ad esempio al timbro del trombone, che solitamente tende (in assenza
di elementi contrastanti) a rendere un passaggio musicale, per usare la terminologia levinsoniana, più prontamente ascoltabile come l’espressione comportamentale umana
della solennità. Ad ogni modo, rimane il fatto che, in osservanza del requisito
dell’analogia (primo desideratum), la proposta avanzata da Levinson preservi un ruolo
primario al fattore della somiglianza tra la musica e i modi d’espressione umani, in particolare di quelli riguardanti il suo comportamento, il suo gesticolare, il modo di camminare o parlare, e via dicendo. L’isomorfismo non è dunque l’unico fattore percepito
responsabile dell’espressività (pur essendo quello principale); inoltre ciò che soprattutto distingue la proposta di Levinson da quelle di Pratt, Budd, Scruton o Davies, è che il
primo chiama in causa, come elemento necessario all’attribuzione di proprietà espressive alla musica, la nostra predisposizione non solo a percepire tali fattori, ma anche a
immaginare, a partire da essi, l’esistenza, attraverso la musica, di un individuo che agisce in una maniera in qualche modo simile a quella seguita dagli esseri umani quando
manifestano le loro emozioni, pur utilizzando risorse diverse da quelle a cui questi ultimi attingono − ovvero risorse che sono analoghe al gesticolare, all’esprimersi con la
voce, al muoversi in maniera espressiva, tipici dell’uomo, in tutte le loro forme, compresa la danza, ma che vanno al di là di queste. Quando la musica è espressiva, essa ci
predispone a interpretarla come se essa fosse, o accogliesse in sé, un individuo che manifesta esternamente la sua vita interiore, attraverso delle modalità nuove e dotate di
una potenza senza precedenti 316 .
Passando invece agli effetti dell’espressività (come peraltro richiesto dal sesto
desideratum, ovvero dal requisito dell’affettività), Levinson sostiene che vi possono essere almeno tre diverse maniere in cui un passaggio musicale espressivo può produrre
uno stato affettivo in un ascoltatore. La prima implica che l’ascoltatore riconosca e identifichi, consapevolmente, il fatto che tale passaggio sia caratterizzato dall’emozione
315
Sull’importanza delle reazioni fisiche suscitate dall’ascolto della musica, si veda anche J. Levinson,
Musical Chills, in Id., Contemplating Art, cit., pp. 220-36.
316
A proposito, Levinson suggerisce anche che ascoltare un passaggio musicale come espressivo di E
possa equivalere ad “ascoltarlo come, o a immaginarlo come se fosse, una persona che parla a noi in un
linguaggio nuovo − un linguaggio che ci sembra di comprendere a un livello emotivo, sebbene non abbiamo familiarità con esso − e che attraverso tale linguaggio esprime ciò che sta provando”. (J. Levinson, Musical Expressiveness, cit., pp. 115-6).
224
E, e quindi reagisca a tale riconoscimento in maniera empatica, simpatetica, o antipatetica. La seconda implica che l’ascoltatore colga, in maniera sub-conscia, il fatto che tale passaggio sia caratterizzato da E, ad esempio riproducendone mentalmente i gesti,
senza tuttavia che ciò sfoci nel riconoscimento intellettuale del tipo di emozione riprodotta. Il terzo, infine, implica che l’ascoltatore, col suo bagaglio di aspettative (musicali
e percettive), semplicemente segua la progressione musicale del passaggio e provi un
insieme variabile di reazioni di piccola scala e di micro-sentimenti del tipo precedentemente esemplificato che si sono in lui generati, i quali in modo naturale alimentano,
in qualità di materiali di base, l’apprensione, conscia o sub-conscia, dell’espressività
del passaggio in questione e influenzano quindi, in ultimo, ciò di cui il passaggio viene
percepito, nell’ascolto, come espressivo.
I sentimenti che proviamo in risposta alla musica non sempre, dunque, sono il
risultato di un’identificazione volontaria con l’emozione del personaggio musicale che
ci immaginiamo nell’ascolto. Altrettanto spesso, certi tipi di risposte emotive − le quali
sono state denominate da Levinson sub-emotive − precederanno e alimenteranno una
siffatta identificazione con un personaggio, così come influenzeranno il modo in cui
l’emozione del personaggio verrà costruita, o il tipo di emozione. Inoltre, quando
l’identificazione con la musica è la via principale per la stimolazione di uno stato affettivo, non si dovrebbe pensare che si tratta sempre di una vera identificazione con, e della condivisione de, l’emozione del personaggio in quanto compresa e classificata in una
certa maniera. Talvolta è sicuramente così; ma spesso si tratta semplicemente dell’autoappropriazione dei gesti percepiti nell’ascolto della musica, o semplicemente
dell’assecondare internamente il fluire della musica nel mentre la si ascolta comprendendola (si pensi ad esempio al silenzioso “cantare insieme alla musica”), nessuno dei
quali (fenomeni) presuppone la percezione consapevole, da parte dell’ascoltatore, del
personaggio che esperisce e esprime una qualche particolare emozione.
Vediamo ora come Levinson affronta alcune delle obiezioni alle quali la concezione che spiega l’espressività musicale in termini di ascoltabilità-come-espressionepersonale può andare incontro. A tale concezione si potrebbe innanzitutto obiettare che
l’immaginare un agente che stia esprimendo, attraverso ciò che avviene all’interno della musica, un’emozione E − al quale atto d’immaginazione potremmo equiparare il
percepire la musica, nell’ascolto, come un’espressione di E − non può essere una condizione necessaria al riconoscimento del fatto che tale musica è espressiva di E, dal
momento che un ascoltatore non ha bisogno di immaginare una siffatta cosa. La rispo225
sta di Levinson consiste nel precisare che l’ascoltare-come immaginativo che, secondo
la sua teoria, solitamente ha luogo quando percepiamo tale espressività, non deve necessariamente essere posto molto in primo piano, né, come egli ha già precedentemente
sottolineato, deve necessariamente essere determinato in maniera assai precisa per ciò
che riguarda la natura e l’identità dell’agente che sta esprimendo l’emozione o i meccanismi attraverso cui il suddetto agente manifesta esteriormente le emozioni per mezzo della musica.
In secondo luogo, si potrebbe obiettare alla concezione di Levinson che essa
implica che l’apprensione dell’espressività musicale sia un processo più riflessivo e intellettuale di quanto non sembri essere nella realtà, il che le impedirebbe di soddisfare
il quarto desideratum della lista fornita all’inizio (ovvero il cosiddetto ‘requisito
dell’immediatezza’). Sembrerebbe infatti che, stando a quanto richiesto dalla teoria di
Levinson, un ascoltatore che trovi un certo passaggio espressivo debba non solo percepire o ascoltare la musica come se fosse espressiva di un’emozione, ma debba anche
inferire o giudicare che essa è stata prontamente e adeguatamente ascoltata in questa
maniera da altre persone. Levinson risponde che, secondo la propria concezione, la
percezione o l’apprensione dell’espressività musicale è davvero, di solito, immediata e
non-inferenziale. Ovvero, un ascoltatore qualificato ascolta la musica come se (essa)
fosse un atto di espressione emotiva, acquisendo così in maniera del tutto normale, e
senza l’intervento della riflessione, la convinzione che la musica sia prontamente e adeguatamente ascoltata in questa maniera da altre persone. Con ciò non va confusa però la conoscenza del fatto che la musica è risultata essere espressiva di un determinato
stato emozionale − il che andrebbe tenuto distinto dalla semplice percezione o apprensione, da parte dell’ascoltatore, di tale espressività −, la quale conoscenza potrebbe in
effetti richiedere la conferma testimoniata dalle reazioni convergenti avute da altri ascoltatori qualificati, o la consultazione di critici riconosciuti, i quali hanno lasciato una
testimonianza scritta delle loro esperienze di ascoltare-come. Se teniamo a mente tale
distinzione, conclude Levinson, allora non c’è alcuna contraddizione tra l’affermazione
secondo cui l’espressività musicale, nella formulazione che da lui ne viene data, è qualcosa che degli ascoltatori adeguatamente informati possono apprendere direttamente, e
l’ammissione che essi con ciò possono non sapere se l’espressività in questione sia
precisamente quella che risulta loro essere.
Si potrebbe ancora obiettare alla concezione di Levinson che essa rischia di ridurre l’espressività nella musica a una forma, seppur particolare, di rappresentazione.
226
Qual è la differenza, ci si potrebbe chiedere, tra l’ascoltare un passaggio come il gioco
delle onde nell’oceano, o come una battaglia, e l’ascoltare un passaggio come
l’espressione sui generis di un’emozione da parte di una persona? In altre parole, è
possibile evitare che l’espressività musicale collassi nella rappresentazione musicale,
allorché adottiamo un modello dell’espressività musicale basato sull’ “ascoltare come
se fosse un atto d’espressione”? 317 . La risposta, secondo Levinson, è affermativa; la sua
teoria riesce a mantenere distinti i piani dell’espressione e della rappresentazione artistiche, sebbene queste siano in verità in una relazione più stretta di quanto solitamente
si pensa (come presupposto dal secondo desideratum, ovvero dal requisito
dell’estendibilità). Secondo la sua concezione, chiarisce Levinson, “un passaggio musicale P esprime E non rappresentando E, ma fornendo ciò che è musicalmente richiesto,
anche solo virtualmente, per la rappresentazione o per le espressioni finzionali di E −
senza con ciò tuttavia rappresentare realmente tali espressioni” 318 . Non vi è una siffatta
rappresentazione, principalmente in quanto le condizioni intenzionali per la rappresentazione non sono soddisfatte; ovvero, i compositori in genere non hanno l’intenzione
che gli ascoltatori percepiscano tali atti espressivi nella loro musica. Inoltre, dato che
l’ascoltare-come qui coinvolto è una forma di ascoltare-come-se-fosse, l’esperienza che
sta al centro dell’ascoltare la musica come espressiva è di un tipo tutto sommato differente da quello dell’ascoltare, nei casi paradigmatici della rappresentazione musicale,
un oggetto o un evento udibile nella musica; il primo è un tipo più attenuato di ascoltare-come, in quanto è un ascoltare che sta sotto l’egida del pensiero di una determinata
espressione.
Un’ultima e particolarmente insidiosa obiezione che è stata indirizzata alla nozione di “modalità sui-generis” di espressione, su cui la concezione di Levinson si basa, può essere formulata nella seguente maniera:
Stando alla concezione difesa da Levinson, la musica espressiva è
una musica che viene ascoltata come l’espressione personale sui generis di un’emozione. La concezione sembra quindi richiedere che gli
ascoltatori ascoltino la musica come se fosse una modalità naturale di
espressione delle emozioni … ovvero “come il modo in cui una per317
In questa seconda tipologia di critiche può essere inserita, crediamo, anche la critica mossa da Silvia
Vizzardelli, la quale rileva che, se è vero, come vuole Levinson, che nell’ascoltare una musica espressiva
noi percepiamo le emozioni musicali “come se queste fossero espressione di un personaggio”, allora il
nostro rapporto con la musica è assimilabile a quello che abbiamo con la letteratura, poiché in ambo i
casi “ci immedesimo in un carattere”; con ciò negando la specificità di ciascuna di queste due forme di
espressività.
318
J. Levinson, Musical Expressiveness, cit., p. 119.
227
sona che sta esperendo l’emozione esprimerebbe comportamentalmente la sua emozione, se le persone esprimessero naturalmente i loro comportamenti attraverso la musica”. L’idea di base dell’ascoltare
la musica come espressiva dell’emozione E si suppone sia questa:
“Se la musica fosse una modalità naturale di espressione, questo brano musicale sarebbe realizzato da una persona che sta esperendo E”.
Tuttavia, se le percezioni espressive che gli ascoltatori hanno di questo brano musicale dipendono da questa considerazione controfattuale, allora essi devono sapere cosa significhi dire che la musica è una
modalità naturale di espressione. Ma dato che questo non si verifica,
e ciononostante essi sono comunque in grado di ascoltare la musica
come espressiva di emozioni, la concezione (basata sulla nozione di
modalità) sui generis, per come è stata esposta, non può essere corretta 319 .
È possibile, secondo Levinson, replicare in due modi a tale obiezione. Il primo
consiste nel continuare a sostenere che la modalità di espressione ascoltata nella musica
deve essere del tipo sui generis appena indicato, aggiungendo tuttavia che gli ascoltatori non devono necessariamente sapere, in maniera dettagliata, cosa significa che la musica è una modalità naturale di espressione, ma devono solamente essere disposti a postulare, nell’immaginazione, che la musica sia una siffatta modalità. Se quest’ultima
condizione viene soddisfatta, nulla ci impedisce di pensare che la musica, in virtù del
suo particolare profilo sonoro, delle risposte sub-emozionali che essa stimola, o di fattori convenzionali di vario genere, possa essere in grado di spingere gli ascoltatori a
percepirla, nell’ascolto, come una naturale e alternativa modalità di espressione.
Il secondo modo di replicare fa maggiori concessioni all’obiezione appena esposta. Esso richiede che si faccia quasi del tutto a meno di considerare la modalità di
espressione ascoltata nella musica espressiva come una modalità sui generis. Sebbene
la somiglianza tra la musica e le modalità di espressione umane sia solo parziale, probabilmente quando percepiamo l’espressività della musica noi stiamo ascoltando in essa non un tipo di espressione straordinario e sui generis, ma piuttosto un tipo non specificato di espressione personale − o anche semplicemente l’espressione personale tout
court. E nondimeno, l’espressione che ascoltiamo nella musica è tale che, se qualcuno
esprimesse davvero le proprie emozioni in quella maniera, ovvero, attraverso quella
che sembra essere una musica emessa spontaneamente, questo costituirebbe un tipo sui
generis di espressione. Quale delle due formulazioni dell’esperienza che funge da criterio per l’espressività musicale, si chiede quindi Levinson, è logicamente e fenomenologicamente la più indicata: 1) l’ascoltatore ascolta P come l’espressione personale di E
319
Ivi, p. 120.
228
(realizzata) in una maniera “musicale” e sui generis; o 2) l’ascoltatore ascolta P semplicemente come l’espressione personale di E, ma (realizzata) in una maniera che, se si
riflettesse su di essa, sarebbe considerata come sui generis? Non è così facile rispondere. Ad ogni modo, se adottassimo la risposta 1), l’obiezione verrebbe confutata; se adottassimo la risposta 2), l’obiezione verrebbe evitata.
Ci si potrebbe ancora chiedere se la teoria dell’ascoltabilità-come-espressionepersonale proposta da Levinson sia in grado di dar conto di quelle forme complesse e
pluri-stratificate dell’espressività musicale di cui normalmente facciamo esperienza. Si
pensi al terzo movimento del Quartetto per archi n. 6 di Bartok, intitolato “Burletta”,
dove vi sono delle parti che esprimono un certo umorismo, e tuttavia evocano in noi, di
primo acchito, l’immagine di una persona ubriaca; oppure si pensi alla musica “goffa”
e “zotica” (in particolar modo per le note suonate dal contrabbasso verso la fine del
pezzo) della Suite di Pulcinella di Stravinsky, la quale tuttavia è espressiva di un “pacchiano buon umore”. Di nuovo, sostiene Levinson, la sua teoria fornisce un buon paradigma per interpretare il carattere espressivo complesso di questi brani. Infatti, la ragione per cui Bartok esprime umorismo e non ubriachezza, e per cui Stravinsky esprime buonumore e non goffaggine, è che nell’ascoltare il primo brano noi percepiamo, in
ultima analisi, non una manifestazione (musicale) di ubriachezza, ma piuttosto
l’esistenza di un agente immaginario che finge, in maniera disinteressata, di essere ubriaco; così come nell’ascoltare il secondo brano noi percepiamo un agente immaginario che fa una parodia della suddetta goffaggine. In ciascuno dei due casi la musica
viene “prontamente” ascoltata, all’interno del rispettivo contesto stilistico, come la parodia di second’ordine del comportamento di prim’ordine che viene in un primo momento chiamato in mente dalla musica, e quindi esprime qualcosa come uno spirito
burlesco piuttosto che uno stato di rozzezza, oppure la parodia di un uomo ubriaco
piuttosto che uno stato di pura ubriachezza. Un’espressione complessa di tipo differente è illustrata dallo Scherzo del Quartetto in Do diesis minore Op. 131 di Beethoven.
Esso sembra essere espressivo di gioia, ma di un tipo particolare − una gioia che potremmo descrivere come frenetica. Questa espressività è in parte una funzione
dell’incedere proprio del brano, fatto di continue “fermate” e “ri-partenze”, di
un’alternanza di segmenti ora lunghi e movimentati, ora brevi e calmi. Noi ascoltiamo
la musica non semplicemente come l’espressione di gioia da parte di una persona, ma
come l’espressione di gioia da parte di una persona frenetica, o di una gioia che viene
esperita in maniera frenetica. È il modo in cui le diverse sezioni musicali sono collega229
te tra loro che è cruciale per la realizzazione di questo tipo più specifico di espressività,
che non si lascia ridurre al carattere immediato proprio delle singole sezioni prese di
per se stesse. Levinson suggerisce anche che in queste come in altre musiche noi percepiamo, in virtù della complessità della struttura compositiva, dei “personaggi musicali di ordine più elevato”, ovvero dotati di una personalità complessa (corrispondente al
modo in cui le diverse unità della composizione sono intrecciate) che non si lascia ridurre a un singolo carattere (corrispondente a una particolare frase, melodia, cellula
ritmiche, ecc).
La concezione dell’espressività musicale difesa da Levinson si accorda anche,
secondo l’autore, col fatto che alcuni, se non molti, passaggi musicali, pur essendo espressivi, non sono espressivi di stati emotivi a noi familiari e facilmente identificabili
(dei quali la suddetta concezione, come visto, dà conto, in osservanza del quinto desideratum, ovvero del requisito della generalità). Ci possono essere diverse ragioni per
questo, puntualmente rilevate da Levinson. Innanzitutto, un passaggio musicale, anche
quando è molto interessante dal punto di vista musicale, può non essere affatto espressivo − ovvero, esso può non indurre degli ascoltatori adeguatamente informati a percepirlo, nell’ascolto, come se fosse un’espressione emozionale di un qualsivoglia genere 320 . (Si pensi, ad esempio, ad alcune delle Invenzioni a due voci di Bach, o a certe
parti del balletto Apollo di Stravinsky, o al terzo movimento della quinta sonata per violoncello op. 105 di Beethoven). Oppure un passaggio potrebbe essere tale da indurre
negli ascoltatori varie e fluttuanti esperienze di ascolto della musica in quanto espressione di emozioni, esperienze che non convergono stabilmente su una particolare emozione; in altre parole, la dimensione espressiva di tale musica è irriducibilmente ambigua o indeterminata. (Alcuni esempi potrebbero essere rappresentati dall’inizio altamente evocativo del primo quartetto d’archi di Janacek, o dal primo movimento
dell’enigmatica Sonata per violoncello e pianoforte di Debussy). Oppure, il che è differente, un passaggio può essere tale da indurre, in ascoltatori adeguati, un’esperienza divisa o duplice, eppure stabile e convergente, di ascolto della musica come se fosse
un’espressione di emozioni; in tali casi vi è l’espressione non di una particolare emozione ma di uno stato emozionale ibrido o misto, uno stato che probabilmente non incontriamo molto spesso in situazioni extramusicali. (Un esempio potrebbe essere il se320
Anche per Levinson, come per altri autori citati nel nostro lavoro (si pensi ad esempio a Budd),
l’espressività, pur essendo un elemento importante della musica (oltre che dell’arte in genere), non è
l’unica fonte di valore di un brano musicale, che può essere interessante sotto molti altri profili (ad esempio per la sua struttura formale, per il suo collegarsi ad altre opere, ecc.). Si veda a tal proposito J.
Levinson, Evaluating Music (1998), ora in Id., Contemplating Art, cit., pp. 184 – 208).
230
condo tema del primo movimento del quartetto d’archi di Ravel, con la sua peculiare
mescolanza di malinconia, sensualità e mistero).
Infine, Levinson ci tiene a precisare in che modo la sua concezione soddisfa
l’ultimo dei desiderata da lui stesso elencati all’inizio, quello che richiede che una
spiegazione dell’espressività musicale debba riconoscere, e rendere intelligibile, il valore di tale espressività. In sintesi, egli sostiene che il valore che l’espressività musicale, intesa come la “pronta ascoltabilità della musica come espressione personale”, ha
per chi la ascolta, è il valore insito nel confrontare “immagini dell’esperienza umana”;
tale confronto, ovviamente, avviene anche nella nostra vita reale e quotidiana, ma
quando ascoltiamo una musica espressiva noi ci formiamo immagini che sono costituite e intrecciate con la sostanza della musica, una sostanza in cui possiamo essere assorbiti così da vicino che è come se, per usare la famosa frase di T.S. Eliot, diventiamo noi
stessi musica mentre la ascoltiamo, e partecipiamo così della vita mentale incarnata
nella musica stessa. Una tale immedesimazione nella musica avviene in virtù del fatto
che, e nella misura in cui, la musica in ultimo ci colpisce come se fosse davvero
l’espressione di una certa emozione da parte di qualcuno. Una volta che ciò accade, “ci
si apre la possibilità di identificarci con quell’atto immaginario di espressione e farlo
nostro, a vari livelli, riproducendo interiormente i suoi gesti e sperimentando attraverso
l’empatia i suoi aspetti più intimi − tutto ciò senza che si perda il contatto con le movenze specificatamente sonore che fanno sì che la musica sia esattamente ciò che è” 321 .
Il motivo per cui abbiamo deciso di concludere il nostro lavoro di ricerca con
l’analisi della teoria di Jerrold Levinson non è casuale. Sin dalle prime pagine del lavoro abbiamo infatti puntualizzato come fosse di primario interesse per noi l’evidenziare i
punti di contatto riscontrabili tra le diverse posizioni che hanno animato il dibattito
analitico sul tema dell’espressività musicale, piuttosto che schierarci con l’uno o con
l’altro partito appoggiandone così l’apparente incompatibilità. Non sono mancati, certo,
da parte dei vari autori qui esaminati, tentativi di mostrare delle affinità con quanto affermato da altri autori sullo stesso argomento. Tentativi che in Levinson assumono per
la prima volta un aspetto sistematico. Egli presenta infatti la sua teoria come il naturale
risultato del perfezionamento delle posizioni, pure per certi aspetti illuminanti, che lo
hanno preceduto e con cui egli si è confrontato.
Ora, ciò che qui in ultimo ci interessa non è tanto vedere se la teoria di Levinson ponga davvero la parola fine al dibattito sull’espressione delle emozioni in musica,
321
J. Levinson, Musical Expressiveness, cit., p. 125.
231
quanto prendere spunto dal metodo da lui seguito e puntualizzare quelli che, a nostro
avviso, sono i presupposti che sembrano accomunare la maggior parte delle posizioni
considerate.
Non ci sembra azzardato riconoscere in un certo grado di isomorfismo tra musica e emozioni la base principale dell’attribuzione di proprietà espressive alla musica.
Tale isomorfismo riguarda per lo più da un lato il movimento musicale, dall’altro la
componente propriamente affettiva (ovvero non cognitiva) delle emozioni. La relazione
di somiglianza isomorfica appena enunciata non è però qualcosa che viene passivamente recepita dal soggetto, il quale si avvale invece della facoltà dell’immaginazione, che
gli permette di percepire, ascoltandolo, il movimento musicale nel suo procedere in sintonia con le dinamiche proprie della vita emotiva dell’uomo. A questo punto serve però
un passaggio definitivo e coraggioso, vale a dire un vero e proprio salto da una nozione
descrittiva di isomorfismo ad una nozione esperienziale. Non importa ciò che naturalmente registriamo come analogo strutturalmente o formalmente, ma ciò che ci appare
tale all’interno della nostra esperienza. È nell’ambito complesso e multiforme della nostra esperienza che si costruiscono ponti, passaggi, conversioni sulla base della percezione diretta e in “prima persona” di isomorfismi. L’esperienza dell’espressività musicale è identificabile in questa attività percettiva; attività che, pur coinvolgendo
l’immaginazione, non ha nulla a che fare con l’inferenza razionale, ma si dà immediatamente e spesso, sebbene non necessariamente, è accompagnata da una reazione emotiva significativa.
Quella che abbiamo appena proposto è una sintesi personale dei risultati fin qui
raggiunti dagli autori analitici che hanno dibattuto sul tema in questione. Volendo, potremmo anche noi estrapolare dalla sintesi appena compiuta alcuni requisiti, o desiderata, che brevemente potremmo chiamare: a) requisito dell’isomorfismo; b) requisito
del movimento musicale; c) requisito del feeling component of emotion; d) requisito
dell’immaginazione; e) requisito della risposta affettiva. A nostro avviso, essi possono
essere un’utile guida per valutare le concezioni dell’espressività musicale che si fronteggiano in ambito analitico, e, crediamo, da essi difficilmente potrà prescindere chiunque voglia proporre nuove concezioni relativamente al problema dell’espressività musicale.
232
BIBLIOGRAFIA
ADDIS, L.
1999
Of Mind and Music, Cornell University Press, New York.
ALLEN, R. T.
1990
“The Arousal and Expression of Emotion by Music”, British Journal of Aesthetics, 30.
BEARDSLEY, M. C.
1981
“On Understanding Music”, in Price, ed.
BEEVER, A.
1998
“Arousal Theory Again”, British Journal of Aesthetics, 38.
BERLIOZ, H.
1932
Memoirs, tr. da Ernest Newman, Tudor, New York.
BERTINETTO, A.
2006
“Bach e il San Bernardo. La filosofia della musica di Peter Kivy”, in Estetica,
1.
BLACK, M.
1954
“Metaphor”, Proceedings of the Aristotelian Society, 55; rist. in Black (1962);
trad. it. Modelli Archetipi Metafore, Pratiche Editrice, Parma, 1983.
1962
Models and Metaphor, Cornell University Press, Ithaca, NY; trad. it. Modelli
Archetipi Metafore, Pratiche Editrice, Parma, 1983.
1977
“More about Metaphor”, Dialectica, 31; rist. in A. Ortony (a cura di), Metaphor and Thought, Cambridge University Press, Cambridge, 1979, trad. it.
Modelli Archetipi Metafore, Pratiche Editrice, Parma, 1983.
233
BOLLINO, F. (a cura di)
2007
Estetica analitica/1, in «Studi di Estetica», 27, CLUEB, Bologna.
2007
Estetica analitica/2, in «Studi di Estetica», 27, CLUEB, Bologna.
BOUWSMA, O. K.
1969
“The Expression Theory of Art”, in Id., Philosophical Essays, University of
Nebraska Press, Lincoln.
BUDD, M.
1983
“Motion and Emotion in Music: How Music Sounds”, British Journal of Aesthetics, 23.
1985a
Music and the Emotions. The Philosophical Theories, Routledge and Kegan
Paul, London.
1985b
“Understanding Music”, Proceedings of the Aristotelian Society, Supp. Vol. 59.
1989a
“Music and Communication of Emotions”, Journal of Aesthetics and Art Criticism, 53.
1989b
“Music and the Expression of Emotions”, Journal of Aesthetic Education, 23,
no. 3.
1992
“Review if Walton’s Mimesis as Make-Believe”, in Mind, 101.
1995
Values of Art, The Penguin Press, London.
2003
“Musical movement and aesthetic metaphors”, British Journal of Aesthetics,
43 (3).
2005
“Aesthetic Realism and Emotional Qualities of Music”, British Journal of
Aesthetics, 45.
CARR, D.
2004
“Music, Meaning, Emotion”, Journal of Aesthetics and Art Criticism», 63.
CAVELL, S.
1977
“Music Discomposed”, Must We Mean What We Say?, Cambridge University
Press, Cambridge.
CHIODO, S.
2006
Visione o costruzione. Nelson Goodman e la filosofia analitica contemporanea, Led, Milano.
2007
Che cosa è arte. La filosofia analitica e l’estetica, Utet Libreria, Torino.
234
COHEN, T.
2002
“Metaphor”, in The Oxford Handbook of Aesthetics, (a cura di) Jerrold Levinson, Oxford University Press, Oxford.
COOKE, D.
1990
The Language of Music, Oxford University Press, London.
COOPER G., MEYER L. B.
1960
The Rhythmic Structure of Music, University of Chicago Press, Chicago.
D’AGOSTINI F. E VASSALLO N. (a cura di)
2002
Storia della filosofia analitica, Einaudi, Torino.
D’ANGELO, P.
2008
Introduzione all’estetica analitica, Laterza, Roma.
2008
Le arti nell’estetica analitica (a cura di), Quodlibet, Macerata.
DANTO, A.
1981
The Transfiguration of the Coomonplace: A Philosophy of Art, Harvard University Press, Cambridge Mass.
DAVIDSON, D.
1978
Che cosa significano le metafore, in Id., Verità e interpretazione, trad. it. di R.
Brigati, a cura di E. Picardi, Il Mulino, Bologna, 1994 (traduce What Metaphors Mean, «Critical inquiry», n. 5, 1978, anche in Id., Inquiries into Truth
and Interpretation, Clarendon Press, Oxford, 2001.
DAVIES, S.
1980
“The Expression of Emotion in Music”, in Mind, 89.
1983
“Is Music a Language of Emotion?”, British Journal of Aesthetics, 23.
1983b
“Attributing Significance to Unobvious Musical Relationship”, Journal of
Music Theory, 27.
1984
“Truth-Values and Metaphors”, Journal of Aesthetics and Art Criticism, 42.
1986
“The Expression Theory Again”, Theoria, 52.
1987
“Review of Kivy’s Music Alone”, Canadian Philosophical Review, 10.
235
1991
“The Ontology of Musical Works and the Authenticity of Their Performances”, in Noûs, 25.
1991b
Definitions of Art, Ithaca, Cornell University Press.
1991c
“Review of Kivy’s Sound Sentiment”, Journal of Aesthetics and Art Criticism, 49.
1993
“Representation in Music”, Journal of Aesthetics Education, 27, n. I.
1994
Musical Meaning and Expression, Cornell University Press, Ithaca.
1994
“Musical Understanding and Musical Kinds”, Journal of Aesthetics and Art
Criticism, 52.
2003
Themes in Philosophy of Music, Oxford University Press, Oxford.
2006
The Philosophy of Art, Blackwell, Malden.
DEMARTIS, L.
2004
L’estetica simbolica di Susanne Katherina Langer, Aesthetica Preprint, Palermo.
ELLIOTT, F.
1967
Aesthetic Theory and the Experience of Art, repr. in H. Osborne, ed., Aesthetics, 1972, Oxford University Press, Oxford.
EVANS, M.
1990
Listening to Music, London, Macmillan.
FERGUSON, D.
1960
Music as Metaphor: The Elements of Expression, University of Minnesota
Press, Minneapolis.
GOLDMAN, A.
1995
“Emotion in Music (A Postscript)”, Journal of Aesthetics and Art Criticism,
53.
GOODMAN, N.
1968
Languages of Art, Bobbs-Merrill, Indianapolis; trad. it. I linguaggi dell’arte, Il
Saggiatore, Milano, 1976.
1979
Metaphor as Moonlighting, «Critical inquiry», n. 6; poi in Elgin C. Z. (a cura
di), The Philosophy of Nelson Goodman, vol. IV: Nelson Goodman’s Theory
of Symbols and Its Applications, Garland, New York.
236
GUANTI, G.
1999
Estetica musicale, La Nuova Italia, Firenze.
GUASTINI, D.
2004
Aristotele e la metafora: un elogio dell’approssimazione. Relazione del 7 Dicembre 2004 in occasione del seminario: Vedere il simile nel dissimile, la metafora in Aristotele e il simbolismo in Kant, tenutosi presso l’istituto di filosofia Arturo Massolo dell’Università di Urbino.
GURNEY, E.
1880
The Power of Sound, Smith Elder, London.
HAGBERG, G.
1984
“Art and Unsayable: Langer’s Tractarian Aesthetics”, British Journal of Aesthetics, 24.
HANSLICK, E.
2001
Il bello musicale (1854), a cura di L. Distaso, Aesthetica Edizioni, Palermo.
HARTSHORNE, C.
1934
The Philosophy and Psychology of Sensation, The University of Chicago
Press, Chicago.
HUSSERL, E.
1993
Lezioni sulla sintesi passiva (1966), trad. it. di V. Costa, a cura di P. Spinicci,
Guerini e Associati, Milano.
ISENBERG, A.
1973
“Critical Communication,” Aesthetic and Theory of Criticism, Selected Essay
of Arnold Isenberg. University of Chicago Press, Chicago and London.
JAMES, W.
1901
The Principles of Psychology, Macmillan & Co, London; 1a ed. H. Holt, 1980;
v. I.
237
KERMAN, J.
1967
The Beethoven Quartets, Alfred Knopf, New York.
KINGSBURY, J.
2002
“Matravers on Musical Expressiveness”, British Journal of Aesthetics, 42.
KIVY, P.
1980
The Corded Shell: Reflections on Musical Expression, Princeton University
Press, Princeton.
1987
“How Music Moves”, in Philip Alperson (ed.), What is music? An Introduction to the Philosophy of Music, Haven, New York.
1989
Sound Sentiment: An Essay on the Musical Emotions, Temple University
Press, Philadelphia.
1990
Music Alone: Philosophical Reflections on the Purely Musical Experience,
Cornell University Press, Ithaca.
1997
Philosophies of Arts: A Study in Differences, Cambridge University Press,
Cambridge.
1999
“Feeling the musical emotions”, British Journal of Aesthetics, 39, 1.
2001
New Essays on Musical Understanding, Clarendon Press, Oxford.
2002
Introduction to a Philosophy of Music, Clarendon Press, Oxford (trad. it., a cura di A. Bertinetto, Filosofia della musica. Un’introduzione, Einaudi, Torino
2007).
2004
The Blackwell Guide to Aesthetics, Blackwell, New York – Oxford.
KOBAU, P.
2005
Ontologie analitiche dell’arte, AlboVersorio, Milano.
KOBAU, P., MATTEUCCI G., VELOTTI. S. (a cura di)
2007
Estetica e filosofia analitica, Il Mulino, Bologna.
KÖHLER, W.
1920
Die Physischen Gestalten in Ruhe und in statiönarem Zustand, by Friedr.
Vieweg & Sohn, Braunschweig, Germany.
1961
La psicologia della Gestalt (1929), Feltrinelli, Milano.
238
KRANTZ, S. C.
1987
“Metaphor in Music”, Journal of Aesthetics and Art Criticism, 45.
LANGER, S. K.
1962
Problemi dell’arte (1957), Il Saggiatore, Milano.
1965
Sentimento e forma (1953), Feltrinelli, Milano.
1972
Filosofia in una nuova chiave (1942), Armando, Roma.
LEVINSON, J.
1980
“What a Musical Work Is”, Journal of Philosophy, 77.
1981
“Truth in Music”, Journal of Aesthetics and Art Criticism, 40.
1982
“Music and Negative Emotion”, Pacific Philosophical Quarterly, 63.
1985
“Review of Kivy’s Sound and Semblance”, Canadian Philosophical Reviews,
5.
1987
“Review of Hanslick’s On the Musically Beautiful, Trans. Geoffrey Payzant”,
Canadian Philosophical Reviews, 7.
1996
“Musical Expressiveness,” in The Pleasures of Aesthetics, Cornell University
Press, Ithaca and London.
1990a
Music, Art, and Metaphysics: Essays in Philosophical Aesthetics, Ithaca, Cornell University Press.
1990b
“Musical Literacy”, Journal of Aesthetic Education, 24.
1992a
“Musical Profundity Misplaced”, Journal of Aesthetics and Art Criticism, 50.
1992b
“Pleasure and the Value of Art and Music”, British Journal of Aesthetics, 32.
2006
“Musical expressiveness as Hearability-as-Expression”, in Contemplating Art,
Clarendon Press, Oxford (N. Y.).
LONGUET-HIGGINS, H. C.
1987
Mental Processes: Studies on Cognitive Science, MIT Press, Cambridge.
MACKINNON, J. E.
1996
Artistic Expression and the Claims of Arousal Theory, British Journal of Aesthetics, 36.
MARGOLIS, J.
1981
“What is When? When is What? Two Questions for Nelson Goodman”, Journal of Aesthetics and Art Criticism, 39.
239
MATRAVERS, D.
1991
“Art and the Feeling Emotions”, British Journal of Aesthetics, 31.
1993
“Unsound Sentiment: A Critique of Kivy’s “Emotive Formalism”, Philosophical Papers, 22.
1994
“Once More with Feeling: A Reply to Ridley”, British Journal of Aesthetics,
34.
1998
Art and Emotion, Clarendon Press, Oxford.
2003
“The Experience of Emotions in Music”, Journal of Aesthetics and Art Criticism, 61, 4.
MATTEUCCI, G. (a cura di )
2005
Elementi di estetica analitica, numero monografico di «Discipline filosofiche», XV, 2.
MCCLARY, S.
1991
Feminine Endings: Music, Gender and Sexuality, University of Minnesota
Press, Minneapolis.
MAUS, E.
1997
Music as Drama, in J. Robinson (a cura di), Musical Meaning, Cornell University Press, Ithaca and London.
MENDELSSOHN, F.
1842
Lettera a Marc André Souchay, Berlin, 5 October.
MEYER, L.
1992
Emozione e significato nella musica, il Mulino, Bologna.
MILA, M.
1965
L’esperienza musicale e l’estetica, Einaudi, Torino.
NOWOTTNY, W.
1962
The Language Poets Use, The Athlone Press, London.
240
NUSSBAUM, M.
2004
L’intelligenza delle emozioni, Il Mulino, Bologna.
OTTOBRE, A.
2003
Sulle proprietà estetiche, in «Rivista di Estetica», XLIII, 23.
2007
L’abuso delle proprietà estetiche, in «Rivista di Estetica», XLVII, 35.
OTTOBRE, A., VELOTTI, S.
2007
Le proprietà estetiche, in Coliva (a cura di, 2007).
PIANA, G.
1986
Intorno alla filosofia della musica di Susanne Langer, materiali di lavoro per
un corso sul tema “Fenomenologia dell’espressione e filosofia della musica”,
tenutosi presso l’Università di Milano.
1991
Filosofia della musica, Guerini e Associati, Milano.
PRATT, C. C.
1931
The Meaning of Music, McGraw-Hill Book Co, New York and London.
1952
Music as the Language of Emotion, D. C.: Library of Congress, Washington.
1954
“The Design of Music”, Journal of Aesthetics and Art Criticism, 12.
PUTMAN, D. A.
1985
“Music and the Metaphor of Touch”, Journal of Aesthetics and Art Criticism,
44.
1989
“Some Distinctions on the Role of Metaphor in Music”, Journal of Aesthetic
Education, 23, n. 2.
RADFORD, C.
1989
“Emotions and Music: A reply to the Cognitivists”, Journal of Aesthetics and
Art Criticism, 47.
1991
“Muddy Waters”, Journal of Aesthetics and Art Criticism, 49.
RICHARDS, I. A.
1936
The Philosophy of Rhetoric, Oxford University Press, New York; trad. it. La
Filosofia della retorica, Milano, 1967.
241
RIDLEY, A.
1995
“Musical Sympathies: The Experience of Expressive Music”, Journal of Aesthetics and Art Criticism, 53.
1995
Music, Value and the Passion, Cornell University Press, Ithaca and London.
2004
The Philosophy of Music: Theme and Variations, Edinburgh University Press,
Edinburgh.
RIEMANN, H.
1888
Wie Hören wir Music? (Come ascoltiamo la musica?), Leipzig.
ROBINSON, J.
1993
“The Expression and Arousal of Emotion in Music”, Journal of Aesthetics and
Art Criticism, 51.
2005
Deeper than Reason: Emotion and its Role in Music, Literature, and Art, Oxford University Press.
RUSKIN, J.
1856
Modern Painters, Volume III, London.
SCHOPENHAUER, A.
2006
Il mondo come volontà e rappresentazione (1819), Bompiani, Milano.
SCHROEDER, D. P.
1990
Haydn and the Enlightenment: The Late Symphonies and their Audience, Clarendon Press, Oxford, 1990.
SCHUMANN, R.
1982
Music and Musicians: First Series, tradotto da Fanny Raymond Ritter. 8th ed.,
William Reeves, London.
SCRUTON, R.
1976
“Representation in Music”, Philosophy, 51.
1980a
“Absolute Music”, in Sadie, ed., Vol. I.
1980b
“The Nature of Musical Expression”, in Sadie, ed., Vol. 6.
1980c
“Programme Music”, in Sadie, ed., Vol. 15.
242
1981
“The Semiology of Music”, in The Politics of Culture and Other Essays,
Manchester, Carcanet Press.
1983
“Understanding Music”, The Aesthetic Understanding, Manchester, Carcanet.
1987
“Analytical Philosophy and the Meaning of Music”, Journal of Aesthetics and
Art Criticism, 46.
1997
The Aesthetics of Music, Oxford University Press, New York.
1998
Art and Imagination. A study in the Philosophy of Mind, St. Augustine’s Press,
South Bend.
SEMI, M. (a cura di)
2008
Il suono eloquente. Musica tra imitazione, espressione e simpatia, Aesthetica
Preprint, Palermo.
SPECK, S.
1991
“Arousal Theory” reconsidered”, British Journal of Aesthetics, 28.
SULLIVAN, J. W. N.
1960
Beethoven, His Spiritual Development, Vintage Books, New York.
TORMEY, A.
1971
The Concept of Expression: A study in Philosophical Psychology and Aesthetics, Princeton University Press, Princeton.
TOVEY, D. F.
1935
Essays in Musical Analysis: Volume I, Symphonies, Oxford University Press,
London.
TREITLER, L.
1993
“Language and the Interpretation of Music”, in Music and Meaning, ed. Jenefer Robinson, Cornell University Press.
VELOTTI, S.
2003
L’opera d’arte: una nozione classificatoria o normativa? Note su Goodman,
Danto e Dickie, in «Studi di Estetica», III serie, 31, 1.
2007
La scelta di Danto, in «Rivista di Estetica», III serie, 35, 2.
2008
Estetica analitica: un breviario critico, Aesthetica Preprint, Palermo.
243
VICO, G.
1974
De nostri temporis studiorum ratione, Armando, Roma.
VIZZARDELLI, S.
2007
Filosofia della musica, Laterza, Roma.
2008
Musica, in Le arti nell’estetica analitica (a cura di P. D’Angelo), Quodlibet, Macerata.
WALTON, K.
1973
“Pictures and Make-Believe”, in Philosophical Review LXXXII (July 1973).
1988
“What Is Abstract about the Art of Music?”, Journal of Aesthetics and Art
Criticism, 46.
WITTGENSTEIN, L.
1999
Ricerche filosofiche, Einaudi, Torino.
ZANGWILL, N.
1995
“The Beautiful, the Dainty and the Dumpy”, British Journal of Aesthetics, 35.
1998
“Aesthetic/Sensory Dependence”, British Journal of Aesthetics, 38.
2001
Metaphysics of Beauty, Cornell University Press, Ithaca.
2004
“Against Emotion: Hanslick was Right about Music”, British Journal of Aesthetics, 44.
2007
“Music, Metaphor, and Emotion”, Journal of Aesthetics and Art Criticism, 65.
ZUCKERKANDL, V.
1956
Sound and Symbol, New York, Prometheus.
244