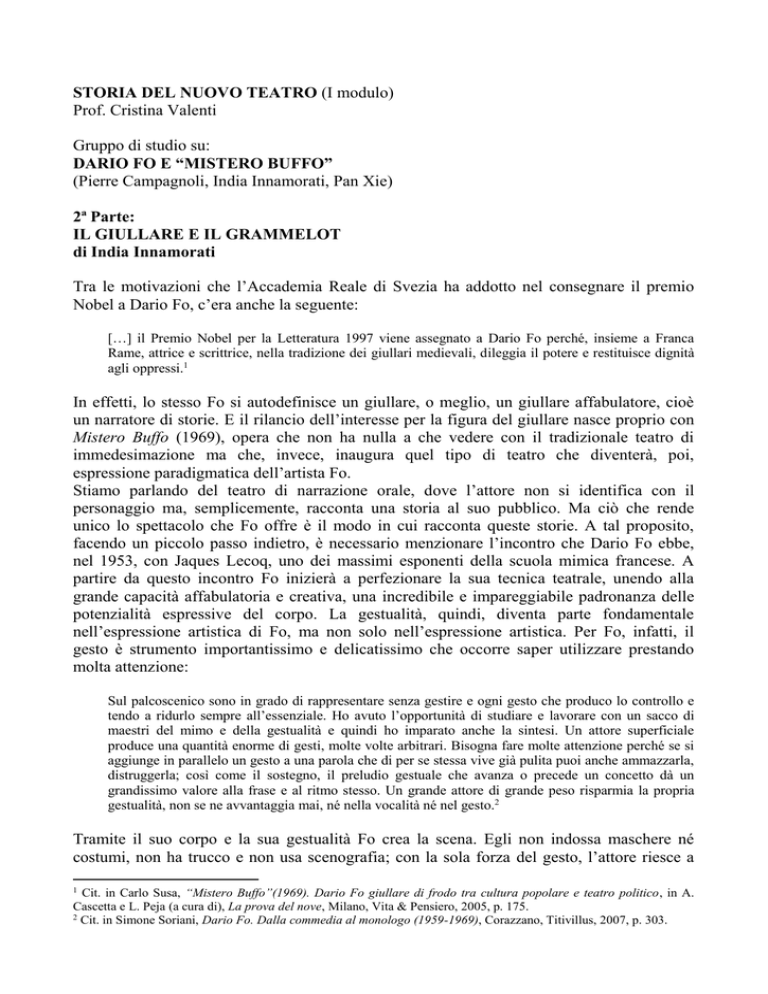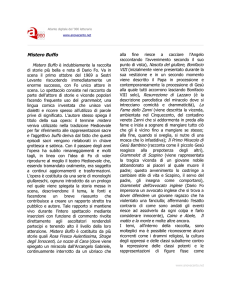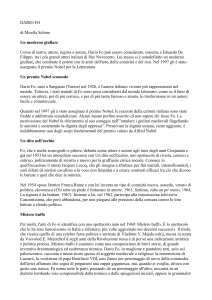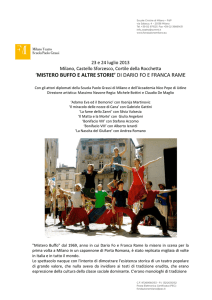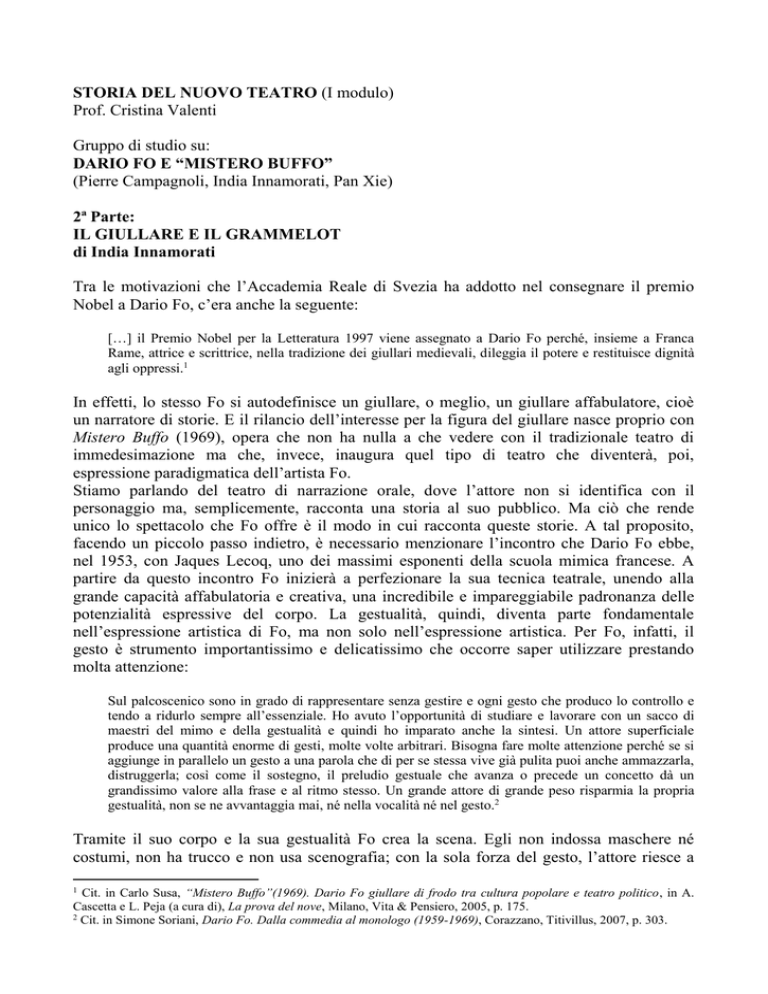
STORIA DEL NUOVO TEATRO (I modulo)
Prof. Cristina Valenti
Gruppo di studio su:
DARIO FO E “MISTERO BUFFO”
(Pierre Campagnoli, India Innamorati, Pan Xie)
2ª Parte:
IL GIULLARE E IL GRAMMELOT
di India Innamorati
Tra le motivazioni che l’Accademia Reale di Svezia ha addotto nel consegnare il premio
Nobel a Dario Fo, c’era anche la seguente:
[…] il Premio Nobel per la Letteratura 1997 viene assegnato a Dario Fo perché, insieme a Franca
Rame, attrice e scrittrice, nella tradizione dei giullari medievali, dileggia il potere e restituisce dignità
agli oppressi.1
In effetti, lo stesso Fo si autodefinisce un giullare, o meglio, un giullare affabulatore, cioè
un narratore di storie. E il rilancio dell’interesse per la figura del giullare nasce proprio con
Mistero Buffo (1969), opera che non ha nulla a che vedere con il tradizionale teatro di
immedesimazione ma che, invece, inaugura quel tipo di teatro che diventerà, poi,
espressione paradigmatica dell’artista Fo.
Stiamo parlando del teatro di narrazione orale, dove l’attore non si identifica con il
personaggio ma, semplicemente, racconta una storia al suo pubblico. Ma ciò che rende
unico lo spettacolo che Fo offre è il modo in cui racconta queste storie. A tal proposito,
facendo un piccolo passo indietro, è necessario menzionare l’incontro che Dario Fo ebbe,
nel 1953, con Jaques Lecoq, uno dei massimi esponenti della scuola mimica francese. A
partire da questo incontro Fo inizierà a perfezionare la sua tecnica teatrale, unendo alla
grande capacità affabulatoria e creativa, una incredibile e impareggiabile padronanza delle
potenzialità espressive del corpo. La gestualità, quindi, diventa parte fondamentale
nell’espressione artistica di Fo, ma non solo nell’espressione artistica. Per Fo, infatti, il
gesto è strumento importantissimo e delicatissimo che occorre saper utilizzare prestando
molta attenzione:
Sul palcoscenico sono in grado di rappresentare senza gestire e ogni gesto che produco lo controllo e
tendo a ridurlo sempre all’essenziale. Ho avuto l’opportunità di studiare e lavorare con un sacco di
maestri del mimo e della gestualità e quindi ho imparato anche la sintesi. Un attore superficiale
produce una quantità enorme di gesti, molte volte arbitrari. Bisogna fare molte attenzione perché se si
aggiunge in parallelo un gesto a una parola che di per se stessa vive già pulita puoi anche ammazzarla,
distruggerla; così come il sostegno, il preludio gestuale che avanza o precede un concetto dà un
grandissimo valore alla frase e al ritmo stesso. Un grande attore di grande peso risparmia la propria
gestualità, non se ne avvantaggia mai, né nella vocalità né nel gesto.2
Tramite il suo corpo e la sua gestualità Fo crea la scena. Egli non indossa maschere né
costumi, non ha trucco e non usa scenografia; con la sola forza del gesto, l’attore riesce a
Cit. in Carlo Susa, “Mistero Buffo”(1969). Dario Fo giullare di frodo tra cultura popolare e teatro politico, in A.
Cascetta e L. Peja (a cura di), La prova del nove, Milano, Vita & Pensiero, 2005, p. 175.
2
Cit. in Simone Soriani, Dario Fo. Dalla commedia al monologo (1959-1969), Corazzano, Titivillus, 2007, p. 303.
1
rievocare oggetti, ambienti, situazioni. Ma non solo. La parola, unita al gesto, permette a Fo
di interpretare più di un personaggio alla volta e in diversi contesti. Proprio perché manca
l’identificazione completa dell’attore con il personaggio, Fo riesce non solo a raccontare
qualcosa, ma anche a fornire agli spettatori i dati necessari all’interpretazione del brano. La
sua recitazione è, quindi, straniata e partecipata allo stesso tempo: il giullare-Fo mette in
scena dei personaggi rimanendo costantemente fuori dalla finzione, e questo distacco gli
permette di entrare e uscire costantemente dalla narrazione. Per questo motivo il teatro di Fo
è racconto ma anche rappresentazione e commento. Scrive l’attore
“Epico”significa che l’attore non deve vestirsi interamente nelle pelle del personaggio che sta
interpretando. Piuttosto, deve presentare il personaggio. È sempre fuori dal personaggio. Per esempio,
quando io recito la parte di Bonifacio VIII io lo proietto verso il pubblico. È ovvio che sono in terza
persona. Sono lo specchio che riflette il personaggio. Ogni volta che si ha l’identificazione dell’attore,
allora si ha orribile teatro.3
Fo, dunque, non è personaggio ma semplice giullare. Ma che cosa intende l’attore quando
parla di giullare? Chi è, o chi era, questa figura? E cosa rappresentava e rappresenta?
Nel Manuale Minimo dell’attore Fo lo definisce così:
Giullare: attore, saltimbanco e giocoliere del Medioevo, di chiara matrice popolare. I giullari si
esibivano in taverne, piazze, cortili e venivano spesso invitati alla corte di signori e principi. In alcune
occasioni, molto particolari, recitavano anche in chiesa.4
E, citando il Muratori, aggiunge che “il giullare nasceva dal popolo e dal popolo prendeva la
sua rabbia per ridarla ancora al popolo, mediata dal grottesco e dalla ragione, affinché il
popolo prenda coscienza della propria condizione”5.
A questo proposito vale la pena di citare brevemente una delle più celebri giullarate di Dario
Fo che narra proprio della nascita del Giullare. È un pezzo emblematico e funzionale al
discorso intrapreso.
La storia da cui Fo trae spunto è antichissima, proviene dalla tradizione orientale; ma egli
ritrova, come spesso accade, una versione molto simile nella Biblioteca di Ragusa, risalente
al 1200. La traduce dal siciliano medievale nella sua lingua-koinè particolare e racconta
pressappoco questo:
Un contadino, stanco e frustrato dalla sua condizione misera, torna a casa ogni sera con
sempre meno voglia di vivere. Lavora tutto il giorno una terra che non è la sua, e dalla quale
non ricaverà mai alcun frutto né soddisfazione. Un giorno, passando davanti a quella grande
collina abbandonata vicino alla sua dimora, si chiede se sia effettivamente di qualcuno e,
soprattutto, se sia coltivabile. La collina in questione è rocciosa (o lavica) e a nessuno mai
era venuto in mente di spenderci fatica e denaro. In paese chiunque gli giura che quella terra
non appartiene ad alcuno quindi il contadino, salito in cima alla collina, inizia a scavare con
le proprie unghie la roccia finché, come per miracolo, non vi trova della terra. E dell’acqua.
Senza pensarci due volte, prende la moglie e i figli e si trasferisce sul quel terreno. Inizia a
coltivarlo da zero e, nel giro di poco tempo, già si vedono i primi frutti; diventerà una sorta
di Eden meraviglioso.
3
Ibidem.
Dario Fo, Manuale minimo dell’attore, Torino, Einaudi, 1997, p. 337.
5
Dario Fo, Mistero Buffo, Torino, Einaudi, 1977, p. 12.
4
Ma il signore del luogo, visti i risultati ottenuti dal contadino, non tarda a rivendicare il
possesso della collina (e dei suoi frutti). Il villano, nonostante gli avvertimenti dei popolani,
non ha alcuna intenzione di cedere. Purtroppo un signore è un signore e, dopo aver
minacciato e incendiato e distrutto tutto ciò che il contadino aveva, arriva a violentargli la
moglie, davanti al villano stesso e ai suoi figli. Non potendo opporsi né vendicarsi, poiché
gravissime sarebbero state le rappresaglie, il contadino lascia fare, assicurandosi, in questo
modo, una vita di vergogna e umiliazioni.
La donna, dopo l’accaduto, scappa lontano coperta dall’onta di essere considerata alla
stregua di una prostituta; dopo poco, i figli del villano muoiono di malattia. E il povero
cristo si ritrova solo, umiliato, in una condizione di miseria assoluta. Medita il suicidio e,
mentre sta quasi per compiere il gesto, qualcuno bussa alla porta. È un giovane barbuto, un
viandante sembrerebbe, il quale chiede al contadino dell’ospitalità e un po’ di cibo. Pur non
avendo quasi nulla, il villano accetta volentieri e approfitta della compagnia per sfogarsi
riguardo le sue sfortune. Lo sconosciuto ascolta attentamente e, alla fine, cerca di
convincere l’altro a denunciare l’accaduto, i soprusi, a scendere in piazza e raccontare alla
gente quello che ha subito. Il contadino si schermisce, dicendogli che non avrebbe neppure
le giuste parole per narrare l’accaduto, visto che a malapena sa farsi capire da lui. E a questo
punto si svela la vera identità del vagabondo, è addirittura Gesù Cristo. Tranquillizza il suo
interlocutore dicendogli:
Gesù Cristo sono io, che vengo a te a darti la parola. E questa lingua bucherà e andrà a schiacciare
come una lama vesciche dappertutto e a dar contro ai padroni, e schiacciarli, perché gli altri capiscano,
perché gli altri apprendano, perché gli altri possano ridere (riderci sopra, sfotterli). Che non è col ridere
che il padrone si fa sbracare, che si ride contro i padroni, il padrone da montagna che è diventa collina,
e poi più niente. Tieni, ti do un bacio che ti farà parlare.6
La “lingua” (sia in senso di favella, sia in senso figurato di “lingua tagliente”) del giullare
viene, quindi, direttamente da Cristo, il quale non solo si fa protettore del popolo oppresso,
ma addirittura ne è il sobillatore. Il giullare era un sovversivo, un canzonatore, una figura
che metteva in crisi la distinzione tra sacro e profano tanto cara all’uomo del Medioevo. Fo
opera un’astrazione mitizzante di questa figura presentandola come simbolo atemporale
della lotta del popolo contro il potere.
Non dimentichiamo, infatti, che Mistero Buffo segna il passaggio di Fo al teatro più
propriamente “politico” e che, negli stessi anni, egli si interessò profondamente della
differenza tra cultura egemone e cultura popolare, sulla scia degli studi gramsciani.
La “giullarata” è espressione propria del giullare: monologica, fondata sull’affabulazione
narrativa, in cui un solo attore recita tutte le parti previste dal copione (emblematica, in
questo, è La resurrezione di Lazzaro); nel Mistero Fo rielabora testi che non vengono, però,
direttamente dalla tradizione giullaresca, bensì appartengono alla tradizione religiosa
popolare e ad alcuni passi dei Vangeli apocrifi. In realtà si tratta di storie atemporali e
universali, incentrate sulla lotta del popolo contro il potere e facilmente riferibili alla
situazione che l’Italia stava vivendo negli anni Sessanta del Novecento.
Proprio per ricollegarsi al presente e riferirsi ad esso in maniera critica e satirica, Fo utilizza
i prologhi (o introduzioni). Questi permettono all’attore lunghe digressioni in cui, partendo
dall’argomento proprio della giullarata, egli arriva, magistralmente, a renderlo attuale,
6
Dario Fo, Mistero Buffo, cit., p. 80.
come, per esempio, accade durante il prologo di Rosa fresca aulentissima. In questo caso Fo
parte con l’intenzione di spiegare al pubblico la poesia di Ciullo d’Alcamo; nel farlo, non
mancano frecciatine all’istituzione scolastica italiana e neppure un’aspra denuncia (seppur
velata) alle leggi contro lo stupro7.
Le introduzioni, però, servono all’attore anche per instaurare un rapporto dialettico col
pubblico. La fruizione del Mistero Buffo è una fruizione tutt’altro che passiva; lo spettatore
è invitato all’attenzione, alla partecipazione, viene interpellato. In questo modo lo spettacolo
diventa un dialogo diretto tra palco e platea, smettendo le vesti di “teatro leggero” al quale
gli spettatori erano abituati.
Infine, i prologhi hanno una funzione esegetica, cioè spiegano ciò che sta per accadere,
poiché, vista la particolare lingua usata da Fo, i monologhi non sono di immediata
comprensione per tutti.
Proprio per quanto riguarda la lingua si deve sottolineare come questa sia una delle più
grandi invenzioni di Fo. La koinè di dialetti padano-veneti che egli utilizza nasce sulla
falsariga della lingua dei giullari, i quali avevano necessità di farsi capire da tutti, in assenza
di una lingua nazionale. Adottando questa sorta di iperdialetto Fo, espressamente, si
immette nella secolare “Questione della lingua” che assilla l’Italia da cinquecento anni; e
proprio nel periodo sessantottino, con la prima grande diffusione dei massmedia, si aveva
l’idea di poter creare e diffondere alle masse il cosiddetto italiano-standard. Fo, andando
contro questa omologazione culturale perseguita dal potere, decide, quindi, di parlare in una
lingua praticamente incomprensibile a chi vive al di sotto della linea Rimini-La Spezia.
Ma è solo con la comparsa del grammelot, nella stagione di Mistero Buffo 1973-74, che Fo
porta alle estreme conseguenze questa critica. Nel già citato Manuale minimo dell’attore, Fo
definisce il grammelot come uno “sproloquio onomatopeico volto a imitare lingue straniere
e dialetti esotici”8.
Il grammelot è una lingua completamente inventata ma che è in grado, tuttavia, di
trasmettere con l’apporto di gesti, ritmi e sonorità, un intero discorso compiuto; è un vero e
proprio codice semiotico, il quale rimanda a una situazione onirica e infantile. Infatti, scrive
Fo:
La prima forma di Grammelot la eseguono senz’altro i bambini con la loro incredibile fantasia quando
fingono di fare discorsi chiarissimi con farfugliamenti straordinari (che fra di loro intendono
perfettamente). Ho assistito al dialogo tra un bambino napoletano e un bambino inglese e ho notato che
entrambi non esitavano un attimo. Per comunicare non usavano la propria lingua, ma un’altra
inventata, appunto il grammelot. Il napoletano fingeva di parlare in inglese e l’altro fingeva di parlare
in italiano meridionalizzato. Si intendevano perfettamente. Attraverso gesti, cadenze e farfugliamenti
variati, avevano costruito un proprio codice.9
E, non dimentico della lezione dei mimi, continua:
Quanto più c’è semplicità e chiarezza nei gesti che accompagnano il grammelot, tanto più è possibile
la comprensione del discorso. Ricapitolando: suoni onomatopeici, gestualità pulita ed evidente, timbri
ritmi coordinazione e, soprattutto, una grande sintesi.10
Per questo stesso argomento si rinvia anche al Grammelot dell’Avvocato inglese.
Dario Fo, Manuale minimo dell’attore, cit., p. 338.
9
Ivi, p. 81.
10
Ivi, p. 83.
7
8
Secondo Fo, il grammelot nacque durante la diaspora dei giullari, dall’Italia postControriformistica verso il resto dell’Europa. Essi si trovarono a dover recitare davanti a un
pubblico straniero e quindi a dover elaborare una lingua universale e accessibile a tutti.
Inoltre era un ottimo escamotage per sfuggire alla censura.
In conclusione, bisogna dire che, anche grazie all’uso di questo particolare codice, assieme
all’assenza di copioni fissi, all’uso di canovacci e improvvisazioni, il Mistero Buffo diventa
un’enorme contenitore che si arricchisce di anno in anno e, sempre, si sottrae alla dittatura
del testo e quindi alla possibilità di leggerlo come opera “letteraria”; è giusto ricordare che,
paradossalmente, per un premio Nobel della letteratura come Fo
il testo non c’entra nulla con la letteratura, anche quando si vuole incastrarcelo. Brecht diceva
giustamente di Shakespeare “Peccato che sia bello anche alla lettura. Questo è il suo unico grande
difetto”. E aveva ragione. Un’opera teatrale valida, per paradosso, non dovrebbe assolutamente
apparire piacevole alla lettura: dovrebbe scoprire i suoi valori solo nel momento della realizzazione
scenica.11
BIBLIOGRAFIA
11
-
Dario Fo, Mistero Buffo, Torino, Einaudi, Torino, 1977.
-
Dario Fo, Manuale minimo dell’attore, Torino, Einaudi, 1997.
-
Carlo Susa, “Mistero Buffo” (1969). Dario Fo giullare di frodo tra cultura popolare
e teatro politico, in A. Cascetta e L. Peja (a cura di), La prova del nove. Scritture per
la scena e temi epocali nel secondo Novecento, Milano, Vita&Pensiero, 2005, pp.
175-216.
-
Simone Soriani, Dario Fo. Dalla commedia al monologo (1959-1969), Corazzano,
Titivillus, 2007.
Ivi, p. 285.