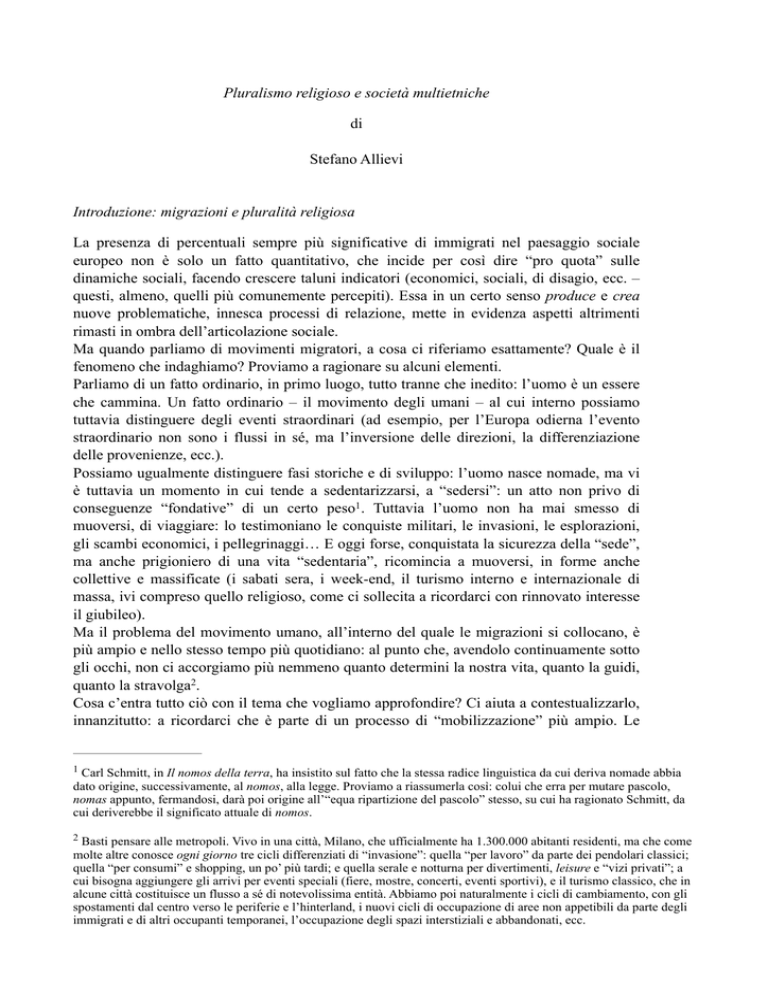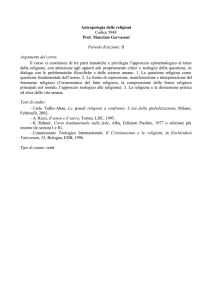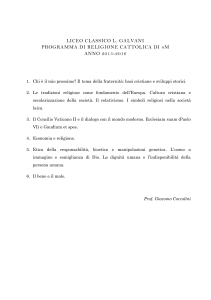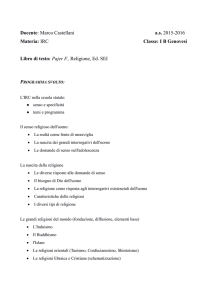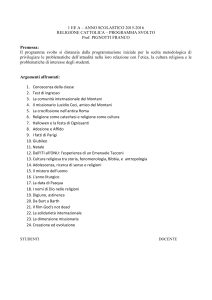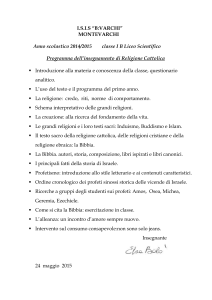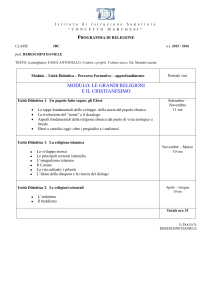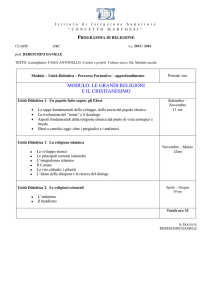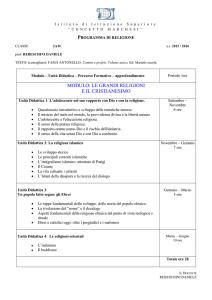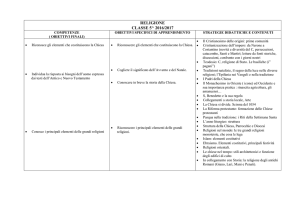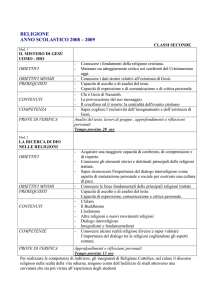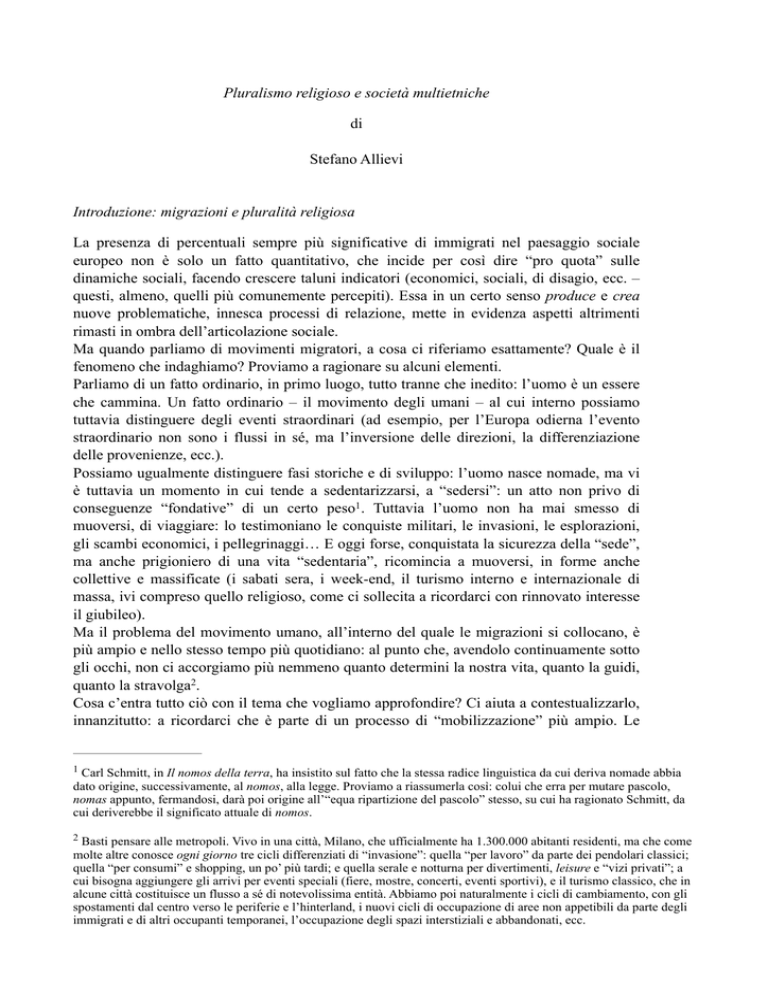
Pluralismo religioso e società multietniche
di
Stefano Allievi
Introduzione: migrazioni e pluralità religiosa
La presenza di percentuali sempre più significative di immigrati nel paesaggio sociale
europeo non è solo un fatto quantitativo, che incide per così dire “pro quota” sulle
dinamiche sociali, facendo crescere taluni indicatori (economici, sociali, di disagio, ecc. –
questi, almeno, quelli più comunemente percepiti). Essa in un certo senso produce e crea
nuove problematiche, innesca processi di relazione, mette in evidenza aspetti altrimenti
rimasti in ombra dell’articolazione sociale.
Ma quando parliamo di movimenti migratori, a cosa ci riferiamo esattamente? Quale è il
fenomeno che indaghiamo? Proviamo a ragionare su alcuni elementi.
Parliamo di un fatto ordinario, in primo luogo, tutto tranne che inedito: l’uomo è un essere
che cammina. Un fatto ordinario – il movimento degli umani – al cui interno possiamo
tuttavia distinguere degli eventi straordinari (ad esempio, per l’Europa odierna l’evento
straordinario non sono i flussi in sé, ma l’inversione delle direzioni, la differenziazione
delle provenienze, ecc.). Possiamo ugualmente distinguere fasi storiche e di sviluppo: l’uomo nasce nomade, ma vi
è tuttavia un momento in cui tende a sedentarizzarsi, a “sedersi”: un atto non privo di
conseguenze “fondative” di un certo peso1. Tuttavia l’uomo non ha mai smesso di
muoversi, di viaggiare: lo testimoniano le conquiste militari, le invasioni, le esplorazioni,
gli scambi economici, i pellegrinaggi… E oggi forse, conquistata la sicurezza della “sede”,
ma anche prigioniero di una vita “sedentaria”, ricomincia a muoversi, in forme anche
collettive e massificate (i sabati sera, i week-end, il turismo interno e internazionale di
massa, ivi compreso quello religioso, come ci sollecita a ricordarci con rinnovato interesse
il giubileo).
Ma il problema del movimento umano, all’interno del quale le migrazioni si collocano, è
più ampio e nello stesso tempo più quotidiano: al punto che, avendolo continuamente sotto
gli occhi, non ci accorgiamo più nemmeno quanto determini la nostra vita, quanto la guidi,
quanto la stravolga2.
Cosa c’entra tutto ciò con il tema che vogliamo approfondire? Ci aiuta a contestualizzarlo,
innanzitutto: a ricordarci che è parte di un processo di “mobilizzazione” più ampio. Le
1!
Carl Schmitt, in Il nomos della terra, ha insistito sul fatto che la stessa radice linguistica da cui deriva nomade abbia
dato origine, successivamente, al nomos, alla legge. Proviamo a riassumerla così: colui che erra per mutare pascolo,
nomas appunto, fermandosi, darà poi origine all’“equa ripartizione del pascolo” stesso, su cui ha ragionato Schmitt, da
cui deriverebbe il significato attuale di nomos.
2!
Basti pensare alle metropoli. Vivo in una città, Milano, che ufficialmente ha 1.300.000 abitanti residenti, ma che come
molte altre conosce ogni giorno tre cicli differenziati di “invasione”: quella “per lavoro” da parte dei pendolari classici;
quella “per consumi” e shopping, un po’ più tardi; e quella serale e notturna per divertimenti, leisure e “vizi privati”; a
cui bisogna aggiungere gli arrivi per eventi speciali (fiere, mostre, concerti, eventi sportivi), e il turismo classico, che in
alcune città costituisce un flusso a sé di notevolissima entità. Abbiamo poi naturalmente i cicli di cambiamento, con gli
spostamenti dal centro verso le periferie e l’hinterland, i nuovi cicli di occupazione di aree non appetibili da parte degli
immigrati e di altri occupanti temporanei, l’occupazione degli spazi interstiziali e abbandonati, ecc.
migrazioni costituiscono infatti solo l’elemento più visibile (non a caso se ne parla come di
un “sesto continente”) di un processo più ampio, che qualcuno ha definito come
“rivoluzione mobiletica”, che coinvolge il movimento di informazioni, merci, denaro, idee,
oltre che uomini e donne3. Un processo, sempre più veloce, che è parte a sua volta del più
noto e concettualizzato processo di globalizzazione.
Fine della premessa. Vediamo ora le conseguenze di questo fenomeno di mobilizzazione:
tra cui quello che qui ci interessa, la com-presenza su un medesimo territorio di una
pluralità culturale e religiosa sempre più ampia4.
Il paesaggio religioso che abitiamo e a cui siamo abituati sta cambiando in gran fretta.
Insieme alle religioni tradizionali della vecchia Europa (le varie famiglie cristiane, la
presenza ebraica, qualche sopravvivenza che una volta si sarebbe definita pagana),
troviamo infatti: i nuovi movimenti religiosi che in Europa nascono o che vengono
importati da altri fiorenti produttori (gli Stati Uniti, ma anche non pochi paesi asiatici:
dall’India al Giappone alla Corea, e altri); un’ampia produzione di spiritualità new age;
sette religiose più o meno legate, magari anche solo per opposizione, al vecchio ceppo
cristiano; nobili tradizioni altrui da noi importate per iniziativa soprattutto di occidentali e
a modo loro (è il caso del buddhismo). In più, con l’arrivo di nuove popolazioni immigrate quello che in sociologia è invalso
chiamare (da Poulat e poi Bourdieu in avanti), con una metafora di derivazione economica
forse discutibile ma efficacemente descrittiva, il mercato dei beni religiosi, si è
“complessificato”. L’offerta di beni religiosi, già ampia, ha trovato un’ulteriore, feconda
nicchia di mercato in cui espandersi, ma anche nuovi imprenditori sociali del sacro, diverse
modalità di consumo, e si sono aperti nuovi canali di import-export religioso. Nel concreto,
significa che vi è una sempre più marcata presenza di tradizioni religiose vecchie e nuove
che sono arrivate insieme agli immigrati: dall’induismo all’islam, passando per le religioni
“etniche” (lo shinto, i sikh, ecc.), l’animismo, forme sincretiche come le cosiddette “nuove
chiese” africane, ecc., oltre che a nuovi membri, allogeni, di tradizioni religiose già
presenti, percepite come indigene (cattolici, denominazioni protestanti, ortodossi, ebrei, ma
anche membri stranieri di comunità religiose recenti, come i testimoni di Geova, ecc.).
Si tratta di un mondo variegato e complesso, che non ha solo degli aspetti sociali: richiama
anche ad alcune rimeditazioni in chiave spirituale, apre degli interrogativi teologici, e pone
dei seri problemi ecclesiali – in tutte le chiese. E più in generale richiama a una profonda e
articolata riflessione sui “fondamentali”. Ne citiamo solo alcuni, senza poterli
approfondire: i presupposti etici del patto sociale, e la sua stessa necessaria ridefinizione in
una situazione di mobilità e dunque di mutamento che diventa caratteristica fisiologica e
3!
Un movimento che, peraltro, non riguarda solo fasce marginali e sostanzialmente sottoprivilegiate di popolazione,
come si tende normalmente a pensare (è questa l’immagine “media” di immigrato che abbiamo in testa). Al contrario,
anche se ci si riflette pochissimo, sono sempre più importanti e probabilmente, in percentuale, anche più incisive, quelle
che potremmo chiamare migrazioni di élite. Gli appartenenti a quelle che sono state chiamate le “classi parlanti”, per
esempio, e in generale i ceti di riferimento dello sviluppo economico e culturale: lo testimoniano, tra l’altro, il mondo
dell’economia – e tanto più quanto più è alto il livello e di conseguenza maggiore il grado di internazionalizzazione –,
della finanza, il mondo scientifico, quello accademico, i settori trainanti della moda, dello sport, dello spettacolo, ecc.
Un fenomeno che starebbe inducendo, in quelle che una volta si chiamavano classi dirigenti (ma, oggi, di che?), a
seguito del sempre minore livello di radicamento, il diffondersi di quella che Lasch (1995) ha chiamato una visione
“turistica” anche delle norme morali.
4!
Potremmo riferirci solo alla prima, con l’aiuto dell’etimologia, se non avessimo dimenticato che cultura e culto
derivano dopo tutto dalla medesima radice.
non più patologica delle comunità umane; il discorso sul rapporto tra individuo e comunità,
e tra queste e territorio (discorso che è già parte integrante della riflessione su
comunitarismo e neo-comunitarismo, ma che andrebbe in qualche modo radicalizzato se
prendessimo ancora più sul serio il fenomeno di …sradicamento cui sempre più
assistiamo); problemi politici non da poco: quale, per esempio, il nesso tra il concetto di
democrazia cui ci riferiamo e il territorio? e come cambia, dunque, la prima, in situazione
di parziale progressiva de-territorializzazione di parti significative della popolazione?;
problemi giuridici conseguenti altrettanto significativi: quale il senso, in questa situazione,
dei riferimenti tradizionali allo jus soli o allo jus sanguinis (e qualcuno comincia a parlare
già oggi di jus religionis, in un sorprendente ritorno di categorie interpretative del passato:
cuius regio…)?; e ancora: quali “paletti” mettere all’applicazione dei diritti (quali diritti
per chi, insomma), quale rapporto tra universalizzazione dei diritti e particolarizzazione (e,
in parte, comunitarizzazione) degli stessi; problemi filosofici di fondo, che poi sono
immediatamente culturali e relazionali, non da poco: quale il rapporto tra ego e alter in una
situazione di condivisione di alcuni ambiti (per esempio il territorio, problematicamente
anche il sistema giuridico, la produzione di reddito e il welfare system), ma non di altri (la
razza, la religione, la cittadinanza)? e dove sono o dove si ricollocano i confini identitari?
Sono, letteralmente, cum-finis, ciò che dopo tutto ho in comune con l’altro, oppure ciò che
separa? e dove la linea di separazione quando si moltiplicano le situazioni di mixité
(matrimoniale, ma non solo) e di meticciato, nel senso più lato possibile del termine? E si
potrebbe continuare a lungo, a porre domande: tutte, ancora, senza risposta.
Questa presenza non è, insomma, neutra. E non ha conseguenze solo per se stessa: la
presenza di questi nuovi ‘inquilini’ è suscettibile di influenzare, e di fatto sta già
influenzando (e per certi aspetti sarebbe auspicabile che molto di più influenzasse), anche i
vecchi “padroni di casa”: le istituzioni, i sistemi sociali, e appunto, cosa su cui si riflette
molto meno, le religioni.
Un passo indietro: l’attuale momento religioso d’occidente
Per comprendere meglio questi fenomeni ci sembra tuttavia utile fare, per il momento, un
passo indietro, che ci consenta, prendendola alla lontana, uno sguardo più ampio e,
letteralmente, comprensivo.
Dagli anni Sessanta in avanti una pubblicistica diffusa, con un insieme di diagnosi che si
sarebbero rivelate il men che si possa dire premature, annunciava le varie modalità della
“morte sociale di Dio” nelle società dette avanzate (la sua morte personale, reale o
presunta che sia, pur essendo attività praticata anche da qualche sociologo, non rientra tra
le competenze disciplinari della sociologia). Più recentemente una vasta letteratura,
quantitativamente forse anche più impressionante, sembra testimoniarne una rigogliosa
rinascita, seppure sovente sotto forme a torto o a ragione considerate inedite.
A posteriori ci pare possibile riassumere che non c’è stata in passato una “eclissi del sacro”
come non c’è ora una “rivincita di Dio”, per riprendere due titoli tra loro molto diversi ma
ugualmente fortunati, pubblicati a trent’anni giusti di distanza l’uno dall’altro, in epoche
che sembrano tra loro più lontane di quanto non siano in realtà (ormai i decenni da questo
punto di vista sembrano diventati decenni-luce)5. 5
!
Il riferimento è ovviamente ai ‘testi sacri’ di Acquaviva (1961) e Kepel (1991).
Tuttavia è indubbio che assistiamo oggi non solo a significative modificazioni nelle forme
del sacro, ma anche a diverse forme di appropriazione del medesimo, a diverse modalità
soggettive di viverlo: - dal punto di vista della domanda, cambia il suo peso specifico nella vita individuale dei
soggetti, cambia il suo ruolo nel determinarne l’identità personale, si modificano le
modalità di appartenenza religiosa;
- dal punto di vista dell’offerta, che qui maggiormente ci interessa, queste stesse modalità
di appartenenza religiosa si ampliano, mediante l’ingresso sul mercato dei beni religiosi di
nuovi attori sociali, di nuovi imprenditori sociali del sacro.
Ci pare dunque particolarmente rilevante sottolineare come caratteristico dell’attuale
“momento religioso”6 vissuto dall’occidente la significatività del processo di
pluralizzazione religiosa, e gli effetti che questo comporta anche nelle possibilità di
fruizione del religioso7.
Il posto della religione nella società e nella teoria sociologica: una premessa teorica
In generale le definizioni e le analisi della religione che ci vengono dai classici della
sociologia (ma anche da altre discipline, e in particolare, per un evidente interesse “di
parte”, dalle stesse teologie) sembrano accentuare le dimensioni della stabilità, della
continuità, della sua funzione integratrice della società, in un’assunzione implicita di un
postulato di unicità e di globalità sostanziale (salvo da parte delle teorie riduzioniste che
negavano semplicemente il ruolo della religione, riducendola al rango di mero residuo).
Nota per esempio Berger (1967, 60 in nota) che «uno dei punti principali della teoria
sociologica della religione proposta da Durkheim sta nella difficoltà di interpretare entro il
suo schema i fenomeni religiosi che non raggiungono l’ampiezza della società, cioè, nei
termini qui usati, nella difficoltà di affrontare in termini durkheimiani le strutture di
plausibilità subsociali». E questo anche perché il problema centrale di Durkheim è proprio
«il problema del rapporto fra solidarietà interindividuale, ordine morale e struttura sociale»
(Ferrarotti 1985, 19); un problema “macro” per definizione.
Solo in tempi più recenti (e in questo è stato decisivo il contributo dello stesso Berger) la
teoria ha cominciato ad assumere la pluralità religiosa come un tema caratterizzante in sé,
anche se non sempre ne ha dedotte tutte le possibile conseguenze. In particolare, la
pluralità stessa viene spesso assunta, un po’ paradossalmente, come “rigida”. Ora, la
caratteristica principale che essa implica è proprio la flessibilità; non solo e non tanto in
termini organizzativi, ciò che appare dubbio e in ogni caso meno interessante e
significativo, quanto in termini di flessibilità soggettiva possibile: ovvero, la pluralità la si
vive, ci si entra e ci esce per così dire, o meglio, all’interno di essa, si cambia. Ora, poche
teorie della religione sembrano in grado di spiegare davvero il cambiamento religioso,
anche se alcune descrivono almeno le condizioni che lo consentono. Come ha osservato
sinteticamente Beckford (1989, 64): «malgrado tutta la loro enfasi sul cambiamento e
l’adattamento, i sociologi classici e i loro successori immediati preferivano operare con
concezioni statiche della religione». Sfuggono quindi, in buona parte, le modalità soggettive, sempre più diffuse, di vivere nella
(o di partecipare alla) sfera religiosa. Oltre alla modalità di appartenenza classica, quella
6
!
L’espressione è di Simmel (1989, 181).
7
!
Per un approfondimento di queste argomentazioni rinviamo a Allievi (1998c, 1999a e 1999b).
tradizionale (sono di una certa religione, sostanzialmente, perché ci sono nato, perché lo
erano i miei genitori), sono infatti sempre più diffusi comportamenti che riassumiamo in
altre tre modalità principali. La prima: non essendoci disponibile, anche se l’affermazione va in parte stemperata,
«nessun modello obbligatorio di religione» (Luckmann 1963, 146), il “supermercato” dei
beni religiosi può permettersi di offrire quello che Luckmann definisce come un sempre
più vasto «assortimento di significati ‘ultimi’», gestito sul lato dell’offerta, sostengono
altrove Berger e Luckmann (1964, 190), da una molteplicità di «agenzie di marketing
dell’identità». E’ uno dei modi di accesso al mercato in questione (quello che Roof e
McKinney, nel loro American Mainline Religion, hanno definito pick and choose),
particolarmente visibile ad esempio nel mondo new age – ma non è il solo.
Una seconda e diversa modalità di presenza è quella definibile attraverso i concetti di
“inclusione” e di “contaminazioni cognitive” (tra gli altri Campiche 1993): il processo di
inclusione (distinto rispetto al concetto di sincretismo), avviene a partire dalle credenze
tradizionali, integrandole con nuove “sensibilità” o con altre credenze, anche
contraddittorie con il sistema di appartenenza e/o di riferimento (esempio particolarmente
significativo: la sempre più frequente credenza nella reincarnazione misurata da diverse
ricerche tra praticanti cristiani). Contrariamente alle apparenze, questa tendenza può farci
parlare appunto di contaminazioni cognitive, ma non necessariamente di dissonanze
cognitive. Esse infatti, che pure risaltano all’osservazione razionale, diciamo oggettiva (per
esempio quella della teologia, che in questo senso ha un’attitudine “sistematica”), non sono
percepite come tali nella sfera soggettiva, che è in grado di sfidare con successo e senza
ripercussioni apparenti il principio di non contraddizione (del resto sfidato spesso anche
dalla stessa teologia…).
L’esperienza dei convertiti mostra una terza e ulteriore modalità di presenza sul mercato:
attraverso la scelta non solo di singoli temi tra loro incoerenti, ma di interi sistemi di
significato, al loro interno più o meno coerenti (in ogni caso percepiti come tali), che
vengono assunti con tutte (o con parte del-) le loro conseguenze pratiche, quotidiane.
Anche se vi sono pure conversioni temporanee, intermittenti, part-time, e pluriconversioni,
al punto che qualche autore ha potuto parlare di conversion careers, riprendendo senza
tematizzarlo il concetto di “carriere morali” elaborato da Goffman. E altri hanno parlato di
religious hopping, qualcuno addirittura definendo quella attuale una age of conversion:
tema peraltro ripreso anche da Marcel Gauchet, che sottolinea (1985, 300) come «ci sono
eccellenti ragioni perché gli uomini del dopo-religione abbiano la tentazione di convertirsi
in tutte le direzioni (tous azimuts). E ce ne sono di ancora migliori perché le loro
conversioni non siano né molto solide né molto durevoli, poiché essi non sono capaci di
rinunciare alle ragioni che li spingono a convertirsi...».
Pluralità di offerta, dunque, pluralità di modalità di accesso, ma anche pluralità e
reversibilità dei percorsi soggettivi.
L’importante è comunque tenere presente che ci troviamo in una fase storica di progressiva
soggettivizzazione del rapporto con la religione, in conseguenza dei processi di
secolarizzazione, privatizzazione e dunque pluralizzazione: processi tra loro collegati, che
fanno sentire le loro conseguenze anche sul fenomeno oggetto del nostro studio.
Come ci siamo arrivati? Secolarizzazione, privatizzazione, pluralizzazione
Non potendo approfondire i concetti (l’abbiamo fatto altrove, Allievi 1998c), ci limitiamo
qui a enunciarli rapidamente.
Il primo, la secolarizzazione. Uno degli esponenti più radicali della teoria della
secolarizzazione la definisce come «il processo per mezzo del quale il pensiero, la pratica e
le istituzioni religiose perdono significanza sociale» (Wilson 1966, xiv), e lo considera
anche un fenomeno, oltre che irreversibile, onnipervasivo, che informa tutta la società e
non solo i suoi aspetti religiosi: «la secolarizzazione non indica solo un cambiamento che
avviene nella società, ma anche un cambiamento della società» (Wilson 1982, 177).
Stark e Bainbridge hanno tuttavia sottolineato l’aspetto auto-limitante del processo di
secolarizzazione. Brown ha sottolineato l’ambiguità delle tendenze in corso, che mostrano
sia un declino del significato sociale della religione (secularization) che una crescita delle
religioni (religionization) (per queste ed altre posizioni critiche, Bruce 1992). Beckford
(1989, 136) sostiene che sia nella natura stessa della società secolare di generare quella che
chiama «la rinascita paradossale della religione». Bell, in polemica diretta con Wilson a cui
contesta una lettura riduzionista e portata a troppo estreme conseguenze della teoria
weberiana della ‘gabbia d’acciaio’, fa notare che «il termine secolarizzazione è un tale
imbroglio perché mischia due tipi molto differenti di fenomeni, il sociale e il culturale, e
due processi molto differenti che non sono congruenti l’uno con l’altro» (1977, 426). Ai nostri fini è meno importante sottolineare che «la secolarizzazione si presenta come
conseguenza dell’alto grado di differenziazione raggiunto dalla società
moderna» (Luhmann 1982, 219) -cioè la secolarizzazione come conseguenza di un
processo- quanto il fatto che essa produce a sua volta differenziazione -la secolarizzazione
come causa-: in particolare il fatto che, a causa del processo di differenziazione, nella
società industriale non c’è più bisogno di un’istituzione particolare, a carattere religioso,
che rappresenti l’unità e la legittimità dell’intero sistema. Come aveva già notato Fenn, cui
del resto Luhmann fa esplicito riferimento, «la secolarizzazione non spinge via la religione
dalla società moderna, ma piuttosto incoraggia un tipo di religione che non possiede alcuna
funzione importante per l’intera società» (Fenn 1972, 31).
L’altra pre-condizione cruciale ai nostri fini è il processo di privatizzazione che
accompagna e allo stesso tempo è potenziato dalla secolarizzazione. Non si tratta in un
certo senso di una novità storica. Già Durkheim sottolineava che, almeno nei paesi a
dominante cristiana, il processo è in corso da tempo perché si troverebbe all’origine stessa
del cristianesimo8. E Berger più compiutamente di altri ne ha tirato le conseguenze: la
secolarizzazione stessa nascerebbe con e grazie al cristianesimo e alla sua scelta di
separare la sfera di Cesare da quella di Dio. Tuttavia è indubitabile che il processo si è
notevolmente ampliato e ha trovato nuova forza nel processo stesso di secolarizzazione,
che renderebbe oggi possibile un believing without belonging (Davie 1990), ripiegato su se
stesso e sul proprio guicciardiniano particulare, privato, insomma. E questo a dispetto di
una pur persistente presenza religiosa, che sia essa “diffusa”, “implicita” o definitivamente
“invisibile”.
8
!
Nel saggio su L’individualisme et les intellectuels, del 1898 (cit. in Bellah 1970a, 260), scrive: «è un errore singolare
presentare la moralità individualista come antagonista della morale cristiana; al contrario essa è derivata da quella». Il
cristianesimo, a differenza delle città stato, avrebbe spostato il centro della vita morale dall’esterno all’interno
dell’individuo. Solo che poi la moralità individuale si sarebbe sviluppata autonomamente e, non sentendo più il bisogno
del rivestimento simbolico del cristianesimo, si sarebbe liberata della sua tutela.
E’ ancora Luhmann (1982, 227) a notare che «mentre prima l’incredulità era un affare
privato, adesso lo diventa la fede», ormai relegata nell’ambito del tempo libero, da esso
limitata e in esso soffocata da altre priorità. Tale processo di privatizzazione, che l’autore
non considera tuttavia individuale («la privatizzazione non è un affare privato») ma al
contrario esso stesso una struttura sociale (e non un fenomeno che concerne la religione,
ma un fenomeno che concerne la struttura del sistema sociale, che a sua volta influisce
sulla religione), consente di sottrarsi a molte forme di controllo sociale di tipo religioso, e
ad aprirsi a possibilità di scelta differenziate.
Terza importante pre-condizione è quella del pluralismo, potremmo dire del politeismo
potenziale che secolarizzazione e privatizzazione offrono all’individuo (Maffesoli 1988
parla di “policulturalismo” e di “politeismo popolare”). La pluralizzazione delle offerte,
dei gruppi, dei “mondi vitali” almeno potenzialmente a disposizione (qualcuno -Possenti
1996- ha parlato di “pluri-verso etico”) costituisce la declinazione concreta di una
secolarizzazione che, altrimenti, potrebbe consentire solo la scelta tra fede e appartenenza
ascritta e suo rifiuto.
Tale situazione implicitamente antimonopolistica è ben descritta, nella sua dimensione
caotica, da un frammento di dialogo di uno scrittore contemporaneo, che sembra mettere
ironicamente in scena la dubbiosa possibilità di scelta dell’uomo contemporaneo:
«- Se la tirano tanto in lungo, quei franchi muratori finiranno per metter su una mahomeria.
- Perché non un buddistero? o un batti-lao-tsero? o un confucionale?»9. In forma diversa il pensiero filosofico ha sintetizzato questo situazione nella celebre
formula di Lyotard sulla fine delle «grandi narrazioni della modernità» che sarebbe
caratteristica della postmodernità.
La teoria sociologica ha trovato in Berger il suo più insistito sostenitore, che ha sempre
considerato la pluralizzazione una sorta di fenomeno gemello della secolarizzazione
(Berger e Luckmann 1966b), ma anche più di quest’ultima una caratteristica peculiare
della modernità (Berger, Berger e Kellner 1973), che incide in entrambe le sfere, la
pubblica e la privata, entrambe pluralizzatesi, ed è entrata a far parte in quanto tale del
processo stesso di socializzazione primaria e dunque della formazione del sé. La
pluralizzazione (questo il nome che dà al fenomeno più generale, di cui il pluralismo
religioso non è che una delle molte varianti; Berger 1992, 41) ha come effetto quello di
moltiplicare ma nello stesso tempo di rendere più precarie le “strutture di plausibilità”, ivi
comprese quelle religiose, che diventano un prodotto dell’attività umana. Una delle
conseguenze di questo processo è la possibilità di “migrazione” tra i diversi mondi religiosi
e le loro relative strutture di plausibilità.
Questo è quello che potremmo definire l’aspetto soggettivo della pluralizzazione, che
sembra far sì che anche a livello sociale, “di massa” per così dire, sia data sempre più per
acquisita una accettazione di fatto della situazione di pluralità (ciò che probabilmente non
sarebbe stato vissuto allo stesso modo, con la stessa “naturalezza”, anche solo una o due
generazioni fa). L’aspetto oggettivo della medesima questione è misurabile nel fatto, e ci
limitiamo a citare il caso più macroscopico, che oggi in Europa occidentale, Italia inclusa
(Allievi e Dassetto 1993), l’islam sia divenuto la seconda religione per numero di
praticanti (Dassetto 1996), e dunque l’Europa una ‘nuova frontiera’ dell’islam (Dassetto e
Bastenier 1991). Una svolta anch’essa non prevedibile anche solo una generazione fa: che,
9
!
R.Queneau, I fiori blu, Torino, Einaudi, 1967, p.5, trad. di Italo Calvino.
dato il vissuto storico di confronto-scontro tra le due rive, anche religiose, del
Mediterraneo, non è eccessivo qualificare come storica (Allievi 1996a), e assai ricca di
implicazioni (anche, incidentalmente, per la ricerca sociale; cf. Allievi 1999c).
Taluni insistono sul fatto che una delle conseguenze del processo di pluralizzazione
sarebbe una sorta di relativismo. Tale concetto (per come viene riempito di contenuto) ci
pare tuttavia più morale che sociologico, più giudicante che euristico. La visione
bergeriana ci sembra in questo senso più sobria. Per parte nostra ci è sufficiente notare che
questa stessa situazione, e quella che più globalmente potremmo chiamare la società
plurale, permette non solo una maggiore facilità e frequenza delle scelte “diverse”, ma
anche una loro de-drammatizzazione: non c’è più un’inquisizione che può consentire o
impedire non solo una “partenza”, ma anche un “ritorno”, come accadeva invece, per
esempio, ai “cristiani di Allah” del passato (Bennassar 1989).
Le trasformazioni dell’identità
Le trasformazioni oggettive, nella e della realtà sociale, inducono o comunque sono
accompagnate da quelle soggettive, nella e della identità personale.
Ci limitiamo qui a constatare che sempre più essa va considerata, e può essere letta e
interpretata, «non già come una “cosa”, come l’unità monolitica di un soggetto, ma come
un sistema di relazioni e di rappresentazioni» (Melucci 1982, 68). E, aggiungiamo, di
autopercezioni, e di percezioni di quella che W.I.Thomas ha chiamato “definizione della
situazione”, ma anche di sé nella situazione. «La definizione dell’identità -ha notato
altrove Melucci (1993)- si sposta dal contenuto al processo, dal dato al potenziale e
coincide sempre più con la capacità degli individui di identificarsi e di differenziarsi dagli
altri: è dunque un processo continuo di identizzazione». Un cammino progressivo, il cui
dato di partenza, come ha notato ancora Berger nel suo saggio su Musil (1984, 26), è «un
“sé” plurale», che non può se non cercare di inventarsi quella “semplicità dell’ordine
narrativo”, in quanto ordinata successione di eventi, che non esiste nella realtà ma che
ognuno cerca di reinventare nella propria biografia, come ha notato lo stesso Musil. Il
mondo, come gli stili di cui parla Schutz, che Berger cita, è vero “fino a nuovo ordine”. Si
assiste a una crescente de-istituzionalizzazione dei corsi di vita, a una progressiva
maggiore “leggerezza” dell’attore sociale nel varcare le frontiere, e dunque a continui
processi di socializzazione e risocializzazione, e quindi di rinegoziazione dei rapporti
(Crespi 1983). Tuttavia non è lecito lasciarsi andare a troppo facili e troppo
intellettualistiche generalizzazioni su un’identità concepita come una sorta di puzzle
insensato infinitamente modificantesi: molto letterarie - già Shakesperare diceva che la
vita non è che «una favola raccontata da un idiota, piena di rumore e di furore, che non
significa nulla» (Macbeth, atto V, scena V) - e molto colte (dunque anche molto
accademiche), ma non sempre rispondenti alla realtà e ai desiderata degli uomini e delle
donne che abitano la realtà sociale. L’uomo, in ogni caso, cerca la continuità, il senso, il
‘filo del racconto’ di cui parlava Musil. Anche nelle rotture, e nelle spiegazioni che si da’
delle stesse: non c’è come ascoltare i racconti di conversione per rendersene conto. Non è
quindi un caso se Simmel, nel suo Excursus sulla fedeltà e sulla gratitudine, sottolineando
il carattere integrativo che la fedeltà ha per l’autoconservazione dell’ordine sociale, porta
come esempio apparentemente paradossale di fedeltà proprio i rinnegati, e specificamente i
giannizzeri nella Turchia dei secoli XVI e XVII.
Immigrati e religioni
Perché abbiamo insistito su quest’analisi di sfondo, che riguarda l’occidente a prescindere
dagli immigrati? Per una ragione molto semplice: perché essa è proprio ciò che consente e
financo favorisce la presenza di nuove religioni, che non viene più percepita né come
scandalosa né come traumatica, e al limite può ammantarsi di una patina di esotismo
perfino attraente, alla moda. E’ questa situazione che fa sì che oggi, in occidente, sia
possibile e largamente facilitato un processo di ingresso e radicamento di nuove religioni
che in altre epoche, più religiosamente monolitiche (o forse sarebbe più esatto dire
monopolistiche), sarebbe stato semplicemente impensabile.
La sua conseguenza immediata è che l’Europa è diventata una sorta di patchwork religioso
alquanto complesso e in continua evoluzione. Forse l’immagine migliore per definirlo non
è quella, spesso usata ma troppo rigida, del mosaico, ma quella dinamica del caleidoscopio
in continuo movimento: certo, con qualche “pezzo” più grosso degli altri.
La presenza di immigrati non è infatti culturalmente né religiosamente neutra. Gli
immigrati non arrivano “nudi”: portano con sé, nel loro bagaglio, anche visioni del mondo,
tradizioni, credenze, pratiche, tavole di valori, sistemi morali, immagini e simboli. E prima
o poi sentono il bisogno, se mai l’hanno perduto, di richiamarsi ad esse come ad
indispensabili nuclei di identità; se non per identificazione, almeno per opposizione. Essi
spesso giustificano e confermano una specificità e anche una sensibilità religiosa, che una
modernità superficiale nelle apparenze e nello stesso tempo profonda e radicale nella sua
capacità di scalfire gli stili di vita tradizionali e i convincimenti su cui si basano,
apparentemente fa di tutto per cancellare. In una parola, la religione, e ancora di più la
religione vissuta collettivamente e comunitariamente, ha un suo spazio e un suo ruolo nella
costruzione dell’identità individuale e collettiva di nuclei significativi di immigrati.
Questo processo provoca un cambiamento radicale – di paradigma, a mio parere, e proprio
nel senso forte che ad esso ha dato Kuhn – nel nostro criterio interpretativo e, ancora
prima, nella nostra percezione, nel nostro vissuto relativo al rapporto tra religione-popoloterritorio. Per dirla nel modo più semplice possibile, noi siamo abituati a immaginare, del
tutto intuitivamente, che, grosso modo, ad un territorio corrisponda un popolo con una
religione dominante, e con l’eventuale corollario di qualche presenza minoritaria (tale era
anche la percezione implicita dei classici della sociologia, a cominciare da Durkheim –
pure, dopo tutto, figlio di un rabbino). Oggi la com-presenza di svariate entità religiose,
resa ancora più visibile e in un certo senso drammatizzata dalla presenza di cospicue
comunità di immigrati che si richiamano a religioni più o meno estranee alla storia
europea, o almeno percepite come tali, ci costringe a fare i conti con quella che mi sembra
pertinente chiamare, mutuando l’espressione dal dibattito filosofico recente, una diversa
“geo-religione”. Non c’è più, insomma (semmai c’è stata in maniera così totale: in realtà anche questa
unitarietà è un mito di origine romantica), un popolo con una propria fede che abita un
determinato territorio; ma assistiamo al progressivo prodursi di una realtà molto più
articolata, in cui su un medesimo territorio si mischiano (o non si mischiano, ma comunque
co-abitano) popoli, religioni ed altro ancora. La pluralità, insomma, da patologia che era si
è fatta fisiologia: è diventata, o sta diventando, “normale”. Un effetto anche questo, e tra i
meno percepiti, della globalizzazione. Per inciso, è proprio questo processo che rende
inconsistenti e improponibili tesi come quella del clash of civilizations, popolarizzata da
Huntington (1996). Tale tesi presuppone che le civiltà, spesso da Huntington identificate
con il nome delle rispettive religioni dominanti in una determinata area, siano una “qui” e
una “là”, separate, impermeabili, radicate con precisione in territori delimitabili. Proprio
ciò che non è o non è più, e non solo in Europa, ma in vaste parti del mondo. Ciò che,
naturalmente, non esclude affatto gli scontri, ma li reinterpreta in chiave diversa: al limite,
azzarderei (pur senza entrare nel campo – alla lettera, minato – delle teorie politologiche e
polemologiche), proprio come effetto del contatto e dell’interconnessione.
Qualche esempio potrà aiutarci a chiarire la situazione, almeno per quel che concerne casa
nostra.
Qualche esempio
Ci pare utile a questo punto proporre qualche esempio di questo processo di ridefinizione
di quella che abbiamo chiamato la nuova configurazione geo-religiosa dell’Europa.
Con la presenza delle nuove immigrazioni, infatti, la pluralizzazione religiosa dell’Europa
si è fatta ancora più articolata, e il processo non accenna a diminuire: al contrario, queste
stesse religioni, inizialmente presenti in forma più o meno “clandestina” e comunque
individuale o al massimo familiare, man mano che si fa più ampia la “soglia etnica” (in
questo caso più correttamente definibile “soglia religiosa”) di riferimento, si
“comunitarizzano”, tendono a diventare fatto sociale duro, incontrovertibile, e a rendersi
visibili anche nello spazio pubblico, e dunque ad essere percepite come tali dalla
popolazione autoctona.
Tale presenza produce l’effetto di metterci in contatto con altre realtà, non solo
sincronicamente, ma anche diacronicamente. In un certo senso è il nostro passato che
ritorna: un fatto particolarmente visibile nelle presenze immigrate cristiane, ma per certi
versi, in una accezione più “teologica”, nei musulmani, che del resto Massignon aveva una
volta definito «i nostri antenati contemporanei».
Qualche esempio, cominciando proprio dalle presenze cristiane. Con gli immigrati sono
arrivati per esempio i cattolici filippini, ed altre presenze asiatiche, africane e centro e sudamericane: un cattolicesimo spesso più simile al cattolicesimo popolare italiano degli anni
‘50, soprattutto meridionale, non avaro di venature superstiziose e molto attaccato al culto
dei santi, per esempio, che al volto pubblico, ufficiale, attuale del cattolicesimo italiano.
Un cattolicesimo, oltre tutto, spesso più conservatore e paternalistico di quello nostrano
(non sono quasi mai le teologie della liberazione ad arrivare da noi, se non attraverso la
presenza di rari testimoni privilegiati): che, in maniera forse troppo generica, possiamo
globalmente qualificare di tradizionale, e in qualche caso di tradizionalista. Nello stesso
tempo un cattolicesimo che si esprime con linguaggi (liturgici, ad esempio) e che manifesta
esigenze (per esempio comunitarie) che possono costituire un interessante elemento di
novità e di rottura. Se nel caso cattolico non possiamo parlare di diversità o di alterità
religiosa rispetto a quella che normalmente si definisce la maggioranza, e che io chiamerei
piuttosto, facendo i conti anche con la secolarizzazione, “minoranza dominante”,
dobbiamo constatare che talvolta non vi siamo neanche così radicalmente lontani.
Nel mondo protestante assistiamo ad analoghi problemi: anche se le sue modeste
dimensioni, e la proporzionalmente più grande presenza di immigrati rispetto al mondo
cattolico, fanno sì che la sensibilità al tema, e le concrete esperienze di integrazione, siano
più diffuse e visibili all’interno delle chiese. Tuttavia le non piccole presenze protestanti
provenienti soprattutto dall’Asia e dall’Africa, ma anche da altrove, portano con sé
teologie più conservatrici e decisamente meno liberal di quelle rappresentate dal
protestantesimo europeo, per esempio su temi come il divorzio, l’aborto, le donne pastore,
o anche le tematiche ecumeniche. Il che porta le chiese protestanti a doversi confrontare ad
inediti problemi ecclesiali, paradossalmente aggravati dalla loro struttura democratica, che
fa sì che queste presenze, in tutti i sensi, “contino”: e questo, in presenza di comunità
immigrate qualche volta cospicue in proporzione alle dimensioni delle comunità ospiti,
può mettere in crisi equilibri sedimentati, oltre che costituire lo stimolo a percorrere strade
non ancora battute.
Entrambi dunque, cattolici e protestanti, si ritrovano confrontati con il loro stesso passato,
e coinvolti in un processo di negoziazione o semplicemente di discussione che ha per
oggetto innanzitutto i luoghi di culto, le liturgie, le lingue utilizzate, i rapporti con le
comunità ospitanti, ma anche modi diversi di essere chiesa e addirittura, come si è visto, le
rispettive teologie. E analoghi processi, seppure in termini numericamente meno incisivi,
stanno vivendo anche le chiese ortodosse10.
Diverso il caso delle nuove chiese africane (mi riferisco a quelle autocefale, non legate alle
chiese storiche, cattoliche o protestanti che siano), ospitate talvolta dagli uni o dagli altri,
ma che mantengono spesso una struttura propria, che non è solo culturale, etnica e/o
linguistica, ma anche propriamente ecclesiologica – loro sì, a differenza delle precedenti
che si ritrovano inserite in un complesso gioco di interazione con le rispettive chiese,
autonome e di fatto incapsulate nella realtà sociale ed ecclesiale.
Ma oltre alle presenze cristiane, e tendenzialmente sempre più cospicue, sono arrivate con
l’immigrazione anche religioni più radicalmente “altre”, sostanzialmente estranee alla
storia culturale europea o come tali a torto o a ragione percepite, oggetto in passato più di
studi antropologici “esterni” che di osservazione sociologica “interna”. Penso all’induismo,
al buddhismo (quello popolare, incarnato anche in culture e comportamenti collettivi, non
quello à la page e ridotto a vaghe e poco impegnative tecniche di meditazione di soubrettes
e calciatori, che certamente non vive di quella dimensione e di quel “respiro” tradizionale e
comunitario cui ci stiamo riferendo), ma anche a mondi religiosi antichi e poco conosciuti
(si pensi all’animismo di varie popolazioni africane), e a religioni identificabili con precisi
gruppi etnici (dallo shintoismo ai sikh), per finire, ultimo e più importante, con l’islam.
Quest’ultimo merita una sottolineatura particolare per un fatto semplice ma decisivo:
perché in pochi anni, di fatto nell’arco di una generazione, da nemico numero uno della
cristianità europea che era, comunque un soggetto altro ed esterno, oltre che estraneo, è
diventato la seconda presenza religiosa in Europa, Italia inclusa, dopo quella cristiana
globalmente intesa: e si tratta di un presenza ormai considerabile definitiva e irreversibile.
Una svolta che, come ho già rilevato, non esito a definire storica. Un processo che per un sottile paradosso della storia, al tempo stesso ironia e nemesi, è
stato innescato dall’arrivo in occidente di gruppi via via più cospicui di immigrati. L’ironia
è data proprio dal fatto che laddove, in quattordici secoli di storia comune, di incontri e
soprattutto di scontri, non erano riusciti gli eserciti e le invasioni, sta riuscendo, senza
nemmeno averlo voluto, quasi come conseguenza casuale e certamente non pianificata
10
! A titolo
di esempio: una recente ricerca da me svolta a Livorno, a partire da un’esigenza molto concreta come la
ridefinizione del piano regolatore a partire anche dall’articolazione plurale, in senso lato, della realtà urbana (La città
plurale, pubblicata solo tra gli atti che hanno portato all’approvazione, per l’appunto, del nuovo piano regolatore,
Comune di Livorno, 1998), mi ha posto sotto gli occhi con un’evidenza palmare quanto la pluralità attuale sia anche un
formidabile mezzo per riportare in vita le “pluralità addormentate” tradizionali, rimettendo in circolo il patrimonio
storico e persino artistico della città, nonché ri-vitalizzando, dando loro letteralmente nuova vita, le presenze religiose e
i mondi associativi collegati – offrendo, in particolare, occasioni di ripensamento alla pluralità stessa come concetto e
come pratica sociale.
della sua presenza, l’“esercito industriale di riserva” dei nuovi immigrati. L’islam penetra
in Europa non sulla punta della spada, ma per le conseguenze impreviste (di tutto si tratta
tranne che di un deliberato disegno, anche se la fantasia propagandistica di alcuni vorrebbe
farcelo credere) di fenomeni sociali che nulla, di per sé, hanno a che fare con la religione. Un islam che tuttavia, al contrario del nostro immaginario (mediatico, ma anche colto,
accademico), è tutt’altro che statico, e lo è ancora meno in emigrazione, per non parlare
delle trasformazioni che subisce nel passaggio dalla prima alla seconda generazione,
dall’islam dei padri all’islam dei figli: esso cambia, si evolve, non è più quello dei padri,
senza per questo perdere necessariamente la propria identità, disperdendosi nel mare
dell’indeterminato e dell’indifferenziato. Producendo anzi interessanti e ancora assai poco
studiate conseguenze sul piano sociale, politico, giuridico, culturale, ma anche religioso e
spirituale: per l’Europa, per il cristianesimo, ma anche per l’islam medesimo, ivi compreso
quello dei paesi d’origine, attraverso effetti di feedback di cui si sa ancora molto poco, e le
cui conseguenze saranno probabilmente più visibili nei prossimi anni11.
Pluralità, incontro – dialogo?
La com-presenza di soggetti religiosi non è fatta di identità giustapposte, tra loro
impermeabili, non comunicanti. Questo può succedere, e può essere il caso soprattutto per
alcuni gruppi religiosi del tipo “setta”, o molto caratterizzati etnicamente e/o
linguisticamente, che finiscono per scegliere di “incapsularsi” nella società, al limite di
fuggirla e di sfuggire ad essa. Ma non è necessariamente il destino comune.
Al contrario, e tanto più se ci si riferisce alle religioni a vocazione universale o comunque
caratterizzate da una presenza e una visibilità sociale, sempre più spesso si creano momenti
11
!
Citiamo alcuni temi rilevanti, tra gli altri, solo per titoli:
- Per l’Europa: la pluralità religiosa sempre maggiore e più incisiva, più visibile (la mezzaluna e la croce, il
minareto e il campanile che si stagliano sul profilo delle città, per usare immagini un po’ stereotipe ma
efficaci); l’immagine dell’altro da ridefinire (reciprocamente); la ridefinizione dei rapporti tra le due sponde
del Mediterraneo (in politica, economia, ecc.); le conseguenze sulle relazioni umane, interpersonali: contatti
personali, quotidiani, matrimoni misti (e loro conseguenze su immagine e concetto di famiglia, di religione,
ecc.); le conseguenze sul concetto stesso di Europa e di occidente, non più identificabile solo con la radice
ebraico-cristiana (a più lungo termine), cioè sull’immagine che gli europei hanno di se stessi attualmente.
- Per l’islam: la separazione dell’identificazione islam-mondo arabo; l’accettazione di fatto (e in prospettiva anche la
teorizzazione e la “teologizzazione”) dello statuto di minoranza, del fatto di vivere come minoranza in una società non
informata islamicamente (un fatto non scontato: l’ortodossia inviterebbe al ritorno in dar al-islam, nella “casa
dell’islam”. Questo vuol dire un cambiamento enorme, che mi pare che la maggioranza anche degli intellettuali
musulmani non percepisca o sul quale preferisca far finta di niente); il ruolo che gioca l’islam nel mondo non islamico,
oggi che è anche un attore interno dei paesi non musulmani, di cui occorrerà sempre più tenere conto; il chiarimento,
credo in buona sostanza tutto ancora da fare, dei rapporti (anche di forza, di subordinazione), dei canali di
comunicazione, degli obiettivi (quali sono comuni e quali no) di questi vari pezzi della umma; quale livello di
“europeizzazione” dell’islam è considerato accettabile senza perdere l’identità musulmana e al contempo senza
chiuderla in un ghetto infecondo; quale ridefinizione del rapporto tra legge religiosa e legge civile (in fondo un
rapporto, anche strumentale, con la legge civile e il potere che incorpora è già in atto, per esempio attraverso la
procedura per l’Intesa. Piaccia o non piaccia, significa aver accettato almeno nei fatti il primato della legge civile. Non
ci si potrà non interrogare sui fondamenti rispettivi delle due concezioni della legge, anche perché gli scontri, per ora
contenuti, sono dietro l’angolo. Ne cito solo alcuni: il problema delle conversioni per matrimonio, comunque ci si
voglia girare intorno, forzate o, il minimo che si possa dire, burocratizzate e prive di contenuto spirituale: non è una
svilizzazione, anche per l’islam degli europei?; il problema dello statuto personale, la legislazione sulla famiglia ripudio, segregazione educativa, ecc. -, il ruolo della donna e i suoi diritti, ecc.); e p.e., teologicamente: quale rapporto
con il testo fondatore, quali possibilità di traduzione e di modi di lettura del Corano - si potrà prescindere anche in
futuro da un’esegesi, nel senso sostanzialmente ormai acquisito nella teologia cristiana? Detto in altri termini: si potrà
chiedere ancora a lungo ai musulmani europei di essere solo musulmani, e di dimenticarsi di essere europei? si potrà
chiedere loro, soprattutto alla seconda, alla terza generazione (e vale tanto per i figli di immigrati quanto per quelli di
musulmani convertiti) di non far incontrare la loro «musulmanità» con la loro «europeità»?
e situazioni di contatto, di incontro, e magari anche di frizione e di scontro, talvolta non
indolore: con la società, tra i soggetti religiosi minoritari, e con le religioni maggioritarie
delle rispettive società.
Dalla pluralità nasce dunque l’incontro: quand’anche non volontario, in qualche modo
obbligato, coatto. E dall’incontro, lo sguardo, l’osservazione reciproca, e infine lo
“scambio della parola” – il dialogo appunto (centrale, del resto, per religioni che dopo
tutto hanno al loro centro il logos, il Verbo, in diversa forma manifestato)12. Contrariamente all’uso comune in ambito religioso, la parola dialogo si rivela spesso più
una aspirazione che una realtà, e viene usata in maniera eccessivamente ‘prematura’. Vero
è che l’impresa dialogica ha per definizione una dimensione ‘titanica’: una sua
significativa definizione ci avverte che essa è “intraprendere l’impossibile e accettare il
provvisorio”.
E’ forse più onesto limitarsi a parlare di incontri interreligiosi, e più in generale di rapporti
interreligiosi o, come ri-comincia a fare, molto opportunamente, anche la teologia più
recente, di “conversazioni” tra religioni. Del resto anche nei documenti vaticani (p.e. un
documento fondativo dei rapporti interreligiosi quale è la dichiarazione conciliare Nostra
Aetate) la parola dialogo traduce il latino colloquium, che evoca una dimensione più
onestamente dimessa e quotidiana. E innanzi tutto quotidiana è la dimensione dialogica che
osserviamo manifestarsi nelle relazioni sociali tra credenti di diversa appartenenza
religiosa. Del resto, essa è influenzata dalla concretezza delle situazioni sociali in cui vive una
religione. Un esempio? «Essere religiosi è essere interreligiosi», recita senza mezzi termini
una dichiarazione dell’Associazione teologica indiana13. E le direttive per il dialogo
interreligioso fornite dalla commissione per l’ecumenismo e il dialogo della conferenza dei
vescovi cattolici dell’India spiegano con una certa “tranquillità”: «la pluralità delle
religioni è una conseguenza della ricchezza della stessa creazione e della grazia multiforme
di Dio. Anche se provengono tutti dalla stessa origine, i popoli hanno percepito l’universo
ed articolato la loro consapevolezza del Mistero divino in molteplici modi, e Dio è stato
sicuramente presente in queste imprese storiche dei suoi figli. Tale pluralismo non va
dunque affatto deplorato, bensì piuttosto riconosciuto esso stesso come un dono divino».
Non stupisce che tali dichiarazioni provengano da paesi lontani, geograficamente ma anche
religiosamente. Dal punto di vista sociologico la spiegazione ci pare semplice e immediata:
non possono venire che da lì, perché è lì che le chiese cristiane, e in questo caso la chiesa
cattolica, si trovano da tempo in interazione con altre religioni, e soprattutto si trovano, nei
confronti di esse, in posizione minoritaria, talvolta subordinata, in ogni caso presenza
relativamente recente rispetto alle tradizioni religiose di queste terre. Non si può, in queste
situazioni, non rendersi conto che le altre tradizioni religiose esistono, si è obbligati a
conoscerle, e conoscendole non si può non riconoscere il “loro” valore anche veritativo. Chi è maggioranza, e pago di esserlo, difficilmente ha la sensibilità per accorgersi degli
altri, dei “piccoli”14: mentre i piccoli sono obbligati a conoscere il grande che li può
schiacciare, e che in ogni caso è un vicino troppo ingombrante per non osservarlo con
!
12
Rinvio, su questi temi, a Allievi (1997, 1998a, 1998b).
!
13
cit. in J.Dupuis (1997), da cui riprendiamo altri riferimenti di seguito citati.
!
14
Non per caso padre Dupuis, per aver scritto queste cose, è stato censurato dalla Congregazione per la dottrina della
fede, ex-Sant’Uffizio.
attenzione, se non con preoccupazione. Non per caso, a contrario, è la stessa situazione che
sta vivendo l’islam: è in Europa, dove si trova in condizione minoritaria e subordinata
rispetto alle confessioni cristiane, e con poche speranze di rovesciare la situazione, che è
costretto a elaborare, prima nella prassi e poi anche nella teoria, una propria teologia della
pluralità, o, se non una ortodossia, quanto meno una ortoprassi che la contempli. Ed è
questo, tra l’altro, uno dei motivi concreti della nostra incomprensione dell’islam
trapiantato in Europa: lo interpretiamo con le categorie dell’islam dei paesi d’origine (un
tutt’uno con lo stato e la società, forte, maggioritario, teologicamente solido e privo di
confronti e di sfide religiose interne), mentre da noi si presenta attraverso minoranze
slegate dalla società e non protette dallo stato (al contrario, talvolta anche stigmatizzate),
con un radicamento sociale debole, prive dei riferimenti tradizionali, e confrontate a
comunità religiose altre che sono maggioritarie, potenti, esse sì, dopo tutto, a dispetto di
una sbandierata laicità dello stato, fortemente intrecciate con le istituzioni statuali dei
rispettivi paesi.
Conseguenze teologiche?
La scoperta dell’altro è innanzitutto riscoperta di sé. Nel caso di ebrei e cristiani significa
andare a cercare le radici bibliche del rapporto con l’altro.
La prima sorpresa, così facendo, è innanzitutto quella di constatare un dato per nulla
scontato: che il tema dello straniero (che tale è anche religiosamente), dell’altro-da-sé, può
essere considerato una specie di filo rosso e diventare una chiave di lettura della Bibbia,
Antico e Nuovo Testamento insieme15 . E che questo forse significa qualcosa per
l’occidente, per quel tanto che da questi testi deriva alcune delle sue impalcature
fondamentali: anche per chi in essi, da un punto di vista religioso, non si riconosce.
Significa scoprire che il testo di riferimento di due dei tre monoteismi abramitici (ma
abbondantemente ripreso, con dovizia di riferimenti, anche nel terzo e nel suo testo)
c’entra anche con gli altri, anche quelli che ad esso riferimento non fanno: ne parla, ne
tiene conto, li interroga e si fa interrogare da essi. Il che impone oggi a coloro che a questi
testi si richiamano e di cui rivendicano l’eredità di rapportarsi diversamente con gli altri
concreti che queste religioni altre incarnano.
E’ vero che c’è un’enfasi eccessiva, talvolta, in molte declinazioni di questa opzione
dialogica. Tanto importante nel concreto e non priva di una dimensione profetica sul piano
individuale, diventa in qualche caso una sorta di retorica ideologia buonista in molti ambiti
in cui viene volentieri pubblicamente reiterata. E tanto più assume questa caratterizzazione
quanto più è pubblicizzata. In questo senso «il “dialogo” può essere un alibi per quella
forma di ciarlataneria, in cui tutti parlano con tutti e nessuno ha nulla da dire» (Berger,
1969). Un’irenismo puramente verbale, e come tale poco impegnativo.
Anche per questo, ma non solo per questo, diventa fondante dimensione dialogica
soprattutto quella personale, privata, incisivamente concreta, come quella vissuta da molti
di coloro che hanno davvero, direttamente e non superficialmente a che fare, per esempio,
con immigrati di altre religioni. In questo senso l’immigrazione si rivela anche un luogo
teologico e profetico. Il più visibile, probabilmente: anche se non il solo. Più che il dialogo teologico, e quello diplomatico tra istituzioni religiose, pur necessari,
sembra essere questa la dimensione del dialogo più interessante e ricca di conseguenze, e
!
15
Per quel che riguarda quest’ultimo, ho abbozzato qualche cenno interpretativo, del tutto introduttivo, in Allievi
(1994).
in definitiva più vera. Il dialogo vero è di carne, e non superficiale. «Vita dialogica non è
quella in cui si ha a che fare con molti uomini, ma quella in cui si ha davvero a che fare
con gli uomini con cui si ha a che fare», ha sottolineato Martin Buber (1923). Ed è dialogo
sulle cose concrete, sui problemi, a partire dal vissuto quotidiano, non da problematiche
astratte. Poi, certo, c’è anche il dialogo religioso vero e proprio: un punto d’arrivo, tuttavia,
non un punto di partenza. Termine ultimo di un cammino che, in quanto tale, è lento per
definizione, va conquistato tappa dopo tappa. E probabilmente non ha fine: voveo
dialogum perpetuum recita, significativamente, una delle formule del voto gesuita. Solo
come tale può diventare anche, in una visione profetica e pro-vocativa forte, come
suggerisce Panikkar, dialogo intrareligioso. Perché dopo tutto, dalla prospettiva di Dio (per
quanto ci è possibile assumerla…), non sappiamo «se il pluralismo delle religioni sia un
fenomeno di fatto o non di principio» (E. Schillebeeckx).
Bibliografia
-Acquaviva, S. (1961), L’eclissi del sacro nella società industriale, Milano, Comunità
-Allievi, S. (1994) Il libro dell’altro, Bologna, EDB
-Allievi, S. (1996) Islam e occidente: lo specchio e l’immagine, in S.Allievi (a cura di),
L’occidente di fronte all’islam, Franco Angeli, Milano
-Allievi, S. (1997) I luoghi del dialogo, in I.Siggillino (a cura di), I luoghi del dialogo. Cristiani e
musulmani in Italia, Melzo (Mi), Cens, 1997 -Allievi, S. (1998a) Pluralismo e dialogo interreligioso. Sfide e interrogativi dell’alterità, in
«Orientamenti», n.1-2, 1998 (numero monografico su Ecumenismo e dialogo interreligioso)
-Allievi, S. (1998b) Immigrazioni e fondamentalismi, in «Servitium», n.117, 1998 (numero
monografico sui fondamentalismi) -Allievi, S. (1998c) Les convertis à l’islam. Les nouveaux musulmans d’Europe, Paris,
L’Harmattan (ediz. it. parz. in I nuovi musulmani, Roma, Edizioni Lavoro, 1999)
-Allievi, S. (1999a) Les conversions à l’islam. Redéfinition des frontières identitaires, entre individu
et communauté, in F. Dassetto (a cura di), Paroles d’islam, Paris, Maisonneuve et Larose
-Allievi, S. (1999b) Pour une sociologie des conversions. Lorsque les Européens deviennent
musulmans, in «Social Compass», n.3, 1999 (numero monografico sulle conversioni)
-Allievi, S. (1999c) Dall’islam ai musulmani. Fare ricerca su una religione ‘immigrata’, in
«Sociologia Urbana e Rurale», n.58, 1999
-Allievi, S. e Dassetto, F. (1993) Il ritorno dell’islam. I musulmani in Italia, Roma,
Edizioni Lavoro
-Beckford, J.A. (1989) Religion and Advanced Industrial Society, London, trad. it.
Religione e società industriale avanzata, Roma, Borla, 1991
-Bell, D. (1987) The return of the sacred?, in «British Journal of Sociology», n.28, pp.
419-444
-Bellah, R. (1970a) Beyond belief, New York, Harper and Row -Bellah, R. (1970b) Christianity and symbolic realism, in «Journal for the Scientific Study
of Religion», n. 9, pp.89-96
-Bennassar, B. e L. (1989) Les chrétiens d'Allah, Paris, Perrin, trad. it. I cristiani di
Allah, Milano, Rizzoli, 1991
-Berger, P.L. (1967) The Sacred Canopy. Elements of a Sociological Theory of Religion,
New York, Doubleday, trad. it. La sacra volta, Milano, Sugarco, 1984
-Berger, P.L. (1969) A Rumor of Angels. Modern Society and the Rediscovery of the
Sacred, New York, Doubleday, trad. it. Il brusio degli angeli, Bologna, Il Mulino,
1970 -Berger, P.L. (1984) Robert Musil and the Salvage of the Self, in «Partizan Review», n.51,
trad.it. Robert Musil e il salvataggio del sé, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1992
-Berger, P.L. (1992) A Far Glory. The Quest for Faith in an Age of Credulity, New York,
Free Press, trad. it. Una gloria remota, Bologna, Il Mulino, 1994
-Berger, P.L. e Luckmann T. (1966a) The Social Construction of Reality, New York,
Doubleday and Co., trad. it. La realtà come costruzione sociale, Bologna, Il Mulino, 1969
-Berger, P.L. e Luckmann T. (1966b) Secularization and Pluralism, in «International
Yearbook for the Sociology of Religion», 47, II, pp.73-86, trad. franc. Aspects
sociologiques du pluralisme,in «Archives de Sociologie des Religions», n.23, 1967, pp.
117-127
-Berger, P.L., Berger, B. e Kellner, H. (1973) The Homeless Mind, Harmondsworth,
Penguin Books
-Bruce, S. (1992) Religion and Modernization. Sociologists and Historians Debate the
Secularization Thesis (a cura di), Oxford, Clarendon Press
-Buber, M. (1923) Ich und Du, in Das dialogische Prinzip, Heidelberg, Lambert
Schneider, trad.it., Il principio dialogico e altri saggi, Milano, San Paolo, 1993
-Campiche, R.J. (1993) Individualisation du croire et recomposition de la religion, in
«Archives de Sciences Sociales des Religions», n.81, pp.117-131
-Crespi, F. (1983) Identità e potere soggettivo, in «Rassegna Italiana di Sociologia», n.1,
pp.5-18
-Dassetto, F. (1996) La construction de l'islam européen. Approche socioanthropologique, Paris, L'Harmattan
-Dassetto, F. e Bastenier, A. (1991) Europa: nuova frontiera dell’Islam, ediz. aggiornata,
Roma, Edizioni Lavoro (ediz. originale 1988)
-Davie, G. (1990) Believing without Belonging: Is This the Future of Religion in Britain?,
in «Social Compass», n.37, pp.455-469
-Dupuis J. (1997) Verso una teologia cristiana del pluralismo religioso, Brescia, Queriniana
-Fenn, R.K. (1972) Towards a new sociology of religion, in «Journal for the Scientific
Study of Religion», n.1, pp.16-32
-Ferrarotti, F. (1985) Il contributo dei classici, in D. Pizzuti (a cura di), Sociologia della
religione, Roma, Borla
-Gauchet, M. (1985) Le désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion,
Paris, Gallimard
-Huntington, S.P. (1996), The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order,
trad.it. Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale, Milano, Garzanti, 1997
-Kepel, G. (1991), La Revanche de Dieu, Paris, Seuil
-Lasch, C. (1995) The Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy, New YorkLondon, Norton & Co., trad.it. La ribellione delle élite, Milano, Feltrinelli, 1995
-Luckmann, T. (1963) The invisible religion, New York, Macmillan Co., trad. it. La
religione invisibile, Bologna, Il Mulino, 1969
-Luhmann, N. (1982) Funktion der Religion, Frankfurt, Suhrkamp, trad. it. Funzione della
religione, Brescia, Morcelliana, 1991
-Luhmann, N. (1985) Society, Meaning, Religion - Based on Self-Reference, in
«Sociological Analysis», n.46, pp.5-20
-Maffesoli, M. (1988) Le temps des tribus, Paris, Méridiens Klincksieck, trad. it. Il tempo
delle tribù. Il declino dell’individuo, Roma, Armando, 1988
-Melucci, A. (1982) L’invenzione del presente, Bologna, Il Mulino
-Melucci, A. (1993) Passaggi di senso e incerte frontiere, in A. Carbonaro e C. Facchini (a
cura di), Biografie e costruzione dell’identità. Tradizione e innovazione nella riproduzione
sociale, Milano, Franco Angeli, pp.362-364
-Possenti, V. (1996) Per una democrazia dei valori, in «Orientamenti», n.6-7, pp.19-32
-Simmel, G (1989) Gesammelte Schriften zur Religionssoziologie, Berlin, Duncker &
Humblot, trad.it. Saggi di sociologia della religione, Roma, Borla, 1993
-Wilson, B.(1966) Religion in Secular Society, London, Watts & Co.
-Wilson, B. (1982) Religion in Sociological Perspective, Oxford, Oxford University Press,
trad. it. La religione nel mondo contemporaneo, Bologna, Il Mulino, 1985