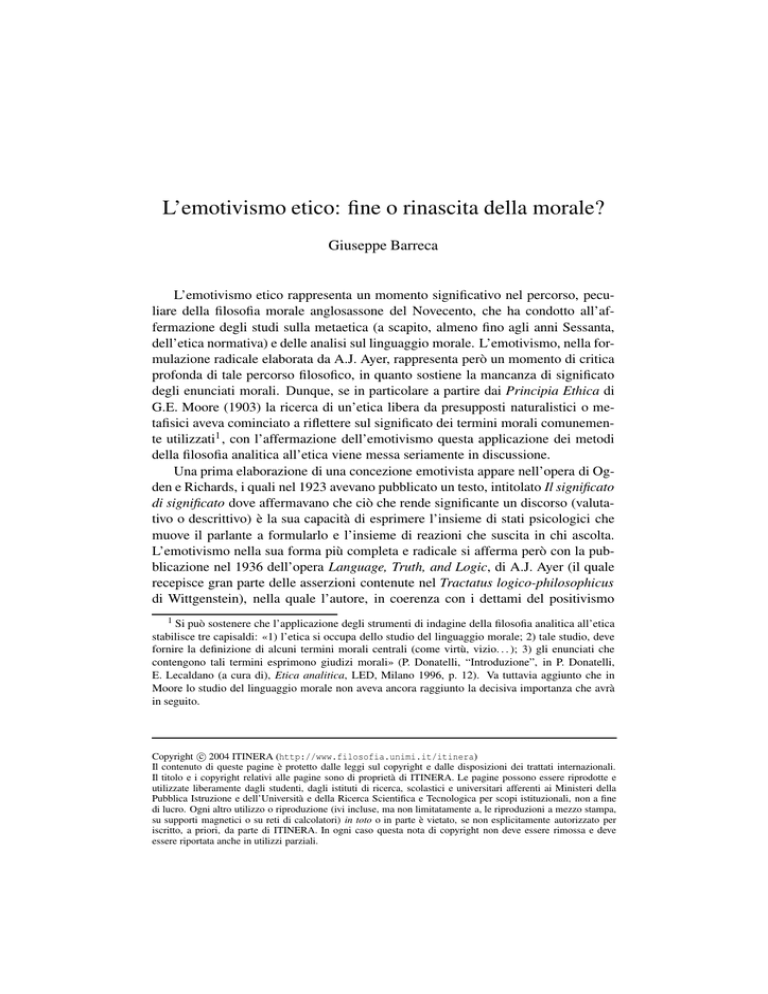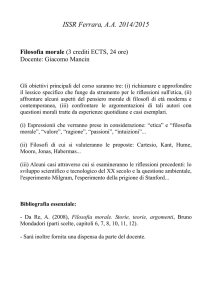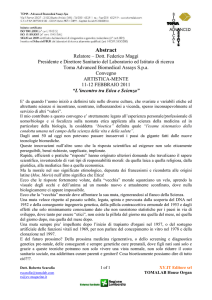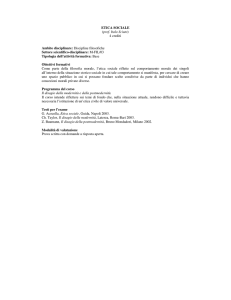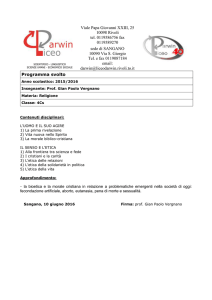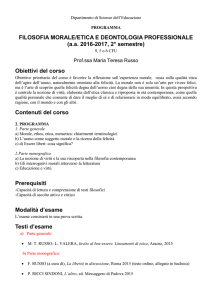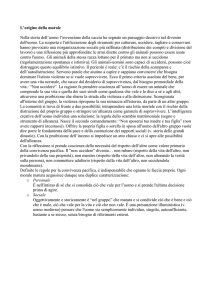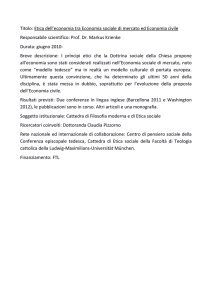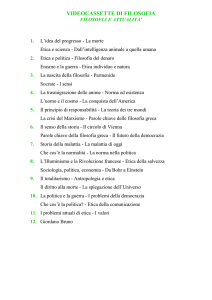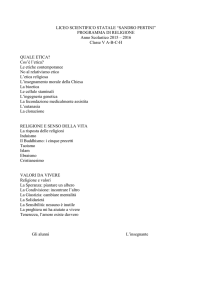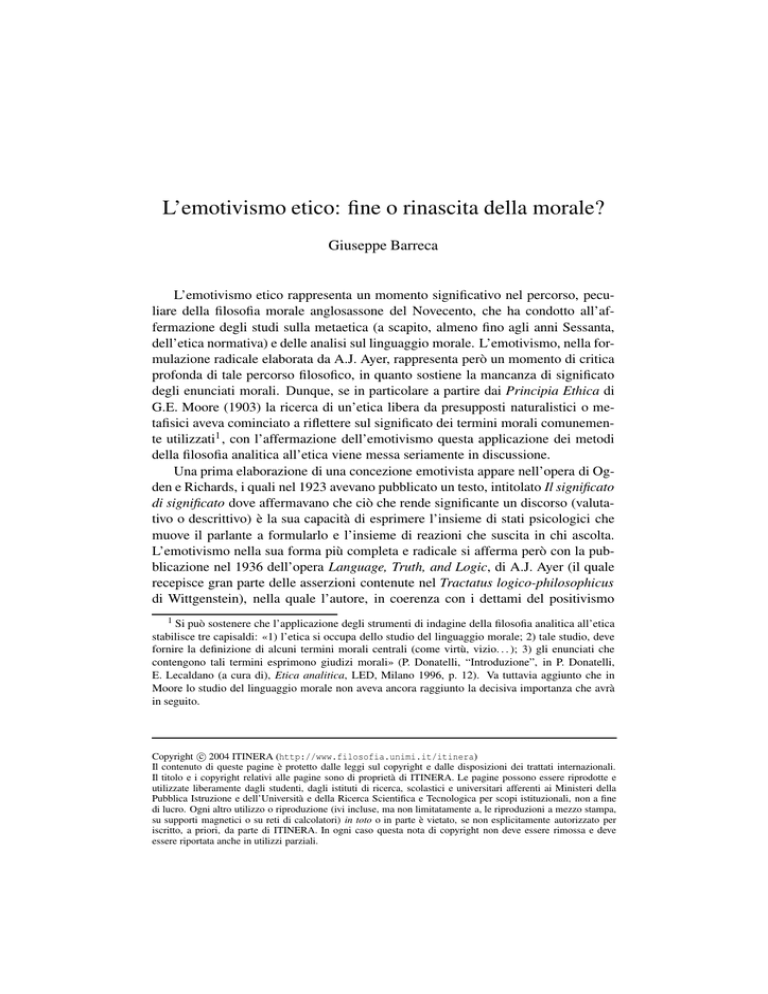
L’emotivismo etico: fine o rinascita della morale?
Giuseppe Barreca
L’emotivismo etico rappresenta un momento significativo nel percorso, peculiare della filosofia morale anglosassone del Novecento, che ha condotto all’affermazione degli studi sulla metaetica (a scapito, almeno fino agli anni Sessanta,
dell’etica normativa) e delle analisi sul linguaggio morale. L’emotivismo, nella formulazione radicale elaborata da A.J. Ayer, rappresenta però un momento di critica
profonda di tale percorso filosofico, in quanto sostiene la mancanza di significato
degli enunciati morali. Dunque, se in particolare a partire dai Principia Ethica di
G.E. Moore (1903) la ricerca di un’etica libera da presupposti naturalistici o metafisici aveva cominciato a riflettere sul significato dei termini morali comunemente utilizzati1 , con l’affermazione dell’emotivismo questa applicazione dei metodi
della filosofia analitica all’etica viene messa seriamente in discussione.
Una prima elaborazione di una concezione emotivista appare nell’opera di Ogden e Richards, i quali nel 1923 avevano pubblicato un testo, intitolato Il significato
di significato dove affermavano che ciò che rende significante un discorso (valutativo o descrittivo) è la sua capacità di esprimere l’insieme di stati psicologici che
muove il parlante a formularlo e l’insieme di reazioni che suscita in chi ascolta.
L’emotivismo nella sua forma più completa e radicale si afferma però con la pubblicazione nel 1936 dell’opera Language, Truth, and Logic, di A.J. Ayer (il quale
recepisce gran parte delle asserzioni contenute nel Tractatus logico-philosophicus
di Wittgenstein), nella quale l’autore, in coerenza con i dettami del positivismo
1 Si può sostenere che l’applicazione degli strumenti di indagine della filosofia analitica all’etica
stabilisce tre capisaldi: «1) l’etica si occupa dello studio del linguaggio morale; 2) tale studio, deve
fornire la definizione di alcuni termini morali centrali (come virtù, vizio. . . ); 3) gli enunciati che
contengono tali termini esprimono giudizi morali» (P. Donatelli, “Introduzione”, in P. Donatelli,
E. Lecaldano (a cura di), Etica analitica, LED, Milano 1996, p. 12). Va tuttavia aggiunto che in
Moore lo studio del linguaggio morale non aveva ancora raggiunto la decisiva importanza che avrà
in seguito.
c 2004 ITINERA (http://www.filosofia.unimi.it/itinera)
Copyright Il contenuto di queste pagine è protetto dalle leggi sul copyright e dalle disposizioni dei trattati internazionali.
Il titolo e i copyright relativi alle pagine sono di proprietà di ITINERA. Le pagine possono essere riprodotte e
utilizzate liberamente dagli studenti, dagli istituti di ricerca, scolastici e universitari afferenti ai Ministeri della
Pubblica Istruzione e dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per scopi istituzionali, non a fine
di lucro. Ogni altro utilizzo o riproduzione (ivi incluse, ma non limitatamente a, le riproduzioni a mezzo stampa,
su supporti magnetici o su reti di calcolatori) in toto o in parte è vietato, se non esplicitamente autorizzato per
iscritto, a priori, da parte di ITINERA. In ogni caso questa nota di copyright non deve essere rimossa e deve
essere riportata anche in utilizzi parziali.
ITINERA – Rivista di Filosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura
logico, applica ai giudizi dell’etica e alle espressioni della mistica il principio di
verificazione:
Il criterio da noi usato per mettere alla prova l’autenticità di quelle che si presentano come affermazioni di fatto è il criterio di verificabilità. Diciamo che
un enunciato è significativo in senso fattuale per qualunque dato individuo,
se e solo se quest’ultimo sa come verificare la proposizione che l’enunciato si
propone di esprimere – cioè, se egli sa quali osservazioni lo condurrebbero,
sotto certe condizioni, ad accettare la proposizione come vera o falsa.2
L’emotivismo etico nega lo status di espressioni verificabili, e quindi dotate di
senso, a tutte quelle proposizioni che esprimono comandi, stati d’animo, convinzioni morali, religiose ed estetiche: le uniche proposizioni dotate di senso sono quelle
cui si può applicare il principio di verificazione, ossia quelle che possono essere vere o false, mentre tutte le altre sono soltanto delle “pseudo-proposizioni” (pseudopropositions), proprio perché non esistono condizioni oggettive che le possano verificare. Non è pertanto possibile costruire un’etica razionale che abbia i caratteri
di obbiettività di una disciplina scientifica: «Se [. . . ] per scienza etica si intende
l’elaborazione di un sistema morale ‘vero’, non può darsi nulla di simile a una
scienza etica [. . . ]. Per noi la filosofia etica consiste semplicemente nel dire che i
concetti etici sono pseudo-concetti, e che pertanto non sono analizzabili»3 .
In tal modo l’emotivismo in campo etico assume una connotazione di radicalità
che rende la riflessione di Ayer senz’altro originale e brillante, ma al tempo stesso
controversa:
ci disponiamo a mostrare che nella misura in cui sono significative, le affermazioni di valore sono normali affermazioni scientifiche; e nella misura in
cui non risultano scientifiche non sono significative nel senso letterale della parola, ma sono semplicemente espressioni di emozioni che non possono
essere né vere e né false.4
Ayer giunge a sostenere che, stante la mancanza di significatività delle proposizione dell’etica, le stesse discussioni a proposito di quello che è giusto o non è
giusto fare sono prive di senso, sia perché sono disomogenee e confuse, sia perché
gli enunciati che le esprimono non hanno significato, dato che non esiste un modo
oggettivo per definire “giusto” e “ingiusto”. Essi si limitano infatti a manifestare
i sentimenti del parlante e sono per questa ragione paragonabili alle interiezioni,
2
A.J. Ayer, Language, Truth, and Logic, Gollacz, London 1946 (tr. it. Linguaggio, verità e logica,
a cura di G. De Toni, Feltrinelli, Milano 1987, p. 13).
3 Ibid., p. 144. Cfr. altresì Wittgenstein, nello scritto Alcune osservazioni sulla forma logica (1929): «dove il linguaggio traveste e maschera la struttura logica, dove esso consente la formazione di pseudoproposizioni, dove esso usa ambiguamente un unico e stesso termine in una infinità di
significati differenti, là noi dobbiamo sostituire al linguaggio comune un simbolismo il quale ci offra
una chiara immagine della struttura logica, escluda pseudoproposizioni, ed usi i termini in modo non
ambiguo» (Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916, a cura di A.G. Conte, Einaudi,
Torino 1998, p. 117).
4 A.J. Ayer, Linguaggio, verità e logica, cit., pp. 102-103.
2
ITINERA – Rivista di Filosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura
a espressioni quali “Ahimè!”. Questo argomento, sostiene Ayer, risulta ancor più
chiaro se si analizza quel che accade quando due o più persone esprimono differenti giudizi etici su un certo atto. Egli infatti pensa che non sia possibile parlare di
un disaccordo morale vero e proprio e della possibilità di comporre razionalmente
tale disaccordo. Se due persone discutono sulla liceità morale del furto e sono in
disaccordo nel definire tale atto come “ingiusto”, tra di esse non vi è un effettivo
disaccordo morale, ma soltanto l’espressione di diverse sensibilità relativamente a
un certo atto. D’altra parte, il termine “ingiusto” in tale contesto risulta prettamente valutativo e dunque privo di significato fattuale, non essendo possibile verificare
un’espressione del tipo “X è ingiusto”. Pertanto, sostenere che un certo tipo di
azione è giusta o ingiusta, non significa fare alcuna asserzione sui fatti. In tal modo
viene disconosciuta l’esistenza di un effettivo disaccordo etico, poiché si parla di
un semplice contrasto fra i sentimenti espressi dai parlanti: «[io] esprimo semplicemente certi sentimenti morali. E chi si prende la pena di contraddirmi sta semplicemente esprimendo i propri sentimenti morali. Cosicché evidentemente non ha
senso chiedere quale dei due abbia ragione. Poiché nessuno dei due sta asserendo
una proposizione autentica»5 . Non resta quindi che ammettere che i giudizi etici
sono inconciliabili e che non sussiste un’argomentazione morale. L’impossibilità
di costruire delle argomentazioni etiche di carattere scientifico, che per Moore era
un segno di una riflessione morale da rifondare su basi intuizioniste, per Ayer è
invece una caratteristica costitutiva e innegabile di tale riflessione: «Risulta allora
che l’etica, quale ramo del sapere, non è nulla più che un settore della psicologia e
della sociologia»6 .
Nella riflessione di Ayer scompare l’idea sostenuta da Moore, secondo la quale i concetti dell’etica possono essere conosciuti, sebbene non in modo oggettivo,
bensì in modo intuitivo7 ; Ayer invece nega agli enunciati dell’etica qualsiasi funzione e valore conoscitivo, giacché essi in realtà non descrivono nulla, ossia non
sono in grado di raffigurare uno stato di cose o di fatti oggettivamente esistente:
essi sono pertanto assolutamente privi di qualsiasi portata conoscitiva. Vi è dunque una netta separazione tra le espressioni che comunicano fatti e le espressioni
valutative.
Si può notare come in tal modo Ayer vada al di là delle argomentazioni sulla
5
Ibid., p. 137.
Ibid., p. 145.
7 Moore, come gli intuizionisti, può per questo essere definito un descrittivista. L’intuizionismo
etico anglosassone rappresenta un’ampia pagina della filosofia morale analitica: esso ha il suo “fondatore” in H. Prichard e il suo più fine teorico in D. Ross. Vi è tuttavia una differenza tra Moore
e questi intuizionisti: Moore infatti non ritiene che vi possa essere un’intuizione diretta dei valori
morali, poiché insiste «sul concetto che i predicati morali sono non naturali, cioè non hanno carattere empirico, e non sono conosciuti né mediante i sensi, né mediante l’introspezione; e quindi usa
‘intuizione’ solo per indicare questo tipo particolare di apprendimento. Ma non [ritiene] che ci sia
un’intuizione diretta dei valori (o del bene come tale); non si intuisce il doveroso, il buono [. . . ]
questa intuizione accompagna la rappresentazione di fatti empirici, sì che quello che si intuisce non
è il valore, ma la sua connessione tra una determinata rappresentazione empirica e il suo valore»
(G. Preti, Morale e metamorale, a cura di E. Migliorini, Angeli, Milano 1989, p. 42).
6
3
ITINERA – Rivista di Filosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura
morale di Wittgenstein, il quale, nella sua Lecture on Ethics del 1929, sebbene sostenga che le proposizioni non fattuali esprimono solo le emozioni, i sentimenti, le
credenze concernenti il senso ultimo della vita e le valutazioni morali, scrive tuttavia che, proprio per questo, esse hanno comunque un senso e una funzione. Infatti,
per il “secondo” Wittgenstein, il quale ha rinunciato al “mito” dell’unicità della nozione di significato, le asserzioni valutative, pur non potendo veicolare conoscenze,
trovano una caratteristica qualificante proprio nella loro capacità di esprimere l’inesprimibile. A parere di Ayer, invece, solo le asserzioni verificabili possiedono
significato, mentre tutte le altre proposizioni vivono nel regno dell’insignificanza:
L’analisi del significato dei termini etici svolta da Ayer si regge sull’assunzione dell’esistenza di un’unica dimensione del significato; questa assunzione si accompagnava con un interesse del tutto estrinseco e secondario per
l’etica [. . . ]. L’emotivismo di Ayer, quindi, ben lontano dal proporsi di rendere conto della natura del discorso etico, sembrava invitare ad occuparsi di
altro.8
Viste le conclusioni radicali dell’analisi di Ayer, non stupisce che anche un
autore emotivista come C.L. Stevenson abbia affermato che tali posizioni impediscono una compiuta indagine sull’etica e sul significato dei termini morali:
Le migliaia di problemi etici che accompagnano la vita di ogni giorno, anche
se possono essere confusi in questo o quel particolare, non lo sono al punto
da far perdere la speranza di una chiarificazione. Essi possono generare un
disaccordo di atteggiamento; ma se questo differisce dal disaccordo delle
scienze pure, non per questo esso è indicativo di “pseudo-problemi” in un
senso che faccia pensare a una disfatta dell’intelligenza.9
Per questa ragione la riflessione di Ayer è stata altresì accusata di incoraggiare
il disinteresse morale, tanto che l’autore, nei Philosophical Essays del 1945, ha
replicato:
Non sto dicendo che le proposizioni della morale sono prive di importanza [. . . ]. Questo sarebbe esso stesso un giudizio di valore che non ho mai
espresso e non desidero esprimere [. . . ]. La [mia] teoria risiede interamente a livello dell’analisi; è un tentativo di mostrare quel che le persone fanno
quando esprimono giudizi morali; non è un insieme di suggerimenti relativi
a quali giudizi morali esse devono esprimere [. . . ]. Tutte le teorie morali, intuizioniste, naturalistiche, oggettivistiche, emotiviste e quel che rimane,
sono neutrali rispetto alla condotta effettiva. Per parlare tecnicamente, esse
appartengono al campo della meta-etica, non propriamente all’etica.10
8
E. Lecaldano, Le analisi del linguaggio morale, Edizioni dell’Ateneo, Roma 1970, p. 128.
C.L. Stevenson, Ethics and Language, Yale University Press, Yale 1944 (tr. it. Etica e
Linguaggio, a cura di S. Ceccato, Longanesi, Milano 1962, p. 348).
10 A.J. Ayer, Philosophical Essays, Macmillan, New York 1945, p. 245 (tr. it. nostra), corsivo
nostro.
9
4
ITINERA – Rivista di Filosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura
Attraverso tali parole pare trasparire una diversa valutazione delle proposizioni dell’etica. In sostanza, sembrerebbe dire Ayer, la riflessione sull’etica non ha
senso se pretende di fondare gli enunciati della moralità pratica, ossia quelli che
regolano la condotta umana, mentre possiede senso come metodologia d’indagine
metaetica, in coerenza con i caratteri della stessa etica analitica. Egli in tal modo
si pone come un sostenitore della neutralità della metaetica, ossia della necessità,
all’interno della riflessione generale sulla morale, di non “parteggiare” per nessun
modello di etica normativa.
Nondimeno non sembra che l’intento della citazione tratta dai Philosophical
Essays sia realmente questo; infatti, a ben vedere, la precisazione di Ayer non
ha valore esclusivamente metodologico, ma ne possiede uno sostanziale che non
modifica la sua opinione rispetto al ruolo dei giudizi valutativi. Attraverso le sue
parole, Ayer pone infatti l’accento sulla più rilevante valenza teoretica che assume l’analisi metaetica. Tuttavia, da questo punto di vista, egli non asserisce nulla
di nuovo, poiché tale posizione è vicina a molte delle riflessioni sull’etica a lui
coeve e successive le quali però, pur giovandosi di alcune asserzioni dell’emotivismo, saranno fortemente critiche con le sue conclusioni radicali. Per esempio,
un autore come Hare ritiene primario lo studio della metaetica per poter fondare
l’etica secondo canoni logico-linguistici; Ayer invece propone l’esclusivo studio
della metaetica perché ritiene il discorso etico normativo insignificante. Pertanto
non sembra corretto parlare di un ripensamento da parte di Ayer delle proprie posizioni, anche perché, leggendo tra le righe della citazione riportata, l’autore non
sembra aver mutato in modo significativo la sua posizione rispetto a quanto asserito
anni prima.
Non si deve però pensare che l’emotivismo abbia con la sua riflessione impedito ogni successiva riflessione sull’etica. Al contrario, soprattutto nella versione
moderata di Stevenson, esso ha influenzato la piena affermazione del non cognitivismo etico, il quale caratterizzerà buona parte della successiva riflessione metaetica11 , la quale accetta l’idea per cui l’etica non è una forma di conoscenza.
L’emotivismo inoltre ha avuto il merito di chiarire cosa significhi giudizio descrittivo e in cosa esso si differenzi da un giudizio valutativo, contribuendo a mettere
ordine nel linguaggio morale e, forse senza volerlo, a favorirne lo studio12 .
Esiste dunque anche un emotivismo definibile “moderato”, elaborato soprattut11
Il cognitivismo etico può essere definito come quella dottrina secondo la quale un enunciato
morale possiede condizioni di verità che sono almeno in un caso soddisfatte. Secondo i cognitivisti,
l’etica può costituirsi come un corpo di conoscenze (alla pari della scienza), perché le sue asserzioni
affermano proprietà che hanno un’esistenza oggettiva e che possono essere giudicate vere o false in
base a determinati criteri. Il non cognitivismo invece nega proprio questo fatto, sostenendo che le
proposizioni morali non sono suscettibili di vero-falsità.
12 L’approccio non cognitivista spesse volte si è unito a una precisa distinzione delle asserzione fattuali da quelle di valore, per evitare la “fallacia naturalistica”, di cui Moore parla nei Principia, a suo
parere derivabile dal celebre paragrafo del Libro III del Treatise on Human Nature di Hume, secondo
il quale non è possibile passare, senza ulteriori spiegazioni, dall’essere al dover essere. La distinzione
tra fatti e valori è stata però molte volte messa in discussione, cfr. per esempio il recente H. Putnam,
Fatto/valore. Fine di una dicotomia, a cura di G. Pellegrino, Fazi Editore, Roma 2004.
5
ITINERA – Rivista di Filosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura
to dal filosofo statunitense Stevenson, il quale fin dal 1937, con la pubblicazione
sulla rivista Mind dell’articolo “The Emotive Theory”, aveva voluto attenuare la carica dell’emotivismo di Ayer, sostenendo che le proposizioni dell’etica possiedono
un significato parzialmente descrittivo, ma soprattutto emotivo. La posizione di
Stevenson si differenzia da quella di Ayer sia per l’influsso del pragmatismo americano, sia per la convinzione che si possa studiare il funzionamento del linguaggio
morale. Come sintetizza G.J. Warnock, Stevenson si domanda se
forse l’uso del linguaggio, nel discorso relativo alla morale, sia solo in parte
finalizzato all’asserzione di fatti. Così C.L. Stevenson è stato condotto a scrivere, in Mind nel 1937, che «la più importante funzione [dei giudizi morali]
non è di indicare fatti, ma di influenzare»; l’uso del linguaggio che noi qui
troviamo in realtà non è “descrittivo”, bensì “dinamico”; nel dire ad un interlocutore che una tale cosa è buona, o giusta, o che dobbiamo farla, non sto
asserendo per nulla un fatto vero o falso [. . . ] ma sto cercando di influenzare
i suoi interessi o, in maniera più ampia, le sue attitudini.13
Nella sua opera principale, Ethics and Language (pubblicata a New York nel
1944), l’autore afferma di ritenere possibile, a differenza di Ayer, un’analisi metodologica sulla funzione e sul significato delle proposizioni etiche. A ogni modo,
anch’egli sostiene che un’analisi dell’etica non debba esaurirsi nella definizione di
un’etica normativa, ossia di precetti per la condotta14 , poiché essa deve prima chiarire il metodo attraverso il quale tali questioni normative devono essere discusse e
affrontate, chiarendo il significato delle loro espressioni:
Uno studio di questo genere ha lo stesso rapporto con l’etica normativa [. . . ]
che l’analisi concettuale e il metodo scientifico hanno con le scienze; e, come nessuno si aspetta che un’opera sul metodo scientifico svolga l’attività della scienza stessa, così non dobbiamo attenderci di trovare qui alcuna
conclusione che ci dica quale condotta è giusta e quale sbagliata.15
Va ricordato a ogni modo che Stevenson non disconosce in toto le sue affinità
con alcune tesi del positivismo logico, giacché asserisce che gli attacchi che sono stati condotti contro le posizioni emotiviste espresse, seppure in forme diverse,
da Ayer, Carnap e Russell, «dimostrano più intolleranza che comprensione». Egli
infatti pensa che questi autori, pur mettendo in discussione la pretesa dell’etica di
porsi come una teoria extra-scientifica, non avrebbero avuto intenzione di screditare l’etica in sé stessa, né le riflessioni su di essa. Infatti, «dire che i giudizi etici
13
G.J. Warnock, “Ethics and Language”, in Id., Morality and Language, Basil Blackwell,
London 1983, p. 149 (tr. it. nostra).
14 È questo un caposaldo dell’etica analitica, già definito da Moore: «Finché l’etica si limita a
dare elenchi di virtù e anche a dare un nome alle parti costitutive dell’ideale, non può distinguersi
dalla casistica [. . . ]. Ma il principale obiettivo dell’etica come scienza sistematica è di fornire ragioni
corrette per pensare che una cosa o un’altra è buona; e se non si risponde alla nostra domanda, tali
ragioni non si possono dare» (Principia Ethica, a cura di G. Vattimo, Bompiani, Milano 1964, cap. I,
§§ 4 e 5).
15 C.L. Stevenson, Etica e Linguaggio, cit., p. 15.
6
ITINERA – Rivista di Filosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura
esprimono sentimenti non comporta che si debbano inibire tutti i sentimenti, dire che i giudizi etici non sono ‘né veri e né falsi’ non è sostenere [. . . ] che sono
fatti a capriccio, ignorando se stessi, la natura e le conseguenze dell’oggetto che
viene giudicato»16 . In realtà, questa è una difesa d’ufficio, poiché la vicinanza di
Stevenson al positivismo logico è piuttosto effimera: i tratti in comune sono profondamente generici e consistono nell’ammettere un’autonomia del discorso etico
rispetto al discorso descrittivo e nel collegare l’etica con le emozioni. Tuttavia,
al di là di questa radice comune, Stevenson, giunge in modo significativo a riconoscere la presenza di una componente di significato descrittivo negli enunciati
etici.
Una fondamentale differenza tra Stevenson e l’emotivismo radicale, risiede nel
fatto per cui egli assegna un determinato significato ai termini etici, ossia la convinzione per cui esiste un linguaggio della morale. Per Stevenson le proposizioni
morali sono infatti caratterizzate da una forma peculiare di significato, il significato
emotivo, il quale «diviene uno strumento raffinato che ci permette di rintracciare
sottili distinzioni e di costruire una mappa graduata e articolata degli usi emotivi»17 . L’argomentazione di Stevenson sembra giungere ai suoi risultati più efficaci
proprio quando, all’interno della nozione generale di significato, descrive i caratteri del significato emotivo, il quale caratterizza i giudizi valutativi, distinguendoli
da quelli descrittivi.
L’autore «sostiene che i giudizi valutativi, sebbene non fattuali e descrittivi,
hanno [. . . ] un significato emotivo, che serve ad orientare gli atteggiamenti dell’interlocutore ed esprimere i propri»18 . Tale significato, come quello di tutti gli
altri termini del linguaggio, si determina in virtù della funzione che esso svolge
nel discorso. Pertanto, è vero che a volte i termini valutativi possono avere anche
un significato descrittivo, ossia fattuale, ma allora in quel caso non ci troveremo
di fronte a un giudizio valutativo, bensì a un termine emotivo utilizzato descrittivamente (per esempio in proposizioni del tipo “l’oggetto X è buono”, quando X è
una macchina o un elettrodomestico che funziona bene. In questo caso il termine
“buono”, pur rimanendo valutativo, non esprime alcun giudizio morale). Pertanto:
Il significato emotivo di una parola sta nel potere che la parola acquista, in
seguito alla sua storia in situazioni emotive, di richiamare o di esprimere direttamente gli atteggiamenti, come fatto distinto, da quello di descriverli e di
16 Ibid., p. 347. A p. 348 l’autore scrive inoltre: «Speriamo di rendere chiaro che ‘emotivo’ non
porta di per sé alcun significato emotivo spregiativo».
17 E. Lecaldano, op. cit., p. 135.
18 C. Bagnoli, “Etica”, in F. D’Agostini, N. Vassallo (a cura di), Storia della filosofia analitica,
Einaudi, Torino 2002, p. 305. Già Hume aveva colto la natura persuasiva di alcune parole morali e la
sua argomentazione, nelle sue linee generali, può essere vicina a quella svolta da Stevenson a proposito della “definizione persuasiva” (cfr. Etica e linguaggio, cit., pp. 272-297). Tuttavia, la vicinanza
con Hume si ferma qui, poiché nella riflessione dell’autore scozzese manca un’analisi dei significati
dei termini etici. Peraltro, l’attribuzione a Hume di una posizione emotivista ante-litteram è fuorviante, mentre quella che gli attribuisce un generico orizzonte “sentimentalista” andrebbe meglio
precisata (cfr. J.L. Mackie, Hume’s Moral Theory, Basil Blackwell, London 1980).
7
ITINERA – Rivista di Filosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura
designarli [. . . ] In virtù di questa specie di significato, i giudizi etici modificano gli atteggiamenti, non facendo appello a forze di cui si è consapevoli
(come avviene per gli imperativi), ma mediante il meccanismo, meno rigido,
della suggestione.19
Le proposizioni imperative hanno la primaria funzione di orientare la condotta
e i fini dell’uomo: certamente esse possono anche descrivere fatti o situazioni, ma
in genere non è questa la ragione per la quale sono pronunciate. Ed è proprio in virtù di queste convinzioni che Stevenson può dunque sostenere che un’affermazione
come “Questo è bene” significa: “Io approvo questo; fa’ altrettanto”20 . Pertanto,
un giudizio valutativo ha un autonomo significato e chi lo esprime si propone di
convincere chi lo ascolta a fare o a credere a quello che egli fa o crede, attraverso
l’espressione di un proprio sentimento. Dunque la primaria funzione di un giudizio morale è di persuadere chi ascolta, senza tuttavia ricorrere alla coercizione
o alla propaganda. Il discorso etico, dunque, non segue stabili modelli oggettivi,
ma è in sostanza legato alla capacità del soggetto di influenzare l’altro, attraverso
l’equivalenza fra l’espressione “Io approvo X ” la quale sottintende l’espressione:
“Fai altrettanto”. Ciò non mostra soltanto che l’etica è diversa dalla scienza, giacché per Stevenson l’espressione “scienza etica” sarebbe senza senso, ma anche che
«è possibile solo una metaetica come filosofia analitica, che verta sui discorsi di
etica [. . . ]. Le varie etiche non sono che tecniche più o meno complesse e raffinate, di operare sull’emotività degli uomini, profittando dei loro condizionamenti
psico-sociali e soprattutto linguistici»21 .
Per queste ragioni, Stevenson è convinto di poter percorrere un’altra strada
rispetto agli emotivisti radicali, dato che non nega legittimità al discorso morale.
Infatti, egli afferma che «è più corretto e istruttivo dire che un giudizio etico può
essere vero o falso, e far notare che la sua verità descrittiva può essere insufficiente
per sostenere le sue ripercussioni emotive»22 , perché, a suo parere, se è vero che
le discussioni sull’etica sono in genere prive del rigore e della razionalità di quelle
scientifiche, ciò non significa che esse siano sempre irrazionali e dogmatiche. Esse
hanno senso proprio perché le loro proposizioni sono caratterizzate dal possesso di
quel significato, non descrittivo, bensì emotivo.
Un’altra differenza fondamentale risiede infine nella diversa valenza che Ayer
e Stevenson attribuiscono al disaccordo morale. L’autore americano, infatti, dedica
una disanima accurata a tale disaccordo (la cui reale esistenza era invece negata da
Ayer), affermando che esso è di due generi: il disaccordo sulle credenze, il quale riguarda la mancata intesa relativamente alle convinzioni su un certo fatto ed è
frequente anche nelle scienze esatte («chiamiamo ‘disaccordo di credenza’ [. . . ] il
contrasto che sorge fra due uomini, di cui l’uno crede che la risposta sia p, l’altro
non-p, o qualche altra proposizione incompatibile con p»); e il disaccordo di at19
C.L. Stevenson, Etica e linguaggio, cit., pp. 55-56.
Ibid., p. 41.
21 E. Riverso, La filosofia analitica in Inghilterra, Armando Editore, Roma 1970, pp. 245-246.
22 C. Stevenson, Etica e linguaggio, cit., p. 349.
20
8
ITINERA – Rivista di Filosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura
teggiamento che coinvolge appunto gli atteggiamenti e le convinzioni più profonde
dei parlanti («si dirà che due uomini sono in disaccordo di atteggiamento, quando
hanno atteggiamenti opposti nei riguardi di uno stesso oggetto: ad esempio, l’uno
lo approva e l’altro lo disapprova»). Come scrive ancora l’autore: «Le due specie di disaccordo differiscono [. . . ] in quanto la prima riguarda il modo in cui si
debbano effettuare descrizioni e spiegazioni vere delle cose, la seconda riguarda
l’approvazione o la disapprovazione ad esse dovuta e quindi il modo in cui esse
debbano essere dirette dagli sforzi degli uomini»23 . A volte, può capitare che vi sia
accordo sulle credenze, ossia su certi fatti o situazioni, ma non sugli atteggiamenti da assumere nei loro confronti. Per esempio, A e B possono essere d’accordo,
in generale, sulla negatività di un fatto come la guerra, ma mentre le convinzioni più profonde di A spingono quest’ultimo a ritenere l’intervento armato sempre
un’azione sbagliata, B può pensare che, in certi casi, il ricorso alla forza sia legittimo. A e B in questo caso credono una cosa simile, ma non derivano da tale comune
credenza un medesimo atteggiamento. Il disaccordo di atteggiamento è molto più
radicato e difficile da risolvere rispetto a quello sulle credenze: mentre infatti quest’ultimo si può comporre in modo razionale, molto più complessa e problematica
è invece la composizione del disaccordo di atteggiamento. Questo genere di disaccordo, infatti, coinvolge i desideri, le preferenze e le convinzioni più radicate
delle persone che esprimono giudizi valutativi e può essere risolto solo attraverso
un’opera di persuasione (la quale va ben distinta dalla propaganda politica) che è,
a parere di Stevenson, il vero scopo del filosofo morale24 .
La proposta di Stevenson ha avuto il merito, secondo molti autori a lui successivi, di rafforzare le innovative asserzioni dell’emotivismo, limitandone gli esiti che
negavano la significatività del discorso morale e sostenevano un approccio soggettivista. La sua riflessione tuttavia ben presto, per ammissione dello stesso autore,
ha incontrato delle difficoltà legate essenzialmente alla sua particolare concezione
del significato. Il problema è che il significato emotivo non assicura la possibilità di sostenere in modo certo che il termine dotato di quel significato è utilizzato
emotivamente. In altre parole, sembra mancare un criterio chiaro per distinguere,
all’interno dei contesti linguistici, i vari generi di significato, i quali evidentemente
si intrecciano.
Secondo Stevenson, il significato emotivo di un termine ricorre quando questo
termine è utilizzato per raccomandare qualcosa e dunque esprime i sentimenti del
parlante; tuttavia, spesso un termine di questo tipo possiede anche un significato
descrittivo, il quale può confondersi con quello emotivo. In realtà, le asserzioni fat23
Ibid., pp. 18-19.
Per Stevenson ha dunque senso occuparsi del disaccordo morale e del ruolo che, all’interno
del linguaggio morale, viene svolto dai termini etici. È questa forse la più significativa differenza
rispetto ad Ayer, il quale era stato anche accusato di favorire il disinteresse morale, in un’epoca storica
(si pensi alle dittature affermatesi in Europa e all’imminente guerra mondiale) nella quale l’idea
dell’impegno diretto degli individui appariva una sorta di improrogabile dovere morale. Lo stesso
Russell, di fronte al pericolo del relativismo morale implicito nelle sue posizioni, le aveva riviste,
abbandonando negli anni Quaranta il soggettivismo radicale.
24
9
ITINERA – Rivista di Filosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura
tuali per Stevenson sono nettamente distinte da quelle etiche, ma come giustificare
questa distinzione? Stevenson ad esempio nota che un termine come coraggioso
è ibrido, poiché il suo significato ha nello stesso tempo una componente fattuale
e una componente valutativa e anzi, essendo in genere utilizzato per riferire fatti lodevoli, esso alla fine sembra possedere solo il significato descrittivo, giacché
quello valutativo appare implicito in esso. Stevenson deve riconoscere di non essere in grado di spiegare in base a quali criteri i termini morali possiedono un
peculiare significato che li differenzia da quelli descrittivi.
Tale difficoltà di Stevenson è ascrivibile alla sua concezione psicologica del
significato, concezione che lo allontana dalla tendenza che invece in quel periodo si stava affermando, ossia la concezione del significato come uso: «Stevenson
[. . . ] rifiuta la concezione del significato come raffigurazione e interpreta invece il
significato di una espressione come la sua tendenza o disposizione a causare o ad
essere causa di certi stati o processi mentali»25 . Secondo Stevenson le espressioni
“buon vino” e “buon uomo” possiedono entrambe significato emotivo, in quanto possono essere utilizzate, almeno potenzialmente, per persuadere chi ascolta,
suscitando in lui un sentimento, una reazione psicologica, di approvazione (o disapprovazione). In realtà, si deve osservare che l’espressione “buon vino” ha una
valenza inferiore e una funzione molto diversa rispetto a “buono uomo”: dunque,
sebbene le reazioni psicologiche da esse suscitate possono essere formalmente paragonabili, ben diversa è la funzione sostanziale del termine “buono”, il quale di
solito, se detto di un vino, descrive un fatto o al massimo una valutazione estetica,
mentre se applicato al termine “uomo” esprime una ben più cogente asserzione morale che può essere indipendente dal desiderio di persuadere chi ascolta sulla bontà
di un certo comportamento. Quello che sfugge a Stevenson, in altri termini, è che
ciò che è fondamentale non sono tanto le reazioni emotive causate dall’espressione
“X è un uomo buono”, bensì la questione se tale enunciato è in grado di motivare
l’interlocutore ad adottare la condotta di X , non in virtù della sola suggestione (la
quale può anche essere assente), ma perché gli vengono fornite ragioni in favore
del comportamento di X 26 .
Se si rimane legati a una concezione psicologica del significato, si può concludere che entrambe le espressioni fanno riferimento a una convinzione interiore,
soggettiva, ma sarebbe difficile sostenere che hanno anche un significato differente
e quando l’uno predomina sull’altro. Al contrario, una concezione del significato inteso come uso, ossia influenzata dal contesto linguistico nel quale il termine ricorre, permette una maggiore distinzione dei termini. «Lo stesso Stevenson
[. . . ] è costretto ad ammettere che laddove la sua analisi si arresta, quella di chi
25 E. Lecaldano, op. cit., p. 136. Con le parole di Stevenson: «Una disposizione del segno a
influenzare l’ascoltatore va chiamata ‘significato’ [. . . ] soltanto se essa è stata causata, e non avrebbe
potuto svilupparsi senza, da un elaborato processo di condizionamento che ha accompagnato l’uso
del segno nella comunicazione» (Etica e linguaggio, cit., p. 85).
26 Per questo motivo R. Hare parlerà di significato prescrittivo, il quale indica una condotta razionale. Per una recente analisi dell’uso delle “ragioni morali” cfr. T. Scanlon, What We Owe to Each
Other, Harvard University Press, Cambridge 1998, pp. 96-98.
10
ITINERA – Rivista di Filosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura
concepisce il significato come un fatto dipendente dalle regole d’uso può ancora
andare avanti»27 .
Questo breve profilo dell’emotivismo etico ha voluto rendere conto di un momento dello sviluppo dell’etica analitica anglosassone: tale momento, pur avendo
esaurito i suoi effetti, è stato significativo in quanto ha favorito l’affermazione di
un modello di argomentazione morale che caratterizzerà una parte della filosofia
morale contemporanea. In particolare, soprattutto la posizione di Stevenson ha
contribuito a evidenziare alcuni concetti che autori successivi svilupperanno: a)
la distinzione netta tra i metodi argomentativi dell’etica e quelli conoscitivi della scienza, per cui l’etica non è una forma di conoscenza (il non cognitivismo);
b) la neutralità dell’analisi metaetica, nelle cui argomentazioni devono essere assenti riferimenti individuali; c) la possibilità, sviluppata da Hare in particolare, di
essere d’accordo con l’idea secondo cui i termini morali non possiedono significato conoscitivo, sostenendo però che essi possiedono un tipo di significato unico
e peculiare, ossia il significato prescrittivo, che oltrepassa e arricchisce la già innovativa idea di Stevenson di significato emotivo. Scrive infatti Hare: «dobbiamo
ammettere la validità di molto di quel che è stato affermato dai verificazionisti; vi
è il significato descrittivo, e la proposizione lo deve possedere, se essa è utilizzata
per determinati propositi, come il comunicare ordini o informazioni»28 . Egli infatti
rammenta che decisivo nella riflessione emotivista è il rigetto di ogni forma di descrittivismo in campo etico, in una forma che lo stesso Moore aveva teorizzato: «ho
cominciato la mia carriera come filosofo morale cercando di confutare gli emotivisti, il cui irrazionalismo non potevo accettare. Ma, a differenza della gran parte
dei loro oppositori, io compresi che l’errore [dell’emotivismo] era l’irrazionalismo,
non il ‘non descrittivismo’»29 . Tali presupposti condurranno Hare a sviluppare un
modello di etica normativa di stampo utilitarista come a voler dimostrare, dal suo
punto di vista, la fecondità di quella concezione dell’etica che l’emotivismo aveva
giudicato senza significato e dunque sterile.
In ultimo è opportuno segnalare l’interessante critica che A. MacIntyre ha condotto contro la metaetica analitica. MacIntyre ritiene che tutta l’etica analitica non
sia altro che uno sviluppo dell’emotivismo, di cui amplia gli errori: egli sostiene
che l’emotivismo è ammissibile come teoria sull’uso del linguaggio morale in determinate circostanze, ma non è accettabile come teoria del significato morale, in
quanto esso, alla pari della metaetica analitica, rende la discussione morale infinita
e improduttiva, misconosce l’identità dell’io e il valore dell’identità personale e,
per questo, non riconosce la nozione di “responsabilità” dell’agente30 . Forse l’equiparazione tra metaetica analitica ed emotivismo è forzata, in quanto, soprattutto
27
E. Lecaldano, op. cit., p. 187.
R.M. Hare, Practical Inferences, Macmillan, London 1971, p. 10 (tr. it. nostra).
29 Id., “Comments”, in D. Senior, N. Fotion (a cura di), Hare and Critics, Clarendon Press,
Oxford 1988, p. 209 (tr. it. nostra).
30 Cfr. A. MacIntyre, After Virtue. A Study in Moral Theory, University of Notre Dame Press,
Notre Dame (Indiana) 1984 (tr. it. Dopo la virtù. Saggio di teoria morale, a cura di P. Capriolo,
Feltrinelli, Milano 1988; in particolare il cap. 1).
28
11
ITINERA – Rivista di Filosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura
con la riflessione di Hare, questo orizzonte di studio si è maggiormente volto verso
il recupero di una dimensione pratico-normativa. Tuttavia, MacIntyre pone un problema reale, domandandosi quanto un’analisi semantica delle proposizioni morali
possa poi effettivamente consentire lo sviluppo di un’etica realmente in grado di
influenzare la condotta.
12