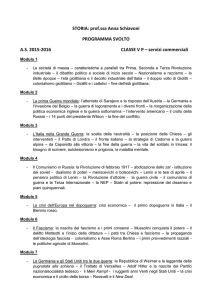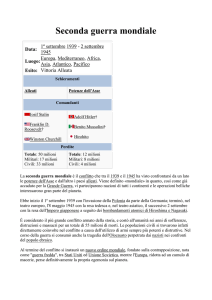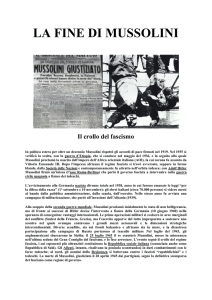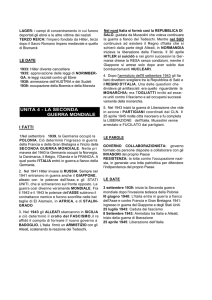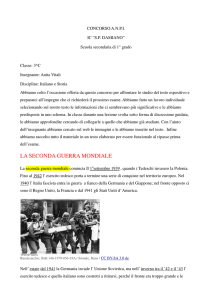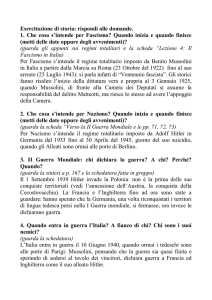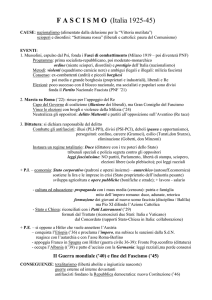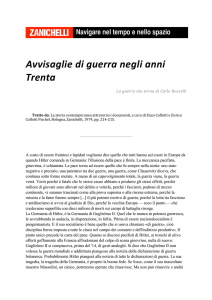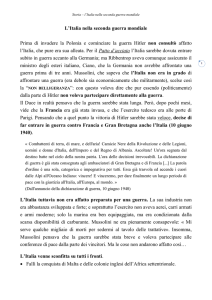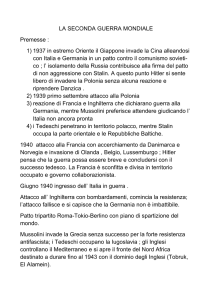08
SETTEMBRE
Il fascismo, la guerra e l’armistizio
Francesco Maria Feltri
CONSAPEVOLEZZA
MEMORIA
Cittadinanza
CONSAPEVOLEZZA
MEMORIA
Cittadinanza
Percorsi e temi di storia, per sentirsi cittadini
in Europa, in Italia e in Emilia Romagna
A cura di
Francesco Maria Feltri
Elenco dei volumi
Modulo 1: 1° maggio, La festa del movimento operaio
Modulo 2: 4 novembre, La memoria della prima guerra mondiale
Modulo 3: 28 ottobre 1922, La marcia su Roma
Modulo 4: 8 settembre, Fascismo, guerra e armistizio
Modulo 5: 8 maggio, La fine della seconda guerra mondiale
Modulo 6: 25 aprile, La festa della liberazione
Modulo 7: 27 gennaio, La giornata della memoria
Modulo 8: 2 giugno, La nascita della Repubblica
Modulo 9: 10 febbraio, Giorno del ricordo
Modulo 10: 8 marzo, La festa della donna
Modulo 11:
25 novembre, Giornata internazionale
per l’eliminazione della violenza contro le donne
INTRODUZIONE GENERALE
Un nuovo inizio per la comunità:
gli eventi frattura radicale
All’inizio del XVI secolo, Niccolò Machiavelli era convinto che
la storia fosse una specie di grande illusione, un errore di prospettiva. I continui rivolgimenti, che investono il mondo della
politica, potrebbero indurci a pensare che il mutamento sia l’aspetto più vero ed ultimo della vicenda umana; per il pensatore
politico fiorentino, al contrario, in ultima analisi non c’è alcun
cambiamento davvero sostanziale. Siamo di fronte a increspature provvisorie, prive di conseguenze radicali, non ad autentiche e decisive fratture storiche.
Per Machiavelli, la storia non è molto diversa dalla realtà naturale: certo, ogni estate, nel campo si raccolgono spighe differenti da quelle degli anni precedenti. Il procedimento, però,
è sempre quello, ciclico e ripetitivo, e non c’è spazio per alcuna significativa novità. Per usare un’altra metafora, si potrebbe pensare ad un palcoscenico: cambiano gli attori e le prime
donne; mutano i fondali e le ambientazioni. Eppure, la commedia rappresentata è sempre la stessa: e per di più, secondo Machiavelli, non è una commedia, bensì una tragedia, i cui ritmi e
movimenti sono dettati dalla spietata natura degli esseri umani,
decisamente più inclinata verso il male che verso il bene.
Nel corso del XIX secolo, comunità nazionali, Stati e associazioni politiche di diversa natura incominciarono ad appropriarsi
del tempo. Fino ad allora, il tempo era stato monopolio della
Chiesa, che lo aveva strutturato secondo un preciso calendario
liturgico. A scadenze periodiche, il fedele incontrava delle precise ricorrenze e festività (Natale, Pasqua, Pentecoste…), che
gli permettevano di fare memoria dei principali eventi della vita
di Cristo o della Chiesa delle origini, e quindi di riscoprire con
rinnovata freschezza la propria identità di cristiano.
A partire dall’Ottocento, mentre si affermava la Nazione, come
II
INTRODUZIONE GENERALE
nuova fonte di valori e destinatario di fedeltà assoluta (fino al
martirio), accanto al calendario liturgico cristiano – e in certi
casi contro di esso, in precisa e polemica alternativa – si impose
una serie di festività civili, che scandivano l’anno e spingevano
l’individuo a riflettere sulla sua identità di cittadino e/o di membro di una comunità nazionale.
Sia la Chiesa che le moderne comunità nazionali del XIX-XX
secolo si ispiravano ad una concezione della Storia e del tempo
diametralmente opposta a quella di Machiavelli. Pur focalizzando la loro attenzione su questioni molto diverse, autorità
ecclesiastiche e intellettuali sensibili al tema della nazione erano
convinti che nella storia si producessero alcuni eventi frattura
radicale, capaci spezzare l’opaca omogeneità della vicenda
storica. Le comunità umane che avevano fatto esperienza di
uno o più di tali eventi, da essi uscivano radicalmente trasformate. Proprio per questo, avevano bisogno di una festa, che ne
conservasse la memoria. Potevano essere esperienze traumatiche o felici, drammatiche o gioiose: comunque, non potevano
e non dovevano essere più dimenticate, perché era grazie a
quelle sconfitte o quelle vittorie, a quelle passioni o quelle resurrezioni, che la comunità si definiva nella propria identità più
autentica e duratura.
Ma la festa, civile o religiosa che sia, nel momento in cui spinge
a fare memoria, mette in moto un meccanismo che è diverso e
molto più forte del puro non dimenticare. Nel suo sforzo di essere efficace di fronte alla vicenda storica decisiva, la memoria
diventa attualizzante. In effetti, se l’evento ricordato è capace
di spezzare la storia, esso continua ad agire per sempre: la sua
onda lunga raggiunge anche noi, che viviamo anni o secoli
dopo l’evento. Insomma, tra comunità (religiosa o civile) e Storia si crea un circolo: per definire se stessa, la comunità deve
andare al passato e riscoprire l’importanza di quell’evento;
l’obiettivo, però, non è puramente archeologico: al contrario,
III
INTRODUZIONE GENERALE
grazie alla riflessione sul passato, si tratta di agire sul proprio
presente, illuminandolo di nuova luce, o meglio di speranze
e valori capaci di superare il tempo, di parlare ad ogni generazione e di ispirarne anche oggi l’azione, religiosa, morale o
politica.
Memoria e cittadinanza attiva
Diritti e democrazia non sono affatto qualcosa di ovvio, di normale, di scontato. Per certi versi, anzi, nel terribile panorama
della storia sono l’eccezione: realtà fragili che sono state conquistate dopo innumerevoli sforzi e che, soprattutto nel Novecento, sono state infrante da progetti totalitari di vario tipo e di
vario genere.
Malgrado tutte le difficoltà, le sconfitte e i ritorni all’indietro,
non è vero che nella storia non è mai cambiato nulla. Anche se
i grandi progetti utopici, di qualunque matrice ideologica, sono
tutti falliti, dopo avere provocato milioni di morti e disastri materiali incalcolabili, non è stato tutto inutile. La storia non è solo
un computo di vittime, di un tipo o dell’altro. Senza indulgere
ad alcun facile ottimismo, o cedere all’ingenua concezione secondo cui saremmo giunti alla fine della Storia e al migliore dei
mondi possibili, è comunque vero che i cittadini e le cittadine di
oggi possono condurre un’esistenza più libera e ricca di opportunità, rispetto a coloro che sono vissuti in altre epoche storiche.
Nulla va dato per scontato o per definitivamente acquisito.
Diritti e democrazia – lo ripetiamo – sono conquiste fragili e
deteriorabili. Proprio per questo, a nostro parere, necessitano
di una sempre maggiore consapevolezza, che a sua volta può
emergere solo dalla memoria, cioè dalla riflessione storica.
Anche ai giorni nostri, tale memoria tende ad organizzarsi intorno a degli eventi di forte impatto emotivo e simbolico; le
celebrazioni ufficiali, però, talvolta li ricoprono di retorica e li
rendono distanti dai cittadini. Paradossalmente, insomma, le ri-
IV
INTRODUZIONE GENERALE
correnze possono ottenere l’effetto opposto, rispetto al fine originario per cui sono nate. La riflessione storica vorrebbe essere
più sobria, più obiettiva, più scarna; proprio per questo, forse,
riuscirà a far emergere di nuovo il significato di svolta epocale
di questo o quell’evento.
Se non si trasforma in spregiudicato strumento ideologico (è
questo, infatti, il principale limite del cosiddetto uso pubblico
della Storia), la conoscenza storica può rendere il cittadino
pienamente consapevole dei propri diritti e dei propri doveri,
nella misura in cui la riflessione sul passato aiuta a comprendere quanto i diritti stessi e la democrazia (in tutti i suoi aspetti,
regole comprese) sono il frutto di complesse (e quindi, spesso,
persino contraddittorie) vicende storiche, di lotte e di tragedie,
vissute (e subite) da chi ci ha preceduto. Sotto questo profilo,
il dovere morale e civile di fare memoria, per mantenere viva
l’importanza di tutte le libertà e le opportunità che ci è concesso
di vivere come cittadini, oggi è ancora più necessaria che nei
secoli passati.
Moduli per riflettere su storia
e cittadinanza
Il lavoro che proponiamo consisterà in alcuni moduli, ognuno
dei quali avrà la stessa struttura di base, anche se potrà variare
la quantità di materiale da cui verrà costituito.
Ogni modulo (materialmente, un libretto di un centinaio di pagine) tratterà un tema, o un problema, importante per la costruzione dell’identità collettiva e di una comune cittadinanza.
Il principio di base che informa l’intero lavoro è lo sforzo di intrecciare costantemente tre piani d’analisi: la dimensione internazionale (l’Europa e, talvolta, il mondo intero), la dimensione
nazionale (l’Italia), la dimensione locale (l’Emilia Romagna). Per
ogni tema, ai tre livelli citati, si cercherà di individuare almeno una vicenda significativa, che si è impressa nella memoria
V
INTRODUZIONE GENERALE
collettiva e che per un gruppo di cittadini è stata epocale, cioè
decisivo, nel caratterizzare la loro esistenza.
Scendendo in dettaglio, ogni modulo avrà la seguente struttura
ideale:
Dimensione internazionale
Scheda 1
Scheda 2
Scheda 3
Scheda
Dimensione nazionale di apertura:
Introduzione
ad un tema
Scheda 1
Scheda 2
Scheda 3
Dimensione regionale
Scheda 1
Scheda 2
Scheda 3
Anche se, in linea di principio, ogni modulo è autonomo, autosufficiente, concluso in se stesso, ciascun elemento ovviamente
dialoga con gli altri dai quali riceve ulteriore chiarezza e forza
di significato.
Buona lettura, a tutti i cittadini e le cittadine che vorranno seguirci nel nostro percorso.
F. M. F.
VI
Indice
Introduzione3
Dimensione internazionale:
La guerra di Hitler:
dalla Blitzkrieg a Stalingrado
Guerra lampo in Polonia e in Francia
L’invasione dell’URSS
La Germania verso la sconfitta
17
28
45
Dimensione nazionale:
La guerra del Duce:
dall’intervento alla disfatta
Non belligeranza e guerra parallela
La campagna di Russia
La caduta del fascismo
63
82
97
Dimensione locale:
La guerra, i fascisti, i tedeschi
I primi anni di guerra
Il fascismo bolognese, tra regime e RSI
Gli internati militari
117
128
148
3
9 Settembre 194
8 Settembre
Il fascismo, la guerra e l’armistizio
Introduzione
N
ella notte tra il 10 e l’11 luglio 1943, gli Alleati attaccarono la Sicilia con 150 mila uomini. Il 17 agosto, gli angloamericani erano padroni assoluti dell’isola. La gravità della
situazione era immediatamente risultata evidente al comandante in capo delle Forze Armate italiane, generale Vittorio
Ambrosio, che suggerì a Mussolini di chiedere ad Hitler che
all’Italia fosse permesso intavolare, il più in fretta possibile,
trattative di pace con gli anglo-americani. Il rifiuto di Mussolini
a procedere in questa direzione determinò la crisi definitiva
del fascismo. Infatti, il 25 luglio, il re Vittorio Emanuele III privò Mussolini del potere e diede al paese un nuovo governo.
Recatosi alla residenza reale per la consueta udienza, il Duce
si sentì dire dal sovrano che non era più il capo del governo e
che al suo posto, per quell’incarico, il re aveva già nominato il
maresciallo Pietro Badoglio. Mussolini, poi, fu arrestato e portato in una località segreta, in modo che non potesse dirigere
una reazione fascista diretta contro la decisione del re.
Alle 22.45 del 25 luglio, furono trasmessi due radiomessaggi
al popolo italiano, nei quali si annunciavano la destituzione
di Mussolini, la nomina di Badoglio a guida del governo e la
assunzione da parte del re del comando delle Forze Armate; nel
medesimo tempo, però, si dichiarava pure che la guerra continuava. Malgrado quest’ultima drammatica precisazione, i due
messaggi furono accolti con entusiasmo dalla popolazione; viceversa, non ci fu alcun tentativo di reazione fascista, neppure
da parte della milizia, la forza armata del partito e del regime.
Il governo Badoglio era un regime autoritario. Tutt’altro che
democratico, temeva, prima d’ogni altra cosa, che i partiti an-
3
8 settembre
tifascisti potessero approfittare della confusa situazione venutasi
a creare e che, sfruttando l’entusiasmo popolare, le forze di sinistra tentassero di dar vita a qualche moto rivoluzionario. A tal
fine, furono presi vari provvedimenti, fra i quali spicca l’ordine
di sparare sulla folla, in caso di tumulti sovversivi, <<anche
con mortai e artiglieria, senza preavvisi di sorta, come se si
procedesse contro il nemico>>.
Intanto, furono presi contatti con gli Alleati, per giungere ad
un armistizio, che venne firmato a Cassibile, in Sicilia, il 3 settembre. Il problema, a quel punto, era rappresentato dai tedeschi, i quali non avevano la minima intenzione di accettare
passivamente la capitolazione dell’Italia, né di lasciare il suo
territorio, nel caso di una pace separata conclusa dal governo
italiano con gli anglo-americani. Badoglio cercò a più riprese
di prendere tempo; gli Alleati, però, gli comunicarono infine
brutalmente che avrebbero reso nota l’avvenuta firma dell’armistizio. L’8 settembre 1943, Badoglio si rassegnò a diffondere
via radio la notizia che l’Italia aveva cessato le ostilità con la
Gran Bretagna e gli Stati Uniti. Il testo del comunicato lasciava
intendere che ci sarebbe stata una immediata e dura reazione
da parte tedesca; malgrado ciò, i comandanti dei vari reparti
dell’esercito furono lasciati del tutto privi di ordini e di indicazioni operative coerenti. Neppure a difesa di Roma fu presa alcuna
misura, in quanto il re e il governo, il 9 settembre, abbandonarono in segreto la capitale, rifugiandosi a Brindisi, appena
liberata dagli Alleati.
Seguendo un piano preparato da tempo dal Comando, le truppe tedesche affluirono sempre più numerose dal Brennero e,
con notevole rapidità, occuparono tutto il territorio nazionale.
La totale mancanza di direttive trasformò la situazione in un vero
e proprio caos generalizzato. La maggior parte dei reparti si disgregò completamente, assumendo quell’atteggiamento che la
formula: <<tutti a casa>>! riassume meglio di tante parole.
4
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
In Italia e nei Balcani, più di 700.000 militari italiani furono catturati dai tedeschi e deportati in Germania; sul territorio nazionale, la maggior parte dei soldati fu disarmata e fatta prigioniera senza avere la possibilità di reagire. Più tragica e concitata fu
la vicenda di molti reparti di stanza in Grecia, in Albania o sulle
isole dell’Egeo e dello Ionio; le truppe che scelsero di resistere
ai tedeschi dovettero affrontare duri combattimenti e la spietata
violenza dei tedeschi, che in alcuni casi fucilarono anche coloro
che si erano arresi. L’episodio più grave si verificò a Cefalonia,
tra il 15 e il 22 settembre: secondo Giorgio Rochat, dopo uno
scontro in cui morirono circa 200 soldati, altri 3.800-4.000
furono fucilati sull’isola, dopo la resa. Altri 1.360, caricati su
una nave tedesca, morirono annegati, a seguito di un bombardamento alleato che affondò l’imbarcazione. Secondo Mario
Torsello, nel complesso, in quelle settimane confuse e drammatiche l’esercito italiano ebbe complessivamente quasi 19.000
morti, tra caduti in combattimento e fucilati dai tedeschi.
Anche la marina e l’aviazione militare furono colte alla sprovvista dall’improvviso annuncio dell’armistizio. Secondo la marina
inglese, 133 unità della flotta passarono sotto il controllo alleato; tuttavia, il destino delle singole navi spesso fu determinato
dai comandanti, molti dei quali trovarono umiliante e disonorevole l’ordine di consegnarsi agli inglesi: piuttosto di ubbidire,
preferirono affidare la loro unità ai tedeschi o affondarla. È possibile che, in questo modo, sia andato perduto un centinaio di
navi. In altri casi, invece, le imbarcazioni militari furono distrutte
dagli aerei tedeschi: è il caso della corazzata Roma, ammiraglia
della flotta, che affondò con 1.253 marinai. Quanto agli aerei,
la maggior parte fu subito catturata dai tedeschi negli aeroporti:
su 800 velivoli, circa 200 raggiunsero i territori controllati dagli
Alleati.
Il 12 settembre 1943, un reparto di paracadutisti tedeschi liberò Mussolini, che era detenuto in un albergo nella zona del
5
8 settembre
Gran Sasso, in Abruzzo. Portato in Germania, il Duce ottenne
da Hitler il permesso di ricostruire uno stato fascista in Italia;
nacque pertanto la cosiddetta Repubblica Sociale Italiana (RSI),
il cui governo prese dimora in varie ville sulla costa del lago di
Garda: e poiché il ministero degli esteri, tenuto personalmente
da Mussolini, aveva sede nella cittadina di Salò, l’espressione
Repubblica di Salò venne ben presto utilizzata per indicare la
nuova realtà politica. In teoria, si trattava di uno Stato sovrano,
alleato della Germania; in pratica, si trattò di un semplice vassallo, privo di qualsiasi autonomia e sottomesso ad un pesante
regime di occupazione militare.
6
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
BADOGLIO ANNUNCIA L’ARMISTIZIO
L
’8 settembre 1943, gli italiani appresero della firma dell’armistizio da un breve comunicato radiofonico del generale
Badoglio. Molte persone pensarono che la guerra fosse finita.
In realtà, essa entrava in una nuova e più terribile fase, che
avrebbe direttamente coinvolto il territorio nazionale e la popolazione civile.
Il governo italiano, riconosciuta l’impossibilità di continuare l’impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell’intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla Nazione, ha
chiesto un armistizio al gen. Eisenhower, comandante in capo
delle Forze alleate anglo-americane.
La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle
forze italiane in ogni luogo. Esse, però, reagiranno ad eventuali
attacchi da qualsiasi altra provenienza.
(E. Collotti, La seconda guerra mondiale, Torino, Loescher,
1985, p. 112)
L’8 SETTEMBRE: LE REAZIONI DEGLI ITALIANI
E DEI TEDESCHI
L
’armistizio dell’8 settembre 1943 ha costituito per tutti gli
italiani che l’hanno vissuto un’esperienza esistenziale di eccezionale portata: nelle memorie individuali e in quella collettiva dell’intera nazione quel giorno è rimasto indelebile per
un’intera generazione (come lo fu a lungo Caporetto, per chi
7
8 settembre
visse la prima guerra mondiale). Tuttavia, come ha osservato giustamente lo storico italiano Claudio Pavone, <<ancora oggi considerare l’8 settembre come una mera tragedia
o come l’inizio di un processo di liberazione è una linea che
distingue le interpretazione di opposte sponde>>: quella filofascista e quella antifascista.
L’annuncio dell’armistizio fu salutato dalla maggioranza della
popolazione con un senso di sollievo e in alcuni casi addirittura
con entusiasmo, anche se non mancò chi vide nella resa agli
angloamericani una scelta umiliante e disonorevole. Il 10 settembre Piero Calamandrei notava nel suo diario: <<Rimango
sorpreso di sentire come è potente anche nella gente umile la
vergogna dell’armistizio>>. Molte testimonianze mostrano una
serie di reazioni che andavano dall’incredulità allo stupore, alla
gioia, e poi alla preoccupazione e allo smarrimento, a mano a
mano che la situazione reale, quella personale di ciascuno e
quella del paese, diveniva più chiara.
Questi sentimenti si succedettero in sequenza più o meno rapida
a tutti i livelli. Ancora una volta, come già era avvenuto il 25
luglio, la gente interpretò la decisione del governo Badoglio di
arrendersi come la fine della guerra. In molte città suonarono
le campane, si improvvisarono balli nelle piazze o più semplicemente bevute e pranzi tra amici e parenti. La maggioranza della
popolazione sperava che fosse finito tutto, che sarebbe tornata
la normalità, o almeno che non si sarebbe più sofferta la fame.
Le iniziali espressioni di contentezza e l’illusione di una conclusione indolore dell’avventura bellica fascista lasciarono ben presto
il posto alla preoccupazione per l’immediato futuro. Che cosa
avrebbero fatto i tedeschi? Sarebbero arrivati gli angloamericani?
La risposta non tardò molto, perché la reazione del Comando
8
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
germanico fu immediata, con l’attivazione del piano Achse, già
preparato da tempo, per l’occupazione delle città e per il <<disarmo a sorpresa, con ogni mezzo e senza il minimo scrupolo,
delle truppe italiane>>. È persino inesatto parlare di una reazione, perché si trattava in realtà dell’attuazione di un piano già predisposto. Infatti quando il 7 settembre si capì che ci sarebbe stato
uno sbarco angloamericano nell’Italia meridionale, il Comando
supremo della Wehrmacht si preparò a chiarire con un <<ultimatum politico e militare>> il rapporto con l’Italia, la cui uscita
dalla guerra era ritenuta imminente. Una nota elencava una serie
di richieste da presentare al governo di Roma: una loro mancata
accettazione avrebbe portato all’assunzione diretta della difesa
dell’Italia da parte tedesca e all’immediato disarmo delle truppe
dell’ex alleato. L’ultimatum doveva essere presentato indipendentemente dall’uscita dell’Italia dalla guerra e le truppe tedesche
erano già in stato di allarme. Così, mentre la maggioranza delle
forze armate italiane venne a conoscenza della firma dell’armistizio dall’annuncio alla radio, e fu quindi colta totalmente di sorpresa, le unità tedesche invece erano già preparate, come risulta
evidente dalla rapidità e dalla simultaneità delle loro iniziative.
Il Comando supremo delle forze armate del Reich emanò tra il 9
e il 15 settembre una serie di direttive, che un autore tedesco [=
lo storico Gerhard Schreiber – n.d.r.] ha definito criminali, sul trattamento da applicare ai soldati italiani. I militari ex alleati dovevano essere divisi in tre gruppi e ricevere un trattamento diverso
sulla base del loro atteggiamento di fronte alla proposta di continuare a combattere a fianco della Germania. Quelli che aderivano potevano conservare le armi ed essere trattati come i soldati
tedeschi; quelli che non volevano collaborare e non volevano
combattere dovevano essere mandati nei campi di internamento
in Germania o in altri paesi alleati, come prigionieri di guerra;
9
8 settembre
infine quelli che opponevano una qualche forma di resistenza o
che si schieravano apertamente con le forze partigiane e nemiche
avrebbero subito un trattamento diverso a seconda che fossero
ufficiali o semplici soldati: gli ufficiali che opponevano resistenza
o non ordinavano ai propri soldati di consegnare le armi dovevano essere fucilati come irregolari, mentre i soldati dovevano
essere impiegati come forza lavoro nei territori dell’Est europeo.
Nelle prime direttive si parlava di prigionieri di guerra; soltanto il
20 settembre, su ordine dello stesso Hitler, agli italiani catturati fu
attribuita la denominazione di internati militari, non tutelati quindi
dalle leggi internazionali, anche se questa decisione era del tutto
arbitraria dal punto di vista del diritto internazionale. […]
Da parte italiana il problema di che cosa fare si pose subito per
i presìdi dell’esercito sparsi in tutta la penisola e per le divisioni
che occupavano la Jugoslavia, la Grecia e l’Albania. Il proclama di Badoglio escludeva una resistenza organizzata e lasciava
i comandi senza direttive. L’accenno alla reazione a <<eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza>> si riferiva ovviamente ai tedeschi, ma escludeva un’iniziativa italiana, mentre
[…] l’abitudine a un atteggiamento passivo e l’incapacità dei
comandanti di assumersi responsabilità ebbero effetti disastrosi. Dopo aver inutilmente aspettato ordini da Roma, una buona
parte dei generali e degli ufficiali superiori delle varie unità se
ne andò alla chetichella. In molti casi i soldati furono consegnati
[= obbligati a rimanere – n.d.r.] nelle caserme, dove poi furono
bloccati e catturati dai tedeschi; in altri furono mandati in licenza
o invitati a sbandarsi e a tornare a casa. Da qui una prima differenza tra quello che accadde in Italia e quello che avvenne fra
le truppe dislocate fuori dai confini nazionali, dove non vi fu uno
sbandamento perché la casa non poteva essere raggiunta: fuori
d’Italia l’alternativa – consegnarsi ai tedeschi o combattere – fu
10
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
fin dall’inizio più netta. Fu tra le divisioni all’estero che si verificarono perciò sia i casi di maggiore collusione con la Wehrmacht,
sia quelli di vero eroismo, come il noto sacrificio della divisione
Acqui a Cefalonia. […]
Nel caso di Cefalonia il Comando supremo delle forze armate tedesche, seguendo una direttiva dello stesso Hitler, ordinò
<<di non fare prigionieri tra gli italiani>>. Gli ordini di Hitler
furono eseguiti pienamente: circa 1.300 militari della divisione Acqui morirono in combattimento o uccisi al momento della
cattura. Le perdite complessive tra caduti in battaglia, fucilati
e morti sulle navi affondate dalle bombe alleate, variano tra
6.500 e 9.500, secondo diverse stime […] A Corfù morirono in
combattimento o fucilati 600-700 uomini. I responsabili di questi massacri furono giudicati come criminali di guerra a Norimberga. Nei Balcani i tedeschi perpetrarono i maggiori eccidi di
militari italiani. Non è possibile precisarne l’entità, perché sia le
fonti italiane che quelle tedesche danno dati spesso contrastanti.
Così, mentre è noto il numero dei morti angloamericani e tedeschi, per gli italiani non è possibile indicare cifre precise. Molte
uccisioni furono effettuate senza che i comandanti tedeschi che
le avevano ordinate provvedessero a stilare elenchi nominativi o
a darne notizia nei diari di guerra. Ne è un esempio tipico il caso
di Cefalonia: il bollettino delle forze armate tedesche del 24 settembre, giorno in cui vennero fucilati i soldati italiani, riferiva che
<<la massa della divisione ribelle fu distrutta in combattimento,
insieme al suo stato maggiore>>, mentre fu sterminata dopo la
resa, in quel giorno e nei giorni successivi.
(E. Aga Rossi, Una nazione allo sbando. L’armistizio italiano
del settembre 1943 e le sue conseguenze, Bologna, Il Mulino,
2003, p. 135-138 e 154)
11
8 settembre
L’8 SETTEMBRE NELLA MEMORIA DI UN
UFFICIALE DEGLI ALPINI
N
uto Revelli partecipò alla drammatica campagna di Russia come sottotenente degli alpini. Scampato alla ritirata,
si convinse che <<l’unica Patria>> in cui valesse la pena di
credere era <<quella dei poveri cristi che hanno pagato con
la vita le colpe degli altri>>. Di qui il suo rifiuto del fascismo
e la sua immediata adesione, dopo l’8 settembre, al movimento partigiano. La scena seguente è ambientata a Cuneo.
L’8 settembre è una data difficile da capire. Gli antifascisti certo
la aspettavano, la prevedevano. Ma io, come tanti, appartenevo
a un altro mondo e continuavo a non capire. La notizia dell’armistizio mi arriva dalla strada, da via Roma. Sono le 18,30, e
vedo la gente raccolta in gruppi che discute, che grida, che parla a voce alta. Vedo soldati che fanno festa, che gridano che
la guerra è finita. Davanti a un bar ascolto il comunicato di Badoglio, inciso su un disco prima di scappare da Roma con il re.
Un messaggio equivoco, una voce vecchia, un disco rotto che
ricomincia sempre dall’inizio. Intuisco che sta per incominciare
un’altra guerra. Ho conosciuto i tedeschi sul Fronte russo e so
che non perdonano.
Corro a casa e mi metto in divisa. Afferro le mie tre armi automatiche e mi presento in caserma, nella caserma del 2° Alpini,
la caserma Cesare Battisti. Al portone ‘entrata’ incontro il capitano Luigi Romiti. Ammira i miei due parabellum [= mitragliatori
russi – n.d.r.] poi mi invita a tornarmene a casa: <<Qui perdi
tempo, - mi dice – qui non c’è nessuna intenzione di sparare sui
tedeschi>>. […] L’indomani, sempre in divisa, torno in caserma,
dove continuano ad aspettare ordini. Poi apprendo che a Cuneo
12
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
sarebbe arrivato un reparto della 4a Armata in fuga dalla Francia.
Con Piero Bellino accorro in via Statuto, dove c’è la sede del
Comando di Zona. Lì incontriamo questo piccolo reparto: pochi automezzi e pochi soldati spauriti, sbandati. I loro ufficiali
sono scomparsi, sono andati a cercare degli abiti borghesi. Poi
arrivano gli altri. A Cuneo, il 10 settembre, ci sono migliaia di
soldati, un’invasione: colonne di camion abbandonati, soldati
senza reparto, ufficiali che si sono tolti i gradi. I nostri contadini
chiameranno l’armistizio il disordine di Badoglio. Si respira il
disastro più che a Podgornoe [= in Russia – n.d.r.], dove almeno c’era una volontà di combattere. Qui, adesso, c’è la disfatta
senza speranza, la resa, il clima da si salvi chi può.
Alla caserma Battisti ormai non si parla che di smobilitazione.
Gli ordini non arrivano. I soldati hanno capito che bisogna disperdersi. Il comandante del 2° Alpini è il colonnello Boccolari,
un super decorato della guerra ’15-18. È ancora in caserma, è
ancora in divisa, ma sul punto di arrendersi. Doveva essere un
appassionato di fiori. Infatti in quei giorni si preoccupa dei suoi
vasi di gerani, che aveva disposto tutto attorno al monumento ai
caduti nel cortile della caserma. Stanno per arrivare i tedeschi,
e il colonnello si preoccupa di salvare i suoi gerani… Il tenente
Nardo Duchi, che poi diventerà uno dei più attivi e coraggiosi
partigiani della banda di Boves [= località in provincia di Cuneo, in cui i tedeschi compirono una delle prime stragi in terra
italiana, il 19 settembre, uccidendo 23 civili – n.d.r.], vorrebbe fucilare il colonnello Boccolari. Discutiamo animatamente,
se fucilarlo o meno. Io mi oppongo. Non è con un colonnello
in meno che risolveremo la situazione. Con Piero Bellino vado
a cercare il colonnello Palazzi. Palazzi è un ufficiale di quelli
seri. Sono le 9 di sera del 10 settembre. Ci apre in pigiama,
un pigiama a righe, da carcerato. Gli dico che in caserma tutti
13
8 settembre
scappano, che abbiamo bisogno del suo intervento. Palazzi mi
conosce, al mio ritorno dalla Russia mi ha abbracciato sotto i
portici di Cuneo. Adesso risponde urlando: <<Fuori dai coglioni! Via, non voglio più saperne. Tutti pidocchi, tutti pidocchi>>.
Ce ne andiamo a testa bassa, umiliati. Abbraccio Piero Bellino,
ci guardiamo e piangiamo. […]
Il giorno 12, alle ore 14, le SS del maggiore Peiper entrano in
Cuneo. Ho voluto aspettarli, i tedeschi, ho voluto vederli. Arrivano con una breve colonna di autoblinde, dal viadotto sul fiume
Stura. Occupano piazza Vittorio. Sono proprio come i tedeschi
che ho visto a Varsavia, che ho visto in Russia. Spavaldi, pieni di
boria, odiosi. Mentre risalgo lungo corso Nizza, per incontrare
Piero Bellino e prendere gli ultimi accordi prima di abbandonare
Cuneo, mi imbatto in un amico d’infanzia che non ha capito nulla e vive come in una giornata normale. Mi ferma, mi propone
di andare a vedere un film al Cinema Monviso. È domenica, e
il cinematografo apre alle 14,30. Non mi tradisco, non gli dico
nulla. Trovo una scusa e scappo via. Ecco, come ognuno poteva
vivere, a modo suo, l’8 settembre.
Incontro Piero, Faramia, Mutisio. Tra un’ora ci ritroveremo a San
Bernardo di Cervasca, lontano da Cuneo, al sicuro. Corro a
casa, smonto le mie tre armi automatiche, le infilo nello zaino,
e in bicicletta raggiungo la cascina Chiari, che diventa la nostra
prima base partigiana. L’indomani, con Piero Bellino, raggiungo
Valera di Caraglio, dove il materiale abbandonato dalla 4a Armata è moltissimo. Nei campi sono più numerosi i fucili buttati
che le margherite. Nascondiamo armi e munizioni. Poi ci spingiamo in Valle Grana.
(N. Revelli, Le due guerre. Guerra fascista e guerra partigiana,
Torino, Einaudi, 2003, pp. 130-134)
14
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
15
Parigi
Soldati tedeschi a
Dimensione internazionale
La guerra di Hitler: dalla
Blitzkrieg a Stalingrado
Guerra lampo in Polonia e in Francia
I
l 1° settembre 1939, le truppe tedesche penetrarono in territorio polacco. Anche se due giorni dopo, il 3 settembre,
Inghilterra e Francia dichiararono guerra alla Germania, la
campagna militare in Polonia fu di una velocità sorprendente:
il 28 settembre Varsavia capitolò, dopo che le forze tedesche
ebbero travolto l’esercito polacco mediante l’applicazione
della cosiddetta guerra lampo (Blitzkrieg). Si trattava, in pratica, dell’utilizzo combinato delle due nuove armi che resero
la seconda guerra mondiale un conflitto radicalmente diverso
da quello del 1914-1918: l’aviazione e il carro armato. In un
settore del fronte, veniva scatenata una massiccia azione di
bombardamento aereo; subito dopo, approfittando del disorientamento provocato dall’aviazione, quel medesimo settore era investito da un violento attacco delle forze corazzate.
Considerando che i polacchi non possedevano carri armati e
che la maggior parte dei loro aerei fu distrutta al suolo, ben si
capiscono le ragioni del repentino successo tedesco.
Ma, per cogliere pienamente l’importanza storica della Blitzkrieg, si deve andare al di là dell’ottica strettamente militare e
strategica; nel 1939, la Germania non aveva affatto impostato
tutta la propria vita economica e sociale in direzione del riarmo
e della produzione utile ai fini bellici. Il tenore di vita dei tedeschi e la disponibilità di beni di consumo in Germania erano
ancora decisamente elevati, né Hitler poteva permettersi di abbassarli, se voleva mantenere il consenso di una popolazione
che era entrata in guerra contro voglia e senza entusiasmo.
Infine, la massiccia importazione di materie prime dall’URSS
mostrava chiaramente che il Terzo Reich non sarebbe stato in
17
8 settembre
grado di sostenere una lunga guerra di logoramento: di qui
l’individuazione di una geniale tattica militare, che permettesse
di giungere rapidamente alla vittoria e permettesse di abbreviare il più possibile i tempi del conflitto.
Il 17 settembre, da est, entrò in Polonia anche l’Armata Rossa,
come previsto dal patto di non aggressione russo-tedesco, firmato a Mosca dai due ministri degli esteri Molotov e Ribbentrop
il 23 agosto.
In Occidente, la guerra divampò veramente solo nella primavera del 1940. Dapprima l’esercito tedesco occupò la Danimarca
e la Norvegia, al fine di garantire alla Germania il regolare rifornimento di ferro, proveniente dalla neutrale Svezia, e di possedere buone basi aeree, da cui poter bombardare l’Inghilterra.
In maggio, la guerra lampo nazista investì Olanda, Belgio e
Francia. Ancora una volta, come l’anno prima in Polonia, risultarono decisive la velocità e la capacità d’urto delle forze corazzate, appoggiate dall’aviazione: aggirato da nord il sistema di
fortificazioni denominato Linea Maginot, i tedeschi sfondarono
il fronte alleato vicino a Sedan e riuscirono ad isolare le armate nemiche impegnate nella Francia settentrionale. La disfatta
anglo-francese, a quel punto, fu totale, e l’unico successo consistette nel fatto che gli inglesi riuscirono ad evacuare dal porto
di Dunkuerque 200 mila soldati britannici e 140 mila francesi.
Il 14 giugno 1940, le truppe tedesche entrarono trionfalmente
a Parigi, dopo di che il governo francese fu costretto a chiedere la resa. La Francia venne divisa in due zone: mentre il nord
fu posto sotto il diretto controllo tedesco, a sud fu instaurato un
governo conservatore. Guidato dal maresciallo Philippe Pétain
(il vincitore di Verdun), il nuovo esecutivo si insediò a Vichy e
si dichiarò subito disposto a collaborare con i tedeschi, nella
convinzione che essi avessero vinto la guerra.
In Germania, l’effetto della fulminea vittoria sulla Francia fu
straordinario. Il prestigio di Hitler toccò il suo massimo livello,
18
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
ed anche quegli ambienti militari che avevano ancora delle riserve nei suoi confronti le abbandonarono definitivamente, accettandolo come indiscutibile guida della Germania e del suo
popolo. Nessun generale tedesco sarebbe più stato in grado,
fino all’estate del 1944, di mettere in discussione le sue direttive. Il 19 luglio, in un discorso al Reichstag, Hitler offrì alla Gran
Bretagna la pace; a Londra, tuttavia, il 10 maggio era diventato
primo ministro Winston Churchill: consapevole di rappresentare
il sentimento comune del popolo inglese, il governo respinse
l’offerta hitleriana e si preparò a resistere ad un conflitto che si
profilava lungo e difficile.
Lo stato maggiore tedesco iniziò a progettare l’invasione della
Gran Bretagna: un’operazione che avrebbe potuto avere successo solo se le navi, mentre attraversavano la Manica, non
fossero state attaccate dall’aviazione inglese. Così, nel corso
dell’estate del 1940, ebbe luogo la cosiddetta battaglia d’Inghilterra, caratterizzata dallo sforzo dei bombardieri tedeschi
di mettere fuori uso gli aeroporti inglesi, di acquistare il dominio assoluto dei cieli e, infine, di rendere possibile l’invasione
dell’isola. L’aviazione inglese (Royal Air Force), tuttavia, riuscì ad
infliggere enormi perdite a quella avversaria, in virtù sia della
superiorità tecnica dei propri caccia (gli Spitfire), sia del rivoluzionario utilizzo del radar, che permise di conoscere in anticipo
da dove proveniva un attacco nemico e di concentrare in quel
settore tutti gli aerei necessari o disponibili.
Verso la fine dell’estate e in autunno, i tedeschi cambiarono
obiettivo e si concentrarono sulle città inglesi. Tra il 7 settembre
e il 13 novembre, Londra fu colpita praticamente ogni giorno e
ogni notte. Per l’aviazione tedesca (Luftwaffe), però, mantenere
una simile pressione sulla popolazione inglese risultò alla fine
impossibile: nel periodo 10 luglio - 31 ottobre, l’aviazione tedesca perse 1733 aerei e 3089 aviatori, a fronte dei 915 velivoli
e 503 piloti della RAF.
19
8 settembre
HITLER E I GENERALI TEDESCHI, ALLA VIGILIA
DELL’INVASIONE DELLA POLONIA
I
l 22 agosto (quando tutto era ormai pronto per la guerra, in
quanto Stalin aveva già annunciato il suo consenso al patto
di non aggressione) una cinquantina di alti ufficiali tedeschi fu
convocata al Berghof, il rifugio sulle Alpi Bavaresi in cui Hitler
amava risiedere quando si allontanava da Berlino. In quell’occasione, il Führer spiegò le ragioni della guerra imminente.
I generali erano seduti su file di sedie. Hitler, appoggiato
al pianoforte a coda, parlò dando rare occhiate al foglietto
di appunti che teneva nella mano sinistra. Non fu redatto
alcun verbale. All’uditorio fu detto esplicitamente di non
prendere appunti dell’incontro. L’ordine fu ignorato da
uno o due dei presenti, tra cui il capo della Abwehr [= il
servizio di spionaggio dell’esercito – n.d.r.], ammiraglio
Canaris, che annotarono di nascosto i punti principali.
Altri, come il capo di stato maggiore colonnello generale
Halder e l’ammiraglio generale Boehm, giudicarono quanto
udito di tale importanza che più tardi quello stesso giorno si
affrettarono a stilarne un sunto.
<<Non avevo dubbi sul fatto che un conflitto con la Polonia
dovesse arrivare, prima o poi>> esordì il cancelliere.
<<Avevo già preso questa decisione in primavera, ma
pensavo di volgermi prima contro l’Occidente, e affrontare
l’Est in seguito>>. Le circostanze, disse, gli avevano fatto
cambiare idea. In primo luogo egli ebbe a sottolineare
l’importanza del proprio ruolo in quella situazione.
<<Sostanzialmente>> dichiarò senza falsa modestia
<<tutto dipende da me, dalla mia esistenza, ed è frutto
20
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
del mio talento politico. A ciò si aggiunga il fatto che forse
mai nessun altro potrà vantare quella fiducia che l’intero
popolo tedesco ripone in me. È probabile che in futuro non
vi sia un altro uomo dotato di un’autorità superiore alla
mia. La mia esistenza è pertanto un elemento di enorme
valore. Ma in qualsiasi momento io posso scomparire per
mano di un criminale o di un pazzo>>. Pose quindi in
rilievo il ruolo personale giocato da Mussolini e da Franco,
laddove Francia e Inghilterra mancavano di <<personalità
ragguardevoli>>. Alle difficoltà economiche della Germania
accennò brevemente quale motivo in più per non rinviare
l’azione. <<Per noi sono decisioni facili da prendere.
Non abbiamo nulla da perdere e tutto da guadagnare.
A causa delle nostre restrizioni (Einschränkungen), la
situazione economica è tale da non consentirci di resistere
più di qualche anno. Göring può darne una conferma. Non
abbiamo scelta. Dobbiamo agire>>. Passò in rassegna
l’insieme delle forze internazionali, concludendo: <<Tutte
queste circostanze favorevoli saranno sparite fra due o
tre anni. Nessuno può sapere quanto mi resta da vivere.
Dunque, meglio una guerra adesso>>.
Proseguiva col suo tipico argomentare. Era meglio testare
subito gli armamenti tedeschi. Impossibile tollerare oltre la
situazione polacca. Si rischiava un crollo di prestigio. Un
intervento occidentale era altamente improbabile. Il rischio
c’era, ma il compito dell’uomo politico come dell’uomo
d’armi era affrontare il rischio con ferrea determinazione.
Così aveva già fatto in passato, in particolare nel recupero
della Renania nel 1936, dimostrando sempre di avere
ragione. Bisognava correre il rischio. <<Ci troviamo di
fronte>> affermò col suo consueto dualismo apocalittico
21
8 settembre
<<alla drastica alternativa tra l’attacco o, presto o tardi, un
sicuro annientamento>>. Passò quindi a un confronto tra la
forza bellica tedesca e quella delle potenze occidentali, per
concludere che l’Inghilterra non era in condizione di aiutare
la Polonia. Né essa poteva avere interesse alcuno in un
conflitto prolungato. Le speranze dell’Occidente erano state
riposte nell’inimicizia tra Russia e Germania. <<Il nemico
non ha fatto i conti con la mia grande forza di volontà>>
esclamò gloriosamente. <<I nostri nemici sono vermiciattoli
(Kleine Würmchen). Li ho visti a Monaco>>. Il patto con la
Russia sarebbe stato firmato di lì a due giorni. <<Ora la
Polonia è nella posizione in cui la volevo>>. Non v’erano
da temere resistenze. […]
L’intervento si chiudeva infine con una sintesi della sua
filosofia: <<Ai vincitori nessuno viene a chiedere se
avevano detto la verità oppure no. Quando si intraprende
una guerra non è la ragione che conta, ma la vittoria.
Chiudete i vostri cuori alla pietà. Agite brutalmente. Ottanta
milioni di persone devono ottenere ciò che loro spetta di
diritto. La loro esistenza va tutelata e resa sicura. La ragione
è del più forte. Dunque, massima severità>>.
Le reazioni dell’uditorio furono contrastanti. A tre mesi circa
dalla riunione, il generale Liebmann, che non poteva dirsi
un ammiratore di Hitler, ricordava le proprie sensazioni. Se
pure dal cancelliere gli era capitato di udire alcuni discorsi
efficaci, scriveva, questo mancava completamente di
lucidità e di senso critico. <<Il suo tono tronfio e chiassoso
era semplicemente ributtante. Sembravano le parole di un
uomo privo di ogni senso di responsabilità, che non avesse
più un’idea precisa di cosa significasse una guerra vittoriosa
e deciso con arbitrarietà inaudita al salto nel buio>>. A
22
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
giudicare dalle facce cupe e dai palesi malumori, molti dei
presenti dovevano a suo avviso pensarla allo stesso modo.
Può darsi che fosse così. Ma se i generali non fecero plauso
alle parole di Hitler, è vero anche che non sollevarono
alcuna obiezione. In linea di massima, lo stato d’animo era
improntato a fatalismo e rassegnazione.
(I. Kershaw, Hitler 1936-1945, Milano, Bompiani, 2001, pp.
322-325. Traduzione di A. Catania)
LA GUERRA-LAMPO IN POLONIA
L
’ambasciatore francese a Varsavia Léon Nöel si rese subito
conto delle novità tattiche introdotte dai tedeschi nella campagna militare del settembre 1939. Su scala ancora maggiore, l’impiego combinato di aviazione e carri armati fu ripetuto
dai tedeschi nell’attacco contro la Francia (maggio 1940) e
poi nell’aggressione contro l’URSS (giugno 1941).
L’attacco tedesco è stato sferrato ed è condotto dallo stato
maggiore tedesco con ritmo fulminante, con una minuzia ed
una maestria nei preparativi, una perfezione nell’esecuzione,
una celerità nei risultati che, sin dalle prime ore, hanno
posto nella situazione più delicata le armate polacche, colte
di sorpresa in piena concentrazione delle loro forze e nel
giorno stesso della mobilitazione generale. La Wehrmacht
e la Luftwaffe hanno applicato metodi nuovi che hanno
provocato quasi immediatamente la disorganizzazione
contemporanea dell’esercito e del paese nemico. Effettuando
23
8 settembre
continui bombardamenti su tutto il territorio polacco,
l’aviazione tedesca ha ostacolato tanto il vettovagliamento
ed i trasporti delle truppe quanto la trasmissione degli ordini
provenienti da stati maggiori che essa inseguiva di quartier
generale in quartier generale. Non più assalti di fanteria
preparati da tiri di artiglieria come durante l’altra guerra. Gli
attacchi sono effettuati da divisioni blindate, da carri armati
che si muovono in massa, seguiti da auto-mitragliatrici e
sostenuti da aerei che mitragliano e bombardano le truppe
polacche a bassa quota; alla fanteria, trasportata per lo
più in camion e in motocicletta, non resta che il compito di
occupare il territorio conquistato. […]
All’atto in cui entrano in guerra prima la Gran Bretagna e poi
la Francia [ 3 settembre 1939 – n.d.r.], sono passate poco
più di quarantotto ore dall’inizio della campagna polacca, e
già le armate polacche sono disciolte, le divisioni disorientate
e divise le une dalle altre, mente le Panzerdivisionen [= le
forze corazzate tedesche, composte da centinaia di carri
armati, detti Panzer - n.d.r.] proseguono senza sosta la
loro avanzata ed invadono il paese a nord, a nord-ovest,
penetrando dalla Prussia orientale, a sud-ovest attraverso la
Slesia e, a sud, provenendo dalla Boemia-Moravia e dalla
Slovacchia.
Invano l’aviazione e l’esercito polacchi manifestano
un’energia ed un coraggio degni delle più belle pagine
della storia della Polonia. Invano, su apparecchi di livello
molto inferiore a quelli tedeschi, gli aviatori compiono le
imprese più straordinarie arrivando a schiantarsi sui loro
nemici quando hanno esaurito le munizioni. Invano hanno
abbattuto, il 1° settembre, 16 aerei nemici e, nei due giorni
successivi, un numero maggiore. Anche loro subiscono
24
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
perdite assai gravi che ben presto renderanno impotente
l’aviazione polacca. L’esercito dà prova di un magnifico
spirito di abnegazione e si batte con accanimento, senza
riuscire a ritardare sensibilmente la marcia della formidabile
macchina bellica tedesca che continua ad avanzare, come
mossa da un potente congegno ad orologeria.
(E. Collotti, La seconda guerra mondiale, Torino, Loescher,
1985, pp. 55-56)
IL DRAMMA DEI PROFUGHI NEL GIUGNO 1940
N
ella primavera del 1940, lo scrittore Arthur Koestler si trovava in Francia con un’amica. In queste pagine descrive
il caos che colpì l’intero paese, al momento della disfatta militare.
Limoges era su di una delle vie principali lungo le quali la
corrente dei profughi scendeva da nord verso sud. I miei
ricordi di quegli ultimi giorni in Francia sono principalmente
di natura acustica: la incessante sinfonia polifonica
dei clacson delle auto, il ruggito e il ronzio dei motori,
il frastuono dei mezzi di trasporto pesanti sulla strada
principale, il rantolo asmatico delle vecchie Citroën, il nitrito
dei cavalli e i pianti dei bambini esausti, a mano a mano
che la caotica corrente fluiva attraverso la città nella sua
corsa senza scopo. Senza interruzione, tutto il giorno e tutta
25
8 settembre
la notte, le divisioni meccanizzate della disfatta sfilavano e
la gente nelle strade le contemplava; alcuni impietositi, altri
con ostile disprezzo, altri con occhi ansiosamente pensierosi,
chiedendosi quando sarebbe venuto il loro turno di unirsi alla
Grande Migrazione verso sud. Perché avevano osservato la
corrente ingrossarsi sin dai primi giorni, quando non era
più di un rivolo con le sorgenti che si perdevano lontano
a nord, in Olanda e in Belgio, e le macchine portavano
ancora targhe straniere; poi nei giorni di Sedan [la zona
in cui l’esercito tedesco sfondò il fronte francese, il 12-13
maggio 1940 – n.d.r.] s’era improvvisamente ingrossata e
sulle targhe erano apparsi i segni delle province francesi, M
per Département du Nord, N per il Pas de Calais; e sempre
più e più vicino, X per Somme, Y per Seine-et-Oise, finché
fecero la loro comparsa i primi autobus verdi di Parigi e per
alcuni giorni nove targhe su dieci portavano la fatale R della
capitale; poi perfino la R sparì e nuove fonti della corrente si
aprirono in Bretagna e sulla Loira. Le targhe sulle automobili
raccontavano la tremenda storia del rullo compressore che
scendeva sulla Francia e svelavano la verità che i comunicati
ufficiali cercavano ancora di nascondere.
G. [la giovane compagna di Koestler – n.d.r.] ed io sedevamo
nella terrasse del Café de l’Orient, di fronte alla place de
la Mairie, dove passava la corrente principale. Per lo più
pioveva e i materassi in cima alle automobili s’inzuppavano
d’acqua. [...] Era un’ironia del destino particolarmente
sadica aver mutato il popolo più piccolo borghese,
meticoloso, sedentario in una nazione di girovaghi. Dieci
milioni di francesi che si muovevano senza scopo lungo le
strade con i loro materassi e tegami, che congestionavano
tutte le vie di comunicazione, che paralizzavano ogni rapido
26
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
movimento militare, che coprivano come uno spesso torrente
di fango quel che rimaneva della nazione, finché l’ultimo
barlume di vita si spense. [...] Era come se tutti gli esemplari
della fauna meccanica, qualunque veicolo potesse muoversi
e puzzare su quattro ruote fuggisse dal diluvio. [...] E tutto
nell’interno traboccava fino all’ultimo centimetro quadrato
di un misto di vecchi, ragazze, nonne, bambini, tegami,
gabbie d’uccelli, macchine da cucire, casse, balle, panieri,
culle, biciclette, orologi a cucù, pani, latte di benzina,
gomme di scorta, grammofoni, fisarmoniche, bottiglie di
vino, cani e gatti – tutto stufato insieme come in una specie
di gulasch surrealista.
(A. Koestler, Schiuma della terra, Bologna, Il Mulino, 2005, pp.
150-152. Traduzione di N. Conenna)
27
8 settembre
L’invasione dell’URSS
N
el settembre del 1940 Hitler rinunciò definitivamente al
progetto di invadere la Gran Bretagna; d’altro canto, fin
dall’estate aveva progettato di procedere contro l’URSS, visto
che, con la sconfitta della Francia, si era verificata quella situazione di sicurezza alle spalle da lui considerata, nel Mein
Kampf, come essenziale per la riuscita della guerra contro la
Russia. La speranza del Führer era di poter sconfiggere l’URSS
con una nuova guerra lampo, che avrebbe dovuto respingere l’esercito russo fino agli Urali prima dell’inverno. A questa
valutazione ottimistica della situazione, il dittatore tedesco fu
mosso dalle pesanti epurazioni condotte da Stalin fra i generali negli anni 1937-38. Un altro elemento decisivo, che
spinse Hitler a sottovalutare le capacità sovietiche di opporre
una valida resistenza all’attacco tedesco, fu la sua concezione
razzista: nell’immaginario hitleriano, l’URSS era comandata
da una banda di bolscevichi ebrei, capaci solo di disgregare e
decomporre le energie vitali di un popolo, e non certo di costruire una solida e potente entità statale. Dunque, contro gli
slavi (considerati da Hitler come sottouomini) e contro i loro
dirigenti ebraici, le forze della Germania avrebbero sicuramente trionfato, secondo il Führer, in un breve lasso di tempo.
Questa concezione razzista è alla base anche della particolare
brutalità che caratterizzò la guerra ad Oriente. Nella primavera
del 1941, a più riprese il Comando supremo tedesco ricevette precise istruzioni relative al fatto che l’esercito sarebbe stato
accompagnato da speciali reparti di SS, incaricati di eliminare
la classe dirigente sovietica: il che, nel giro di breve tempo, provocò l’esecuzione di tutti gli ebrei che si trovavano in territorio
sovietico. Da parte loro, il 6 giugno, gli alti comandi militari
emanarono un ordine (denominato Kommissarbefehl) in base
al quale dovevano essere giustiziati sommariamente tutti i com-
28
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
missari politici e i funzionari comunisti che fossero stati catturati.
Nel solo territorio di competenza del gruppo d’armate Centro,
la Wehrmacht fucilò da 3 a 5.000 commissari politici, mentre le
SS, nella stessa area, ne eliminarono circa 10.000. Tale comportamento era del tutto coerente con il fine ultimo della campagna d’Oriente: la conquista dello spazio vitale (Lebensraum)
per il popolo tedesco, lo sfruttamento coloniale delle risorse
russe e la trasformazione della sua popolazione in un’informe
moltitudine di schiavi al servizio dei conquistatori.
In tempi più brevi, però, il ragionamento di Hitler era dettato
anche da motivazioni tattiche. Nei suoi progetti, la rapida conquista dell’URSS avrebbe dovuto indurre la Gran Bretagna ad
una pace di compromesso con la Germania, ormai diventata
nuova potenza egemone sul continente europeo. In alternativa,
nel caso in cui Churchill si ostinasse a proseguire la guerra ad
oltranza, le immense riserve agrarie e minerarie russe avrebbero
finalmente fornito al Terzo Reich le risorse alimentari e le materie
prime per combattere una lunga guerra di logoramento.
Denominata in codice Operazione Barbarossa, l’offensiva iniziò
il 22 giugno 1941, cogliendo completamente di sorpresa Stalin,
che fino all’ultimo aveva prestato fede al patto di non aggressione e creduto che Hitler non avrebbe attaccato. In un primo momento, l’attacco tedesco registrò un successo clamoroso. Alla
fine dell’estate 1941, il numero di prigionieri sovietici aveva
sicuramente raggiunto la cifra di 3 milioni (circa mezzo milione
di essi fu costretto ad arrendersi al momento della conquista
di Kiev, il 19 settembre). Nel maggio 1942, quando i tedeschi
ripresero l’offensiva, altri 239.000 prigionieri furono catturati nei
pressi di Kharkov, in Ucraina. Alla fine del conflitto, il numero globale di soldati sovietici caduti in mani tedesche toccò la quota di
5,7 milioni. In un primo tempo, le loro condizioni di detenzione
furono terribili: non a caso, si calcola che almeno 3.300.000 di
essi siano periti di stenti o vittime di esecuzioni sommarie. I nazisti
29
8 settembre
presero come pretesto il fatto che l’URSS non aveva firmato la
Convenzione di Ginevra sui prigionieri di guerra. In realtà, la
motivazione vera della violenza nazista verso i sovietici era di
natura ideologica: il disprezzo razzista contro i sottouomini slavi
si mescolava con l’odio per il nemico bolscevico.
Alla metà di settembre, l’esercito di Hitler era riuscito ad avanzare in territorio russo per una profondità di 800 chilometri, conquistando un territorio che - più vasto dell’intera Germania - garantiva prima della guerra all’URSS il 36% della sua produzione
di grano, il 60% di quella di ferro e di acciaio, il 55% di quella
del carbone. Eppure, malgrado tutti questi successi, nessuno dei
grandi obiettivi che la Germania si era proposta di conseguire in
tempi brevi era stato raggiunto. A nord Leningrado - per quanto
assediata e affamata (al punto che più di un terzo dei suoi tre
milioni di abitanti morì per denutrizione, tra il 1941 e il 1944) non capitolò, mentre a sud la conquista dell’Ucraina (con le sue
miniere e le sue acciaierie) non si rivelò così decisiva come si era
sperato. Negli anni Trenta, il regime sovietico aveva provveduto
a creare una nuova regione industriale negli Urali; pertanto, la
perdita dell’Ucraina (e del suo grano) provocò senza dubbio
gravi problemi per il rifornimento alimentare delle città russe,
ma non significò affatto il collasso dell’industria bellica sovietica, che al contrario, dal 1942, fu in grado di produrre mensilmente 2.000 carri armati e 3.000 aeroplani. Quanto al settore
centrale del fronte (quello che avrebbe dovuto comprendere, in
teoria, anche la conquista di Mosca), l’esercito tedesco subì una
prima battuta d’arresto fin dalla metà di luglio, nella regione di
Smolensk. Le truppe di Hitler arrivarono poi, in novembre, fino
ai sobborghi di Mosca; ma il 5 dicembre, quando già l’inverno
russo infieriva e causava terribili problemi ai soldati tedeschi,
l’Armata Rossa contrattaccò davanti alla capitale, provocando
la definitiva cessazione della guerra lampo e la sua trasformazione in una micidiale guerra di logoramento.
30
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
LA GUERRA AD ORIENTE NELLA CONCEZIONE
DI HITLER
L
a guerra contro l’URSS fu concepita da Hitler come uno
scontro che avrebbe aperto una nuova fase nella storia della Germania. Il suo obiettivo era lo sfruttamento coloniale degli immensi spazi russi e la trasformazione della popolazione
slava in una massa di schiavi al servizio della razza ariana,
considerata superiore.
Hitler non solo puntava all’eliminazione militare della
grande potenza avversaria - come aveva fatto nella
campagna contro la Francia -, ma intendeva preparare
sulle ceneri dell’Unione Sovietica la costruzione dell’Impero
orientale germanico cui aveva sempre mirato, con tutte le
conseguenze che discendevano dal suo dogma razziale. [...]
Le affermazioni fatte da Hitler in ambienti ristretti negli ultimi
mesi prima dell’inizio dell’aggressione permettono di provare
la continuità dei suoi vecchi obiettivi programmatici, e le
direttive segrete impartite alla stampa tedesca sollecitavano
la riproposizione dell’immagine del nemico che era stata
costantemente evocata fino alla svolta del 1938-39 e che
era quella del bolscevismo giudaico. Quattro erano gli
obiettivi che si intrecciavano l’un l’altro nella concezione
della guerra ad oriente di Hitler.
1. Lo sterminio della classe dirigente giudaico-bolscevica
dell’Unione Sovietica, inclusa la sua presunta radice
biologica costituita dai milioni di ebrei dell’Europa centroorientale.
2. La conquista di uno spazio coloniale per insediamenti
tedeschi nelle zone della Russia ritenute più fertili.
31
8 settembre
3. La decimazione delle popolazioni slave e la loro
sottomissione al dominio tedesco nei quattro Commissariati
del Reich di Ostland (Russia Bianca, Lituania, Lettonia,
Estonia), Ucraina, Moscovia, Caucasia, retti da vicerè
tedeschi, secondo l’espressione che Hitler coniò guardando
al suo ideale di dominio coloniale, ossia al ruolo della
Gran Bretagna in India. I compiti principali affidati a questi
Commissariati del Reich (di cui per altro furono istituiti solo
i primi due a causa degli sviluppi della guerra nel 1941,
del tutto opposti al programma) consistevano nell’estirpare
dalle masse slave qualsiasi ricordo del grande Stato russo e
di ridurre queste stesse masse in una condizione di ottusa e
cieca obbedienza nei confronti dei nuovi padroni.
4. La realizzazione dell’autarchia in una grande area
dell’Europa continentale sottoposta al dominio tedesco e
a prova di blocco, rispetto alla quale i territori conquistati
all’est avrebbero dovuto rappresentare il serbatoio
presumibilmente inesauribile di materie prime e di derrate
alimentari. Sembrava questo il presupposto indispensabile
affinché il Reich hitleriano potesse sostenere una guerra
contro le potenze marittime anglo-americane ed essere in
grado nel futuro di affrontare qualsiasi eventuale nuova
guerra mondiale. Nelle linee direttive destinate allo Stato
maggiore per l’economia nei territori orientali, fissate il 2
maggio 1941, era già previsto che la sola intenzione di
rifornire le forze armate tedesche sfruttando esclusivamente
la Russia avrebbe comportato la <<morte per fame di
parecchi milioni di persone>>.
Mentre nella fase precedente l’attacco all’Unione Sovietica,
e anche in Polonia nel 1939, i compiti dell’esercito e delle SS
erano stati tutto sommato ancora relativamente separati in
32
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
modo molto netto, e quindi l’esercito aveva sempre condotto
la guerra contro i suoi avversari, soprattutto contro le potenze
occidentali, rispettando le regole della Convenzione dell’Aia
in materia di guerra terrestre, nella guerra contro l’Unione
Sovietica, Hitler invalidò a suo completo arbitrio questi ed
altri principi del diritto internazionale già prima di dare
inizio all’attacco. La sua perseveranza nel cancellare la linea
divisoria, fino a quel momento rispettata, tra SS ed esercito,
e nel trasformare quest’ultimo in uno strumento diretto della
sua guerra ideologico-razziale ad oriente, derivava dalle
parole chiare ed inequivocabili che egli aveva pronunciato
il 30 marzo 1941 dinanzi a 200-250 comandanti generali
e ufficiali superiori, i quali le avevano accolte, in parte
positivamente, in parte con riserva: <<Lotta tra due opposte
concezioni del mondo. Giudizio distruttivo sul bolscevismo.
Equiparato a criminalità sociale. Comunismo, pericolo
enorme per il futuro. Si tratta di una lotta di annientamento.
Se non la concepiamo così, colpiremo magari il nemico, ma
entro trent’anni ci ritroveremo di fronte un nemico comunista.
Commissari e adepti della GPU [Direzione Politica di Stato]
[= la polizia segreta sovietica - n.d.r.] sono criminali e
così vanno trattati. La lotta sarà assai diversa da quella ad
occidente. Ad oriente bisogna essere spietati oggi per poter
essere indulgenti nel futuro>>.
(A. Hillgruber, Storia della seconda guerra mondiale. Obiettivi
di guerra e strategia delle grandi potenze, Roma-Bari, Laterza,
198, pp. 78-80. La citazione tra virgolette è tratta dagli appunti
del generale Halder)
33
8 settembre
ANTISEMITISMO E DISPREZZO RAZZISTA VERSO I
RUSSI, TRA I GENERALI TEDESCHI
N
on tutti i generali tedeschi erano dei nazisti fanatici. Tuttavia, molti di loro condividevano con Hitler un profondo
disprezzo per gli ebrei, per i russi e per il comunismo. Pertanto,
da parte dei militari, non emerse mai alcuna vera opposizione
di principio all’impostazione propriamente nazista del conflitto
ad Oriente, concepito come guerra di annientamento del nemico, col quale non era possibile alcun accordo.
Dalle Linee-guida sul comportamento delle truppe in Russia
(documento emanato dallo Stato maggiore nel maggio 1941).
<<La lotta richiede iniziative energiche e spietate contro
agitatori bolscevichi, guerriglieri sabotatori ed ebrei, e la
completa eliminazione di ogni resistenza attiva e passiva. I
membri dell’Armata Rossa – prigionieri compresi – devono
essere trattati con estremo riserbo e massima cautela, dovendosi
fare i conti con tecniche di lotta particolarmente subdole. In
particolare, i militari dell’Armata Rossa di origine asiatica hanno
una mentalità contorta e sono astuti e privi di sentimenti>>.
Direttive emanate dal generale Erich Hoepner, il 2 maggio
1941.
<<La guerra alla Russia è un capitolo importante della lotta
per l’esistenza della nazione germanica. È l’antica battaglia
tra popoli germanici e slavi, per la difesa della cultura
europea dall’inondazione asiatico-moscovita e il ripudio del
bolscevismo ebraico. Il fine di questa battaglia dev’essere la
distruzione dell’odierna Russia, ed essa va quindi combattuta
con severità senza precedenti. Ogni operazione bellica
34
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
dev’essere guidata, nella pianificazione e nell’esecuzione,
dalla ferrea volontà di sterminare il nemico spietatamente e
totalmente. In particolare, non si dovrà risparmiare nessun
aderente all’attuale sistema russo-bolscevico>>.
Direttive emanate alle truppe dal generale Hermann Hoth,
nel novembre 1941.
<<Ogni segno di resistenza attiva o passiva e ogni sorta di
macchinazione da parte degli agitatori ebraico-bolscevichi
dev’essere represso subito e senza misericordia… Questi
ambienti sono sostenitori del bolscevismo, fautori delle sue
organizzazioni criminali, complici dei partigiani. Si tratta degli
stessi ambienti ebraici che tanto hanno danneggiato la nostra
patria con le loro attività contro la nazione e la civiltà, che in tutto
il mondo si fanno promotori di tendenze antitedesche, e che
per primi incorreranno nella giusta punizione. Il loro sterminio
è una condizione della nostra stessa sopravvivenza>>.
(M. Burleigh, Il Terzo Reich, Milano, Rizzoli, 2003, pp. 580581. Traduzione di C. Capararo, S. Galli, M. Mendolicchio)
LE DIRETTIVE DEL FELDMARESCIALLO
VON REICHENAU
P
robabilmente, il feldmaresciallo Walter von Reichenau fu l’alto ufficiale tedesco ideologicamente più compromesso con il
regime nazista. La sua direttiva emanata il 10 ottobre 1941,
indirizzata alla VI Armata (operante in Ucraina), mostra che il
generale condivideva al cento per cento la politica di sterminio
che, a quell’epoca, aveva assunto i propri contorni più netti e
35
8 settembre
spietati. Un documento datato 13 novembre 1941 mostra che
Hitler lesse e approvò personalmente la direttiva di Reichenau.
Vi sono ancora molte idee oscure sulla condotta dell’esercito
nei confronti del sistema bolscevico. Lo scopo essenziale della
campagna contro il sistema giudaico-bolscevico è la distruzione
completa della potenza e lo sterminio dell’influenza asiatica
nell’area culturale europea. In rapporto a questo si presentano
anche per i militari compiti che vanno oltre la concezione
tradizionale e unilaterale che abbiamo del soldato. Nello spazio
orientale il soldato non è solo il combattente secondo le regole
dell’arte militare, ma anche il portatore dell’imprescindibile
idea di popolo e il vendicatore di tutti gli atti bestiali commessi
contro il popolo tedesco e i popoli ad esso apparentati. Il
soldato deve pertanto comprendere appieno la necessità di
una dura ma giusta espiazione da parte della subumanità
ebraica. Inoltre deve mirare a stroncare sul nascere eventuali
rivolte dietro le linee del fronte della Wehrmacht, che, stando
all’esperienza, sono sempre fomentate da ebrei. […]
Indipendentemente da qualsiasi considerazione politica sul
futuro, il soldato deve svolgere un duplice compito:
1) Annientare l’eresia bolscevica, lo stato sovietico e le sue
forze armate.
2) Sterminare senza pietà le insidie e le crudeltà delle specie
straniere e in tal modo garantire la sicurezza della Wehrmacht
tedesca in Russia. Solo in questo modo assolveremo al compito
storico di liberare una volta per tutte il popolo tedesco dal
pericolo dell’ebraismo asiatico.
(M. Weinreich, I professori di Hitler. Il ruolo dell’Università nei
crimini contro gli ebrei, Milano, Il Saggiatore, 2003, pp. 165166. Traduzione di C. Salmaggi)
36
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
I SOLDATI TEDESCHI SUL FRONTE ORIENTALE
N
on è facile valutare il grado di allineamento ideologico
dei soldati comuni (inquadrati nell’esercito, la Wehrmacht,
non nelle SS), in quanto le fonti a volte sono di difficile lettura e
contraddittorie. Nei diari e nella corrispondenza, affermazioni
tipicamente naziste sono associate ad altre espressioni, di segno opposto, che denotano scarso interesse per la guerra e la
vittoria finale.
Nei primi sei mesi di combattimenti, le forze dell’Asse [=
l’alleanza tra Itala fascista e Germania nazista – n.d.r.]
persero 750.000 uomini, saliti a un milione nel marzo
1942; di questi, 250.000 erano morti dispersi. I soldati del
reggimento d’assalto Gross Deutschland cominciarono la
campagna di Russia in 6.000; alla fine del 1941, le perdite
erano pari a 4.070 unità; nel febbraio 1942, quello che
restava del reggimento erano tre ufficiali e 30 soldati. Nel
dicembre 1941, gli effettivi della 6a e 7a divisione corazzata
erano ridotti rispettivamente a 180 e 200 uomini, mentre
la 18a divisione corazzata consisteva in quattro battaglioni
di fanteria. Perdite così elevate significavano che i reparti
si riducevano a raggruppamenti di estranei messi insieme
solo per fare numero, senza nemmeno l’ombra dei forti
legami regionali e sociali che di solito cementano un’unità
combattente. Di fronte all’evidente superiorità dell’avversario
in uomini, mezzi e comandanti, le forze dell’Asse erano
tenute insieme solo da una disciplina ferrea, che puniva
anche infrazioni di poco conto – per non parlare della
diserzione, del panico o dell’automutilazione – col plotone di
37
8 settembre
esecuzione. Circa 15.000 uomini furono condannati a morte
dalle Corti marziali sul fronte orientale, mentre centinaia
di migliaia furono destinati ai battaglioni di punizione o
imprigionati. […] Il problema, nel collegare questi fattori
generali con le atrocità razziali, è che le seconde furono
pianificate in anticipo, e cominciarono non appena soldati e
reparti di polizia tedeschi ebbero varcato il confine. È quindi
impossibile attribuirle esclusivamente al deterioramento e
all’imbarbarimento del conflitto, che si verificarono in un
secondo tempo.
La licenza di comportarsi a piacimento col nemico fece in
qualche modo da contrappeso alla draconiana disciplina
imposta alla Wehrmacht. Nella forma più banale, le
truppe tedesche misero in atto tecniche di sopravvivenza
quotidiana rubando alimenti, bestiame e animali da tiro, il
contenuto di interi vagoni merci, abiti pesanti e calzature
di feltro, incuranti dei danni così arrecati ai civili. Si giunse
a togliere la paglia dai tetti delle casupole contadine per
nutrire gli animali da tiro. Inoltre i soldati saccheggiavano
le abitazioni senza alcun ritegno, come risulta evidente da
un rapporto del novembre 1941 dall’area arretrata 582:
<<Gli oggetti rubati includono, per esempio, sciarpe,
federe, tovaglie, asciugamani, calzoni, tendaggi, giacche,
capi di abbigliamento di ogni genere, arredi funerari,
scarpe da donna e da bambino, biancheria intima
femminile, eccetera>>. In alcuni casi il valore non di uso,
ma pecuniario, della refurtiva fa pensare all’esistenza di
qualche forma di criminalità organizzata. Così verso la fine
del 1941, a Witebsk, scomparvero 118 capi di bestiame, 15
tonnellate di sale, e un milione di fogli di compensato. In
altre località i militari vandalizzarono impianti e macchinari,
38
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
o distrussero risorse ittiche in tal misura, dandosi alla pesca
con le bombe a mano, da potersi parlare di autentiche
forme di delinquenza. E come sempre, qualunque resistenza
della gente del posto era soffocata nel sangue.
La brutalità militare era anche influenzata dal
condizionamento subito dai soldati, cresciuti sotto il nazismo
ed esposti al supplemento di ideologia dell’addestramento.
Anche se bisogna andare cauti nel discutere di un così
enorme numero di uomini diversi per origini, età e convinzioni
politiche e religiose, ci sarebbe da stupirsi se molti di loro
non avessero creduto ardentemente nel Volk, nella patria e
nel Führer, nel naturale diritto dei tedeschi di conquistare
e signoreggiare, o nell’inferiorità culturale e razziale
degli altri popoli. […] Non è difficile trovare tracce della
mentalità da razza superiore nel comune soldato tedesco,
specialmente se si guardano le semiufficiali raccolte di
frasi e opinioni compilate dai nazisti. Ma simili opere di
natura propagandistica miravano a dimostrare che le forze
armate condividevano le idee del Führer. Così le raccolte di
corrispondenza dal fronte – se di questo veramente si trattava
– appaiono straordinariamente imbevute di razzismo, come
questa lettera di un soldato semplice datata agosto 1941:
<<Cosa sarebbe stato della nostra colta Europa se questi
figli della steppa, avvelenati ed ebbri di idee distruttive,
questi esseri subumani dalle menti plagiate, avessero invaso
la nostra bella Germania? Ringraziamo sempre con amore
e lealtà il nostro Führer, salvatore della patria e figura
storica>>. O questa, di un soldato scelto: <<Solo un
ebreo può essere bolscevico, per simili sanguisughe non si
può immaginare sorte migliore… Dovunque uno sputi, salta
fuori un ebreo… Per quanto ne so, non un solo ebreo ha
39
8 settembre
mai lavorato nel paradiso dei lavoratori; tutti, anche l’ebreo
più misero, hanno un posto [nell’apparato], ovviamente con
privilegi più o meno grandi>>.
L’odio razzista tipicamente nazionalsocialista di cui simile
corrispondenza è imbevuta, e la sua uniformità, danno da
pensare o almeno fanno desiderare di consultare gli archivi
degli editori, per cercare di capire se siano autentiche o
ritoccate. Lettere ritrovate di recente a Mosca, provenienti da
uffici postali della Russia occupata, poi ripresi dall’Armata
Rossa, hanno un tono diverso, molto più personale; il tono
di uomini che in un bunker, a lume di candela, affidano
alla carta pensieri sui famigliari o sulla morte sempre
incombente. La stragrande maggioranza di queste lettere,
molte messe insieme con fatica da soldati per i quali
ortografia, grammatica ed espressione verbale delle mozioni
erano attività inconsuete, rivela inoltre la preoccupazione di
cosa succedesse a casa. I loro autori non si soffermano né
sugli ebrei né sui civili russi; vogliono notizie dei parenti,
delle mogli, delle fidanzate, dei fratelli e delle sorelle, e
ricostruiscono con la fantasia quello che hanno perduto,
alcuni temporaneamente, molti per sempre. Se accennano
alla guerra è per descrivere fatiche e privazioni: le marce,
i digiuni, le notti all’addiaccio o in ripari miseri e malsani,
l’impossibilità di lavarsi e conservare il decoro personale. Si
attengono a quello che li attanaglia al ventre o alle gambe.
In queste descrizioni il nemico non ha molto spazio, se
non in quanto temuta parentesi di paura che s’intromette
nella continua ricerca di cibo e calore. […] Col deteriorarsi
della situazione al fronte, il sentimento predominante era
il desiderio di tornare a casa vivi. Come Herbert, un altro
soldato, scrisse ai genitori nel gennaio 1943: <<Sarò felice
40
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
se non dovrò mai più rivedere questa dannatissima Russia,
perché col tempo è capace di distruggere chiunque. Come
quasi tutti i miei commilitoni, ho un solo desiderio: tirarmi
fuori da questo paradiso dei lavoratori e non rivederlo né
sentirne parlare mai più. Vogliamo tutti una cosa sola: pace
e tranquillità e cibo a sufficienza, e tutto il resto che vada a
farsi fottere>>.
(M. Burleigh, Il Terzo Reich, Milano, Rizzoli, 2003, pp. 584589. Traduzione di C. Capararo, S. Galli, M. Mendolicchio)
IL DISCORSO DI STALIN DEL 3 LUGLIO 1941
L
’invasione tedesca dell’Urss iniziò il 22 giugno 1941. Per
quasi due settimane, Stalin restò in silenzio totale. Forse, era
convinto che l’offensiva nazista avrebbe travolto l’Armata Rossa e sarebbe arrivata fino a Mosca. Il leader che si fece udire
il 3 luglio era un uomo provato e insolitamente affaticato.
Forse, in quell’occasione, Stalin superò la soglia che nessun
leader carismatico, neppure il più democratico e aperto alle
masse, può superare, pena la perdita di fiducia in lui e la trasformazione in soggetto debole. Di qui il suo sforzo, nel corso
della guerra e dopo la vittoria, di assumere atteggiamenti più
solenni e marziali, di quelli tenuti in precedenza.
Fu la radio a portare in tutto (o quasi tutto) il paese le parole
accorate e insolitamente informali del compagno Stalin il 3
luglio 1941. Radio Mosca era diffusa su un ampio territorio,
ma molte zone periferiche erano ancora servite da stazioni
locali. Fuori delle grandi città il possesso di apparecchi
41
8 settembre
procapite era basso, ma l’ascolto collettivo in posti di
lavoro e circoli ricreativi era consueto. Nei primi giorni di
guerra fu ordinato che tutti gli apparecchi privati venissero
consegnati alle autorità; l’unica modalità di ascolto restava
la rete di radiodiffusione via cavo, collegata ad altoparlanti
sistemati nelle strade e apparecchi riproduttori nelle case.
Anche per questo il testo del discorso, pronunciato dopo
due enigmatiche e misteriose settimane di silenzio da parte
del leader in seguito all’invasione tedesca del 22 giugno,
fu diffuso anche a mezzo stampa, proprio perché più
capillarmente potesse raggiungere angoli e zone sperdute
del paese. La guerra segnò una svolta importante nel mezzo
di comunicazione radiofonico: regole, tempi e abitudini
censorie, dopo una prima frenata all’efficienza del servizio
d’informazione stesso, dovettero essere riviste e adattate
allo stato di emergenza. […]
Il paese fu colto impreparato dalla furia espansionistica
tedesca: <<Ci potrà essere chi si chiede: come è potuto
succedere che il Governo Sovietico abbia concluso un patto
di non aggressione con gente tanto fedifraga e tirannica
come Hitler e Ribbentrop? Non è che l’Unione Sovietica ha
commesso un errore?>>. Dovette retoricamente domandare
Stalin alla nazione dai microfoni di Radio Mosca un paio
di settimane dopo l’invasione. La sua risposta, altrettanto
retorica, non poté che essere: <<Certamente no!>>.
Ma assieme al tono, al lessico e al registro utilizzato nel
breve discorso, anche dichiarazioni come questa sarebbero
passate alla storia per la loro anomalia. […]
Affrontata la situazione internazionale, Stalin sarebbe
passato al punto più emotivamente coinvolgente: l’appello al
popolo per chiedere solidarietà e abnegazione totali. Ma per
42
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
capirne la portata e l’impatto su chi lo ascoltava è necessario
tornare all’attacco del suo discorso: a quel <<Fratelli
e sorelle!>> messo quasi di sfuggita tra i più consueti e
scontati appellativi: <<Compagni! Cittadini! Combattenti
del nostro esercito e della nostra flotta!>>. E poi, con
tono familiare e domestico, pur restando ben conscio della
propria posizione e dell’effetto che un tale atteggiamento
avrebbe suscitato, il tocco finale nell’apertura: <<Sono io
che mi rivolgo a voi, amici miei!>>.
Pronunciò parole inusitate: <<Amici miei! Fratelli e
sorelle!>>, rimandando a una situazione di rapporto
non politico ma familiare, non però della scontata grande
famiglia da cartolina di Stalinland. Questa volta c’è da
credere che gli accenti intimi e amichevoli mirassero altrove.
<<Fratelli e sorelle>>, con lessico e tono che, nonostante gli
anni passati, tutti avrebbero riconosciuto essere quelli della
vecchia chiesa ortodossa, della tradizione russa contadina.
<<Fratelli e sorelle>>, ostentando una vicinanza, una
confidenza che lasciava trapelare imbarazzo, insicurezza
e paura, esplicitate dalle pause per bere, nonostante la
brevità dell’intervento. Tutto tra le righe, difficile da cogliere
per quanto inatteso e improbabile. Pressoché inaccettabile
da parte degli ascoltatori, del popolo, ma reale e inedito.
Così evocato, negli anni tra il 1955 e il 1959 (in piena
destalinizzazione), da Konstantin Simonov nel romanzo I
vivi e i morti:
<<L’altoparlante era appeso nel corridoio, accanto al
tavolino dell’infermiere di turno. Lo accesero al massimo
volume e spalancarono le porte delle corsie. Stalin parlava
con voce monotona e lenta, con un forte accento georgiano.
Una volta, durante il discorso, si poté sentire il rumore di un
43
8 settembre
bicchiere da cui beveva acqua. La voce di Stalin era bassa
di tono e di volume; sarebbe potuto sembrare perfettamente
calmo se non fosse stato per quel suo respiro pesante e
affaticato e per quell’acqua che si era messo a bere durante
il discorso. Ma, per quanto fosse agitato, l’intonazione del
suo discorso restava uniforme, la voce sorda risuonava
senza alti e bassi, né punti esclamativi>>.
Jurij Lotman noterà che nel periodo bellico e anche dopo
la guerra, nonostante la vittoria, ma proprio a causa di
queste insicurezze e timori, Stalin muterà anche il proprio
abbigliamento. Passerà dalla sobrietà della casacca militare
di chi sta a guardare gli altri, sicuro del proprio potere e
della propria forza, alla necessità del culto della personalità,
sostenuta dalla solennità di una divisa, necessaria a chi
si sente osservato e cerca modi e maniere per sostenere
una posizione che si è, seppure lievemente, incrinata.
Significative a questo proposito sono le fotografie che lo
ritraggono sulla prima pagina della Pravda, in occasione
dei festeggiamenti di novembre, nei diversi anni di guerra.
Nel 1942, ormai citato come Commissario del popolo per
la difesa, indossa ancora la classica giacca che lo aveva
contraddistinto da sempre. Nel 1943 appare con cappotto,
cappello e mostrine. Nel 1944 sul petto si affollano medaglie
e decorazioni. Nel 1945 è in divisa solenne bianca da gran
maresciallo.
(G.P. Piretto, Il radioso avvenire. Mitologie culturali sovietiche,
Torino, Einaudi, 2001, pp. 175-178)
44
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
La Germania verso la sconfitta
N
ell’estate del 1942, l’esercito germanico riprese la sua
avanzata in territorio sovietico. Tuttavia, a differenza del
1941, l’offensiva non ebbe come obiettivo principale Mosca,
bensì i campi petroliferi del Caucaso. Occupata quella preziosa regione, le truppe tedesche avrebbero poi dovuto, nelle intenzioni di Hitler, puntare sulla capitale sovietica da sud,
risalendo il Volga. Ma Hitler, dopo alcune clamorose vittorie
estive, il 23 luglio compì l’errore strategico più grave di tutta
la guerra, in quanto ordinò al suo esercito di dividersi in due
gruppi di armate, in modo da attaccare contemporaneamente
sia il Caucaso che Stalingrado, un importante centro industriale che si estendeva per una trentina di chilometri lungo
la riva destra del Volga. Il risultato fu che nessuno dei due
obiettivi venne conseguito, visto che la capacità d’urto delle armate tedesche (per altro già gravemente provate dalla
campagna del 1941) venne irrimediabilmente compromessa
da quella divisione di forze. La resistenza sovietica a Stalingrado, in particolare, fu tale che i tedeschi non ebbero mai
il completo controllo della città, ed anzi si dissanguarono nel
disperato tentativo di conquistarla. I sovietici infatti combatterono casa per casa e all’interno delle fabbriche, in un groviglio inestricabile di rovine e di macerie che rese difficile ai
tedeschi l’elaborazione di qualsiasi manovra di vasto respiro
e li obbligò a condurre quella che definirono una guerra da
topi (Rattenkrieg).
Nel novembre 1942, l’Armata Rossa passò al contrattacco e
riuscì ad accerchiare i 250 mila soldati della VI Armata tedesca
impegnata a Stalingrado. Hitler vietò esplicitamente al generale von Paulus ogni ritirata dalla città, in cui - da assedianti - i
tedeschi si erano trasformati in assediati; ma, al tempo stesso,
non vi fu nessuna possibilità né di rompere l’accerchiamento
45
8 settembre
dall’esterno né di rifornire la VI Armata per via aerea. Il risultato fu che Von Paulus, il 31 gennaio del 1943, fu costretto ad
arrendersi con gli ultimi 91 mila tedeschi superstiti. Per molti
aspetti, quella di Stalingrado fu la battaglia decisiva di tutta la
guerra. Certo, la situazione della Germania era ancora, all’inizio del 1943, tutt’altro che disperata; tuttavia, da allora in
poi, le armate tedesche persero l’iniziativa e furono costrette
sulla difensiva, subendo il peso di una coalizione di nemici che,
di mese in mese, rafforzava la propria capacità di produzione
bellica.
Nell’estate del 1943, i tedeschi lanciarono nella Russia centrale
un’ultima poderosa offensiva, denominata operazione Zitadelle. Nella regione di Kursk, dal 5 luglio al 23 agosto 1943 ebbe
luogo la più vasta battaglia campale di tutta la guerra, che
coinvolse un numero elevatissimo di carri armati, da entrambe
le parti. Sconfitto ancora una volta (il merito della vittoria spettò
soprattutto ai carri sovietici T-34, che si dimostrarono superiori
ai Tiger germanici) e ormai consapevole della formidabile potenza della coalizione nemica, Hitler decise allora di procedere
ad una mobilitazione di tutte le risorse tedesche. Ciò significò
che, per la prima volta dall’inizio della guerra, gli investimenti
diretti ai beni di consumo furono in Germania drasticamente ridotti, mentre il tenore di vita dei tedeschi venne radicalmente
ridimensionato.
Il compito di gestire l’economia tedesca in questo disperato
sforzo fu assegnato ad Albert Speer, che nel settembre 1943
assunse la carica di Ministro per l’Armamento e la Produzione di guerra. I risultati ottenuti dall’organizzazione costruita da
Speer hanno del miracoloso: basti pensare che la Germania
riuscì a produrre, nel 1944, 105.258 armi belliche (cannoni
pesanti, aerei, carri armati), contro le 36.804 del 1942. Tale
dato è ancora più sorprendente se si tiene conto che, nel 1943,
le incursioni aeree anglo-americane sui centri industriali del-
46
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
la Germania si fecero sempre più massicce e metodiche: nel
complesso, sull’intera Germania caddero 207.600 tonnellate
di bombe nel 1943, salite a 915 mila nel 1944; soltanto su
Berlino, furono sganciate 50 mila tonnellate di bombe tra il
novembre 1943 e il marzo 1944.
Per sopperire alla carenza di manodopera, vennero deportati
in Germania tecnici e operai prelevati da tutti i territori controllati dall’esercito tedesco; nel 1944, la cifra globale di tali
lavoratori stranieri occupati in Germania superava i 7 milioni.
Le loro condizioni di vita erano molto diverse, a seconda delle
caratteristiche razziali. Quanti provenivano da paesi occidentali
(Francia, Belgio, Olanda, ad esempio) erano trattati in modo
relativamente decente; russi e polacchi, invece, furono in genere sfruttati come veri e propri schiavi nei lavori più faticosi e pericolosi, quando non furono addirittura lasciati semplicemente
morire per fame e per sfinimento fisico.
I primi 148.000 civili furono catturati in URSS nel maggio
1942; in giugno se aggiunsero altri 164.000. In tutto, furono
circa 2. 800.000 (tra il 1942 e il 1944) i cittadini sovietici che
furono deportati in Germania. Le modalità di reclutamento furono ben presto così sommarie e brutali, da lasciare perplessi
persino molti funzionari tedeschi, convinti che le retate di massa
compiute nei cinema o tra le donne in fila per comprare il latte,
avessero come unico risultato quello di spingere un numero
crescente di civili nelle fila dei partigiani. Persino il governatore
della Polonia Hans Frank, verso la fine del 1943, denunciò il
fatto che le razzie indiscriminate di lavoratori polacchi (in tutto, più di 2.500.000) da spedire all’interno del Reich avevano gravissimi effetti controproducenti, in quanto aggravarono
notevolmente l’odio della popolazione contro i tedeschi. Una
volta condotti in Germania, questi lavoratori forzati dovevano
47
8 settembre
portare ben in vista sui vestiti precisi segni di identificazione: una
P per i polacchi, una OST (= Est) per i sovietici. Se qualcuno
dei deportati dall’Est avesse osato avere relazioni sessuali con
una donna tedesca, sarebbe stato punito con la pena di morte.
48
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
UN CRONISTA RUSSO A STALINGRADO
N
el 1942, lo scrittore russo Vasilij Grossman era corrispondente di guerra da Stalingrado, per il giornale dell’Armata Rossa Krasnaia Zvezda (Stella Rossa). I suoi articoli erano
un appassionato appello a resistere, per difendere l’indipendenza della Russia e la libertà del suo popolo. Lo scrittore
sperava che, dopo la guerra, Stalin avrebbe alleggerito la sua
dittatura. In questo, come molti altri, Grossman sarebbe rimasto profondamente deluso.
In un mese i tedeschi lanciarono centodiciassette attacchi
contro i reggimenti della divisione siberiana. In una terribile
giornata, la fanteria e i carri tedeschi attaccarono per ventitrè
volte. E per ventitrè volte furono respinti. Per un mese intero,
con l’eccezione di tre sole giornate, l’aviazione tedesca
rimase in volo sulla divisione dalle dieci alle dodici ore al
giorno. Il che, su un mese, fa trecentoventi ore. La sezione
operativa fece l’astronomico totale delle bombe sganciate
dai tedeschi sulla divisione: ne venne fuori un numero con
quattro zeri. La stessa cosa si può dire delle incursioni aeree.
E questo su un fronte di un chilometro e mezzo o due. Questo
fragore avrebbe potuto assordare l’umanità intera; questo
fuoco e questo metallo sarebbero bastati a incendiare e
annientare un intero Stato. I tedeschi contavano di spezzare
così la tempra morale dei reggimenti siberiani. Pensavano
di aver superato il limite di sopportazione del cuore e dei
nervi dell’uomo. Invece, cosa stupefacente, quegli uomini
non si sono piegati, non hanno perso la ragione. […]
Verso la fine della seconda decade di ottobre i tedeschi
diedero l’assalto finale alla fabbrica. Nessuno aveva ancora
49
8 settembre
visto un’azione preparatoria di quella portata. Per ottanta
ore, l’aviazione, l’artiglieria e i mortai pesanti tedeschi
attaccarono senza sosta. Per tre giorni e tre notti fu un caos
di fumo, di fuoco, di esplosioni. […] Passate ottanta ore,
la preparazione dell’artiglieria si fermò di colpo, e, dalle
cinque del mattino, fu l’attacco: carri pesanti e medi, orde
di mitraglieri forsennati, reggimenti di fanteria. I tedeschi
riuscirono a penetrare nella fabbrica; i loro carri, rombando
sotto le mura delle officine, tagliarono le nostre difese,
dividendo le postazioni di comando della divisione e dei
reggimenti dall’estremo limite della prima linea. Si poteva
pensare che la divisione, privata del comando, avrebbe
perso ogni capacità di resistenza; che i posti di comando,
esposti ai colpi diretti del nemico, sarebbero stati annientati.
Invece si verificò una cosa sorprendente: ogni trincea, ogni
rifugio, ogni nido di fanteria, così come le rovine fortificate
delle case, diventò una piccola cittadella, con il proprio
comando e i propri collegamenti. Sergenti e soldati semplici
assunsero il comando e respinsero gli attacchi con abilità e
intelligenza. […]
Questa battaglia senza pari per il suo accanimento proseguì
per molti giorni e molte notti di fila. Non si combatteva più
per il possesso di una casa o di un reparto della fabbrica.
Si combatteva per ogni gradino delle scale, per ogni
cantone di uno stretto corridoio, per una macchina, per un
passaggio tra le file dei torni, per una conduttura del gas.
[…] Gli stabilimenti della fabbrica passarono di mano in
mano più e più volte. Nel corso della battaglia, i tedeschi
riuscirono a impadronirsi di molti stabilimenti e reparti
della fabbrica. I loro assalti raggiunsero in quei momenti la
massima intensità. Era l’ultimo sforzo delle armate nemiche
50
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
sull’asse di tensione principale: come se, per aver sollevato
un carico troppo pesante, la forza interiore che, metteva in
azione il loro ariete, fosse venuta meno.
(V. Grossman, Anni di guerra, Napoli, L’ancora, 1999, pp. 7177. A cura di M. Bellini)
STALINGRADO
L
a seconda poderosa offensiva tedesca iniziò il 28 giugno
1942. Incapaci di fronteggiare l’attacco nemico, i russi si
ritirarono fino al Volga, cosicché Stalingrado divenne il punto
strategico più importante del fronte. Tra le macerie della città,
si svolse uno scontro spietato e confuso, che i tedeschi definirono Rattenkrieg (guerra da topi). Per i sovietici, l’unica speranza di vittoria consisteva nel costante flusso di rifornimenti
che arrivava dalla riva orientale del fiume Volga.
Durante la precipitosa ritirata [dell’estate 1942 – n.d.r.]
la disciplina dell’esercito sovietico cominciò a cedere: i
reparti abbandonavano le armi e gli equipaggiamenti, i
soldati preferivano ricorrere all’autolesionismo piuttosto
che affrontare il gigante tedesco. L’autorità degli ufficiali
e dei commissari militari minacciò di dissolversi. Il 28 luglio
Stalin si mosse per frenare il crollo, emanando l’ordine
227, Ne Shagu Nazad! (Neppure un passo indietro!). La
pubblicazione dell’ordine capitò in un momento di crisi
acuta. Stalin disse alle forze armate che la ritirata doveva
interrompersi: <<Ogni posizione, ogni metro di territorio
51
8 settembre
sovietico deve essere difeso con accanimento, fino all’ultima
goccia di sangue. Dobbiamo aggrapparci a ogni centimetro
di suolo sovietico e dobbiamo difenderlo fino alla fine!>>.
Dopo la guerra fu vietato divulgare i particolari dell’ordine
numero 227, anche se era stato distribuito a tutti i reparti
combattenti. […] Tutti coloro che fossero caduti nelle maglie
di quell’ordine, sia i disseminatori di panico che i codardi,
erano passibili di esecuzione sommaria o di essere assegnati
agli shtrafbaty, i battaglioni penali. […] Le rivelazioni sul
terrore nelle forze armate mettono in luce un’evidente realtà
storica, ma distorcono anche la nostra visione dello sforzo
bellico sovietico: non tutti i soldati avevano un fucile puntato
alla schiena, non tutti i casi di sacrificio e di sfida coraggiosa
erano il prodotto della coercizione e della paura. Crederlo
significherebbe sminuire l’eccezionale eroismo di migliaia di
uomini e donne normali, la cui sincera dedizione alla causa
sovietica non può essere messa in dubbio. Nell’estate e
nell’autunno del 1942 la popolazione sovietica era animata
da qualcosa di più della paura dell’NKVD. […] [= Narodnyj
komissariat vnutrennich del, cioè Commissariato del popolo
agli affari interni - n.d.r.] La guerra divenne non una
semplice difesa del comunismo, con il quale molti russi non
erano d’accordo, ma una lotta patriottica contro un nemico
temuto e odiato. […]
Le battaglie di settembre avevano spinto l’Armata Rossa
ai limiti della resistenza umana e del Volga. In tre giorni
di aspri combattimenti, iniziati il 13 settembre, le forze
tedesche si fecero strada attraverso le macerie e le rovine,
fino alla stazione ferroviaria centrale e alle pendici del
Kurgan di Mamajev. La stazione cambiò padrone quindici
volte. Piccoli distaccamenti di soldati sovietici attaccavano di
52
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
notte per riconquistare quello che i tedeschi avevano preso
di giorno. La sommità del Kurgan di Mamajev fu conquistata
prima da una parte, poi dall’altra. La collina si trasformò
in un paesaggio lunare, cosparso di crateri e di cenere
grigia. Di fronte a forze tanto superiori, le truppe esauste
di Cujkov si ritiravano casa per casa, isolato per isolato, in
gruppi formati dai superstiti di quelle che un tempo erano
state intere divisioni. Sull’altra riva del Volga era rimasto
poco da inviare in soccorso. Disperato, Stalin ordinò alla
13ª divisione della Guardia, comandata da Aleksandr
Rodimtsev, un eroe dell’Unione Sovietica, di accorrere a
prestare aiuto. La divisione sbarcò in uno spoglio capolinea
ferroviario allestito in mezzo alla steppa, a chilometri dal
fronte. I soldati intrapresero un’estenuante marcia forzata e
arrivarono al traghetto stanchi, in qualche caso disarmati.
Ma, come la cavalleria dei proverbi, arrivarono appena
in tempo: Cujkov stava resistendo, con soli quindici carri
armati e pochi uomini, agli sforzi furiosi della 6ª armata per
giungere alle banchine del centro. Le Guardie di Rodimtsev
furono immediatamente traghettate su alcune barche e
gettate nel pieno della battaglia, in pratica senza alcuna
preparazione. Le loro perdite raggiunsero quasi il 100
percento, ma ottennero il risultato voluto: la 62ª armata
tenne la sua sottile striscia di riva occidentale del Volga, e
la città fu salva.
Il campo di battaglia, nel quale erano stati gettati gli uomini
di Rodimtsev, non assomigliava a nessun campo di battaglia
conosciuto: la città sembrava essere stata l’epicentro di un
gigantesco terremoto. Su tutta l’area si era posato uno strato
di cenere spessa e scura prodotta dall’incendio degli edifici,
e si sollevava in nuvole di cenere grigia a ogni scoppio di
53
8 settembre
un’altra granata o a ogni soffio del vento della steppa.
Nell’aria gravavano gli odori acri del legno e dei mattoni
bruciacchiati e, a volte, il puzzo della carne bruciata. Ogni
nuovo bombardamento aereo o d’artiglieria contorceva
ulteriormente le rovine. I soldati sovietici e tedeschi si
nascondevano o vivevano nelle cantine, combattevano tra
i muri abbattuti, che fornivano un riparo sommario contro
il fuoco continuo delle mitragliatrici pesanti e dei mitra. Le
linee del fronte non erano definite in modo netto: le due parti
non distavano più di un lancio di bomba a mano. I soldati
sovietici che si trovavano intrappolati dietro le linee tedesche
continuavano a combattere. Furono quasi tutti feriti, ma le
ferite leggere non garantivano più il ritiro dal combattimento.
I feriti gravi venivano recuperati, se possibile, ma morirono a
centinaia là dov’erano caduti, preda delle torme di ratti che
correvano come un fiume caldo sui vivi e sui morti.
La strategia seguita da Cujkov e da Paulus fu molto
semplificata dalla battaglia. Il comandante sovietico doveva
tenere Stalingrado a qualsiasi costo, l’obiettivo tedesco era
spingere i difensori nel Volga. Il conflitto non si basava sulla
strategia, ma sulla tattica. In breve tempo Cujkov divenne
un maestro del combattimento urbano. Ordinò ai suoi
uomini di tenersi il più vicino possibile alle linee tedesche,
obbligando il nemico a rinunciare alla superiorità aerea e
di fuoco per evitare di colpire le proprie truppe. Alla fine
di settembre questo era anche un fatto di sopravvivenza,
perché solo poche centinaia di metri separavano i reparti
avanzati tedeschi dalla riva del fiume. Oltre il Volga,
dalle posizioni sovietiche della riva orientale, giungeva un
ininterrotto bombardamento d’artiglieria e di razzi, facilitato
dal fatto di avere un bersaglio molto più ampio. L’esercito
54
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
tedesco trovò il conflitto urbano molto diverso, in peggio,
dalle veloci operazioni aeree e corazzate attraverso la
steppa. A Stalingrado si trovò a dover combattere in modo
frustrante contro un nemico inafferrabile e micidiale. Cujkov
ordinò ai suoi uomini di sfruttare in tutti i modi il terreno e
le proprie capacità combattive. Quando potevano, le forze
sovietiche combattevano di notte: si infiltravano tra i reparti
tedeschi e, a un dato ordine, lanciavano urla spaventose,
sparando con le mitragliatrici contro il nemico atterrito. Di
notte sui soldati tedeschi scendeva una coltre di paura. I rudi
siberiani e i tartari sovietici usavano i coltelli e le baionette
per massacrare le unità nemiche rimaste isolate, impreparate
al combattimento corpo a corpo nell’oscurità. Di giorno i
cecchini restavano appostati in attesa di qualunque cosa si
muovesse nel settore tedesco. Giunsero da Berlino eccellenti
tiratori, scelti per neutralizzare la minaccia dei cecchini,
ma caddero anch’essi vittime della guerra nascosta
dell’Armata Rossa. Un sottufficiale tedesco scrisse: <<È un
combattimento accanito. Il nemico spara da tutte le parti,
da ogni buco. Non devi mai farti vedere>>.
(R. Overy, Russia in guerra 1941-1945, Milano, Net, 2003, pp.
169-172 e 183-185. Traduzione di P. Modola)
GUERRA AEREA E STRATEGIA MILITARE
N
egli anni Trenta, si fronteggiarono due diverse scuole di
pensiero strategico, a proposito della guerra aerea. Mentre un primo gruppo di politici e di militari diede la precedenza
55
8 settembre
ad aerei di piccola o media dimensione, da usare soprattutto
in battaglia, a sostegno dell’esercito, un secondo orientamento era favorevole alla costruzione di aerei imponenti, capaci di
portare distruzione nelle città del nemico.
Con l’importante eccezione degli Stati Uniti, nessuno degli altri
stati in guerra vedeva grandi vantaggi nei bombardamenti
strategici a lungo raggio: su iniziativa dello stesso Stalin il
programma di sviluppo dei bombardieri pesanti era stato
chiuso in Unione Sovietica già nel 1937 e gli sfortunati
promotori, capeggiati da Aleksandr Tupolev, spediti in
campi di lavoro, dove continuarono la loro opera dietro il
filo spinato. L’esperienza della guerra civile spagnola, nella
quale i piloti sovietici avevano combattuto a fianco delle
forze repubblicane contro Franco nel 1936, aveva convinto
Stalin che le forze aeree erano più utili se usate in prima
linea, come appoggio per l’esercito. Gli osservatori tedeschi
e francesi arrivarono più o meno alle stesse conclusioni.
Durante la guerra civile spagnola l’aeronautica provò in
combattimento il suo nuovo bombardiere da picchiata, lo
Junker Ju-87 [meglio noto col nome di Stuka – n.d.r.], con
la sua terrificante sirena che annunciava il bombardamento
imminente. Questo aereo era opera del colonnello Ernst
Udet, aviatore di mitica fama che faceva fremere le platee
cinematografiche negli anni Venti con le sue acrobazie, oltre
che essere un noto vignettista. L’appoggio dato alla causa di
Hitler gli fruttò l’incarico di dirigere la produzione delle forze
aeree tedesche. Il suo amore per le acrobazie aeree lo portò
a trascurare i bombardamenti a lungo raggio per favorire
bombardieri più piccoli che potessero scendere in picchiata
e distruggere anche bersagli di piccole dimensioni sul
56
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
campo di battaglia. Quando il responsabile dell’aviazione
tedesca, Hermann Göring, insistette perché la Germania
producesse anche un bombardiere quadrimotore a lungo
raggio d’azione, Udet disse ai progettisti tedeschi che
anch’esso doveva essere in grado di scendere in picchiata,
una richiesta che ne ritardò la realizzazione di tre anni.
Quando scoppiò la guerra la Germania diede la priorità
alla cooperazione tra l’aviazione e l’esercito, una strategia
che fu mantenuta, così come in Unione Sovietica, fino alla
fine del conflitto.
Perché dunque Gran Bretagna e Stati Uniti si schierarono
contro ogni conoscenza militare acquisita e insistettero
con i bombardamenti? [...] L’aviazione e i politici britannici
rimasero legati alla loro visione degli anni tra le due guerre
mondiali che un bombardamento indiscriminato, finalizzato
al raggiungimento di un rapido <<colpo finale>>,
sarebbe stato probabilmente una delle caratteristiche
della successiva guerra: per opporsi alla minaccia dei
bombardamenti bisognava dotarsi a propria volta di
bombardieri propri. Le radici della deterrenza post-bellica
risalgono dunque alla decisione britannica degli anni Trenta
di costituire una potente forza d’attacco di bombardieri per
spaventare i potenziali nemici.
C’erano, naturalmente, ragioni più fondate per portare
avanti i bombardamenti che non il timore di esserne
vittime. Nessuno voleva che si ripetesse lo spaventoso
spargimento di sangue della grande guerra, e una guerra
di bombardamenti, nonostante i suoi molteplici orrori,
sembrava promettere un conflitto più rapido e asettico. Il
colonnello Fitzmaurice confortò i suoi lettori rassicurandoli
che il suo Super-Armageddon avrebbe posto fine alle guerre
57
8 settembre
di logoramento una volta per tutte, garantendo che queste
erano <<sepolte e dimenticate nel fango, nella poltiglia e nei
cimiteri di guerra delle Fiandre>>. A paragone dello spreco
di giovani vite nello stallo delle trincee, i bombardamenti
potevano causare una settimana di orrori seguita dalla resa:
si profilava insomma una guerra a poco prezzo, che faceva
risparmiare non solo vite ma anche denaro, una strategia
economica che risultava parimenti attraente al contribuente
democratico e al ministro del Tesoro.
Tutto ciò lasciava aperte importanti questioni: cosa avrebbero
dovuto colpire i bombardieri? [...] L’aviazione britannica
e quella americana, assai più libere dalle soffocanti
restrizioni di eserciti con lunga tradizione, volevano una
strategia che concedesse loro un’effettiva indipendenza,
il giusto complemento della novità e modernità delle
armi a loro disposizione. Scelsero poi quello che venne
chiamato il bombardamento strategico, per distinguerlo
dal puro e semplice bombardamento tattico di appoggio
all’esercito e alla marina. L’obiettivo del bombardiere
strategico era il cuore stesso del paese nemico, la sua
popolazione e la sua economia. La grande guerra aveva
aperto la strada a un nuovo genere di conflitto, la guerra
totale, nella quale la distinzione tra civile e militare non
valeva: il bombardiere ne era lo strumento per eccellenza,
capace com’era di polverizzare le industrie del nemico e
terrorizzare la popolazione per indurla alla resa. [...] Per
tutti gli anni Trenta, e ancora nelle prime fasi della guerra,
questa strategia fu impossibile da realizzare tecnicamente e
operativamente poco seria. Nel dicembre 1937, comunque,
il comando bombardieri britannico ricevette l’ordine di
progettare la distruzione dell’economia tedesca con una
58
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
serie di bombardamenti, e da quel momento fu posta la
base di quella che sarebbe diventata l’offensiva coordinata
di bombardamenti lanciata nel 1943.
(R. Overy, La strada della vittoria. Perché gli Alleati hanno vinto la seconda guerra mondiale, Bologna, Il Mulino, 2002, pp.
157-159. Traduzione di N. Rainò)
L’INGEGNERIA DELL’INCENDIO
L
’esperienza dimostrò, nel giro di poco tempo, che era più
facile provocare gravi danni alle città nemiche con il fuoco,
piuttosto che per mezzo delle bombe dirompenti ad alto potenziale. Le città tedesche, dunque, si trasformarono in giganteschi roghi, impossibili da domare.
Sin dalla fine del 1942 gli scienziati alle dipendenze del
ministero dell’Aviazione britannico studiavano un modo per
mettere a frutto le proprietà distruttive del fuoco. Le bombe
dirompenti erano pesanti da trasportare e infliggevano
danni che impressionavano relativamente poco il nemico;
il materiale incendiario era più leggero, poteva essere
sganciato in grossi quantitativi e, una volta colpito
l’obiettivo, dava inizio a un processo di distruzione che si
propagava da sé. In determinate circostanze una bomba
incendiaria da due chilogrammi desertificava una superficie
superiore a quella devastata da una bomba dirompente
mille o duemila volte più pesante. [...] Gli attacchi
incendiari scatenati sulle città tedesche costituirono una
59
8 settembre
novità assoluta nella storia bellica: era la prima volta che il
controllo di un’arma era totalmente in mano agli scienziati,
la prima volta che ideazione e utilizzo andavano così di pari
passo. Quando fu raggiunto il culmine della sinergia fra
conoscenze, realizzabilità tecnica, disponibilità di materiale
e apparecchiature, la guerra finì. Se gli Alleati non si fossero
dedicati con tenacia all’elaborazione anche concettuale
dell’annientamento, la tempesta di fuoco sarebbe rimasta
un’arma spuntata com’era all’inizio. Prima di raggiungere
la perfezione, si procedette a lungo a tastoni, attraverso
correzioni progressive.
Inizialmente il fuoco veniva appiccato soltanto per illuminare
gli obiettivi delle bombe dirompenti durante gli attacchi
notturni. L’analisi comparativa delle riprese aeree dimostrò
che settemila tonnellate d’esplosivo causavano trenta
chilometri di danni, mentre la stessa quantità di sostanze
incendiarie ne provocava centocinquanta. L’opinione
secondo cui le città erano più facili da bruciare che da far
esplodere e che un incendio di dimensioni sufficienti avrebbe
raggiunto entrambi gli obiettivi si consolidò solo nell’estate
del 1943. Ci si arrivò con l’esperienza e con una serie di
bombardamenti che in parte funzionarono e in parte no. [...]
Il primo lancio sperimentale di uno spezzone incendiario era
avvenuto nel 1936, grazie alla collaborazione tra la RAF [
= Royal Air Force – n.d.r.] e le Imperial Chemical Industries;
il test fu considerato un successo: la bomba si accendeva
sempre e non si spezzava mai. Nell’ottobre dello stesso
anno, il governo britannico ne ordinò 4.500.000 esemplari.
Allo scoppio della guerra, le scorte erano di cinque milioni.
La robustezza, l’efficienza incendiaria e l’abbondanza
fecero delle bacchette di electron imbottite di termite (in
60
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
coppia con le blockbusters [= schiacciaisolati; si trattava
di bombe dirompenti cilindriche da 4.000 libbre - n.d.r.])
l’arma principe della guerra aerea sulla Germania. Nel
1944, una semplice modifica rese l’impiego degli spezzoni
incendiari ancora più micidiale. Gli ordigni cominciarono a
essere sganciati in grappoli legati fra loro che si separavano
poco prima dell’urto. La densità maggiore permise di
produrre vere e proprie tempeste di fuoco capaci di divorare
città come Darmstadt, Heilbronn, Pforzheim e Würzburg. Un
bombardamento protratto per più giorni, a base di diverse
miscele incendiarie di benzina, gomma, resina artificiale,
olio, asfalto fluido, glicerina e piccole quantità di saponi
metallici, acidi grassi e fosforo, dispiegava un potenziale
distruttivo superato solo dalle armi nucleari.
(J. Friedrich, La Germania bombardata. La popolazione tedesca
sotto gli attacchi alleati 1940-1945, Milano, Mondadori, 2004,
pp. 11-18. Traduzione di M. Bosonetto, F. Pisani, C. Proto)
61
ia
Grecia - Cefalon
Soldati italiani in
Dimensione nazionale
La guerra del Duce:
dall’intervento alla disfatta
Non belligeranza e guerra parallela
S
econdo il Patto d’acciaio (stipulato solennemente il 22
maggio 1939), l’Italia avrebbe dovuto immediatamente
entrare in guerra a fianco del Terzo Reich, nel momento stesso
in cui la Germania iniziava l’invasione della Polonia. Mussolini tuttavia, quando venne a conoscenza della decisione di
Hitler di iniziare il conflitto in tempi brevi, presentò all’alleato
un lunghissimo elenco di richieste, che mettevano a nudo la
strutturale debolezza economica dell’Italia.
Sul piano strettamente militare, le carenze delle forze armate
italiane erano a dir poco clamorose. Il paese era del tutto privo
di difesa contro i bombardamenti nemici: con 2 (due!) riflettori e
230 batterie antiaeree era evidentemente impossibile difendere
tutte le città del vasto territorio nazionale. L’Italia poi non possedeva aerei, carri armati e pezzi d’artiglieria moderni e adeguati, mentre le navi non erano munite di alcun tipo di radar.
In realtà, le carenze militari dell’esercito italiano non erano da
attribuire al solo Mussolini: molti generali italiani, infatti, non
avevano appreso alcuna lezione dal primo conflitto mondiale
e continuavano ad affermare che l’uomo, non la macchina,
era l’elemento vincente in uno scontro bellico. Pertanto, non
meraviglia che lo stato maggiore italiano non abbia mai seriamente imposto alla FIAT-Ansaldo di progettare un carro armato
davvero efficiente e pesante, capace di reggere il confronto con
i mezzi inglesi o russi, e sia stato a dir poco tollerante e indulgente nei confronti dei pessimi prodotti con cui la casa torinese
riforniva le forze armate.
Nel settembre 1939, Hitler disse a Mussolini che, per la sua
63
8 settembre
guerra, non aveva certo bisogno dell’Italia; il Duce optò allora
per la cosiddetta non belligeranza, un’espressione che, nelle
sue intenzioni, non significava affatto neutralità, bensì pieno
appoggio politico alla Germania, senza diretta ed effettiva
partecipazione al conflitto. La prospettiva prevista dal Duce era
quella di una guerra lunga, nella quale l’Italia avrebbe potuto
intervenire nel giro di due o tre anni. La rapida e imprevista
sconfitta della Francia sconvolse completamente i progetti di
Mussolini, che il 10 giugno 1940 annunciò pubblicamente la
sua decisione di scendere in campo. La ragione per cui Mussolini, pur consapevole della gravissima impreparazione delle
forze armate italiane, scelse ugualmente di gettare il Paese nel
conflitto, va ricercata fondamentalmente nella sua convinzione
che Hitler avesse già vinto la guerra. Sconfitta la Francia - secondo Mussolini – l’Inghilterra sarebbe senz’altro scesa a patti
con la Germania; pertanto, solo una partecipazione effettiva e
diretta allo scontro, secondo il dittatore fascista, avrebbe garantito all’Italia la possibilità di far udire la propria voce all’imminente tavolo delle trattative di pace.
Il progetto di Mussolini era di conquistare la Corsica, Nizza, la
Savoia e alcune colonie, capaci di ingrandire l’impero fascista.
In una prospettiva ancora più ambiziosa, il Duce sperava di
creare una vasta area sotto controllo italiano e di realizzare
una duratura egemonia romana nel Mediterraneo e nei Balcani. Tuttavia, nell’estate del 1940, poiché la Gran Bretagna
respinse ogni offerta di armistizio da parte di Hitler, l’Italia si
trovò coinvolta in un grande conflitto europeo, senza avere la
minima speranza di vincerlo.
L’11 novembre 1940, gli aerosiluranti inglesi riuscirono senza
problemi ad affondare tre corazzate nel porto di Taranto e a
mettere fuori combattimento metà dell’intera flotta da guerra
italiana. Qualche mese più tardi, il 27 marzo 1941, al largo
di Capo Matapan (la punta più meridionale della Grecia) gli
64
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
italiani persero altri 5 incrociatori e 2.400 marinai. In Etiopia,
intanto, le mal equipaggiate truppe italiane - del tutto tagliate
fuori dalla madrepatria e quindi assolutamente prive di rifornimenti - subirono presto gravi sconfitte e non poterono impedire
che, il 6 aprile 1941, gli inglesi occupassero Addis Abeba e
rimettessero sul trono il negus Hailè Selassiè.
Mentre le disfatte si moltiplicavano, nel giro di pochi mesi le
riserve d’oro dello Stato minacciarono di esaurirsi e il paese
divenne totalmente dipendente dalla Germania per il proprio
fabbisogno energetico. Il Terzo Reich fornì all’Italia 12 milioni
di tonnellate di carbone nel 1940-1941 e 11 milioni nel 19411942; malgrado questo sforzo tedesco, la già magra produzione di acciaio in Italia (nel 1938, essa era un decimo di quella
tedesca e pari al 38% di quella giapponese) calò vistosamente
passando da 2,32 milioni di tonnellate (1938) a 1,73 milioni di
tonnellate (1942), a causa della carenza di materie prime. Con
un simile retroterra industriale precario, l’esercito e la marina
si trovarono subito in gravi difficoltà, in quanto non furono in
grado di sostituire il materiale che veniva distrutto dal nemico. Mussolini però non comprese mai le strutturali debolezze dell’esercito e della società che guidava, ed anzi continuò a sopravvalutare ampiamente le reali possibilità italiane. Pertanto, il 28
ottobre 1940 dichiarò guerra alla Grecia. L’obiettivo del Duce
era di tipo politico, cioè voleva mostrare che l’Italia non era
una semplice pedina tedesca, bensì poteva condurre - in piena
autonomia e proprie risorse - una guerra parallela, con obiettivi rispondenti solo agli interessi italiani. L’attacco fu condotto dall’Albania, un piccolo regno che l’Italia aveva occupato
nell’aprile del 1939, dopo che la Germania si era impadronita,
in marzo, della Cecoslovacchia. Mussolini immaginava una
campagna rapida, capace di portare gloria e prestigio al re-
65
8 settembre
gime. All’opposto, incontrò una tenacissima resistenza greca,
mentre sulle montagne i soldati italiani dovettero affrontare il
freddo invernale con un equipaggiamento scadente e inadeguato. Insomma, l’insuccesso fu totale, e il risultato fu del tutto opposto a quello sperato. L’esercito italiano fu salvato dalla
completa disfatta solo in virtù del tempestivo intervento tedesco
nei Balcani, nell’aprile 1941.
66
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
DISCORSO DI MUSSOLINI DEL 10 GIUGNO 1940
M
ussolini annunciò l’entrata in guerra dell’Italia con un
solenne discorso, pronunciato dal balcone di Palazzo
Venezia, a Roma. In quell’occasione, il Duce rilanciò la retorica nazionalista (inventata da Enrico Corradini) secondo cui
nel mondo le nazioni giovani, feconde e proletarie si contrapponevano ai paesi ricchi, ma ormai condannati al declino
politico.
Combattenti di terra, di mare e dell’aria! Camicie nere
della rivoluzione e delle legioni! Uomini e donne d’Italia,
dell’impero e del Regno d’Albania! Ascoltate!
Un’ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra
patria. L’ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione
di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di
Gran Bretagna e di Francia. Scendiamo in campo contro
le democrazie plutocratiche e reazionarie dell’Occidente,
che, in ogni tempo, hanno ostacolato la marcia, e spesso
insidiato l’esistenza medesima del popolo italiano.
Alcuni lustri della storia più recente si possono riassumere
in queste frasi: promesse, minacce, ricatti e, alla fine, quale
coronamento dell’edificio, l’ignobile assedio societario
[= promosso dalla Società delle Nazioni – n.d.r.] di
cinquantadue Stati.
La nostra coscienza è assolutamente tranquilla. Con voi il
mondo intero è testimone che l’Italia del Littorio ha fatto
quanto era umanamente possibile per evitare la tormenta
che sconvolge l’Europa; ma tutto fu vano.
Bastava rivedere i trattati per adeguarli alle mutevoli
67
8 settembre
esigenze della vita delle nazioni e non considerarli intangibili
per l’eternità; bastava non iniziare la stolta politica delle
garanzie [= allusione a Francia e Inghilterra, che nel
1939 si erano impegnate a garantire l’indipendenza della
Polonia, in caso di aggressione da parte della Germania
– n.d.r.], che si è palesata soprattutto micidiale per coloro
che le hanno accettate [= per la Polonia, di cui Francia e
Inghilterra non avevano potuto impedire la conquista, da
parte della Germania – n.d.r.]; bastava non respingere la
proposta che il Führer fece il 6 ottobre dell’anno scorso,
dopo la finita campagna di Polonia.
Oramai tutto ciò appartiene al passato. Se noi oggi siamo
decisi ad affrontare i rischi ed i sacrifici di una guerra,
gli è che l’onore, gli interessi, l’avvenire ferreamente lo
impongono, poiché un grande popolo è veramente tale se
considera sacri i suoi impegni e se non evade dalle prove
supreme che determinano il corso della storia.
Noi impugniamo le armi per risolvere, dopo il problema
risolto delle nostre frontiere continentali, il problema delle
nostre frontiere marittime; noi vogliamo spezzare le catene
di ordine territoriale e militare che ci soffocano nel nostro
mare, poiché un popolo di quarantacinque milioni di
anime non è veramente libero se non ha libero l’accesso
all’Oceano. Questa lotta gigantesca non è che una fase
dello sviluppo logico della nostra rivoluzione; è la lotta dei
popoli poveri e numerosi di braccia contro gli affamatori che
detengono ferocemente il monopolio di tutte le ricchezze
e di tutto l’oro della terra; è la lotta dei popoli fecondi e
giovani contro i popoli isteriliti e volgenti al tramonto; è la
lotta tra due secoli e due idee.
Ora che i dadi sono gettati e la nostra volontà ha bruciato
68
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
alle nostre spalle i vascelli, io dichiaro solennemente che
l’Italia non intende trascinare altri popoli nel conflitto con
essa confinanti per mare o per terra. Svizzera, Jugoslavia,
Grecia, Turchia, Egitto prendano atto di queste mie parole
e dipende da loro, soltanto da loro, se esse saranno o no
rigorosamente confermate.
Italiani!
In una memorabile adunata, quella di Berlino, io dissi
che, secondo le leggi della morale fascista, quando si ha
un amico si marcia con lui sino in fondo. Questo abbiamo
fatto e faremo con la Germania, col suo popolo, con le sue
meravigliose Forze Armate. In questa vigilia di un evento
di una portata secolare, rivolgiamo il nostro pensiero alla
Maestà del re imperatore, che, come sempre, ha interpretato
l’anima della patria. E salutiamo alla voce il Führer, il capo
della grande Germania alleata.
L’Italia, proletaria e fascista, è per la terza volta [dopo la
guerra in Etiopia e quella di Spagna – n.d.r.] in piedi, forte,
fiera e compatta come non mai. La parola d’ordine è una
sola, categorica e impegnativa per tutti. Essa già trasvola
e accende i cuori dalle Alpi all’Oceano Indiano: vincere! E
vinceremo, per dare finalmente un lungo periodo di pace
con la giustizia all’Italia, all’Europa, al mondo.
Popolo italiano!
Corri alle armi, e dimostra la tua tenacia, il tuo coraggio, il
tuo valore!
(E. Collotti, La seconda guerra mondiale, Torino, Loescher,
1985, pp. 90-91)
69
8 settembre
LE CARENZE STRUTTURALI DELLE FORZE ARMATE
ITALIANE
L
o storico inglese MacGregor Knox è uno specialista di Storia militare che ha studiato in modo dettagliato il Regio
Esercito durante la seconda guerra mondiale. A suo giudizio,
la disfatta fu l’inevitabile conseguenza della combinazione di
due fattori: le errate valutazioni politiche di Mussolini e la meschinità dei vertici militari, accusati da Knox di incompetenza,
provincialismo, ottuso attaccamento al passato e connivenza
con la venalità della grande industria. La sua impietosa conclusione è che <<il fallimento militare dell’Italia fascista fu
innanzitutto il fallimento della cultura militare e delle istituzioni
militari italiane>>.
Resta fuori questione che le armi e i weapon systems [=
l’apparato bellico – n.d.r.] italiani erano i meno efficaci, i
meno numerosi e i più costosi prodotti nei principali paesi
belligeranti della seconda guerra mondiale. L’acciaio
italiano costava il quadruplo rispetto al prezzo del mercato
internazionale. Secondo una stima autorevole, le nuove
corazzate della classe Littorio consegnate alla marina
a partire dal 1940 furono pagate il doppio di quanto
sarebbero costate se fossero state costruite nei cantieri
francesi, certo non i più economici del mondo. E in settori
quali progettazione di macchine belliche, metallurgia,
tecnica della catena di montaggio, macchine utensili,
strumenti di precisione, elettronica per le comunicazioni,
radiolocalizzatori e ecogoniometri, l’industria italiana entrò
in guerra – e in grande misura rimase sempre – in una
condizione di ostinata e provinciale arretratezza. Ricerca e
70
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
controllo di qualità in settori chiave quale quello dei mezzi
corazzati erano a un livello rudimentale o del tutto assenti;
le piastre bullonate del primo carro armato medio FIATAnsaldo che vide un ampio impiego in guerra, l’M13/1940,
si frantumavano come vetro. La progettazione di veicoli e
carri armati era un’attività che dipendeva dalla genialità
individuale e dalla sperimentazione condotta a tastoni da
dei singoli progettisti, anziché da un lavoro di squadra;
all’Ansaldo un solo uomo progettò tutti i carri armati e i
mezzi corazzati italiani dal 1933 al 1943. Non sorprende
dunque che non riuscì mai a costruire un carro armato
soddisfacente. Nonostante la cattura e il trasferimento in
Italia a scopo di studio – nel 1941-42 – di un T-34 sovietico,
il miglior carro armato medio di tutta la guerra, il prodotto
più affidabile della FIAT-Ansaldo fu un semovente alquanto
robusto con un obice da 75 mm a bassa velocità iniziale.
Peraltro il complesso industriale non tollerò la competizione
di macchine straniere di gran lunga migliori quali il carro
medio che la Skoda offrì nel 1941. La FIAT-Ansaldo riuscì
clandestinamente a impedire la produzione in Italia del
Panzer III o IV, di cui la Germania – e Hitler in persona –
offrì in diverse occasioni i progetti, il brevetto e finanche i
macchinari per costruirlo.
Sebbene la produzione di velivoli fosse oligopolistica più
che monopolistica, il reparto aviazione FIAT si distinse per
aver progettato e venduto all’aeronautica forse il peggior
monoplano da caccia della seconda guerra mondiale,
il FIAT G50. La raffinatezza aerodinamica evidente, ad
esempio, nello Zero nipponico – un aereo che, benché
montasse un motore simile al G50 e al Macchi MC200, era
equipaggiato con due cannoncini da 20 mm anziché con le
71
8 settembre
inutili mitragliatrici degli apparecchi italiani – era pressoché
assente. Analogamente, fino al 1942-43 l’industria non
riuscì a produrre un efficiente aereo da assalto al suolo:
quelli con cui l’aeronautica entrò in guerra erano un pericolo
più per l’equipaggio che per il nemico. La progettazione di
motori avio era incentrata su copie e derivazioni di motori
stranieri brevettati negli anni Venti e nei primi anni Trenta.
L’incapacità dell’industria petrolifera statale e parastatale
di produrre carburanti ad alto numero di ottani o lubrificanti
che non rovinassero i motori contribuì anch’essa a frenare
l’innovazione. Tutti i tentativi di progettare l’affidabile
motore da 1500 CV necessario ad alimentare i caccia
monoposto da 650 km/h e armati di cannoncini fallirono
miseramente. L’azienda Piaggio falsificò impunemente
i risultati di una prova di omologazione di un suo motore
dopo essere entrata nel mirino perché i motori si fermavano
regolarmente in volo. L’aeronautica portò la questione
all’attenzione di Mussolini, ma la Piaggio continuò a
produrre motori talmente inaffidabili da risultare pericolosi.
Lo stesso rappresentante dell’aeronautica distaccato presso
la Piaggio, preso di petto, affermò seraficamente che i
tecnici addetti al controllo di qualità dell’aeronautica erano
eccessivamente severi: <<Ma non avete ancora capito che
tanto la guerra la fanno i tedeschi?>>. […]
Per l’esercito, l’elemento decisivo della guerra era
la superiorità numerica, un’ottica solo in apparenza
corroborata [= confermata – n.d.r.] dall’esperienza del
1915-18. Sul finire del primo conflitto mondiale il regio
esercito aveva acquisito un buon numero di macchine
da guerra, ma i suoi vertici avevano sempre rifiutato una
realtà che l’alto comando tedesco aveva invece accettato
72
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
già a metà del 1916: la guerra era diventata una guerra
di macchine. Alla fiducia nella volontà umana si affiancava
la fede nel numero; e forse entrambe contribuirono a far sì
che l’esercito tollerasse fino al 1939 di vedersi consegnare i
carri armati leggeri L3 da 3,5 tonnellate della FIAT-Ansaldo,
facilmente perforabili dal fuoco delle mitragliatrici e che in
un’occasione vennero distrutti da abissini armati di pietre.
[…] Malgrado le sue gravi inefficienze, la FIAT-Ansaldo
godette sempre della tolleranza dell’esercito. E sebbene
l’ultimo capo di stato maggiore del periodo prebellico,
Pariani, avesse correttamente previsto già nel 1936-37 che
il centro di gravità strategico dell’imminente guerra italiana
sarebbe stato un’avanzata su Suez, progettò di combattere
tale guerra principalmente con la fanteria autotrasportata.
Il primo carro armato medio italiano, il pessimo M11/39,
aveva il cannone praticamente inservibile perché collocato
in casamatta anziché sulla torretta girevole, una soluzione
evidentemente dettata dall’incapacità di progettare
torrette con cannoni o dalla presunta necessità di ridurre
la larghezza del veicolo per adattarlo alle strade italiane.
Uno dei pochi generali italiani con esperienza di comando
di unità corazzate in combattimento, Ettore Bastico, fu
evidentemente così intimidito dall’opposizione dei suoi
colleghi alla nuova arma che durante una riunione di
generali superiori indetta nel novembre del 1937 per
discutere del futuro dei mezzi corazzati, convenne che <<il
carro è un mezzo potente che non dobbiamo disconoscere,
ma non gridiamogli osanna. L’osanna riserviamolo per il
fante e per il mulo>>. L’innovazione fu sempre vista con
sospetto, in quanto significava scompaginare una struttura
di forze che rifletteva una concezione bellica profondamente
73
8 settembre
radicata nell’esercito e serviva al meglio gli interessi del
corpo ufficiali. La cosa davvero straordinaria è quanto poco
e quanto lentamente le dure lezioni della guerra scalfirono
la venerazione dell’esercito per la fanteria e per i muli.
(MG. Knox, Alleati di Hitler. Le regie forze armate, il regime fascista e la guerra del 1940-1943, Milano, Garzanti, 2002, pp.
52-54 e 61-65. Traduzione di S. Minucci e dell’autore)
IL RANCIO DEL SOLDATO ITALIANO
L
’efficienza di un esercito non si misura solo dalle armi che
utilizza. Anche il vitto è un parametro importantissimo per
valutare la modernità di un apparato militare, oltre ad essere
un fattore determinante del morale dei soldati. Dotati di un
equipaggiamento scarso e inadeguato, i soldati italiani furono
trattati peggio dei militari di tutti gli altri eserciti anche a questo elementare livello, mentre gli ufficiali difesero fino all’ultimo i propri privilegi legati al grado.
Il vitto dei soldati merita una trattazione a parte per
un’importanza che non occorre sottolineare, anche
se spesso sottovalutata dagli studi (non certo dalla
memorialistica). Ci offre una testimonianza impietosa dei
ritardi dell’esercito, qui il regime fascista c’entra poco,
salvo per le crescenti difficoltà di approvvigionamento.
<<Il rancio di mezzogiorno era di solito brodo di carne
con un po’ di pasta ed un pezzetto di lesso; la sera c’era
il minestrone; poche rare volte la pastasciutta… alla
74
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
domenica c’era anche un po’ di vino>> (1938). Dalla fine
dell’Ottocento alla seconda Guerra mondiale, la razione
giornaliera dell’esercito aveva quattro componenti base:
pane di buona qualità; carne bovina fresca o congelata
(carne con l’osso, quindi con una percentuale di scarto, nel
1915-18 la razione era di 375 grammi di carne in piedi,
ossia calcolata sull’animale vivo); pasta (maccheroni, i tubi
della memorialistica) o riso due volte alla settimana; infine
patate e legumi per il minestrone serale. […] Un vitto per
un paese povero, agli inizi del secolo per i contadini e gli
operai mangiare pane bianco e carne tutti i giorni era un
lusso, malgrado la bassa qualità tradizionale delle cucine
militari. Nel 1940 la razione era sufficiente in caserma e
nelle retrovie, non però al fronte, come attestano tutte le
memorie e le testimonianze dei reduci. Al fronte, in tutti i
teatri di guerra, la fame era garantita.
Possiamo indicare due ragioni di fondo. Gli alti comandi che
parlavano di guerra di rapido corso non avevano pensato
a modernizzare un sistema di vettovagliamento adeguato
ai fronti statici della prima Guerra mondiale, quando si
provvedeva alle truppe con forni e cucine nelle retrovie.
Nulla fu fatto per migliorare i forni Weiss per la panificazione
che si erano dimostrati pesanti e poco mobili già in Etiopia;
dovevano restare così lontano dal fronte che spesso in
Albania il pane arrivava vecchio e ammuffito. Sembra poi
incredibile, ma è documentato, l’esercito non disponeva
di cucine mobili (i primi esemplari entrarono in servizio nel
1943 e, in omaggio alla tradizione, funzionavano a legna
anziché a nafta o benzina più reperibili), ma contava ancora
sulle casse di cottura di fine Ottocento e sulle gloriose
marmitte da campo modello 1855. Ossia il rancio veniva
75
8 settembre
avviato al fronte da cucine nelle retrovie, si può immaginare
con quali fatiche e ritardi se le truppe erano in movimento
o su posizioni difficilmente raggiungibili, dove arrivava un
pastone tiepido eppure prezioso, date le circostanze. Le
cucine poi si riducevano a cucinieri poco addestrati, agli
attrezzi e a grandi marmitte appese a strutture precarie
da rinnovare ad ogni spostamento, con fuoco a legna da
reperire sul posto; problemi piccoli in condizioni normali,
non facili da risolvere durante gli spostamenti o in regioni
prive di legna come la Libia. Inoltre, in tre anni di guerra
su fronti diversi questo sistema non fu modificato con una
modernizzazione delle attrezzature e il decentramento della
preparazione del rancio, dove possibile o necessario, o la
distribuzione di fornelli ai reparti. I soldati si arrangiavano
accendendo fuochi sotto le gavette quando potevano,
rubacchiando viveri qua e là, ma avrebbero meritato di
meglio.
L’altro problema di fondo era la desolante insufficienza
dei generi di integrazione al rancio. L’immagine del
soldato inglese che si prepara il breakfeast abbrustolendo
il bacon, poi si concede una tazza di the è un po’ troppo
idilliaca in contrapposto al soldato italiano che inzuppa
il pane nella brodaglia di un caffè, però inquadra il
problema. Il rancio rimane lo stesso dalle caserme al
fronte, peggiora inevitabilmente di qualità e regolarità
in momenti in cui le truppe sono sottoposte alle fatiche e
tensioni del combattimento. La razione di Albania prevede
la distribuzione eventuale di un bicchierino di cognac (3 cl)
oppure 50 grammi di marmellata oppure 25 di cioccolato,
con un cenno alla possibilità di una distribuzione continuativa
per periodi eccezionali. Manca la concezione che il soldato
76
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
al fronte debba avere un vitto più ricco e curato, garantito
anche in caso di collasso dei rifornimenti. La razione di
riserva si riduceva a 400 grammi di galletta e una scatoletta
di carne, a volte la scadente minestra Chiarizia in scatola;
molti reparti in Albania (e poi in Africa settentrionale) non
ebbero di meglio per settimane. Un confronto con la razione
K del soldato americano (tutto il necessario per 24 ore salvo
l’acqua in una sola confezione: scatolette varie, minestra
liofilizzata, caffè in polvere, gallette, fornellino a meta,
sigarette, fiammiferi, carta igienica eccetera) è umiliante,
segna il confine non tra due eserciti, ma tra due civiltà. […]
In tutti gli eserciti si distingueva tra mensa ufficiali, mensa
sottufficiali e rancio dei soldati, in tempo di pace e in guerra
nelle retrovie, con ovvie varianti. Al fronte però il vitto era
uguale per tutti, salvo che per le forze armate italiane che
conservarono fino al crollo il privilegio di una mensa a
parte, più ricca e curata, per gli ufficiali e per i sottufficiali.
La memorialistica di Libia attesta sia lo stupore degli italiani
quando vedevano Rommel pranzare con pane nero e
marmellata, sia il piacere degli ufficiali tedeschi invitati alla
mensa dei colleghi italiani, dove pastasciutta e vino erano
garantiti (ovviamente non durante i combattimenti). Per i
soldati, dovunque, soltanto la gavetta o le razioni a secco.
MacGregor Knox ha trovato le risposte dei comandi della II
armata in Jugoslavia a un sondaggio sull’abolizione delle
mense privilegiate, promosso nell’estate 1941 dallo stato
maggiore dell’esercito su richiesta di Mussolini. <<Gran
parte dei comandanti si disse favorevole per motivi logistici
più che di leadership. Ma “la massa degli ufficiali” si dimostrò
palesemente poco entusiasta. Un comandante di corpo
d’armata sostenne che gli ufficiali fossero semplicemente
77
8 settembre
incapaci di svolgere le loro funzioni nutrendosi con il rancio
normale dei soldati: “La mensa ristora e mette l’ufficiale
nelle condizioni fisiche e di spirito per ben assolvere il
suo non facile compito. Una differenziazione, ai fini del
morale degli ufficiali, ci deve assolutamente essere”. La
soppressione delle mense da campo per ufficiali avrebbe
inoltre potuto produrre una “eccessiva dimestichezza e
conseguente diminuzione di prestigio”, nonché una perdita
di “affiatamento e cameratismo” tra gli ufficiali dei reparti.
Infine il nuovo sistema, se esteso alla vita di guarnigione,
avrebbe potuto condurre a “diminuzioni della già tenue
autorevolezza dei giovani subalterni, conseguente dalla
soppressione di distinzioni formali”. La tenacia con cui il
corpo ufficiali difese tali “distinzioni formali” lascia ben
intendere la misura dei propri dubbi sulla sua stessa capacità
di comando>>. Una pagina triste, un esercito vecchio che
non riusciva ad assicurare un rancio sufficiente alle truppe
e cercava di garantire il prestigio degli ufficiali con privilegi
di casta ottocenteschi anziché selezione e addestramento.
(G. Rochat, Le guerre italiane 1935-1943, Torino, Einaudi,
2005, pp. 280-285)
IL RAPPORTO TRA ITALIANI E TEDESCHI IN GRECIA
I
l tipo di occupazione che fu instaurato in Grecia riflette sul
piano politico il reale rapporto di forze venutosi a creare sul
campo. Gli italiani furono trattati dai tedeschi come delle pedine, mentre tutte le decisioni importanti erano prese esclusivamente a Berlino e poi calate dall’alto da Hitler a Mussolini.
78
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
Il primo episodio di scontro tra Italia e Germania si ha al
momento dell’offerta di capitolazione da parte dell’esercito
greco sul fronte epiro-macedone, rivolto ai tedeschi. Il
governo tedesco era stato considerato dalla politica estera
greca, negli anni tra le due guerre mondiali, quasi come un
mediatore, e diventa dopo la sconfitta il vero interlocutore.
L’Italia pretende che la richiesta di capitolazione venga
rivolta anche all’esercito italiano e insiste per essere
presente ad Atene (dove in realtà le truppe del regno
arrivano cinque-sei giorni dopo i tedeschi) per partecipare
alla parata militare delle truppe occupanti. Questa vicenda
illustra bene le ragioni per cui i greci vedono nei tedeschi i
veri interlocutori e assegnano all’Italia un ruolo subordinato,
non riconoscendo di essere stati sconfitti dall’Italia.
Tutto il problema della politica d’occupazione italiana
sembra determinata da problemi di prestigio, da una parte,
e di rapporti di potere all’interno del gruppo dirigente
fascista. La prima ipotesi avanzata è quella di ricorrere a
un governatore civile, e per questa carica emerge il nome
di Dino Grandi [...]. Per quanto altri nomi vengano poi fatti
(quello di Bottai, ad esempio), del governatorato civile ben
presto non si parla più perché i tedeschi pongono in atto
una loro strategia che condiziona le mosse dell’Italia. Essa
si differenzia da quella adottata in altri paesi occupati:
non un’amministrazione diretta tedesca, ma un governo
collaborazionista greco affiancato da un plenipotenziario
politico-diplomatico del Reich. A questa strategia si deve
pertanto adeguare l’Italia che provvede alla nomina di un
omologo italiano nella persona di un diplomatico piuttosto
capace, Pellegrino Ghigi. In questo modo, caduta l’ipotesi
del governatorato civile italiano, si crea una struttura che è
79
8 settembre
stata impropriamente definita di mezzadria italo-tedesca: si
tratta in realtà di un vero e proprio dualismo di poteri.
L’Italia si trova nella condizione di dover costantemente
inseguire l’iniziativa tedesca, quasi costretta ad agire in
modo da non scomparire rispetto all’alleato; e questa
graduatoria si riflette anche negli atteggiamenti della
popolazione greca. L’atteggiamento più ostile registrato tra
i greci è rivolto ai bulgari, a cui si attribuisce il massimo
di brutalità; seguono poi i tedeschi, verso i quali c’è un
atteggiamento ambivalente di rispetto e di timore; e infine
gli italiani, considerati con ironia e scherno. [...] Occorre
sottolineare che l’Italia non prevedeva affatto la presenza
di un governo greco che potesse essere intermediario
nei confronti della popolazione civile. Sono i tedeschi a
prendere accordi per la costituzione di questo governo (24
aprile) immediatamente dopo la capitolazione. Gli italiani
si trovano di fronte al fatto compiuto. I tedeschi sembrano
considerare l’occupazione della Grecia come un fatto imposto
da ragioni di carattere strategico, non motivato tuttavia da
particolare ostilità verso la Grecia e la sua popolazione. C’è
una certa similitudine con quanto avviene nei confronti della
Francia: fino al 1942 i tedeschi valutano attentamente il
ruolo che può avere Vichy sotto il punto di vista economico
e politico nel quadro del Nuovo ordine europeo. L’Italia
sarebbe molto più dura nel sostenere le sue rivendicazioni,
che sono di fatto bloccate dai tedeschi che richiamano
l’alleata all’importanza di aggregare Vichy al complesso del
Nuovo ordine europeo, rimandando a più tardi i problemi
delle rivendicazioni territoriali. Con la Grecia si verifica una
situazione analoga. L’amministrazione italiana riconosce
con riluttanza questo stato di fatto. Filippo Anfuso, cui è
80
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
affidato l’incarico di seguire la situazione greca, in uno dei
suoi primi rapporti (già alla fine di aprile del 1941) scrive
a proposito della soluzione adottata dai tedeschi: <<Con
tale soluzione il governo germanico concede alla Grecia
non il trattamento delle nazioni nemiche del Reich, quali
la Serbia e la Polonia, ma di quelle che per imprescindibili
ragioni politiche strategiche è stato costretto ad occupare
(Norvegia e Olanda). Trattamento preferenziale che la
Grecia certo non merita anche perché lo stato d’animo
della popolazione è di averla scampata bella e di essersi
sottratta miracolosamente all’occupazione italiana>>. [...]
Il problema principale che si presenta è quello del rapporto
dualistico con l’amministrazione tedesca. È particolarmente
significativo che nel governo greco – governo di un paese
sconfitto – non esistesse un ministro degli Esteri. Nel suo
diario il generale Cavallero annota che c’è un senso nel fatto
che non esista un ministro degli Esteri greco, in quanto tale
funzione è assolta dal plenipotenziario tedesco Altenburg.
Gli italiani, in sostanza, colsero immediatamente come la
gestione della situazione greca fosse ormai sfuggita dalle
loro mani e la loro condotta non avrebbe potuto esser altro
che quella di una consapevole subalternità alla Germania.
(E. Collotti, L’Europa nazista. Il progetto di un Nuovo ordine
europeo (1939-1945), Firenze, Giunti, 2002, pp. 295-298)
81
8 settembre
La campagna di Russia
I
l principale teatro della guerra tra Italia e Gran Bretagna fu
l’Africa del Nord. Dalla Libia, gli italiani tentarono più volte di
penetrare in Egitto, di conquistare Alessandria e di bloccare il
canale di Suez. In un teatro di questo genere, sarebbe stato essenziale agire con grande mobilità e con materiale adeguato.
Ancora una volta, però, l’esercito italiano fu costretto a scontrarsi con gravissime carenze di tipo organizzativo. I carri armati
e i camion per spostare rapidamente le truppe furono sempre
scarsi e inferiori a quelli britannici. Gli equipaggi dei carri italiani, ad esempio, erano pressoché privi di radiotelefoni e di
bussole per automezzi, mentre i motori degli aeroplani e le mitragliatrici, per parecchio tempo, furono privi di filtri antisabbia.
Nel febbraio 1941, le inadeguate truppe italiane furono rafforzate da un contingente tedesco, denominato Afrika Korps, guidato dal generale Erwin Rommel. Dotato di numerosi e veloci
carri armati, Rommel riuscì a conquistare il porto di Tobruk e a
penetrare infine in territorio egiziano, fino a 100 chilometri da
Alessandria. Nell’autunno del 1942, tuttavia, gli inglesi ottennero imponenti rifornimenti e scatenarono una grande offensiva
nei pressi di El Alamein, ricacciando indietro le truppe italiane e
tedesche. La battaglia di El Alamein chiuse definitivamente ogni
speranza di una conquista del Canale di Suez da parte dei nemici dell’Inghilterra. Nello stesso tempo, il 7-8 novembre 1942,
truppe anglo-americane sbarcarono in Marocco e in Algeria,
col risultato che le forze italo-tedesche si trovarono compresse,
in Tunisia, sia da Oriente che da Occidente, e infine dovettero
arrendersi. Gli Alleati fecero 130.000 prigionieri, l’intero Mediterraneo passò nelle loro mani, mentre l’Italia divenne una sorta
di fortezza assediata.
82
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
Insieme alle carenze nei materiali e nella produzione bellica,
una delle principali cause delle ripetute disfatte italiane è da individuare nella dispersione delle forze. Infatti, mentre gli inglesi
attaccavano a El Alamein, Mussolini aveva bloccato ben 30
divisioni (600.000 uomini) nei Balcani e, soprattutto, ne aveva
inviati altri 229.000 sul fronte russo. Inizialmente, il Duce aveva
insistito con Hitler affinché alla grande campagna antibolscevica lanciata dal Terzo Reich partecipasse anche un piccolo contingente italiano (62.000 uomini). Nel 1942, dopo il fallimento
dell’Operazione Barbarossa, fu Hitler a chiedere all’Italia un
maggiore contributo: così, alle tre divisioni iniziali se ne aggiunsero altre sette. In Russia, il Regio Esercito impiegò in tutto
10 divisioni (229.000 uomini), su un totale di 65: per l’esercito
italiano si trattò di uno sforzo notevole; oltre tutto, furono inviate
nella steppa russa anche moltissimi alpini, il cui impiego sarebbe stato più proficuo tra le montagne della Jugoslavia.
L’ARMIR (Armata Italiana in Russia) era assolutamente inadatta per il tipo di scontro che dovette affrontare. I soldati erano
privi di armi automatiche individuali (fucili mitragliatori), mentre le pesanti mitragliatrici in dotazione ai reparti spesso erano
inutilizzabili nel rigido inverno russo, con temperature spesso
inferiori a -25°. La qualità della lana delle divise era cattiva,
pessima quella delle scarpe, che spesso perdevano la suola e
comunque non erano in grado di impedire (come già era accaduto in Grecia) il congelamento dei piedi. I pochi carri armati
non reggevano minimamente il confronto con quelli tedeschi
o russi: pesavano al massimo 3 tonnellate (più o meno come
un camion), a fronte delle 27 dei panzer e delle 34 dei carri
sovietici.
Nell’autunno 1942, insieme all’armata romena, l’ARMIR era
schierata sul fiume Don, a protezione del fianco sinistro della
Wehrmacht, impegnata a Stalingrado. La grande offensiva sovietica che il 19 novembre portò all’accerchiamento dei tede-
83
8 settembre
schi sfondò il fronte in più punti e infine (il 17 gennaio) rinchiuse
anche 150.000 italiani, in maggioranza alpini, in una grande
sacca, obbligandoli ad una terribile ritirata in mezzo alla neve.
Quasi tutti i cannoni furono abbandonati sul Don, mentre gli
automezzi disponibili e funzionanti erano insufficienti. La ritirata
verso ovest, pertanto, avvenne a piedi; in linea d’aria, si trattava di un tragitto di circa 120 chilometri. In realtà, furono molti
di più, a causa della confusione e della necessità di compiere
continue deviazioni, per evitare di affrontare i russi, decisamente superiori in uomini e mezzi. L’odissea nella neve di coloro
che riuscirono a uscire dalla sacca durò una decina di giorni:
la divisione alpina Tridentina riuscì ad uscire dalla sacca – sfondando le linee russe a Nikolajewka – solo il 26 gennaio 1943.
In questo disastro, l’esercito italiano perse circa 95.000 uomini;
di questi, 10.030 riuscirono a tornare dalla prigionia, a guerra
finita, mentre tutti gli altri morirono per le cause più disparate: attacchi russi, assideramento durante la ritirata, congelamento e malnutrizione durante il trasferimento verso i campi di
concentramento sovietici o nel periodo dell’internamento. Per
coloro che furono catturati, infatti, l’esperienza della prigionia
fu estremamente dura, a cominciare dalle marce del davaj, la
parola russa (avanti!) con cui le guardie di scorta incitavano i
soldati prigionieri a camminare. In teoria, le direttive sovietiche
affermavano che bisognava trattare i nemici catturati in modo
corretto e dignitoso; in pratica, nessuna delle direttive fu applicata, e solo tardivamente le autorità si preoccuparono di farle
rispettare maggiormente.
84
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
LE CARENZE DELL’ARMAMENTO ITALIANO
C
ristoforo Moscioni Negri prese parte alla campagna di
Russia come sottotenente degli alpini. Rientrato in Italia,
dopo l’8 settembre 1943 comandò un reparto partigiano in
Provincia di Pesaro. Nel suo resoconto, più volte ribadisce che
gli alpini combattevano per spirito di corpo. All’opposto, la
constatazione delle carenze militari privò i soldati di qualsiasi
fiducia nei generali e, a maggior ragione, in Mussolini e nel
regime fascista. La scena seguente va ambientata nel dicembre 1942, poco prima della grande offensiva sovietica.
Passai fuori molte ore pensando a come avrebbero attaccato
i russi e ai punti deboli della nostra difesa. Ero sicuro che
non sarebbero venuti dopo una preparazione di artiglieria
per non metterci sull’avviso, ma di sorpresa con una
rapida corsa attraverso il fiume gelato. Ancora una volta,
coi parabellum [= fucili mitragliatori, capaci di sparare a
raffica, di cui i russi erano dotati, mentre gli italiani avevano
solo fucili a colpo singolo – n.d.r.] contro i fucili, sarebbe
stato un massacro. I nostri mitragliatori infatti non potevano
essere tenuti pronti in postazione perché si gelavano e non
sparavano più, dato che non avevano nemmeno mai visto la
miscela antigelo promessaci sin dall’estate. Dovevamo tenerli
nei ricoveri, sopra le stufe, ravvolti da una coperta in modo
che l’umidità non si condensasse a contatto dell’acciaio,
ma anche così non bastava. Portati fuori occorreva qualche
minuto prima che si sciogliessero, sparando un colpo alla
volta, e la raffica partisse.
Delle tre postazioni fucilieri, quella di Minelli al centro e
85
8 settembre
l’ultima sulla destra avevano un lieve margine di sicurezza
perché una breve scarpata le separava dal piano del fiume.
Su di essa, forse, potevano fermare i russi coi fucili intanto
che i mitragliatori si scaldavano. Ma quella di Pintossi
situata a sinistra verso la valle, dove il Don era più stretto,
non aveva davanti nessun ostacolo. Almeno fosse stato
possibile difendersi con le bombe a mano. Ma le nostre
non erano come le tedesche o le russe: facevano soltanto
rumore e per di più sulla neve molte volte non scoppiavano
affatto. Se poi i russi avessero attaccato con l’appoggio
dei carri, ci avrebbero fatti a pezzi senza possibilità di
difesa. I tedeschi almeno, oltre a cannoni di calibro adatto,
avevano tenuto dei corsi per cacciatori di carri e i loro fanti
potevano difendersi con una tecnica ben studiata e mezzi
opportuni. Noi avevamo degli uomini di tempra magari più
salda, ma dai nostri comandi arrivavano soltanto inutili e
prolisse circolari: il nostro maggiore, al rapporto ufficiali,
usava distribuirle come carta per bassi servizi a chi ne aveva
bisogno.
(C. Moscioni Negri, I lunghi fucili. Ricordi della guerra di Russia.
Bologna, Il Mulino, 2005, pp. 16-17)
86
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
I SOLDATI ITALIANI NEL 1943, DOPO
LA CAMPAGNA DI RUSSIA
D
opo la tremenda ritirata di Russia, tra i soldati si diffusero
stanchezza, scoraggiamento e rassegnazione. Gli uomini
erano del tutto incapaci di capire il senso della guerra che
erano chiamati a condurre. Non a caso, molti di questi soldati
e di questi ufficiali, una volta rientrati in Italia, parteciparono
poi attivamente, dopo l’8 settembre 1943, alla Resistenza. La
lettera seguente (datata 10 aprile 1943) fu inviata da un ufficiale fascista alle autorità italiane, per avvertirle della gravità
della situazione.
Personale (il testo reca il timbro VISTO DAL DUCE)
Zona di guerra P.M. 53, lì 10/4/XXI
Caro Bastianini [sottosegretario agli Esteri nel 1943 - n.d.r.]
da un mese e mezzo circa mi trovo in Russia. Sono qui giunto
mentre le nostre truppe eroicamente ripiegavano sotto l’urto
possente superiore di mezzi del nemico. [...] Purtroppo la
situazione delle nostre truppe rimaste in Russia non è delle
più brillanti e desta negli elementi che hanno il diretto
comando dei reparti serie preoccupazioni. [...] La truppa è
organicamente deperita, stanca, sfiduciata. Da mesi essa si
è rifugiata di località in località, e per la maggior parte sono
soldati che hanno percorso dai 400 agli 800 Km a piedi
sulla neve, combattendo aspramente, senza mai potersi
a lungo e convenientemente riposare. Tuttora dorme per
terra, agglomerata in locali inadatti, come gregge, senza
paglia e senza essersi potuta del tutto spidocchiare. Il tifo
petecchiale, o dermo-tifo come ora lo si vuole chiamare, ha
87
8 settembre
già fatto la sua comparsa, né si è riusciti per le condizioni
ambientali in cui si vive a debellarlo. Se tu, caro Bastianini,
entrassi in uno qualunque di questi dormitori nostri avresti la
visione viva, palpitante di un lazzaretto manzoniano. Pensa
che ne abbiamo uno, ad esempio, nel quale i soldati sono
costretti, per mancanza di vetri alle finestre, a sopportare
giorno e notte senza interruzione la luce accecante di un
riflettore! Tanto spettacolo di miseria stringe profondamente
il cuore.
I medicinali scarseggiano, gli ospedali rigurgitano di
ammalati ed oltre a non essere attrezzati (operazioni
chirurgiche non è possibile eseguirne) sono insufficienti
ad accogliere tutti gli abbisognevoli di cure ospitaliere.
Il rancio - e la truppa non a torto si lamenta - è scarso.
Valga un esempio; da ier l’altro e per otto giorni non vi
sarà distribuzione di carne fresca. La razione giornaliera è
pertanto costituita da 600 gr di pane, 200 gr di pasta, mezza
scatoletta di carne (e il soldato non la può più sopportare
per l’abuso che ne è stato fatto) e 40 gr di formaggio. [...]
Nessuno, dico nessuno, e ancora un’ora fa verbalmente il
capitano medico del reggimento me lo confermava, degli
elementi che attualmente disponiamo è in condizioni fisiche
di sopportare ancora un inverno russo in trincea. Il morale
della truppa - conseguenza logica di uno stato di cose è oltremodo basso e così dicasi della maggioranza, per
quello degli ufficiali inferiori in modo particolare. Bisogna
vivere nei reparti per rendersi conto dello stato vero d’animo
degli uomini. Si direbbe che sono stati colpiti da un trauma
psichico che li conduce a un senso fatalistico: manca per
tanto uno spirito aggressivo e guerriero. [...]
Il nostro soldato in Russia, compresi, ripeto, la maggioranza
88
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
degli ufficiali inferiori, è portato istintivamente a non
considerare più - dopo il trattamento ospitale e generoso
degli indigeni durante il ripiegamento, in contrasto spesso a
quello poco cameratesco dei camerati alleati [= i Tedeschi
- n.d.r.] - il russo come suo primo nemico. La riprova la
troviamo nella corrispondenza privata diretta ai familiari.
Negli ufficiali poi, tanto in alto quanto in basso, predomina
generalmente un senso di rancore e di sfiducia nei confronti
del Regime che viene incolpato di tutti gli errori. Cova,
serpeggia un pericoloso spirito antifascista. Anche la
personalità del Duce, più o meno velatamente, viene posta
in discussione. [...]
Caro Bastianini, con piena consapevolezza ti ho prospettato
per sommi capi la reale situazione delle nostre truppe in
Russia. Qui si sta consumando un tradimento alle spalle
del Paese e del Regime. Qui certe verità non si vogliono
intendere; vi è un muro attraverso il quale la verità non può
e non deve passare. Qui si pensa unicamente a se stessi
ed alla propria carriera pronti a riversare in un domani
ogni errore e colpa sul Regime e sull’ Uomo che la Divina
Provvidenza ci ha dato. [...] Fai di questa mia l’uso che
ne credi più opportuno. A mio avviso è bene che il Duce
la legga e ne prenda integrale conoscenza. [...] Con ogni
augurio t’abbraccio, Tuo
GEMELLI
(F.W. Deakin, La brutale amicizia. Mussolini, Hitler e la caduta
del fascismo italiano, Torino, Einaudi, 1990, pp. 292-294. Traduzione di R. De Felice, F. Golzio, O. Francisci)
89
8 settembre
LE CONSEGUENZE DELLA DISFATTA IN RUSSIA
L
a tragedia degli italiani in Russia si consumò in diverse fasi:
la battaglia impari con le truppe sovietiche, la ritirata, la
cattura, le marce e il trasporto versi i campi di internamento,
la terribile prigionia. Poiché le strutture russe erano assolutamente inadeguate ad accogliere in blocco le migliaia di soldati nemici catturati nella battaglia di Stalingrado, moltissimi
italiani e tedeschi morirono di freddo, di fame e di fatica.
Sulla tragica ritirata degli alpini (dal Don a Nikolajewka ci
sono circa 120 km in linea d’aria, gli alpini ne fecero molti di
più, più un altro centinaio fino alla nuova linea tedesca per
quelli che riuscirono a uscire dalla sacca) abbiamo buoni
studi e una ricca memorialistica [...]. I battaglioni alpini si
mossero per dieci giorni nella neve, senza indicazioni, né
viveri, né altri mezzi che le poche slitte sovraccariche di
feriti trainate da muli straordinari e sacrificati. Se in parte
riuscirono a uscire dalla sacca lo si dovette a due fattori,
il mediocre impegno dei russi nell’inseguimento, affidato
soprattutto alle milizie partigiane, e la grande prova di
solidità di questi battaglioni, che in condizioni estreme,
pur assottigliati da perdite e sbandamenti, riuscirono a
conservare la capacità di superare combattendo i successivi
sbarramenti. La Tridentina riuscì a sfondare a Nikolajewka,
il 26 gennaio, aprendo la via a una colonna di decine di
migliaia di sbandati. Le altre divisioni furono bloccate dagli
sbarramenti russi e dovettero arrendersi. [...]
Le cifre ufficiali sulle perdite nell’inverno 1942-43 sono di
85.000 dispersi e di 27.000 feriti o congelati, da rapportare
90
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
ai circa 150.000 uomini schierati sul Don [...]. Sulla sorte
di questi dispersi l’unica cifra certa riguarda i prigionieri
rimpatriati nel 1946 che sono 10.030. Quindi circa 75.000
caduti in quattro diverse fasi, i combattimenti sul Don e nella
ritirata, poi, dopo la cattura, le tragiche marce forzate verso
le stazioni ferroviarie russe al di là del Don in condizioni
disastrose, quindi molti giorni di treno in condizioni sempre
disastrose. La quarta fase fu ancora peggiore, con l’arrivo in
campi di prigionia sprovvisti di tutto, dove le malattie fecero
strage di uomini debilitati da mesi di sofferenze e privazioni.
[...] Ripartire i caduti tra le diverse fasi accennate non
sarà mai possibile, le stime variano secondo le vicende dei
reduci. Quelli che riuscirono a uscire dalla sacca tendono
ad accentuare le perdite della ritirata, i superstiti della
prigionia ne rivendicano la drammaticità e i tantissimi morti
(50.000 come dato orientativo e discusso).
Per inquadrare questa falcidie bisogna ricordare la condotta
barbara dei tedeschi che fucilavano subito i commissari
politici sovietici e una parte dei prigionieri; e lasciarono
morire nei campi gran parte di quelli arresisi nel 1941-42,
poi nel 1943 cominciarono a utilizzarli come forza lavoro.
In totale 3.300.000 morti su 5.700.000 prigionieri russi.
Da parte sovietica c’era l’ordine di risparmiare i prigionieri,
tranne i russi passati con i tedeschi da fucilare sul campo. [...]
La falcidie dei prigionieri italiani fu dovuta alla tragica
disorganizzazione dei russi, sopraffatti dal mezzo milione di
prigionieri catturati nel corso della battaglia di Stalingrado
(fino a quel momento ne avevano fatti ben pochi). Lo
sforzo bellico sovietico sacrificava tutto al combattimento,
sussistenza e sanità erano già precarie per le truppe, per la
massa dei prigionieri mancava tutto, a cominciare dai viveri.
91
8 settembre
I comandi russi avevano scarsa attenzione per la vita dei
loro uomini (dalle grandi perdite negli attacchi di fanteria a
un altissimo numero di fucilazioni); non ne dedicarono molta
alla sopravvivenza dei prigionieri nelle marce forzate e nei
treni strapieni. Va comunque ricordato che tutto il sistema di
trasporti russo era sconvolto dall’invasione e dalle necessità
belliche e che le condizioni di alimentazione erano tragiche
anche per i cittadini russi. Di conseguenza ci vollero alcuni
mesi perché i campi di prigionia garantissero condizioni di
sopravvivenza; nel frattempo la maggior parte degli italiani
erano morti. Lo stesso accadde ai tedeschi, su circa 110.000
catturati nella sacca di Stalingrado ne sopravvissero soltanto
5.000. Poi il trattamento dei prigionieri migliorò (in totale
morirono il 12% dei soldati tedeschi presi prigionieri dai
sovietici e il 58% dei soldati russi caduti in mano ai tedeschi),
ma per gli italiani era troppo tardi.
(G.Rochat, Le guerre italiane 1935-1943, Torino, Einaudi,
2005, pp. 392-397)
92
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
I COMUNISTI ITALIANI IN URSS
E LA QUESTIONE DEI PRIGIONIERI
N
ei primi mesi del 1943, subito dopo la tragedia della ritirata dell’ARMIR, due dirigenti comunisti italiani in Russia
– Vincenzo Bianco e Palmiro Togliatti – si scambiarono alcune
lettere sulla questione delle durissime condizioni in cui si trovavano i prigionieri nei campi sovietici. Conoscendo in anticipo
la posizione di Stalin, Togliatti respinse la richiesta di intervenire presso le autorità russe per ottenere un miglioramento della
situazione.
All’inizio del 1943, subito dopo la disfatta dell’esercito italiano
sul fronte del Don, Bianco ebbe l’incarico di organizzare il
lavoro politico tra i prigionieri di guerra italiani, creando le
scuole politiche e il giornale per i prigionieri. Questo ruolo
lo portava spesso a visitare i lager e quindi ad avere un’idea
chiara sullo stato fisico e psicologico in cui si trovavano i
prigionieri italiani. Ciò risulta anche dalla ben nota lettera
che Bianco inviò a Togliatti il 31 gennaio 1943, e che, tra
le altre cose, affrontava il problema dei prigionieri: <<Ti
pongo una questione molto delicata di carattere politico
molto grande. Penso che bisogna trovare una via, un mezzo
per cercare, con le dovute forme, con il dovuto tatto politico,
di porre il problema, affinché non abbia a registrarsi il caso
che i prigionieri di guerra muoiano in massa come ciò è già
avvenuto. Non mi dilungo, tu mi comprendi, perciò lascio a
te di trovare la forma per farlo…>>.
Bianco chiedeva dunque a Togliatti di intervenire, e
appellandosi al <<tatto politico>> dimostrava di essere
93
8 settembre
consapevole della reazione che avrebbe potuto avere Stalin a
una simile interferenza da parte del segretario del Komintern.
La visione staliniana della politica non ammetteva alcun
atteggiamento indipendente né autorizzava intromissioni
politiche, anche da parte di altri esponenti comunisti,
soprattutto in una fase della guerra così critica. La risposta
di Togliatti a Bianco, del 15 febbraio-3 marzo 1943, rivela il
clima di tensione che si respirava nell’Urss in quegli anni e
svela la mancanza di libertà d’azione, di capacità propositiva
di fronte al potere staliniano, nonché la completa aderenza
ai canoni del comunismo internazionale. La richiesta di
Bianco, sostanzialmente, rappresentava una deviazione,
che nel gergo staliniano era chiamata umanesimo astratto,
oppure <<il tentativo di porre gli interessi nazionali al di
sopra di quelli di classe>>. Secondo Togliatti, che aveva
imparato la lezione durante tutti quegli anni di esperienza
e di vita nell’Urss, Bianco era troppo sentimentale e con i
suoi ragionamenti filantropici si discostava dalla posizione
assunta dalla leadership staliniana.
Scriveva dunque Togliatti: <<L’altra questione sulla quale
sono in disaccordo con te è quella del trattamento dei
prigionieri. Non sono per niente feroce, come tu sai. Sono
umanitario quanto te. O quanto può esserlo una dama della
Croce Rossa. La nostra posizione di principio rispetto agli
eserciti che hanno invaso l’Unione Sovietica, è stata definita
da Stalin, e non vi è più niente da dire. Nella pratica, però,
se un buon numero di prigionieri morirà in conseguenza
delle dure condizioni di fatto, non ci trovo assolutamente
niente da dire. Anzi. E ti spiego il perché. Non c’è dubbio
che il popolo italiano è stato avvelenato dalla ideologia
imperialista e brigantesca del fascismo. Non nella stessa
94
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
misura che il popolo tedesco, ma in misura considerevole. Il
veleno è penetrato tra i contadini, tra gli operai, non parliamo
della piccola borghesia e degli intellettuali, è penetrato nel
popolo, insomma. Il fatto che per migliaia e migliaia di
famiglie la guerra di Mussolini, e soprattutto la spedizione
contro la Russia, si concludano con una tragedia, con un
lutto personale, è il migliore, è il più efficace degli antidoti.
Quanto più largamente penetrerà nel popolo la convinzione
che aggressione contro altri paesi significa rovina e morte
per il proprio, significa rovina e morte per ogni cittadino
individualmente preso, tanto meglio sarà per l’avvenire
d’Italia. I massacri di Dogali e di Adua furono uno dei freni
più potenti allo sviluppo dell’imperialismo italiano, e uno dei
più potenti stimoli allo sviluppo del movimento socialista.
Dobbiamo ottenere che la distruzione dell’Armata italiana
in Russia abbia la stessa funzione oggi. In fondo, coloro
che dicono ai prigionieri, come tu mi riferivi: “Nessuno
vi ha chiesto di venir qui: dunque non avete niente da
lamentarvi”, dicono una cosa che è profondamente giusta,
anche se è vero che molti dei prigionieri sono venuti qui solo
perché mandati. È difficile, anzi impossibile, distinguere in
un popolo chi è responsabile di una politica, da chi non lo è,
soprattutto quando non si vede nel popolo una lotta aperta
contro la politica delle classi dirigenti. T’ho già detto: io non
sostengo affatto che i prigionieri si debbano sopprimere,
tanto più che possiamo servircene per ottenere certi risultati
in un altro modo; ma nelle durezze oggettive che possono
provocare la fine di molti di loro, non riesco a vedere altro
che la concreta espressione di quella giustizia che il vecchio
Hegel diceva essere immanente in tutta la storia. E ora alle
questioni di lavoro>>.
95
8 settembre
Il rifiuto di Togliatti di prendere qualsiasi iniziativa per salvare
i prigionieri di guerra italiani, il tentativo di presentare
la morte di migliaia di uomini come la giusta nemesi per
aver partecipato alla guerra contro l’Urss dimostrano la
totale subordinazione della dirigenza del Pci alla politica
staliniana. […] Bianco replicò seccamente con una lettera
del 20 marzo: <<Non intendo aprire una discussione né
con te né con nessun altro. […] Ma mettere una croce sulla
massa dei lavoratori dei paesi del blocco fascista, tu sai
meglio di me cosa significa, e, oltre tutto, io so benissimo
che tu non la pensi così. Ma, purtroppo, devo constatare
che questa opinione è largamente diffusa>>. […] Le
accuse di Bianco si scontravano con una mentalità che
non tollerava atteggiamenti umanitari. L’insistenza con cui
Bianco si rivolse sia a Togliatti sia ai responsabili sovietici dei
prigionieri di guerra, nonché allo stesso Dimitrov, dimostra
come egli fosse sinceramente interessato alla sorte dei suoi
connazionali. Del resto lui, a differenza di Togliatti, i campi
di prigionia li aveva visitati.
(M. T. Giusti, I prigionieri italiani in Russia, Bologna, Il Mulino,
2003, pp. 53-57)
96
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
La caduta del fascismo
I
n Italia, dopo i primi anni di guerra, la situazione economica ed alimentare era diventata drammatica. Nel giugno
del 1942, la razione giornaliera di pane venne fissata a 150
grammi per persona, mentre grassi commestibili e zuccheri
furono distribuiti rispettivamente nella misura di 400 e 500
grammi mensili. I prezzi dei generi alimentari salirono, dall’indice 100 del 1939, a 172 nel 1942. Viceversa, i salari rimasero praticamente fermi, col risultato che il loro potere d’acquisto reale era proporzionalmente diminuito.
A seguito di questa drammatica situazione, il 5 marzo 1943
scoppiò a Torino una serie di scioperi di protesta; il regime fu
colto completamente alla sprovvista e si mostrò del tutto incapace di reprimere le agitazioni, che ben presto si estesero
alle industrie milanesi e coinvolsero un numero elevatissimo di
operai: 130.000. Il 2 aprile, il governo fu costretto ad annunciare un aumento generale dei salari e degli stipendi, <<da
corrispondersi per l’anniversario della fondazione di Roma, il
21 aprile>>. Appellandosi a questa data simbolica, il regime
voleva far finta di mascherare (a se stesso, in primo luogo) la
grave situazione di malcontento diffuso fra la popolazione. Il significato degli scioperi della primavera del 1943 sta proprio in
questa progressiva corrosione del consenso del popolo italiano
nei confronti del fascismo.
Meno spettacolare (ma non meno importante, come sintomo
e segnale della crisi di consenso che stava per investire il fascismo) fu l’episodio delle dimissioni del conte Cini da Ministro
delle Comunicazioni, il 14 giugno (tre giorni dopo l’occupazione di Pantelleria e di Lampedusa da parte degli anglo-americani). Cini, infatti, era una figura di primo piano del mondo
dell’industria e dell’imprenditoria, cioè di quella borghesia che,
97
8 settembre
nel 1922, aveva accettato che il fascismo andasse al potere,
considerandolo l’unica barriera di fronte al pericolo della rivoluzione sociale. Le dimissioni di Cini sono, per certi versi, il
parallelo borghese degli scioperi operai; si trattò di un distacco,
di una presa di distanza critica: da ogni parte, e persino negli
ambienti che avevano appoggiato per anni il regime, si stava
insomma creando, intorno a Mussolini, il vuoto.
Dopo lo sbarco alleato in Sicilia, le motivazioni che indussero Vittorio Emanuele III a destituire Mussolini furono, sostanzialmente, di natura dinastica; il sovrano temeva, infatti, che
l’imminente disfatta militare avrebbe potuto travolgere lo stesso
istituto monarchico. Lo sforzo del re fu quello di distinguere,
almeno all’ultimo momento, la monarchia dal fascismo e dalla
guerra voluta dal regime mussoliniano, in modo che la caduta
del Duce (inevitabile, in caso di sconfitta) non coinvolgesse la
dinastia sabauda.
Il 19 luglio (dopo che Roma era stata pesantemente bombardata e Mussolini, incontratosi con Hitler a Feltre, non aveva
trovato il coraggio di porre al Führer la questione dello sganciamento dell’Italia dal conflitto) il re prese accordi col generale
Ambrosio e con il comandante dei Carabinieri, in modo da arrestare Mussolini il 26 luglio, in occasione dell’udienza che, in
quel giorno, il Duce avrebbe avuto presso il sovrano. La seduta
del Gran Consiglio del Fascismo, la notte tra il 24 e il 25 luglio,
precipitò gli eventi.
La convocazione del supremo organo del regime fu richiesta
il 16 luglio da una quindicina di gerarchi fascisti desiderosi di
discutere insieme al Duce i provvedimenti che la gravità della
situazione richiedeva. Un gruppo di alti esponenti del partito,
però, decise di sfruttare l’occasione per mettere sotto accusa
Mussolini e chiederne, di fatto, la destituzione. Tale nucleo di
dissidenti era guidato da Dino Grandi e da Galeazzo Ciano;
il primo era stato ambasciatore a Londra dal 1932 al 1939,
98
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
allorché fu richiamato in Italia e nominato Presidente della Camera. Nel suo periodo londinese, Grandi aveva fatto di tutto
per mantenere buoni i rapporti dell’Italia con l’Inghilterra ed
impedire l’avvicinamento del fascismo al nazionalsocialismo tedesco. Ciano, genero del Duce, era invece stato ministro degli
Esteri dal giugno 1936 al febbraio 1943; dopo la catastrofe di
Stalingrado, aveva a più riprese sollecitato Mussolini di premere su Hitler affinché concedesse una maggior attenzione al
fronte mediterraneo, o meglio ancora giungesse ad una pace
negoziata con l’URSS, in modo da poter concentrare tutte le
forze contro gli anglo-americani.
La riunione del Gran Consiglio del Fascismo ebbe inizio alle 17
del 24 luglio 1943; Grandi pose in votazione un proprio ordine
del giorno, che in sostanza esautorava Mussolini da ogni potere, visto che chiedeva il ritorno del re al comando delle Forze
Armate (assunto da Mussolini il 10 giugno 1940, al momento
dell’ingresso dell’Italia in guerra) e il regolare funzionamento
di tutti gli organi dello Stato, primo fra tutti la Camera. Certamente, nelle intenzioni di Grandi, non si trattava di un vero ritorno alla Stato liberale e al parlamentarismo; piuttosto, Grandi
e i suoi sostenitori prospettavano una sorta di fascismo senza
Mussolini, di regime autoritario senza la dittatura personale del
Duce, di Stato forte nel quale, al massimo, potesse esistere un
certo margine per il dibattito e la discussione: se non altro, per
ottenere di nuovo la collaborazione di tutte quelle forze conservatrici (la grande borghesia e l’esercito, ad esempio) che avevano abbandonato Mussolini al suo destino. In ogni caso, per
il momento, secondo Grandi erano importanti soprattutto lo
sganciamento dalla Germania e l’armistizio con gli anglo-americani; tutto il resto, in ultima analisi, era subordinato a questa
fondamentale svolta in politica estera. La drammatica e confusa
riunione del supremo organo del fascismo durò dieci ore ed
ebbe termine alle 2.40 del mattino del 25 luglio, dopo l’appro-
99
8 settembre
vazione dell’ordine del giorno Grandi (19 a favore, 7 contrari,
1 astenuto). Il re vide nella decisione del Gran Consiglio la
legittimazione finale del colpo di stato che stava per attuare,
e che ebbe effettivamente luogo nel pomeriggio del 25 luglio.
100
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
GLI SCIOPERI OPERAI DEL MARZO 1943
L
’improvvisa ondata di scioperi che, nel marzo 1943, investì i grandi centri industriali del Nord Italia sono il segnale
dell’irreversibile crisi del fascismo. Da un lato, evidenziarono il
fallimento completo del modello corporativo, del tutto incapace di mediare i conflitti sociali; dall’altro, mostrarono l’abisso
che la guerra aveva scavato fra il regime e il popolo italiano.
All’inizio di marzo la situazione esplose improvvisamente.
Alle dieci del mattino del 5 marzo, i lavoratori delle grandi
fabbriche Fiat Mirafiori incrociarono le braccia. Il segnale
prestabilito doveva essere la quotidiana prova a quell’ora
delle sirene d’allarme. La direzione tuttavia era stata avvisata
e non avvenne la prova. Ma nel giro di pochi minuti ogni
lavoro si arrestò in ogni punto della fabbrica, e la notizia
si sparse fulminea per Torino. Benché le unità della milizia
fascista fossero all’erta sin dall’alba, dato che le autorità
si aspettavano qualche dimostrazione preordinata, non fu
presa nessuna immediata contromisura. Entro quella sera lo
sciopero si era esteso ad altre sette fabbriche di Torino. L’8
marzo il locale segretario della Confederazione fascista dei
lavoratori dell’industria aveva telegrafato al nuovo ministro
delle Corporazioni a Roma, Tullio Cianetti, che gli scioperi
simbolici avvenuti alle dieci di quella mattina avevano
messo in agitazione da 30 a 35.000 lavoratori. Entro il
12 marzo avevano scioperato più di 100.000 lavoratori.
Il giorno seguente si tennero a Torino incontri clandestini
fra i dirigenti dello sciopero, nel corso dei quali furono
discusse le richieste economiche degli scioperanti e fu
101
8 settembre
decisa la diffusione di volantini che incitavano a continuare
il movimento e a estenderlo ad altre regioni. Il 14 marzo il
comitato clandestino del Partito comunista italiano per la
Lombardia si riunì a Milano per ascoltare un rapporto sugli
avvenimenti di Torino e del Piemonte. Nei giorni seguenti
l’agitazione si estese alla Lombardia. L’invito allo sciopero
fu annunciato a Milano il giorno 24 e le fabbriche Pirelli
e Falk seguirono l’esempio di Torino. Sembra che fossero
interessati allo sciopero più di 130.000 lavoratori, e le
industrie belliche chiave del paese furono temporaneamente
paralizzate.
Dietro le richieste economiche – 192 ore pagate al mese,
indennità di carovita, aumento delle razioni – c’erano i segni
di un’agitazione politica concertata. […] Lo sciopero chiave
che dette inizio a tutto il movimento, e che scoppiò alla Fiat
Mirafiori, era stato preparato il mese precedente dal capo
della locale cellula comunista. Fra i 21.000 lavoratori c’era
una cellula di 80 iscritti, nessuno dei quali pagò regolari
contributi al partito fino al maggio seguente, e in tre altre
grosse fabbriche di Torino gli iscritti alla cellula erano
rispettivamente 30, 72 e 60. Il significato fondamentale del
movimento deriva dal fatto che pochi quadri riuscirono a
fare esplodere un’azione di massa, che ebbe effetti decisivi
sulla struttura e il prestigio del fascismo. La reazione delle
autorità fasciste rivelò, ancor più chiaramente dello stesso
sciopero, la debolezza del regime. Il capo della polizia,
Carmine Senise, descrisse la situazione nelle sue memorie:
<<[Gli] scioperi [furono] proclamati per motivi economici
ma con finalità politiche, specialmente pel fatto che gli
stabilimenti nei quali gli operai incrociarono le braccia erano
tutti di produzione bellica. […] Il fatto notevole fu che allo
102
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
sciopero tutti parteciparono: fascisti e non fascisti, persino
quelli che facevano parte della milizia. Alla Fiat di Torino
anzi esisteva un’apposita legione, costituita interamente di
operai di quegli stabilimenti, creata d’accordo fra il Partito
e i dirigenti di quell’industria allo scopo di controllare
il comportamento politico della massa: ebbene, i militi
parteciparono allo sciopero come tutti gli altri operai e non
si può proprio pensare che non avessero compreso le finalità
di un movimento di cui erano evidenti il carattere politico e
il fine contrario alla guerra>>. […]
Il capo del primo sciopero alla Fiat fu arrestato insieme con
circa trenta compagni. La polizia capì di trovarsi di fronte
a un’organizzazione che lavorava per indebolire il fronte
interno. Nella relazione dell’ispettore generale di pubblica
sicurezza al capo della polizia a Roma, era scritto: <<I
risultati dell’operazione, sia per il sequestro del materiale
di propaganda, sia per le confessioni della maggior parte
degli arrestati, stanno a provare obiettivamente l’avvenuta
ricostruzione del Partito comunista torinese, personalmente
diretto da un emissario del partito rimasto finora non
identificato, e l’opera sovvertitrice che esso svolgeva col
fine di sconvolgere la compagine nazionale, di aizzare la
massa operaia e gli stessi militari contro la guerra e contro
l’alleata Germania, di sollevare il popolo contro il regime e
contro i poteri dello Stato>>. Questa insistenza sul pericolo
comunista nelle agitazioni popolari era una vecchia tattica
delle autorità fasciste, e un’espressione della paura per
quel fantasma storico creato dagli stessi fascisti nel passato
per giustificare la conquista del potere. La risposta delle
masse all’azione di un gruppo di cospiratori era in realtà
allarmante e la scarsa presa del partito fascista sulle masse,
103
8 settembre
manifestatasi in tale occasione, rivelava, meglio di quanto
fosse avvenuto prima nella storia del regime, la falsità degli
obiettivi dello Stato corporativo. […] Questo significato degli
scioperi di marzo è duramente e chiaramente affermato in
una lettera di Farinacci a Mussolini del 1° aprile:
<< […] Non mi sgridare se ancora una volta ti affermo
che l’esperimento corporativo, attraverso innovatori,
improvvisatori, dottrinari e demagoghi, non è riuscito
secondo quello spirito che animò la nostra fede e i nostri
propositi […]. Il partito è assente e impotente… Ora avviene
l’inverosimile. Dovunque, nei tram, nei caffè, nei teatri, nei
cinematografi, nei rifugi, nei treni, si critica, si inveisce
contro il regime e si denigra non più questo o quel gerarca,
ma addirittura il Duce. E la cosa gravissima è che nessuno
più insorge. Anche le Questure rimangono assenti, come se
l’opera loro fosse ormai inutile. Andiamo incontro a giorni
che gli avvenimenti militari potrebbero far diventare più
angosciosi. Difendiamo la nostra rivoluzione con tutte le
forze… E poi, caro Presidente, perché non convochi il Gran
Consiglio? Lascia che ognuno sfoghi il suo stato d’animo,
che ognuno ti dica il suo pensiero. E fa in modo che tutti
ritornino rincuorati dalla tua parola>>. Era la prima
richiesta volta a ottenere che i dirigenti fascisti compissero
un esame al massimo livello, al di sopra della segreteria
del partito, della situazione interna italiana. Il regime era
di fronte alla più grande crisi politica della sua storia dopo
l’assassinio di Matteotti nel 1924 e, come allora, Farinacci,
fra le fila dei gerarchi fascisti, si fece portavoce dell’esigenza
di drastici provvedimenti. La sua proposta di convocare il
Gran Consiglio fu la prima richiesta in tal senso nel 1943,
e non fu che tre mesi dopo, quando la situazione militare
104
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
raggiunse l’orlo dell’abisso, che Mussolini si arrese a questa
richiesta.
(F. W. Deakin, La brutale amicizia. Mussolini, Hitler e la caduta
del fascismo italiano, Torino, Einaudi, 1990, pp. 302-308. Traduzione di R. De Felice, F. Golzio, O. Francisci)
RITRATTO DI DINO GRANDI
L
’ex capo squadrista bolognese Dino Grandi (1895-1988) fu
il principale tessitore del progetto finalizzato a estromettere
Mussolini, al fine di intavolare credibili negoziati di pace, che
evitassero all’Italia un’umiliante resa incondizionata (come
Churchill e Roosevelt avevano proclamato, da Casablanca,
nel gennaio 1943). Anzi, Grandi arrivò a proporre al re di capovolgere le alleanze, di dichiarare guerra alla Germania e di
schierarsi al fianco degli anglo-americani. Vittorio Emanuele
III, però, non accettò un progetto così machiavellico e restò
in attesa. In tal modo, fu perso tempo prezioso, che permise
ai tedeschi di far affluire truppe in Italia e di occuparne facilmente l’intero territorio nazionale, al momento dell’armistizio.
Nel 1939 e nei primi mesi del 1940, Grandi era stato ostile
alla partecipazione dell’Italia alla guerra e aveva fatto il
possibile per scongiurarla, arrivando, il 1° settembre 1939,
sino a prospettare in Consiglio dei ministri l’opportunità
di rivedere radicalmente i rapporti con la Germania e, il
105
8 settembre
21 aprile successivo, a scrivere a Mussolini per metterlo in
guardia contro decisioni affrettate; poi, di fronte all’inatteso
crollo della Francia, anche lui aveva per un momento pensato
che Mussolini potesse aver ragione e, entrata l’Italia in
guerra, aveva, come Balbo e altri avversari dell’alleanza con
la Germania, uniformato il suo comportamento all’antico
motto inglese che poco prima di Monaco aveva ricordato
a Chamberlain: <<right or wrong, my country>> [= a
torto o a ragione, il mio paese – n.d.r.]. Le vicende belliche
della fine del 1940 e degli inizi del 1941, in particolare la
campagna di Grecia, lo avevano però fatto ricredere presto
e da allora aveva sempre pensato che fosse necessario
trovare il modo di far uscire, prima che fosse troppo tardi,
l’Italia dal conflitto. Data la sua lunga permanenza come
ambasciatore a Londra dal 1932 al 1939, la sua conoscenza
dell’ambiente politico inglese e i suoi ottimi rapporti con
alcune delle personalità più importanti della vita politica e
della diplomazia di quel paese, a cominciare da Churchill,
più che agli Stati Uniti, anche dopo che questi erano scesi
in guerra, le sue speranze per una trattativa in tal senso si
erano sempre rivolte all’Inghilterra. […]
L’udienza del 4 giugno [1943 fu] l’ultima che Grandi ebbe
dal sovrano prima del 25 luglio. Al punto in cui erano
arrivate le cose Grandi […] parlò chiaro, tanto più che
una domanda del re (<<La Camera approva la politica e
l’azione del governo?>>) l’aveva lasciato di stucco: <<La
Camera – rispose – è immobilizzata ma inquieta. La grande
maggioranza dei consiglieri nazionali non attende altro che
un gesto di forza da parte di vostra maestà. L’Italia intera
ha condannato ormai la dittatura, vuole uscire da una
guerra che non è sua, ma bensì soltanto del dittatore che
106
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
l’ha proclamata. Sino a quando noi siamo stati padroni del
Mediterraneo una pace separata era possibile, oggi, dopo
le decisioni di Casablanca, una pace onorevole cogli Alleati
è possibile soltanto se noi avremo il coraggio di affrontare
in campo aperto i tedeschi. È questa la sola condizione
per rendere inoperante la resa incondizionata decisa
dalle potenze nemiche a Casablanca>>. Di fronte ad un
discorso così netto, il tono del re si era fatto duro: <<Le
ho detto mille volte che io sono un re costituzionale e che
deve essere il Parlamento ad indicarmi la strada>>. E ai
tentativi di Grandi di replicare rifacendosi ai precedenti del
maggio 1915 e dell’ottobre 1922, quando Vittorio Emanuele
non aveva tenuto conto delle maggioranze neutralista
e antifascista esistenti in parlamento, aveva ribattuto:
<<Sì, ma in entrambi i casi ho atteso il voto di fiducia
del Parlamento. Oggi il Parlamento tace, imprigionato,
lo so, ma c’è anche il Gran Consiglio che potrebbe in via
eccezionale costituire un surrogato del Parlamento>>.
Una frase, quest’ultima, che indubbiamente può e poteva
essere intesa come una precisa indicazione su quali basi
operare, ma che – a nostro avviso – non può essere
assolutamente estrapolata dal resto del discorso, dalla
sua parte cioè relativa all’atteggiamento da tenere verso
i tedeschi. A questo proposito il re fu assi esplicito: […]
se egli doveva essere convinto che nella liquidazione di
Mussolini, Grandi poteva giocare un ruolo importante,
certo più importante di quello delle opposizioni [= dei
deboli e disorganizzati partiti antifascisti – n.d.r.], doveva
però aver accolto del tutto negativamente la sua idea di
un capovolgimento immediato di fronte: una idea, per lui,
non solo <<temeraria>>, ma inconcepibile, che andava
107
8 settembre
contro sia alle sue più radicate norme di comportamento,
sia ai suoi progetti, che prevedevano, invece, un’operazione
in due tempi, prima la liquidazione di Mussolini, poi
l’armistizio con gli anglo-americani, e non dovevano
menomamente contemplare il passaggio all’offensiva
contro i tedeschi. Ma a questo punto non si trattava più di
una diversità di valutazioni politiche: era il contrasto netto
tra due temperamenti, due culture, due modi di concepire la
vita che non avevano nulla in comune e, in quel momento
almeno, non potevano assolutamente intendersi. […]
Stando così le cose, Grandi – convinto com’era che quella
fosse l’occasione decisiva e praticamente l’unica sulla
quale poter contare – si mosse dal 21 al 24 luglio e durante
la stessa riunione del Gran Consiglio con la massima
spregiudicatezza guardando solo al risultato e, per il resto,
lasciando che ciascuno interpretasse il suo ordine del giorno
e le sue parole come voleva, purché lo sostenesse, anche solo
strumentalmente. […] Significativa ci sembra la disponibilità
dimostrata da Grandi ad accettare l’adesione di Ciano –
che personalmente non avrebbe voluto per motivi politici
(ciò che Ciano aveva rappresentato a lungo con la sua
politica filotedesca), morali (la sua parentela con Mussolini)
e, aggiungiamo noi, personali (la loro sorda inimicizia)
– non appena l’ex ministro degli Esteri si disse disposto a
sottoscrivere il suo ordine del giorno e Bottai appoggiò la sua
richiesta. E, del resto, una conferma indiretta di questa nostra
opinione la si può trovare in quanto anni dopo avrebbe scritto
Federzoni: <<Non so, a dire il vero, se tutti i sottoscrittori
avessero ancora un chiaro concetto dei possibili effetti politici
di ciò che stavano per fare>>. In un certo senso, si può dire
che, se di lealtà si può parlare per questo genere di cose e in
108
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
circostanze, per di più, tanto drammatiche, fu con Mussolini
che Grandi si dimostrò più leale […]: nei limiti del possibile,
Grandi non volle che il suo operato assumesse il carattere
di una congiura alle spalle di Mussolini e, forse, volle dargli
addirittura una chance per uscire di scena salvando in qualche
modo la faccia, ché, infatti, Grandi conosceva troppo bene
Mussolini e la sua sensibilità politica per non capire che egli
si rendeva conto di cosa lo aspettava se l’ordine del giorno
Grandi avesse raccolto la maggioranza.
(R. De Felice, Mussolini l’alleato. 1. L’Italia in guerra 1940-1943,
Torino, Einaudi, 1996, pp. 1228. 1236-1238. 1249-1252)
I SENTIMENTI DELLA POPOLAZIONE NEL 1943
N
ell’estate 1943, temendo un attacco degli anglo-americani in Sicilia, Mussolini tenne alla radio numerosi discorsi infarciti di espressioni retoriche. Tra l’altro (il 18 giugno)
dichiarò che i nemici sarebbero stati fermati sulla spiaggia (o
meglio, sul bagnasciuga) e che ogni città dell’isola sarebbe
stata una trincea. Il documento seguente, datato 9 luglio, è
tratto da un rapporto dei Carabinieri di Enna: dimostra che
la popolazione non credeva più alla retorica e considerava la
guerra irrimediabilmente perduta.
Il discorso del Duce ha lasciato il pubblico indifferente…
non è stato sentito dalla maggioranza dei cittadini, che non
hanno più fede in colui che guida i destini della nazione.
109
8 settembre
Il pubblico, oltre le cose di primaria necessità, ha bisogno
di sapone – che ora viene consegnato totalmente alle forze
armate – olio, zucchero (che non sono distribuiti), vestiti e
scarpe che sono scomparse completamente dal mercato. A
tutto questo si devono aggiungere i continui bombardamenti
delle città piccole e grandi dell’isola, senza sufficiente
opposizione da parte nostra, che hanno abbassato il morale
della popolazione a un punto tale che essa prega per la fine
della guerra come una santa liberazione.
(E. Aga Rossi, Una nazione allo sbando. L’armistizio italiano
del settembre 1943 e le sue conseguenze, Bologna, Il Mulino,
2003, p. 66)
LA REAZIONE DEGLI ITALIANI ALL’ANNUNCIO
DELLA FINE DEL REGIME
L
’annuncio dell’arresto di Mussolini fu accolto dalla maggioranza degli italiani con sollievo, soddisfazione ed entusiasmo. Temendo un’improvvisa insurrezione popolare, Badoglio
autorizzò i suoi subordinati ad usare qualsiasi strumento, pur
di mantenere l’ordine. Tra il 25 luglio e l’8 settembre 1943, la
repressione delle manifestazioni di piazza provocò 93 morti,
536 feriti e 2.276 arresti.
All’annuncio che il sovrano ha accettato <<le dimissioni
dalla carica di capo del governo, primo ministro segretario
di Stato, di sua eccellenza il cavalier Benito Mussolini>>
110
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
strade e piazze sono invase da gruppi di cittadini in tripudio,
che innalzano cartelli e vessilli tricolori. Le scritte murali
esprimono lo stato d’animo di ampi settori della popolazione
urbana: <<VIVA IL DUCE LADRO>>, <<ABBASSO IL
TRUCE>>, <<ASSASSINO DI MATTEOTTI>>… Sentimenti
rimasti repressi per anni esplodono e nel loro libero riproporsi
ritrovano la prova oggettiva della loro veridicità: non è più
l’isolato antifascista a ingiuriare il tiranno, rischiando con
ciò stesso il confino, bensì la moltitudine ridivenuta soggetto
attivo, che dimostra la propria esistenza denegando il
regime decapitato dalla congiura di palazzo. Come gli
scioperi industriali del marzo 1943 avevano seriamente
incrinato la credibilità della dittatura, stavolta le sfilate di
migliaia di cittadini in tripudio forniscono un contributo –
apparentemente postumo, in realtà essenziale – al tracollo
del fascismo, sepolto dall’evidenza del totale isolamento
dopo un ventennale monopolio delle piazze.
La folla si assiepa dinanzi agli edifici e incita alcuni
ardimentosi che, issati su precari appoggi, scalzano lapidi e
scalpellano fasci littori. L’esigenza di vilipendere e rimuovere
i segni del Ventennio è impellente nella capitale, dove più
che altrove la coreografia imperiale aveva segnato l’arredo
urbano; gruppi di giovani prendono d’assalto monumenti
e statue del deposto autocrate, animati da fervore
iconoclasta. Il servizio fotografico più significativo riprende
i momenti culminanti della distruzione di un gigantesco
simulacro bronzeo di Mussolini: l’enorme testa, staccata dal
busto, giace rovesciata sul selciato, colpita da bastonate
e finalmente trascinata per le vie da una frotta di ragazzi,
probabilmente quegli stessi ai quali farà riferimento nelle
sue memorie l’ex comandante della Milizia, irritato dalla
111
8 settembre
<<folla di donne e di giovinastri>> impadronitasi delle
strade per festeggiare la fine della dittatura. Il sentimento
popolare si sfoga simbolicamente sulle rappresentazioni
feticistiche del potere mussoliniano, con una prefigurazione
allusiva di quanto sarebbe accaduto di lì a venti mesi a
piazzale Loreto. […]
La parola d’ordine lanciata dal duce (<<Vincere!>>)
si rivela ogni giorno più irrealistica, e nell’estate 1943 la
guerra fascista si è trasformata in un’estenuante tragedia
quotidiana di morte, di fame e di battaglie perdute. Le
ottimistiche valutazioni riportate dalla stampa sui danni
inferti dalle armate dell’Asse agli eserciti delle forze
demo-plutocratiche e bolsceviche sono contraddette
dalla travolgente offensiva anglo-americana in Sicilia e
dall’inasprimento dei micidiali bombardamenti aerei, che
radono al suolo alcuni quartieri di Roma. Il 25 luglio il
quartier generale delle forze armate maschera i successi
degli avversari (<<In Sicilia si è anche ieri duramente
combattuto. L’urto nemico, contenuto nei settori orientale
e centrale del fronte si è ripetuto particolarmente intenso
sull’ala settentrionale del nostro schieramento>>), ma non
può sottacere l’ennesimo tributo di vittime civili, riprova
della vulnerabilità del territorio nazionale: <<A seguito
delle incursioni aeree dei giorni scorsi sono state accertate
le seguenti perdite tra la popolazione civile: a Bologna 97
morti e 270 feriti; ad Aquino (Frosinone) 4 morti e 10 feriti
per scoppio ritardato di bombe; a Capo Rizzuto 1 morto e 2
feriti; a Livorno 17 feriti di cui 2 gravi>>. […]
Il governo Badoglio, timoroso sia della ripresa
dell’antifascismo sia di possibili colpi di coda dei seguaci
di Mussolini, supplisce alla sostanziale inerzia in tema di
112
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
politica estera con robuste dosi di decisionismo sul piano
interno, stringendo ulteriormente le maglie dell’ordine
pubblico in una militarizzazione del territorio rivolta non già
a preparare la lotta al malfido alleato tedesco (nel frattempo
impegnato a rafforzare la sua rete militare in Italia) bensì a
reprimere moti di protesta. Il generale Mario Roatta, capo
di stato maggiore dell’esercito, sollecita i tutori dell’ordine
pubblico a considerare delittuosa <<qualunque pietà e
qualunque riguardo nella repressione>>, poiché <<poco
sangue versato inizialmente risparmia fiumi di sangue in
seguito; perciò ogni movimento deve essere inesorabilmente
stroncato in origine>>. Le direttive dell’alto ufficiale non
lasciano spazio a equivoci di sorta sull’atteggiamento dei
comandi militari verso la ripresa dell’antifascismo:
<<Muovendo contro gruppi di individui che perturbino
ordine aut non si attengano prescrizione autorità militare,
si proceda in formazione di combattimento et si apra fuoco
a distanza, anche con mortai et artiglieria senza preavviso
di sorta, come se si procedesse contro truppe nemiche.
Medesimo procedimento venga usato da reparti in posizione
contro gruppi di individui avanzanti. Non est ammesso il tiro
in aria; si tira sempre a colpire come in combattimento… Il
militare che, impiegato in servizio ordine pubblico, compia
il minimo gesto di solidarietà con i perturbatori dell’ordine,
aut si ribelli, aut non obbedisca agli ordini, aut vilipenda
superiori et istituzioni, venga immediatamente passato per
le armi>>.
I due primi decreti emanati dal nuovo esecutivo – pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio – sono espressione
del doppio binario perseguito dalla Corte e dagli alti circoli
militari: lo smarcamento dal fascismo agonizzante e il
113
8 settembre
mantenimento del ferreo controllo sulla popolazione. Il regio
decreto legge n. 668 sopprime il Tribunale speciale per la
difesa dello Stato e ne trasferisce le competenze ai tribunali
militari (<<La cognizione dei reati già spettante al Tribunale
predetto è devoluta, durante lo stato di guerra, ai Tribunali
militari, secondo la rispettiva competenza territoriale. La
devoluzione ha luogo anche per i procedimenti in corso.
Relativamente ai predetti reati, i Tribunali militari procedono
in ogni caso, durante lo stato di guerra, col rito di guerra>>),
mentre il regio decreto legge n. 669 estende il controllo
militare all’intera nazione (articolo unico: <<La legge
penale militare di guerra è applicabile anche nel territorio
delle provincie non dichiarate o considerate in stato di
guerra>>). Ne deriva un accresciuto controllo sulle residue
libertà degli italiani. A Bari l’attuazione pedissequa dello
stato d’assedio provoca una strage: il 27 luglio una ventina
di manifestanti vengono falciati dai soldati (ma la censura
sulla stampa mantiene riservata la notizia dell’eccidio).
L’indomani una manifestazione operaia indetta a Reggio
Emilia dai comunisti con la parola d’ordine: <<Basta con la
guerra! I tedeschi in Germania!>> viene dispersa al prezzo
di una decina di morti e di numerosi feriti gravi.
(M. Franzinelli, “Il 25 luglio”, in M. Isnenghi (a cura di), I luoghi
della memoria. Personaggi e date dell’Italia unita, Roma-Bari,
Laterza, 1997, pp. 221-230)
114
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
115
Leandro Arpinati
45)
(Bo), 22 aprile 19
1892 - Argelato
o
ai
br
feb
29
,
na
(Civitella di Romag
Dimensione locale
La guerra, i fascisti,
i tedeschi
I primi anni di guerra
S
econdo alcune testimonianze, la folla di bolognesi che, il
10 giugno 1940, in piazza Vittorio Emanuele ascoltò il discorso con il quale il Duce annunciò l’intervento dell’Italia in
guerra, nel momento decisivo (<<la dichiarazione di guerra
è già stata consegnata…>>) restò per un attimo perplessa,
in pensoso silenzio. Anche a Bologna, dunque, il conflitto del
1939-1940 non fu accolto con l’entusiasmo che aveva caratterizzato le masse nell’agosto 1914. D’altra parte, poiché
era convinzione universale che la guerra – dopo la resa della
Francia – sarebbe durata pochissimo, su Il Resto del Carlino
continuarono regolarmente ad essere pubblicate inserzioni
pubblicitarie che suggerivano soggiorni sulle Dolomiti, sulla
riviera romagnola, persino a Viareggio (meta però ritenuta
all’epoca, da molti emiliani, esotica, o meglio troppo lontana
e difficile da raggiungere). A Ferragosto, erano già partite per
la villeggiatura circa 20.000 persone.
Per chi rimase in città, l’estate del 1940 fu il tempo dell’oscuramento e degli improvvisi allarmi aerei, che tuttavia non comportarono alcuna incursione, ma solo improvvise e generali accensioni di luci, capaci di rendere nulle in un attimo tutte le severe
prescrizioni emanate dalle autorità. Più rigorosi e rigidamente
applicati, invece, i divieti di circolazione per le automobili, concesse solo a chi ne aveva bisogno per ragioni professionali e su
percorsi stabiliti con estrema precisione. Tale faccenda, però,
riguardava un’infima minoranza di cittadini (a Bologna, la targa
BO, nel 1940, non superava il numero 25.000), mentre era la
117
8 settembre
bicicletta il mezzo di spostamento veramente di massa in una
città che comprendeva appena 250.000 abitanti. Più tardi, nel
1941, furono requisiti tutti i pneumatici, rendendo impossibile
qualsiasi circolazione di veicoli a motore privati.
Alla fine della prima estate di guerra (settembre 1940) cominciarono a scarseggiare in città zucchero e sapone, mentre numerose cancellate di ville e giardini furono abbattute e requisite,
per ottenere metallo utile allo sforzo bellico. Le occasioni si svago e divertimento, però, non mancavano: i cinema proiettavano ancora film americani, mentre i teatri offrirono numerosi
concerti e spettacoli di opera lirica.
Il 1941 obbligò i bolognesi ad un confronto più serio con la
realtà della guerra. L’ospedale Rizzoli, infatti, ospitò numerosissimi feriti, costretti a subire terribili amputazioni, a seguito del
congelamento degli arti sulle montagne dell’Albania e della
Grecia. In inverno, i combustibili da riscaldamento furono facilmente reperibili, sia pure a costi notevolmente più alti, rispetto
all’anno precedente. I generi alimentari, invece, cominciarono
a scarseggiare; mentre pasta e farina bianca divennero pressoché introvabili, gli unici beni acquistabili liberamente erano
surrogati dal sapore stomachevole, fabbricati con ingredienti
ignoti. L’anno seguente, il razionamento investì anche vari beni
di consumo non commestibili (come cappelli, cravatte e guanti), mentre surrogati di pessima qualità sostituirono i saponi da
barba. D’altra parte, nel 1942, i rapporti tra città e campagna
si fecero più stretti e sistematici, permettendo agli abitanti del
centro urbano di rifornirsi regolarmente nel contado di derrate alimentari. Infine, nella primavera del 1943 molte famiglie
decisero di trasferirsi a tempo indeterminato nelle campagne,
sia per garantirsi un regolare rifornimento di beni primari, sia
per sfuggire ai bombardamenti, che cominciarono a rovesciarsi
sulle principali città italiane.
Nodo ferroviario di primaria importanza, Bologna fu attaccata
118
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
per la prima volta il 16 luglio 1943 (9 morti); molto più grave
fu il bombardamento del 24 luglio (97 morti, 270 feriti), che
investì il centro della città e provocò la parziale distruzione della chiesa di San Francesco. Il giorno seguente (25 luglio), la
caduta del fascismo mise in moto alcuni cambiamenti importanti: all’università, fu nominato rettore Enrico Redenti, insigne
giurista, mentre all’ex-sindaco socialista Francesco Zanardi fu
concesso di ritornare dal confino. Tuttavia, il diffuso entusiasmo
popolare fu attenuato dal pesante bombardamento che investì
la città la mattina del 2 settembre (14 morti).
La notizia dell’armistizio fu diffusa pubblicamente alle 19,30,
in piazza Vittorio Emanuele; tra la folla, molti ritratti del re, ma
anche scritte che chiedevano libertà e pace oppure un governo
elettivo. Nel pomeriggio del 9 settembre, il comando tedesco
si stabilì all’hotel Baglioni, nel centro di Bologna. La massima
autorità, designata per il controllo sulla cosiddetta Militärkommandantur 1012 (comprendente le zone di Bologna e Modena), fu inizialmente il colonnello Helmuth Dannhel, coadiuvato
dal maggiore Hans Senn. Alla fine di marzo del 1944, Dannhel
fu sostituito dal generale Paul Steinbach, che fissò il proprio ufficio in via Putti 13, mentre l’hotel Baglioni fu utilizzato solo come
sede di rappresentanza o in occasioni mondane. Le SS si stabilirono in via Santa Chiara 6/2, la Gestapo in viale Aldini132. Nei
giorni seguenti, tra il 10 e il 16 settembre, i proclami tedeschi si
moltiplicarono, imponendo il coprifuoco e minacciando durissime rappresaglie contro la popolazione civile, nel caso in cui
fossero stati compiuti atti ostili nei confronti delle forze armate
tedesche.
Il 25 settembre 1943, Bologna subì l’incursione aerea più dura
di tutta la guerra: condotta da 120 Liberator B24 americani,
fu organizzata in tre ondate, durò dalle 10,56 alle 11,20 e
provocò, secondo alcune stime, circa 2.000 vittime. In quella
occasione, fu colpita anche la sede de Il Resto del Carlino, sic-
119
8 settembre
ché la pubblicazione del giornale fu sospesa per quattro giorni.
Diverse chiese (quella del Sacro Cuore e della Mascarella, San
Martino e – di nuovo – San Francesco), cinema e teatri furono devastati. Moltissime persone abbandonarono la città, ma
scoprirono che (nei dintorni) anche Mezzolara, Budrio, Minerbio e Vedrana (Budrio) erano stati colpiti. Il 5 ottobre, invece,
furono colpiti duramente i binari ferroviari, distrutti insieme agli
alberghi Bologna e Astoria; anche il Carlino, di nuovo, subì
gravissimi danni
120
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
BOLOGNA AL BATTESIMO DEL FUOCO
L
a testimonianza seguente fu rilasciata da Sergio Soglia,
operaio bolognese, che all’epoca aveva 16-17 anni. La tragica realtà della guerra appare per certi aspetti filtrata dalla
consapevolezza di essere i protagonisti di un’importante pagina di storia e dalla fiducia che il contributo di tutti (persino di
semplici apprendisti) possa servire a provocare la sconfitta dei
tedeschi e dei fascisti.
Giunse anche per Bologna il battesimo del fuoco. Il primo
bombardamento aereo della città avviene nel pieno della
notte: alle ore 3 del 16 luglio 1943, nove giorni prima
della caduta di Mussolini, del padrone, come dicevamo
in fabbrica. È un attacco breve e limitato. Sono sganciate
alcune bombe nella zona di via Agucchi. I morti sono 9 e
i feriti 20. Sono cittadini colti di sorpresa, nel sonno. La
stampa locale dà pochissimo rilievo all’incursione. Il Resto
del Carlino esce il giorno dopo, sabato 17 luglio, con questo
titolo a due colonne: L’incursione aerea – Le onoranze delle
vittime avranno luogo stamane in Certosa. Nel breve articolo
sono riportati i nomi dei morti e dei feriti. Non si parla della
zona colpita né dell’ora della incursione. La dimenticanza del
cronista mi sorprende. Mi sento in qualche modo defraudato.
<<L’obiettivo vero – diciamo noi ragazzi – era la nostra
fabbrica>>. Gli anziani sono meno sicuri, <<Forse>>, si
limitano a dire. È chiaro, soprattutto, che non comprendono
la nostra eccitazione. Per noi non ci sono dubbi: volevano
colpire la SABIEM, a poche centinaia di metri in linea d’aria
dalle abitazioni civili centrate dalle bombe.
121
8 settembre
Nella pausa di mezzogiorno non andiamo in mensa.
Facciamo un rapido sopraluogo in via Agucchi. Vediamo
le case sventrate. Le abitazioni colpite dalle bombe sono
modeste; sono case di operai e di barrocciai, che lavorano
la ghiaia in Reno. Siamo un gruppo di ragazzi di 16-17 anni,
apprendisti aggiustatori nella fabbrica di S. Viola. Il nostro
commento non è molto patriottico: <<Peccato – diciamo –
che non abbiano sbaraccato l’officina>>. Lavoriamo per
la guerra. Confezioniamo un particolare dell’obice 149:
il sollevamento elastico. Sabotiamo da un paio di anni
la produzione, come ci hanno insegnato i nostri maestri,
operai dalle mani d’oro. Essi sanno arrangiare il pezzo in
modo che possa superare il collaudo, ma è certo che dopo
un paio di cannonate qualcosa nel meccanismo si guasterà.
<<Bisogna – ci dicono – farla finita con la guerra. Prima
finisce meglio è per tutti>>. Noi giovani siamo talmente
convinti della necessità di farla finita che ci auguriamo il
ritorno dei bombardieri alleati. <<Speriamo – è l’auspicio
corale – siano più precisi la prossima volta>>. È l’unica
nostra preoccupazione. Facile e tragica è la profezia.
I bombardamenti continuano. Bologna, in alcuni quartieri,
è ridotta ad un cumulo di macerie. Gli alleati angloamericani hanno inizialmente cercato di colpire gli
obiettivi bellici. È successo così che ad essere rasi al suolo
sono i quartieri popolari che sorgono in prossimità delle
fabbriche. Dopo il 25 luglio 1943, la guerra psicologica per
accelerare l’armistizio si è fatta ancora più martellante. I
bombardamenti, come si dice, non guardano più in faccia
a nessuno. È solo dovuto al caso che i quartieri alti, le zone
residenziali nella parte collinare della città, rimangano illesi.
[…] Il bombardamento di via Agucchi, primo della lunga
122
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
serie, accelera lo sfollamento della città. Più severi si fanno
i controlli per il rispetto delle norme sull’oscuramento, ma
non si migliora la difesa contraerea che rimane pressoché
inesistente.
(L. Goldoni – A. Ferrari – G. Leoni, I giorni di Bologna Kaputt,
Bologna, Edizioni Giornalisti associati, 1980, pp. 75-76)
RAZIONAMENTO ALIMENTARE E REQUISIZIONI
F
ino ai bombardamenti dell’estate 1943 e all’arrivo dei tedeschi, per i bolognesi la guerra fu innanzi tutto razionamento dei generi di prima necessità (sapone, zucchero, grassi…), acquisto di misteriosi surrogati alimentari e requisizione
dei metalli, della gomma e delle automobili. La testimonianza
seguente è di Aldo Ferrari, che all’epoca era un ragazzo di
15 anni.
Mia madre, in guerra, calò venti chili. La dieta era ferrea; i punti
erano quelli della tessera; così perse in poco tempo quel peso che
aveva messo su quindici anni prima per tenermi al mondo col suo
latte per soddisfazione di mio padre, perché una sposa florida era
il simbolo di una famiglia felice. Io, invece, in quel tempo continuai
a crescere un po’ per legge di natura e un po’ perché avevo a
disposizione per sfamarmi proprio quei chili cui lei rinunciava.
La tessera era terribile e doveva peggiorare via via. Si cominciò
con 120 grammi di pane al giorno e 200 se eri un addetto ai
lavori pesanti e 300 se eri un minatore e tutti, allora, dicevano
123
8 settembre
<<fortunato te>>. Un giorno che avevo appetito, e lo chiamavo
fame, mia madre, come al solito, mi diede un pezzo del suo
pane, facilmente individuabile perché i bollini lo personalizzavano
chiaramente e il tuo era sempre ben diviso da quello di un altro e
c’era chi consumava il suo pane in fretta sfruttando tutti i bollini di
un anno in due mesi così poi per gli altri dieci si arrangiava, ma
forse sperava che la guerra finisse prima. […]
<<Prendilo, mi diceva, io non ho fame>>. Quella
volta, prima di mangiarlo ci pensai su. Avevo notato
che nel generale dimagrimento le mamme dei miei
amici dimagrivano più in fretta degli altri e mi era allora
balenata la verità e facevo conti amari. Trentatrè grammi di
mortadella li avevo ingurgitati col bollino di mezzogiorno;
il giorno dopo saremmo andati a comperare pochi grammi
di carne, che distribuivano, sempre con la tessera, due
giorni la settimana, e un po’ di pasta da condire col burro
che avrei ricavato quel pomeriggio agitando la bottiglia
a metà piena di latte. Il siero lo si buttava via e il grasso
bianco andava raccolto raschiando il vetro con un lungo
ferro da calza. Era un lavoro non facile, lungo e noioso, ma
necessario perché nella dieta, invano corretta coi prodotti
degli orticelli di guerra (avevamo piantato due fagioli in un
vaso e ne attendevamo con ansia la crescita) si avvertiva
in maniera particolare la mancanza di grassi. Servivano, si
diceva, per i cannoni e non ce n’era nemmeno più per il
sapone che facevamo bollendo in un pentolone pece greca,
soda caustica, pezzi di animali marci, cotiche usate e talco.
Veniva fuori una pappa gialla e puzzolente che tagliavamo
a fette dopo averla fatta raffreddare. […]
[Dal fornaio], negli scaffali quasi vuoti vidi due etichette
di speranza per rinvigorire la dieta familiare: la Vegetina
124
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
e l’Ovolina. Non ne avevo mai sentito parlare; mia madre
sì, e proprio per questo si era ben guardata dall’usarle,
ma io non lo sapevo e le portai a casa trionfante. Con la
Vegetina ci preparai una torta. Verde. Dopo discutemmo
a lungo di cosa potesse essere composto quel tritume
che pareva armonizzare soltanto coi colori del Gordon
sottomarino sull’Avventuroso. Forse erano alghe, forse erbe
macinate; qualcuno azzardò fossero bucce di piselli o punte
di carciofo. Forse era un po’ di tutto. L’Ovolina, invece, fu
una sorpresa. Come diceva il suo nome, sostituiva l’uovo
nella confezione della sfoglia. Lo assicurava la Sant’Unione,
la ditta che la produceva nel suo stabilimento appena fuori
Bologna, verso San Ruffillo. Era una specie di colla gialla
e riusciva in qualche modo a tenere insieme quel po’ di
farina quasi bianca che ogni tanto ci capitava in casa. Con
il cavaliere Emilio Sant’Unione sono andato a chiacchierare
pochi mesi fa. <<All’inizio l’Ovolina era fatta di polvere
d’uovo essiccato che veniva dalla Cina – mi ha raccontato
– ma poi, quando smise di arrivare, dovemmo arrangiarci
alla meglio. Ricorremmo alla fecola di patata con un po’
d’amido come addensante e un po’ di pittura. Non c’era
nulla da mangiare in quel tempo, nulla di nulla e allora io mi
misi a fabbricare illusioni. Illusioni d’uova, illusioni di spezie,
illusioni di pepe, che vendevo in polvere mischiando erbe
qualsiasi e peperoncino>>. […]
Ma la guerra non permetteva neppure l’illusione. Un giorno
andai, come sempre dopo un bombardamento, a vedere i
danni, guidando la bicicletta là dove si vedeva salire fumo
e polverone: era la Sant’Unione che bruciava. La pittura
e le finte spezie e i diluenti e gli addensanti continuarono
a bruciare per un mese e così fu costretta a chiudere la
125
8 settembre
fabbrica, che del resto già faceva fatica ad andare avanti
perché le banche non mettevano fuori più di cinquemila
lire al giorno e non bastavano per il giro. E non bastavano
ormai più le auto e i camioncini per la distribuzione dei
prodotti. Anche andando a carbonella, con la pentola sul
parafango, o a metano, con le bombole a schiacciare la
cappotta, mancavano i pneumatici. Gomme alla patria era
il nuovo imperativo dopo quello dell’oro (nel ’36) e quello
delle cancellate (nel ’40) e se le fedi erano state sostituite
dall’acciaio con la memore scritta, i giardini li avevano
recintati di reti metalliche leggerissime che in breve avevano
messo su pancia come le serrande dei negozi risucchiati in
fuori dalle esplosioni. Era l’amore che le gonfiava, perché,
così cedevoli, facevano da amaca solo che ti ci appoggiassi
col dolce peso addosso.
Senza gomme le auto divennero inutili e così le sequestrarono.
Chi le aveva cercò di nasconderle: Ardea, Balilla, Auguste,
Alfa, finirono isolate in montagna, alcune sepolte in
giardino. Il fornaio vicino a casa nascose sotto le patate la
sua Maserati da corsa, rossa, modello 1930, col seggiolino
del meccanico sfalsato rispetto a quello del pilota. Gli era
servita, fino allo scoppio della guerra, per farci un giro la
domenica e qualche volta mi aveva preso su, anche se non
mi piaceva molto perché non superava mai i dieci all’ora;
credo che lo disturbasse lo sventolio dello spolverino bianco.
Le patate erano libere. Uno, se ci aveva i soldi e se ne
trovava, ne poteva comperare quante ne voleva. Così lui ne
aveva messe insieme tante e le aveva ammucchiate sopra la
vettura protetta da sacchi di tela in fondo a un capannone.
Passò del tempo e nessuno si ricordava neppure più di quella
macchina quando, a furia di mangiarne, il mucchio delle
126
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
patate scemò e un bel giorno si intravide un sacco di tela.
Qualcuno andò a guardarci sotto e scoprì la Maserati. Ne
ebbe un colpo al cuore: era come aver trovato un cadavere
in cantina. Si trattava di coprirla di nuovo, prima che la
vedessero in troppi, prima che la voce arrivasse ai tedeschi,
che non portassero in Germania anche lei. Per ricostruire
quel sepolcro ci si ammucchiò sopra, allora, fascine e stracci
e tutto quello che non sarebbe servito mai più, ma che non
si aveva l’animo di gettare.
(L. Goldoni – A. Ferrari – G. Leoni, I giorni di Bologna Kaputt,
Bologna, Edizioni Giornalisti associati, 1980, pp. 27-30)
127
8 settembre
Il fascismo bolognese, tra regime e RSI
A
Bologna, subito dopo l’occupazione tedesca, il partito
fascista riorganizzò le proprie fila intorno all’autorevole
figura di Goffredo Coppola, che dal 1931 insegnava letteratura latina e greca all’università della città e che, il 24
novembre 1943, divenne il pro-rettore dell’ateneo. Per offrire un’immagine rinnovata del fascismo, a guida del PNF fu
collocato Aristide Sarti, un brillante ufficiale dell’aviazione di
26 anni. A dirigere Il Resto del Carlino fu invece chiamato
Giorgio Pini che nel 1926 aveva pubblicato una biografia di
Mussolini molto gradita dal Duce. Nel più generale clima di
rilancio di temi e figure dello squadrismo, Sarti e Pini tentarono di recuperare anche Leandro Arpinati, una delle figure più
controverse e discusse del fascismo bolognese.
Nato a Civitella (Forlì) il 29 febbraio 1892, Arpinati era romagnolo, come Mussolini. Inoltre, come il futuro duce del fascismo, anche lui aveva alle spalle una militanza rivoluzionaria
di estrema sinistra, sia pure nelle file dell’anarchismo, mentre
Mussolini aveva preferito il sindacalismo soreliano, prima di approdare al PSI. Dal 1920, Arpinati fu uno dei più prestigiosi ed
attivi esponenti dello squadrismo bolognese, ma fin dal 1923
si propose l’obiettivo di offrire una immagine diversa, normale
e rassicurante, del movimento che aveva appena conquistato
il potere. Il fascismo, disse in un’intervista rilasciata al Corriere italiano, e subito ripresa da Il Resto del Carlino (11 ottobre
1923) non era affatto <<una accolta di bastonatori, di gente
violenta, incapace di perseguire ogni serio proposito di operosità pubblica>>. Il 16 dicembre 1926, Mussolini designò
Arpinati come podestà di Bologna, cioè lo nominò alla guida
del Comune, dopo che la figura del sindaco democraticamente
eletto era stata sostituita da quella di un soggetto scelto dall’al-
128
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
to, dal Capo del governo. Per un istante, era sembrato che la
nomina di Arpinati non dovesse giungere, in quanto proprio a
Bologna, il 31 ottobre 1926, Mussolini aveva rischiato di essere
assassinato da un colpo di pistola, all’angolo tra via Indipendenza e via Rizzoli. Accusato di essere l’attentatore, un giovane
quindicenne, Anteo Zamboni, fu giustiziato sul posto.
La vicenda dell’attentato di Bologna presenta numerosi punti
oscuri. Infatti, non portò alcun esito l’inchiesta condotta a carico
della famiglia Zamboni, accusata di aver ordito una vera congiura familiare a danno del Duce; Mammolo Zamboni (padre
di Anteo) e sua cognata, (Virginia Tabarroni, sorella della madre
di Anteo) furono condannati dal Tribunale Speciale a 30 anni di
reclusione, ma la loro innocenza è riconosciuta da tutti gli storici. L’ipotesi più verosimile è che il giovanissimo Anteo fosse del
tutto estraneo ai fatti: fu ucciso sul posto dai veri attentatori, che
probabilmente erano fascisti radicali, legati alla figura di Roberto Farinacci, il quale non sopportava l’emarginazione imposta
da Mussolini ai vecchi capi dello squadrismo. Percorsa da alcuni zelanti funzionari di polizia, questa pista fu in breve tempo
volutamente insabbiata, per non scatenare una faida interna al
fascismo, che avrebbe potuto indebolire il regime. Al contrario,
l’attentato di Bologna fu abilmente sfruttato dal Duce per completare il controllo ormai assoluto del potere. Le cosiddette Leggi fascistissime, emanate nel novembre del 1926, soppressero
tutti i partiti, dichiararono decaduti dal loro incarico i deputati
dei partiti antifascisti e istituirono il Tribunale Speciale, incaricato
di punire in modo esemplare tutti gli avversari del regime, ormai
bollati come nemici dello Stato e dell’Italia.
A Bologna, Arpinati si distinse soprattutto per la sua attività di
ristrutturazione urbanistica, che riguardò la rete tranviaria, la costruzione di edifici scolastici e di case popolari, il potenziamento dell’illuminazione pubblica e la riorganizzazione del centro
storico, l’avvio dei lavori per la funivia di San Luca, inaugurata
129
8 settembre
il 14 maggio 1931. Particolare attenzione fu poi dedicata agli
impianti sportivi, in quanto Arpinati, prima e meglio di altri, concepì lo sport come un efficace strumento di mobilitazione delle
masse e di costruzione di consenso intorno al regime. Nella zona
dell’Arcoveggio fu realizzato un nuovo ippodromo (inaugurato
il 5 giugno 1932), mentre lo stadio del Littoriale fu iniziato il 12
giugno 1925; completato 16 mesi dopo, inaugurato il 31 ottobre 1926 alla presenza di Mussolini (che poi, lo stesso giorno,
subì l’attentato già menzionato) era il più grande stadio d’Italia,
in un momento in cui la squadra del Bologna era al vertice delle
classifiche di campionato. Per l’epoca, si trattava di una struttura
d’avanguardia, in quanto il campo da calcio era affiancato da
una pista podistica a sei corsie, due piscine e sei campi da tennis.
Non a caso, nel 1931, Arpinati divenne presidente del CONI.
A quell’epoca, Arpinati aveva già raggiunto il vertice del suo
potere, in quanto Mussolini, nel 1929, lo nominò sottosegretario agli Interni. Il leader fascista bolognese, però, si scontrò ben
presto con Storace sulla questione della obbligatorietà della tessera per gli impieghi pubblici, mentre espresse giudizi fortemente
acritici sul corporativismo e sull’intervento dello Stato in campo
economico. Obbligato a dimettersi il 1° maggio 1933, Arpinati
fu poi arrestato e condannato al confino. Dopo due anni di residenza coatta a Lipari, potè scontare il resto della pena nella sua
tenuta di Malacappa (nella campagna bolognese).
Il 7 ottobre 1943, Pini e Sarti organizzarono un incontro tra
Arpinati e Mussolini, al fine di permettere una riconciliazione
tra i due e guadagnare il vecchio squadrista alla causa della
RSI. Arpinati si mantenne freddo e distante, accusò il Duce di
essere prigioniero dei tedeschi e rinunciò all’incarico di ministro dell’Interno che Mussolini gli offriva. Malgrado questo suo
netto rifiuto a collaborare col fascismo repubblicano, Arpinati
fu comunque ucciso, il 22 aprile 1945, assieme al socialista
Torquato Nanni, da un reparto di partigiani comunisti.
130
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
LE CONSEGUENZE DELL’ATTENTATO DI BOLOGNA
L
’attentato subito da Mussolini a Bologna il 31ottobre 1926
ebbe numerose conseguenze a livello nazionale. Mentre lo
squadrismo si scatenò di nuovo e colpì duramente numerosi
antifascisti, la legislazione repressiva trasformò l’Italia in una
dittatura durissima, cancellando quanto ancora restava dello
Stato liberale.
L’ordine del ministro Federzoni ai prefetti è che sulla stampa
non compaia alcuna notizia di incidenti di qualsiasi tipo
avvenuti durante le manifestazioni seguite all’attentato.
Perché ciò sia assicurato vengono sospesi dal 1° novembre,
per misure di ordine pubblico, tutti i giornali di opposizione.
Nulla deve turbare questa immagine di un paese che si
stringe solidale e fermo, con ordine, attorno al suo capo.
In questa direzione va anche l’altra disposizione di non
riprodurre sui giornali alcuna fotografia dell’attentatore.
Troppo imbarazzante l’immagine di Anteo Zamboni: se
riprodotto da vivo, risulterebbe palesemente un adolescente;
se da morto, manifestamente un adolescente trucidato con
una ferocia difficilmente compatibile con l’esercizio di una
<<immediata e fatale>> giustizia da parte della folla,
come si è voluto far credere. In realtà il clima è feroce e
ovunque si respira aria di violenza. Incidenti e rappresaglie
avvengono in molte città, seppure minimizzati dai prefetti
nelle loro comunicazioni ufficiali al ministero degli Interni. Le
cifre ufficiali sono sicuramente sottostimate, anche perché la
maggior parte delle vittime si guarderà bene dal denunciare
le aggressioni subite. Gli incidenti più gravi si hanno a
131
8 settembre
Genova: è incendiata la sede de Il Lavoro e, per impedire
la devastazione dell’abitazione dell’ex deputato Francesco
Rossi, deve intervenire la polizia facendo uso delle armi;
saccheggiate sono invece le case dell’ex ministro Canepa,
del giornalista Ansaldo e di altri esponenti dell’antifascismo
cittadino. A Milano sono devastate e incendiate le
tipografie de L’Unità e dell’Avanti!, la sede centrale della
Confederazione generale del lavoro, gli uffici della casa
editrice La Coltura; stessa sorte tocca a Brescia agli
stabilimenti tipografici del giornale Il Cittadino di Brescia;
ovunque sono prese di mira particolarmente le sedi dei
giornali: a Venezia Il Gazzettino, a Trento il Nuovo Trentino,
a Roma il Mondo, il Risorgimento e la Voce Repubblicana,
il cui direttore è ferito gravemente da colpi di manganello, a
Cagliari le tipografie del Corriere di Sardegna e de Il Solco.
In Veneto, e in particolare nelle province di Treviso, Vicenza,
Belluno, Rovigo, Padova, Verona e Venezia, nonché a Udine,
Trento e Fiume, le rappresaglie fasciste si indirizzano contro
le organizzazioni popolari e cattoliche, tanto da indurre il
patriarca di Venezia e molti vescovi della regione a inviare
direttamente al capo del governo una lettera di protesta.
Senza contare le aggressioni alle singole persone, operai,
gente comune, sindacalisti, professionisti, giornalisti,
intellettuali, politici, deputati, tutti travolti in quello che
Salvemini avrebbe chiamato il pogrom del novembre 1926.
A questo clima va ricondotto l’episodio che segna la vita di
Emilio Lussu, costretto a sparare a Cagliari per difendersi
da un assalto fascista alla sua casa, uccidendo uno degli
aggressori; così anche l’assalto alla casa di Benedetto
Croce a Napoli, dove pure assalite le abitazioni dei deputati
Arturo Labriola e Arnaldo Lucci, del drammaturgo Roberto
132
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
Bracco e di altri ancora. […]
Non mancano nel partito fascista le spinte a sfruttare il
clima esasperato dall’attentato per radicalizzare in senso
<<rivoluzionario>> la situazione. […] Lo stesso segretario
del partito Augusto Turati, nel suo discorso alle Camicie
nere dell’Urbe, rinfocola i toni della vendetta e della rivalsa:
<<Dopo il quarto attentato alla vita del Duce il fascismo
non può accontentarsi di fare delle manifestazioni di gioia
per lo scampato pericolo. Nel messaggio che io ho lanciato
ai fascisti sono dette parole molto chiare e molto ferme. Il
primo gesto di giustizia è stato compiuto; presto compiremo
gli altri. Restano ora da colpire i complici (voci: la forca). Ma
c’è un’altra cosa che nel messaggio non è stata detta e che
io dirò a voi questa sera. Nel messaggio non è stato fatto
cenno a quegli altri delinquenti che prima hanno attentato e
che ancora oggi attendono tranquillamente che la giustizia…
(voci: la forca). Siamo d’accordo (applausi scroscianti)
attendono troppo tranquillamente e troppo serenamente
che la giustizia prepari un processo per una condanna
qualunque (bene, applausi). Noi non possiamo dissociare
l’un attentato dall’altro, perché la serie degli attentati
compiuti dimostra che c’è una catena di responsabilità e
un focolaio di infezione all’interno e all’esterno che bisogna
debellare! […] >>.
Il tentativo di radicalizzare la situazione è evidente, e
altrettanto evidente il messaggio a Mussolini perché attui
una ulteriore e definitiva fascistizzazione della vita politica
italiana. Mussolini non si lascia certo scappare l’occasione,
ma i tempi e i modi della sua azione sono più politici e
richiedono, per intanto, che le violenze dei più esagitati
cessino immediatamente. […] La strada di Mussolini è in
133
8 settembre
realtà ben più radicale, e passa attraverso la sostanziale
soppressione di ogni residua garanzia del vecchio
ordinamento liberal-democratico e la definitiva svolta in
senso autoritario dello Stato e delle sue leggi. Il disegno
prende avvio con l’introduzione di misure eccezionali
proposte da Federzoni e varate dal Consiglio dei ministri
il 5 novembre 1926. In quella sede viene deliberato:
l’annullamento di tutti i passaporti per l’estero; severe
sanzioni contro gli espatri clandestini; la revoca della
gerenza [= del diritto di gestire e guidare – n.d.r.], e quindi
la soppressione, di tutti i giornali antifascisti; lo scioglimento
di tutti i partiti, le associazioni e le organizzazioni contrarie al
fascismo; l’istituzione del confino di polizia per gli oppositori;
l’istituzione di un servizio di investigazione politica presso
la milizia fascista. Il ministro Rocco presenta inoltre un
disegno di legge concernente i <<provvedimenti per la
difesa dello Stato>>, che avrebbero dovuto avere validità
per un quinquennio, ma destinati a divenire perpetui. Esso
prevede l’introduzione della pena di morte per chi attenti
alla vita dei sovrani o del capo del governo; la reclusione da
tre a dieci anni per chi ricostituisca i partiti, le associazioni
e organizzazioni disciolte; la costituzione di un Tribunale
speciale per la difesa dello Stato, che avrebbe applicato le
norme del codice penale militare di guerra, e contro le cui
sentenze non è ammesso ricorso.
Il Gran Consiglio del fascismo, riunito nella notte stessa
fra il 5 e il 6 novembre approva incondizionatamente la
nuova linea del governo, che assicura la massima tutela del
regime. <<Finalmente!>> titola il giorno dopo l’editoriale
de Il Resto del Carlino, e il giorno dopo ancora <<Come
in guerra>>, a rendere esplicito il consenso al giro di vite
134
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
attuato. La situazione precipita rapidamente: pubblicati
sulla Gazzetta ufficiale già l’8 novembre, i provvedimenti
di polizia vengono resi esecutivi subito; la notte fra l’8 e il
9 novembre sono occupate dalle forze dell’ordine le sedi
dei partiti e delle associazioni disciolte e un certo numero
di deputati dell’opposizione arrestati: fra questi Antonio
Gramsci. Il 9 novembre, alla riapertura della Camera, viene
approvata una mozione, presentata dal segretario del partito
Turati, per la quale si dichiarano decaduti dal mandato
parlamentare tutti i deputati dell’opposizione coinvolti,
dall’assassinio di Matteotti, nella secessione dell’Aventino,
compresi i comunisti tornati in realtà, dopo un periodo di
astensione, in Parlamento. È quindi presentata la proposta di
legge del guardasigilli Rocco, relatore il deputato bolognese
Angelo Manaresi, che a sostegno dell’introduzione della
pena di morte, ha modo di citare l’esempio della sua
città dove <<le folle, che… il 31 ottobre fecero giustizia
sommaria del delinquente che aveva osato alzare la mano
armata contro la sacra persona del Duce, hanno espresso la
volontà precisa della Nazione, hanno precorso l’opera dei
legislatori e dei giudici, hanno additato, tra il consenso di
tutto il popolo, alla nostra Assemblea la via da seguire>>.
La legge, approvata dal Parlamento e siglata dal re, diviene
esecutiva il 25 novembre 1926. È la fine della vita politica
nel paese e la sconfitta definitiva dell’antifascismo.
(B. Della Casa, Attentato al duce. Le molte storie del caso Zamboni, Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 28-34)
135
8 settembre
RITRATTO DI LEANDRO ARPINATI
S
econdo Renzo De Felice, la vicenda della destituzione di
Arpinati è sintomatica di un’imminente svolta, all’interno
del regime. Dalla metà degli anni Trenta, Mussolini scelse collaboratori sempre più scialbi e privi di personalità, esecutori
meccanici dei suoi ordini. Arpinati, all’opposto, si era segnalato per le sue critiche al Concordato, all’imposizione della
tessera obbligatoria per i pubblici uffici, all’intervento dello
Stato nella vita economica e, quindi, al modello corporativo.
Arpinati non era solo il sottosegretario agli Interni, in
pratica il ministro; era anche uno degli uomini più in vista
del fascismo: ancora nel ’41 G. Ciano [Galeazzo Ciano,
genero del Duce – n.d.r.] nel suo diario scriverà: <<Tra
gli uomini del Regime, Arpinati è qualcuno>>. Impulsivo,
forse non molto intelligente e dotato della cultura tipica
dell’autodidatta, era però un uomo personalmente molto
retto, spregiudicato, molto legato a Mussolini ma senza
piaggeria alcuna, politicamente un puro; dall’originario
anarchismo individualista si era, via via, spostato sul terreno
di un fascismo caratterizzato soprattutto, per un verso, da
un forte liberismo alla Pantaleoni e, per un altro verso, da
un profondo senso dello Stato; nonostante il suo fascismo e
la carica che ricopriva, non aveva interrotto i suoi rapporti
con vari antifascisti. Come sottosegretario aveva cercato di
frenare certe tendenze più smaccatamente illegalistiche, di
contenere le ingerenze del partito nello Stato, di assicurare un
esercizio corretto della pubblica amministrazione comunale
e provinciale e di combattere i profittatori e gli arrivisti. In
136
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
contrasto con la tendenza generalmente invalsa, per esempio,
aveva permesso che ai concorsi banditi dagli enti locali e
parastatali non fosse richiesta ai partecipanti l’iscrizione al
PNF e che nella scelta dei vincitori si assumesse il primo della
terna, senza discriminazioni tra iscritti e non iscritti. […]
Nella scelta di Arpinati nel ’29 per il sottosegretariato agli Interni
Mussolini doveva aver visto anche un espediente per risolvere
la situazione bolognese: allontanare Arpinati dal suo rassato
[= territorio in cui era il padrone incontrastato, il ras, come
si diceva all’epoca, usando un termine etiopico che equivale
a satrapo o signore feudale – n.d.r.] e, al tempo stesso, non
metterlo localmente in una condizione di inferiorità rispetto a
Grandi. Alla base della scelta vi era stata però soprattutto una
personale valutazione positiva dell’uomo e del fascista, tanto è
vero che – secondo A. [Agostino – n.d.r.] Iraci, che di Arpinati
fu capo di gabinetto – aveva persino pensato di nominarlo
ministro tout court e se non lo fece fu solo su suggerimento
dello stesso Arpinati. E, una volta tanto, non si era sbagliato.
Col tempo era diventato chiaro che su molte questioni i due
avevano idee diverse. In particolare Arpinati era un avversario
tenacissimo del corporativismo e di ogni forma, esplicita o
larvata, di intervento dello Stato nell’economia. In questa
sua posizione egli non era certo solo; al vertice del regime il
corporativismo era visto con sospetto da non pochi: sia pure
con sfumature e motivazioni diverse, per esempio da Turati, da
Giuriati, da Rosoni, da De Bono. Solo che, diversamente da
costoro, Arpinati esternava pubblicamente la sua avversione.
Il 10 agosto ’31, durante un discorso pronunciato a Pistoia,
era arrivato a dire: <<Lo Stato non può far tutto, non può
provvedere a tutto. Se il mondo è in crisi, nessun paese può
vivere fuori della crisi e nella prosperità, per quanto grandi
137
8 settembre
siano l’autorità e la volontà dello Stato. Bisogna difendersi
da certe tendenze che vorrebbero conferire allo Stato quei
compiti e quei doveri, che sono esclusivi dei privati. Nessuno
Stato fu mai buon industriale o buon commerciante. Tutti
gli esperimenti in questo senso sono costati e costano gravi
sacrifici e non meno gravi delusioni… Lo Stato, quando non
interviene per aiutare i vecchi e i bambini, finisce sempre per
sostenere i meno meritevoli, i negligenti, gli inetti, gli incapaci,
a tutto danno dei volonterosi, degli abili, degli attivi. Tutto ciò
determina un marasma, che mentre danneggia e avvilisce i
buoni, aumenta il numero dei parassiti che sperano di vivere
eternamente a carico della collettività. Ed è facile prevedere
come tali concezioni portino, presto o tardi, al generale
disinganno e alla generale rovina. Il fascismo ha fatto la
sua rivoluzione contro queste tendenze e per impedire che il
nostro paese fosse travolto da quella sinistra utopia, che sta
devastando un gran popolo e un gran paese>>.
Di fronte ad una presa di posizione così esplicita Mussolini si
era sentito in dovere di dare ad Arpinati una risposta altrettanto
esplicita e pubblica. Otto giorni dopo, parlando in Campidoglio
per celebrare il centenario del Consiglio di Stato, aveva
ribadito a tutte lettere che lo Stato fascista era corporativo,
<<anzi fascista perché corporativo e viceversa, poiché senza
la costituzione corporativa… non vi è rivoluzione fascista>>,
aveva definito una <<concezione filistea e piccolo borghese
della rivoluzione fascista>>, <<da respingere come una
parodia e un insulto>>, quella di coloro che riducevano la
rivoluzione fascista alla <<semplice costituzione di un governo
forte che può garantire in ogni evenienza l’ordine pubblico>>
e aveva drasticamente concluso: <<Discutere ancora se la
sfera dell’economico rientri nello Stato e appartenga allo
138
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
Stato è semplicemente, nella migliore delle ipotesi, assurdo
e inattuabile. Nessuna sfera della vita individuale e collettiva
può essere sottratta allo Stato; ogni sfera, anzi, rientra nello
Stato e vive in quanto è nello Stato>>. […]
Oggettivamente la vicenda di Arpinati si colloca nel momento
in cui il regime, al proprio interno, stava cominciando la
parabola discendente, cominciava a corrompersi nella
propria intima sostanza, diremmo quasi nella propria
particolare moralità; nel momento in cui la logica del
potere dittatoriale cominciava ad intaccare profondamente
Mussolini e a renderlo sempre più prigioniero del proprio
mito e della propria grandezza. Una grandezza che
aveva bisogno assoluto sia di sempre nuovi successi sia
di una facciata totalitaria, senza crepe e senza ombre di
nessun genere, e che, pertanto, non poteva affidarsi che
alle mani di esecutori mediocri o senza scrupoli, convinti
o disposti a tutto per realizzarla, senza rendersi conto (o
senza osare dirlo) dei rischi futuri e del costo immediato che
essa aveva non solo per il paese ma per il regime stesso,
che si accontentavano della facciata senza curarsi delle
fondamenta (o curandosene solo in maniera burocratica e
repressiva) e che, assai spesso, tendevano a far coincidere
l’interesse del regime col proprio personale e concreto
interesse e, così facendo, corrompevano, via via, con il
loro esempio e con l’omertà, attiva e passiva, implicita
nel loro comportamento le strutture superiori e centrali del
regime, che inevitabilmente non potevano a loro volta non
corrompere progressivamente quelle inferiori e periferiche.
(R. De Felice, Mussolini il duce. I. Gli anni del consenso 19291936, Torino, Einaudi, 1996, pp. 292- 300)
139
8 settembre
DESTITUZIONE E CONDANNA DI ARPINATI
D
opo essere stato costretto ad abbandonare l’incarico di
sottosegretario agli Interni, Arpinati fu accusato da Starace – segretario del PNF - di numerosi comportamenti pericolosi e criminali. Tra l’altro, venne pure avanzata l’ipotesi di una
sua complicità nell’attentato subito da Mussolini a Bologna il
31 ottobre 1926. Arpinati fu arrestato e condannato al confino. Con la fine della sua carriera, si chiudeva per il momento
anche la prospettiva di fare di Bologna un centro di primaria
importanza, capace di fare concorrenza a città come Milano
o Torino.
Il 1° maggio [1933] Mussolini invia al suo sottosegretario
una missiva perentoria: <<Caro Arpinati – scrive – si è
determinata una situazione per cui ti prego di rassegnare le
tue dimissioni dalla carica di sottosegretario agli Interni>>.
A stretto giro di posta la risposta di Arpinati: <<Caro
Presidente, a seguito e in conformità dell’invito rivoltomi
con lettera in data odierna rassegno le mie dimissioni da
S.S. di Stato per l’Interno. Con immutata devozione>>.
Nonostante la notizia delle dimissioni venga tenuta
riservata per volontà dello stesso Mussolini – sarà resa
pubblica soltanto il 3 maggio con un comunicato ufficiale
dello stesso capo del governo alla agenzia Stefani – il
giorno dopo puntuali da Bologna partono i veleni contro il
potente ras bolognese caduto in disgrazia […]. Ad avvallare
la necessità di procedere col pugno di ferro nei confronti
del sottosegretario, viene evocata anche una sua sospetta
complicità nell’attentato del 31 ottobre 1926, riesumando
140
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
così le voci calunniose a suo tempo circolate e allora messe
a tacere. Il 9 maggio Arpinati dà le dimissioni anche da
presidente della Federazione del Calcio, accompagnandole
con una orgogliosa lettera di difesa del proprio operato
inviata direttamente a Mussolini, e in cui, dichiarandosi
<<addolorato ma non pentito>> rivendica la lealtà del
suo comportamento, in contrapposizione a quello di Starace,
e la dignità del suo agire politico.
In realtà Arpinati non si rendeva ancora conto – o, meglio,
tra l’incredulo e lo sbigottito, stenta a farlo – che Starace
è solo una pedina di una macchinazione ben congegnata
a suo danno dallo stesso Mussolini. E ne è una riprova il
fatto che, a differenza delle modalità utilizzate in altri casi
per esautorare dalle loro cariche personaggi del fascismo
della prima ora (come Grandi, Balbo, De Vecchi, ecc.), che
per essere rimossi vengono promossi ad alte ed altisonanti
cariche, prive però di possibili influenze o lontane dall’Italia,
la condanna di Mussolini nei confronti di Arpinati sarà
implacabile. Le ripercussioni a Bologna della caduta in
disgrazia del suo nume tutelare sono immediate. Ghinelli,
braccio destro di Arpinati, deve rassegnare le dimissioni
dalla carica di federale, che è assunta da Ciro Martignoni;
espulso dal partito e allontanato dalla città, gli viene
assegnata la città di Napoli quale domicilio obbligatorio.
Il nuovo federale provvede a una radicale ristrutturazione
della Federazione e del Fascio sia nel personale politico
che nell’organizzazione degli uffici […]. Allo stesso Arpinati,
nel frattempo rientrato a Bologna, Martignoni comunica in
ottobre il mancato rinnovo della tessera di iscrizione al PNF
per l’anno successivo, <<d’ordine di S. E. il Segretario del
Partito>>, e lo invita a restituire il distintivo fascista. Sempre
141
8 settembre
in ottobre in un drammatico e aspro braccio di ferro con
lo stesso Mussolini, Arpinati è costretto a consegnare al
prefetto Guadagnini le azioni de Il Resto del Carlino, di cui
egli rivendica la proprietà personale, in contrapposizione al
duce che le considera <<indiscutibilmente>> del partito.
[…]
Piegato sì, quindi, ma non domo. Ed è indubbio che questo
suo orgoglioso atteggiamento contribuirà a rincrudire la
vendetta e la repressione nei suoi confronti. Nel marzo 1934
gli viene sospeso dal Ministero delle Comunicazioni persino
lo stipendio di ferroviere sino ad allora ricevuto per congedo
parlamentare. Contemporaneamente aveva preso l’avvio
l’epurazione dei fascisti del suo entourage, i cosiddetti
arpinatiani: su L’Assalto del 28 ottobre compare la prima
lista di quelli a cui viene ritirata la tessera per avere assunto,
<<in seguito alla sostituzione del segretario federale…
atteggiamento in contrasto con le norme disciplinari del Pnf
dimostrando di non possedere le qualità che costituiscono lo
spirito tradizionale fascista>>. […]
Intanto aumentano i controlli di polizia su Arpinati e sugli
<<abituali frequentatori>> di Malacappa, la tenuta
agricola alle porte di Bologna da lui acquistata in novembre
con i fondi di un assegno assicurativo percepito per un
vecchio incidente d’auto e con l’aiuto di amici fedeli, e che
diviene la meta di una spola continua di auto rigorosamente
registrate e trasmesse al capo della polizia a Roma. La sera
del 23 luglio 1934 l’agenzia Stefani dirama il seguente
comunicato dell’Ufficio stampa della Federazione dei Fasci
di Bologna: <<S. E. il Segretario del Pnf, ha disposto
l’espulsione dal Partito Nazionale Fascista dell’iscritto al
Fascio di Bologna Leandro Arpinati per il seguente motivo:
142
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
“In diverse circostanze assumeva atteggiamenti contrastanti
con le direttive che deve seguire chi ha l’onore di militare
nelle file del Partito Nazionale Fascista” >>. La mattina del
24 la notizia è su tutta la stampa locale e nazionale e provoca
grande fermento in città fra i sostenitori di Arpinati, fino ad
allora illusi che la situazione possa rientrare e risolversi a loro
favore, soprattutto in previsione dell’annunciato cambio del
segretario federale con l’avv. Colliva, considerato loro amico.
Assembramenti di arpinatiani <<vivamente contrariati>>
davanti ai diversi bar del centro cittadini; di lì per tutta la
giornata partenze di auto con diversi gruppi alla volta di
Malacappa. La situazione precipita. Il 25 luglio Mussolini
convoca a Roma il prefetto Natoli e alla presenza di Buffarini
Guidi e di Starace dà l’ordine di arrestare immediatamente
Arpinati e i suoi amici. La mattina del 26 luglio Arpinati
viene arrestato nella sua tenuta di Malacappa. […]
Il 30 luglio la Commissione provinciale per i provvedimenti di
polizia si riunisce e, senza interrogare l’imputato, infligge ad
Arpinati la massima pena prevista dalla legge, ossia cinque
anni di confino da scontarsi nella colonia penale di Lipari.
Viene fatto partire per l’isola la sera stessa, con traduzione
straordinaria in treno, scortato da due funzionari e quattro
agenti. […] Con il confino, rinnovato per altri cinque anni nel
1939 – attenuato soltanto dal permesso ottenuto nel 1935 di
rientrare, per ragioni di salute della moglie, a Malacappa in
regime di domicilio coatto e quindi sotto stretta sorveglianza
di polizia – si conclude la carriera politica di Arpinati. Messo
al bando da un Mussolini sempre più prigioniero del suo
mito e del suo potere dittatoriale, una sorta di damnatio
memoriae colpisce la persona di Arpinati. Tutto di lui deve
essere cancellato, il suo nome, le sue opere, il suo entourage
143
8 settembre
politico. La caduta di Arpinati e la sua sostituzione con un
personale politico di basso profilo e subalterno, finiscono
tuttavia con l’appannare l’immagine di Bologna e della
Decima Legione, relegandole inesorabilmente in una sorta
di periferia politica del regime.
(B. Della Casa, <<Squadrista, podestà, sottosegretario agli
interni: la carriera esemplare di Leonardo Arpinati tra intransigenza e normalizzazione>>, in AA.VV. Fascismo e Antifascismo
nella Valle Padana, Bologna, CLUEB, 2007, pp. 420-426)
WEISZ, DALL’ARA, IL BOLOGNA E IL LITTORIALE
I
ntorno alla metà degli anni Trenta, si creò una situazione
particolarmente favorevole, che permise a Bologna di essere
il vero centro del calcio italiano: un impianto sportivo all’avanguardia (il Littoriale), che non aveva rivali nel resto della
Penisola; un presidente ambizioso ed energico (Renato Dall’Ara); un allenatore di eccezionale livello tecnico (l’ungherese
ebreo Arpad Weisz, che dovette abbandonare il suo incarico
nel 1938, a causa delle leggi razziali).
Quando Weisz è arrivato sotto le Due Torri, nel gennaio
1935, lo ha fatto con la consapevolezza di giocarsi tutto.
Non gusta il sapore della vittoria da cinque anni, e gli manca
come l’ossigeno. Il piatto è ghiotto, Bologna è abituata al
successo. La città è arrivata ad avere quasi trecentomila
144
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
abitanti ed è una piazza che con gli ungheresi ha un feeling
cementato: oltre a Kovacs, del quale Weisz ha preso il posto
in panchina, i tifosi ricordano bene Lelovich, scopritore più
tardi di Giacomo Bulgarelli. Nella lista va inserito anche
Hermann Felsner, austriaco, ma esponente della scuola
danubiana. Ha firmato gli scudetti del 1925 e del 1929, e
nel mezzo avrebbe vinto pure quello del 1927, revocato al
Torino per un episodio ante litteram di calcioscommesse e
spettante al Bologna giunto secondo. Ma Arpinati, podestà
cittadino e presidente federale, ha temuto le accuse di
partigianeria.
Il 1935 è un anno di attese e sottili inquietudini per la città
emiliana, così come per tutta l’Italia. […] I sogni si scatenano
davanti alle copertine della Domenica del Corriere, magari
per una vacanza sugli sci o per assistere a una bella partita
allo stadio come la raffigura Achille Beltrame, sempre piena
di colori e di spalti pieni. È il popolo degli impiegati stretti
dentro ai tram, la piccola borghesia urbana che si sente un
gradino più in alto del proletariato e che alla sera rincasa,
se non soddisfatta, quantomeno appagata [sotto il profilo
economico – n.d.r.]. Il calcio è il suo passatempo preferito,
e indubbiamente le squadre più amate, un po’ come oggi,
risultano la Juventus, il Milan e l’Ambrosiana, così come si
chiama l’Inter di quegli anni per volere del regime [che si
sforzava di limitare l’uso dei termini stranieri – n.d.r.]. C’è
anche il Bologna, come no? Weisz vi è giunto con qualcosa
di grande cui aspirare. […] Lo abbiamo detto: ha un’enorme
sete di rivincita e per placarla ha accettato di raccogliere
dalle mani del presidente del Bologna, Renato Dall’Ara, una
squadra bloccata dopo il successo del settembre in Coppa
Europa.
145
8 settembre
Ma chi è Renato Dall’Ara? È impossibile proseguire nel
racconto di Weisz senza soffermarsi sull’uomo che l’ha
voluto. […] Lo hanno obbligato a prendere il club rossoblu
l’anno prima [= nel 1934 – n.d.r.]. Si sostiene in giro che
sia stato Mussolini in persona a tirarlo dentro l’impresa,
smanioso di mettere in secondo piano Leandro Arpinati, il
gerarca che ha fatto grande lo sport bolognese e che ha
fatto ombra a tanti soloni di Roma. Ciò che ha ricevuto,
Dall’Ara l’ha trasformato in un gioiello, il fiore che le autorità
cittadine vogliono apporsi ogni domenica sulle camicie
nere. Il podestà Manaresi, il segretario federale Colliva, che
gli succederà più tardi, il prefetto Natoli, il questore Diaz, un
paio di immancabili deputati locali: ognuno si mette in coda
a omaggiare il Bologna che cresce d’importanza e richiama
un pubblico, via via, maggiore. L’agosto successivo, alla
ripresa della preparazione, scandirà il podestà: <<Invito
voi giovani a lottare strenuamente per ottenere i migliori
risultati>>. Accanto a lui, Dall’Ara in camicia nera. […]
Il Littoriale in pochi mesi è diventata la seconda casa di
Weisz: una sorta di palcoscenico dove mandare in scena
i frutti del suo laboratorio, una simbiosi tra artigiano e
bottega. Il Bologna degli anni Trenta è famoso in ogni angolo
d’Europa per questo impianto, disegnato dall’ingegner
Costantini, la cui prima pietra è stata posta, nel giugno
del 1925, da Vittorio Emanuele III. Due anni dopo è stato
inaugurato da Mussolini, trionfante su un cavallo bianco e
vittima dell’attentato di Anteo Zamboni, poche ore più tardi.
È chiaro comunque che lo stadio costituisca un emblema
del fascio bolognese, al punto da essere mostrato a ogni
visitatore istituzionale di passaggio in città. <<I tecnici
stranieri – scrive la rivista del Comune di Bologna – rimasero
146
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
ammirati dalla romana grandiosità della costruzione, che
supera per la modernità degli apprestamenti i campi più
rinomati all’estero>>.
È curioso pensare che sarà un ebreo, presto perseguitato
dal regime, a rendere ancora più famoso il fascistissimo
impianto. Non solo: molti progressi li ha attenuti lui. Un
esempio? Nella primavera del 1938, a ridosso del suo
forzato addio, Arpad insisterà con il presidente Dall’Ara
perché affidi ad una società specializzata la sistemazione
del campo. Opera che toccherà alla De Bernardi di Torino. Si
è pure battuto per avere un Gabinetto medico per l’indagine
sanitaria sugli sforzi degli atleti e delle loro possibilità.
Tradotto: un ambulatorio medico-sportivo. Lo stadio ha
numeri sostanziosi: quattromila posti nel parcheggio,
cinquantamila sugli spalti, seicento bambini che ogni giorno
frequentano gratuitamente la piscina limitrofa. Ma non c’è
dubbio: l’attrazione maggiore è la torre di Maratona. Alta
ventiquattro metri, modellata su diversi livelli, ha in cima
la bandiera regalata alla città dalla Marina militare. Più
in alto, sulla punta estrema del pennone, è posta la statua
dorata della vittoria. Prima di essere smontata (oggi è
visibile nella tribuna dello stadio) diventerà il bersaglio dei
soldati americani accampati sul terreno di gioco durante la
risalita del fronte alleato.
(M. Marani, Dallo scudetto ad Auschwitz. Vita e morte di Arpad
Weisz, allenatore ebreo, Reggio Emilia, Aliberti, 2007, pp. 58-65)
147
8 settembre
Gli internati militari
E
saminare, a livello regionale, le conseguenze dell’8 settembre per i soldati, significa muoversi su due piani complementari. Innanzi tutto è opportuno comprendere come si
svolse il collasso del regio esercito in Emilia Romagna; parallelamente, è giusto esaminare le esperienze di migliaia di militari emiliani e romagnoli che furono deportati in Germania,
ma che spesso furono catturati in terre molto distanti dalla
loro, cioè in altre aree d’Italia o addirittura in Grecia, in Albania e Jugoslavia.
A Bologna, l’azione dei tedeschi nei confronti dei militari italiani fu rapidissima e condotta senza sforzi particolari. Pare che
l’intera operazione di controllo del capoluogo abbia coinvolto
appena 70 soldati della Wehrmacht. Di fronte all’intimazione
tedesca di deporre le armi, qualche segno di resistenza si ebbe
nella caserma del 6a reggimento bersaglieri (comandato dal
colonnello Ubaldo Panceri), in quella della cavalleria (ad opera
del capitano Conte Luigi Revelli di Beumont) e in quelle del
3° reggimento artiglieria e del 35° fanteria. Anche i carabinieri si arresero mal volentieri, e infatti alcuni di loro, in seguito,
parteciparono alle attività clandestine antitedesche. Tutte queste
azioni, però, non furono per nulla coordinate tra loro, in quanto
il comandante della Difesa territoriale si rifiutò di organizzare
un’organica resistenza, non si assunse alcuna responsabilità
e respinse la richiesta dell’opposizione antifascista di distribuire armi ai volontari civili che si fossero offerti di combattere a
fianco dei militari. Ancora una volta, la mancanza di direttive
precise, unita all’assenza di iniziativa tipica di molti ufficiali del
regio esercito, abituati solo ad eseguire gli ordini superiori, facilitarono notevolmente il compito delle truppe tedesche.
Nel modenese, nella notte tra l’8 e il 9 settembre, verso le due
148
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
del mattino furono catturate senza colpo ferire tutte le reclute del
1924 accantonate a Vignola. Poche ore dopo, furono occupate
l’Accademia militare e le caserme della città, insieme all’ufficio delle Poste e dei Telefoni. L’unico (breve) scontro avvenne
a Sassuolo, nei pressi del Palazzo Ducale, sede di campagna
dell’Accademia: morì un soldato italiano (Lino Morselli); in seguito, il comandante del reparto che aveva opposto resistenza
(generale Ferrero) fu catturato e deportato in Polonia, ove morì
in prigionia. Fu uno degli oltre 200 tra ammiragli e generali
(dell’esercito e dell’aeronautica) che furono arrestati e spediti in
Germania nei caotici giorni che seguirono la resa italiana. Due
battaglioni, insieme allo Squadrone degli Allievi ufficiali dell’Accademia militare di Modena, si trovavano a circa 70 chilometri
dal capoluogo, in località Piane di Mocogno, al comando del
colonnello Giovanni Duca. Ricevuta la notizia dell’armistizio, si
trasferirono in località Monchio e qui – in mancanza di ordini
superiori – il comandante sciolse i reparti, che si sbandarono
lasciando sul terreno grandi quantità di muli, di cavalli, di automezzi e di armi, recuperati poco dopo dai tedeschi.
Una ricerca recente, condotta da Rossella Ropa, ha valutato in
9.127 il numero dei militari bolognesi deportati in Germania,
dopo essere stati disarmati e catturati sui diversi teatri in cui si
trovavano in servizio.
Per la maggior parte, erano poco più che ventenni (il 40,91%
di essi apparteneva alle classi di leva 1920-1924) ed erano originari della provincia. Il 73,13% di essi era formato da soldati
semplici di fanteria. In molti casi, l’indicazione dell’area di operazioni in cui avvenne l’arresto è vago e generico: comunque,
pare corretto affermare che circa il 50% apparteneva alle armate schierate nei Balcani (Albania, Erzegovina, Montenegro,
Grecia ed isole dell’Egeo) mentre un altro 27% fu catturato in
Slovenia, Croazia e Dalmazia.Il 54,04% venne catturato nelle
ore immediatamente seguenti alla dichiarazione dell’armistizio;
149
8 settembre
il 37,88% fu catturato nella settimana seguente; il resto, tranne
pochissime eccezioni, entro la fine del mese. Le testimonianze raccolte ricordano spesso l’iniziale esultanza, trasformatasi
subito in incubo, alla comparsa dei primi minacciosi reparti
tedeschi. Non mancarono le situazioni paradossali, di reparti
che non solo furono colti completamente alla sprovvista dalla
notizia dell’armistizio, bensì l’appresero dai tedeschi che li catturavano o dai partigiani che, fino al giorno prima, erano loro
nemici. Molti ex soldati ricordano il caos generalizzato che si
venne a creare e forniscono un’immagine ben poco lusinghiera
non solo dei massimi vertici dell’esercito, ma anche dei loro
ufficiali, che impedirono esplicitamente una coordinata azione
di resistenza ai tedeschi oppure abbandonarono i reparti al loro
destino, scappando per proprio conto. Nel complesso, furono 1.503 i bolognesi che dichiararono di essere stati catturati
dopo aver combattuto: non a caso, il 69, 53% lo fece all’estero, e solo il 30, 47% di questi sul territorio metropolitano, ove le
speranze di fuga e di trovare protezione presso la popolazione
civile erano decisamente maggiori. In Grecia (dove furono catturati 1.838 bolognesi), si opposero ai tedeschi 314 di quanti
furono poi internati, mentre 13 dichiararono di essersi uniti ai
partigiani. Di questi combattenti deportati, 116 scamparono
alla battaglia e agli eccidi di Cefalonia; 16 di loro, però, morirono a seguito dell’affondamento delle navi che li portavano
verso la Germania, mentre 4 scamparono al naufragio della
nave Ardena su cui erano stati caricati. A Corfù, dopo un acceso combattimento che provocò 600-700 vittime italiane (molte,
però, fucilate dopo la resa), furono catturati 45 bolognesi; a
Rodi i prigionieri furono 156 (ma solo 78 dichiararono di aver
partecipato ai combattimenti contro i tedeschi).
Giunti in Germania, la maggioranza dei militari bolognesi fu
impiegata nel settore industriale (59,51%). I deportati, morti in
regime di prigionia, furono 358. Di 164 di loro si sa che il de-
150
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
cesso avvenne a seguito di una malattia (in genere legata alla
fame e alla debilitazione); 61, invece, morirono a causa dei
bombardamenti alleati sulla Germania. Di ben 103 internati,
invece, non si conosce la causa della morte
151
8 settembre
L’8 SETTEMBRE A MODENA
L
a testimonianza seguente, di Giancarlo Silingardi, mostra il
clima di solidarietà che si creò istintivamente tra popolazione civile e soldati catturati dai tedeschi, che a Modena rinchiusero all’interno della cosiddetta Cittadella moltissimi militari
destinati all’internamento in Germania.
La mattina del 9 settembre andai davanti al portone del
6a Reggimento Campale a vedere quanto succedeva. Dalla
città arrivò una colonna di carri armati che si fermarono
sulla strada. I tedeschi in parte scesero e di corsa entrarono
nella caserma, in parte restarono sui carri. Dopo un bel po’
di tempo, potevano essere le nove, dalla finestra di casa
mia vedemmo passare una colonna lunghissima di soldati
disarmati. I tedeschi li tenevano a bada coi fucili. I tedeschi
erano pochi. C’era un carro armato in testa alla colonna e
qualcuno in coda. Venivano dalla via Emilia, attraverso lo
spiazzo dove è la Stazione delle Autocorriere, andavano in
Cittadella. Molta gente era in strada a vedere. I prigionieri
gettavano bigliettini con scritti i loro indirizzi e gridavano:
<<Scrivete a casa. Dite che siamo vivi. Raccontate quello
che succede>>. Un bigliettino toccò anche a me e mi
ricordo che scrissi una cartolina in un paese in provincia
di Siena. Molte donne strillavano, qualcuna piangeva. I
tedeschi si guardavano in giro. Non dicevano niente.
(E. Gorrieri, La Repubblica di Montefiorino. Per una storia della
Resistenza in Emilia, Bologna, Il Mulino, 1970, p. 23)
152
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
MODENA TRA CAOS, RAZIONAMENTO E
SOLIDARITÀ POPOLARE
S
ullo sfondo tragico del completo dissolvimento delle autorità militari e civili, Ermanno Gorrieri mette in risalto l’azione
della popolazione, spontaneamente disponibile a compiere
atti di protezione e sostegno nei confronti di soldati sbandati,
sfuggiti alla cattura o evasi dalle mani dei tedeschi.
Il frettoloso sbandamento dei battaglioni allievi
dell’Accademia sull’Appennino fece mancare in Emilia quel
diretto passaggio di reparti militari alla guerriglia verificatosi
in alcune vallate alpine; sicché la Resistenza dovette
cominciare da zero, con armamento ed equipaggiamento
estremamente più ridotto e sommario, neppur lontanamente
paragonabile a quello di cui disponeva l’Accademia. E
inoltre la facilità con cui il Partito Comunista riuscì ad
egemonizzare la lotta di liberazione in queste province, se
trova spiegazione anche nella insufficienza e nelle lentezze
di altre forze politiche, fu dovuta prima di tutto alla totale
assenza di tempestive iniziative da parte degli alti ufficiali
che avevano responsabilità di comando in provincia di
Modena.
Il 9 settembre, agli entusiasmi della sera precedente
fece seguito, nell’animo dei modenesi, la più profonda
costernazione; le illusorie speranze di una rapida avanzata
alleata non bastavano a cancellare la dura realtà
dell’occupazione tedesca, del crollo dell’esercito, della
cattura dei nostri soldati. Il venir meno di ogni autorità,
le lunghe privazioni e il timore delle razzie tedesche
153
8 settembre
scatenarono, il 10 settembre, l’assalto ai magazzini
di generi alimentari. Nel corso del 1943 le difficoltà
annonarie [= connesse al rifornimento dei più elementari
prodotti destinati all’alimentazione – n.d.r.] erano andate
continuamente crescendo; la razione giornaliera di pane
era ridotta a 150 gr. per persona, e inoltre si trattava di
pane in cui crusca, patate e granturco superavano la farina
di frumento. In queste condizioni è facile capire perché
la folla si diede ad assaltare e a saccheggiare fabbriche,
depositi, caseifici e mulini. […] Nessuno aveva promosso
o guidato gli assalti ai magazzini: erano state la fame e le
privazioni a far muovere spontaneamente la povera gente.
Anche se i saccheggi erano giustificati dal timore che i viveri
potessero finire in mano ai tedeschi, il modo disordinato
e caotico con cui furono compiuti non fu che un aspetto,
una manifestazione clamorosa della generale anarchia e
confusione. Il disorientamento degli animi e lo sbandamento
morale non potevano essere più gravi. […]
Di fronte allo sbandamento generale, due reazioni
immediate e spontanee dimostrarono che le energie morali
del popolo non erano del tutto fiaccate: l’una veniva dalle
masse, l’altra da gruppi ristretti. Nei giorni che seguirono
l’8 settembre, tutto il popolo, in uno slancio generoso di
solidarietà fraterna, offrì ogni assistenza ai soldati italiani
che cercavano di sottrarsi alla cattura tedesca: migliaia
di uomini furono aiutati a fuggire, alloggiati, nascosti,
sfamati, vestiti in borghese e assistiti nel cammino verso
casa. <<Da tempo abiti e stoffe erano razionati, dovunque
c’era grande penuria: eppure in quei giorni la gente era
pronta a privarsi di giacche, di camicie, di pantaloni, per
darli ai fuggiaschi. Poiché spesso i treni venivano bloccati
154
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
e perquisiti dai tedeschi, nelle campagne, per le case dei
contadini, continuo era il passaggio di giovani, in viaggio
a piedi verso i loro paesi: essi sapevano che non sarebbero
stati traditi, che potevano contare sull’appoggio e sull’aiuto
della popolazione. I soldati catturati in provincia di Modena
vennero concentrati nella Cittadella, l’antica fortezza estense
dove fu impiccato Ciro Menotti, divenuta la sede del 36a
Reggimento di Fanteria: i tedeschi la scelsero come centro
di raccolta e di smistamento dei soldati italiani prima del
trasferimento in Germania; nella Cittadella furono dunque
trattenuti per alcuni giorni migliaia di uomini e fu qui che si
manifestarono la generosità e l’ingegnosità dei modenesi,
non solo per portare da mangiare ai soldati, ma soprattutto
per aiutarli nella fuga. La principale via di fuga fu quella delle
fognature: due ragazzi, Lella Malavolti e Luciano Bonacini,
che abitavano nelle vicine case popolari, portarono dentro
alla caserma la pianta delle fognature avuta da uno
stradino e fecero loro stessi da guida ai soldati negli stretti
cunicoli maleodoranti. Altri riuscirono con pretesti vari a
portar dentro vestiti, con cui i soldati poterono andarsene:
fra questi don Elio Monari, che ne fece uscire alcuni vestiti
da prete>> (G. G., Fuga dalla Cittadella, 1961). […]
D’altra natura fu il fenomeno del recupero delle armi;
non intendiamo riferirci a quello che fu l’occultamento
occasionale di moschetti e rivoltelle, lasciate dai soldati
presso le famiglie che li avevano aiutati a mettersi in
borghese, ma all’opera attiva di sottrazione delle armi
abbandonate dai vari reparti dell’Esercito. Quest’opera
non fu promossa e organizzata da un centro, che allora
non c’era; siamo invece di fronte ad una serie di iniziative
spontanee, senza collegamento tra loro, di provenienza
155
8 settembre
diversa, aventi un solo denominatore comune: la volontà di
non lasciare che le armi nostre, le armi italiane cadessero in
mano allo straniero e la convinzione che più avanti, forse,
sarebbero diventate utili. Il rischio affrontato per queste
operazioni era la morte. Questo era infatti il contenuto del
punto 2 dell’ordinanza del Comandante superiore tedesco
[…]: <<Chiunque tenga nascoste armi e non ne effettui
la consegna presso un Comando militare germanico entro
24 ore dalla pubblicazione di questo proclama sarà fucilato
secondo la legge marziale>>. […] Il bottino di gran
lunga più rilevante fu quello abbandonato sull’Appennino
dall’Accademia Militare: nella zona non esisteva in quel
momento nessun nucleo, nessun embrione di organizzazione
antifascista; fu perciò la popolazione dei paesi circostanti,
attirata naturalmente più dagli equipaggiamenti che dalle
armi, ad operare il recupero e l’occultamento, costituendo
così un abbondante fonte di rifornimento per le future
formazioni partigiane, che in quella zona avranno la loro
culla anche in conseguenza della presenza di armi in tante
case.
(E. Gorrieri, La Repubblica di Montefiorino. Per una storia della
Resistenza in Emilia, Bologna, Il Mulino, 1970, pp. 26-33)
156
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
I MILITARI BOLOGNESI, NEI GIORNI SUCCESSIVI AL
DISARMO
A
ccusati di tradimento, i soldati italiani catturati dopo l’8
settembre furono trattati dai tedeschi con estrema durezza. Il primo impatto con la violenza nazista si ebbe nei campi di transito, dove i militari furono radunati a migliaia, in
condizioni sanitarie pessime. Seguirono poi il trasferimento
in Germania e l’internamento in lager. Sotto questo profilo,
il destino e l’esperienza degli oltre 9.000 militari bolognesi
catturati sono rappresentativi di quello che si verificò a tutti gli
altri soldati italiani catturati (che secondo alcune stime recenti,
proposte da Gerhard Schreiber, avrebbero raggiunto l’astronomica cifra di 802.722, al 1° febbraio 1944).
<<Le strade sono letteralmente congestionate da truppe
italiane arresesi e da tedeschi che si recano ad occupare le
posizioni lasciate da noi… I cigli delle strade sono cosparsi
di ogni sorta di materiale bellico: fucili, bombe a mano,
cassette di munizioni, mortai, baionette, giberne e altro
ancora… Molti dei nostri piccoli carri L sono rovesciati e
immobili nelle posizioni più strane, alcuni completamente
sventrati, colpiti in pieno dai cannoni dei Tigre tedeschi. A
Dubrovnik un triste spettacolo si è presentato ai nostri occhi:
i segni della battaglia sono ancora freschissimi e l’aria è
ancora impregnata di un acre odore di polvere da sparo
e di carne bruciata. Giacciono qua e là i corpi dei nostri
soldati crivellati di colpi, alcuni addirittura a brandelli. Altri
corpi invece sono a terra, rattrappiti, senza presentare ferite
di sorta, solo i feriti e i cadaveri tedeschi sono già stati
portati via. In gran numero anche le carcasse di muli e di
157
8 settembre
cavalli della nostra artiglieria ippotrainata… Anche in città
un’enorme quantità di materiale bellico per ogni dove…
Intanto lunghe colonne di prigionieri di ogni arma passano
giorno e notte dalla strada che fiancheggia il campo…
non è possibile avvicinarli ma sembra che siano diretti in
Germania. Sono malridotti e malvestiti>> (L. Morsiani).
Questo, in linea di massima, lo scenario che fece da sfondo
alle operazioni di cattura e di disarmo degli oltre 9.000
bolognesi che, fin dai primi momenti, vennero sottoposti
a un trattamento durissimo: furono trattenuti nei campi di
transito e smistamento (Durchgangslager - Dulag), senza
preoccupazioni per le condizioni alimentari; poi trasportati in
Germania o in Polonia in carri bestiame insaccati di uomini,
chiusi e sorvegliati, senza cibo né acqua, per più giorni. Non
tutti furono deportati: 845 (il 9,26%) rimasero nei territori
dove erano stati disarmati: in Iugoslavia vennero rinchiusi
nei campi a Brod, Nisch, Zagabria, Belgrado; in Grecia in
quelli situati ad Atene, Salonicco, Ioannina, Rodi; mentre
Grenoble, Perpignan, Calais sono solo alcuni dei tanti luoghi
di detenzione in Francia, citati nelle testimonianze. Di questi,
nel corso del tempo, dodici aderirono [= accettarono di
collaborare con i tedeschi e con la RSI – n.d.r.] (1,42%): otto
come militari e quattro come lavoratori. Non sono molti quelli
che raccontano, con dovizia di particolari, la loro esperienza
di prigionia nei territori occupati: alcuni furono chiusi in
Lager veri e propri e utilizzati in lavori pesanti (in fabbrica
o in miniera); altri vennero destinati d’autorità a reparti di
lavoratori posti alle dirette dipendenze della Wehrmacht
e costretti a seguire le truppe tedesche in ritirata. In ogni
caso, le loro condizioni non furono molto diverse e dipesero
soprattutto da svariate circostanze. […]
158
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
La maggioranza dei bolognesi, dunque, venne rinchiusa in
centri di raccolta provvisori: caserme, campi sportivi, stadi
di calcio, vecchi accampamenti abbandonati (in genere, i
soldati separati dagli ufficiali), e qui cominciarono a patire
le anticipazioni di quelli che sarebbero stati gli aspetti più
dolorosi dell’esperienza concentrazionaria, sperimentando il
difficile mestiere della sopravvivenza: dormire all’aperto, bere
acqua non potabile, rimanere senza cibo e ricorrere al baratto,
un espediente che poteva solo ritardare, ma non scongiurare,
la fame che iniziò ad essere compagna costante.
<<13 settembre: ieri sera sulle sei pomeridiane reparti di
fanteria tedesca (tutti soldati giovanissimi) ci hanno incolonnato
e fatti scendere a Dubrovnik con tutto il nostro armamentario,
cannoni compresi, per la resa definitiva in questo campo
di concentramento provvisorio, già accampamento di un
reparto di artiglieria ippotrainata. Il campo si trova nella zona
periferica della città e a sud di essa; è spazioso e il terreno,
in parte ondeggiato e in parte piano, è stato recintato alla
meglio da siepi e da steccati, in legno e filo spinato. Non vi
sono edifici in muratura, ma solo qualche baracca in legno
ad uso magazzino: la truppa infatti era attendata, mentre i
cavalli, a quanto sembra, dormivano all’aperto…
30 settembre: …, sono stato anche indisposto forse a causa
dell’acqua non potabile che siamo costretti a bere. Il campo
è stato organizzato e si provvede da soli alla cucina, agli
alloggi, alla pulizia. Per i viveri finora si è tirato avanti con le
scorte cui ci rifornimmo al momento del caos; i tedeschi non
hanno mai distribuito nulla. Adesso però le abbiamo quasi
esaurite e presto, se non si provvederà, saremo alla fame.
Speriamo sempre che succeda qualcosa di nuovo e finisca
tutto, in modo da poter tornare a casa…
159
8 settembre
22 ottobre: la situazione è diventata critica per quanto riguarda
il vettovagliamento, esaurite tutte le scorte, viviamo nutrendoci
per buona parte di carne di muli e cavalli morti di inedia o che
uccidiamo durante la notte di nascosto. Riusciamo anche a fare
qualche permuta con i civili jugoslavi: essi ci offrono farina e
pane in cambio di capi di vestiario, di cui ancora disponiamo,
ma tutto ciò non potrà durare a lungo>> (L. Morsiani). […]
Molti dei testimoni, allora giovani poco più che ventenni,
descrivono lo smarrimento provato quando capirono che
non avrebbero fatto ritorno alle proprie case. Il senso di
abbandono che li colse allora, non li lasciò più e segnò non
solo la loro vicenda di prigionia, ma anche il loro ritorno in
patria. Il racconto del viaggio è poi caratterizzato soprattutto
dai pesanti disagi patiti: la mancanza di spazio (nei vagoni
bestiame piombati il tetto massimo di quaranta persone
venne spesso superato e i termini usati che descrivono il
sovraffollamento rendono perfettamente l’idea: i bolognesi
scrivono di essere stati pigiati, schiacciati, chiusi come animali
e caricati in treno come sardelle), la fame (misere razioni
alimentari, costituite da pane e scatolette di carne, che in ogni
caso dovevano bastare per più giorni), la sete, le precarie
condizioni igieniche, cui si aggiunsero violenze, umiliazioni e
degradazioni: <<un trattamento peggiore che non facevano
con le bestie>>. […] Ci fu anche chi, rinchiuso in un vagone
che non venne aperto per cinque giorni, perse l’uso della
ragione, caso particolarmente tragico ma che restituisce, in
modo esemplare, lo stato emotivo di quegli uomini.
(R. Ropa, Prigionieri del Terzo Reich. Storia e memoria dei militari bolognesi internati nella Germania nazista, Bologna, CLUEB,
2008, pp. 104-113)
160
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
LE CONDIZIONI DI VITA DEGLI INTERNATI MILITARI
ITALIANI NEI LAGER
I
l durissimo atteggiamento tenuto dai tedeschi nei confronti
degli IMI [=Internati Militari Italiani] non si attenuò in Germania, allorché i soldati catturati furono internati in appositi
lager e adibiti al lavoro nelle industrie tedesche. Le testimonianze dei superstiti pongono l’accento soprattutto sulla fame
patita e sulle malattie che colpivano i deportati, a causa delle
carenze alimentari.
Nel lager di Sandbostel il 16 aprile 1944 il tenente Giovanni
Guareschi scriveva su un diario destinato a divenire famoso:
<<Cammino su e giù… e vado svelto ma la fame mi
insegue… Quante ore prima di poter masticare? Ancora
cinque ore, poi avrò due patate e una scodella di rape; e
lo stomaco, compreso rapidamente l’inganno, riprenderà
a spasimare più dolorosamente. Sento anche la fame del
dopo>>. Una ventina d’anni più tardi, rievocando con
un amico i giorni di Sandbostel, Guareschi dirà che a
quell’epoca gli tornavano spesso in mente le pagine di un
libro di Carlo Castorino sulla fame sofferta dai prigionieri
italiani a Mauthausen durante la Grande guerra e che
lo scrittore genovese aveva significativamente intitolato
La prova della fame: nel febbraio 1944, l’80 per cento
dei 1.900 ufficiali internati a Czestochova soffrirono per
edemi da fame e, come in altri lager polacchi, dal 30 al
40 per cento si ammalarono di tubercolosi in seguito alla
denutrizione. La fame diventò la misura di tutte le cose. Nel
lager di Przemysl, nel novembre 1943, un chilo di patate si
161
8 settembre
pagava cento lire e una pagnotta ne costava novecento,
mentre in Italia il prezzo del pane al mercato nero oscillava
attorno alle 20 lire al chilo. Per acquistare pane, sigarette,
patate e grassi gli internati italiani vendettero tutto quello
che possedevano, anche le fedi matrimoniali, perché l’oro
era la merce di scambio più ambita dai tedeschi: un orologio
d’oro veniva valutato sei-otto filoni di pane.
Come razione quotidiana gli ufficiali ricevevano ogni
mattina un litro di infuso caldo di tiglio – di così scarso
valore nutritivo che più d’uno se ne serviva per lavarsi o
farsi la barba -; a metà giornata una minestra di rape, o
di barbabietole già spremute, con qualche patata; oppure
crauti crudi, qualche grammo di condimento, una fetta di
pane da 2-300 grammi, un cucchiaio di miele sintetico o
di marmellata o di zucchero (25 grammi); un pezzetto di
margarina o di ricotta o di qualche surrogato di proteine (25
grammi): <<Troppo poco per vivere, troppo per morire>>
(G. Storti). La razione per i soldati, i graduati di truppa
e i sottufficiali era simile, forse con un po’ più di patate;
per gli addetti ai lavori pesanti la minestra di rape era più
abbondante e, di solito, più densa. Poi c’era l’alimento
principale, il pane del lager. Nero e stopposo, era fatto con
farina di segala e aveva forma di cassetta come il pancarré.
Ogni pagnotta, solitamente lunga una trentina di centimetri
e larga dieci, pesava fra i 1.500 e i 1.800 grammi, pari
a sette razioni individuali circa. In genere la pagnotta era
di qualità scadente e vecchia: il 25 settembre 1943, a
Sandbostel gli internati militari italiani ricevettero del pane
ammuffito sul quale era stampigliata la data dell’11 maggio
di quell’anno. La fame, compagna indivisibile del deportato,
spingeva a una ossessionante ricerca di giustizia nella
162
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
spartizione dei viveri, e specialmente del pane che veniva
distribuito baracca per baracca, a gruppi di venti-trenta
prigionieri. La spartizione del pane comportava ogni giorno
complicate misurazioni e sorteggi allo scopo di eliminare
qualsiasi possibilità di recriminazione: <<Una forma
di pane, di quel pesante e umido pane che la guerra ha
fatto conoscere in tutta l’Europa, veniva divisa con bilance
sensibili come quella dei farmacisti e quando l’eguaglianza
nel peso e nella forma era quasi assoluta, si tirava ancora a
sorte>> (A. Natta). A questo punto, infatti, uno del gruppo
andava in fondo alla baracca, si voltava col viso alla parete
e, in risposta alla domanda: <<A chi questo?>>, faceva
il nome di uno dei compagni assegnando così, con assoluta
casualità, una delle porzioni pronte.
La fame divenne disumana, e mortale, per gli IMI che
lavoravano nelle grandi industrie quando il 28 febbraio
1944 fu introdotta una disposizione secondo la quale il
vitto dei deportati doveva essere proporzionato al loro
rendimento sul lavoro: <<Il Führer esige che gli internati
militari italiani siano costretti, con severe misure, ad un
alacre lavoro. Il vettovagliamento è perciò da commisurare
al lavoro compiuto… La decisione relativa alla diminuzione
è di competenza del datore di lavoro>>. Molte industrie
tedesche applicarono immediatamente la direttiva di Hitler
e quindi, per stimolare i deportati-schiavi a una maggiore
produttività, finirono per affamarli ancora di più, riducendo
le loro già scarsissime razioni. Nello Stalag VIII-B di Tesin,
nella regione di Breslavia […], dov’erano rinchiusi 8.827
militari italiani adibiti prevalentemente alle miniere, il rancio
fu fissato, dal marzo 1944, sulla base del rendimento
nel lavoro. Analogamente a quanto già adottato per i
163
8 settembre
prigionieri di guerra russi, gli internati italiani vennero divisi
in tre gruppi: i buoni lavoratori; i medi ma fisicamente deboli
e quelli che non riuscivano a lavorare, definiti fannulloni. I
pasti caldi si cucinavano per tutti, ma gli appartenenti al
primo gruppo ricevevano due litri e mezzo di minestra; quelli
del secondo due litri e gli appartenenti al terzo soltanto
mezzo litro. Anche nelle miniere di Peterswald, in Alta Slesia,
i tedeschi suddivisero i 530 militari italiani che vi lavoravano
in tre categorie – prima, seconda, terza – corrispondendo
il rancio secondo la categoria di appartenenza: <<Più
lavorare, più mangiare>>, annunciarono. Questo metodo,
chiamato Leistungsernährung (alimentazione proporzionata
alla produttività), varato già nel 1942, collocava nella
prima categoria coloro che avevano un rendimento pari, o
superiore, all’80 per cento di un operaio tedesco di uguale
qualifica; nella seconda coloro il cui rendimento oscillava
fra l’80 e il 60 per cento; la terza, infine, rappresentata da
chi aveva un rendimento inferiore al 60 per cento; la parte
di rancio tolta agli schiavi di quest’ultima categoria andava,
come premio, a quelli della prima. Poiché dimezzare il
vitto giornaliero, anche agli ammalati, costituiva una
delle punizioni collettive più frequenti, le razioni potevano
scendere a livelli minimi – e mortali – di 900 calorie al giorno
contro le 1.730 prescritte e le 2.500-3.000 necessarie per
lavorare.
(G. Mayda, Storia della deportazione dall’Italia 1943-1945.
Militari, ebrei e politici nei lager del Terzo Reich, Torino, Bollati
Boringhieri, 2002, pp. 326-329)
164
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
LA FARFALLA
I
l poeta romagnolo Tonino Guerra fu uno dei moltissimi internati militari in Germania che dovette subire la fame nei campi tedeschi. Guerra ricorda che già all’interno del lager iniziò
a comporre poesie in dialetto, <<per tenere compagnia a dei
contadini romagnoli>>, cui dava conforto e speranza sentire
parlare nella loro lingua materna. Il testo che presentiamo,
invece, fu scritto dopo la liberazione ed esprime in pochi versi
il dramma di un’intera generazione.
Cuntént, ma propri cuntént
(Contento, ma contento davvero)
a so stè una masa ad vòlti tla vòita
(sono stato molte volte, nella vita)
mò piò di tòtt quant ch’i m’a liberè
(ma più di tutte, quando mi hanno liberato)
in Germania
(in Germania)
ch’am so mèss a guardè una farfàla
(e mi sono messo a guardare una farfalla)
senza la vòia ad magnèla
(senza la voglia di mangiarla)
(S. Pivato, <<Letteratura e guerra a Rimini>>, in A. Bianchini
– F. Lolli (a cura di), Letteratura e Resistenza, Bologna, CLUEB,
1997, p. 268)
165
8 settembre
INDICE ICONOGRAFICO
Immagine: 9 settembre 1943
Fonte: Il Resto del Carlino
Archivio Istituto Storico Parri. Emilia-Romagna
Per concessione: Istituto Storico Parri Emilia-Romagna, Via Sant’Isaia, n.
18, 40100 - Bologna
Immagine: 9 settembre 1943
Fonte: Il Resto del Carlino
Archivio Istituto Storico Parri. Emilia-Romagna
Per concessione: Istituto Storico Parri Emilia-Romagna, Via Sant’Isaia, n.
18, 40100 - Bologna
Immagine: 9 settembre 1943
Fonte: Il Resto del Carlino
Archivio Istituto Storico Parri. Emilia-Romagna
Per concessione: Istituto Storico Parri Emilia-Romagna, Via Sant’Isaia, n.
18, 40100 - Bologna
Immagine: 9 settembre 1943
Fonte: Il Resto del Carlino
Archivio Istituto Storico Parri. Emilia-Romagna
Per concessione: Istituto Storico Parri Emilia-Romagna, Via Sant’Isaia, n.
18, 40100 - Bologna
Immagine: 9 settembre 1943
Fonte: Il Resto del Carlino
Archivio Istituto Storico Parri. Emilia-Romagna
Per concessione: Istituto Storico Parri Emilia-Romagna, Via Sant’Isaia, n.
18, 40100 - Bologna
Immagine: 9 settembre 1943
Fonte: Il Resto del Carlino
Archivio Istituto Storico Parri. Emilia-Romagna
Per concessione: Istituto Storico Parri Emilia-Romagna, Via Sant’Isaia, n.
18, 40100 - Bologna
Immagine: Soldati tedeschi a Parigi
Fonte: La seconda guerra mondiale : immagini dal fronte / testi di David
Boyle. - Vercelli, : White Star, 1999. - 598 p. : in gran parte ill. ; 31 cm.
(Trad. e ampliamento del testo a cura di Fabio Bourbon)
166
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
Per concessione: Istituto Storico Parri Emilia-Romagna, Via Sant’Isaia, n.
18, 40100 - Bologna
Immagine: Soldati italiani in Grecia - Cefalonia
Fonte: Fondo Fotografico Luigi Arbizzani, Istituto Storico Parri. Emilia-Romagna
Per concessione: Fondo Fotografico Luigi Arbizzani, Istituto Storico Parri
Emilia-Romagna, Via Sant’Isaia, n. 18, 40100 - Bologna
Immagine: Leandro Arpinati (Civitella di Romagna, 29 febbraio 1892 -Argelato (Bo), 22 aprile 1945)
Fonte: Le legioni bolognesi in armi / Giorgio Pini. - Bologna : Edizione de
l’assalto, 1923. - 108 p. : ill.; 24 cm
Per concessione: Istituto Storico Parri Emilia-Romagna, Via Sant’Isaia, n.
18, 40100 - Bologna
167
8 settembre
168
IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO
169
© Regione Emila-Romagna - Assemblea Legislativa
Progetto grafico: lucignolo progetti grafici (Bo)
I° edizione - finito di stampare il xx Xxxxxx 2011
stampa a cura di XXXXXXX
Francesco Maria Feltri
insegna Italiano e Storia
presso l'ITAS "Francesco Selmi" di Modena.
E' autore di numerosi manuali
di Storia per la Scuola Superiore,
tra cui ricordiamo "I giorni e le idee" (SEI, Torino, 2001)
e "Chiaroscuro" (SEI, Torino, 2011).
In qualità di studioso della Shoah,
ha collaborato con la Fondazione Anne Frank
di Amsterdam e con il Museo Yad Vashem di Gerusalemme.
Per l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, ha
curato il sussidio didattico on line
"Viaggio visivo nel Novecento totalitario".
CONSAPEVOLEZZA
MEMORIA
LucignoloProgettiGrafici
Cittadinanza