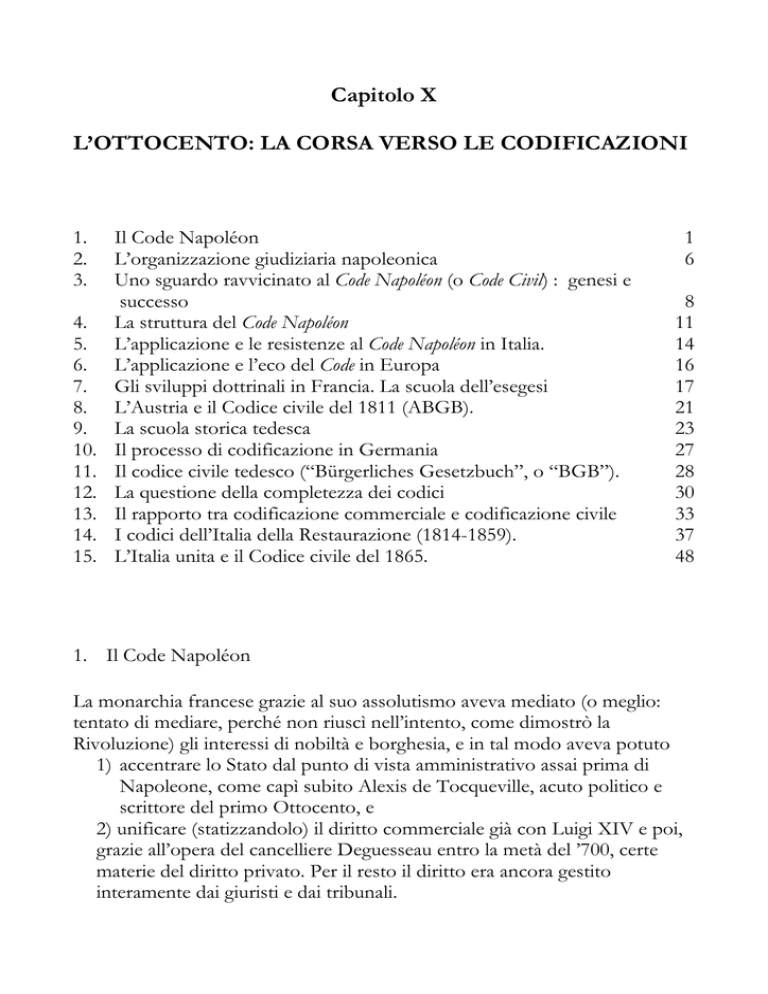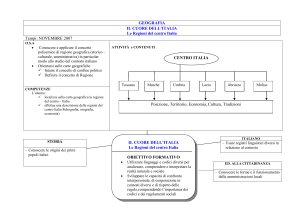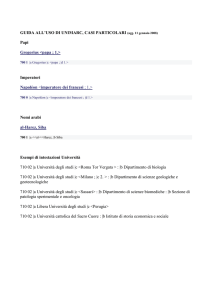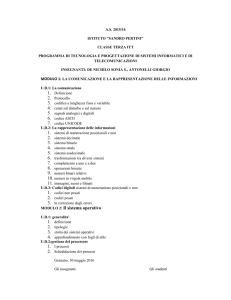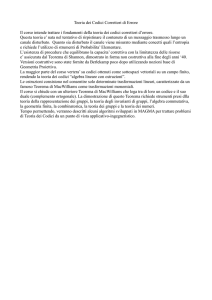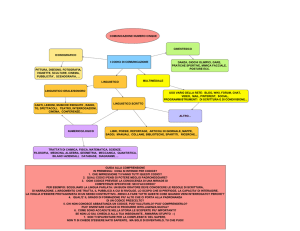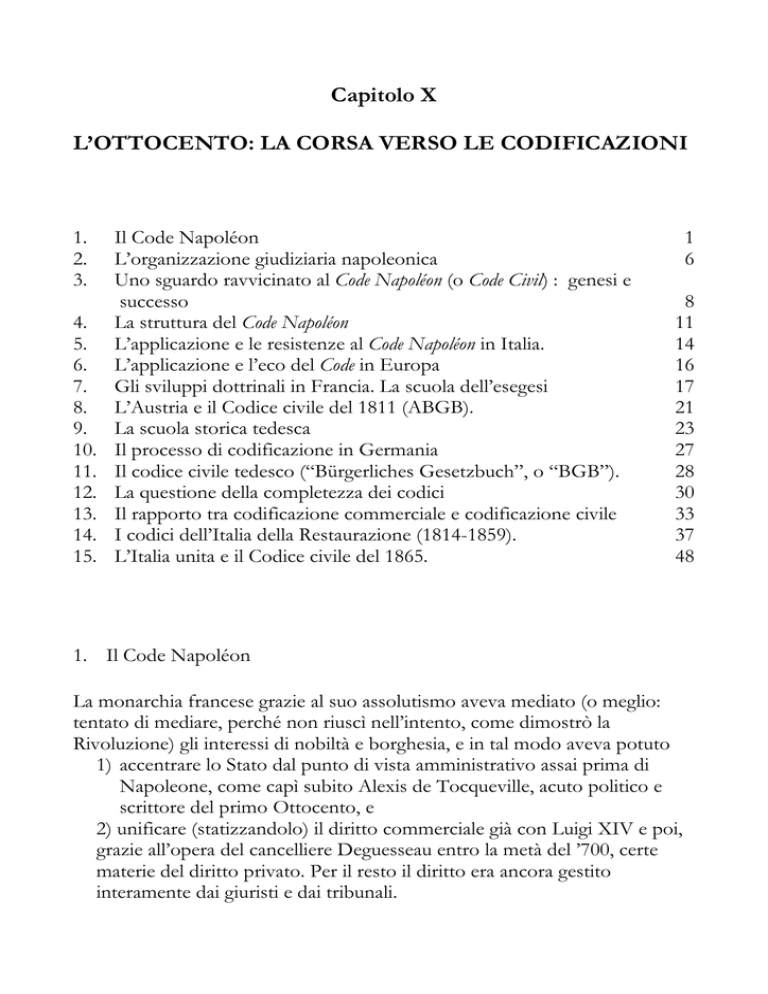
Capitolo X
L’OTTOCENTO: LA CORSA VERSO LE CODIFICAZIONI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Il Code Napoléon
L’organizzazione giudiziaria napoleonica
Uno sguardo ravvicinato al Code Napoléon (o Code Civil) : genesi e
successo
La struttura del Code Napoléon
L’applicazione e le resistenze al Code Napoléon in Italia.
L’applicazione e l’eco del Code in Europa
Gli sviluppi dottrinali in Francia. La scuola dell’esegesi
L’Austria e il Codice civile del 1811 (ABGB).
La scuola storica tedesca
Il processo di codificazione in Germania
Il codice civile tedesco (“Bürgerliches Gesetzbuch”, o “BGB”).
La questione della completezza dei codici
Il rapporto tra codificazione commerciale e codificazione civile
I codici dell’Italia della Restaurazione (1814-1859).
L’Italia unita e il Codice civile del 1865.
1
6
8
11
14
16
17
21
23
27
28
30
33
37
48
1. Il Code Napoléon
La monarchia francese grazie al suo assolutismo aveva mediato (o meglio:
tentato di mediare, perché non riuscì nell’intento, come dimostrò la
Rivoluzione) gli interessi di nobiltà e borghesia, e in tal modo aveva potuto
1) accentrare lo Stato dal punto di vista amministrativo assai prima di
Napoleone, come capì subito Alexis de Tocqueville, acuto politico e
scrittore del primo Ottocento, e
2) unificare (statizzandolo) il diritto commerciale già con Luigi XIV e poi,
grazie all’opera del cancelliere Deguesseau entro la metà del ’700, certe
materie del diritto privato. Per il resto il diritto era ancora gestito
interamente dai giuristi e dai tribunali.
Fu la Rivoluzione a porsi il problema della codificazione per motivi politici
contro i privilegi di ceto, e quindi a fare un passo ulteriore. Solo la
Rivoluzione del resto avrebbe potuto metter mano a un’area del diritto
privato altrimenti intangibile, come matrimonio e famiglia, fino ad allora in
gran parte sotto l’influsso della Chiesa tridentina. Il risultato duraturo della
Rivoluzione fu appunto la ‘laicizzazione’ dello Stato, che poteva così intervenire
anche in questi settori prima preclusi. Perciò il matrimonio contrattuale
statale - inesistente per il diritto della Chiesa - entrò a far parte della vita
quotidiana come vi entrò addirittura la possibilità del divorzio, che fu
introdotto allora col Code Napoléon per la prima volta (e quindi anche, sia pure
per pochi anni, in Italia); ugualmente, divenne normale l’anagrafe civile, prima
curata invece dai parroci. Perciò anche i rapporti patrimoniali tra coniugi
trovarono ora la loro completa regolamentazione nella legge, la quale
individuò la famiglia come la prima cellula autoritaria della società, posta
sotto l’autorità del padre e marito, che deve sovrintendere alla attività
giuridica della moglie, ritenuta non all’altezza delle sottigliezze giuridiche.
L’operazione di ‘statizzazione’ del diritto privato riesce dunque in Francia,
grazie alla Rivoluzione che l’aveva prevista tra le sue riforme, col Code civil
approvato nel 1804, detto poi Napoléon per ossequio all’Imperatore dei
Francesi, che del resto intervenne attivamente alle riunioni per la sua
redazione.
Il Codice nell’intenzione di Napoleone doveva costituire una sorta di ‘Bibbia
del cittadino’, un libro che l’avrebbe accompagnato negli affari giuridici dalla
nascita alla morte, un libro che doveva essergli comprensibile - e perciò fu
scritto chiaramente e nella lingua nazionale contro tutte le astruserie del
diritto d’Ancien régime. Napoleone vuole assicurare anche il superamento degli
estremismi di sinistra del passato e le inconcludenze del governo del
Direttorio. Il Codice vuole dare l’idea di una società pacificata e unificata,
basata sul consenso (e egli ne ricevette certamente tantissimo: è il c.d.
‘bonapartismo’ che tormenterà l’acutissimo Marx), sicura perché ordinata,
popolata di proprietari (molti dei quali hanno comprato i beni ‘nazionali’ tolti
a chiese e monasteri) e al tempo stesso buoni mariti e padri con a
disposizione gli strumenti giuridici per far valere il loro buon senso
patriarcale.
Il Codice è perciò incentrato essenzialmente sulla proprietà (e, come vedremo
in seguito nel presente capitolo, essenzialmente sulla proprietà immobiliare),
sui suoi modi di acquisto e di trasferimento da parte del ‘cittadino’, che è la
nuova figura astratta creata dalla Rivoluzione e accortamente non rinnegata
da Napoleone.
Non più nobili, borghesi, mercanti e preti per la legge, ma l’unico soggetto di
diritto: il cittadino. Napoleone imperatore creerà una sua nobiltà, così come il
clero, i militari e i commercianti continueranno ad esistere naturalmente, ma
lo status soggettivo non doveva comportare regole diverse ai fini privatistici.
Sul piano pubblicistico le differenze continuarono però ad esistere, dato ad
esempio che le leggi elettorali assicuravano l’elettorato solo a chi aveva un
certo ‘censo’, ossia una certa ricchezza. Ma il ricco, il nobile, il clochard (il
barbone, pron. ‘closciar’) avevano ora tutti uguali strumenti a disposizione dal
punto di vista privatistico, ed essi erano chiaramente rinvenibili nel grande
Code.
Strumenti, si badi, a disposizione di chiunque in tutte le parti del Paese. Per la
prima volta nella storia francese, ora non ci sarebbero più state differenze tra
Bretoni e Provenzali etc., ma un unico diritto privato uguale per tutti, che
eliminava l’antica divisione tra Paesi di diritto scritto e di diritto
consuetudinario. Val la pena di sottolineare quanto ciò abbia giovato al senso
di Nazione dei Francesi e quanto anche alla penetrazione della propaganda
portata all’estero da Napoleone?
Il Code mirava a una società nuova, perché dava concretezza alla libertà e
all’uguaglianza (solo giuridica) se non proprio alla fratellanza in concreto. I
Francesi riescono così a costruirsi l’immagine di coloro che si sacrificano,
anche a prezzo della vita, per portare ovunque il nuovo Verbo, per spezzare
le catene che hanno vincolato per tanto tempo le energie ‘naturali’ degli
uomini. La novità di questa ideologia è dimostrata dalla relativa facilità con
cui essa trovò accoglienza - almeno in un primo tempo - all’estero,
sollecitando contro le dinastie di diritto divino regnanti (terrorizzate
dall’egualitarismo diffuso dai Francesi) il sorgere di nuclei di ‘patrioti’ pronti a
trasferire localmente il Verbo rivoluzionario (moderato ormai, ma sempre
rivoluzionario di fronte ai regimi d’Antico regime) per creare la Grande Nation
affratellata contro il passato oscurantista. È questo il germe ancora confuso
da cui si svilupperanno i moti liberali e risorgimentali anche in Italia.
Anche se i Francesi furono poi localmente quanto mai autoritari e a favore
del centralismo parigino al punto da provocare presto risentimenti estesi
sfocianti anche in sanguinose rivolte - soprattutto per non aver rispettato le
tradizioni religiose profondamente radicate (pensiamo ai moti ‘sanfedisti’ al
Sud, o ai Viva Maria in Toscana) -, non c’è dubbio che la loro martellante
propaganda a favore dei diritti dei ‘cittadini’ e dei ‘popoli’ in rivolta contro i
governi dispotici di un tempo, contro i ‘signori’ feudali e i nobili del passato, e
a favore di una fratellanza che andava al di là delle Nazioni storiche, dei
confini, delle differenze di religione, di lingua e di storia, contribuirono
enormemente alla diffusione entro il senso comune, di tutti, del razionalismo
moderno ed egualitario prima appannaggio soltanto di ristrette élites.
Anche se di fatto (un po’ com’è successo spesso nella storia della Chiesa)
tradirono gli ideali da essi stessi propagandati, con i fermenti introdotti
ovunque in Europa, i Francesi finirono per contribuire potentemente, in
pochi anni, direttamente o meno, e anche solo per reazione, a creare
l’orizzonte ideale che sostanzia la civiltà contemporanea. Contro
semplicistiche e/o frettolose sottovalutazioni della Rivoluzione apparse in
occasione del II centenario celebrato pochi anni fa, si può certamente dire
che la Rivoluzione e Napoleone, con i sommovimenti materiali e ideali che
hanno provocato in Europa, sono direttamente collegabili agli eventi
grandiosi dell’Ottocento e del Novecento, ai movimenti nazionali, italiani,
tedeschi etc., liberali e democratici e così via ovunque radicatisi e stimolo di
vicende diversissime - e anche drammatiche: vedi il caso del ‘socialismo’
sovietico -, ma con un minimo comun denominatore: 1) la dimensione di
massa dei fenomeni sociali, a cominciare dalla diffusione delle ideologie e, 2),
il loro ‘temporalizzarsi’, secolarizzarsi - ossia l’essere ormai ancorate
saldamente ai problemi terreni, di ogni giorno ed entro un quadro politico
dato, ‘regionale’, crollate le prospettive di salvezza universale del
Cristianesimo.
Ma il Code è da un certo punto di vista anche più importante delle Costituzioni
francesi portate dalle truppe (in particolare quella dell’anno III, imitata quasi
ovunque a cominciare dall’Italia napoleonica), perché le costituzioni
mutarono con relativa frequenza, in relazione ai mutamenti politicoistituzionali decisi a Parigi (prima Repubbliche locali, poi monarchie collegate
all’Impero napoleonico), mentre il Code espresse subito una normativa in
accordo con bisogni sociali profondi. La politica con le sue necessità
congiunturali modificava (e modifica oggi) in continuazione gli equilibri
giuspubblicistici, anche se già allora diffuse potentemente l’idea che ogni
Paese civile deve avere una ‘sua’ costituzione, mentre il diritto privato può
apparire ‘immobile’, ‘naturale’, una volta che esso è riuscito - appunto con il
codice napoleonico - ad esprimere l’ordine della natura descritto da Domat e
dai Fisiocratici.
Operazione ideologica di enorme portata, quindi, con la traduzione sul piano
‘privatistico’ delle aspirazioni illuministe, che avevano presente un uomo
astratto, ‘naturale’, al di là delle sue qualificazioni socio-economiche.
Operazione bollata come ‘conservatrice’ naturalmente da chi si rende conto
oggi che il ‘soggetto unico’ del codice è pura forma mistificante, perché
comporta la conseguenza di oscurare le disuguaglianze reali presenti nella
società, dato che il clochard non avrà mai modo di utilizzare né i contratti del
codice né il testamento, visto che non ha proprietà di cui disporre.
Ma intanto si è creato un quadro legislativo favorevole alla libertà economica,
perché si può comprare e vendere liberamente tutto, ora che finalmente si
sono aboliti feudi, grandi manomorte, primogeniture e fedecommessi. La
proprietà venne ‘socializzata’ nel senso che viene messa sul mercato, a
disposizione di chi volesse investire e intraprendere. Da qui viene fuori anche
quel ceto di piccoli e medi proprietari rurali (spesso conservatori) che ha
avuto un’importanza enorme nella storia di Francia: si pensi che il Code è
tanto individualistico e ‘borghese’ che non solo valorizza la autonomia privata
con la libertà contrattuale, col consenso che basta a trasferire la proprietà, ma
guarda con sfavore alla comproprietà, perché si riteneva che non consentisse
una buona gestione dei patrimoni.
È quindi il codice del ‘mercato’com’era pensato allora, essenzialmente
agricolo, che lancia un segnale politico inequivocabile. Non a caso durante la
Restaurazione laddove esso fu conservato o imitato (e fu questa la regola),
pur in ordinamenti ridivenuti ‘assolutistici’, cioè privi di libertà politiche, il
Codice fu riguardato come un baluardo di importanza ‘costituzionale’, perché
garantiva almeno un certo quadro ‘civile’, di libertà socio-economiche, anche
se non accompagnate da quelle politiche come la libertà di stampa, di
associazione etc.
Tra l’altro, i governi ‘restaurati’ non fecero tesoro soltanto di queste
innovazioni rivoluzionarie (guardandosi bene ad esempio dal restaurare i
feudi), ma presto cominciarono a guardare ad altre novità giuspubblicistiche
francesi molto utili al rafforzamento dei poteri centrali. Il prefetto ad esempio,
l’onnipotente e onnipresente commissario governativo sovrintendente alle
autonomie locali, divenne per tutti i governi un modello da copiare, come lo
erano altre novità ‘rivoluzionarie’.
Si pensi ad una conseguenza importantissima della separazione dei poteri,
come quella per cui si comincia a pensare che gli atti amministrativi non
potevano essere sindacati dal giudice ordinario e che portò anche alla tesi che
non si potevano neppure inquisire penalmente i funzionari amministrativi,
perché sarebbe equivalso a ledere la loro immunità derivante dalla
separazione dei poteri! Così le materie amministrative più interessanti per il
governo (quelle fiscali ad es.) vennero sottoposte a giudici speciali dipendenti
dal governo stesso: siamo alle origini dell’attuale giustizia amministrativa, di cui
il Consiglio di Stato è il frutto ottocentesco migliore. Per le stesse questioni
civili, invece dei Parlements, che erano state corti sovrane decentrate
indipendenti una dall’altra, si organizzarono corti dipendenti
burocraticamente l’una dall’altra, con in cima la Corte di Cassazione.
2. L’organizzazione giudiziaria napoleonica
Quel che é certo é che le linee dell’organizzazione amministrativa e giudiziaria
create in Francia nel periodo consolare ebbero grande successo non solo in
Francia, ma furono esportate in Italia e in altre zona d’Europa e seguite in
seguito come modelli di razionalizzazione e semplificazione laddove in
precedenza allignavano caos o costanti sovrapposizioni di competenze.
Le riforma giudiziaria é coeva di quella amministrativa: la prima é datata 18
marzo1800, la seconda 17 febbraio dello stesso anno. Entrambe sono frutto
di un decreto consolare.
Il protagonista della nuova amministrazione sarà senza dubbio il prefetto,
rappresentante dello stato centrale nel dipartimento e superiore gerarchico
rispetto alle varie branche dell’amministrazione locale.
La nuova organizzazione giudiziaria, invece, pur rispondendo alle istanze di
separazione dei poteri fatte proprie dalla Rivoluzione (che già nel novembre
1789 aveva abolito quegli organi misti amministrativi/giudiziari di grande
influenza che erano i Parlements), instaurerà una giustizia basata su una chiara e
ben disciplinata pluralità di gradi di giurisdizione ma composta questa volta di
personale non più eletto dal popolo (come aveva previsto la prima grande
legge di riforma giudiziaria, quella varata tra il 16 e 24 agosto 1790), ma
nominato dal governo e inamovibile solo dopo un certo numero di anni (5)di
esercizio professionale, la qual cosa non scoraggerà le famose epurazioni della
magistratura effettuate dal Bonaparte (e che rimarranno una costante della
storia francese sino ad oggi!).
Il decreto del 18 marzo 1800 prevede, alla base della piramide giudiziaria, il
giudice di pace, figura “vicina al popolo”, con funzioni sia giudicanti vere e
proprie che di arbitrato tra la parti. In materia civile, é competente in unica
istanza per le cause fino a 50 franchi di valore, con appello fino a 100 franchi.
In materia penale, é competente per i reati di più lieve entità. In seconda
istanza, é poi creato un tribunale (collegiale) di “arrondissement” (distretto,
circoscrizione del dipartimento), formato da un minimo di tre giudici secondo
l’importanza e la popolazione del distretto: ha competenza in civile per cause
fino a mille franchi, e oltre tale soglia solo in prima istanza, in penale invece
per reati comportanti pene correzionali e in ogni caso non superiori ai due
anni di reclusione. Infine, sono creati dei tribunali d’appello (chiamati “corti
d’appello” dal 1804, “corti imperiali” dal 1810) costituiti da una o più sezioni
e a competenza unicamente civile, in ragione di uno per ogni tre dipartimenti
e giudicanti in appello le sentenze emesse dai tribunali civili d’arrondissement.
In penale, si ha la creazione di tribunali criminali giudicanti anch’essi in
appello dalle sentenze penali dei tribunali di distretto, o, in istanza unica, sulle
pene più gravi (le c.d. “pene infamanti”) previste dalla legge penale (il Code
pénal del 1791, cui succederà il Code pénal napoleonico del 1810). Si tenga
inoltre presente :
a) che presso ogni tribunale di distretto e tribunale criminale funzionava
una giuria, analoga alle attuali giurie popolari. Tale giuria era presieduta
da un “direttore della giuria” che era normalmente uno dei magistrati
che componevano il relativo organo giudicante;
b) che presso ogni tribunale (salvo che presso i giudici di pace) era
presente, come rappresentante del pubblico interesse, un pubblico
ministero, chiamato “commissario del governo”. A partire dal periodo
imperiale (dopo il 1804), esso prenderà il nome di procuratore imperiale
(procuratore generale per i tribunali/le corti d’appello);
c) che, nonostante tutto, si ricorrerà spesso, in periodo napoleonico
(specialmente a Napoli), all’istituzione di tribunali “speciali” e militari
deroganti alla competenza dei normali tribunali criminali e volti a
reprimere reati quali il brigantaggio, la renitenza alla leva ecc.
Vertice assoluto della piramide era l’importantissima Cour de cassation sedente a
Parigi, creata nel 1790 e giudice, come si é detto, di mera legittimità.
E’ utile tenere presente questo rapido schema, poiché esso attraverserà la
penisola durante tutto il periodo napoleonico, resterà durante la
Restaurazione e costituirà un precedente importante del decreto 6 dicembre
1865 sull’organizzazione giudiziaria del Regno d’Italia.
Infatti, l’organizzazione giudiziaria dell’Italia unita – che ormai suona
familiare alle nostre orecchie di contemporanei con la sua articolazione in
giudici conciliatori, pretori monocratici, tribunali di circondario, corti
d’appello e d’assise e corti di cassazione (la cassazione unica verrà creata solo
nel 1923) recava ancora i segni evidenti della razionalizzazione napoleonica.
3. Uno sguardo ravvicinato al Code Napoléon (o Code Civil) : genesi e
successo
Promulgato il 21 marzo 1804, il Code Napoléon (all’epoca chiamato “Code
Civil des Français”) è senza dubbio un traguardo storico non solo per la
storia del diritto francese, ma europea in senso lato. Esso chiude per sempre
l’era – più che millenaria – del cosiddetto “diritto comune” (quella
fondamentale fonte di diritto, costituita dal complesso del diritto giustinianeo
a cui si era aggiunta e sedimentata, col passare dei secoli, la massa delle opinio
iuris, delle sentenze delle supreme giurisdizioni, degli editti imperiali ecc.) e
costituisce il punto di partenza ( o perlomeno uno dei punti di partenza) del
diritto contemporaneo.
In Francia, più d’un giurista d’antico regime aveva auspicato l’unificazione di
un diritto privato già diviso territorialmente tra “pays des coutumes” (nord
della Francia, ove era in vigore un diritto consuetudinario, originariamente
non scritto, di origine germanica, pur se costantemente influenzato dal diritto
comune) e “pays de droit écrit” (sud della Francia a partire grosso modo dalla
Loira, ove il diritto comune scritto era fonte di diritto a pieno titolo, pur se
accanto alle consuetudini locali). In fondo, le grandi opere di giuristi come
Domat e Pothier miravano ad una tale unificazione nel nome della “raison
écrite” romana, sebbene rimangano circoscritte al piano dottrinale, e non a
quello “de iure condito”. Nonostante una Francia dell’89 ancora localistica e
legata alla tradizione non formulasse quasi nessun auspicio agli Stati generali
per un’unificazione del diritto civile (mentre nel penale si auspicava
abolizione della tortura, la trasparenza delle procedure etc.), l’Assemblea
Costituente scaturita dalla Rivoluzione dell’Ottantanove decreterà invece che
“sarà fatto un Codice di leggi civili comune a tutto il Regno”.
Per realizzare una tale ambizione, uno dei più noti giuristi francesi, il
Cambacérès, aveva presentato tre progetti – rispettivamente nel 1793, 1794 e
1796 – naufragati però di fronte all’incalzare degli eventi rivoluzionari e
all’instaurazione del Terrore robespierriano.
Nel nuovo clima di “legge ed ordine” instaurato dal Consolato, Bonaparte
Primo Console, può ‘riprendere l’opera codificatoria. E soprattutto, quel che
più conta, egli può disporre dell’appoggio di gran parte dei giuristi, desiderosi
di collaborare con il nuovo regime.
Si tratta di nomi spesso famosi, come Tronchet, Target, Cambacérès e altri,
caduti in disgrazia a rischio della vita durante il Terrore (1792-1794), e che
credono nella necessità di un ristabilimento dell’ordine (nel linguaggio
odierno, seppure approssimativamente, potremmo parlare di desiderio di
“svolta moderata”) e della concordia nazionali. Bonaparte appare ai loro
occhi come l’incarnazione di questo auspicio politico. Tale singolare contesto
psicologico, che ha reso così gradita agli occhi della classe dei giuristi la figura
del Bonaparte, è stata oggetto di recenti ricerche, tra l’altro ad opera di JeanLouis Halperin in Francia (il quale, nel suo volume “L’impossibile Codice
Civile” ben ha messo in evidenza come Napoleone abbia “sbloccato” una
situazione giuridico-politica che in precedenza non si prestava certo alla
redazione di un nuovo codice civile in tempi rapidi, nonostante l’unificazione
del diritto in Francia fosse un’aspirazione di vecchia data dei pratici del
diritto, pur “affezionati” alle loro consuetudini locali) e di Adriano Cavanna
in Italia.
Bonaparte può quindi riprendere l’iniziativa : un nuovo progetto di codice è
affidato, nell’anno 1800, alle cure di una commissione governativa
comprendente quattro grandi nomi del diritto francese : Tronchet (lo
sfortunato difensore ufficiale di Luigi XVI nel processo intentatogli dalla
Convenzione nel 1792, e che si concluderà, per un solo voto di maggioranza,
con la sua condanna a morte), Portalis, Bigot de Préameneu e Maleville. Il
loro lavoro durerà cinque mesi.
Successivamente, il progetto di Codice è trasmesso ai tribunali e rivisto dal
Consiglio di Stato nel corso di una serie di un centinaio di sedute (a buona
parte delle quali lo stesso Bonaparte interverrà attivamente), per poi essere
sottoposto per parere e voto finale ad altri importanti organi costituzionali
quali il Tribunato ed il Corpo Legislativo. L’opposizione di parte dei Tribuni
e del Legislatori (gli odierni deputati) sarà superata dal Bonaparte grazie ad
epurazioni e al voto finale da parte di assemblee completamente sottomesse
alla sua volontà (1802-1803). Anche per questo motivo, il Code può ben
meritare l’appellativo di Code Napoléon che gli fu dato qualche anno dopo!
Il Code, come accennato sopra, unisce desiderio di codificazione unitaria e
culto della legge. Sarà figlio della Rivoluzione nelle sue norme di libertà
giuridica ed eguaglianza (“ogni francese godrà dei diritti civili”, proclama
l’articolo 8 confermando così l’abolizione di ogni privilegio di casta o classe e
tirando un tratto di penna rivoluzionario su tutto l’Antico Regime), laicità (il
matrimonio esclusivamente civile ed il divorzio sono introdotti) e trionfo
della proprietà, ma si coniugherà nondimeno con un quadro politico
napoleonico di autoritarismo (riflettuto, curiosamente, nel microcosmo
familiare costruito nel Code : le disposizioni sulla famiglia sono infatti
improntate nettamente alla rigida supremazia maritale).
In Francia, per ottanta anni, il Code non sarà oggetto di alcuna modifica di
rilievo. La prima in ordine di tempo sarà la reintroduzione del divorzio,
abolito durante la Restaurazione e ripristinato appunto nel 1884 (peraltro in
forma ristretta, essendo la sua esperibilità limitata a casi – es. adulterio –
tassativamente prescritti) . Ma occorrerà attendere il secondo dopoguerra per
assistere ad un’importante opera di novellazione su un testo ancora vigoroso
pur nel suo progressivo invecchiamento. Attualmente, si calcola che circa la
metà delle sue originarie 2281 disposizioni siano ancora in vigore nella forma
primigenia.
Al di fuori della Francia, il Code ha avuto, per buona parte del XIX secolo,
grande successo, sia come testo adottato in molti paesi a seguito
dell’occupazione o influenza francese su buona parte dell’Europa tra il 1800
e il 1814 e sopravvissuto alla bufera napoleonica (conclusasi definitivamente
nel 1815), sia come modello ispiratorio di ulteriori codificazioni civilistiche.
Nel primo caso, occorre ricordare la sua sopravvivenza nei territori della
Renania fino al 1900 (anno dell’entrata in vigore del BGB tedesco), nel
Cantone di Ginevra sino al 1912, in Polonia e in Romania sino al 1945. Nel
Belgio e nel Lussemburgo, poi, entrato in vigore con l’occupazione
napoleonica, esso vi è tuttora in vigore (e incarna una sorta di -- parziale “unità del diritto” dei paesi francofoni d’Europa).
In Italia, fu mantenuto in vigore nel Principato di Lucca sino al 1865, a
Napoli sino al 1819 e a Genova sino al 1837.
Ma ben più importante fu il suo fungere da modello per codificazioni
successive. E qui, l’esempio italiano è quanto mai significativo : il primo
codice civile dell’Italia unificata, il Codice Pisanelli del 1865 (così chiamato dal
nome del Guardasigilli dell’epoca) si pone, per la sua struttura e parte delle
sue disposizioni, nel solco del Code.
4. La struttura del Code Napoléon
Tecnicamente, il Code si presenta diviso in tre libri (seguendo così da vicino
l’antica ripartizione in personae, res e actiones cara al diritto romano) : il primo è
dedicato alle persone, il secondo alla proprietà, il terzo ai modi di
trasmissione o modifica della stessa. In realtà, il terzo libro é comprensivo di
norme sulle obbligazioni, i contratti, le successioni ecc. tutte però viste e
accorpate sotto l’angolo visuale della proprietà come manifestazione concreta
e fisica della nuova “libertà” acquisita dal cittadino e sanzionata nelle
Costituzioni dell’epoca rivoluzionaria e post-rivoluzionaria, in America e in
Francia.
Il primo libro del Code crea un diritto delle persone improntato all’eguaglianza
e alla libertà individuale : il cittadino è ora libero di possedere, di disporre e
godere dei suoi beni senza più vincoli o limiti derivanti dalla sua appartenenza
a ceti, caste o classi, e senza più discriminazioni. Ogni privilegio in tal senso è
abolito. Un’impostazione certo rivoluzionaria, perché, opponendosi al
“passato prossimo” di un Antico Regime popolato da privilegi e vincoli
individuali, feudali e territoriali di ogni sorta, crea una società di “eguali”, o
meglio di cittadini “liberi nell’eguaglianza”, le cui differenze sono ora date
unicamente dalle singole possibilità economiche. E’ per questo che si è spesso
parlato e si parla tuttora di un Codice “borghese”, intendendo con tale
espressione una codificazione indubbiamente funzionale alle aspirazioni di
una borghesia fondiaria e commerciale (non ancora però industriale, agli
albori del XIX secolo in una Francia ancora agricola al 90%) in ascesa, ora
libera di comprare e intraprendere, in gran parte acquirente dei “beni
nazionali” e desiderosa di consolidare il proprio ruolo sociale.
Ma attenzione : tale espressione di Codice “borghese”, ahimè usata e abusata,
non deve risolversi in una generica banalizzazione, poiché in prospettiva
storica non è da perdere di vista il grande e rivoluzionario progresso di libertà
del codice rispetto alle angustie feudali degli anni precedenti al 1789 (sempre
che si voglia adottare tale data come spartiacque tra un “prima” e un “dopo”).
Alla libertà “esterna” nella società corrispondeva comunque, nel Code, una
“autorità interna” che era quella dell’uomo nel microcosmo familiare.
Napoleone fu spinto a tale “maschilismo” familiare per sue presunte
convinzioni antifemministe? Gli storici hanno azzardato anche tale ipotesi,
tra le altre.
Comunque stiano le cose, é certo che la famiglia disegnata dal Code si presenta
estremamente squilibrata a favore dell’uomo. L’uomo, come sposo e padre,
era capofamiglia unico e unico titolare della patria potestà; alla donna –
secondo il tradizionale concetto giuridico dell’inferiorità femminile - era
imposto un dovere di obbedienza e di seguire il marito ovunque egli
intendesse stabilirsi, ed eventuali trasgressioni agli obblighi di fedeltà
(adulterio) erano sanzionati più severamente per la donna che per l’uomo.
Inoltre, fatto di non poco rilievo, la donna abbisognava dell’autorizzazione
maritale per ogni atto di natura patrimoniale (eccetto il testamento) ed era
esclusa da ogni autorità sui figli, mentre l’uomo deteneva nei loro riguardi
ampi poteri disciplinari ed era peraltro usufruttuario dei loro beni.
A tale riguardo, occorre però, con senso della storia, notare due elementi :
a) tali disposizioni, oggi ovviamente totalmente anacronistiche e in stridente
contrasto col comune sentire sociale, sono state abolite nel corso dei decenni
da una costante modifica per novellazione (norme di produzione legislativa
che si inseriscono nel Codice modificandolo settorialmente) che ha finito per
creare progressivamente la parità tra i coniugi. E non molto tempo fa: si pensi
ad esempio che l’autorizzazione maritale è stata abolita in Francia,
parzialmente, solo nel 1938 e, definitivamente, nel 1967 (in Italia
l’autorizzazione fu abolita ipso iure nel 1919).
b) nonostante questo, persino la materia familiare presentava notevoli
progressi e innovazioni rispetto all’antico regime : pensiamo all’introduzione
dell’istituto del divorzio (esperibile anche da parte femminile), pur se con una
portata limitata nell’originaria versione del Code, o al fatto che i doveri di
assistenza e fedeltà familiare avevano pur sempre una valenza reciproca
(imponendo così doveri anche all’uomo), o alla possibilità per la donna di
ricorrere al giudice in caso di ingiustificato rifiuto dell’autorizzazione maritale.
Infine, i poteri sui figli non erano vitalizi ma avevano fine con la maggiore
età: né il Code prevedeva più nei riguardi dei figli, come talune codificazioni
europee di antico regime, una crudele casistica di pene corporali (la
“Züchtigung” di prussiana memoria, lett. “castigo” inflitto dal padre).
In tema di proprietà, il Code innova ovviamente in profondità. Nella sua
ispirazione liberale, il Code considera la proprietà come un diritto individuale
per antonomasia, e non più come un diritto spettante, collettivamente, a
gruppi o famiglie. Essa è, secondo l’articolo 544, “il diritto di godere e
disporre delle cose nel modo più assoluto, purché se ne faccia un uso lecito
secondo le leggi o i regolamenti”. Una definizione che non potrebbe essere
più chiara e intelligibile! Ne consegue che il proprietario può escludere il
diritto altrui, e proteggere il bene contro possibili intrusioni : l’espropriazione
ha carattere eccezionale.
Nel 1804,anno di nascita del Code, il padre di famiglia, che abbiamo visto
protagonista del Libro I, è un buon padre di famiglia se è proprietario e se
lascia in eredità dei beni ai figli. Il Code è, in fondo, dedicato a lui : a questo
padre di famiglia/proprietario, saggio, buon padre e buon cittadino, marito e
padre, attento ad aumentare il capitale che possiede per poterlo, un giorno,
trasmettere ai propri discendenti.
Ma gli artefici del Code hanno esplicitamente voluto richiamarsi ad una
falsariga di proprietà individuale già tracciata dal diritto romano. Il diritto
romano aveva infatti conosciuto e regolamentato una proprietà unitariamente
concepita e intesa come dominium (l’odierno diritto di godere, e di disporre, di
un bene), che poi il diritto feudale, per sue esigenze di organizzazione della
società, aveva scisso nel dominium eminens del titolare del diritto e nel dominium
utile di chi concretamente lo utilizza.
Orbene, il Code (pur non ignorando forme di “scissione” della proprietà, quali
l’usufrutto) vuole rompere col diritto feudale e ritornare ad una concezione
unitaria del dominium, che non però poteva non essere quanto di più
funzionale si potesse porre in essere in omaggio al principio – sancito dal già
citato articolo 544 - della illimitata facoltà di disporre di un bene. E alla
lettura di tale norma, è inevitabile il pensiero di quanto essa abbia influenzato
le codificazioni successive (ivi compresa, in fin dei conti, quella vigente
attualmente in Italia)!
La disciplina del possesso, poi, qualificato dall’articolo 2228 del Code, in senso
estremamente liberale, come “la detenzione di un bene che è in nostro possesso o il
godimento di un diritto esercitato da noi stessi o per mezzo di un altro che detiene la cosa o
esercita tale diritto in nostro nome”, forse più di ogni altra norma di codificazioni
moderne o contemporanee permetterà e avvallerà il crearsi e consolidarsi
della nuova classe dei proprietari.
Gli sconvolgimenti patrimoniali verificatisi in Francia e in Europa a seguito
degli eventi rivoluzionari con l’espropriazione e la vendita dei “beni
nazionali” (proprietà ecclesiastiche ecc. fino ad allora inalienabili) trovavano
ora, infatti, una base giuridica che consentiva una legittimazione all’acquisto
di tali beni. E una legittimazione alla loro libera circolazione : per i nuovi
proprietari, infatti, il possesso varrà titolo, dato che l’articolo 2279 permetterà
il trasferimento di proprietà di un bene mobile mediante la semplice
consegna, anche nel caso il cui l’alienante non ne sia proprietario!!
Il regime successorio, infine, visto non in sé (come nel codice attualmente
vigente, che gli dedica un intero libro), ma come pura “tecnica” di
trasmissione della proprietà , veniva anch’esso grandemente semplificato : era
abolita, ad esempio, l’accettazione di eredità, e gli eredi potevano direttamente
entrare in possesso dei beni (a tal proposito si innovava rispetto al passato,
poiché veniva creata eguaglianza tra eredi di sesso maschile e femminile).
Non solo, ma con la disposizione dell’articolo 732 (“la legge non considera, ai fini
della successione, né la natura né l’origine dei beni”) tutti i beni venivano dichiarati
libero oggetto di successione.
5. L’applicazione e le resistenze al Code Napoléon in Italia.
Per un certo tempo, il Code divenne legge vigente anche in Italia. Questo
accadde a seguito dell’occupazione e annessione diretta all’Impero
napoleonico, dal 1802 al 1810, di vaste parti della penisola (Piemonte, Liguria,
Parma, Toscana, Lazio), nonché a seguito della creazione di Stati italiani
satelliti della Francia (regno d’Italia, con capitale Milano, dal 1805 ; Regno di
Napoli dal 1806).
Per il regno d’Italia napoleonico, ad esempio, Bonaparte dispone la messa in
vigore del “suo” Code a partire dal 1° gennaio 1806, data che poi “slitterà” al
primo aprile dello stesso anno (Terzo Statuto costituzionale del Regno,
articolo 56). Grande attenzione è riservata all’elemento linguistico, e per
evitare problemi se ne dispone la traduzione in italiano (“Il Codice sarà in seguito
stampato e pubblicato in latino, in italiano e in francese. La sola traduzione italiana potrà
essere citata nei tribunali, ed avere forza di legge”).
La vigenza del Code durò pochi anni, poiché nel 1814 gli antichi sovrani
tornarono sui loro troni restaurati e richiamarono più o meno tutti in vigore
(ad eccezione di Lucca e Genova) le antiche leggi prenapoleoniche;
cionondimeno, tale esperimento ebbe grande importanza se non altro come
“laboratorio di prova” per la formazione di una nuova classe di giuristi,
teorici e pratici, nonché per gli echi futuri che tale testo susciterà,
allorquando, due generazioni più tardi, sarà ripreso a modello della
codificazione dell’Italia unita.
In vigore dunque su gran parte della penisola per un arco di tempo di poco
meno di un decennio, il Code sarà ben accetto, in generale, ma susciterà talora
anche resistenze.
Ben accetto innanzitutto e sostanzialmente, con le sue norme in tema di
famiglia ma anche di circolazione dei beni, ad una società “borghese”
portatrice, anche in Italia – almeno nelle sue regioni più avanzate -, di quelle
stesse esigenze di certezza giuridica e libertà economica, ma anche di ordine
gerarchico, domestico e sociale, già viste in precedenza in Francia.
Ma ben accetto anche ai “tecnici” : la classe dei giuristi chiamati a gestirlo si
renderà infatti ben presto conto degli enormi vantaggi in termini di
semplificazione del diritto applicabile, rispetto alla molteplicità di fonti
normative del diritto comune (spesso una vera e propria giungla : chi non
ricorda l’Azzeccagarbugli, riuscita caricatura manzoniana di tale caos
giuridico?). E alla facile critica del carattere “straniero” del Code, essi
replicheranno in gran parte che, certo, esso proviene innegabilmente
d’Oltr’alpe, ma che sostanzialmente, nei suoi istituti (es. la disciplina della
proprietà), esso riprende, razionalizza e semplifica una tradizione romanistica
nata, sviluppatasi e fiorita innanzitutto in Italia prima di partire alla conquista
dell’Europa e diventarne patrimonio comune.
Se resistenze al Code vi furono, esse riguardarono essenzialmente taluni istituti
forse più difficilmente “digeribili” dal punto di vista sociale nell’Italia –
ancora scarsamente laicizzata – dell’epoca : é il caso del divorzio, o della
comunione dei beni. Vi furono in effetti su questi punti vaste perplessità
ovunque, e, soprattutto nel regno di Napoli, proposte di ritardarne
l’applicazione o addirittura di emendarlo, stralciando il divorzio. A Bologna,
nel 1806, il Senato cittadino ebbe a protestare pubblicamente di fronte al
prefetto.
In generale, si può dire che relativamente pochi furono –secondo un ormai
celebre scritto di Croce degli inizi del secolo – i casi di divorzio nell’Italia
napoleonica.
La lingua non rappresentò minimamente un problema di comprensibilità tale
da suscitare resistenze o perlomeno perplessità poiché, salvo nelle regioni
direttamente annesse, in cui il francese era più o meno conosciuto
(Piemonte), furono rapidamente approntate traduzioni in lingua italiana
facenti fede in ogni circostanza. E nel 1810 Napoleone, forse memore delle
sue origini corse, dispone, che nella Toscana da poco annessa all’impero
francese, le disposizioni del Code faranno fede in italiano.
In definitiva, se resistenze da parte dei giuristi vi furono, esse poterono
provenire non già dai teorici, ma dai pratici del diritto: resistenze
“semiclandestine”, ed esempio, di magistrati formatisi alla scuola del diritto
comune, e quindi abituati da sempre ad utilizzarlo : essi, presumibilmente,
potrebbero aver continuato, per mentalità o abitudine inveterata, a usare,
nelle loro sentenze, lo ius commune come fonte sussidiaria del Code. Tale
ipotesi, ampiamente dimostrata e fondata per certe aree della Germania
(Renania) non é pero ancora dimostrata per l’Italia e attende di essere
suffragata da future ricerche sull’immenso materiale giudiziario dell’epoca.
6. L’applicazione e l’eco del Code in Europa
Analogamente, e come accennato sopra, il Code Napoléon ebbe una vasta eco
in ambito europeo : fu applicato direttamente (o “in fotocopia” tradotta,
come nel Baden nel 1806) in territori annessi o satelliti dell’impero francese
nel decennio 1804-1814 (es. Belgio, Olanda, Renania, Svizzera, Polonia, Italia
come già visto), ed é servito in seguito, più in generale, come punto di
riferimento di una prima riuscita codificazione. La sua fortuna declinò poi
con l’emergere, alla fine del XIX secolo, di altri codici di grande rilievo :
primo fra tutti, il BGB tedesco.
Un’analisi storica compiuta di quello che rappresentò il Code Napoléon in
Europa non può però prescindere - soprattutto nel momento attuale in cui ci
si accinge a celebrarne il bicentenario dell’esistenza in Francia, Belgio,
Lussemburgo e in molti altri paesi europei ed extraeuropei, come quelli
d’America Latina – dalla considerazione di base che, se da un lato esso fu
funzionale alla nuova libertà economica legata all’ascesa della borghesia
commerciale, dall’altro si scontrò, anche in Europa e non solamente quindi
in Italia, con le resistenze dei “pratici” : spesso giudici che malvolentieri
rinunciavano dall’oggi al domani ad applicare lo ius comune (essenzialmente, il
corpus del diritto giustinianeo) e che quindi hanno continuato, nella loro
attività quotidiana, ad integrare (contra legem, s’intende) il Code con tale fonte di
diritto.
Un esempio è stato oggetto di ricerche esaustive : la giurisprudenza della
Corte d’Appello di Treviri, competente in materia civile per tutti i territori
renani annessi alla Francia napoleonica. Vi sono frequentissime sentenze, già
in piena vigenza del Code, la cui base legale è costituita non solo da articoli di
tale testo, ma anche (come in piena età del diritto comune) dalle disposizioni
del Codex giustinianeo, o dalla menzione di principi tratti dal diritto romano
quale “ragione scritta” che s’impone sempre e comunque al legislatore.
7. Gli sviluppi dottrinali in Francia. La scuola dell’esegesi
Il Codice napoleonico è stato esaltato come un capolavoro giuridico e
linguistico. Stendhal ne raccomandava la lettura a Balzac proprio da questo
punto di vista. In realtà c’è molto di vero in questo ‘mito’ codicistico.
Esso ha infatti avuto un successo enorme, venendo presto imitato anche in
America latina e poi nei Paesi socialisti, oltreché in Europa continentale, dove
viene portato subito dalle armate napoleoniche.
Perché? Esso si presenta come ‘legge di ragione’, approvata dalla ‘volontà
generale’ del popolo più che dai giuristi (anche se fu preparato da giuristi), di
cui la Rivoluzione diffidava considerandoli controrivoluzionari. Le Facoltà di
giurisprudenza vennero persino chiuse per un certo tempo e si auspicarono
sistemi di giustizia privi di tecnici del diritto! Il codice doveva fornire un
argine ai poteri dei giudici, che dovevano divenire bouche de la loi (bocca della
legge), ma anche le leggi dovevano intanto operare in questo senso.
Il Code è il frutto di un’opera di semplificazione di quattro diversi progetti,
alcuni giudicati troppo casistici, altri troppo astratti. Esso risulta dunque un
punto di equilibrio tra questi due estremi, ed è rimasto come modello di
redazione delle norme giuridiche ancora oggi seguito nella tradizione giuridica
continentale, detta di “civil law”. La ‘regola’ codicistica non deve essere
troppo generale, perché se così fosse non fornirebbe nessuna guida, ma
neppure troppo casistica dovendo applicarsi a una categoria intera di
situazioni. Il codice non può risolvere tutte le questioni che si presenteranno,
ma deve accogliere un insieme di regole che nel loro complesso, viste
complessivamente - in sistema - lo consentano. Esso deve essere senza lacune
e contraddizioni, per evitare di creare quell’incertezza del diritto che darebbe
di nuovo spazio ai giudici.
In realtà il codice non è privo di ambiguità e lacune, come osservarono presto
anche i pandettisti. Il diritto di proprietà - si dice ad esempio - è al centro del
codice, che lo definisce come ‘diritto assoluto’, ma poi si aggiunge che
regolamenti e atti amministrativi per necessità pubbliche possono consentirne
l’esproprio o modificare l’uso del bene, e quindi lo possono annullare.
Nell’art. 1108 per il contratto, che si dice libero e autonomo, si prescrive una
‘causa lecita’ che all’art. 1133 si precisa esserci quando il contratto non è
contro i buoni costumi o l’ordine pubblico: ma come vanno intesi i due
concetti che sono causa di invalidità del contratto? Rimane incerta, in
sostanza, la validità di qualsiasi accordo.
La responsabilità civile viene basata sulla colpa, ma che cosa è la faute
(pronuncia fot, colpa) codicistica? Non sarà da riempire di contenuti in base a
certi criteri che non sono indicati?
Il mito del codice autosufficiente, completo, non regge alla critica storica
odierna, eppure venne già alimentato dai giuristi che lo applicarono per primi
- quelli che furono poi detti giuristi della École de l’exégèse, ossia della Scuola
dell’esegesi, che tanta importanza ha avuto in Italia fino alla seconda metà
dell’Ottocento. Essi infatti temerono di essere tacciati di manipolare il diritto
sotto veste di equità come avevano fatto i giudici dei Parlements e i ‘dottori’
secondo le accuse degli illuministi, ma in realtà per fini clientelari e politici.
Perciò accettarono in toto la teoria ‘positivistica’ delle fonti proposta dalla
Rivoluzione, ossia
1) del primato assoluto della legge e
2) della riduzione ad essa del diritto.
Essi si presentarono infatti come semplici ‘esegeti’, burocrati del codice,
facendo continue affermazioni di rispetto per la lettera della legge e della
volontà del legislatore. Non vollero pertanto assumersi (almeno
esteriormente) responsabilità politiche, come avevano fatto invece i giuristi di
diritto comune con la loro interpretatio (estensiva o restrittiva), ma si
presentarono come meri esecutori della legge, accettando l’assunto che tutto il
diritto fosse nella legge. È appunto un carattere precipuo della Scuola
dell’Esegesi, ossia il mos (= lo stile) francese ottocentesco di interpretare il
codice, in opposizione netta alla Scuola storica tedesca.
In realtà le cose andarono ben diversamente, perché i giuristi anche francesi
(giudici compresi) in pratica usarono tutte le tecniche interpretative elaborate
nel corso dei secoli a partire dalla ‘rinascita’ bolognese. Gli esegeti perciò non
furono affatto succubi della norma codicistica. Per cui:
1) salvo novità di grande rilievo politico (come il divorzio) c’è una certa (e per
certi aspetti notevole) continuità di contenuti, ossia di disciplina concreta, tra ius
commune e diritto codificato. Il Codice napoleonico infatti fonde la tradizione
romanistica, per la proprietà e le obbligazioni in particolare, con quella di
diritto consuetudinario (famiglia e successioni), mettendo a livello legislativo
quello che a livello dottrinale aveva ‘combinato’ il Pothier, che aveva
armonizzato le varie fonti del diritto francese tradizionale. Ma c’è anche
2) qualcosa di più profondo che bene colgono gli studiosi stranieri, in
particolare gli anglo-americani, guardando al problema del rapporto diritto
comune-diritto codificato: ossia che il sistema introdotto dal Code Napoléon
voleva fare completamente a meno del diritto comune, l’esecrato diritto
dell’Ancien régime, ma in realtà continuò per certi aspetti quel sistema. Certo, non
c’è più da riferirsi ora, nelle sentenze, alle leggi del Corpus iuris quanto invece
agli articoli del Code, ma si continuò il sistema nel senso che vi continuò ad
avere una larga parte l’interpretazione dei giuristi.
Questo è in fondo il grande contrassegno dei sistemi di civil law, cioè quelli di
origine romanistica dell’Europa continentale: il ruolo importantissimo che vi
ha sempre svolto (in misura più o meno ampia in base alle circostanze) il
giurista, ossia la dottrina, a differenza di quanto avviene nei sistemi di common
law, a sviluppo giurisprudenziale in senso giudiziario, ossia guidato dai
‘giudici’, più che dal legislatore e dal ‘dottore’. La discontinuità quindi tra ius
commune e Code è da un lato nei modi della formulazione delle norme, ora
raccolte in un unico testo e formulate in modo generale ed astratto, e
dall’altro nel ruolo della legge, che vi appare come fonte assoluta di
produzione normativa, e perciò non ‘eterointegrabile’.
Il codice quindi richiama e si fonda su quello stesso sistema che era stato
costruito dai giuristi sulla base del Corpus iuris. Quanto alla responsabilità
civile, ad esempio, all’art. 1382 dichiara che “il danno obbliga chi lo ha
commesso per sua colpa a ripararlo”. Una formula tanto ampia favorì in
pochi anni, di fatto, l’affermazione della regola opposta, che cioè di regola
invece non si risarcisce il danno. Questa interpretazione venne giustificata
con il fatto che se l’art. 1382 si trovava nel capitolo dedicato ai ‘delitti e quasi
delitti’, ai fini del risarcimento si doveva innanzitutto avere un atto illecito.
Ogni volta quindi bisognava rintracciare una norma proibitiva di un dato
comportamento! Solo in un secondo tempo si ampliarono progressivamente
le ipotesi di responsabilità civile, ma come si vede sempre (e inevitabilmente!)
per via interpretativa.
Insomma, i giuristi francesi furono dei tecnocrati molto abili, la cui opera
trasformò profondamente il codice, ma essi accreditarono comunque il mito
che il codice fosse organico e completo come richiesto dall’opportunità
politica e dalla cultura del tempo! Essi operarono abilmente tra principi
generali e regole di decisione, ad un livello diverso da quello del legislatore,
usando entrambi i livelli e con sinergie tra dottrina e giurisprudenza. Il che fu
possibile perché gli stessi autori del codice erano dei pratici, profondi
conoscitori della giurisprudenza (dei dottori e dei tribunali). Ad esempio,
consigliere di Napoleone fu il Merlin, poi Procuratore generale presso la
Cassazione fino alla Restaurazione, che non lo perdonò di aver votato la
condanna a morte di Luigi XVI nel 1793.
Dal Merlin prende avvio comunque un dialogo tra dottrina e giurisprudenza, che
operò in modo molto libero, ma senza darlo a vedere, con prudenza. Il che fu
possibile perché i tribunali, in particolare la Cassazione, da subito seguendo
un po’ la prassi dei Parlements soppressi dalla Rivoluzione, motivò con
un’unica frase, il tipico attendu que (‘atteso che’, detto stile del jugement à phrase
unique, ‘giudizio a frase unica’), che fa mostra di applicare il sillogismo
giuridico, ma in realtà consente di operare molto liberamente.
La motivazione di questo tipo è un ottimo modo per tenere lontano occhi
indiscreti, ma impedisce che si formi una giurisprudenza consolidata, anche
perché tace sui fatti, per cui non si può ricostruire il distinguishing, l’arte di
distinguere, ossia come si sono differenziate le fattispecie. Essa dà solo la
decisione nel caso concreto.
La dottrina in sostanza provvede a sistematizzare gli indirizzi della
giurisprudenza. Non per niente la migliore opera, ancora oggi utilizzabile,
dell’École de l’Exégèse, è quella di due giuristi dell’Università di Strasburgo,
Aubry e Rau (pron. ‘obrì’ e ‘ro’), nata dall’opera in tedesco di Zachariae von
Lingenthal (‘Zacarie fon linghental’), professore a Heidelberg. Questi aveva
scritto un manuale di diritto francese, dato che il codice continuò ad
applicarsi in alcuni territori della Germania pur dopo la Restaurazione;
l’opera, fortemente sistematica, alla tedesca, fu dai due francesi tradotta e
ampliata al punto di renderla un’opera nuova, autonoma: ebbene, essa è stata
ancora riedita nel 1933 e a suo tempo, nel corso dell’800, tradotta in italiano!
Tuttavia, mentre la sistematica della Pandettistica tedesca fu rigorosa, perché
faceva discendere le applicazioni dai principi primi, quella della scuola
francese dovette sempre fronteggiare la giurisprudenza dei tribunali, per cui
faceva delle regole e poi ammetteva come eccezioni gli indirizzi
giurisprudenziali dissenzienti.
Ad esempio, Aubry e Rau alla III edizione cessarono di sostenere una certa
tesi in tema di azioni possessorie perché - ammisero - la giurisprudenza era in
senso contrario. Altre volte furono più duri e criticarono aspramente la
giurisprudenza. Nel complesso, comunque, la dottrina fu molto vivace e
anche polemica al proprio interno: ciò che importava era convincere i giudici
a dare certe interpretazioni.
Si ebbe così una vera e propria fioritura della letteratura giuridica. Si contano
ben 17 trattati di diritto civile della Scuola, di cui uno, quello del Laurent
(pron. ‘loràn’), in ben 33 volumi! Il codice portò insomma a complesse
interazioni tra dottrina, legge e giurisprudenza. Particolare importanza poi
rivestì la Corte di Cassazione, che si discostò raramente dai propri precedenti,
pur non essendo obbligata a seguirli (come anche in Italia), e che nel giro di
pochi decenni dominò le Corti d’Appello che si ostinavano a interpretare in
modo libero, sentendosi soggette solo alla legge!
8. L’Austria e il Codice civile del 1811 (ABGB).
Ben diverso fu il contesto nel quale si sviluppò e vide la luce il codice civile
austriaco del 1811. Esso é il portato e la conseguenza dell’opera riformatrice
instancabile di Maria Teresa prima (1740-1780) e del figlio Giuseppe II poi
(1780-1792), opera volta a razionalizzare e semplificare il diritto dei paesi
facenti parte della Casa d’Austria (tra cui é da annoverare ovviamente anche,
dal 1714, la Lombardia). Una prima tappa é raggiunta nel 1776 grazie al
cosiddetto Codex Teresianus ; però, a partire dal 1780, Giuseppe II si convince
che la codificazione – in cui (come nelle compilazioni tipiche del ‘700 quali
Modena, 1723, o il Piemonte, 1770-71) ampio spazio trovavano ancora il
riconoscimento dei diritti locali e il diritto comune - necessita di una fase
ulteriore di modernizzazione.
Il suo obbiettivo, del quale la codificazione rappresenta una parte, seppure
importante, é infatti più vasto : la riduzione o eliminazione dei privilegi
nobiliari ed ecclesiastici e il consolidamento del potere centrale.
In effetti, negli anni ’80 del ‘700, l’instancabile sovrano emana una serie di
provvedimenti che anticipano, in un quadro di riforme pacifico e ordinato, le
turbolente e spesso convulse conquiste della Rivoluzione francese di quasi un
decennio successive : nel 1781, un editto di tolleranza pone le basi della
separazione tra Stato e chiese e dell’eguaglianza dei sudditi/credenti di fronte
alla legge, nel 1783 é “creato” il matrimonio civile, nel 1785 sono ridotti i
privilegi nobiliari in materia successoria ed é varato un editto sulla libertà di
commercio (1786) e infine, in quel 1789 rivoluzionario in cui nella turbolenta
Francia i contadini indigenti per la carestia daranno l’assalto alle dimore
feudali, é adottata invece in Austria una legge sui riscatti delle terre feudali che
consente ai contadini l’affrancamento e la loro trasformazione in affittuari
ereditari.
Nel 1787 fu poi emanato il primo libro di un Codice che conteneva la
disciplina delle persone e della famiglia e a cui avrebbe dovuto seguirne un
secondo dedicato alla proprietà, ma che rimarrà incompleto. La morte di
Giuseppe II e le vicende legate alle guerre contro la Francia rivoluzionaria e
napoleonica bloccheranno per diversi anni il completamento dell’opera
civilistica, che vedrà la luce solo nel 1811 per entrare poi ufficialmente in
vigore, nei vasti, eterogenei e multilingui domini della Casa d’Austria, il 1°
gennaio 1812 col nome di “Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch”
(letteralmente “codice civile generale”).
Il codice civile austriaco costituisce, nel campo del diritto, una vera e propria
alternativa ideale rispetto al Code Napoléon.
Innanzitutto, esso é grandemente legato all’influsso che il diritto naturale –
nella sua grande tradizione del XVII-XVIII secolo in Inghilterra e nei paesi
germanofoni, tradizione legata a Locke, Thomasius, Pufendorf e Wolf - ebbe
sui giuristi che ne curarono la redazione, primi fra tutti lo Horten e il Martini.
Contrariamente alla concezione – giuridica e codicistica - francese, ancor oggi
fortemente statualistica, secondo cui il legislatore crea ed istituisce diritti
individuali prima inesistenti, l’idea alla base dell’ABGB é che un corpo di
leggi (statali) non é se non il migliore strumento per dare attuazione a diritti
soggettivi già preesistenti ma che senza una trasposizione in norma positiva
non avrebbero certezza giuridica.
Inoltre, pur inaugurando anch’esso la serie dei codici “moderni” che
escludevano – come il Code Napoléon - ogni possibilità di integrazione esterna
da parte del diritto comune, l’ABGB consente (una sua disposizione lo
prevede esplicitamente) un accoglimento di “principi tratti dal diritto
naturale” in caso di lacuna.
Nella struttura, poi, pur seguendo la tradizionale suddivisione in una (breve)
parte generale, una prima parte sul diritto delle persone, una seconda parte sul
diritto delle cose, e una terza parte (di circa 160 articoli) dedicata alle
“disposizioni generali”, l’ABGB é anche qui ben diverso rispetto al suo
(quasi) coetaneo omologo francese :
a) in primo luogo, é ben più breve e conciso di questo (700 articoli in
meno : 1502 contro 2281);
b) inoltre, la terza parte dell’ABGB prefigura per la prima volta, seppure
per sommi capi, quella figura del negozio giuridico che avrà poi enorme
fortuna nella dottrina giuridica continentale grazie soprattutto
all’elaborazione fattane dalla Pandettistica;
c) infine, l’ABGB lascia più largo margine di quanto ne lasci il Code al
lavoro dell’interprete. Anche per questo motivo, la dottrina giuridica
non si limiterà ad essere, in Austria (e ancor più in Germania), una
semplice “scuola dell’esegesi” all’ombra di un invadente codice
monocentrico, ma assumerà iniziative molto più autonome nell’ambito
dell’elaborazione, innovazione e riforma del diritto.
Occorre poi dire, da ultimo, che l’ABGB é stato anch’esso parte integrante
della storia del diritto italiana, in quanto fu introdotto nel Lombardo-Veneto
a partire dal 1° gennaio 1816 (Restaurazione) e vi rimase in vigore fino alla
vigilia dell’Unità d’Italia.
9. La scuola storica tedesca
Il Giusnaturalismo in Francia – nella misura in cui ebbe un seguito tra i
giuristi - fu gestito, oltreché da filosofi, da giuristi operanti a stretto contatto
con la giurisdizione nazionale, per cui ebbe riflessi molto pratici e politici. In
Germania invece fu sviluppato da professori d’Università e da governanti, in
una situazione di frammentazione politica e giurisdizionale. I giusnaturalisti
tedeschi erano lontani dalla pratica, per cui l’insegnamento loro rimase
lontano dall’usus modernus del foro e collegato piuttosto alla giurisprudenza c.d.
elegante di tipo umanistico, molto in uso tra i giuristi olandesi del Seicento.
La ‘Scuola storica’ nacque e crebbe nello spazio lasciato da questa lacuna della
dottrina. La Scuola storica, per quanto nata in contrapposizione al
giusnaturalismo, ora a distanza di tempo è vista accanto ad esso come
manifestatosi in Germania. L’una e l’altra corrente elaborarono una
dogmatica fondata sulla sistematica giuridica e sul metodo induttivo (scuola
storica) e deduttivo (filosofica): diritto soggettivo, diritto oggettivo, negozio
giuridico sono elementi di studio comuni a entrambe le scuole.
Dove si ha una divergenza è nell’apriorismo del giusnaturalismo, che la scuola
storica non condivide affatto; inoltre nel fatto che Savigny è un vero
positivista, perché parte dal diritto ‘dato’, perché ritiene che il giurista debba
occuparsi solo del diritto positivo - bandendo diritto naturale etc. Egli
sosteneva che le Università - come quella di Berlino, di nuova fondazione,
1810, sulla base del programma riformatore di von Humboldt - si dovessero
occupare di nuovo seriamente di diritto positivo per formare davvero dei
buoni giuristi (che la Germania aveva solo in misura limitatissima allora). Così
le Università forgiarono i concetti raffinati con cui affrontare i problemi
nuovi degli Stati liberali e dell’economia capitalistica.
Secondo la Scuola storica tedesca infatti (portando alle estreme conseguenze
le dottrine di Thomasius e Montesquieu) il diritto non risulta dalla natura
dell’uomo - come vogliono i giusnaturalisti - ma dalla storia di ogni popolo, o
meglio dalle sue forze latenti, indicate nell’espressione Volksgeist (‘spirito del
popolo’, pron.: ‘folksgaist’), ma non da intendersi in modo democratico,
perché la scuola fu piuttosto aristocratica, elitaria, politicamente
conservatrice, attenta alla consuetudine.
Infatti, per loro il popolo non si esprime direttamente, ma solo per il tramite
dei giuristi, che sono gli unici tecnici abilitati a capire che cosa il popolo
stesso ha prodotto. Quindi questi studiano il diritto del proprio popolo per
stabilire quale è il ‘patrimonio’ che si deve amministrare, e in sostanza spetta a
loro definire come ‘ringiovanirlo’, come renderlo attuale. Quindi il giurista
deve essere anche storico e ricostruire la letteratura giuridica della Nazione,
che permette di conoscerne il diritto.
Orbene, tale letteratura era di tipo romanistico, perché è vero che tra i
fondatori della scuola ci furono anche degli studiosi di diritto germanico
antico, ma gli studi in questo campo erano allora appena agli inizi, per cui
inizialmente non poterono influire in modo efficace. Savigny invece ebbe
subito una grande fortuna e fu considerato fondatore della scuola, anche se a
dire il vero iniziatore era stato un professore dell’Università di Gottinga,
Gustav Hugo (1764-1844). Savigny però fu subito molto noto anche per lo
stile: il suo famoso scritto contro la codificazione, ossia Della vocazione del
nostro tempo per la legislazione e la giurisprudenza, venne considerato una delle
prose più belle della letteratura tedesca.
Savigny era un romanista, per cui lavorò sulle fonti romanistiche in modo
dotto, come nella giurisprudenza elegante e umanistica, ripudiando il lavoro
farraginoso dei Commentatori italiani, che giudicava negativamente - come
già avevano fatto gli umanisti prima di lui -, perché a suo avviso avevano
corrotto il diritto romano. Egli passava direttamente dai Glossatori ai Culti
nel tentativo di meglio capire il diritto giustinianeo e la sua genesi (capire quel
diritto per applicarlo ammodernato e sistematizzato nel presente).
Inizia da qui la c.d. giurisprudenza dei concetti, che dal nome dato ai libri prodotti,
cioè i manuali di Pandette, prese anche il nome di pandettistica. Gli esponenti
più celebri, oltre a Savigny e al suo allievo Georg Friederich Puchta (m. l846),
furono Brinz, Arndts, Dernburg e soprattutto Bernhard Windscheid (m.
1892), il cui manuale di Pandette compendiò il lavoro di tutta la scuola: sette
edizioni durante la vita dell’autore!
Idea base della pandettistica è che l’ordinamento giuridico costituisca un
sistema completo, chiuso. Il che si adattava molto bene al nazionalismo
dell’Ottocento e all’idea d’uno Stato sovrano, non comunicante con gli altri
Stati che in modo formale, tramite le istituzioni legittimate a farlo. Quindi le
eventuali lacune delle leggi non erano anche lacune del sistema che aveva
sempre, nelle sue strutture logiche, i mezzi per colmarle. Il giurista non
doveva far altro che ‘trovare’ la soluzione già presente nel sistema.
Quest’ultimo ha in sé la propria validità in quanto la sua logicità è garanzia di
giustizia. In ciò si vede un chiaro influsso dell’idealismo del filosofo Hegel:
vera realtà sono i concetti e le proposizioni dommatiche. Che il dominio
(proprietà) sia ‘elastico’ è non una conseguenza di quanto dice la legge, ma un
carattere reale della proprietà!
Una critica ad essi mossa fu che, conoscendo anche il diritto romano
pregiustinianeo, i pandettisti nel loro lavoro dommatico armonizzarono fonti
diverse, costruendo un diritto romano che non ha mai avuto vigenza storica.
Essi cioè misero assieme, entro il tessuto connettivo della sistematica, un
diritto romano ‘meta-storico’, al di là della storia, fittizio. In particolare ciò
emerse nell’elaborare la parte generale (Allgemeiner Teil), ossia i concetti base
del diritto privato, in cui andarono ben oltre l’elaborazione dei giusnaturalisti
e dell’ABGB (pronuncia ‘abeghebé’), ossia il Codice civile austriaco del 1811.
Un’altra critica riguardò il loro formalismo, la loro insensibilità per i bisogni
della pratica e la pretesa di fissità del loro sistema, che portava al quietismo
legislativo (“si lascino fare i giuristi”). Critiche furono mosse ad esempio da
Rudolf von Jhering (‘fon ierin’, m.1892) e da Otto von Gierke (‘fon ghirke’,
m.1921) nonché dalla Scuola del socialismo giuridico, e sboccarono nella
giurisprudenza degli interessi. In Serio e faceto nella giurisprudenza (1884, ed. ital.
1954), Jhering immaginò che nell’aldilà ci fosse un paradiso dei concetti
giuridici in cui venivano ammessi in eterna beatitudine solo i giuristi
dogmatici; gli eletti dovevano essere abili ad usare la macchina spacca-capello.
Paradiso rimasto a lungo vuoto, ma poi con l’ingresso di Puchta, nel 1846,
esso cominciò finalmente ad essere popolato di giuristi tedeschi; lo stesso
Savigny, però, morto dopo il suo allievo, nel ‘61, rischiò di non essere
ammesso! Egli infatti aveva paventato la sistematica astratta e la separazione
di teoria e prassi, difetti propri del giusnaturalismo, ma i suoi allievi si fecero
prendere la mano dagli strumenti che il Savigny stesso aveva loro consegnato
e finirono per ricadere in difetti del genere.
Tra le opere del Savigny - oltre a Della vocazione già citato - ricordiamo: La
dottrina del metodo giuridico, corso tenuto a Marburg nel 1802-03 ove ebbe due
allievi d’eccezione, i fratelli Grimm (proprio loro: quelli delle fiabe!), che
presero degli appunti alle lezioni del Savigny poi ritrovati e editi soltanto nel
1951; Il diritto del possesso (I ed. del 1803), dove con metodo rigoroso, costituì
un modello per ricerche successive; la Storia del diritto romano nel medioevo (in 7
voll. usciti tra il 1815 e il 1831 in I ed.), opera ancora oggi utile per lo studio
della giurisprudenza medievale (tradotta in italiano dalla I ed. soltanto); il
Sistema del diritto romano attuale (8 voll., 1839-49, solo parte generale); il Diritto
delle obbligazioni (che è una parte speciale dell’opera precedente). I suoi Scritti
vari occupano 5 voll., in buona parte pubblicati sulla “Rivista per la
giurisprudenza storica” da lui fondata e che si continua ancor oggi col titolo
di Rivista della Fondazione Savigny per la storia del diritto (si chiama infatti
“Zeitschrift für Rechtsgeschichte der Savigny-Stiftung”). Tra gli scritti
programmatici importante il Della vocazione già citato, del 1814, scritto
polemico contro un altro del Thibaut, professore a Heidelberg, scritto in
favore della codificazione anche in Germania, sempre del 1814. Lo scritto di
Savigny è un po’ la carta programmatica della sua scuola.
La Scuola è quindi molto diversa da quella esegetica francese, che trionfò in
Italia almeno fino al codice del 1865 e agli anni ’70 dell’Ottocento. Ma c’è
anche qui una fondamentale esigenza positivistica che consentiva la saldatura
della Pandettistica con le correnti liberali del tempo e fece sì che in Germania
la codificazione si svolgesse alla sua insegna. Inoltre non va dimenticato che
la Pandettistica ha svolto la funzione storica primaria di unificare
culturalmente i giuristi tedeschi ben prima che la Germania lo fosse grazie
all’opera di Bismark, con la proclamazione del Reich nel 1871!
10. Il processo di codificazione in Germania
All’inizio dell’Ottocento infatti, quando operava il Savigny, la Germania si
presentava ancora politicamente disunita ben più dell’Italia. Il Sacro Romano
Impero (ed il Tribunale camerale dell’Impero) era stato dichiarato estinto
dall’imperatore asburgico nel 1806. Il Deutscher Bund (la lega tedesca, ‘doiccer
bunt’) che uscì dal Congresso di Vienna invece dei preesistenti 400 Stati fu
composto ancora di ben 40 stati sovrani (35 principati più 5 città libere), di
cui due in forte contrasto tra loro: Prussia e Austria, entrambi con un loro
codice, rispettivamente l’ALR (letteralmente ‘diritto territoriale generale’) del
1794 e ABGB (letteralmente: ‘libro della legge civile generale’) del 1811; la
Renania e il Baden conservarono il Code Civil. Nonostante il frazionamento
politico, la coscienza nazionale si rafforzava e Thibaut esprimeva appunto
l’idea dei progressisti liberali che lottavano per l’unificazione del Paese
pensando che il codice l’avrebbe favorita, così come avrebbe modernizzato il
Paese.
Savigny replicava nella Vocazione in modo molto articolato. Per lui i codici
erano da considerare un intervento o inutile o dannoso, perché sono i giuristi
gli interpreti dello spirito popolare e non il legislatore; loro devono cercare
nella storia le soluzioni migliori. Roma l’ha mostrato chiaramente: il diritto si
evolvette praticamente in assenza di legislazione grazie ai suoi giuristi e fu il
migliore mai esistito! I codici per lui erano modesti, anche l’ABGB - che pure
è ancora in vigore oggi in Austria. Comunque i giuristi tedeschi erano per lui
ancora impreparati a predisporre un codice, perché non l’avrebbero potuto
fare veramente ‘tedesco’. Si dovevano a suo avviso studiare prima il diritto
vigente, la recezione e il diritto romano, che è poi il diritto dell’Europa
universale, che avrebbe salvato la Germania dal provincialismo e dal
particolarismo.
Il discorso del Savigny, anche se abile, non era privo di contraddizioni: il
diritto romano veniva proposto come fulcro delle tradizioni tedesche, perché
così i giuristi tedeschi sarebbero stati i più universali, i primi in Europa.
Comunque il suo scritto ebbe successo anche perché, per motivi politici, un
codice unitario non era possibile.
Tuttavia anche in Germania ci furono momenti legislativi importanti, come la
legge cambiaria del 1848 (rimasta in vigore fino dopo la Convenzione
internazionale di Ginevra del 1930), ma poi soprattutto il Codice generale di
commercio del 1861, adottato entro il ’65 da tutti gli Stati. Esso ovviamente
favoriva i rapporti interstatali e commerciali ed ebbe un taglio molto pratico;
fu sostituito solo nel 1900 da un nuovo codice di commercio - ancora in
vigore.
11. Il codice civile tedesco (“Bürgerliches Gesetzbuch”, o “BGB”).
Il BGB, codice civile tedesco, entrò in vigore nel 1900 dopo lavori
preparatori durati più decenni, e a quasi trent’anni di distanza
dall’unificazione del paese.
Nel 1873, due anni dopo l’unificazione della Germania, fu varata una legge
che stabiliva per la prima volta una competenza legislativa a livello federale,
rompendo così la competenza fino allora esclusiva dei singoli stati tedeschi.
Era la premessa indispensabile per partire alla carica con un nuovo codice
civile nazionale: nel 1874 si insediò una prima commissione formata da otto
eminenti esperti, col compito di presentare un progetto di codice civile
unitario. Tale progetto, elaborato in più di settecento sedute della
commissione, fu presentato ben tredici anni dopo (1887), ma subito si presto’
a energiche critiche. Von Gierke e altri non mancarono di rilevarne
l’eccessiva astrattezza, la lontananza dalla prassi, nonché il fatto di non
rispettare le tradizioni tedesche, cioè di essere troppo romanistico, mentre
Menger, un esponente del socialismo giuridico, lo bollava come codice del
capitalismo. Apprezzamenti vennero invece sul piano linguistico, per la
precisione dei concetti esposti e delle espressioni utilizzate.
Le critiche obbligarono a continuare i lavori : una seconda commissione si
insediò, lavorando dal 1891 al 1895. Il nuovo progetto fu presentato al
Reichstag (il parlamento tedesco) sotto forma di progetto di legge il 17
gennaio 1896, fu approvato e fu pubblicato nella gazzetta ufficiale in agosto
dello stesso anno. La sua entrata in vigore (che pose il suggello alla definitiva
unificazione giuridica della Germania) avvenne il 1° gennaio 1900.
Con i suoi 5 libri, articolati in parte generale, diritto delle obbligazioni, diritti
reali, di famiglia e successioni, finisce l’epoca di formale vigenza delle norme
romanistiche in Europa! La sua parte generale, con una sezione apposita sul
negozio giuridico, divenne stimolo per la dottrina giuridica di tutta Europa e
non solo. Il BGB fu copiato, ad esempio, dalla Grecia e dal Giappone (che
pur aveva prima chiamato un francese per modernizzare le proprie tradizioni
giuridiche), perché si ritenne tale codice tecnicamente migliore.
In effetti è di grande livello, ma certo diversissimo da quello napoleonico.
Questo era per i cittadini, quello si dirige espressamente ai tecnici, perché ha
un linguaggio estremamente difficile, dato che è un tedesco derivato dal
linguaggio scientifico romanistico; inoltre è anche molto poco maneggevole
perché essendo una specie di trattato dottrinale sistematico (ed infatti è detto
anche “il piccolo Windscheid” per indicare che è una specie di riassunto del
trattato pandettistico di quest’autore!), per seguire la disciplina di un singolo
contratto bisogna prima andare alle regole generali sulla capacità d’agire, poi a
quelle generali sui contratti, poi a quelle specifiche sul singolo contratto!
Con tutto ciò (e veniamo all’oggi), il BGB è ancora in vigore, ma con enormi
modifiche. Se infatti si può affermare che la versione iniziale costruisse e
contenesse concetti cari all’economia liberale – l’assoluta libertà negoziale – o
riprendesse nella sua purezza concetti già cari al Code Napoléon – es. la
proprietà come diritto assoluto -, é però anche vero che ormai da decenni il
BGB va soggetto ad un’incessante opera di modifica e di riforma (per impulsi
nazionali e soprattutto europei), tanto da renderne irriconoscibili intere e
ampie parti. E’ stato grandemente modificato il diritto di famiglia, certo, che è
quello che più ha risentito, in tutta Europa, del riconoscimento
dell’uguaglianza dei coniugi e della pari loro responsabilità nei confronti dei
figli. Ma mutate sono anche – per fare alcuni esempi - la materia societaria,
quella delle condizioni generali di contratto e quella, introdotta nel BGB per
recezione di direttive della UE, della (accresciuta) tutela del consumatore.
Certi concetti-base cari al liberalismo, poi, come quello della proprietà
“assoluta”, sono stati profondamente ripensati nel segno di una maggiore
sensibilità sociale : si pensi alla materia delle locazioni e alla forte tutela del
locatario ivi contenuta - in uno stato, la Germania, in cui la costituzione
vigente (“Grundgesetz”) richiama espressamente il concetto di “economia
sociale di mercato”.
12. La questione della completezza dei codici
Generalmente si dice che il diritto comune cessò di aver vigore quando
entrarono in funzione i codici (1804 Francia; 1811 Austria; 1900 Germania).
Il codice civile austriaco caduto Napoleone venne introdotto nel Regno
Lombardo-Veneto, per cui si tratta di un codice che riguardò direttamente la
storia del diritto in Italia.
I codici statalizzarono il diritto, per cui ufficialmente non vi fu più spazio per
il diritto di formazione giurisprudenziale, sia in senso dottrinale che
giudiziaria. Con il codice si entrava ufficialmente nel regno dello ‘Stato di
diritto’; ciò voleva dire che non solo le attività delle amministrazioni erano
regolate dalla legge, ma che ci devono essere la costituzione a fissare i diritti
dei cittadini e delle leggi (e non atti governativi) a disciplinare l’attività delle
amministrazioni. Il cittadino è tutelato nei confronti dell’attività di Governo,
può ricorrere all’attività giudiziaria ordinaria per far valere le sue pretese, e alla
giustizia amministrativa per le violazioni nella sua sfera giuridica da parte di
atti amministrativi. Tutto nel rispetto della divisione dei poteri, perché dove
non c’è questa, non ci sarebbe neanche lo Stato di diritto, dato che un potere
prevarrebbe sull’altro - come aveva insegnato Montesquieu, notissimo
nell’Ottocento.
Corollario di questa visione è il giudice ritenuto “bouche de la loi” (bocca
della legge), secondo l’espressione che troviamo già in Montesquieu. A metà
Settecento infatti si diceva polemicamente che perché il diritto fosse
rispettato era necessario che il giudice, nel pronunziare una sentenza
applicasse semplicemente il diritto, non mettendoci niente di suo, a differenza
di quello che facevano i giudici di Ancien régime, che con le loro decisioni
sviluppavano giurisprudenzialmente il sistema. Ora invece abbiamo una
visione nettamente positivistica, dove l’unico diritto è quello positivo, dato
dal legislatore, per cui il giudice non può aggiungere niente.
Il principio di legalità dell’amministrazione che si va creando in questo periodo
sancisce la preminenza della legge. Questo fu il quadro delle fonti tipicamente
ottocentesco, che si chiama anche dell’assolutismo giuridico o legislativo,
diverso da quello politico (Luigi XIV: “Lo Stato sono io”, e pertanto sono
anche momento di unificazione dei poteri statuali). Quest’ultimo era
incompatibile con una costituzione, perché il sovrano si riteneva libero da
vincoli secondo la massima già vista: Princeps legibus solutus. L’assolutismo
giuridico invece è quello della legge, dove questa è vista come fonte da cui
dipende non solo l’esecutivo e il giudice, ma anche la dottrina (perciò
‘esegetica’, alla francese). Conformemente a questa idea c’era quella del
sillogismo giudiziario: il giudice deve soltanto trovare la norma che include la
fattispecie concreta e sussumerla nella fattispecie generale, applicandola
meccanicamente.
I codici hanno così portato a due conseguenze: sono completi e non sono
eterointegrabili. Eterointegrabile significa che un codice non può essere
colmato, quando si trova una lacuna, ricorrendo a principi esterni al codice
stesso. Questo è vietato perché si darebbe al giudice un grimaldello per
modificare il codice riferendosi a principi che non vi sono dentro.
Un appiglio a sostenere questa tesi esisteva nel Codice civile napoleonico che,
all’art. 4, disciplinava il diniego di giustizia, secondo cui il giudice non poteva
rifiutarsi di amministrare la giustizia (“Il giudice che rifiuterà di giudicare
sotto pretesto di silenzio, di oscurità o di insufficienza del diritto potrà essere
perseguito come colpevole di diniego di giustizia”); ebbene, sulla base di
questo articolo si disse che se il giudice non poteva ‘denegare’, era ovvio che
ci fosse sempre una norma da applicare. L’idea era quella di contenere
l’arbitrio dei giudici, ma già nell’opera di un commentatore si cominciò a dire
che qualora ci fosse stata una lacuna ‘completa’ bisognava ricorrere all’equità.
Ebbene, questo dell’equità è evidentemente un criterio di eterointegrazione,
perché con esso si consente al giudice di seguire propri criteri equitativi,
esterni (‘etero’ rispetto) al codice. Una cosa era quindi la teoria ufficiale delle
fonti, secondo cui dottrina e giurisprudenza non facevano diritto, ed altra
cosa fu la prassi giudiziaria concreta, tanto è vero che le lacune e
contraddizioni del codice vennero risolte in parte dalla dottrina ed in parte
dalla giurisprudenza, e in particolare dalla corte di Cassazione, grande novità
delle riforme giudiziarie francesi.
Essa fu istituita proprio per garantire l’esatta applicazione del codice, per cui
non fu (e non è) che una corte di legittimità, perché non entra nel ‘merito’ delle
sentenze pronunciate dai giudici di prima istanza e di appello, e quindi opera
solo sulle interpretazioni che i giudici hanno dato. La sua principale funzione è
appunto di ‘cassare’ la sentenza quando i giudici hanno interpretato male la
legge, e in questo modo essa assicura l’uniforme interpretazione della legge
(funzione c.d. nomofilattica). Le sue decisioni, che circolarono ampiamente,
riuscirono ad integrare le lacune del codice napoleonico e a coordinarne le
varie parti.
Il Codice austriaco invece, come si é detto in precedenza, aveva un articolo
sull’eterointegrazione che recitava: “Qualora un caso non si possa decidere né
secondo le parole, né secondo il senso naturale della legge, si avrà riguardo ai
casi consimili (analogia)... rimanendo nondimeno dubbioso il caso si dovrà
decidere secondo i principi del diritto naturale ....”, che fungevano quindi da
norme integrative del codice. Una situazione del genere si ha oggi in Irlanda, che
esplicitamente ammette l’integrazione giusnaturalistica, il che poi non
meraviglia molto tenuto conto che è un Paese cattolico in modo anche più
netto del nostro.
Altro punto da notare. Abbiamo ripetuto che il diritto comune con i codici
muore, ma va ricordato che spesso nei commenti che vennero fatti ai codici
nel corso dell’Ottocento per capire meglio la norma del codice si utilizzò
anche il diritto romano, perché c’erano dei concetti non spiegati nel codice.
Classico l’articolo del Codice napoleonico in questioni di beni mobili: “il
possesso equivale a titolo”, ci dice, ma chi ci spiega cos’è il possesso, il ‘titolo’
ecc.?
Questa idea che il Codice richiedesse solo esegesi letterale anziché un vero e
proprio lavoro di interpretazione è quindi un’idea ingenua, ma tornava bene
alla congiuntura politica e alle polemiche dei pandettisti, i quali in Germania
sostenevano che, fatto il codice, fosse finito il lavoro del giurista. Questo
invece fu appieno valorizzato in Germania non essendo più vigente in nessun
Land (salvo poche limitate eccezioni) un codice di tipo francese. In questo
modo il giurista rispondeva alle domande più ardue in caso di lacune o di
conflitti tra norme locali sulla base della logica giuridica e dei principi che
discendevano della sistematica dottrinale pandettistica. I giuristi vissero in
questo clima di diritto comune - e non per niente proseguirono i consilia dati
dalle Facoltà giuridiche - fino all’entrata in vigore del codice, nel 1900,
applicando quindi, quand’era il caso, un diritto dottrinario elaborato a
tavolino sulla base della storia, lo stesso diritto che, per il singolare prestigio
di questi giuristi, diresse l’opera dei legislatori e la stessa interpretazione delle
singole leggi.
Il diritto comune quindi è stato ufficialmente superato da noi, anche se vive
nella cultura giuridica - e lo si è visto nella decisione delle Sezioni unite
riportata a suo tempo. Ma ci sono Paesi in cui per circostanze varie è ancora
possibile far riferimento esplicito a principi del diritto comune europeo
precodificatorio. Pensiamo alla Repubblica di San Marino, a quella di
Andorra, ma anche a realtà ben più corpose, come il Sud Africa - che per
essere stato colonizzato dagli olandesi ricevette il diritto romano-olandese del
’700, conservato poi nonostante l’occupazione inglese -, oppure il Quebec, in
Canada - che ha conservato il legame con l’antico diritto europeo come
momento di identità culturale -, oppure ancora alla Lousiana, che è una mixed
jurisdiction, un Paese cioè in cui convivono con grande difficoltà tradizione
romanistica europea locale e common law in conseguenza delle giurisdizioni
federali. Non a caso a New Orleans esiste una Bartolus’ Society, per coltivare il
ricordo del grande giurista di Sassoferrato, ignoto in Italia; si pensi piuttosto
ancora alla Scozia (Edinburgo è un centro di studi romanistici importante),
che recepì nella propria cultura giuridica il diritto continentale dal ’500,
quando i suoi giovani cominciarono a formarsi una cultura nel Continente,
evitando l’Inghilterra proprio per non perdere un’identità sempre minacciata
dalla egemonia inglese.
Ora in questi Paesi il diritto comune ha uno spazio naturalmente residuale può essere invocato solo in casi rari, con molte differenze però da un posto
all’altro -, ma rimane come rivendicato contrassegno di significato più che
altro culturale. In che senso? Perché qui non c’è stato o non ha avuto grande
importanza l’illuminismo, né ciò che esso ha significato, ossia il tentativo
razionalistico e antistoricistico di far tabula rasa del passato. Non c’era un
problema politico di lotta contro i giudici, per cui non si sentì neppure
bisogno di fare una lotta culturale anti-romanistica - come si sentì invece in
Paesi che avrebbero avuto ben maggiori motivi di rimanere aderenti al diritto
comune! È uno dei tanti paradossi della storia, e non meraviglia più di tanto.
Ma bisogna almeno esserne consapevoli.
13. Il rapporto tra codificazione commerciale e codificazione civile
Il Codice civile non fu l’unico codice napoleonico. In pochi anni si
susseguirono gli altri, ossia quello penale a quelli di procedura penale e
criminale, fino a quello di commercio. Con essi il principio codificatorio si
impose nei vari rami del diritto relativo ai privati, che erano i più interessati a
superare la incertezza ed arbitrarietà dell’Ancien régime e della sua
discutibilissima giustizia. Tuttavia i codici per il solito fatto di metter per
scritto in modo precettivo e chiaro i comportamenti richiesti davano maggior
garanzia di certezza (e di nuovo furono imitati come modello negli altri Paesi
anche dopo o durante la Restaurazione), specie quello penale, ma non è
sempre detto che fossero anche innovativi come quello civile. Quelli di
procedura derivarono da una semplice razionalizzazione e modernizzazione
delle Ordonnances di Luigi XIV (ma la Rivoluzione portò la novità della giuria,
importante come momento di valorizzazione del ‘cittadino’, che veniva così
giudicato dai suoi ‘pari’), come anche quello di commercio. E qui bisogna
richiamare il discorso già fatto per l’Inghilterra, che unificò il diritto delle
obbligazioni in anticipo rispetto a tutti - noi ci siamo arrivati col 1942 e si
vedrà come -, favorendo così lo sviluppo del capitalismo.
La dicotomia dei due codici invece è rimasta sia in Francia che in Germania, e
con un significato diverso. In Francia il Codice di commercio napoleonico fu solo
in parte innovativo, perché dipende ampiamente dall’Ordinanza del
commercio e della marina di Luigi XIV. Ma perché si conservò a parte?
Perché il Codice civile rappresentava la normativa per il cittadino ‘normale’,
che era (quando gli andava bene) un (nobile o borghese) proprietario terriero,
che comprava per sé e la famiglia, e non per speculare. Perciò su quella
proprietà era incentrato il codice. Esso rifletteva pertanto una società ancora
agricola, come era il Continente a quel tempo. Tanto è vero che quando a
metà Ottocento comincerà a diffondersi la società industriale, il Codice era
per alcuni aspetti invecchiato: si pensi che non prevedeva una disciplina
specifica per il rapporto di lavoro, ancora inteso come una particolare
locazione (d’opera, come nel diritto romano), e perciò cominciò ad attirarsi
anche le critiche, sempre piú incisive verso la fine del secolo, del c.d. socialismo
giuridico.
La società più dinamica dei traffici, rappresentata dalla borghesia degli affari e
del capitale mobiliare, era appunto prevista dalla normativa commercialistica,
ma ancora come disciplina speciale rispetto a quella ordinaria del codice civile
in Francia. Ciò significa che i valori civilistici erano largamente prevalenti e
quelli commerciali ancora in netta minoranza. Comunque, il codice di
commercio francese non poteva aspirare ad assumere l’importanza di quello
civile, perché disciplinava
1) solo gli atti di commercio, ossia di speculazione, anche se da chiunque
compiuti (disciplina oggettiva, quindi, e non più soggettiva come in
passato), come le compere per rivendere, i cambi, le operazioni di
banca, le mediazioni, le costruzioni; e,
2) i commercianti, intendendo per tali coloro che facessero quegli atti
professionalmente, e che quindi venivano sottoposti a regole soggettive
particolari a tutela del pubblico dei contraenti, come le regole sul
fallimento e sui libri di commercio nella tradizione di Luigi XIV.
Ma che fosse una disciplina secondaria, per così dire, quella commercialistica
lo fa vedere bene come si svolgeva la concorrenza tra i due diritti. Se l’attore
d’una causa era un commerciante contro un altro commerciante nulla quaestio:
si andava al tribunale di commercio (ove sono presenti dei commercianti); se
era contro un cittadino doveva invece convenirlo nel tribunale civile, che in
ogni caso riceveva gli appelli contro il tribunale di commercio; se poi era un
cittadino l’attore, egli poteva invece scegliere a quale corte rivolgersi, e se
andava in quella di commercio si applicava comunque in prima istanza il
codice civile e solo per quanto non disposto (contratti appunto commerciali)
il codice di commercio.
Le corti commerciali naturalmente erano più accessibili, perché più rapide e
meno costose, potendosi anche evitare il patrocinio del legale, ma ciò non
toglie che il diritto commerciale fosse poco sviluppato, un diritto veramente
‘sussidiario’ in Francia, e che quindi non ledeva l’uguaglianza dei cittadini di
fronte alla legge.
Questa situazione si ricreò in Italia con i due codici unitari, civile e di
commercio del 1865, largamente tributari di quelli francesi. Ma intanto era
venuto fuori un nuovo modello ben diverso, ossia quello tedesco del 1861accettato da tutti gli Stati tedeschi entro il 1865. È molto significativo che la
Germania ancora prima dell’unificazione politica potesse conseguire quella del
diritto commerciale. Il fatto ci conferma che, come di solito nella storia, il
diritto commerciale è stato un diritto ‘speciale’ più dinamico, che ha
anticipato quello che poi sarebbe avvenuto nel diritto civile, il quale è un
diritto più tradizionale, più lento a modificarsi e ad accettare delle novità.
In Germania così, in piena Pandettistica, grazie all’accordo doganale tra gli
Stati si impose una disciplina uniforme delle obbligazioni commercialistiche
che rappresenta un passo in avanti rispetto al modello francese; modello
molto significativo, perché il codice tedesco disciplinava per intero - dovendo
applicarsi tra ‘commercianti’ di Stati diversi nei quali il diritto privato aveva
differenti discipline - i rapporti obbligatori, e creava quindi una disciplina
esaustiva, parallela a quella privatistica. Con in più due regole che indicavano
in che direzione si voleva andare, cioè a favore dello sviluppo mercantile e
industriale anche a sfavore dei semplici cittadini:
1) che cioè il diritto commerciale si applicava anche quando uno solo dei
contraenti era un commerciante. Nasce da qui una disparità di
trattamento, perché il cittadino non commerciante viene sottoposto alla
giurisdizione mercantile sempre, in deroga al suo giudice ‘naturale’;
2) in mancanza di precise regole commercialistiche, prima delle norme
privatistiche si applicavano gli usi commerciali, naturalmente creati dai
commercianti e pertanto tendenzialmente a loro favore.
Questo è il modello che fu recepito in Italia quando nel 1882 fu riformato il
Codice di commercio, ed è facile immaginare le polemiche cui dette l’avvio. È
chiaro che si trattava di favorire la circolazione delle merci, favorire la
conclusione dei contratti e i creditori in modo che potessero reinvestire e così
via, ma proprio in quegli anni veniva fuori in tutta evidenza la questione
operaia (che portava in quell’anno alla costituzione del partito operaio e poi ai
primi deputati di vera opposizione al sistema politico e al governo), per cui ci
furono i giuristi che, sensibili al clima da ‘socialismo giuridico’ gridarono allo
scandalo. Ma come, si disse, ci sono cittadini di serie A e di serie B?
È un diritto di classe quello commerciale, e ad esso sacrifichiamo
l’uguaglianza tra i cittadini? Perciò alcuni, primo tra tutti un commercialista
validissimo come il Vivante, cominciarono a richiedere con forza l’unificazione
del diritto privato mediante un codice unico in modo da avere un’uguale
normativa per tutti, che assicurasse un equilibrio tra esigenze dei traffici e
della vita ‘normale’, e quindi la solidarietà tra le classi.
È quanto riuscì a fare proprio allora, nel 1883, la Svizzera, con il Codice unico
delle obbligazioni, ma l’Italia rimase sulla vecchia strada come ci rimase la
Germania, che solo nel 1900 si dette un nuovo codice anche di commercio
molto moderno, che proiettò il Paese sui mercati internazionali, favorendo un
diritto commerciale uniforme a livello internazionale, a disposizione dei
professionisti degli scambi.
In Italia il Codice di commercio del 1882 si fuse con quello civile solo nel 1942,
alla fine dell’epoca fascista, non certo per una esigenza di uguaglianza dei
cittadini, ma perché il fascismo era contrario alla lotta di classe, che la duplicità
dei codici quasi sottointendeva, e per svecchiare la società ancora rurale. Solo
che l’unificazione del diritto delle obbligazioni in tal modo effettuata, fatta per
integrare il corpo sociale, avvenne a scapito del diritto civile, perché nel
codice del ’42 i principi del Codice di commercio furono talvolta recepiti ed
imposti a tutta la società, attuandosi la c.d. commercializzazione del diritto privato.
Si era eliminata così la polemica contro gli “atti unilateralmente commerciali”,
per cui bastava che una delle parti fosse un commerciante perché la norma
applicabile fosse quella del codice di commercio, più favorevole ai
commercianti, ma ora tutti erano sottoposti alle regole ‘mercantili’.
Francesco Galgano, un commercialista che ha studiato a lungo questi temi,
segnala in particolare questi punti:
- la disciplina dell’acquisto ‘a non domino’ di cose mobili, che non ha
riscontro in altre discipline, protegge dal ’42 l’acquirente di buona fede anche
quando trattasi di cose rubate o smarrite;
- la norma che subordina l’azione di annullamento del contratto alla
riconoscibilità dell’errore, per cui si è vincolati al contratto non voluto;
- o che subordina l’annullamento del contratto dell’incapace alla prova della
malafede dell’altro contraente;
- o che rende la simulazione inopponibile al terzo acquirente di buona fede;
- o quando si fanno salvi i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona
fede.
14. I codici dell’Italia della Restaurazione (1814-1859).
In seguito al crollo del sistema napoleonico nel 1814, dappertutto in Italia (a
Torino, Milano, nei Ducati padani, a Firenze, nello Stato della Chiesa, a
Napoli) fecero ritorno i sovrani “restaurati”, vale a dire coloro che
detenevano il potere anteriormente all’irruzione delle armate napoleoniche in
Italia. Con alcune eccezioni, però : ad esempio, il Congresso di Vienna
decretò la fine delle Repubbliche di Genova (annessa al Piemonte) e di
Venezia (che fu annessa alla Lombardia già austriaca, per formare il c.d.
Regno Lombardo-veneto), e alcune modifiche minori (es. il Ducato di Parma
e Piacenza fu affidato all’arciduchessa Maria Luisa d’Austria, già seconda
moglie di Napoleone).
Un passo indietro, tale da cancellare il passato recente, politico e giuridico?
Seppure in apparenza sembrerebbe così (a leggere ad esempio il brano delle
memorie del piemontese Massimo D’Azeglio sul ritorno a Torino dei
“codini” del seguito della corte di re Vittorio Emanuele I), in realtà il colpo di
spugna sul passato era di ben difficile realizzazione. Gli storici (come A.
Saitta) già da decenni parlano di una “impossibile Restaurazione”, per
significare che il fermento provocato nelle coscienze degli italiani dal periodo
napoleonico (su più aspetti : ideale, politico, anche militare visti i tanti italiani
che avevano valorosamente combattuto nelle armate napoleoniche) era
destinato a dar ben presto i suoi frutti.
Sul piano della storia del diritto il discorso é analogo, sebbene più “tecnico”, e
si può riassumere in una constatazione di fondo : il dato dell’esperienza
codicistica (civile, penale, di procedura) era ormai ineliminabile in buona parte
d’Italia, e un ritorno all’epoca del diritto comune o delle compilazioni
settecentesche era impossibile. L’elemento “codice” era ormai acquisito,
oltreché uno strumento efficace aumentare il proprio potere e accentuare nei
loro domini il già annoso processo di “statualizzazione” del diritto. Per Carlo
Ghisalberti, acutamente, “la forza stessa delle cose finiva con l’imporre il mantenimento
di quella soluzione codicistica realizzata nell’intera penisola durante la dominazione
napoleonica e, persino, progettata nella Sicilia in quegli anni restata sotto la sovranità
borbonica. Il fatto che anche in quell’isola dove non era stato evidentemente possibile recepire
dalla Francia un sistema normativo codificato se ne fosse studiata egualmente
l’introduzione, offriva senza dubbio una prova della generale diffusione di quelle istanze
codicistiche alle quali non avrebbero più potuto sottrarsi i sovrani della Restaurazione”.
Eppoi, in fin dei conti, anche ragioni di buon senso militavano a favore di
un’accettazione del modello codicistico in buona parte degli stati italiani : i
sovrani più “illuminati” si rendevano infatti conto che un nuovo
sconvolgimento nel modo di legiferare avrebbe nuociuto notevolmente alla
certezza del diritto e quindi alla stabilità dei domini recentemente recuperati, e
questo non era certo nel loro interesse.
Insomma, il dato “codice” fu culturalmente ineliminabile, anche se non vi
furono dappertutto codici nella penisola.
Ma quel che è interessante è che anche nel contenuto della codificazione i
codici degli stati italiani preunitari si rivelano in buona parte “figli” della
codificazione napoleonica. Essi infatti riprendono non pochi (e
importantissimi) elementi di derivazione francese : si pensi all’uguaglianza
giuridica e civile (e all’eliminazione di privilegi di casta), già comunque
concettualmente non ignota e al centro dei dibattiti e delle riforme
settecentesche, o alla disciplina dei beni, e segnatamente della proprietà –
seppure tale scelta di rendere “assoluta” la proprietà è giustificata riferendosi
alla tradizione locale e quindi allo ius comune.
E non solo questo: sul lungo periodo i codici preunitari svolgono
storicamente anche una funzione - importantissima - di “cinghia di
trasmissione”: come ha infatti brillantemente ipotizzato A. Padoa Schioppa,
essi hanno costituito il tramite attraverso il quale l’idea stessa di codice, con
quanto essa comportava riguardo al sistema delle fonti del diritto privato e al
rapporto tra legge, dottrina e giurisprudenza, si è trasmessa al futuro stato
unitario.
Dove ci si discosta dal dato napoleonico, è unicamente nel tentativo di
resuscitare, ma sempre nel corpus dei codici, taluni vieti istituti di antico regime
(rafforzamento della patria potestà, limitazione della posizione successoria
della donna).
Eccezioni alla tendenza ad adottare nuovi codici ?
Non mancarono. Il regno di Sardegna vivrà un processo codificatorio assai
lento, durato due decenni ma pur alla fine riuscito ; il Ducato di Modena e il
Granducato di Toscana, pur percorrendo vie diverse, si risolveranno
estremamente tardi ad una codificazione moderna, quando ormai i
rivolgimenti politici che avrebbero accelerato l’unificazione della penisola
erano alle porte. Lo Stato Pontificio, non da ultimo per l’intrinseca
commistione - giuridica e politica - tra elemento civile e religioso, sarà
incapace fino all’ultimo di varare codici modernamente intesi. In tutti gli altri
stati, invece, il processo codificatorio procederà più o meno speditamente.
Se il modello è indiscusso, va però tenuta presente una differenza di
contenuti tra codificazione civile e codificazione penale: così, se nel campo
del diritto civile l’autorità del Code Napoléon è più difficilmente discutibile, non
così sarà per le norme severe del Code pénal francese del 1810 (che ai fini
della pena non distingueva, ad esempio, tra reato tentato e consumato, o
ancora irrogava la pena capitale in una serie estesa di casi), da cui i codificatori
preunitari, pur emanando anch’essi codici penali, si discosteranno spesso.
Insomma, ben presto i due codici finiranno per godere di un prestigio
ineguale!
Fatte queste premesse, esaminiamo ora più da vicino i codici dei principali
stati italiani preunitari, percorrendo la penisola da nord a sud.
a) Il regno Lombardo-veneto. Creato dal Congresso di Vienna nel 1815 e formato
dall’unificazione delle terre lombarde, sotto il controllo dell’Austria fin dal
1714, con l’antico territorio della Repubblica di Venezia (che però già nel
1797 a Campoformio aveva perso la sua millenaria indipendenza), il
Lombardo-Veneto viene integrato ai domini della Casa d’Austria. Vi viene
introdotta tout court la legislazione austriaca, civile e penale, e segnatamente,
dal 1° gennaio 1816, l’ABGB del 1811 (cfr. paragrafo 7). il Lombardo-Veneto
non vedrà quindi nascere una codificazione autoctona. Come ha giustamente
notato il Bonini, “si tratta di un singolare gioco del destino, in forza del quale proprio
nei territori che avevano costituito il centro intellettuale, sociale ed economico del precedente
Regno d’Italia il codice francese veniva soppiantato dal suo grande rivale austriaco, senza
sopravvivere di conseguenza, come in altri territori italiani, neppure a livello di fonte
d’ispirazione”.
b) Il Regno di Sardegna. Formato da territori estremamente eterogenei
geograficamente e linguisticamente, venuti ad aggregarsi progressivamente ai
primitivi nuclei piemontese e savoiardo, il Regno di Sardegna ottenne il
territorio di Genova dal Congresso di Vienna – e quindi uno sbocco sul mare
- come sorta di “risarcimento” per la lunga occupazione francese. Ed é
proprio qui, in odio alla dominazione francese, che il sovrano restaurato,
Vittorio Emanuele I, sembra voler realizzare allo stato puro l’idea di un
ritorno integrale al passato: un editto del 21maggio 1814 cancella d’un tratto
l’intero corpus delle leggi francesi e richiama in vigore il diritto anteriore, vale a
dire le Regie Costituzioni del 1771, gli statuti locali, il diritto comune.
Ma tale involuzione giuridica si realizzerà a prezzo del sacrificio dell’unità
legislativa del Regno : a Genova, infatti, il potere centrale si rassegnerà a
lasciare in vigore non solo il Code Napoléon, ma anche il Code de commerce che
sopravvivranno poi ancora per vent’anni (fino al 1837): un fatto, questo,
pressoché unico in Italia (se si esclude il principato di Lucca), nonché
paradossale se si pensa che é accaduto nel regno più “reazionario” d’Italia !
Peraltro, il re di Sardegna, in una prammatica del 1817, si era ripromesso di
addivenire ben presto alla redazione di nuovi codici, abbandonando così le
leggi di antico regime. Ma tale progetto, viste le notevoli resistenze, non potrà
compiersi che nel 1837, dopo 20 anni di immobilismo pressoché assoluto,
rotto unicamente da un compilazione locale sarda (le “Leggi civili e criminali”
del 1827) valida localmente e per niente innovativa sotto il profilo tecnico.
Fino agli anni Trenta dell’Ottocento, quindi, i territori piemontesi, la Savoia e
la Contea di Nizza saranno rette dal diritto di antico regime ; a Genova
resistevano invece il Code Napoléon e il Code de commerce ; in Sardegna vigeva la
compilazione del 1827.
L’avvento al trono, nel 1831, di Carlo Alberto – più aperto dei suoi
predecessori - sbloccherà la situazione e consentirà l’emanazione di nuovi
codici che daranno finalmente al Regno quell’unità giuridica mancata (in
terraferma) : il Codice civile del 1837 (la cui denominazione ufficiale sarà
“Codice civile per gli Stati in terraferma del Re di Sardegna”), il Codice penale
del 1839, il Codice di commercio del 1842 e il Codice di procedura penale del
1847. Il tutto fu frutto di un imponente, lungo e arduo lavoro di riforma,
affidato da Carlo Alberto ad eminenti giuristi tra cui quel Federico Sclopis
che sarà l’autore, agli albori dell’Unità, di una famosa “Storia della legislazione
italiana” e che difenderà contro ogni attacco, all’indomani della sua entrata in
vigore il 1° gennaio del 1838, il “suo” Codice civile.
Visto il regime bilingue del Regno e il rapido approntamento di una versione
francese del Codice civile, esso era quello che più si prestava, infatti, ad essere
letto a conosciuto all’estero. E critiche non mancheranno, tra l’altro,
dall’ormai vecchio Portalis (l’autore del famoso “Discorso Preliminare” al
Code Napoléon, vi ricordate?) sulle norme di privilegio per la chiesa cattolica
(come la dichiarazione iniziale, ripresa un decennio dopo nello Statuto, della
religione cattolica “religione dello Stato”) e sull’indebolimento della posizione
successoria delle figlie rispetto ai dettami del Code Napoléon ( che nel
frattempo – come si sa – era pur sempre in vigore in Francia, sebbene senza
più divorzio).
Il Codice civile piemontese del 1837 segue la partizione napoleonica in tre
libri. Tra le sue norme – molte delle quali poi sorpassate dalla successiva
laicizzazione e modernizzazione del regno a partire dagli anni ’50
dell’Ottocento (cfr. infra) – la più nota resta senza dubbio quella, iniziale, del
richiamo ai “principi generali del diritto” come metodo per colmare eventuali
lacune ; una norma che fece scuola e che esiste ancor oggi nel Codice vigente!
Quanto al codice penale del 1839, esso è portatore di alcune importanti
modifiche rispetto al Code pénal francese del 1810 : una più ristretta
applicazione della pena di morte, la distinzione, ai fini delle pene da irrogare,
tra delitto tentato e consumato, una maggiore articolazione dell’imputabilità a
seconda della situazione del reo, maggiori poteri affidati al giudice nello
stabilire le pene (con possibilità di applicare le circostanze attenuanti) rispetto
alla rigidità applicativa del Code pénal (di cui spesso il magistrato diveniva
semplice esecutore meccanico), e infine il computo della custodia preventiva
nella durata globale della pena. Il codice penale risente dei principi, cari ai
riformatori piemontesi dell’epoca, della rieducazione ed emenda del reo, per
cui rilevante diventa la condizione carceraria e l’importanza di migliorarla.
Dal preambolo al codice è utile leggere che l’intento del Codice penale, a
detta dei suoi compilatori, era infatti quello di dettare “leggi penali che, eguali per
tutti, e fondate su regole certe, e tra di esse coordinate, dessero ai giudici sicure norme
nell’applicazione delle pene, lasciando loro però nella misura di esse quella discreta
latitudine che la molteplice varietà di circostanze, non tutte dalla legge prevedibili, consiglia
di confidare al prudente loro arbitrio. Ebbimo pure di mira di stabilire un’equa
proporzione tra i reati e le pene, e che queste non solo inserissero al pubblico esempio, ma
(…) pel miglioramento dei luoghi di detenzione fossero dirette all’emendazione dei
colpevoli..” (Vinciguerra, p.356). Particolarmente dura resta comunque, in
omaggio alla stretta compenetrazione tra Stato e chiesa, la repressione dei
reati contro la religione cattolica.
Il codice del 1839 fu riformato nel novembre 1859 per renderlo adeguato ai
tempi : il Piemonte si era nel frattempo in buona parte laicizzato (leggi
Siccardi, cfr. infra), e l’unificazione politica in corso imponeva uno sforzo di
uniformizzazione con le leggi penali di altre regioni italiane. Il nuovo codice
penale, entrato in vigore il 1° gennaio 1860, riprenderà però in gran parte le
norme di quello precedente e costituirà la base della legislazione penale
vigente in Italia (salvo che in Toscana) fino all’entrata in vigore del Codice
Zanardelli (cfr. capitolo seguente, par. 13).
c) Il Ducato di Parma
Retto per un trentennio (1816-1847) dall’arciduchessa Maria Luisa d’Austria,
seconda moglie di Napoleone, il Ducato di Parma potrà evitare, grazie ad una
classe dirigente illuminata, gli eccessi del “ritorno al passato” del Piemonte: la
codificazione napoleonica vi resterà infatti in vigore senza soluzione di
continuità fino all’emanazione dei nuovi codici civile, penale e di procedura,
nel 1820.
Il codice civile parmense, giudicato da taluni studiosi (Ghisalberti, Padoa
Schioppa) come il più pregevole tra tutti i codici preunitari, pur seguendo
strutturalmente e ratione materiae il modello del Code Napoléon se ne allontana
in talune parti (per Parma, vista la provenienza dell’arciduchessa e del suo
consigliere, il conte Neipperg, occorre parlare infatti di influenza di modelli
austriaci) : ad esempio, è abolito l’obbligo della dote per le figlie, e il regime
patrimoniale dei coniugi ridiventa (conformemente alla tradizione generale di
ius commune) la separazione dei beni.
Quanto al (coevo) codice penale (adottato il 5 novembre 1820 e in vigore dal
1° gennaio 1821), gli storici ne hanno a volte sottolineato (alla stregua di
quello piemontese) una certa durezza, specie nei reati contro la religione, ma
anche una estrema articolazione in fattispecie ignote tanto al Code pénal del
1810 che al codice penale del Regno delle Due Sicilie (1819) : la previsione
del sordo-mutismo come causa di diminuzione dell’imputabilità, le modalità
di conversione delle pene pecuniarie in detentive, una specifica disciplina –
con dovizia di distinzioni – della complicità nella commissione dei reati (il
Code pénal invece irrogava quasi invariabilmente la stessa pena all’autore e al
complice, e non distingueva tra più tipologie di complici) o ancora, nella parte
speciale, le specifiche fattispecie del duello, della falsa moneta e dell’esercizio
arbitrario delle proprie ragioni. Il legislatore penale piemontese del 1839 si
ispirerà a tali fattispecie che, accoltevi, si trasmetteranno, seppure
mediatamente, nella legislazione penale del Regno d’Italia.
d) Il Ducato di Modena
Il Ducato di Modena si risolverà ad una codificazione moderna pochi anni
prima dell’Unità con un codice civile, del 1852, e un codice penale, del 1855,
emanati per volontà dell’ultimo duca, Francesco V. Quest’ultimo ebbe
pertanto almeno il merito di mitigare in extremis la severissima legislazione
penale e di polizia estense durata fino ad allora e provvida di fattispecie in cui
era in uso la tortura giudiziaria.
Modena fu quindi retta per quasi tutto il periodo della Restaurazione da
quelle “Leggi e costituzioni per gli Stati Estensi” (detti comunemente “Codice
Estense”) emanate nel 1771 e richiamate in vigore nel 1814. Taluni storici del
diritto tendono a vedere nella estrema modernità del settecentesco Codice
Estense una sorta di “mitigazione” nella durezza di questo ritorno all’ancien
régime modenese. Come infatti ha acutamente notato il Bonini, il Codice
Estense si presentava già al suo nascere nel 1771 come un codice moderno e
pionieristico in quanto, contrariamente alle altre consolidazioni settecentesche
di materiali preesistenti, esso conteneva norme positive nuove e
organicamente strutturate.
e) Il Granducato di Toscana
Nel Granducato di Toscana (annesso all’impero napoleonico dal 1808 al
1814) fu richiamato in vigore, alla caduta di Napoleone, il complesso delle
antiche leggi granducali unitamente al diritto comune: ma il tutto si
accompagnò (diversamente da Modena o dai primi anni della restaurazione
piemontese) ad un’intensa opera di riforma da cui si poteva chiaramente
capire che il passato regime giuridico era orami tramontato: furono infatti
aboliti i fedecommessi, gli statuti municipali, i feudi. Il Code de commerce,
introdotto nel 1808, vi fu mantenuto, e fu, questo, un dato di grande
importanza per la vita commerciale e mercantile della Toscana.
L’intento riformatore fu quindi presente e si accentuò con l’ultimo duca,
Leopoldo II il quale, pur non riuscendo a varare un nuovo codice civile,
emanerà almeno un codice penale in piena linea con la tradizionale mitezza
della penalistica toscana risalente all’ormai celeberrimo Codice Leopldino del
1786 (primo nell’abolire la pena di morte : cfr. capitolo seguente, par. 13).
Questo codice penale “illuminato” (da cui sarà poi stralciata la pena di morte
per decreto del governo provvisorio toscano costituitosi nel 1859 in attesa
dell’annessione al Regno d’Italia) resterà in vigore in Toscana fino al 1890 e
avrà un profondo valore propulsivo del diritto penale postunitario: esso starà
ad indicare che là, in Toscana, e contrariamente al resto d’Italia, si era
concretizzata una alternativa penale “progressista”.
Le pene vi erano nettamente più miti che negli altri codici della Restaurazione
e nel Codice piemontese/italiano del 1859; i reati non erano più distinti,
secondo la loro gravità, in crimini e delitti, ma considerati tutti,
egualitariamente di fonte alla legge, come delitti – segno, anche questo, di
maggiore mitezza e dell’assenza di un “preconcetto punitivo”; contrariamente
all’archetipo francese e secondo la tradizione toscana si adottava quindi il
criterio della bipartizione, e non più tripartizione dei reati; la pena capitale
quando era prevista (e fino al 1859, come si è detto), lo era solo in rari casi
(es. omicidi compiuti con particolare efferatezza); dovunque, infine, allignava
poi l’idea dell’emenda, e non già della punizione esemplare del colpevole.
f) Lo Stato della Chiesa
Nello Stato della Chiesa, come giustamente ha notato il Ghisalberti, “non si
accompagnò mai l’attuazione di un disegno legislativo di rifondazione di un organico
sistema giuridico”, e né Papa Pio VII e l’illuminato cardinale Consalvi riuscirono
mai “a portare innanzi l’elaborazione di codici, opera questa naturalmente più difficile
nello Stato Pontificio che il altri Stati anche per il peso che vi esercitava il diritto canonico
nella vita civile e per la conseguente rilevanza assunta tradizionalmente da questo nel
sistema delle fonti del diritto”.
Mancò, sostanzialmente, in quello che possiamo senza ombra di dubbio
definire il “fanalino di coda” giuridico tra tutti gli Stati preunitari, l’idea di
voler riformare in senso moderno ( e laico) il diritto. Mancarono poi anche
quei dibattiti e (a volte) scontri tra “progressisti” e “conservatori” che altrove
(come in Piemonte), seppure in ambito ristretto, avevano già caratterizzato e
accompagnato la nascita dei codici preunitari.
Videro la luce, certo, un codice di procedura civile nel 1817 e un codice di
commercio nel 1827, e, sotto il papato di Gregorio XVI (1831-1846) si
vararono una riforma della procedura civile e penale nel 1831, e, nel 1835,
addirittura un “Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili”. Il
fatto è però che tale opera ebbe sostanzialmente un carattere compilativo di
stampo settecentesco, che non abrogava il diritto comune, né gli statuti locali
e il diritto canonico. Né la breve vita della Repubblica romana del 1849 (cfr.
capitolo seguente) riuscirà a sradicare tale stato di cose, ché si prolungherà
sino all’annessione al regno d’Italia nel 1870.
g) Il Regno delle Due Sicilie
Si é scelto l’approccio geografico da nord a sud per parlare dei codici degli
stati italiani preunitari, ma occorre ora tenere ben presente che il Regno di
Napoli, qui trattato per ultimo, fu invece il primo in ordine cronologico a
darsi una codificazione civile, penale, di procedura. E fu una codificazione
per molti aspetti non troppo retrograda rispetto all’archetipo francese in
vigore sino al 1815. Ovvio, quindi, che tale codificazione fosse poi imitata in
altri Stati della penisola (specie in Piemonte).
A Napoli, nonostante il ritorno dei Borboni sul trono nel 1815 e la fine del
periodo di regno del cognato di Napoleone, Gioacchino Murat (e
contrariamente a quanto accadde in Piemonte, a Modena o a Roma) non vi fu
alcun greve revival di passati ordinamenti: semplicemente, i codici francesi
poterono restare in vigore (ad eccezione delle norme sul divorzio, subito
abrogate) fino a quando non furono sostituiti, nel 1819, da un corpo di leggi
civili, penali e di procedura chiamato, nel suo insieme, “Codice per lo Regno
delle Due Sicilie”. Nel regno che la pubblicistica italiana successiva
(influenzata dagli eventi del 1848-48 e dalle repressioni poliziesche degli anni
seguenti) dipinse come la quintessenza della “reazione” e dell’anti-liberalismo,
il modello codicistico di importazione francese ( e austriaca) fu dunque
accettato senza riserve, riprodotto e ....imitato in altri stati !
Re Ferdinando I istituì il 2 agosto 1815 una commissione incaricata di
redigere una nuova codificazione. Ne fecero parte anche giuristi attivi durante
il decennio napoleonico (come Donato Tommasi, ex allievo di Gaetano
Filangieri). Già questo fatto, oltre all’incarico della commissione illustrato nel
testo del decreto reale di nomina, rende evidente che non si voleva ritornare
tout court al passato; al contrario, il futuro corpus di leggi avrebbe dovuto essere
“adatto all’indole dei nostri popoli, allo odierno stato della civilizzazione”, e garantire “
il grande oggetto della sicurezza delle persone e della proprietà”.
Anche dal punto di vista formale, e nell’impianto strutturale, le analogie con
gli archetipi francesi sono evidenti. Basti dire che il “Codice per lo Regno
delle Due Sicilie”, proprio come i cinq codes francesi di epoca napoleonica, si
suddivideva in cinque parti (civile, penale, di procedura “ne’ giudizi civili”, e
di procedura “ne’ giudizi penali”, commerciale) ma si presentava formalmente
in veste unitaria. Nella sostanza, poi, si può rilevare come il “Codice”,
perlomeno nella parte civilistica, accetti di mantenere in vita quanto delle
nuove conquiste civili non era incompatibile con la Restaurazione. I suoi
redattori non potevano certo, a Napoli, ignorare le novità del decennio
napoleonico (1806-1814) di Giuseppe Bonaparte e di Gioacchino Murat, e in
particolare l’abolizione degli istituti feudali!
Così, per citare due esempi, le “Leggi civili” mantengono il regime di libera
proprietà oramai instaurato, rendendolo di fatto irreversibile, e garantiscono
l’eguaglianza civile e giuridica. E accolgono, disciplinandolo negli effetti e
forme di pubblicità, una tipologia di matrimonio civile incompleto e meno
articolato rispetto a quello regolato dalla famosa “patente” di Giuseppe II del
1783 nonché rispetto al Code Napoléon, ma pur sempre distinto dal
matrimonio canonico.
Quanto alle “Leggi penali”, esse seguono la falsariga del Code pénal del 1810
(con ad esempio la tripartizione dei reati in crimini, delitti e contravvenzioni),
discostandosene in taluni punti come le pene (severe) per i reati contro la
religione e la (diffusa) applicazione della pena di morte.
Vengono tuttavia introdotte figure che, totalmente inesistenti nel Code pénal,
diverranno poi, per imitazione ed accoglimento in altri codici, patrimonio
comune della penalistica italiana : ci riferiamo alla distinzione, ai fini delle
pene, tra reato consumato e reato tentato (o addirittura mancato), alla
dettagliata disciplina della complicità nel reato (in cui i complici si
suddividono in varie categorie : mandanti, istigatori ecc.), ed infine alla
rinuncia alla pena fissa, cara al Code pénal, con una articolata previsione di
circostanze attenuanti oggetto di più libera valutazione da parte del giudice.
Concludendo questa veloce disamina dei codici della Restaurazione, possiamo
focalizzare alcuni punti importanti :
a) la derivazione, come si é ampiamente visto, da modelli francesi, ben
presto imitati largamente e quindi sempre meno posti in discussione col
tempo anche negli stati più “reazionari”. E qui, l’esempio “propulsore”
e di “accettazione” di tali modelli fornito dal Regno di Napoli già nel
1819 é innegabile;
b) il maggiore prestigio goduto dal Code Napoléon rispetto al Code pénal : i
legislatori italiani, primo fra tutti quello di Napoli – per non parlare
della Toscana e della sua grande tradizione penalistica – non esiteranno
ad opporre infatti al Code pénal del 1810 figure ed istituti totalmente
inesistenti oltr’Alpe (lo si é detto : bipartizione dei reati, distinzione tra
reato consumato e tentato, complicità, disciplina più dettagliata dei vari
casi di imputabilità, a volte riduzione drastica dei casi di previsione della
pena capitale ecc.).
c) La presenza, in materia penale, di norme “antiliberali”, che rivelano un
forte influsso della religione dominante e hanno il sapore di una sorta di
“braccio secolare” - nel senso dell’alleanza trono-altare : si pensi, ad
esempio, alla dura punizione del prestito ad usura, modellata sulla
perdurante condanna canonistica del prestito ad interesse. Tutti i codici
penali preunitari sanzionano l’usura (seguendo peraltro una falsariga
punitiva tracciata dalla legge francese del 1807), e occorrerà giungere
all’unità d’Italia e alla “laicizzazione” del diritto e dello stato perché tale
sanzione cada in nome del principio della libertà di contrarre, e della
libera fissazione degli interessi (lasciando peraltro insoluta questa grave
piaga sociale).
d) Infine, la totale inadeguatezza politica di tali opere codificatorie con il
progredire del Risorgimento italiano e l’affermarsi di ideali politici più
schiettamente liberali e costituzionali. Come ebbe a scrivere uno dei più
famosi teorici del costituzionalismo moderno, Benjamin Constant,
commentando la “Scienza della Legislazione” di Gaetano Filangieri, é
vana speranza pretendere che “delle buone leggi bastino ad assicurare la
sicurezza e la generale prosperità, senza bisogno di istituzioni costituzionali volte a
proteggere queste stesse leggi. Sarebbe come pretendere che le fondamenta di un edificio
siano superflue per la sua solidità”.
15. L’Italia unita e il Codice civile del 1865.
Gli eventi che portarono all’unificazione politica dell’Italia subirono, come é
ben noto, una rapida accelerazione tra il 1859 e il 1860 : dapprima la guerra
contro l’Austria del 1859, e successivamente, tra il 1859 e il 1860,
l’instaurazione di governi provvisori nell’Italia centrale abilmente diretti dietro
le quinte dal Cavour e dai suoi collaboratori (con la forzata, ma tutto
sommata benevola acquiescenza della Francia di Napoleone III, poi
“ricompenasata” con l’annessione della Savoia e di Nizza) e la dirompente
Spedizione dei Mille garibaldina – anch’essa alla fine ricondotta nell’alveo
della politica di annessione diretta dal Piemonte – fecero si’ che, il 17 marzo
del 1861, con la proclamazione dell’unità italiana da parte del Parlamento
riunito a Torino, un nuovo, eterogeneissimo paese si aggiungesse al contesto
europeo.
Ben si espresse allora il D’Azeglio con la famosa frase “fatta l’Italia, occorre
fare gli italiani”, per sintetizzare la situazione di un paese che necessitava in
tempi rapidi dell’allestimento di una solida intelaiatura giuridica volta a
cementare e rendere irreversibile l’unificazione politica raggiunta.
Come unificare giuridicamente l’Italia? Diciamo subito che, nel campo del
diritto penale, l’unificazione si farà attendere per un trentennio, vale a dire
fino al 1° gennaio 1890, data dell’entrata in vigore del Codice Zanardelli (per
questi aspetti, cfr. il capitolo seguente, paragrafo 13). Per il diritto
commerciale (per cenni esaustivi in tale materia cfr. il paragrafo precedente),
il diritto civile e la vasta legislazione amministrativa (tra cui farà spicco la
legge abolitrice del contenzioso amministrativo, cfr. capitolo seguente),
invece, l’opera poté dirsi compiuta già nel 1865, ma le scelte da compiere per
giungervi non furono scontate.
Occupiamoci in particolare della codificazione civile, che avrà a suo
coronamento il Codice Pisanelli del 1865. Come ci si arrivò? Diverse
opzioni, pure teoricamente possibili, furono scartate : così, non si rinunciò
ad un diritto codificato, ché tale esperienza durava in Italia da ormai un
cinquantennio ; né si sceglierà come codice unitario – opzione politicamente
impraticabile - uno dei codici ancora in vigore negli stati preunitari ( é noto
che Federico Sclopis, già protagonista della codificazione piemontese, aveva
proposto, con grande imparzialità di scegliere il codice napoletano!), o
addirittura lo “straniero” Code Napoléon. Scartata fu anche, dopo poco tempo,
una delle ipotesi più “solide”, consistente nell’estendere il codice civile
piemontese del 1837 al resto del territorio italiano. Il codice piemontese fu
esteso unicamente alle province pontificie conquistate e annesse nel 1860
(Romagna, Marche, Umbria), visto il vuoto legislativo che colà esisteva, ma fu
una mera soluzione transitoria in attesa di un codice unico, poiché gli altri
territori poterono mantenere in vigore i codici preunitari. Man mano che i
rappresentanti dei territori annessi al nuovo regno confluirono poi a Torino e
cominciarono a partecipare alle discussioni su un codice unico, non
mancarono polemiche e dure prese di posizione contro l’eccessiva
“piemontesizzazione”, per cui si paventava – e alla fine si rintuzzò – il
pericolo di un’estensione ipso facto del codice piemontese.
I progetti di codice civile unico, comunque, si succedettero alla Camera dei
deputati e al Senato (siti a Torino fino al trasferimento della capitale a Firenze
nel 1865), presentati volta a volta dai guardasigilli Cassinis, Miglietti, Pisanelli,
Vacca. La svolta si ebbe nel 1864, allorché, per accelerare i tempi, si ricorse
(per la prima volta nel neonato Regno d’Italia) allo strumento della leggedelega (é noto che tale metodo diverrà poi prassi; se ne ricorrerà
costantemente, dal Codice Zanardelli sino al recente codice di procedura
penale del 1989). In tal modo, promulgato nel gennaio del 1865, il Codice
civile (chiamato “Codice Pisanelli” dal nome dell’ex guardasigilli che ne fu
relatore in Parlamento) poté entrare in vigore il 1° gennaio 1866. Nel
frattempo, erano entrati in vigore la legge sull’unificazione legislativa (2
aprile 1865) e, nello stesso anno, il nuovo codice di commercio, modellato su
quello piemontese del 1842.
Tecnicamente, il Codice Pisanelli riecheggia immediatamente l’archetipo del
Code Napoléon (che a sua volta ha però alla base, lo ripetiamo, lo schema
romanistico della tripartizione in personae, res et actiones). Comunque sia,
all’epoca non si mancherà di evidenziare che la derivazione del nuovo Codice
dal modello napoleonico nasceva da una “adesione” di entrambi allo schema
romanistico, presentato da una parte non trascurabile della nostra
pubblicistica come “diritto patrio”, di tradizione cioé schiettamente italiana).
L’opera é divisa in tre libri, dedicati rispettivamente alle persone (libro primo),
ai beni e alla proprietà (libro secondo) e ai modi di trasmissione dei beni,
della proprietà e degli altri diritti (libro terzo). Anche nel Codice Pisanelli,
infatti, la proprietà, diritto assoluto, ha sicuramente un ruolo da protagonista ;
e purtuttavia, qualcosa si riesce ad innovare anche rispetto al Code francese: ad
esempio, si introduce il concetto di proprietà intellettuale, e si disciplina la
trascrizione a garanzia della certezza del diritto nei trasferimenti immobiliari.
In tema di diritto di famiglia, il Codice Pisanelli innova rispetto alle scelte
eccessivamente retrive di taluni codici preunitari. Il Bonini ha osservato che
esso si colloca “a mezza via fra i principi più avanzati del Code Napoléon e i ritorni
all’”indietro registratisi all’epoca della Restaurazione”. Così, il divorzio non vi é
introdotto. In omaggio però al principio, liberale e cavouriano, della
separazione tra Stato e chiesa, vi trova spazio (e nasce così nell’Italia unita)
una compiuta disciplina del matrimonio laico civile, totalmente slegato e
affrancato da qualsiasi ipoteca religiosa (si tenga presente, d’altronde, che
spesso nella storia dell’Italia liberale l’opposizione al divorzio fu giustificata
adducendo una maggiore tutela per la donna, in una società in cui il lavoro
femminile oltre le mura domestiche non era certo ancora moneta corrente).
Non fu soppressa l’autorizzazione maritale (presente nel Code francese, ma
assente nell’ABGB austriaco e quindi, fino ad allora, anche in Lombardia e
Veneto), ma (novità assoluta) fu riconosciuta alla donna una
compartecipazione alla patria potestà, seppure in subordine al marito o in
caso di sua impossibilità ad esercitarla. La comunione dei beni di napoleonica
memoria fu rigettata, e si mantenne l’istituto romanistico tradizionale della
dote già presente nei codici preunitari. La patria potestà, infine, fu temperata
da talune norme innovative : fu bandita ad esempio (e mai più ripristinata in
Italia) la diseredazione, e semplificata la procedura per ottenere il consenso
paterno al matrimonio.
Si deve infine all’iniziativa di Pasquale Stanislao Mancini (eminente studioso
di diritto internazionale nonché uomo politico della Sinistra) l’articolo che
disponeva la parificazione dello straniero al cittadino quanto al godimento dei
diritti civili.
All’adozione del Codice Pisanelli – che sarebbe quindi banale e riduttivo
considerare una mera imitazione del Code, viste le novità apportate - seguirà
una relativa stasi nella riforma del diritto civile italiano, quasi che la civilistica
si reputasse paga del risultato raggiunto. La prima modifica avvenne nel 1877,
con la legge che aboliva l’arresto per debiti (mentre la diffusa piaga dell’usura,
cadute ormai le norme di derivazione canonistica accolte spesso nei codici
preunitari e sancita la libertà dei tassi di interesse come corollario della libertà
negoziale, non trovava più una sanzione specifica se non nella classica norma
sulla rescissone dei contratti per lesione ultra dimidium). In seguito, non
mancheranno – soprattutto - progetti di legge sul divorzio, presentati con
cadenza quasi regolare ma mai coronati da successo, e, dagli anni Ottanta
dell’Ottocento, si acuirà la critica “sociale” ad un codice che sarà ormai
accusato di ignorare, con la sua “divinizzazione” della proprietà, l’emergere
dirompente della “questione sociale”.
Occorrerà attendere la fine della prima guerra mondiale – in un contesto
politico-sociale totalmente mutato, caratterizzato da una mutata sensibilità
per la “questione sociale”, dallo sviluppo di norme sul c.d. “welfare” e
dall’irruzione delle “masse” nella vita politica, preludio tuttavia al fascismo per assistere ai primi organici disegni di riforma del diritto civile, forieri della
preparazione di quel codice civile del 1942 che é tuttora il codice vigente in
Italia.