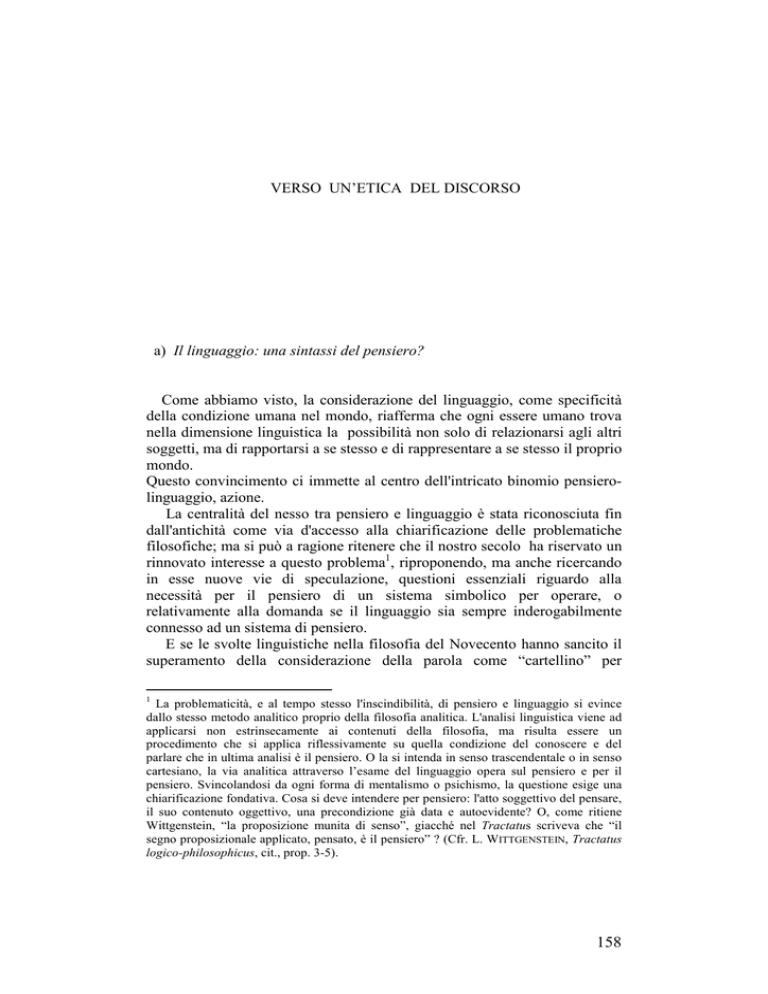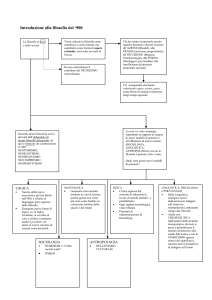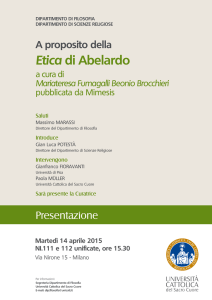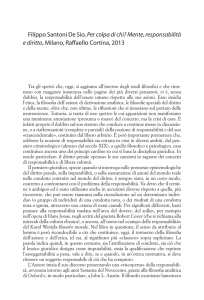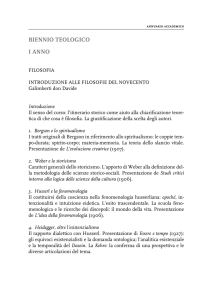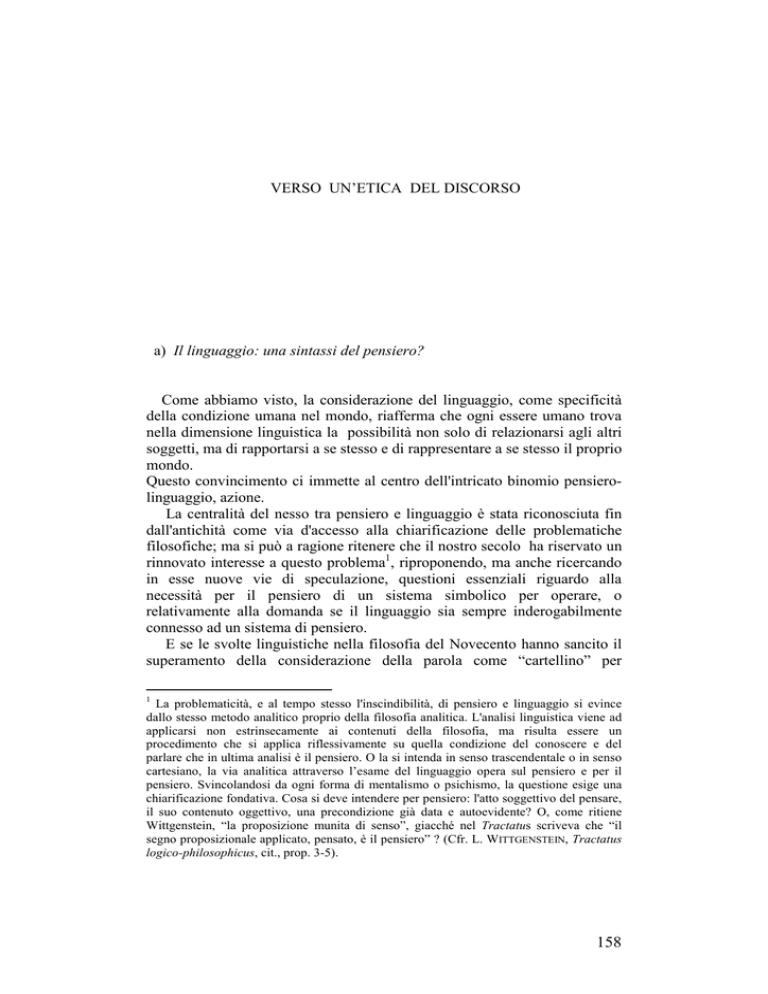
VERSO UN’ETICA DEL DISCORSO
a) Il linguaggio: una sintassi del pensiero?
Come abbiamo visto, la considerazione del linguaggio, come specificità
della condizione umana nel mondo, riafferma che ogni essere umano trova
nella dimensione linguistica la possibilità non solo di relazionarsi agli altri
soggetti, ma di rapportarsi a se stesso e di rappresentare a se stesso il proprio
mondo.
Questo convincimento ci immette al centro dell'intricato binomio pensierolinguaggio, azione.
La centralità del nesso tra pensiero e linguaggio è stata riconosciuta fin
dall'antichità come via d'accesso alla chiarificazione delle problematiche
filosofiche; ma si può a ragione ritenere che il nostro secolo ha riservato un
rinnovato interesse a questo problema1, riproponendo, ma anche ricercando
in esse nuove vie di speculazione, questioni essenziali riguardo alla
necessità per il pensiero di un sistema simbolico per operare, o
relativamente alla domanda se il linguaggio sia sempre inderogabilmente
connesso ad un sistema di pensiero.
E se le svolte linguistiche nella filosofia del Novecento hanno sancito il
superamento della considerazione della parola come “cartellino” per
1
La problematicità, e al tempo stesso l'inscindibilità, di pensiero e linguaggio si evince
dallo stesso metodo analitico proprio della filosofia analitica. L'analisi linguistica viene ad
applicarsi non estrinsecamente ai contenuti della filosofia, ma risulta essere un
procedimento che si applica riflessivamente su quella condizione del conoscere e del
parlare che in ultima analisi è il pensiero. O la si intenda in senso trascendentale o in senso
cartesiano, la via analitica attraverso l’esame del linguaggio opera sul pensiero e per il
pensiero. Svincolandosi da ogni forma di mentalismo o psichismo, la questione esige una
chiarificazione fondativa. Cosa si deve intendere per pensiero: l'atto soggettivo del pensare,
il suo contenuto oggettivo, una precondizione già data e autoevidente? O, come ritiene
Wittgenstein, “la proposizione munita di senso”, giacché nel Tractatus scriveva che “il
segno proposizionale applicato, pensato, è il pensiero” ? (Cfr. L. WITTGENSTEIN, Tractatus
logico-philosophicus, cit., prop. 3-5).
158
denominare oggetti, la parola è comunque da considerarsi l'etichetta di un
concetto2?
Il fatto che la parola non sia solo segno ma, come afferma Gadamer, già
sempre significato, ci ricollega alla convinzione che essa “ha in sé, in un
qualche modo enigmatico, un legame con ciò che essa ‘rappresenta’ ”, ma
non in un rapporto speculare con l’oggetto, bensì in un’implicazione
profonda con la rappresentazione e con il pensiero. Pertanto, “è una pura
astrazione immaginarsi il sistema della verità come un sistema di possibilità
tutto dispiegato, a cui dovrebbero essere conformati i segni che poi il
soggetto impiegherebbe per cogliere la realtà”3.
Ma non solo in ambito filosofico ci si è interessati dei rapporti tra
pensiero e linguaggio. Studiosi di aree scientifiche di varia natura hanno
insistito sulle implicazioni di tale relazione. Lo studio del linguaggio, sia da
prospettiva scientifica che filosofica, si è da sempre interrogato sulla
relazione esistente tra strutture del pensiero e sistema linguistico, attraverso
la problematizzazione di tale rapporto nei termini di un'indagine
sull'effettiva correlazione e l'eventuale priorità da riconoscere all'uno nei
confronti dell'altro.
La struttura logico-concettuale della proposizione non può ridursi alla
semplice emissione di suoni. Considerare il linguaggio come “lo stampo del
pensiero”4 vuol dire rilevare al suo interno una inscindibilità, non solo
funzionale ma strutturale, con i processi mentali.
Infatti Sapir ritiene che “il pensiero senza il linguaggio sia altrettanto
inconcepibile che il ragionamento matematico svolto senza il supporto di un
simbolismo matematico adeguato”5. Ed è illusorio pensare che si possa fare
a meno del linguaggio per qualsivoglia attività del pensiero, anche se la
consueta considerazione della lingua e la confusione che si determina tra
immagine e pensiero possono indurci a credere il contrario. “In effetti,
appena noi tentiamo di stabilire una consapevole relazione fra un'immagine
e l'altra, ci accorgiamo che stiamo scivolando in un flusso di parole
silenziose. Può essere che il pensiero sia un'area naturale separata dall'area
artificiale del linguaggio, tuttavia il linguaggio sembra essere l'unica via a
noi nota che conduce a questo dominio del pensiero”6.
2
Cfr. E. SAPIR, Il linguaggio, tr. it., Einaudi, Torino, 1969, p. 13.
H. G. GADAMER, Verità e metodo, cit., p. 478. In questo senso Gadamer intende
sottolineare che la parola non è un segno a cui si fa ricorso per un uso meramente
estrinseco, cioè qualcosa “che si fa o che si dà a qualcuno”, non può essere presa dal mondo
esterno e caricata dell’idealità del significato, che invece risiede nella parola stessa. (Cfr.
ivi, p. 479. Si veda anche il rapporto tra linguaggio e formazione del concetto, ivi, pp. 490502).
4
E. SAPIR, op. cit., p. 21.
5
Ivi, p. 15.
6
Ibidem. Secondo Sapir piuttosto che ritenere la lingua un “ornamento” di cui il pensiero
potrebbe anche fare a meno nel momento in cui non è implicata alcuna esigenza
comunicativa ed intersoggettiva, ma solo “interna” alla coscienza e ai processi psichici,
3
159
Studiosi come Chase o Peirce sono convinti che parlare sia un
processo del pensiero e che il pensiero segua le tracce del linguaggio nel suo
incidere sulla realtà e nel suo essere organizzato in funzione di questa7. Ed
anche Chomsky afferma l’esistenza di una struttura profonda che lega la
natura stessa del linguaggio all’intenzionalità del pensiero8. Vygotsky, dal
canto suo, sostiene che il linguaggio porta alla luce il pensiero che, nella
sua essenza profonda, è espressione e intenzionalità del significare9. Gli
studi condotti da Sapir e Whorf, e soprattutto la loro teoria del relativismo
linguistico, come è ben noto, sostengono la capacità del linguaggio di
modellare il nostro modo di concepire la realtà, e pertanto ogni linguaggio è
un modo di disegnare e concepire un mondo differente o un differente modo
di concepire il mondo10.
Partendo, dunque, dalla reciproca implicazione tra processi cognitivi e
categorie linguistiche, se è vero che pensare vuol dire leggere e ordinare il
mondo in un certo "ordine" di significati e di simboli, il rapporto
linguaggio-visione del mondo risulta essere pienamente ascrivibile alla
riconsiderazione dell'analisi linguistica come metodo di indagine e
chiarificazione logica dei processi conoscitivi. Se infatti il mondo reale
viene costruito sulle abitudini linguistiche del soggetto e della collettività, la
lingua può essere considerata uno speciale come del pensiero, e il
linguaggio si configura, per cosi dire, come sintassi dei processi mentali11.
Questa linea interpretativa si viene ad affermare con la progressiva
maturazione della svolta pragmatica del pensiero analitico, in cui vengono
definitivamente superati sia il presupposto neopositivistico di una
formalizzazione linguistica, come pure il processo di svuotamento di ogni
intenzionalità comunicativa che in quel paradigma era insito.
Va comunque riservato un inciso preliminare alla stessa nozione di
“filosofia analitica” per l'aspetto composito che questo movimento
bisognerebbe provare a pensarla come “una strada o un binario già ben preparato”, di cui il
pensiero si serve, ma il cui prodotto “cresce insieme con lo strumento” (ivi, p. 15). E spiega
ancora Sapir: “La lingua può essere considerata come uno strumento che può essere usato
per tutta una serie di usi diversi sul piano psicologico. Essa non soltanto fluisce
parallelamente al movimento interno della coscienza, ma, restando parallelo, si muove a
livelli diversi, che vanno dalla cognizione in cui la mente è tutta occupata da immagini
particolari, fino alla condizione in cui la mente è interamente concentrata su concetti astratti
e sulle loro relazioni: quest'ultimo modo di attività è quello che si intende di solito quando
si parla di ragionare” (ivi, p. 14).
7
Cfr. S. CHASE, Il potere delle parole, tr. it., Bompiani, Milano, 1966; e C. S. PEIRCE,
Collected Papers, a cura di C. Harteshorne, Harward University, 1931-1936.
8
Cfr. N. CHOMSKY, Saggi linguistici, vol. 3, Filosofia del linguaggio: ricerche teoriche e
storiche, tr. it., Boringhieri, Torino, 1969.
9
Cfr. L. S. VYGOTSKY, Pensiero e linguaggio, tr. it., La Nuova Italia, Firenze, 1966.
10
Cfr. B. L. WHORF, Linguaggio, pensiero e realtà, tr. it., Boringhieri, Torino, 1970.
11
Cfr. M. BALDINI - D. ANTISERI, Lezioni di filosofia del linguaggio, Nardini, Firenze,
1989.
160
filosofico presenta12. La filosofia analitica, nel suo carattere peculiare di
approccio ai problemi filosofici, opera con una metodologia, condivisa da
tutti gli appartenenti, che presenta l’indagine filosofica come “chiarificatrice
o riformatrice”, facendo dell’analisi la chiarificazione logica dei processi
linguistici per penetrare all'interno dei processi mentali13. Questo significa
più esattamente “trasformare le tradizionali questioni filosofiche in
questioni sul senso (da descrivere o da riformare) degli enunciati che
valgono ad esprimerle”14.
Dunque la “rivoluzione”15a cui si assiste ad opera del movimento analitico
12
È noto che con tale termine si fa riferimento ad un numeroso gruppo di filosofi che, a
cominciare dal 1892, anno in cui G. Frege pubblica Senso e denotazione, si estende ed
abbraccia posizioni teoriche di varia matrice epistemica. Tralasceremo la fase iniziale
rappresentata dalle teorie di Russel e Moore e da quelle note come positivismo logico,
centrate su un'impostazione epistemologica dello statuto del linguaggio e avvicinate alle
teorie contenute nel Tractatus logico-philosophicus di L. Wittgenstein. Ci riferiremo,
invece, a quella fase successiva che determina una cambiamento di direzione degli studi sul
linguaggio, rivelandone la portata contestualmente sociale e intenzionale, nota come
movimento analitico anglosassone e statunitense, che viene ad affermarsi soprattutto a
partire dagli anni Quaranta in poi, anche se il momento di passaggio alla nuova prospettiva
viene emblematicamente considerato il ritorno di Wittgenstein a Cambridge nel 1929 e la
stesura delle Ricerche filosofiche. Per comprendere il senso della svolta analitica bisogna
tener conto del fatto che si viene a determinare quasi un dualismo teorico tra
neopositivismo logico e filosofia analitica anglosassone: da un lato le tesi relative alla
delineazione di un modello linguistico quale quello scientifico, dall'altro la rilevanza del
linguaggio comune con il quale, nel contesto quotidiano, ci si trova a svolgere una
molteplicità di operazioni o attività, che corrispondono a quelle famose “forme di vita” di
cui ci parla Wittgenstein nelle Ricerche. Si vedano in proposito, M. DUMMET, Alle origini
della filosofia analitica, tr. it., Il Mulino, Bologna, 1990; e E. TUGENDHAT, Introduzione
alla filosofia analitica, tr. it., Marietti, Genova, 1989.
13
Il processo di analisi può esser pensato come una scomposizione o smontaggio ed una
esplicitazione del materiale linguistico, arrivando ad operare un risultato non lontano da
quello ottenuto dalle tecniche di interpretazione proprie della filosofia ermeneutica, tanto da
far risultare evidente, per alcuni aspetti, un avvicinamento della filosofia analitica
all'ermeneutica. La filosofia analitica, in qualità di filosofia linguistica per eccellenza dei
primi decenni del secolo, è dunque una filosofia “centrata sull'analisi (o sul problema
dell'analisi)” in cui “si conferisce un particolare ruolo esemplificativo alla filosofia “pura”,
ossia impegnata in riflessioni sulla natura e i compiti del pensiero, del linguaggio, della
logica, e sulla natura e i compiti della filosofia stessa” (F. D'Agostini, Filosofia analitica,
Paravia, Torino, 1997, cit. p. 13).
14
V. VILLA, Sulla nozione di “filosofia analitica”, in M. JORI (a cura di), Ermeneutica e
filosofia analitica. Due concezioni del diritto a confronto, cit., p. 171. Ma cos'è che l'analisi
analizza e come procede nella sua operazione chiarificatoria? L’analisi di cui si occupano i
filosofi a Cambridge e ad Oxford si concentra sullo studio del funzionamento del
linguaggio ordinario, cioè come è in uso quotidianamente, e non più di un linguaggio ideale
o protocollare come accadeva nel Circolo di Vienna. Il metodo analitico deve partire da ciò
che abbiamo sottomano nelle esperienze linguistiche di ogni giorno, ed è dunque un'analisi
delle proposizioni come esse sono e non come dovrebbero essere.
15
Si veda il volume curato da A AYER, La svolta linguistica in filosofia, tr. it., Città
Nuova, Roma, 1975; cfr anche R. RORTY, The Linguist Turn, University of Chicago Press,
Chicago, 1968.
161
è da intendersi come una rinnovata consapevolezza della specificità
linguistica di ogni esperienza umana e dello stesso filosofare: la filosofia
deve prendere coscienza che alcuni errori concettuali sono in realtà usi
impropri e fuorvianti del linguaggio, il cui arbitrio semantico ha trattato
categorie gnoseologiche o metafisiche come fossero oggetti o dati
fenomenici, essendo quelle invece irriducibili alla sfera empirico-fattuale ed
esigendo una differenziazione, e non già una gerarchizzazione, tra piani
semantici e logico-simbolici16.
La scelta metodologica dell’analisi linguistica rimanda, tuttavia, ad una
sua giustificazione filosofica ulteriore: bisogna risalire alle ragioni del
risolversi dei problemi filosofici in problemi di linguaggio. Assumere quella
che Villa indica come una definizione “forte” di filosofia analitica porta a
trovare la sua caratterizzazione unitaria nell’assunzione di alcuni “postulati
filosofici” fondamentali, quali la grande divisione fra linguaggio descrittivo
e linguaggio prescrittivo, la dicotomia analitico-sintetico, la distinzione tra
metalinguaggio e linguaggio-oggetto, la distinzione tra contesto di
giustificazione e contesto di scoperta. Considerare questi assunti come i
“nodi tematici fondamentali da cui questo movimento non può prescindere”
dovrebbe indurre a rilevare che “l’attenzione nei confronti del linguaggio
rappresenta un carattere derivato della filosofia analitica”17.
Ma a ben guardare anche questa via definitoria secondo Villa è
insoddisfacente, poiché sembra sbilanciare troppo la definizione sul piano
delle concezioni più che su quello dei concetti, finendo per identificare la
parte con il tutto. Bisogna, dunque, individuare un concetto che abbia
costituito il comune presupposto per lo sviluppo di concezioni
metodologiche e sostanziali diverse; questo può forse essere reperito,
secondo l’indicazione di Dummet, in “certe presupposizioni di fondo”.
L’assioma di fondo, che caratterizzerebbe la filosofia analitica, è il rapporto
di stretta connessione tra pensiero e linguaggio, intendendo quest’ultimo
“come il veicolo necessario del pensiero” e convergendo sulla convinzione
che ogni analisi del pensiero passa attraverso l’analisi del linguaggio18.
16
Si delinea, infatti, anche una svolta cognitiva del movimento analitico, che mira appunto
ad evidenziare che la correlazione tra processi mentali e strutture linguistiche forma una
indissolubile triangolazione con l'esperienza che l'uomo ha del suo mondo e della realtà in
cui vive. Lo stesso esercizio del pensiero, di cui disponiamo per riflettere sui suoi contenuti
e mezzi espressivi, è operazione metacognitiva e metalinguistica al tempo stesso. (Cfr. D.
MARCONI, Semantica cognitiva, in M. SANTAMBROGIO (a cura di), Laterza, Roma-Bari,
1992; si veda anche R. JACKENDOFF, Semantics and Cognition, Cambridge, MIT Press,
1983).
17
V. VILLA, Sulla nozione di “filosofia analitica”, cit., pp. 172-173.
18
Ivi, p. 175. “Si ha qui, pertanto, forse il primo esempio di quello che è, per la filosofia
analitica, il modo di trattare i problemi filosofici: quello che consiste nel trasformarli da
problemi ontologici a problemi di significato” (ivi, p. 176). Cfr. M. DUMMET, Truth and
Other Enigmas, tr. it. parziale, Il Saggiatore, Milano, 1986.
162
Possiamo considerare le Ricerche filosofiche l’opera meglio
rappresentativa della svolta analitica, ma il valore delle posizioni assunte da
Wittgenstein si può cogliere ancor meglio se si tiene conto del confronto
con le precedenti tesi del Tractatus19.
Nella Prefazione a quest'opera, Wittgenstein afferma chiaramente di
volersi occupare dei problemi filosofici entrando dalla porta principale, cioè
del linguaggio, poiché essi si fondano sul fraintendimento della logica del
nostro parlare. E per operare in tal senso occorre “tracciare al pensiero un
limite”20 tra ciò che ha senso e ciò che non lo ha. Un limite linguistico,
dunque, che è circoscrizione delle facoltà del pensiero e della ragione, definizione della limitatezza del dicibile e della concepibilità del reale
attraverso le parole21. In questa prospettiva, la relazione mondo-linguaggiopensiero veniva ad articolarsi in una reciproca corrispondenza lineare e
descrittiva: con le proposizioni possiamo sensatamente e chiaramente
descrivere uno stato di cose e questo è l'ambito entro il quale il pensiero può
muoversi e applicarsi con chiarezza ed evidenza.
Dunque il compito del filosofo è, già dalle tesi del Tractatus, la
chiarificazione dei concetti, ma nel senso proprio di una loro delimitazione
entro l’ambito scientifico: soltanto definendo l'indicibile e l'impensabile, la
filosofia potrà mostrare ciò che è pensabile e dicibile22.
19
La scintilla che diede inizio ad un ripensamento delle tesi del Tractatus, dopo una pausa
di circa dieci anni, di cui sei dedicati com’è noto all’insegnamento elementare, fu
determinata da una conferenza tenuta da L. E. J. Brouwer a Vienna nel 1928. Wittgenstein,
assistendo a quella lezione sui fondamenti dell'aritmetica, rimase colpito perché si rese
conto che venivano rimesse in discussione alcuni assunti fondamentali del Tractatus. Come
riferisce M. Trinchero nella nota introduttiva all'edizione italiana delle Ricerche filosofiche,
“l’influenza di Brouwer è evidente, oltre che nella scelta dei temi, nell'abbandono della
concezione della logica come linguaggio “fenomenologico” o “primario” e nel
riconoscimento che i linguaggi costituiscono una classe, la cui descrizione è il compito
essenziale della filosofia” (M. TRINCHERO, Introduzione, in L. WITTGENSTEIN, Ricerche
filosofiche, cit., p. XI). Ma il passaggio decisivo per la maturazione della teoria dei giochi
linguistici delle Ricerche ed il definitivo distacco dal linguaggio del Tractatus si può
cogliere nell'opera Blue Book and Brown Book, tr. it., Torino, Einaudi, 1983. Qui
Wittgenstein comincia a tratteggiare il concetto di “gioco linguistico”, che verrà poi
sviluppato compiutamente e costituirà la chiave di volta di una nuova e più feconda
concezione non solo del linguaggio, ma dell’agire dell'uomo in un mondo non più solo di
fatti, bensì di relazioni e rapporti linguistici.
20
L. WITTGENSTEIN, Tractatus, cit., p. 3.
21
Se, infatti, il linguaggio costituisce un limite al pensiero, quest'ultimo non potrà spingersi
oltre ciò che può esprimersi con chiarezza. Per questo si arriva alla ormai nota esortazione
wittgensteiniana “su ciò di cui non si può parlare si deve tacere” (ivi, p. 82, prop. 7). Anche
altrove Wittgenstein dichiara che la tendenza umana è quella di avventarsi contro i limiti
del linguaggio21( L. WITTGENSTEIN, Lezioni e conversazioni di etica, religione, economia,
cit., pp. 21-22), e quando dal mondo dei fatti ci si spinge ad oltrepassare la referenza
empirica delle parole alle cose si producono solo non sensi.
22
Cfr. L. WITTGENSTEIN, Tractatus, cit., p. 28. In queste posizioni si ritrovano alcuni
caposaldi del neopositivismo, a cui il giovane Wittgenstein non aderì esplicitamente, ma
con cui condivise il valore del paradigma scientifico ed il rifiuto di quei cosiddetti
163
I suggerimenti di L. Wittgenstein nelle Ricerche filosofiche sono da
considerarsi determinanti: "la filosofia è la battaglia contro lo stregamento
del nostro intelletto per mezzo del nostro linguaggio"23. E se il metodo del
lavoro filosofico analitico è la chiarificazione logica attraverso l'analisi degli
enunciati, lo scopo è "indicare alla mosca la via d'uscita dalla bottiglia"24,
poiché i problemi filosofici non sono altro che problemi linguistici, cioè
sorti da un errato o non chiaro uso delle parole.
Il principio d'uso diventa così il criterio paradigmatico per definire il
senso di una parola come di un enunciato: le proposizioni hanno un
significato solo se hanno un'applicazione, poiché il "significato di una
parola è il suo uso nella lingua". Quindi cercare il modo in cui un termine
viene usato in uno specifico contesto di discorso implica trovare anche il
significato. In tal modo le espressioni linguistiche diventano delle ipotesiregole in funzione dell'orientamento dei comportamenti umani e della
strutturazione dei sistemi delle aspettative umane. Ciò implica che tutto il
problema della verità si lega non solo all’uso, cioè al contesto in cui viene
praticato il linguaggio, ma in modo determinante alle convenzioni che
regolano l’enunciato o il contesto di discorso, e dunque la totalità del senso
è data dalla sua operatività nelle situazioni di interlocuzione, cioè nel tessuto
enunciativo intersoggettivo. La forza illocutoria degli atti linguistici diventa
così il tema centrale della comunicazione, e quella dualità tra soggetto
conoscente e oggetto conosciuto diventa accordo delle intenzioni o scontro
delle pretese dei parlanti.
La battaglia per la chiarificazione logica del linguaggio si risolve in una
battaglia per la chiarezza linguistica, convinzione che comunque aveva
caratterizzato anche le tesi del Tractatus ma con sviluppi differenti. In
effetti ora questa considerazione consente di guardare alle parole come pezzi
degli scacchi25, e il linguaggio può essere pensato come una cassetta di
attrezzi da cui, a seconda della funzione e del valore, ognuno tira fuori lo
strumento linguistico più adatto per i diversi contesti di applicazione.
Pensare quindi al linguaggio, nella molteplicità di funzioni che può
pseudoproblemi sorti perché il linguaggio, al di fuori dell'ambito scientifico, perde i
requisiti di precisione e chiarezza, e si spinge verso “oscure lontananze e profondità
impenetrabili” che nulla hanno a che vedere con una concezione scientifica del mondo.
(Cfr. H. HAHN, R. CARNAP, O. NEURATH, La concezione scientifica del mondo, tr. it.,
Laterza, Bari, 1979, p. 74). Si veda inoltre cosa scrive Carnap riguardo la sostituzione di
ogni metafisica, “poesia concettuale”, con una metodologia filosofica strettamente
scientifica: quei concetti “che sono irriducibili sia al dato, sia a ciò che è fisico”, sono
concetti “ puramente illusori che vanno rigettati dal punto di vista epistemologico, come
pure da quello scientifico. Sono parole senza senso, qualunque sia il grado in cui sono
santificate dalla tradizione e impregnate di sentimento” (ivi, p. 90); cfr. ID., Meaning
Postulates, in “Philosophical Studies”, 1952, pp. 65-73.
23
L. WITTGENSTEIN, Ricerche filosofiche, cit., par. 109.
24
Ivi, par. 309.
25
Ivi, par. 108, p. 66.
164
assolvere nei vari contesti di discorso, mette in evidenza, in modo molto
plastico, che parlare un linguaggio fa parte di un'attività o forma di vita26, e
che l'esperienza umana nel mondo e del mondo comprende un'infinita
gamma di attività linguistiche27.
Ma in che senso e sotto quali aspetti la giocabilità degli enunciati apre la
strada ad una “svolta” in senso pragmatico?
Habermas si sofferma sulla relazione tra gioco linguistico e regola
linguistica. Quando Wittgenstein invita a vedere ogni attività linguistica
come gioco in cui i partecipanti, nell’atto di linguaggio, interagiscono
seguendo le stesse regole linguistiche, “svolge la prova che l’identità dei
significati dipende logicamente dalla capacità di seguire regole valide
intersoggettivamente insieme ad almeno un altro soggetto; laddove entrambi
devono disporre della competenza sia al comportamento guidato da una
regola sia al giudizio critico su questo comportamento”28.
In questa elaborazione del concetto di gioco, il senso intenzionale
dell’agire è da concepire nel modo di funzionare del linguaggio in cui, come
scrive lo stesso Wittgenstein, intenzione e adempimento si toccano29.
Comprendere il senso di un’intenzione significa comprendere il ruolo di un
enunciato in un sistema linguistico. Infatti, ciò che interessa a Wittgenstein,
secondo la ricostruzione di Habermas, non è tanto sottolineare la
dimensione propriamente linguistica delle regole, quanto la loro dimensione
pragmatica: il concetto di “grammatica” del gioco linguistico non va quindi
confuso con il riferimento alla grammatica della lingua30. Pensiamo
piuttosto che “la stessa forma di vita comunicativa è dipendente dalla
grammatica dei giochi linguistici”31. Inoltre, consideriamo che la
regolamentazione linguistica è anche una de-limitazione della
partecipazione alla prassi sociale. Nella rielaborazione apeliana tale
delimitazione dell’agire attraverso le regole del dire rimanda infatti alla
finitezza del vivere intersoggettivo32.
26
Ivi, p. 7, par. 19.
"Comandare, Descrivere un oggetto, Costruire un oggetto, Riferire un avvenimento, Far
congetture, Recitare in teatro, Cantare, Sciogliere indovinelli” (ivi, par. 23, p. 21). Vi è
infatti una varietà di "giochi" quante sono le funzioni e i modi di funzionare del linguaggio,
o potremmo dire dei linguaggi, di cui è intrisa ogni esistenza umana. Inoltre, il concetto di
gioco linguistico presuppone il fatto che il linguaggio non è dato una volta per tutte, ma
nuovi tipi di linguaggio, nuovi "giochi linguistici" sorgono, altri invecchiano e vengono
dimenticati. Cfr. ivi, par. 7, 21, 22, 23.
28
J. HABERMAS, Gioco linguistico, intenzione e significato, in. S. CREMASCHI (a cura di),
Filosofia analitica e filosofia continentale, La Nuova Italia, Firenze, 1997, p. 87.
29
Cfr. L. WITTGENSTEIN, Ricerche filosofiche, cit., p. 172.
30
Cfr. ivi, p. 90. Cfr. anche L. WITTGENSTEIN, Grammatica filosofica, tr. it., La Nuova
Italia, Firenze, parte I, par. 115.
31
Ivi, p. 102.
32
Il mondo oggettivo si costituisce in strutture linguistiche che sono essenzialmente
dialogiche e, in senso lato, sociali. I giochi di Wittgenstein, nell’incontro con la comunità
illimitata dei ricercatori di Peirce, fecondano l’idea della comunità illimitata della
27
165
Tuttavia, la valenza pragmatica dei giochi wittgensteiniani è da
considerarsi,
secondo
l’interpretazione
apeliana,
prettamente
comportamentista o pragmatistico-behavioristica. Se, infatti, il compito del
filosofo è quello di descrivere il funzionamento dei vari giochi e delle regole
che consentono agli uomini di prender parte alla loro giocabilità, non si
tiene conto però che tali giochi, se considerati come dati oggettivi, vengono
ad essere concepiti atomisticamente e non in relazione di interazione
reciproca; inoltre, se non si ammette la cogenza di un gioco linguistico
trascendentale, cade anche la possibilità di descrivere il funzionamento
delle attività di linguaggio, dal momento che viene meno il riconoscimento
di una regola trascendentale che imponga il rispetto delle regole dei giochi
stessi33. Sembra quasi che la filosofia per Wittgenstein deve riconoscere
solo “che i suoi problemi segnalano l’interrompersi del gioco”e in questa
logica “il senso del linguaggio non consiste in nient’altro che nella prassi
vivente dell’uso linguistico”34.
Ma la descrizione della prassi linguistica non è di per sé comprensione
del comportamento umano che in essa si estrinseca. In Wittgenstein, infatti,
non “pervengono al linguaggio né l’intimo impulso di ogni gioco linguistico
all’autoriflessione, impulso che rende possibile ogni traduzione e ogni
interpretazione da parte delle scienze dello spirito, né la continuità,
condizionata proprio da ciò, di un colloquio umano capace di connettere
tutti i giochi linguistici”35.
L’influsso della teoria dei giochi e del significato situazionale sul
pensiero di Austin è notevole36.
comunicazione come gioco linguistico trascendentale. Come rileva Vattimo, l’attributo di
trascendentale non appartiene alla teorizzazione di Wittgenstein, ma il concetto del
linguaggio come “giochi linguistici” sancisce un’accentuazione pragmatica nel senso che,
studiando il funzionamento effettivo del linguaggio nei vari contesti di vita, si possono
riconoscere in esso le regole di comportamento dei partecipanti ai vari “giochi”
dell’esistere, ognuno dei quali, nel proprio ambito di significazione, ha legittimità.
33
Cfr. G. VATTIMO, Introduzione, in K.O. APEL, Comunità e comunicazione, cit., p.
XXVII.
34
R. BUBNER, Azione, linguaggio e ragione, cit. pp. 142-143.
35
K. O. APEL, Comunità e comunicazione, cit., p. 41.
36
Come per Wittgenstein il linguaggio, in particolare quello della filosofia, è il grande
malato e i suoi ingranaggi girano a vuoto necessitando una terapia, anche per Austin tale
pratica terapeutica ha il suo fine nel raggiungimento, attraverso la descrizione dei nostri
crampi mentali, di una chiarezza completa. Così il compito del filosofo è quello di isolare e
descrivere le strutture logiche delle diverse forme di enunciati secondo le loro funzioni. Per
operare in questa direzione è necessario però rimuovere l’errore perpetrato dalla tradizione
filosofica occidentale della fallacia descrittivistica, che consiste nel considerare lo
strumento linguistico nella sola funzione descrittivo-referenziale, inquinando, per così dire,
il modo di studiare la struttura del linguaggio e i suoi processi di significazione, e
favorendo una lunga serie di interpretazioni restrittive e fuorvianti del fenomeno linguistico
166
Il passaggio da un'analisi degli enunciati alla famosa teoria degli atti
linguistici, anche se una vera e propria teoria degli atti linguistici è forse da
ricondurre solo a J. Searle37, rivela il percorso di un’analisi del linguaggio
sempre più nel senso di un’accentuazione pragmatica. Un'attività linguistica
non solo ricorre a certe regole per poter esprimere contenuti o messaggi; ma
tali regole, come sintassi linguistica del pensiero, della coscienza e
dell'intenzionalità del soggetto, strutturano l'azione dell'uomo, la rendono
condivisibile, e ne definiscono il senso, la direzione, l'incontro relazionale
con altri soggetti38.
Austin, prima con la distinzione tra performativo e constativo39, poi
con le sue indicazioni per una teoria degli atti linguistici40, ci lascia una
e delle sue applicazioni. (Cfr. A. PIERETTI, Il linguaggio come comunicazione, Città
Nuova, Roma, 1978, p. 26).
37
Cfr. J. R. SEARLE, Atti linguistici, tr. it., Boringhieri, Torino, 1976. “Credo che sia
essenziale - afferma infatti Searle - per ogni comunicazione linguistica contenere un atto
linguistico. L'unità della comunicazione linguistica non è, come è stato generalmente
supposto, il simbolo, la parola, la frase o anche l'enunciato del simbolo, della parola o della
frase, ma è piuttosto la produzione dell'enunciato nell'esecuzione dell'atto linguistico che
costituisce l'unità fondamentale della comunicazione linguistica. Più precisamente, la
produzione dell'enunciato della frase sotto certe condizioni costituisce l'atto allocativo, e
l'atto allocativo è l'unità minima della comunicazione linguistica.(...) Eseguire degli atti
allocativi significa impegnarsi in una forma di comportamento governata da regole.
Sosterrò che fatti come il porre delle domande e il fare delle asserzioni sono governati da
regole in una maniera abbastanza simile a quella in cui fare una base nel baseball o
muovere un cavallo negli scacchi sono tipi di atti governati da regole” (J. R. SEARLE, Che
cos’è un atto linguistico, in P. P. GIGLIOLI, (a cura di), Linguaggio e società, Il Mulino,
Bologna, 1973, p. 90).
38
Così Searle: “Io distinguo due tipi di regole: alcune regolano forme di comportamento
preesistenti, come ad esempio le regole di etichetta che regolano le relazioni interpersonali;
tuttavia queste relazioni esistono indipendentemente dalle regole di etichetta. Vi sono
invece altre regole che non regolano soltanto, ma creano e definiscono nuove forme di
comportamento. Le regole del rugby, ad esempio, non servono soltanto per regolare il gioco
del rugby ma rendono possibile, o definiscono, tale attività. L'attività del gioco del rugby è
costituita dall'azione effettuata secondo tali regole; il rugby non esiste senza queste regole.
Chiamerò questo tipo di regole costitutive (constitutive rules) e il primo tipo di regole
normative (regulative rules)” ( ivi, p. 91).
39
E proprio dall'analisi del linguaggio ordinario, il filosofo inglese opera una prima
divisione tra enunciati constativi e performativi. I primi rispondono alla funzione
descrittiva, i secondi sono quegli enunciati con cui piuttosto che dire qualcosa, facciamo
qualcosa, e troviamo infatti in essi il ricorso a verbi come “promettere”, “giurare”,
“scusarsi”, “scommettere, e simili. Usare questi verbi sotto determinate condizioni significa
espletare un atto umano carico di conseguenze morali, economiche, giuridiche, e via
dicendo; per cui ampie zone del linguaggio giuridico, religioso, morale, sono performative.
40
In How to Do Things with Words troviamo la nozione di atto linguistico, secondo cui
dire qualcosa implica sempre fare qualcosa. Una locuzione è, infatti, propriamente un atto
locutorio; e siccome dire qualcosa corrisponde a svolgere diverse operazioni, come
emettere suoni ed articolare parole che appartengono ad un lessico conosciuto conforme ad
una grammatica, ogni atto locutorio viene a sua volta ad essere suddiviso in un atto fonetico
167
singolare elaborazione della natura pragmatica del linguaggio ordinario, le
cui finalità non sono la mera locuzione, ma l'estrinsecazione di una forza,
che è diretta ad esercitare un cambiamento del comportamento di chi
ascolta41.
Tuttavia affermare che il linguaggio ordinario è la prima parola, ha
anche un significato che possiamo definire metodologico per ricondurre
l'analisi linguistica alla sua funzione comunicativa. Significa appunto
orientare l'attenzione prioritariamente sull'efficacia operativa dell'atto
linguistico, che non solo assolve una funzione pragmatica e sociale
nell'ambito delle occupazioni quotidiane dell'agire e dell'interagire umano,
ma lo configura come azione linguistica, come prassi comunicativa. Anche
in questo caso il reperimento di senso, attraverso e ancor più oltre la
definizione di significato, va effettuato nell'enunciazione e non nella parola
in generale avulsa dal contesto, fino a poterne definire la forza all'interno di
ogni atto linguistico come evento in cui la parola stessa si storicizza e si
temporalizza, caricandosi di intenzionalità.
Dunque gli enunciati per se stessi non sono né veri né falsi; verità e
falsità possono qualificarsi come tali in riferimento alla contestualizzazione
di una proposizione, anzi nel suo divenire contesto di comunicazione nel
momento stesso in cui è messa in opera42.
(emissione di suoni), fatico (proferire certi vocaboli appartenenti ad un lessico definito con
una certa costruzione grammaticale), e retico (dare un certo senso o riferimento
all'espressione). Ma accanto agli atti locutori, come abbiamo già detto, esistono quelli che
Austin chiama atti illocutori e perlocutori, che per il nostro discorso risultano di grande
rilevanza. Va detto che non è sempre chiara la distinzione tra atto illocutorio e perlocutorio,
e di questo fu consapevole lo stesso Austin. Si può dire comunque che l'illocuzione si
caratterizza per la forza impressa all'enunciato, e che invece la perlocuzione sottolinea
l'essere indotti a compiere un'azione. Va aggiunto che l'atto illocutorio, nonostante la sua
forza, non prevede necessariamente di avere degli effetti sull'uditorio; mentre 1'atto
perlocutorio comporta sempre delle conseguenze, sebbene i suoi effetti non siano sempre
facili da stabilire né da prevedere. (Cfr. J. AUSTIN, Come fare cose con le parole, tr. it.,
Marietti, Genova, 1974.)
41
La ormai nota differenziazione tra locuzione e forza illocutoria e perlocutoria vuole porre
1'accento sulle modalità concrete dell'uso del linguaggio come strumento di scambio delle
opinioni, di condivisione di progetti e impegni comuni. Attraverso ciò che si dice, e
soprattutto come lo si dice e a chi, si realizza una quantità di operazioni linguistiche, che
sono vere e proprie azioni, e che comportano o inducono altre azioni: di accettazione o
esclusione, di ripetizione o rimozione, di consenso o rifiuto, ecc. Certo non va dimenticato
che il concetto di forza delle proposizioni non può essere confuso con quello di significato.
Per questo lo stesso Austin si troverà a dover affrontare il problema relativo alla distinzione
tra livello discorsivo del linguaggio come poter fare, e livello metadiscorsivo come poter
significare. Il progetto austiniano incontrerà anche per questa divaricazione non poche
difficoltà nella risoluzione della dicotomia di fondo performativo-constativo. Si veda in
proposito, M. SBISA’ (a cura di), Gli atti linguistici. Aspetti e problemi della filosofia del
linguaggio, Feltrinelli, Milano, 1978; e di J. R. SEARLE (a cura di), Austin on Locutionary
and Illocutionary Acts, “The Philosophical Review” 77/4, 1968.
42
Austin definisce il suo metodo di indagine del fenomeno linguistico, pur con qualche
riserva, “fenomenologico, consistente cioè nell'osservare, descrivere e raccogliere,
168
Pertanto possiamo dire che la revisione dell’idea di linguaggio, sia nelle
Ricerche che nelle teorie degli atti linguistici, sembra restituire una parola
che si protende verso un tessuto intercomunicativo evocativo
dell’intenzionalità linguistica.
Ma sul logos in relazione al soggetto e ai suo tratti intersoggettivi,
Wittgenstein non pare fornire sostegni giustificativi. L’individuo risulta
quasi retrocedere rispetto alla valenza pragmatico-sociale della
comunicazione e del gioco dei “giochi” linguistici vari.
Dov’è il soggetto tra i soggetti, e come si muove nel gioco linguistico
che gli è proprio tra i tanti giochi dell'esistere? E se la soggettività è un
rapportarsi, qual è la coniugazione linguistica di questo rapporto?
La domanda pare a Wittgenstein superflua, o comunque non decisiva per
la connessione soggetto-linguaggio. A dire il vero è proprio questo innesto
che pare dissolversi nella mobilità pragmatica del linguaggio in azione
come forma di vita: non vi è discorso giocabile a partire dal soggetto, che
recupera la soggettività nella relazione pubblica del comunicare.
Si è affermato che l'uomo è un ente che si progetta. E si riconosce
progetto anche per quel poter significare e comunicare che dà senso alla sua
libertà come qualificazione ontologica43. In virtù di essa si dà la possibilità
della ricerca del posto dell'uomo situato nell’orizzonte finito dell'esistere,
che è sempre coesistenziale. “E’ in primo luogo e sempre nel linguaggio scrive Ricoeur - che viene ad esprimersi ogni comprensione ontica ed
ontologica”44. E’ dunque nel linguaggio stesso che bisogna cercare
l’indicazione secondo cui il comprendere è un modo di essere: ma di chi?
L'ermeneutica contemporanea richiama ad una visione della storicità
umana come dialogo nel conflitto delle interpretazioni45. E con il contributo
ordinandoli, tutti gli usi linguistici quotidiani, attraverso un'analisi che ne comprenda e
chiarisca la natura e la funzione, e soprattutto che consenta una sorta di disincantamento e
di liberazione da ciò che è illusorio e ingannevole. Come fa notare Pieretti, il carattere della
fenomenologia linguistica austiniana non è tuttavia empirico-descrittivo, come compete
piuttosto ad un approccio linguistico scientifico, bensì sempre collocato nell'area della
ricerca filosofica: lo scopo è la rimozione degli impedimenti semantici alla comprensione
ed esatta impostazione dei problemi filosofici stessi. Gli abusi linguistico-concettuali di cui
si è macchiata la filosofia occidentale, tra cui la già citata “fallacia descrittivistica”, hanno
implicato una erronea impostazione metafisica di tali problemi; pertanto lo scopo
dell'operazione austiniana mira “a porre le condizioni linguisticamente più idonee per
affrontarli senza pregiudizi, lontano dal rischio di incorrere in fraintendimenti” (A.
PIERETTI, Il linguaggio come comunicazione, cit., p. 52).
43
Il linguaggio in Heidegger è “l’espressione del discorso” ed il discorso è “linguaggio
esistenziale, perché l’ente di cui esso articola l’apertura in base a significati ha il modo di
essere dell’essere-nel-mondo, gettato e confinato nel < mondo>”( M. HEIDEGGER, Essere e
tempo, cit., p. 204).
44
P. RICOEUR, Il conflitto delle interpretazioni, tr. it., Jaca Book, Milano, 1986, p. 25.
45
L’idea di un conflitto delle interpretazioni in Ricoeur rimanda proprio al carattere di
apertura dell’universo dei segni proprio dell’interpretazione ermeneutica, diversamente da
169
di Gadamer viene accentuata la universalità strutturale del linguaggio (si
parla con lui di un’accentuazione linguistica in seno all'ermeneutica) come
struttura stessa dell'azione dell'uomo in quanto discorsività, e come
orizzonte intrascendibile della nostra esperienza del mondo e di ogni
movimento di conoscenza ermeneutica. L'universalità di quella conoscenza
consegue dal carattere di universalità attribuita all'esperienza linguistica in
virtù della sua ontologizzazione. E lo stesso problema della relazione
gnoseologica e della verità è da reperire all'interno di una situazione
linguistica che è orizzonte del comprendere e dell'agire. Nella circolarità del
comprendere ermeneutico si afferma inoltre quel carattere evenemenziale
del linguaggio: l’evento del linguaggio è la situazione discorsiva in cui si
attua la comprensione e l'intendersi.
Dunque, mentre nell’ottica analitica la proposizione è un segno che
rinvia a qualcos'altro da sé, il discorso per l’ermeneutica è prima di tutto un
evento oltre che sistema di segni, cioè una situazione conoscitiva
relazionale, all'interno della quale si deve cercare il controllo razionale della
comunicazione. Il carattere evenemenziale del linguaggio è connesso con
quelle coordinate ontologiche storico-temporali entro le quali, ed in virtù
delle quali, il soggetto si configura come Da-sein. La relazionalità
discorsiva, come circolarità del conoscere e del comprendere, ha sempre
luogo in una situazione di interlocuzione, in cui i soggetti impegnati
costruiscono contestualmente il suo senso, che non si trova già posto innanzi
ad essi.
Il rapporto soggetto-oggetto dell’interpretazione porta inoltre in primo
piano l’autonomia del testo rispetto al soggetto-interprete, invitando a
letture e interpretazioni molteplici. Ma poiché l’ermeneutica “deve puntare
al contenuto oggettuale di un testo che progetta un mondo”, la soggettività
viene quasi relegata più al ruolo di discepola che di padrona del testo e
“anziché essere il punto di partenza, la soggettività rappresenta la forza
realizzatrice
grazie
alla
quale
l’ermeneutica
conduce
all’autocomprensione”46.
In ogni caso, il linguaggio nell’ottica ermeneutica non è semplice
strumento espressivo, mero sistema convenzionale di segni oggettivanti, ma
è disvelamento di una determinata situazione storica, o di un mondo, come
quello spazio in cui gli interpreti partecipano ad un gioco linguistico
scommettendo con i loro pregiudizi, e lasciandosi giocare dal linguaggio
stesso, il quale si rivolge loro offrendosi e sottraendosi, ponendo domande e
ciò che accade nel campo della linguistica che è invece nell’ottica di una chiusura dell’
universo dei segni. Il carattere di apertura, in cui “la presa del linguaggio sull’essere e
dell’essere sul linguaggio, si attua in molti modi” e dà luogo a quella rivalità delle
interpretazioni come evento in cui il linguaggio ha incessantemente il potere di scoprire,
manifestare, portare alla luce l’equivocità dell’essere, o meglio, aprire la molteplicità del
senso sulla equivocità dell’essere ( ivi, pp. 80-82.)
46
J. BLEICHER, L’ermeneutica contemporanea, tr. it., Il Mulino, Bologna, 1986, p. 269.
170
dando risposte.
L'esperienza ermeneutica, infatti, rivela una chiara struttura dialettica, o
meglio dialogica: la logica ermeneutica si configura come logica di
domanda e risposta, dialogo dell'interprete con il testo. Così la
interpretazione di un testo consiste nel trovare la domanda a cui questo
fornisce la risposta e, contemporaneamente, il testo può essere oggetto di
interpretazione solo se rivolge una domanda all'interprete47. Senza
dimenticare che ciò che è oggetto di interpretazione è sempre e solo il
linguaggio, nel senso che ogni incontro con il mondo è sempre e solo
linguistico. Non si dà, infatti, esperienza del mondo prelinguistica o
extralinguistica, a cui la parola si aggiunga in un secondo momento come
mezzo convenzionale di comunicazione.
Dunque la dialettica di domanda e risposta mostra il comprendere
come dialogo. “L’attesa di una risposta presuppone già, dal canto suo, che
colui che domanda sia toccato e interpellato dalla tradizione. E’ questa la
verità della determinazione storica. Essa è la coscienza che ha esperienza
della storia; che, proprio nella misura in cui si rifiuta all’ideale fantomatico
di un completo illuminismo, è aperta a fare esperienza storica”48.
b) Le svolte linguistiche tra emancipazione e terapia.
L’analisi critica della società, come impegno di emancipazione dall’
ideologia, è al centro dell’interesse di quell’ermeneutica critica che,
attraverso i contributi di Habermas ed Apel, si pone anche il compito di
vagliare le possibilità di rifondazione della razionalità per un’etica della
comunicazione. Il percorso che conduce alla delineazione di questa proposta
di trasformazione della filosofia49, come intende propriamente Apel, si
delinea come uno dei progetti più stimolanti del pensiero filosofico del
nostro tempo, al cui interno confluiscono e si fondono gli sviluppi della
svolta linguistica
sia analitica che ermeneutica. L’interesse per
47
Cfr. H. G. GADAMER, Verità e metodo, cit., pp. 418-426 e 427-437. “L’orizzonte della
domanda” è propriamente l’orizzonte ermeneutico in cui si decide la “direzione
significativa del testo”. Pertanto la comprensione è un “risalire con il domandare al di là di
ciò che è detto. Deve comprendere il detto come risposta, in base alla domanda di cui
rappresenta la risposta. In questo risalire oltre il detto è però implicito un domandare al di
là di esso” (ivi, p. 427).
48
Ivi, p. 436.
49
Cfr. K. O. APEL, Transformation der Philosophie, Suhrkamp, Frankfurt, 1973, (
parzialmente tradotto col titolo Comunità e comunicazione, cit.).
171
l’emancipazione dell’uomo da ogni forma di dominio, che è il tratto
distintivo delle scienze sociali critiche, chiama in causa quella
“autoriflessione liberante il soggetto dalla dipendenza”, intesa come
reazione alla “distorsione esercitata sempre dall’azione repressiva
dell’autorità”50.
Ma ogni progetto emancipativo è anche il tentativo di restituire al soggetto
e alla comunità degli uomini la dignità della ragione e della libertà dell’
autodeterminazione. Tale tentativo, che ha anche il senso di una
riabilitazione dei fondamenti etici della prassi comunicativa, sbocca, in seno
ad un’area del pensiero ermeneutico contemporaneo, nella delineazione di
un’etica del discorso, che si propone come ricerca dei fondamenti di una
razionalità non più strumentale, ma discorsiva, in grado, almeno in linea di
principio, di porsi come garanzia di una normazione comunicativa che sia
regola di espressione reciproca di libertà di parola nella libertà dalla parola.
Quest’operazione, come dimostrano gli studi di Apel ed Habermas, si
rende possibile tenendo conto del confronto serrato tra razionalità analitica e
razionalità ermeneutica51, al fine di conferire a quest’ultima quei requisiti di
pragmaticità e trascendentalità messi in evidenza soprattutto dalle teorie del
secondo Wittgenstein, dalla introduzione del concetto di atti linguistici e
dalle tesi di Peirce, secondo quanto gli stessi autori dichiarano nei loro
scritti52.
In tal senso l’analisi delle regole interne alle forme di azione
comunicativa, che costituiscono la struttura, oltre che la forma, dell’
interazione sociale, è affrontata con la prospettiva di una via di
emancipazione dall’autorità e dall’ideologia, nel recupero di una
progettualità discorsiva e di una razionalità comunicativa che possano aprire
il ripensamento di una etica per la comunicazione.
Come abbiamo detto, per arrivare a comprendere il percorso che conduce
alla delineazione di questa istanza rifondativa ed emancipativa della prassi,
bisogna tener conto degli esiti del linguistic turn analitico ed ermeneutico.
Ciò consente di cogliere, all’interno di un confronto dialettico, gli elementi
delle due diverse proposte teoriche che, in linea di convergenza, conducono
50
G. RIPANTI, Introduzione in AA.VV., Ermeneutica e critica dell’ideologia, Queriniana,
Brecia, 1979, p. 18.
51
“Esistono punti di contatto precisi tra la razionalità analitica e quella continentale (nella
versione ermeneutica): il comune rifiuto dell’impianto soggettivistico o “coscienzialistico”
della filosofia moderna (il “solipsismo metodico” della soggettività cartesiana); il comune
privilegiamento del linguaggio come nuovo paradigma entro il quale formulare le questioni
classiche della filosofia. Esistono anche precise divergenze: nella tradizione ermeneuticaesistenziale prevale un taglio trascendentale, ossia la concezione del linguaggio come
apriori dell’esperienza; nella filosofia analitica domina l’istanza pragmatica(…), ovvero
l’idea di una connessione non universalizzabile tra linguaggio e forme di vita” (F.
D’AGOSTINI, Analitici e continentali, cit., p. 383).
52
Cfr. K. O. APEL, L’influsso della filosofia analitica sul mio itinerario intellettuale, in S.
CREMASCHI (a cura di), Filosofia analitica e filosofia continentale, cit., pp. 209-247.
172
a conferire all’azione discorsiva una validità normativa fondante
l’intersoggettività, e dunque a farne un trascendentale regolativo della
comunicazione umana, da assumere non come risoluzione finale, ma come
terreno di prova per una riformulazione dei rapporti tra etica, politica e
linguaggio53.
Ma questo percorso speculativo che si verifica all'interno della filosofia
del Novecento e che prende il nome di svolta linguistica54, si presenta come
un intreccio di posizioni ed elaborazioni concettuali che difficilmente si
lasciano ridurre a schematizzazioni. Il concetto stesso di “svolta linguistica”
andrebbe declinato al plurale, nel riferimento a quelle evoluzioni nel modo
di intendere il linguaggio che si verificano in seno ad un vasto fronte di
orientamenti nel pensiero filosofico contemporaneo55.
A noi qui interessa ciò che accade tra gli anni Trenta e Sessanta in due
grandi aree di indagine filosofica, che si differenziano non solo per la
diversa impostazione dei problemi filosofici, ma anche per la diversa
concentrazione geografica dei loro esponenti. Per definire questa duplice
articolazione di studi filosofici, si fa ricorso alla distinzione tra “analitici” e
“continentali”56, con riferimento sia a quel vasto movimento di pensiero
53
Si veda in proposito il saggio di M. SBISA’, Linguaggio, ragione, interazione, Il Mulino,
Bologna, 1989.
54
Cfr. J. HABERMAS, Il pensiero post-metafisico, cit., pp. 47-55. Habermas intende la svolta
linguistica come quel fenomeno “dovuto al distacco, già delineato da Humboldt, da quella
tradizionale concezione che rappresenta il linguaggio in base al modello dell’attribuzione di
nomi agli oggetti e lo comprende come uno strumento di comunicazione (Mitteilung) che
rimane però esterno al contenuto di pensiero. La nuova concezione linguistica elaborata
trascendentalmente, acquista invece una rilevanza paradigmatica, soprattutto attraverso la
superiorità metodica nei confronti di una filosofia del soggetto che si deve richiamare all’
accesso introspettivo ai fatti della coscienza” ( ivi, p. 49).
55
Cfr. F. D’ AGOSTINI, Analitici e continentali, cit., pp. 57-77, e 61; cfr. S. CREMASCHI (a
cura di), Filosofia analitica e filosofia continentale, cit., pp. 6-7. Secondo Cremaschi si può
parlare di due svolte linguistiche parallele tra gli anni Trenta e Cinquanta. Il secondo
Wittgenstein nelle Ricerche filosofiche rovesciava la sua posizione del Tractatus,
abbandonando la teoria del significato come raffigurazione e la nozione di un linguaggio
ideale, per sostituirvi la nozione di gioco linguistico, ed Austin dava origine alla filosofia
del linguaggio ordinario con l’idea del fare le cose con le parole. In Germania la
fenomenologia del primo Husserl veniva capovolta nella Crisi delle scienze europee e
Heidegger passava da un’analitica dell’esistenza ad una ontologia dell’interpretazione. La
sua ontologia ermeneutica fu poi ripresa da uno dei suoi primi allievi, H. G. Gadamer, il
quale, puntando sull’interpretazione dei testi e sulla linguisticità del comprendere, faceva
del linguaggio l’ “orizzonte ultimo del pensiero”, e vedeva l’esperienza ermeneutica come
il mezzo attraverso cui la ragione si sottrae alla prigionia del linguaggio, esperienza che si
costituisce a sua volta come linguaggio. (Cfr. H. G. GADAMER, Verità e metodo, cit., p.
462).
56
Il ricorso a questi due termini risale per la prima volta al discorso di apertura tenuto da J.
Wahl nel 1958 in occasione del Convegno di Cérisy-la-Salle sulla filosofia analitica, e ad
uno scritto di J. Habermas del 1961 in cui questi pone a confronto la natura epistemologica
della filosofia analitica nella sua radice neopositivistica, con una epistemologia
ermeneutico-dialettica secondo cui il soggetto è implicato e partecipe nella costituzione dei
173
che chiamiamo filosofia analitica, diffuso in Gran Bretagna, Stati Uniti,
Olanda e Scandinavia; sia all’altro variegato fronte di studi filosofici che
comprende esponenti dello storicismo, pensatori ermeneutici, fenomenologi
ed esistenzialisti, detti “continentali” poiché la loro matrice geografica è
prevalentemente europea57.
Tenendo conto delle sostanziali differenze epistemiche e
metodologiche tra “analitici” e “continentali”, si è tuttavia andato
accentuando una sorta di avvicinamento, e in particolare si è evidenziata una
confluenza relativa all’implicazione, avvertita da entrambi gli orientamenti,
tra linguaggio, azione e prassi sociale.
Sia Apel che Habermas hanno individuato lucidamente le linee di una
dialettica tra la prospettiva analitica ed ermeneutica: il progetto di far
affiorare alcune fondamentali convergenze si fonda sulla constatazione che
quella parte della filosofia analitica ispirata al secondo Wittgenstein, avendo
ricusato ogni concezione rigidamente formalistica del linguaggio, è andata
mettendo in luce il valore pragmatico del linguaggio, che diventa anche
normativo della prassi sociale, attraverso il famoso concetto di giochi
linguistici come attività di linguaggio che costituiscono le forme di vita
intersoggettive dell’esperienza sociale del mondo58. Si tratta però di
propri oggetti d’esperienza e che rispetto ad un approccio analitico predilige quello
dialettico. Si veda in proposito, L. BECK (a cura di), La philosophie analytique, Seuil, Paris,
1962 .
57
Per un confronto tra le due scuole filosofiche, si veda, tra gli altri, per l’ermeneutica: J.
BLEICHER, L’ermeneutica contemporanea, cit.; M. FERRARIS, Storia dell’ermeneutica,
Bompiani, Milano, 1988; G. MURA, Ermeneutica e verità. Storia e problemi della filosofia
dell’interpretazione, Città Nuova, Roma, 1990; F. BIANCO, Pensare l’interpretazione. Temi
e figure dell’ermeneutica contemporanea, Editori Riuniti, Roma, 1991; M. RAVERA, Il
pensiero ermeneutico, Marietti, Genova, 1986; G. NICOLACCI, La controversia
ermeneutica, Jaca Book, Milano, 1989; S. MAFFETTONE, Ermeneutica e scelta collettiva,
Guida, Napoli, 1992; per la filosofia analitica si veda, tra gli altri, D. ANTISERI, Dal
neopositivismo alla filosofia analitica, Abete, Roma, 1966; ID., Dopo Wittgenstein. Dove
va la filosofia analitica, Armando, Roma, 1977; P. PARRINI, Linguaggio e teoria, La Nuova
Italia, Firenze, 1986; I. HACKING, Linguaggio e filosofia, tr. it., Raffaello Cortina Editore,
Milano, 1994; G. GAVA, A. PIOVESAN (a cura di), La filosofia analitica, Liviana, Padova,
1972; G. PENCO, Significato e teorie del linguaggio, Franco Angeli, Milano, 1990, P.
EMANUELE, Il mito dell’analisi da Aristotele a Rorty, Laterza, Roma-Bari, 1993.
58
“Nelle Ricerche filosofiche che ho studiato dal punto di vista di un sistematico confronto
con l’architettura quasi-trascendentale del Tractatus, ho trovato non soltanto una
concezione nuova - compiutamente pragmatica - del linguaggio e del suo significato ma
anche, insieme alla continuazione del programma di Sprachkritik, una trasformazione
dell’architettonica quasi-trascendentale del Tractatus… Si potrebbe giungere alla
conclusione che il problema quasi-kantiano delle condizioni di possibilità della descrizione
(o interpretazione) del mondo ha subito una diversificazione secondo le diverse - forse
anche incommensurabili - strutture profonde ( ivi inclusi “modelli”, “criteri” o “paradigmi”
extralinguistici) dell’uso del linguaggio in giochi linguistici diversi appartenenti a “forme di
vita” diverse. Ora, questa diversificazione dell’a priori dell’interpretazione linguistica del
mondo era atta ad aprire una nuova prospettiva anche sul problema della comprensione
174
comprendere effettivamente in che senso si può parlare di un percorso di
avvicinamento tra le due prospettive filosofiche, per loro matrice così
differenti, e quali siano i possibili o reali punti di intersezione che non
vengano ad intaccare né a ibridizzare le rispettive specificità59.
Diciamo subito che filosofia analitica ed ermeneutica condividono
l’interesse per il linguaggio come snodo concettuale primario; ma si può
individuare su questo punto anche un primo piano di differenziazione
ricordando che l'unità linguistica di base per la filosofia analitica è
l'enunciato, e per l'ermeneutica risulta essere il discorso. E sebbene questa
possa sembrare una semplificazione riduttivistica dei due diversi approcci al
linguaggio, tuttavia le implicazioni di tali assunti rinviano proprio al diverso
percorso teoretico ed epistemologico tracciato da entrambi gli orientamenti
e ne evocano la diversa matrice: epistemologica e quindi neopositivistica
per la filosofia analitica, storicistica ed ontologica per l'ermeneutica.
Secondo queste diverse configurazioni del linguaggio, non è in gioco
soltanto il diverso tipo di funzione linguistica da ammettere al vaglio della
significanza, ma, più in profondità, si tratta di cogliere il diverso tipo di
problema filosofico ritenuto fondamentale.
In altri termini, è il tipo di domanda filosofica da cui muovono i rispettivi
orientamenti che è differente. Nella prospettiva ermeneutica piuttosto che
interrogarsi su “come conosco”, ci si interroga su quale sia la caratteristica
ontologica, dunque l'essenza, del soggetto che conosce, in quanto posto su
un piano ontologico differente rispetto agli enti.
Il movimento analitico, tenendo conto della sua matrice neopositivistica,
passa da una indagine linguistica spiccatamente semantica alla risoluzione
del linguaggio come attività intenzionale intersoggettiva, che più
sinteticamente viene definita pragmatica, secondo cui il compito del filosofo
diventa un compito terapeutico, cioè un’opera di chiarificazione logica del
pensiero attraverso il linguaggio nel suo uso quotidiano.
L'ermeneutica nel riferirsi a quell'unità di senso che è il discorso, si pone
l’obiettivo di stabilire il nesso essenziale tra linguaggio e comprensione,
intendendo il linguaggio come luogo della relazione umana, come orizzonte
che costituisce e dà senso al coesistere. La risoluzione del linguaggio nella
pratica discorsiva della “comunità di discorso” mette in evidenza che ogni
processo di comprensione è da ricondursi ad un contesto comunicativo, a
cui i soggetti prendono parte come coimplicati nell’opera di comprensione.
In questo senso la comprensione ermeneutica rinvia ad un “impegno totale”
da parte del soggetto, poiché “ha luogo nella vita di ognuno e consiste nel
cogliere il senso del discorso”60. Il ruolo della comunità dei parlanti,
ermeneutica” (K. O. APEL, L’influsso della filosofia analitica sul mio itinerario
intellettuale, cit, p. 217).
59
Si veda, per una lettura critica, R. BUBNER, La convergenza tra filosofia analitica e
filosofia ermeneutica, in S. CREMASCHI (a cura di), op. cit., pp. 197-207.
60
J. BLEICHER, L’ermeneutica contemporanea, cit., p. 49.
175
rivelando un carattere “sovra-individuale” e trascendentale, rischia però di
venire a far luce sulla possibilità della comunicazione facendo appello a se
stessa, cioè in quanto categoria che già presuppone la comunicazione come
sua struttura relazionale.
Dal canto suo, l’operazione decisiva del movimento analitico sulla via
del ripensamento delle tesi neopositivistiche è stato il superamento di una
piena corrispondenza tra l'unità linguistica di significato, cioè la
proposizione, e i fatti del mondo in senso estensivo, introducendo la
legittima significanza di una molteplicità di funzioni linguistiche e di usi del
linguaggio. Si fa strada, cioè, la consapevolezza che la crisi del modello
ideale, per cui ad ogni enunciato corrisponde una proposizione, porti ad un
ampliamento del campo di legittimità semantica del linguaggio e all'acquisto
di una valenza pragmatica: i giochi wittgensteiniani sono comportamenti
linguistici governati da regole linguistiche, che sono in definitiva regole
coesistenziali di azione ed interazione sociale. E proprio il concetto di
regola linguistica viene a porsi come crocevia tra linguaggio e inter-azione,
collegando l’idea di un ordine logico con la prassi concreta.
Anche secondo la prospettiva ermeneutica gadameriana ogni
comprensione di un testo dischiude sempre un orizzonte pragmatico
dell’applicazione; dunque la comprensione della regola è condizione per
l’esercizio della sua funzione. Come osserva Bubner però, a differenza delle
leggi, le regole producono conformità nel senso che “la regola osservata
struttura la molteplicità pratica col prescrivere una prosecuzione dell’agire
nello stesso senso o nella stessa direzione”61. Ma affinché ciò si verifichi
come continuità dell’agire e come possibilità di tale continuità dell’azione, è
necessario che l’agire indicato dalla regola non si esaurisca nel caso singolo
o nel caso contingente e mutevole: la regola, per essere tale, deve “creare
ordine prescrivendo un comportamento uguale”62.
La metafora del gioco allude alle sue caratteristiche di luogo, durata e
dunque di limitazione spazio-temporale: ha uno svolgimento proprio e un
senso in sé; anzi potremmo dire che acquista sempre più senso proprio nello
svolgersi, cioè nel suo divenire, nell’alternarsi dei ruoli e delle possibilità63.
Ma il riferimento al gioco evoca anche il suo fissarsi come cultura, poiché
può essere ripetuto, fissato nella memoria e tramandato. E se ogni gioco, per
la sua struttura interna che prescrive forme di vita condivisa, ha sempre le
sue regole, esse determinano, nella loro assoluta obbligatorietà, ciò che avrà
valore in quel mondo temporaneamente delimitato dal gioco stesso64, un
mondo in cui domina l’ordine, perché il concetto stesso di gioco ha
un’essenza normativa.
Le regole d’azione costituite dai giochi linguistici sottolineano la
61
R. BUBNER, Azione, linguaggio e ragione, cit., p.164.
Ivi, p. 165.
63
Cfr. J. HUIZINGA, Homo ludens, tr. it ., Einaudi, Torino, 1982, pp. 13-14.
64
Ivi, p.16.
62
176
necessità di stabilire criteri di razionalità pragmatica che governino ogni
comportamento comunicativo, senza fare riferimento a fatti extra-linguistici
ma ad elementi normativi relativi ai giochi sociali. Ciò che conta non è il
contenuto fattuale, ma l’insieme degli elementi, ognuno dei quali non può
determinarsi senza il riferimento e l’interdipendenza con gli altri elementi. Il
linguaggio dei fatti e il linguaggio delle azioni non sono assimilabili ma
nemmeno conflittuali. Si tratta di riconoscere due livelli di comportamento
linguistico, uno in cui ricorre il criterio di verità falsità, e l’altro in cui
sottolineiamo piuttosto l’intenzione e la direzione a uno scopo di un
comportamento. E non è forse l’intenzionalità dell’azione umana nel mondo
della vita a fare di essa un atto razionale e non solo un fatto naturale?
c) Azione e comunicazione in Habermas.
La nota “teoria dell’agire comunicativo” di Habermas è innanzitutto il
tentativo di istituire un criterio razionale come guida dell’azione che si fondi
sulla reciprocità interlocutoria del dialogo, e il tentativo di superare la
inconciliabilità tra questo, inteso come metodo critico, e la prassi sociale.
La comunicazione pertanto fa ricorso alla ratio dialogica come
applicazione pratica, di un agire che va a finire nella “negoziazione di un
consenso”65. Il concetto di comunicazione in questo senso allude anche alla
situazionalità dell’agire come inter-azione linguistica, in cui si intersecano
piani d’azione che sono piani di vita. L’interazione linguistica istituisce,
infatti, una distribuzione di regole e di competenze tra soggetti che mirano
ad un consenso e ad un reciproco riconoscimento.
Spesso il pensiero di Habermas viene meglio focalizzato in posizione
dialettica con quello di Luhmann. Se infatti la costruzione di Luhmann di
una contingenza sistemica66 sembra aver liquidato ogni impronta
65
R. BUBNER, Azione, linguaggio e ragione, cit., p. 287.
Come fa rilevare Barcellona, il concetto di contingenza sistemica di Luhmann è una
contingenza artificiale, non “un dato naturale, empirico, ma la stessa complessità del
sistema che si struttura sempre come alternative possibili”. In tal modo si viene a creare
una polarizzazione tra artificialità e ricerca del vero, anzi la verità viene
“desostanzializzata” da Luhmann in una trasposizione sistemica che ne rescinde anche il
nesso con il diritto e la morale (cfr. P. BARCELLONA, Il declino dello stato, cit., p. 222).
66
177
antropologica ed ogni soggettivismo razionale, edificando sulla morte del
soggetto un individuo come equivalente funzionale nel sistema67, Habermas
cerca di ripristinare una soggettività capace di ricercare la verità in un lavoro
consensuale di impegno dialogico.
Il progetto filosofico, condiviso con Apel, di un’etica del discorso
diventa anche l’ipotesi che in tale rifondazione etica si ricostituisca il nesso
soggetto-oggetto della prassi attraverso la ridefinizione di categorie
trascendentali dell’intendersi quali l’agire comunicativo ed il discorso.
Questa, che possiamo definire una rifondazione etica attraverso la ratio
discorsiva, rivela anche l’istanza che una pragmatica della comunicazione
non si risolva in uno sforzo riduzionistico di formalizzazione, ma che ricorra
ad una ragione comunicativa, “analizzabile inscindibilmente dai nessi vitali
della prassi sociale”, e ridisegni una soggettività che è tale perché inserita in
un contesto intersoggettivo strutturato linguisticamente68.
Dietro il concetto di agire comunicativo vi è infatti un progetto complesso,
che offre infiniti versanti di accostamento69. Pur tuttavia, si può individuare
nel progetto di una razionalità comunicativa il tratteggio portante di questa
nuova proposta teoretica70.
Il paradigma di una comunicazione, che si ponga come agire razionale e
consensuale, si lega strettamente all’esame della razionalità comunicativa o
discorsiva. Ma induce anche a chiedersi quale debba essere il telos
dell’agire intercomunicativo e del linguaggio come medium del reperimento
di verità nel discorso.
Il primo passo è dunque quello di riprecisare i termini della polarizzazione
tra una razionalità strumentale o procedurale e una “razionalità
comunicativa”71. Quest’ultima fa riferimento al recupero di un concetto di
logos che inerisca alla prassi comunicativa come struttura logico-dialettica
intersoggettiva. Il discorso razionale, in tal senso, viene ad essere quello in
cui i parlanti partecipano ad un mondo vitale, il cui “telos” non appare come
67
Cfr. J. HABERMAS, N. LUHMANN, Teorie della società o tecnologia sociale, tr. it., Etas
Kompass, Milano, 1973. In quest’opera Habermas si confronta con Luhmann
contrapponendo alla sua teoria sistemica una teoria della competenza comunicativa.
68
Cfr. W. PRIVITERA, Comunicazione ed emancipazione. La svolta linguistica della teoria
di J. Habermas, in AA.VV., Ragione emancipativa. Studi sul pensiero di J. Habermas, ILA
Palma, Palermo, 1983, pp. 178 sgg.
69
Per un’analisi più globale del concetto di agire comunicativo, si veda AA.VV., La svolta
comunicativa. Studi sul pensiero dell’ultimo Habermas, Franco Angeli, Milano,1984;
AA.VV., Jurgen Habermas. Comunicazione, prassi, società, Franco Angeli, Milano, 1985.
70
Infatti il riferimento serrato dell’opera habermasiana ad autori quali Durkheim, Weber,
Mead e Parsone, ne fa uno strumento di lavoro impareggiabile per la discussione filosofica,
sia di ispirazione politico-giuridica che linguistico-comunicativa, oltre che etico-morale. E
forse proprio in questa prismaticità teoretica consiste il valore dell’opera, ed anche la
difficoltà di rendere ragione della sua complessità attraverso uno sguardo sintetico.
71
Cfr. J. HABERMAS, Teoria dell’agire comunicativo. Razionalità nell’azione e
razionalizzazione sociale, cit., pp. 64-65.
178
“disposizione strumentale”, ma come “intesa comunicativa”72. Infatti,
proprio con il concetto di agire comunicativo, Habermas sviluppa
l’intuizione che il telos dell’intesa è intrinseco al linguaggio. E con “intesa”
egli vuole riferirsi ad un “concetto di contenuto normativo”, che non va
confuso con l’intesa di espressioni grammaticali, ma che costituisce le
condizioni linguistiche della comprensione linguistica del significato e
dunque della validità dell’atto linguistico stesso: “nel linguaggio – infatti le dimensioni del significato e della validità sono internamente connesse”73.
Ma l’obiettivo primario in Habermas si conferma quello di riportare tali
teorizzazioni ad una rifondazione dell’agire sociale come prassi
comunicativa che, come lui stesso scrive, è anche una teoria dell’ordine
sociale74. Pertanto, si tratta di rielaborare innanzitutto una teoria dell’azione
alla luce del rapporto con la valenza pragmatica del linguaggio.
Il concetto di prassi comunicativa viene raffrontato con quello dell’agire
teleologico, dell’agire drammaturgico e dell’agire normativo. L’analisi di
quest’ultimo assume notevole rilevanza poiché il concetto di agire
governato da regole, che presuppone due mondi, quello sociale a carattere
prescrittivo e quello degli “stati di fatto esistenti”, dovrebbe consentire
all’attore di distinguere “le componenti fattuali da quelle normative della
sua situazione di azione, vale a dire le condizioni e i mezzi dai valori”75.
Anche il modello comunicativo dell’azione è un’interazione governata da
regole che sono linguistiche. Ma qual è dunque la differenza?
Nell’agire normativo “il concetto centrale - scrive Habermas - è la
decisione fra alternative d’azione, orientata alla realizzazione di uno scopo,
guidata da massime e basata su una interpretazione della situazione”76. Ma il
concetto di un agire “regolato da norme”77 avverte appunto l’istanza
normativa allorché il soggetto è parte di un gruppo sociale, ossia nella sua
dimensione intersoggettiva, cioè in un interagire in cui almeno due soggetti,
capaci di linguaggio e di azione, stabiliscono una relazione interpersonale78.
Il concetto di agire governato da regole richiama certamente la penetrazione
di elementi wittgensteiniani, secondo cui il rapporto tra linguaggio e realtà
risulta fondato sulla pratica delle forme di vita e sulla pluralità di giochi
72
Ivi, p. 66.
Ivi, p. 73.
74
Ivi, pp. 79-84.
75
J. HABERMAS, Toria dell’agire comunicativo. Razionalità nell’azione e razionalizzazione
sociale, cit , pp. 162-163.
76
Ivi, p. 156.
77
Secondo quanto scrive Habermas, questa tipologia di azione regolata da norme
presuppone due mondi: un mondo sociale e quello oggettivo. Si tratta però di vedere come
questi due mondi entrino o non entrino in rapporto fra loro, e cosa comporti la loro
separazione o compenetrazione.
78
Cfr. ivi, pp. 156-157 e pp. 160-163. Vedi anche in proposito: E. DICIOTTI, I conflitti
normativi e l’etica del discorso, in “Rivista internazionale di filosofia del diritto”, LXXII,
1, 1995.
73
179
linguistici come regole linguistiche d’azione intersoggettiva. La razionalità
comunicativa a cui fa riferimento Habermas diventa dunque quel principio
comune dinamico come relazione discorsiva tra soggetti che partecipano ai
diversi giochi linguistici della realtà sociale79.
L’analisi linguistica, tuttavia, non può eliminare la dimensione storica
dell’agire comunicativo, ossia non può risolversi esclusivamente nella
considerazione della valenza intersoggettiva dei giochi linguistici,
tralasciando il più complesso rapporto tra linguaggio e prassi, che si lega
alla considerazione della connessione tra strutture istituzionalizzate come
strutture di potere, condizioni materiali e mondo della vita.
Il nesso tra comunicazione e potere del linguaggio, inteso come controllo
e possibilità di distorsione della razionalità comunicativa, richiede che
quest’ultima si presenti sempre come alternativa ad ogni razionalità
strumentale.
Ora bisogna chiedersi: il convenire ad un agire normativo quali presupposti
chiede al costituirsi dei soggetti come agenti sociali, e su cosa si basa questo
carattere consensuale? Inoltre l’agire teleologico, l’agire comunicativo e
l’agire drammaturgico, sottendono uno stesso concetto ed una stessa
funzione del linguaggio 80?
Per Habermas la natura e il pre-requisito di un rapportarsi consensuale
poggiano sulla dimensione linguistica del comunicare come agire sociale.
Dimensione che varia da modello a modello dell’agire. Il modello
dell’azione normativa del discorso si fonda su un linguaggio che media
“valori culturali e veicola un consenso”, e solo nell’agire comunicativo il
linguaggio non subisce riduzionismi ed esplica tutta la sua carica pragmatica
e semantica del senso intersoggettivo della prassi linguistica.
“Come emerge dagli approcci etnometodologici e da quelli della
ermeneutica filosofica, sussiste certo il pericolo - avverte Habermas - che
l’agire sociale sia ridotto all’opera di interpretazione dei partecipanti alla
comunicazione, che l’agire sia assimilato al parlare, l’interazione alla
conversazione. Di fatto però l’intesa linguistica è soltanto il meccanismo del
coordinamento dell’agire che tiene insieme i piani di azione e le attività
volte ad uno scopo dei partecipanti”81.
La teoria dell’agire comunicativo, quindi, non solo si rivela una teoria
consensuale della verità nel discorso senza ricorrere alla coazione, ma anche
l’alternativa razionale alla teoria sistemica e alla logica funzionalistica82. A
fronte della comunicazione massmediale, che vanta il primato della
79
Cfr. J. HABERMAS, Agire comunicativo e logica delle scienze sociali, tr. it., Il Mulino,
Bologna, 1980, p. 220.
80
Cfr. J. HABERMAS, Teoria dell’agire comunicativo, cit., p. 163.
81
Ivi, p. 171.
82
Il ricorso ad una verità discorsiva si appoggia a sua volta alla determinazione di una
comunicazione fondata da un logos come “a priori dell’intendersi” (Cfr. P. BARCELLONA, Il
declino dello stato, cit., pp. 223-224.)
180
strumentalità del linguaggio e l’efficacia tecnologica dell’interazione, la
dimensione umana del comunicare per Habermas è esercizio e pratica
comune della discorsività, che è tale solo nella misura in cui consente di
liberare i parlanti dall’egemonia di un linguaggio mistificante, attraverso la
ricostruzione di strutture universali del comprendere e dell’intendersi. E’
questa una “pragmatica universale” come “scienza ricostruttiva”, nel senso
che lo scopo di un’analisi ricostruttiva del linguaggio “è la descrizione
esplicita delle regole che un parlante competente deve padroneggiare”83.
Per questo Habermas ricorre alla distinzione tra “agire comunicativo” e
“agire strategico”, che sottende un diverso costituirsi dei piani d’azione dei
parlanti e un diverso valore della mediazione linguistica nella ricerca
razionale dell’accordo. Quest’ultimo non può essere raggiunto né con
estorsioni consensuali né, per così dire, “dall’esterno” attraverso
condizionamenti e pressioni di una parte sull’altra, e soprattutto non può
essere mosso dal calcolo di un vantaggio individuale84.
L’“agire strategico”, invece, lavora appunto in questa direzione,
orientando il meccanismo dell’intesa alla costruzione di un’interazione, in
cui vengono svuotate “le pretese di verità proposizionale, di giustezza
normativa e di veridicità soggettiva”, poiché la comunicazione esegue atti
linguistici in cui “si ritirano le forze illocutorie dell’integrazione” ed il
linguaggio “si restringe a mezzo di informazione”85. Perdere la forza
illocutoria degli atti linguistici vuol dire anche che l’orientamento e il
coordinamento dei piani d’azione cedono ad influenze esterne al linguaggio,
e soggiacciono solo all’istanza di informazione come mera comunicazione
di messaggi. In altre parole, l’agire linguistico dell’agire strategico è quello
in cui gli atti linguistici giocano una funzione solo strumentale, ed in tal
modo “non mirano a far sì che il destinatario prenda una posizione motivata
razionalmente”86.
La teorizzazione di Habermas, inquadrata nella più ampia ma intrinseca
dialettica tra linguaggio dell’epistemologia e linguaggio ermeneutico,
consente di raffrontare due modi di intendere l’atto linguistico e l’agente
linguistico. L’uso non-comunicativo o cognitivo del linguaggio rimanda ad
una “relazione fra proposizioni e qualcosa del mondo”; il linguaggio
“comunicativo” invece esprime la sua intenzionalità, è volto
costitutivamente verso l’altro, è un linguaggio “all’opera” molto vicino a
quello dei giochi wittgesteiniani, “così come viene adoperato allo scopo di
giungere alla comprensione comune di una cosa, o a una veduta comune”87.
83
Citato in E. AGAZZI, Introduzione, in J. HABERMAS, Etica del discorso, tr. it., Laterza,
Roma-Bari, 2000, p. XXI.
84
Cfr. J. HABERMAS, Il pensiero post-metafisico, cit., p. 66.
85
Ivi, p. 69.
86
Ivi, p. 71.
87
Ivi, p. 29. Cfr sull’argomento V. PEDRONI, Fondazione e critica della comunicazione.
Studi su Jurgen Habermas, Franco Angeli, Milano, 1992.
181
Dunque Habermas è convinto che vi possa essere in ogni rapporto
comunicativo un presupposto di razionalità. I punti di contatto con la teoria
di K.O. Apel paiono innegabili, soprattutto quando questi ritiene che l’apriori kantiano, come base della conoscenza e dell’universalità della
scienza, sia da intendere linguisticamente; o per meglio dire, che il concetto
di comunità illimitata della comunicazione è l’a-priori linguistico di ogni
comunicazione, e tale condizione di possibilità del comunicare ne fa il luogo
in cui l’apertura di tutti partecipanti allo scambio linguistico può aspirare a
quelle pretese di verità discorsiva e consensuale di cui parla Habermas88. E’
infatti la razionalità comunicativa, come criterio universale dell’intendersi,
che, trascendendo ogni posizione individuale del comprendere, diventa la
situazione linguistica ideale per una garanzia di fondazione etica del
comunicare.
d) Apel e il trascendentale linguistico intersoggettivo.
Il progetto di una trasformazione della filosofia in K. O. Apel è resa
possibile facendo convergere il pragmatismo di Peirce, la filosofia
linguistica di Wittgenstein e l’ontologia esistenziale.
In Comunità e comunicazione Apel svolge un confronto serrato tra le tesi
heideggeriane e quelle che caratterizzano il passaggio dal primo al secondo
Wittgenstein, per una sorta di transizione dall'ontologia ermeneutica alla
ricerca di un gioco linguistico trascendentale pervenendo così all’idea della
“comunità illimitata della comunicazione”. In essa si ripropone la domanda
di senso e di legittimità per una fondazione razionale dell'etica e del
presupposto trascendentale delle scienze sociali89.
Vattimo coglie certamente nel segno quando afferma che Apel è stato uno
dei primi a vedere le profonde analogie che legano gli esiti “linguistici”
dell'ultimo Heidegger e gli sviluppi ultimi della filosofia analitica,
soprattutto nel Wittgenstein delle Ricerche filosofiche 90.
La sintesi tra la posizione ermeneutica e quella filosofico-analitica
88
Secondo Habermas tali pretese di validità sono verità, correttezza e sincerità, a cui
corrispondono alcune modalità specifiche di linguaggio, funzione constativa, funzione
regolativa e funzione espressiva.
89
Ivi, p. 205 e 168.
90
Apel parla di una contiguità tra il pensiero di Wittgenstein e quello di Heidegger, pur
nell’appartenenza a scuole di pensiero che “non hanno mai preso seriamente nota gli uni
degli altri” (K. O. APEL, Comunità e comunicazione, cit., p. 3).
182
condurrà a quella “trasformazione semiotica del Kantismo” e ciò significa
“che se resta vero, con Kant, che il mondo degli oggetti è con-costituito
nelle sue strutture reggenti dall'attività del soggetto (la sintesi trascendentale
dell'appercezione, senza di cui non si può dare, kantianamente, alcuna
oggettività), la semiotica mette in luce definitivamente che questa
costituzione dell'oggetto come oggetto, cioè di un “qualcosa in quanto
qualcosa”, non avviene se non attraverso l'uso di segni, e cioè con la
mediazione del linguaggio”91.
Il valore connettivale del linguaggio, nell'evoluzione che lega le tesi di
Wittgenstein e quelle heideggeriane fino alle soluzioni ermeneutiche
dialettiche di Gadamer e Habermas, è nel restituire al soggetto la sua
storicità e la sua finitezza reale; ma, al tempo stesso, la possibilità di
recuperarle nella trama linguistica della comunicazione umana, quest’ultima
non intesa meramente come “gioco linguistico”, (cioè in senso
comportamentistico), ma in quel dispiegarsi e rinsaldarsi costante del
binomio linguaggio-esperienza intersoggettiva del comprendere.
“In risposta alla critica ‘totale' della ragione e all'autocomprensione
metodologica della filosofia suggerite dal post-modernismo, e
protendendosi verso una trasformazione in chiave linguistica della filosofia
kantiana, Apel elabora una teoria dei tipi di razionalità che, attraverso una
differenziazione tra i paradigmi scientifico-ermeneutici, intende dar conto
riflessivamente del tipo di razionalità cui appartiene la razionalità
filosofica”92, che può rifondarsi nel prender coscienza autoriflessivamente
del suo statuto trascendentale nell'innesto con quel gioco linguistico che è il
discorso argomentativo.
La rilettura del pensiero heideggeriano nell'analisi dell' Esserci offre
l'invito a considerare la mancanza di un'istanza normativa, per mettere in
questione il problema della fondazione e della validità del comprendere
comunicativo. In altri termini, Apel sembra chiedersi se ogni soggetto, nel
suo essere temporalmente e storicamente gettato nel mondo, possa
tralasciare, o sottendere, il problema della validità intersoggettiva del
conoscere.
Apel in tal senso offre lo spunto per tratteggiare una linea d'indagine
che coglie alcuni aspetti paradigmatici della svolta linguistica del XX
secolo, la quale sposta progressivamente il suo centro focale da un
approccio sintattico (nel senso di sintassi logica dei costrutti scientifici) ad
una prospettiva per così dire semantica, per pervenire alla pragmatica come
relazione tra la natura dei segni e l'uso sociale, di cui si trovano indizi nel
pensiero di Peirce. A questi Apel riconosce anche il merito di averlo
condotto, attraverso il principio del fallibilismo, alla convinzione che
debbano esistere delle condizioni a priori, ossia idee regolative riguardanti il
91
92
G. VATTIMO, Introduzione, in K.O. APEL, Comunità e comunicazione, cit., p. XXI.
A. PUNZI, Patto, Diritto Discorso, cit., p. 83.
183
progresso conoscitivo. Peirce sostiene, infatti, la centralità della deduzione
trascendentale della validità sul lungo periodo dei processi inferenziali
sintetici93.
A fronte di una relazione binaria, un processo gnoseologico non può
dirsi davvero tale se non tiene conto della categoria della terzietà e secondo
Peirce essa è la mediazione segnica, ma intesa non come medio formale o
empiricamente strumentale, e neppure come “nuda mediazione tramite
concetti nel senso della sintesi trascendentale dell'appercezione di Kant”94.
Piuttosto la funzione segnica del linguaggio, per cui si parla di
trasformazione semiotica della gnoseologia, si risolve, secondo la rilettura
che ne dà Apel, in almeno tre sviluppi tematici: 1) “Non c’è conoscenza
alcuna di qualcosa come qualcosa senza una mediazione reale dei segni
sulla base di veicoli segnici materiali.”; 2) “Non c’è funzione
rappresentativa alcuna del segno per una coscienza senza un mondo reale,
che si deve per principio pensare come rappresentabile sotto aspetti
determinati e cioè come conoscibili”; 3) “Non c’è rappresentazione alcuna
di qualcosa come qualcosa attraverso un segno senza interpretazione da
parte di un interprete reale”95.
La conoscenza è dunque mediata semioticamente, e tale mediazione
segnica è rappresentazione di un “mondo reale” da parte di un “interprete
reale”: questo sembra essere l'assunto di base riassumibile dai tre enunciati
apeliani.
Dunque il problema del senso rimanda fondativamente ad una premessa
trascendentale che consenta di offrire le condizioni di pensabilità e
possibilità del discorso intersoggettivo, ma non è del tutto chiaro quali
possano essere le condizioni necessarie a giustificare la portata relazionale
della comunicazione come prassi semiotica. In altri termini, vi può essere un
postulato da assumere come validità intersoggetiva a priori, per fornire
senso e valore ai giochi linguistici empirici di cui è intessuta l'esperienza
umana del comunicare?
La domanda allude all'inglobamento dell'istanza fondativa semiotica
nel concetto di gioco linguistico, e sottende anche un concetto di
comunicazione che fa perno più che sull'attività del soggetto, sulla nozione
di “comunità illimitata della comunicazione” come polo trascendentale,
cioè come condizione di intelligibilità dell'atto discorsivo stesso.
E l’evoluzione in senso semiologico offerta da Peirce pone nei segni il
medio attraverso cui realizzare questa comunità della comunicazione. Infatti
per Peirce la relazione segnica, caratterizzata da quella terzietà, dal trittico
segno-oggetto-interprete, funge non solo da condizione della
comunicazione, ma anche come regolamentazione normativa della comunità
dei parlanti: i segni linguistici, del resto, sono mediazioni regolative,
93
K. O. APEL, Discorso, verità, responsabilità, cit., p. 69.
Ivi, pp. 141-142
95
Ibidem.
94
184
condizioni nomologiche di una relazionalità vivibile e condivisibile.
Procedendo sulla via aperta dalla pragmatica peirceiana, la
comunicazione intersoggettiva è la condizione ermeneutica-trascendentale
della possibilità e della validità di ogni conoscenza indirizzata in senso
oggettivo. Ossia, l’emergere del linguaggio “come istanza di mediazione
della conoscenza”, mostra che “soltanto una filosofia trascendentale
trasformata in senso semiotico è in grado di concepire adeguatamente
l’origine dell’impostazione problematica ermeneutica a partire dall’interesse
di comunicazione, complementare all’interesse di conoscenza scientifico”96.
Pertanto, la “comunità del discorso” non può costituirsi se non
recuperando un paradigma di razionalità come recupero di un logos
riflessivo del discorso stesso, cioè garantendo nell'azione sociale un
esercizio della razionalità discorsiva simmetrico e critico, e potremmo anche
dire libero. Tale esercizio però esige una regolamentazione criticodiscorsiva: un logos fondativo che va reperito nella dialettica tra senso e
verità della dimensione linguistica.
L'implicazione logico-normativa dei giochi linguistici, che è poi
regolamentazione dell'agire interumano, è riletta con l'istanza di un
superamento della mera giocabilità e frammentarietà delle applicazioni
linguistiche contingenti al dialogo comunicativo, al fine di sancire la portata
normativa del medio linguistico come medio strutturante la relazione tra
soggetti.
E nella concezione del linguaggio come gioco linguistico, cioè come
uso condiviso di segni materiali in una situazione di vita sociale, Apel ha
scorto la mediazione tra un modello di linguaggio come sistema, in cui la
valenza intersoggettiva è garantita dall’apriori della forma logica delle
proposizioni, ed un altro modello visto nell’ottica coscienziale del soggetto
inteso individualmente97.
Lo sviluppo centrale del percorso apeliano, teso al superamento di
ogni solipsismo metodico, pare risolversi proprio nella domanda sul valore
possibile ed effettuale del linguaggio nell'orizzonte del convivere tra
soggetti, ponendo implicitamente una richiesta di indagine pre-fondativa
dell'apriori linguistico e inducendo a chiedersi se sia ancora ascrivibile al
valore trascendentale il conferimento di senso all'attività linguistica fuori
della situazione intercomunicativa.
Se, in altri termini, l'apriori kantiano era del soggetto e nel soggetto,
ora l'apriori linguistico è ancora pensabile in questi termini, o non rafforza la
sua apriorità, cioè la sua universalizzabilità e incondizionatezza, nell’essere
per il soggetto condizione di possibilità del relazionarsi a se stessi e ad altri?
Ci sembra di capire che la stessa condizione di possibilità della
comprensione, in quanto fondata sulla pre-comprensione del soggetto,
96
K. O. APEL, Comunità e comunicazione, cit., p. 153.
Cfr. V. MARZOCCHI, Introduzione, in K. O. APEL, Discorso, verità, responsabilità, cit.,
pp. 26-27.
97
185
venga a dischiudersi nel circolo ermeneutico, proprio in virtù di una
circolarità che è transitività dell'agire e del comprendere linguistico.
L’approdo alla comunità della comunicazione, come luogo relazionale
simbolico in cui si giocano i reali e concreti possibili rapporti di verità e
potere, di libertà e assoggettamento, ribadisce la interpretazione del
linguaggio come insieme di regole pragmatico-semantiche, e porta
l’evidenza “sempre mia” della coscienza ad una validità della conoscenza
vincolante a priori in una teoria consensuale della verità98.
La delineazione di un’affinità tra principio del discorso e principio della
democrazia, che in Habermas significa anche co-originarietà di diritto e
morale, è riproposta in termini di problematizazione degli assunti
habermasiani, delineandone internamente anche qualche aporia concettuale.
Apel condivide con Habermas l’esistenza di una relazione interna tra il
principio del discorso e il nucleo centrale del principio della democrazia. Né
pare sfuggire ad Apel l’importanza della convinzione di Habermas che una
fondazione della giustizia politica, nella prospettiva di una teoria etica del
discorso, venga a caratterizzarsi per il rilievo che conferisce alla procedura
democratica99.
Tuttavia Apel è dell’opinione che “oggi - dinnanzi alla necessità di una
globalizzazione del confronto discorsivo a riguardo del rapporto tra morale
e giustizia, etica della vita buona entro una data cultura e ordinamento
politico-giuridico, della società - il compito sia quello di cogliere fino in
fondo a riguardo di questi temi, l’opportunità per una discussione sui
fondamenti, filosoficamente distanziata e radicalmente riflessiva”100. Non si
può, in altri termini, contare sull’ovvietà della democrazia, ma bisogna
interrogarsi riflessivamente sulla sua fondatezza. Si tratta della
“collaborazione per l’instaurazione delle condizioni istituzionali,
indispensabili all’esercizio, allargato all’intero pianeta, di quella morale
discorsiva rappresentata dalle norme puramente deontologiche e procedurali
dell’etica del discorso; e quindi si tratta, tra l’altro, di assicurare i
presupposti, dati nello Stato di diritto, per l’apertura di quello spazio
indispensabile alla pratica della morale razionale in quanto morale
discorsiva” 101.
L’etica del discorso applicata al diritto appare così il tentativo di
ricomporre quello strappo tra diritto e morale attraverso l’esercizio di una
98
In altri termini, non ci si può porre in una posizione esterna alle regole del gioco
linguistico trascendentale della comunità della comunicazione senza cadere in quel
solipsismo metodico della gnoseologia moderna, dove l’Io già presuppone la comunità
della comunicazione e si pone in essa con una pretesa autofondativa. Tuttavia è anche vero
che il soggetto non può vedersi negata la scelta consapevole e razionale della comunità
della comunicazione, poiché diversamente si troverebbe non più giocatore del gioco
linguistico trascendentale ma giocato da esso.
99
Cfr. K. O. APEL, Discorso, verità, responsabilità, cit., pp. 346-348.
100
Ivi, p. 349.
101
Ivi, pp. 288-289.
186
ragione discorsiva pubblica, che riconosca il diritto in quanto
istituzionalizzazione di una relazione di riconoscimento mediata da un
giudizio imparziale e universalizzabile.
Ciò conduce a pensare che si abbia soluzione razionale dei conflitti
argomentativamente e processualmente, grazie alla riconduzione delle
controversie a un discorso pubblico, sensibile alla concretezza degli
interessi in gioco, ma al tempo stesso ancorato a principi etici inviolabili.
Ecco allora che il giudizio che risolve la controversia appare giustificato
fin quando dichiara la legittimità solo di quelle pretese che, in linea di
principio, potrebbero venire accolte dopo un confronto dialogico
argomentativo, orientato a contemplare e tutelare i diritti di ogni possibile
essere umano.
e) Gli effetti del Linguistic Turn nello studio del diritto.
La speculare corrispondenza tra linguaggio e mondo ad opera del
neopositivismo aveva dissolto la comunicazione intersoggettiva nel
risolvere la logica del linguaggio a sistema di calcolo. In tal modo il
rapporto soggetto-linguaggio-mondo si riduce ad una dualità soggettooggetto a cui risulta estranea l’esigenza di un’intesa comunicativa
finalizzata alla costituzione di senso.
L’accentuazione del carattere fortemente intersoggettivo del linguaggio
per effetto della svolta linguistica in filosofia rinvia anche ad una diversa
considerazione del rapporto tra soggetto conoscente e oggetto conosciuto, e
dunque tra soggetto e norma: la relazione soggetto-oggetto acquista di per sé
una rilevanza non solo gnoseologica e metaepistemologica, ma anche
sociale e politica oltre che giuridica.
Se consideriamo che i presupposti per l’universalizzazione dei processi
conoscitivi, e dunque della verità, si danno nel medio linguistico come
“mezzo universale in cui si attua la comprensione stessa”102, in questo
senso Gadamer ci lascia capire che i problemi del linguaggio sono già
problemi della comprensione, e viene anche a ribadire quel “carattere
enigmatico”, ma inestricabile, del nesso tra pensiero e linguaggio a cui è
102
H. G. GADAMER, Verità e metodo, cit., p. 447.
187
rivolto il metodo “terapeutico” dell’analisi linguistica nella filosofia
analitica.
Nonostante la diversa considerazione di fondo del linguaggio, il
confronto, e come vedremo per alcuni versi anche l’incontro, tra la filosofia
analitica e l’ermeneutica sulla valenza pragmatico-intersoggettiva della
struttura linguistica apporta, nello studio del diritto, importanti revisioni nel
modo di intendere non solo il giuridico, ma l’intero asse rapportuale
soggetto, norma e mondo dell’azione.
Innanzitutto si può osservare che dalla crisi della soggettività postmoderna, che non può più trovare in se stessa il senso ultimo del mondo e
del pensiero, si viene a porre nel linguaggio quel carattere di
trascendentalità che prima competeva al soggetto.
Nel linguaggio, dunque, il mondo perviene alla coscienza del soggetto e
alla sua dimensione intersoggettiva. Entro questo nuovo orizzonte
linguistico ha sede e senso la comprensione e la partecipazione al mondo
come contesto vitale. E dunque le questioni inerenti il problema del senso e
della verità delle proposizioni vanno affrontate, sia in sede di riflessione
analitica che ermeneutica, senza poter aggirare il medium linguistico, nel
contesto di un’interazione linguistica che si struttura come tessitura di un
reticolo comunicativo o discorsivo di regole pragmatiche.
In questa riformulazione linguistica del modo sociale di entrare in
relazione, l’identità individuale non è già precostituita e autosufficiente, ma
si costituisce e riceve attestazione continua e dinamica dall’incontro con
l’alterità, che è un incontarsi linguistico; così come il linguaggio stesso non
è un mezzo oggettivante e predefinito, ma un costrutto relazionale che si
alimenta e si modifica nei modi dell’agire comunicativo dei soggetti, luogo
dell’intendersi come anche del fraintendersi.
La lezione di Wittgenstein, che insiste sulla compenetrazione tra
linguaggi e forme di vita, sposta l’attenzione più che sul concetto di regole
come oggetti mentalistici che guidino l’azione, secondo una concezione
rappresentata efficacemente dalle teorie normativiste, sull’opportunità di
studiare quei comportamenti linguistico-interpretativi che costituiscono il
“seguire una regola”: “Anche quando creiamo regole lo facciamo secondo
regole”103 e questo significa che un’azione non si riduce ad essere orientata
ad uno scopo avulso da un piano di inter-azione, ma è contestualizzata in un
insieme di regole di comportamento, interagenti fra loro, entro cui si situa
già l’intenzionalità.
Ogni esperienza umana, infatti, in quanto costitutivamente esperienza di
linguaggio, si costituisce a livello di intersoggettività pratica, ma non intesa
come attività di un “insieme irrelato di soggetti - il che significherebbe
riproporre il vizio del paradigma soggettivistico - quanto come il prodotto
103
F. VIOLA, Il diritto come pratica sociale, Jaca Book, Milano, 1990, p. 157.
188
del processo dialogico e comunicativo che costituisce i soggetti e fornisce
loro identità e individualita”104.
L’apertura prospettata dai giochi linguistici trova, in un certo senso,
corrispondenze indirette nella tendenza della filosofia ermeneutica a partire
dalle concrete istanze di discorso come sede appropriata della pienezza di
senso, abbandonando, anche in questo caso, ogni concezione mentalistica
della norma e osservando il linguaggio giuridico come una delle pratiche
interpretative che si identificano “nel seguire regole”. Così, la
configurazione delle regole giuridiche rimanda al coordinamento di piani
d’azione che, pur attraverso azioni individuali specifiche, non possono
raggiungere lo scopo se non visti e compresi nell’intreccio relazionale di
inter-azioni comuni: il diritto “non è solo regola, non è solo azione, ma è un
impresa cooperativa strutturata da finalità immanenti” e in questo sta il suo
carattere istituzionale105.
Quindi, tenendo ferme le rispettive differenze, la comune convinzione che
vi è piena compenetrazione tra linguaggio e mondo, conduce alla
fondamentale convergenza, tra filosofia analitica ed ermeneutica, sul fatto
che l’orizzonte linguistico è un mondo linguisticamente strutturato, entro
cui i soggetti non solo comunicano, ma, comunicando, vivono e si
riconoscono intersoggettivamente fondati. Il linguaggio è il luogo
dell’articolazione del mondo della vita sociale ed è incorporato nelle azioni,
per questo il superamento della referenzialità del linguaggio, cioè della sua
corrispondenza con il mondo delle cose, implica che il linguaggio stesso
diventi espressione del mondo della convivenza, del conflitto e
dell’interazione106.
Sul piano del diritto, la crisi della proposizione in seno a quelle che
possiamo anche chiamare teorie semantiche107 aveva condotto ad una
revisione profonda dell’approccio alla norma giuridica e del modo di
ricercare i criteri di validità del diritto. Se prima nel modello empirico
neopositivistico l’asse portante era proposizione-referenza-verità, ora esso
diventa discorso-relazione dialogica-verità argomentativa108.
104
G. ZACCARIA, Tra ermeneutica e analitica, in M. JORI (a cura di), op. cit., p. 114.
Cfr. F. VIOLA, G. ZACCARIA, Diritto e interpretazione, Laterza, Roma-Bari, 1999, p. 9.
106
F. VIOLA, Critica dell’ermeneutica alla filosofia analitica italiana del diritto, in M.
JORI, op. cit., p. 77.
107
“Le teorie semantiche del diritto - scrive Viola - sono rivolte ad identificare i criteri di
validità del diritto, cioè la definizione del diritto e le condizioni di verità delle proposizioni
giuridiche. Le teorie positivistiche tradizionali da Austin a Kelsen sono di questa specie e
differiscono tra loro nell’individuazione dei fatti storici decisivi per la validità”. Se dunque
nella teoria semantica il diritto è un “oggetto”, l’approccio interpretativo “considera il
diritto non già come ‘cosa’ da osservare dall’esterno, ma come attività che nel suo
conoscersi si va svolgendo e attuando” (F. VIOLA, Il diritto come pratica sociale, cit., p.
158).
108
Va anche però precisato che la rinuncia alla referenzialità epistemologica non significa
affatto il rifiuto di ogni referenza del linguaggio giuridico. Né significa una rinuncia alla
conoscenza scientifica, come già si è detto, ma al contrario si pone a difesa di quella
105
189
Appare pertanto ora più appropriato assumere il discorso come unità
linguistica dell’analisi giuridica, poiché esso è quella situazionalità storicodialogica del linguaggio in cui si attua la comprensione e l’intendersi.
All’interno di questa situazione discorsiva, che è prima di tutto un evento,
deve cercarsi il controllo razionale dell’interpretazione giuridica. Così
nell’evento del discorso la stessa attività conoscitiva diventa parte integrale
del mondo dell’esperienza e non si separa da esso.
Se infatti le teorie semantiche hanno come obiettivo l’individuazione
preliminare di ciò su cui deve esercitarsi l’interpretazione giuridica, per
farne ciò che c’è di certo e di stabile nel diritto, le teorie interpretative,
invece, non partono da oggetti prestabiliti, ma considerano il diritto come
una prassi interpretativa, all’interno della quale prendono corpo le
consolidazioni giuridiche. Le teorie semantiche, perciò, si preoccupano di
definire e delimitare il campo della giuridicità, al cui interno devono
esercitarsi l’interpretazione giuridica, e la giuridicità si ritiene che risieda in
ben individuati settori dell’esperienza, siano essi fatti, norme,
comportamenti o valori morali109. Infatti la concezione oggettualistica
dell’interpretazione semantica del diritto ci presenta quest’ ultimo come una
realtà già costituita, e in certo qual modo compiuta, prima ancora
dell’intervento dell’interprete.
Dal canto suo la filosofia ermeneutica, che offre alle teorie
dell’interpretazione giuridica strumenti di risoluzione per le questioni
lasciate irrisolte dalla tradizione analitica, ma che anche dialoga con esse,
insiste sulla considerazione del processo creativo che si instaura tra soggetto
interpretante e oggetto da interpretare: non vi è statica polarità o cesura tra i
due momenti della circolarità ermeneutica, ma appartenenza allo stesso
orizzonte di senso.
Secondo l’approccio ermeneutico, dunque, l’atto interpretativo di singole
espressioni linguistiche presuppone già costituito il linguaggio
dell’interazione, e si muove dentro un mondo già segnato dalla reciprocità e
dalla cooperazione, oltre che da un senso intersoggettivo contestuale, che in
qualche modo guida l’interprete e costituisce un vincolo nell’opera di
iscrizione dei significati. In quest’ottica la “forza illocutiva degli atti
conoscenza scientifica che è propria della vita pratica. Tuttavia, è altresì rischioso pensare
che l’alternativa alle teorie semantiche per il diritto stia nella scelta di un approccio
squisitamente pragmatico. Come osserva Rosenfeld, gli stessi studi di un neopragmatista
come Rorty passano dal rifiuto del primato della scienza empirica e del ricorso all’analisi
preposizionale, secondo l’ispirazione tipicamente antifondazionalista, ad una sorta di
fondazionalismo rovesciato. Proprio l’atteggiamento pragmatico-antifondazionalista
diventa “paralizzante” e irrisolvente ai fini dei problemi aperti in seno all’interpretazione
giuridica e ai rapporti tra politica e diritto: “la frattura tra giustizia secondo il diritto e
giustizia oltre il diritto non può essere superata tramite un semplice rifiuto dei fondamenti,
o tramite un’ esclusiva attenzione ai mezzi a scapito dei fini” (M. ROSENFELD,
Interpretazioni, tr. it., Il Mulino, Bologna, 2000, p. 318).
109
F. VIOLA, Il dirtto come pratica sociale, cit., pp. 12-13.
190
linguistici diviene il tema principale della comunicazione al posto del
contenuto proposizionale”110 e la verità non è più ciò che sta dinanzi al
soggetto conoscente e chiede il suo consenso. Le teorie degli atti linguistici,
infatti, marcando il carattere d’azione degli atti di linguaggio, ci ricordano
che gli enunciati linguistici delle norme giuridiche non costituiscono una
realtà completa e indipendente, ma sono indissociabili dai contesti di azione
implicati111.
Proprio per questo in campo giuridico il principio ermeneutico per cui il
testo e l’interprete si producono reciprocamente porta a ricercare il
significato normativo all’interno di un contesto. Ciò significa anche che il
significato della proposizione può essere colto non a livello atomistico,
bensì sul piano olistico del suo collegamento con l’insieme degli enunciati
linguistici. E le condizione di conoscenza dell’agente non sono soltanto
dipendenti dalla sua soggettività, ma anche dal suo essere impegnato nel
mondo. Insomma le nostre configurazioni del mondo sono derivate da forme
di vita che abbiamo in comune con gli altri: all’atomismo epistemologico ed
etico si sostituisce la comunità come luogo primario dell’identità storica
degli individui.
Infatti, la necessaria e insopprimibile distanza tra l’universalità della
norma e la particolarità di ogni caso concreto, rende indispensabile un’opera
inesauribile di integrazione produttiva del diritto. Perciò l’interpretazione
giuridica ermeneutica parte dal riconoscimento che la norma astratta rivela
una sua struttura necessariamente incompleta, completabile solo col
procedimento ermeneutico di concretizzazione della norma giuridica
all’interno della decisione di un caso concreto.
Il processo di comprensione del diritto non può fermarsi, quindi, al solo
piano del linguaggio legislativo, come sequenza radicalmente empirica di
segni, senza continuamente integrare l’atto linguistico-legislativo con l’uso
che di tale linguaggio è effettuato nel processo di comprensione del diritto
da parte dell’interprete. Il rinnovato interesse per il linguaggio assume
pertanto un ruolo decisivo, sia perché l’interpretazione giuridica richiede
l’adeguata comprensione di un nesso linguistico che parte dal giuridico, sia
perché la decisione deve essere adeguatamente motivata tramite il medium
linguistico nei riguardi dell’ambiente circostante.
L’esigenza del controllo sociale e della regolamentazione dei conflitti
deve poter offrire parametri di verità incontrovertibili per l’opera
interpretativa del giurista, al fine di sottrarre il campo del diritto all’arbitrio
e all’incertezza. Risulta, pertanto, determinante l’attenzione posta
dall’interpretazione giuridica sull’aspetto collaborativo del rapporto che si
stringe tra tutti quelli impegnati nel contesto applicativo delle norme, e la
110
F. VIOLA, Critica dell’ermeneutica alla filosofia analitica italiana del diritto, in M.
JORI, Ermeneutica e filosofia analitica. Due concezioni del diritto a confronto, cit., p. 89.
111
Cfr. G. ZACCARIA, Tra ermeneutica ed analitica, cit., p. 141.
191
considerazione del testo giuridico legislativo utilizzando l’apporto della
filosofia ermeneutica, mai autonomo e pre-contestuale.
Se per un verso, infatti, nessun processo interpretativo esclude momenti
di decisione, per l’altro nessuna decisione è nell’interpretazione giuridica
mero decisionismo, ma una scelta che si viene compiendo dentro un
processo circolare di comprensione e interpretazione. Sembra così respinto
il modo di concepire tecnicisticamente il diritto come “dato finito”, e di
intendere l’applicazione come il riprodurre, in tutti i casi sussumibili sotto
una determinata norma, un significato già compiutamente dato una volta per
tutte.
“Il modello di tipo imperativistico e coattivo di un diritto, la cui funzione è
sempre e solo quella di guidare unidirezionalmente la condotta, di
costringere a fare - cui simmetricamente corrisponde un atteggiamento di
passiva obbedienza da parte di organi giurisdizionali e privati cittadini oltre ad essere ingenuo, non rende conto della configurazione attuale del
fenomeno giuridico che, nei contesti occidentali di Welfare State, si
caratterizza sempre più per funzioni di tipo promozionale e per
un’inarrestabile – anche se non sempre positiva – tendenza ad una crescente
consensualizzazione. Appare perciò ben più aderente alla realtà attuale il
qualificarlo come discorso, come gioco comunicativo e linguistico
complesso che comporta l’interazione di una serie differenziata di soggetti”
112
.
Tuttavia sorge il dubbio se la categoria della discorsività consenta di
fondare il diritto sulle istanze ermeneutiche di un ordine relazionale non
solo del conoscere, ma del riconoscersi dei soggetti impegnati nel vincolo
intersoggettivo. E’ plausibile ripensare il diritto strutturato come
discorso113? Ed in questo caso, è possibile rintracciare un avvicinamento
con la proposta di Viola del diritto inteso come pratica sociale, dal momento
che l’attività discorsiva è intesa dall’ermeneutica come azione linguistica
intersoggettiva che apre il mondo come orizzonte di senso dell’intesa e
dell’accordo?
Se pensiamo al diritto come pratica sociale, sembra di capire che la
proposta di Viola allude ad un controllo veritativo della pratica giuridica,
che scaturisce dalla considerazione di significati intersoggettivi contestuali
nel momento in cui entriamo a far parte della pratica sociale come mondo
comune d’azione. L’idea che ne scaturisce del diritto come “linguaggio
dell’interazione”114, fa pensare proprio ad una considerazione del diritto di
112
G. ZACCARIA, Tra Ermeneutica ed analitica, in M. JORI, (a cura di), cit, p. 142. Sul
problema della premialità del diritto, si veda S. ARMELLINI, Le due mani della giustizia,
Giappichelli, Torino, 1996.
113
Cfr. B. ROMANO, Il diritto strutturato come il discorso, cit.
114
Espressione adottata da Viola che la riprende da L. L. FULLER, Human Interaction and
Law, in The Principles of Social Order, ed. by K. I. Winston, Duke U. P., Durham, N. C.,
1981, p. 212.
192
ampio respiro, che intende porsi come modo relazionale per la
partecipazione ad un lavoro comune di intesa e cooperazione.
Tuttavia si pone il problema di come considerare il concetto di validità e
di verità all’interno del diritto inteso come pratica sociale, e se si possa
ancora parlare di validità, giacché è caratteristica di una pratica sociale
cercare al suo interno la propria referenza. Ma affermare che la pratica
giuridica è il referente del discorso giuridico non rischia di far cadere in una
anti-referenzialità che perde di vista la realtà come dato storico, come
certezza? Abbiamo detto, infatti, che all’interno della pratica giuridica la
scienza rappresenta il momento della consapevolezza, cioè della presa di
coscienza delle condizioni di intenzionalità che consistono nelle
precomprensioni, nelle presupposizioni, e nelle finalità della pratica stessa.
Di conseguenza, appartiene anche alla scienza giuridica il compito di
controllare i processi argomentativi interni che costituiscono la vita stessa
della pratica.
Tutto ciò che nell’ambito ermeneutico si riassume sotto la cifra centrale
del concetto di pre-comprensione, acquista rilievo epistemologico in quel
tessuto di apprendimento pre-scientifico, in quel legame di ritorno tra la
scienza e la vita che precede e condiziona lo spiegare proprio della
conoscenza scientifica.
Se dunque tener conto del diritto come pratica deve indurre a non
considerare più il rapporto tra soggetto e oggetto nei termini di un “faccia a
faccia”, e che “il problema della verità di una pratica richiede l’assunzione
di un punto di vista interno”115, crediamo però che si debba parlare di
pratica sociale sempre nell’interazione con il livello legislativo
giurisprudenziale. Altrimenti pare legittimo il pericolo di quello scollamento
che vede, da un lato un diritto avvertito come prassi discorsiva ed
intersoggettiva, in cui la storicità dell’interpretazione è mutevole nel tempo
e nel fondersi degli orizzonti; e dall’altro un rapporto tra soggetto e norma
incagliato nel relativismo, nella perdita della positività come oggettività,
come prassi vincolata da regole già precostituite ma universali.
La stessa ricerca del senso dell’agire umano, e quindi del suo interagire,
si fonda sul riferimento a regole di orientamento dell’azione. Se
l’implicazione intersoggettiva comunicativa della svolta linguistica analitica
aveva scongiurato la chiusura al soggettivismo ( la prassi non è individuale
ma è linguaggio come prodotto dell’agire comunicativo), in questa
prospettiva il profilo di soggetto-interprete e dell’oggetto-interpretandum
come rapporto intersoggettivo io-altri corre qualche rischio.
Se l’ermeneutica giuridica crede nella possibilità della comunicazione
discorsiva di liberare dalla prassi assoggettante, ossia dal controllo della
comunicazione, così come l’ermeneutica in politica vuole porsi come
emancipazione da ogni forma di domino, il diritto, inteso come prassi
115
F. VIOLA, Il diritto come pratica sociale, cit., p. 168.
193
sociale e forma comunicativa, ha però anche bisogno della sua
rappresentazione formale, la cui applicazione dipende dal soggetto
interpretante che, ermeneuticamente, è sempre situato in una determinazione
storica, dove il pericolo dell’arbitrio del decisionismo interpretativo è
sempre presente.
L’antidoto forse torna ad essere la collocazione di ogni processo
interpretativo nella circolarità del comprendere, una circolarità dialogica
entro cui può attuarsi il controllo sulla libera, ma a volte anche troppo
creativa, attività del soggetto interpretante.
In ogni caso, la verità a cui tendere è una verità discorsiva, ma mai
rescissa da un obbligo contestuale. Se infatti è giusto chiedersi come si
inserisca la regola nel movimento di costituzione della soggettività e
dell’eterosoggettività nel diritto come discorso, è altresì vero che agire
comunicativo e mondo si con-costituiscono attorno e attraverso la
regolamentazione del vivere coesistenziale.
La regola comune, quindi, come forma ed esito di un cammino
coesistenziale, non cade mai fuori del movimento relazionale, ma plasma il
mondo rapportuale offrendo agli stessi soggetti che l’hanno posta un vincolo
transitivo, che diventa unica garanzia di sottrarsi ad una libertà asimmetrica
e al prevalere della forza.
L’ermeneutica ha offerto spunti preziosi in tal senso, nel costituirsi del
linguaggio come medio strutturale della relazione. Qui l’analisi della
mediazione della parola, come medio del riconoscimento tra soggetti,
converge e si integra con l’analisi della regola come cardine del rapporto
intersoggettivo.
In altri termini, nel concreto mondo comune, nell’orizzonte del
coesistere, i parlanti si riconoscono in quanto soggetti le cui pretese
chiedono la garanzia transitiva offerta dalla regola comune e terza, la cui
istituzione positiva li costituisce in rapporto giuridico.
Strettissimo dunque si rivela il rapporto tra struttura del discorso,
relazionalità e diritto, in cui quel logos riflessivo del discorso cui allude
Apel, come garanzia di universalità e reciprocità disassoggettante, è un
logos-linguaggio che è libertà della ragione nel sottrarsi ad ogni forma di
razionalismo o di irrazionalismo, per tendere piuttosto a quella
ragionevolezza dell’interpretazione e del comprendere: forse così possono
tornare a saldarsi le ragioni del diritto con le ragioni della politica?
194
f) Per una rifondazione etica della comunicazione. Sbocchi e aporie.
Questa nostra epoca che vede attuarsi le svolte linguistiche in filosofia e
aprirsi nuove sfide all’indagine filosofica attraverso e sulle nuove forme di
linguaggio, è anche l’orizzonte entro cui si verifica quella che possiamo
definire una svolta etica116 pur nel contesto di un’era post-deontica117.
Nella frammentazione dei paradigmi tradizionali, dei linguaggi e delle
porzioni mondo che ne discendono, si fa strada lo sforzo di una nuova
riflessione sulle condizioni di rifondazione etica della prassi, che si presenta
anche con i tratti di un’etica del discorso e dell’argomentazione118.
Questo movimento di “riabilitazione della filosofia pratica”, sottende il
rifiuto di una considerazione della razionalità solo in termini scientificostrumentali e si propone di superare anche gli effetti del divisionismo eticopolitico del Novecento, il quale sancisce quella separazione tra fatto e valore
espressa nella famosa legge di Hume ad opera di G. E. Moore, che trova in
Weber uno dei teorizzatori più significativi del carattere di avalutatività
delle scienze sociali e nel positivismo giuridico di Kelsen una delle voci più
incisive riguardo ad una concezione del diritto reale ed empirico, come
sistema gerarchico di norme che non va sottoposto a processi di
giustificazione valutativa119.
116
Per un panorama sulle diverse posizioni, cfr. AA.VV., Etiche in dialogo, Marietti,
Genova, 1990. Sul concetto di etica della responsabilità si veda H. JONAS, Il principio di
responsabilità. Un’etica per la società tecnologica, tr. it., Einaudi, Torino, 1990. In
quest’opera si afferma l’urgenza per l’umanità di una rifondazione dell’etica in chiave
ontologica, che ponga la coscienza politica dinnanzi alla prospettiva distruttiva degli effetti
dell’arbitrio tecnologico sulla natura. L’appello ad un’ “etica della responsabilità” allude
dunque all’impegno inalienabile di una co-rresponsabilità collettiva, e dunque politica, per
una ricomposizione dell’azione dell’uomo con il senso ultimo ed il valore della vita in ogni
sua forma ed espressione.
117
Nell’alveo di una razionalità autoconfutativa, che si identifica con il paradigma delle
scienze naturali nell’affermarsi della conoscenza di tipo empirico-analitico, il problema del
valore assiologico e teleologico dell’agire umano viene ad espungere la possibilità di una
sua indagabilità razionale. Ma se il post-moderno si caratterizza come epoca della fine
dell’etica, cioè l’epoca del post-deontico, questo non significa, secondo Bauman, che le
possibilità di rendere morale la vita sociale siano venute meno; si tratta piuttosto di
sganciarsi dal modo tipicamente moderno di considerare la fondazione etica del mondo
della prassi. (Cfr. Z. BAUMAN, Le sfide dell’etica, cit., pp. 8-10).
118
Cfr. S. PETRUCCIANI, Etica dell’argomentazione, Marietti, Genova, 1988; cfr. anche F.
VOLPI, Il problema della fondazione razionale dell’etica nell’età della scienza, in
“Verifiche”, 112, 1983.
119
In questa direzione un apporto fondamentale, come rileva giustamente Pieretti, è stato
quello proveniente dagli studi della cosiddetta metaetica analitica “che identificava il
proprio compito con la descrizione avalutativa delle regole logiche del cosiddetto ‘discorso
morale’ ”. Essa, tuttavia, “oltre a non cogliere l’autentica natura del problema morale e lo
specifico significato che esso ha per l’esistenza umana, si lascia anche sfuggire la
complessa articolazione secondo cui di fatto si struttura. Si preclude dunque anche la
possibilità di individuare gli atti intenzionali, le decisioni che ne sono alla base e che lo
195
L’opera di trasformazione semiotica del kantismo di Apel ed Habermas,
o il ritorno alla distinzione aristotelica tra praxis e poiesis, che troviamo nel
pensiero della Arendt come premessa per affrontare il controverso rapporto
tra azione e discorso120, sono tutti tentativi di una rifondazione dei principi
dell’agire comunicativo. E confluiscono nel ripensamento della politica
come lo spazio in cui si possono, e dunque si devono, fissare
consensualmente, nella normatività dell’agire intersoggettivo e nella
dimensione politico-relazionale della discorsività, le finalità non meramente
contingenti dell’interagire sociale, e poter quindi costruire le condizioni di
liberazione da ogni forma di violenza sul pensiero e sull’azione attraverso le
strutture di linguaggio121. Del resto “per comprendere la vera natura della
morale, bisogna porsi sul terreno delle forme concrete in cui si manifesta.
Solo prendendo in considerazione l’esperienza effettiva dell’uomo nella sua
visione e complessa articolazione infatti è possibile individuarne l’identità.
Per questo indirizzo, negli sviluppi più recenti della riflessione sullo statuto
morale, si è diffusa la tendenza a prendere in esame l’aspetto intenzionale
dell’attività pratica dell’uomo e i suoi riflessi nel contesto dei rapporti
intersoggettivi”122.
Riflettere sul rapporto tra società tecnologica ed etica mette però, come
scrive Apel, dinnanzi ad una “situazione paradossale”. Da una parte
avvertiamo infatti il bisogno di tornare ad un’etica universale che abbia
motivano, in quanto costituiscono la condizione trascendentale del suo concreto
manifestarsi” (A. PIERETTI, Etica della persuasione e etica della testimonianza, in AA.VV.
La filosofia del dialogo, cit., p. 58).
120
Il rapporto tra azione e discorso nella Arendt consente di cogliere, a nostro avviso,
l’opportunità di ritrovare un senso rivelativo della relazione umana che possa sottrarsi al
dominio della reificazione e dell’isolamento. Queste sono forme che deprivano il soggetto
della facoltà di agire nella linguisticità del suo essere, cioè di agire politicamente. Sia l’
azione che il discorso, - ma potremmo anche dire l’azione come discorso e il discorso come
azione,- stabiliscono relazioni. E tutto ciò che depriva l’azione della sua transitività è una
“degradazione della politica a mezzo per qualcos’altro” (H. ARENDT, Vita activa, cit., p.
244).
121
Il contributo apeliano alla svolta etica ci offre la riflessione sulla possibilità di fissare
principi etici dell’agire comunicativo come apriori etico-teorici della comunicazione stessa.
Per Habermas l’individuazione di una “situazione discorsiva ideale” dovrebbe consentire di
garantire quelle pretese di validità universale del comunicare, che egli, come abbiamo già
detto, riassume in comprensibilità, verità, veridicità, e correttezza. In H. Arendt è proprio
l’analisi della correlazione tra azione e discorso che riporta in primo piano il significato di
vita activa , come un’esistenza che ha la consapevolezza di non poter rinunciare al discorso
e all’azione, poiché con esse “ci inseriamo nel mondo umano, e questa inserzione è come
una seconda nascita in cui confermiamo e ci sobbarchiamo la nuda realtà della nostra
apparenza fisica originale” (ivi, p. 187). Ed è quindi l’unica realtà che consente all’uomo di
esprimere la libertà del suo creare il mondo della vita, più che dominarlo tecnologicamente.
122
A. PIERETTI, Etica della persuasione e etica della testimonianza, cit., p. 59.
196
carattere vincolante per la società umana, dall’altro mai come in questo
momento epocale tale compito sembra più arduo e persino inattuale123.
Tuttavia l’impegno apeliano di cercare le pre-condizioni di legittimità
della comunità della comunicazione tratteggia un’etica come “metaistituzione trascendentale” nel suo essere costituita dalla “primigenia
comunità discorsiva dell’umanità”: è questa in fondo un’etica della “ragione
responsabile”, che vuole condurre ad una formazione di coscienza
“procedural-democratica” a livello giuridico-politico nello spirito dell’etica
del discorso124. Ci si muove dunque verso una definizione di “responsabilità
nella reciprocità” che presuppone che gli uomini si riconoscano però come
“inter-soggetti”125.
Si tratta però di capire, nella ricerca di giustificazione di tale progetto
etico-discorsivo, dove e quali siano le garanzie dell’intesa comunicativa, e
se possano essere individuate a priori senza ricadere in un gioco
metacomunicativo che rinvii all’infinito a se stesso; inoltre se in tale
progetto non si insinui aporeticamente una incapacità di riconoscere le
ragioni fondanti del senso relazionale dell’esistere nella “comunità della
comunicazione”.
In altri termini, viene da chiedersi come sia possibile fondare una
“primigenia e trascendentale co-rresponsabilità di tutti gli uomini per
l’ambito storico dell’interazione sociale”126 affidandosi interamente ad un
logos argomentativo, che viene a porsi come unico elemento fondante la
comunicazione stessa.
Il principio del discorso argomentativo si presenta come quell’apriori
normativo della “primigenia solidarietà di tutti i possibili partner del
discorso”, la quale riassume il contenuto ed il senso eticamente normativo
del principio del discorso stesso: bisogna vedere se la cooperazione, mirante
all’intesa e al riconoscimento di una pari dignità dei parlanti e delle
rispettive pretese in campo, sia giustificata solo in virtù della
trascendentalità della comunità illimitata della comunicazione. Ed in tal
caso non si può non notare che pare sfuggire ad Apel una adeguata
tematizzazione della stessa trascendentalità relazionale del comunicare e
del senso relazionale dell’identità comunitaria dei soggetti.
Quale profilo antropologico sottende questa assunzione della razionalità
discorsiva come accesso alla verità e al senso del comunicare?
123
Cfr. K. O. APEL, Comunità e comunicazione, cit., pp. 205-206. Questo ci ricorda, come
scrive Bauman, che nonostante la caduta di eticità del nostro tempo, dobbiamo considerare
quanto “la responsabilità morale - essere per l’Altro prima di poter essere con l’Altro - sia
la prima realtà dell’io, un punto di partenza piuttosto che un prodotto della società” (Z.
BAUMAN, Le sfide dell’etica, cit., p. 20).
124
Cfr. K. O. APEL, Discorso, verità, responsabilità, cit., pp. 335-336.
125
Ivi, p. 340.
126
Ivi, p. 341.
197
Il valore etico della comunicazione, connesso al riconoscimento di un
ideale normativo della pratica intersoggettiva, non è soprattutto possibilità
di realizzare, per ogni soggetto implicato nel comunicare, una apertura
all’alterità che si muove già sempre nell’ascolto di se stessi per essere
ascolto dell’altro?
Questa dimensione relazionale della parola sembra non prendere corpo
nell’ambito della prospettiva etica del discorso apeliana, e nemmeno in
quella di Habermas.
Se l’intersoggettività “non può limitarsi a coordinare le libertà individuali,
ma si estende anche ai progetti di vita”, e per questo “senza intersoggettività
non sarà possibile né la formazione consapevole delle proprie scelte, né
quella cooperazione sociale che è necessaria”127, bisogna però interrogarsi
su come si arriva di fatto al valore intersoggettivo del vivere.
L’impronta pragmatica impressa dalla svolta analitica incide certo
fecondamente sul tentativo di ripensare la coesistenza umana attraverso la
validità di un paradigma linguistico-intersoggettivo, le cui regole
linguistiche impegnano nel mutuo riconoscimento di una normatività
universale.
Tuttavia, il senso linguistico coesistenziale sembra rimanere opacizzato, e
con esso il senso dia-logico delle garanzie giuridiche del venire alla parola
attraverso l’esser parola128.
Nell’intento, certo pregevole, di dettare le pre-condizioni per una modalità
di vita sociale e politica che si sottragga al dominio dell’individualismo e
dell’arbitrio reificante della parola-merce, e nel ricondurre l’identità
linguistico-intersoggettiva dei soggetti nell’esercizio di un gioco
argomentativo comunitario, le cui regole di vita sono riconosciute come
garanzie di una pari dignità e titolarità di diritti della persona, l’etica del
discorso presenta, tuttavia, tratti aporetici.
L’intento di realizzare una liberazione dei parlanti dalle tirannie del
linguaggio non può non interrogarci sul costituirsi di quale libertà per il
soggetto. Crediamo che lo scopo sia quello di sostituire, come osserva
Romano, alla causalità di una comunicazione infra-sistemica, la libertà di
parlanti che si pongono nella reciprocità del “chiamare-sollecitare e del
rispondere-formare”129. Ma in questo caso non si può omettere di
qualificare appunto l’alterità , - e, attraverso di essa, la soggettività dei
127
F. VIOLA, Il diritto come pratica sociale, cit., p. 187.
Come osserva giustamente Punzi, “Il dialogo non è mai solo tramite per confermare la
validità delle norme pragmaticamente implicate nella comunicazione, ma dimensione che
coinvolge ciascun soggetto nella sua totalità,dialogica di apertura ala parola dell’altro ed
esercizio di risposta ove ciascun parlante mette in gioco se stesso e la propria
autocomprensione, avanzando non solo una pretesa di validità relativa agli argomenti, ma
una più radicale domanda di riconoscimento, di accoglienza integrale del sé nell’
unità/differenza rispetto agli altri” (A. PUNZI, op. cit., p. 315).
129
B. ROMANO, La legge del testo. Coalescenza di nomos e logos, Giappichelli, Torino,
1999, p. 137.
128
198
parlanti -: come Esso o come Tu? Come altro che mi costituisce e mi apre al
mondo in quanto condiviso e presentato nella relazione, o come causalità
del rapportarsi ad un altro polo relazionale, verso cui si dà solo la ripetizione
circolare di interazioni procedurali130?
Le regole del gioco argomentativo apeliano, che in fondo vengono a
porsi nel senso della terzietà che caratterizza ogni struttura relazionale, non
incidono sulla qualificazione della relazione stessa, e profilano quasi la
trascendentalità di un riconoscimento solo formale della regolamentazione
discorsiva, senza “precisare perché e a quali condizioni la fondazione
discorsiva
delle
norme
possa
essere
considerata
morale”.
Conseguentemente, sembra legittima la domanda se la filosofia giuridica
apeliana non sia forse pregiudicata all’origine da un’interpretazione
riduzionistica del discorso umano131.
E i rischi del riduzionismo comunicativo possono essere intesi oggi in un
senso ampio come dominio linguistico: nell’impedimento del dischiudere lo
spazio della presenza dell’altro (presenza intesa come accoglienza del suo
esser-ci nel mio mondo), nel non riconoscere il suo eccedere ogni
captazione strumentale ed il suo sottrarsi ad ogni presa fattuale dell’atto di
linguaggio, nell’annullare la dialettica inter-umana di domanda-risposta.
L’incontro dei linguaggi corre quindi il rischio di soggiacere al medio
strumentale, delegando al puro “mezzo” il dischiudere del significato. In
questo modo la parola non è più medio della relazione, ma come dice Buber,
ostacolo relazionale132. E, inevitabilmente, “produrre l’assoggettamento
dell’altro è prodursi lo svuotamento della propria soggettività; negare
all’altro il diritto primo è negarlo a se stesso”133.
Pertanto, i problemi sollevati dall’emergere di un’istanza di ricostituzione
etica del discorso nel nostro tempo, impongono di spingere questa ricerca di
senso alla radice di ciò che chiamiamo, sotto varie accezioni,
comunicazione. E’ stato questo il perno concettuale attorno al quale
abbiamo cercato di far ruotare l’intero percorso di questo lavoro, provando a
forzare la logica tecno-economica dei processi di linguaggio, per indicare la
forza coercitiva e ideologica della parola che si svincola dal parlante, cioè
130
Ciò non significa che una dimensione debba annullare l’altra, poiché non è pensabile
eliminare la qualificazione dell’alterità come Esso dalla concretezza dell’agire fattuale, cioè
quei contesti d’azione quotidiani in cui sono inevitabili quelle procedure che “richiedono
una condotta da assumere e da svolgere secondo modelli e schemi già dati e solo da
ripetere, com’è il caso di molti adempimenti amministrativi” (ivi, p. 134).
131
Nell’ambito del giuridico si viene a delineare una polarità di modelli: “un diritto
fondato sull’intersoggettività” e un “diritto ridotto a procedura discorsiva” (A. PUNZI, op.
cit., p. 303).
132
Cfr. M. BUBER, Il principio dialogico e altri saggi, tr. it., Ed. di Comunità, Milano,1958,
p. 60
133
B. ROMANO, La legge del testo, cit., p. 88. Si veda dello stesso autore, Assoggettamento,
diritto e condizione logotecnica, Bulzoni, Roma, 1992.
199
che si aliena dall’esercizio di autocomprensione del soggetto e di comprensione dell’altro.
Riconoscere la dialettica dei linguaggi del potere e sottrarsi ad una
comunicazione che produce messaggi ma crea spesso isolamento o
mancanza di trasparenza, e’ un impegno emancipativo; ma emancipazione
da cosa? E soprattutto, verso cosa? Un nuovo progetto di polis tecnologica o
una dimensione del politico che sappia coniugare le ragioni della tecnica
con quella di un’antropologia sottratta alla tecnocrazia? E che sappia
cogliere nella molteplicità la ricchezza del pluralismo, ma anche il rischio di
lacerazioni insanabili tra identità individuale e identità sociale?
Il valore trascendentale dell’argomentazione intersoggettiva vuole offrire
il luogo di un discorso pubblico che preservi ad ognuno, democraticamente,
lo spazio di parola, e che consenta il rispetto e la responsabilità per l’altro in
quanto co-implicato in un progetto comune di vita sociale. Ma come può il
ricorso al principio dell’argomentazione sottrarre la pratica sociale al
dominio e alla reificazione rapportuale?
Nel principio del discorso come luogo trascendentale dell’intesa
democratica, vi è quasi una presupposizione di fondo, quella di una
simmetria partecipativa al linguaggio, che invece non può essere assunta
come norma primaria, ma scaturisce dalla coscienza di una originaria
costituzione asimmetrica della relazionalità134.
Vi è dunque uno sfondo retrostante, a cui attingere per una
ritematizzazione della dimensione originaria dell’essere in comune, che se
pure si fa linguaggio, sopravanza il dire e, in un certo senso, lo
problematizza? Vi è un logos che si ponga anche come nomos della
relazione, nel senso che ne scongiuri la caduta, non solo formalmente, nel
disordine del simbolico e nella perdita di differenza tra ordine del reale e
ordine del simbolico?
Teniamo presente che se la dimensione del comunicare è costituiva
dell’essere uomini, non è però né risolutiva né completamente rivelativa
della sua verità, cioè della sua essenza: quanto si es-prime e quanto si vela
del sé nel comunicare?
Vorremmo aggiungere, quasi paradossalmente, che tanto la parola ricostituisce continuamente l’identità relazionale del soggetto, tanto la
proliferazione linguistica può omologare questa ricerca di identità,
trasformandola in bisogno di presenzialità comunicativa di chi non si pone
con l’altro, ma in un accanto frontale, che è già un prevalere su di esso135.
134
Abbiamo detto più volte che il concetto di asimmetria o differenza allude ad un piano di
indisponibilità dell’altro alla reificazione da parte dell’io.
135
Qui non è in gioco il mero comunicare, ma una opportunità di interlocuzione che non
inizia e non finisce nel rumore della parola. E’ un legame “originario” e “irreversibile”,
come scrive Savarese, poiché di fatto “non dipende dal comportamento o
dall’atteggiamento dell’uno o dell’altro, ma si mostra precedente, oltre che eccedente,
200
Il senso irriducibile del chi?, che Ricoeur tematizza come domanda
fondante la ricerca identitaria del sé nel passo autoriflessivo del pensiero,
può trovare una risposta identitaria se si apre ad una responsabilità dell’agire
politico come co-rresponsabilità dell’esigenza di costruire e riconoscere una
struttura relazionale, che non sia solo pragmatica comunicativa, ma una
comunicazione vitale: vitale nel senso forte di un ex-sistere che si sporge da
ogni processo di significazione dato, e che travalica, pur transitando in esso,
il circuito dei codici, poiché chiede di essere attraverso, ma anche al di là
del suo dire.
La liberazione dall’egemonia del codice, che non consente ai soggetti di
riconoscersi come risposte, ma solo come elaboratori di dati, può trovare nel
principio della comunicazione ideale un momento di propulsione feconda
per la domanda filosofica; ma ci pare che additi contestualmente al
superamento di se stessa, verso una responsabilità della parola che sia
responsabilità per l’incontro dell’altro attraverso la parola, ed anche per il
suo diritto a sottrarsi alla coercitività dell’ipercomunicazione planetaria.
E’ emblematico infatti che il ritrarsi dal circuito del discorso pubblico
mediatico viene oggi ad equivalere, quasi automaticamente, all’esclusione
del soggetto, non tanto dalla partecipazione pubblica, quanto dalla sua stessa
identità sociale. Ciò denota quasi una sorta di intolleranza verso forme di
sospensione della parola. Così possiamo intendere la rimozione del silenzio
quasi come pericolo per il pensare collettivo, poiché il suo velare la parola
svela la potenzialità di un linguaggio, e dunque di un pensiero, divergente.
Anche perché nell’odierno universo ipermediatizzato, l’incanalarsi nel
flusso della parola è la forma plateale di inclusione sociale, nel momento in
cui esprimere un assenso alla logica della produttività linguistica. Ma un
linguaggio che parla e non ascolta il suo tacere consente davvero all’uomo
di venire alla luce nella parola?
E se riconosciamo nei rapporti comunicativi odierni l’affermarsi di un
linguaggio-sistema, dobbiamo ammettere anche l’ideologia del codice che
in esso si afferma: cioè il suo non differenziarsi tra dicibile e indicibile, il
suo non ritrarsi dinnanzi all’incedere della parola d’alterità per ricercare il
senso dialogico del mondo136, il ricorso all’astrazione della soggettività
parlante e il piegarsi alle leggi di mercato dei linguaggi globali 137.
Forse per un approccio alla linguisticità che sia rivelativo del senso della
concretezza dialogica, bisogna forzare il paradigma comunicativo di stampo
l’occorrenza rapportuale in cui ricorre” (P. SAVARESE, Il diritto nella relazione, cit., p.
208).
136
Cfr. P. PRINI, Il senso dialogico dell’esistenza, in AA.VV., La filosofia del dialogo, cit.,
pp. 39-52.
137
Alla fattualità del linguaggio come sistema B. Romano propone di opporre la
controfattualità del diritto, giacché i “principi della giuridicità sono la ripresa inesauribile
del riconoscimento, come superamento dell’esclusione, che è la attualità disconoscente” (B.
ROMANO, La legge del testo, cit., p. 257).
201
prassistico-produttivo, e sostituire ad esso un paradigma antropologico
intersoggettivo come ricerca di senso per la totalità dell’esperienza umana
del linguaggio.
Viene a riqualificarsi così anche il rapporto tra parola e silenzio, che non
può uscire da un fronteggiarsi dialettico e asimmetrico tra apertura e
chiusura all’alterità, tra mancarsi della parola o assenza della parola.
In tale sforzo la modalità dell’ascolto si interpone come medio
coesistenziale tra parola e silenzio, e diventa durata e memoria di un
ricostituirsi del sé nel disassoggettamento del linguaggio al codice, della
parola al dato, del Tu all’Esso.
Il linguaggio, del resto, oltre i modi dell’affermare, forse trova
nell’interrogare il suo qualificarsi co-esistenziale, poiché il suo domandare
non si risolve nella domanda di parola, ma nell’essere l’uomo una domanda
della parola che transita in essa per portarsi al di là di essa.
Ritrovare i sensi del linguaggio è un impegno totale che, al di là del poter
dire, incontra i linguaggi del senso, attraverso cui non si consumano parolemerci ma si collabora all’opera infinita della comunanza degli uomini.
202