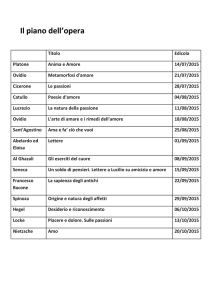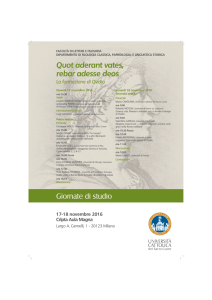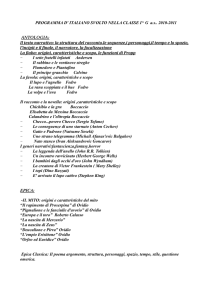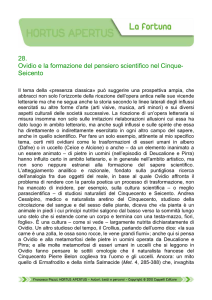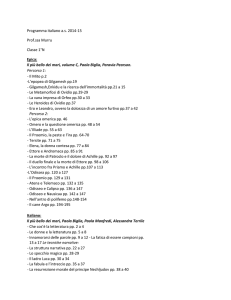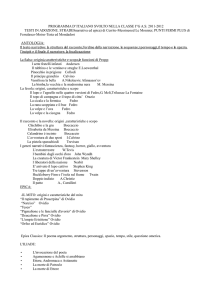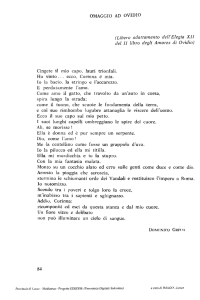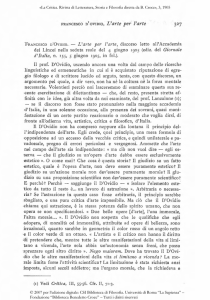L’importanza di Ovidio
di Maurizio Bettini
Per illustrare l’importanza di Ovidio nella nostra cultura, vorrei soffermarmi su due aspetti del
suo personaggio: uno decisamente letterario, l’altro invece biografico – lontano, certo, ma tale
da costituire oggi un paradigma di ‘umanità’ decisamente attuale.
Cominciamo con la letteratura. Ovidio è, almeno per noi, il creatore della “metamorfosi”. Il
suo poema in 15 libri, che porta appunto questo titolo, è un meraviglioso ciclo di avventure
mitologiche cucite assieme da questo stesso, inarrestabile filo: la mutazione, il mutare. Prima di
quella ovidiana sono esistite, in Grecia, altre opere poetiche incentrate sulla metamorfosi: come
gli Heteroiumena lett. “il diventare altro” di Nicandro e l'Ornithogonia “origine degli uccelli”
attribuita a Boio. Solo che queste opere non ci sono pervenute, possiamo solo leggerne dei
riassunti redatti da un grammatico del I o II secolo d. c. di nome Antonino Liberale. E quindi
quello di Ovidio resta per noi il primo, grandioso esempio di opera letteraria incentrata
totalmente sulla “trasformazione”. E anzi, forse non molti sanno che la parola metamórphosis,
ossia appunto “trasformazione”, è sì una parola greca, come fra un momento vedremo, solo
che in greco non è mai attestata prima di Ovidio: la prima volta che la incontriamo è proprio
nel titolo del poema ovidiano. In altre parole, potremmo dire che dobbiamo al poeta di
Sulmona non solo la prima opera ‘metamorfica’ che ci sia pervenuta, ma anche la parola che
ancora oggi usiamo per indicare questo inquietante processo. Proviamo però a chiederci: in che
cosa consiste, propriamente, una ‘metamorfosi’?
Quando si parla di metamorfosi, ci si riferisce propriamente a una mutazione di “forma”
(greco morphé) subita da un oggetto o più spesso – almeno nei miti e nei racconti di magia – da
una persona. Il preverbio greco meta- non lascia dubbi in proposito: si tratta di un “assumere
forma”, di un “formarsi” (-morphosis) che va nella direzione di un cambiamento (meta-) rispetto
allo stadio precedente. Di che natura o entità è questo cambiamento di morphé? Totale, o
almeno così parrebbe.
Facciamo subito un esempio. Allorché Deucalione e Pirra, nelle Metamorfosi di Ovidio,
lanciano sassi dietro le proprie spalle – per ricostituire l’umanità distrutta dal diluvio – ecco che
quelle pietre cominciano ad assumere forme ancora imprecise, come abbozzi cavati dal marmo,
fino a guadagnarsi l’aspetto definitivo e completo di uomini e di donne. La morphé dei sassi ha
subito il “cambiamento di forma” voluto dai numi. Prima c’erano dei frammenti di roccia,
adesso ci sono degli esseri totalmente e pienamente umani. Allo stesso modo quando Dafne,
ancora nelle Metamorfosi ovidiane, viene mutata in alloro, siamo abituati a pensare che, dove
1
prima stava una fanciulla, adesso sta qualcosa di radicalmente diverso: una pianta d’alloro,
identica in tutto e per tutto a una qualsiasi altra pianta cresciuta da un seme o da una radice.
Anche la morphé della bella Dafne si è cambiata in un’altra. Ma è davvero così?
Ciò che intendiamo dire è che, in realtà, nei racconti di metamorfosi l’oggetto finale della
trasformazione non può essere radicalmente altro rispetto a ciò che era prima. Questo
negherebbe la stessa natura metamorfica del prodotto e, in definitiva, renderebbe inutile, se
non privo di senso, il racconto creato per narrarne la vicenda. L’identità dell’oggetto
metamorfico consiste proprio, paradossalmente, nell’assommarne due: nel caso di Dafne,
l’identità umana di fanciulla e l’identità vegetale di alloro. E’ in questa ambivalenza che risiede
l’aspetto forse più saliente dell’oggetto metamorfico, ossia il suo carattere perturbante: nelle
parole di Ernst Jentsch, “il dubbio che un essere apparentemente animato sia vivo davvero e,
viceversa, il dubbio che un oggetto privo di vita non sia per caso animato”. I territori della
metamorfosi sconfinano immediatamente in quelli, perturbanti, dell’ambivalenza fra vita e
inerzia, fra fissità e movimento, fra umanità e altri regni della natura.
Dei sassi scagliati da Deucalione e Pirra, ci spiega Ovidio, «quella parte (delle pietre) che era
terrosa e umida per qualche umore, si muta nella funzione di corpo (in corporis usum); ciò che è
solido ... si muta in ossa, e ciò che già era ‘vena’ [della roccia], mantiene lo stesso nome (quae
modo vena fuit, sub eodem nomine mansit)». Ecco dunque entrare in gioco la categoria del manere del
“mantenere” del “restare”: dello stato precedente qualcosa si mantiene, resta – la solidità della
pietra che trascorre senza scosse nella solidità delle ossa, le vene della roccia che sono già
pronte ad accogliere il sangue dell’essere umano. Della nuova forma, dunque, fanno parte
anche alcuni elementi che – alla maniera di tessere trasferite da un mosaico a un altro – erano
già presenti nella precedente. Questi elementi hanno mutato funzione, certo, come la parte di
terra umida «si muta nella funzione di corpo (in corporis usum)». Però sono ancora lì. Nel seguito
del suo racconto Ovidio è ancora più esplicito: per questo, continua, perché deriviamo dai
sassi, «noi (uomini) siamo un stirpe dura e capace di resistere alle fatiche, e forniamo segni
(documenta) dell’origine da cui proveniamo».
Dunque il processo di trasformazione lascia documenta, come li chiama Ovidio, “prove”
“segni” capaci di docere, cioè di rivelare la precedente natura dell’essere metamorfico. Quei tratti
della forma originaria che erano destinati a manere nella nuova, assumendo diversa funzione,
costituiscono al tempo stesso i documenta della condizione passata. Le cose non vanno
differentemente per Dafne.
Quando la bella ninfa riceve forma vegetale, ci viene detto che «i suoi capelli crescono a mo’
di fronde, le sue braccia a mo’ di rami (in frondem crines, in ramos bracchia crescunt)». Anche in
questo caso, la metamorfosi conserva alcuni elementi che facevano parte della forma
2
precedente, mutandone la funzione. In effetti, i Romani definiscono coma “chioma” anche le
fronde di un albero, proprio come facciamo noi, mentre in latino bracchium indica
indifferentemente tanto l’arto umano quanto il ramo di un albero. La metamorfosi segue un
principio di economia, si muove sfruttando ogni contiguità – ogni possibile ponte metonimico
o metaforico – fra la forma primitiva e la nuova. Ciò che manet nella forma nuova costituisce
un segno, un documentum, della vecchia. Ma non basta. Per lo stesso motivo, all’interno della
vecchia forma questi stessi elementi costituiscono altrettante anticipazioni della forma nuova. I
due versus sono simmetrici, l’uno implica necessariamente l’altro. Terra umida, solidità, vene,
formavano una sorta di premonizione delle forme a venire, così come i crines di Dafne
anticipavano le fronde dell’alloro, e i suoi bei bracchia facevano intravedere i rami dell’albero.
Il discorso potrebbe continuare a lungo, ma il risultato sarebbe sostanzialmente lo stesso:
così per le gocce di ambra che serbano traccia delle lacrime delle Eliadi – ovvero, per le lacrime
delle Eliadi che anticipavano l’avvento delle gocce d’ambra; così per il canto dell’usignolo /
Filomela (itu, itu ...), che serba traccia del nome del fanciullo assassinato, Ity – ovvero, per il
nome del povero fanciullo, Ity, che anticipava il futuro canto dell’usignolo. La presenza di
documenta della precedente natura o, inversamente, di elementi che anticipavano la forma a
venire, costituisce un momento fondamentale nell’evento della metamorfosi: mutazione e
permanenza, premonizione e conferma sono due facce della stessa medaglia, l’una non avrebbe
senso senza l’altra. Per questo la metamorfosi, concepita nella maniera in cui Ovidio ce l’ha
presentata, costituisce un processo a un tempo così affascinante e, contemporaneamente, così
perturbante. Nella metamorfosi essere e divenire, prima e dopo, alterità e identità, si fondono
in un’entità inaudita.
Vediamo adesso il secondo aspetto della persona ovidiana che abbiamo scelto di illustrate,
quello biografico.
Nell’anno 8 dopo Cristo Ovidio si vide relegare a Tomi, remota cittadina sul Mar Nero, per
una colpa di cui non si è mai compreso bene la natura. Intrighi di corte, adulteri imperiali, lotte
politiche, perfino sospetti di congiure – non sappiamo, anche se le ipotesi formulate sono state
ovviamente innumerevoli. La frase con cui Ovidio allude all’origine della sua sventura è
divenuta quasi proverbiale (Tristia 2, 1, 207 sg.): Perdiderint cum me duo crimina, carmen et error /
alterius facti culpa silenda mihi “Due accuse mi hanno perduto, una poesia e un errore, ma la colpa
di questo secondo fatto io debbo tacerla”. Tacerla perché, continua Ovidio, essa riaprirebbe la
ferita nel cuore di Augusto, e lui non vuole far soffrire una seconda volta il monarca. Più
probabilmente, tornare a rinvangare quel factum avrebbe costituito per Ovidio ragione di nuove
disgrazie, dunque era meglio non parlarne. Ovidio si trovò così esule in una regione incolta e
remota. L’elegante cittadino romano, sicuro dei propri privilegi, il poeta acclamato e adorato,
3
viveva adesso esiliato in una terra in cui era costretto a interpretare il ruolo dello straniero.
Straniero fra uomini e donne che vivevano in un clima differente, secondo costumi differenti, e
soprattutto parlavano lingue differenti – lingue barbare, secondo la percezione che i Romani
avevano degli idiomi diversi dal loro e, ovviamente, dal greco.
Tomi, l’odierna Costanza in Romania, sorgeva ai confini nord orientali dell’impero, ed era
un luogo veramente remoto. Per Ovidio non fu facile raggiungerla. Calcolando che, com’è
probabile, egli fosse partito da Roma alla fine di ottobre dell’8, egli si imbarcò in novembre in
un porto sconosciuto dell’Adriatico, raggiungendo finalmente Corinto dopo che una tempesta
lo aveva rigettato sulle coste italiane. A dicembre attraversò a piedi l’istmo e discese nel golfo
Saronico, a Cencre, dove l’attendeva una nuova nave. Con questa Ovidio arrivò fino
all’imboccatura dell’Ellesponto, ma piegò a sinistra, e sbarcò nell’isola di Samotracia. Da qui,
con una terza nave, Ovidio arrivò a Tempira, in Tracia, vicino alle foci dell’Ebro, ma non volle
attraversare l’Ellesponto per paura delle correnti e dei venti invernali. Si era già in gennaio,
forse febbraio. Da Tempira non poté muoversi che agli inizi di primavera, stavolta a piedi,
accompagnato da una scorta che l’amico Sesto Pompeo gli aveva messo a disposizione per
difendersi dagli attacchi dei Traci. Giunse così finalmente ad Apollonia, sul Mar Nero, dove si
imbarcò sulla stessa nave che a suo tempo lo aveva condotto a Tempira, ma sulla quale non
aveva voluto attraversare l’Ellesponto. Da Apollonia raggiunse finalmente Tomi, era il Marzo
del 9 d. c. Parliamo dunque di un viaggio durato quattro o cinque mesi. Tanto ci volle al
celebre poeta romano per raggiungere il luogo della sua relegazione.
Nelle opere dell’esilio, i Tristia e le Epistulae ex Ponto, Ovidio descrive le proprie esperienze di
esiliato, di straniero in un luogo remoto dalla sua patria. E in questo modo ci permette di
dipanare un filo che, attraversando la cultura romana, connette i temi dell'exilium, dell'estraneità
e della diversità culturale. Prima di iniziare, però, vorremmo aggiungere due versi del poeta di
Roma, anzi ormai di Tomi, indirizzati all’amico Rufino. Meglio di qualsiasi altra considerazione
o ragionamento storico, infatti, queste parole possono farci comprendere qual era il
sentimento, la percezione interiore dell’esperienza dell’esiliato (Epistulae ex Ponto, 1, 3, 43 sg.):
Nonostante ciò tu pensi che le tue consolazioni
possano allentare dal cuore il morso dell’esilio (exilii morsus).
L’esilio dunque è un morso, una ‘morsa’ diremmo noi, che attanaglia il cuore nella sofferenza.
Ma che cos’è, propriamente, l’esilio per i Romani?
Costretti a ‘andar fuori’
4
Cominciamo con la parola che designa in latino questa triste condizione, cioè exilium. E’
sempre opportuno sforzarsi di vedere le esperienze degli antichi – e in questo caso quella di
Ovidio – attraverso i loro stessi occhi: ossia, attraverso le parole che essi usavano per
designarle. Per comprendere meglio che cosa significava exilium per un romano, prenderemo
un esempio dall’altro grande poeta romano, forse il maggiore di tutti i tempi: Virgilio.
Nel secondo libro dell’Eneide (2, 637 sg.), Enea racconta a Didone che cosa accadde
quando, dopo aver attraversato le fiamme e le rovine che divoravano Troia, egli giunse
finalmente di fronte alla casa paterna. Come c’era da aspettarsi Enea, da buon (futuro) romano,
avrebbe desiderato sopra ogni cosa salvare il proprio padre. Ma Anchise non intende fuggire,
anzi, distrutta Troia, rifiuta addirittura di vivere: e soprattutto abnegat ... exilium ... pati “si rifiuta
di patire l’esilio”. Questa parola è assolutamente propria in bocca ad Anchise, come lo sarebbe
in bocca a qualsiasi abitante della città distrutta: si sa che i Troiani sono gli ‘esuli’ per
eccellenza, paradigma di tutti gli scacciati e di tutti i fuggiaschi. Lo erano per Virgilio e i suoi
lettori, lo saranno nella modernità per Chateaubriand o Baudelaire, continuano a esserlo per un
poeta di oggi come Tiziano Rossi:
Detto immigrato: sopra questo ovest
(strano catrame, bagnato impiantito)
fumando sigaretta guardingo si trapianta
ignoto Enea, che mica lo si canta.
Il troiano, l’esule per eccellenza, si è dunque reincarnato nell’immigrante contemporaneo,
forse scampato anche lui a guerre spietate, e comunque vittima della moderna società
globalizzata. Torniamo dunque ai versi dell’Eneide. Ecco infatti Servio, il commentatore antico
di Virgilio, aggiungere in calce al testo questa nota: exilium dictum quasi extra solum “si chiama
exilium quasi che fosse ‘fuori dal suolo’” (Servius auctus in Vergilii Aeneidem 2, 639). Nella
percezione del commentatore, dunque, andare in esilio significa propriamente rinunciare (ex-)
al solum, al “terreno”: per Anchise quella fuga – quell’exilium – assumerebbe immediatamente il
sapore di un distacco dal “terreno” che ha sempre calpestato, il solum di Troia, la sua patria. Ed
ecco come Cassiodoro (Grammatici Latini VII, 152, 6) faceva eco a questa interpretazione della
nostra parola: “exsilium ... significa andarsene dal solum, quasi che fosse exsolium ... i nostri
antichi dicevano infatti exsoles”. A Cassiodoro interessava soprattutto la grafia della parola, non
solo il significato, ma la sua interpretazione è tanto chiara quanto quella proposta da Servio.
Chi sceglie l’exilium abbandona il proprio solum.
5
Questa etimologia antica della parola exilium è certamente falsa dal punto di vista della
linguistica storica; ma il fatto che un romano sentisse affiorare, dietro l’exilium, prima di tutto la
perdita del solum, aggiunge a questa nozione una concretezza che altrimenti potrebbe sfuggirci.
Per il tramite di questa antica etimologia l’exilium assume una dimensione apertamente fisica –
nella percezione culturale dei Romani, l’esilio è un fatto di ‘terreno’.
Da questo punto di vista, è evidente che l’exul romano si presenta (disgraziatamente) come
una figura estremamente attuale nel panorama mondiale. I migranti, i richiedenti asilo che si
affacciano oggi alle coste italiane o spagnole in cerca di un’accoglienza spesso negata, agli occhi
dei Romani sarebbero stati da considerare altrettanti exules, altrettanti Troiani che fuggono dalle
rovine fumanti della loro città. Si rammenti peraltro che i Troiani, almeno inizialmente, furono
respinti da tutte le terre in cui cercarono rifugio, anche quelle del Latium. E solo con
l’intervento di Giove poterono finalmente metter fine al loro disperato vagabondare.
Perdere la lingua, perdere se stessi
Dopo questo breve viaggio nell’exilium dei Romani, possiamo tornare all’esiliato per eccellenza,
il personaggio da cui siamo partiti: Ovidio. Come anticipavamo, infatti, il poeta affidò ai propri
versi (del resto si sa che non poté mai smettere di scrivere) il diario spirituale del periodo in cui
fu relegatus a Tomi, la piccola e sperduta città sulle coste del Mar Nero di cui abbiamo già fatto
cenno. Ora, la cosa forse più rilevante ci pare che l’isolamento a cui Augusto lo aveva
condannato non era solo geografico, ma anche linguistico. Fra le lamentele più frequenti, e più
amare, che il poeta ci trasmette, sta proprio quella di non riuscire a comprendere quel che gli
dicono gli abitanti del luogo, anzi il timore di essere deriso per questo; e reciprocamente, la
vergogna per non riuscire a farsi comprendere da loro. Tutto intorno a lui è barbarie getica,
sarmatica, pontica, nessuno che sappia ricambiargli una parola nel sermo – la lingua – della sua
patria. Egli è costretto a esprimersi a gesti, ci racconta esplicitamente; e quante volte avrà detto
“sì”, si lamenta, quando invece avrebbe dovuto dire “no”! Ma non basta. Nell’animo di Ovidio
sembra farsi strada anche una preoccupazione complementare a quella di non capire e non
esser capito: quella di perdere il controllo della lingua materna. Ma prima di rileggere queste
testimonianze ovidiane, è necessario compiere un breve excursus all’interno della cultura
romana, per chiedersi: a quale facoltà spirituale si lega, per un romano, la capacità linguistica?
Quella che l’exilium patito rischia di far perdere a Ovidio? Ennio, poeta vissuto fra il III e il II
secolo a. c. (uno dei padri della cultura e della letteratura latina) potrà aiutarci a rispondere a
questa domanda.
Ennio infatti era un osco di Rudiae, in Apulia, il quale oltre la lingua osca conosceva anche
il greco e il latino. Ed ecco come lui stesso definiva il suo trilinguismo (Gellio, Noctes Atticae 17,
6
17, 1): “Ennio diceva di avere tre cuori (tria corda), perché sapeva parlare greco, osco e latino”.
La conoscenza di una lingua sembra dunque avere direttamente relazione con il cor – anzi, per
Ennio la diversa ‘competenza’ in ciascuna lingua costituisce una sorta di cor separato. In un
certo senso, è come se Ennio, con la sua capacità di parlare tre lingue diverse, possedesse
anche tre diversi “cuori”. Questa condizione è così sconcertante, almeno per noi, che sorge
inevitabile questa domanda: ma che cosa è il cor per i Romani? Qual è la definizione, interna
alla cultura romana, di questo luogo anatomico e facoltà spirituale nello stesso tempo?
Chiediamolo ancora ad Ennio, e in particolare ad un frammento dei suo Annales.
In uno dei brani poetici più belli della poesia latina arcaica – il sogno di Ilia, figlia di Enea –
la fanciulla sconvolta racconta alla sorella il sogno che ha appena avuto: “mi pareva” le dice
“che un uomo bello mi trascinasse con sé attraverso meravigliosi boschi di salici, e rive, e
luoghi mai visti; poi restavo sola e vagavo, o sorella, camminavo a passi incerti, e ti cercavo, ma
invano, neque posse corde capessere: non c’era alcun sentiero che potesse indicarmi la direzione”.
Con questa espressione, neque posse corde capessere, Ilia vuole indicare che, smarrita nel suo sogno,
ella non poteva (letteralmente) “prendere col cuore”, cioè non riusciva a “ritrovarsi”, a
“raccapezzarsi”, come appunto capita nei sogni quando ci si sente smarriti e non si sa più dove
si è (Ennio, Annales, fr. 32 Skutsch). Come si vede, in questo caso cor indica il luogo della
consapevolezza, dell’autocoscienza. Il fatto che il cor costituisse per i Romani un luogo delle
facoltà intellettuali, comunque, ci è confermato anche da altre testimonianze, che non è qui il
caso di citare. Quello che ci interessa mettere in evidenza è che, per i Romani, il cor era sede
della consapevolezza, delle facoltà spirituali, così come quella della memoria, e per questo,
come ci hanno insegnato i “tre cuori” del trilingue Ennio, anche della capacità linguistica.
Ciò detto, possiamo tornare nuovamente a Ovidio, l’esule sul Mar Nero che si trova ad
affrontare lo shock che gli procura la sua radicale alterità linguistica (Tristia, 3, 14, 45 sgg.).
Leggiamo assieme alcuni brani delle sue opere dall’esilio, indirizzate a un amico rimasto a
Roma:
A volte mentre cerco di dire qualcosa (mi vergogno a confessarlo) mi mancano le
parole, ho disimparato a parlare (dedidicique loqui). Sono circondato da suoni traci e
sciti, e a volte mi sembra di poter scrivere in versi geti. Credimi, ho paura che nei miei
carmi ci siano parole pontiche, e che tu le legga.
Dunque Ovidio sta perdendo il possesso della lingua madre. Si sente avvolto da una sfera
verbale che non gli appartiene, ci sono momenti in cui la sua Musa, notoriamente prolifica,
addirittura suggerisce al suo orecchio (o almeno così gli pare) versi in lingua getica. Soprattutto
7
però teme che, frammiste alle parole latine, dalla sua poesia possano fiorire parole pontiche, e
che il suo colto corrispondente possa leggerle. Perché un evento del genere desta in lui tanto
disagio? Possiamo comprenderlo meglio se, in qualche modo, cerchiamo di pensare come
Ovidio, ossia se ci sforziamo di trovare l’espressione che lui avrebbe usato per descrivere la
propria lingua fuori da ogni influenza pontica: l’avrebbe infatti definita purus sermo, una lingua
“pura”. E’ proprio questa infatti l’espressione che ricorre correntemente negli autori romani
per designare, attraverso l’aggettivo che indica la purezza, il valore della correttezza linguistica,
un sermo libero da barbarismi o solecismi. Solo che purus è un aggettivo tutt’altro che neutro. Si
usa a proposito di sostanze come l’acqua, che si vuole appunto pura, ovvero per indicare l’aura
di purezza che deve avvolgere la vita e il corpo delle fanciulle, così come le pratiche religiose.
Dunque la lingua madre, mischiandosi con le parole degli stranieri, perderebbe la propria
“purezza”? E’ proprio quello che ci dice Cicerone in un passo del suo De republica (2, 7)
allorché descrive la generale corruzione in cui sono destinate a cadere le città di mare. In esse,
scrive, “è insita una certa corruzione e mutazione dei costumi (mores): vi si mescolano infatti
lingue estranee (novi sermones) e nuovi comportamenti, vi si importano non solo merci che
vengono da fuori ma anche abitudini, di modo che nulla dei patri costumi può rimanere
inalterato”. La mescolanza di lingue fa tutt’uno con quella dei modi di comportarsi e con quella
delle merci, e la conseguenza a cui simili mistioni possono condurre è solo una: la generale
corruzione.
Continuiamo con le ansie linguistiche di Ovidio. Nel suo caso, infatti, la perdita del
controllo sul latino suona perfino ironica, paradossale. Il signore della lingua di Roma che,
praticamente, balbetta (Tristia, 5, 7, 55 sgg.):
Io, vate romano (perdonate o Muse), sono costretto a dire la maggior parte delle cose in
lingua sarmatica. Mi vergogno ma lo ammetto, ormai, non usandole da lungo tempo,
le parole latine mi vengono a stento (uix subeunt ipsi uerba Latina mihi).
Per questo, prosegue Ovidio, a volte mi esercito a parlare da solo. E infine (Tristia, 5, 12,
57):
Ho paura di aver dimenticato il latino, perché ho imparato a parlare getico e sarmata.
Come si vede, la consuetudine con le lingue barbare fa balenare agli occhi di Ovidio non
solo la preoccupazione di perdere la padronanza della propria ma, si intravede, anche l’angoscia
di smarrire la sua ‘identità’, come diremmo noi; ovvero quella di perdere il proprio cor, come
8
avrebbero detto i Romani. Acquisendo il getico, il sarmatico, lo scitico, o quel che sia, il poeta
teme soprattutto di perdere se stesso. E’ come se Ovidio, a differenza di Ennio, fosse convinto
di non poter possedere più corda, ma soltanto uno: romano o barbaro, scegliere il secondo
significa rinunciare al primo. Sia come sia, la sua ansia dimostra che egli sentiva profondamente
legati fra loro lingua e identità personale, lingua e cor. Per questo il bilinguismo gli pareva non
solo temibile, ma impossibile. Ancora una volta, il mondo romano disegna sotto i nostri occhi
un altro dei drammi vissuti dall’esiliato del mondo contemporaneo: il terrore di perdere,
attraverso la propria lingua, direttamente se stessi.
Non lasciamoci sfuggire, però, un aspetto della questione che potrebbe invece rivelarsi
interessante, soprattutto per noi soggetti moderni, coinvolti (più o meno nostro malgrado)
nella globalizzazione di lingue e culture. La situazione in cui Ovidio viene a trovarsi a Tomi,
infatti, ci mette di fronte a qualcosa di paradossale. Le parole del poeta ci testimoniano infatti
un’angoscia – quella di perdere l’identità a seguito del forzato inserimento in un contesto
linguistico altro – che è tipica di chi appartiene a una comunità dominata: non di chi appartiene
a quella dominante. I sentimenti che Ovidio descrive sono piuttosto quelli che oggi manifestano i
gruppi minacciati dal cosiddetto “killer English”, come lo chiamano alcuni studiosi, ossia
l’inglese che più o meno insensibilmente “uccide” le lingue locali a vantaggio di una versione
impoverita della lingua che fu di Shakespeare o di Charles Dickens. I sentimenti che Ovidio
descrive, però, ossia il timore di perdere se stessi e le propria lingua, non sono certo quelli
espressi da chi è in possesso della lingua del potere, la lingua dominante, quale era allora la lingua
di Roma. Il paradosso vuole, dunque, che si sia spinti in qualche modo solidarizzare con le
sofferenze di Ovidio senza pensare a quegli innumerevoli Geti o Sarmati che a Roma, o nelle
province in cui si parlava Latino, avranno sofferto le sue stesse pene, se non peggiori,
sentendosi avvolti da una lingua che non conoscevano – il latino – e in procinto di perdere la
propria. Il fatto è che il poeta di Roma ha potuto scrivere di quanto gli accadeva, Geti e Sarmati
deportati come schiavi in altre terre dell’impero non hanno potuto farlo. Il relegato di Tomi,
l’uomo in procinto di perdere se stesso sommerso dalla lingua degli altri (o almeno così
racconta), resta pur sempre in possesso della lingua dominante, quella usata per tramandare le
informazioni e per stabilire le gerarchie. Può così accadere che egli senta di perdere la propria
identità linguistica fra popolazioni che continua a chiamare “barbare”, in un contesto
linguistico che lui, comunque in possesso della lingua dominante, non esita a definire bestiale:
(“sono luoghi di barbarie e di voci ferine”). E soprattutto possa scrivere e tramandare nei secoli
a venire le proprie sofferenze linguistiche.
9