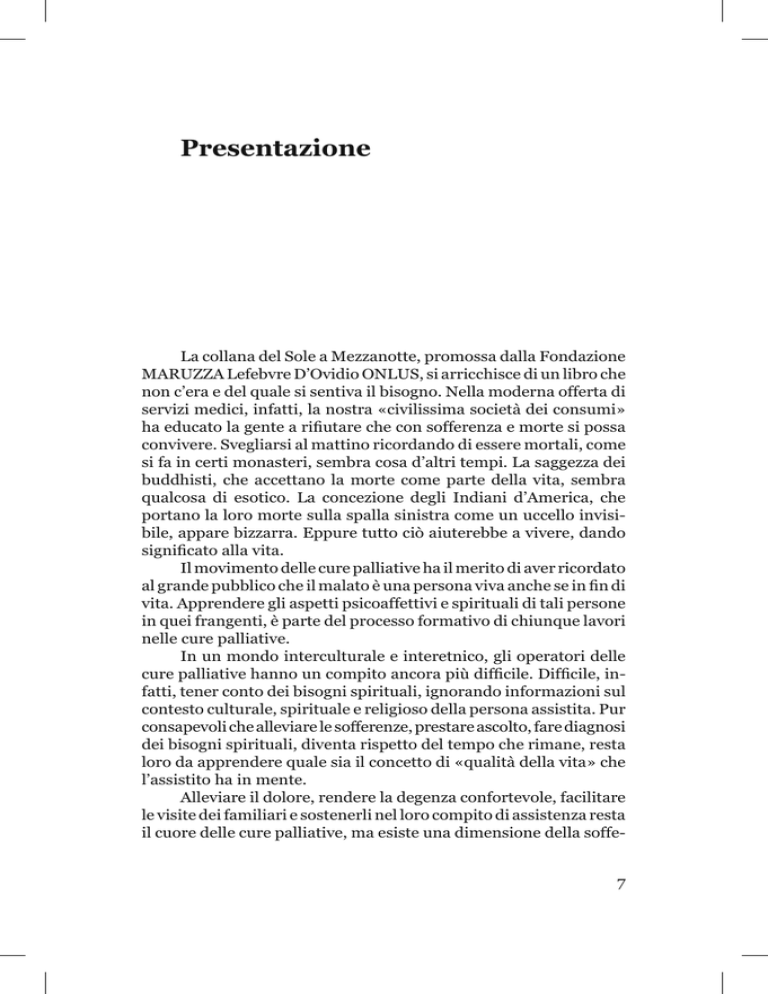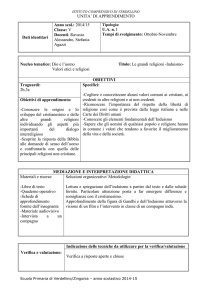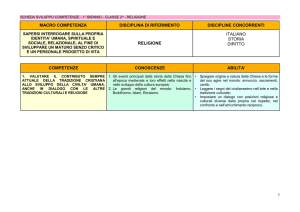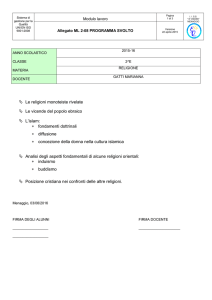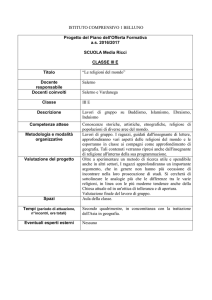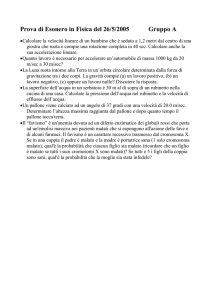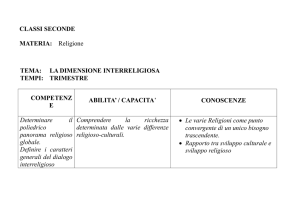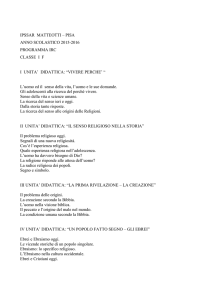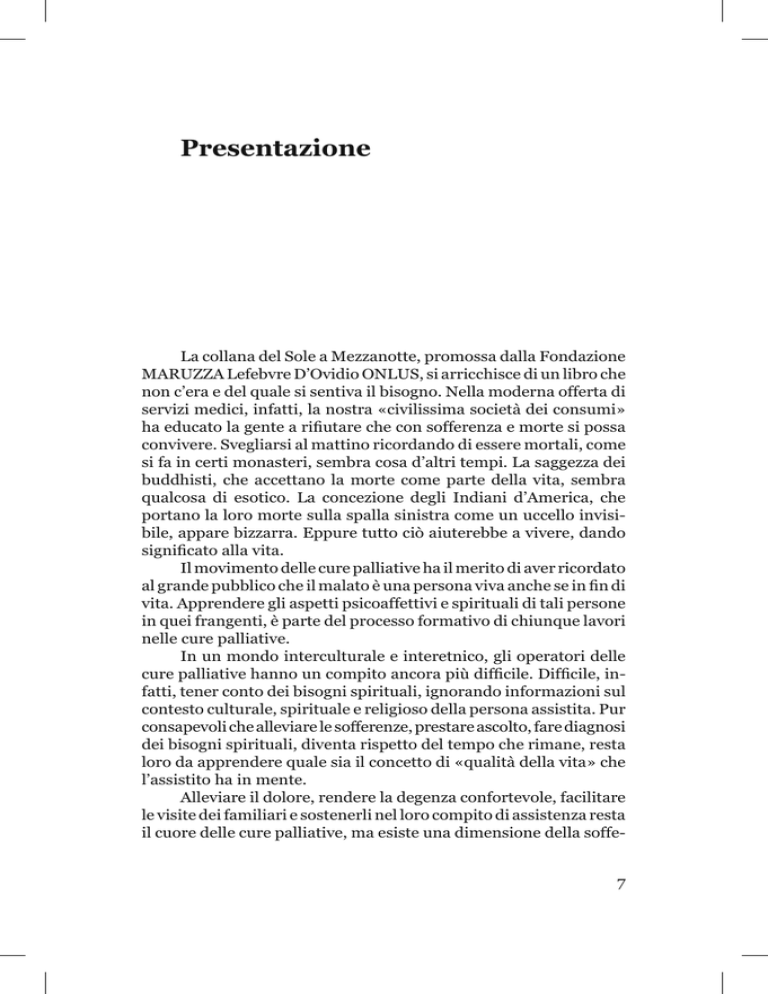
Presentazione
La collana del Sole a Mezzanotte, promossa dalla Fondazione
MARUZZA Lefebvre D’Ovidio ONLUS, si arricchisce di un libro che
non c’era e del quale si sentiva il bisogno. Nella moderna offerta di
servizi medici, infatti, la nostra «civilissima società dei consumi»
ha educato la gente a rifiutare che con sofferenza e morte si possa
convivere. Svegliarsi al mattino ricordando di essere mortali, come
si fa in certi monasteri, sembra cosa d’altri tempi. La saggezza dei
buddhisti, che accettano la morte come parte della vita, sembra
qualcosa di esotico. La concezione degli Indiani d’America, che
portano la loro morte sulla spalla sinistra come un uccello invisibile, appare bizzarra. Eppure tutto ciò aiuterebbe a vivere, dando
significato alla vita.
Il movimento delle cure palliative ha il merito di aver ricordato
al grande pubblico che il malato è una persona viva anche se in fin di
vita. Apprendere gli aspetti psicoaffettivi e spirituali di tali persone
in quei frangenti, è parte del processo formativo di chiunque lavori
nelle cure palliative.
In un mondo interculturale e interetnico, gli operatori delle
cure palliative hanno un compito ancora più difficile. Difficile, infatti, tener conto dei bisogni spirituali, ignorando informazioni sul
contesto culturale, spirituale e religioso della persona assistita. Pur
consapevoli che alleviare le sofferenze, prestare ascolto, fare diagnosi
dei bisogni spirituali, diventa rispetto del tempo che rimane, resta
loro da apprendere quale sia il concetto di «qualità della vita» che
l’assistito ha in mente.
Alleviare il dolore, rendere la degenza confortevole, facilitare
le visite dei familiari e sostenerli nel loro compito di assistenza resta
il cuore delle cure palliative, ma esiste una dimensione della soffe-
7
renza globale ancora poco curata: la sofferenza spirituale. Quella
più intima, che nasce dall’assenza di significato. Morire senza che
sofferenza, malattia e morte abbiano senso, toglie senso all’esistenza.
Questo si vede in gran parte dei malati proiettati alla fine dei propri giorni da un mondo moderno laico e secolarizzato. Fondato su
un’etica ispirata dalla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, questo
nostro mondo si è allontanato dalla saggezza delle grandi tradizioni, ma soprattutto le ignora. Rifiutando, spesso non a torto, vecchi
dogmi e dichiarazioni d’autorità, l’etica odierna sembra privata
della capacità di riflessione su temi propri del significato e del sacro.
L’homo consumens non tiene conto di questioni essenziali, quelle
che si presentano a ciascuno di fronte alla morte.
Ma si possono evitare? Possiamo vivere come inutile, superstiziosa o beghina ogni forma di spiritualità e trascendenza? Forse,
ma non prima di approfondire questa contraddizione: accettare di
non capire il perché della morte significa non essersi dati risposte
personali e meditate sul mistero di esistere e morire.
Il mondo che ci circonda non insegna a morire. A ben vedere,
la morte è l’ultimo irriducibile tabù. Morte e sofferenza sono ridotte
a fiction o a luoghi lontani: film strappalacrime, serial televisivi
melensi, documentari africani su migliaia di morti bambini, non ci
riguardano. Malattia e morte, quelle vere di tutti i giorni nelle corsie
degli ospedali, sono nascoste, per indurci a vivere senza pensarci,
dedicandosi a nuovi obiettivi materiali. La nostra società ci invita a
consumare, induce tutti a «riuscire nella vita», ma ciò è ben diverso
dal vivere. Fare, avere, essere felici, questo è ciò che conta. Poi, però,
arriva il tempo di invecchiare, affrontare la malattia e morire.
Non è importante essere religiosi per capire che non siamo fatti
per produrre e consumare. Ciascuno di noi, quando la speranza di
guarire diventa minima, si pone domande spirituali (qual è il senso
della mia vita? Esiste qualcosa di trascendente? Quale sarà, se ci
sarà, l’evoluzione del mio essere?). La religione fornisce le proprie
risposte, ma la fede resta piena di incertezze e solitudine, quando
non si possono condividere con un altro i propri dubbi.
I bisogni spirituali non sono solo del sofferente, ma anche
dei familiari che lo assistono. Cosa dire e fare dinanzi all’assurdità
del lutto, al dolore, alla mancanza di speranza? Cosa rispondere a
8
chi maledice Dio, chiedendosi «perché proprio a noi»? Molti medici, psicologi, infermieri, altri operatori sanitari pensano che non
sia compito loro. Non fa parte del mansionario né della propria
competenza. Ci si rimette ai rappresentanti dei vari culti religiosi,
al cappellano dell’ospedale, al volontario, al rabbino o al himam,
senza domandarsi se così facendo non si alimenti la confusione che
esiste tra spiritualità e religione. Questi due termini vengono, infatti,
utilizzati come sinonimi. Aderire a un credo può essere un modo
di vivere la propria spiritualità. Ma si può benissimo viverla senza
religione. La spiritualità appartiene a ciascun uomo pensante e al
suo rapporto con i valori che trascendono l’esistenza. Le religioni
rappresentano risposte preconfezionate che l’umanità tenta di dare
da sempre, attraverso un insieme di magie, pratiche, liturgie, credenze. Chi trova sostegno nella preghiera e nei sacramenti, aiuta se
stesso e chi lo assiste, sino a un punto critico nel quale perfino i più
convinti, Cristo per primo, si interrogano sul senso di solitudine e
abbandono. Chi non ha conforto da religioni diverse dalla nostra o
vive con la propria religione un rapporto difficile, rabbioso o pieno
di sensi di colpa, ha una spiritualità che il care giver deve riuscire
a leggere, imparando ad ascoltare, chiedere, aiutare. Non deve dare
risposte, perché non sono quelle che cerca chi sta di fronte all’imminenza della morte, ma può apprendere le qualità di una vicinanza
umana che aiuti a superare quel «dolore globale» del quale le cure
palliative hanno indicato dimensioni e rilevanza.
In una società laica, lo spirituale non è riconosciuto, le religioni
diverse dalla tradizionale diventano un buffo mistero. Tuttavia, è
ovvio a tutti che la fede sulla laica onnipotenza della scienza e della
tecnica non supporta lo spirito, perché non ha inventato l’aldilà. Negli
ospedali si cura «l’aldiqua» dei corpi malati. Ma quale competenza
è necessario avere sulla sfera emotiva, spirituale e affettiva della
persona che soffre? Farmaci ansiolitici e antidepressivi aiutano,
certo, ma la sofferenza resta, gli interrogativi spirituali sono lì, le
religioni parlano senza convincere del tutto, i dubbi risorgono in
occasione di una crisi o di un lutto.
Questo libro aiuta molto chi si prende cura del malato. Leggere
e interrogare la tradizione partendo dalla personale vicinanza con la
sofferenza e la morte aiuta a rivedere i propri valori, anche quando
non abbiano salde radici nei dogmi o nelle credenze religiose. La
9
solidarietà, della presenza, dell’attenzione, dell’arricchimento reciproco, dà senso alla relazione di cura. Apprendere quanto il dialogo
religioso al letto del malato ha saputo fare nei secoli, diventa così
più importante di quanto abbiamo sempre creduto.
Paolo Cornaglia Ferraris
Direttore scientifico
Fondazione MARUZZA Lefebvre D’Ovidio ONLUS
Roma
10
Prefazione
Nel mondo contemporaneo capita che i credenti appartenenti
a religioni diverse si incontrino molto più frequentemente che nei
secoli passati. Le occasioni per viaggiare e per comunicare in tempo reale in tutto il mondo sono ora maggiori rispetto a ogni altro
periodo della storia umana. Il termine «villaggio globale» rende
bene l’idea di un mondo in cui le comunicazioni hanno annullato
le distanze geografiche.
Ma non sono solo il desiderio di viaggiare e il progresso della
tecnologia a portare a contatto popoli e religioni diverse. Contribuiscono anche gli squilibri sociali portati dalla fame e da disastri
naturali, dalle guerre e da conflitti interni, che hanno spostato grandi
numeri di persone. La necessità economica ha spesso condotto le
persone a cercare lavoro anche molto lontano, in altri continenti.
Tutto questo ha contribuito ad aumentare il contatto, anche nelle
istituzioni assistenziali, tra persone che appartengono a diverse
tradizioni religiose. Fortunatamente ciò che le persone e le religioni
hanno in comune viene quasi sempre ritenuto più importante di
ciò che le divide.
Uno dei luoghi privilegiati d’incontro tra persone appartenenti
a diverse culture e tradizioni religiose è l’ospedale, dove l’uomo vive
il mistero della sua vulnerabilità e mortalità. L’ospedale è diventato
un crocevia importante dell’umanità, un punto d’incontro delle
diverse biografie personali, culturali, geografiche, religiose.1
Gli ospedali, o in senso più ampio le istituzioni assistenziali,
sono i luoghi dove le persone si aspettano che la loro individualità
1
Pangrazzi A., Introduzione, in Id. (a cura), Salute, malattia e morte nelle
grandi religioni, Torino, Camilliane, 2002, p. 8.
11
sia considerata fra le procedure cliniche per il loro benessere fisico, psicologico e spirituale. Mancando di prestare attenzione alla
persona — per esempio alle prescrizioni alimentari proprie di una
religione — aumenta la loro vulnerabilità.
È per questo che quando le società divengono multiculturali
bisogna fare sempre più attenzione nell’ambito dell’assistenza
sanitaria, non solo di bisogni clinici, ma anche ai bisogni culturali,
religiosi e spirituali. Il guarire (come difesa della vita, cura delle malattie e promozione della salute) che ha caratterizzato la missione di
Gesù e ne è stato un segno importante del regno, non soltanto deve
esserlo anche per la Chiesa, ma può diventare, nelle varie modalità
e ambiti in cui si esprime, terra di dialogo in contesti sempre più
connotati da pluralismo religioso.2
Il concetto di cultura e le sue relazioni con le convinzioni e i
valori religiosi sulla salute, sulla malattia e sulla morte sono infatti
indispensabili da capire quando si affronta il discorso della competenza nell’erogazione di servizi assistenziali sanitari. I valori culturali
e religiosi influiscono sul significato che ogni persona dà alla sua
vita. Si tratta di valori che sono vissuti quasi inconsciamente. Si
è affermato che la cultura è fortemente intrecciata alla vita di un
uomo e pervade continuamente i suoi pensieri, le sue azioni, i suoi
sentimenti e persino il suo stato di salute.3
Per molte persone le tradizioni religiose sono tra le fonti
culturali più importanti e più ricche di significati e di immagini
per interpretare la realtà, le cause, le implicazioni della malattia.
In generale si può dire che in ambito religioso le interpretazioni
più frequenti della malattia portano a concepirla come una prova,
una punizione, un messaggio. Molti studi storici e transculturali
confermano che le interpretazioni che connettono la malattia alla
sofferenza spirituale e a un rapporto con il divino sono molto antiche, ma conservano tuttora il loro profondo significato e coesistono
con le spiegazioni scientifiche del medico. Ancora, possono avere
un ruolo importante nello stesso processo di guarigione, a latere
del successo terapeutico. Infatti, il supporto sociale, la preghiera,
i rituali religiosi ed altre esperienze di spiritualità sono elementi
2
3
Sandrin L., Chiesa, comunità sanante. Una prospettiva teologico-pastorale,
Milano, Paoline, 2000, p. 108.
Leininger M., The culture concept and its relevance to nursing, «Journal
of Nursing Education», vol. 6, n. 2, 1967, p. 27.
12
significativi nelle dinamiche della fede e della guarigione, talmente
importanti che la loro considerazione e il loro supporto dovrebbero essere parte anche del ruolo del medico e degli altri operatori
sociosanitari. Anche quando la malattia ha una prognosi infausta,
la risorsa della fede e del supporto di una comunità religiosa sono
fonti importanti di ricerca di significato e di speranza.4
Le dimensioni esistenziali, morali, simboliche dell’esperienza
di malattia devono essere intese pertanto come una sfida che la
persona malata deve affrontare con le proprie risorse culturali,
personali, religiose; in questa sfida il cappellano o un altro operatore sono chiamati ad aiutare il prossimo, al di là delle differenze
religiose, e nella consapevolezza che i credenti conservano sempre
il diritto di scegliere sia il modo in cui realizzare la propria comunicazione e la comunicazione con Dio, sia le persone che sono
chiamate ad assisterli spiritualmente. Nel momento della malattia
e del dolore le domande su Dio diventano «essenziali» e le risposte
più soddisfacenti passano attraverso le relazioni. Dio è nell’accompagnamento pastorale, rispettoso e discreto, è nella relazione che
ritma gli scambi sul vissuto dell’altro, è nel camminare insieme,5 e,
seppure in presenza di religioni diverse, nella consapevolezza del
malato di essere umanamente compreso nei suo valori.
Le religioni sono le vie di vita di gran parte dell’umanità. Sono
spesso le espressioni principali delle anime di vasti gruppi di persone e portano con sé l’eco di centinaia di anni di ricerche di Dio da
parte dell’umanità. Oltre a ciò, le religioni del mondo possiedono
un impressionante patrimonio di testi profondamente religiosi e di
sapienza assimilata dai popoli e dalle culture. Questi testi hanno
insegnato a generazioni di persone come pregare, come vivere, come
morire e come prendersi cura dei morti.6
Ha affermato papa Giovanni Paolo II che
la ricerca e le cure mediche non spiegano totalmente né vincono
completamente la sofferenza. Nella sua profondità e nelle sue molte
forme, essa va considerata da un punto di vista che trascende l’aspetto
4
5
6
Lunn L., Spiritual concern in palliation, in C. Saunders e N. Sykes (a cura
di), The management of terminal malignant disease, London, F. Arnold,
1993, pp. 213-225.
Sandrin L., Chiesa comunità sanante. Una prospettiva teologico-pastorale,
Milano, Paoline, 2000, pp. 102-103.
Cfr. Paolo VI, Evangelii Nuntiandi, 53.
13
meramente fisico. Le varie religioni dell’umanità hanno sempre cercato
di rispondere alla questione del significato del dolore e riconoscono
la necessità di mostrare a quanti soffrono compassione e bontà. Per
tale motivo le convinzioni religiose hanno dato origine a pratiche
mediche volte a curare e guarire dalla malattia, e la storia delle varie
religioni narra di forme organizzate di assistenza sanitaria esistenti
già in tempi molto antichi.7
In ambito assistenziale, poi, è noto che gli stereotipi rinforzano
negativamente gli atteggiamenti verso coloro che sono diversi da
noi, eppure spesso si commette l’errore di basare l’approccio con
pazienti di cultura diversa proprio su questi stereotipi.
Si afferma spesso che la cultura sociosanitaria rischia di
trascurare l’individualità del paziente e della sua famiglia. Questa
possibilità aumenta quando l’identità culturale ed etnica dei pazienti e dei suoi congiunti è differente da quella del Paese nel quale
si viene assistiti. Infatti sono molte le barriere, a cominciare dalla
lingua, che si possono frapporre tra pazienti e operatori sanitari.
Se si afferma che il ricovero in ospedale è problematico e spesso
alienante per una persona, figurarsi quando si constata anche una
barriera culturale e religiosa.
L’esigenza di introdurre gli studi religiosi nei curricula studiorum della facoltà di medicina — ma lo stesso si potrebbe dire per
la formazione di ogni operatore sociosanitario — deriva quindi da
tre aspetti che connotano la religiosità personale: la religione come
fonte di significato, la religione come fonte di valori, la religione
come ambito per apprezzare la diversità umana.8 D’altra parte, la
medicina-scienza è la medicina di un contesto sociale e la medicina-professione non è mai una realtà neutra, bensì è la medicina di
un contesto sociopolitico. Il modo in cui le persone soffrono è un
atteggiamento profondamente sociale; la struttura delle cure della
salute è inseparabile dall’organizzazione generale della società.9
7
8
9
Messaggio per la Giornata Mondiale del Malato 2002, in Gioia F. (a cura),
Dialogo Interreligioso nell’insegnamento ufficiale della Chiesa Cattolica dal
Concilio Vaticano II a Giovanni Paolo II (1963-2005), Città del Vaticano,
Libreria Editrice Vaticana, 2006, pp. 1113-1114.
Caretta F. e Petrini M., Ai confini del dolore. Salute e malattia nelle culture
religiose, Roma, Città Nuova, 1999, p. 26.
Cosmacini G., La medicina della storia. Questione medica e questione sanitaria: antropologia e tecnologia a confronto, Milano, Epistema Editrice,
1996, p. 8.
14
L’ambito spirituale e religioso investe anche il lavoro del
medico e dell’operatore sociosanitario. Nella relazione di aiuto
e nell’accompagnamento pastorale, è però la comunità che deve
camminare insieme con il malato. La capacità di stare accanto a un
malato, soprattutto in fase terminale, prestando conforto e supporto,
pone domande che investono non solo il ruolo professionale. Stare
accanto a un malato che esprime collera, angoscia o disperazione
per la propria situazione richiede coraggio, un coraggio che il medico
può non derivare da convinzioni religiose, ma questa situazione
assistenziale richiede almeno la convinzione che le sofferenze non
siano senza uno scopo. Si può affermare che le convinzioni religiose del medico concorrono a rafforzare la sua capacità di rimanere
«vicino», in una relazione terapeutica, nella sofferenza, nella disabilità, nella morte.10 D’altra parte si è affermato che le conoscenze
religiose sono importanti per il medico, ma si può aggiungere che
ciò vale per ogni operatore sanitario, dal momento che la religione
è spesso importante per il paziente.11 I valori religiosi poi, possono
condizionare e determinare particolari valori etici, e l’assistenza
sociosanitaria in molti interventi terapeutici può richiedere scelte
etiche sulle quali è necessario anche il consenso del paziente. Senza
dimenticare che nell’ambito dell’assistenza il rispetto di convinzioni
religiose può determinare anche l’esigenza di attenersi a determinate
e particolari abitudini igieniche, alimentari, comportamentali.
È per questo che è sempre più necessario, anche nell’ambito
sociosanitario italiano — che è investito da queste problematiche in
tempi più recenti rispetto ad altri Paesi — che, per un più coerente
e consapevole processo assistenziale, gli operatori professionali e i
cappellani devono tenere conto di alcuni elementi culturali e religiosi
fondamentali per il rapporto con i pazienti. A tal fine, si indicano di
seguito alcuni consigli che possono sembrare ovvi ma costituiscono
il fondamento di ogni intervento:12
– acquistare una buona conoscenza e comprensione dei propri
modelli culturali, specialmente quando questi potrebbero condizionare l’atteggiamento verso i pazienti di differenti culture;
10
11
12
Caretta F. e Petrini M., Near to the sick, Roma, CEPSAG, 1998.
Cabot R.C., Training and rewards of the physician, Philadelphia, J.B.
Lippincott, 1918.
Hollins S., Religions, culture and healthcare. A practical handbook for
use in healthcare environments, Abingdon (UK), Radcliffe, 2006, p. 6.
15
– essere consapevole che le culture cambiano nel tempo;
– ascoltare i pazienti con disponibilità e con attenzione;
– cercare di scoprire i valori e le convinzioni del paziente, e l’importanza che rivestono nella quotidianità;
– evitare idee e risposte sulla base di stereotipi;
– essere consapevole di tutti gli elementi che costituiscono e sostengono l’identità di una persona;
– usare con attenzione le informazioni sulla cultura e sulla religione
del paziente senza farsi condizionare da opinioni personali.
– resistere alla tentazione di giudicare «una diversità» come un
elemento negativo a priori.13
Quanto si è detto finora però ha anche un’altra valenza, poiché
costituisce quel rapporto con credenti di altre religioni che la Chiesa
ha definito il «dialogo religioso della vita», nell’ambito dell’impostazione del dialogo ecumenico e di quello interreligioso sanciti dal
Concilio Vaticano II. In particolare, l’apertura della Chiesa italiana al
fenomeno migratorio, la sua disponibilità alla solidarietà anche con
i credenti di altre religioni, hanno fatto della diversa appartenenza
religiosa una base di confronto e di dialogo interreligioso.
Cosa significa esattamente, in una prospettiva cristiana, «dialogo
interreligioso»? Va subito detto che il dialogo interreligioso non è un
semplice studio delle varie religioni o una loro comparazione — nonostante questa operazione sia importante e utile — né uno sforzo per
persuadere le altre persone ad abbracciare la propria religione.
Il dialogo interreligioso è un incontro di persone di diverse
convinzioni religiose, in un’atmosfera di libertà e di apertura,
con lo scopo di ascoltarsi reciprocamente, per cercare di capire
la religione dell’altro e, pieni di speranza, cercare possibilità di
collaborazione. Si spera che l’interlocutore contraccambi, perché
il dialogo naturalmente presuppone reciprocità. La reciprocità è
nella natura del dialogo. L’altro elemento fondamentale è l’ascolto. È importante sottolinearlo perché le persone possono trovare
difficoltà nell’ascoltarsi reciprocamente. La propensione all’ascolto
implica apprezzamento per ciò che l’altra persona è, crede, prega o
vive, insieme con la convinzione che vale la pena di sacrificare del
tempo per essere informati.
13
16
Purnell D.L. e Paulanka J.B., Guide to culturally competent health care,
Philadelphia, F.A. Davis Company, 2005, p. 4.
Il dialogo interreligioso può aiutare ogni interlocutore a crescere nella sua fede, se tutti si impegnano in un calmo e sincero
confronto di credenze religiose, pratiche e valori. Qualche volta
una convinzione religiosa, e la stessa fede, è meglio apprezzata,
ulteriormente studiata, approfondita, capita e vissuta con grande
convinzione, quando viene illuminata da altri punti di vista.
Un cammino che pone delle sfide a livello spirituale. Da una
parte, come si è detto, un arricchimento della propria fede: attraverso l’esperienza e la testimonianza dell’interlocutore si potranno
scoprire in modo più profondo alcuni aspetti e dimensioni del mistero divino meno percepiti e, forse, più trascurati dalla tradizione
cristiana. Dall’altra parte, il dialogo interreligioso implica una
purificazione della propria fede: l’occasione dell’incontro spingerà
spesso a mettersi in discussione, sia che si tratti di rivedere alcune
credenze non fondate o pregiudizi storici, o anche di modificare
concezioni e prospettive limitate.
Si tratta di un dialogo che non è stato dettato dalle necessità
suscitate dalle correnti migratorie, poiché già la lettera enciclica
«Ecclesiam suam» di papa Paolo VI, pubblicata nel 1964 durante i
lavori del Concilio, segna l’ingresso del dialogo interreligioso nella
prospettiva del programma di rinnovamento conciliare della Chiesa
e costituisce una dimensione importante dell’apertura al mondo
voluta dal Concilio Vaticano II. Lo stesso termine «dialogo» (colloquium) appare qui per la prima volta in un documento ufficiale
della Chiesa.
La lettera enciclica «Ecclesiam suam», peraltro, preannuncia
quanto il Concilio Vaticano II affermerà riconoscendo gli elementi
positivi che sono contenuti nelle religioni non cristiane e registrandone i valori spirituali e religiosi. Il Concilio, infatti, interpreta il
rapporto con le religioni attraverso il desiderio, espresso nei documenti conciliari, di riconoscere tutto ciò che si trova di «verità e
grazia», non solo nella vita religiosa individuale dei fedeli di altre
religioni, ma anche negli elementi oggettivi che compongono le
tradizioni religiose stesse.
Nel Concilio Vaticano II si parla del dialogo interreligioso in
diversi documenti e con diverse accentuazioni: ecumenico (Decreto Unitatis redintegratio), interreligioso (Dichiarazione Nostra
aetate), con i non credenti (Costituzione pastorale Gaudium et
spes), missionario (Decreto Ad gentes), ma ciò che accomuna queste diverse forme come attività specifica o come metodo sembra
17
essere un clima di incontro e collaborazione con disponibilità a
comprendere.
Il documento pubblicato dall’allora Segretariato per i non cristiani,14 intitolato Atteggiamento della Chiesa di fronte ai seguaci di altre
religioni, del 1984, distingue quattro forme di dialogo interreligioso.
Si tratta: a) del dialogo della vita accessibile a tutti, in cui le persone
si sforzano di vivere in uno spirito di apertura e di cordialità nei confronti del prossimo, condividendo le proprie gioie e i propri dolori,
i problemi e le preoccupazioni; b) dell’impegno comune nelle opere
di giustizia e liberazione umana, in cui in un «dialogo delle opere» i
cristiani e i credenti di altre fedi collaborano per lo sviluppo e la liberazione di tutti i popoli; c) del dialogo intellettuale degli specialisti,
in cui in un dialogo degli scambi teologici gli specialisti cercano di
approfondire la loro comprensione delle rispettive tradizioni religiose
e di apprezzare i reciproci valori spirituali, sempre tenendo conto
della necessità della ricerca della verità ultima; d) della condivisione
di esperienze religiose nella ricerca comune dell’Assoluto, un dialogo
dell’esperienza religiosa nel quale le persone, radicate nelle proprie
tradizioni religiose, condividono le ricchezze spirituali, per esempio
per quanto riguarda la preghiera e la contemplazione, la fede e i vari
modi di cercare Dio o l’Assoluto.
È chiaro che queste forme di dialogo non si escludono reciprocamente, ed è anche evidente che da nessuno ci si aspetta che si pratichino tutte le forme di dialogo in tutte le circostanze; ma quando un
credente incontra un’altra persona con convinzioni religiose diverse,
dobbiamo cercare almeno una forma possibile di dialogo.
È interessante però notare che il dialogo della vita ha un ruolo
primario, poiché
implica attenzione, rispetto e accoglienza verso l’altro, al quale si riconosce spazio per la sua identità personale, per le sue espressioni, i suoi
valori. [...] Ogni seguace di Cristo, in forza della sua vocazione umana e
cristiana, è chiamato a vivere il dialogo delle opere e della collaborazione
per obiettivi di carattere umanitario, sociale, economico e politico che
tendano alla liberazione e alla promozione dell’uomo.15
Queste affermazioni possono essere lette come il riconoscimento che il dialogo interreligioso si estende, al di là della propria
14
15
18
Oggi Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso.
Giovanni Paolo II, Udienza generale, 21 aprile 1999.
sfera di esperienza religiosa, all’impegno comune, religiosamente
ispirato, per l’uomo e la società; un impegno comune per la giustizia
e la liberazione dell’uomo che ha priorità sul discorso teologico. I
membri delle diverse tradizioni religiose possono e devono lavorare
insieme, a partire dalle loro rispettive convinzioni religiose, per
la promozione di un mondo più umano, preparando un discorso
teologico tra specialisti e uno scambio autentico di esperienze
religiose.
I cristiani portano al dialogo un universalismo che crede fermamente nel diritto della persona umana alla libertà religiosa.
Ma anche il cristianesimo può ricevere un apporto utile dal
confronto e incontro con altre religioni e con le loro caratteristiche
culturali: lingue, categorie filosofiche, espressioni rituali e stili locali.
Nel dialogo interreligioso si tratta di rispondere a un appello «divino» perché lo scambio e la condivisione conducano a una mutua
testimonianza della propria visione religiosa, a un’approfondita
conoscenza delle rispettive convinzioni e a un’intesa su alcuni valori
fondamentali.
Si è affermato che un punto di partenza può essere costituito
dagli interrogativi fondamentali che ogni uomo religioso, a qualunque tradizione religiosa appartenga, si pone: «Cos’è l’uomo? Qual
è il significato del dolore, del male, della morte, che malgrado ogni
progresso continuano a sussistere? Cosa valgono queste conquiste
a così caro prezzo raggiunte? Che cosa reca l’uomo alla società, e
cosa si può attendere da essa? Cosa ci sarà dopo questa vita?». E
questi interrogativi — lo sappiamo bene — sono posti da sempre
più persone e con rinnovata intensità.
Anche la dichiarazione Nostra aetate recepisce «gli enigmi
della condizione umana, che ieri come oggi turbano profondamente
il cuore dell’uomo» e la cui risposta «gli uomini attendono dalle
varie religioni», indicando
la natura dell’uomo, il senso e il fine della nostra vita, il bene e il peccato,
l’origine e il fine del dolore, la via per raggiungere la vera felicità, la
morte, il giudizio e la sanzione dopo la morte, infine l’ultimo e ineffabile mistero che circonda la nostra esistenza, dal quale noi traiamo la
nostra origine e verso cui tendiamo.
Ha affermato Giovanni Paolo II che
in ciascun Paese del mondo, in ogni città e villaggio, in ogni famiglia,
addirittura in ogni vita umana, ci troviamo di fronte all’onnipresente
19
realtà della sofferenza umana. Il «libro non scritto» della storia dell’umanità parla costantemente del tema della sofferenza. (Salvifici
doloris, 7)16
Naturalmente la domanda sull’uomo e le domande che l’uomo
si pone portano alla domanda su Dio; attraverso il dialogo, allora, i
cristiani e i loro interlocutori camminano insieme verso la verità.
Ma il dialogo presuppone la conoscenza, di qui la necessità di
leggere le tradizioni religiose nella prospettiva di quelle domande
sul senso della vita, della sofferenza, della morte e sulla prospettiva
escatologica, che ancora oggi interpellano l’uomo credente, qualunque sia la sua fede religiosa. La natura umana è universalmente
condivisa: ogni essere umano è essenzialmente corpo e anima,
materia e spirito, un essere dotato di intelligenza e volontà. Ciò che
più conta, però, è che ogni essere umano ha un desiderio, nascosto o
manifesto, consapevole o inconsapevole, per un Dio trascendente e
che, forse, il dolore e la sofferenza possono rappresentare momenti,
seppur difficili, di meditazione sulla vita e il destino di ogni essere
umano.
16
Giovanni Paolo II, Alle Autorità religiose dell’India, Calcutta, 3 febbraio
1986.
20
diciannove benedizioni (in origine diciotto), si prega per il «raduno
dei dispersi», la «riedificazione di Gerusalemme» e la «venuta del
discendente del tuo servo Davide».
Linee-guida per gli operatori sanitari
L’Ebraismo è una religione con una forte affermazione della
vita. Il principio religioso pikkuach nefesh, la «salvezza della vita»,
che connota tutta la letteratura ebraica, è tanto importante che
per salvare una vita è possibile trasgredire i comandamenti e le
proibizioni della Legge. Le tre eccezioni sono l’omicidio, l’incesto
l’idolatria. Con questa convinzione è evidente che il paziente ebraico
coopererà, nella maggior parte dei casi, in tutti i trattamenti e le
terapie, comunque spiacevoli.140
Molto aiuto deve essere dato al paziente da parte di coloro
che lo assistono. Per far questo lo staff assistenziale deve avere
una conoscenza di base dei rituali ebraici e delle osservanze e una
sommaria comprensione della filosofia di vita dell’Ebraismo, magari
consultando anche la famiglia del paziente.
In ospedale i pazienti potrebbero chiedere di osservare il
rituale del Sabato; qualche incoraggiamento può essere fatto alla
famiglia per ricreare intorno a lui l’atmosfera della festa. Se il vino
e il pane fossero dannosi per il paziente, la benedizione può essere
eseguita su un succo d’uva e, nel caso del pane, su due pani ricoperti
di semi di papavero.
In ogni caso lo staff non dovrebbe meravigliarsi se un paziente
ebreo si immerge nella lettura di un testo religioso del Sabato e
prega. Celebrare il Sabato durante il ricovero in ospedale è un uso
molto frequente, anche se lo stato di malattia sospende molti doveri religiosi; così, ad esempio, è possibile accendere la luce nella
stanza di degenza.
• Alimentazione: le problematiche religiose di un paziente ebreo
sono numerose, legate alle diverse pratiche rituali quotidiane.141
140
141
McGilloway O. e Myco F. (a cura di), Nursing and spiritual care, London,
Harper & Row, Publishers, 1995, p. 97.
Di Segni R., L’Ebraismo, in S. Aletti, Salute e salvezza. Le religioni di fronte
alla nascita, alla malattia e alla morte, Torino/Bologna , Claudiana/EDB,
2003, p. 49.
84
Si possono citare in primo luogo le regole alimentari; per garantirne pienamente l’osservanza, ogni cibo cucinato dovrebbe
essere preparato sotto controllo: le regole riguardano non solo gli
alimenti ma anche la loro preparazione: Kasherut è il sistema di
leggi che riguardano l’alimentazione, sia rispetto ai cibi concessi
che al modo di cucinarli. Pertanto, molti pazienti ebrei possono
chiedere cibo kasher cioè carne di agnello, manzo o pollo macellata
in modo particolare. Assolutamente proibito è il maiale, mentre
sono permesse le qualità di pesce con le pinne e con le squame,
non i crostacei. Si deve anche ricordare che il latte e la carne non
devono essere presenti insieme nel pasto.142
Molti, ma non tutti, gradiranno cibi vegetariani, se quello kasher
non è disponibile. Il paziente naturalmente dovrà essere consultato
sulla sua osservanza delle regole alimentari.143
In ambiente ospedaliero il problema si può risolvere con servizi
di catering, con l’uso dei pochi cibi consumabili senza controllo o
consentendo l’invio di pasti da casa. La pratica dei digiuni interferisce poco, perché per la gravità delle loro condizioni i pazienti
ne sono esentati.
• Pudore: un’ulteriore raccomandazione, in ambito più generale,
riguarda la tutela del pudore e della modestia sia maschile che
femminile. In generale gli ebrei ortodossi considerano immorale
toccare donne che non siano le loro mogli, così come alcune
ebree ortodosse preferiscono evitare di stringere la mano agli
uomini.
Alcuni uomini ebrei preferiscono tenere sempre il capo coperto,
in particolare quando pregano. Alcune pazienti ebree ortodosse
142
143
Ciò che è adatto (Kasher) è individuato da regole precise: tra gli animali
acquatici solo quelli con pinne e squame (non i crostacei, né i molluschi);
tra gli animali terrestri solo quelli erbivori con unghia fessa, zoccolo spaccato e rumine (quindi bovini, ovini e caprini); sono permessi polli, oche,
tacchini e anatre. Sono invece esclusi i cammellidi, gli equini, lepri, conigli,
uccelli rapaci. È proibito il maiale. La macellazione deve avvenire mediante
il taglio dell’esofago e della trachea, in un solo colpo,; la carne deve essere
privata del sangue. Non possono essere mangiate la testa, le interiora e
porzioni di posteriore (Procaccia M., La donna ebrea, in AA.VV., La donna: memoria e attualità, vol. IV, La donna nelle altre religioni, Città del
Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2001, p. 14.
Caretta F. e Petrini M., Ai confini del dolore. Salute e malattia nelle culture
religiose, Roma, Città Nuova, 1999, p. 140.
85
vogliono vestire con abiti che non scoprano le braccia e, se sposate,
spesso indossano una parrucca oppure tengono sempre coperta
la testa.
Per salutare una donna ebrea ortodossa non si dovrebbe offrirle di
stringerle la mano ma piuttosto salutarla con un cenno del capo. Un
paziente o una paziente ebrea ortodossa preferiranno essere curati
da operatori sanitari dello stesso sesso. In ambito pediatrico se una
mamma dorme accanto al letto del suo bambino e quello del letto
vicino è assistito dal padre, è preferibile una stanza singola, poiché
le leggi religiose proibiscono a una donna sposata di dormire nella
stessa stanza con un uomo che non sia suo marito.
• Igiene: gli ebrei desiderano lavarsi le mani prima dei pasti. Sono
sufficienti una caraffa e una bacinella, per un paziente costretto
a letto.
• Preghiera e osservanza religiosa: gli obblighi della preghiera,
nell’ambito di un’istituzione assistenziale, si scontrano con difficoltà ambientali, anche perché per pregare gli uomini devono
indossare lo scialle e i filatteri, che richiedono spazi puliti e non
maleodoranti, oltre a un’indispensabile discrezione. Il paziente
ebreo prega tre volte al giorno (mattina, pomeriggio, sera).Queste problematiche naturalmente valgono anche per la festività
del Sabato, tenendo conto che è la festa principale, nel quale è
obbligatoria l’astinenza completa da qualsiasi lavoro. In tal modo
si esprime la fede nel vero Creatore e trasformatore del mondo.
L’importanza della festa del Sabato è sottolineata anche dal fatto
che i giorni della settimana, in ebraico, sono chiamati semplicemente «primo giorno», «secondo giorno» e così di seguito fino
al sesto giorno; il settimo giorno interrompe la numerazione per
assumere il nome di Shabbat. Secondo la tradizione ebraica, il
Sabato inizia prima del tramonto del venerdì e si conclude il giorno
successivo all’apparire delle prime tre stelle.144
Alcuni pazienti possono desiderare, com’è tradizione, di accendere
due candele e festeggiare l’inizio con un bicchierino di vino o succo
di frutta e con un pane speciale. Il paziente potrebbe richiedere
che un familiare o un rabbino provvedano a ciò. Come si è detto,
il Sabato, il lavoro è proibito: tale tradizione comprende anche
lo scrivere o l’accendere la luce, ma può anche non essere intera144
Garribba P., Ricorda il giorno del Sabato, in Id. (a cura), Le feste ebraiche,
Roma, Edizioni Com Nuovi Tempi, 1999, p. 15.
86
mente rispettato da un ebreo riformato. Si dovrebbe chiedere ai
congiunti o al paziente cosa possa o non possa fare.
Le altre feste che potrebbero interessare una persona ebrea
ricoverata in ospedale sono:
– la Pasqua, in marzo o aprile, quando è permesso solo pane azzimo e altri particolari cibi kasher che possono essere richiesti dal
paziente. La celebrazione dura otto giorni — sette per gli ebrei
riformati e gli ebrei provenienti da Israele. È particolarmente
importante la prima notte; un rabbino o un credente potrebbero
desiderare di portare al paziente un cibo rituale, seder, preparato
con condimenti tradizionali e simbolici. Anche ebrei non particolarmente osservanti possono essere sensibili a questa festa;
– il giorno dell’Espiazione, in settembre o ottobre, è un giorno di
digiuno: questa osservanza deve essere pertanto considerata nell’ambito di una terapia medica, in particolare per pazienti ebrei
ortodossi. È il giorno più importante dell’anno, e anche ebrei non
particolarmente osservanti spesso desiderano celebrarla con il
digiuno e la preghiera.145
• Assistenza del paziente morente: un dato importante è che la
famiglia è tenuta a restare al fianco del paziente in punto di morte
in segno di interessamento, mostrando rispetto per il familiare.
Vi è inoltre un dovere spirituale di vegliare il morente durante il
trapasso. I componenti della famiglia ebraica recitano delle preghiere, sperando di ottenere la benedizione da parte di Dio, che è
il vero Giudice nel momento della morte. In ospedale, la famiglia
spesso si preoccupa che venga prestata un’assistenza adeguata al
paziente che sta morendo in un ambiente estraneo:
– se il paziente o i familiari chiedono di parlare con il rabbino
della famiglia, questi deve essere chiamato. Se non è reperibile,
occorre chiedere al paziente se è ortodosso o liberale e chiamare il rabbino locale della stessa osservanza. Il rabbino o un
familiare possono desiderare di recitare una preghiera dopo la
morte del paziente, ma ciò non è tassativo;
– dopo la morte, in alcuni casi il figlio o il parente più prossimo
possono chiudere gli occhi o la bocca del congiunto;
145
Caretta F. e Petrini M., Ai confini del dolore. Salute e malattia nelle culture
religiose, Roma, Città Nuova, 1999, p. 141.
87
– alcuni ebrei ortodossi possono chiedere che il corpo rimanga
sul posto fino a che non sia celebrato il funerale, ma la maggior
parte dei congiunti accetterà che il corpo sia portato in camera
mortuaria, a condizione che possa rimanergli vicino;
– se il paziente muore di sabato, in ogni caso dovrebbe rimanere
nel luogo di morte, poiché il corpo non può essere spostato in
quel giorno;
– ai parenti in lutto, se non sono sicuri su quello che bisogna fare,
può essere consigliato di contattare la loro sinagoga o il loro
rabbino per le modalità del funerale. Se non sono membri di
una particolare sinagoga, possono essere aiutati a contattare
quella locale o il rabbino locale;
– gli ebrei ortodossi devono essere seppelliti e il funerale, se
possibile, dovrebbe aver luogo entro 24 ore. Gli ebrei liberali
possono essere cremati, ma la sepoltura è più frequente: in ogni
caso il funerale dovrebbe avvenire il più presto possibile.
• Altro: un rabbino sarà consultato nel caso dell’adozione di complesse decisioni mediche o etiche. Il Sabato, in caso di pericolo di
vita, l’Ebraismo permette alcune deroghe: può essere chiamato
telefonicamente un congiunto in caso di estrema necessità; ancora, se normalmente non è consentito viaggiare, un malato può
essere trasportato in autoambulanza. La dimissione non dovrebbe
avvenire durante la festa del Sabato, poiché il paziente ebreo non
potrebbe usare il telefono per avvisare i congiunti, non potrebbe
usare l’automobile o ricorrere ai mezzi pubblici. È lecito solo
camminare a piedi per tornare a casa.
Un ebreo fondamentalista, ancor più un rabbino, non dovrebbe
essere assistito da un infermiere donna, alla quale non è concesso
neanche stringere la mano.
La famiglia di un paziente ebreo, tradizionalmente, usa offrire
doni agli infermieri durante la degenza come modo per assicurare
un buon livello assistenziale.
• Assistenza: un ebreo riformato o liberale non si opporrà alla
somministrazione di farmaci il Sabato, e se le condizioni sono
gravi anche alla somministrazione di farmaci non kasher (cioè
contenenti sostanze suine o emoprodotti o gelatina).
Interventi chirurgici, esami diagnostici e altre procedure non
dovrebbero essere previste per il Sabato o altri giorni sacri.
Un ebreo ortodosso si aspetta un clima di rispetto per le sue convinzioni religiose.
88
•
•
•
•
•
Tutti i farmaci dovrebbero essere kasher, l’eccezione è permessa
solo nel caso di grave pericolo di vita poiché il dovere di salvare
una vita supera ogni proibizione.
In un giorno sacro è preferibile iniettare un farmaco piuttosto che
somministrarlo per via orale.
Nascita: un ebreo ortodosso non toccherà sua moglie durante il
parto, poiché impura per la perdite di sangue.
I bambini maschi sono circoncisi otto giorni dopo la nascita; si
può rimandare il rito se il bambino è affetto da itterizia, è nato
prematuro o per altre controindicazioni. Per le bambine è richiesta
solo l’imposizione del nome.
Per gli ortodossi, il nome alla bambina sarà imposto il sabato dopo
la nascita, al bambino dopo la circoncisione.
Tra gli ebrei riformati hanno luogo cerimonie di benedizione sia
per i bambini che per le bambine, svolte durante la preghiera del
sabato in sinagoga.
Atteggiamenti degli ebrei ortodossi verso l’aborto spontaneo e
la morte neonatale: prima di 30 giorni al feto non è accordato lo
status di persona e non è richiesto nessun obbligo religioso.
Quando il feto ha raggiunto i quaranta giorni o più, è considerato
portatore di «un soffio di vita» e deve essere considerato come
una persona vivente. Dopo quaranta giorni di gravidanza, in caso
di aborto spontaneo, il feto deve essere seppellito.
Gli ebrei ortodossi generalmente non desiderano vedere il corpo
di un bambino nato morto, tuttavia vi possono essere eccezioni.
Atteggiamenti degli ebrei riformati verso l’aborto spontaneo
e la morte neonatale: si ammette che la perdita di un bambino
arrechi dolore ai genitori o agli altri membri della famiglia, così
da prevedere una formale espressione del loro dolore.
Anche se il funerale non è possibile, un rabbino conduce un rituale
a casa, se i genitori lo desiderano.
Per un bambino nato morto è possibile celebrare un rito al momento del seppellimento.
Esami post mortem: gli ebrei ortodossi non sono favorevoli ad
accertamenti diagnostici sul corpo del defunto, se non richiesti
dalla legge. Si pone molta enfasi sull’integrità fisica del defunto.
Gli ebrei riformati e liberali sono invece favorevoli nella prospettiva
che questo possa essere utile per altri pazienti.
Norme degli ebrei ortodossi per l’esecuzione di esami post mortem: il corpo del defunto deve essere posto su un telo bianco che
89
deve raccogliere i fluidi corporei e non deve essere supino. I prelievi devono essere limitati al massimo e, se possibile, dovrebbero
essere evitate incisioni. Dopo gli accertamenti, gli eventuali organi
prelevati dovrebbero essere correttamente riposizionati nel corpo,
se possibile, e il telo bianco dovrebbe avvolgerlo.
• Donazione di organi e tessuti: la donazione di organi è permessa
quando si prevede un immediato e specifico trapianto.
La legge ebraica non permette il prelievo di organi per la ricerca
o per una banca di organi.
Fondamentalmente il prelievo di organi è permesso per salvare
una vita. Questo principio supera qualsiasi obiezione al rispetto
del corpo del defunto o al ritardo della sepoltura.
• Norme degli ebrei ortodossi per la donazione di organi e tessuti:
il prelievo di organi è ammesso solo per salvare una vita.
Generalmente un ebreo ortodosso accetta una trasfusione, la
somministrazione di emoderivati, il trapianto di midollo osseo,
cornea e rene. Tuttavia un dottore della legge esaminerà il donatore
prima dell’esecuzione di queste terapie.
Il principio fondamentale è che il corpo deve essere sepolto integro; si accetta la donazione di sangue e midollo osseo, in quanto
elementi che il corpo può riprodurre.
• Norme degli ebrei riformati per la donazione di organi e tessuti:
si permette il prelievo di organi anche quando non è previsto un
immediato trapianto e anche quando questo è destinato a un
miglioramento della qualità della vita (per esempio il trapianto
di cornea).
La donazione di organi da un vivente è permesso solo quando il
prelievo non mette in pericolo la vita del donatore (per esempio
il prelievo di un rene o di midollo osseo).
Un paziente ebreo può ricevere un organo di un altro paziente ebreo
o non ebreo quando questo trapianto è indispensabile per salvare
la vita. Questo principio si applica anche per organi provenienti da
animali (per esempio una valvola cardiaca suina) poiché salvare
una vita è più importante di qualsiasi regola religiosa.146
146
Hollins S., Religions, culture and healthcare. A practical handbook for use
in healthcare environments, Abingdon Oxford (UK), Radcliffe Publishing,
2006, pp. 82-83; Purnell D.L. e Paulanka J.B., Guide to culturally competent health care, Philadelphia, F.A. Davis Company, 2005, pp. 328-330.
90
L’assistenza al malato
In ambito sociale, i musulmani devono preoccuparsi, anche
personalmente, dei deboli, dei bisognosi e degli orfani, provvedendo
loro con cibo e ogni sorta di sostegno; ne deriva che sono richieste
anche la solidarietà e la responsabilità sociale verso il malato.104 Più
che l’osservanza rigorosa delle norme rituali, questa attenzione verso
il bisogno deve essere letta come un segno evidente di autentica religiosità (Corano II,177). Una sura invita i fedeli non solo a visitare
i malati ma dice anche che «le porte del paradiso vengono aperte
solo a chi riesce a sollevare il peso dalle spalle di un ammalato».
Il Profeta affida ai suoi fedeli sette direttive — cinque o sei,
secondo altre versioni — ma tutte comprendono il precetto di visitare
il malato, sottolineando naturalmente che bisogna fare qualsiasi cosa
per migliorarne le condizioni; in particolare, un moribondo non deve
mai essere lasciato solo. Nella letteratura hadith sono fortemente
sottolineati i meriti spirituali che derivano dalla visita ai malati. In
un famoso hadith il Profeta afferma: «Andate a trovare l’ammalato,
date da mangiare all’affamato, e rimettete in libertà il prigioniero».
Ancora, secondo Abu Horaira, il Profeta ha detto:
Allah’, sia esaltato, dirà il giorno della Resurrezione: «Oh figlio di
Adamo, ero infermo e non mi visitasti?». «Signore», risponde l’uomo,
«come ti potevo visitare se Te sei il Signore del mondo? Non sapevi
che il mio servo... era ammalato e non lo visitasti? Non sapevi che se
lo avessi visitato avresti incontrato me?105
La visita al malato però implica delle raccomandazioni che devono essere attuate perché la visita stessa sia utile ed efficace:106
a) la visita deve effettuarsi durante il giorno, semplicemente per
evitare di disturbare il paziente e la sua famiglia la mattina presto
o in piena notte. In questo ambito si devono ricordare le direttive
dell’Islam e abbandonare costumi obsoleti quale quello che la
visita si deve effettuare quando sono passati almeno tre giorni
dall’inizio della malattia;
104
105
106
Khoury A.Th., Chi è il prossimo per il musulmano? In A.Th. Khoury e P.
Hunermann (a cura di), Chi è il mio prossimo?, Roma, Città Nuova, 1992,
pp. 113-128.
Aarab Hafid D., El proceso de morir en el Islam, «Labor Hospitalaria» n.
268, 2003, pp. 25-26.
Ivi.
131
b) il requisito imprescindibile è quello di animare il paziente ed è
auspicabile che chi incontra il malato lo aiuti a capire, a perdonare, a riconciliarsi. Un sorriso e una mano posta delicatamente
sopra la fronte o una parola di pace potranno essere, per il malato,
motivo di accettazione della sua situazione e di incoraggiamento
spirituale. Il Profeta raccomandò: «Oh Allah, Signore dell’uomo,
allevia il male, curalo perché Tu sei l’unico che può curare e nessuno senza di Te può curarsi, e la Tua assistenza non trascura
nessun momento di una malattia»;
c) chi visita il malato deve aiutarlo a mantenere la speranza nella
guarigione e in una vita lunga e felice. Dice il Profeta: «Se vai a
visitare un malato, chiedi a Allah che allunghi la sua vita, perché
questo consola il malato»;107
d) chi visita il malato può chiedere ad Allah che la persona malata
sia doppiamente ricompensata;
e) chi visita il malato può chiedergli una preghiera a suo favore;
ha detto il Profeta: «Quando visiti un infermo puoi chiedergli
che invochi Allah per te poiché le sue invocazioni sono simili a
quelle degli angeli»;
f) chi visita il malato è raccomandabile che invochi Allah a favore
del malato e reciti il Corano. In questo caso, il compito di chi
visita è quello di percepire quello che lo opprime e di offrirlo in
preghiera ad Allah. Senza questo supporto il malato rischia di
sentirsi incompreso, di non poter pregare, al punto di vivere le
ultime fasi della vita come abbandonato da Allah;
g) la visita deve essere breve, salvo il desiderio espresso dal malato
che inviti a rimanere, perché il malato può non voler farsi vedere
in un momento di crisi. Ha detto il Profeta che la visita migliore
— per quanto riguarda la ricompensa divina — è quella breve;
h) chi visita il malato, anche con le migliori intenzioni, non deve
porre domande sulla malattia, per evitare che questi si angusti
riflettendo eccessivamente sulle sue condizioni;
i) chi visita il malato deve comprendere che in qualche momento,
per stanchezza o per dolore, questi può esprimere qualche rimprovero incolpando direttamente o indirettamente la provvidenza
divina per la sua situazione. È desiderabile che chi visita sia
107
Ahmad Ibn Mohammad (Imam Ahmad), Bàki mosnad al mokzirìn (El
resto la tradiciòn — de autenticidad verificada — de los insolentes), Beirut,
Dàr Al Oloum Al Islàmiyyah, 1982, detto n. 12645).
132
prudente e intelligente e sappia comportarsi, perché le parole
possono uccidere chi potrebbe salvarsi. Inoltre, chi desidera
che il suo premio sia maggiore, può aiutare il malato nei suoi
problemi familiari e personali, contribuendo così al sollievo del
suo dolore e all’incoraggiamento del suo animo.
Ogni persona può coltivare sentimenti di odio, di conflitto, di
colpa: la malattia è il momento nel quale questi sentimenti tornano
vivi nella memoria e possono generare il bisogno di una riconciliazione. Il ruolo di coloro che sono attorno al malato è di identificare
questo desiderio, e di ascoltare con benevolenza la storia di una
vita che il malato può non leggere con soddisfazione. L’obiettivo, in
definitiva, è di aiutare il malato a riconciliarsi con la sua vita.
Uno degli aspetti che spesso suscita timore nel malato è la
probabilità di essere privato del proprio ruolo sociale e delle proprie
responsabilità. Dipendente per la malattia, si scontra, inevitabilmente, con il dover accettare che la gestione della sua vita passi
nelle mani di altri. È questo che potrà generare la consapevolezza
di rimanere escluso dalle decisioni che lo concernono e di sentirsi
inutile. Anche nella fase terminale della vita il malato deve, senza
essere giudicato, avere la libertà di esprimere i suoi atteggiamenti,
le sue apprensioni, le sue pene, le sue paure, le sue difficoltà. A
questo deve rispondere un amore incondizionato e gratuito che si
esprime, in definitiva, in un «contratto di non abbandono». Inoltre è auspicabile che si permetta al malato di adottare decisioni in
ambito familiare, di mettere in ordine i suoi affari, di redigere il
testamento, di prendere le decisioni necessarie per essere in pace
malgrado la morte.
In sintesi, è di vitale importanza che la famiglia abbia un ruolo
dominante nell’assistenza, anche spirituale, in modo che questo
compito non debba rimanere esclusivamente in mano al medico e
agli operatori sanitari. Con la sua presenza e la sua attenzione, la
famiglia riconosce al congiunto malato di essere ancora un essere
umano integro, degno di rispetto e di amore.
Un supporto spirituale che deve essere un impegno assunto
da tutte le persone vicine al malato, naturalmente secondo il loro
livello di competenza. Questo supporto non elimina la sofferenza
del malato, non toglie la sua angoscia, né la sua stanchezza, però
umanizza il rapporto e può arricchire tutti coloro che sono in relazione con lui.
133
CAPITOLO TERZO
INDUISMO
Introduzione
L’Induismo è la religione originaria dell’India;1 ha assunto tale
nome quando alla fine del XII secolo, popolazioni turche di fede islamica conquistarono l’India settentrionale, usando il termine Hind
per indicare la zona, chiamando quindi hindi la sua lingua e hindu
i suoi abitanti. Infine gli inglesi coniarono, a partire dal termine
hindu, la denominazione hinduism, da cui l’italiano «Induismo».
L’altra denominazione di questa religione, Bramanesimo, deriva
dalla casta sacerdotale indiana dei bramani.
L’Induismo si manifesta in una sorprendente varietà di forme,
ed è presentato e interpretato dai suoi seguaci in modi così diversi
da rendere ogni sua descrizione estremamente difficile e quasi
1
Induismo è un termine che esprime un ampio e articolato panorama delle
tradizioni religiose indiane. Si è affermato che proprio per queste diversità
non vi è «un Induismo» (Cantwell S., The meaning and end of religion,
New York, MacMillan, 1962, pp. 64ss.), mentre si è d’accordo nel ritenere
l’Induismo come «un ombrello» che copre molte tradizioni e di usare il
termine come un’autopercezione (Weghtman S., Hinduism in the village
setting, Manchester, Open University, 1990, pp. 55ss.) sviluppatasi con
l’aumentare dei movimenti Neo-Hindu del XIX secolo e del nazionalismo
indiano. A questo, però, si sono contrapposti l’Induismo dei villaggi rurali
e la tradizione sanscrita dei bramini. In tutta la sua storia, l’Induismo ha
contemplato diversità di teorie e pratiche, e la stessa tradizione sanscrita
è approdata nel suo ambito. Quindi si potrebbe affermare che quello che
mantiene l’unità dell’Induismo sia il dharma, il codice etico che governa
tutti gli aspetti della vita, un codice che è considerato come sacro ed eterno
(Barati A., Hindu views and ways and the hindu-muslim interface, Santa
Barbara, Ross-Erikson, 1982).
151
impossibile da definire nei contenuti. Per quanto in Occidente sia
considerato una delle grandi religioni del mondo, l’Induismo è molto
più di questo: è un modo di vivere, è una cultura ricca e articolata, è
l’ambiente che circonda e avvolge da prima della nascita a dopo la
morte. Il termine con cui gli hindu stessi si riferiscono a ciò che noi
chiamiamo Induismo è sanatana dharma, la «legge eterna».
L’Induismo non ha un fondatore conosciuto, in quanto viene
pensato come eterno, tuttavia le sue origini hanno radici preistoriche: è senza dubbio la più antica delle grandi tradizioni religiose
ancora esistenti. Si ritiene che abbia avuto inizio in India, nel 1800
a.C., ma le sue origini sono incerte.
L’Induismo venera una serie di dèi riconducibili ai processi
elementari della natura e della vita, ma non si tratta di un vero e
proprio politeismo, perché tutti questi dèi altro non sono che varie
manifestazioni dell’unico essere impersonale, il brahman. Vi sono
dèi che dominano i fenomeni naturali, uragani e tempeste, sole
e pioggia, e altri preposti ai processi irriducibili di morte, vita e
amore; vi sono dèi che causano malattie e altri che le combattono.
L’essere supremo, brahman, controlla il mondo attraverso tre
qualità maggiori che sono rappresentate nella trimurti: Brahma
il creatore, Visnù il conservatore e Shiva il distruttore del mondo.
Nell’Induismo, Dio non è né maschile né femminile, ma, poiché
brahman abbraccia tutta la creazione, può prendere forma maschile, femminile o animale. Oggi Brahma è adorato raramente,
ma Visnù ha milioni di seguaci. Si ritiene che Visnù visiti la terra
come un avatar — «uno che discende» o «incarnazione» — ogni
volta che il male raggiunge un livello inaccettabile. Nove dei dieci
promessi avatar di Visnù si sono già realizzati. Tra questi si ricorda
Krishna, che spiega in parte perché la vacca sia un animale sacro
e perciò mai macellato. Un altro dio molto amato è Ganesha, il
dio-elefante, le cui grandi orecchie rappresentano l’accrescimento
della conoscenza attraverso la riflessione e l’ascolto, mentre le sue
zanne, una perfettamente sagomata e l’altra rotta, rappresentano la
perfezione e l’imperfezione, che sono presenti ovunque nel mondo.
Ganesha simboleggia una forte supremazia; egli è colui che rimuove
gli ostacoli ed è miniera di saggezza e perfezione. Gli si rende culto
prima di avventurarsi in una nuova impresa di affari o prima di
dare inizio a una nuova famiglia.
La letteratura sacra — tramandata oralmente e poi trascritta
— denominata Veda (sapienza) e sorta in un arco di tempo tra il
152
1500 e l’800 a.C., è redatta perlopiù in sanscrito, detta «lingua dei
Veda» e trasmessa oralmente per migliaia di anni.
All’interno della letteratura Veda, il cui termine indiano è Sruti
ossia «ciò che è stato percepito attraverso l’udito», è possibile operare
una divisione a livello di contenuto degli scritti che costituiscono
per gli hindu il canone autoritativo:
• I Mantra (Samhita): raccolte di inni, preghiere, canti magici,
benedizioni, formule sacrificali e litanie.
• I Brahmana: contengono le spiegazioni, destinate ai Bramani
(sacerdoti), per l’esecuzione dei sacrifici e di altre cerimonie e
riti.
• Gli Aranyaka e le Upanishad: comprendono i testi e le dottrine
iniziatiche per eremiti; hanno tratti esoterici e sottolineano il
significato simbolico del culto sacrificale e delle altre funzioni
sacerdotali esteriori.
Delle raccolte che si sono citate, al primo punto si sono conservate quattro opere, ognuna delle quali è chiamata Veda, e che si
possono distinguere a loro volta dal punto di vista contenutistico in:
Rigveda, «Veda dei versi»; Samaveda, «Veda dei canti»; Yajurveda,
«Veda delle formule sacrificali»; Atharvaveda, che prende il nome
da Atharva, un sacerdote mitico dell’epoca primitiva.
La compilazione della letteratura vedica è attribuita ai Rsi,
gli antichi veggenti che hanno deposto in essa la loro «sapienza
eterna». Tale scrittura è accessibile solo alle tre classi superiori
dell’ordinamento delle caste, mentre alla classe infima, ai Sdra, cioè
agli «intoccabili», che svolgono attività giudicate sconvenienti dal
rituale (macellai, spazzini, addetti alle pulizie, ecc.), è proibito lo
studio delle sacre scritture e anche qualsiasi contatto con esse.
L’etica hindu si ritiene sia fondata sulla rivelazione (sruti) dei
Veda, che si articola in vari libri legali, il Dharmasastras, e in vari
sistemi filosofici — il più importante dei quali è il Mimamsa, e diviene
l’ideologia pratica delle famiglie delle caste hindu elevate. Questa
ideologia subisce poi anche l’influenza eterodossa del Tantrismo.2
Accanto alla letteratura rivelata esiste poi anche un secondo genere
di scritti religiosi, la Smriti («ciò che si ricorda») che conservano la
tradizione originaria tramandata dal popolo e infatti si chiamano
2
Flood D.G., Induism, in J. Holm e J. Bowker (a cura di), Making moral
decisions, London, Pinter, 1994, pp. 68-69.
153
anche Scritti della Tradizione; gli Itihasa, di contenuto filosofico;
i Purana, vaste opere mitologiche in versi in cui vengono esaltati
e glorificati alcuni degli dèi principali; due vaste epopee, il Mahabharata, che offre un compendio dell’Induismo dal punto di vista
religioso, e il Ramayana, che presenta un modello di vita perfetta
nella figura di Rama, incarnazione del dio Visnù.
Il primo di questi due poemi epici comprende la Bhagavadgita, il «Canto del Beato», il più autorevole e più profondamente
religioso dei sacri testi induisti, nel quale emerge un doppio aspetto
dell’amore, inteso come amore personale della divinità per l’uomo
e come amore-risposta dell’uomo per la divinità.
La letteratura Smriti non ha carattere sacrale e ad essa hanno libero accesso anche gli intoccabili o impuri, le donne e i fuori
casta.
Le esigenze del rituale vedico, basato sulla sruti, e l’abbondanza
degli scritti che compongono la smrti hanno portato allo sviluppo di
opere in cui fosse riassunto e sistematizzato il contenuto dei testi sacri.
Si è pertanto sviluppato un gran numero di Sutra, «fili» o «compendi»,
nei quali sono adeguatamente sintetizzati i molteplici riferimenti ai
riti e ai regolamenti. Poi i Vedanga, scienze ausiliarie connesse allo
studio del Veda, e gli Upaveda (le scienze minori), la cui padronanza
apriva la strada a quelle che oggi chiameremmo «professioni». In
questo ambito si sottolinea l’Ayur-veda (la conoscenza della vita),
ovvero la medicina, che comprende quanto ha a che fare con la salute,
dalle nozioni sull’alimentazione e i principali rimedi, ai consigli su
come vivere per assicurarsi un’esistenza felice e prospera.
È necessario ora puntualizzare che il fondamento spirituale
dell’Induismo è dato da una visione precisa della vita nel cosmo,
secondo cui tutti gli esseri viventi formano una scala discendente
dagli dèi agli uomini, dagli uomini agli animali e dagli animali alle
piante. E gli esseri umani hanno diritti e doveri differenti a seconda del varna (colore/casta) in cui sono nati. L’umanità è ordinata
gerarchicamente: al vertice stanno gli Indù, cioè gli indiani che
osservano i precetti morali e rituali e che si suddividono a loro volta
nelle classi sociali dei sacerdoti (Bramini), dei guerrieri (Kshatriya)
e degli agricoltori e commercianti (Vaishya). Un grado nettamente
inferiore occupano i Sudra, che esercitano le professioni più varie,
escluse quelle sopraccitate, e così impuri da non poter accedere
allo studio della sacra letteratura dei Veda (Bhagavadgita, XVIII,
42-44).
154
I quattro differenti varna provengono da un racconto del Rig
Veda in cui il dio Brama, che è incaricato del potere creativo, forma
il primo uomo Perusha, che in seguito è sacrificato e dal suo corpo
sono estratti i quattro varna:3
• il varna più elevato (bianco) — il Bramino — uscì dalla bocca di
Perusha. I Bramini sono sacerdoti che svolgono i servizi religiosi
e cantano le scritture;
• il secondo varna (rosso) — il Kshatriya — uscì dalle braccia di
Perusha. Questo varna ha generato i guerrieri e i sovrani dell’India;
• il terzo varna (giallo) — il Vaishya — uscì dalle gambe di Perusha
e generò quanti sono di importanza fondamentale per la vita economica e sociale del paese, come coltivatori e commercianti;
• il quarto varna (nero) — il Sudra — uscì dai piedi di Perusha.
Esso serve il resto del corpo e ha dato origine ai lavoratori, che
provvedono i servizi fondamentali per gli altri.
Ancora al di sotto dei Sudra si collocano gli «intoccabili»,
i Paria, che svolgono attività giudicate repellenti e impure dal
rituale. Con il termine «intoccabili» si traduce spesso il sanscrito
avarna «senza un colore», che indica tutti coloro che sono esclusi
dal sistema castale indiano. I cosiddetti intoccabili sono addetti ai
lavori più umili e degradanti, legati alla morte e alla sporcizia, e il
contatto con loro è considerato contaminante per le caste superiori,
che dunque li evitano accuratamente.
I non indù rimangono al di sotto e al di fuori di questi gruppi.
La casta è formata da un gruppo di persone che hanno un
antenato comune, divino o umano, esercitano la stessa professione,
hanno l’obbligo del matrimonio all’interno della casta e possono aver
contatto e consumare i pasti solo con membri della propria casta. Gli
appartenenti alle singole caste sono inoltre tenuti all’osservanza e al
compimento di determinate pratiche rituali concernenti l’alimentazione, la lettura di libri e il rapporto con il prossimo, durante il
quale ci si deve guardare dal pericolo della contaminazione. Membri
di una casta si diventa solo per diritto di nascita e l’appartenenza
a una casta è condizione necessaria e indispensabile per far parte
dell’Induismo.
3
Keene M., Le religioni del mondo, Leumann (Torino), Elledici, 2002, pp.
12-13.
155
La medicina nella tradizione buddhista
Occorre notare che il Buddha stesso ebbe interesse per la
medicina e, in senso più generale, per l’assistenza sanitaria. Si
racconta, infatti, che dopo aver trovato un monaco affetto da
dissenteria e che giaceva negli escrementi, insieme con il fedele
discepolo Ananda ne lavò il corpo e poi, successivamente, spiegò
ai monaci riuniti:
Monaci, voi non avete una madre, voi non avete un padre che possono occuparsi di voi. Se voi, monaci, non vi soccorrete sollecitamente
l’un con l’altro, chi si occuperà di voi? Chiunque voglia seguire me,
deve soccorrere il malato.43
Si dice che il Buddha abbia impartito le regole per l’assistenza
e la cura del malato con la seguente dichiarazione:
[...] Dotato di cinque qualità, monaci, colui che assiste il malato
è adatto ad assistere il malato: diventa competente nell’attuazione
dell’arte medica, egli sa cos’è salutare e cosa non lo è; egli elimina
ciò che non è salutare e adopera ciò che lo è; assiste il malato per
un senso di amicizia, non per la speranza di un guadagno; non si
dimostra una persona riluttante a rimuovere escrementi o urina o
sudore o vomito; egli si dimostra competente per allietare...deliziare
il malato di quando in quando con la parola del dharma. Se dotato di
queste cinque qualità, monaci, colui che assiste il malato è adatto ad
assistere il malato [...].44
Il Buddha come medico è idealizzato in esseri celesti come
Bhaisajyaguru, il Buddha della medicina, e Avalokitesvara, il Bodhisattva della compassione. Questi guaritori celesti hanno ancora
oggi grande popolarità in Asia. Il Buddha riteneva che un corpo in
salute favorisse il cammino della vita spirituale.45
In effetti, due fonti distinte ma concettualmente correlate
costituiscono il fondamento dell’etica buddhista dell’assistere e del
curare: la solidarietà nella comunità di fede e la compassione per
43
44
45
Kitagawa J.M., Buddhist Medical History, in E.L. Sullivan, Healing and
Restoring, New York, McMillan, 1989, pp. 13ss.
Pant R.D., Buddhismo, medicina e bioetica, in L. Biagi e R. Pegoraro (a
cura di), Religioni e bioetica. Un confronto sugli inizi della vita, Padova,
Gregoriana, 1997.
Nakasone Y.R., Buddhism, in W.T. Reich, Encyclopedia of Bioethics, New
York, MacMillan, 1995, p. 316.
217
tutti gli esseri viventi. Nel buddhismo hinayana, l’atteggiamento
assistenziale e di cura sembra essere maturato parallelamente al
concetto di solidarietà entro la comunità di fede. Nella tradizione
Mahayana, l’elaborazione della dottrina della misericordia sembra
aver fornito la motivazione di un’etica di assistenza e cura.46
Negli edifici che componevano i monasteri venivano destinati
spazi all’assistenza ai monaci anziani e malati. Con il passare del
tempo, questi spazi divennero centri ospedalieri aperti anche alla
comunità esterna; si diffuse così il sistema degli ospedali-templi, per
l’assistenza a persone e animali malati. Nel complesso si può dire
che la storia medica buddhista si sia sviluppata grazie al contributo
della medicina cinese e delle tradizioni locali (terapie sciamaniche
e popolari). Il buddhismo, quindi, nel suo sviluppo ha incorporato i
sistemi curativi generati e sviluppati nei diversi contesti ecosistemici
ed etnoculturali nei quali si è diffuso, dando vita a un’eterogeneità
terapeutica che può arrivare a tre diversi livelli di azione: clinica,
filosofica e magico-religiosa. I tre livelli sono spesso connessi e la
prevalenza dell’uno o dell’altro dipende dai soggetti (guaritori,
pazienti) e dal contesto.
La medicina buddhista insegna che il corpo è costituito da
quattro elementi: terra, fuoco, acqua e aria. Quando questi si combinano provvisoriamente in un’armonia dinamica, si ha la vita. Le
varie malattie si verificano se tale armonia viene alterata, mentre
quando si spezza irrimediabilmente sopravviene la morte.
In base al principio buddhista dell’unicità di corpo e mente
(shikishin funi), l’aspetto fisico e quello mentale o spirituale sono
due facce della stessa medaglia: letteralmente «due, ma non due».
Nello stesso tempo, per quanto al livello più profondo i due aspetti
siano inseparabili, rientrano in due differenti sfere fenomenologiche.
Se il corpo e lo spirito si influenzano a vicenda, la gioia, la speranza
e altri sentimenti positivi attivano alcuni meccanismi e rafforzano
i processi immunitari dell’organismo, mentre lo sconforto e altre
emozioni negative li indeboliscono.
Naturalmente negli ultimi due secoli la medicina scientifica
moderna si è diffusa sempre più nella maggior parte dei Paesi
asiatici.
46
Pant R.D., Buddhismo, medicina e bioetica, in L. Biagi e R. Pegoraro (a
cura di), Religioni e bioetica. Un confronto sugli inizi della vita, Padova,
Gregoriana, 1997.
218
Tuttavia ancora oggi la medicina classica e quella scientifica
convivono l’una accanto all’altra. Un esempio emblematico di
medicina tradizionale è quello fornito dalla medicina tibetana, che
rappresenta l’integrazione della religione buddhista, della scienza
medica classica indiana e della cultura tibetana. Essa attribuisce
grande importanza ai fattori sovraumani; la medicina tibetana ritiene
che gli «spiriti cattivi» siano i responsabili delle turbe neuropsichiche
e una delle quattro cause principali delle patologie addominali.
I testi-base della medicina tibetana sono comunemente conosciuti con il nome di Gyushy. Il nome sanscrito, Amrita hrydaya
Anga Asta Ghuya upa dhesha Tanta nama, ha il seguente significato:
Amrita vuol dire eterno; in alcune credenze, coloro che vivono secondo Amrita possono raggiungere l’immortalità. Hrydaya significa
Essenza: il Gyushy è considerato l’essenza di tutta la scienza medica,
come la panna lo è del latte. Anga Asta vuol dire «Otto Discipline»:
medicina generale, pediatra, ginecologia, disturbi provocati da spiriti nefasti, ferite, tossicologia, studio dei tonici e dei rinvigorenti,
terapie contro la senescenza. Ghuya significa segreto: significa che
la rivelazione di questo testo deve restare segreta per tre categorie
di persone: coloro che sono come un vaso che perde, come un vaso
rovesciato o come un vaso contaminato. Upa dhesha è la trasmissione orale della quintessenza da un guru al suo discepolo. Tantra è
la combinazione di Tanu — «il corpo» — e di Taya — «proteggere»
— e quindi significa: «come proteggere il corpo». Si hanno opinioni
diverse riguardo l’origine e l’autore di questi testi. Alcuni sostengono
che si tratti della parola autentica del «Buddha di medicina» (un
epiteto del Buddha che simboleggia il benessere e i benefici del corpo,
della parola e dello spirito in tutti gli esseri viventi). Il «Buddha di
medicina» avrebbe insegnato questo Gyushy nell’899 a.C. mentre
soggiornava nella «foresta di guarigione».47
La medicina tibetana, nata sul filone del buddhismo tantrico
e sulla falsariga del trattato dell’Ayurveda, ha sviluppato quanto
era in nuce nelle concezioni più antiche. Si è così servita della
distinzione delle parti del corpo e delle varie arterie elaborata dal
tantrismo per cogliere corrispondenze a livello cosmico: il corpo
rispecchia dunque l’universo, come nell’antica concezione delle
Upanishad. È significativo, a questo proposito, notare come alla
47
Qusar N. e Sergent J.C., Medicina tibetana e alimentazione, Parma, Pratiche
Editrice, 1996.
219
parola «salute» corrisponda in tibetano il concetto di tro-va-ten,
che letteralmente indica «affidarsi a ciò con cui si ha affinità», in
base al quale è importante e necessario trovare l’elemento naturale
con cui si ha affinità. Però la medicina tibetana ha calcato anche
le orme del buddhismo classico, evidenziando a livello spirituale
le vere deficienze che fanno del corpo un ricettacolo di tendenze e
conflitti, alle origini della malattia. La mancanza di controllo della
propria mente è sempre all’origine degli smarrimenti ed è in rapporto
all’ignoranza. La costruzione su cui si basa la medicina tibetana è
spirituale e somatica a un tempo; è psicologica e psicofisica.48
Nella medicina tibetana si nota infatti come le risorse
terapeutiche siano principalmente la riforma alimentare, le
modificazioni dell’«igiene di vita», i rimedi, altri procedimenti
terapeutici.
Si ritiene inutile ricorrere alle cure mediche propriamente
dette, se prima non sono stati attuati gli accorgimenti alimentari e
igienici e se non sono stati applicati secondo le indicazioni relative
alla patologia.
Secondo il sistema medico tibetano tradizionale, l’alimentazione, l’igiene di vita, l’influsso delle stagioni e uno spirito malevolo
sono i principali fattori responsabili delle manifestazioni di malattie.
Tali fattori modificano le condizioni dell’equilibrio psicosomatico
che si ritiene essere il normale stato di buona salute. Il corpo e lo
spirito sono strettamente legati, poiché la salute, il benessere o il
malessere dell’uno coinvolgono automaticamente e immediatamente
anche l’altro.
L’oggetto stesso della medicina tibetana è quindi di mantenere
o restaurare, una volta perdute, l’unità e l’integrazione degli elementi
dell’uomo per ricreare l’equilibrio personale, collegato all’armonia
che si rivela nell’ordine universale. L’equilibrio nasce dalla coesione,
l’armonia vitale dal suo mantenimento. Gli organi e i tessuti del
corpo umano sono strutturalmente distinti e diversi gli uni dagli
altri, ma la loro unità funzionale deve restare primaria. Un singolo
organo non può essere sano se tutti gli altri che lo circondano sono
malati; ne deriva che, se un organo si ammala, anche gli altri organi
vengono curati contemporaneamente. Che si tratti di prevenzione
o di terapia del corpo, dello spirito o della mente, tutto deve essere
48
Terrin A.N., Il sacro off limits, l’esperienza religiosa e il suo travaglio,
Bologna, EDB, 1995, pp. 167-168.
220
considerato e curato in maniera globale, in quella prospettiva definita
olistica che oggi in Occidente si sta riscoprendo.
Per quanto riguarda la medicina tibetana, è importante notare
che fu sempre intimamente connessa alla religione. La medicina
veniva praticata e insegnata solamente nei monasteri buddhisti,
il più importante dei quali si trovava a Lhasa. I monasteri erano
i depositari dei tredici rotoli che rappresentavano la totalità della
teoria e della pratica medica tibetana.
Infine va detto che, specialmente nella medicina tibetana, la
guarigione richiede sempre la collaborazione del paziente e che soltanto nella misura in cui la persona modifica i suoi atteggiamenti di
vita, può venire guarita. Vale il principio fondamentale secondo cui
non sono le circostanze che determinano la felicità o l’infelicità della
persona, ma sono le capacità di porsi nella condizione favorevole per
poter superare i suoi condizionamenti, a creare l’ambiente adatto alla
salute e alla guarigione. È per questo che la medicina tibetana non
può restare estranea alla sfera spirituale, poiché essa comprende la
vita interiore, sottile, e la vita divina di ogni individuo, che è compreso
in un tutto, il Grande Tutto. Non si può guarire senza amore e senza
avere capito ciò che ha portato la persona alla malattia. Solo le virtù
— amore, fede, compassione, pazienza, umiltà, modestia e devozione
— possono guarire perché richiameranno tutte le energie cosmiche
indispensabili alla cessazione dello stato di malattia.
Il sostegno al malato viene offerto normalmente dalla famiglia e dalla comunità religiosa che si occupa di accompagnarlo con
discorsi, insegnamenti e preghiere. Possono essere recitati testi
(sutra) per favorire la guarigione, recitati mantra, fatte offerte ai
templi, possono essere posti al capezzale del malato piccoli oggetti
devozionali davanti ai quali bruciare incensi o fare offerte di cibo
e acqua. Ma si possono fare anche pratiche di trasferimento dei
meriti, ovvero il malato offre la propria sofferenza per purificare
anche gli altri esseri da karma negativi. Un tratto fondamentale
dell’insegnamento buddhista è infatti la compassione che deve essere esercitata nei confronti di tutti gli esseri «che possono essere
stati tutti nostre madri nelle esistenze precedenti». Viene il più
possibile mantenuto un atteggiamento riservato, dignitoso e non
troppo emotivo, proprio delle culture asiatiche.49
49
Falà M.A., Tradizione buddhista, in A. Pangrazzi (a cura di), Salute, malattia
e morte nelle grandi religioni, Torino, Edizioni Camilliane, 2002, p. 139.
221
Il funerale
In queste società tradizionali, nel periodo immediatamente
successivo alla morte di una persona, si osserva un comportamento timoroso: c’è timore di non fare quanto dovrebbe essere fatto,
timore che il defunto non abbia ancora lasciato la terra dei viventi.
La tensione viene accresciuta dal fatto che il defunto viene spesso
sepolto in casa o appena fuori casa. In tutta l’Africa lo svolgimento
corretto dei funerali è fondamentale per non fallire il «passaggio» e
non trasformare il defunto in un morto-errante che tutti gli abitanti
del villaggio temerebbero. I turbamenti suscitati da questo fantasma non cesseranno finché non gli sarà data la giusta sepoltura, o
finché non saranno eseguiti i riti appropriati e complessi in grado
di placarlo.
Nella maggioranza dei popoli, dunque, lo spirito del defunto
viene in un primo tempo «allontanato» con tutto il rispetto e le cerimonie dovuti: vi è poi un periodo di latenza prima che si manifesti
come antenato, sotto delle forme previste e rivelate dagli anziani
della sua classe di età o dalla sua famiglia.47
Vari atti e simboli parlano così della morte e della continuazione
della vita: le attività quotidiane si interrompono per un giorno dopo
la morte o il funerale; si lavano i capelli, la casa del defunto è chiusa
o abbandonata, si indossano abiti del colore che simbolizza il lutto
(bianco, nero o rosso), i corpi dei familiari sopravvissuti sono dipinti
con fango o gesso bianco, il bestiame viene allontanato dalla casa
del defunto, e il fuoco è spento. Alcune società sotterrano gli oggetti
personali del defunto come pentole, ornamenti, denaro e abiti. In
altre comunità i beni del defunto sono distribuiti tra i congiunti o
i membri del clan.
Il lutto
Il lutto non è quindi un’espressione di sofferenza, ma è una
dichiarazione ufficiale di non aver partecipato in alcun modo a ciò
che ha causato la morte della persona. Le donne devono seguire un
lutto più lungo rispetto agli uomini perché, pur essendo sposate e
47
Ibidem, pp. 347-353.
292
inserite nella famiglia del marito, conservano in qualche misura
la tensione della propria origine; potrebbero quindi estraniarsi e
diventare la causa, mediante atti di stregoneria, della morte del
congiunto. Con un lungo lutto si dichiara invece il proprio affetto
e si presta la propria opera perché il marito possa raggiungere felicemente il regno dei morti.
Quando il cammino dei morti è giunto al suo termine, la situazione è completamente diversa: si tiene una grande festa, in cui tutti
i membri del gruppo si trovano insieme in amicizia, con abbondanza
di cibi e bevande, perché finalmente il defunto è stato dichiarato
«personaggio residente di diritto nel regno dei morti».
Dal rapporto di timore si passa a un rapporto di gioia, di fiducia
e di comunicazione, e di qui al culto degli antenati. Questa festa si
può chiamare la «seconda sepoltura»: il rapporto diventa gioioso,
perché ciò che conta resta comunque la vita e la certezza della vita,
che la morte non distrugge, ma continua. Senza i viventi, i defunti
non possono raggiungere il regno dei morti, dal quale i defunti si
preoccupano continuamente dei vivi: tale catena di rapporti ha una
grande importanza presso tutte queste società.48
I defunti verranno infatti invocati nelle preghiere e nei momenti
di difficoltà e nei sacrifici. Ogni volta che la famiglia e la comunità
ricordano un defunto, questi si rende presente con il suo spirito,
con la sua anima. Poiché l’anima umana in questo stato gode di un
rapporto particolare con Dio, si richiede allo spirito degli antenati
di intercedere presso Dio per ottenere la sua benevolenza per se
stessi, per la famiglia, per il popolo. Gli antenati immortali sono
pertanto considerati mediatori fra l’uomo e Dio.49
In Africa le città non hanno grandi cimiteri, poiché tutti coloro
che possono, tornano nella propria terra di origine.
Ogni società clanica ha il suo territorio, nel quale devono
svolgersi la sepoltura e i riti funerari. Quando un africano muore
lontano dal suo Paese e non è possibile il trasporto del corpo fino
al luogo di origine per la sepoltura, si tagliano una ciocca dei suoi
capelli e le unghie, che vengono poi portati nel villaggio d’origine
per una sepoltura rituale al posto del corpo. In tal modo, dopo la
48
49
Maconi V., Oltre la morte nelle religioni primitive, «Quaderni», n. 33,
1986, pp. 1-9.
Nkafu Nkemnkia M., Il pensare africano come «vitalogia», Roma, Città
Nuova, 1995, pp. 100-101.
293
celebrazione dei riti funerari, il defunto potrà entrare nel regno degli
antenati.50 Essere antenati significa possedere lo status più elevato
all’interno della società.
Questa escatologia non si inserisce in una teologia: se per tutte
queste società il regno dei vivi è il luogo della manifestazione di Dio,
in quanto la divinità è origine e originante la realtà in cui si trova
l’uomo (da cui il concetto di presenza diffusa della divinità in ogni
cosa), allora il regno dei morti non è il regno di Dio, di nessun dio.
Non c’e alcuna traccia del fatto che Dio, o un dio, riceva i morti.
I morti dimorano nel loro regno, in un distacco che non significa
opposizione: ciascuno occupa la propria parte dell’universo, che è
tutto impregnato di divinità.
Il concetto di «oltre la morte» non fa parte della teologia bensì
della cosmologia, un inserimento in quel tutto di cui Dio è sovrano,
pur senza un’esplicita dichiarazione in tal senso.51
Il ricordo del defunto si esplica praticamente nel dare il suo
nome a nuovi nati, prendendosi cura della tomba, ponendo offerte
di birra, vino, latte, thè, nonché cibo e fiori sulla tomba stessa o
sull’altare familiare. Vi è quindi una continuità di comunicazione
tra i viventi, i defunti e Dio.
L’armonia di questi rapporti è necessaria per mantenere
un’unità spirituale.
Etica medica
Una nuova area di notevole interesse nel campo dell’etnomedicina si è aperta in seguito all’incontro dei costumi medici
tradizionali con le moderne pratiche scientifiche e con il Cristianesimo.
L’introduzione dei metodi scientifici nelle società indigene da
parte di medici e di ospedali occidentali ha dato origine a un atteggiamento diversificato nelle popolazioni delle culture tradizionali.
La tendenza generale di queste popolazioni è quella di scegliere
l’approccio tradizionale oppure quello moderno, a seconda della
50
51
Pombo K., La visione dell’uomo nella religione tradizionale dell’Africa
subsahariana, «Teresianum», n. 1, 1998, pp. 305-355.
Maconi V., Oltre la morte nelle religioni primitive, «Quaderni», n. 33,
1986, pp. 1-9.
294
natura della malattia;52 talvolta vengono scelti entrambi i modelli.
È da notare, tuttavia, che istituzioni e medici occidentali accettano
talvolta la collaborazione dei guaritori tradizionali per la cura di
malattie psichiche.
La società africana generalmente ha grande cura per le persone
con disabilità fisica o mentale. Parte di questa preoccupazione deriva
dalla paura che un loro eventuale maltrattamento possa riflettersi
sui propri familiari collocando anch’essi in queste situazioni. Analogamente, l’aborto è parzialmente evitato per la paura di eventi quali
non avere più bambini nella famiglia della donna che ha abortito.
Se in alcune aree i parti gemellari sono motivo di preoccupazione
poiché si ritiene che portino eventi sfortunati, in altre sono considerati eventi fortunati apportatori di benedizioni o di straordinarie
capacità, così da essere definiti «bambini di Dio».
Informazioni scritte sull’«uccisione per pietà» o eutanasia sono
molto scarse, ma il suicidio e l’omicidio sono presenti in molte aree.
Di tanto in tanto la comunità è costretta ad agire per gravi eventi
occorsi (furti, rapine) o pratiche di stregoneria, o reati sessuali quali
incesto, rapporti con bambini, stupri, adulteri, rapporti omosessuali). In questi casi, punito il responsabile, anche con la morte,
la comunità si sottomette a processi di guarigione. In ogni caso,
occorre ricordare che la vita e la dignità della comunità sono valori
superiori rispetto alla vita dei singoli membri che non rispettano i
suoi valori e le sue norme.53
52
53
Veith L., Medicina e religione nelle culture tribali, in AA.VV., Enciclopedia
delle religioni, vol. III, L’esperienza — Vita religiosa individuale e collettiva,
Milano, Jaca Book/ Marzorati, 1996, pp. 339-356.
Mbiti S.J., African religion, in W.T. Reich, Encyclopedia of bioethics, New
York, McMillan, 1995, p. 83.
295