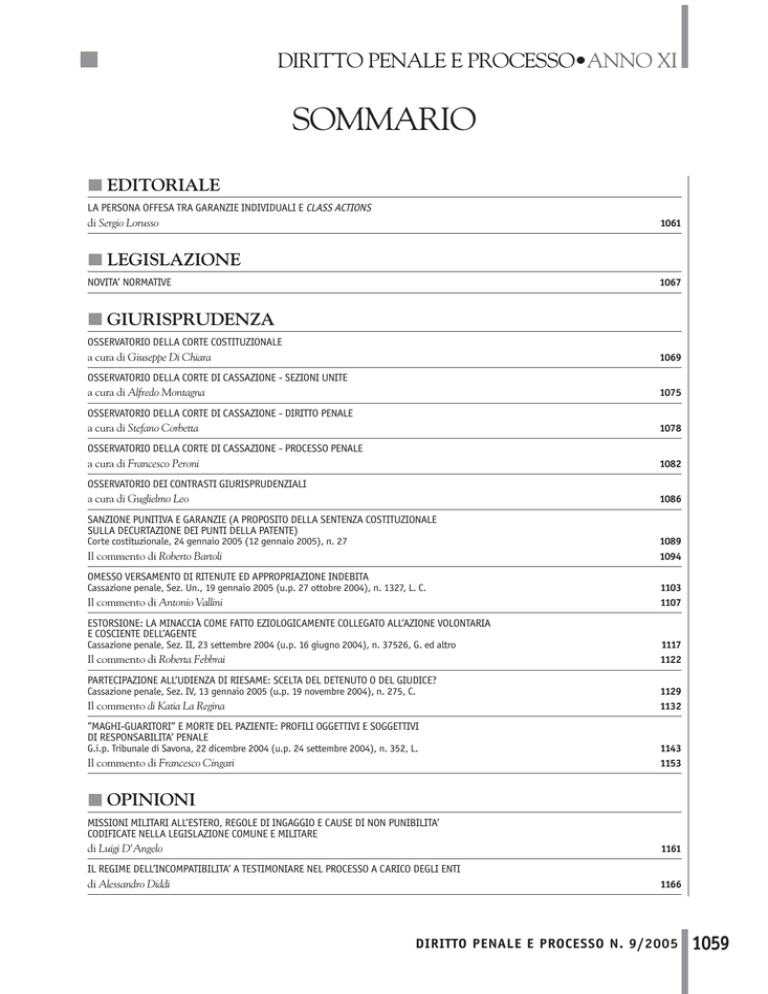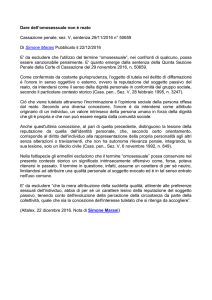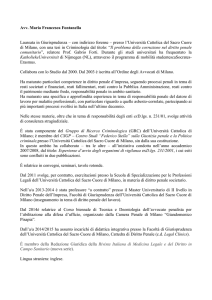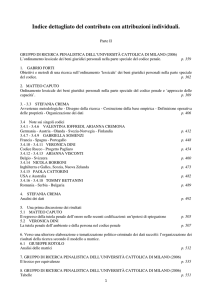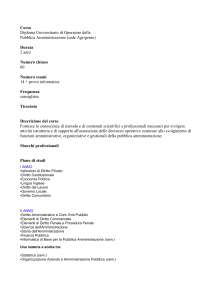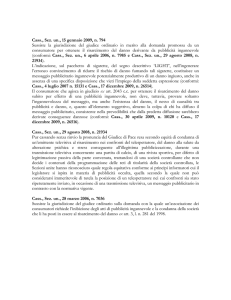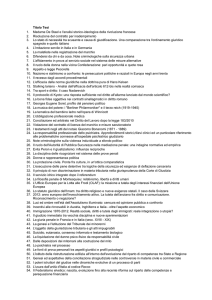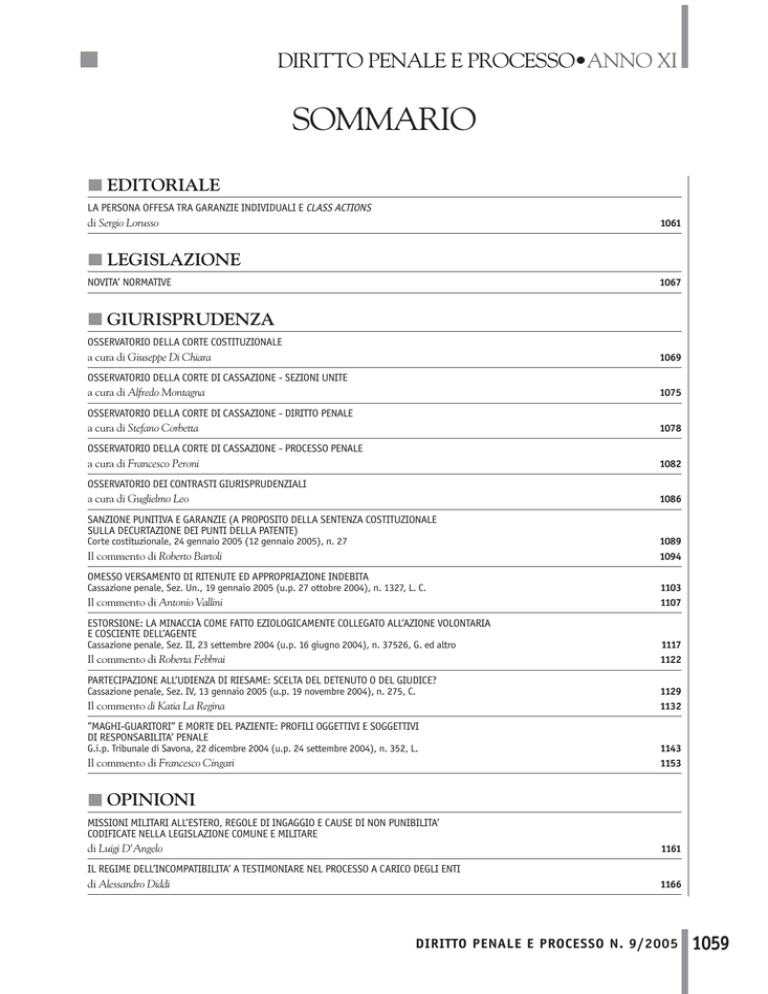
DIRITTO PENALE E PROCESSO•ANNO XI
SOMMARIO
EDITORIALE
LA PERSONA OFFESA TRA GARANZIE INDIVIDUALI E CLASS ACTIONS
di Sergio Lorusso
1061
LEGISLAZIONE
NOVITA’ NORMATIVE
1067
GIURISPRUDENZA
OSSERVATORIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE
a cura di Giuseppe Di Chiara
1069
OSSERVATORIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE
a cura di Alfredo Montagna
1075
OSSERVATORIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - DIRITTO PENALE
a cura di Stefano Corbetta
1078
OSSERVATORIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - PROCESSO PENALE
a cura di Francesco Peroni
1082
OSSERVATORIO DEI CONTRASTI GIURISPRUDENZIALI
a cura di Guglielmo Leo
1086
SANZIONE PUNITIVA E GARANZIE (A PROPOSITO DELLA SENTENZA COSTITUZIONALE
SULLA DECURTAZIONE DEI PUNTI DELLA PATENTE)
Corte costituzionale, 24 gennaio 2005 (12 gennaio 2005), n. 27
1089
1094
Il commento di Roberto Bartoli
OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE ED APPROPRIAZIONE INDEBITA
Cassazione penale, Sez. Un., 19 gennaio 2005 (u.p. 27 ottobre 2004), n. 1327, L. C.
Il commento di Antonio Vallini
1103
1107
ESTORSIONE: LA MINACCIA COME FATTO EZIOLOGICAMENTE COLLEGATO ALL’AZIONE VOLONTARIA
E COSCIENTE DELL’AGENTE
Cassazione penale, Sez. II, 23 settembre 2004 (u.p. 16 giugno 2004), n. 37526, G. ed altro
Il commento di Roberta Febbrai
1117
1122
PARTECIPAZIONE ALL’UDIENZA DI RIESAME: SCELTA DEL DETENUTO O DEL GIUDICE?
Cassazione penale, Sez. IV, 13 gennaio 2005 (u.p. 19 novembre 2004), n. 275, C.
Il commento di Katia La Regina
1129
1132
”MAGHI-GUARITORI” E MORTE DEL PAZIENTE: PROFILI OGGETTIVI E SOGGETTIVI
DI RESPONSABILITA’ PENALE
G.i.p. Tribunale di Savona, 22 dicembre 2004 (u.p. 24 settembre 2004), n. 352, L.
Il commento di Francesco Cingari
1143
1153
OPINIONI
MISSIONI MILITARI ALL’ESTERO, REGOLE DI INGAGGIO E CAUSE DI NON PUNIBILITA’
CODIFICATE NELLA LEGISLAZIONE COMUNE E MILITARE
di Luigi D’Angelo
1161
IL REGIME DELL’INCOMPATIBILITA’ A TESTIMONIARE NEL PROCESSO A CARICO DEGLI ENTI
di Alessandro Diddi
1166
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1059
DIRITTO PENALE E PROCESSO•ANNO XI
GIUSTIZIA SOVRANAZIONALE
IL NE BIS IN IDEM E CORTE DI GIUSTIZIA: ANCORA UN CHIARIMENTO SULLA NOZIONE
DI “SENTENZA DEFINITIVA”
di Anna Fabbricatore
1171
OSSERVATORIO DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI
a cura di Giulio Garuti
1175
OSSERVATORIO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE
a cura di Silvio Riondato
1178
OSSERVATORIO DEI TRIBUNALI PENALI INTERNAZIONALI
a cura di Gabriele Della Morte
1180
INDICI
AUTORI
1184
CRONOLOGICO
1184
ANALITICO
1185
EDITRICE
Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Strada 1, Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (MI)
INDIRIZZO INTERNET
HTTP://www.ipsoa.it/dirittopenaleeprocesso
DIRETTORE RESPONSABILE
Donatella Treu
REDAZIONE
Ermanno Pagella, Isabella Viscardi
REALIZZAZIONE GRAFICA
Ipsoa Editore S.r.l.
FOTOCOMPOSIZIONE
ABCompos s.r.l.
20090 Rozzano - Via Pavese, 1/3 - Tel 02/57789422
STAMPA
GECA s.p.a. - Via Magellano, 11
20090 Cesano Boscone (MI)
Concessionaria esclusiva per la pubblicità:
db communication s.r.l.
via Leopoldo Gasparotto 168
21100 Varese
tel. 0332/282160 - fax 0332/282483
e-mail: [email protected]
www.dbcomm.it
1060
REDAZIONE
AMMINISTRAZIONE
Per informazioni in merito
a contributi, articoli ed argomenti trattati
scrivere o telefonare a:
Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri
arretrati, cambi d’indirizzo, ecc.
IPSOA Redazione
scrivere o telefonare a:
Casella Postale 12055 - 20120 Milano
telefono (02) 82476686 - telefax (02)
82476.079
[email protected]
IPSOA Servizio Clienti
Casella postale 12055 - 20120 Milano
telefono (02) 824761 - telefax (02) 82476.799
Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 635
del 5 dicembre 1994
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione
in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv.
in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano
Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa
con il n. 3353 vol. 34 Foglio 417 in data 31 luglio 1991
Iscrizione al R.O.C. n. 1702
ABBONAMENTI
Gli abbonamenti hanno durata annuale e si intendono
confermati per l’anno successivo se non disdettati entro la
scadenza a mezzo semplice lettera.
ITALIA
Abbonamento annuale: € 162,00
Abbonamento annuale + monografia: € 194,00
Abbonamento annuale + codici legali: € 212,00
ESTERO
Abbonamento annuale: € 324,00
MAGISTRATI e UDITORI GIUDIZIARI - sconto del 30%
sull’acquisto della abbonamento annuale alla rivista,
applicabile rivolgendosi alle Agenzie lpsoa di zona
(www.ipsoa.it/agenzie) o inviando l’ordine via posta
a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Strada 1 Pal. F6, 20090
Milanofiori Assago (Ml) o via fax al n. 02-82476403 o
rivolgendosi al Servizio Informazioni Commerciali al n.
02-82476794. Nell’ordine di acquisto i magistrati dovranno
allegare fotocopia del proprio tesserino identificativo
attestante l’appartenenza alla magistratura e dichiarare di
essere iscritti all’Associazione Nazionale Magistrati.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Versare l’importo sul C/C/P n. 583203 intestato a
WKI S.r.l. Gestione incassi - Strada 1, Palazzo F6, Milanofiori
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
oppure
Inviare assegno bancario/circolare non trasferibile intestato
a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Indicare nella causale del
versamento il titolo della rivista e l’anno di abbonamento
Prezzo copia: € 14,00
Arretrati: prezzo dell’anno in corso all’atto della richiesta
Sono disponibili le annate arretrate rilegate al prezzo di
€ 140,00
DISTRIBUZIONE
Vendita esclusiva per abbonamento
Il corrispettivo per l’abbonamento a questo periodico è
comprensivo dell’IVA assolta dall’editore ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto dell’art. 74 del D.P.R.
26/10/1972, n. 633, e del D.M. 29/12/1989
e successive modificazioni e integrazioni.
Egregio abbonato,
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 30.6.2003 n. 196. La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel data base informatico del titolare del trattamento, Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Responsabile del trattamento: Ufficio MID. L’elenco aggiornato di tutti i responsabili del trattamento potrà essere richiesto per iscritto all’Ufficio MID presso la sede della società. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società, da
enti e società esterne ad essa collegati, nonché da soggetti
terzi, titolari autonomi del trattamento, solo per l’invio di
materiale amministrativo-contabile, commerciale e promozionale. Ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs., Lei ha diritto di
conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, mediante
comunicazione scritta a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Ufficio
MID, Milanofiori, Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (Mi).
EDITORIALE•PROCESSO PENALE
La persona offesa tra garanzie
individuali e class actions
di SERGIO LORUSSO
Straordinario di diritto processuale penale nell’Università degli studi di Foggia
I
l nostro ordinamento evidenzia ormai da tempo un
difetto di interesse nei confronti della persona offesa,
intento com’è da sempre a potenziare il pur fondamentale corredo delle garanzie poste a tutela dell’imputato, indiscusso protagonista della contesa processuale.
Nessun dubbio che, nell’attuale assetto, la persona offesa emerga come semplice comprimario nella dialettica
processuale, ma tutto ciò non dovrebbe comportare che
il suo ruolo venga ridotto a quello di una semplice comparsa, svilito, come spesso di fatto accade nonostante i
più ampi spazi teorici conferiti dal codice 1988 (rispetto
al codice 1930) e gli affascinanti mutamenti di prospettiva che si colgono in riforme di settore, come quella relativa alla competenza penale del giudice di pace.
Molteplici sono le ragioni di un siffatto stato di cose: dall’atteggiamento non di rado elusivo della dottrina, alla
scarsa attenzione della giurisprudenza (per lo più orientata a rilanciare la palla al giudice civile), fino al comportamento tendenzialmente omissivo del legislatore. Il
tutto riflette una carenza, per non dire un’assenza, della
nostra cultura giuridica e processuale in particolare (1).
I tempi, tuttavia, sono maturi per un cambiamento di
rotta che, oltre a soddisfare le esigenze di chi, troppo
spesso, oltre a subire le conseguenze pregiudizievoli del
reato rimane sfornito di una tutela effettiva, risponda all’esigenza di conformare il nostro ordinamento alle direttive dell’Unione europea in materia di vittime del
reato.
Com’è noto, infatti, il Consiglio dell’Unione europea,
con la decisione-quadro 15 marzo 2001, n.
2001/220/GAI, costituita da 19 articoli, affronta in maniera globale il tema, non limitandosi al contesto processuale, ma preoccupandosi anche di ciò che accade
“prima” e “dopo” il processo.
Tale decisione-quadro, che giunge al culmine di un iter
iniziato alla fine degli anni settanta del secolo scorso grazie ad una Risoluzione del Consiglio d’Europa in tema di
risarcimento del danno subito dalle vittime del reato (la
n. 77-27 del 28 settembre 1977) (2), prevede all’art. 17
l’obbligo, per ciascun Stato membro, di predisporre e
rendere effettive le disposizioni di carattere legislativo,
regolamentare ed amministrativo necessarie per la sua
attuazione entro il 22 marzo 2002, eccezion fatta per le
previsioni contenute negli artt. 5 e 6 (per le quali la scadenza è quella del 22 marzo 2004) e nell’art. 10 (la cui
scadenza è fissata al 22 marzo 2006).
Le iniziative del nostro legislatore tese a far trasmigrare
sul piano interno quanto prospettato a livello comunitario, nonostante il summenzionato scadenzario rigorosamente scandito, sono però a tutt’oggi in itinere.
Vanno ricordate, in particolare: a) la proposta di legge
quadro per l’assistenza e il sostegno delle vittime dei reati, elaborata dalla Commissione ministeriale di studio sui
problemi e sul sostegno delle vittime dei reati (istituita
nell’aprile del 2001 e presieduta da Giorgio Santacroce)
costituita da 15 articoli, con l’obiettivo di rivisitare la
normativa processuale conferendo alla persona offesa
dal reato l’esercizio di tutti i poteri necessari alla tutela
dei suoi interessi in ogni fase processuale, indipendentemente dalla sua (eventuale) costituzione in giudizio come parte civile; b) il disegno di legge AS 2464, presentato in Senato il 1° agosto 2003, denominato «Legge quadro per l’assistenza, il sostegno e la tutela di vittime di
reati», allo scopo di rimediare all’inerzia governativa in
materia, il quale sostanzialmente riproduce i risultati del
lavoro svolto dalla Commissione ministeriale istituita
nel 2001.
Il disegno di legge si sviluppa seguendo tre direttrici, così sintetizzabili: a) predisposizione di un adeguato sistema
informativo, nell’ambito di un rafforzamento delle garanzie e dei poteri di impulso, stimolo, collaborazione e
controllo degli atti (artt. 4 e 5); b) costituzione di un
Fondo di assistenza alle vittime finalizzato alla riparazione del danno non ottenibile altrimenti, limitatamente
ad alcune fattispecie di reato (artt. 6 e 7); c) istituzione
di un organismo con funzioni riparatorie e propulsive,
denominato Comitato per l’assistenza e il sostegno delle
vittime dei reati (artt. 8 e 9).
Note:
(1) È sintomatico che per ritrovare un contributo organico sul punto, se
si eccettua il volume di S. Tessa, La persona offesa dal reato nel processo penale, Torino, 1996, passim, occorra risalire alle fondamentali pagine di A.
Giarda, La persona offesa dal reato nel processo penale, Milano 1971, passim.
(2) Va ricordata anche la Raccomandazione n. R. (85) 11 del 28 giugno
1985 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, di particolare interesse per il tema del risarcimento del danno subito dalla vittima del reato, ove si propone una liquidazione in via diretta ed automatica da parte
del giudice penale, anche in assenza di un’espressa istanza dell’interessato, e in caso di insolvenza del reo un intervento surrogatorio da parte dello Stato. A livello internazionale un cenno merita anche la Dichiarazione O.N.U. A/Res/34 del 29 novembre 1985, recante princìpi basilari di
giustizia per le vittime del crimine e dell’abuso di potere.
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1061
EDITORIALE•PROCESSO PENALE
T
ornando al testo della decisione-quadro del 2001,
occorre evidenziare come lo stesso affronti il tema
a trecentosessanta gradi, muovendo dal terreno
definitorio. Si forniscono così concetti fondamentali,
come quello di “vittima del reato”, per il quale si accoglie
una nozione ampia, di fatto comprensiva di quella di
persona danneggiata dal reato; è considerata tale, infatti,
la persona fisica che abbia subito un pregiudizio, anche
fisico o mentale, sofferenze psichiche o danni materiali
determinati da atti od omissioni che concretano una
violazione del diritto penale di uno Stato membro (art.
1) (3). L’affermazione è importante, per le considerazioni che seguiranno.
Sempre sul piano definitorio, si prospettano i concetti di
“procedimento penale” (4), di “procedimento” (5), di
“mediazione delle cause penali” (6) e di “organizzazione
di assistenza alle vittime” (7) (art. 1), offrendo un importante contributo di chiarificazione al legislatore nazionale ed all’interprete.
Le garanzie conferite alla persona offesa sono molteplici,
a partire dal terreno probatorio, con il riconoscimento
della possibilità, per la vittima, di essere sentita durante
il procedimento e di fornire elementi di prova, prevedendo altresì l’interrogatorio della vittima solo «per
quanto è necessario al procedimento penale» (art. 3).
Sotto il profilo informativo, poi, peculiare cura è riservata al diritto della vittima di aver accesso, fin dal primo
contatto con l’autorità giudiziaria, a tutte le informazioni ritenute rilevanti ai fini della tutela dei propri interessi, per quanto possibile in una lingua generalmente compresa (8). Tra queste, in particolare, rientrano le informazioni relative al tipo di servizi o di organizzazioni predisposti per l’assistenza delle vittime e sulle tipologie di
assistenza, sulle modalità per sporgere denuncia, sulle
procedure successive e sul ruolo della vittima in tale contesto, sulle modalità di accesso all’assistenza legale, al
gratuito patrocinio e ad ogni altra forma di assistenza, sui
requisiti necessari per ottenere un risarcimento e sui
meccanismi a cui ricorrere, se residente in altro Stato,
per tutelare i propri interessi (art. 4 comma 1).
Notiamo subito un primo accenno al diritto al risarcimento, tema centrale nell’economia della persona offesa
dal reato, poi affrontato e sviluppato dall’art. 9 della decisione-quadro, ove si prevede che ogni Stato membro
garantisca alla vittima del reato il diritto di ottenere, entro un tempo ragionevole, una decisione concernente il
risarcimento da parte dell’autore del reato all’interno del
procedimento penale, salvo che «il diritto nazionale preveda altre modalità di risarcimento» (art. 9 comma 1),
così riconoscendo la possibilità per gli ordinamenti interni di articolare strumenti risarcitori alternativi.
In tal modo si afferma, implicitamente, che la via tradizionale del processo penale non può essere l’unica praticabile, delegando agli ordinamenti nazionali, nell’ottica
dominante della monetizzazione delle lesioni agli interessi penalmente tutelati, la prospettazione di rimedi ad
hoc, che si palesino maggiormente efficaci tenuto conto
1062
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
dell’esistenza di una realtà giuridica specchio di una
realtà socio-economica sempre più complessa e articolata.
Lo stesso art. 9 impone a ciascuno Stato membro di
adottare le misure idonee ad incoraggiare l’autore del
reato a prestare un adeguato risarcimento alla vittima
(art. 9 comma 2), a conferma della particolare attenzione riservata al problema del ristoro del danno derivante
dal reato. Va ricordato anche l’art. 7, che offre alla vittima, costituitasi parte civile o testimone, la possibilità di
essere rimborsata, secondo la normativa nazionale applicabile, delle spese sostenute in ragione della sua (legittima) partecipazione al procedimento penale.
Ulteriori garanzie informative, in prospettiva dinamica,
sono riservate alla vittima, che lo desideri, con riferimento agli sviluppi scaturenti dalla sua denuncia, agli
elementi che, in caso di esercizio dell’azione penale, attengono allo svolgimento del procedimento penale (eccezion fatta per i casi in cui ciò possa pregiudicarne il
corretto svolgimento) ed alla decisione finale (art. 4
comma 2); il tutto in un’ottica di costante informazione
delle attività svolte all’interno del processo - che costituisce garanzia rinunciabile (art. 4 comma 4) - prodromica all’esercizio dei diritti della vittima.
La valorizzazione del ruolo della vittima, all’interno del
processo, è desumibile anche dalla considerazione della
stessa coma vera e propria parte, destinataria di garanzie
simmetriche a quelle dell’imputato: lo si afferma a chiare lettere nell’art. 5, ove l’adozione da parte di ciascun
Stato membro delle misure necessarie per ridurre le difficoltà di comunicazione attinenti alla comprensione
od alla partecipazione della vittima alle fasi processuali
più importanti quale testimone o parte è prescritta a parità di condizioni con il suo antagonista. Anche l’art. 6
parla di vittime quali possibili parti del procedimento
penale.
Note:
(3) Cfr., in proposito, P. Martucci, Verso una legge generale per la tutela delle vittime?, in questa Rivista, 2003, 1163.
(4) È tale quello conforme al diritto nazionale applicabile (art. 1 lett. c).
(5) Si fa qui riferimento al procedimento in senso lato, comprensivo di
tutti i contatti tra la vittima del reato e qualsivoglia autorità, servizio pubblico od organizzazione di assistenza alle vittime, anteriormente, durante
o successivamente allo svolgimento del processo penale (art. 1 lett. d).
(6) Il riferimento è al tentativo, prima o durante il procedimento penale,
di addivenire ad una soluzione negoziata tra la vittima e l’autore del reato, grazie all’intervento di mediazione di una persona competente (art. 1
lett. e). Della mediazione processuale si occupa poi specificamente l’art.
10.
(7) Trattasi di organizzazione non governativa, presente in uno Stato
membro, che svolge un’attività gratuita di assistenza alle vittime dei reati in funzione integrativa dell’attività svolta in materia dallo Stato (art. 1
lett. b).
(8) Quest’ultima espressione appare alquanto generica, insufficiente e discutibile, dovendosi piuttosto tutelare il diritto della vittima del reato ad
ottenere informazioni in una lingua da lui compresa, come oggi previsto
- nel nostro ordinamento - dall’art. 111 comma 3 Cost.
EDITORIALE•PROCESSO PENALE
I
l quadro composito di garanzie qui richiamato (9)
consente di formulare alcune riflessioni sul ruolo da
assegnare alla persona offesa nel nostro ordinamento
e sugli spazi configurabili per un risarcimento del danno,
sia in sede penale che in sede extra-penale.
Se infatti in passato la progressiva accentuazione della
natura pubblicistica del processo penale ha comportato
una svalutazione dei poteri processuali conferiti alla persona offesa, e se la stessa è stata considerata dal codice
1988 un mero soggetto processuale, come tale privo di
uno ius postulandi, è indubbio che essa risulta il più delle
volte portatrice di una pretesa patrimoniale al risarcimento dei danni derivanti dal reato, indipendentemente dalla sua (eventuale) costituzione di parte civile, che
mal si concilia con lo status di soggetto terzo (10).
L’adesione al concetto di vittima del reato prospettato
dalla decisione-quadro su richiamata, del resto, comporta il superamento delle barriere presenti nella legislazione vigente che pure, nelle intenzioni dei redattori del
codice 1988, intendeva valorizzare il ruolo della persona
offesa dal reato nel processo penale (11).
La posizione di naturale antagonista dell’imputato, pur
in un sistema che non concede spazi ad un’azione penale privata (12), impone insomma dei correttivi a livello
sistematico, che possano finalmente conferire un ruolo
dignitoso alla persona offesa e conseguentemente una
posizione di rilievo nella dinamica processuale.
Tutto questo senza dimenticare che, molto spesso, il processo penale non è sede idonea per un adeguato soddisfacimento delle pretese vantate dalla vittima del reato.
E qui il discorso si fa più complesso.
Se guardiamo infatti alle vittime di comportamenti illeciti legati ad attività economiche produttive, vale a dire
alla cd. “società del rischio”, è palpabile il problema della difficoltà dell’accertamento in sede penale, essendo
quasi impossibile raggiungere la prova della responsabilità individuale e di conseguenza pervenire ad un soddisfacimento della vittima (sia sotto profilo simbolico della dichiarazione di colpevolezza che dal punto di vista sostanziale del risarcimento del danno subito) (13).
Le lesioni di portata collettiva dei diritti dei singoli hanno già da tempo condotto gli ordinamenti di common
law a predisporre e promuovere un sistema articolato e
differenziato di tutela, il sistema delle class actions (14).
Occorre chiedersi se tale soluzione sia prospettabile e
praticabile anche in Italia.
L’approccio tendente a privilegiare il processo civile,
mediante l’adozione del criterio della “preponderanza
dell’evidenza” (15), non è stato recepito dalla nostra giurisprudenza, determinando una “fuga” verso la sede processuale penale delle istanze dei soggetti danneggiati da
attività produttive legate alla cd. “società del rischio”.
Sembrerebbe così privilegiata e valorizzata la giurisdizione penale, ma in realtà la presenza di rigorose regole probatorie e di giudizio finisce per impedire in concreto il
raggiungimento di un risultato positivo, sempre che non
si pensi di stravolgere tali regole con decisioni di con-
danna pronunciate nonostante il mancato raggiungimento della prova “oltre il ragionevole dubbio” della responsabilità individuale.
D’altro canto, il diffondersi del risarcimento in sede penale, con la correlativa creazione di class actions improprie (o spurie), con una molteplicità di parti civili che
sostengono le medesime richieste, non tiene conto del
fatto che l’esigenza prioritaria, per le persone offese, è (o
dovrebbe essere) non già quella di veder puniti i colpevoli, rispondendo ad un istinto primordiale di vendetta,
ma piuttosto quella di essere risarcite. Esigenza che, per
le fattispecie meno complesse ed in particolare per quelle che non sottintendono un risarcimento collettivo, dovrebbe trovare ristoro e soddisfazione in sede penale,
mentre negli altri casi potrebbe avvalersi di nuove e diverse vie.
L’inadeguatezza della tutela prospettata in sede civile ha
condotto a prendere in considerazione altri percorsi, come la tutela in sede amministrativa, sempre sull’onda
dell’esperienza nordamericana, dove - partendo dalla
constatazione che nella prassi le Corti si dimostrano resistenti ad accogliere nel processo civile le deroghe ed
eccezioni che appaiono necessarie per superare i pesanti
requisiti probatori richiesti e dall’osservazione che le
norme di common law in tema di responsabilità civile si
sono affermate quando non erano ancora rappresentabili le implicazioni derivanti dall’azione di danno per rischi
economici collettivi - si propone di abbandonare il modello civile in favore di uno schema risarcitorio di natura amministrativa.
In tal modo, peraltro, si aprono spazi inusitati ad una rivoluzione copernicana che guarda non più soltanto alNote:
(9) Ulteriori garanzie sono delineate dall’art. 11 per le vittime residenti
in uno Stato membro differente da quello in cui il reato è stato commesso, prevedendo la possibilità di raccogliere la deposizione della vittima
nell’immediatezza del fatto e l’utilizzo, per l’audizione delle vittime residenti all’estero, delle disposizioni in tema di videoconferenze e teleconferenze previste dalla Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea del 28 maggio
2000.
(10) V. in proposito le sempre attuali considerazioni di A. Giarda, La persona offesa dal reato, cit., 1-2.
(11) Sul concetto di persona offesa dal reato e sul suo ruolo nell’ordinamento vigente cfr. C. Quaglierini, Le parti private diverse dall’imputato e
l’offeso dal reato, Milano, 2003, 155 s.
(12) Sulla prospettazione di una iniziativa privata innanzi al giudice di
pace (e, più in generale sul ruolo della persona offesa nel relativo procedimento) v. C. Pansini, Contributo dell’offeso e snodi procedimentali, Padova, 2004, 123 s.
(13) Cfr. lo studio di F. Stella, Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, 3ª ed., Milano, 2003, passim.
(14) In argomento v. C. Consolo, Class actions fuori dagli USA?, in Riv.
dir. civ., I, 1993, 609 s.; A. Giussani, Studi sulle “class actions”, Padova,
1996, passim.
(15) Si tratta della regola secondo cui è attendibile la prova che valga almeno 0,51, su cui v., in dottrina, M. Taruffo, La prova dei fatti giuridici, Milano, 1992, 261 s.
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1063
EDITORIALE•PROCESSO PENALE
l’aspetto della repressione ma anche a quello della prevenzione, inglobando nel risarcimento il potenziale danno futuro.
Anche da questo punto di vista, i seppur timidi tentativi
effettuati nel nostro ordinamento appaiono a tutt’oggi
infruttuosi, a differenza di quanto accaduto negli Stati
Uniti, ove le Agenzie amministrative federali già alla fine degli anni sessanta del secolo scorso avevano adottato e posto in pratica ben precise strategie di prevenzione
dei rischi per la salute, la sicurezza e l’ambiente fondate
sulla cd. “regola di precauzione”, dalle quali era nata l’idea di delegare alle stesse il compito di risarcire il danno
alle vittime dell’attività economica nociva, seguendo
schemi di diritto amministrativo (16).
In Italia, dunque, il diritto amministrativo preferisce
ignorare tale innovativa via, e la stessa possibilità di ricorrere alla giurisdizione amministrativa per vedere tutelati in via collettiva i suddetti diritti è apertamente disincentivata, quando non negata, se si eccettuano sporadiche decisioni in cui una elaborazione giurisprudenziale “di frontiera” ha aperto spazi inusuali quanto inattesi:
è il caso della sentenza del T.A.R. Puglia del 23 marzo
1999, n. 229 nella quale si afferma che i rimedi predisposti dalla legge a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti vanno ricompresi nella categoria delle class actions, legittimando così le associazioni di categoria a costituirsi per la tutela collettiva di posizioni soggettive individuali. In tal modo il titolare del diritto può agire individualmente, a tutela (preventiva o successiva) della
propria situazione protetta, ovvero - alla luce di una legittimazione concorrente - l’associazione può assumere
l’iniziativa, anche in assenza di un accordo con la persona lesa (17).
Anche la predisposizione di un modello amministrativo
in sostituzione di quello della responsabilità civile, tuttavia, presenta non pochi ostacoli, in quanto dare vita ad
un foro nazionale unico - costituito da un comitato di
esperti investito del potere di decidere sui ricorsi in materia applicando il criterio della proporzionalità e di liquidare i relativi danni seguendo canoni tabellari - se pone rimedio alle anomalie legate alla “regola della preponderanza dell’evidenza” applicata in sede civile rappresenta al contempo una soluzione allo stato politicamente poco praticabile in Italia, sia per i costi che essa
comporta che per gli interessi che va ad infrangere.
Se dunque le strade suggerite dall’esperienza nordamericana appaiono tutt’altro che agevoli da percorrere nel
nostro contesto, anche per il diverso assetto ordinamentale di quel sistema, non per questo ci si deve astenere dal
prospettare de iure condendo alcune possibili soluzioni.
Così, se si dovesse optare per un risarcimento in sede civile, il primo passo da compiere dovrebbe essere quello
dell’adozione del criterio della proporzionalità, pensando magari all’istituzione di un foro nazionale unico costituito da giudici specializzati integrati da esperti del settore, con la predisposizione di procedimenti unificati per le
azioni di danno di massa.
1064
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
Oppure, si potrebbero creare delle sezioni specializzate
(anche a composizione mista), come accade già oggi a
tutela di interessi particolari: si pensi all’istituzione delle
sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed
intellettuale, ad opera del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168.
In tal modo sarebbe possibile utilizzare professionalità
adeguate e pervenire a decisioni omogenee e (altro punctum dolens sul tappeto) in tempi rapidi.
Quel che maggiormente stupisce l’osservatore, però, è la
quasi totale assenza di una organica politica legislativa in
materia, tesa a colmare le lacune dell’ordinamento adeguandolo alle nuove istanze ed esigenze prospettate con
forza dalla “società del rischio” e, last but not least, alle indicazioni prospettate a livello comunitario.
Quanto all’area del diritto civile, lo sforzo legislativo teso ad introdurre nel nostro ordinamento un sistema di
class actions è a tutt’oggi rimasto a livello di mere intenzioni, nonostante le numerose iniziative legislative pendenti in Parlamento (18) e le Commissioni ad hoc istituite a vari livelli (come quella del Consiglio Nazionale
Forense).
Anche in ambito penalistico le varie iniziative prese, cui
si è fatto prima cenno, non sono purtroppo ancora sfociate in regolamentazioni positive, scontando il difetto
di interesse di cui si è detto in apertura nei confronti della vittima del reato.
E
ccoci tornati al punto da cui eravamo partiti.
Nonostante il movimento internazionale teso ormai da alcuni decenni a valorizzare il ruolo della
vittima del reato, che ha mostrato particolare attenzione
al problema del danno derivante dal reato, distinguendo
tra danno primario (direttamente scaturente dalla condotta illecita) e danno secondario (ascrivibile al comportamento dell’apparato giudiziario successivo al compimento del reato ed ai suoi riverberi sulla persona offesa), il silenzio del legislatore sul punto appare per certi
versi inquietante e sembra riconfermare una tradizione
giuridica ormai plurisecolare tesa a sminuire il ruolo della vittima del reato nel nostro ordinamento.
È noto che, storicamente, l’emergere di strutture processuali penali pubbliche, prima, e l’affermazione degli Stati nazionali moderni, a struttura burocratica centralizzata, poi, ha comportato una progressiva marginalizzazione
del ruolo della vittima del reato all’interno del processo
penale, che perde il suo carattere di luogo di composizio-
Note:
(16) S. Jasanoff, Science at the Bar: Law, Science and Technology in America, 1995 (La scienza davanti ai giudici, ed. it., Milano, 2001), 128 s.
(17) T.A.R. Puglia, Sez. I, 23 marzo 1999, n. 229, Codacons e altri c. Ministero della pubblica istruzione e altri, in Foro amm., 1999, 1878 s., in tema di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti (art. 3 l. 30 luglio
1998, n. 281).
(18) Il riferimento è, da ultimo, al disegno di legge AS 3058, presentato
al Senato della Repubblica il 22 luglio 2004. Cfr., in argomento, G. Costantino, Note sulle tecniche di tutela collettiva (disegni di legge sulla tutela del
risparmio e dei risparmiatori), in Riv. dir. proc., 2004, 1009 s.
EDITORIALE•PROCESSO PENALE
ne della controversia per divenire principalmente sede
di irrogazione della sanzione penale.
Così neutralizzata da parte del diritto penale statale, la
vittima del reato ha perso il suo ruolo di protagonista del
processo penale, e lo stesso diritto penale si è trasformato da “diritto penale per la vittima” a “Magna Charta del
reo”, con l’effetto di produrre un clima culturale diffuso,
a tutt’oggi dominante, di scarsa attenzione nei confronti
della persona offesa e delle sue esigenze (19).
Mentre in vari sistemi giuridici nazionali si è sviluppata
la cd. restorative justice (giustizia riparativa), incentrata
per l’appunto sul risarcimento del danno patito dalla
persona offesa, oltre a strategie di assistenza e di sostegno
della stessa sia all’interno che all’esterno del sistema processuale (20), in Italia perdura una situazione di stallo.
Lungi dall’accogliere l’orientamento emerso a livello internazionale, teso a concepire un risarcimento diretto da
parte dell’autore del reato (restitution) e, in via alternativa e subordinata, un indennizzo da parte dello Stato secondo un’ottica solidaristica (compensation), i tentativi
di introdurre una disciplina idonea a soddisfare le molteplici esigenze nascenti dalla presenza di interessi individuali o collettivi lesi dal reato segnano il passo.
Anche lo sforzo di “smuovere le acque”, operato dal disegno di legge AS 2464, presentato come detto al Senato nel 2003 recependo quasi integralmente la proposta
di legge quadro per l’assistenza e il sostegno delle vittime
dei reati, elaborata dalla Commissione Santacroce, è rimasto ad oggi senza effetto, nonostante i numerosi profili positivi in esso contenuti.
Tra essi, particolare rilievo assume la prospettazione di
una nozione più ampia di vittima del reato, che pure non
riproduce la definizione contenuta nella decisione-quadro del 2001: è tale, secondo l’art. 1, la persona offesa dal
reato e, qualora questa sia deceduta in conseguenza del
reato, i suoi prossimi congiunti, chi è legato alla persona
offesa dal vincolo di adozione e chi, pur non essendo coniuge, conviveva come tale stabilmente con essa (art. 1
comma 2).
Viene altresì fissato quale obiettivo di Stato, regioni ed
autonomie locali quello di promuovere, organizzare e curare l’assistenza, pronta e gratuita, delle vittime di tutti i
reati, fornendo il necessario supporto psicologico, morale, sanitario, legale e finanziario (art. 3 comma 1).
Lo stesso art. 3 scandisce poi i modi dell’intervento della vittima, prevedendo tra l’altro: a) il gratuito patrocinio; b) l’incentivazione delle procedure di mediazione e
di conciliazione tra la vittima e l’autore del reato, anche
ai fini del risarcimento del danno, per i reati perseguibili
a querela, per quelli commessi da minorenni e per ogni
altro reato rispetto al quale tali procedure si palesino idonee a tutelare in concreto gli interessi della vittima; c) la
predisposizione di procedure (giudiziarie ed extragiudiziarie) tese a consentire - entro tempi ragionevoli - la riparazione del danno patrimoniale o non patrimoniale
cagionato dal reato, sia da parte dell’autore del reato che
da parte di organismi pubblici ad hoc nel caso in cui la
persona offesa non possa diversamente ottenere il risarcimento del danno patito, recependo l’orientamento internazionale testé ricordato che affianca al risarcimento
in via diretta quello alternativo di stampo solidaristico a
carico delle pubbliche istituzioni (art. 3 comma 3).
L’art. 4 (come il successivo art. 5) si occupa degli aspetti
più squisitamente processuali, rendendo effettivo il diritto di informazione - con riferimento ai tempi, modi e
luoghi di presentazione della denuncia e della querela,
alle forme di assistenza fruibili da parte della vittima, alle modalità di risarcimento del danno, alle condizioni e
misure di protezione della vita privata e della incolumità
fisica della persona offesa e dei suoi familiari, nella qualità di persone informate sui fatti o di testimoni, nonché
ai risultati delle indagini preliminari, quando ne abbia
fatto espressa richiesta e sempre che ciò non pregiudichi
la corretta prosecuzione dell’attività investigativa - e
prevedendo, in attuazione dell’art. 11 della decisionequadro del 2001, la possibilità per la persona offesa residente in altro Stato di presentare denuncia innanzi all’autorità competente dello Stato in cui risiede e di chiedere di essere sentita mediante videoconferenza o teleconferenza, ai sensi degli artt. 10 e 11 della Convenzione di Bruxelles relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea del
28 maggio 2000 (art. 4 commi 1 e 2) (21).
Significative modifiche al codice di rito sono prospettate dall’art. 5, con riferimento agli artt. 79, 90, 98, 293,
306, 392, 393, 394, 396, 397, 408, 410, 412, 415-bis, 548
e 666 c.p.p., allo scopo di rendere possibile alla persona
offesa dal reato l’esercizio in tutte le fasi processuali dei
poteri necessari alla tutela dei suoi interessi, a prescindere dalla sua costituzione in giudizio quale parte civile.
In particolare, si prospetta l’allargamento dei soggetti
chiamati ad esercitare le facoltà e i diritti della persona
offesa a chi è legato alla persona offesa da vincolo di adozione e a chi, pur non essendo suo coniuge, conviveva
stabilmente con la stessa (art. 90 comma 3 c.p.p.), in sintonia con il concetto di vittima del reato fornito; l’estensione del gratuito patrocinio secondo quanto previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (t.u. spese di giustizia), con particolari adeguamenti nel caso di vittime
cd. “a tutela rafforzata” (art. 98 c.p.p.); la possibilità per
la persona offesa di richiedere l’incidente probatorio direttamente, e non più in via indiretta, per il tramite del
pubblico ministero (artt. 392-394 c.p.p.) (22); l’ampliamento degli oneri informativi, dovendo essere comuniNote:
(19) Sul punto v. più diffusamente P. Martucci, voce Vittima del reato, in
Enc. giur., XXXII, 2003, 1 s.
(20) Nella stessa direzione si muove la summenzionata decisione-quadro
del 2001, prevedendo agli artt. 13, 14 e 15 un sistema composito di servizi specializzati e di organizzazioni di assistenza alle vittime.
(21) V. supra, nota 9.
(22) L’attribuzione di poteri probatori rende di fatto la persona offesa una
parte, e non più un mero soggetto processuale.
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1065
EDITORIALE•PROCESSO PENALE
cate alla persona offesa le ordinanze in tema di misure
cautelari (art. 293 c.p.p.) ed in caso di particolari reati
l’ordinanza che dispone la liberazione dell’indagato o
dell’imputato per perdita di efficacia della custodia cautelare (art. 306 c.p.p.), l’avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.), l’avviso di deposito della sentenza (art. 548 c.p.p.) e l’avviso di fissazione
dell’udienza camerale nel procedimento d’esecuzione
per la concessione della liberazione condizionale (artt.
666 e 682 c.p.p.).
Q
uali che siano le determinazioni del legislatore
sui singoli punti in discussione, quel che è certo
e che è giunto il momento di attuare anche in
Italia uno statuto delle vittime dei reati, sulla falsariga di
quanto previsto in altri ordinamenti come quello nordamericano, dove da oltre un decennio è in vigore il Crime
Victim’s Bill of Right.
CD-ROM
Occorre insomma predisporre un’adeguata tutela, in sede processuale ed extra-processuale, della vittima, che risponda in maniera globale alle esigenze troppo spesso
ignorate della persona offesa, sottraendo una volta per
tutte la sua partecipazione processuale all’ottica, squisitamente inquisitoria, di mera cooperazione all’accertamento della verità per valorizzare le istanze di tutela dei
suoi interessi personali, in un quadro di coordinamento
con gli altri ordinamenti, specie a livello comunitario.
Solo così l’opzione accusatoria, a cui il codice 1988 afferma ispirarsi e che i successivi interventi e progetti di
riforma si propongono di perpetuare, potrà dirsi veramente realizzata, ed i canoni costituzionali del “giusto
processo” potranno trovare compiuta espressione in
un’ottica di piena legittimazione, a livello sociale, del sistema della giustizia penale, altrimenti destinato a soffrire una sempre maggiore distanza dalle esigenze della collettività.
Penale
Documentazione Casistica Formule
Note procedurali Bibliografia Diagrammi di flusso
Con aggiornamento on-line incluso nel prezzo dell’abbonamento
L’unica banca dati specifica in materia di
diritto penale. Rappresenta uno strumento professionale indispensabile per Avvocati e Magistrati.
Offre un’informazione completa e costantemente aggiornata in materia penale, sia
dal punto di vista sostanziale che da
quello processuale.
La facilità di navigazione, la ricchezza
delle correlazioni, i diagrammi di flusso,
le formule, l’ampia selezione di casistica
ne fanno uno strumento operativo di facile utilizzo, irrinunciabile per tutti i Professionisti del diritto penale.
CONTENUTO
Casistica: l’esposizione ragionata per argomenti dei casi concreti affrontati dalla
giurisprudenza correlata al Codice penale
e al Codice di procedura penale.
Formulario: tutti gli atti ed i provvedimenti
del processo penale.
Note procedurali: la segnalazione, per
ciascun tipo di reato previsto dal Codice
penale, del giudice competente, del regime di procedibilità e delle misure cautelari applicabili.
Bibliografia: l’indicazione delle principali
1066
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
pubblicazioni, organizzata per ciascun articolo del Codice penale e del Codice di
procedura penale.
Diagrammi di flusso: lo schema dei principali istituti processuali con rimandi ipertestuali alla legislazione che a sua volta si
correla alla giurisprudenza, alle formule,
alla bibliografia.
Documentazione: la legislazione nazionale, i trattati e le convenzioni internazionali;
la giurisprudenza della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione, dei giudici di merito e della Corte europea dei diritti dell’uomo; le circolari delle principali
istituzioni competenti in materia.
Prezzo Abbonamento:
€ 260,00 + IVA 20%
Canone annuo di aggiornamento:
€ 200,00 + IVA 20%
Periodicità di aggiornamento:
trimestrale (4 Cd-Rom all’anno)
Per informazioni
• Servizio Informazioni Commerciali
(tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)
• Agente Ipsoa di zona (www.ipsoa.it/agenzie)
• www.ipsoa.it
LEGISLAZIONE•SINTESI
Novità normative
Delitti contro la personalità dello Stato
Legge 31 luglio 2005, n. 155 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale» (G.U. 1° agosto 2005, n. 177)
La legge in esame converte, con modificazioni, il “pacchetto antiterrorismo”, varato con il d.l. 27 luglio 2005, n.
144 (in G.U., 27 luglio 2005, n. 173), che contiene misure di contrasto al terrorismo internazionale. Numerosi ed
importanti sono gli interventi - qui solo brevemente accennati - che incidono sull’apparato lato sensu repressivo.
Quando al diritto sostanziale, da segnalare, in primo luogo, l’introduzione nel codice penale di due nuove figure delittuose: l’«arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale» (art. 270-quater), che punisce con la reclusione da 7 a 15 anni «chiunque, al di fuori dei casi di cui all’art. 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti
contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale», e l’«addestramento ad attività con finalità
di terrorismo anche internazionale» (art. 270-quinquies), che commina la reclusione da 5 a 15 anni nei confronti di
chi «addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o
di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per
il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche
se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale»; la stessa pena si applica nei confronti dell’addestrato. In sede di conversione, è stato inserito anche l’art. 270-sexies, che, come recita la rubrica, contiene un’importante norma definitoria delle «condotte con finalità di terrorismo»: «Sono considerate con finalità
di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o
un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere
le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre
norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia». Ancora, viene introdotto l’art. 497-bis, che incrimina il possesso e la fabbricazione di documenti di identificazione falsi: si punisce con la reclusione da 1 a 4 anni «chiunque è
trovato in possesso di un documento falso valido per l’espatrio»; a norma del comma 2, la pena «è aumentata da un
terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale». Vengono infine ritoccate le fattispecie di cui agli artt. 495 e 414 c.p.; quanto alla prima, al comma 4 n. 2, dopo le parole: «da un imputato all’autorità giudiziaria», sono inserite le seguenti: «o da una persona sottoposta ad indagini alla stessa autorità o alla polizia giudiziaria delegata alle indagini»; in relazione alla seconda, viene aggiunto
il comma 4, che così recita: «fuori dei casi di cui all’articolo 302, se l’istigazione o l’apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità la pena è aumentata della metà».
Sul terreno del processuale, le novità si registrano su più fronti. Anzitutto, quanto all’arresto obbligatorio in flagranza, il minimo edittale previsto per l’adozione della misura relativamente ai delitti commessi con finalità di terrorismo scende da 5 a 4 anni di reclusione (art. 380 comma 2 lett. i c.p.p.); inoltre, tra i reati per i quali è previsto
l’arresto obbligatorio viene inserito anche il nuovo delitto di cui all’art. 497-bis c.p. (art. 380 comma 2 lett. m-bis
c.p.p.) Il fermo ex art. 384 c.p.p. viene esteso ai delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale,
o di eversione dell’ordine democratico; inoltre, tra gli elementi sintomatici del pericolo di fuga, presupposto per
l’applicazione del fermo da parte della polizia giudiziaria a norma del comma 3, viene espressamente previsto il possesso di documenti falsi.
Vengono modificate le disposizioni relative all’identificazione personale. In primo luogo si autorizza il prelievo di
saliva o di capelli, anche contro il consenso dell’interessato, a condizione che avvenga nel rispetto della dignità
personale dell’identificando e via sia l’autorizzazione - anche orale ma poi confermata per iscritto - del p.m. (art.
349 comma 2-bis c.p.p.). Inoltre, la polizia è autorizzata a trattenere sino a ventiquattro ore la persona da identificare, previo avviso anche orale al pubblico ministero, «nel caso in cui l’identificazione risulti particolarmente
complessa oppure occorra l’assistenza dell’autorità consolare o di un interprete ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente» (art. 349 comma 4 c.p.p.). A norma del nuovo art. 66bis c.p.p., «in ogni stato e grado del procedimento, quando risulta che la persona sottoposta alle indagini o l’imputato è stato segnalato, anche sotto diverso nome, all’autorità giudiziaria quale autore di un reato commesso antecedentemente o successivamente a quello per il quale si procede, sono eseguite le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente ai fini dell’applicazione della legge penale».
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1067
LEGISLAZIONE•SINTESI
Novità anche in tema di intercettazioni ambientali: i direttori dei Servizi informativi e di sicurezza, su delega del
Presidente del Consiglio dei Ministri, possono richiedere al Procuratore generale del distretto di Corte d’appello,
del luogo dove si trova il soggetto da controllare ovvero ove sono sorte le esigenze di prevenzione, l’autorizzazione
per svolgere le attività di intercettazione ambientali, di cui all’art. 226 disp. att. c.p.p., quando siano ritenute indispensabili per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell’ordinamento costituzionale. Nel settore
della comunicazioni, fino al 31 dicembre 2007 è sospesa l’applicazione delle disposizioni di legge, di regolamento
o dell’autorità amministrativa che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni e limitatamente alle informazioni che consentono la
tracciabilità degli accessi e dei servizi.
Da segnalare, ancora, che la p.g. viene alleggerita da compiti sussidiari nel processo penale; a norma del nuovo art.
148 comma 2 c.p.p., nei procedimenti con imputati detenuti le notificazioni possono essere effettuate dalla polizia penitenziaria; ai sensi del nuovo testo dell’art. 151 comma 1 c.p.p., le notificazioni di atti del p.m. nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, ovvero dalla p.g. nei soli casi di atti di indagine o
provvedimenti che la stessa p.g. è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire.
Quanto alla legislazione speciale, i colloqui a fini investigativi, previsti dall’art. 18-bis l. 26 luglio 1975, n. 354, sono autorizzati anche per acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e repressione
dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico.
Numerosi sono agli interventi relativi alla disciplina dell’immigrazione; tra questi, da segnalare la previsione di
procedura più snella in materia di espulsione degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo: il Ministro
dell’interno, o, su sua delega, il prefetto, può disporre l’espulsione dello straniero appartenente ad una delle categorie di soggetti pericolosi di cui all’art. 18 l. 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di
ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività
terroristiche, anche internazionali. Una procedura ad hoc è inoltre prevista nel caso in cui lo straniero collabori con
la giustizia: costui può ottenere, in deroga alla disciplina vigente, uno speciale permesso di soggiorno per fini investigativi, di durata annuale e rinnovabile, rilasciato dal il questore, anche su segnalazione dei responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia o dei Servizi informativi e di sicurezza, ovvero su richiesta del p.m. Lo
straniero può inoltre ottenere la carta di soggiorno se la collaborazione offerta ha avuto straordinaria rilevanza per
la prevenzione nel territorio dello Stato di attentati terroristici alla vita o all’incolumità delle persone o per la concreta riduzione delle conseguenze dannose o pericolose degli attentati stessi, ovvero per l’identificazione dei responsabili.
(La presente legge sarà pubblicata e commentata sul prossimo fascicolo)
Ordine pubblico
Decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162 «Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive» (G.U. 18 agosto 2005, n. 191)
È in vigore del 19 agosto 2005 il decreto legge in esame, che detta ulteriori le misure per contrastare la violenza negli stadi. Il decreto legge apporta numerose modifiche alla l. 13 dicembre 1989, n. 401. Oltre al rafforzamento delle sanzioni amministrative, tra cui l’inasprimento del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni
sportive - che, tra l’altro, può essere disposto anche nell’ipotesi in cui queste si svolgano all’estero, specificamente
indicate, ovvero dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell’Unione europea per le manifestazioni
sportive che si svolgono in Italia (art. 6) - vengono potenziate anche le misure repressive. In particolare, all’art. 6bis, che incrimina il lancio di materiale pericoloso, sono aggiunte, al comma 1, due nuove circostanze aggravanti:
«La pena è aumentata se dal fatto deriva un danno alle persone. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto
deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l’interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva».
Anche al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo, che prevede una nuova aggravante: «La pena è della
reclusione da 1 mese a 3 anni e 6 mesi se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l’interruzione
o la cancellazione della manifestazione sportiva». Di nuovo conio è la fattispecie di cui all’art. 6-quater, che estende la tutela accordata dagli artt. 336 e 337 c.p. agli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni
sportive: «Ai sensi e per gli effetti degli articoli 336 e 337 del codice penale, sono considerati incaricati di un pubblico servizio gli incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell’instradamento degli spettatori e quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d’uso dell’impianto dove si svolgono manifestazioni sportive».
(Il presente decreto, una volta convertito in legge, sarà pubblicato per esteso e commentato in uno dei prossimi fascicoli)
1068
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
GIURISPRUDENZA•SINTESI
Osservatorio
della Corte costituzionale
a cura di GIUSEPPE DI CHIARA
Diritto penitenziario
LIBERAZIONE ANTICIPATA,
PROCEDIMENTO DE PLANO
E CONTRADDITTORIO DIFFERITO EVENTUALE
Corte costituzionale, ordinanza 19 luglio 2005 (7 luglio
2005), n. 291 - Pres. Capotosti - Red. Flick
(Art. 69-bis ord. penit.)
È manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 69-bis ord. penit., introdotto dall’art. 1 comma 2 l. 19 dicembre 2002, n. 277 («Modifiche
alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione
anticipata»), nella parte in cui stabilisce che il magistrato
di sorveglianza provvede con rito senza formalità sulla
concessione della liberazione anticipata al condannato detenuto in carcere o in misura alternativa, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost.
Il rito de plano previsto dal “nuovo” art. 69-bis ord. penit.
in tema di liberazione anticipata assurge ancora a oggetto di scrutinio di costituzionalità. Già di recente, per vero, la Corte ne aveva escluso il contrasto con il diritto di
difesa (Corte cost. n. 352 del 2003, in questa Rivista,
2004, 53), osservando come la nuova disciplina del procedimento - in forza della quale il magistrato di sorveglianza decide sull’istanza dell’interessato de plano, salva
una fase successiva di reclamo, a contraddittorio pieno,
davanti al tribunale di sorveglianza - sia stata introdotta
dalla l. n. 277 del 2002 «in risposta ad esigenze di snellimento procedurale fortemente sentite nella prassi, tenuto conto anche dell’elevato numero delle istanze di cui si
discute». Veniva, infatti, «avvertita come fonte di ingiustificato aggravio (e ritardo nella decisione) la previsione
di un procedimento in contraddittorio, in vista dell’adozione di un provvedimento che ben poteva essere - ed in
larga parte dei casi era - di accoglimento della richiesta
dell’interessato: apparendo assai più ragionevole, di contro, che l’instaurazione di un contraddittorio pieno avvenisse solo nel caso di eventuale insoddisfazione del richiedente (o del pubblico ministero) per la decisione assunta». D’altronde, insistendo su una chiave di lettura
costante nella giurisprudenza costituzionale, la Corte
aveva già ribadito «la piena compatibilità con il diritto di
difesa dei modelli processuali a contraddittorio eventua-
le e differito: caratterizzati cioè - in ossequio a criteri di
economia processuale e di massima speditezza - da una
decisione de plano seguita da una fase a contraddittorio
pieno, attivata dalla parte che intenda insorgere rispetto
al decisum» (cfr., in tal senso, altresì, ex plurimis, Corte n.
292 del 2004; nn. 257, 132 e 131 del 2003, nonché n. 32
del 2003, in questa Rivista, 2003, 280); e ciò «conformemente al consolidato principio per cui il diritto di difesa
può essere regolato in modo diverso, onde adattarlo alle
esigenze ed alle specifiche caratteristiche dei singoli procedimenti, purché di tale diritto siano assicurati lo scopo
e la funzione» (cfr., ex plurimis, Corte cost. n. 321 del
2004).
Tali conclusioni - ribadisce l’odierno decisum - «valgono a
maggior ragione per il procedimento in esame, nel quale il
giudice è chiamato a decidere su una domanda proposta
dalla stessa parte del cui diritto di difesa si discute»; circostanza che - rimarca ancora la Corte - «rende tra l’altro non
persuasiva la tesi, prospettata dal giudice a quo, secondo cui
il richiedente, in assenza di previsione espressa, non sarebbe legittimato a produrre memorie difensive a sostegno della propria richiesta».
Né può - osserva la Corte - ritenersi, come mostra invece il giudice rimettente, che il meccanismo del contraddittorio differito potrebbe comunque pregiudicare
l’interessato - il quale fosse in grado di dimostrare la
fondatezza delle sue tesi, ove ammesso a partecipare al
procedimento davanti al magistrato di sorveglianza - allorché la concessione del beneficio implicasse l’immediata conclusione dell’espiazione della pena: invero, la
previsione del procedimento de plano «giova senz’altro
alla rapidità della decisione in rapporto al complesso
delle istanze in parola, rispetto alle quali (…) è in fatto
nettamente preponderante la percentuale dei provvedimenti di accoglimento: evitando così il pregiudizio che
il rimettente ipotizza sotto altro profilo, ossia che i tempi più lunghi, richiesti al fine di una decisione in contraddittorio già in prima battuta, danneggino i condannati con pena da espiare prossima alla conclusione», e
«tutto ciò senza considerare che, proprio attraverso il
meccanismo censurato, viene assicurato, in sostanza, al
condannato un doppio scrutinio nel merito della sua
istanza».
In argomento cfr., tra gli altri, L. Filippi, Il nuovo rito de plano per la liberazione anticipata: un contraddittorio eventuale e
differito in linea con l’art. 111 Cost.?, in questa Rivista, 2003,
276 ss.
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1069
GIURISPRUDENZA•SINTESI
Esecuzione della pena
INCOSTITUZIONALE IL DIVIETO DI ACCESSO
ALL’“INDULTINO” PER I CONDANNATI
IN MISURA ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE
Corte costituzionale, sentenza 15 luglio 2005 (7 luglio
2005), n. 278 - Pres. Capotosti - Red. Finocchiaro
(Art. 1 comma 3 lett. d l. 1° agosto 2003, n. 207)
È incostituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 1
comma 3 lett. d l. 1° agosto 2003, n. 207 («Sospensione
condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni»).
La norma adesso dichiarata costituzionalmente illegittima
prevedeva, quale causa ostativa del beneficio della sospensione condizionata della pena previsto dall’art. 1 comma 1
l. n. 207 del 2003, l’ammissione del condannato a una misura alternativa alla detenzione; nel sollevare la quaestio de
legitimitate, il giudice a quo ne aveva denunciato il contrasto
con l’art. 3 Cost., stigmatizzando l’irrazionalità della disposizione, nonché con l’art. 27 comma 3 Cost., «perché la pena non avrebbe alcuna funzione rieducativa o preventiva,
non avendo il giudice di sorveglianza alcun apprezzamento
discrezionale sulla concessione del beneficio».
La Corte ha accolto le prospettazioni del rimettente con riguardo al parametro dell’irragionevolezza della scelta normativa sottoposta a scrutinio, ritenendo assorbite le censure sollevate in ordine al parametro residuo. La norma - sottolinea la pronuncia in esame - «determina una irragionevole disparità di trattamento fra il condannato che, perché
“meritevole”, è stato ammesso a misure alternative alla detenzione e il condannato che - o perché “immeritevole” o
perché non versava nelle condizioni oggettive per avanzare la relativa richiesta - non è stato ammesso al godimento
di tali misure, dal momento che il primo non può godere
del beneficio della sospensione condizionata della pena residua, mentre il secondo ottiene prima la sospensione della
pena, e poi, se non commette entro cinque anni delitti non
colposi per i quali riporti una condanna non inferiore a sei
mesi di detenzione, l’estinzione della pena stessa».
È bensì vero - nota la Corte - che rientra nella discrezionalità del legislatore modulare in vario modo i benefici da
concedere ai condannati, con l’unico limite della non manifesta irragionevolezza; proprio tale limite, tuttavia, nella
specie, risulta violato, «non potendo la circostanza dell’ammissione o meno a misure alternative alla detenzione costituire un discrimine per il godimento del c.d. “indultino”, e
ciò soprattutto ove si tenga presente che di quest’ultimo
verrebbero a godere condannati ritenuti non meritevoli di
misure alternative e non anche quelli che sono stati giudicati meritevoli di tali misure».
Sul c.d. “indultino” introdotto dalla l. n. 207 del 2003 cfr.,
tra gli altri, L. Filippi, “Indultino”: sospensione condizionata
della pena detentiva nel limite massimo di due anni. Rilievi di di-
1070
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
ritto processuale, in questa Rivista, 2003, 1471 ss.; F. Palazzo,
“Indultino”: sospensione condizionata della pena detentiva nel
limite massimo di due anni. Introduzione, ibidem, 1470 s.; R.
Turrini Vita, “Indultino”: sospensione condizionata della pena
detentiva nel limite massimo di due anni. Rilievi di diritto penitenziario, ibidem, 1476 ss.; nonché L.L. Colognese, “Indultino”: rilievi critici e primi risvolti applicativi, ivi, 2004, 1020 ss.,
e F. Counsulich, La difficile appartenenza dogmatica del c.d.
“indultino”, ibidem, 731 ss.
Indagini preliminari
TERMINI PER LE INDAGINI E RITARDATA
ISCRIZIONE DEL NOME DELL’INDAGATO
NEL REGISTRO GENERALE
DELLE NOTIZIE DI REATO
Corte costituzionale, ordinanza 22 luglio 2005 (7 luglio
2005), n. 307 - Pres. Capotosti - Red. Flick
(Artt. 335 comma 1 e 407 comma 3 c.p.p.)
È manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 335 comma 1 e 407 comma 3
c.p.p., nella parte in cui non prevedono l’inutilizzabilità
degli atti di indagine compiuti nei confronti dell’imputato
in epoca anteriore alla sua iscrizione nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. e successiva al momento in cui ha comunque assunto la qualità di persona nei cui confronti sono
svolte le indagini, sollevata in riferimento agli artt. 3 comma 1, 24 e 11 comma 3 Cost.
Nel sollevare la quaestio, il giudice a quo si doleva della
mancata previsione dell’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti nei confronti di un determinato soggetto dopo
che sia emersa la sua qualità di persona sottoposta alle indagini, ma prima della formale iscrizione del suo nominativo nel registro delle notizie di reato.
Il medesimo rimettente, tuttavia, non mancava di aderire
all’indirizzo interpretativo secondo cui la qualità di persona
sottoposta alle indagini non discende dall’iscrizione nel registro: tale iscrizione - rilevava lo stesso giudice a quo - assume piuttosto «una mera funzione ricognitiva di un dato
procedimentale potenzialmente preesistente» (cfr., per tale
indirizzo, per applicazioni specifiche, tra le altre, Cass., Sez.
V, 28 dicembre 1995, Sibilla, in C.E.D. Cass., n. 203945,
e Cass., Sez. I, 7 maggio 1997, P.m. in c. Giuliani, ibidem, n.
207427): tale qualità, soggiungeva il giudice a quo, ove non
emerga direttamente dalla notitia criminis, si acquisisce, infatti, prima e a prescindere dall’iscrizione, in ragione della
«direzione soggettiva» concretamente assunta dall’attività
investigativa, e ciò alla luce di un insieme di previsioni normative (cfr. artt. 63 comma 2, 349 e 350 comma 5 c.p.p.)
rivelatrici dell’intenzione del legislatore.
Ciò posto - nota la Corte - se l’iscrizione nel registro ha una
valenza meramente ricognitiva, e non già costitutiva dello
GIURISPRUDENZA•SINTESI
status di persona sottoposta alle indagini, «è di tutta evidenza come le garanzie difensive che la legge accorda a quest’ultima, in relazione ai singoli atti compiuti, debbano ritenersi pienamente operanti anche in assenza dell’iscrizione», sicché «il tardivo espletamento della formalità non
può essere considerato fonte di pregiudizio al diritto di difesa sotto il profilo indicato dal giudice rimettente».
Del pari insussistente risulta, di conseguenza, la ventilata disparità di trattamento tra «indagati» tempestivamente iscritti e «indagati» tardivamente iscritti: «nell’ipotesi, infatti, in
cui il pubblico ministero procrastini indebitamente l’iscrizione del registro, il problema che può porsi attiene unicamente all’artificiosa dilazione del termine di durata massima delle indagini preliminari», vale a dire «alla possibile elusione
della sanzione di inutilizzabilità che colpirebbe, ai sensi dell’art. 407 comma 3 c.p.p., gli atti di indagine collocati temporalmente “a valle” della scadenza del predetto termine,
computato a partire dal momento in cui l’iscrizione avrebbe
dovuto essere effettuata», profilo, questo, estraneo al thema
decidendum oggetto della pronuncia in esame.
Neppure è ravvisabile, infine, ad avviso della Corte, la dedotta violazione dell’art. 111 comma 3 Cost., sotto il profilo che la ritardata iscrizione conculcherebbe il diritto della
persona accusata di essere, nel più breve tempo possibile,
informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico. Dall’iscrizione nel registro delle
notizie di reato - nota la Corte - non scaturisce, infatti, alcun diretto obbligo informativo dell’organo dell’accusa nei
confronti dell’indagato; né viene qui in rilievo la facoltà
della persona, cui il reato è attribuito, di ottenere la comunicazione dell’iscrizione, ai sensi dell’art. 335 comma 3
c.p.p., atteso che tale facoltà, oltre ad incontrare il limite
del potere di “segretazione” del pubblico ministero (comma
3-bis del medesimo articolo), presuppone comunque la richiesta dell’interessato, richiesta che - in punto di rilevanza - non risulta essere stata formulata nel caso di specie.
L’anzidetto obbligo informativo del pubblico ministero si
connette, per contro, nell’ambito delle indagini preliminari, solo al compimento di un “atto garantito”, ossia di un atto che - dovendo essere compiuto alla presenza del difensore - presuppone l’invio dell’informazione di garanzia (art.
369 c.p.p.): dal che scaturisce la declaratoria di infondatezza del dubbio sottoposto a scrutinio.
Sul complesso tema delle iscrizioni nel registro generale ex
art. 335 c.p.p. e degli effetti che ne scaturiscono cfr., per tutti, A. Marandola, I registri del pubblico ministero. Tra notizia
di reato ed effetti procedimentali, Padova, 2001, passim.
Misure cautelari
REGRESSO DEL PROCEDIMENTO,
COMPUTO DEI TERMINI DI FASE
E RILEVANZA DELLA CUSTODIA CAUTELARE
SOFFERTA IN FASI O GRADI NON OMOGENEI
Corte costituzionale, sentenza 22 luglio 2005 (7 lu-
glio 2005), n. 299 - Pres. Capotosti - Red. Neppi Modona
(Artt. 303 comma 2 e 304 comma 6 c.p.p.)
È incostituzionale, per violazione degli artt. 3 e 13 Cost.,
l’art. 303 comma 2 c.p.p. nella parte in cui non consente di
computare, ai fini dei termini massimi di fase determinati dall’art. 304 comma 6 c.p.p., i periodi di custodia cautelare sofferti in fasi o in gradi diversi dalla fase o dal grado
in cui il procedimento è regredito.
Giunge al culmine, con la pronuncia in epigrafe, la tensione - non priva di toni aspri - tra il giudice di legittimità e la
Corte costituzionale in tema di computabilità, ai fini dei
termini massimi di fase di custodia cautelare, dei periodi di
custodia sofferti in fasi o gradi diversi dalla fase o dal grado
in cui il procedimento è regredito: l’ormai non disconoscibile coagularsi di un “diritto vivente” in tema, reiteratamente ribadito dalla Corte di legittimità nel suo più ampio
consesso pur a fronte degli stigmi messi a fuoco dal giudice
delle leggi, ha condotto, infine, all’odierna declaratoria
“manipolativa” di incostituzionalità con cui si è forse apposto il sigillo conclusivo a una tormentata vicenda ermeneutica.
Non par possibile cogliere il senso della pronuncia in esame
senza averne rapidamente riguardato le trame anteriori,
che la Corte, d’altronde, ha qui cura di ripercorrere in motivazione.
Il problema interpretativo al centro della querelle concerne
la portata della norma oggi dichiarata incostituzionale: a
mente dell’art. 303 comma 2 c.p.p., nell’ipotesi di regressione del procedimento a seguito di annullamento con rinvio, dalla data del provvedimento che dispone il rinvio decorrono nuovamente i termini previsti dal precedente
comma 1.
Permaneva, tuttavia, il dubbio circa la computabilità, ai fini del calcolo dei termini massimi di fase, della custodia sofferta in pendenza di fasi del giudizio diverse da quella oggetto di regressione: così, con riguardo all’ipotesi di annullamento con rinvio, risultava pacifico che dovesse computarsi la custodia subita nella fase conclusasi con il provvedimento poi annullato, cui occorreva addizionare la privazione di libertà sofferta nella parallela fase di rinvio; ci si chiedeva, invece, se nel computo dovesse o no altresì rientrare
la custodia subita in pendenza dell’intermedio giudizio di
Cassazione conclusosi con l’annullamento con rinvio del
primo decisum.
Chiamate ad esprimersi sul punto, le sezioni unite (Cass.,
Sez. Un., 29 febbraio 2000, Musitano, in questa Rivista,
2001, 454, con commento di A. Privitera, Termini di fase e
favor libertatis), consolidando l’indirizzo maggioritario,
avevano statuito il principio secondo cui, in caso di regresso del procedimento, ai fini del computo del doppio del termine di fase e del conseguente diritto alla scarcerazione
dell’imputato detenuto, si deve tenere conto anche dei periodi di detenzione imputabili ad altra fase o grado del pro-
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1071
GIURISPRUDENZA•SINTESI
cedimento medesimo, ma limitatamente ai periodi riferibili a fasi o gradi omogenei, secondo il combinato disposto
degli artt. 303 comma 2 e 304 comma 6 c.p.p.; alla stregua
di ciò risulterebbero, dunque, sterili, in ordine al computo
dei termini di fase, i periodi di custodia subiti in fasi o gradi
diversi, sicché, ad esempio, in caso di annullamento con
rinvio, non rileverebbe a tal fine la detenzione subita pendente il giudizio di cassazione.
L’emergere, tuttavia, di ulteriori contrasti sul punto induceva le medesime Sezioni Unite ad attivare un test di costituzionalità, la cui ultima intentio si palesava volta a propiziare
un indiretto consolidamento dell’indirizzo già fatto proprio
dal decisum a pieni ranghi del 2000: veniva, perciò, sollevata una quaestio de legitimitate dell’art. 303 comma 2 comma
c.p.p. «nella parte in cui impedisce di tenere conto, ai fini
del computo dei termini massimi di fase stabiliti dal successivo art. 304 comma 6, dei periodi di detenzione sofferti in
una fase o in un grado diversi da quelli in cui il procedimento è regredito» (Cass., Sez. Un., 10 luglio 2002, D’Agostino, in C.E.D. Cass., n. 222022).
I dubbi venivano, tuttavia, dichiarati - non senza incisività
- manifestamente inammissibili (Corte cost. n. 243 del
2003, in questa Rivista, 2003, 1080). Richiamando la chiave di lettura illo tempore fornita da una anteriore pronuncia
(Corte cost. n. 292 del 1998, ivi, 1998, 1239), la Corte affermava che quella precedente interpretazione dovesse ritenersi costituzionalmente vincolata, e precisava, stigmatizzando l’operato delle Sezioni Unite, che «un simile approccio alla giustizia costituzionale» non fosse ammissibile:
nel suo impianto testuale l’ordinanza di rimessione - rimarcava la Corte - appare «perplessa», posto che «in una motivazione tutta protesa, nella sostanza, a dimostrare l’infondatezza della questione, il denunciato contrasto si riduce a
un laconico “forse”»; di più, Corte cost. n. 243 del 2003
stigmatizzava «l’esplicito invito al “rispetto delle reciproche
attribuzioni”», con cui si chiudeva l’ordinanza di rimessione degli atti, «come se a questa Corte fosse consentito affermare i principi costituzionali soltanto attraverso sentenze caducatorie e le fosse negato, in altri tipi di pronunce, interpretare le leggi alla luce della Costituzione».
L’asprezza del contrasto trovava eco, peraltro, nel corpo della Relazione sulla giurisprudenza delle Sezioni unite penali
(2002-2003), curata dall’Ufficio del massimario della Corte di Cassazione (e riprodotta, in parte qua, in Foro it., 2004,
II, 300 s.): vi si legge che «il tono insolitamente polemico»
della pronuncia costituzionale, con cui la Corte ha tratteggiato «una sorta di diktat interpretativo che per tanti versi
lascia perplessi, sia sul tema specifico che le Sezioni unite
avevano posto, sia sul piano più generale della delimitazione delle sfere di attribuzione istituzionali tra giudici ordinari e giudice delle leggi, certamente costituisce un fatto nuovo nella storia dei rapporti tra le due alte Corti, i quali avevano conosciuto momenti di tensione solo in epoca ormai
remota». L’episodio - si rimarca ancora in quella sede «non può mettere a repentaglio il dialogo tra le istituzioni
interessate, ma potrebbe determinare non semplici problemi per la certezza del diritto, ove dovesse perdurare, in que-
1072
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
sto come in altri settori dell’interpretazione, l’insistenza
della Corte costituzionale per scelte formalmente non vincolanti, se non per il giudice a quo, e quindi oggettivamente “deboli”, in luogo di decisioni di illegittimità costituzionale, che hanno, com’è noto, efficacia erga omnes».
Si addiveniva, così, a un nuovo pronunciamento delle sezioni unite (Cass., Sez. Un., 17 maggio 2004, P., in questa
Rivista, 2004, 812), in cui veniva ancora ribadito l’indirizzo
secondo il quale, in caso di regresso del procedimento, ai fini del computo del doppio del termine di fase e del conseguente diritto alla scarcerazione dell’imputato detenuto, si
deve tener conto anche dei periodi di detenzione imputabili ad altra fase o grado del procedimento medesimo, limitatamente ai periodi riferibili a fasi o gradi omogenei: veniva, dunque, confermata la non computabilità, nel giudizio
di rinvio, ai fini dei termini massimi di fase, della custodia
sofferta in pendenza del giudizio di Cassazione.
Ormai cristallizzatosi un non più disconoscibile “diritto vivente” in tema (pur non monolitico: cfr., ad esempio, l’opposta lettura di Cass., Sez. VI, 7 febbraio 2005, P., in Cass.
pen., 2005, 1886, con nota di G. Romeo, La tela di Penelope, ibidem, 1889 ss.), nuove verifiche di costituzionalità venivano, a tal punto, attivate, alle quali è conseguito, infine,
d’odierno decisum.
«Nel corso della vicenda in esame», precisa la pronuncia in
commento, «la Corte costituzionale ha applicato il principio di astenersi dal pronunciare una dichiarazione di illegittimità sin dove è stato possibile prospettare una interpretazione della norma censurata conforme a Costituzione,
anche al fine di evitare il formarsi di lacune nel sistema,
particolarmente critiche quando la disciplina censurata riguarda la libertà personale»; proprio «sulla base di questo
consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte ha
appunto pronunciato la sentenza interpretativa di rigetto
n. 292 del 1998, ed ha poi confermato la scelta della via interpretativa dopo i primi interventi delle sezioni unite della Cassazione, sollecitate a dirimere i contrasti insorti in
materia tra le diverse sezioni, sino a quando la Corte di cassazione a sezioni unite», con la citata pronuncia del 2004,
«ha confermato con particolare forza il proprio indirizzo interpretativo». Orbene, «a seguito di tali decisioni e, in particolare, della sentenza da ultimo citata, non vi è dubbio
che l’indirizzo delle sezioni unite debba ritenersi oramai
consolidato, sì da costituire diritto vivente, rispetto al quale non sono più proponibili decisioni interpretative».
Ciò chiarito, la Corte rimarca con incisività che le considerazioni in precedenza svolte circa il rispetto dei principi
di adeguatezza e di proporzionalità, operanti anche in relazione ai limiti che deve incontrare la durata della custodia
cautelare, «discendono direttamente dalla natura servente
che la Costituzione assegna alla carcerazione preventiva rispetto al perseguimento delle finalità del processo, da un lato, e alle esigenze di tutela della collettività, dall’altro, tali
da giustificare, nel bilanciamento tra interessi meritevoli di
tutela, il temporaneo sacrificio della libertà personale di chi
non è ancora stato giudicato colpevole in via definitiva».
Nel quadro della giurisprudenza costituzionale, d’altronde,
GIURISPRUDENZA•SINTESI
«le esigenze che impongono, nella logica dell’art. 13 Cost.,
di privilegiare soluzioni che comportino il minor sacrificio
della libertà personale trovano le loro radici nella fondamentale sentenza n. 64 del 1970, che ha aperto la via alla
vigente disciplina in tema di termini massimi (di fase, complessivi e finali) della custodia cautelare».
La Corte (allora chiamata a pronunciarsi, tra l’altro, sulla
legittimità costituzionale dell’art. 272 c.p.p. 1930, nella
parte in cui limitava «l’operatività dei termini massimi della custodia preventiva alla sola fase istruttoria» e consentiva che, dopo la chiusura dell’istruzione, la custodia non fosse soggetta ad alcun limite) nell’accogliere la questione
muoveva dalla constatazione che, con l’art. 13 comma 5, la
Costituzione ha voluto evitare che il sacrificio della libertà
determinato dalla custodia preventiva «sia interamente subordinato alle vicende del procedimento; ed ha, pertanto,
voluto che, con la legislazione ordinaria, si determinassero
i limiti temporali massimi della carcerazione preventiva, al
di là dei quali verrebbe compromesso il bene della libertà
personale, che (…) costituisce una delle basi della convivenza civile». La stessa Corte precisava peraltro che le statuizioni della sentenza «non precludono al legislatore una
nuova disciplina della materia, eventualmente differenziata (…) anche in relazione alle varie fasi del procedimento,
purché, in conformità con l’ultimo comma dell’art. 13 Cost., si assicuri in ogni caso la predeterminazione d’un ragionevole limite di durata della detenzione preventiva».
Dunque, «per essere conformi a Costituzione, i termini
massimi devono (…) coprire l’intera durata del procedimento, sino alla sentenza definitiva; ove non fossero disciplinati termini massimi di custodia cautelare, il sacrificio
della libertà risulterebbe infatti interamente subordinato
alle esigenze processuali e ne risulterebbe compromesso il
bene fondamentale della libertà personale; ove siano previsti termini massimi in relazione alle varie fasi del procedimento, la relativa disciplina deve essere tale da assicurare
in ogni modo un ragionevole limite di durata della custodia, in conformità d’altra parte ai parametri di proporzionalità e adeguatezza interni allo stesso precetto sancito dall’ultimo comma dell’art. 13 Cost.».
Perciò, «le limitazioni della libertà connesse alle vicende
processuali devono rispettare il principio di proporzionalità, posto che contrasterebbe con il giusto equilibrio tra le
esigenze del processo e la tutela della libertà una disciplina
della detenzione cautelare priva di limiti di durata ragguagliati, da un lato, alla pena prevista per il reato contestato o
ritenuto in sentenza e, dall’altro, alla concreta dinamica del
processo e alle diverse fasi in cui esso si articola». Invero,
«unitamente al principio di adeguatezza, il criterio di proporzionalità tra la gravità della pena prevista per il reato e
la durata della custodia lungo l’intiero corso del procedimento ispira l’esigenza di assicurare un ragionevole limite
di durata della custodia cautelare in relazione alla sua durata complessiva e alle singole fasi del processo».
In tal senso, «processo e fatto di reato sono (…) termini inscindibili del binomio al quale va sempre parametrata la disciplina della custodia cautelare e ad entrambi deve sempre
essere ancorata la problematica dei termini entro i quali la
durata delle misure limitative della libertà personale può
dirsi proporzionata e, quindi, ragionevole», peraltro «in
conformità ai valori espressi dall’art. 5 par. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, secondo l’interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo»; invero, «nel sistema
attuale, la durata ragionevole è, appunto, assicurata anche
dai termini massimi di fase, in quanto proporzionati alla effettiva evoluzione della situazione processuale dell’imputato».
Infine, «proporzionalità e ragionevolezza stanno alla base
del principio secondo cui, in ossequio al favor libertatis che
ispira l’art. 13 Cost., deve comunque essere scelta la soluzione che comporta il minor sacrificio della libertà personale»; la tutela della libertà personale che si realizza attraverso i limiti massimi di custodia voluti dall’art. 13 comma
5 Cost. è quindi «un valore unitario e indivisibile, che non
può subire deroghe o eccezioni riferite a particolari e contingenti vicende processuali, ovvero desunte da una ricostruzione dell’attuale sistema processuale che non consenta
di tenere conto, ai fini della garanzia del termine massimo
finale di fase, dei periodi di custodia cautelare “comunque”
sofferti nel corso del procedimento».
Donde la conclusione: «sulla base di tali principi, ai quali
questa Corte si è costantemente richiamata per interpretare la disciplina censurata in modo conforme a Costituzione,
e preso atto che si è formato un diritto vivente incompatibile con l’interpretazione sinora sostenuta, la Corte stessa
non può che dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 303 comma 2 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 13
Cost.».
Sulla pronuncia, cfr. G. Leo, Superato l’impasse tra giurisdizioni grazie al peso del «diritto vivente», in Guida dir., 2005,
31, 66 ss. Sul tema cfr., tra gli altri, P. Bruno, Divergenze interpretative tra le Sezioni unite e la Corte costituzionale in tema
di custodia cautelare, in Cass. pen., 2004, 2718 ss.; R. Conti,
Regresso del procedimento e computo dei termini di fase, in questa Rivista, 2005, 1013 ss.; G. Romeo, Magis amica veritas:
la Cassazione ignora i diktat della Consulta, in Cass. pen.,
2004, 2715 ss. Sugli addentellati costituzionali del sistema
dei termini custodiali cfr., per tutti, per un’analisi nitida, C.
Conti, La sospensione dei termini di custodia cautelare. Modelli rigidi e flessibili a confronto, Padova, 2001, spec. 1 ss.
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1073
GIURISPRUDENZA•SINTESI
Osservatorio della Corte
di cassazione - Sezioni Unite
a cura di ALFREDO MONTAGNA
Impugnazioni
INAMMISSIBILITÀ
DEL RICORSO PER CASSAZIONE
E PRECLUSIONE ALLA DICHIARAZIONE
DI ESTINZIONE PER PRESCRIZIONE
Cassazione penale, Sez. Un., 22 giugno 2005 (u.p. 22 marzo 2005), n. 23428 - Pres. Marvulli - Rel. De Roberto - P.M.
Siniscalchi (conf.) - B., ricorrente
(Artt. 129, 581 e 591 c.p.p.)
L’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la
possibilità di dichiarare, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., l’estinzione del reato per prescrizione, maturata in data antecedente alla pronuncia della sentenza d’appello, ma non
dedotta né rilevata dal giudice.
La Sezione II della Corte rimetteva alle Sezioni Unite la
questione, già oggetto di precedente rimessione, ma non risolta per l’esistenza di una preclusione processuale, sulla
possibilità o meno di dichiarare l’estinzione del reato per
prescrizione, maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza d’appello, ma non dedotta né rilevata dal giudice, in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione.
In precedenza le stesse Sezioni Unite si erano occupate della inammissibilità del ricorso per cassazione nelle pronunce
De Luca e Cavallera. Nella prima (Cass., Sez. Un., 21 dicembre 2000, De Luca, in questa Rivista, 2001, 60), la Corte aveva operato una ricostruzione storica della distinzione
tra inammissibilità originaria ed inammissibilità sopravvenuta, includendo tra le prime tutte le cause di inammissibilità previste dall’art. 591 c.p.p., osservando come da esse
derivasse l’assenza radicale di un valido rapporto di impugnazione e la conseguente impossibilità per il giudice di rilevare eventuali cause di non punibilità ai sensi dell’art.
129 c.p.p.; nella decisione Cavallera (Cass., Sez. Un., 11
settembre 2001, Cavallera, ibidem, 1231) risultava affermato come ogni pronuncia di inammissibilità si risolvesse in
una absolutio ab istantia derivante dalla mera apparenza dell’atto di impugnazione, così da precludere al giudice l’applicazione della causa di non punibilità.
In materia, con la pronuncia Tuzzolino (Cass., Sez. Un., 28
giugno 2000, Tuzzolino, ivi, 2000, 937), la Corte, nel risolvere positivamente il conflitto interpretativo relativo al
formarsi del giudicato sul capo e non sul punto della decisione, aveva subordinato l’applicabilità della causa estintiva alla mancata formazione del giudicato sui singoli capi
della sentenza.
Successivamente alla ricostruzione operata dalle Sezioni
Unite la giurisprudenza delle Sezioni semplici avevano ribadito come l’inammissibilità del ricorso per cassazione per
qualunque causa intervenuta non consentisse il formarsi di
un valido rapporto processuale (Cass., Sez. IV, 25 gennaio
2001, Varas, in C.E.D. Cass., n. 218972; Cass., Sez. IV, 20
gennaio 2004, T., inedita; Cass., Sez. IV, 6 aprile 2004, M.,
inedita).
Le Sezioni Unite, hanno preliminarmente precisato come
la questione sottoposta al vaglio della Corte non fosse, in
effetti, al centro di un contrasto giurisprudenziale, ricordando come l’applicazione dei risultati interpretativi raggiunti dalla consolidata giurisprudenza delle stesse Sezioni
unite non potesse non comportare che una soluzione negativa al quesito riproposto dalla sezione remittente, e ad avvalorare tale posizione hanno ripercorso il tragitto delineato dalle precedenti pronunce delle stesse Sezioni Unite (sin
dalle decisioni Cass., Sez. Un., 11 novembre 1994, Cresci,
in C.E.D. Cass., n. 199903 e Cass., Sez. Un., 30 giugno
1999, Piepoli, ivi, n. 213981), ribadendo come l’intrinseca
incapacità dell’atto invalido di accedere davanti al giudice
dell’impugnazione viene a tradursi in una vera e propria absolutio ab instantia, così che l’unica ipotesi di cognizione da
parte del giudice dell’impugnazione inammissibile rimane
quella relativa all’accertamento dell’abolitio criminis o della
dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice formante oggetto dell’imputazione, desumibile dall’eccezionale possibilità di incidere in executivis sul
provvedimento contrassegnato dalla formazione del giudicato formale, così come nell’ipotesi in cui debba essere dichiarata l’estinzione del reato a norma dell’art. 150 c.p.,
sempre salvo il caso di proposizione tardiva del gravame.
Pertanto la Corte è giunta alla conclusione che l’intervenuta formazione del giudicato sostanziale, derivante dalla
proposizione di un atto di impugnazione invalido perché
contrassegnato da uno dei vizi indicati dalla legge, precluda
ogni possibilità sia di far valere una causa di non punibilità
precedentemente maturata sia di rilevarla di ufficio.
In dottrina A. Ciavola, Le sezioni unite superano la tradizionale distinzione tra cause di inammissibilità originaria e sopravvenuta e pongono un importante freno alla prassi dei ricorsi manifestamente infondati o pretestuosi, in Cass. pen., 2001,
2989; N. Ciaravolo, Altolà delle sezioni unite contro il proces-
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1075
GIURISPRUDENZA•SINTESI
so come strumento dilatorio, in Guida dir., 2001, 8, 76; G. Fumu, Ricorso finto, prescrizione impossibile, in Dir. giust., 2001,
5; B. Monastero, Inammissibilità delle impugnazioni e applicabilità dell’art. 129 c.p.p. nel giudizio di legittimità, in Cass.
pen., 2002, 92.
Misure cautelari
MISURE CAUTELARI PERSONALI: OMESSO
DEPOSITO DELL’ORDINANZA APPLICATIVA
ED INTERROGATORIO DI GARANZIA
Cassazione penale, Sez. Un., 20 luglio 2005 (c.c. 28 giugno 2005), n. 26798 - Pres. Marvulli - Rel. Ferrua - P.M.
Esposito (diff.) - V., ricorrente
(Artt. 5, 178, 180, 293, 294 e 302 c.p.p.)
L’omesso deposito dell’ordinanza applicativa di una misura cautelare personale e degli atti prescritti dall’art. 293
comma 3 c.p.p. è causa di nullità, di ordine generale, dell’interrogatorio di garanzia per violazione del diritto di difesa.
La Sezione I della Corte, con ordinanza 12 aprile 2005, rimetteva alle Sezioni Unite la questione sugli effetti dell’omesso deposito dell’ordinanza applicativa di una misura
cautelare personale e degli atti prescritti in base al disposto
dell’art. 293 comma 3 c.p.p., ovvero se ciò fosse causa o meno di nullità dell’interrogatorio di garanzia per violazione
del diritto di difesa, nonché di perdita di efficacia della stessa ordinanza.
Le pronunce più recenti avevano escluso conseguenze in
caso di omesso deposito dell’ordinanza de quo precedentemente all’interrogatorio di garanzia, affermando come l’unica conseguenza che ne derivava era riferibile al dies a quo
del computo dei termini per proporre impugnazione, costituendo il deposito del provvedimento restrittivo un adempimento successivo, che come tale non potrebbe comportare la nullità dell’ordinanza stessa (Cass., Sez. VI, 28 maggio 2004, T., in C.E.D. Cass., n. 229470; Cass., Sez. VI, 28
maggio 2005, D., ivi, n. 229318). Precedentemente nello
stesso senso si erano espresse altre Sezioni, sia prima (Cass.,
Sez. I, 14 luglio 1994, Calò, ivi, n. 199304; Cass., Sez. I, 13
luglio 1994, Graviano, in Cass. pen., 1996, 202), che dopo
l’introduzione, ad opera della l. n. 332 del 1995, del comma
3 del citato art. 293 nella sua attuale formulazione (Cass.,
Sez. II, 12 febbraio 1997, Riccioli, in C.E.D. Cass., n.
208750; Cass., Sez. IV, 19 aprile 2001, Veshti, ivi, n.
219454), con le quali si escludeva ogni nullità in ossequio
al principio di tassatività e sull’ulteriore rilievo che la perdita di efficacia della misura cautelare risultava regolamentata in conseguenza di specifiche carenze previste dal codice di rito.
Altre pronunce avevano escluso che l’omissione del deposito dell’ordinanza avesse conseguenze sul provvedimento
1076
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
restrittivo o sull’interrogatorio, e ciò spesso con riferimento al provvedimento custodiale applicato all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo (Cass., Sez. II,
9 luglio 2004, Cernica, ivi, n. 229646; Cass., Sez. I, 20 novembre 2003, Croce, ivi, n. 226632); più in generale era
stato ritenuto che la violazione all’obbligo di deposito dell’ordinanza e degli atti sui quali la stessa era stata fondata,
compresa la richiesta del p.m., costituisse un vizio dell’interrogatorio, incidendo sull’esercizio del diritto di difesa da
parte dell’indagato, e determinando una nullità di ordine
generale (Cass., Sez. I, 5 aprile 2002, Scintu, ivi, n.
222194; Cass., Sez. V, 17 gennaio 2003, Brunetto, ivi, n.
224665).
In merito va ricordata la decisione della Consulta (Corte
cost. 24 febbraio 1997, n. 192, in Giur. cost., 1997, 1883),
che, nel valutare la incostituzionalità del comma terzo dell’art. 293 c.p.p. (laddove non prevedeva la facoltà per il difensore di estrarre copia degli atti depositati) ha affermato
la indefettibilità dell’obbligo di deposito per realizzare la disponibilità informativa del difensore.
Le Sezioni Unite hanno ritenuto di aderire all’orientamento che riconosceva alle omissioni in esame una incidenza sul diritto di difesa, osservando come il deposito di
cui all’art. 293 comma 3 c.p.p. costituisca uno degli adempimenti esecutivi della misura e l’interrogatorio presupponga che questi adempimenti siano stati espletati. La verifica successiva deve essere necessariamente quella sulla
funzione di tali adempimenti, che è quella di consentire al
difensore la conoscenza diretta dell’ordinanza applicativa,
della richiesta del p.m. e degli atti su cui essa si è fondata;
correlativamente l’interrogatorio rappresenta il primo atto con il quale si instaura il contraddittorio sullo “questio
libertatis”, rappresentando il momento cruciale dell’impegno difensivo, in quanto, atteso che nel nostro sistema
processuale l’iniziativa cautelare appartiene al pubblico
ministero ed il giudice emette il provvedimento senza
sentire preventivamente le parti, la valutazione della posizione e delle ragioni del soggetto che quel provvedimento deve subire è posticipata al momento dell’interrogatorio.
Rispetto a tali considerazioni, secondo la Corte, risulta ingiustificatamente restrittivo l’assunto secondo cui il deposito sarebbe previsto esclusivamente in relazione all’eventuale richiesta di riesame, mentre deve riconoscersi che la
conoscenza anticipata degli atti in base ai quali il pubblico
ministero ha proposto l’istanza ed il giudice ha adottato il
provvedimento cautelare, permette alla difesa di affrontare con adeguata preparazione l’interrogatorio (anche in
considerazione che la segnalazione degli elementi a carico
fornita in sede di interrogatorio non esaurisce l’insieme
delle informazioni ricavabili dal deposito ex art. 293 c. 3
c.p.p.).
Le Sezioni Unite, dopo avere richiamato le affermazioni
della citata decisione n. 192 del giudice delle leggi, hanno
ulteriormente osservato che una volta riconosciuto che il
deposito dell’ordinanza cautelare e dei relativi atti deve essere attuato subito dopo l’esecuzione della misura, l’even-
GIURISPRUDENZA•SINTESI
tualità che la notifica dell’avviso prevista dall’ultima parte
dell’art. 293 comma 3, non sia stata ancora espletata quando il giudice procede all’interrogatorio rimane priva di rilevanza rispetto all’attività difensiva, giungendo ad affermare
conclusivamente che l’omesso deposito dell’ordinanza applicativa di una misura cautelare, della richiesta del pubblico ministero e degli atti allegati, compromette ingiustificatamente il diritto di difesa e pertanto determina la nullità
dell’interrogatorio dell’indagato (o dell’imputato) ai sensi
degli artt. 178 lett. c, 180 e 182 c.p.p., nullità a regime in-
LIBRI
termedio che deve essere eccepita al compimento dell’atto,
ossia dell’interrogatorio.
In dottrina, F.M. Molinari, Sui rapporti tra deposito degli atti
ex art. 293 ed interrogatorio di garanzia ex art. 194, in Cass.
pen., 1998, 3025; A. Giarda, Un’altra tessera di garantismo
per la libertà personale dell’indagato, in Riv. it. dir. e proc. pen.,
1998, 1018; P. Tonini, Manuale di procedura penale, 6ª ed.,
Milano, 2005, 347; G. Di Chiara, Deposito degli atti e diritto
alla copia: prodromi del contraddittorio e garanzie difensive, in
Giur. cost., 1997, 1883.
COMMENTARI
Codice commentato
delle nuove società
Società di capitali – Cooperative – Consorzi – Reati societari
A cura di G. Bonfante, D. Corapi, G. Marziale, R. Rordorf, V. Salafia
Il Codice commenta le norme codicistiche in materia societaria novellate dal
D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 di riforma
del diritto societario (nel testo definitivo
aggiornato al D.Lgs. n. 37/2004) proponendo una lettura sistematica e al tempo
stesso approfondita degli articoli compresi tra il 2325 e il 2642 del Codice civile relativi a: società di capitali, cooperative,
consorzi, reati societari. L’opera nella
sua trattazione ripercorre l’ordine del Libro V del Codice civile, in conformità alla
divisione in Titoli, Capi e Sezioni. I principali gruppi di istituti sono presentati da Introduzioni che forniscono il quadro generale della disciplina relativa. Per ogni singola norma viene illustrato l’aspetto civilistico e penale collegato al nuovo articolato del Codice civile, senza dimenticare i
rinvii alla disciplina delle società quotate
(che tiene conto del coordinamento con la
riforma societaria apportato dal D.Lgs. n.
37/2004 e del disegno di legge per la
riforma del risparmio) ed a quella comunitaria (con particolare riferimento alla società europea ed alla cooperativa europea). Il volume è completato da una Appendice documentale che comprende il
testo previgente del Libro V del Codice
civile e la normativa complementare collegata, italiana e comunitaria: D. Lgs. 17
gennaio 2003, n. 5 (procedimenti in materia societaria, bancaria, finanziaria),
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
Unico finanziario), Regolamento U.E. 22
luglio 2003, n. 1435 (Società cooperativa
europea), Regolamento U.E. 8 ottobre
2001, n. 2157 (Società europea) Regolamento CEE 25 luglio 1985, n. 2137
(GEIE). Il Codice commentato delle nuove
società fornisce una panoramica esaustiva delle novità introdotte dalla riforma grazie all’attenta connessione tra vecchia e
nuova disciplina; rappresenta l’ideale ausilio per l’analisi delle principali “questioni” sollevate dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Si tratta di un’opera che, come è nella migliore tradizione dei Commentari Ipsoa, coniuga il rigore scientifico con le esigenze della pratica professionale. Consapevoli di offrire uno strumento completo, i Curatori e gli Autori sono certi di ottenere l’approvazione che è
già stata accordata per le altre opere della collana Commentari.
Ipsoa 2004, pagg. 2.400, € 130,00
Per informazioni
• Servizio Informazioni Commerciali
(tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)
• Agente Ipsoa di zona
(www.ipsoa.it/agenzie)
• www.ipsoa.it
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1077
GIURISPRUDENZA•SINTESI
Osservatorio della Corte
di cassazione - Diritto penale
a cura di STEFANO CORBETTA
Beni culturali
OMESSA DENUNCIA
DEL TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ
O DI DETENZIONE DI BENI CULTURALI
Cassazione penale, Sez. III, 8 giugno 2005 (c.c. 15 febbraio 2005), n. 21400 - Pres. Zumbo - Rel. Fiale - P.S.,
ricorrente
(Art. 173 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)
Il tribunale confermava il sequestro probatorio di 113 reperti archeologici integri di varie forme e frammenti di vasi, ravvisando il delitto di cui all’art. 173 comma 1 lett. b
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (per una sintesi, v. in questa
Rivista, 2004, 271), che punisce con pena pecuniaria
«chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine
indicato all’articolo 59, comma 2, la denuncia degli atti di
trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali». Occupandosi, per la prima volta, di questa nuova
fattispecie delittuosa, la Suprema Corte, in primo luogo, ha
precisato cosa debba intendersi per «altre cose individuate
dalle legge o in base alla legge quali testimonianze aventi
valore di civiltà», che, a norma della seconda parte dell’art.
2 comma 2 d.lgs. n. 42 del 2002, designa la nozione di “beni culturali”; tale locuzione «costituisce una formula di
chiusura che consente di ravvisare il bene giuridico protetto dalle nuove disposizioni sui beni culturali ed ambientali
non soltanto nel patrimonio storico-artistico-ambientale
“dichiarato” (beni la cui valenza culturale p oggetto di previa dichiarazione), bensì anche in quello “reale” (beni protetti in virtù del loro intrinseco valore, indipendentemente dal previo riconoscimento di esso da parte delle autorità
competenti)». La Corte ha inoltre chiarito che l’obbligo di
denuncia, imposto dall’art. 59 comma 2 d.lgs. cit., «si correla già soltanto alla mera detenzione delle “cose individuate dalle legge o in base alla legge quali testimonianze
aventi valore di civiltà”, mentre, dopo la formale dichiarazione dell’interesse culturale (di cui ali artt. 11 e ss.), altre
disposizioni puniscono le violazioni alle modalità di conformazione dell’uso del bene, come specificamente regolamentare dalla P.A.». La Cassazione si è quindi soffermata
sul significato della locuzione racchiusa nell’art. 2 comma
2, precisando che con il termine “civiltà” si intende, secondo il linguaggio comune, «il complesso degli aspetti culturali, spontanei ed organizzati, relativi ad una collettività in
una determinata epoca». Inoltre, «l’attitudine a “testimo-
1078
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
niare” aspetti siffatti è agevolmente desumibile dalle caratteristiche della res, dal suo valore comunicativo spirituale,
dai requisiti peculiari attinenti alla tipologia, alla localizzazione alla rarità ecc.» (analogamente, in riferimento alla
fattispecie di illecito impossessamento di beni culturali, di
cui all’abrogato art. 125 d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, cfr.
Cass., Sez. III, 14 novembre 2001, Cricelli, in C.E.D.
Cass., n. 220742). La Cassazione ha quindi dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della fattispecie in esame, sollevata per violazione
dell’art. 25 Cost. Dopo aver richiamato l’elaborazione della
Corte costituzionale relativamente al rispetto del principio
di precisione - in particolare, le decisioni n. 414 del 1995
(in questa Rivista, 1995, 1393) e n. 312 del 1996 (ivi, 1996,
1194) - la Corte ha sottolineato come «l’inclusione, nella
formula descrittiva dell’illecito penale, di espressioni sommarie, di vocaboli polisensi, ovvero di concetti “elastici”
non comporta un vulnus del parametro costituzionale in
esame, quando (…) quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile, e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo».
Alla luce di queste premesse, la Corte ha perciò ritenuto
che la nozione di “beni culturali”, richiamata dall’art. 173
con riguardo alle «altre cose individuate dalle legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà»,
«viene ad assumere, tenuto conto delle norme specifiche di
settore e dell’evoluzione storico-scientifica della configurazione dell’interesse culturale, un’accezione peculiare, che la
rende precisa e per nulla indeterminata».
Delitti contro la fede pubblica
FALSA ATTESTAZIONE
DELL’AUTENTICITÀ DELLA FIRMA APPOSTA
IN CALCE AD UN RICORSO PER CASSAZIONE
Cassazione penale, Sez. V, 14 giugno 2005 (u.p. 28 aprile 2005), n. 22496 - Pres. Sica - Rel. Nappi - P.m. in c.
B.G., ricorrente
(Artt. 480 e 481 c.p.)
Tratto a giudizio per avere falsamente attestato l’autenticità
della firma del ricorrente in calce ad un ricorso per cassa-
GIURISPRUDENZA•SINTESI
zione, l’imputato, nella veste di legale, veniva assolto dal
delitto di cui all’art. 481 c.p.; secondo il tribunale, infatti,
da un lato l’impugnazione era stata presentata a mezzo di un
incaricato, ciò che rendeva inutile l’attestazione di autenticità della sottoscrizione; dall’altro, la mancanza di abilitazione del legale all’esercizio della difesa dinanzi alla Corte
di cassazione configurava un’ipotesi di falso inutile, come
tale non punibile. In accoglimento del ricorso promosso
dalla pubblica accusa, la Cassazione, in primo luogo, ha
chiarito che il difensore è persona che esercita un servizio
di pubblica utilità, sicché le falsità ideologiche commesse
da costui nell’esercizio della professione sono punibili solo
a norma dell’art. 481 c.p.; infatti, «la legge qualifica come
servizio di pubblica necessità la professione forense indipendentemente dalla natura degli atti specifici compiuti
nell’esercizio di tale professione» (nel senso che l’attestazione, da parte dell’assicuratore, di dati non veritieri nel
certificato di assicurazione R.C.A. integra il delitto di falsità ideologica in certificati commessa da persona esercente un servizio di pubblica necessità, previsto dall’art. 481
c.p., cfr. Cass., Sez. Un., 11 maggio 2002, Panarelli, in questa Rivista, 2002, 820). Secondo la Corte, deve qualificarsi
come certificato, a mente dell’art. 481 c.p., «qualsiasi attestazione di fatti rilevanti nell’ambito del servizio di pubblica necessità esercitato dall’autore dell’atto». I certificati di
esercenti un servizio di pubblica necessità non sono certificati in senso proprio, in quanto, a differenza dei certificati
amministrativi, «possono anche richiedere un accertamento di fatti direttamene percepiti da parte dell’autore dell’atto» (in questo senso Cass., Sez. V, 26 novembre 1981, Faina, in C.E.D. Cass., n. 152705; Cass., Sez. V, 14 dicembre
1977, Cristiani, ivi, n. 138192; nel senso che la falsa sottoscrizione di una procura ad litem e la falsa attestazione dell’autenticità di detta sottoscrizione comportano, a carico
del difensore che se ne sia reso autore, la configurabilità rispettivamente del reato di falso in scrittura privata ex art.
485 c.p. e di quello di falsità ideologica commessa da persona esercente un servizio di pubblica necessità di cui all’art.
481 c.p., cfr. Cass., Sez. II, 26 novembre 2002, Quattrone,
ivi, n. 223829). Ciò chiarito, la Corte ha confutato le argomentazioni sostenute dai giudici di merito. Quanto all’assunto secondo cui la presentazione dell’impugnazione a
mezzo di incarico non esigeva l’autenticazione della firma,
la Cassazione ha messo in luce che il delitto in esame era
già stato consumato «nel momento in cui l’impugnazione
fu presentata a norma dell’art. 582 c.p.p., anziché spedita a
norma dell’art. 583 c.p.p., sicché quella scelta sopravvenuta non può avere effetto di escludere la punibilità del fatto
già commesso». Quanto al secondo profilo, relativo alla
presunta inutilità - e quindi non punibilità - del falso, la
Corte si è ricollegata alla giurisprudenza in tema di falso
ideologico commesso da pubblico ufficiale incompetente,
secondo cui «l’incompetenza funzionale del pubblico ufficiale non determinando, diversamente dalla incompetenza
assoluta, l’inesistenza dell’atto pubblico, ma tutt’al più la
sua nullità, non esclude la configurabilità del delitto di falsità ideologica previsto dall’art. 479 c.p.» (in questi termini
Cass., Sez. Un., 30 giugno 1984, Nirella, in Giust. pen.,
1984, II, 609; in senso conforme Cass., Sez. V, 26 aprile
1989, Binazzi, in C.E.D. Cass., n. 182243). Analogamente, secondo la Corte, «deve ritenersi che la mancanza di
abilitazione al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori non esclude la punibilità a norma dell’art. 481 c.p. della
falsa attestazione relativa a un ricorso per cassazione compiuta da un soggetto che sia comunque abilitato all’esercizio della professione forense». La sentenza è stata perciò
cassata con rinvio per nuovo esame.
In dottrina cfr. A. Cristiani, voce Fede pubblica (delitti contro la), in Dig. disc. pen., V, 1991, 176 ss.; A. Nappi, voce
Fede pubblica (delitti contro la), in Enc. giur. Treccani, XIV,
1989; T. Padovani, La coscienza dell’offesa nel dolo del falso:
un requisito ad pompam?, in Mass Cass. pen., 1981, 1544 ss.;
F. Ramacci, La falsità ideologica nel sistema del falso documentale, Napoli, 1965, passim.
Delitti contro la persona
SINISTRO STRADALE CAUSATO
DA VEICOLO MILITARE: QUALI LE DEROGHE
AL CODICE DELLA STRADA CONSENTITE
Cassazione penale, Sez. IV, 25 maggio 2005 (u.p. 3 febbraio 2005), n. 19797 - Pres. Olivieri - Rel. Piccialli - M.
M., ricorrente
(Artt. 51 e 589 c.p.)
Nei due gradi di giudizio, l’imputato veniva condannato in
relazione all’art. 589 c.p., per aver cagionato la morte di un
militare, che viaggiava, in qualità di passeggero, sull’autocarro condotto dall’imputato medesimo; secondo i giudici,
il sinistro si era verificato a causa dell’eccessiva velocità del
mezzo, che procedeva non solo a 65 anziché 60 km/h, ma,
soprattutto, senza tener conto del fatto che il terreno bagnato avrebbe imposto una velocità in ogni caso inferiore
ai limiti previsti con fondo asciutto. Tra i motivi di ricorso,
la difesa deduceva l’erronea applicazione dell’art. 51 c.p.,
in quanto le infrazioni commesse erano giustificate a norma dell’art. 177 comma 2 c. strada, secondo cui i conducenti di autoveicoli adibiti a servizi di polizia «nell’espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e
quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non
sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza». Nel rigettare il ricorso, la Corte ha sottolineato
che, anche nel caso di veicolo impegnati in servizi urgenti
di istituto, il conducente non è affatto esonerato «dall’osservanza dalle regole di comune prudenza e diligenza». In
particolare, il «conducente non è tenuto ad osservare gli
obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1079
GIURISPRUDENZA•SINTESI
stradale, di guisa che non potrà esser sanzionato per le relative violazioni; ma da questa disciplina derogativa non
può trarsi la conseguenza che egli sia anche autorizzato a
creare ingiustificate situazioni di rischio per altre persone o
che non debba tener conto di particolari situazioni della
strada o del traffico o di altre particolari circostanze, adeguando ad essere la condotta di guida (esemplificando: il
conducente in servizio urgente di istituto può ben tenere
una velocità superiore al consentito, ma, allorché giunga
in prossimità di un incrocio percorso da altri veicoli con
diritto di precedenza, deve verificare, prima di immettersi
nell’incrocio medesimo, che i conducenti abbiano avvertito la situazione di pericolo e abbiano posto in essere le
opportune manovre per concedere la precedenza al veicolo favorito)» (negli stessi termini, cfr. Cass., Sez. IV, 19 settembre 2002, Cassano, in questa Rivista, 2003, 1255, con
commento di A. Cerulo, Incidente provocato da auto di servizio e deroghe al codice della strada, cui si rinvia per ulteriori indicazioni bibliografiche; analogamente Cass., Sez. IV,
9 settembre 2000, Scaglione, ivi, 2001, 234, nonché, con
riferimento all’art. 126 c. strada previgente, Cass., Sez. IV,
14 maggio 1996, Accarpio, in Riv. pen., 1997, 86; Cass.,
Sez. IV, 5 luglio 1988, Motta, Riv. giur. circ. e trasp., 1990,
61; Cass., Sez. IV, 10 ottobre 1983, Lombardo, in C.E.D.
Cass., n. 161494).
ricolo mediante frode considerati dagli artt. 439, 440, 441,
442 e 444 c.p. Invero, ha osservato la Cassazione, «tali fattispecie criminose si riferiscono ad un’attività di avvelenamento, adulterazione, contraffazione o messa in commercio di sostanza alimentari o di cose destinate al commercio,
in modo pericoloso alla salute pubblica, ma non già all’ipotesi di somministrazione di una sostanza, pur nociva per la
salute umana, ma non destinata all’alimentazione, e, senza
alcuna opera di avvelenamento, adulterazione o contraffazione, confusa per mero errore di fatto con una sostanza alimentare». La condotta, peraltro, assume rilievo solo in relazione alle conseguenze lesive colposamente cagionate;
nella specie, tuttavia, si trattava di lesioni lievi, in relazione
alle quali l’avventore non aveva presentato querela.
In dottrina cfr. M. Agnoli, Alcune osservazioni sul reato di
commercio delle sostanze alimentari pericolose, in Giur. merito,
1976, II, 33 ss.; S. Ardizzone, voce Comune pericolo (delitti
colposi di), in Dig. disc. pen, II, 1988, 390 ss.; B. Assumma,
voce Avvelenamento, adulterazione o contraffazione in danno
della salute pubblica, ivi, I, 1987, 391 ss., C. Correra, La difesa del consumatore nelle frodi in commercio, Milano, 3ª ed.,
2002, 242 ss.; G. Pizzorno, Responsabilità penale dei titolari e
dei dipendenti di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande nocivi, in Giur. merito, 1978, II, 943.
Estinzione del reato
Delitti contro l’incolumità pubblica
SOMMINISTRAZIONE DI LIQUIDO
PER LAVASTOVIGLIE AL POSTO
DI ACQUA MINERALE
Cassazione penale, Sez. I, 30 maggio 2005 (u.p. 17 maggio 2005), n. 20391 - Pres. Fabbri - Rel. Canzio - P.G. in
c. T.F., ricorrente
(Artt. 441, 444 e 452 c.p.)
Condannato in primo grado in relazione al delitto di cui
agli artt. 441, 452 c.p. (così modificata l’originaria imputazione ex artt. 444, 452 c.p.) per avere, quale gestore di un
bar, somministrato per errore ad un cliente, che aveva chiesto un bicchiere di acqua minerale, del liquido da lavastoviglie, tossico e nocivo, contenuto in una bottiglia recante
l’etichetta di una nota acqua minerale e posta sul bancone,
l’imputato veniva assolto in appello, sul rilievo che la sostanza, pur pericolosa per la salute, non era né alimentare,
né desinata all’alimentazione umana, e nemmeno adulterata o contraffatta. Rigettando il ricorso del P.g., che aveva
fatto leva sull’indirizzo giurisprudenziale in base al quale il
titolare di una ditta di commercio ha l’obbligo di osservare
la massima diligenza nella messa in commercio dei prodotti alimentari (in questo senso, da ultimo, cfr. Cass., Sez. IV,
5 dicembre 2002, Giannini, in questa Rivista, 2003, 564), la
Suprema Corte ha avallato l’interpretazione seguita dai
giudici di appello, escludendo che la condotta realizzata dal
gestore del bar fosse riconducibile tra i delitti di comune pe-
1080
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
REATO CONTINUATO: DA QUANDO DECORRE
IL TERMINE PRESCRIZIONALE
Cassazione penale, Sez. V, 1° luglio 2005 (u.p. 3 febbraio
2005), n. 24527 - Pres. Providenti - Rel. Marasca - P. A.,
ricorrente
(Art. 158 c.p.)
Con sentenza confermata in appello, l’imputato veniva
condannato in relazione a ventiquattro episodi di furto pluriaggravato, commessi negli anni 1996, 1997 e 1998, ritenuta la continuazione tra tutti i fatti. Tra i motivi di ricorso, la difesa lamentava l’erronea applicazione dell’art. 158
c.p., sul presupposto che la continuazione deve essere contestata prima del decorso del termine prescrizionale, ciò
che, nella specie, non era avvento. Nel rigettare il ricorso,
la Cassazione ha apertamente preso le distanze da un recente indirizzo (espresso, da ultimo, da Cass., Sez. III, 5
marzo 2004, T., in questa Rivista, 2004, 819, cui si rinvia per
ulteriori indicazioni), secondo cui, quando la continuazione non è stata ritenuta prima del decorso del termine prescrizionale per alcuni reati, il giudice, a norma dell’art. 129
c.p.p., deve dichiarare immediatamente l’intervenuta prescrizione di quei reati. Un’interpretazione del genere, secondo la Corte, contrasta, in primo luogo, con la lettera
dell’art. 158 c.p., «che non legittima la differenziazione che
si intende operare»; è perciò irrilevante «se la continuazione sia stata o meno contestata nel capo di imputazione,
perché in effetti il giudice, con la sentenza, anche in man-
GIURISPRUDENZA•SINTESI
canza di una formale contestazione iniziale, non fa altro
che riconoscere una situazione soggettiva esistente fin dal
momento della programmazione dei vari reati». In altri termini, «le condizioni oggettive e soggettive necessarie per
ritenere la continuazione tra vari reati debbono sussistere
nel momento in cui i reati vengono commessi, sicché quella del giudice è una mera azione ricognitiva e dichiarativa
di una situazione preesistente». La Corte si infatti ricollega
all’indirizzo pressoché costante secondo cui, ai fini della
configurabilità della continuazione, rilevanza decisiva acquisita l’identità del disegno criminoso, «che si orienta ancora più nettamente in senso soggettivo, come ideazione,
volizione di uno scopo unitario che dà senso ad un programma complessivo, nel quale si collocano le singole azioni od omissioni, di volta in volta poi commesse come singole determinazioni, sul piano volitivo» (in questo senso,
tra le più recenti, cfr. Cass., Sez. I, 15 marzo 1994, Castaldo,
in C.E.D. Cass., n. 198919; Cass., Sez. I, 21 dicembre
1993, Moro, ivi, n. 196545; Cass., Sez. I, 28 gennaio 1991,
Liveri, in Cass. pen., 1992, 2368). Se, quindi, occorre che
il programma criminoso sia prefigurato sin dalla consumazione del primo reato, che si assume rientrare nella continuazione, «è evidente allora che si tratta di una condizione
soggettivo-psichica che deve sussistere nel momento della
commissione dei reati e che il giudice riconosce nel momento della decisione, cosicché è del tutto irrilevante la
circostanza della avvenuta indicazione o meno della continuazione nella formulazione dei capi di imputazione». La
Corte ha quindi formulato il seguente principio di diritto:
«In materia di reato continuato, l’inizio del termine di prescrizione coincide con l’esaurimento della condotta, come
previsto dall’art. 158 c.p., anche nella ipotesi in cui il vincolo della continuazione non sia stato formalmente contestato, ma sia stato successivamente riconosciuto in sentenza» (senso analogo, cfr. Cass., Sez. II, 24 ottobre 2003, Del
Miglio, in C.E.D. Cass., n. 227616; Cass., Sez. I, 18 febbraio 1998, Silvestro, ivi, n. 210038; Cass., Sez. III, 9 novembre 1990, Trinchero, ivi, n. 185963).
In dottrina cfr. V. Militello, Sulla decorrenza della prescrizione nella continuazione dei reati, in Foro it., 1986, II, 1220
ss.; A. Molari, voce Prescrizione del reato e della pena, in
Noviss. Dig. it., XII, 1966, 679 ss.; P. Pisa, voce Prescrizione (dir pen. ), in Enc. dir., XXXV, 1986, 78 ss.; M. Romano, sub Art. 158 c.p., in M. Romano-G. Grasso-T. Padovani, Commentario sistematico del codice penale, III, Milano, 1994, 69 ss.
(Artt. 53 l. 24 novembre 1981, n. 689; 30 proc. pen. min. )
La Corte d’appello, sezione minorenni, riduceva la pena inflitta in primo a grado a mesi uno di reclusione ed euro 50
di multa, rigettando al contempo la richiesta di sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria, a norma dell’art. 53 l. 24 novembre 1981, n. 689, stante lo sbarramento posto dall’art. 30 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (proc.
pen. min. ), che, nel giudizio a carico di imputati minorenni, considera espressamente solo la semidetenzione e la libertà controllata. In accoglimento del ricorso difensivo, la
Cassazione ha censurato l’interpretazione seguita dalla
Corte territoriale. Invero, ha sottolineato la Suprema Corte, «le disposizioni dell’art. 53 l. n. 689 del 1981, che disciplinano le sanzioni sostitutive della semidetenzione, della
libertà controllata e della sostituzione della pena detentiva
con quella pecuniaria corrispondente, trovano puntuale
possibilità di applicazione nei confronti di qualsiasi imputato, sia esso maggiorenne o minorenne». La previsione dell’art. 30 proc. pen. min., infatti, «non ha certamente dettato una disciplina sostitutiva delle disposizioni relative alla
semidetenzione e alla libertà controllata ma, in evidente
applicazione di un principio di favore nei confronti dell’imputato minorenne, si è limitato ad innalzare il tetto della
pena massima irroganda (da un anno e mezzo a due anni),
ampliando la possibilità di applicazione nelle ipotesi delle
suddette sanzioni sostitutive, in nulla innovando con riguardo alla possibile sostituzione delle pene detentive brevi con quelle pecuniarie corrispondenti» (in senso conforme, cfr. Cass., Sez. IV, 12 febbraio 1999, Nikolic, in C.E.D.
Cass., n. 212992). La sentenza è stata perciò annullata con
rinvio.
In dottrina cfr. E. Dolcini - C. Paliero, voce Sanzioni sostitutive: a) diritto penale, in Enc. dir., 1989, XLI, 488 ss.; F. Mencarelli, voce Sanzioni sostitutive, in Enc. giur. Treccani, 1992,
XXVIII; G. Ventura, Imputato minorenne e sanzioni sostitutive, in Giur. cost., 1998, I, 87 ss.
Sanzioni sostitutive
APPLICABILE AL MINORENNE
LA PENA PECUNIARIA
COME SANZIONE SOSTITUTIVA
Cassazione penale, Sez. V, 6 luglio 2005 (u.p. 14 giugno
2005), n. 24894 - Pres. Foscarini - Rel. Sica - D. C. A.,
ricorrente
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1081
GIURISPRUDENZA•SINTESI
Osservatorio della Corte
di cassazione - Processo penale
a cura di FRANCESCO PERONI
Atti
NON È IRREPERIBILITÀ L’ASSENZA TEMPORANEA
DAL DOMICILIO DICHIARATO
Cassazione penale, Sez. I, 24 giugno 2005 (u.p. 8 giugno
2005), n. 23799 - Pres. Sossi - Rel. Bardovagni - B., ricorrente
(Art. 161 c.p.p.)
Con ricorso per cassazione, l’imputato, contumace in appello, deduceva la nullità del giudizio di secondo grado,
sostenendo che la relativa citazione era stata irritualmente notificata mediante consegna al difensore, a seguito di
invalida attestazione di irreperibilità dell’interessato al
domicilio dichiarato. In particolare, l’imputato - pur ammettendo di essersi momentaneamente allontanato dal
domicilio - censurava il fatto che l’ufficiale giudiziario
non avesse effettuato la consegna ad una delle persone indicate dall’art. 157 c.p.p. o, in difetto, presso la casa comunale. Nell’affrontare la questione, la Suprema Corte
ha premesso che la prescrizione relativa alla notifica di cui
alla norma da ultimo menzionata opera limitatamente al
caso in cui il destinatario, ancorché effettivamente reperibile al recapito dichiarato, non sia momentaneamente
sul posto. Esula pertanto dalla fattispecie in esame l’ipotesi in cui il soggetto abbia cessato ogni suo rapporto con il
luogo, donde la consegna a persone ivi reperite si ridurrebbe a un adempimento meramente apparente e inidoneo allo scopo. E proprio in quest’ultima evenienza, infatti, è imposto all’ufficiale giudiziario, esperite tutte le verifiche in loco, procedere alla notifica presso il difensore del
destinatario. Tanto precisato, la Cassazione ha negato con ciò confutando uno degli argomenti del ricorrente che all’ufficiale giudiziario sia preclusa la via di attestare
l’irreperibilità dell’interessato: attestazione, secondo la
parte impugnante, subordinata ad una serie di verifiche
prescritte per la dichiarazione di irreperibilità che all’ufficiale giudiziario sarebbero di fatto interdette. Invero, secondo il Supremo Collegio, la disciplina dell’irreperibilità
di cui all’art. 159 c.p.p. non è destinata ad operare laddove - come nel caso dedotto - sia avvenuta la dichiarazione
o l’elezione del domicilio (analogamente, seppure con la
precisazione che l’erronea adozione della procedura per
gli irreperibili integrerebbe una mera irregolarità, Cass.,
Sez. V, 19 ottobre 1999, Auriemma, in Cass. pen., 2000,
3364). In altri termini, l’irreperibilità in senso stretto ine-
1082
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
risce alla situazione in cui il soggetto non sia rintracciabile in alcun luogo, mentre del tutto distinta è l’evenienza
in cui egli non sia raggiungibile presso il luogo indicato.
In quest’ultima ipotesi, l’accertamento dell’assenza dal
domicilio deve essere svolto sommariamente dall’ufficiale
giudiziario, dando luogo a una presunzione semplice di
sussistenza dell’impossibilità di eseguire la notifica al domicilio dichiarato. «Ne segue che - ha concluso la Cassazione - di fronte all’allegazione da parte dell’interessato o
del difensore della solo temporanea assenza, il giudice è
tenuto a verificare la circostanza rappresentata e, ove risulti fondata, a disporre il rinnovo della notifica nelle forme ordinarie». In concreto, i giudici di legittimità hanno
accolto le censure del ricorrente sotto lo specifico profilo
dell’omessa verifica, da parte del giudice di seconde cure,
delle condizioni di validità della notifica dell’atto di citazione.
In argomento, L. Grilli, Le notificazioni penali, Milano,
1990, passim; A. Jazzetti-M. Pacini, La disciplina degli atti nel
nuovo processo penale, Milano, 1993, 129; A. Palumbo, Le
notificazioni nel rito penale, Napoli, 1992, passim.
LA NUOVA DISCIPLINA DEI TERMINI SOGGETTA
AL PRINCIPIO TEMPUS REGIT ACTUM
Cassazione penale, Sez. I, 28 giugno 2005 (c.c. 15 giugno
2005), n. 24380 - Pres. Fabbri - Rel. Piraccini - D’A., ricorrente
(Art. 175 c.p.p.)
Ecco una tra le prime applicazioni giurisprudenziali della
recente novella in materia di contumacia, operata con d.l.
21 febbraio 2005, n. 17, conv. dalla l. 22 aprile 2005, n. 60.
Nella specie, l’imputata - condannata in contumacia in primo grado - si era vista respingere dalla corte d’appello un’istanza di restituzione nel termine per impugnare. Con successivo ricorso per cassazione, l’interessata invocava la sopravvenuta disciplina in materia, sotto il duplice profilo
dell’estensione del termine per proporre l’istanza di restituzione, elevato da dieci a trenta giorni, e del modificato regime della prova circa le non conoscenza della sentenza
contumaciale. Sennonché, nel respingere il ricorso dichiarandolo inammissibile, la Suprema Corte ha osservato come la novella in parola, in quanto relativa a normativa processuale, «obbedisce al principio del tempus regit actum, con
la conseguenza che se la richiesta non è stata tempestivamente presentata nel vigore della norma processuale appli-
GIURISPRUDENZA•SINTESI
cabile in quel momento si è verificata una decadenza dal diritto e non è possibile riaprire quei termini in virtù di una
nuova legge processuale che li ha ampliati e ciò per la certezza del diritto che non può consentire che i propri provvedimenti definitivi siano sottoposti all’infinito alla possibile regressione in una fase antecedente» (per analoga presa di posizione, ancorché su diverso oggetto normativo,
Cass., Sez. III, 10 novembre 2000, X, in C.E.D. Cass., n.
217445).
In argomento, G. Garuti, Nuove norme sulla restituzione nel
termine per l’impugnazione di sentenze contumaciali e decreti di
condanna, in questa Rivista, 2005, 684 ss.
RITO CAMERALE PER LA DECISIONE
SULLA RESTITUZIONE IN TERMINI
Cassazione penale, Sez. VI, 2 agosto 2005 (c.c. 20 giugno 2005), n. 29157 - Pres. Fulgenzi - Rel. Di Casola I., ricorrente
(Art. 175 c.p.p.)
Avverso il provvedimento con cui il giudice d’appello
aveva respinto una sua istanza di restituzione nel termine
per impugnare, l’imputato presentava ricorso per cassazione, denunciando come il giudice di merito avesse deciso su detta istanza de plano, anziché procedere con rito
in camera di consiglio. Nell’accogliere il ricorso, la Suprema Corte si è allineata a quell’indirizzo giurisprudenziale (Cass., Sez. VI, 8 aprile 2002, Ciotola, in C.E.D.
Cass., n. 222048), propenso a riconoscere l’operatività
della disciplina di cui all’art. 127 c.p.p. nel caso di incidente sulla restituzione in termine. Invero, secondo i giudici di legittimità, militano a favore di detta soluzione ermeneutica due ordini di ragioni. Anzitutto, occorre osservare che, sebbene sprovvista di apposito dettato sul
punto, la disciplina codicistica dell’istituto di cui all’art.
175 c.p.p. pare avvalorare l’esigenza del rito camerale,
laddove conferisce al provvedimento finale la forma dell’ordinanza. In secondo luogo, tale esegesi è da ritenersi
obbligata alla luce dell’art. 111 Cost., «che impone una
rigorosa interpretazione, costituzionalmente orientata,
della volontà del legislatore di assicurare il rispetto della
tutela dei contrapposti interessi coinvolti nel processo.
Sicché, in mancanza di espressa previsione, deve presumersi che il legislatore propenda per l’adozione del rito
maggiormente garantito». Da notare come, così decidendo, la Corte regolatrice abbia smentito un diverso e opposto filone giurisprudenziale, ancora di recente affermato (Cass., Sez. II, 7 marzo 2005 n. 8773, F., in questa Rivista, 2005, 828), sulla scorta di argomenti quali l’omessa
previsione, nell’art. 175 c.p.p., di un’apposita udienza camerale (Cass., Sez. I, 23 novembre 2003, Carli, in
C.E.D. Cass., n. 226759) e la mancanza di alcun rinvio
all’art. 127 c.p.p. (sul punto, Cass., Sez. I, 26 febbraio
2004, H., ivi, n. 226898).
In argomento, G. Garuti, La restituzione nel termine, Padova, 2000, passim.
Esecuzione
IRREVOCABILITÀ DELLA SENTENZA
E SUA IMPUGNAZIONE TARDIVA
Cassazione penale, Sez. I, 4 luglio 2005 (c.c. 18 maggio
2005), n. 24643 - Pres. Mocali - Rel. Cassano - P., ricorrente
(Art. 648 c.p.p.)
Movendo dall’ipotesi in cui, a seguito di impugnazione tardiva, penda ricorso per cassazione avverso l’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità della stessa, la Suprema
Corte si è trovata a stabilire se ciò sia di ostacolo al corso
dell’esecuzione della sentenza. In particolare, l’imputato ricorrente censurava la decisione del giudice dell’esecuzione,
nella parte in cui aveva dichiarato l’esecutività del provvedimento impugnato. Nell’accogliere il ricorso, il Supremo
Collegio ha fatto riferimento, anzitutto, all’art. 648 c.p.p.,
osservando come, dal suo dettato, si evinca chiaramente
che la sentenza diviene irrevocabile, oltre che in difetto di
impugnazione, qualora sia spirato il termine per impugnare
il provvedimento che ne dichiara l’inammissibilità, rimanendo diversamente sospesi i relativi effetti. Peraltro, ha
sottolineato la Corte regolatrice come il descritto sistema
normativo debba essere interpretato alla luce del principio
costituzionale della ragionevole durata del processo (art.
111 Cost.), al fine di prevenire interpretazioni paradossali,
idonee a consentire la paralisi dell’esecuzione, propiziata da
impugnazioni pretestuosamente tardive della sentenza
(analogamente, Cass., Sez. V, 28 febbraio 1996, Guarise, in
C.E.D. Cass., n. 204091). In altre parole, occorre operare
il coordinamento dell’art. 648 con l’art. 670 c.p.p., di guisa
che l’impugnazione dinanzi al giudice di cognizione sia ritenuta ammissibile fino a che pende la relativa fase processuale. Correlativamente, ove si versi in fase di esecuzione
dovrà demandarsi al giudice di detta fase ogni questione
sull’esistenza e sulla validità del titolo esecutivo. In estrema
sintesi, si deve concludere «che l’art. 648 c.p.p. è applicabile esclusivamente nei casi in cui non vi è stata impugnazione o l’impugnazione è stata proposta prima che iniziasse la
fase dell’esecuzione».
In argomento, A. Gaito - G. Ranaldi, Esecuzione penale, 2ª
ed., Milano, 2005, 59.
QUALE SOLUZIONE AL CONFLITTO
DI DECISIONI IN EXECUTIVIS?
Cassazione penale, Sez. I, 14 luglio 2005 (c.c. 5 luglio
2005), n. 26031 - Pres. Teresi - Rel. Silvestri - C., ricorrente
(Art. 669 c.p.p.)
Quid iuris nell’ipotesi in cui, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 c.p.p.,
vengano pronunciate due ordinanze, divenute poi irrevocabili? Nel caso portato all’attenzione del Supremo Colle-
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1083
GIURISPRUDENZA•SINTESI
gio era accaduto che il giudice dell’esecuzione competente,
constatata l’anomalia, revocasse l’ordinanza cronologicamente posteriore. Ne seguiva ricorso per cassazione dell’interessato, che censurava detta decisione, nella parte in cui
l’ordinanza da revocare era stata individuata sulla base di
un criterio di ordine temporale, in violazione del principio
del favor rei che, ai sensi dell’art. 669 c.p.p. avrebbe dovuto
far propendere per la conservazione dell’ordinanza più recente, in quanto di contenuto più favorevole all’interessato. Nell’accogliere le censure del ricorrente, la Suprema
Corte ha preliminarmente inquadrato la ratio della norma
invocata, osservando come essa, in quanto devoluta all’ipotesi di pluralità di decisioni irrevocabili intervenute in
fase di cognizione, si correli al principio del ne bis in idem,
ponendosi in chiave di prevenzione del conflitto di giudicati. In particolare, l’anomala evenienza del conflitto di
giudicati è fronteggiata con l’applicazione del criterio del
favor rei, che, secondo i giudici di legittimità «permea l’intero ordinamento, stabilendo che debba prevalere la decisione costitutiva di condizioni giuridiche più favorevoli»
per l’imputato. In siffatta cornice sistematica, la Cassazione
ha ancora precisato che il principio del ne bis in idem deve
ritenersi operante anche in sede esecutiva, così come è dato desumere dall’art. 666 c.p.p., che stabilisce l’inammissibilità di un nuovo incidente di esecuzione fondato sui medesimi presupposti di fatto e sulle stesse ragioni di diritto di
altro precedente (Cass., Sez. I, 23 marzo 1994, Chianetta,
in C.E.D. Cass., n. 196861; Cass., Sez. I, 16 giugno 1993,
Esposito, in Cass. pen., 1994, 2218). Orbene, la configurabilità di una preclusione processuale in rapporto a decisioni emesse dal giudice dell’esecuzione giustifica la possibilità
del venire in essere di provvedimenti irrevocabili, tra loro
inconciliabili, aventi lo stesso oggetto e riguardanti il medesimo condannato. In evenienze di tal genere, ha concluso la Corte regolatrice, «è da ritenere che le linee fondanti
del sistema processuale convergano univocamente verso il
risultato di rendere applicabile la disciplina posta dall’art.
669 c.p.p. Tale normativa, pur essendo adottata in riferimento alle sentenze emesse nel processo di cognizione, è
munita di intrinseca forza espansiva, perché espressione di
un principio fondamentale (quello, appunto, del favor rei),
che permette l’applicazione analogica, in bonam partem,
delle disposizioni che regolano il contrasto di giudicati scaturito dalla violazione del divieto di una seconda decisione
contro la medesima persona su un oggetto connotato dall’identità dei presupposti di fatto e di diritto» (così anche,
Cass., Sez. I, 28 novembre 1991, Soru, in Arch. n. proc.
pen., 1992, 441).
In argomento, F. Corbi, L’esecuzione nel processo penale, Torino, 1992, 320.
Indagini preliminari
L’EFFETTO PRECLUSIVO DELL’ARCHIVIAZIONE
Cassazione penale, Sez. I, 23 giugno 2005 (u.p. 28 apri-
1084
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
le 2005), n. 23663 - Pres. Fazzioli - Rel. Riggio - P.m. in
c. S., ricorrente
(Art. 414 c.p.p.)
In fase di merito, il giudice aveva dichiarato non doversi
procedere nei confronti dell’imputato, avendo constatato
che, per il medesimo fatto, altro giudice aveva precedentemente emesso decreto di archiviazione. Ne seguiva ricorso
per cassazione del pubblico ministero, il quale censurava il
fondamento della decisione impugnata, nella parte in cui
aveva argomentato l’operatività, per analogia, del principio
del ne bis in idem anche al caso di procedimento definito
con decreto di archiviazione. Nell’accogliere il ricorso, la
Corte regolatrice ha preso le mosse dalla natura del provvedimento di archiviazione, osservando come esso costituisca una condizione di improcedibilità (così anche Corte
cost., 19 gennaio 1995, n. 27, in Giur. cost., 1995, 257), impeditiva dell’esercizio dell’azione penale, fino all’eventuale
sopraggiungere dell’autorizzazione a riaprire le indagini
(analogamente, Cass., Sez. Un., 22 marzo 2000, Finocchiaro, in Cass. pen., 2000, 2610). Peraltro - ha aggiunto la
Cassazione - tale «effetto preclusivo opera solo nei confronti dell’autorità giudiziaria che aveva emesso il decreto
di autorizzazione». Ed infatti, il provvedimento di riapertura ha natura di revoca, con la conseguenza che esso deve
emanare dallo stesso organo giurisdizionale che ha deliberato l’archiviazione e deve inerire alla gestione dell’azione
penale da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero. Quest’ultimo elemento è confortato dal dato testuale,
laddove l’art. 414 c.p.p., nello specificare che «quando è
autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a nuova iscrizione», presuppone evidentemente
l’identità dell’ufficio dell’accusa procedente, il quale, per
l’appunto, dopo la prima, iscrive la nuova notizia di reato.
In sintesi - ha concluso la Corte - «la preclusione derivante dall’archiviazione esaurisce il potere decisionale dell’autorità che ha pronunciato il provvedimento, ma non di
un’altra, omologa autorità, che quel potere non ha esercitato».
In argomento, F. Caprioli, Archiviazione della notizia di reato
e successivo esercizio dell’azione penale, in Riv. it. dir. e proc.
pen., 1995, 1374; G. Giostra, L’archiviazione, 2ª ed., Torino,
1994, 92; R. Orlandi, Effetti preclusivi dell’archiviazione e procedimento cautelare, in Cass. pen., 1998, 3291; C. Valentini
Reuter, Le forme di controllo sull’esercizio dell’azione penale,
Padova, 1994, 250.
ESAME DEL D.N. A. E DIRITTO
AL CONTRADDITTORIO
Cassazione penale, Sez. VI, 4 luglio 2005 (u.p. 28 aprile
2005), n. 24586 - Pres. Fulgenzi - Rel. Leonasi - P., ricorrente
(Art. 359 c.p.p.)
La quaestio giunta all’attenzione della Suprema Corte muove da una vicenda processuale in tema di paternità, nel-
GIURISPRUDENZA•SINTESI
l’ambito della quale il preteso padre era stato condannato
per alterazione di stato civile, con sentenza confermata in
appello. Con ricorso per cassazione, l’imputato censurava la
decisione in parola, nella parte in cui essa si reggeva su risultanze connesse all’esame del D.N.A., esperito su un
campione del suo sangue, prelevato per ragioni estranee alle indagini, e successivamente utilizzato dall’autorità inquirente. Nel respingere il ricorso, la Cassazione ha ricondotto la fattispecie nell’alveo dell’art. 359 c.p.p., osservando
come, nella specie, l’esame del D.N.A. costituisca «un accertamento tecnico per sua natura ripetibile», in relazione
al quale la disciplina codicistica non prescrive alcun preavviso al difensore per fini di contraddittorio. Quanto alla lamentata condotta surrettizia dell’autorità procedente - individuabile, secondo il ricorrente, nell’impiego di un campione del suo sangue ad altro scopo destinato - i giudici di
legittimità hanno notato come il prelievo fosse avvenuto
nell’ambito delle formalità imposte dall’ordinamento penitenziario, nel momento in cui l’interessato aveva fatto ingresso in carcere. Detto prelievo risultava pertanto del tutto regolare, senza che alcuna rilevanza potesse assumere il
consenso dell’imputato ai fini della successiva utilizzazione
processuale del sangue prelevato.
In argomento, P. Felicioni, L’esecuzione coattiva del prelievo
ematico: profili problematici, in Cass. pen., 1997, 315; R.E.
Kostoris, I consulenti tecnici nel processo penale, Milano,
1993, passim; D. Vigoni, Corte costituzionale, prelievo ematico coattivo e test del DNA, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1996,
1022.
dell’evaso. Al proposito, si è ricordato come si sia ritenuto
legittimato a proporre ricorso per cassazione anche il difensore non iscritto all’albo di cui all’art. 613 c.p.p., con il limite, peraltro, della fase della discussione dinanzi alla Corte, comunque aperta al solo professionista abilitato (Cass.,
Sez. I, 11 luglio 2003, Mohamad Taher, in C.E.D. Cass., n.
225750; Cass., Sez. IV, 16 gennaio 2003, Marsalone, ivi, n.
223564; Cass., Sez. V, 4 maggio 2000, Jonuzi, in Cass. pen.,
2001, 1511; Cass., Sez. V, 22 dicembre 1998, Amato, ivi,
2000, 686). Detto orientamento si fonda sul particolare
vincolo che, nella fattispecie, si istituisce tra difensore e imputato, il quale, a’ termini dall’art. 165 comma 3 c.p.p. «è
rappresentato a ogni effetto dal difensore». Ebbene, secondo il Supremo Collegio, «tale principio deve ritenersi valido anche per l’irreperibile, non potendo la maggiore laconicità dell’analoga formula “è rappresentato dal difensore”
usata nell’art. 159 comma 2 c.p.p. costituire ostacolo di apprezzabile rilievo giuridico, stante l’assenza comunque di
clausole che limitino l’applicazione della norma». Conforta tale soluzione ermeneutica quell’esigenza di salvaguardare il concreto esercizio del diritto di difesa tecnica - preservandolo da limitazioni «che porrebbero seri problemi di costituzionalità, in conseguenza di particolari situazioni in cui
l’imputato, ancorché colpevolmente, si sia venuto a trovare - che nel caso dell’irreperibile viene a riproporsi, e con
ancora maggiore forza rispetto al latitante e all’evaso, poiché la eventuale ignoranza del provvedimento da impugnare può anche non derivare sa sua colpa».
In argomento, A. Zappulla, Difensore del latitante, difensore
del contumace e impugnazione della sentenza, in Cass. pen.,
2000, 2318.
Soggetti
IL DIFENSORE DELL’IRREPERIBILE COMUNQUE
ABILITATO AL PATROCINIO IN CASSAZIONE
Cassazione penale, Sez. I, 6 giugno 2005 (u.p. 29 aprile
2005), n. 21045 - Pres. Fabbri - Rel. Giordano - S., ricorrente
(Art. 97 c.p.p.)
Piuttosto singolare la vicenda processuale sullo sfondo della decisione in epigrafe. In fase di merito, era accaduto che
l’imputato, dichiarato irreperibile, fosse assistito da un difensore d’ufficio, non iscritto all’albo dei patrocinanti in
Cassazione di cui all’art. 613 c.p.p. All’atto di interporre ricorso per cassazione, lo stesso difensore rappresentava di
aver invano chiesto al giudice di essere sostituito da un professionista abilitato: prospettava, quindi, nell’ipotesi che la
sua impugnazione fosse ritenuta inammissibile, questione
di legittimità costituzionale dell’art. 97 c.p.p., nella parte in
cui prevede la nomina di un solo difensore d’ufficio, da individuarsi tra avvocati che possono, come nel caso dedotto,
non essere cassazionisti, inseriti negli appositi elenchi predisposti dagli ordini forensi. La Suprema Corte ha tuttavia
confutato l’interpretazione in parola, attingendo alla propria giurisprudenza in materia di difensore del latitante o
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1085
GIURISPRUDENZA•SINTESI
Osservatorio dei contrasti
giurisprudenziali
a cura di GUGLIELMO LEO
Impugnazioni
SULLA LEGITTIMAZIONE AD IMPUGNARE
DEL VICE-PROCURATORE ONORARIO
(Artt. 53 e 570 c.p.p.; 71 e 72 ord. giud.)
La giurisprudenza è da tempo divisa a proposito della possibilità che le sentenze deliberate dal giudice monocratico
vengano impugnate dal vice procuratore onorario che, nel
corso del dibattimento, abbia eventualmente esercitato le
funzioni di pubblico ministero.
Com’è noto l’art. 71 ord. giud. prevede che siano addetti alle procure della Repubblica dei magistrati onorari, affinché
provvedano ad espletare le funzioni indicate dal successivo
art. 72, e le altre ad essi specificamente attribuite dalla legge. Il citato art. 72 regola una serie di attività processuali,
tra cui la rappresentanza della pubblica accusa nel dibattimento penale celebrato dal tribunale in composizione monocratica. Per la verità l’ultimo comma della norma indica
al procuratore della Repubblica il “criterio” di affidare le
funzioni di pubblico ministero ai vice procuratori per i soli
reati a citazione diretta, ma non può dirsi che la prassi esprima una piena e costante adesione alla pur ragionevole prescrizione del legislatore. Risulta dunque tanto più significativo, per il numero e per la rilevanza delle questioni trattate, il fenomeno delle sentenze penali pubblicate nel corso
di udienze ove le funzioni d’accusa sono state esercitate da
un magistrato onorario.
Si deve stabilire, per tutti i casi in questione, quale sia il valore della norma generale fissata al secondo comma dell’art.
570 c.p.p., secondo cui il gravame può essere proposto anche dal rappresentante del pubblico ministero che abbia
“presentato le conclusioni” nel procedimento culminato
con il provvedimento da impugnare.
Secondo alcune decisioni della Suprema Corte, la regola
troverebbe piena applicazione anche con riguardo al magistrato onorario, quando questi abbia “presentato le conclusioni” della pubblica accusa nel corso del dibattimento.
Una soluzione contraria svilirebbe, per una porzione significativa dell’attività giudiziaria, il principio di autonomia
nell’udienza del pubblico ministero (art. 53 c.p.p.), e comunque contrasterebbe con il principio generale del favor
impugnationis (Cass., Sez. VI, 12 novembre 1992, P.m. in c.
Serafini, in C.E.D. Cass., n. 192876; Cass., Sez. III, 19 dicembre 1994, P.m. in c. Tomasoni, in Giust. pen. 1995, II,
677; Cass., Sez. III, 9 marzo 1995, P.m. in c. De Tutti, ivi,
1996, III, 27).
1086
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
Sembra stia consolidandosi, però, un orientamento di segno contrario. Con una prima decisione la Corte aveva valorizzato il tenore letterale delle norme dell’ordinamento,
che assegnano al magistrato onorario le sole funzioni
espressamente previste dalla legge, tra le quali non è compresa quella di proporre impugnazioni contro la sentenza
pronunciata dal giudice monocratico. Quanto poi alla pretesa rilevanza del comma 2 dell’art. 570 c.p.p., si era osservato che la relativa previsione andrebbe comunque riferita
ai soggetti elencati nel comma precedente, e cioè (a parte
la scomparsa figura del procuratore presso la Pretura) il procuratore presso il Tribunale e quello presso la Corte di appello (Cass., Sez. III, 18 aprile 1997, P.m. in c. Camera, in
C.E.D. Cass., n. 207634). In ogni caso l’ordinamento giudiziario, subordinando all’espressa previsione della legge
l’esercizio di funzioni da parte del magistrato onorario,
avrebbe comunque neutralizzato, per una sorta di specialità, la norma di carattere generale inserita nel codice di rito (Cass., Sez. III, 3 giugno 1997, P.m. in c. Cerruti, in Cass.
pen., 1998, 2063; Cass., Sez. III, 3 luglio 1998, Bonciolini,
ivi, 1998, 3179, con nota di N. Rombi, Brevi note in tema di
legittimazione a impugnare dei vice procuratori onorari).
Sull’argomento la Corte suprema è tornata molto recentemente, ribadendo la tesi negativa circa la legittimazione ad
impugnare del vice procuratore. La circostanza è tanto più
significativa considerando che la questione è stata affrontata nella prospettiva di un concreto inconveniente determinato dalla ritenuta carenza di legittimazione del magistrato
onorario. Il comma 2 dell’art. 585 c.p.p. stabilisce infatti
che i termini per l’impugnazione della sentenza, quando il
giudice provvede alla motivazione contestuale e dunque alla pubblicazione in udienza dell’integrale provvedimento,
decorrano proprio dalla data dell’udienza, per tutte le parti
che - presenti o meno alla lettura - devono considerarsi presenti nel giudizio. Questa regola, correlata al difetto di legittimazione per il rappresentante d’udienza del pubblico
ministero, comporta che il tempo a disposizione della pubblica accusa per interporre il gravame corra senza che i soggetti abilitati a procedere abbiano una comunicazione diretta del provvedimento deliberato dal giudice.
Secondo la Corte, che ha dato per acquisita la carenza di legittimazione del magistrato onorario, la situazione non può
legittimare una deroga alla disposizione sulla decorrenza del
termine, la quale dunque resta fissata alla data di pubblicazione della sentenza. Del resto, si è osservato, i titolari del
potere di impugnazione vengono comunque informati del
provvedimento attraverso il documento interno (cd. “stati-
GIURISPRUDENZA•SINTESI
no”) che i rappresentanti del pubblico ministero nell’udienza sono in genere chiamati a compilare (Cass., Sez. III,
2 febbraio 2005, n. 1606, P.m. in c. F., in C.E.D. Cass., n.
230737). L’inconveniente non è parso neppure tale, evidentemente, da indurre un ripensamento sulla legittimazione, proprio a partire dalla regola dell’art. 585 comma 2,
che potrebbe rappresentare anzi un segnale, tra gli altri, della volontà legislativa di conferire il potere di impugnazione
anche al magistrato onorario, quando sia stato quest’ultimo
ad operare nel dibattimento.
Misure cautelari
SUL MOMENTO DI DECORRENZA
DEL TERMINE DI DURATA MASSIMA
DELLA CUSTODIA CAUTELARE
(Artt. 172, 297 comma 1 e 303 c.p.p.)
Una recente sentenza della Suprema Corte (Cass., Sez. II,
22 dicembre 2004, n. 49296, L., in C.E.D. Cass., nn.
230562 e 230563) presenta particolare interesse a proposito delle modalità per individuare l’esatto momento di decorrenza (e dunque quello di effettiva scadenza) del termine di durata massima della custodia cautelare.
Il provvedimento interviene anzitutto a ribadire l’orientamento prevalente della giurisprudenza a proposito del primo giorno di privazione della libertà. Sebbene la regola generale in materia di termini stabilisca che non si tenga conto del giorno in cui inizia la relativa decorrenza (art. 172
comma 3 c.p.p.), per la materia cautelare vige l’opposto
principio, alla luce della norma fissata dal primo comma
dell’art. 297 c.p.p.: gli effetti della custodia decorrono dal
momento della cattura, dell’arresto o del fermo.
L’affermazione non è affatto banale, visto che periodicamente viene adottata la soluzione opposta, ed anche l’ultima decisione sul tema aveva sostenuto la rilevanza del
principio “dies a quo non computatur” (Cass., Sez. V, 13 ottobre 2003, Et’Hemai, ivi, n. 227298). Una tale conclusione è stata in genere sostenuta attraverso un riferimento all’art. 14 c.p., il cui comma 2 in effetti stabilisce testualmente: «ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine
per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine». La stessa regola,
dunque, dell’art. 172 del codice di rito. D’altra parte il successivo art. 297 non varrebbe affatto a derogare l’ordinaria
disciplina del computo dei termini, ma solo ad eliminare
possibili incertezze sull’evento in base al quale provvedere
al computo stesso. In altre parole, la norma sarebbe mirata
ad evitare possibili incertezze sul punto di riferimento cui
ancorare la decorrenza del termine (ad esempio, il momento del fermo e non quello successivo della convalida con
applicazione della misura cautelare), ma rispetto a quel
punto dovrebbe poi applicarsi la disciplina ordinaria. Di
conseguenza, nel caso di termine pari ad 1 anno, la scadenza si avrebbe nel giorno corrispondente dell’anno successivo a quello in cui è iniziato il decorso (nello stesso senso
Cass., Sez. II, 24 luglio 1992, Liccardo, ivi, n. 191609;
Cass., Sez. I, 9 giugno 1995, P.m. in c. Moccia, in Arch. n.
proc. pen. 1995, 584; Cass., Sez. VI, 29 settembre 1995,
Buonanuova, in C.E.D. Cass., n. 203082).
Come si è detto, il nuovo (e per ora ultimo) arresto della
Corte riprende l’opposto e prevalente orientamento (Cass.,
Sez. IV, 23 aprile 1998, Salih, in Cass. pen., 1999, 1556;
Cass., Sez. I, 28 febbraio 1998, P.g. in c. De Lucia, ibidem,
1555; Cass., Sez. V, 23 settembre 1998, Chourga, in
C.E.D. Cass., n. 211831; Cass., Sez. V, 9 marzo 2000,
Hoxa, in Cass. pen., 2001, 1295; Cass., Sez. I, 16 giugno
2001, Ballerini, in C.E.D. Cass., n. 219411; Cass., Sez. V,
13 settembre 2002, Murati, ivi, n. 222078). Ma vi è un secondo motivo di interesse della sentenza, che risiede nella
precisazione circa l’irrilevanza dell’ora di esecuzione del
provvedimento restrittivo nel computo del termine di durata della custodia.
Fino ad oggi, sull’argomento, risultava essere intervenuta
una sola e remota pronuncia (Cass., Sez. I, 14 maggio 1991,
Pagliuca, ivi, n. 187496), per altro relativa alla diversa questione del termine entro il quale, a pena di inefficacia della
misura cautelare, deve essere effettuato il cd. “interrogatorio di garanzia”. In quella occasione la Corte aveva rilevato
come il termine sia fissato in cinque giorni, e non in centoventi ore, e come dunque non debba tenersi conto dell’orario di inizio della custodia, secondo quanto dispone il
quarto comma dell’art. 172 c.p.p., non essendo a tal fine introdotta alcuna deroga dal disposto del comma 1 del successivo art. 297.
Con la sua nuova sentenza, la Cassazione ha ribadito il
concetto, evidenziandone l’ovvia implicazione, e cioè che
il termine massimo per la custodia viene in scadenza alle
ore 24 dell’ultimo giorno, in qualunque orario abbia avuto
esecuzione il provvedimento restrittivo considerato. Da ciò
consegue che, quando la durata massima della misura sia
fissata in mesi o in anni, il provvedimento utile ad inibirne
l’estinzione (nella specie si trattava del decreto di rinvio a
giudizio) può maturare, nell’ultimo giorno utile, anche in
orario successivo a quello dell’intervenuta privazione della
libertà.
Procedimenti speciali
OPPOSIZIONE AL DECRETO PENALE
E MODIFICA DELL’IMPUTAZIONE
NEL PROCEDIMENTO CONSEGUENTE
(Artt. 464 e 516 c.p.p.)
Si è posto il problema dell’ammissibilità, nel giudizio di merito che consegue all’opposizione proposta contro il decreto penale di condanna, di modifiche dell’imputazione originariamente elevata dal pubblico ministero. Com’è noto,
nel caso si opponga al provvedimento che lo riguarda, l’imputato può chiedere l’accesso al giudizio nelle forme ordinarie, sollecitando un decreto di giudizio immediato (art.
461 c.p.p.). Alla stessa soluzione si giunge quando l’interes-
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1087
GIURISPRUDENZA•SINTESI
sato, pur manifestando tempestivamente l’opposizione,
non abbia formulato alcuna richiesta (art. 464, comma 1,
c.p.p.). Si apre così un giudizio in forma dibattimentale, e
resta da stabilire se la particolare “procedura” di innesco del
processo eserciti qualche influenza sulle norme che ne regolano l’andamento.
Una prima risposta al quesito, di carattere affermativo, è
venuta da una pronuncia relativamente recente della Suprema Corte (Cass., Sez. III, 24 aprile 2002, Meucci, in
C.E.D. Cass., n. 221690). Si trattava nella specie di verificare la legittimità del provvedimento con il quale un giudice dibattimentale aveva consentito al pubblico ministero,
nel giudizio di opposizione, una modifica dell’imputazione
ai sensi dell’art. 516 c.p.p. Stando al provvedimento impugnato, il dibattimento conseguente al decreto penale, una
volta introdotto, sarebbe “in tutto e per tutto” simile a
quello innescato da altri provvedimenti di vocatio in iudicium. Secondo la Corte, invece, il fatto che il giudizio conseguente all’opposizione sia un ordinario procedimento di
cognizione non implica la necessaria assenza di deroghe alla disciplina generale del dibattimento. Nella sentenza si ricorda come, secondo l’opinione assolutamente maggioritaria, nel procedimento per decreto sia esclusa l’applicazione
dell’art. 415-bis c.p.p., così come in precedenza si escludeva
la necessaria emissione, da parte del pubblico ministero, di
un invito rivolto all’indagato a rendere interrogatorio ex
art. 375 comma 3 del codice di rito. Sarebbe quindi «ben
possibile, ed anzi normale, che disposizioni ed istituti che
trovano applicazione nei procedimenti che si svolgono nelle forme ordinarie non trovino invece applicazione nel procedimento che nasce con l’emissione di decreto penale di
condanna e prosegue con il giudizio conseguente all’opposizione». Tra le disposizioni inapplicabili, come accennato,
vi sarebbe l’art. 516 c.p.p.
A giustificare la deroga concorrerebbe anzitutto il provvedimento che introduce il giudizio, che nel caso in esame
esprime una valutazione di merito sull’accusa, tanto da risultare potenzialmente idoneo a determinare il giudicato.
Viene soprattutto in evidenza, poi, la dipendenza del giudizio in forma ordinaria da una sorta di “negozio” espresso
dall’imputato. Quando questi si vede notificare un decreto
di condanna, al fine di esercitare le facoltà che la legge gli
riconosce, valuta ovviamente il tenore dell’accusa elevata
dal pubblico ministero. La rinuncia a prestare acquiescenza
(con i conseguenti vantaggi), od a valersi degli ulteriori riti speciali, matura in base ad un determinato quadro accusatorio. Non si potrebbe allora consentire, una volta introdotto il giudizio che l’imputato ha scelto su determinate
premesse, che il pubblico ministero modifichi a piacimento l’imputazione, formulando un addebito di fronte al quale l’imputato avrebbe potuto compiere scelte diverse, o essere messo in condizione di contrastare l’avvio del dibattimento.
Secondo la Corte il principio di conservazione delle “opportunità” avrebbe trovato rango costituzionale nella giurisprudenza della Consulta, allorquando si è stabilito che il
sistema deve consentire l’accesso ai riti speciali, oltre la so-
1088
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
glia fisiologica del dibattimento, quando la modifica dell’imputazione costituisca essenzialmente il frutto di un errore o di un ritardo del pubblico ministero (Corte cost. 30
giugno 1994, n. 265).
Sulla base di queste premesse, in definitiva, dovrebbe concludersi che «con l’emissione del decreto penale di condanna, si verifichi una sorta di “cristallizzazione della imputazione”, la quale diviene irrevocabile ed acquista forza esecutiva in caso di mancata opposizione ma che non può poi
essere più modificata qualora, in considerazione di tale imputazione, il condannato abbia invece proposto opposizione».
La Corte, naturalmente, si era rappresentata l’eventualità
che nel corso del dibattimento il fatto risulti diverso da
quello contestato: «in tal caso (…) il giudice dovrebbe pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129
c.p.p. (…) e dovrebbe trasmettere gli atti al pubblico ministero affinché proceda per il fatto diverso come emerso in
dibattimento, eventualmente mediante una nuova richiesta di decreto penale di condanna».
In tempi recenti si è registrato un nuovo intervento sul tema, di segno esattamente opposto a quello tracciato dall’unico precedente. La Corte ha stabilito infatti, pur consapevole del contrasto indotto per tal via, che «nel giudizio
conseguente all’opposizione proposta contro il decreto penale di condanna, quando il fatto risulta diverso da quello
contestato, è consentita al P.M. la modifica dell’imputazione» (Cass., Sez. III, 31 marzo 2005, n. 12293, P. ed altro, ivi,
n. 231054).
Due i passaggi essenziali del ragionamento. Anzitutto, in
mancanza di una deroga esplicita, non si vede in base a quali parametri dovrebbe considerarsi preclusa l’applicazione
della disciplina ordinaria sul regime dell’imputazione nel
dibattimento. Quanto poi allo “affidamento” che l’imputato riporrebbe nella stabilità della situazione determinata
dal decreto penale, e da lui valutata al fine di decidere se
proporre o meno l’opposizione, viene notato che la legge
non preclude un trattamento più severo a conclusione del
dibattimento, il che varrebbe a comprovare l’irrilevanza di
un tale affidamento e l’applicabilità dell’art. 516 c.p.p.
Potrebbe aggiungersi, per completezza, che gli esempi portati a documentazione di altre pretese anomalie del dibattimento scaturito dall’opposizione al decreto penale (l’irrilevanza del meccanismo oggi disciplinato dall’art. 415-bis
c.p.p.) risultano di dubbia pertinenza, visto che attengono
alla validazione dell’atto di esercizio dell’azione, ma non incidono, appunto, sulle regole interne alla fase dibattimentale.
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
Codice della strada
Sanzione punitiva e garanzie
(a proposito della sentenza
costituzionale sulla decurtazione
dei punti della patente)
CORTE COSTITUZIONALE, 24 gennaio 2005 (12 gennaio 2005), n. 27
Pres. Onida - Rel. Quaranta
Patente a punti - Mancata identificazione del conducente responsabile dell’illecito - Decurtazione dei punti della patente a carico del proprietario (persona fisica) del veicolo - Preteso contrasto con i princìpi di ragionevolezza e di personalità della responsabilità - Illegittimità costituzionale per contrasto con il principio di ragionevolezza.
(Artt. 3, 27 comma 1, Cost.; art. 126-bis comma 2 c. strada)
È costituzionalmente illegittimo per violazione del principio di ragionevolezza, l’art. 126-bis comma 2, Codice della strada, nella parte in cui prevede che, nel caso di mancata identificazione del conducente responsabile della violazione delle norme del codice della strada, la segnalazione della decurtazione dei punti della patente alla Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida debba essere effettuata a carico del proprietario
del veicolo. Tale disposizione, infatti, dà vita a una sanzione assolutamente sui generis, giacché questa - pur
essendo di natura personale - non appare riconducibile ad un contegno direttamente posto in essere dal proprietario del veicolo.
(Omissis).
Considerato in diritto
1. - I Giudici di pace di Genova, sezione distaccata di
Voltri (r.o. n. 120 del 2004), Mestre (r.o. n. 569 del
2004), Ficarolo (r.o. n. 465 del 2004), Bra (r.o. n. 503 del
2004), Montefiascone (r.o. n. 575 del 2004), Lanciano
(r.o. nn. 643 e 658 del 2004), Carrara (r.o. n. 701 del
2004) e Casale Monferrato (r.o. nn. 721 e 722 del 2004)
hanno sollevato questione di legittimità costituzionale deducendo, nel complesso, la violazione degli articoli 3,
24, 25 (l’indicazione di quest’ultimo parametro apparendo, per vero, frutto di un laspsus calami) e 27 della Costituzione - dell’art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
introdotto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio
2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1 comma 1,
della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7 comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), come modificato - a propria volta - dalla legge di conversione 1°
agosto 2003, n. 214.
La disposizione de qua è sospettata di incostituzionalità
nella parte in cui prevede che, nel caso di mancata identificazione del conducente, «responsabile della violazione» delle norme del codice della strada per le quali «è
prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente», la segnalazione della decurtazione del punteggio attribuito alla patente di guida debba essere effettuata a carico del proprietario del veicolo,
«salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni
dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati
personali e della patente del conducente al momento
della commessa violazione».
1.1. - Deducono taluni dei predetti rimettenti (e segnatamente il Giudice di pace di Genova, sezione distaccata di Voltri, nonché quelli di Mestre, Ficarolo, Montefiascone, Lanciano e Carrara) la violazione dell’art. 3
della Costituzione, ravvisata sotto diversi profili. Innanzitutto, perché la disposizione impugnata configurerebbe
una “sanzione intermittente”, operando soltanto nei
confronti dei proprietari di veicoli che risultino muniti
di patente (r.o. nn. 120, 575, 643 e 701 del 2004), ovvero esclusivamente nei confronti delle persone fisiche e
non anche di quelle giuridiche (r.o. nn. 465 e 643 del
2004); in secondo luogo, perché la stessa - in contrasto
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1089
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
con la previsione di cui all’art. 3 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), che fissa il
principio della “personalità” della responsabilità amministrativa - realizzerebbe un’ingiustificata «disparità di
trattamento tra i trasgressori di alcune norme del codice
della strada ed i trasgressori di altre norme amministrative» (r.o. n. 120 del 2004).
Il contrasto con il parametro di cui all’art. 3 Cost. è ipotizzato, inoltre, anche in relazione al difetto di ragionevolezza che connoterebbe la disposizione de qua (r.o. nn.
120 e 569 del 2004). Essa, difatti, opera un intervento,
consistente nella previsione di un’ipotesi di responsabilità “per fatto altrui”, che - se appare «corretto» nei casi
contemplati dagli articoli 196 del codice della strada e
2054 del codice civile (giacché qui la responsabilità solidale del proprietario del veicolo, «per l’aspetto puramente riparatorio», risponde alla duplice necessità di
evitare che «molte norme sulla circolazione stradale» restino «eluse» e che i danneggiati in sinistri stradali possano «non ottenere il giusto risarcimento»; così in particolare r.o. n. 120 del 2004) - risulta, invece, irragionevole nel caso di specie, trattandosi di applicare una sanzione di natura «personale» (così, nuovamente, r.o. n. 120
del 2004).
1.2. - L’art. 126-bis comma 2, del codice della strada,
inoltre, sarebbe in contrasto - secondo quanto ipotizzato
dai rimettenti di Mestre, Ficarolo, Bra, Lanciano, Carrara e Casale Monferrato - con l’art. 24 della Costituzione,
e ciò sotto un triplice alternativo profilo.
Da un lato si assume che «la possibilità di irrogare sanzioni senza la contestazione immediata, anche se prevista dalla legge», costituirebbe «di per sé una compromissione del diritto di difesa» (r.o. n. 643 del 2004).
Per altro verso, invece, si sottolinea che - qualora le persone del proprietario del veicolo e del conducente, responsabile dell’infrazione, coincidano - la necessità di
evitare (almeno) l’irrogazione della sanzione pecuniaria
di cui all’art. 180, comma 8, del codice della strada
(comminata a carico del proprietario che non provveda
a soddisfare la richiesta di comunicare i “dati personali e
della patente” del conducente), dovrebbe indurre il destinatario della richiesta suddetta ad autodenunciarsi,
con conseguente violazione del principio del nemo tenetur se detegere (r.o. nn. 465, 503, 658, 701, 721 e 722 del
2004).
Infine, si deduce la violazione del diritto di difesa anche
sotto un ulteriore profilo (r.o. n. 503 del 2004), evidenziando come la previsione di un termine di appena trenta giorni, entro il quale il proprietario del veicolo deve
comunicare i dati personali e della patente del conducente responsabile dell’infrazione, risulti «nettamente
inferiore al termine di sessanta giorni per proporre ricorso al Giudice di pace o al Prefetto, al fine di conseguire
l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione stradale». Orbene, tale “sfasatura” temporale comporterebbe l’eventualità che sia «irrogata una sanzione
accessoria in mancanza di un giudicato sulla sanzione
1090
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
principale, in palese contrasto con il principio, logico
prima ancora che giuridico, secondo cui la sanzione accessoria non ha ragione di esistere quando manchi ab origine o venga successivamente meno quella principale».
1.3. - Viene, infine, ipotizzata - dai soli Giudici di pace di
Bra, Mestre, Montefiascone, Lanciano (ma esclusivamente nell’ordinanza r.o. n. 658 del 2004) e Carrara - la
violazione anche dell’art. 27 della Costituzione.
Si assume, difatti, che il principio - sancito dal primo
comma di tale articolo - secondo cui la «responsabilità
penale è personale» deve intendersi riferito anche alla
responsabilità amministrativa.
2. - Il Giudice di pace di Genova, sezione distaccata di
Voltri (r.o. n. 120 del 2004), ha, inoltre, sollevato questione di legittimità costituzionale - per contrasto con gli
articoli 3, 24, primo comma, e 113, secondo comma,
della Costituzione - dell’art. 204-bis, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, disposizione introdotta
dall’art. 4, comma 1-septies, del già citato d.l. n. 151 del
2003, aggiunta dalla legge di conversione n. 214 del
2003.
Il rimettente lamenta la irragionevole disparità di trattamento - realizzata dalla disposizione di legge impugnata tra quanti adiscono le vie giudiziali per l’annullamento
del verbale di contestazione dell’infrazione stradale, e
coloro che, in alternativa, decidano o di proporre, allo
stesso scopo, ricorso amministrativo all’autorità prefettizia, ovvero impugnino direttamente la c.d. “ordinanzaingiunzione”, giacché «l’incombente procedurale di cui
al comma 3 dell’art. 204-bis» del codice della strada (versamento di una “cauzione”, prevista a pena d’inammissibilità dell’iniziativa esperita) risulterebbe stabilito solamente nella prima delle tre ipotesi. Si deduce, inoltre,
che l’imposizione dell’onere procedurale de quo limiterebbe ingiustificatamente «la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei diritti», non essendo difatti «dettata
da ragioni di giustizia o di carattere processuale», contravvenendo inoltre al precetto costituzionale il quale
«prevede che la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione».
3. - Infine, un’ulteriore questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis del d.lgs. n. 285 del 1992 è sollevata dal Giudice di pace di Mestre (nella prima ordinanza - r.o. n. 267 del 2004 - da esso pronunciata), sotto un
profilo del tutto diverso da quelli testé illustrati.
È dedotta l’irragionevole disparità di trattamento - e
dunque il contrasto con l’art. 3 Cost. - che la disposizione in esame realizzerebbe a carico di taluni utenti della
strada, esclusi ratione temporis dalla possibilità di partecipazione ai corsi per il recupero del punteggio detratto
dalla patente, giacché sanzionati anteriormente all’avvento del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 29 luglio 2003 (Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida) con il quale sono
state «introdotte le norme di dettaglio sull’organizzazione dei corsi di recupero previsti dall’art. 126-bis» del co-
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
dice della strada. Secondo il rimettente, difatti, i soggetti che abbiano subito la decurtazione di punti dalla propria patente di guida in ragione di infrazioni commesse
tra il 1 luglio 2003 ed il successivo 6 agosto (cioè a dire
in un arco temporale che, nella prospettazione del giudice a quo, sarebbe compreso tra la data dell’entrata in vigore della nuova normativa relativa alla “patente a punti” e quella della pubblicazione del decreto ministeriale
concernente i c.d. “corsi di recupero”) sarebbero impossibilitati ad accedere a tali corsi, essendo divenute operative le norme di dettaglio sulla loro organizzazione soltanto successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto ministeriale suddetto (e dunque il 6
agosto 2003).
4. - Ciò premesso in merito alle iniziative assunte dai diversi giudici a quibus, deve preliminarmente disporsi data la connessione oggettiva esistente tra le varie ordinanze di rimessione - la riunione dei relativi giudizi ai fini di una unica decisione.
Quanto, invece, al contenuto di quest’ultima, appare
necessario definire, in via preliminare, tra le questioni di
legittimità costituzionale sollevate dal Giudice di pace di
Genova, sezione distaccata di Voltri (r.o. n. 120 del
2004), quella avente ad oggetto l’art. 204-bis comma 3,
del codice della strada, nonché, di seguito, quella posta
dal rimettente di Mestre nella prima delle due ordinanze
da esso pronunciate (r.o. n. 267 del 2004).
5. - La questione di legittimità costituzionale dell’art.
204-bis comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, sollevata dal
rimettente genovese, è manifestamente inammissibile.
La disposizione de qua è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza di questa Corte n. 114
del 2004, la quale ha rilevato che l’imposizione dell’onere economico da essa previsto finisce «con il pregiudicare l’esercizio dei diritti che l’art. 24 della Costituzione
proclama inviolabili, considerato che il mancato versamento comporta un effetto preclusivo dello svoglimento
del giudizio, incidendo direttamente sull’ammissibilità
dell’azione esperita».
6. - La questione sollevata dal Giudice di pace di Mestre
con l’ordinanza r.o. n. 267 del 2004 è, invece, infondata.
Secondo il rimettente, dalla previsione contenuta nell’art. 126-bis del codice della strada discenderebbe la
«impossibilità giuridica, per un trasgressore sanzionato
nel periodo dal 1° luglio al 6 agosto 2003», di accedere ai
corsi di recupero della patente, essendo divenute operative le norme di dettaglio sull’organizzazione dei corsi
stessi solo successivamente a tale periodo, di talché, «a
fronte della imposizione di una sanzione, per la quale sono previsti rimedi di natura riabilitativa», sarebbe «in
concreto negato al soggetto sanzionato l’accesso incondizionato ai benefici previsti, con conseguente ingiustificata disparità di trattamento dipendente esclusivamente
dal momento in cui la sanzione viene applicata».
L’impugnato articolo 126-bis ha previsto e disciplinato
il sistema della c.d. patente a punti, stabilendo che all’atto del rilascio della patente vengano attribuiti ven-
ti punti, annotati in una apposita anagrafe nazionale
(comma 1). Tale punteggio è destinato a subire decurtazioni a seguito della comunicazione, alla suddetta
anagrafe, della «violazione di una delle norme per le
quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente ovvero di una tra le
norme di comportamento di cui al titolo V» dello stesso codice della strada (meglio indicate in una apposita
tabella ad esso allegata). Il comma 4 del medesimo art.
126-bis dispone che, fuori dai casi di perdita totale del
punteggio e purché questo non sia del tutto esaurito, è
consentito ai trasgressori di recuperare un certo numero di punti mediante la frequenza di corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti
pubblici o privati a ciò espressamente autorizzati. L’ultimo periodo del comma sopra indicato dispone che
«con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell’autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei
corsi di aggiornamento».
L’art. 126-bis in esame è entrato in vigore a decorrere dal
30 giugno 2003 (secondo quanto previsto dall’art. 8 del
già citato d.l. n. 151 del 2003); da tale data è dunque divenuto operativo il sistema della patente a punti. Il decreto ministeriale che ha disciplinato i corsi di recupero,
per contro, è stato adottato in data 29 luglio 2003 ed è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il successivo 6
agosto 2003.
L’infrazione al codice della strada, sottoposta al giudizio
del giudice rimettente, è stata commessa il 3 luglio 2003,
dopo cioè l’entrata in vigore della disposizione censurata
e prima della pubblicazione del decreto. Secondo il rimettente, la norma censurata sarebbe incostituzionale,
in quanto «la nuova disciplina sarebbe incompleta non
essendo stata introdotta la puntuale disciplina dei c.d.
corsi di recupero, che dovrebbero, secondo il disegno del
legislatore, consentire al conducente sanzionato il recupero dei punti detratti».
La censura prospettata non può essere accolta per due ragioni, ciascuna delle quali ha carattere assorbente.
In primo luogo, anche per le infrazioni commesse tra il
30 giugno 2003 e la data di entrata in vigore del già menzionato decreto ministeriale relativo all’organizzazione
dei corsi di recupero dei punti perduti (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2003) era ed è possibile
l’accesso ai corsi stessi. Da un lato, infatti, nessuna preclusione di carattere temporale per l’iscrizione ai medesimi è prevista, né dall’articolo 126-bis del codice della
strada, né dal d.m. 29 luglio 2003, essendo - dall’altro del tutto logico che la partecipazione ai predetti corsi
debba avvenire in epoca successiva all’accertamento
dell’infrazione ed alla applicazione delle due sanzioni
combinate, la prima di natura pecuniaria, e la seconda
concernente la decurtazione del punteggio. Nessun pregiudizio, dunque, può derivare al soggetto che abbia
commesso l’infrazione al codice della strada nel suddetto
arco di tempo, atteso che nessuna preclusione per la par-
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1091
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
tecipazione ai corsi di recupero è ipotizzabile per il contravventore.
In secondo luogo, l’eventuale ritardo imputabile all’autorità amministrativa nel porre in essere gli atti di adempimento di una determinata normativa non può tradursi in una ragione di illegittimità costituzionale della normativa stessa.
7. - In relazione, invece, alla questione di legittimità del
comma 2 del medesimo art. 126-bis del codice della strada (sollevata da tutti gli altri rimettenti, compreso il
Giudice di pace di Genova, sezione distaccata di Voltri,
nella seconda parte della sua ordinanza, prima esaminata sotto un diverso profilo), occorre procedere ad uno
scrutinio differenziato in relazione ai diversi parametri
evocati, presentandosi tale questione fondata solo nei limiti di seguito precisati.
8. - È necessario, peraltro, premettere il quadro di fondo
nel quale si colloca la disposizione oggetto di censura, la
cui legittimità costituzionale è posta in dubbio dai rimettenti nella parte in cui essa stabilisce che, nel caso di
mancata identificazione del contravventore, la decurtazione dei punti della patente «deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non
comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo
di polizia che procede, i dati personali e della patente del
conducente al momento della commessa violazione».
L’originario comma 2 dell’art. 126-bis del codice della
strada, introdotto dall’art. 7 del decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive
del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1
comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), disponeva
che l’organo accertatore della violazione comportante la
perdita di punteggio dovesse dare notizia, entro trenta
giorni dalla definizione della contestazione, all’anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida. In particolare, il comma in questione prevedeva che la comunicazione dovesse essere effettuata «solo se la persona del conducente,
quale responsabile della violazione», fosse stata «identificata inequivocabilmente». In base a tale disposizione,
quindi, nelle ipotesi in cui non fosse stata possibile la
identificazione del conducente, il proprietario rispondeva soltanto per il pagamento della sanzione pecuniaria
prevista per l’infrazione, stante il vincolo di solidarietà
passiva con il conducente, ma non subiva alcuna conseguenza relativamente alla decurtazione del punteggio
della sua patente. La decurtazione presupponeva, pertanto, l’avvenuta identificazione, in ogni caso, del conducente del veicolo.
Soltanto in virtù di quanto stabilito dall’art. 7 comma 3,
lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151
(Modifiche ed integrazioni al codice della strada), nel testo a sua volta modificato dalla relativa legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214, l’ultima parte del comma 2
dell’art. 126-bis è stata sostituita, prevedendosi che, nel
caso di mancata identificazione del conducente, la segnalazione all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida debba «essere effettuata a carico del proprietario del
1092
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
veicolo», aggiungendosi che il suddetto proprietario, per
evitare tale effetto pregiudizievole, è tenuto a comunicare, entro trenta giorni dalla richiesta ricevutane, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della violazione commessa. È poi previsto che «se il proprietario del veicolo
risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede».
La norma in esame, infine, aggiunge che «se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall’art. 180 comma 8», vale a dire quella secondo la quale «chiunque senza giustificato
motivo non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell’invito medesimo, ad
uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 343,35 a euro 1.376,55».
Dall’insieme delle citate disposizioni emerge, dunque,
che nel caso in cui proprietario del veicolo sia una persona fisica munita di patente e l’infrazione sia punita, oltre che con la sanzione pecuniaria prevista da altre norme del codice, specificamente indicate in una apposita
tabella, anche con quella della decurtazione del punteggio della patente, il proprietario del mezzo, da un lato, risponde in solido con il conducente per il pagamento della sanzione pecuniaria principale (art. 196 del codice
della strada), e, dall’altro, si vede detratti i punti della patente. Tale ulteriore sanzione si applica, peraltro, quando
non sia stato possibile identificare il conducente e il proprietario medesimo, ricevutane apposita richiesta, abbia
omesso di indicare all’autorità le generalità ed i dati della patente del conducente che era alla guida del veicolo;
indicazione che, invece, come si è detto, determina l’inapplicabilità al proprietario della sanzione consistente
nella decurtazione del punteggio.
Ora, appare evidente che l’applicazione di questa ulteriore sanzione prescinde da qualsivoglia accertamento
della responsabilità personale del proprietario del veicolo in relazione alla violazione delle norme concernenti la
circolazione stradale.
9. - È alla luce di siffatta disciplina complessiva che deve
essere effettuato lo scrutinio di costituzionalità sollecitato dai rimettenti, i quali ritengono che la sanzione de qua
sia incompatibile con uno o più dei parametri costituzionali evocati.
9.1. - Viene, innanzi tutto, in rilievo la censura con la
quale è stata dedotta la violazione dell’art. 24 della Costituzione.
Assumono taluni dei giudici rimettenti che «la possibilità di irrogare sanzioni senza la contestazione immediata» costituirebbe «di per sé una compromissione del diritto di difesa». Sotto altro aspetto, ancora con riferimento al citato parametro costituzionale, viene dedotto
che la disposizione censurata pregiudicherebbe «il dirit-
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
to a non fornire elementi in proprio danno e, più in generale, a non collaborare con l’Autorità per la propria
incriminazione»; diritto che sarebbe sancito «in ossequio all’antico brocardo nemo tenetur se detegere». Infine,
si assume che il diritto alla difesa risulterebbe pregiudicato, in ogni caso, dal fatto che la disposizione in esame
prevede un termine di appena trenta giorni, entro il quale il proprietario del veicolo è tenuto a comunicare i dati personali e della patente del conducente responsabile
dell’infrazione; un termine, pertanto, «nettamente inferiore» a quello di sessanta giorni per proporre ricorso al
Giudice di pace o al prefetto, al fine di conseguire l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione
stradale. L’irrogazione della sanzione della decurtazione
del punteggio dalla patente di guida, sebbene risulti ancora pendente il termine per adire le vie giudiziali o amministrative onde attingere la caducazione del verbale di
contestazione dell’infrazione, rappresenterebbe una menomazione del diritto di difesa.
9.1.1. - Va chiarito, in proposito, che la mancata previsione della contestazione “immediata” dell’infrazione
punita con una misura amministrativa non integra di per
sé una violazione del diritto di difesa. E a ciò va aggiunto che, in sostanza, la doglianza investe la possibilità prevista dall’art. 4 comma 4, del decreto-legge 20 giugno
2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito nella legge
1° agosto 2002, n. 168 - di non procedere alla contestazione immediata dell’infrazione rilevata, di talché essa,
più che indirizzarsi contro la previsione dell’art. 126-bis
comma 2, del codice della strada, avrebbe dovuto investire la disposizione che tale possibilità contempla.
9.1.2. - Quanto alla paventata necessità per il proprietario del veicolo di autodenunciarsi, il dubbio di costituzionalità sollevato dai rimettenti appare fondarsi su di
una inesatta esegesi del dato normativo. Si consideri, difatti, che la disposizione impugnata espressamente stabilisce che la comunicazione all’anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida dell’avvenuta perdita del punteggio
dalla patente (e cioè l’adempimento che ha come presupposto, nel caso di mancata identificazione del conducente responsabile della violazione, proprio l’avvenuta
inutile richiesta al proprietario del veicolo di fornire i dati personali e della patente del predetto conducente) deve avvenire «entro trenta giorni dalla definizione della
contestazione effettuata», definizione che presuppone, a
sua volta, che «siano conclusi i procedimenti dei ricorsi
amministrativi o giurisdizionali ammessi», ovvero - ed è
proprio siffatta previsione ad essere dirimente rispetto alla censura in esame - che «siano decorsi i termini per la
proposizione dei medesimi».
In nessun caso, quindi, il proprietario è tenuto a rivelare
i dati personali e della patente del conducente prima
della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione.
9.2. - Fondate sono, invece, le censure di violazione del-
l’art. 3 della Costituzione sotto il profilo della irragionevolezza della disposizione, nel senso che essa dà vita ad
una sanzione assolutamente sui generis, giacché la stessa pur essendo di natura personale - non appare riconducibile ad un contegno direttamente posto in essere dal
proprietario del veicolo e consistente nella trasgressione
di una specifica norma relativa alla circolazione stradale.
9.2.1. - A tale conclusione conduce la ricostruzione del
contenuto della disposizione censurata alla luce della disciplina generale del sistema sanzionatorio previsto per
gli illeciti amministrativi, dalla legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale).
L’art. 3 di tale legge fissa due principî fondamentali: quello secondo il quale «nelle violazioni cui è applicabile una
sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della
propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia
essa dolosa o colposa» (primo comma); e quello secondo
il quale «nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa» (secondo comma). Il
citato articolo ancora la responsabilità per comportamenti tipizzati dalla norma al carattere personale della
condotta commissiva od omissiva del contravventore.
Ciò premesso, dunque, sul carattere “generale” del principio della personalità della responsabilità amministrativa, deve inoltre osservarsi come l’art. 6 della stessa legge
n. 689 del 1981 disciplini, a sua volta, ma per le sole sanzioni pecuniarie, la solidarietà passiva tra «il proprietario
della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l’usufruttuario o, se trattasi di bene
immobile, il titolare di un diritto personale di godimento» e «l’autore della violazione».
Orbene, il codice della strada, all’art. 196, con riferimento quasi testuale all’art. 6 della citata legge n. 689
del 1981 fa proprio il «principio di solidarietà», disponendo, al comma 1, che «per le violazioni punibili con la
sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del
veicolo» (o, in sua vece, «l’usufruttuario, l’acquirente
con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di
locazione finanziaria») è «obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi
dovuta».
L’art. 126-bis comma 2, invece, intervenendo in materia
diversa dalla responsabilità per il pagamento di somme e
in una ipotesi di sanzione di carattere schiettamente personale, pone a carico del proprietario del veicolo, solo
perché tale, una autonoma sanzione, appunto, personale, prescindendo dalla violazione, al medesimo proprietario direttamente ascrivibile, di regole disciplinanti la
circolazione stradale.
9.2.2. - È pur vero che in più occasioni questa Corte (ordinanze nn. 323 e 319 del 2002 e n. 33 del 2001) ha affermato che la responsabilità del proprietario di un veicolo, per le violazioni commesse da chi si trovi alla guida, costituisce, nel sistema delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme relative alla
circolazione stradale, un principio di ordine generale,
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1093
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
operante, in particolare, nel caso del fermo amministrativo del veicolo, anche quando sia di proprietà di terzi
(art. 214, comma 1-bis, del codice della strada). Nondimeno, deve rilevarsi che nelle ipotesi prese in considerazione dalla citata giurisprudenza si versava pur sempre
in tema di sanzioni aventi il carattere della patrimonialità e dunque suscettibili d’essere oggetto del regime della solidarietà passiva coinvolgente il proprietario del
veicolo. Ed infatti con l’irrogazione della sanzione del
fermo amministrativo del veicolo non si incide sulla
“persona” del proprietario, giacché la norma «si limita a
sottrargli la disponibilità, per un tempo limitato, di un
bene patrimoniale» (ordinanza n. 282 del 2001), determinando così una compressione soltanto di quelle facoltà di “godimento” della res che ineriscono al diritto
di proprietà.
Nella fattispecie ipotizzata dall’art. 126-bis, invece, assume preponderante rilievo il carattere schiettamente personale della sanzione che viene direttamente ad incidere sull’autorizzazione alla guida.
Si tratta, dunque, di una ipotesi di illecito amministrativo che, per più aspetti, appare assimilabile a quella della
sospensione della patente, la cui «natura afflittiva (…)
incide sul profilo della legittimazione soggettiva alla
conduzione di ogni veicolo, gravando sul relativo atto
amministrativo di abilitazione, a seguito dell’accertata
trasgressione di regole di comportamento afferenti alla
sicurezza della circolazione» (ordinanza n. 74 del 2000).
È, in effetti, proprio la peculiare natura della sanzione
prevista dall’art. 126-bis, al pari della sospensione della
patente incidente anch’essa sulla «legittimazione soggettiva alla conduzione di ogni veicolo», che fa emergere l’irragionevolezza della scelta legislativa di porre la
stessa a carico del proprietario del veicolo che non sia
anche il responsabile dell’infrazione stradale.
E ciò senza che venga in rilievo il pur denunciato contrasto tra la norma censurata e il principio costituzionale fissato dall’art. 27 della Costituzione; profilo che resta
assorbito.
In conclusione, l’art. 126-bis comma 2, del codice della
strada, nella parte in cui assoggetta il proprietario del
veicolo alla decurtazione dei punti della patente quando ometta di comunicare all’Autorità amministrativa
procedente le generalità del conducente che abbia
commesso l’infrazione alle regole della circolazione
stradale, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.
10. - L’accoglimento della questione di legittimità costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza,
rende, tuttavia, necessario precisare che nel caso in cui il
proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 180 comma 8, del codice della strada.
In tal modo viene anche fugato il dubbio - che pure è
stato avanzato da taluni dei rimettenti - in ordine ad
una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra
i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente
accidentale che le stesse siano munite o meno di patente.
Resta, tuttavia, ferma - ovviamente - la possibilità per il
legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, di conferire alla materia un nuovo e diverso assetto.
(Omissis).
IL COMMENTO
di Roberto Bartoli
Con la sentenza in commento la Corte costituzionale
ammette che anche alle sanzioni punitive amministrative vengano estese le stesse garanzie elaborate
per la pena, allorquando tali sanzioni siano per l’appunto capaci d’incidere sulla persona del soggetto responsabile. La soluzione adottata dalla Corte consente di raggiunge un punto di equilibrio tra istanze di
garanzia ed esigenze preventive. Ci si può tuttavia
chiedere se non sia possibile prospettare una soluzione che, privilegiando la prospettiva funzionale, estenda a tutte le sanzioni punitive, e quindi anche a quelle aventi carattere patrimoniale, i princìpi di colpevolezza, proporzione e irretroattività.
1094
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
In un momento storico come quello attuale, in
cui dottrina e giurisprudenza tendono a rivelare una
certa difficoltà a confrontarsi e a dialogare, mostrandosi a volte addirittura divise su alcune problematiche centrali della penalistica (si pensi, ad esempio, al
tema della causalità o a quello del concorso esterno in
associazione mafiosa), per quanto riguarda la questione delle garanzie costituzionali da estendere all’illecito punitivo amministrativo si deve invece registrare
un accordo assoluto, consolidatosi già da moltissimo
tempo: come infatti si tramanda da quasi quattro decenni dalla uniforme giurisprudenza costituzionale e
di legittimità e dalla unanime dottrina, i princìpi di
garanzia aventi rango costituzionale ed elaborati rispetto al sistema penale (riserva di legge, determinatezza e tassatività, irretroattività, colpevolezza, pro-
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
porzione ecc.) non si estendono all’illecito punitivo
amministrativo (1).
A dire il vero, qualche volta, anche coloro che
escludono categoricamente ogni possibilità di circondare l’illecito amministrativo delle stesse garanzie elaborate per il reato, ammettono qualche “strappo alla regola”.
Così, forse perché pungolati da una sorta di rimorso di
coscienza per l’eccessiva disinvoltura con cui si risolve
una questione che con l’incessante espandersi dell’illecito amministrativo sta divenendo sempre più delicata,
non si è mancato di dire che ad esempio il principio di
proporzione e il divieto di trattamenti contrari al senso
di umanità validi per le pene sarebbero da estendere anche alle sanzioni punitive amministrative (2). Comunque sia, nonostante queste rare eccezioni, per la verità
non sempre giustificate in modo esauriente e compiuto,
resta l’opinione indiscussa che i princìpi di garanzia costituzionalmente sanciti per l’illecito penale non riguardano anche quello amministrativo.
A questa convinzione diffusa ed espressa con tanta
fermezza, non corrisponde tuttavia altrettanta forza argomentativa. Nel momento in cui, infatti, si passa dalla
enunciazione della conclusione alla spiegazione del suo
fondamento, ci si rende conto che le motivazioni addotte non sono poi così persuasive come si vorrebbe credere. Ed infatti, per sostenere la non pertinenza dei princìpi alla sfera dell’illecito amministrativo, si richiamano
anzitutto ragioni di ordine storico (3): quando i costituenti
elaborarono i princìpi costituzionali - si dice - non si riferirono, come risulta anche dai lavori preparatori, al diritto punitivo complessivamente inteso, ma soltanto alla branca del diritto penale, e ciò non solo perché il diritto punitivo amministrativo non era a quel tempo particolarmente sviluppato, ma anche perché era stato proprio il diritto penale a rivelarsi un pericoloso strumento
persecutorio nelle mani del potere politico. D’altra parte, tale argomentazione, ineccepibile in una prospettiva
meramente storica, finisce però per svelare un approccio
di fondo alla Carta costituzionale che rischia di essere un
po’ troppo riduttivo, guardando più a un remoto passato
che a un prossimo futuro, o più semplicemente a un immediato presente. Se infatti è vero che i princìpi penali
sanciti dalla Costituzione sono stati elaborati avendo in
mente soprattutto i soprusi e le barbarie compiute nel
ventennio fascista, è anche vero che ancorare tali
princìpi soltanto a siffatto contesto storico significherebbe svilire e attenuare non solo la funzione di garanzia
propria dei princìpi ma anche, e soprattutto, la funzione
di persistente e costante “bussola” svolta dal testo costituzionale per orientare la mutevole complessità giuridico-sociale. In sostanza, la Costituzione deve sempre e
necessariamente fare i conti con la realtà e quindi confrontarsi anche con gli istituti che emergono nel tempo
e con le nuove problematiche che essi pongono.
In secondo luogo, molto spesso si richiamano ragioni
di politica criminale. Si tratta sicuramente dell’argomentazione più forte e che va per la maggiore. Riconosciuta la
sostanziale identità funzionale della sanzione amministrativa e della sanzione penale, e quindi la “naturale”
tendenza ad estendere anche alla prima i princìpi della
seconda, si nota tuttavia come, dal punto di vista funzionale, e per l’appunto della politica criminale, sia un controsenso predisporre anche per l’illecito punitivo amministrativo le stesse garanzie elaborate per il diritto penale
sostanziale, poiché si verrebbe a creare una sorta di inutile doppione: ragion per cui diventa necessario distinguere questi due sottosistemi sia in ordine ai princìpi, che rispetto alla disciplina (4). Come accennato, si tratta di
un’argomentazione molto forte, che in linea di fondo ci
sentiamo oltretutto di condividere, ma che tuttavia necessita di qualche precisazione. A ben vedere, infatti,
questo modo di ragionare riguarda più la disciplina che i
princìpi di garanzia, la portata e la configurazione dei quali non può essere desunta o ricavata da esigenze di politica criminale. Ma anche in ordine alla disciplina il ragionamento in esame abbisogna di qualche chiarimento,
poiché la possibilità di distinguere il contenuto delle norme positive è pur sempre condizionata dalla effettiva possibilità di distinguere sul piano delle garanzie i due sottosistemi. In buona sostanza, anche in una prospettiva che
privilegia valutazioni di politica criminale occorre anzitutto verificare se e di quali argini necessiti il diritto punitivo amministrativo, verifica - lo ripetiamo - del tutto
svincolata da ragioni di politica criminale, ma ancorata a
questioni funzionali e di garanzia; e solo in un secondo
momento, sempre che i princìpi lo consentano, si potrà
eventualmente approntare una diversa disciplina che sia
in grado di giustificare l’esistenza di un sottosistema punitivo diverso da quello penale.
Infine, per giustificare la non estensibilità delle garanzie all’illecito punitivo amministrativo non si è manNote:
(1) Nella giurisprudenza costituzionale, in ordine al principio di riserva di
legge, cfr. Corte cost., 14 aprile 1988, n. 447, in Giur. cost., 1988, 2057 ss.;
in ordine al principio di irretroattività, cfr. Corte cost., 3 maggio 2002, n.
150, ord., ivi, 2002, 1283 ss.; Corte cost., 24 luglio 1995, n. 356, ivi, 1995,
2631 ss.; Corte cost., 3 giugno 1992, n. 250, ord., ivi, 1992, 1916 ss.; Corte cost., 14 marzo 1984, n. 68, ivi, 1984, 422 ss.; in ordine al principio della personalità della responsabilità penale, cfr. Corte cost., 5 luglio 2002,
n. 323, ord., ivi, 2002, 2502 ss.; Corte cost., 5 luglio 2002, n. 319, ord., ibidem, 2466 ss.; Corte cost., 9 febbraio 2001, n. 33, ord., ivi, 2001, 125 ss.;
Corte cost., 21 aprile 1994, n. 159, ord., ivi, 1994, 1214 ss.; Corte cost., 19
novembre 1987, n. 420, ord., ivi, 1987, 2879 ss. Nella giurisprudenza di
legittimità v. di recente Cass., Sez. I, 23 marzo 2004, inedita. In dottrina
v. per tutti G. Berliri, Sanzioni amministrative e princìpi costituzionali della
potestà punitiva penale, in AA.VV., Le sanzioni amministrative, Milano,
1982, 291 ss.; C.E. Paliero-A. Travi, La sanzione amministrativa. Profili sistematici, Milano, 1988, 135 ss.; Id., voce Sanzioni amministrative, in Enc.
dir., vol. XLI, 1989, 371 ss. e, in particolare, 375 ss.
(2) Con riferimento al principio di proporzione v. F. Palazzo, Corso di diritto penale, Parte generale, Torino, 2005, 40; rispetto al divieto di trattamenti disumani v. C.E. Paliero-A. Travi, voce Sanzioni amministrative,
cit., 377.
(3) Sul punto v. C.E. Paliero-A. Travi, La sanzione amministrativa, cit.,
137; Id., voce Sanzioni amministrative, cit., 372.
(4) In argomento cfr. per tutti F. Palazzo, Corso di diritto penale, cit., 41-42.
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1095
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
cato di ragionare in termini di garanzia, utilizzando però argomentazioni che - per così dire - non hanno come diretto punto di riferimento l’illecito punitivo, quanto
piuttosto il diritto penale. Più precisamente, in questa
prospettiva si è anzitutto notato che un’eventuale estensione al diritto punitivo amministrativo delle garanzie
del diritto penale determinerebbe una caduta e un abbassamento delle garanzie concernenti quest’ultimo,
«non essendo ipotizzabile all’interno della stessa normativa una diversa flessibilità della garanzia a seconda del
tipo di sanzione» (5). A ben vedere, però, questa argomentazione ancora una volta prova troppo, ponendo un
limite all’attività ermeneutica ed interpretativa delle
norme costituzionali per certi aspetti privo di una reale
giustificazione, rappresentando il frutto di una concezione a nostro avviso troppo rigida. Nonostante qualche disagio iniziale, infatti, nessuno può negare che una stessa
disposizione di rango costituzionale, possa modulare livelli
regolativi diversi avuto riguardo al tipo di sanzione punitiva o comunque, più in generale, a caratteri peculiari
che conformano interi sistemi di disciplina. Ne è un
esempio recente l’art. 27 comma 1, Cost., il quale, dopo
la previsione della responsabilità da reato degli enti collettivi, viene nella sostanza interpretato in modo diverso
a seconda che la “personalità” della responsabilità sia riferita alla persona fisica oppure a quella giuridica. Il profilo sul quale deve essere posta l’attenzione è un altro, e
cioè se tra questi tipi di sanzioni o più in generale tra i diversi sottosistemi punitivi sussista o meno una diversità
tale da non giustificare l’estensione di siffatti princìpi.
Sempre in questa prospettiva “garantista” si è poi notato
come le norme costituzionali si inscrivano in un tessuto
sistematico strettamente legato alla pena: così, ad esempio, l’art. 27 comma 1, Cost., relativo alla personalità
della responsabilità, non può essere letto che in relazione all’art. 27 comma 3, Cost., concernente la funzione
rieducativa della pena, la quale, se intesa in senso pregnante, non può che essere relazionata alla sola pena criminale (6). D’altra parte, anche questa argomentazione
è suscettibile di qualche considerazione critica, visto
che, come vedremo meglio in seguito, la colpevolezza è
funzionale anche ad altri scopi della pena, come ad
esempio la prevenzione generale, la quale è propria anche dell’illecito punitivo amministrativo. Inoltre, ammessa, come abbiamo visto, la possibilità di configurare
gradi diversi di garanzia all’interno di una stessa disposizione costituzionale, una lettura dell’art. 27 comma 1, in
relazione all’art. 27 comma 3, Cost. può riguardare il diritto penale, ma non è detto che debba interessare anche
l’illecito punitivo aministrativo.
In sostanza, a noi pare che non ci si possa interrogare sulla estensibilità o meno dei princìpi penali al diritto
punitivo senza muovere dalla questione di fondo relativa
al rapporto, e quindi alle omogeneità o differenze che intercorrono tra la pena e la sanzione amministrativa punitiva. E questa sentenza della Corte costituzionale in
commento merita a nostro avviso la più attenta conside-
1096
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
razione proprio perché si muove in questa prospettiva.
Essa, infatti, nell’affrontare la questione della illegittimità costituzionale dell’art. 126-bis comma 2, Nuovo codice della strada, nella parte in cui prevede la decurtazione dei punti della patente a carico del proprietario
che non ha commesso l’illecito, con ogni probabilità
rappresenta il tentativo più compiuto e consapevole di
spiegare le ragioni, il perché di questa differenza sul piano delle garanzie, spingendosi per l’appunto, come del
resto era inevitabile, e come fino ad ora non era mai stato fatto, al cuore del problema, e cioè addentrandosi nell’esame del concetto di sanzione punitiva.
La questione affrontata dalla Corte costituzionale
e l’impianto argomentativo basato
sul principio di ragionevolezza
Come accennato, la questione che ha offerto questo
spunto alla Corte riguarda l’art. 126-bis comma 2, Nuovo
codice della strada, nella parte in cui prevede che, nel caso di mancata identificazione del conducente responsabile della violazione delle norme del codice della strada per
le quali è prevista la sospensione della patente, la segnalazione della decurtazione dei punti della patente debba
essere effettuata a carico del proprietario del veicolo.
A dire il vero non è chiaro se la questione esaminata abbia riguardato la norma come ipotesi di responsabilità per fatto altrui oppure in quanto ipotesi di responsabilità per fatto proprio ma oggettiva. Dall’espressione riportata in motivazione secondo cui l’art. 126-bis comma
2, cit. «non appare riconducibile ad un contegno direttamente posto in essere dal proprietario del veicolo», ci
sembra che la Corte si sia orientata nella prima prospettiva. Tuttavia, a nostro avviso, esistono ottimi elementi
per ritenere più corretta l’opinione che ravvisa nella fattispecie dichiarata illegittima, e più in generale in tutte
le disposizioni che sanciscono il principio della solidarietà della persona fisica, un’ipotesi di responsabilità oggettiva. Da un lato, infatti, il proprietario del veicolo
non risponde per la sola posizione che riveste, ma sulla
base di un nesso causale che intercorre tra l’affidamento
o la mancata custodia del veicolo e la realizzazione dell’illecito (responsabilità per fatto proprio). Dall’altro lato, però, rispetto alla violazione realizzata in concreto,
egli non è né in dolo, né in colpa (responsabilità oggettiva). Ed infatti, l’art. 196, comma 1, Nuovo codice della strada, riproducendo quasi testualmente il 1° comma
dell’art. 6 della legge n. 681 del 1981, fa proprio il principio di solidarietà nel limite in cui la cosa non sia stata
utilizzata contro la volontà del proprietario. E come è
stato giustamente notato da tempo, «ciò non significa,
Note:
(5) Così F. Bricola, Legalità e crisi: l’art. 25 commi 2° e 3° della Costituzione
rivisitati alla fine degli anni ‘70, in Quest. crim., 1980, 179 ss. Nello stesso
senso, con sviluppi ulteriori, cfr. C.E. Paliero-A. Travi, La sanzione amministrativa, cit., 137 ss.
(6) C.E. Paliero-A. Travi, La sanzione amministrativa, cit., 149-150.
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
che la responsabilità del proprietario per l’illecito amministrativo possa qualificarsi come colposa. Il rimprovero
di negligenza investe infatti la sola custodia della cosa ed
il suo conseguente utilizzo da parte di un terzo; non si
estende invece alla realizzazione del fatto illecito […] si
tratta dunque di una responsabilità obiettiva» (7).
Comunque sia, al di là di questo aspetto, per la verità non privo di qualche conseguenza, su cui ci soffermeremo in seguito, per il momento a noi interessa concentrare la nostra attenzione sul tipo di ragionamento
che ha portato la Corte a dichiarare la norma costituzionalmente illegittima. Ebbene, basandosi sul principio di
ragionevolezza, anziché su quello della personalità della
responsabilità penale, essa ha compiuto una fondamentale distinzione tra sanzioni aventi il carattere della patrimonialità, da considerarsi nella sostanza estranee alle
garanzie costituzionali, e sanzioni aventi invece il carattere della personalità, rispetto alle quali i principi di garanzia devono essere estesi, concludendo che l’art. 126bis comma 2, cit. è disposizione irragionevole perché «dà
vita a una sanzione assolutamente sui generis, giacché la
stessa - pur essendo di natura personale - non appare riconducibile ad un contegno direttamente posto in essere dal proprietario del veicolo». Ed infatti, mentre non
risulta irragionevole ricondurre le sanzioni a carattere
patrimoniale a un comportamento diverso da quello che
ha effettivamente realizzato l’infrazione, in quanto per
l’appunto incidono sul solo patrimonio del soggetto responsabile, al contrario, le sanzioni personali, proprio
perché affliggono la persona, non possono che essere ricondotte ad un comportamento posto in essere dallo
stesso soggetto che le subisce. Così, ad esempio, il fermo
amministrativo del veicolo che sia di proprietà di terzi risulta legittimo, in quanto si tratta di sanzione a carattere
patrimoniale: afferma infatti la Corte che «con l’irrogazione della sanzione del fermo amministrativo del veicolo non si incide sulla “persona” del proprietario giacché
la norma “si limita a sottrargli la disponibilità, per un
tempo limitato, di un bene patrimoniale” (ordinanza
282 del 2001), determinando così una compressione soltanto di quelle facoltà di godimento della res che ineriscono al diritto di proprietà». Al contrario, la fattispecie
ipotizzata dall’art. 126-bis oppure quella della sospensione della patente devono essere poste a carico del proprietario del veicolo che sia anche responsabile dell’infrazione stradale e ciò perché «la natura afflittiva […] incide sul profilo della legittimazione soggettiva alla conduzione di ogni veicolo, gravando sul relativo atto amministrativo di abilitazione».
Qualche considerazione sul parametro
della ragionevolezza e sull’“equilibrio”
della soluzione adottata dalla Corte
Il ragionamento condotto dalla Corte merita un’attenta considerazione sia per quanto concerne il parametro utilizzato, sia in ordine alla conclusione a cui approda. In particolare, sotto il primo profilo, suscita partico-
lare interesse il fatto che, come accennato, la Corte non
faccia riferimento al principio della personalità della responsabilità penale, ma a quello della ragionevolezza.
Senza alcun dubbio, in una prospettiva - per così dire - di
ampio respiro, dietro tale scelta v’è l’intento della Corte
di non impiegare un parametro così rigido e inflessibile
come quello della personalità della responsabilità penale, essendo ormai una tendenza consolidata all’interno
della giurisprudenza costituzionale quella di preferire
princìpi che non si pongono nei termini rigorosi dell’autaut, ma in termini - per così dire - più duttili e dialogici
con la materia oggetto del giudizio (8). Ed infatti, anche
se si tende ad affermare, e giustamente, che tutti i princìpi, proprio perché tali, differiscono dalla disciplina sotto
il profilo della loro maggiore elasticità contenutistica
(9), è anche vero che alcuni di questi princìpi, come ad
esempio il principio di offensività o per l’appunto quello
di colpevolezza, quando costituiscono parametri di legittimità costituzionale, tornano inevitabilmente ad assumere una certa rigidità, basandosi in definitiva sullo
schema implacabile del “o tutto o niente”: in buona sostanza, la disciplina legale non può corrispondere in misura maggiore o minore al principio di offensività oppure a quello di colpevolezza, dovendo risultare o compatibile o incompatibile con siffatti princìpi. Ecco allora la
tendenza di fondo della Corte a impiegare altri princìpi,
come per l’appunto quello di ragionevolezza, che hanno
un contenuto piuttosto elastico anche al momento del
controllo della legittimità costituzionale, permettendo
così di compiere eventuali differenziazioni e quindi di instaurare una sorta di dialogo con l’intera disciplina in cui
si trova inserita la norma oggetto della questione, con il
risultato finale di poter articolare maggiormente il ragionamento per meglio attagliarsi alla complessità normativa dell’intero sistema.
Traducendo quanto detto in una prospettiva più
immediata, si può dire che la Corte ha utilizzato il parametro della ragionevolezza proprio perché le ha consentito di compiere questa fondamentale distinzione tra
sanzioni a carattere patrimoniale e sanzioni che invece
incidono sulla persona, distinzione altrimenti difficilmente prospettabile. Ed infatti, se avesse utilizzato il
Note:
(7) E. Dolcini, Commento all’art. 6, in E. Dolcini-A. Giarda-F. Mucciarelli-C.E. Paliero-E. Riva Crugnola, Commentario delle “Modifiche al sistema penale” (Legge 24 novembre 1981, n. 689), Milano, 1982, 43.
(8) Sul punto v. per tutti F. Palazzo, Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto delle leggi penali, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1998, 369 ss. Su questo principio, cfr. anche G. Insolera, Democrazia, ragione e prevaricazione. Dalle vicende del falso in bilancio ad un nuovo riparto
costituzionale nella attribuzione dei poteri?, Milano, 2003, 35 ss. A conferma
di quanto detto, si veda la recente ordinanza della Corte costituzionale 31
maggio 2005, n. 218, inedita, in cui è stata esaminata la questione della
determinatezza dell’art. 141 comma 3 c. strada, facendo proprio riferimento al paramentro della ragionevolezza.
(9) In generale, sul particolare contenuto elastico dei princìpi, cfr. per
tutti G. Fiandaca, in G. Fiandaca-G. Di Chiara, Una introduzione al sistema penale. Per una lettura costituzionalmente orientata, Napoli, 2003, 8.
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1097
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
principio della personalità della responsabilità, la Corte
avrebbe dovuto concludere in modo secco e perentorio
o per la legittimità della disposizione in esame - soluzione per la verità difficilmente sostenibile - oppure per la
sua illegittimità. E in questa seconda prospettiva la Consulta si sarebbe comunque trovata in una certa difficoltà.
E infatti, da un lato, se avesse accolto la questione senza
alcuna ulteriore precisazione o specificazione in ordine
al contenuto del principio di personalità della responsabilità, avrebbe finito per aprire una breccia all’interno
del proprio sistema, dalla quale in futuro sarebbero potute passare questioni di illegittimità costituzionale relative ad ipotesi di responsabilità oggettiva o per fatto altrui
senza dubbio esistenti nei vari sistemi in cui si punisce
l’illecito amministrativo. Dall’altro lato, proprio per evitare questi possibili inconvenienti futuri, la Corte avrebbe dovuto compiere nell’immediato precisazioni e distinguo all’interno del contenuto del principio della personalità della responsabilità, inerpicandosi così su uno
dei terreni più dibattuti degli ultimi decenni, ma soprattutto correndo il rischio di “vincolarsi” anche per le decisioni a venire. Ecco allora che l’impiego dell’art. 3 Cost. ha consentito alla Corte di raggiungere lo stesso risultato che si sarebbe ottenuto mediante il riferimento all’art. 27 comma 1, Cost., senza tuttavia doversi sbilanciare o esporsi in modo eccessivo.
Passando al secondo profilo, relativo al tipo di conclusione a cui è giunta la Corte, occorre anzitutto notare
che essa si pone in perfetta continuità con la precedente
giurisprudenza costituzionale, limitandosi ad apportare per così dire - soltanto un correttivo. Ciò si desume non
solo dalla circostanza che si continua a non utilizzare il
parametro della personalità, e quindi un principio proprio del diritto penale, ma anche dal fatto che si seguita
ad affermare che rispetto all’illecito amministrativo punito con il pagamento di una somma di denaro, e cioè
punito con la sanzione più significativa dell’eterogeneo
mondo delle misure amministrative lato sensu punitive,
non si estendono i princìpi di garanzia. In buona sostanza, la Corte, ed ecco il correttivo, non distingue più tra i
sottosistemi del diritto penale e del diritto punitivo amministrativo, bensì, a seconda del loro contenuto, tra tipologie sanzionatorie, con la conseguenza che anche
sanzioni amministrative punitive possono godere delle
garanzie del diritto penale, purché incidano sulla persona. In secondo luogo, non si può non sottolineare come
la soluzione adottata riesca a trovare un punto di equilibrio tra le due contrapposte esigenze che da sempre tormentano il diritto penale, e cioè le esigenze di garanzia e
quelle di prevenzione. Da un lato, infatti, affermando
che alle sanzioni che incidono sulla persona si devono
estendere i princìpi di garanzia, la Corte appaga in pieno
le istanze fondamentali di tutela dell’individuo, visto
che tra queste sanzioni coperte dalle garanzie rientrano
senza alcun dubbio tutte le sanzioni che fanno parte del
diritto penale (le quali com’è noto incidono direttamente o indirettamente sul bene primario della libertà perso-
1098
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
nale), come anche la vasta gamma di sanzioni (penali e
non) aventi contenuto interdittivo, le quali sono capaci
d’incidere sulla piena esplicazione della persona in modo
spesso più penetrante delle sanzioni aventi contenuto
patrimoniale. Dall’altro lato, però, la Corte, proprio perché non estende queste garanzie alle sanzioni che hanno
il carattere della patrimonialità, riesce ad appagare le
contrapposte esigenze preventive, nel senso che, rispetto
a queste sanzioni il legislatore non troverà alcun argine
al proprio potere punitivo.
I limiti della sentenza
Al di là di questi importanti meriti testé evidenziati, il ragionamento della Corte offre lo spunto per compiere anche qualche considerazione critica. Anzitutto
non si può fare a meno di notare che se dalla prospettiva
dell’intero sistema punitivo si riesce a trovare una sorta
di armonia tra esigenze di garanzia ed esigenze preventive, tuttavia, dalla prospettiva del sottosistema dell’illecito punitivo amministrativo la soluzione presenta toni per così dire - piuttosto radicali, e ciò proprio perché alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento
di una somma di denaro non risulta estensibile alcuna
delle garanzie elaborate in materia penale. Una volta,
infatti, che ci si basa sul contenuto della sanzione, il sistema di garanzie relativo alle sanzioni punitive che hanno contenuto patrimoniale non è suscettibile di flessibilità, non può essere modulato o articolato, e quindi rispetto a queste sanzioni non si può parlare di garanzie affievolite, ma nella sostanza di una loro assenza totale,
non essendo per l’appunto possibile compiere una differenziazione e una cernita tra le stesse. Con la conseguenza, a nostro avviso assai forte, che ad esempio neppure un principio come quello della responsabilità per
fatto proprio potrà essere esteso all’illecito amministrativo punitivo con sanzione a contenuto patrimoniale, e
che pertanto, come si ricava implicitamente anche dall’impianto argomentativo tratteggiato dalla sentenza in
commento, se ad esempio un giorno il legislatore decidesse di riformare la legge n. 689 del 1981 prevedendo
ipotesi di responsabilità per fatto altrui anche a carico
delle persone fisiche, si dovrebbe ritenere che si tratta di
un’operazione costituzionalmente legittima, proprio perché la garanzia della personalità della responsabilità penale si estende solo a sanzioni che incidono direttamente o indirettamente sulla persona.
Andando ancor più nel dettaglio, ciò che non persuade della sentenza in commento è l’idea di fondo che
sottende l’intero suo ragionamento, secondo cui il criterio metapositivo che permette di distinguere il diritto punitivo coperto dalle garanzie da quello invece estraneo alle stesse si fonda sul contenuto della sanzione (10). Per
Nota:
(10) In dottrina adotta lo stesso criterio della Corte costituzionale G. de
Vero, Corso di diritto penale, I, Torino, 2004, 51-52. Spunti anche in F. Palazzo, Introduzione ai princìpi del diritto penale, Torino, 1999, 190.
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
prima cosa, infatti, non può sfuggire che il criterio di incidenza sulla persona o sul patrimonio è solo in apparenza un parametro sufficientemente chiaro e determinato.
Da un lato, infatti, è difficile negare che al giorno d’oggi
la componente patrimoniale non costituisca un mezzo
necessario per il pieno sviluppo e per la piena esplicazione della persona. Dall’altro lato, poi, se quando ha parlato di “carattere personale” della sanzione, la Corte ha voluto riferirsi alla natura infungibile della “prestazione” a
cui è “costretto” il soggetto responsabile, allora si deve
concludere che anche sanzioni aventi pacificamente natura extrapenale, come ad esempio la reintegrazione nel
posto di lavoro, hanno natura punitiva.
In secondo luogo, seguendo la ricostruzione della
Corte si viene a creare una sorta di paradosso, per cui,
come mostra la stessa sanzione che viene richiamata a titolo esemplificativo nella sentenza (sospensione della
patente), si finisce per circondare di maggiori garanzie
quelle che, avendo un contenuto interdittivo, rivelano
una natura senza alcun dubbio impeditiva, rispetto a
quelle che hanno invece una vera e propria natura punitiva perché connotate da un contenuto afflittivo.
Ed eccoci a quello che noi consideriamo il vero limite della sentenza. Per individuare correttamente il criterio che consente di distinguere tra sanzioni bisognose
di garanzie e sanzioni che invece non lo sono, a nostro
avviso occorre muovere non solo dal contenuto afflittivo della sanzione, ma anche, e soprattutto, dallo stretto
legame che intercorre tra contenuto della sanzione, funzione preventiva della stessa ed esigenze di garanzia (11).
Ebbene, in questa prospettiva appare evidente che queste esigenze di garanzia prendono origine dai pericoli di
strumentalizzazione del soggetto che subisce la sanzione,
i quali a loro volta scaturiscono dalla funzione preventiva della pena, la quale, ed ecco il punto, non deriva tanto dalla natura patrimoniale o personale del contenuto
della sanzione, ma dalla circostanza che tale contenuto
si caratterizza per una sua afflittività, e più precisamente
per una sua totale ed assoluta inutilità immediata, dovuta a tutta una serie di fattori, come ad esempio l’eterogeneità del contenuto della sanzione rispetto al contenuto
dell’illecito oppure l’eventuale terzietà del “beneficiario”
della sanzione (es. lo Stato nel caso delle sanzioni pecuniarie). In sostanza, detto in altri termini, se da un lato è
vero che le esigenze di garanzia sono strettamente connesse ai pericoli di strumentalizzazione derivanti dalla
funzione preventiva della pena, dall’altro lato è anche
vero che la funzione preventiva di una sanzione non è
tanto legata alla natura personale o patrimoniale della
sanzione, al tipo di bene che attinge, quanto al suo carattere afflittivo derivante dalla inutilità immediata.
Con la conseguenza decisiva che anche sanzioni afflittive aventi natura patrimoniale sono in grado di svolgere
una funzione preventiva e quindi, essendo suscettibili di
un utilizzo strumentalizzante, devono essere circondate
da garanzie.
È evidente che seguendo in modo rigoroso questa
prospettiva si delinea un criterio distintivo metapositivo
diverso da quello adottato dalla Corte costituzionale, che
tiene conto della funzione della sanzione punitiva. D’altra parte, anche l’impiego di questo criterio porta a delle
conseguenze non del tutto soddisfacenti, in quanto risulta affetto da un “radicalismo” identico a quello che abbiamo riscontrato nella soluzione precedente, visto che
porta a concludere per la necessità di estendere a tutte le
sanzioni punitive, quale che sia il loro contenuto e il bene a cui attingono, tutte le garanzie elaborate per la pena.
Verso un nuovo criterio distintivo
basato sulla funzione delle sanzioni punitive
e sul loro diverso modo di incidere sul reo
A questo punto occorre chiedersi se non sia possibile individuare una soluzione che per il suo “orientamento di fondo” si riveli diversa da quelle precedenti, una soluzione, cioè, che sappia veramente trovare un punto di
equilibrio tra le esigenze di prevenzione e le esigenze di
garanzia. A noi pare che si possa dare una risposta positiva a siffatto quesito, notando come sia possibile delineare un criterio ulteriore, frutto di una combinazione tra
quelli precedentemente tratteggiati. Da un lato, infatti,
occorre muovere dal dato funzionale messo prima in evidenza e riconoscere che tutte le sanzioni punitive, anche
quelle che hanno il carattere della patrimonialità, necessitano di garanzie, e ciò proprio perché anche queste
sanzioni, grazie al loro contenuto afflittivo e di inutilità
immediata, svolgono una funzione preventiva e quindi si
prestano ad un uso strumentale. Dall’altro lato, si deve
tuttavia riconoscere che il modo di incidere sul reo da
parte delle sanzioni punitive può essere diverso e che
pertanto le garanzie possono essere modulate in termini
differenziati a seconda che si tratti di sanzioni punitive
aventi il carattere della “personalità”, rispetto alle quali
si devono estendere tutte le garanzie, e sanzioni punitive
aventi invece il carattere della patrimonialità, rispetto
alle quali, invece, non è necessario estendere tutte le garanzie, ma solo alcune, e più precisamente tutte quelle
garanzie la cui attuazione rappresenta addirittura un presupposto necessario affinché la stessa sanzione punitiva
possa esplicare la sua funzione preventiva.
In particolare, sotto quest’ultimo profilo, non si
può fare a meno di notare come già da un pò di tempo
sia stata dimostrata l’esistenza di un legame indissolubile tra alcuni princìpi di garanzia e la stessa funzione preventiva esplicata dalle sanzioni punitive, nel senso per
l’appunto che, affinché si possa realizzare lo stesso effetto preventivo che s’intende perseguire, risulta necessario dare piena attuazione a determinati princìpi di garanzia: e questi princìpi indissolubilmente compenetrati con la stessa funzione che intendono arginare sono la
colpevolezza, la proporzione e la irretroattività della legNota:
(11) Sul punto cfr. ampiamente F. Palazzo, Introduzione ai princìpi del diritto penale, cit., 35 ss.
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1099
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
ge punitiva (12). Ed infatti soltanto se ha un legame psichico quanto meno con il fatto illecito, il soggetto è in
grado di orientare in modo consapevole il proprio comportamento; parimenti, soltanto se le conseguenze sanzionatorie risultano proporzionate al disvalore del fatto,
il reo “accetta” di sottoporsi ad esse; e infine, soltanto se
la legge che impone il comportamento esiste prima della commissione del fatto, essa è effettivamente in grado
di influenzare la scelta del destinatario del precetto.
Alcune considerazioni conclusive sui diversi criteri
metapositivi elaborati per distinguere
tra sanzioni punitive circondate da garanzie
e sanzioni punitive non coperte dalle stesse
A questo punto della nostra indagine possiamo tentare di ricondurre - per così dire - a sistema quanto abbiamo detto finora. Premessa di fondo è che, a nostro parere, il ragionamento della Corte, e più in generale l’intero
dibattito che si è sviluppato sul tema delle garanzie da
estendere all’illecito punitivo amministrativo, è stato forse un pò troppo condizionato dalla circostanza che la legge ordinaria che disciplina tale illecito è una legge fondamentalmente rispettosa dei principi di garanzia, dando
quindi l’impressione che non vi fosse la necessità di vincolare il legisaltore e che pertanto si potesse prescindere
da un riconoscimento costituzionale degli stessi. Tuttavia, quando si riflette sulle garanzie non si può avere come punto di riferimento la disciplina positiva, dovendo
necessariamente spingere il proprio sguardo al di là di essa. Ed infatti, non appena sono state introdotte all’interno del sistema positivo ipotesi di responsabilità per fatto
altrui o comunque oggettiva particolarmente penetranti,
l’impianto elaborato nel tempo dalla Corte rispetto alla
precedente disciplina positiva di per sé rispettosa dei
princìpi di garanzia ha dovuto subire qualche correttivo.
Ciò posto, anzitutto, si deve notare come sia in verità impraticabile la soluzione - per così dire - quantitativa, secondo cui, muovendo dalla identità funzione dei
due sottosistemi, a causa del minore contenuto affittivo
della sanzione punitiva, e quindi a causa del minore effetto preventivo che ne scaturisce, le garanzie possono
essere affievolite (13). A ben vedere, infatti, questa lettura è possibile solo in una prospettiva che muove dal diritto positivo, allorquando il sistema vigente è costruito
appunto nei termini suddetti di garanzie affievolite, ma
non in una prospettiva metapositiva. Da un lato, infatti,
il criterio quantitativo non è in realtà in grado di orientare le scelte del legislatore: così, ad esempio, non si riuscirebbe a comprendere perché dal carattere meno afflittivo della sanzione, dovrebbe derivare ad esempio l’irrilevanza dell’errore sul precetto oppure la legittimità di
ipotesi di responsabilità oggettiva oppure addirittura per
fatto altrui. Dall’altro lato, poi, a noi pare che dietro questo criterio quantitativo si nasconda in verità o un criterio basato sulla natura del contenuto della sanzione, con
conseguente totale estromissione della sanzione punitiva avente carattere patrimoniale dalla portata dei princì-
1100
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
pi di garanzia (14); oppure un criterio che al contrario
spinge per circondare qualsiasi sanzione punitiva con le
stesse garanzie elaborate per la pena (15).
Ecco allora che i criteri distintivi in definitiva prospettabili sono proprio questi ultimi due, e cioè per l’appunto quello adottato dalla Corte costituzionale, che fa
leva sulla natura del contenuto della sanzione e che potremmo definire qualitativo, e quello che invece si fonda
sulla funzione preventiva delle sanzioni punitive, che
potremmo chiamare funzionale. Il primo modello, come
accennato in precedenza, raggiunge senza dubbio un importante punto di equilibrio all’interno dell’intero sistema, e tuttavia finisce per porsi in contrasto con la premessa della identità funzionale tra sanzioni penali e sanzioni punitive amministrative. Una volta dimostrata, infatti, l’esistenza di un legame indissolubile tra funzione
preventiva della sanzione punitiva e alcuni princìpi di
garanzia, si deve riconoscere che è addirittura dall’opzione per certi princìpi che deriva la finalità della pena, ovvero che la funzione di una sanzione si determina sulla
base dei princìpi che ispirano il sistema. Ecco allora che,
essendo il modello adottato dalla Corte vòlto ad estromettere i princìpi, ne consegue che la sanzione punitiva
avente carattere patrimoniale non svolge più una funzione preventiva, quanto piuttosto una funzione di retribuzione giuridica o comunque di oggettiva compensazione dell’offesa, come del resto emerge anche dal meccanismo della solidarietà. Il secondo modello si caratterizza invece per un opposto di radicalismo, perché porta
a concludere che alle sanzioni amministrative si debbono estendere tutte le garanzie.
E questi due criteri possono forse essere composti in
un unico criterio funzionale-qualitativo, che, come visto,
porta non tanto ad un affievolimento delle garanzie,
quanto piuttosto a una loro selezione qualitativa illuminata dal profilo funzionale.
Gli effetti della sentenza
sulla procedura di decurtazione dei punti
È anche alla luce di tutte queste considerazioni fatte finora che adesso si devono prendere in esame alcune
problematiche aperte dalla sentenza in commento strettamente connesse alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 126-bis comma 2, cit., e in particolaNote:
(12) Sul punto cfr. per tutti F. Palazzo, Introduzione ai princìpi del diritto penale, cit., 61-62, rispetto al principio di colpevolezza; 70-72, rispetto al
principio di proporzione; e 291, circa il principio di irretroattività.
(13) In questo senso v. per tutti C.E. Paliero, “Materia penale” e illecito
amministrativo secondo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: una questione
“classica” a una svolta radicale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1985, 920 ss.
(14) Sembra essere questa la posizione di C.E. Paliero-A. Travi, voce Sanzioni amministrative, cit., 375 ss., che, nella prospettiva “prelegislativa”, alla fine non estendono per l’appunto alcuna garanzia alle sanzioni amministrative.
(15) E questa sembra essere la posizione di M. Siniscalco, Depenalizzazione e garanzia, Bologna, 1995, passim.
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
re concernenti gli effetti della sentenza sulle procedure
di decurtazione dei punti pendenti e future (16).
Per comprendere meglio siffatte problematiche, ci
pare opportuno richiamare brevissimamente la disciplina di tale procedimento, allorquando il conducente del
veicolo non sia stato identificato. In particolare, prima
della sentenza della Corte costituzionale, l’art. 126-bis
distingueva a seconda che proprietario del veicolo fosse
una persona fisica oppure una persona giuridica. Nella
prima ipotesi, l’organo che aveva accertato la violazione
che comportava la perdita di punteggio, entro trenta
giorni dalla definizione della contestazione effettuata,
notificava al proprietario del veicolo la richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente
al momento della commessa violazione, con la conseguenza che se il proprietario ometteva di compiere questa comunicazione entro trenta giorni dalla notifica, la
decurtazione dei punti veniva fatta a carico del proprietario stesso. Se invece il proprietario del veicolo era una
persona giuridica, e il suo rappresentante legale o un suo
delegato ometteva di fornire i dati del conducente al
momento della commessa violazione, poiché non potevano essere decurtati i punti, non esistendo alcuna patente, alla persona giuridica si applicava una sanzione
pecuniaria. Dopo la sentenza della Corte costituzionale
si può dire che è venuta meno questa distinzione tra persone fisiche e persone giuridiche, e ciò perché non solo
la Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 126-bis comma 2,
nella parte in cui prevedeva che la decurtazione dei punti doveva essere effettuata a carico del proprietario, ma
anche perché all’interno del punto 10 della motivazione, la Corte ha avuto modo di precisare che «l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale, per
violazione del principio di ragionevolezza, rende, tuttavia, necessario precisare che nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente
del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all’art. 180 comma 8, del codice della strada».
Con la conseguenza che nella sostanza il procedimento
di decurtazione dei punti è pressoché lo stesso, sia che si
tratti di persona fisica oppure di persona giuridica, risultando in entrambe le ipotesi applicabile una sanzione
pecuniaria in caso di inadempienza.
Ebbene, per verificare gli effetti della sentenza sulle
procedure di decurtazione dei punti è opportuno distinguere tre ipotesi diverse. La prima si ha quando il verbale di accertamento dell’illecito, contenente quindi la richiesta al proprietario del veicolo di segnalare l’effettivo
conducente, è stato notificato dopo la data di pubblicazione della sentenza (26 gennaio 2005). In questo caso,
come accennato, trova applicazione quanto affermato
dalla Corte costituzionale all’interno del punto 10 della
sentenza, e cioè che, se il proprietario omette di segnalare l’effettivo conducente, va incontro a una sanzione pecuniaria. È opportuno notare che l’intervento della Corte ha senza dubbio il carattere di una manipolazione additiva, ponendosi quindi il problema di stabilire l’am-
missibilità o meno di tale operazione. E stando alla ricostruzione della Corte, non v’è dubbio che l’intervento
della Corte sia legittimo, visto che ha ad oggetto una
sanzione pecuniaria rispetto alla quale non si estendono
i princìpi di garanzia, e quindi neppure quello della riserva di legge. E alla stessa conclusione, a nostro avviso, si
deve giungere anche se si muove dall’idea da noi prospettata secondo cui alle sanzioni punitive aventi carattere patrimoniale si estendono i princìpi di garanzia necessari per far esplicare alla sanzione lo stesso effetto preventivo: come accennato, infatti, il principio di riserva
di legge è del tutto estraneo a questa logica funzionale.
Solo se si muove da una concezione rigorosamente funzionale, quindi, si deve concludere che sentenze manipolative additive come quelle in esame non sono ammissibili neppure in ordine a illeciti puniti con la sanzione amministrativa a carattere patrimoniale.
La seconda ipotesi si ha quando il verbale di accertamento dell’illecito è stato notificato prima della data
di pubblicazione della sentenza, ma non è stata ancora
effettuata la comunicazione all’Anagrafe. Qui occorre
distinguere: se la mancata comunicazione alla Anagrafe
dipende da ragioni - per così dire - interne all’organo
competente, è chiaro che questi non dovrà più effettuare le relative comunicazioni. Se, invece, la mancata comunicazione dipende dal fatto che il proprietario non ha
compiuto la segnalazione, si pone di nuovo il problema
se a questi possa essere applicata subito la sanzione pecunicaria derivante dalla “precisazione” additiva della Corte costituzionale o se invece non si debba, come noi riteniamo, procedere a una nuova richiesta di segnalazione
dell’effettivo conducente, “minacciando” il proprietario
che in caso di inadempimento troverà applicazione una
sanzione pecuniaria.
Infine la terza ipotesi si ha quando la notifica è stata effettuata prima della pubblicazione della sentenza ed
è già stata eseguita la comunicazione all’Anagrafe o comunque è già stata notificata al proprietario l’avvenuta
decurtazione dei punti. In questo caso ci si chiede se i
punti tolti debbano essere restituiti e quindi in buona sostanza se la sentenza della Corte costituzionale abbia o
meno effetti retroattivi. Al di là dei notevoli problemi
tecnici che una tale operazione pone, per rispondere a
questa domanda occorre riferirci a quanto abbiamo detto in precedenza circa la natura della sanzione amministrativa, e sul punto è facile notare che anche muovendo
dalla concezione della Corte costituzionale si deve necessariamente concludere per la retroattività degli effetti della sentenza, in quanto la sanzione che si viene a colpire è una sanzione avente carattere personale, destinata
quindi a godere delle stesse garanzie prospettate per il diritto penale, compreso il principio di retroattività della
legge più favorevole desumibile dall’art. 3 Cost.
Nota:
(16) In argomento si consulti anche la circolare del Ministero dell’Interno, 4 febbraio 2005, n. 41236.
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1101
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
Diritto penale del lavoro
Omesso versamento di ritenute
ed appropriazione indebita
CASSAZIONE PENALE, Sez. Un., 19 gennaio 2005 (u.p. 27 ottobre 2004), n. 1327
Pres. Marvulli - Est. Fazzioli - P.m. Siniscalchi (diff.) - L. C., ricorrente (*)
Delitti contro il patrimonio mediante frode - Appropriazione indebita - Nozione di “cosa mobile altrui” - Omesso accantonamento presso la Cassa Edile di somme trattenute sulla retribuzione del dipendente - Reato - Esclusione - Illecito amministrativo di cui all’art. 8 l. 14 luglio 1959, n. 741 - Sussistenza
(Artt. 61 n. 11 e 646 c.p.; 8 l. 14 luglio 1959, n. 741)
Non può dirsi “cosa altrui” il denaro, destinato alla Cassa Edile, trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione del dipendente. Tale denaro, infatti, non fuoriesce mai dal patrimonio del datore di lavoro per divenire di proprietà del lavoratore. Il mancato accantonamento di tali somme presso la Cassa Edile, dunque, non
integra gli estremi del reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p., aggravato ex art. 61 n. 11 c.p.), ma
soltanto quelli della fattispecie di cui all’art. 8 l. 14 luglio 1959, n. 741 (mutata in mero illecito amministrativo dall’art. 13 d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758).
(Omissis).
1.1. Con sentenza del 7 maggio 2002 la corte d’appello
di Caltanissetta, accogliendo l’appello proposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Nicosia,
dichiarava L. C. A. responsabile del delitto di cui agli
artt. 81, 646, 61 n. 11, c.p. «perché in più occasioni
ometteva di versare somme che egli, quale imprenditore
edile, aveva trattenuto sugli stipendi dei lavoratori dipendenti per versarle alla Cassa Edile per ferie gratifica
natalizia e contributi» fino al giugno 1997 e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia.
Contro la sentenza il L. C., per mezzo del difensore, ha
proposto ricorso per cassazione, denunziando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1 e 8 legge 14 luglio 1959, n. 741, 646 c.p., 2 legge 12 settembre 1983,
n. 463.
Sostiene il ricorrente che non è ravvisabile il reato di appropriazione indebita per difetto del requisito della “altruità” della somma trattenuta dal datore di lavoro sulla
retribuzione dovuta al lavoratore. Infatti, essendo l’obbligazione del datore di lavoro un’obbligazione di genere, la proprietà delle somme da versare alla Cassa Edile si
trasferisce soltanto con la loro “individuazione” che si
avrebbe all’atto dell’effettivo versamento al lavoratore
od alla Cassa Edile della somma trattenuta sulla retribuzione.
Il fatto, quindi, integrerebbe soltanto la contravvenzione di cui agli artt. 1 ed 8, legge 741/1959, trasformata in
illecito amministrativo dall’art. 13 d. lgs. 19 dicembre
1994, n. 758; in subordine, potrebbe ipotizzarsi il delitto
di cui all’art. 2 d.l. 12 settembre 1983, n. 463, per il qua-
le, tuttavia, il ricorrente non sarebbe punibile, avendo
provveduto al versamento delle somme trattenute come
previsto dall’art. 1 d. lgs. 24 marzo 1994, n. 211 che ha
ulteriormente modificato l’originario dettato dell’art. 2
d.l. 463/1983.
1.2. La seconda Sezione, alla quale il ricorso è stato assegnato per competenza interna, ha rimesso con ordinanza del 20 maggio 2004 la decisione alle Sezioni Unite,
osservando che nella giurisprudenza di questa Corte sussiste un sostanziale contrasto in ordine alla determinazione del concetto di “altruità” delle somme o delle cose
oggetto del delitto di appropriazione indebita con specifico riferimento alle somme «trattenute dal datore di lavoro e destinate a terzi a vario titolo». Infatti, mentre nel
caso delle trattenute effettuate per fini previdenziali è
stata ritenuta la sussistenza del reato in esame, la ricorrenza del medesimo è stata esclusa per le trattenute effettuate per conto del fisco, pur non presentando i due
prelievi rilevanti differenze.
Aggiunge la sezione rimettente che, pur avendo il diritto penale caratteristiche proprie, il concetto di “altruità”
non può essere definito senza tenere conto almeno dei
principi generali del diritto civile, in considerazione della “unicità” dell’ordinamento.
Infine, qualora fosse ritenuta l’esistenza del reato di appropriazione indebita, sarebbe necessario verificare i
rapporti intercorrenti tra questo e le autonome figure
Nota:
(*) N.d.R.: v. già in questa Rivista, 2005, 282.
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1103
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
criminose previste dall’art. 2 comma 1 e 1-bis d.l. 12 settembre 1983, n. 463 e dagli artt. 1 e 8 legge 14 luglio
1959, n. 741.
Il Primo Presidente, con apposito decreto, ha assegnato
il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione
l’odierna udienza pubblica.
Considerato in diritto
2.1. La questione giuridica controversa che le Sezioni
Unite sono chiamate a risolvere è la seguente:
«Se integra il reato di appropriazione indebita aggravata
ex art. 61 n. 11 c.p. il mancato versamento delle somme
“trattenute” dal datore di lavoro sulla retribuzione del dipendente e da destinare alla Cassa Edile per ferie, gratifiche natalizie, festività, ovvero tale condotta integri soltanto l’illecito amministrativo previsto dagli artt. 1 e 8
della legge 14 luglio 1959, n. 741 e dall’art. 13 del d.lg.
19 dicembre 1994, n. 758».
Per la soluzione delle questione è necessario esaminare
previamente la natura e le modalità delle “trattenute” effettuate dal datore di lavoro nel caso di specie, approfondimento tanto più necessario in considerazione della
coesistenza, in ipotesi, di più disposizioni incriminatrici
applicabili.
Con la legge 14 luglio 1959, n. 741 il legislatore, al fine
di dare esecuzione all’art. 38 della Costituzione, delegava il Governo «ad emanare norme giuridiche aventi forza di legge, al fine di assicurare minimi inderogabili di
trattamento economico e normativo nei confronti di
tutti gli appartenenti ad una medesima categoria».
In esecuzione della delega, il Governo ha recepito, con
decreti presidenziali, nel corso degli anni gli accordi economici ed i contratti nazionali collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori. Tra questi, per il caso che ne occupa, debbono essere presi in esame i C.C.N.L. «per gli addetti
delle piccole e medie industrie edilizie ed affini», che,
con disposizione risalente e sostanzialmente immutata,
hanno previsto che al fine di assicurare «il trattamento
spettante agli operai per le ferie e per la gratifica natalizia» e festività infrasettimanali l’impresa è tenuta ad “accantonare”, mediante versamento alla Cassa Edile (od
ad altro istituto di credito che la riversi alla Cassa Edile ciò a seguito della dichiarazione di incostituzionalità delle disposizioni originarie: cfr. C. cost. 7 novembre 1994,
n. 258 - ) la somma corrispondente ad una percentuale
complessiva, calcolata su determinati “elementi” della
retribuzione, onde consentire la successiva corresponsione da parte delle Casse Edili (di solito costituite in ogni
provincia) delle somme spettanti a ciascun lavoratore
per ferie, gratifica natalizia e festività infrasettimanali
«alle scadenze e secondo le modalità (...) stabilite dagli
accordi locali»; ed altresì che, con il versamento della
percentuale alle Casse Edili «s’intendono integralmente
assolti gli obblighi a carico del datore di lavoro» per i
trattamenti economici cui i versamenti si riferiscono.
2.2. La giurisprudenza civile di legittimità, alla quale è
1104
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
necessario fare riferimento per la qualificazione dei rapporti derivanti dal C.C.N.L., ha escluso che la Cassa
Edile sia assimilabile «ad un ente previdenziale perché è
depositaria di somme da corrispondere agli aventi diritto
alla scadenza a titolo retributivo, sicché viene a svolgere
una funzione di intermediazione e non di previdenza ed
assistenza» (Cass., sez. lav., 19 aprile 2001, n. 5741) ed
ha affermato che «le somme che il datore di lavoro ha
l’obbligo di versare alla casse edili quali accantonamenti
al pagamento delle somme dovute per ferie, gratifiche
natalizie e festività infrasettimanali, costituiscono somme spettanti ai lavoratori a titolo retributivo», di guisa
che «il meccanismo previsto per il pagamento da parte
del datore di lavoro ed il conseguente diritto dei lavoratori, integra una delegazione di pagamento». Quindi, «la
cassa non diventa obbligata nei confronti del lavoratore
con il mero sorgere del rapporto di lavoro, bensì solo con
il pagamento da parte del datore, delle somme stesse»; e
di conseguenza «ben può il lavoratore agire nei confronti del datore di lavoro per il pagamento delle somme dovute per ferie, festività e gratifiche natalizie» (Cass., sez.
lav., 1° ottobre 2003, n. 14658).
La giurisprudenza civile di legittimità ha ritenuto pertanto che il lavoratore è titolare di un diritto di credito
nei confronti del datore di lavoro direttamente azionabile anche nel caso in cui quest’ultimo abbia omesso il versamento delle somme trattenute sulla retribuzione.
2.3. Con riferimento al delitto di appropriazione indebita ascritto al ricorrente, non essendo stata contestata la
sussistenza degli altri elementi costituivi del reato, l’indagine deve essere incentrata, come rilevato dalla Sezione remittente, sulla verifica della sussistenza del requisito della “altruità” delle somme trattenute dal datore di
lavoro.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria di legittimità
(condivisa da una parte della dottrina) il concetto di “altruità” nel delitto di appropriazione indebita non va determinato con riferimento all’istituto civile della “proprietà”, ma in base alla ratio della disposizione incriminatrice di volta in volta presa in esame, che per il reato
di cui all’art. 646 c.p. «deve essere individuata nella volontà del legislatore di sanzionare penalmente il fatto di
chi, avendo l’autonoma disponibilità della res, dia alla
stessa una destinazione incompatibile con il titolo e le
ragioni che giustificano il possesso della stessa, altresì nel
caso che si tratti di una somma di denaro» (Cass., sez. II,
3 marzo 1989, n. 11628, Barbuto).
Su tali presupposti è stato ritenuto - in una fattispecie
relativa ad omesso versamento di contributi in favore
della “Nuova Cassa Edile” (Cass., sez. II, 11 febbraio
1999, n. 5785, p.m. in proc. Visentin; conf. Sez. II, 27
giugno 2003, n. 30075, p.m. in proc. Gallini) - che “le
somme “trattenute” dal datore di lavoro sulla retribuzione del dipendente e destinate a terzi a vario titolo (per
legge, per contratto collettivo o per ogni altro atto idoneo a far sorgere nello stesso datore di lavoro un obbligo giuridico di versare somme per conto del lavoratore)
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
fanno parte integrante della retribuzione spettante al lavoratore come corrispettivo per la prestazione già resa;
tali somme, dunque, non appartengono più al datore di
lavoro, che ne ha solo una disponibilità precaria posto
che esse hanno una destinazione precisa, non modificabile unilateralmente in maniera lecita, ma vincolata ad
un versamento da effettuare entro un termine previsto a
garanzia del terzo e del lavoratore. Ne deriva che commette il reato di appropriazione indebita il datore di lavoro che scientemente lascia trascorrere il termine per
il versamento, manifestando la volontà di appropriarsi
di una somma non sua e di cui solo provvisoriamente
dispone”.
2.4. Le conclusioni cui giungono le sentenze Visentini e
Gallini non sono tuttavia condivise dal Collegio, sull’assorbente rilievo che esse, come osservato dalla Sezione
rimettente, sono incoerenti con il principio affermato
per l’analoga fattispecie delle ritenute sulle retribuzioni
effettuate dal datore di lavoro a favore dell’Erario.
Con riguardo a tali ritenute, il cui meccanismo è del tutto assimilabile a quello previsto per le trattenute sulla retribuzione da versarsi alle Casse Edili, va infatti rilevato
che con giurisprudenza costante (Cass., sez. II, 26 maggio 1983, n. 10667, Sdattrino, RV. 161665; Sez. II, 26
maggio 1983, n. 8780, Francino, RV. 160823; Sez. II, 26
maggio 1983, n. 9037, Montanari, RV.160912; Sez. II,
26 maggio 1983, n. 10437, Carion, RV. 161553; da ultimo, sez. III, 5 ottobre 2001, n. 39178, Romagnoli A.,
RV. 220359) è stata esclusa la configurabilità del reato di
appropriazione indebita, sia a danno dei lavoratori dipendenti, sia nei confronti dello Stato proprio sul presupposto della mancanza del requisito dalla “altruità”
delle somme trattenute.
Si è, al riguardo, considerato che il datore di lavoro, quale “sostituto d’imposta”, è debitore in proprio e non meramente responsabile per un debito altrui, per cui è direttamente e personalmente obbligato verso lo Stato per
le somme dovute dai lavoratori dipendenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche e da lui ritenute
sulla retribuzione. Pertanto, il mancato versamento all’erario da parte del datore di lavoro delle dette somme,
sulle quali non può configurarsi una titolarità attiva da
parte del lavoratore (liberato dall’obbligazione tributaria
a seguito della ritenuta effettuata), non integra il reato di
appropriazione indebita, la cui essenza consiste nella lesione del diritto di “proprietà” o di altro diritto reale mediante l’abuso di cosa o denaro altrui.
È agevole rilevare che le citate sentenze, mentre affrontano la natura del rapporto tra il datore di lavoro - sostituto di imposta e lo Stato e tra questo ed il lavoratore
contribuente, nulla dicono sul rapporto intercorrente tra
il datore di lavoro e il dipendente. La circostanza, infatti, che il datore di lavoro sia un sostituto di imposta e,
quindi, obbligato “direttamente e personalmente” nei
confronti dello Stato, non spiega la ragione per la quale
la somma da lui trattenuta sulle retribuzioni con l’obbligo di versarla allo Stato non venga considerata di “pro-
prietà” del lavoratore, pur non essendovi alcun dubbio
che la stessa viene trattenuta sulla sua retribuzione con
l’obbligo di versarla alle scadenze ad un terzo.
Né alcuna rilevanza può attribuirsi al fatto che il lavoratore è sciolto dall’obbligazione tributaria, in quanto la
liberazione dall’obbligo del versamento del tributo è
una conseguenza del fatto che la “ritenuta” è stata effettuata, e che, quindi, costui ha assolto al suo dovere di
contribuente, anche se per fatto a lui non imputabile la
somma non è confluita nelle casse dello Stato. E che la
liberazione sia la conseguenza dell’adempimento dell’obbligazione da parte del lavoratore risulta dal fatto
che il reato di cui all’art. 2, comma 2, d.l. 429/1982 è
configurabile soltanto per l’omesso versamento all’erario «delle ritenute effettivamente operate ... sulle somme pagate».
Va osservato che se la ragione per la quale è esclusa la
“altruità” della somma fosse quella della liberazione del
lavoratore dall’obbligo del pagamento del tributo, a
maggior ragione dovrebbe escludersi la sussistenza di tale requisito nel caso delle trattenute sulla retribuzione da
versarsi alle Cassa Edile (e delle ritenute per contributi
previdenziali) atteso che l’obbligazione grava sin dal suo
nascere unicamente sul datore di lavoro (anche per la
parte di contributi a carico del lavoratore).
In definitiva, la posizione del datore di lavoro - sostituto
d’imposta è completamente sovrapponibile a quella del
datore di lavoro che effettua le trattenute sulle retribuzioni per riversarle alla Cassa Edile, ed a maggior ragione
al datore di lavoro che effettua le ritenute dei contributi
previdenziali, in quanto, in ogni caso, si è in presenza di
un “accantonamento” di una somma determinata di denaro finalizzata ad un fine determinato da versarsi ad un
terzo alle scadenze stabilite.
2.5. In realtà, se si confrontano le fattispecie in esame
contraddistinte dalla comune caratteristica dell’obbligo
del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore la retribuzione al netto di “ritenute” a vario titolo effettuate
(per debito di imposta, per contributi previdenziali, in
forza di accordi economici o di contratti collettivi) con
gli altri casi di appropriazione indebita in cui è stata ritenuta la sussistenza del requisito della “altruità” del denaro o della cosa mobile, si rileva che la peculiarità è data
dalla circostanza che il denaro oggetto dell’appropriazione è rappresentato da una quota ideale del “patrimonio”
del possessore, indistinta da tutti gli altri beni e rapporti
che contribuiscono a costituirlo.
La somma “trattenuta” o “ritenuta” rimane, infatti, sempre nella esclusiva disponibilità del “possessore”, non
soltanto perché non è mai materialmente versata al lavoratore, ma soprattutto in quanto mai potrebbe esserlo,
avendo il dipendente soltanto il diritto di percepire la retribuzione al netto delle trattenute effettuate alla fonte
dal datore di lavoro.
Le “trattenute”, quindi, si risolvono a ben vedere in una
operazione meramente contabile diretta a determinare
l’importo della somma che il datore di lavoro è obbliga-
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1105
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
to a versare, in base ad una norma di legge o avente forza di legge, alla scadenza pattuita in conseguenza della
corresponsione della retribuzione.
Al contrario, in tutti gli altri casi trattati dalla giurisprudenza, il denaro o la cosa mobile di cui l’agente si appropria, non fanno mai parte ab origine del “patrimonio” del
possessore, ma si tratta sempre di denaro o di cose di
“proprietà” diretta od indiretta di altri, che pur confluendo per una determinata ragione nel “patrimonio”
dell’agente, non divengono, proprio per il vincolo di destinazione che le caratterizza, di sua proprietà, in deroga
- come espressamente previsto dall’art. 646 c.p. - ai principi del diritto civile in tema di acquisto della proprietà
delle cose fungibili (cfr. Cass., sez. II, 17 giugno 1977, n.
2445, Pomar, RV. 137092).
Sicché, ove l’agente dia alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo per cui la possiede, ovvero a richiesta o alla scadenza non restituisca la cosa o il
denaro, commette il reato di appropriazione indebita,
tutti casi, tradizionalmente individuati dalla giurisprudenza di legittimità, in cui la somma entra ab extrinseco a
far parte del patrimonio del possessore e con questo non
si confonde proprio perché connotata da un vincolo
specifico di destinazione.
Va rilevato, d’altra parte, che se l’appropriazione consistesse nel solo fatto «di chi, avendo l’autonoma disponibilità della res, dia alla stessa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che giustificano il possesso
della stessa, altresì nel caso che si tratti di una somma di
denaro» (Cass., sez. II, 3 marzo 1989, n. 11628, Barbuto,
cit.), non si comprenderebbe la ragione per la quale il
reato in esame dovrebbe essere escluso nell’ipotesi della
mancata corresponsione della retribuzione. Anche in
questo caso, infatti, potrebbe sostenersi che il denaro da
corrispondere alla scadenza al lavoratore ha una destinazione specifica prevista da una norma avente forza di legge, consistente nel C.C.N.L. recepito dal Governo al fine di garantire «minimi di trattamento economico e
normativo» ex art. 1 legge 741/1959.
Al quesito posto alle Sezioni Unite deve darsi, pertanto,
risposta negativa.
Sia per quanto concerne il caso di specie, che per quanto riguarda le altre analoghe forme di ritenute alla fonte,
il denaro “trattenuto” dal datore di lavoro al dipendente
rimane sempre nel “patrimonio” del datore di lavoro,
confuso con tutti gli altri diritti e beni che lo compongono. Il lavoratore, di conseguenza, non acquista alla scadenza la proprietà delle somme trattenute, ed il datore di
lavoro non perde la “proprietà” di tale somme, ma ha
soltanto l’obbligo, analogamente a quanto avviene per il
sostituto d’imposta, di versarle alla Cassa Edile ed agli
Enti di Previdenza nella misura ed alle scadenze previste
dalle singole disposizioni.
2.6. Questa conclusione comporta che il mancato versamento delle trattenute in percentuale da parte del datore di lavoro sulla retribuzione per il versamento alle Casse edili può configurare unicamente la infrazione ammi-
1106
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
nistrativa prevista dall’art. 13 d.lvo 19 dicembre 1994, n.
758, che ha sostituito integralmente l’art. 8 legge 14 luglio 1959, n. 741.
Deve al riguardo porsi in evidenza che, contrariamente a
quanto stabilito per «le ritenute previdenziali ed assistenziali» (art. 2, commi 1 e 2, d.l. 9 ottobre 1989, n. 338
che ha sostituito l’art. 2, comma 1, d.l. 12 settembre
1983, n. 463) e per «le ritenute effettivamente operate,
a titolo di acconto di imposta» (art. 2, comma 2 n. 4, d.l.
10 luglio 1982, n. 429, ora abrogato: Cass, sez. III, 5 ottobre 2001, n. 39178, cit.), l’omesso versamento della
“percentuale trattenuta” dal datore di lavoro sulla retribuzione per effetto degli accordi economici e del
C.C.N.L. non forma oggetto di una specifica fattispecie
penale.
Né può ritenersi applicabile la fattispecie speciale di cui
all’art. 2, comma 2, d.l. 463/1983, come modificato dall’art. 1 d.lgs. 211/1994: disposizione, questa, emanata al
fine di assicurare il tempestivo versamento da parte di
tutti i datori di lavoro, esclusi quelli agricoli, «entro termini uniformi», «(del)l’imposta sul valore aggiunto,
(del)le somme dovute quali sostituti d’imposta e (di)
quelle dovute a gestioni previdenziali ed assistenziali...».
Risulta infatti evidente che non può essere riconosciuto
alle Casse Edili natura di enti di previdenza e di assistenza, sia perché con la locuzione «gestioni previdenziali ed
assistenziali» il legislatore, come pacificamente ammesso, intendeva riferirsi agli enti di previdenza ed assistenza all’epoca esistenti, quali l’INPS, l’INAM, l’INAIL ed
altre gestioni speciali autonome; sia perché la trattenuta
effettuata a favore della Casse Edili non ha natura «contributiva previdenziale o assistenziale», ma di salario differito che trova la sua legittimazione in un accordo contrattuale (sia pure recepito formalmente in un atto avente forza di legge); sia, infine, perché le Casse Edili non
svolgono funzioni previdenziali ed assistenziali, ma di intermediazione tra datori di lavoro e lavoratori, secondo
gli approdi consolidati della giurisprudenza civile di legittimità.
La condotta in esame, quindi, integra esclusivamente
l’illecito di cui all’art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741,
che, con disposizione onnicomprensiva, punisce «il datore di lavoro che non adempie agli obblighi derivanti
dalle norme di cui all’art. 1 della presente legge», obblighi tra i quali deve senz’altro annoverarsi l’omesso versamento alla scadenza delle somme trattenute sulla retribuzione del lavoratore.
Con la conseguenza che, essendo stato trasformato tale
illecito in violazione amministrativa dall’art. 13 d.lgs. n.
758 del 1994, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
In forza della disposizione di carattere generale di cui all’art. 41 legge 24 novembre 1981, n. 689 va disposta la
trasmissione degli atti all’Autorità amministrativa competente.
(Omissis).
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
IL COMMENTO
di Antonio Vallini
La cosa “altrui” ex art. 646 c.p. è principalmente
quella soggetta ad un altrui diritto di proprietà. Rispetto al denaro, la norma incriminatrice si limita a
derogare a quella particolare ipotesi di acquisto della
proprietà che consiste nella c.d. “confusione”. Non
può dunque ritenersi “altrui” il denaro non acquisito
per “confusione”, ma sempre rimasto nel patrimonio
del possessore, come nel caso delle ritenute effettuate a vario titolo dal datore di lavoro sullo stipendio del
lavoratore.
Il ramo dell’edilizia si contraddistingue per una elevata mobilità interaziendale della manodopera, stante il
tipo di prestazioni richieste, di durata limitata e per opere predeterminate. Ad evitare che tali circostanze rendano difficoltosa una corresponsione continua e regolare di
determinate voci retributive, quali le gratifiche natalizie
ed il trattamento per ferie (1), il contratto collettivo nazionale del settore (2) ha istituito un particolare sistema
di “accantonamenti”, amministrato da un ente bilaterale (3) denominato “Cassa Edile”. Ogni mese le imprese
accumulano le somme destinate ai pagamenti in questione presso la locale Cassa, la quale, alle scadenze prefissate, provvede ad erogare agli operai quanto complessivamente dovuto (4).
Lungi dal fornire una prestazione di tipo previdenziale, la Cassa Edile s’atteggia dunque a mera intermediaria tra il datore di lavoro ed il dipendente nel versamento di parte della retribuzione (5). Sia che si individui
nell’istituzione di cui si discute una “depositaria” delle
somme (6), sia che si evochi lo schema della “delegazione di pagamento” di cui agli artt.1268 ss. c.c. (7), controparti all’interno del rapporto debito-credito continuano ad essere il datore di lavoro, da un lato, ed i lavoratori, dall’altro. Tanto che questi ultimi, in caso di mancato accantonamento, sono legittimati ad agire direttamente nei confronti del primo (8).
Interrogata circa il possibile rilievo penale dell’omesso versamento di quanto dovuto alla Cassa da parte
del datore di lavoro, in un primo momento la Cassazione risponde affermativamente, evocando la figura criminosa della “appropriazione indebita” (art. 646 c.p.; di solito unitamente all’aggravante di cui all’art. 61 n. 11, con
conseguente applicabilità dell’ultimo comma dell’art.
646 medesimo).
Le somme “trattenute” sugli stipendi - si dice - costituendo parte della retribuzione dovuta ad altri come
corrispettivo di una prestazione già resa, non appartengono (più) al datore di lavoro; egli ne ha soltanto una
«disponibilità precaria» (9), vincolata ad un pagamento
da effettuarsi entro precisi termini, a tutela dell’interesse
del lavoratore. Quel danaro, dunque, è “cosa mobile altrui”, perché destinata ad altri; la “disponibilità precaria”
delinea il requisito del “possesso”; il mancato pagamento
alla scadenza rappresenta l’atto “appropriativo”, nella
misura in cui attribuisce alla “cosa” una «destinazione
incompatibile con il titolo e le ragioni che giustificano il
possesso» (10).
Questa soluzione è coerente con quanto proposto
dalla stessa giurisprudenza di legittimità a proposito di un
Note:
(1) Se tali voci dovessero essere calcolate e versate distintamente rispetto ad ogni singolo rapporto contrattuale, si disperderebbero in una pluralità di somme in sé minime (dunque di difficile erogazione), al cui pagamento sarebbe obbligata una pluralità di datori di lavoro.
(2) V. da ultimo l’art. 37 c.c.n. l. 29 gennaio 2000.
(3) Ovvero gestito pariteticamente dalle organizzazione locali dei datori
di lavoro e da quelle dei lavoratori.
(4) Per ulteriori approfondimenti sulla natura e le funzioni delle Casse
Edili, si rinvia al sito web ww.cnce.it; v. poi A. Rondo, Accantonamenti
presso le casse edili: retribuzione o atti di previdenza privata?, in Lav. giur.,
2001, 658 ss.; M. Correale, L’obbligatorietà dei versamenti alla Cassa Edile,
in Arch. civ., 2000, 21.
(5) Cfr. G. Pera-M. Papaleoni, Diritto del lavoro, 7a ed., Padova 2003,
561. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è concorde: Cass., Sez. lav.,
19 aprile 2001, n. 5741, Palladino c. D’Acunti, in C.E.D. Cass., n.
546064; Cass., Sez. lav., 10 febbraio 1987, n. 1442, Soc. Nicolosi c. Cassa Edile A.M.I.LA, ivi, n. 450898; Cass., Sez. lav., 11 gennaio 1988, n. 77,
Cassa Edile Capitan c. Soc. segn. strad., ivi, n. 456732; Cass., Sez. lav., 1°
ottobre 2003, n. 14658, Cascato c. Branchina, ivi, n. 567280. Inquadra
invece i versamenti alla Cassa edile nel contesto di un “rapporto previdenziale facoltativo”: Trib. Modena, 22 settembre 2000, Cassa Edile Modena c. Fallimento F.lli Nappa s.n.c., in Lav. giur., 2001, 657, con nota critica di A. Rondo. In generale, sulla nozione di “retribuzione”, v. da ultimo
e per tutti O. Mazzotta, Diritto del lavoro, 2a ed., Milano, 2005, 583 ss.
(6) Cfr. Cass. civ., Sez. lav., 11 gennaio 1988, n. 77, cit.; Cass. civ., Sez.
lav., 19 aprile 2001, n. 5741, cit.
(7) Cass. civ., Sez. lav., 1° ottobre 2003, n. 14658, cit.
(8) Cass. civ., Sez. lav., 1° ottobre 2003, n. 14658, cit.
(9) Cass., Sez. II, 7 maggio 1999, Visentin, in Cass. pen., 2000, 1937, con
nota di P. Palladino, Appropriazione indebita e omesso versamento contributivo: ancora dubbi mentre la Cassazione conferma il proprio orientamento;
Cass., Sez. II, 17 luglio 2003, Vecchio, in Dir. pratica lav., 2003, 35, 2410;
Cass., Sez. II, 23 novembre 1993, Giallini, in Cass. pen., 1995, 1504;
Cass., Sez. II, 6 ottobre 1987, Ratini, in C.E.D. Cass., n. 176762.
(10) Per questa nozione di “appropriazione” v. già, tra le tante, Cass., Sez.
II, 24 febbraio 1971, Locatelli, in C.E.D. Cass., n. 116818 (ove si equipara alla attribuzione di una destinazione incompatibile con il titolo del
possesso anche la deliberata mancata restituzione della cosa: negli stessi
termini Cass., Sez. VI, 30 gennaio 1974, Di Stefano, in C.E.D. Cass., n.
126048); Cass., Sez. II, 7 settembre 1989, Barbuto, in Riv. pen., 1990,
563.
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1107
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
fenomeno dalle dinamiche analoghe: il mancato versamento all’ente previdenziale (INPS) delle trattenute
operate a tal fine sullo stipendio del lavoratore. Anche a
questo riguardo il datore di lavoro viene ritenuto “mero
depositario” di somme “altrui” perché comunque ormai
“di spettanza” del lavoratore. Non eseguendo il pagamento, egli realizza quella “interversione del possesso”
che concretizza lo schema tipico del reato di cui all’art.
646 c.p. (11).
A diverse conclusioni la Suprema Corte perviene,
invece, rispetto ad un’ulteriore ipotesi, pur assai simile a
quelle di cui s’è detto: quella del datore di lavoro-sostituto di imposta che non versi all’erario le c.d. “ritenute fiscali”. In varie sentenze (12) si è infatti osservato come,
nei confronti dell’erario, il sostituto di imposta sia debitore “in proprio”, e non già responsabile di un pagamento da compiere per conto di altri. Con l’effettuazione
della ritenuta, infatti, si estinguono ope legis sia l’obbligazione del datore di lavoro nei confronti del lavoratore
(almeno per la somma oggetto di ritenuta) sia quella del
lavoratore, per il reddito prodotto, nei confronti dell’amministrazione finanziaria; residua soltanto, per l’appunto, l’obbligo personale del datore di lavoro nei confronti di quest’ultima (13).
La “disparità di trattamento” tra l’ultima classe di
casi e le prime due è parsa delineare, alla Sezione II della Cassazione (chiamata a pronunziarsi su di un ennesimo caso di omesso accantonamento delle ritenute destinate alla Cassa Edile), un dissidio giurisprudenziale meritevole d’essere risolto dalle Sezioni Unite, poi effettivamente intervenute in materia con la sentenza in epigrafe (14).
Sennonché, di un dissidio forse solo apparente si
trattava: tutte queste decisioni attribuiscono credito, difatti, alla medesima nozione non civilistica di “altruità” (e
più in generale di tutti gli altri elementi del reato di cui
all’art. 646 c.p.).
Il privatista altro non vedrebbe, nelle situazioni prese in esame, se non una complessa trama di rapporti obbligatori (tra il datore di lavoro e il lavoratore; tra il datore di lavoro e la Cassa edile, l’ente previdenziale, l’erario; tra questi ultimi soggetti ed il lavoratore, se del caso),
ma mai penserebbe di qualificare il potere che il datore
di lavoro ha sul denaro nei termini di un mero “possesso”
di una cosa “altrui”: di quelle somme il datore di lavoro è
e resta proprietario, non avendo egli realizzato alcun atto o negozio idoneo a trasferire il proprio diritto soggettivo.
Il diritto penale, tuttavia - sembra(va) volerci dire
la Cassazione - non deve lasciarsi fuorviare da “formalismi” che acquistano un senso soltanto ai fini specifici di
altre discipline: è necessario badare alla “sostanza” dei
valori e degli interessi concretamente in gioco. Adottando questa visuale, le decisioni in esame arrivano ad
intravedere nel paradigma della “trattenuta non versata”
i tratti - mutatis mutandis - della seguente e più “pacifica”
ipotesi di appropriazione indebita: Tizio affida una som-
1108
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
ma di denaro a Caio affinché questi la utilizzi per determinati pagamenti da effettuarsi nell’interesse di Tizio
medesimo, ed invece Caio trattiene presso di sé quanto
ricevuto, senza assolvere all’impegno assunto. Certo: nei
casi in discussione non si intravede alcuna materiale
consegna di danaro da Tizio (il lavoratore) a Caio (il datore di lavoro), ma ciò solo perché il secondo è a sua volta debitore del primo (in virtù del rapporto di lavoro) per
una certa somma di danaro (la retribuzione), di modo
che l’“affidamento” del danaro al secondo da parte del
primo si risolve in una mera operazione contabile (Caio
paga a Tizio meno di quel che gli deve; la differenza - le
c.d. “ritenute” - corrisponde a ciò che Tizio gli “affida”
per operare i pagamenti di cui si è detto). La sostanza,
però, non cambia.
Se poi nell’ipotesi del datore di lavoro-sostituto di
imposta la Cassazione nega la sussistenza dell’appropriazione indebita, è sempre per l’attenzione dedicata ai riverberi effettivi della vicenda concreta: le ritenute a fini
fiscali, per vero, estinguono ipso facto, una volta operate,
l’obbligo che il lavoratore ha nei confronti dell’erario;
dal punto di vista del lavoratore, dunque, è come se (volendo insistere nella similitudine) Caio avesse già effettivamente compiuto il pagamento al quale era obbligato
per conto di Tizio.
Rispetto a questo modo d’affrontare la problematica in esame sono state avanzate, in dottrina, essenzialmente due obiezioni.
Note:
(11) Cass., Sez. II, 12 settembre 1970, Marzano, in C.E.D. Cass., n.
115348; Cass., Sez. II, 23 aprile 1983, Magnelli, in Cass. pen. 1984, 2166,
con nota di T. Camelio, Appropriazione indebita e violazione amministrativa
nell’omesso versamento delle ritenute previdenziali a carico del lavoratore. Più
di recente l’assunto viene confermato da alcuni obiter dicta contenuti in
Cass., Sez. Un., 26 giugno 2003, Silvestri, in Dir. giust., 2003, 33, 10, con
nota di C. Cardarello.
(12) Cass., Sez. II, 3 dicembre 1983, Carion, in Giust. pen., 1984, II, 687;
Cass., Sez. II, 10 dicembre 1983, Sdattrino, in C.E.D. Cass., n. 161665;
cfr. anche Cass., Sez. II, 20 ottobre 1983, Francino, in Riv. pen., 1984,
501; Cass., Sez. II, 27 ottobre 1983, Montanari, in C.E.D. Cass., n.
160912; Cass., Sez. III, 5 ottobre 2002, Romagnoli, in Arch. n. proc. pen.,
2002, 205, e in Giur. imp., 2002, 1449, con nota sostanzialmente adesiva
di G.L. Soana, Omesso versamento delle ritenute e delitto di appropriazione indebita.
(13) Dissente da questa impostazione App. Torino, Sez. I, 23 novembre
1981, Botta, in Riv. it. dir. proc. pen. 1982, 1247, con nota di Aless. Rossi, Considerazioni sulle conseguenze penali degli omessi versamenti all’Erario
dell’I.V.A. e della ritenuta d’acconto da parte dei soggetti obbligati: se si postula una nozione di “altruità” del danaro come spettanza ad altri di certe
somme, deve riconoscersi che la «titolarità attiva sul denaro depositato
presso il datore di lavoro spetta al lavoratore sino al momento del versamento, ed allo Stato da quel momento in poi». V. anche Alb. Rossi, Irrilevanza penale dell’omesso versamento delle ritenute?, Il Fisco, 2002, 15,
2284: a parere dell’A., dalla giurisprudenza della sezione tributaria della
Suprema Corte si dedurrebbe che, nell’ipotesi di ritenuta d’acconto, debitore IRPEF resta il dipendente, mentre il datore di lavoro assume le vesti di un coobbligato in solido. Questa ricostruzione viene smentita, con
ampie e convincenti argomentazioni, da G.L. Soana, op. cit., 1458 ss.
(14) Per un primo commento, v. F.M. Ferrari, La nozione di possesso non
cambia pelle nel passaggio dal campo civile al penale, in Dir. giust., 2005, 5, 38
ss.
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
In primo luogo si è lamentata una difettosa comprensione dell’assetto di interessi espresso, in particolare,
dal caso del mancato versamento delle ritenute previdenziali. Questa situazione, si sostiene, presenterebbe
analogie ben più significative con l’ipotesi del datore di
lavoro-sostituto di imposta inadempiente che non con
quella, contrapposta, del datore di lavoro che non accantoni parte dell’altrui retribuzione (15). Basti questo
breve cenno: tale opinione poco rileva in questa sede,
visto che essa si rivolge ad uno specifico sviluppo applicativo (diverso da quello di nostro immediato interesse)
di un paradigma esegetico di cui, comunque, non si mette in dubbio la struttura portante.
Ben altro rilievo, nell’economia di questo commento, riveste invece una seconda obiezione, direttamente rivolta alla stessa nozione di “cosa mobile altrui”
adottata dalla Cassazione. Si osserva: comunque vengano intesi i rapporti tra datore di lavoro, lavoratore ed
ente terzo (o erario), deve negarsi in ogni caso l’altruità
delle somme “trattenute”, giacché queste mai divengono di proprietà del lavoratore. Esse possono certo considerarsi di “spettanza” di quest’ultimo, ma tanto non basta ad affermarne l’“altruità”, altrimenti l’inadempimento ad una qualsiasi obbligazione di “dare” dovrebbe
essere qualificato, solo perché tale, come appropriazione
indebita (16).
È proprio a questa ricostruzione critica che paiono
ispirarsi le Sezioni Unite nella sentenza che qui si commenta. Affermano, infatti, che «sia per quanto concerne
il caso di specie, che per quanto riguarda le altre analoghe forme di ritenute alla fonte, il denaro ‘‘trattenuto’’
dal datore di lavoro al dipendente» non può dirsi “altrui”, perché esso «rimane sempre nel ‘‘patrimonio’’ del
datore di lavoro, confuso con tutti gli altri diritti e beni
che lo compongono […]. Il lavoratore, di conseguenza,
non acquista alla scadenza la proprietà delle somme trattenute, ed il datore di lavoro non perde la ‘‘proprietà” di
tale somme, ma ha soltanto l’obbligo, analogamente a
quanto avviene per il sostituto d’imposta, di versarle alla
Cassa edile ed agli Enti di previdenza nella misura ed alle scadenze previste dalle singole disposizioni». Altrimenti opinando, si aggiunge, «non si comprenderebbe la
ragione per la quale il reato in esame dovrebbe essere
escluso nell’ipotesi della mancata corresponsione della
retribuzione».
L’accoglimento di una nozione “dinamica”
di “altruità” del denaro
Da una visione, per così dire, “sostanzialistica” degli
estremi dell’appropriazione indebita - quale è quella che
ispira la precedente giurisprudenza di legittimità - sembra passarsi d’un colpo, con la sentenza in commento
delle Sezioni Unite, ad una formale identificazione dell’altruità con la altrui proprietà. Un’inversione di rotta
sulla cui portata e sulle cui ragioni di fondo merita soffermarsi con attenzione. In primo luogo sgombrando il
campo da ogni possibile fraintendimento.
È bene infatti precisare sin da subito che le Sezioni
Unite non operano affatto un’inaspettata rivalutazione
di quella concezione c.d. “pancivilistica” dei reati contro il patrimonio, stando alla quale ogni analogia terminologica tra disposizione incriminatrice e specifici istituti di diritto privato (possesso, proprietà ecc.) andrebbe intesa sic et simpliciter come un rinvio senza filtri alla
relativa disciplina ed alle relative definizioni di diritto privato (17).
Di tale impostazione, invero, da tempo sono stati
evidenziati i limiti, nella misura in cui essa risente di superate visioni penologiche (in particolare quella c.d.
“sanzionatoria”). È oggi un dato acquisito che ogni ambito del diritto risponda ad esigenze diverse e diversi fini
persegua, sì da apparire sconsigliabile l’acritica trasposizione delle categorie proprie di una disciplina all’interno
degli schemi operativi dell’altra (18).
Le Sezioni Unite, dal canto loro, si guardano bene
dal prendere posizione sul problema “generale” dei rapporti tra diritto penale e diritto privato. D’altra parte,
neppure la passata giurisprudenza presupponeva, di necessità, un’adesione alla speculare ed egualmente drastica impostazione “autonomista”, in virtù della quale il significato della norma penale deve essere sempre e comunque ricostruito prescindendo dalle norme non penali pur all’apparenza evocate (19) (approccio a sua volta difficilmente condivisibile, non essendo verosimile
che l’ordinamento penale, nel momento stesso in cui diNote:
(15) L’idea che le somme trattenute per essere versate all’INPS rappresentino parte ideale della retribuzione costituirebbe il sedimento d’una
ormai superata accezione “lavoristica” del rapporto previdenziale (cfr.
R.Mancuso, voce Contribuzione nel diritto della sicurezza sociale, in Dig. disc. priv., Sez. comm., IV, 1989, 133). Da preferire sarebbe invece la diversa “concezione tributarista”, stando alla quale il datore di lavoro è direttamente vincolato nei confronti dell’ente previdenziale da un’obbligazione contributiva, il cui ammontare viene calcolato prendendo a parametro, tra gli altri, (una quota del)la retribuzione dovuta al lavoratore. Il lavoratore è dunque estraneo al rapporto contributivo anzidetto; egli è,
piuttosto, beneficiario delle prestazioni erogabili dall’Ente nel contesto di
un diverso ed autonomo rapporto di tipo (questo sì) “previdenziale”. Adottando una simile prospettiva, in effetti, non appare più lecito ragionare
“come se” il lavoratore affidasse del denaro al datore di lavoro ai fini di un
determinato pagamento. Il lavoratore, infatti, non deve effettuare alcun
pagamento (non è obbligato rispetto all’ente), e la sua retribuzione non è
“decurtata” della somma che il datore di lavoro pagherà, costituendo solamente una base numerica per calcolare l’ammontare di un debito personale del datore di lavoro medesimo. V. P. Palladino, op. cit., 1940 ss.; T.
Camelio, op. cit., 2168 s.; F. Mucciarelli, Qualche osservazione sulla natura
istantanea o permanente del delitto di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1984, 1207.
(16) In dottrina: T. Camelio, op. cit., 2169 s. In giurisprudenza: Pret. Milano, 6 maggio 1985, Canchero e altro, in Riv. giur. lav. prev. soc., 1985,
IV, 343 ss.
(17) In Italia tale impostazione è sostenuta, ad es., da A. Rocco, L’oggetto
del reato e della tutela giuridica penale. Contributo alle teorie generali del reato
e della pena, Milano-Torino-Roma, 1913, 49 ss.
(18) Per tutti F. Mantovani, Diritto penale. Delitti contro il patrimonio, 2a
ed., Padova, 2002, 15.
(19) In tal senso v. ad es. G. Maggiore, Diritto penale, II, 2, Bologna, 1948,
903.
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1109
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
sciplina relazioni comunque di carattere patrimoniale,
oltretutto ricorrendo ad una terminologia di innegabile
ascendenza civilistica, intenda programmaticamente
sovvertire assetti e significati che di certe locuzioni e di
certi rapporti il diritto privato disegna) (20).
La contrapposizione tra le pregresse tendenze giurisprudenziali e la decisione in esame sembra svolgersi in
una prospettiva, se vogliamo, più “minimalista”: ci si interroga su quali siano le soluzioni più corrette, nella visuale di un’interpretazione teleologica d’una specifica disposizione incriminatrice, rispetto ad una classe peculiare di “casi concreti”. In sostanza, tanto la sentenza che
qui si commenta, quanto quelle che essa mira a superare,
meglio si prestano ad essere intese come espressione di
quell’opzione metodologica - chiamiamola “esegeticosperimentale” (21) - che oggi riscontra maggiori consensi in dottrina, stando alla quale l’operatore del diritto,
lungi dal prestar inflessibile omaggio a questa o quella visione di principio delle interrelazioni tra diritto penale
ed altre branche dell’ordinamento, deve limitarsi a valutare quanto una certa scelta interpretativa sia opportuna
e plausibile in rapporto alla portata testuale della norma
incriminatrice ed allo specifico orientamento di tutela
che essa sottende (22).
Sennonché, anche qualora dovessimo riconoscere
nella decisione in esame una predilezione per un rapporto simmetrico tra “altruità” e “proprietà di terzi”, espressa con limitato riferimento ai casi concreti di cui si discute, nel contesto di un’interpretazione del solo art. 646
c.p., non potremmo esimerci dal manifestare comunque
qualche perplessità.
V’è da premettere che un tale “rapporto simmetrico” non appare suggerito dal testo dell’art. 646 c.p.: al
termine “altruità” non corrisponde un significato tecnico-civilistico particolare, e tantomeno quel termine
esprime un richiamo puntuale ed esclusivo all’istituto
della proprietà (23).
Per il resto, chi propone un’argomentazione
“orientata alle conseguenze” è solitamente propenso a
smentire, più che a confermare, che “altruità” significhi “altrui proprietà”. Diversamente opinando, si osserva, bisognerebbe considerare estranee all’ambito applicativo della norma incriminatrice una serie di situazioni fattuali che esprimono invece chiaramente il disvalore tipico dell’appropriazione indebita (si pensi, una
per tutte, all’ipotesi dell’appropriazione di cose ricevute per errore) (24). V’è da dire, con tutta onestà, che
questo modo di procedere non appare del tutto persuasivo, perché in qualche misura tautologico: se l’interpretazione di una norma incriminatrice è (come pare
dover essere) funzionale alla successiva individuazione
del relativo ambito applicativo, non può essere la previa definizione di tale ambito applicativo ad orientare
l’interpretazione (25).
Determinante, ai nostri fini, appare piuttosto una
seconda argomentazione. Si osserva: se vogliamo realmente intendere il “possesso di cosa mobile altrui” quale
1110
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
sinonimo di “possesso di cosa mobile di proprietà altrui”,
una tale situazione mai sarebbe configurabile a proposito
del possesso di denaro, per il semplice fatto che tale peculiare “bene fungibile”, una volta “confuso” col patrimonio di chi lo possiede, diviene ipso facto di “proprietà”
di questi (26). Sennonché, è lo stesso legislatore a contemplare l’ipotesi di un’appropriazione indebita avente
Note:
(20) G. Marini, Delitti contro il patrimonio, Torino 1999, 15. Una critica
più articolata in P. Nuvolone, Il possesso nel diritto penale, Milano, 1942, 50
ss.
(21) Terminologia di P. Nuvolone, op. cit., 42, ripresa da F. Mantovani,
op. cit., 16.
(22) V., tra i tanti (con diversità di accenti): F. Antolisei, Manuale di Diritto penale, Parte speciale, I, 14ª ed., Milano, 2002, 270 s.; A. Carmona,
Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo, Bologna, 1996, 152; G.
Fiandaca-E. Musco, Diritto penale, Parte speciale, II, 2, I delitti contro il patrimonio, 3a ed., Roma, 2002, 22; G. Marini, op. cit.,16; V. Militello, voce
Patrimonio (delitti contro il), in Dig. disc. pen., IX, 1995, 280 s.; C. Pedrazzi, voce Appropriazione indebita, in Enc. dir., II, 1958, 834; B. Petrocelli,
L’appropriazione indebita, Napoli, 1933, 81 ss.; R. Rampioni, voce Possesso
(dir. pen. ), in Enc. Dir., XXXIV, 1985, 522 ss. Importanti precisazioni in
S. Moccia, Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali, Padova,
1988, 71 ss., e in P. Nuvolone, op. cit., 57 ss. (sul concetto di “funzione”
della norma da prendere a riferimento nell’interpretazione).
(23) Ampiamente, sul punto, A. Pagliaro, L’altruità della cosa nei delitti
contro il patrimonio, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1965, 700 ss.; v. anche
G.Fiandaca-E.Musco, op. cit., 30.
(24) A. Pagliaro, op. cit., 713; Id., voce Appropriazione indebita, in Dig. disc. pen., I, 1987, 231.
(25) Secondo A. Carmona, op. cit., 162, ad es., pensare l’altruità soltanto
in termini “civilistici” di proprietà significa determinare «aree rilevanti di
non-contenuto del sistema nei confronti di condotte, per ogni altro
aspetto, formalmente tipiche e fortemente lesive di reali interessi patrimoniali»; è evidente peraltro che, così ragionando, la “tipicità” è la premessa, non l’esito, dell’atto interpretativo. Per quanto indubbiamente
suggestivo, non convince appieno neppure l’altro argomento proposto
dallo stesso Autore. Egli sostiene che estromettere il proprietario della cosa dall’ambito dei possibili soggetti attivi del reato, vuol dire ipotizzare un
diritto penale che favorisce a priori la proprietà, anche quando essa si muti in abuso ai danni di altri soggetti titolari comunque di un interesse qualificato al godimento della cosa, dimenticando che la Costituzione valorizza sì la proprietà, ma allo scopo di favorirne la funzione sociale. Nondimeno, vincolare al concetto di altrui proprietà la nozione di altruità, non
significa affatto tutelare il proprietario che abusi del suo diritto; vuol dire,
ben diversamente, sostenere che certe tipologie di condotta - danneggiamento, sottrazione, appropriazione - possono essere rilevanti come reati
contro il patrimonio soltanto quando non concernano beni appartenenti al
soggetto attivo. In mancanza di questo presupposto, potranno comunque
dirsi integrate altre fattispecie criminose, meglio espressive della tipologia
d’offesa comunque riscontrabile nel caso concreto (offesa all’altrui libertà,
all’altrui domicilio, ecc.).
(26) A parere di M. Bianca, Diritto civile, VI, La proprietà, Milano, 1999,
392 s., tale pacifica regola andrebbe ricondotta al più generale istituto della “commistione” (art. 939 c.c.), e tuttavia meriterebbe d’essere autonomamente definita come “confusione”, avendo di caratteristico - rispetto
alla commistione - di non dar vita ad una comproprietà: «la regola della
confusione si applica anche al denaro, il quale passa in proprietà di chi lo
percepisce, diventando parte indistinta del suo patrimonio. Non vi è luogo alla formazione di una comunione poiché il denaro non rileva per la
sua materialità ma per il suo valore, concorrendo a formare un’entità contabile, la liquidità pecuniaria, generalmente costituita da diritti di credito. In mancanza di un atto di pagamento, l’acquisto del denaro è a titolo
originario, e comporta l’obbligo di indennizzo secondo la regola della confusione».
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
ad oggetto danaro altrui; ergo, la nozione di altruità, almeno con riferimento al danaro (ma è proprio questo il caso che qui interessa) deve essere concettualmente scissa dalle regole civilistiche in tema di acquisizione e trasferimento
della proprietà (27).
Orbene: da un’attenta lettura si ricava che le Sezioni Unite sono ben consapevoli di quanto s’è appena
constatato. In un passo della sentenza, difatti, si riconosce espressamente all’art. 646 c.p. la capacità di derogare
alle «regole civilistiche in tema di acquisto della proprietà delle cose fungibili» (28).
La decisione in esame, in conclusione, non propugna affatto una inflessibile corrispondenza tra l’aggettivo
“altrui” e l’individuazione di un formale diritto di proprietà in capo a terzi, neppure nella limitata visuale di
una interpretazione orientata alle conseguenze. Il proprium della presa di posizione della Suprema Corte sta altrove, e con esso è il caso, finalmente, di confrontarsi.
Il discrimine tra altruità e non altruità del danaro
viene tracciato valorizzando, in termini innovativi, il
profilo del trasferimento effettivo e preliminare del possesso.
Laddove venga consegnato danaro ad un terzo acciocché se ne faccia un determinato uso nell’interesse del tradens, nella visuale penalistica l’appartenenza del denaro
a quest’ultimo non viene meno, di talché il consegnatario ben può dirsi investito del possesso di somme “altrui”;
tuttavia, se non avviene alcun processo di materiale dislocazione della disponibilità del danaro, questo è e resta di chi
lo possiede e lo ha sempre posseduto. Un possesso di
somme di danaro altrui è insomma prospettabile, precisano le Sezioni Unite, solo qualora «la somma entra ab
extrinseco a far parte del patrimonio del possessore e con
questo non si confonde proprio perché connotata da un
vincolo specifico di destinazione».
Nessuna acritica subordinazione, dunque, alle categorie del diritto civile in tema di proprietà; a delinearsi è,
piuttosto, una particolare nozione penalistica di “altruità” del danaro, che prende sì in considerazione il rapporto giuridico intercorrente tra i soggetti coinvolti, ma
per valorizzarne la dimensione dinamica (la materiale
consegna del danaro da parte di terzi), più che i risvolti
statici e formali (il nomen juris del rapporto tra soggetto attivo e passivo e dei rispettivi diritti).
Si tratta d’una soluzione che può apparire singolare,
di primo acchito, ma che riteniamo opportuno condividere. Vediamo perché, procedendo con ordine.
graverebbe sulle singole specie, ma sulla quantità astrattamente considerata (29): è il caso, per l’appunto, di
somme “destinate” alla retribuzione del lavoratore, ma
rimaste in possesso del datore di lavoro).
Al posto di un rigido riferimento alle categorie e alle norme del diritto civile, questa tesi propone un criterio elastico, incentrato sull’individuazione di un “nucleo
di interesse”, non meglio definito, alla cui soddisfazione
sarebbe volto un “vincolo di destinazione” - anch’esso
non meglio definito - gravante sulla cosa. Così opinando, però, i nodi vengono al pettine.
A questa impostazione si è rimproverato di determinare una dilatazione incontrollabile della fattispecie di
appropriazione indebita. Se per “interesse” finale rilevante si intendesse anche quello non tutelato dal diritto, il
reato apparirebbe riscontrabile finanche rispetto a condotte non costituenti illecito extrapenale: un esito palesemente assurdo. Ma anche a limitare l’ambito dei “vincoli” e degli “interessi” significativi a quelli, e solo a quelli, oggetto di tutela giuridica, comunque quel “vincolo di
destinazione” che rende la cosa “altrui” appare riscontrabile in ogni obbligazione civilistica di “dare” o “restituire”, in
quanto tale (30). Di questo inconveniente già s’è fatto
cenno, così come già s’è fatto cenno all’esemplificazione
al proposito compiuta dalle Sezioni Unite (31).
Questo è il punto: la posizione adottata dalla precedente giurisprudenza, nella sua propensione a liberare la
nozione di “altruità” da vincoli definitori di matrice privatistica, paradossalmente perviene a risultati maggiormente
pregni di “pancivilismo” (ovvero meno rispettosi del principio di frammentarietà) che non la contrapposta impostaNote:
(27) Da tale pacifica constatazione gli interpreti traggono conclusioni
differenziate. Da un lato v’è chi sostiene che, se “altrui” non può voler dire “di altrui proprietà” rispetto al danaro, identico significato lo stesso aggettivo dovrà mantenere rispetto ad una qualsiasi altra “cosa mobile” oggetto del reato (A. Pagliaro, L’altruità, cit., 712 s.). Dall’altro lato si osserva invece che, se la nozione di altruità fosse sempre e comunque scissa da
quella di proprietà, nessun senso avrebbe, nella norma, l’autonoma menzione del “denaro”, essendo quest’ultimo concettualmente già compreso
nel più generale elemento “cosa mobile”. Se invece si presuppone che
“altruità” significhi “altrui proprietà”, la precisazione operata dal legislatore acquista un senso: per l’appunto quello di rendere inoperante, rispetto al denaro, il principio della “confusione” (F. Antolisei, Manuale di diritto penale, Parte speciale, I, 14ª ed., Milano, 2002, 338).
(28) In tal senso v. già, ad es. Cass., Sez. I, 13 ottobre 1977, Pomar, in
C.E.D. Cass., n. 137092; Cass., Sez. II, 3 marzo 1989, Barbuto, cit.
(29) V. in particolare C. Pedrazzi, Appropriazione, cit., 841.
Il paradosso delle impostazioni c.d. “autonomiste”
(30) A. Pagliaro, L’altruità, cit., 715 s.
Sostenere che “altruità”, nel contesto dell’art. 646
c.p., non può voler dire “altrui proprietà” (almeno rispetto al danaro), non comporta affatto un’adesione a
quella visuale - pur autorevolmente patrocinata in dottrina, e (come si è visto nel primo paragrafo) spesso adottata dalla giurisprudenza - secondo la quale “altrui” sarebbe la cosa sottoposta ad un “vincolo di destinazione
attuale a uno scopo cui altri ha interesse” (laddove si
tratti di bene fungibile, tale vincolo di destinazione non
(31) La riproponiamo più nel dettaglio: se l’appropriazione consistesse
nel solo fatto «di chi, avendo l’autonoma disponibilità della res, dia alla
stessa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che giustificano il possesso della stessa, altresì nel caso che si tratti di una somma di
denaro», non si comprenderebbe la ragione per la quale il reato in esame
dovrebbe essere escluso nell’ipotesi di mancata corresponsione tout court
della retribuzione. Anche in questo caso, infatti, ben può sostenersi che il
denaro da erogare abbia una destinazione specifica prevista da una norma
avente forza di legge, «consistente nel Ccnl recepito dal Governo al fine
di garantire “minimi di trattamento economico e normativo” ex art. 1
legge n. 741/1959».
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1111
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
zione che connette il concetto di “altruità” a quello di “proprietà di altri”. In questa prospettiva solo all’apparenza
“autonomista”, infatti, l’ambito della disposizione incriminatrice di cui si discute finisce col comprendere indistintamente ogni rapporto di dare-avere. La pena diviene
lo strumento per sanzionare un qualsivoglia inadempimento ad una obbligazione del suddetto tipo, perdendo
il proprio significato di strumento riservato a condotte
connotate da un disvalore peculiarmente pregnante. Con
esito esattamente opposto a quello perseguito, alla norma penale viene nei fatti riconosciuta una funzione meramente sanzionatoria.
Com’è che si spiega un tale paradosso? La risposta la
si trova abbandonando, solo per un momento, l’angusta
prospettiva esegetico-applicativa, per lasciarsi coinvolgere da considerazioni di respiro politico-criminale.
Come evidenziato in un celebre “studio” di qualche
anno fa (32), la condotta di “appropriazione indebita”
ha la caratteristica di insistere su di un previo contatto di
tipo contrattuale tra “autore” e “vittima”, o comunque
su di una relazione tra questi soggetti normativamente
regolata e dunque lecita. Proprio per questa sua aderenza
a moduli di scambio socialmente e giuridicamente fisiologici, trattasi di un comportamento avvertito come
“meno grave” rispetto a quello, ad es., di “sottrazione”,
che costituisce invece la negazione, il sovvertimento, di
quei moduli (l’“anticontratto”) (33). La funzione del
reato in discussione è, dunque, quella di definire un confine, di delineare con precisione quali sono gli spazi di
“non intervento” «in corrispondenza di quei comportamenti che costituiscono il fondamento del dominio borghese e ne consentono il riprodursi». La fattispecie di cui
all’art. 646 c.p. assume un ruolo servente rispetto ad interessi e posizioni privatistico-individuali, nel senso che
serve al privato «quale mezzo, particolarmente intenso e
persuasivo, per ottenere le dovute restituzioni ed i dovuti risarcimenti economici», perseguendo, dunque, lo scopo di aiutare la vittima nel ripristino di un equilibrio patrimoniale alterato: tanto che la perseguibilità è subordinata alla querela, ovvero ad una valutazione d’opportunità ed utilità del privato (34).
Tali considerazioni - anche a non volerne condividere tutti i presupposti e tutte le articolazioni - appaiono
difficilmente contestabili, laddove mettono in luce come l’appropriazione indebita sia figura di “confine” rispetto a comportamenti costituenti un mero illecito civile, per lo più di tipo contrattuale; un confine che, tra
l’altro, non distanzia due territori stranieri, ma delinea
una “cittadella” penalistica all’interno di una regione che
comunque è ancora e principalmente “civilistica”. L’appropriazione indebita è un inadempimento qualificato; nessun afflato “autonomista” può conculcarne tale natura.
Se, come pare opportuno (ed anzi necessario), si
intende comunque garantire alla disposizione incriminatrice dell’art. 646 c.p. un ruolo autonomo e peculiare,
volto alla repressione di condotte particolarmente connotate da disvalore (in ossequio al principio di “fram-
1112
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
mentarietà” che informa il diritto penale e ne fonda la
legittimità (35)), due sono le esigenze che non possono
essere trascurate dall’interprete. Da un lato, il confine di
cui si è parlato deve essere saldo, ben definito e circoscritto, perché ogni indecisione sull’estensione applicativa
dell’art. 646 c.p. finisce inevitabilmente con l’avallare
probabili espansioni della stessa con conseguente “appiattimento” del “penale” sul “civile” (tanto più quando
i profili tipici del fatto vengano tratteggiati ricorrendo a
formule ambigue - il “vincolo di destinazione” - che
molto ricordano una traduzione “laica” di quello che
giuridicamente meglio potrebbe dirsi un “rapporto obbligatorio”). Dall’altro lato, quel confine - perché risulti effettivamente “saldo”, “definito” e funzionale allo
scopo - deve essere tracciato facendo in qualche modo
riferimento alle opzioni definitorie del diritto civile, dato che
è proprio all’interno di, e rispetto a, questa branca dell’ordinamento che la selezione del “meritevole di pena” deve essere operata.
Quanto si è appena detto ha la seguente ricaduta
tecnica: non è opportuno trattare come elementi valutativi, rimandanti a considerazione di valore svincolate
da parametri determinati, profili del reato (altruità, ma
anche “possesso”, “appropriazione”, “profitto”) che ben
si prestano ad essere intesi nei termini di elementi normativi giuridici. Il circuito di richiami attivato dall’“elemento normativo” è infatti concepito proprio per soddisfare la duplice esigenza di cui sopra. Da un lato esso
intrattiene quel rapporto funzionale che s’è visto necessario con le categorie della contrapposta branca dell’ordinamento (36); dall’altro lato - se si tratta di elemento
normativo, ribadiamo, “giuridico” - dà stabilità e certezza, dà determinatezza all’opzione selettiva di cui s’è appena detto (37).
Note:
(32) F. Sgubbi, Uno studio sulla tutela penale del patrimonio. Libertà economica, difesa dei rapporti di proprietà e «reati contro il patrimonio», Milano,
1980, spec. 171 ss.
(33) Lasciando intuire, tra l’altro, la presenza di un “tipo di autore” più
“pericoloso” (F. Sgubbi, op. cit., spec. 151 ss.). Per considerazioni in qualche misura corrispondenti, pur nel diverso quadro d’uno studio volto ad
individuare ruolo e legittimazione del diritto penale nella definizione di
pre-condizioni strumentali alla realizzazione di programmi di tutela, cfr.,
di recente, G.A. De Francesco, Programmi di tutela e ruolo dell’intervento
penale, Torino, 2004, 59 ss.
(34) F. Sgubbi, op. cit., 177 ss.
(35) Sulle ragioni per cui, in tema di tutela del patrimonio, l’ambito del
“penalmente rilevante” non possa “appiattirsi” su quello del “civilmente
rilevante”, v., ad es., S. Moccia, op. cit., 73 ss.; F. Sgubbi, op. cit, 83 s.
(36) Cfr. ad es. D. Pulitanò, L’errore di diritto nella teoria del reato, Milano,
1976, 225.
(37) Sulla contrapposizione tra elementi valutativi (nei quali si fanno
rientrare anche gli elementi normativi c.d. “extragiuridici”), da un lato,
ed elementi normativi giuridici - elementi descrittivi naturalistici, dall’altro lato, dal punto di vista della diversa compatibilità con il principio di
determinatezza, v. le interessanti pagine di L. Risicato, Gli elementi normativi della fattispecie penale. Profili generali e problemi applicativi, Milano,
2004, 192-225.
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
Le relazioni tra significato “comune” e portata
“extrapenale” dell’elemento normativo “altrui”.
Il caso particolare dell’appropriazione di denaro
Ricapitolando: vi sono ottime ragioni per ritenere
che “altrui”, rispetto al denaro, non possa voler dire sic et
simpliciter “di altrui proprietà”. Ragioni altrettanto buone, nondimeno, suggeriscono di individuare in quel termine un elemento normativo, evocativo di norme e categorie civilistiche.
Ma quali norme, quali categorie?
Per rispondere a questa domanda, si impone una riflessione che ancora una volta trascenda, sia pur brevemente, i limiti d’una analisi prettamente esegetica, per
intrecciarsi con considerazioni più generali, inerenti al
concetto stesso di “elemento normativo”.
Gli elementi normativi, si suol dire, si caratterizzano (e si differenziano dai semplici “rinvii in bianco”) per
un nucleo semantico dotato d’un significato autonomo,
riconoscibile a prescindere da un riferimento alle specifiche norme richiamate; la funzione di queste ultime si
apprezza soltanto ai fini del processo di sussunzione del
caso concreto nella fattispecie astratta (38). Così - proprio questo è l’esempio proposto - anche i bambini e gli
analfabeti e, più in generale, anche chi neppure sappia
dell’esistenza di un codice civile, sono in grado di capire
e di conoscere il significato del divieto di “rubare cose altrui”; ed è tanto vero che quel divieto (e quell’aggettivo)
hanno un significato autonomo (rispetto alle norme di
volta in volta funzionali alla loro “concretizzazione”),
che nessuno riterrebbe mutato il “senso” del precetto
“non rubare” per l’avvenuta modifica di una o più regole in tema di circolazione della proprietà (39). Tali regole, d’altronde, non spiegano come ci si deve comportare rispetto alle cose altrui, ma quand’è che una cosa può dirsi
altrui (40).
Simili considerazioni, che hanno acquisito la loro
legittimità essenzialmente sul piano della teoria dell’errore, meritano d’essere tenute a mente anche dal
diverso punto di vista dell’interpretazione di norme incriminatrici contenenti elementi normativi. Il significato che il termine utilizzato dal legislatore per descrivere l’elemento normativo assume nel linguaggio comune, in quanto funzionale alla definizione del “senso” del divieto, deve essere ben individuato prima della, e a prescindere dalla, individuazione delle norme extrapenali da quell’elemento richiamate. Breve: prima
si deve capire che cosa il legislatore penale ha voluto
dire nel porre la norma incriminatrice, a quali classi di
fatti ha inteso fare riferimento, quale tipologia di disvalore ha messo a fuoco; dopo, e soltanto dopo, è possibile individuare le disposizioni extrapenali richiamate in quelle consentanee al “senso” della fattispecie
come in precedenza individuato. Costituisce un’evidente inversione metodologica andare prima a selezionare le norme che, a parere dell’interprete, integrano
l’elemento normativo, e poi desumere da esse il senso
della fattispecie.
Quanto si va dicendo può certo apparire un’ovvietà. Tuttavia trattasi di un’ovvietà che è bene ribadire,
nella misura in consente di escludere a priori la validità di
impostazioni che - programmaticamente o, comunque,
nei fatti - finiscono con l’individuare l’”altruità” anche
laddove il terzo sia titolare di un mero “diritto di credito”
rispetto al bene.
“Altrui”, in italiano, significa «degli altri, che appartiene ad altri» (41). Se così è, tale termine appare utilizzato a sproposito laddove il terzo vanti, rispetto alla “cosa”, un diritto ad ottenere quell’“appartenenza” mediante la collaborazione (obbligatoria e necessaria) di chi ha
sulla cosa medesima un qualche dominio. Nel momento
in cui si riconosce una pretesa giuridicamente tutelata ad
acquisire un potere sulla cosa, si postula, a rigor di logica,
che il titolare di quella pretesa sia attualmente privo di siffatto potere. “Appartenenza” (dunque “altruità”) e “diritto di credito” sono termini concettualmente incompatibili.
Se vogliamo tradurre in linguaggio giuscivilistico il
termine “cosa altrui”, appare allora opportuno evocare
il concetto di “cosa sottoposta all’altrui proprietàî (o,
tutt’al più, all’altrui diritto reale o di godimento”) (42).
Occorre insomma fare riferimento a diritti i quali, condividendo (anche solo in parte) le facoltà tipiche del
proprietario, esprimono, per l’appunto, una appartenenza, ovvero un legittimo ed attuale potere sulla cosa per
la cui giuridica sussistenza non è necessaria l’attiva collaborazione altrui (43).
Sennonché, anche ammesso che questa sia la soluzione più opportuna con riferimento al significato assunto in generale dall’aggettivo “altrui” nei reati contro il
patrimonio, la stessa però non risulta ancora appagante
Note:
(38) Si vedano, sul punto, le ormai “classiche” pagine di D. Pulitanò, op.
cit., 241-348. V. anche M. Romano, Commentario sistematico del codice penale, 3a ed., Milano, 2004, 497 s., nonché, da ultimo L. Risicato, op. cit.,
97 ss., 175 ss. Simile negli esiti, ma non corrispondente nei presupposti e
nei passaggi argomentativi, la tesi di chi distingue tra errore sull’esistenza
e sulla struttura del precetto - tale quello concernente il significato generale e “basico” di una certa norma incriminatrice - ed errore invece sull’ampiezza del precetto - concernente il processo di specificazione che dal
precetto, necessariamente generale ed astratto, muove verso il fatto concreto, necessariamente specifico e particolare (F. Palazzo, L’errore sulla legge extrapenale, Milano, 1974, spec. 133 ss.). Per una critica a queste impostazioni: E. Belfiore, Contributo alla teoria dell’errore in diritto penale, Torino, 1997, 61-87.
(39) Cfr. M. Romano, Repressione della condotta antisindacale, Milano,
1974, 140.
(40) D. Pulitanò, op. cit., 259 ss.
(41) Cfr. Vocabolario Treccani della lingua italiana, I, Roma, 1986, 141, sub
“altrùi”.
(42) V. ad es. A. Carmona, op. cit., 165.
(43) È A. Pagliaro ad evidenziare la necessità di individuare lo spazio semantico dell’aggettivo “altrui” muovendo, in primo luogo, da quella che
è la «nozione comune» del termine (L’altruità, cit., 716), sottolineando, al
contempo, come tale nozione debba poi concretizzarsi attraverso un riferimento a norme extrapenali: “l’interesse” sulla cosa che fonda l’altruità
deve essere giuridicamente qualificato.
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1113
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
rispetto alla particolare ipotesi di nostro interesse: quella
dell’appropriazione di denaro. In effetti, non è giuridicamente concepibile il possesso di danaro su cui altri vantino un “diritto reale o di godimento”. La ragione è quella consueta: il danaro, una volta posseduto, qualunque
ne sia la provenienza e qualunque sia il titolo del possesso, si confonde (v. supra, nota 26) con quello del possessore che ne diventa pieno proprietario; nessun diritto altrui su quel particolarissimo bene può a questo punto
immaginarsi, se non, laddove ve ne siano i presupposti,
un diritto alla corresponsione del tantundem, un diritto di
credito avente ad oggetto un valore (44).
Sembra veramente d’essere incappati in un vicolo
cieco: “altrui” non può indicare un altrui diritto di credito, per incompatibilità semantica; d’altro canto, rispetto
ad una somma di denaro da taluno “posseduta”, niente
più che un diritto di credito è ipotizzabile in capo a terzi,
per lo meno dal punto di vista civilistico.
Una via d’uscita, però, c’è, e la si imbocca aderendo
all’opinione di chi evidenzia come l’espressa menzione
del “denaro” «fra i possibili oggetti materiali dell’appropriazione indebita», lungi dall’essere una precisazione
superflua (rientrando il denaro nell’ambito più generale
delle “cose mobili”), intende «ribadire, in conformità
della tradizione, che in questo reato non trova applicazione il principio civilistico secondo cui le cose fungibili
diventano di proprietà della persona a cui vengono consegnate, a meno che non restino nettamente individuate» (45). In sostanza, il legislatore penale ci vuol far capire, ponendo un’eccezione rispetto alle regole civilistiche, che ai fini dell’appropriazione indebita il denaro
non diviene “proprio” del possessore per il solo fatto del
possesso.
Non v’è peraltro motivo per cui questa constatazione dovrebbe condurre a sovvertire la nozione di “altruità” rispetto alla quale già si è manifestata la nostra
preferenza. L’espressa menzione del denaro non dà nuova linfa alle impostazioni che finiscono col riconoscere
l’“altruità” anche laddove sussista, in capo ad un terzo,
un mero diritto di credito; più limitatamente, essa lascia
intuire un’eccezione rispetto a quelle che sono le regole
in tema di trasmissione della proprietà. Nella visuale del
penalista, bisogna ragionare “come se”, rispetto al denaro,
non operasse il criterio della confusione.
Ergo, laddove il denaro venga consegnato nell’esecuzione di contratti che per loro natura non fanno acquisire la proprietà in capo all’accipiens (si pensi ad es. al
deposito o al mandato), il denaro rimane “altrui”, ai fini
dell’applicazione dell’art. 646 c.p.; mai, però, potrà dirsi
“altrui” il denaro solo perché gravato da un “vincolo di
destinazione” rispetto ad interessi di terzi, quando tale
vincolo si riferisca a denaro che è di chi lo possiede non
per mera confusione, ma in virtù di altri titoli di acquisto
della proprietà. In questo caso, difatti, anche a ragionare
“come se” non operasse l’istituto della confusione, si dovrebbe comunque riconoscere la proprietà del possessore sul danaro posseduto, e la sussistenza di un mero cre-
1114
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
dito in capo ad altri, credito in sé insuscettibile di delineare una “altruità”. In poche parole, un “possesso di denaro altrui” è concepibile soltanto quando il denaro sia stato consegnato da altri, cui apparteneva, senza che ciò costituisca esecuzione di un contratto intrinsecamente idoneo a
trasferire la proprietà (46).
È proprio la conclusione alla quale, come s’è detto,
giungono nella sostanza le Sezioni Unite, finendo coerentemente con l’escludere l’integrazione di un’appropriazione indebita in tutti i casi riconducibili al paradigma del mancato versamento di danaro “trattenuto”
dallo stipendio del lavoratore. Una simile nozione di
altruità, d’altra parte, può illuminare una ben più estesa costellazione di casi problematici. Su suggestione dei
repertori di giurisprudenza potremmo immaginarne diversi: ci limitiamo a trattarne uno. Si ipotizzi un mandato “senza rappresentanza” ad alienare un determinato bene; si ipotizzi, poi, che il mandatario non provveda a fare avere al mandante quanto ottenuto dalla
compravendita. Se di un impossessamento si tratta, è
un impossessamento di danaro “proprio”, in quanto appartenente al mandatario non per “confusione”, ma perché «il mandatario che agisce in proprio nome acquista
i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi» (art. 1705 c.c.). Quei soldi sicuramente “spettano” al mandante (egli vanta un diritto di credito in tal senso) (47), ma tanto non basta a renderli
“altrui”.
Problematiche residue:
la condotta “appropriativa”; il concorso di norme
Alcune precisazioni, a mo’ di chiosa finale. La nostra attenzione s’è concentrata sul concetto di “altruità”
perché a tanto costringono i contenuti della sentenza in
esame. Ad aver tempo e spazio, sarebbe stato interessanNote:
(44) Analogamente G. Marini, op. cit., 538.
(45) F. Antolisei, op. cit., 338.
(46) Sembra dunque avere ragione, almeno rispetto al limitato ambito di
ipotesi col quale ci siamo confrontati, quella dottrina minoritaria, ma autorevole, secondo la quale sarebbe elemento necessario della fattispecie
un «titolo derivativo» del possesso «(cioè mediante affidamento della cosa), e non originario (mediante apprensione diretta della stessa), […] non
traslativo della proprietà» (F. Mantovani, op. cit., 119). Per quanto concerne, in particolare, la necessità di un titolo d’acquisizione del possesso non
traslativo della proprietà, v. B. Petrocelli, op. cit., 261 s.. Per uno spunto
comparatistico: M. Papa, voce Patrimonio (reati contro il) in diritto angloamericano, in Dig. disc. pen., IX, 1995, 320 s. Di recente, ribadisce invece
che «la fonte del possesso che funge da presupposto dell’appropriazione
indebita (“a qualsiasi titolo”) è definibile soltanto in negativo: nel senso
che non deve provenire da sottrazione furtiva o da altra attività delittuosa»: C. Pedrazzi, Sui limiti della «appropriazione», in Riv. it. dir. e proc. pen.,
1997, 1443.
(47) A dire il vero, parte della dottrina civilistica ritiene che la proprietà,
in tali casi, spetti al mandante, argomentando dalla facoltà che l’ordinamento gli riconosce di agire in “revindica”: sul punto v., per tutti, in termini critici, C. Santagata, Del mandato. Disposizioni generali, in AA.VV.,
Commentario al codice civile, a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma,
1998, 205 ss.
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
te prendere in considerazione altri elementi del fatto tipico. Particolare attenzione avrebbe meritato soprattutto l’elemento della “appropriazione”: in che misura un
“mancato pagamento” di quanto dovuto può ritenersi,
in sé e per sé, espressione di un atto (e di un animus) appropriativo? Sul punto ci limitiamo ad osservare quanto
segue.
Il mero “non versare somme dovute” è comportamento interamente omissivo, e non è affatto scontato
che una fattispecie come l’“appropriazione indebita”, in
quanto “a forma vincolata”, possa essere convertita in
fattispecie omissiva impropria ex art. 40 ultimo comma
c.p.
Ancora: il “mancato pagamento” può apparire
espressione di una “appropriazione” solo se accompagnato da una volontà in tal senso orientata, trattandosi, in sé
per sé, di un’omissione dalla valenza ambigua. Se così è,
il riscontro di una indebita appropriazione in un caso del
genere verrebbe a fondarsi, alla fin fine, su un’indagine
di profili psicologici in niente aiutata dal senso esteriormente percepibile del comportamento (non) tenuto,
con rischio di violazione del principio cogitationis poenam
nemo patitur (48).
Per tutte queste ragioni, appare preferibile individuare un atto appropriativo soltanto in quel non pagamento accompagnato da altri comportamenti “attivi” e
in sé “pregnanti”, capaci di connotare di tipicità la condotta già ad una valutazione “dall’esterno” (ad es. espressioni palesi di un rifiuto di restituire) (49).
Chiusa l’analisi inerente alla tipicità del fatto concreto rispetto al paradigma dell’art. 646 c.p., qualche
cenno finale lo merita un problema di concorso di norme, dal significato tutt’altro che residuale.
Il mancato accantonamento presso la Cassa Edile
di somme destinate ai lavoratori, come riconosciuto
dalle stesse Sezioni Unite, integra gli estremi della fattispecie (riformulata nelle forme di un illecito amministrativo dall’art. 13 d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758)
dall’art. 8 l. 14 luglio 1959, n. 741, con la quale si sanziona l’inottemperanza agli obblighi derivanti dai contratti collettivi recepiti dai decreti “aventi forza di legge”, esecutivi della delega contenuta nell’art. 1 della
medesima l. n. 741 del 1959. Tra questi “obblighi” v’è,
infatti, anche quello di depositare presso le Casse Edili le somme dovute ai dipendenti a titolo di ferie e di
gratifica natalizia (obbligo originariamente previsto
dall’art. 34 del «contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini»
del 24 luglio 1959, e quindi “reso esecutivo” dall’articolo unico del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032) (50). Se
questa interpretazione è esatta - e così ritiene una giurisprudenza ormai costante (51) - attraverso la catena
di rinvii da una norma all’altra, viene a delinearsi una
disposizione sanzionatoria specificamente contemplata proprio in rapporto a quella tipologia di omissione
che si vorrebbe altrimenti stigmatizzare ricorrendo all’art. 646 c.p.
Anche a non volersi addentrare nei meandri d’una
rigorosa verifica dei rapporti strutturali tra le fattispecie
convergenti, ci pare che, a prescindere da ogni altra considerazione, il caso in esame avrebbe potuto essere risolto nei seguenti e più stringati termini: se neghiamo che
l’omesso pagamento di quanto dovuto alla Cassa Edile
costituisca, in sé e per sé, appropriazione indebita, allora
a quel fatto si applica soltanto la norma sanzionatoria di
cui all’art. 8 l. n. 741 del 1959. Se, invece, riteniamo che
l’inottemperanza ad un mero obbligo di “dare” o restituire” possa costituire, di per sé, il “fatto tipico” di cui all’art.
646 c.p., allora non può neppure negarsi che la fattispecie derivante dal combinato disposto degli artt. 1 ed 8 l.
n. 741 del 1959, 1 d.P.R. n. 1032 del 1960 e 34 c.c.l. 24
luglio 1959, in quanto incentrata sulla stessa tipologia di
condotta, delinei una ipotesi speciale di appropriazione
indebita, realizzata attraverso l’inadempimento ad uno
specifico obbligo di “dare”; di talché l’art. 646 c.p. non
potrebbe essere comunque applicabile, stante la prevalenza della disposizione speciale ex art. 9 l. n. 689 del
1981. In sostanza, sia che si affermi, sia che si neghi la tipiNote:
(48) Per queste considerazioni cfr. A. Pagliaro, Appropriazione, cit., 227.
Cfr. anche F. Mantovani, op. cit., 121. Diversamente C. Pedrazzi, Appropriazione, cit., 843, ritiene che la condotta illecita possa assumere anche
forma omissiva, «purché valga come manifestazione concreta ed adeguata - come esercizio - di una signoria assoluta in atto»; o purché sia accompagnata dalla volontà di trattenere la cosa come fosse propria (così D. Pisapia, voce Appropriazione indebita (diritto penale), in Noviss. Dig. it., 1968,
800). D’altra parte - osserva A. Regina, voce Appropriazione indebita, in
Enc. giur., II, 1988, 3 - se la consumazione dell’appropriazione indebita si
ha con il verificarsi della mera possibilità del profitto (così ancora D. Pisapia, op. cit., 801), nei casi di appropriazione per mera ritenzione, sussistendo l’obbligo giuridico di restituire, l’elemento del profitto addirittura
già s’è concretizzato.
(49) Da un diverso punto di vista v’è poi da aggiungere che, se “appropriarsi” del danaro significa utilizzarlo per una destinazione incompatibile
con il titolo del possesso (ed invece compatibile con un atteggiamento uti
dominus dell’agente), tale incompatibilità forse ancora non può dirsi realizzata quando il soggetto sia comunque pienamente solvibile, e dunque il
debito rilevante possa ancora venire interamente soddisfatto (sia pure in
ritardo). Sulla “espropriazione” quale elemento essenziale della appropriazione, sussistente «quando non solo risulta alterato il vincolo strumentale, ma sussiste anche la definitiva rottura della relazione tra il proprietario e la cosa», v., da ultimo, R. Bartoli, La distinzione tra appropriazione e
distrazione e le attuali esigenze di tutela patrimoniale, in questa Rivista, 2001,
1143 ss. (corsivi nostri). V. poi C. Pedrazzi, Sui limiti della «appropriazione»,
cit., 1441 ss.
(50) Sul punto, cfr. G. Rubino, Le Casse Edili, in Riv. it. prev. soc., 1962,
809 ss.. La Corte Costituzionale (con sentenza 4 luglio 1963, n. 129, in
C.E.D. Cost., n. 1951) ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’articolo unico del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, per la parte con cui rende obbligatori erga omnes l’art. 34, pel riferimento alle Casse edili di cui alla fine del terz’ultimo comma, e l’art. 62 del contratto collettivo 24 luglio
1959 che disciplina l’istituzione di tali Casse per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini» (v. anche Corte cost. 16 dicembre 1965, n. 100,
ivi, 2474). A seguito di questa sentenza - come la stessa Corte ha peraltro
evidenziato - non viene tuttavia meno l’obbligo di accantonamento delle voci di retribuzione di cui si è detto; solo che, per i soggetti non vincolati con le Casse Edili, tale accantonamento dovrà avvenire presso istituti di credito.
(51) V. ad es. Cass., Sez. II, 12 maggio 1993, Giallini, cit.; Cass., Sez. III,
12 agosto 1986, Luciani, in C.E.D. Cass., n. 173563.
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1115
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
cità dell’omissione del datore di lavoro ai sensi dell’art.
646 c.p., la conclusione è la stessa, ovvero l’applicabilità
del solo art. 8 cit. (52)
Nota:
(52) In realtà, aderendo all’ipotesi affermativa, tra le due fattispecie parrebbe più propriamente riscontrabile un rapporto di “specialità reciproca”, contenendo l’art. 646 c.p. un profilo di dolo specifico estraneo all’art.
8 cit. Ritengono comunque applicabile l’art. 9 l. n. 689 del 1981 anche in
casi del genere: G.A. De Francesco, voce Specialità (Principio di), in Noviss. Dig. it., app., VII, 1997, 492 ss.; M. Siniscalco, Commento all’art. 9 l.
n. 689 del 1981, in Legisl. pen., 1982, 227. Più problematicamente: A.
Vallini, Concorso di norme e di reati, in Introduzione al sistema penale, II, Torino, 2001, 391 ss. L’art. 8 cit. risulterebbe comunque prevalente, dovendosi ritenere “più specifica” la fattispecie con soggetto attivo qualificato
(cfr. G.A. De Francesco, Lex specialis, Milano, 1980, 134 ss., F. Mantovani, Concorso e conflitto di norme nel diritto penale, Bologna, 1966, 458 s.; T.
Padovani, Diritto penale, 7ª ed., Milano, 2004, 359 s.: l’art. 9 cit. non richiama, a differenza dell’art. 15 c.p., il criterio della specialità delle leggi).
Considerazioni analoghe ben potrebbero ripetersi per quanto concerne la
contigua ipotesi del mancato versamento delle ritenute INPS, esistendo
anche al proposito una norma incriminatrice specificamente dedicata a
tale condotta. Si fa riferimento al reato di «omesso versamento delle ritenute previdenziali» (art. 2 comma 1 d.l. n. 463 del 1983, conv. dalla l. 11
novembre 1983, n. 638), nel quale è stata di recente espressamente riconosciuta, dalle stesse Sezioni Unite della Cassazione, una tipologia spe-
ciale di appropriazione indebita (Cass., Sez. Un., 26 giugno 2003, Silvestri, cit.; di tale decisione v. la sintesi di D. Notaro, corredata da un vasto
apparato di richiami giurisprudenziali e bibliografici, in La giurisprudenza
delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Diritto Penale, curata da F. Palazzo, Torino 2005, 264 ss.). V. anche, in precedenza, Pret. Milano, 21
marzo 1984, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1984, 1203, con nota critica di F.
Mucciarelli. Nota T. Padovani, op. cit., 339: se davvero i fatti cui l’art. 2
cit. si applica fossero rilevanti ex art. 646 c.p. (norma tra l’altro caratterizzata da un apparato sanzionatorio del tutto corrispondente), quale motivo avrebbe spinto il legislatore ad introdurre nell’ordinamento l’art. 2
medesimo? L’esistenza di questa norma conferma, insomma, la convinzione che l’omesso versamento delle ritenute non sia un’appropriazione indebita. In senso opposto (con riferimento all’art. 4 d.l. 10 gennaio 1983,
n. 3, che rinviava peraltro sic et simpliciter alla fattispecie dell’art. 646 c.p.
in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali): G. La Cute,
Manuale di diritto penale del lavoro, Napoli, 1983, 191. In conclusione, soltanto rispetto al caso dell’omesso versamento all’erario delle ritenute fiscali il problema dell’eventuale integrazione del reato di cui all’art. 646
c.p. mantiene un reale significato pratico. L’art. 2 d.l. n. 429 del 1982,
conv. dalla l. n. 516 del 1982, poi sostituito dall’art. 3 d.l. n. 83 del 1991,
a sua volta convertito dalla l. n. 154 del 1991, prevedeva un’apposita fattispecie criminosa dedicata all’omesso versamento delle ritenute da parte
del sostituto di imposta. Una norma analoga non appare tuttavia riproposta dalla attuale disciplina dei reati tributari (d.lgs. n. 74 del 2000), la
quale, com’è noto, ha abrogato per intero la normativa dell’82 (v. art. 25
lett. d). La questione del possibile, residuo rilievo penale di quell’omissione ex art. 646 c.p. è dunque tornata d’attualità (v. G.L. Soana, op. cit.,
1453).
CONVEGNO GRATUITO
“ARRINGHE: che resta oggi dell’eloquenza”
Venerdì 30 settembre 2005
dalle ore 15 alle ore 19
Sede: Aula “Auditorium” c/o Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense
Via E.Q. Visconti, 8 - Roma
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
[email protected]
1116
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
Delitti contro il patrimonio
Estorsione: la minaccia come fatto
eziologicamente collegato all’azione
volontaria e cosciente dell’agente
CASSAZIONE PENALE, Sez. II, 23 settembre 2004 (u.p. 16 giugno 2004), n. 37526
Pres. Di Jorio - Rel. Carmenini - G. ed altro, ricorrenti
Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone - Estorsione - Elemento oggettivo - Minaccia Indifferenza della forma - Condotta minacciosa concretamente realizzata dall’agente - Necessità - Esclusione - Effettiva intimidazione del soggetto passivo - Necessità - Esclusione - Insussistenza del reato.
(Art. 629 c.p.)
La minaccia costitutiva del delitto di estorsione può essere manifestata anche in maniera implicita, larvata,
indiretta ed indeterminata. Tuttavia deve pur sempre essere una minaccia strettamente collegabile alla condotta dell’agente, quale rappresentatasi e voluta dall’agente stesso, che deve porre la controparte in condizione di non avere scelte e di essere costretta a subire la situazione minatoria. In particolare, non si configura necessariamente ed automaticamente il delitto di estorsione ogni volta che vi siano rapporti tra una
parte più forte ed una più debole, per lo squilibrio oggettivo esistente, ma deve rigorosamente provarsi che
nel singolo caso concreto vi sia, tra gli altri, il requisito della minaccia, sia pure implicita, dovuta al comportamento cosciente e volontario del soggetto più forte.
(Omissis).
Le imputazioni sono a carico di due avvocati del Foro di
Arezzo, G. R. e A. S..
Si tratta di due addebiti (di cui si parlerà più diffusamente in seguito), di estorsione (capo A) e tentata estorsione aggravate (capo B), in danno di V. G., M. B. e D. M.,
soci ed amministratori della M.. s.r.l.
Il Tribunale di Arezzo, con sentenza dell’1 marzo 2001,
condannò alla pena di due anni e otto mesi di reclusione
e lire 3 milioni di multa, oltre alle statuizioni in favore
delle parti civili, l’A. per il reato di cui al capo B), esclusa l’aggravante delle più persone riunite; assolse il G. dallo stesso reato, per non aver commesso il fatto; assolse
entrambi gli imputati dal reato di cui al capo A) per insussistenza del fatto, ritenendo che difettasse l’elemento
della minaccia.
Su gravame del P.M. e dell’A., la Corte di Appello di
Firenze, con la sentenza del 26 marzo 2003, oggetto
delle presenti impugnazioni, dichiarava entrambi gli
imputati colpevoli dell’estorsione sub A), concedendo
le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle
aggravanti contestate; riteneva, per l’A., la continuazione tra i due reati, confermando quindi la condanna
anche per il reato sub B); determinava le pene, anche
accessorie.
Il P.M. aveva proposto appello, quanto al capo A), nei
confronti di entrambi gli imputati; quanto al capo B),
aveva chiesto soltanto l’aumento di pena per l’A.
La situazione processuale, pertanto, può dirsi ormai definita per il G. relativamente alla tentata estorsione, contestata al capo B), con l’assoluzione per non avere commesso il fatto.
Tutte le altre posizioni sono coinvolte dai ricorsi per cassazione proposti da entrambi gli imputati.
Prima di chiarire sulla base di quali elementi si è pervenuti alle relative contestazioni, appare utile riprodurre
integralmente i capi d’imputazione.
CAPO A): reato p. e p. dagli artt. 110, 629, commi 1 e
3 in relazione agli artt. 628 n. 1 e 61 n. 11 c.p., per avere, in concorso tra loro, mediante implicita minaccia rivolta a V. G., M. B. e D. M. - soci ed amministratori della “M..” s.r.l. in favore della quale i due legali avevano
già prestato la loro opera professionale in occasione del
sequestro di una di una partita di 69 Kg. di oro che, acquistato di contrabbando da detta società, era stato sequestrato dalla Guardia di Finanza di Arezzo in data 31
ottobre 1994, ed in relazione al quale gli indagati si erano fattivamente adoperati per reperire ditte estere (poi
individuate nella “S. P.” con sede in Spagna e nella ditta “V. G.” con sede in Germania) che si prestassero ad
emettere false fatture idonee a dimostrare la regolarità
dell’acquisto dei 69 Kg. di oro ottenendone così il disse-
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1117
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
questro - di rivelare la natura fittizia della documentazione fiscale emessa dalla “S. P.” e dalla ditta “V. G.”,
procurati l’ingiusto profitto consistito nella pretesa di
pagamento di una parcella pari a lire 500 milioni (poi
ridotta a circa 350 milioni di lire) da corrispondersi, come in effetti avvenuto, in più riprese, in contanti e senza alcuna ricevuta e/o fattura, quale compenso per l’attività prestata al fine di ottenere, negli illeciti modi sopra descritti, il dissequestro dei 69 Kg. di oro. Con l’aggravante del fatto commesso con abuso di prestazione
professionale;
CAPO B): reato p. e p. dagli artt. 110, 56, 629, commi 1
e 3 in relazione agli artt. 628 n. 1 e 61 n. 11 c.p., per avere, in concorso tra loro, mediante minaccia consistita
nel dire al V. G., al M. B. e al D. M. che avrebbero fatto
in modo di far chiudere l’azienda M.. di cui erano soci ed
amministratori e di rovinarli, facendo quindi seguire a
tali minacce azioni giudiziarie intentate dalla “S. P.”, su
espressa richiesta degli indagati, contro la M.. ed in particolare facendo notificare agli amministratori di quest’ultima società un atto di citazione per risarcimento
danni ed una richiesta di sequestro conservativo basati
su quella fornitura di 69 Kg. di cui al capo che precede ed
in realtà mai effettuata dalla “S. P.” e nel contempo facendo sapere al V. ed al M. che tali azioni legali sarebbero cessate non appena costoro avessero corrisposto una
somma di denaro ulteriore rispetto a quella già riscossa
ed indicata al capo A) e quantificata in lire 100 milioni,
compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a
procurarsi l’ingiusto profitto del pagamento di detta
somma e non riuscendo nel loro intento per il rifiuto opposto dalle parti offese di corrispondere quanto indebitamente loro richiesto. Con l’aggravante del fatto commesso con abuso di prestazione professionale. In Arezzo,
tra il settembre 1996 ed il novembre 1998. Fatti unificati dal vincolo della continuazione.
Le indagini avevano avuto inizio a seguito di attività d’istituto della Guardia di Finanza, la quale, in data 23 ottobre 1994, fermava tale V. G. con un carico di oro puro
di circa 69 Kg.; il V. giustificava il possesso dell’oro, affermando che aveva dimenticato i documenti in un ristorante di Milano; nel contesto delle indagini venivano
sequestrati, oltre il metallo prezioso, tre assegni, di cui
uno protestato a seguito di presentazione presso la Cassa
di Risparmio di S. Marino.
La Guardia di Finanza iniziava una verifica generale nei
confronti di una società, la “M.. s.r.l.”, di cui il V. era socio unitamente a D. M. e M. B..
Dal conseguente rapporto, scaturivano un procedimento penale, per contrabbando ed altro, a carico dei tre responsabili della ditta M.. s.r.l.; nonché un procedimento
amministrativo presso l’Ufficio Italiano Cambi e poi
presso il Ministero del Tesoro, ai sensi della L. 689/81,
volto ad ottenere il dissequestro dell’oro.
Secondo i giudici di merito è certo che l’oro era stato acquistato in nero sul mercato di Milano; che i tre si fecero assistere dai due avvocati odierni imputati, i quali li
1118
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
aiutarono anche a reperire documentazione falsa presso
due ditte estere: la ditta spagnola “S. P.” di C. B. (ma il
reale amministratore era tale I. S.; l’avv. A. aveva accompagnato il V. in Spagna) e la ditta tedesca “G. V. G.”
di G. V..
Sia il procedimento penale che quello amministrativo
andarono a buon fine; la richiesta di rogatoria fatta dal
P.M. di Arezzo al Commissario della legge di San Marino era stata respinta.
I due legali presentarono, a seguito delle attività sopra
descritte, una nota delle loro competenze per le prestazioni giudiziali e stragiudiziali, inizialmente di oltre lire
900 milioni, poi ridotte a lire 500 milioni; da ultimo, atteso lo stato deficitario della società, le parti si accordarono per una riduzione della notula a lire 360 milioni, secondo i giudici di merito interamente pagati in contanti
e senza ricevute.
Nel contempo l’avv. G., che era stato legale di L. G., si
adoperò per far avere da quest’ultimo un finanziamento
di due miliardi di lire alla soc. M., che si trovava in gravi
difficoltà economiche.
A questo punto si può dire che i risvolti penalistici a carico dei due odierni imputati si biforcano, in relazione ai
due capi d’imputazione.
Quanto al capo A), la premessa comune per entrambi i
giudici di merito è che il rapporto legali - clienti è illecito e la pretesa stessa dei legali è comunque ingiusta; tuttavia, secondo il tribunale i soggetti offesi dal reato avevano accettato di pagare la somma pretesa dagli avvocati non a causa di una pressione, esplicita o implicita, ma
soltanto perché si trovavano in una situazione di debolezza: di qui l’assoluzione per insussistenza del fatto (v.
sentenza C. Appello pagg. 28-29).
Secondo la Corte territoriale, invece, la minaccia ci fu,
sebbene implicita. Essa è ricavabile dall’ingiustizia della
richiesta, dalla personalità dei soggetti attivi, dalle circostanze e dalla posizione dei soggetti passivi. Gli imputati
sapevano che le parti offese non avevano alcuna possibilità di opporre loro un rifiuto e finirono obtorto collo per
l’accettare la somma ridotta di lire 360 milioni, pur ritenendola non dovuta; né è possibile diversificare le posizioni dei due avvocati (pagg. 31 e inizio 32 della sentenza).
Per quanto riguarda la tentata estorsione, invece, essa è
attribuita da entrambi i giudici di merito al solo avv. A.,
il quale avrebbe preteso un “supplemento” di parcella superiore ai cento milioni (l’A. parlava di un residuo credito di 160 milioni), oltre i 360 milioni già versati; ed
avrebbe utilizzato come minaccia il fatto di servirsi dei
documenti ottenuti per frodare la legge per promuovere,
con la connivenza dell’I. S., azioni da parte della S. P. nei
confronti della M.., che sapeva prive di fondamento giuridico e che avevano il solo scopo di costringere i tre soci a versargli l’ulteriore somma richiesta.
Questa essendo, in estrema sintesi, la situazione fattuale e processuale de qua, si può passare all’esame dei ricorsi.
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
Motivi della decisione
Avverso l’indicata sentenza della Corte di Appello di Firenze, in data 26 marzo 2003, hanno proposto ricorso per
cassazione G. R. di persona, nonché il difensore dello
stesso G. e di A. S.
Il G. di persona ha dedotto un unico motivo, “inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, relativamente al disposto, di cui all’art. 629 c.p., in riferimento all’art. 606, comma 1 lett. b, c.p.p.”, specie sotto il
profilo della omessa valutazione e della mancata individuazione dell’ingiusto profitto del delitto di estorsione.
Il difensore del G. ha esposto cinque motivi: 1) Nullità
della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione
della legge penale, in relazione al disposto dell’art. 192
cod. proc. pen., nonché mancanza o manifesta illogicità
della motivazione (art. 606, lett. b ed e cod. proc. pen. ),
in ordine alla ritenuta sussistenza di prove a carico dell’avv. G.; 2) Nullità della sentenza per inosservanza ed
erronea applicazione della legge penale, in relazione al
disposto dell’art. 521 cod. proc. pen., nonché mancanza
o manifesta illogicità della motivazione (art. 606, lett. b
ed e cod. proc. pen. ), per mancanza di correlazione tra
l’imputazione contestata e la sentenza; 3) Nullità della
sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della
legge penale, in relazione al disposto dell’art. 629 cod.
pen., nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. b ed e cod. proc. pen. ), circa la
ritenuta sussistenza della minaccia implicita; 4) Nullità
della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione
della legge penale, in relazione al disposto dell’art. 629
cod. pen., nonché mancanza o manifesta illogicità della
motivazione (art. 606, lett. b ed e cod. proc. pen. ), circa
la ritenuta sussistenza del profitto ingiusto; 5) Nullità
della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione
della legge penale, in relazione al disposto dell’art. 629
cod. pen., nonché mancanza della motivazione (art.
606, lett. b ed e cod. proc. pen. ), circa l’elemento psicologico del reato.
Il difensore dell’A. ha dedotto sei motivi: 1) Violazione
dell’art. 606 lett. b c.p.p. in relazione agli artt. 1325,
1418, comma 2°, 2229 e 2233 c.c., consistente nell’inosservanza e nell’erronea applicazione di norme giuridiche
diverse dalla legge penale, di cui si doveva tenere conto
nell’applicazione della legge penale; 2) Violazione dell’art. 606 lett. 3 c.p.p., consistente nella omessa o comunque nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, su un
punto decisivo della causa; 3) Violazione dell’art. 606,
lett. e c.p.p., consistente nella omessa motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, su un
punto decisivo della causa; 4) Violazione dell’art. 606,
lett. b), c.p.p., consistente sia nell’inosservanza o erronea
applicazione di norme penali con riferimento all’art. 629
c.p., sia nell’inosservanza di norme extrapenali delle
quali si doveva tenere conto nell’applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 1321 c.c.; e violazione
dell’art. 606, lett. e, consistente nell’omessa motivazione
risultante dal testo del provvedimento impugnato, su un
punto decisivo della causa; 5) Violazione dell’art. 606,
lett. e) c.p.p., consistente nella omessa motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, circa
un punto decisivo della causa; 6) Violazione dell’art.
606, lett. e), c.p.p., per omessa motivazione o comunque
per illogicità della stessa, circa l’esistenza dell’elemento
psicologico del reato di cui all’art. 629 c.p.p. Con riferimento ai motivi da 2) a 5), la difesa espone i vari punti,
a suo avviso decisivi, che la Corte territoriale non avrebbe considerato, o avrebbe male valutato, pervenendo ad
una decisione errata.
Sono state presentate memorie aggiuntive.
Ciò posto, ritiene la Corte che debba essere operata una
netta distinzione tra i due addebiti mossi agli imputati, i
relativi fatti e le conseguenti valutazioni.
Nucleo centrale della contestazione contenuta nel capo
A) sono due degli elementi costitutivi dell’estorsione: la
minaccia e il profitto ingiusto.
La minaccia delineata dall’accusa è una minaccia “implicita”, consistente nella possibilità di «rivelare la natura fittizia della documentazione fiscale emessa dalla S. P.
e dalla ditta V. G.»; l’ingiusto profitto è delineato in relazione alla «pretesa di pagamento di una parcella pari a
lire 500 milioni, poi ridotti a lire 350 milioni, ... quale
compenso per l’attività prestata al fine di ottenere, negli
illeciti modi sopra descritti, il dissequestro dei 69 kg. di
oro».
Al riguardo si deve subito rilevare che - come risulta dalla sentenza impugnata - le stesse parti coinvolte nella vicenda non ebbero mai a dubitare che ai due professionisti fosse dovuto un compenso per le loro prestazioni; che
in effetti questi ultimi svolsero una complessa attività difensiva su vari fronti. Si deve altresì rilevare che tale attività professionale fu prestata secondo i canoni delle varie procedure e con sapiente svolgimento di difesa tecnica: tutta questa attività non può dirsi inficiata da connotati di illiceità.
La sentenza impugnata, invero, dà atto che, secondo le
dichiarazioni dello stesso V., dopo il dissequestro dell’oro, gli orafi avevano chiesto il conto definitivo ai propri
avvocati che avevano presentato una notula di un miliardo, poi ridotti a 525 milioni. La notula era stata mostrata dal V. al M. ed era stata oggetto di una riunione
con i due avvocati nel corso della quale i soci della M.
contestavano l’esosità della richiesta, vi erano state lunghe discussioni ed alla fine l’importo delle spettanze era
stato ridotto a 360 milioni.
Ai fini della rilevanza penale di questi fatti deve, quindi,
tenersi conto che non era oggetto di contestazione tra le
parti che i due imputati avessero svolto un’attività difensiva in loro favore e che dovessero essere pagati; deve osservarsi che per la difesa tecnica prestata la richiesta di
compenso non era illecita; ne consegue che la disamina
deve essere rivolta verso le modalità e l’oggetto della richiesta.
Il “progetto di notula” presentato dai due avvocati si di-
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1119
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
stingueva in due parti: la prima parte riguardava le controversie con l’U.I.C. ed il Ministero del Tesoro, ed era
ulteriormente ripartita in “fase giudiziaria civile” e “fase
giudiziaria amministrativa”; la seconda parte riguardava
la “fase stragiudiziale”.
L’attenzione della Corte di merito si pone soprattutto su
quest’ultima voce, ritenuta sganciata da ogni concreto
riferimento a dati reali; a suo avviso non risultava che i
difensori avessero dovuto porre in essere un’attività così
pregnante, né che il valore del giro di affari trattato fosse dell’importo indicato.
La questione, proprio per il peculiare tipo di minaccia e
di ingiusto profitto contestato, va vista in un contesto
più ampio, dato che il compenso era in realtà esaustivo
di tutta l’opera professionale del rapporto avvocatocliente.
La soc. M. si trovò in una situazione di particolare difficoltà: un ingente quantitativo di oro sequestrato, la possibilità di estensione di indagini a S. Marino, la grave situazione finanziaria con esposizione debitoria ingente.
L’attività professionale si estese su tutti questi versanti,
finanche a far ottenere un finanziamento di due miliardi. Dal contesto motivazionale si evince che, quanto al
capo A), la somma pretesa dai due legali era - come detto - esaustiva di tutta la loro opera.
In questo quadro, che ebbe sbocchi positivi per la società
(dissequestro dell’oro, finanziamento, reiezione di rogatoria internazionale), si innesta la richiesta dei due imputati, che è andata progressivamente diminuendo e che
è stata oggetto di trattative e di successivi accomodamenti. Tra i soci della società, che contestavano l’esosità
della richiesta iniziale, ed i due avvocati vi erano state
«lunghe discussioni ed alla fine l’importo delle spettanze
era stato ridotto a 360 milioni».
Può, quindi, affermarsi che in sede di merito è stato accertato che la società, e per essa i soci, ritennero di dover
pagare onorari per incisive e consistenti prestazioni professionali effettivamente erogate; che l’importo richiesto
inizialmente fu oggetto di contestazioni e trattative che
portarono ad un accordo; che l’importo finale fu fissato
in una somma pur sempre considerevole, ma notevolmente inferiore a quella originaria; che tale somma fu
pagata e le parti, in buona sostanza, considerarono la vicenda conclusa (venne alla luce solo a seguito di indagini della P.G. su altri versanti).
Sulla base di questi dati di fatto - accertati in maniera
congrua e coerente e quindi non sindacabili in sede di legittimità - la Corte di Appello conclude con un percorso argomentativo, che si può sintetizzare nei termini che
seguono.
«Le ingiuste pretese economiche avanzate dagli imputati vanno messe in relazione alla situazione, ben descritta dal Tribunale, della società che era in gravi difficoltà economiche e nell’impossibilità di ricorrere al
credito bancario». Il finanziamento ottenuto dal G.,
grazie all’intermediazione dell’avv. G., era stato erogato solo in parte. «Ora era evidente per tutti che il G.,
1120
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
così come aveva speso la sua influenza con il G. per far
ottenere il mutuo, poteva con maggiore facilità bloccare il finanziamento (v. dichiarazioni del M.). ... In sostanza gli orafi, pur rendendosi conto che agli avvocati,
per il ruolo svolto nella vicenda, spettava un compenso speciale ritenevano le pretese degli avvocati esorbitanti e non dovute e tuttavia non erano in condizioni
di opporre un rifiuto, perché erano coscienti che correvano il rischio di non ottenere il residuo importo del
mutuo. Si deve aggiungere che i due legali ... erano venuti a conoscenza del conto bancario a San Marino ...
era fin troppo evidente che gli avvocati, se chiamati a
fornire giustificazioni sul valore attribuito alla fase stragiudiziale, avrebbero immediatamente parlato del conto bancario di San Marino e della funzione cui era destinato. ... ... In conclusione gli imputati chiedevano
cifre non dovute, sapendo che i propri clienti non avevano alcuna possibilità di opporre un rifiuto, allora appare inutile ricordare che mai gli avvocati giunsero a
minacciare le parti offese per costringerle ad accettare
l’esoso pagamento».
Al riguardo deve osservarsi che, secondo la consolidata
giurisprudenza di questa corte, la minaccia costitutiva
del delitto di estorsione oltre che essere palese, esplicita
e determinata, può essere manifestata in modi e forme
differenti, anche in maniera implicita, larvata, indiretta
ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla
personalità dell’agente, alle condizioni soggettive della
vittima od alle condizioni ambientali in cui questa opera (v. Cass., Sez. 3, anno/numero 2001/20382 rv
219866).
Tuttavia deve pur sempre essere una minaccia strettamente collegabile alla condotta dell’agente, quale rappresentatasi e voluta dall’agente stesso, che deve porre la
controparte in condizione di non avere scelte e di essere
costretta a subire la situazione minatoria.
Ad esempio nella richiesta da parte del ladro di una somma di denaro per la restituzione della refurtiva, non esistono alternative alla perdita del bene, di modo che la
stessa condotta è implicitamente minatoria.
In buona sostanza, non può affermarsi che si configura
necessariamente ed automaticamente il delitto di estorsione ogni volta che vi siano rapporti tra una parte più
forte ed una più debole, per lo squilibrio oggettivo esistente, ma deve rigorosamente provarsi che nel singolo
caso concreto vi sia - fra gli altri - il requisito della minaccia, sia pure implicita, dovuta al comportamento cosciente e volontario del soggetto più forte.
Nel caso di specie la richiesta dei legali e le trattative
intercorse dimostrano che la condotta degli agenti non
era a direzione univoca, ossia necessariamente minatoria, dal momento che la possibilità di far sospendere l’erogazione del prestito e di far emergere il conto sammarinese era soltanto una delle possibili opzioni, mai
neppure cripticamente emersa dai fatti, se non da sup-
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
posizioni. Per altro non è consona alle emergenze processuali l’affermazione che gli imputati chiedevano cifre non dovute; essi avanzavano pretese relative a prestazioni professionali, sicuramente dovute nell’an; di
modo che il contesto minatorio sarebbe comunque limitato ad un’eventuale eccedenza della richiesta, laddove gli stessi orafi ritenevano di dovere un “compenso speciale”.
Dalla situazione accertata in sede di merito si ricava,
invece, come detto, che i legali presentarono un conto elevato e poi lo ridimensionarono in seguito a trattative.
La mancanza di un collegamento della pretesa minaccia
implicita con la condotta degli imputati emerge - oltre
che dal complessivo contesto motivazionale della sentenza impugnata, di cui si è detto, che fa riferimento
piuttosto a timori e supposizioni soggettive degli orafi anche dalla stessa incertezza nella definizione del contenuto della minaccia come si evince anche dal fatto che
nel capo d’imputazione tale minaccia è configurata nella possibilità di rivelare la natura fittizia della documentazione fiscale emessa dalla “S. P.” e dalla ditta “V. G.”,
mentre nella sentenza si conclude nel senso che essa si
collega al «rischio di non ottenere il residuo importo del
mutuo» e al fatto che gli avvocati avrebbero parlato del
mutuo a San Marino.
In definitiva, sono stati accertati in fatto i seguenti elementi: un “compenso speciale” era dovuto; ci furono
trattative sfociate in un accordo con forte riduzione della richiesta iniziale; i clienti, sia pure di mala voglia, pagarono e considerarono chiusa la vicenda; non è stato
definito univocamente l’esatto contenuto della minaccia implicita, in correlazione con l’imputazione come
contestata; non sono emerse condotte diverse dalla iniziale richiesta “esosa”, tali da far discendere l’esistenza di
una minaccia voluta ed attuata dai legali, in via criptica,
indiretta ed emergente ex se.
Ne deriva che, come aveva esattamente ritenuto il Tribunale, la minaccia implicita non poteva essere ritenuta
esistente per il solo fatto che gli orafi erano la parte contraente più debole; in difetto di concreti elementi su uno
degli elementi configuranti il delitto di estorsione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in
ordine al capo a), nei confronti di entrambi gli imputati,
perché il fatto non sussiste.
L’annullamento è senza rinvio dato che i fatti sono stati
esaurientemente accertati e delineati e un eventuale
nuovo giudizio di merito non potrebbe avere il compito
di colmare situazioni di vuoto probatorio, mentre le qualificazioni giuridiche dei fatti appartengono al giudizio di
questa Corte.
Questa conclusione assorbe tutti i motivi di ricorso presentati in favore di G. R., nonché i primi tre motivi presentati in favore di A. S., e parte del quarto.
I residui motivi di quest’ultimo imputato riguardano la
contestazione sub B); essi, in realtà, tendono a contestare la ricostruzione dei fatti e le conclusioni operate
dalla Corte di merito, specie nell’assunto che la ulteriore richiesta di denaro non costituirebbe un surplus rispetto ai 360 milioni di cui al capo A), non vi sarebbero minacce e non si tratterebbe di una richiesta ingiusta.
Tutti i motivi concernenti il capo B) si dimostrano
infondati.
La Corte di Appello, con argomentazioni immuni da vizi logico - giuridici, ha accertato in fatto, attraverso molteplici testimonianze non solo delle persone offese dal
reato che, oltre la somma di lire 360 milioni, vi fu un’ulteriore richiesta di pagamento di lire 160 milioni da parte dell’A.; che quest’ultimo, quando seppe che gli orafi
non volevano accedere alle sue richieste, aveva avvertito che avrebbe intrapreso azioni giudiziarie e cautelari
contro la M., azionando i presunti crediti vantati dalla S.
P.; che, «con una totale spregiudicatezza, si servì del simulato contratto tra la M. e la S. P. e delle lettere apparentemente provenienti dalla ditta spagnola, che in
realtà egli stesso aveva formato a suo tempo per rendere
credibile la messa in scena» per iniziare un’azione per
danni, con richiesta di sequestro conservativo, mettendo «in atto un formidabile strumento di pressione idoneo a costringere la M. a cedere alle sue ingiuste pretese
economiche».
Questa situazione - ampiamente descritta in sentenza
con profusione di coerenti supporti probatori - configura, in tutti i suoi elementi un’azione estorsiva, fermatasi
alla fase del tentativo.
La minaccia di iniziare un’azione giudiziaria creata artificiosamente, sulla base di atti formati per altri fini, per ottenere il pagamento di una somma non dovuta, in quanto ulteriore a quella già versata per le prestazioni professionali; la utilizzazione effettiva di tale “spregiudicata”
iniziativa giudiziaria; le espressioni usate: tutti questi fatti contengono una minaccia palese, e palesata, alla quale le persone offese non avevano possibilità di opporsi;
tale minaccia era volta ad ottenere un profitto ingiusto;
le azioni giudiziarie furono effettivamente iniziate, dimostrandosi inequivoche e del tutto idonee a condurre in
porto le illecite mire del prevenuto.
La situazione di fatto, accettata in relazione al capo B), è,
per altro, anche una dimostrazione indiretta della mancanza di minacce nella richiesta di pagamento delle prestazioni professionali di cui al capo A).
Risulta, quindi, corretta l’affermazione di responsabilità
di A. S. in ordine al reato contestato al capo B), occorrendo rinviare ad altra Sezione della corte di Appello di
Firenze per la determinazione della relativa pena, non
essendo possibile per questa Corte provvedere ai sensi
dell’art. 619 comma 2 c.p.p.
(Omissis).
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1121
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
IL COMMENTO
di Roberta Febbrai
La minaccia costitutiva del reato di estorsione deve
essere riscontrabile in concreto come fatto direttamente ed esclusivamente dipendente dal comportamento volontario e cosciente del soggetto agente,
non potendo essere presunta o ricavata dal contesto
ambientale o dalla posizione socio-economica dei
soggetti coinvolti. L’assenza di una condotta dotata
di reale attitudine cogente ascrivibile all’agente ed
univocamente percepibile dal soggetto passivo impedisce pertanto la configurabilità della fattispecie
obiettiva dell’estorsione.
Con la decisione in esame, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Firenze del 26 marzo 2003 che riconosceva i due imputati,
nella veste di difensori, colpevoli del delitto di estorsione per aver posto in essere, benché implicitamente, una
minaccia in danno dei tre clienti, costringendoli a versare, come corrispettivo per l’attività professionale svolta,
una somma di denaro esorbitante, così procurandosi l’ingiusto profitto con altrui danno ai sensi dell’art. 629 c.p.
La Suprema Corte, chiamata ad accertare che nella
fattispecie concreta fossero riscontrabili gli elementi costitutivi del reato di estorsione rappresentati dall’ingiusto profitto e dalla minaccia, ripercorre la motivazione
posta dalla Corte d’appello di Firenze a fondamento della sentenza di condanna e ne prende le distanze. Per
quanto concerne l’elemento costitutivo dell’ingiusto
profitto, la Corte ne ha escluso la sussistenza, negando la
natura illecita, e quindi ingiusta, della pretesa di pagamento della parcella da parte dei due legali. La Corte ha
infatti rilevato che dalla ricostruzione dei fatti effettuata
in sede di merito risulta che i due difensori avevano prestato una complessa attività giudiziale e stragiudiziale a
favore dei tre clienti, attività tra l’altro esercitata con sapiente svolgimento di difesa tecnica, come confermato
dal buon esito sia del processo penale che di quello amministrativo. Gli stessi clienti, continua la Corte, non
ebbero del resto mai a dubitare che un compenso fosse
dovuto ai legali, posto che furono i soci medesimi a chiedere il conto definitivo ai propri avvocati e, una volta effettuato il pagamento, a considerare “chiusa la vicenda”.
Le pretese di compenso avanzate dagli imputati devono
pertanto considerarsi sicuramente dovute, in considerazione delle complesse prestazioni professionali effettivamente rese. Per quanto concerne poi un’eventuale eccedenza della parcella, e la conseguente possibilità di individuare l’ingiustizia della richiesta in relazione al quantum, la Cassazione ha rilevato che l’importo inizialmente fissato dai legali venne notevolmente ridotto in seguito alla contestazioni sollevate dai soci. Al termine di nu-
1122
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
merose discussioni tra le parti si giunse infatti ad un accordo, con cui l’importo finale fu fissato in una somma
che, pur essendo comunque considerevole, era assai inferiore a quella originaria: tale compenso, conclude la
Corte, risultava esaustivo di tutta l’opera professionale
svolta. Gli stessi soci, del resto, riconoscevano che un
“compenso speciale” era dovuto ai legali per le incisive e
consistenti prestazioni ricevute.
Ritenuta di per sé lecita, e pertanto dovuta, la richiesta del compenso, la Cassazione si è soffermata sulle
modalità della richiesta medesima, per verificare se esse
abbiano integrato l’ulteriore requisito della minaccia.
Poiché gli imputati mai giunsero a minacciare le parti offese per costringerle ad accettare il pagamento, la Suprema Corte ha dovuto stabilire, in particolare, se nella richiesta dei legali fosse ravvisabile una minaccia c.d. implicita, idonea, in relazione alle circostanze del caso concreto, a coartare la volontà dei clienti e a costringerli a
corrispondere l’ingente cifra. La Corte d’Appello di Firenze aveva infatti desunto l’elemento costitutivo de quo
sia dalla pretesa natura ingiusta della richiesta, sia dalla
personalità degli agenti che dalla posizione dei soggetti
passivi. Questi ultimi si sarebbero visti costretti a pagare
la cifra richiesta per il timore che il finanziamento in
corso, ottenuto grazie all’influenza degli avvocati medesimi, potesse essere bloccato, con conseguente aggravamento della già difficile situazione economica in cui versava la società. Secondo la Corte territoriale gli imputati sapevano che le parti offese non avevano alcuna possibilità di opporre un rifiuto e queste finirono obtorto collo per accettare la somma finale richiesta, pur ritenendola non dovuta. Secondo i giudici di secondo grado, dunque, la condotta degli imputati risulterebbe, in relazione
alle circostanze concrete, caratterizzata dalla nota modale della minaccia, realizzata in forma implicita, quale
strumento coercitivo della volontà altrui ex art. 629 c.p.
Con la sentenza qui in commento, la Cassazione
conferma il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la minaccia costitutiva del delitto di
estorsione, oltre che essere palese, esplicita e determinata, può essere manifestata in modi e forme differenti,
anche in maniera implicita e larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle condizioni soggettive della vittima
ed alle condizioni ambientali in cui questa opera (1).
Pur dando atto che la minaccia rilevante ex art. 629 c.p.
può manifestarsi anche in forma implicita e indiretta, la
Nota:
(1) Per la giurisprudenza in materia di minaccia c.d. implicita, v. note 1112.
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
Suprema Corte ha peraltro chiarito che «deve pur sempre essere una minaccia strettamente collegabile alla
condotta dell’agente, quale rappresentatasi e voluta dall’agente stesso, che deve porre la controparte in condizione di non avere scelte e di essere costretta a subire la
situazione minatoria». Ed è sulla base di tale precisazione che la Suprema Corte è giunta ad escludere che nella fattispecie concreta siano ravvisabili gli estremi dell’estorsione. Il reato de quo, spiega infatti la Cassazione,
non può considerarsi necessariamente ed automaticamente configurato «ogni volta che vi siano rapporti tra
una parte più forte ed una più debole, per lo squilibrio
oggettivo esistente», essendo invece necessario che nel
singolo caso ricorra, tra gli altri, il requisito della minaccia, sia pure implicita, dovuta al comportamento cosciente e volontario del soggetto più forte. Nel caso di
specie, invece, i giudici di legittimità hanno rilevato
che la condotta degli imputati non era necessariamente
minatoria: il fatto che tra i legali ed i clienti siano intercorse trattative, conclusesi con la riduzione dell’ammontare della parcella, dimostra, al contrario, che la
condotta dei legali non era a direzione univoca. La loro
richiesta di compenso non ha infatti costituito un fatto
obiettivamente intimidatorio, collegato cioè all’imminenza di danni reali e diretti, dal momento che la possibilità che gli avvocati, in caso di mancato pagamento,
facessero emergere il conto sammarinese e sospendere
l’erogazione del prestito, con conseguente aggravamento della situazione economica della s.r.l., era soltanto
una delle possibili opzioni, mai neppure cripticamente
emersa dai fatti, se non da mere supposizioni e semplici
timori soggettivi degli orafi. La Cassazione ha dunque
dichiarato l’insussistenza del fatto di estorsione in relazione alla fattispecie concreta per la mancanza di una
condotta dotata di reale attitudine cogente ascrivibile
agli imputati e univocamente percepibile dai soggetti
passivi, dalla quale far discendere l’esistenza di una minaccia voluta ed attuata dagli imputati, in via criptica,
indiretta ed emergente ex se.
La progressiva estensione della minaccia
ai confini della forma “implicita”
Il fatto costitutivo del reato di estorsione consiste
nel procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno, costringendo taluno, mediante violenza o minaccia, a fare
o ad omettere qualcosa (2). L’azione criminosa deve essere qualificata dalla violenza e dalla minaccia, quali
strumenti coercitivi della volontà altrui, utilizzati dall’agente singolarmente o in via cumulativa.
In generale, per quanto attiene alla nota modale
della minaccia, essa consiste nella prospettazione ad una
persona di un male futuro, ovvero della prosecuzione di
uno stato penoso preesistente (3), dipendente dalla volontà dell’autore e tale da raggiungere l’effetto di coartazione della volontà del soggetto passivo. In mancanza di
ulteriori precisazioni da parte del legislatore, che non ha
ritenuto di delimitarne la nozione mediante il ricorso ad
elementi normativi come, ad esempio, quelli della giustizia/ingiustizia o della liceità/illiceità, si ritiene che la
minaccia di cui all’art. 629 c.p. non debba essere necessariamente “ingiusta”, e cioè “non coperta” dal diritto
(sine jure) né contraria alle disposizioni esistenti in un
qualche settore dell’ordinamento (contra ius). Essa può
cioè avere ad oggetto qualsiasi danno futuro, prescindendosi dalla valutazione della sua rilevanza favorevole
o sfavorevole nell’ordinamento penale o extrapenale
(4). Il male minacciato può riguardare qualsiasi bene del
soggetto passivo, sia personale (oltre la vita e l’incolumità fisica o psichica, l’onore, la reputazione, il pudore,
ecc.) sia patrimoniale (ad esempio, la minaccia di distruggere un oggetto altrui di valore), dovendosi però
sempre trattare di un bene giuridicamente rilevante (tale non è la prospettazione di rompere un’amicizia o di togliere il saluto, trattandosi di rapporti meramente sociali). La minaccia di danno può anche essere rivolta ad un
bene di cui la vittima non ha ancora la disponibilità, essendo sufficiente che l’azione intimidatrice sia in grado
di determinare quest’ultima alla prestazione richiesta
(5), nonché essere diretta, oltre che al soggetto passivo
del reato, anche ad una terza persona particolarmente legata al primo, poiché in tal caso il male prospettato al
terzo si presenta come male anche per l’effettivo destinatario (6). Affinché la minaccia assuma il carattere di
mezzo coercitivo è peraltro necessario che il male miNote:
(2) Sull’estorsione, in generale, cfr. D. Angelotti, Delitti contro il patrimonio,
in Trattato di diritto penale, Milano, 1934, 294 ss.; F. Antolisei, Manuale di
Diritto penale - Parte speciale, Milano, 2002, 405 ss.; F.G. Barbalinardo, Brevi note in tema di rapporti fra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione e di concorso di persone nel reato configurabile, in Giur. merito, 1989, 958
ss.; F. Bellini, Appunti schematici sull’estorsione, in Riv. pen., 1989, 655 ss.; L.
Conti, voce Estorsione, in Enc. dir., XV, 1966, 995 ss.; A. De Marsico, Delitti contro il patrimonio, Napoli, 1951, 78 ss.; G. Fiandaca-E. Musco, Diritto
penale - Delitti contro il patrimonio, Bologna, 1996, 142 ss.; F. Mantovani,
Diritto penale - Delitti contro il patrimonio, Padova, 1989, 147 ss.; Id., voce
Estorsione, in Enc. giur. Treccani, XIII, 1988; V. Manzini, Trattato di diritto
penale italiano, IX, Torino, 1938, 346 ss; G. Maggiore, Diritto penale - Parte
speciale, Bologna, 1948, II, 2, 971 ss.; G. Marini, Delitti contro il patrimonio,
Torino, 1999, 213 ss; Id., voce Estorsione, in Dig. disc. pen., IV, 1990, 377
ss; M.A. Marra, Estorsione, in Riv. pol., 2002, 3, 403 ss.; D. Pisapia, Reati
contro il patrimonio, Milano, 1948, passim; G. Ragno, Il delitto di estorsione,
Milano, 1966, passim; A. Salvini, Estorsione e sequestro di persona a scopo di
rapina o di estorsione, in Noviss. dig. it., VI, 1960, 1000 ss.; O. Vannini, Manuale di diritto penale italiano - Parte speciale, Milano, 1951, 346 ss. Su questioni particolari, P. Pisa, Consegna del denaro sotto controllo: reato consumato o tentato?, in questa Rivista, 1996, 601 ss.; Id, Istituito il fondo di solidarietà
per le vittime di richieste estorsive, ivi, 1999, 278 ss.
(3) F. Mantovani, Diritto penale, cit., 49, il quale riporta l’esempio della
minaccia di persistere nel sequestro.
(4) In tal senso, Cass., Sez. I, 10 maggio 1982, Pilone, in Cass. pen., 1984,
865. In dottrina, G. Fiandaca-E. Musco, Diritto penale, cit., 14; G. Marini, Estorsione, cit., 381. Nel senso, invece, della necessaria ingiustizia del
danno, Cass., Sez. II, 26 settembre 1996, De Carlo, in Riv. pen., 1997,
170. In dottrina, L. Conti, Estorsione, cit., 997; D. Salvini, Estorsione, cit.,
1001.
(5) Cass., Sez. II, 5 marzo 2002, Sassolino, in Cass. pen., 2003, II, 1558.
(6) In tal senso, Cass., Sez. II, 24 marzo 1972, Balsamo, in Cass. pen.,
1973, 999.
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1123
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
nacciato venga prospettato come dipendente dalla volontà dell’agente, versandosi altrimenti in un’ipotesi di
semplice avvertimento, come nel caso del medico che
prospetti al paziente una rapida fine in caso di rifiuto delle cure (7). Pertanto, dovendo il male apparire causalmente ricollegabile ad un comportamento del soggetto,
la dottrina prevalente ritiene che la minaccia possa avere ad oggetto, oltre che un’azione, anche un’omissione, a
condizione però che, secondo quanto dettato dall’art. 40
comma 2 c.p., sul soggetto agente gravi un obbligo giuridico di compiere l’azione la cui omissione viene minacciata (8).
In particolare, per quanto concerne le modalità della minaccia, come evidenziato dalla Cassazione anche
nella sentenza in commento, essa può assumere gli aspetti più diversi. La casistica dimostra le infinite forme in cui
la minaccia si concreta e i modi sempre nuovi in cui si
presenta, cosicché, in nessun reato, più che nell’estorsione, «l’interprete deve penetrare con acuto senso di esperienza il rivestimento esteriore delle forme per rendersi
conto del proposito vero dell’agente e della idoneità del
mezzo che egli adopera» (9). Sia in dottrina che in giurisprudenza si riscontra un incontrastato orientamento favorevole ad interpretare in chiave espansiva il requisito
della minaccia, quale contrassegno strutturale di caratterizzazione normativa della condotta punibile a titolo di
estorsione ex art. 629 c.p. La dottrina è infatti concorde
nel precisare che la minaccia può essere fatta direttamente o a mezzo di intermediario, in modo palese o larvato,
reale o simbolico; espressa con parole, gesti, scritti, disegni, oggetti; operata per posta, telefono, mass media ecc.
(10). Analogamente, la giurisprudenza dominante, richiamata anche dalla pronuncia in esame, è costante
nell’affermare che, ai fini della coartazione della volontà
della persona offesa, sono indifferenti la forma e le modalità della minaccia, diretta o indiretta, palesa o larvata,
reale, figurata o scritta, determinata o indeterminata, essendo solo necessaria la sua idoneità, in relazione alle circostanze concrete, ad incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo (11). In particolare, gli organi
giudicanti ritengono integrato l’elemento costitutivo della minaccia dell’estorsione anche in presenza della c.d.
minaccia implicita, caratterizzata cioè da un messaggio
intimidatorio velato e non esplicitato apertamente, purché percepibile dal destinatario e tale da far sorgere in
quest’ultimo il timore di un concreto pregiudizio (12).
Così, ad esempio, è stato recentemente ritenuto configurabile, il reato di estorsione nei confronti del titolare di
un’azienda che versava ai dipendenti una retribuzione inferiore a quella dovuta, trattandosi di comportamento
idoneo a condizionare la volontà dei soggetti passivi, interessati ad assicurarsi una possibilità lavorativa che sarebbe stata altrimenti esclusa; analogamente è stato qualificato come tentativo di estorsione quello posto in essere da un soggetto operante nell’ambito delle aste giudiziarie il quale, consapevole dell’interesse nutrito dalla persona offesa, proprietaria al cinquanta per cento di un bene
1124
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
immobile la cui residua quota era stata messa all’asta, ad
ottenerne l’aggiudicazione, aveva richiesto il versamento
di una somma di denaro come unico mezzo per garantire
tale risultato (13). Secondo tale impostazione, la connotazione della condotta come minacciosa e la sua idoneità
ad integrare l’elemento strutturale del delitto de quo devono essere valutate in relazione alle circostanze oggettive del caso concreto, con la conseguenza che la minaccia
di cui all’art. 629 c.p. deve considerarsi sussistente ogni
volta in cui, avuto riguardo alla personalità sopraffattrice
dell’agente, alle circostanze ambientali, all’ingiustizia della pretesa, alle particolari condizioni della vittima, questa, di fronte all’ingiusta richiesta dell’agente, venga a trovarsi nella condizione di doverne subire la volontà, per
evitare, in caso di mancata adesione, il paventato verificarsi di un più grave pericolo (14). Si è così affermato che
è da ritenersi sufficiente «la prospettazione di un male
che, in relazione alle circostanze che lo accompagnano,
sia tale da far sorgere nella vittima il timore di un grave
pregiudizio» (15) e che «la richiesta di denaro (…) integra gli estremi del delitto di estorsione anche se formulata in termini di estrema cortesia, quando l’invito a pagare serva ad incutere nella vittima il timore di rischi e pericoli inevitabili (…) implicitamente, per le allusioni generiche a danni futuri» (16). Anche un comportamento
Note:
(7) F. Mantovani, Diritto penale, cit., 49.
(8) In tal senso, L. Conti, Estorsione, cit., 998; G. Marini, Estorsione, cit.,
383. Sull’argomento cfr. C. Pedrazzi, Estorsione mediante minaccia di comportamento omissivo?, in Riv. it. dir. e proc. pen, 1980, 1445 ss.
(9) A. De Marsico, Delitti contro il patrimonio, cit., 81.
(10) L. Conti, Estorsione, cit., 998; Fiandaca-E. Musco, Diritto penale, cit.,
148; F. Mantovani, Diritto penale, cit., 50; V. Manzini, Trattato, cit., 352;
A. Salvini, Estorsione, cit., 1001.
(11) Cass., Sez., VI, 25 febbraio 1998, Pera, in Cass. pen., 1999, 1448;
Cass., Sez. II, 24 aprile 1985, Sedicino, in Giust. pen., 1986, II, 216; Cass.,
sez. II, 8 novembre 1983, Bulletti, in Riv. pen., 1985, 389; Cass., Sez. II,
22 febbraio 1983, Langella, in Giust. pen., 1984, II, 285; Cass., Sez. I, 9
aprile 1981, Formisano, ivi, 1982, II, 90; Cass., Sez. II, 20 febbraio 1979,
Rapocciolo, in Cass. pen., 1980, 1277; Cass., Sez. I, 19 gennaio 1979,
Quarta, in Giust. pen., 1979, II, 622.
(12) Cass., Sez. III, 10 aprile 2001, Massaro, in Cass. pen., 2002, 2361;
Cass., Sez. I, 13 febbraio 1995, Mingacci, ibidem, 498; Cass., Sez. II, 19
giugno 1986, Calvino, ibidem, II, 556; Cass., Sez. II, 19 novembre 1985,
Fichera, ivi, 1987, 547; Cass., Sez. II, 24 aprile 1985, Sedicino, cit.; Cass.,
Sez. I, 12 luglio 1982, Sentinella, in Cass. pen., 1984, 63; Cass., Sez, I, 22
gennaio 1980, Cassaro, in Giust. pen., 1980, II, 696; Cass., Sez. I, 10 gennaio 1980, Del Cosimo, ibidem, 696; Cass, Sez. I, 5 novembre 1979, Mannolo, in Cass. pen., 1981, 31; Cass., Sez. I, 18 aprile 1979, Artistico, in
Giust. pen., 1980, II, 169; Cass., Sez. I, 2 marzo 1979, Bussolino, ivi, 1979,
II, 623.
(13) Rispettivamente, Cass., Sez. II, 13 novembre 2001, Zaccuri, in Cass.
pen., 2002, 3460 e Cass., Sez. VI, 26 gennaio 1999, Savian, in Riv. pen.,
1999, 566.
(14) Cass., Sez. II, 15 maggio 1991, Rizzi, in Giust. pen., 1992, II, 46.
(15) Cass., Sez. VI, 19 settembre 1990, Matarazzo, in Giust. pen., 1991,
II, 354
(16) Cass., Sez. II, 2 marzo 1987, Soriano, in Foro it. Rep., 1988, voce
Estorsione, n. 5.
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
apparentemente corretto come la richiesta di denaro fatta sotto forma di colletta presso gli abitanti di rione e a
beneficio degli ex-detenuti, è stato ritenuto integrare il
reato di estorsione, trattandosi di condotta implicitamente portatrice di minacce (17). In una siffatta prospettiva,
che tende a dare del concetto di minaccia un’interpretazione estremamente lata, persino l’esortazione e la preghiera, quando per le modalità di ambiente o di persona
siano tali da esercitare un’apprezzabile pressione sull’animo del destinatario, possono infatti acquisire rilievo ex
art. 629 c.p. (18)
cussione (22), tali decisioni finiscono con l’esportare
la formula del condizionamento ambientale al di fuori
del particolare ambito dei delitti contro la pubblica
amministrazione nel quale era originariamente maturata. L’introduzione della parallela figura della c.d.
concussione ambientale (23), quale fattispecie incriminatrice espressa, è stata infatti a più riprese riproposta (24) con lo scopo di risolvere il controverso problema della distinzione tra i reati di concussione per
induzione e corruzione (25) realizzati in un contesto
Profili problematici della minaccia implicita:
la c.d. “estorsione ambientale”
Note:
Il riconoscimento da parte dell’indirizzo ermeneutico indicato della minaccia nella forma larvata solleva
peraltro delicati problemi in relazione all’ammissibilità
nel nostro ordinamento della c.d. estorsione ambientale,
legata al presunto clima di intimidazione eventualmente gravante sui consociati, o sui consociati trovatisi in alcune parti del territorio nazionale (19). Alcune recenti
pronunce hanno infatti considerato sussistere il reato di
estorsione in relazione ad uno stato di soggezione della
vittima connesso, per l’appunto, al contesto ambientale,
culturale e politico in cui l’estorsione era stata subdolamente operata. In particolare, il Tribunale di Vercelli ha
ritenuto che la semplice richiesta avente ad oggetto l’erogazione di un contributo per la costruzione dell’erigenda sede locale del partito, formulata da un politico locale, nei confronti di un imprenditore precedentemente
agevolato nel conseguimento di incarichi professionali
pubblici, integrasse gli estremi della minaccia ex art. 629
c.p. (20). I giudici di merito hanno ravvisato in tale condotta un’intrinseca potenzialità coattiva, derivante dal
suo collegamento organico con un più ampio e diffuso
contesto in cui si fa sistematicamente ricorso alla ‘tangente’ quale abituale meccanismo di scelta del contraente privato, interessato all’assegnazione delle commesse
pubbliche, da parte della organi della pubblica amministrazione. Nel caso di specie la minaccia, quale elemento tipico espresso del reato di estorsione, è stata considerata implicita, cioè contestuale alla richiesta di pagamento, in quanto “a quel livello di rapporti non occorrevano certo atti notarili per intendersi”. Sotto l’apparente libera dazione, avrebbe dunque operato un sottile
meccanismo di coazione ‘ambientale’, tale da indurre il
professionista a effettuare il pagamento.
Il riferimento al modello della c.d. estorsione ambientale, mai recepita dal nostro codice penale nonostante alcuni tentativi di riforma (21), risulta evidentemente escogitato dalla giurisprudenza al fine di attribuire rilevanza a condotte che altrimenti difficilmente
potrebbero rientrare nella fattispecie di cui all’art. 629
c.p., trattandosi di comportamenti che, in sé considerati, appaiono neutri, ossia privi di un messaggio intimidatorio univocamente percepibile. Valorizzando la
significativa contiguità esistente tra estorsione e con-
(18) In tal senso, L. Conti, Estorsione, cit., 998.
(17) Cass., Sez. II, 17 aprile 1986, Neri, in Cass. pen., 1988, 280.
(19) Sull’argomento, A. Tesauro, “Meglio prevenire che curare”: la c.d.
estorsione ambientale al vaglio della giurisprudenza di merito, in Foro it., 1995,
II, 366. Cfr. anche Cass., Sez. V, 28 marzo 2003, Lavornia, in Dir. giust.
2003, 21, 26, con nota di L. Cremonesi, La prova dell’estorsione “ambientale”.
(20) Trib. Vercelli, 2 febbraio 1995, Cattaneo, in Foro it, 1995, II, 365.
(21) All’art. 629 c.p. si voleva affiancare una seconda disposizione, destinata a disciplinare «altre attività estorsive»: si trattava dell’art. 629-bis,
dapprima inserito nel codice penale con l’art. 9 d.l. 29 ottobre 1991, n.
346 non convertito in legge, e poi con l’art. 9 d.l. 31 dicembre 1991, n.
419, soppresso quest’ultimo peraltro in sede di conversione in legge (art.
1 l. 18 febbraio 1992, n. 172). In base a tale disposizione, «salvo che il fatto costituisse più grave reato, la pena prevista dall’art. 629, primo comma,
si applicava nei confronti di chiunque realizzasse profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416bis. La pena era aumentata se i fatti fossero stati commessi da persona che
facesse parte dell’associazione di cui all’art. 416-bis».
(22) Sugli elementi differenziali tra i due reati, G. Contento, Commento
agli art. 317-317-bis, in AA.VV., I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, a cura di T. Padovani, Torino, 1996, 89 ss.; G. Forti, Sulla distinzione fra i reati di corruzione e concussione, in Studium Juris,
1997, 725 ss.; P. Gianniti, Corruzione e concussione. Riflessioni sui caratteri
differenziali, in Giur. it., 1995, IV, 33 ss.; C. F. Grosso, Commento agli art.
318-322, in AA.VV., I delitti dei pubblici ufficiali, cit., 224 ss.; Id, voce I delitti di corruzione nei progetti di riforma, in Dig. disc. pen., III, 168 ss.; G. Insolera, Corruzione e concussione nella riforma del diritto e del processo, in Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia, I, Milano, 2000, 662 ss.; R. Li Vecchi,
Vecchi e nuovi problemi ermeneutici in tema di concussione, in Riv. pen.,
1992, 705 ss.
(23) Sulla c.d. concussione ambientale, G. Contento, Concussione, in
AA.VV., I delitti dei pubblici ufficiali, cit., 116 ss.; C. Fiore, La “concussione
ambientale” quale spazio normativo?, in AA.VV., I delitti contro la pubblica
amministrazione - Riflessioni sulla riforma, in Quaderni della Riv. pen. economia, diretti da E. Palombi, I, Napoli, 1989, 114 ss.; G. Forti, L’insostenibile pesantezza della “tangente ambientale”: inattualità di disciplina e disagi applicativi nel rapporto corruzione - concussione, in Riv. it dir. e proc. pen, 1996,
476 ss.; M. Petrone, La nuova disciplina dei delitti degli agenti pubblici contro
la P.A.: dalle prospettive di riforma alla legge n. 86/90, ivi, 1993, 928 ss.; F.
Romano, La concussione ambientale, in Giur. merito, IV, 208 ss.
(24) La codificazione di una fattispecie di concussione ambientale era
stata originariamente proposta in diversi progetti di legge: d.d.l. n. 1780
presentato dall’on. Azzarro e altri in data 31 maggio 1984 alla camera dei
deputati; d.d.l. n. 2844 presentato dal ministro di grazia e giustizia Martinazzoli in data 31 maggio 1985 alla camera dei deputati; d.d.l. n. 2241
presentato dal ministro di grazia e giustizia Vassalli in data 7 marzo 1988
alla camera dei deputati.
(25) Sulla questione, per tutti, A. Pagliaro, Principi di diritto penale - Parte
speciale. Delitti contro la Pubblica Amministrazione, Milano, 1998, 164 ss.;
Id., Per una modifica delle norme in tema di corruzione e concussione (Atti del
(segue)
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1125
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
politico-amministrativo di sistematica criminalità, oggettivamente connotato dal ricorso permanente al pagamento di una “tangente” per ottenere quanto dovuto. Ed è proprio in ragione delle difficoltà che sorgono
nella qualificazione giuridica di singoli episodi criminosi realizzati all’interno di un sistema d’illegalità diffusa e consolidata che parte della giurisprudenza, facendo leva sui confini incerti della condotta induttiva
(26) di cui all’art. 317 c.p., ha valorizzato il paradigma
della concussione ambientale, «il cui dato distintivo è
rappresentato dal fatto che opera, da entrambe le parti, il riferimento ad una sorta di convenzione tacitamente riconosciuta, che il pubblico ufficiale fa valere
e che il privato subisce, nel contesto di una comunicazione resa più semplice nella sostanza e più sfumata
nelle forme per il fatto di richiamarsi a condotte già
“codificate”» (27). Tale orientamento riconosce dunque la sola responsabilità del pubblico ufficiale, affermando l’esistenza della concussione per induzione anche nel caso di tacita conferma della convinzione del
privato di versare nell’ipotesi di ineluttabilità del pagamento, ingenerata da una prassi illegale in tal senso,
ed arrivando ad attribuire rilievo anche alla situazione
in cui tra quanto operato dal pubblico ufficiale e la situazione psicologica di soggezione del privato non vi
sia alcun nesso specifico, essendosi il primo limitato a
sfruttare una preesistente condizione di timore (28).
Nonostante con alcune pronunce, nelle quali si è precisato che la condizione di costrizione in cui versa il
privato cittadino non può farsi derivare dalla generica
posizione di supremazia dell’agente pubblico, occorrendo «una costrizione o induzione qualificata», e cioè
«il concreto abuso…della qualità o funzione» (29), si
sia tentato in qualche maniera di “aggiustare il tiro”,
l’orientamento ermeneutico in esame solleva forti critiche proprio perché, di fatto, fa a meno del requisito
della condotta abusiva del pubblico ufficiale (30), ridotta a mere suggestioni tacite, ammissioni e silenzi da
parte del soggetto agente (31).
Decisioni che, come quella pronunciata dal Tribunale di Vercelli, ritengono integrata la fattispecie di
estorsione in presenza di un presunto “stato oggettivo di
soggezione”, diffuso in un dato contesto socio-culturale,
appaiono dunque erette su cadenze argomentative simili a quelle utilizzate dalla giurisprudenza indicata in materia di concussione ambientale, sollevando perplessità
analoghe in relazione all’effettiva integrazione dell’elemento oggettivo del fatto di reato in presenza di comportamenti fondati su una mera presunzione circa la
(pensabile) condotta dell’agente. Perplessità che non
possono non farsi ancora più forti se si considera che, in
relazione alla fattispecie di cui all’art. 317 c.p, il ricorso
ad un siffatto modello di penalizzazione aggiuntivo viene
realizzato dalla giurisprudenza grazie alla complicità della sfumata condotta induttiva, ridotta ad una forma “minore” o larvata di costrizione, non legata a forme predeterminate e tassative (32), laddove la fattispecie di cui
1126
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
all’art. 629 c.p. contempla soltanto la più chiara e delimitata condotta costrittiva (33).
Conclusioni
L’analisi degli orientamenti ermenuetici indicati
nel paragrafo precedente consente di valutare appieno la
portata della sentenza qui in commento, con cui la Cassazione, pur dando atto che la minaccia del delitto di
estorsione non deve essere necessariamente verbalizzata
in modo diretto e manifesto, ha precisato l’esatta latitudine da assegnare all’elemento costitutivo de quo.
La Suprema Corte circoscrive il perimetro dei fatti
punibili ex art. 629 c.p. ai soli comportamenti in cui sia
fenomenicamente accertabile una condotta di tipo costrittivo ascrivibile all’agente della pretesa estorsione, la
quale risulti collegata, come causa ad evento, alla condizione di timore e lesione della libertà di autodeterminaNote:
(continua nota 25)
Convegno di Studi di diritto penale, Bari, 21-22 aprile 1995), Bari, 1995,
19. Cfr. altresì E. Palombi, Il delitto di concussione nelle prospettive di riforma,
in AA.VV., La riforma dei delitti contro la Pubblica amministrazione, a cura
di A. Stile, Napoli, 1987, 276 ss. Sull’argomento, amplius, M. Pelissero, Il
ruolo della vittima ad un bivio: il fenomeno della corruzione, in AA.VV., Ruolo e tutela della vittima in diritto penale, in Quaderni del Dipartimento di diritto pubblico (Università di Pisa), Torino, 2004, 159 ss.
(26) Sul punto, E. Palombi, La concussione, Torino, 1998, 7 ss.
(27) Cass., Sez. VI, 19 gennaio 1998, Pancheri, in Cass. pen., 1998, 2917,
con nota di G. Amato, Quale discrimen tra concussione e corruzione?
(28) In tal senso, Cass., Sez. VI, 24 gennaio 2001, Ferrante, in Foro it.,
2001, III, II, 468; Cass., Sez. VI, 13 luglio 1998, Salvi, ivi, 1999, III, 664
ss., con nota critica di V. Manes, “La concussione ambientale” da fenomenologia a fattispecie “extra legemî; Cass., Sez. VI, 17 novembre 1994, Provini, in Cass. pen., 1995, 2129.
(29) Cass., Sez., VI, 13 gennaio 2000, Lattanzio, in Cass. pen., 2001, 132.
In senso sostanzialmente analogo, Cass., Sez. VI, 21 novembre 2000, Pivetti, ibidem, III, 1138. Per la giurisprudenza di merito, cfr. App. Venezia,
24 giugno 1996, Cunico, in Giur. merito, 1998, 92, con nota di D. Mascaro-S. Marazza, La concussione ambientale, tra vuoto legislativo e prassi giurisprudenziale.
(30) Sul punto, G. Contento, Concussione, cit., 117; C. Benussi, I delitti
contro la pubblica amministrazione, I, I delitti dei pubblici ufficiali, Padova,
2001, 372. Sulla possibile incostituzionalità per carenza di determinatezza della nozione d’induzione, incostituzionalità derivante proprio dall’evoluzione interpretativa che ne ha allargato l’ambito secondo le modalità
descritte, T. Padovani, Il confine conteso. Metamorfosi dei rapporti tra concussione e corruzione ed esigenze “improcrastinabili” di riforma, in Riv. it. dir.
e proc. pen., 1999, 1302 ss. Cfr. altresì G. Fiandaca, Esigenze e prospettive
di riforma dei reati di corruzione e concussione, ivi, 2000, 883 ss.
(31) In tal senso, Trib. Roma, 20 luglio 2000, Bosca, in Foro it., 2001, III,
478, con nota di P. La Spina, Affidamento di lavori ed individuazione (illegittima?) del contraente privato: un caso chiaro di concussione ambientale? In
senso più restrittivo, cfr. Cass., Sez. VI, 22 ottobre 1993, Fedele, in Foro it.
Rep., 1995, voce Concussione, n. 7 e, nella giurisprudenza di merito, G.i.p.
Trib. Milano, 28 novembre 1992, Chiesa, in Riv. pen., 1995, 929, con nota di G. Bersani, Criteri distintivi tra concussione e corruzione: proposte per
un’ulteriore riforma e ruolo della giurisprudenza.
(32) Cass., Sez. VI, 17 ottobre 1994, Armanini, in Cass. pen., 1996,
1130. Sull’argomento, F. Esposito, La concussione per induzione e lo stato di
soggezione della vittima, in Riv. pen., 1999, 995 ss.
(33) G. Marini, Estorsione, cit., 384; F. Mantovani, Diritto penale, cit., 148.
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
zione del soggetto passivo. La Corte evidenzia che il collegamento tra il comportamento minaccioso dell’agente
e l’effetto di costrizione della vittima costituisce requisito essenziale nella struttura del reato di cui all’art. 629
c.p., a prescindere dalla forma e dalle modalità assunte
dalla minaccia nella fattispecie concreta. In particolare,
nel caso di minaccia c.d implicita, il reato di estorsione
può ritenersi integrato soltanto in presenza di una condotta che, in relazione alle circostanze del caso concreto,
risulti necessariamente minatoria, ossia posta in essere
dal soggetto attivo con il solo obiettivo di conseguire un
profitto ingiusto con altrui danno, nonché realizzata con
modalità tali da coartare effettivamente la volontà della
vittima.
In relazione al requisito della idoneità della minaccia a cagionare un effetto di costrizione della vittima
(34), la Cassazione con la sentenza in epigrafe esclude
che tale elemento costitutivo possa ritenersi automaticamente integrato per il solo fatto che il soggetto passivo
della presunta estorsione si trovi in una posizione di inferiorità rispetto all’agente, ricorrendo necessariamente
un siffatto squilibrio oggettivo ogni volta in cui si instaurino rapporti contrattuali tra una parte economicamente più forte ed una più debole (35). Irrilevanti ai fini dell’accertamento della potenzialità coattiva della minaccia, anche quando questa assuma una forma larvata, sono pertanto le mere supposizioni e i semplici timori interni del soggetto passivo i quali non risultino causalmente riconducibili al comportamento cosciente e volontario del contraente più forte. Nella ricostruzione
dell’idoneità cogente della condotta dell’agente occorre
dunque, secondo le indicazioni della Suprema Corte, abbandonare la prospettiva della vittima «in carne ed ossa» (36), sostituendo alla semplice analisi della sua “posizione psicologica” l’accertamento che la situazione di
timore e conseguente compressione della sua libertà di
autodeterminazione sia stata direttamente ed esclusivamente cagionata dalla paura del male minacciato dal
soggetto attivo (37). Quest’ultimo, in particolare, deve
essere posto dall’agente come alternativa alla vittima, alla quale cioè deve essere prospettato il dilemma: o sottomettersi alla volontà del minacciante o subire il male indicato (38).
A chiarimento dei requisiti che l’elemento costitutivo della minaccia deve possedere anche qualora venga
realizzata nella forma implicita, la Corte ha riportato il
caso del ladro che richieda al derubato il pagamento di
una somma come condizione per la restituzione della refurtiva. La minaccia della mancata restituzione del bene
sottratto non concede alla vittima alternative alla perdita della cosa e realizza pertanto una condotta implicitamente minatoria (39). La giurisprudenza è infatti unanime nel ritenere che una simile richiesta da parte dell’autore del furto contenga l’implicito annuncio di un male
futuro ed ingiusto, consistente per l’appunto nella perdita delle cose rubate, da cui scaturisce una coazione psichica a fare ciò che viene preteso, con conseguente rea-
lizzazione degli estremi dell’ingiusto profitto e dell’altrui
danno richiesti ex art. 629 c.p. (40). Il delitto di estorsione ai danni del derubato viene del resto ritenuto sussistente anche nel caso in cui sia costui ad offrire, di propria iniziativa, una somma al ladro, in quanto il comportamento, indotto alla corresponsione di denaro o altra
utilità per ottenere la restituzione dell’oggetto sottratto,
è pur sempre determinato dalla minaccia implicita della
perdita definitiva del bene (41): l’accettazione dello
scambio proposto dal derubato comporta la conferma
della implicita minaccia del ladro di non restituire la refurtiva se non a condizione che la vittima si sottometta
alla sua volontà (42).
Precisando che tra condotta intimidatoria e costrizione psicologica deve sempre sussistere un rapporto
strumentale ed eziologico, la Cassazione ha voluto evidentemente arginare quell’allarmante trend interpretativo che, collocandosi nel solco del consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale favorevole ad interpretare in chiave espansiva la minaccia ex art. 629, arriva a riconosce integrato il reato di estorsione anche in
assenza di un preciso contegno dell’agente, essendo la
minaccia ritenuta presente in re ipsa sulla base di semplici generalizzazioni del senso comune fondate sulla diffusione di determinati comportamenti in un certo contesto ambientale. Le recenti decisioni della giurisprudenza
di merito che, come visto nel paragrafo precedente, attribuiscono rilevanza a situazioni di mero sfruttamento
Note:
(34) Su tale requisito, per tutte, Cass., Sez. II, 11 giugno 1991, Battista, in
Cass. pen., 1993, 51.
(35) Sulla c.d. estorsione contrattuale, L. Barillà, Estremi del danno e del
profitto e limiti di configurabilità della c.d. “estorsione contrattuale”, in questa
Rivista, 2003, III, 1537 ss.
(36) In tal senso, App. Milano, 5 novembre1993, Segalla e altri, in Foro
it., 1995, II, 693.
(37) Sulle problematiche connesse alla ricostruzione dell’idoneità della
minaccia nella prospettiva della vittima, amplius, C. Bernasconi, Il ruolo
della vittima nel reato di estorsione, in AA.VV., Ruolo e tutela della vittima in
diritto penale, cit., 77 ss.
(38) In dottrina, F. Antolisei, Manuale, cit., 140; in giurisprudenza, Cass.,
Sez. II, 7 novembre 2000, Sala, in Cass. pen., 2003, 1905, con nota di I.
Gioffré, Brevi note a margine di una sentenza in tema di tentata estorsione del
lavoratore.
(39) Sul punto, R. Pettenati, Restituzione, previo compenso, della cosa rubata e responsabilità per estorsione, in Riv. pen. dir. e proc. pen., 1963, 227
ss.; M. Spasari, Restituzione della refurtiva condizionata al pagamento di una
somma e delitto di estorsione, ibidem, 231ss.
(40) Cass., Sez. II, 11 ottobre 2000, Delle Lenti, in Cass. pen., 2001,
2359; Cass., Sez. II, 4 aprile 1986, Lucarella, in Giust. pen., 1987, II, 557;
Cass., sez., VI, 30 marzo 1990, Brugnara, ivi, 1991, II, 297; Cass., sez. VI,
29 marzo 1990, Seligardi, in Riv. pen., 1991, 394; Cass., sez. II, 8 giugno
1983, Praino, in Giust. pen., 1984, II, 352.
(41) Cass., Sez. II, 18 marzo 1986, Adriani, in Riv. pen., 1986, 1037;
Cass., Sez. II, 16 giugno 1986, Gatti, in Giust. pen., 1987, II, 416; Cass.,
Sez. II, 2 ottobre 1983, De Feudis, in Cass. pen., 1983, I, 64; Cass., Sez. V,
9 ottobre 1980, Leoni, ivi, 1982, 249; Cass., Sez. I, 2 marzo 1979, Bussolino, ivi, 1980, 1032.
(42) M. Spasari, Restituzione, cit., 234.
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1127
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
di una pressione ambientale, finiscono infatti con il realizzare un procedimento ermeneutico che va ben oltre
ogni lecita operazione di dilatazione interpretativa del
concetto di minaccia, proprio perché giungono a considerare integrata la fattispecie dell’estorsione a prescindere dalla verifica circa l’effettiva sussistenza di una condotta ascrivibile al soggetto attivo e, tanto meno, di una
condotta che integri le note modali espressamente previste dall’art. 629 c.p.
Come ricorda anche la dottrina che condivide in toto il principio dell’indifferenza delle forme e dei modi
della minaccia nell’estorsione, per la sussistenza della
fattispecie in esame è invece necessario che vi sia pur
sempre una concreta condotta di “minaccia” (o “violenza”), finalizzata nei termini fissati dal legislatore e produttiva degli eventi in essa tipicizzati (43). Tra la condotta intimidatoria dell’agente e la costrizione psicologica del soggetto passivo deve sempre intercorrere un diretto ed esclusivo rapporto causale, con la conseguenza
che qualora l’effetto di coazione trovasse nell’azione o
nell’omissione dell’autore solo uno dei tanti antecedenti
non potrebbe mai parlarsi di estorsione (44). Lo stesso
consolidato indirizzo giurisprudenziale che, favorevole
ad una interpretazione ‘allargata’ del concetto di minaccia ex art. 629 c.p., ne ammette la forma implicita, non
ha del resto mai trascurato di evidenziare che tale fondamentale requisito modale di specificazione della condotta punibile non può prescindere dalla concreta prospettazione di una futura lesione degli interessi del soggetto
minacciato: la condotta del soggetto attivo deve, cioè,
essere posta in essere nella sola prospettiva di conseguire
RIVISTE
un ingiusto profitto con altrui danno, attraverso un percorso comportamentale che ponga concretamente la
vittima in uno stato di soggezione, ravvisabile nell’alternativa di accedere all’ingiusta richiesta dell’agente o di
subire un più grave pregiudizio, anche se non esplicitamente prospettato (45).
Se è vero dunque che sono indifferenti la forma e le
modalità in cui la minaccia costitutiva dell’estorsione si
manifesta, è altrettanto vero che il principio di legalità
impone che la minaccia medesima sia concretamente riscontrabile come fatto dipendente dalla condotta volontaria del soggetto agente, non potendo essere presunta o
ricavata dal contesto ambientale o dalla posizione socioeconomica in cui si trovano i soggetti quando interagiscono tra di loro.
Nel caso di specie, conclude quindi la Corte, la ravvisata mancanza di una concreta condotta degli autori
della pretesa estorsione che abbia determinato, anche
solo surrettiziamente, nei soggetti passivi il timore di subire un danno ingiusto, con conseguente costrizione degli stessi al pagamento della parcella, impedisce che si
configuri la fattispecie obiettiva del reato di cui all’art.
629 c.p.
Note:
(43) Per tutti, G. Marini, Delitti contro il patrimonio, cit., 216-217.
(44) G. Fiandaca - E. Musco, Diritto penale, cit., 150. In termini analoghi,
F. Mantovani, Diritto penale, cit., 148.
(45) Per tutte, Cass., Sez. III, 13 novembre 2001, Zaccuri, in Cass. pen.,
III, 2002, 1132.
Il Corriere giuridico
Mensile di giurisprudenza, legislazione e opinione
Direttore scientifico: Piero Schlesinger
Comitato scientifico: Vincenzo Carbone, Mario Cicala, Claudio Consolo,
Adolfo Di Majo, Giuseppe Lombardi, Vincenzo Mariconda
Periodicità: mensile
Corriere Giuridico è il mensile di diritto e
procedura civile che non trascura gli spunti innovativi offerti dal diritto penale e amministrativo e affronta con tempestività e
autorevolezza tutte le problematiche con
le quali si misurano gli operatori del diritto. Offre un duplice aggiornamento: segnala in forma sintetica le pronunce della
Corte costituzionale, della Corte di giustizia CE, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte europea dei diritti dell’uomo con note di richiamo ai precedenti e agli orientamenti della dottrina;
pubblica per esteso, con approfonditi
commenti, le novità legislative e giurisprudenziali di maggior interesse. Trimestralmente Corriere Giuridico viene affiancato
da INT`L LIS, il prestigioso supplemento
1128
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
dedicato al diritto processuale internazionale e all’arbitrato internazionale.
Il servizio online, riservato esclusivamente agli abbonati e consultabile all’indirizzo
www.ipsoa.it/ilcorrieregiuridico, permette all’utente di accedere con tempestività
a tutte le novità d’interesse.
Abbonamento annuale € 175,00
Per informazioni
• Servizio Informazioni Commerciali
(tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)
• Agente Ipsoa di zona (www.ipsoa.it/agenzie)
• www.ipsoa.it
GIURISPRUDENZA•PROCESSO PENALE
Misure cautelari
Partecipazione all’udienza di riesame:
scelta del detenuto o del giudice?
CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 13 gennaio 2005 (u.p. 19 novembre 2004), n. 275
Pres. Brusco - Rel. Visconti - P.m. Meloni (….) - C., ricorrente (*)
Misure cautelari personali - Impugnazioni - Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva - Procedimento - Comparizione in udienza del detenuto in un luogo posto fuori della circoscrizione del giudice - Condizioni.
(Artt. 127 comma 3 e 309 c.p.p.)
In tema di riesame di misure cautelari personali, il diritto del detenuto in un luogo posto fuori dal circondario di esporre le proprie ragioni al tribunale competente si deve conciliare con la particolare celerità e speditezza del procedimento. Ciò non preclude all’interessato di chiedere la traduzione e al giudice del riesame
di disporla, qualora abbia valutato utile tale presenza, non apparendo sufficiente all’espletamento di una
difesa “completa” l’audizione da parte del magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione. Considerato,
pertanto, che la deroga alla procedura prevista dall’art. 127 comma 3 c.p.p., oltre a rientrare nei poteri di
valutazione del giudice di merito, deve comunque derivare dalla tutela del diritto di difesa, e non da un’imposizione immotivata, e di conseguenza arbitraria, da parte dell’imputato o indagato, questo non ha diritto alla traduzione qualora non abbia prospettato esigenze difensive tali da legittimare la sua presenza nell’udienza camerale.
(Omissis).
Con atto in data 9 luglio 2004 C. L., a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso
l’ordinanza del 16 giugno 2004 del Tribunale di Brescia,
in funzione di giudice del riesame, con la quale era stata
confermata l’ordinanza di applicazione della misura
coercitiva della custodia cautelare in carcere emessa dal
GIP dello stesso Tribunale il 9.9.2003 nei confronti del
C. ed altri in ordine al reato di cui all’art. 73 d.P.R.
309/90 (detenzione a fine di spaccio di cocaina).
Con il primo motivo di ricorso il C. ha chiesto di dichiarare la nullità dell’udienza camerale per violazione
dell’art. 127, 4° comma, c.p.p., e cioè per assenza dell’istante, che aveva fatto espressa richiesta di traduzione. Il
ricorrente ha quindi eccepito la decadenza della misura
cautelare a norma dell’art. 309, 1° comma, c.p.p., essendo inequivocabile la sua volontà di presenziare all’udienza camerale, e non essendo rilevante che egli non abbia
esercitato la facoltà concessagli di essere sentito dal magistrato di sorveglianza.
Con un secondo motivo il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata per violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla richiesta subordinata di sostituire la misura cautelare della custodia
in carcere con gli arresti domiciliari.
Prima di esaminare in diritto il primo motivo di ricorso,
è opportuno precisare perché il C. non sia stato tradotto,
trattandosi - come è noto - di situazione processuale che
può verificarsi per vari motivi (mancato interpello; audizione da parte del magistrato di sorveglianza; audizione
in videoconferenza; ecc.).
Dall’esame degli atti, consentito per valutare un motivo
di ricorso attinente a violazione della legge processuale,
risulta che i fatti si sono svolti nel modo seguente: a) il
12 giugno 2004 l’indagato ha chiesto di presenziare all’udienza camerale del 16 giugno successivo; b) il 14 giugno il Presidente del Tribunale del riesame ha disposto la
traduzione; c) in pari data dalla casa circondariale di Brescia hanno risposto che il 12.6 il C. era stato trasferito al
carcere di Vigevano; d) sempre il 14 giugno il Presidente ha disposto l’audizione del ricorrente a mezzo del magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione; e) all’udienza del 16 giugno l’indagato non è stato tradotto ed il
difensore ha dedotto la nullità dell’udienza camerale.
Inoltre, dal contenuto dell’atto di impugnazione si evince che il ricorrente, informato della facoltà di essere sentito dal magistrato di sorveglianza competente, non ha
inteso avvalersi di tale diritto.
La fattispecie è disciplinata dagli artt. 309, 8° comma, e
127, 3° comma, c.p.p.. Infatti, la prima norma citata dispone che il procedimento davanti al tribunale in funzione di giudice del riesame si svolge in camera di consiNota:
(*) N.d.R.: v. già in questa Rivista, 2005, 41.
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1129
GIURISPRUDENZA•PROCESSO PENALE
glio nelle forme previste dall’art. 127. Quest’ultima disposizione prevede che «il pubblico ministero, gli altri
destinatari dell’avviso nonché i difensori sono sentiti se
compaiono. Se l’interessato è detenuto o internato in
luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa
richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo».
La giurisprudenza di questa Corte non è univoca nell’interpretazione del dato normativo, essendovi alcune sentenze che hanno escluso il diritto alla traduzione (e quindi alla partecipazione in camera di consiglio) del detenuto in luogo esterno al circondario del tribunale del riesame (Cass. 11 febbraio 1997 n. 603, rv. 207175; Cass.
11 gennaio 1995 n. 4692, rv. 200321; Cass. 9 marzo
1994 n. 1422, rv. 197997), ed altre orientate nel senso
che l’interessato, anche se detenuto in altra circoscrizione, ha il diritto di essere tradotto davanti al tribunale
quando esplicitamente lo richieda, determinandosi in
mancanza una nullità assoluta (Cass. 15 gennaio 1997,
n. 5166, rv. 206781). Tale interpretazione è peraltro
quella indicata dalle sezioni unite di questa Corte con la
sentenza n. 40 del 23 novembre 1995, rv. 203771, con la
quale è stato ritenuto che «la mancata traduzione, perché non disposta o non eseguita, dell’imputato, indagato
o condannato che ne abbia fatto richiesta, all’udienza di
riesame determina la nullità assoluta o insanabile, a norma dell’art. 179 c.p.p., dell’udienza camerale e della successiva pronuncia del Tribunale sull’istanza di riesame».
Le SS.UU., ritenuto che non sussiste differenza tra il caso del detenuto infradistrettuale e quello extradistrettuale, hanno comunque precisato - diversamente da quanto
assunto dal ricorrente - che tale nullità non comporterebbe la cessazione dell’efficacia della misura coercitiva,
esulando dalle ipotesi previste dal 10° comma dell’art.
309 c.p.p., ma esclusivamente l’annullamento con rinvio al Tribunale del riesame procedente perché tenga
l’udienza camerale previa traduzione dell’interessato detenuto, che ha fatto richiesta di comparire.
La decisione delle SS.UU. non ha comunque unificato
l’orientamento giurisprudenziale, essendovi state decisioni successive difformi, come quella citata n. 603 del
1997, e non riguardando la fattispecie in esame l’altra
sentenza delle sezioni unite n. 9 del 25 marzo 1998, rv.
210799, la quale ha stabilito che l’omessa indicazione
nell’avviso di udienza del diritto alla traduzione per essere sentito davanti al magistrato di sorveglianza o a quello del riesame, non produce nullità alcuna.
Difforme dalla sentenza a SS.UU. n. 40/1996 è anche la
decisione della 6° sezione di questa Corte n. 2903 del 22
dicembre 1998, rv. 212901 la quale, pur incidentalmente, ha ritenuto corretta la trasmissione degli atti da parte
del tribunale del riesame al giudice di sorveglianza del
luogo di detenzione, a norma dell’art. 127, 3° comma,
c.p.p., in presenza della richiesta dell’indagato detenuto
fuori della circoscrizione del tribunale di «essere tradotto in udienza per presenziare».
Il contrasto giurisprudenziale è stato preceduto dalla sen-
1130
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
tenza, interpretativa di rigetto, della Corte Costituzionale n 45 del 17 gennaio 1991, la quale dichiarò infondata
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 309,
8° comma, e 127, 3° comma, c.p.p., sollevata in riferimento all’art. 24, 2° comma Cost., nella parte in cui prevedono che l’imputato, se detenuto fuori della circoscrizione del giudice, deve essere sentito, qualora ne faccia
richiesta, dal magistrato di sorveglianza del luogo, anziché dal tribunale del riesame, ma rilevò anche che l’art.
309 può essere interpretato nel senso di non escludere la
comparizione personale dell’imputato, se questi ne abbia
fatto richiesta oppure se il giudice lo ritenga ex officio
opportuno. Più precisamente, riportandosi la massima
della sentenza succitata, rilevata dalla motivazione, il
giudice delle leggi ha ritenuto che “in caso di riesame dei
provvedimenti di custodia cautelare da espletarsi in camera di consiglio, il fatto che il legislatore, di regola, per
ragioni di sicurezza e di economia processuale, abbia previsto la delega rogatoria al giudice di sorveglianza quando l’imputato sia detenuto in luogo esterno al circondario, non esclude - e l’art. 309 c.p.p. certamente non lo
vieta - che ove l’imputato ne abbia fatto espressa richiesta, o il giudice di cognizione lo ritenga necessario, possa
ordinarne la traduzione innanzi a sé, rientrando nei
principi generali d’immediatezza e di oralità, cui si ispira
l’attuale sistema processuale, il diritto - dovere del giudice di cognizione di sentire personalmente l’imputato; e il
diritto di quest’ultimo di essere ascoltato dal giudice che
dovrà giudicarlo”.
Questo Collegio ritiene, in primo luogo, che il dato letterale, della norma sia inequivoco, nel senso che il rinvio
all’art. 127 non consente interpretazioni alternative a
quella che, nelle procedure camerali, l’interessato, detenuto fuori dal circondario, se ne fa richiesta, è sentito dal
magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione, e nessuna sanzione di nullità è prevista qualora il tribunale del
riesame adotti tale procedura, peraltro espressamente
consentita dalla legge (art. 177 c.p.p.).
Né tale valutazione può essere insidiata dal valore costituzionale del contraddittorio, particolarmente rivalutato
dall’art. 111, 2° comma, Cost.. Nella specie, inflitti, i valori costituzionali da tutelare sono molteplici, e il legislatore li ha ben dosati e conciliati fra loro, per cui il riferimento al mero principio del contraddittorio, in uno all’oralità del procedimento penale, non appare utile all’esame complessivo della legittimità della norma, tenendo
anche conto delle altre disposizioni costituzionali.
Infatti, nel disciplinare il procedimento di riesame di
una misura cautelare personale il legislatore ha dovuto
tenere conto dell’art. 13, sui limiti alla libertà personale,
dell’art. 24 sull’inviolabilità del diritto di difesa, e, attualmente bisogna osservare le più recenti disposizioni
dell’art. 111, 2° comma, che, se è vero che tutelano il
contraddittorio nella sua massima espressione, egualmente ineriscono alla ragionevole durata del processo,
che, in tema di misure coercitive, deve essere ridotta al
massimo, tanto è vero che già la disciplina preesistente
GIURISPRUDENZA•PROCESSO PENALE
articola la procedura di riesame in termini ristrettissimi,
alla cui inosservanza consegue la perdita di efficacia delle misure suddette.
Ne consegue che il diritto della persona sottoposta a misura cautelare di esporre le proprie ragioni si deve conciliare con la particolare celerità e speditezza del procedimento di riesame, sicché la soluzione “suggerita” dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 45/1991, ma senza alcuna imposizione con declaratoria di incostituzionalità, risulta essere quella di consentire la partecipazione
dell’indagato o imputato all’udienza camerale qualora il
giudice del riesame abbia valutato utile tale presenza,
non apparendo sufficiente all’espletamento di una difesa
“completa” l’audizione da parte del magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione.
Tale valutazione tiene conto del rilievo della Corte costituzionale, secondo il quale l’art. 309, 6° comma, contiene un quid pluris rispetto all’art. 127, 3° comma, in
quanto consente a chi ha fatto richiesta l’enunciazione
di nuovi motivi «prima dell’inizio della discussione»,
espressione ben diversa da quella «prima del giorno dell’udienza» di cui al citato 3° comma dell’art. 127.
Va, però, rilevato che la questione di legittimità costituzionale esaminata dal giudice delle leggi con la sentenza
n. 45/1991 ha riguardato il caso in cui l’imputato avrebbe dovuto contestare nuovi elementi di prova portati dal
pubblico ministero dopo l’emissione dell’ordinanza di
custodia cautelare, e, pur con la particolare rilevanza del
caso, la Corte costituzionale ha ritenuto che rientrava
nei poteri del giudice di merito disporre la partecipazione della persona sottoposta a misura coercitiva all’udienza camerale, e quindi la sua traduzione, per esprimere direttamente al collegio argomenti a lui favorevoli, nell’ipotesi che sia fatta richiesta di comparizione ed il tribunale l’abbia ritenuta opportuna ai fini di un esercizio assolutamente non limitabile della difesa.
Pertanto, è senz’altro principio indiscusso che l’indagato
o l’imputato sottoposto a misura cautelare possa integrare le proprie ragioni prima della decisione del tribunale
del riesame. Nel caso di detenuto in luogo posto fuori del
circondario, per ragioni di sicurezza e altresì di economia
e speditezza processuale, di particolare rilievo trattandosi di procedura incidentale sulla libertà personale, da
conciliare con quella del rispetto del contraddittorio, la
procedura espressamente prevista dall’art. 127, 3° comma, per il richiamo dell’art. 309, 8° comma, è quella dell’audizione da parte del magistrato di sorveglianza del
luogo di detenzione. Ciò non preclude all’interessato di
chiedere la traduzione e al giudice del riesame di disporla, qualora ne ravvisi la necessità o quanto meno l’opportunità ai fini difensivi.
Nella specie, il ricorrente ha immotivatamente rifiutato
di essere ascoltato dal magistrato di sorveglianza, assumendo essere suo diritto quello di essere sentito dal tribunale del riesame, dato che era stata già disposta la sua
traduzione dinanzi al collegio. In realtà, come risulta dall’esposizione dei fatti (pagg. 1 e 2 di questa sentenza), la
traduzione era stata disposta non perché il tribunale abbia ritenuto necessaria o quanto meno opportuna la partecipazione del ricorrente all’udienza camerale, ma perché - al momento in cui era stata disposta - il presidente
del collegio riteneva che il C. era detenuto infracircondariale, e quindi non si applicava la diversa situazione
prevista dall’art. 127, 3° comma, per il detenuto in luogo
posto fuori dal circondario. Né successivamente il ricorrente ha indicato, neppure nel ricorso per cassazione, un
esigenza difensiva che legittimasse la sua presenza all’udienza camerale, e che non potesse essere esercitata dinanzi al magistrato di sorveglianza.
Considerato, pertanto, che la deroga alla procedura prevista dall’art 127, 3° comma, proprio nell’interpretazione indicata dalla Corte costituzionale, oltre a rientrare
nei poteri di valutazione del giudice di merito, deve comunque derivare dalla tutela del diritto della difesa, e
non da una imposizione immotivata, e di conseguenza
arbitraria, da parte dell’imputato o indagato, nessuna
censura sul punto può essere fatta alla decisione del tribunale del riesame di rigettare la eccezione proposta dal
difensore del ricorrente all’udienza del riesame.
Il secondo motivo di ricorso è invece fondato e va accolto. Il ricorrente ha eccepito la violazione dell’art. 275
c.p.p. per mancanza di motivazione sulla richiesta proposta dal difensore all’udienza camerale, di sostituzione
della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto che «l’art. 275 del c.p.p., nell’indicare i criteri in
forza dei quali il giudice di merito deve scegliere la misura idonea a soddisfare le esigenze cautelari, gli attribuisce, nell’ambito di detti criteri, poteri discrezionali assai
estesi nella scelta di quella ritenuta adeguata a soddisfare le esigenze cautelari e proporzionata al fatto concreto.
In particolare, nel caso in cui si prospetti la sostituibilità
della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, l’indagine che il giudice deve compiere,
volta ad accertare l’adeguatezza o meno di quest’ultima,
presuppone l’individuazione delle esigenze cautelari da
soddisfare e l’indicazione delle ragioni per le quali essa
viene ritenuta, in ipotesi, non idonea allo scopo né proporzionata all’entità e gravità dei fatti reati in contestazione. La determinazione in proposito assunta dal giudice di merito è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da idonea motivazione immune da vizi logico-giuridici» (Cass. 10 giugno 2003, n. 34910, conforme Cass.
4 luglio 2003, n. 36617).
Nella specie, la motivazione dell’ordinanza impugnata,
pur essendo molto analitica in ordine ai gravi indizi di
colpevolezza di cui all’art. 273 c.p.p., e adeguata e logica
in relazione alle esigenze cautelari di cui all’art. 274 lett.
b e c c.p.p. (pagg. 16 e 17), omette completamente di
spiegare le ragioni per le quali la richiesta difensiva di sostituire la misura cautelare della custodia in carcere con
gli arresti domiciliari è stata rigettata, tanto da configurarsi la mancanza di motivazione ex art. 606 lett. e c.p.p.
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1131
GIURISPRUDENZA•PROCESSO PENALE
in relazione all’art. 125, 3° comma, dello stesso codice di
rito.
Infatti, sul punto il Tribunale, dopo avere motivato sulle esigenze cautelari, ha scritto quanto segue: «l’ordinanza impugnata va pertanto confermata, unica misura
cautelare idonea essendo quella carceraria». Tale locuzione non spiega in alcun modo perché la misura attenuata degli arresti domiciliari non è idonea allo scopo
né proporzionata all’entità e gravità dei fatti reati in
contestazione, circostanze sulle quali il giudice di rinvio
dovrà motivare, non essendo sufficiente il mero richiamo alle esigenze cautelari, che legittimano la sottoposizione a misura coercitiva, ma non comportano automaticamente ed immotivatamente la scelta di quella più
gravosa.
In conclusione, l’ordinanza impugnata viene annullata
limitatamente al punto appena esposto, con rinvio, a
norma dell’art. 623 lett. a c.p.p., allo stesso Tribunale di
Brescia per nuovo esame. Il ricorso è rigettato nel resto.
(Omissis).
IL COMMENTO
di Katia La Regina
In udienza di riesame, l’unica esigenza difensiva
che legittima la comparizione del detenuto in un
luogo posto fuori della circoscrizione del giudice è
quella di voler partecipare personalmente al contraddittorio.
La decisione in commento, affrontando la tematica
relativa alle modalità attraverso cui il detenuto in un
luogo posto fuori dalla circoscrizione del tribunale del
riesame possa esercitare il suo diritto di difesa, rappresenta solo l’ultima tappa di un’elaborazione giurisprudenziale piuttosto controversa ed articolata, della quale
appare indispensabile ripercorrere le linee essenziali non
prima, tuttavia, di aver ricostruito il contesto normativo
in cui si inserisce la fattispecie sottoposta al vaglio della
Suprema Corte.
Mentre l’art. 25 l. 5 agosto 1988, n. 330 (1) attribuiva la facoltà d’intervento all’udienza di riesame soltanto al difensore ed al pubblico ministero, il codice del
1988 ha esteso tale possibilità anche alla persona destinataria della misura coercitiva.
Lo strumento della partecipazione diretta, tuttavia,
viene configurato come esclusivamente funzionale alla
difesa degli interessati sottoposti ad una misura coercitiva non custodiale e dei detenuti o internati in un luogo
compreso nella circoscrizione (2) del tribunale del riesame competente, poiché per i detenuti o internati extracircondario viene prevista l’audizione, non ad opera del
giudice del riesame, bensì tramite la cd. “delega-rogatoria” (art. 127 comma 3 c.p.p.).
Sul punto l’art. 127 comma 3 c.p.p., richiamato
dall’art. 309 comma 8 c.p.p., opera, pertanto, una duplice distinzione. La prima - correlata allo status in cui
versa il destinatario della misura coercitiva - è relativa
alle modalità attraverso cui l’interessato può legittimare la sua audizione ad opera dell’organo giurisdizionale. Qualora, infatti, il provvedimento cautelare non
1132
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
abbia carattere custodiale, la sola partecipazione in
udienza attribuisce all’imputato il diritto di essere sentito (3). Un diverso iter, invece, deve seguire il detenuto, sia fuori che dentro il circondario, qualora intenda interloquire a sostegno della propria difesa.
Questo, infatti, previa ricezione dell’avviso della data
fissata per l’udienza, ha l’onere (4) di avanzare un’apNote:
(1) Recante norme relative alla «Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale»; può leggersi in
www.infoleges.it/normativa statale.
(2) La circoscrizione «è l’ambito territoriale entro cui esercita il potere
giurisdizionale ciascun giudice, e che, per il tribunale, corrisponde al circondario. La determinazione di tale ambito territoriale è determinata
per il tribunale dall’art. 42 dell’Ordinamento giudiziario, che fa rinvio
alla tabella A annessa all’art. 1 della l. 1 febbraio 1989, n. 30: tale tabella individua normativamente i comuni facenti parte del circondario di
ogni tribunale, che per lo più si identificano in quelli che rientrano nell’ambito della provincia. All’interprete non può pertanto sfuggire il difetto di coordinamento che risulta dal raffronto tra la determinazione
normativa del circondario del tribunale e l’ambito territoriale di competenza del tribunale della libertà. Quest’ultimo, infatti, alla stregua della
l. 23 dicembre 1996, n. 652, estende eccezionalmente la propria competenza territoriale in tutta l’area del distretto nel quale ha sede, e quindi
oltre il proprio ambito circoscrizionale. Ciò comporta che un imputato
può essere detenuto fuori dalla circoscrizione del tribunale della libertà,
ma nell’area di competenza territoriale di questo». Così M. Polvani, Le
impugnazioni de libertate, 2ª ed., Padova, 1999, 314, il quale rileva come
questo «difetto di sovrapposizione tra l’area di competenza territoriale
del tribunale della libertà e l’ambito del circondario di tale tribunale,
rende praticabile l’audizione per rogatoria, oltre che nelle ipotesi in cui
l’imputato sia detenuto fuori del distretto in cui ha sede il tribunale, anche in quelle in cui sia detenuto entro il distretto ma fuori dal circondario del tribunale».
(3) Come rileva M. Garavelli, sub Art. 127 c.p.p., in AA.VV., Commento al nuovo codice di procedura penale, coordinato da M. Chiavaro, 2° agg.,
Torino, 1994, 97, «tutti i destinatari dell’avviso, nonché i difensori delle
parti, devono essere sentiti, se presenti, indipendentemente da una loro
richiesta».
(4) Si esprimono in termini di onere M. Garavelli, sub Art. 127 c.p.p.,
cit., 97 e E. Amodio, sub Art. 127, in AA.VV., Commentario del nuovo codice di procedura penale, a cura di E. Amodio-O. Dominioni, I, Milano,
1989, 92.
GIURISPRUDENZA•PROCESSO PENALE
posita richiesta (5), i cui sviluppi, tuttavia, vengono
fatti dipendere da un elemento contingente (6), rappresentato dal locus detentionis. Nel caso, infatti, in cui
il richiedente sia detenuto o internato in un luogo
compreso nella circoscrizione del Tribunale competente, potrà rappresentare le proprie ragioni direttamente dinnanzi all’organo investito del potere di
emettere la decisione (7) (arg. ex art. 127 comma 3
c.p.p.). Qualora, al contrario, l’interessato si trovi ristretto altrove, è prevista la sua audizione, prima del
giorno dell’udienza, da parte del magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione o internamento (art.
127 comma 3 c.p.p.) (8).
Questo diverso modus procedendi incide anche sui
tempi della decisione. Sul punto,infatti, l’art. 101 comma 2 disp. att. c.p.p. individua il momento della decorrenza dei termini di cui all’art. 309 comma 10 c.p.p. in
quello «in cui pervengono al tribunale gli atti assunti dal
magistrato di sorveglianza» che, pertanto, dovrà trasmetterli «con il mezzo più celere» (9).
L’interpretazione della Corte Costituzionale
La ratio del meccanismo rogatoriale contemplato
nell’art. 127 comma 3 c.p.p. è facilmente intuibile:
evitare «i pericoli di un trasporto in stato di detenzione» (10) ed ovviare ai «sicuri intralci che determinerebbe la traduzione nel luogo in cui si svolge il procedimento» (11).
Il fatto che delle esigenze di carattere pratico prendessero il sopravvento sulla piena esplicazione del diritto
di difesa del detenuto in vinculis (12), ha indotto la stessa Commissione parlamentare, durante i lavori preparatori, ad assumere un atteggiamento di particolare cautela, teso a contemperare le - certamente meritevoli - pretese di sicurezza, con i principi costituzionali dell’inviolabilità della difesa e del diritto di uguaglianza (13). La
proposta (14) di prevedere che fosse il giudice procedente (o un giudice all’uopo delegato, nel caso di organo collegiale) a recarsi presso il luogo di detenzione o di internamento, tuttavia, non venne accolta dal legislatore delegato ad avviso del quale non potevano ritenersi sussistenti i paventati dubbi di ortodossia costituzionale, rispetto ai quali, con riferimento alla disciplina degli incidenti di esecuzione (15), si era già pronunciata la Corte
Note:
(5) Da rilevare, che la richiesta di essere sentito personalmente, avanzata dal detenuto in un luogo compreso nella circoscrizione del giudice che
procede viene considerata «atto personalissimo, non delegabile al difensore» da Cass., Sez. VI, 16 giugno 1992, Balestra, in Arch. n. proc. pen.,
1993, 612.
(6) T. Della Marra, Sulla partecipazione dell’imputato detenuto all’udienza di
riesame, in Giur. it., 725, si riferisce al locus custodiae come «ad un dato
contingente (...) assolutamente estraneo alla volontà dell’interessato».
(7) In tal senso M. Garavelli, sub Art. 127, cit., 98.
(8) Cass., Sez. II, 8 ottobre 1997, Di Rocco, in Cass. pen., 1998, 2414, ha
specificato che tale organo giudiziario è obbligato a «provvedere direttamente all’incombente, non potendo tale adempimento, che costituisce
espletamento di attività giurisdizionale, essere delegato alla polizia penitenziaria». Da rilevare, inoltre, che la dizione “detenuti o internati” impiegata nell’art. 127 c.p.p., non viene riferita esclusivamente a coloro che
versano in stato di custodia cautelare in senso stretto. Viene sottolineato,
a tal proposito, che se «detenuto è colui che si trova nello stato di custodia cautelare in carcere e se l’art. 284 comma quinto c.p.p. considera, a
tutti gli effetti, gli arresti domiciliari come custodia cautelare in carcere
(...) deve ritenersi che la delega» al magistrato di sorveglianza «può essere conferita pure nel caso in cui l’imputato trovisi agli arresti domiciliari e
debba essere sentito per un procedimento in camera di consiglio” che si
svolge in un luogo diverso da quello in cui si trova il giudice che procede:
così Cass., sez. I, 30 ottobre 1991, Truscello, in Arch. nuova proc. pen.,
1992, p. 568.
(9) L’art. 101 comma 2 disp. att. c.p.p., prescrive, come adempimento
preliminare all’audizione dell’imputato, il tempestivo avviso al difensore;
sul punto, la giurisprudenza è costante nel ritenere che la sua omissione
sia causa di nullità, sia dell’atto che del provvedimento adottato sulla base di esso. L’orientamento prevalente ravvisa in questa ipotesi una nullità
a regime intermedio, sanata, dunque, se non dedotta tempestivamente, e,
pertanto, prima della decisione sull’istanza di riesame; in tal senso, Cass.,
Sez. I, 18 febbraio 1999, Terminio, in Cass. pen., 2000, 1003; in particolare Cass., Sez. VI, 2 dicembre 1997, Ferraro, ivi, 1999, 1865, rileva come
nel procedimento camerale di cui all’art. 309 c.p.p., «l’audizione (...) da
parte del magistrato di sorveglianza dell’interessato che si trovi detenuto
in un luogo posto fuori del circondario del tribunale competente è sostitutiva dell’intervento diretto in udienza e dunque parte integrante della
stessa, per cui è regolata dalla medesima disciplina; ne deriva che l’omissione dell’avviso al difensore realizza una nullità generale ai sensi dell’art.
178 lett. c c.p.p., da classificarsi tuttavia non fra quelle assolute bensì tra
quelle a regime intermedio, perché la presenza del difensore nel procedimento incidentale de libertate non è obbligatoria»; analogamente Cass.,
Sez. II, 10 aprile 1996, Ziglioli, ivi, 1997, 2526; Cass., Sez. I, 21 novembre
1994, Guidotto, ivi, 1996, 237, Cass., Sez. I, 22 aprile 1993, Muto, ivi,
1994, 1873; non mancano, tuttavia, posizioni che propendono per una
qualificazione in termini di nullità assoluta: tra queste, in particolare,
Cass., Sez. VI, 23 febbraio 1993, Madonia, ibidem, 1994, 3052, secondo
cui l’audizione ad opera del magistrato di sorveglianza, «sostitutiva dell’intervento diretto in udienza», è considerata come «parte dell’udienza
stessa e la sua disciplina non può, dunque, non essere ricondotta a quella
dettata per l’udienza camerale».
(10) In questi termini T. Della Marra, Sulla partecipazione dell’imputato detenuto all’udienza di riesame, cit., 725.
(11) A. Galati, Gli atti, in D. Siracusano-A. Galati-G. Tranchino-E. Zappalà, Diritto processuale penale, I, Milano, 1996, 266.
(12) In tal senso G. Di Chiara, Procedimento di riesame e autodifese dell’interessato in vinculis: note a margine di un indirizzo innovativo, in Foro it., II,
1996, 723.
(13) Anche - e soprattutto - dei mezzi difensivi, come sottolinea T. Della
Marra, Sulla partecipazione dell’imputato detenuto all’udienza di riesame, cit.,
725.
(14) Che può leggersi in G. Conso-V. Grevi-G. Neppi Modona, Il nuovo
codice di procedura penale - Dalle leggi delega ai decreti delegati, V, Padova,
1990, 628.
(15) L’art. 630 comma 2 c.p.p. 1930 stabiliva che i detenuti «in un luogo
diverso da quello in cui risiede il giudice» sarebbero stati «previamente
uditi a loro domanda dal magistrato di sorveglianza o dal pretore del luogo all’uopo delegato». Questa disposizione rappresenta «per communis
opinio, il modello ispiratore della vigente disciplina camerale “di genere”»: così G. Di Chiara, Procedimento di riesame e autodifese dell’indagato in
vinculis, cit., 723. Analogamente, E. Amodio, sub Artt. 127-128, in
AA.VV., Commentario, cit., 85, in cui si pone in evidenza come «con la
normativa racchiusa nell’art. 127 il nuovo codice offre per la prima volta
all’interprete una disciplina compiuta e di portata generale intesa a regolare il modus procedendi per le ipotesi in cui il giudice è chiamato a pronunciarsi senza le forme dell’udienza dibattimentale. Prendendo a modello l’incidente di esecuzione descritto dall’art. 630 c.p.p. 1930, il legislatore ha voluto creare uno schema procedimentale destinato a trovare
operatività nell’iter antecedente alla decisione di questioni che non esi(segue)
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1133
GIURISPRUDENZA•PROCESSO PENALE
costituzionale (16), affermandone la piena legittimità.
D’altronde - si legge nella Relazione al testo definitivo
del codice - «la disciplina assicura all’interessato la possibilità di far sentire comunque le sue ragioni al giudice;
e a quest’ultimo è, comunque, rimessa la valutazione dell’opportunità di una presenza fisica nei casi in cui la stessa appaia utile ai fini della decisione», senza trascurare
soprattutto che la disciplina suggerita dalla Commissione parlamentare «comporterebbe (...) notevoli difficoltà
di ordine pratico e l’inevitabile protrarsi della durata del
procedimento» (17).
Queste argomentazioni non convinsero ne i primi
Commentatori (18), ne la giurisprudenza più sensibile al
rispetto dei valori costituzionali (19), tanto che, all’indomani dall’entrata in vigore del codice di procedura penale, veniva sollevata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 127 comma 3
c.p.p. e 309 comma 8 c.p.p., in relazione all’art. 24 comma 2 Cost., nella parte in cui prescrive che il detenuto
posto fuori dalla circoscrizione del giudice debba essere
sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione anziché dal Tribunale del riesame.
La Corte costituzionale (20), dopo aver richiamato
lo “stato della giurisprudenza” sulla disciplina degli incidenti di esecuzione (21), ha offerto una risposta positiva
alla questione relativa alla compatibilità tra la funzione
del procedimento di riesame e l’interesse dell’imputato
alla comparizione personale nella relativa udienza, per
comprendere la quale appare opportuno riportare alcuni
passaggi della motivazione. Si legge, in particolare, che
se «il giudice chiamato al riesame del provvedimento
applicativo della misura cautelare deve valutare questioni di fatto concernenti la condotta dell’interessato (... )
è evidente» che sussista «l’interesse dell’imputato a comparire personalmente per contrastare - se lo voglia - le risultanze probatorie e indicare eventualmente altre circostanze a lui favorevoli: così come è evidente l’importanza che il contraddittorio abbia a svolgersi innanzi al giudice che dovrà poi assumere la decisione».
Dopo questa premessa, tuttavia, la Corte nega l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli
artt. 127 comma 3 c.p.p. e 309 comma 8 c.p.p., individuando in queste disposizioni le potenzialità necessarie
per un superamento della loro stessa lettera a beneficio
di un’interpretazione costituzionalmente orientata. Ad
avviso della Corte, infatti, l’art. 309 c.p.p. non vieta «la
comparizione personale dell’imputato se questi ne abbia
fatto richiesta oppure se il giudice competente lo ritenga
ex officio opportuno».
Sulla scia di un consolidato indirizzo, dunque, la
Corte costituzionale «fra più interpretazioni possibili
della stessa norma» ha preferito «quella che consente di
dare ad essa un significato conforme (... ) con la Costituzione» (22). Nulla da eccepire: la duplice via - previa richiesta o iussu iudicis - attraverso cui il detenuto extracircondario può vedersi assicurata la presenza nell’udienza
di riesame, garantisce i valori costituzionali della difesa e
1134
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
dell’uguaglianza oltre che i principi ispiratori del codice
di procedura penale quali contraddittorio, immediatezza
ed oralità. A questi ultimi, del resto, si richiama la Consulta per fornire una qualificazione delle posizioni soggettive del giudice e dell’imputato: il primo ha un «diritto-dovere di sentire personalmente l’imputato» ed il secondo ha «diritto (...) di essere ascoltato dal giudice che
dovrà giudicarlo».
A scalfire la persuasività di queste argomentazioni
un’unica zona d’ombra, rappresentata dal passaggio in
Note:
(continua nota 15)
gono la solennità e i complessi meccanismi procedurali tipici del dibattimento»; nello stesso senso v., M. Gianrusso, sub Art. 127 c.p.p., in Lattanzi-Lupo, Codice di procedura penale, Rassegna di giurisprudenza e dottrina,
Milano, 1998, 112; M. Garavelli, sub Art. 127 c.p.p., cit., 95.
(16) Corte cost. 22 gennaio 1970, n. 5, in Giur. cost., 1970, I, 48, secondo cui, rispetto alla difesa, la circostanza che l’audizione del detenuto
«non venga effettuata dallo stesso giudice che provvede alla decisione
dell’incidente» non è tale da determinare «un’apprezzabile variazione di
tutela di quel diritto», mentre rispetto al principio di uguaglianza, la differenza «di trattamento che è riservata al condannato il quale sconta la
pena in altra sede (...) non sarebbe irrazionale. Il legislatore ha giustamente ritenuto prevalernti in senso ostativo le difficoltà pratiche che un
trasporto in stato di detenzione presenta, di fronte all’irrilevanza che il
beneficio di essere ascoltato di persona dal giudice competente a decidere rappresenta per il detenuto, garantito nella sua difesa, dagli altri mezzi
a lui offerti dalla legge». Per una severa critica di queste conclusioni, v. V.
Grevi, Incidenti di esecuzione e autodifesa del detenuto, in Giur. cost., 1970,
I, 49.
(17) Così Relazione al testo definitivo del codice di procedura penale, in G.U.,
24 ottobre 1988, n. 250, Suppl. ord., n. 2, 178.
(18) Per tutti M. Garavelli, sub Art. 127 c.p.p., cit., 98, il quale sostiene
che la «dubbia costituzionalità» dell’art. 127 comma 3 c.p.p. si possa ricavare dalla sentenza della Corte costituzionale del 1982, n. 98 (la quale
può leggersi in Giur. cost., 1982, I, 990) che, dichiarando l’illegittimità
costituzionale dell’art. 630 comma 2 c.p.p. 1930 nella parte in cui non
prevedeva il rinvio della trattazione dell’incidente di esecuzione qualora
l’imputato o il condannato, che avesse richiesto di partecipare personalmente, non comparisse per legittimo impedimento, afferma la necessità
che l’interessato abbia «la possibilità di rappresentare le proprie ragioni
direttamente al giudicante».
(19) V. ord. Trib. Torino, 15 giugno 1990, Vizzini, in Arch. n. proc. pen.,
1990, 519, con la quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 127 comma 3 c.p.p. e 309
comma 8 c.p.p. perché, attraverso il meccanismo dell’esame per rogatoria, si determinerebbe un’ingiustificata compressione del diritto di difesa
a beneficio di esigenze, quali quella di speditezza del procedimento e di
economia processuale, che, al contrario del primo, non rivestono dignità
costituzionale.
(20) Corte cost., 31 gennaio 1991, n. 45, in Giur. cost., 1991, 304.
(21) Il riferimento corre a Corte cost. n. del 1970 e Corte cost. n. 98 del
1982, cit.; con quest’ultima, in particolare, la Consulta aveva individuato nell’«accertamento inerente a questioni di fatto» il fine che «solo potrebbe richiedere l’intervento personale dell’interessato, imputato o condannato».
(22) Così Corte cost. 25 giugno 1996, n. 216, in www.giurcost.org, in cui
viene richiamata la sentenza n. 45 del 1991 per ribadire la sussistenza del
diritto dell’imputato detenuto extracircondario di essere sentito personalmente dal giudice del riesame, «benché l’art. 127 comma 3 del codice
in questa ipotesi preveda espressamente soltanto che egli sia sentito, a richiesta, prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del
luogo».
GIURISPRUDENZA•PROCESSO PENALE
cui la Corte sembra affidare al giudice del riesame la
possibilità di ordinare la traduzione del detenuto in
udienza (23). Quest’ultimo punto ha rappresentato il
varco attraverso il quale avrebbero ripreso vita i contrasti giurisprudenziali.
Le oscillazioni della Corte di cassazione
Così, se un primo orientamento offre una lettura rigidamente formale del comb. disp. degli artt. 127 c.p.p. e
309 comma 8 c.p.p., «confermando la differenza dei diritti esercitabili dal detenuto in relazione al luogo della
detenzione» (24) (diritto alla partecipazione in udienza/diritto di essere sentito dal magistrato di sorveglianza
del luogo) (25), per un secondo indirizzo - al quale aderisce la sentenza che si annota - la decisione della Corte
costituzionale andrebbe letta nel senso che l’ordine di
traduzione in udienza sarebbe sempre rimesso alla scelta
discrezionale del giudice del riesame il quale è chiamato
a «valutare l’opportunità di fare eccezione alla regola generale dell’audizione da parte del giudice di sorveglianza
(...) per evitare di dare ingresso ad istanze meramente
defatigatorie, intese ad un superamento dei termini per
la pronuncia» (26).
A conclusioni diametralmente opposte giunge, infine, quell’orientamento che, valorizzando la lettura secundum costitutionem offerta dalla Consulta, riconosce in capo al detenuto extracircondario la sussistenza di un vero
e proprio diritto alla comparizione in udienza, il quale,
pur se subordinato sotto il profilo operativo ad una preventiva richiesta di audizione diretta (27), viene affidato,
per il suo concreto esercizio, alla libera determinazione
della persona in vinculis (28). Quest’ ultima posizione vieNote:
(23) Si legge, infatti, nella motivazione della sentenza n. 45 del 1991,
«che di regola il legislatore, per ragioni di sicurezza e di economia processuale, abbia previsto la delega rogatoria al giudice di sorveglianza quando
l’imputato sia detenuto in un luogo esterno al circondario, non esclude
che, ove l’imputato ne abbia fatto espressa richiesta, o il giudice di cognizione lo ritenga necessario, possa ordinarne la traduzione innanzi a se».
(24) Così G. Spangher, sub Art. 309 c.p.p., in AA.VV., Codice di procedura penale commentato, Milano, 2001, 1876.
(25) «Sempreché abbia espresso la richiesta in tempo utile»: così Cass.,
Sez. VI, 25 agosto 1993, Rossi, in Arch. n. proc. pen., 1994, 124, nella
quale, si afferma che l’inosservanza delle relative previsioni determini
«una nullità riconducibile a quelle di cui all’art. 178, primo comma lettera c, c.p.p., di carattere assoluto ed insanabile ex art. 179, primo comma,
che si estende a tutti gli atti del procedimento, sino ad investire la decisione conclusiva»; analogamente, Cass., Sez. fer., 5 settembre 1991, Cusimano, in Cass. pen., 1992, 347, in cui si specifica che la sussistenza di
tale nullità non determina la perdita di efficacia della misura, la quale «è
collegata dal comma 10 dell’art. 309 c.p.p. esclusivamente alla mancata
pronuncia (...) da parte del tribunale del riesame entro il prescritto termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti»; ne consegue che «la nullità della pronuncia si trasforma in motivo d’impugnazione della stessa da
far valere con ricorso per cassazione ex art. 311 comma 1» c.p.p., in mancanza del quale «la nullità della pronuncia resta “coperta” dal giudicato»;
nello stesso senso Cass., Sez. VI, 25 agosto 1993, Portaro, in Arch. n. proc.
pen., 1994, 125; analogamente Cass., Sez. VI, 29 ottobre 1992, Bon Chebel Ghanan, ivi, 1993, 325, in cui correttamente si puntualizza come a
nulla rilevi «che nel corso del procedimento di merito l’imputato fosse
stato già sentito, in quanto l’audizione ex art. 309 adempie a ben altri fini, concerne il riesame di misure coercitive ed ovviamente, i presupposti
delle stesse, su cui l’indagato ha diritto di interloquire”; ancora nello stesso senso, Cass., Sez. VI, 11 gennaio 1992, Priolo, ivi, 1992, 450; Cass.,
Sez. VI, 30 aprile 1993, Caterino, ivi, 1993, 325; Cass., Sez. VI, 21 luglio
1999, Labarbera, in Giust. pen., 2000, 503. Non mancano, peraltro, posizioni diversificate: in dottrina, F. Cordero, Procedura penale, 7ª ed., Milano, 2003, 393, ravvisa nell’ipotesi in discorso una nullità a regime intermedio, rilevabile secondo il regime descritto dall’art. 180 c.p.p.; analogamente, P. Comucci, In tema di nullità per violazioni del diritto di difesa nelle impugnazioni de libertate, in Cass. pen., 1995, 2308; in giurisprudenza,
Cass., Sez. I, 11 marzo 1992, Marsella, ivi, 1993, 2550, ravvisa nell’omessa audizione da parte del magistrato di sorveglianza «una nullità relativa,
che deve essere eccepita ai sensi dell’art. 181» c.p.p. «prima del provvedimento emesso a conclusione dell’udienza in camera di consiglio». Non
può che destare perplessità, infine, quell’orientamento, fortunatamente
isolato, in cui si afferma che «l’invito “ad audiendum”, ai sensi dell’art. 127
c.p.p., da parte del magistrato di sorveglianza all’imputato detenuto che
ne abbia fatto richiesta non è prescritto a pena di nullità, sicché la relativa previsione resta nel novero delle disposizioni ordinatorie la cui inosservanza può solo avere conseguenze di natura amministrativa e non giurisdizionale-processuale»: così Cass., Sez. VI, 5 febbraio 1991, Alberti, in
Arch. n. proc. pen., 1991, 441.
(26) Così Cass., Sez. V, 2 luglio 1993, Spierto, in Arch. n. proc. pen.,
1994, 279. Analogamente, Cass., Sez. I, 11 gennaio 1993, Granillo, ivi,
1993, 639, per la quale «a norma dell’art. 127 comma 3 c.p.p., quando
l’interessato è detenuto in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del
giudice, non ha diritto a presenziare all’udienza camerale, ma può solo
chiedere di essere sentito dal magistrato di sorveglianza territorialmente
competente al quale deve, quindi, inoltrare la necessaria istanza nelle forme previste dall’art. 123 c.p.p. Evidenti ragioni di speditezza processuale
e di sicurezza hanno indotto il legislatore a dettare questa particolare disciplina la quale - come la Corte costituzionale ha confermato con la sentenza n. 45 del 1991, non lede in alcun modo il diritto di difesa e non
può,quindi, subire deroghe per volontà di parte, ma eventualmente solo
nel caso che il giudice ritenga indispensabile la presenza dell’interessato»;
nello stesso senso, Cass., Sez. fer., 9 settembre 1993, Esposito, ibidem,
1993, 689; Cass., Sez. I, 24 ottobre 1994, Madonia, in Giust. pen., 1995,
560; Cass., Sez. IV, 27 febbraio 1996, Dursun, in Cass. pen., 1997, 1090,
in cui si riscontra un articolato tentativo di mitigare la rigidità delle precedenti posizioni. La Corte, infatti, estende all’appello, «stante l’identità
di ratio», la soluzione offerta dalla Corte costituzionale nel 1991, in cui,
pur non potendo scorgersi il riconoscimento di un «diritto pieno e indiscutibile dell’indagato o dell’imputato, detenuto altrove e che ne faccia
richiesta, ad essere sentito proprio dal giudice del riesame o dell’appello»,
è dato ravvisare dei casi di sussistenza di un tale diritto. Questi, pertanto,
potrebbero scorgersi «solo con riferimento alle ipotesi nelle quali sono
prese in esame questioni di fatto concernenti la condotta dell’interessato,
quando cioè costui voglia contestare le risultanze probatorie ed indicare
eventualmente circostanze a lui favorevoli, restando invece ferma la facoltà del giudice di disattendere richieste di audizione formulate genericamente o a fini puramente defatigatori».
(27) L’art. 123 comma 1 c.p.p. dispone, a tal proposito che le dichiarazioni e le richieste di persone detenute o internate formulate all’autorità carceraria devono essere «immediatamente comunicate all’autorità competente e» acquistano «efficacia come se fossero ricevute direttamente dall’autorità giudiziaria». Inoltre, l’art. 44 disp. att. c.p.p. stabilisce che questa trasmissione debba avvenire «nel giorno stesso, o al più tardi nel giorno successivo (...) mediante estratto o copia autentica, anche per mezzo
di lettera raccomandata», ed in ogni caso di “speciale urgenza” mediante
l’uso di qualunque mezzo tecnicamente idoneo.
(28) Così, Cass., Sez. II, 3 febbraio 1994, Gioffrè ed altri, in Arch. n. proc.
pen., 1994, 580; nello stesso senso, Cass., Sez. V, 24 maggio 1994, Piras,
in Cass. pen., 1994, 3053; Cass., Sez. II, 3 maggio 1993, Tangorra, in Arch. n. proc. pen., 1993, 430; Per l’adesione della dottrina a questo orientamento, v. F. Cordero, Procedura penale, cit., 393, che sottolinea come, se
pur «con qualche forzatura al testo» sia «postulabile un» diritto per il detenuto «a interloquire all’udienza» ove lo chieda; sottolinea l’Autore che
soltanto inteso in questa maniera l’art. 127 c.p.p. «appare conforme all’art. 24 comma 2 Cost.»; in senso conforme M. Ceresa Gastaldo, Il riesa(segue)
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1135
GIURISPRUDENZA•PROCESSO PENALE
ne condivisa dalle Sezioni unite con una pronuncia (29)
che si segnala per alcune affermazioni di notevole interesse che emergono già nell’impostazione del thema decidendum. La Corte, infatti, affrontando l’attiguo tema delle patologie processuali conseguenti all’omessa traduzione del detenuto in udienza di riesame, sottolinea come,
in seguito all’intervento della Corte costituzionale, la
questione si ponga, per il detenuto extracircondario, «negli stessi termini» (30) che per colui che sia ristretto nell’ambito della circoscrizione del tribunale. In entrambi i
casi, infatti, «il giudice del riesame è tenuto ad assicurare
la presenza dell’interessato dinnanzi a sé qualora questi ne
faccia specifica richiesta» (31). Il dovere del giudice di attivarsi per garantire la comparizione del detenuto discende dal fatto che «l’ordine di traduzione e la sua esecuzione costituiscono, insieme con l’avviso dell’udienza camerale e la sua notificazione, atti indefettibili della procedura diretta alla regolare costituzione del contraddittorio.
Senza di essi infatti l’avviso non può svolgere in concreto
l’unica funzione che gli è propria, quella della vocatio in
iudicium, che può definirsi tale solo in quanto rivolta a chi
ad essa sia in grado di rispondere».
Dopo questa decisa ed inequivoca presa di posizione, che condurrà la Suprema Corte a sussumere l’omessa traduzione nell’ambito delle nullità assolute (32), le
Sezioni unite, in una nuova pronuncia (33), ribadiscono
la sussistenza per il detenuto in un luogo esterno al circondario di un diritto alla traduzione, subordinandolo
soltanto ad una esplicita richiesta in tal senso (34).
Non stupisce, dunque, che, sulla scorta di queste autorevoli conferme, la dottrina abbia ravvisato nell’audizione per rogatoria un meccanismo destinato ad un uso
ormai soltanto residuale (35), suscettibile di venire in riNote:
(continua nota 28)
me delle misure coercitive nel processo penale, Milano, 1993, 140, che rileva
come la previsione contenuta nell’art. 127 comma 3 c.p.p. «non parrebbe
risultare indenne da critiche sul piano della legittimità costituzionale ove
la regola ivi contenuta dovesse essere intesa nel senso di privare gli imputati detenuti in istituti localizzati al di fuori del circondario in cui ha sede
il tribunale della libertà della possibilità di essere sentiti personalmente.
(..) Il diritto di contestare di persona le circostanze di fatto sulle quali si baserà la pronuncia di riesame (...) rappresenta, infatti, una diretta espressione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.»; analogamente N. Triggiani, Sul diritto dell’imputato detenuto (o internato) a partecipare all’udienza di
riesame, in Cass. pen., 1994, 3054, il quale sottolinea che questa soluzione
interpretativa “non” sia «semplicemente preferibile», ma appaia «piuttosto come l’unica conforme all’art. 24 comma 2 Cost. e a una corretta lettura della sentenza costituzionale n. 45 del 1991». In linea con tale orientamento e con riguardo all’udienza camerale in grado d’appello (art. 599
c.p.p.), v. Cass., Sez. V, 29 luglio 2002, Rosmini, in Cass. pen., 2003, 3846
e Cass., Sez. II, 8 gennaio 2002, Liuzzo, ibidem, 1228.
(29) Cass., Sez. Un., 7 marzo 1996, Carlutti, in Cass. pen., 1996, 2125,
con osservazioni di P. Pazienza; la sentenza può leggersi per estratto anche
in Foro it., 1996, II, 724, con nota di G. Di Chiara, Procedimento di riesame e autodifesa dell’interessato in vinculis: note a margine di un indirizzo innovativo
(30) Cass., Sez. Un., 7 marzo 1996, Carlutti, cit.
(31) Cass., Sez. Un., 7 marzo 1996, Carlutti, cit.
1136
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
(32) Così facendo, le Sezioni Unite hanno operato una scelta esegetica
estremamente più rigorosa rispetto all’orientamento precedente. Infatti,
prima di questo intervento, la giurisprudenza di legittimità incline al riconoscimento per il detenuto fuori circoscrizione del diritto di presenziare all’udienza di riesame, aveva manifestato una tendenza rivolta a distinguere
lo scopo dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale da quello degli incombenti successivi ad esso. Se il primo, pertanto, rappresenta la vocatio in
iudicium, funzionale ad una valida instaurazione del contraddittorio, i secondi, tra cui sarebbe da annoverare l’ordine di traduzione e gli adempimenti necessari al suo concreto espletamento, si pongono, al contrario, a
garanzia della partecipazione del detenuto in vinculis al procedimento di
riesame. Questa distinzione funzionale si è tradotta, dunque, nella sussunzione della nullità in due distinte tipologie: l’omissione dell’avviso di fissazione dell’udienza si traduce in una nullità assoluta (art. 179 c.p.p.), in
quanto si risolve nell’omessa citazione dell’imputato, mentre all’omessa
traduzione, in quanto afferente il suo intervento, consegue una nullità a
regime intermedio di cui all’art. 178 lett. c (sul punto, v. Cass., Sez. V, 24
maggio 1994, Piras, cit., in cui si afferma che la suddetta nullità non è sanata se viene dedotta prima del compimento dell’atto dalla parte che vi assiste, «sicché, la nullità riguarda le sole dichiarazioni del ricorrente e deve
essere dedotta nel corso della loro assunzione, se vi procede il magistrato di
sorveglianza; riguarda l’intero procedimento di riesame e deve essere dedotta dal difensore presente all’udienza camerale dinanzi al giudice, se l’atto viene del tutto omesso»; analogamente, Cass., Sez. II, 3 febbraio 1994,
Gioffrè, cit.; Cass., Sez. II, 3 maggio 1993, Tangorra, cit.). Le Sezioni Unite, al contrario, hanno sottolineato che la richiesta di partecipare all’udienza di riesame, così come i conseguenti adempimenti esecutivi rappresentano, insieme all’avviso di fissazione dell’udienza, gli elementi costitutivi di una fattispecie complessa, presidiata da nullità insanabile ex art. 179
c.p.p., in quanto afferente nel suo complesso alla citazione dell’imputato.
Nello stesso senso, dopo questa pronuncia, Cass., Sez. II, 16 dicembre
2002, Bello, in Cass. pen., 2003, 3129; Cass., Sez. VI, 1° aprile 1998, Caggia, ivi, 1999, 1551; Cass., Sez. VI, 11 giugno 1998, Lania, in Arch. n. proc.
pen., 1999, 211; Cass., Sez. IV, 15 gennaio 1997, Bergonzoni, in Cass.
pen., 1998, 180; Cass., Sez. II, 7 aprile 1997, Notarianni, ibidem, 1706. In
dottrina questa interpretazione non viene condivisa da R.A. Ruggiero, La
videoconferenza nell’udienza camerale di riesame, in Cass. pen., 2003, 3144,
la quale ritiene che «per potersi considerare avvenuta la citazione è sufficiente (...) che il procedimento di notificazione sia avvenuto regolarmente. Dunque, l’omessa traduzione (...) attiene ad un momento successivo rispetto all’avviso dell’udienza camerale, realizzato ritualmente. Con la conseguenza che ad esserne pregiudicato è il diritto dell’imputato di intervenire, sanzionato ai sensi degli artt. 178 e 180 c.p.p. con una nullità di carattere intermedio»; è «avanzabile qualche riserva» anche secondo G. Di
Chiara, Procedimento di riesame e autodifesa dell’interessato in vinculis, cit.,
727, il quale, tuttavia, non manca di riscontrare nel suddetto orientamento «un’attenzione nuova verso una più solida effettività delle garanzie partecipative del singolo».
(33) Cass., Sez. Un., 30 giugno 1998, D’Abramo, in Cass. pen., 1998,
2874.
(34) In questa occasione la Suprema Corte ha puntualizzato che «l’indicazione di tale diritto nell’avviso di udienza non è prevista da alcuna disposizione, né la sua omissione può integrare una nullità, stante il principio di tassatività delle stesse che devono, peraltro, concernere l’inosservanza di disposizioni espressamente stabilite per gli atti del procedimento
a norma dell’art. 177 c.p.p.».
(35) Già all’indomani dell’intervento della Corte costituzionale si legge,
peraltro, che «l’evenienza dell’audizione dell’imputato delegata al magistrato di sorveglianza (art. 309 comma 8 parte prima ed art. 127 comma
3 c.p.p.), e il conseguente diverso regime di decorrenza dei termini introdotto dall’art. 101 comma 2 n. att. c.p.p., sembrano destinati a trovare
scarsa applicazione. Un recente intervento della Corte costituzionale ha
infatti chiarito come l’imputato detenuto fuori circondario possa essere
sentito direttamente, qualora ne faccia richiesta o qualora il giudice di cognizione lo ritenga ex officio opportuno, direttamente dal tribunale della
libertà anziché dal magistrato di sorveglianza»: così A. Giannone, sub
Art. 101 disp. att. c.p.p., in AA.VV., Commento al nuovo codice di procedura penale. La normativa complementare, coordinato da M. Chiavaro, Torino, 1992, 372; nello stesso senso, M. Ceresa Gastaldo, Il riesame delle misure coercitive nel processo penale, cit., 142; N. Triggiani, Sul diritto dell’imputato detenuto (o internato) a partecipare all’udienza di riesame, cit., 3056.
GIURISPRUDENZA•PROCESSO PENALE
lievo «nelle sole ipotesi in cui il soggetto non chieda di
presenziare all’udienza per essere ascoltato dal collegio
giudicante o quest’ultimo non ritenga ex officio opportuna la sua partecipazione» (36).
Quello che, al contrario, lascia perplessi è l’ostinata
sopravvivenza di oscillazioni giurisprudenziali.
Così, accanto a posizioni che, riconoscendo il diritto alla comparizione per il detenuto altrove, negano la
sussistenza di un potere del giudice di valutare l’istanza di
traduzione (37), per la quale, dunque, non viene richiesta alcuna motivazione (38), si collocano orientamenti a cui aderisce la sentenza in commento - che, pur ammettendo ampie possibilità d’intervento in udienza (39),
riconoscono al giudice «la facoltà di disattendere richieste di audizione formulate genericamente» (40) sul presupposto che non sia sussistente un diritto pieno ed indiscutibile alla comparizione.
Prospettive di accesso alla dinamica camerale
In quest’ultimo contesto, dunque, si inserisce la
sentenza che si annota, la quale, utilizzando le tradizionali argomentazioni fatte proprie dall’indirizzo sensibile
alle esigenze di celerità e di speditezza del procedimento
di riesame (41), pur affermando la sussistenza di un «diritto della persona sottoposta a misura cautelare di esporre le proprie ragioni» ne consente l’esercizio in udienza
soltanto «qualora il giudice (...) abbia valutato utile tale
presenza, non apparendo sufficiente all’espletamento di
una difesa “completa” l’audizione da parte del magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione». Questa deroga alla procedura prevista dall’art. 127 comma 3 c.p.p.
«deve comunque derivare dalla tutela del diritto di difesa, e non da un’imposizione immotivata, e di conseguenza arbitraria, da parte dell’imputato o indagato» il quale,
pertanto, non ha diritto alla traduzione qualora non abbia prospettato esigenze difensive tali da legittimare la
sua presenza nell’udienza camerale.
Il Supremo Collegio perviene a questa conclusione,
in primo luogo, osservando che «il rinvio all’art. 127
non consente interpretazioni alternative a quella che,
nelle procedure camerali l’interessato, detenuto fuori dal
circondario, se ne fa richiesta, è sentito dal magistrato di
sorveglianza del luogo di detenzione».
A ben vedere, questa preliminare affermazione appare molto poco convincente, non foss’altro che per ragioni di coerenza argomentativa. Se, infatti, dovessimo
arrestarci di fronte ad un’interpretazione rigidamente
formale del comb. disp. degli artt. 127 c.p.p. e 309 comma 8 c.p.p., non potremmo far altro che constatare la
differenza dei diritti esercitabili dal detenuto in relazione
al locus detentionis. Se, dunque, questa fosse l’unica soluzione interpretativa consentita sulla scorta di un dato
letterale definito - ottimisticamente - inequivoco, sarebbe sicuramente esclusa la sussistenza di un diritto alla traduzione del detenuto extracircondario, ma non di meno
sarebbe esclusa la sussistenza di un potere del giudice del
riesame di valutare la necessità o anche solo l’opportu-
nità di assecondare una richiesta in tal senso. L’affermazione relativa alla sussistenza di una simile prerogativa
giurisdizionale, in effetti, non è che il frutto di un’interpretazione “alternativa” a quella scaturente dalla lettera
della norma, offerta nella consapevolezza che la diversificazione dei mezzi di esercizio dell’autodifesa possa, in
alcuni casi, pregiudicare la posizione processuale del detenuto. Del resto, è questa la ragione per cui, ad avviso
della Corte di cassazione, la Consulta «ha ritenuto che
rientrava nei poteri del giudice di merito disporre la partecipazione della persona sottoposta a misura coercitiva
all’udienza camerale, e quindi la sua traduzione, per
esprimere direttamente al collegio argomenti a lui favorevoli, nell’ipotesi che sia fatta richiesta di comparizione
ed il tribunale l’abbia ritenuta opportuna ai fini di un
esercizio assolutamente non limitabile della difesa». Ma
Note:
(36) Così, dopo l’intervento delle Sezioni unite, M. Bordieri, La garanzia
del diritto dell’imputato alla partecipazione all’udienza di riesame anche mediante videoconferenza, in Cass. pen., 2003, 3134; analogamente M. Polvani, Le impugnazioni de libertate, Padova, 1999, 305; parzialmente
difforme E. Aprile, I procedimenti dinnanzi al tribunale della libertà, Milano,
1999, 114, il quale afferma «che l’imputato abbia diritto a presenziare all’udienza camerale solo quando ha presentato personalmente l’istanza di
riesame (...); che spetta comunque al giudice valutare l’indispensabilità
della presenza dell’istante che abbia chiesto di partecipare personalmente alla camera di consiglio (...) al fine di evitare di dare seguito a richieste
formulate genericamente o con finalità defatigatorie e per verificare la
reale necessità che l’interessato intervenga personalmente per interloquire sulle risultanze probatorie e per indicare circostanze a lui favorevoli».
(37) In tal senso, Cass., Sez. II, 16 dicembre 2002, Bello, cit., in cui si sottolinea, ripercorrendo le linee interpretative tracciate dalla Corte costituzionale nel 1991 e dalle Sezioni unite nel 1996, che «nell’ipotesi in cui
l’imputato detenuto, in qualunque istituto si trovi ristretto e dunque anche al di fuori della circoscrizione del giudice che procede, manifesti tempestivamente la volontà di comparire nel giudizio camerale di riesame disciplinato dagli artt. 127 e 309 c.p.p. ne deve essere disposta la traduzione ed assicurata la possibilità di presenziare all’udienza (...) a pena di nullità assoluta ed insanabile». Secondo la Corte, inoltre, non è consentito
neppure «introdurre distinzioni fra soggetti legittimati a enunciare motivi nuovi (...) ai sensi del comma 6 dell’art. 309 c.p.p., nel senso che, nell’ipotesi di impugnazione presentata dal solo difensore (...) all’indagato
sarebbe preclusa detta facoltà sicché ne potrebbe essere legittimamente
inibita la partecipazione all’udienza. A prescindere, infatti, dalla considerazione che, come affermato dalla (...) sentenza costituzionale, sussiste
sempre e comunque l’interesse dell’indagato a comparire personalmente
per contrastare, se lo voglia, le risultanze probatorie a suo carico, l’interpretazione della disposizione predetta (...) non può essere restrittiva dovendosi l’espressione legislativa riferire alla parte istante nel suo complesso e dunque all’interessato ed ai suoi difensori che costituiscono un unico
soggetto processuale al quale sono congiuntamente attribuiti diritti e facoltà»; analogamente, Cass., Sez. I, 10 dicembre 2001, Schiavone, in
Cass. pen., 2003, 2019; Cass., Sez. VI, 1° aprile 1998, Caggia, cit.; Cass.,
Sez. VI, 11 giugno 1998, Lania, cit.; Cass., Sez. IV, 15 gennaio 1997, Bergonzoni, cit.; Cass., Sez. II, 7 aprile 1997, Notarianni, cit.
(38) Così Cass., Sez. I, 10 dicembre 2001, Schiavone, cit., 2021.
(39) Cass., Sez. VI, 3 aprile 2003, Leontino, in Cass. pen., 2004, 3710, le
individua «con riferimento alle ipotesi nelle quali sono prese in esame
questioni di fatto concernenti la condotta dell’interessato, ovvero quando costui voglia contestare le risultanze probatorie ed indicare eventualmente circostanze a lui favorevoli».
(40) In questi termini, Cass., Sez. VI, 3 aprile 2003, Leontino, cit.
(41) V. supra.
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1137
GIURISPRUDENZA•PROCESSO PENALE
così come rientra nei poteri del giudice disporre la traduzione del detenuto per esercitare una facoltà, quella di
enunciare «nuovi motivi», non esercitabile dinnanzi al
magistrato di sorveglianza, altrettanto rientra nei suoi
poteri non assecondare richieste di traduzione in cui non
vengano rappresentate esigenze difensive che non possano essere soddisfatte tramite l’audizione per rogatoria.
Il fatto che questa, ad avviso della Cassazione, sia la
soluzione “suggerita” dalla Corte costituzionale, troverebbe, del resto, conferma nella necessità di conciliare
«il diritto della persona sottoposta a misura cautelare di
esporre le proprie ragioni» e, dunque, il suo diritto di difesa, «con la particolare celerità e speditezza del procedimento di riesame», a cui oggi viene, oltretutto, riconosciuta dignità di principio costituzionale, in quanto inerente alla ragionevole durata del processo (art. 111 comma 2 Cost.). Il differente regime di audizione e il potere
del giudice di valutare il mezzo più idoneo sarebbero,
dunque, i meccanismi attraverso i quali il legislatore
avrebbe operato l’adattamento del diritto di difesa alla
particolare struttura del procedimento di riesame e, pertanto, nella necessità di questo adattamento andrebbe
ricercato il motivo dell’insussistenza, per il detenuto altrove, di un diritto pieno ed indiscutibile alla partecipazione in udienza.
Occorre iniziare l’analisi proprio da quest’ultimo
punto, perché, oltre ad aver guidato la Suprema Corte
nell’interpretazione della sentenza n. 45 del 1991, risulta essere il vero nodo da sciogliere. La soluzione della
questione, infatti, sarebbe decisamente approssimativa
se fosse limitata alla constatazione che la pronuncia della Corte costituzionale è suscettibile di ben altra lettura.
È di tutta evidenza, infatti, che valorizzando alcuni passaggi della motivazione, come, ad esempio, quello in cui
si afferma il «diritto-dovere del giudice di cognizione di
sentire personalmente l’imputato e il diritto di quest’ultimo di essere ascoltato» (42), o ancora, quello in cui si
afferma l’evidente sussistenza di un «interesse dell’imputato a comparire personalmente per contrastare - se lo
voglia - le risultanze probatorie e indicare eventualmente altre circostanze a lui favorevoli» (43), si possa constatare il riconoscimento del diritto alla partecipazione
in udienza del detenuto fuori circondario. Ma è altrettanto indiscutibile che questo riconoscimento potrebbe
essere smentito ponendo l’accento sul fatto «che di regola il legislatore per ragioni di sicurezza e di economia
processuale, abbia previsto la delega rogatoria al giudice
di sorveglianza quando l’imputato sia detenuto in un
luogo esterno al circondario, non esclude che, ove l’imputato ne abbia fatto espressa richiesta, o il giudice di cognizione lo ritenga necessario possa ordinarne la traduzione» (44). Che questo “sezionamento” della pronuncia costituzionale non conduca a risultati soddisfacenti
lo dimostra l’evoluzione, o meglio, i “corsi e ricorsi” che
la vicenda della traduzione ha subito del tempo e che,
probabilmente, continuerà a subire, fintanto che si cercherà di risolverla sulla base di una decisione evidente-
1138
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
mente non idonea a fornire dei sicuri lumi interpretativi.
Come accennato in precedenza, dunque, quello
che appare più utile domandarsi è, in primo luogo, se,
nel bilanciamento tra le esigenze di celerità e speditezza
del procedimento di riesame ed il diritto di difesa, sia
quest’ultimo a dover essere compromesso. Secondo il
Supremo Collegio, la risposta positiva dovrebbe fondarsi soprattutto sull’incidenza del principio della ragionevole durata del processo (111 comma 2 Cost.) sui caratteri del procedimento di riesame. Questa, infatti, emerge
dalla disciplina dei termini per la decisione, alla cui inosservanza consegue la perdita di efficacia della misura
(art. 309 comma 10 c.p.p.).
Questa risposta non appare soddisfacente, perché
configurare la sussistenza di un interesse confliggente
con il diritto di difesa, significa soltanto impostare i termini della questione, ma non certo risolverla. Inoltre,
delle perplessità possono essere avanzate anche con riferimento alla natura dell’interesse evocato per giustificare la predisposizione del meccanismo rogatoriale. Se, infatti, è indiscutibile che il profilo cronologico della disciplina del riesame sia stato disegnato con l’obbiettivo di
offrire una precipua garanzia al destinatario della misura
coercitiva, non altrettanta certezza si può manifestare
nell’individuazione delle ragioni che hanno condotto il
legislatore a predisporre un diverso strumento di audizione qualora la persona sia ristretta altrove.
Il principio della ragionevole durata del processo,
infatti, e, dunque, i ristretti termini imposti dalla disciplina del riesame, sono una garanzia per l’imputato - detenuto fuori o nell’ambito del circondario - perché gli assicurano «una decisione tempestiva sull’istanza de libertate» (45). Ma questa garanzia non ha valore assoluto, perché, in ogni caso, va coordinata con l’effettività della difesa (46). E che di questa necessità di integrazione il legislatore abbia tenuto conto nel disciplinare il procedimento camerale e, dunque, quello di riesame, vi è sicura
traccia nel comma 4 dell’art. 127 c.p.p., in cui si dispone
esplicitamente il rinvio dell’udienza, con conseguente
nuovo decorso dei termini per la decisione (art. 101
comma 1 disp. att. c.p.p.), nel caso di legittimo impedimento dell’imputato che abbia chiesto di essere sentito
personalmente e che - si badi - «non sia detenuto o internato in un luogo diverso da quello in cui ha sede il
giudice» (art. 127 comma 4 c.p.p.) Alla luce di questa
differente disciplina e, quindi, del fatto che per il detenuto in loco venga riconosciuta prevalente l’istanza di effettività della difesa su quella di celerità del procedimenNote:
(42) Così Corte cost., 31 gennaio 1991, n. 45, cit.
(43) Corte cost., 31 gennaio 1991, n. 45, cit.
(44) Corte cost., 31 gennaio 1991, n. 45, cit.
(45) Così Corte cost., 25 giugno 1996, n. 216, cit.
(46) In tal senso Corte cost., 25 giugno 1996, n. 216, cit.
GIURISPRUDENZA•PROCESSO PENALE
to, che verrebbe senza dubbio compromessa da un rinvio
tanto quanto lo sarebbe a causa di una traduzione, a meno di non ritenere, come pure è stato fatto da una parte
della dottrina (47), che il legislatore abbia predisposto
una disciplina in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., si
può ragionevolmente sostenere che i motivi che hanno
condotto alla predisposizione del meccanismo rogatoriale siano solo in parte ispirati a quello che oggi è il principio della ragionevole durata del processo. L’impressione,
infatti, è quella di una disciplina in cui prevalgono considerazioni d’ordine più pratico, quali la necessità di ovviare ai pericoli derivanti da «un trasporto in stato di detenzione» (48) ed ai costi, in termini di uomini e mezzi,
che una simile operazione può comportare. Il punto non
è di scarsa rilevanza, perché una cosa è effettuare, come
pure ha fatto la Corte nel caso di specie, un bilanciamento tra valori di pari dignità costituzionale, mentre
ben altro è, al contrario, mediare tra il principio di inviolabilità della difesa e fattori che - ancorché rilevanti non hanno un esplicito riconoscimento costituzionale.
Questi ultimi, infatti, potrebbero essere tenuti in considerazione e, quindi, improntare i caratteri di una determinata disciplina, soltanto qualora ai primi venisse data
concreta attuazione. Ma anche se si affermasse che «l’interesse idoneo a comprimere la sfera costituzionalmente
tutelata può essere tratto non solo da una disposizione
ma anche da un principio desumibile dalla Carta costituzionale» (49) o, ancora, se si riconoscesse dignità costituzionale agli interessi sopra menzionati, non potrebbe darsi per scontato, come invece ha fatto la Corte, che
il risultato del bilanciamento conduca ad una limitazione del diritto di difesa operata attraverso l’assegnazione
al giudice di un potere di scelta circa le modalità del suo
esercizio. Una simile opzione esegetica, infatti, potrebbe
essere accolta soltanto dimostrando un rapporto di fungibilità, sotto il profilo dell’efficienza autodifensiva tra
l’audizione per delega e quella diretta, o comunque, nel
caso in cui ciò venisse escluso, dimostrando che l’assegnazione al giudice del potere di valutare i casi in cui sia
necessario o opportuno ricorrere allo strumento più efficacie, non si traduca, per ciò solo, in una compressione
del diritto di difesa che, considerata la struttura del procedimento di riesame e tenuto conto delle potenzialità
autodifensive che esso offre, non appaia ingiustificata.
L’analisi prospettata dalla Corte in merito ad entrambi i profili risulta estremamente approssimativa. La
Cassazione, infatti, individua i casi in cui non appaia sufficiente l’audizione ad opera del magistrato di sorveglianza, identificandoli sia nella volontà di enunciare
«nuovi motivi prima dell’inizio della discussione» (art.
309 comma 6 c.p.p.) sia in quella di esprimere argomenti favorevoli al detenuto, ma poi finisce per rimette al
giudice il potere di apprezzarne l’utilità, trascurando del
tutto di analizzare - certa della soluzione «suggerita dalla
Corte costituzionale» - se le caratteristiche del procedimento consentano una tale valutazione nel rispetto del
diritto di difesa (50). Ma a ben vedere, è proprio l’anali-
si di queste ultime a smentire la praticabilità dell’opzione ermeneutica prospettata dalla Corte di cassazione.
In proposito, infatti, è opportuno rilevare come il
giudizio di riesame, si caratterizzi per lo spiccato rilievo
che assume la presenza dell’indagato - libero o detenuto
- nell’udienza camerale. L’importanza e l’incidenza che
l’autodifesa può spiegare in questo ultimo contesto non
emergono tanto dal riconoscimento della facoltà di presentare «nuovi motivi prima dell’inizio della discussione» (309 comma 6 c.p.p.), perché questa è attribuita a
chi «ha proposto la richiesta» e, dunque, tanto alla persona sottoposta alla misura coercitiva quanto al suo difensore, ma piuttosto dalla norma che descrive i poteri
attribuiti al tribunale del riesame. «Considerata la natura pienamente devolutiva del procedimento (...)» l’art.
309 comma 9 c.p.p. riconosce al tribunale il potere «di
pronunciarsi anche sulla base degli elementi addotti dalle parti» (51) nel corso dell’udienza. Queste ultime, pertanto, esercitando la suddetta facoltà, possono conferire
all’udienza camerale un andamento certamente non
ipotizzabile in astratto, perché se è vero che il momento
processuale prescelto per addurre elementi utilizzabili ai
fini della decisione è stato collocato “nel corso” e, dunque, nell’ambito dell’udienza, è altrettanto vero che l’area delle prospettazioni difensive finisce col dipendere
anche dagli sviluppi della vicenda camerale (52) e, dunque, in ultima analisi, non soltanto dagli elementi che il
detenuto intende addurre a sostegno della propria difesa
- che sarebbero i soli ad essere valutati dal giudice in seNote:
(47) Così, M. Garavelli, sub Art. 127 c.p.p., cit., 98. Ad avviso di chi scrive tale conclusione, pur condivisa sotto il profilo della doverosa sensibilità verso principi che prima di essere cardine dell’ordinamento sono i pilastri di una società democratica, è evitabile attraverso il ricorso ad un’interpretazione che valorizzi le potenzialità garantistiche presenti nella disciplina, offuscate da un tenore letterale solo apparentemente insuperabile.
(48) Così T. Della Marra, Sulla partecipazione dell’imputato detenuto all’udienza di riesame, cit., 725.
(49) In questi termini, criticamente, G.P. Voena, voce Difesa (III. Difesa
penale), in Enc. giur. Treccani, X, 1988, il quale osserva che, attraverso tale affermazione, «si è aperta inevitabilmente la strada ad una vasta gamma di interessi, spesso costruiti in maniera tanto vaga da servire per tutti
gli usi, oppure forniti di nessuna o, al più, di marginale rilevanza costituzionale».
(50) Quest’ultima analisi sarebbe stata indispensabile nell’economia di
un percorso argomentativo che trae le mosse da un bilanciamento tra interessi riconosciuti, o anche solo desumibili, dalla Carta costituzionale ed
il diritto di difesa. In effetti, come sottolinea G.P. Voena, loc. cit., «la qualifica in termini di inviolabilità del diritto di difesa (...) attribuirebbe» a
questo «una posizione in cima alla scala dei valori costituzionali con il
conseguente prevalere delle situazioni di inviolabilità rispetto ad ogni altra pur costituzionalmente rilevante». L’Autore, inoltre, condivisibilmente sottolinea come, nonostante debba escludersi che l’inviolabilità
possa risolversi in un «selettore automatico tra più soluzioni antinomiche», non possa non riconoscersi in questa qualificazione «un sicuro criterio guida» che conduce a privilegiare «quelle operazioni interpretative
capaci di attribuire all’art. 24, 2° Cost. la portata più ampia».
(51) In questi termini G. Spangher, sub Art. 309 c.p.p., cit., 1881.
(52) In tal senso Cass., Sez. Un., 7 marzo 1996, Carlutti, cit., 2128.
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1139
GIURISPRUDENZA•PROCESSO PENALE
guito alla richiesta di traduzione - ma anche dagli elementi prospettati dalle altre parti. Ed è proprio su questi
ultimi che conviene porre l’accento. Considerato, infatti, che, in quanto “addotti nel corso dell’udienza”, questi
elementi non sono soggetti ad un obbligo di anticipata
discovery, l’udienza rappresenta la sede in cui può essere
assicurata la tutela del contraddittorio. Ne consegue che
anche qualora il detenuto non esercitasse la facoltà di
addurre nuovi elementi, le sue possibilità autodifensive
non sarebbero esaurite, perché rimarrebbe integro il suo
diritto di interloquire sui risultati dell’attività altrui. Nonostante, infatti, il riesame sia un procedimento camerale, nel quale, perciò, non sussiste «un vero e proprio rapporto di contrapposizione dialettica e di opposizione delle tesi, degli argomenti e dei dati probatori» (53), il riconoscimento della facoltà delle parti di addurre elementi
nel corso dell’udienza induce a respingere l’idea che il loro intervento possa risolversi in un breve riassunto delle
rispettive tesi (54) . Questo, ad avviso di chi scrive, può
escludersi in ragione dell’incidenza che tali elementi potenzialmente rivestono con riguardo alla decisione;
un’incidenza, dunque, che impone di garantire, nel rispetto dei tempi del procedimento, una corretta dialettica tra le parti (55).
Rispetto al modello ordinario di procedimento camerale, in quello di riesame, pertanto, si può sostenere
che la configurazione dell’autodifesa come «personale
partecipazione al contraddittorio» (56) si accentui in relazione alle specifiche caratteristiche del mezzo d’impugnazione.
Sono prima di tutto queste ultime che, pertanto,
escludono la configurabilità di prerogative giurisdizionali rivolte a regolare l’accesso alla dialettica camerale.
L’utilità della presenza dell’interessato, infatti, potrebbe essere misurata dal giudice soltanto considerandola
in una prospettiva statica e, dunque, a prescindere dagli apporti che le altre parti possono addurre nel corso
dell’udienza. Soltanto in un simile contesto, in effetti,
si può richiedere la rappresentazione di esigenze difensive che, in quanto non esercitabili dinnanzi al magistrato di sorveglianza, siano tali da legittimare la presenza del detenuto in udienza. Ma in un ambito dinamico, qual è quello dell’udienza di riesame, l’unica esigenza difensiva che legittima la comparizione del detenuto in alio loco è quella di voler partecipare personalmente al contraddittorio.
La comparizione, pertanto, non può essere subordinata ad un onere di esternazione di questo interesse, perché è il solo fatto di domandare la traduzione che ne
manifesta la sussistenza. Un onere semmai sussiste proprio con riferimento a tale ultima attività, rispetto alla
quale, però, non deve fuorviare il fatto che si utilizzi l’espressione “richiesta”, perché la sua funzione non è quella di condurre ad una risposta in termini di accoglimento o di rigetto. Nell’economia di un procedimento a contraddittorio eventuale (57), la richiesta rappresenta un
atto che, manifestando implicitamente la scelta dell’in-
1140
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
teressato, costituisce semplicemente il presupposto per
un’iniziativa dell’autorità giudiziaria rivolta a rimuovere
l’ostacolo alla libertà di spostamento derivante dallo stato restrittivo in cui lo stesso interessato versa; e che soltanto questa sia la sua funzione è testimoniato anche
dall’analisi del regime partecipativo del detenuto in loco
con riferimento al quale, pur se incentrato su una richiesta, non si dubita della sussistenza di un diritto alla comparizione (arg. ex art. 127 comma 4 c.p.p.).
Se, pertanto, come si sottolinea nella sentenza in
commento, «il diritto della persona sottoposta a misura
cautelare di esporre le proprie ragioni» deve essere oggetto di un adattamento, deve escludersi che la soluzione possa essere affidata alle valutazioni del giudice del
riesame. Se così fosse, infatti, l’adeguamento alle esigenze di celerità e di sicurezza diverrebbe un agevole espediente per ridurre l’area protetta dagli artt. 3 e 24 comma
2 Cost., essendo evidente che questi interessi verrebbero
garantiti attraverso il sacrificio del diritto di difesa della
persona sottoposta a misura coercitiva. A ben vedere,
inoltre, questa soluzione, prima ancora di essere incompatibile principi generali risulta poco coerente con i caratteri del procedimento di riesame nel quale «la valenza dell’autodifesa assume un rilievo talvolta anche supeNote:
(53) Così M. Ceresa Gastaldo, Il riesame delle misure coercitive nel processo
penale, cit., 135.
(54) In tal senso M. Garavelli, sub Art. 127 c.p.p., cit., 97; analogamente M. Polvani, Le impugnazioni de libertate, cit., 311.
(55) A tal fine risultano esercitabili dal Presidente del Collegio «i tradizionali poteri di polizia e di direzione dell’udienza previsti dall’art. 470 per
il dibattimento, nonché il compito di impedire divagazioni, ripetizioni ed
interruzioni nell’esposizione delle ragioni delle parti, sulla traccia dell’art.
523, norme che, entrambe, sono (...) applicabili per analogia, in mancanza di diverse indicazioni»: così M. Polvani, Le impugnazioni de libertate, cit., 310, il quale, peraltro, reputa non applicabili al procedimento di
riesame le disposizioni dell’art. 523 c.p.p. che prevedono «sia il diritto di
replica per il difensore delle parti e per il pubblico ministero, sia quello di
imputato e difensore di avere per ultimi la parola». Se quest’ultima posizione è condivisibile in omaggio alle caratteristiche semplificate della
dialettica camerale, non altrettanto può dirsi rispetto alla scelta che l’A.
effettua in merito all’ordine degli interventi. Questo è invertito rispetto a
quello delineato nell’art. 523 c.p.p., tanto che la parola dovrebbe essere
data per prima «alla parte impugnante, e solo successivamente all’altra
parte». Questa non appare una soluzione funzionale ad un’efficacie esplicazione della difesa da parte di colui della cui libertà personale si tratta o
comunque del suo difensore. Entrambi, infatti, non avendo diritto di replica o, comunque non potendo avere la parola per ultimi, potrebbero
sfruttare l’ordine degli interventi previsto per il dibattimento (art. 523
comma 1 c.p.p.) per contrastare, con maggiore consapevolezza, le argomentazioni avversarie.
(56) G. Bellavista, voce Difesa, II) Difesa giudiziaria penale, cit., 456.
(57) Sul punto, F. Cordero, Procedura penale, cit., 391, che sottolinea come nel procedimento camerale di cui all’art. 127 c.p.p. «parti, “interessati”, difensori ricevono l’avviso; quando l’imputato non abbia difensore,
gliene viene nominato uno; ma adempiuti tali requisiti, importa poco che
i destinatari siano o no presenti; i comparsi interloquiscono. Difesa e contraddittorio, insomma, sono pure facoltà e, correlativamente, oneri: vale
un modello liberistico congeniale allo stile accusatorio; ognuno agisce
come meglio ritiene, correndo i relativi rischi; nessuno provvede all’inerte».
GIURISPRUDENZA•PROCESSO PENALE
riore alla difesa tecnica» (58). Ma proprio perché si tratta di un procedimento in cui l’autodifesa ha un ruolo
centrale deve mantenersi fermo il principio per cui è
l’interessato a scegliere il mezzo con cui difendersi. In
questo modo, qualora il detenuto ritenga che la dinamica camerale nulla aggiunga alle ragioni della propria difesa, potrà accedere al meccanismo rogatoriale, la cui
speditezza e semplicità ben si adattano all’esercizio dell’autodifesa attraverso l’offerta di dichiarazioni spontanee; nel caso in cui, al contrario, ritenga opportuno
«contestare di persona le circostanze di fatto sulle quali
si baserà la pronuncia di riesame» (59) potrà optare per
la comparizione. Soltanto considerando queste due forme di esercizio dell’autodifesa in un rapporto non di regola/eccezione, ma di alternatività (60) si può, dunque,
operare un contemperamento tra il diritto di difesa e la
celerità del procedimento di riesame, che possa dirsi
conforme ai principi costituzionali dell’uguaglianza e
dell’inviolabilità della difesa, in quanto non incentrato
sulla ricerca di quale interesse sia prevalente e quale debba essere sacrificato, ma piuttosto rivolto alla ricerca di
un equilibrio che soddisfi, con mezzi diversi, esigenze difensive diverse.
Così intesa la disciplina scaturente dal combinato
disposto degli artt. 127 c.p.p. e 309 comma 8 c.p.p., non
determina alcuna distinzione tra detenuti nell’ambito
della circoscrizione del giudice e coloro che siano ristretti altrove, sia sotto il profilo della comparizione che per
quello relativo alla disciplina del rinvio dell’udienza in
caso di legittimo impedimento. Non solo, come espressamente prevede l’art. 127 comma 4 c.p.p. (61), il detenuto nello stesso luogo in cui ha sede il giudice ma anche
il detenuto extracircondario, infatti, avrà diritto ad un
rinvio dell’udienza qualora versi in stato di legittimo impedimento (62). Ragionando diversamente si finirebbe
per avallare un’interpretazione palesemente in contrasto
con gli artt. 3 e 24 comma 2 Cost., non certamente giustificabile sulla scorta della tanto evocata esigenza di speditezza del procedimento, perché, come sottolineato in
precedenza, è la stessa disciplina del rinvio che manifesta la prevalenza della garanzia di effettività della difesa
sulla celerità del procedimento; una prevalenza che, oltretutto, è resa ancora più evidente dall’ampiezza della
nozione di legittimo impedimento offerta dalla Corte
costituzionale (63). La Consulta, dopo aver riaffermato
l’orientamento espresso nella sentenza n. 45 del 1991
circa la sussistenza del «diritto dell’imputato di essere
sentito personalmente dal giudice del riesame (...) anche
quando» il destinatario della misura coercitiva «sia detenuto in un altro luogo» (64), ha ritenuto che costituisca
legittimo impedimento dell’imputato «l’impossibilità
per il medesimo di conferire con il proprio difensore, a
causa di un concomitante provvedimento di differimento dell’esercizio del diritto al colloquio» (65) anche se
adottato nell’ambito di un altro procedimento.
Note:
(58) Così Cass. Sez. un., 7 marzo 1996, Carlutti, cit.
(59) In questi termini M. Ceresa Gastaldo, Il riesame delle misure coercitive nel processo penale, cit., 141.
(60) Descrive l’audizione ad opera del magistrato di sorveglianza come
modalità alternativa e “del tutto eventuale” alla personale comparizione
in udienza, M. Polvani, Le impugnazioni de libertate, cit., 321. In giurisprudenza, al contrario, Cass., Sez. II, 3 febbraio 1994, Gioffrè, cit., ritiene che «l’audizione del detenuto da parte del magistrato di sorveglianza
non esclude il diritto del detenuto stesso a comparire all’udienza camerale allorché ne abbia fatto specifica richiesta; ed in tal caso non compete
all’indagato detenuto “richiedere la traduzione”, poiché il predetto deve
limitarsi a chiedere di comparire personalmente all’udienza camerale».
(61) T. Della Marra, Sulla partecipazione dell’imputato detenuto all’udienza di
riesame, cit., 725, nota 11, considera questa norma «di difficile comprensione» considerando che «l’orientamento interpretativo secondo il quale deve considerarsi essenziale alla dialettica processuale l’intervento personale dell’imputato o del condannato era» già «emerso sotto il vigore
del codice abrogato con riferimento alla disciplina dell’incidente di esecuzione. La Corte costituzionale, con sentenza n. 98 del 1982, aveva dichiarato illegittimo l’art. 630, 2° comma, c.p.p. 1930 nella parte in cui
non prevedeva il rinvio della trattazione dell’incidente di esecuzione, ove
l’imputato o il condannato, che avesse fatto domanda di essere sentito
personalmente, non fosse comparso per legittimo impedimento».
(62) In dottrina, sul riconoscimento di un diritto al rinvio anche per il
detenuto fuori sede, F. Cordero, Procedura penale, cit., 542; analogamente
M. Polvani, Le impugnazioni de libertate, cit., 325, il quale sottolinea che
in mancanza della richiesta di comparire personalmente «non può trovare accoglimento l’istanza di rinvio del difensore motivata con l’impedimento legittimo dell’imputato».
(63) Corte cost., 25 giugno 1996, n. 216, cit.
(64) Corte cost., 25 giugno 1996, n. 216, cit.
(65) Corte cost., 25 giugno 1996, n. 216, cit.
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1141
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
Delitti contro la persona
“Maghi-guaritori” e morte del paziente:
profili oggettivi e soggettivi
di responsabilità penale
G.I.P. TRIBUNALE DI SAVONA, 22 dicembre 2004 (u.p. 24 settembre 2004), n. 352
Giud. Luppi - L., imputato
Delitti contro la vita e l’incolumità individuale - Omicidio - Attività illecita dei c.d. “maghi-guaritori” - Morte del “paziente-cliente” - Omicidio mediante omissione - Configurabilità - Esclusione - Omicidio commissivo - Nesso di causalità tra la condotta illecita del “guaritore” e la morte del “paziente” - Sussistenza - Elemento soggettivo - Dolo intenzionale - Esclusione - Dolo eventuale - Esclusione - Dolo diretto - Sussistenza.
(Artt. 40, 43, 575 c.p.)
Nell’ipotesi in cui il c.d. “ mago-guaritore”, al fine di conseguire un illecito profitto, induca il “pazientecliente” a non sottoporsi ai trattamenti terapeutici proposti dalla medicina ufficiale idonei ad evitare la
morte o comunque a rallentare il decorso di una patologia tumorale, il “guaritore” può essere chiamato a rispondere per omicidio doloso (sub specie di dolo diretto) qualora, a causa della degenerazione della malattia, il “paziente-cliente” muoia.
(Omissis).
Il fatto
Alla fine del 1994 M.A., una donna di 32 ani, mediante
autopalpazione si accorge di avere un nodulo nella
mammella sinistra.
Nel mese di maggio del 1995, quando le dimensioni
del nodulo si sono triplicate, la M. si reca presso l’IST
(Istituto Nazionale Tumori) di Milano dove le viene
diagnosticato che la formazione in questione ha carattere neoplastico (specificamente si tratta di un carcinoma).
I medici milanesi consigliano alla donna di sottoporsi ad
intervento chirurgico e a trattamento chemioterapico.
Quest’ultimo, destinato a ridurre la massa tumorale,
avrebbe avuto una finalità preparatoria rispetto all’operazione chirurgica con la quale la neoplasia sarebbe stata
successivamente rimossa.
In quel momento (siamo nei primi giorni di maggio
1995) la M., che, a causa di un tumore mammario, aveva già perduto la madre (nel 1987) ed una zia materna,
cade in preda alla disperazione e mostra un rifiuto della
realtà.
In tale contesto psicologico, che sarà fra poco analizzato
più approfonditamente, la M. inizia ad avere perplessità
e paure con riguardo ai rimedi terapeutici e chirurgici
che, in base ai dettami della medicina ufficiale, le sono
stati suggeriti dai sanitari milanesi.
Il venerdì (5 maggio) apprende la terribile notizia del tu-
more e già il lunedì successivo dovrebbe entrare in ospedale per iniziare le cure.
Nei giorni che la separano dall’ingresso in ospedale la
donna casualmente, mentre si trova in macchina, ascolta una trasmissione di un’emittente locale nel corso della quale un individuo (il L.) invita a diffidare della medicina ufficiale e ad evitare i trattamenti chemioterapici.
In alternativa il L. «… proponeva di affidarsi alle sue cure,
vegetariane e naturopate» (queste furono le parole usate
dal L. e riferite testualmente dalla M. nel corso delle dichiarazioni che la stessa rese in sede di incidente probatorio).
Il lunedì successivo, pertanto, la sventurata donna, anziché ricoverarsi in ospedale si reca a Quiliano (SV), dove
il L. “opera” in un centro denominato ECIN (Ente Culturale Igienistiche Naturali).
Affidatasi dunque al guaritore, la M. segue i suoi consigli, che per ora, così sintetizziamo: applicare sulla mammella impacchi a base di argilla; alimentarsi solo con
succhi di carote. In tal modo il tumore sarebbe stato
espulso dopo 42 giorni («vi sarebbe stata ulcerazione e fuoriuscita del male»).
Naturalmente i succhi di frutta e l’argilla vengono venduti alla M. dal L. al prezzo complessivo di alcuni milioni di lire.
L. garantisce alla donna che, grazie ai trattamenti sopra
indicati, il tumore fuoriuscirà e vi sarà completa guarigione.
– Nel luglio del 1995 la M. constata che, nonostante le
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1143
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
promesse del L., la malattia, ancorché regredire, si è aggravata (la massa tumorale è aumentata consistentemente).
Ciononostante la donna continua ad accettare le nuove
terapie che L. le propone.
– Nel settembre 1995 la M. effettua una biopsia all’IST
di Genova (che ribadisce la diagnosi di carcinoma mammario). Il tumore ha raggiunto, in quella fase, dimensioni considerevoli. Il prof. R.R., dell’IST di Genova, nominato perito dal GUP, sintetizza in questo modo, sulla
base della documentazione effettuata nel settembre de
1995: «… vi è un coinvolgimento dei linfonodi ascellari omolaterali. Il carcinoma è aggressivo a causa di vari fattori (poco differenziato, recettori differenziali negativi, alta attività
proliferativa) e l’esame istologico dimostra un’infiltrazione
anche nel tessuto sottocutaneo».
– Nel novembre 1995 la M. interrompe i rapporti con il
L. Per un brevissimo periodo si rivolge a un centro di
medicina alternativa di Finalborgo;
– nel dicembre 1995 si verifica l’ulcerazione della mammella;
– nel marzo 1996 dopo l’ulcerazione si ha una necrotizzazione dei tessuti («pezzi di carne si staccavano dal seno»,
riferì la M. nel corso dell’incidente probatorio). Seguono
le prime emorragie.
Nel luglio del 1996, quando la situazione è ulteriormente peggiorata (la M. versai n uno stato di grave anemia,
vi è una vasta estensione del carcinoma e di scompaginamento della normale struttura mammaria), la donna,
finalmente, decide di sottoporsi alle terapie chemioterapiche e, successivamente, alla mastectomia (viene al tal
fine ricoverata all’Ospedale S. Corona di Pietra Ligure).
Dopo un breve periodo di ripresa e di apparente miglioramento, le condizioni della M. precipitano e, a causa
delle metastasi tumorali, la donna muore il3 novembre
1998.
Dalla documentazione in atti risulta la penale responsabilità dell’imputato in ordine a tutti i reati ascrittigli.
Preliminarmente si evidenzieranno gli elementi sulla base dei quali si ritiene dimostrata la più grave delle accuse
mosse al L.: quella di “omicidio volontario aggravato”.
Va premesso che, in relazione a tale reato, il capo d’imputazione predisposto dal PM contiene la contestazione
di due condotte “alternative” che il L. avrebbe posto in
essere, ritenute entrambe eziologicamente, connesse al
decesso della signora M. una, basata sulla “determinazione” dell’evento (la morte della M.), l’altra sul “non impedimento” dell’evento medesimo. Quest’ultima fondata sulla violazione dell’art. 40 comma 2 cp. (in combinato disposto con l’art. 575 cp.).
Più analiticamente, nella parte successiva, il capo d’imputazione presenta una descrizione e specificazione delle
condotte attraverso le quali venne provocata la morte
della M.
Dalla lettura del capo d’imputazione emerge con evidenza che il PM ha formulato la contestazione del reato
anche in forma commissiva (la scelta del termine “de-
1144
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
terminatore”, peraltro tipicamente proprio della tematica del concorso di persone nel reato, risulta comunque
esplicita nel riferimento a una condotta positiva dell’agente); rispetto a tale forma di realizzazione del reato
sembrerebbe essere stata dedicata maggiore attenzione e
precisione alla descrizione della condotta omicida contraddistinta da omissione: «… comunque, non impedendo
l’evento che aveva l’obbligo giuridico di impedire, in considerazione della posizione di garanzia assunta rispetto alla persona offesa».
I riferimenti successivi, che prima facie sembrerebbero
concernere la sola omissione, ad un’attenta lettura, si rivelano certamente riferibili anche alla condotta commissiva contestata al L. «… in particolare impedendo o comunque proibendo che questa potesse liberamente ricorrere
ad ogni corretto intervento terapeutico, anche e soprattutto di
carattere chirurgico, volto a debellare il carcinoma allo stato
iniziale dal quale era affetta, o quantomeno a procrastinarne
gli effetti letali ed anzi propinandole diversi trattamenti empirici non solo di scontata inefficacia, ma finanche tali da aggravare la patologia in atto…».
L’ascrivibilità della condotta omicida all’imputato L’impedimento di un intervento “soccorritore”
Sotto il profilo materiale ritiene questo Giudice che la
condotta del L. sia stata determinata nella causazione
della morte della signora M.
La donna morì il 3 novembre 1998 in conseguenza delle
metastasi provocate dal carcinoma mammario.
Va subito chiarito che la condotta del L. eziologicamente connessa alla morte della M., non può essere individuata nella somministrazione alla donna di taluni trattamenti e di particolari diete alimentari che l’imputato le
prescrisse.
Infatti la documentazione medica e le perizie espletate
fanno escludere una qualsivoglia incidenza causale (in
relazione al nefasto esito della malattia della M.) delle
pratiche e del regime alimentare al quale per un certo
periodo la sventurata donna fu avviata dal L.
A supporto di tale conclusione è sufficiente riportare il
risultato della perizia svolta dal Prof. R.R., specialista di
Oncologia Clinica, responsabile della Divisione Oncologica dell’Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro
di Genova:
«… le pratiche “terapeutiche” effettuate dal L. … possono
essere considerate del tutto ininfluenti per quanto attiene all’evoluzione della neoplasia. Alcune di queste pratiche, ed in
particolare il digiuno prolungato, potrebbero avere avuto un
effetto debilitante sulla donna, ma certamente non in grado di
influire in maniera significativa sull’evoluzione della malattia,
specie in considerazione del periodo in cui i trattamenti vennero effettuati…».
Ritiene questo Giudice che, sempre limitando il campo
d’indagine alla tematica causale, l’elemento fondante la
responsabilità dell’imputato in ordine al decesso della signora M., vada individuato in un complesso di attività
destinate ad incidere sulla psiche della donna e ad ope-
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
rare una trasformazione (o un rafforzamento) della sua
volontà (nel senso di determinarla a non sottoporsi alle
cure previste dalla medicina ufficiale), senza il compimento delle quali, con un ragionevole grado di certezza,
può affermarsi che l’evento letale non si sarebbe verificato (in quanto la donna si sarebbe sottoposta alle cure e
ai trattamenti idonei previsti dal protocollo medico).
Più precisamente, e confortati in tali conclusioni (che
appresso si illustreranno analiticamente) dalle risultanze
di tutte le perizie medico-legali e dalla documentazione
acquisita, può affermarsi che, se il corso degli eventi (e
delle scelte che li determinarono) fosse stato diverso, la
M. sarebbe, con un rilevante grado di probabilità guarita, sfuggita alla morte e, comunque (ma certamente), la
sua esistenza sarebbe durata più a lungo di quanto non
sia accaduto.
– Dalla perizia sfilata dall’autorevole Prof. R. si evince
che vi fu senz’altro un ritardo diagnostico (ovviamente
non ascrivibile al L.). Tale ritardo viene stimato dal Prof.
R. in 20-24 settimane: « la paziente si accorse del nodulo alla mammella verso la fine del 1994 e si rivolse all’IST di Milano nel maggio 1995, dove venne posta diagnosi di carcinoma mammario e venne proposto un corretto programma terapeutico (chemioterapia seguita da intervento chirurgico)
che la paziente decise autonomamente di non seguire».
Certamente il ritardo diagnostico è imputabile soltanto
alla M., la quale troppo indugiò prima di effettuare seri
accertamenti sulla natura del nodulo, la cui presenza
aveva constatato mediante autopalpazione.
Per quel che concerne il ritardo terapeutico, invece, il
ruolo del L. risulta significativo e rilevante.
I primi contatti della donna con il L. sono del maggio
1995. Il distacco della M. dall’imputato si verifica nel
novembre 1995.
Ora, prima di analizzare l’importante questione (sempre
inerente il profilo causale) relativa all’atteggiamento
della persona offesa, in relazione al fatto di sottoporsi o
meno alle cure della medicina ufficiale, risulta importante verificare quel che, ipotizzabilmente (ma verosimilmente), sarebbe accaduto qualora nelle settimane
che seguirono la diagnosi e i conseguenti suggerimenti
terapeutici (chemioterapia e intervento chirurgico), la
M. si fosse attenuta agli stessi.
Su questo punto il Prof. R. venne chiamato a rispondere ad un quesito che fu formulato in relazione ad un
periodo di tempo posticipato, rispetto alle esigenze di
informazione necessarie al Giudice ai fini della decisione.
Infatti il GUP (che pure redasse i quesiti con analiticità
e rivelando un attento studio delle problematiche sottese al caso) interrogò l’illustre scienziato (circa l’efficacia
esplicata sul decesso della M. dalla mancanza di cure appropriate) con riguardo a un periodo successivo all’entrata in scena del L. (da fine ottobre 1995 sino al momento del ricovero, avvenuto nel luglio 1996).
Ora, poiché i contatti con il L. iniziarono dal maggio
1995, sarebbe stato opportuno, accertare cosa sarebbe
potuto accadere se le cure necessarie fossero state somministrate alla M. a decorrere da tale momento.
Tuttavia le conclusioni alle quali è pervenuto il perito
sono tali da soddisfare, attraverso un ragionamento a fortiori, le esigenze informative di cui il Giudice necessita.
Scrive il Prof. R. nella sua relazione peritale: «La mancanza di cure adeguate nel periodo indicato (ottobre 1995/luglio 1996, epoca del ricovero) ha certamente esplicato un’efficacia causale sull’evento-morte, riducendo in modo significativo le probabilità di guarigione della paziente».
Sul punto (determinare in ordine all’accertamento circa la sussistenza di un nesso causale tra l condotta del L.,
“impeditiva” delle cure necessarie, e la morte della M.)
risultano altresì chiarissime le conclusioni del dott.
M.S., specialista dell’Istituto di Medicina Legale all’Università degli Studi di Genova: «… la condotta contestata all’imputato, impedendo alla paziente di usufruire di
cure adeguate e incidendo quindi significativamente sulle
probabilità di guarigione della neoplasia, ha avuto un’efficacia causale sulla morte della M., in termini di anticipazione
dell’evento… La mancanza di cure appropriate da fine ottobre 1995 al momento del ricovero ha praticamente abolito
qualsiasi probabilità di guarigione della paziente… Se la paziente fosse stata sottoposta a cure adeguate in un periodo
antecedente al dicembre 1995, sarebbe stato possibile garantirle una possibilità di guarigione significativamente superiore
a quella stimabile nel momento in cui la neoplasia mammaria si è ulcerata».
Ed ancora, il CT del PM, dott. F.B, medico legale, nelle
sue conclusioni, stilate quando la M. era ancora in vita
(il 2 dicembre 1996), scriveva (dopo aver escluso che i
trattamenti propinati dal L. alla donna avessero avuto
effetti dannosi) che «… un corretto trattamento medico
avrebbe potuto modificare la prognosi quoad vitam ...».
Ora, alla luce di quanto evidenziato può ritenersi che il
L., con l’impedire alla M. (mediante un’attività di persuasione continuativa ed efficace) di sottoporsi a trattamento chemioterapico e al successivo intervento chirurgico, previsto dal protocollo terapeutico del caso, diede
un contributo determinante alla causazione della sua
morte o, comunque, ad una (consistente) anticipazione
della stessa, rispetto a quella che sarebbe stata l’evoluzione degli eventi senza il suo intervento.
La condotta del L. è stata dunque condizione necessaria
del decesso (o del decesso consistentemente anticipato)
della M.
L’accertamento della sussistenza del nesso causale è stato
condotto (doverosamente) utilizzando il contributo delle leggi scientifiche (medico legali, oncologiche, etc.) e
statistiche, in grado di spiegare le relazioni tra cause ed
effetti nella materia sottoposta ad esame.
Non risulta necessario, se non marginalmente, richiamare in questa sede i contenuti dell’importantissima
sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione, (10 luglio 1002, n. 30328, Franzese). Tale decisione ineriva la
tematica del nesso di causalità in relazione ad un’imputazione di omicidio colposo (nell’ambito dell’attività
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1145
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
medico-chirurgica) realizzato attraverso una condotta
omissiva.
Deve osservarsi che, pur nella diversità del caso in esame, rispetto a quello deciso dalle SS.UU., i principi dettati hanno un valore generale nell’individuazione dei
parametri ritenuti necessari per l’accertamento dell’elemento costitutivo de quo.
Va poi aggiunto che, se è vero che nel caso in oggetto, a
carico del L. non viene ravvisata responsabilità in ragione di una condotta omissiva, bensì per aver egli impedito che un soggetto affetto da tumore si sottoponesse ad
un trattamento terapeutico e chirurgico, la valutazione
che il giudice è chiamato a compiere (in termini di giudizio ipotetico, contrafattuale), risulta identica a quella
inerente il caso sottoposto al vaglio delle SS.UU.
Il Tribunale, nella vicenda della morte della signora M.,
è chiamato, infatti, a rispondere ai seguenti quesiti:
– «sarebbe sopravvissuta la M. qualora nel maggio 1995
(o a breve distanza da tale data) si fosse sottoposta alle
cure mediche ed al successivo intervento chirurgico?»;
– ed ancora: anche ammesso che il ritardo (questo certamente ascrivibile alla M.) dal momento della constatazione del nodulo a quello della diagnosi di neoplasia non
potesse consentire di evitare un esito nefasto della malattia, la morte della donna venne anticipata consistentemente dall’assai tardiva sottoposizione alle terapie e all’intervento chirurgico?
Ora, ad avviso di questo Giudice, sulla scorta delle indicazioni fornite dalle SS.UU. con la menzionata sentenza (ex art. 173 comma 3 dispp. att. cpp) la risposta al primo quesito è negativa.
Come è noto, non è possibile, nella materia in esame,
formulare valutazioni in termini di certezza assoluta ma
soltanto in termini di probabilità (il cui grado più elevato viene si individuato in una “certezza”, ma questa può
essere solo “ragionevole” stante il carattere “non esatto”
della certezza medica).
Ebbene, nel caso della signora M., tutti i periti hanno
concluso in termini assai distanti dalla “ragionevole certezza” di guarigione nell’ipotesi di tempestivo ricorso alle terapie prescritte e ad intervento chirurgico (Prof. R.:
«… in termini di elevata probabilità … sarebbe stato possibile offrire alla paziente una probabilità di guarigione significativamente superiore rispetto alla malattia in stadio III B (rispetto allo stadio III A del dicembre 1995»; Dott. S.: «… sarebbe stato possibile garantire una probabilità di guarigione significativamente superiore a quella stimabile al momento in
cui la neoplasia si è ulcerata»; Dott. B.: «… un corretto trattamento medico avrebbe potuto modificare la prognosi quoad
vitam».
Risulta evidente, dunque, che sulla base di tali indicazioni, non potrebbe attribuirsi la responsabilità al L. per la
morte della M.
Se ci si accontentasse di una normale probabilità, secondo quanto acutamente sottolineato dal Supremo Consesso di legittimità, si trasformerebbe, un reato “di danno”, quale è l’omicidio (in sentenza il ragionamento è ri-
1146
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
ferito al delitto colposo, ma può essere sicuramente esteso alla particolare fattispecie dolosa in oggetto) in un
reato “di pericolo”.
In proposito si riportano le illuminanti enunciazioni della sentenza menzionata: «Non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell’ipotesi accusatoria sull’esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificare
la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del
fatto e dell’evidenza disponibile, così che, all’esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l’interferenza di
fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa
la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata
condizione necessaria dell’evento lesivo con “alto o elevato
grado di credibilità razionale” o “probabilità logica”».
– Dai principi enunciati nella medesima decisione si ricava invece la possibilità di dare una risposta positiva al
secondo quesito.
Sempre alla luce delle risultanze delle perizie e delle
consulenze mediche sopra menzionate può affermarsi
con certezza che l’azione del L. (impeditiva del ricorso,
da parte della M., alle terapie prescritte e all’intervento
chirurgico provocò l’anticipazione di un’evento (la
morte della donna), che si sarebbe (forse, probabilmente, molto probabilmente) verificato ugualmente, ma
certamente in un momento consistentemente differito,
rispetto a quello in cui realmente accadde (Prof. R. afferma che: «… il ritardo nelle cure ebbe un ruolo significativo nell’evoluzione della malattia», Dott. S.: «… la condotta del L. da maggio a novembre 1995 impedì che la paziente venisse curata sì da assicurarle maggiori probabilità di
sopravvivenza. Tale condotta ha pertanto svolto un ruolo
causale nel determinismo della morte del soggetto, anticipandone l’evento».
Si deve pertanto ricordare quanto affermato sul punto
dalla SS.UU.: «… Il nesso causale può essere ravvisato
quando, alla stregua del giudizio contrattuale condotto sulla
base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge
scientifica - universale o statistica -, si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell’evento hic et nunc, questo non si sarebbe verificato,
ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente
posteriore…».
– In conclusione va rilevato che il risultato dell’indagine
inerente il nesso di causalità è stato raggiunto tenendo
conto dell’ininfluenza che la (negligente) condotta della persona offesa ebbe sull’evoluzione della malattia.
Il ritardo iniziale nel compimento di approfonditi accertamenti diagnostici (effettuati nel maggio 1995) rispetto
al momento della contestazione da parte della M. della
presenza di noduli al seno (dicembre 1994) influì sugli
eventi successivi (e avrebbe comunque potuto influenzarli anche in assenza dell’intervento del L. e di sottoposizione a cure ed operazione chirurgica in epoca decorrente dal maggio 1995).
Ma, con specifico riguardo all’anticipazione dell’evento
(unica situazione che si ritiene giuridicamente addebi-
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
tabile al L.), è emerso dagli accertamenti peritali svolti
che l’ulteriore, considerevole ritardo, nell’adesione alle
terapie previste dalla medicina tradizionale, ebbe
un’importanza (quantomeno) nel progredire della malattia e nel propagarsi delle metastasi tumorali (v. la
complessiva documentazione medica e le perizie più
volte menzionate).
Alla luce di tali considerazioni, dunque, il concorso di
cause preesistenti, indipendenti dall’azione del L. (art.
41 comma 1 cp.), nel caso in oggetto, non può far escludere il nesso di causalità tra la condotta dell’imputato
(impeditiva di un intervento terapeutico appropriato) e
l’anticipato decesso della M.
Vale a dire che il ritardo diagnostico, non fu “da solo sufficiente” a provocare il decesso considerevolmente anticipato della M.
Determinante in tal senso fu, invece, come si è detto,
l’ulteriormente ritardato (si aggiungeva, infatti, al ritardo diagnostico) ricorso da parte della M. alle cure della
medicina ufficiale, conseguente la condotta del L.
– Una volta accertato che un tempestivo ricorso alle terapie mediche e all’intervento chirurgico avrebbe certamente (e considerevolmente) procrastinato l’epoca della morte della donna, resta da esaminare l’ulteriore punto, inerente l’incidenza causale che ebbe l’attività posta
in essere dal L. sulle scelte compiute dalla M.
La difesa ha, pervicacemente, ma in modo non convincente, cercato di dimostrare che tale incidenza fu assolutamente irrilevante. La M. sarebbe stata ab initio (dal
momento della scoperta del nodulo e della successiva
diagnosi di carcinoma mammario) risoluta nel non affidarsi a terapie mediche e, in particolare chemioterapiche).
La difesa ha evidenziato che la donna, dal momento in
cui ebbe conoscenza della grave malattia che l’aveva colpita ebbe la possibilità di entrare in contatto con medici
(il medico curante dott. B.; il dottor. R., che subentrò al
primo poiché la M. non sopportava l’insistenza con cui il
dott. B. cercava di convincerla a curarsi seriamente, il
dott. P., dal quale la donna fu visitata all’IST di Genova
nel settembre 1995; la dott.ssa F. che visitò la donna a
Vercelli).
Orbene, secondo la tesi difensiva, questi elementi fanno
ritenere che la M. fosse in ogni caso assolutamente già
orientata a rifiutare le terapie della medicina tradizionale (fosse “omnimodo factura”, per usare una terminologia,
ancora una volta, mutuata dalla tematica del concorso
(morale) di persone nel reato (come è già accaduto in
precedenza laddove - nel capo d’imputazione - il PM ha
definito L. “determinatore”).
Si sostiene, infatti, che la M. aveva un radicato, profondo e insuperabile convincimento che le cure previste
dalla medicina ufficiale sarebbero state non solo inutili
ma addirittura dannose.
Tale rifiuto verso la medicina ufficiale sarebbe stato
espresso anche dall’avvicinamento della donna, proprio
nel periodo in cui questa fu “in cura” dal L., ad altri ope-
ratori della medicina c.d. alternativa (lo studio A. di Finalborgo ed un tal E.O., numerologo).
È stato evidenziato che anche quando, nel marzo 1996,
in seguito a peggioramento delle sue condizioni, venne
ricoverata all’Ospedale di S. Corona, la donna accettò
alcune trasfusioni di sangue ma non di sottoporsi ad altri
interventi (terapeutici o chirurgici che fossero).
Prima che ciò accadesse (luglio 1996) la M. si affidò ancora a “rimedi” ascientifici e, per vincere la malattia e
sperando in un miracolo, si recò a Lourdes.
– Questo Tribunale non condivide le considerazioni difensive sul punto. Ritiene, invece, che la M., anche a
causa del vero e proprio terrore e della disperazione che
si impadronirono di lei (v. le risultanze peritali che più
oltre si evidenzieranno), subì un influsso determinante
dalla subdola e penetrante attività di convincimento posta in essere dall’imputato.
L. fu la prima persona alla quale la M., dopo aver avuto
contezza della natura della malattia che l’aveva colpita,
si rivolse.
Ciò consentì all’imputato di esercitare i poteri di persuasione necessari a convincere la cliente ad affidarsi a lui
(almeno per un certo periodo) in via esclusiva.
A supporto delle considerazioni sopra esposte si riportano le precise informazioni rese dalla M. in sede di incidente probatorio: « - pag. 4 -: … ho sentito la sua voce, per
la prima volta, quando qualche giorno dopo la diagnosi di carcinoma) per radio in macchina… lui consigliava di non affidarsi alla medicina tradizionale, di non fare assolutamente
chemioterapia in caso di tumore… perché ciò provocava un
peggioramento del tumore … per cui consigliava le sue cure
vegetariane e naturopate … Ho cominciato a fantasticare …
Sono andata da lui… - pag. 5 -: … Aveva dei metodi di convincimento molto validi e c’erano nello studio tante persone
che lo ascoltavano a bocca aperta, anche la ragazza che lavorava con lui… Tutto quello che raccontava aveva un che di
fantastico e di magico e le bugie erano raccontate in modo
magistrale… le gonfiava fino a farle diventare favole, però
purtroppo tutti noi che eravamo lì chi per un problema chi per
un altro, malati o desiderosi di un punto di riferimento e di
aiuto, eravamo vicini a lui e ci affidavamo alle se cure».
Ma certamente, la più chiara, incisiva (e toccante) testimonianza dell’incidenza che il L. ebbe sulle scelte della
M., si rinviene a pag. 38 delle dichiarazioni rese dalla
donna nel corso dell’incidente probatorio.
Dalle sue parole si evince il travaglio psicologico che la
stessa stava vivendo subito dopo che le fu comunicata la
diagnosi del male che l’aveva colpita.
La donna si trovò ad un bivio: affidarsi alla medicina tradizionale (verso la quale nutriva forte diffidenza, a causa
della morte della madre e della nonna, che i medici non
erano riusciti a salvare) o mettersi nelle mani del guaritore L.
Sul punto le parole della M. illuminano in maniera inequivocabile, rilevando quale effetto determinante ebbe
l’azione persuasiva dell’imputato: (a Milano, al Centro
Tumori, dopo la diagnosi, avevano proposto alla donna
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1147
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
il ricovero e l’inizio del trattamento chemioterapico) a
domanda del PM che le chiede se avesse ritenuto di non
aderire a tale proposta la M. risponde: «Non avevo ancora deciso ma ero molto spaventata da questa prospettiva» …
«poi è successo che mi sono vista con E. (L.) … in base a
quello che poi lui ha detto, in base a quel che c’era dentro di
me, alla mia paura e alla mia disperazione, al mio affidarmi a
lui e al rifiutare la realtà».
Ritiene questo Tribunale che quel «non avevo ancora deciso» evidenzi in modo chiaro che la M. subì, da parte del
L., un influsso determinante nella successiva scelta di
sottrarsi alle cure che l’avrebbero salvata o avrebbero
prolungato considerevolmente le sue aspettative di vita.
Per usare un immagine efficace, che dimostra in modo
evidente il contributo causale che il L. diede al verificarsi della morte (o comunque al verificarsi di una morte
considerevolmente anticipata) della M., può risultare
utile l’esempio dell’inesperto bagnante che, trovandosi
in difficoltà, invoca aiuto. E mentre il bagnino lo invita
ad avvicinarsi verso di lui perché possa lanciargli una
ciambella di salvataggio, un’altra persona, criminosamente, lo sospinge a orientarsi in altra direzione, dove la
presenza di mulinelli lo porterà ad annegare.
Va aggiunto che, per meglio riuscire nella propria attività di persuasione, il L., che si era presentato alla M. come pranoterapeuta, si vantò di avere conseguito anche
la laurea in Medicina, asserendo di averla poi strappata
di fronte al suo maestro che lo aveva avviato allo studio
e alla conoscenza della medicina naturale (tal C.). Tale
gesto (che rappresentava un segno di abiura verso la medicina ufficiale) colpì profondamente la M.
Dal racconto della donna ben si comprende quale influenza ebbero su di lei le parole del L. (v. pag. 7 trascrizioni inc. prot.: «… io credevo a tutto quello che diceva …
io ero lì, pendevo dalle sue labbra perché tutto quello che diceva mi sembrava vero».
Per ammantare i suoi poteri di un carattere esoterico-religioso L. diceva alla cliente di “lavorare con Padre Pio”
di cui affermava essere anche cugino e che confidenzialmente chiamava “amico Schultz”, sostenendo di ricevere consigli dallo stesso.
La M. rimase oltremodo colpita da tale ultimo particolare, anche perché da quando aveva scoperto la malattia,
si era riavvicinata alla fede («per cui credevo anche in questa cosa»).
La condotta del L., per poter sortire l’effetto desiderato,
necessitava, una volta plagiata la M., che nessun altro
soggetto potesse infrangere il meccanismo di dipendenza realizzato.
Per tale ragione il L., comprendendo che il convivente
della M., C.G. (il quale ovviamente insisteva perché la
sua compagna si curasse adeguatamente), poteva ostacolare l’operazione truffaldina intrapresa (e che costituiva
il fine principale perseguito dall’imputato), cercò di screditarlo agli occhi della donna, sino a indurla a mandarlo
via di casa (pag. 17 delle trascrizioni: «(L.) mi consigliava
di mettere questo cataplasma (l’argilla delle Dolomiti, ma in
1148
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
realtà del cuneese) sul seno ed anche sulla pancia durante la
notte… e che se si sbriciolava la cura funzionava… in caso
contrario la causa di un mancato sbriciolamento poteva essere il mio convivente… Diceva che G. esercitava un influsso
negativo perché non era d’accordo con quello che stavo facendo, per cui la sua negatività poteva compromettere l’esito
di tutte le cure…».
Il C. cercò effettivamente, in ogni modo, di togliere la
M. dalle mani del “guaritore” (fu proprio il compagno
della persona offesa che fece partire le indagini con una
denunzia ai carabinieri).
La M. giunse addirittura ad allontanarlo da casa: «… L.
dapprima mi disse che non dovevo dormire con lui e che
poi influenzava negativamente tutta la cosa».
La M., nella sua deposizione, aveva precisato che, all’epoca, il rapporto con il C. era già in crisi, ma le parole del
L. ebbero l’effetto di indurla ad una rottura definitiva (si
sottolinea come l’esternazione di tali precise circostanze
renda ancor più attendibili le dichiarazioni della donna).
La difesa, sempre al fine di ridimensionare il ruolo del L.
nella vicenda, ha sottolineato che la M., anche dopo la
rottura del rapporto con il L., attese ancora vari mesi prima di decidersi a ricorrere alla medicina ufficiale. Tale
circostanza, per le ragioni che appresso si illustreranno,
non fa, tuttavia, escludere la rilevanza del contributo
causale dato dall’imputato al verificarsi dell’evento.
Deve premettersi che l’interruzione del rapporto con il
L. va collocata in epoca di poco antecedente il dicembre
del 1995 (v. inc. prob. pag. 20).
Il punto è stato oggetto di contrasto fra le parti, ma al riguardo vi sono precise indicazioni fornite dalla persona
offesa. In sede di SIT rilasciate il 10 gennaio 1997 la M.
riferisce al PM: «… in sostanza L. mi allontanò quando si
accorse che il tumore era ormai in fase avanzata. Nel novembre 1995 si fece pagare e due giorni dopo mi riempì di
contumelie in ragione del fatto che in quei giorni mi ero rivolta a due giovani chiromanti…».
Ora, ritiene questo giudice che l’attività posta in essere
dal L. di vera e propria demonizzazione della Medicina
ufficiale (e di parallela esaltazione dei pseudo trattamenti terapeutici alternativi etc.) abbia avuto un effetto per
così dire “prolungato”. Anche a causa di una predisposizione mentale della M., che aveva già originariamente
delle perplessità sui trattamenti e le terapie mediche, il
L. instillò nella mente della sua cliente un’insuperabile
diffidenza, quasi un’idiosincrasia che la condusse a rifiutare la medicina a vantaggio di altre pratiche, prive di
valore scientifico e di qualsivoglia utilità (se non per chi
le poneva in essere).
E tale opera di persuasione fu così efficace e penetrante
che solo quando la situazione si rivelò in tutta la sua tragicità (le dimensioni del tumore, ulcerato e fuoruscito,
divennero gigantesche, le emorragie abbondanti etc.) la
donna, nel luglio 1996, finalmente si affidò ai medici
dell’Ospedale di S. Corona. Qui fu operata e, nonostante la drammaticità della situazione, visse ancora per circa 16 mesi (elemento quest’ultimo che rafforza ancor più
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
l’attendibilità delle previsioni peritali sull’efficacia che
avrebbero potuto esplicare le terapie chemioterapiche e
l’intervento chirurgico se effettuati molti mesi prima).
L’elemento psicologico del reato
Ritiene questo Giudice che non sussistano dubbi circa
l’addebitabilità al L. della condotta omicida a titolo di
dolo.
Sotto il profilo rappresentativo, dagli atti emerge con assoluta certezza che l’imputato, allorché nel maggio 1995
entrò in contatto con la M., sapeva perfettamente da
quale grave patologia (carcinoma mammario) la donna
era stata colpita.
A tale conclusione (contestata fermamente dalla difesa)
si deve giungere sulla base, innanzitutto, delle precise,
chiare ed inequivocabili informazioni rese dalla M. sia
innanzi al PM che nel corso dell’incidente probatorio.
La persona offesa il 10 gennaio 1997 così si espresse, interrogata dal PM: «quando mi recai dal L. la prima volta …
(lui mi disse) che il tumore sarebbe sparito; … che l’applicazione di terra delle Dolomiti al seno avrebbe estiparto il tumore; allo scadere del 42° giorno di digiuno… vi sarebbe stata
l’ulcerazione del tumore con fuoriuscita del male. Certamente L. era consapevole (della natura della malattia della
M.)».
– Coerentemente, nel corso dell’incidente probatorio
tenutosi il 14 aprile 1997 la M. precisò: «… sono andata
da lui … mi ha proposto la lettura di un libricino intitolato
“Cancro e Leucemie” di Adolf Oris» «, … disse che con il digiuno la massa tumorale sarebbe scomparsa…».
Le affermazioni della M., per quanto sopra evidenziato,
risultano assolutamente credibili.
Da altri elementi emerge, comunque, con certezza, che il
L. era perfettamente a conoscenza della natura della malattia della M.
a) C.G., convivente della persona offesa, riferì in sede di
S.I.T.: «… nel giugno del 1995 andai dal L. e gli dissi che A.
sarebbe morta se non fosse stata curata…».
b) P.P., che accudiva i bimbi della M. durante la malattia
di costei, sempre in sede di SIT dichiarò di aver appreso
dalla amica che «… il guaritore le aveva garantito che, se
avesse seguito i suoi consigli il male sarebbe stato estirpato…»,
c) il L., in sede di interrogatorio, ha negato la circostanza in oggetto, ma lo ha fatto in modo apodittico. Non ha
spiegato per quale ragione consegnò alla M. un libro intitolato “Cancro e Leucemie”.
Ha poi ammesso di aver appreso «successivamente, dopo
qualche mese» del tumore e che la donna gli chiedeva
sempre e in modo martellante (quindi ripetutamente e
nel corso di un arco di tempo non limitato) se sarebbe
guarita.
Ha, in un primo tempo, negato di aver visitato la donna,
per poi ammettere, invece, di averle diagnosticato «per
mezzo di una “discussione iridologica”» (sic), una putrefazione intestinale.
Ora, poiché è provato pacificamente che il L. prescris-
se alla persona offesa di effettuare applicazioni di terra
delle Dolomiti sul seno malato, non si comprende
quale senso avrebbe avuto una tale indicazione terapeutica connessa all’affezione intestinale riferita dall’imputato.
Attesa la pregnanza degli elementi sopra evidenziati, si
conclude sul punto, con una considerazione di carattere
logico: la M., in preda alla disperazione per aver appreso
della terribile malattia che l’aveva colpita, ascoltò casualmente alla radio dell’esistenza di un guaritore che
consigliava ai malati di cancro di non sottoporsi a chemioterapia, cobalfoterapia e interventi chirurgici, affermando di poter curare e guarire gli stessi con metodi naturali. Poiché la donna, in breve tempo, colpita dalle parole del L., si presentò da lui, deve ritenersi assolutamente verosimile che allo stesso abbia esternato la sua drammatica situazione, rendendolo edotto circa la natura del
male che le era stato diagnosticato.
– Una volta chiarito che il L. era perfettamente a conoscenza della malattia che aveva colpita la M., occorre
verificare da quale atteggiamento psicologico furono accompagnate le sue azioni successive, con particolare riguardo a quelle che condussero la M. a rifiutare i trattamenti previsti, in casi simili, dal protocollo medico-chirurgico.
In particolare ci si deve domandare se un soggetto come
il L. avrebbe potuto prevedere quali conseguenze vi sarebbero state nell’impedire (tramite una complessa ed
efficace attività di persuasione e di rafforzamento di una
volontà solo parzialmente già orientata) ad un’ammalata di cancro al seno di sottoporsi a trattamento chemioterapico e chirurgico.
Orbene ritiene questo Tribunale che ogni cittadino, anche di livello culturale non elevato, nell’attuale contesto
storico-sociale-culturale è a conoscenza del fatto che, per
una donna alla quale sia stato diagnosticato un tumore al
seno, le uniche speranze di guarigione o di prolungamento delle aspettative di vita sono affidate, in via esclusiva, alla sottoposizione a trattamenti di chemio o radioterapia, preceduti o seguiti da eventuale intervento chirurgico finalizzato all’asportazione della massa tumorale.
Non solo quest’ultimo è un dato di conoscenza comune
ma, anche grazie alle martellanti campagne informative
(di stampa, radio televisive etc.), è altresì noto agli utenti del servizio sanitario nazionale che assume particolare
importanza per sconfiggere il cancro in generale (ed ancor più il carcinoma mammario), oltre alla precocità della diagnosi, anche la tempestività dell’intervento terapeutico e chirurgico.
Ed il L., che lanciava i suoi appelli per mezzo di una radio privata per attirare a sé “polli da spennare”, dissuadendoli dal ricorrere alle cure chemioterapiche etc., non
poteva ignorare l’importanza che tali cure avevano per
sconfiggere le malattie neoplastiche.
Egli non era un medico (anche se si spacciò per tale con
la M.) ma aveva quotidianamente a che fare con persone che soffrivano di patologie tumorali (talune delle
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1149
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
quali erano morte anche durante il periodo in cui la M.
era “in cura” dall’imputato).
Nell’indurre la M. a rinunziare alle terapie della medicina ufficiale (imponendo rimedi consistenti in pratiche
prive di qualsivoglia valore scientifico) egli, scientemente, previde quale sarebbe stato l’esito della propria condotta: la morte del soggetto indotto a non curarsi adeguatamente o la considerevole anticipazione di un tale
evento.
Sempre con riguardo al profilo rappresentativo va sottolineato che il L. era pienamente consapevole dell’inidoneità dei trattamenti e delle “cure” prescritte alla M. Ciò
si desume dal fatto che, se così non fosse stato, si sarebbe
prospettata la possibilità di valutare un’eventuale condizione di infermità psichica dell’imputato, all’origine delle sue scellerate azioni. Ma così non è stato, in quanto L.
era pienamente compos sui.
Proprio perché consapevole che i succhi di carota e l’argilla del cuneese erano assolutamente inefficaci nella cura del cancro, l’imputato ha cercato di dimostrare (invano, perché, come sopra si è evidenziato, smentito da più
elementi) che egli ignorava che la M. fosse affetta da una
patologia tumorale.
Il momento volitivo del dolo
Si è visto che il L., innanzi a una donna affetta da carcinoma mammario come la M., non ebbe alcuno scrupolo, per spillarle qualche milione di lire, a convincerla a
non sottoporsi ai trattamenti previsti dalla medicina ufficiale e, conseguentemente, a lasciare che il tempo trascorresse e la situazione clinica divenisse non più rimediabile.
Questo Tribunale, alla luce di quanto sopra illustrato, ritiene che l’evento-morte della M., nel momento in cui il
L., per vari mesi le impedì, di fatto, di sottoporsi alle terapie ed ai trattamenti chirurgici necessari, si prospettava come conseguenza certa della sua condotta.
L’imputato, nel continuare a vendere alla donna, a peso
d’oro, i suoi succhi di carota e l’argilla delle dolomiti
(che in realtà proveniva dalle, forse meno blasonate,
colline del cuneese) e nel precludere alla M. il ricorso alla medicina ufficiale per combattere il carcinoma mammario, non poteva ritenere che la stessa avrebbe avuto
qualche probabilità di sopravvivenza.
Non vi fu, pertanto, un’azione impeditiva delle cure, accompagnata dal convincimento da parte dell’imputato
che la M., nonostante il trascorrere del tempo, avrebbe
forse potuto salvarsi ugualmente e la sua morte (o la sua
morte considerevolmente anticipata) sarebbe stata solo
un, accettato, possibile rischio (evenienza che, comunque, ovviamente, renderebbe il reato di omicidio addebitabile al L. a titolo di dolo eventuale).
Ritiene, invece, questo giudice, che nel caso, la certezza
del verificarsi dell’evento, come conseguenza della condotta dell’imputato, debba far ritenere quest’ultimo responsabile del reato di cui all’art. 575 cp. a titolo di dolo
diretto.
1150
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
Tale forma di imputazione soggettiva del reato, come è
noto, è configurabile anche quando l’evento, deriva o
dall’azione od omissione, si prospettava come conseguenza certa di queste ultime, pur non essendo il fine primario verso il quale la condotta delittuosa del reo era rivolta.
Esplicativo di un tale atteggiarsi della volontà dell’agente è il caso (ricorrente anche nella manualistica)
del soggetto che, al fine di conseguire il premio assicurativo per il caso di incendio di un’abitazione di sua
proprietà, simulando un evento fortuito, appicchi il
fuoco alla stessa pur sapendo che all’interno del locale
si trova un’anziana invalida, impossibilitata a mettersi
in salvo.
Il piromane che mira in tal modo a frodare la compagnia
di assicurazione non ha lo scopo di uccidere la donna,
tuttavia, pur rappresentandosi come certa la sua morte
non rinunzia a porre in essere la sua azione.
Il caso in oggetto presenta caratteristiche analoghe: L.
non aveva certamente quale obiettivo la morta della M.
Un tale evento era, tuttavia, la prevedibile, inevitabile,
certa conseguenza della complessa attività (di persuasione a non curarsi con la medicina ufficiale ma con i costosi, inutili prodotti venduti dallo stesso imputato) alla
quale la donna fu sottoposta dal L.
In tal modo, al prezzo di sacrificare la vita dalla M., il L.
avrebbe così potuto conseguire il profitto della sua attività di circonvenzione.
Per poter spillare denaro alla sventurata donna occorreva venderle i succhi di frutta e la terra argillosa a prezzi
stratosferici. Occorreva quindi impedire alla cliente (più
che alla paziente) di scegliere l’alternativa della medicina ufficiale.
Se, infatti, la M. avesse optato per quest’altra via L. non
avrebbe potuto tenere in mano la donna con continuità
e per un periodo di tempo non trascurabile. Inoltre, il
contatto con medici avverrebbe verosimilmente convito la M. a non affidarsi (anche parallelamente alle cure
mediche) a rimedi alchimistici, privi di qualsivoglia valore scientifico.
– Nel corso della (purtroppo assai lunga) vicenda processuale in esame si è affacciata l’ipotesi di un inquadramento del (più grave) fatto addebitato al L. sotto le previsioni dell’art. 586 cp. («morte… come conseguenza di
altro delitto»: quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole la morte… di una persona, si applicano le disposizioni dell’art. 83 ma le pene stabilite negli articoli 589
e 590 sono aumentate).
Questo Tribunale ritiene che, alla luce di quanto sopra
esposto, tale possibilità debba essere esclusa perché non
giuridicamente corretta.
La norma in oggetto prevede, come è noto, che un evento letale possa verificarsi in connessione causale con un
delitto (diverso dalle lesioni o dalle percosse, le quali, se
seguite dalla morte della vittima, possono integrare la
fattispecie di cui all’art. 584 cp.).
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
L’art. 586 prevede dunque un’ipotesi (con sanzione aggravata) di aberratio delicti.
Per quel che concerne i criteri di imputazione soggettiva dell’evento, le soluzioni interpretative sono state,
nel tempo, differenti. Sostanzialmente si sono confrontate le posizioni di chi ritiene sufficiente ad integrare
l’ipotesi di reato di cui all’art. 586 cp la sussistenza di un
nesso di causalità tra il fatto che l’agente voleva commettere e la morte della persona, e quella di chi, invece, ritiene necessario un coefficiente psicologico (colpa), negando che la norma in oggetto possa comportare per l’agente un addebito di responsabilità di carattere oggettivo.
Nell’ambito di tale indirizzo si è poi prospettata la possibilità di fondare la colpa unicamente sull’inosservanza
di norme cautelari di comune esperienza (colpa generica) oppure di ritenere possibile anche un addebito di
colpa specifica, fondata proprio sull’inosservanza della
norma penale (inerente il delitto da cui è derivata la
morte della persona). In quest’ultimo caso, onde evitare di ricadere nelle maglie di una ricostruzione che conducesse a un addebito oggettivo di responsabilità, si è rifiutata la prospettazione di una colpa specifica mascherante una “colpa presunta” (provato che l’agente ha
commesso il delitto-base, attribuita alla norma che lo
prevede natura cautelare rispetto all’impedimento di
eventi letali, si individua ipso iure la responsabilità dell’agente “a titolo di colpa”).
Si è, invece, ritenuto necessario, in ogni caso, verificare
se il colpevole (del delitto-base) nel commetterlo, ha infranto norme cautelari che miravano ad impedire lo specifico evento dannoso in concreto verificatosi.
Non ci si dilunga oltre in queste considerazioni, atteso
che, per quanto illustrato sopra, non pare corretto ravvisare una responsabilità del L. ex art. 586 cp. per morte
della M. conseguente al delitto di “circonvenzione di
persona incapace”.
Tale prospettazione sarebbe stata possibile solo se fosse
stata esclusa la sussistenza del dolo di omicidio in capo
all’imputato.
In tal caso sarebbero state compiute le valutazioni sulla
sussistenza della colpa alla stregua dell’adesione uno degli orientamenti sopra indicati.
L’addebito concernente la condotta omissiva del L.
Come più sopra si è evidenziato al L. è stato contestato,
in alternativa alla realizzazione del reato per mezzo di
una condotta attiva, il delitto di omicidio volontario,
commesso mediante omissione.
Si verserebbe in un’ipotesi di reato omissivo improprio.
L’at. 40 comma 2 cp., come è noto, opera un’estensione
della portata descrittiva delle singole fattispecie incriminatrici (in questo caso dell’art. 575 cp.).
In assenza del disposto delle norma citata, infatti, non
sarebbe possibile addebitare un evento naturalistico in
capo ad un soggetto che sia rimasto inerte; che non abbia cioè tenuto una condotta positiva (nel nostro caso il
“cagionare”) caratterizzata da un movimento corporeo).
A tale condotta, sulla base di un giudizio fattuale, deve
essere ricollegabile l’evento verificatosi.
Naturalmente un’operazione estensiva come quella sopra sintetizzata non risulta possibile per ogni categoria di
reato. Non sarebbe logicamente concepibile per i reati di
pura condotta o formali (che non presentano tra gli elementi che li contraddistinguono un evento, naturalisticamente inteso) e neppure per quelle fattispecie (c.d. a
condotta vincolata) per la realizzazione delle quali il reo
deve tenere una condotta complessa, articolata in una
serie di attività, che il legislatore ha descritto con precisione, ritenendo che solo in presenza di quelle particolari modalità della condotta dell’agente, quest’ultimo sia
meritevole della sanzione penale.
Nessun ostacolo sussiste, invece, in ordine al compimento dell’operazione sopra indicata (di “allargamento”
del novero delle condotte punibili, mediante applicazione dell’art. 40 comma 2 cp.) ai reati cd. “causalmente
orientati”, come l’omicidio volontario, in cui, individuato l’evento la cui ca???azione dà luogo all’integrazione
della fattispecie incriminatrice, risulta indifferente il
processo causativo realizzato dal reo con la propria condotta.
In questa categoria di reati il Giudice, con riguardo all’indagine sul contributo causale dato dal soggetto che si
assume non aver tenuto la condotta richiesta, è chiamato ad effettuare una valutazione, assolutamente diversa
rispetto all’analogo accertamento da svolgersi in relazione ai reati commissivi.
Infatti, deve, sostanzialmente, valutare se il compimento dell’azione doverosa avrebbe impedito il verificarsi
dell’evento previsto dalla norma incriminatrice (delineata anche in base alla norma estensiva di cui all’art. 40
comma 2 cp.) come conseguenza dell’omissione.
Tale valutazione si fonda su un giudizio che, a differenza
di quel che accade per i reati commissivi, non ha, dunque, natura reale, “fattuale”, bensì ipotetica.
Il problema che in questi casi il Giudice deve risolvere è
quello di verificare se, nel caso in cui la condotta prescritta fosse stata posta in essere, l’evento sarebbe stato
impedito.
Naturalmente, per poter attribuire la responsabilità ad
un soggetto in relazione a un evento verificatosi a causa
di una sua condotta omissiva occorre che al compimento dell’azione “impeditiva” tale soggetto fosse obbligato.
È questo il senso del disposto dell’art. 40 comma 2 cp.,
allorché, nell’equiparare il “non impedire” un evento al
“cagionarlo”, fa riferimento alla necessaria sussistenza in
capo al soggetto di un “obbligo giuridico” (e non meramente morale) di attivarsi per impedire l’evento medesimo.
L’ordinamento, dunque, sulla base di una valutazione
dell’importanza dei beni da tutelare, delle possibilità che
determinati soggetti hanno, di salvaguardarli (posizione
di garanzia c.d. di protezione) o per la possibilità di controllo su determinate fonti di pericolo (posizione di ga-
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1151
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
ranzia c.d. di controllo), impone a taluni soggetti e non
ad altri di impedire eventi lesivi dei predetti beni.
Vengono così delineate figure di “reato proprio”, vale a
dire commissibili, soltanto da determinati soggetti: coloro che rivestono il ruolo di “garante” nel senso appena
descritto.
Nell’accertamento della sussistenza di un tale obbligo e
nella scelta delle modalità di individuazione dello stesso
entrano in gioco principi costituzionali di elevata importanza. In primo luogo il principio di “riserva di legge”, ma
anche quello di necessaria “tassatività” delle norme penali incriminatrici (art. 25 Cost.). Trattandosi di delineare in quali situazioni un soggetto è passibile di sanzione penale occorre che, direttamente o indirettamente,
sia una norma di legge a prevedere quali condotte omissive (impeditive di un evento) siano punibili ed occorre
altresì che tale individuazione possa avvenire sulla base
di criteri ed elementi certi e determinati.
– Ora, ritornando alla vicenda sottoposta al giudizio di
questo Tribunale, si ritiene che non fosse individuabile
in capo al L. alcuna posizione di garanzia, nel senso sopra
esposto.
Questo Giudice non ritiene condivisibili le posizioni
espresse sul punto dal PM innanzitutto, ma anche da altri Giudici (GIP e Tribunale per il riesame) che nel corso delle indagini preliminari si sono incidentalmente occupati della vicenda (in sede di applicazione e sostituzione di misure cautelari) e che hanno ritenuto, pur nella
sommarietà delle valutazioni di loro competenza, la sussistenza in capo al L. di un obbligo giuridico di attivarsi
per impedire la morte della M.
Nell’esplicitare le ragioni che hanno condotto alla conclusione indicata, si vuole sottolineare, la complessità
tecnica della valutazione giuridica in questione.
Si darà ora conto del percorso logico che ha condotto
questo Giudice alla conclusione sopra enunciata.
Va ricordato che la Pubblica Accusa ha individuato la
fonte di un obbligo giuridico rilevante ex art. 40 comma
2 cp.) nel contratto che la M. aveva stipulato con il guaritore-pranoterapeuta L.
Sul piano civilistico si trattava di un contratto di prestazione d’opera professionale.
Ora, va sottolineato che sulla base degli accordi intervenuti tra le parti il L. si impegnò a guarire la M. dal cancro, attraverso la somministrazione delle “terapie” e dei
“trattamenti” che sono stati in precedenza descritti (argilla, succhi di carota etc.).
Occorre a questo punto verificare se il contratto in questione avesse una validità ed efficacia. Se da esso potessero scaturire specifici obblighi in capo al L.
Certamente il panorama giurisprudenziale e dottrinale
offre all’interprete una vasta panoramica di contratti affetti da vizi, dai quali scaturiscono comunque obblighi
per le parti: tipico è il caso della baby sitter che ha pattuito di accudire un bimbo fino ad una certa ora, nella quale i genitori hanno promesso di rientrare; è pacifico che,
se questi ultimi, per errore sulla durata della prestazione
1152
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
richiesta, rientrano più tardi rispetto agli accordi presi,
alla badante non è certamente consentito di andarsene
di casa e lasciare il bambino da solo.
Il contratto stipulato nel caso in esame non poteva invece far sorgere alcun obbligo in capo al L.
Qui il negozio giuridico stipulato tra la M. ed il L. è nullo per la specifica ragione che ha un contenuto illecito:
tale l’illiceità deriva dalla mancanza in capo al soggetto
delle competenze tecniche (previamente accertate dall’ordinamento mediante esami di idoneità che consentano l’iscrizione ad un albo professionale) necessarie per
poter svolgere attività diagnostica e prognostica, e per
poter somministrare terapie e trattamenti curativi.
Qui la prestazione di tali attività da parte di un soggetto
non in possesso dei requisiti formali (ma che presuppongono un’idoneità sostanziale) è proibita da norme imperative (art. 1418 comma 1 c.c.).
La violazione di queste ultime è considerata dall’ordinamento giuridico talmente grave e rilevante da comportare a carico del trasgressore l’inflizione di sanzioni penali (previste appunto - ex art. 348 cp. - per l’esercizio abusivo di attività riservata al medico).
Quale condotta si sarebbe potuto pretendere dal L., che
non era medico, né, tantomeno, oncologo? Non certamente che curasse adeguatamente la M., dato che egli
non aveva alcuna competenza nella materia medica.
L’unico obbligo che gravava sull’imputato era quello di
astenersi dal compimento di ogni attività riservata al
medico.
Risulta dunque evidente che l’accordo contrattuale intervenuto tra la M. e il L. non poteva far sorgere in capo
a quest’ultimo alcuna situazione di effettivo affidamento
allo stesso, in qualità di garante, del bene da proteggere
(la vita della donna gravemente ammalata). Ciò a causa
dell’assoluta inidoneità del L. ad assumere una tale posizione.
(Omissis).
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
IL COMMENTO
di Francesco Cingari
Non c’è dubbio che nei casi di c.d. “causalità psichica”
l’individuazione di vere e proprie leggi scientifiche sia
alquanto difficile. Tuttavia, il modello di accertamento causale “individualizzante”, che fa leva sugli elementi che emergono dalla ricostruzione empirica della singola vicenda storica, rischia di portare a confondere il piano della dimostrazione del nesso di causalità con quello della sua prova. Ai fini della sussistenza del c.d. “dolo diretto” non è sufficiente che il soggetto agente si rappresenti come certa la realizzazione dell’evento, ma occorre che se la rappresenti come
certa conseguenza della propria condotta.
La sentenza in commento porta tristemente alla ribalta giudiziaria il fenomeno dei sedicenti “guaritori” (1)
che, abusando delle credenze irrazionali e della disperazione delle persone affette da gravi malattie, propongono
trattamenti terapeutici alternativi, spesso meno invasivi
di quelli proposti dalla medicina ufficiale, ma privi di
qualsiasi reale efficacia terapeutica, al fine di indurre i
malati al pagamento di ingenti somme di denaro. In particolare, la sentenza in esame riguarda la drammatica vicenda di una donna alla quale era stata diagnosticata
una grave forma di tumore (carcinoma mammario) che,
dopo avere ascoltato una trasmissione radiofonica nella
quale un sedicente “guaritore” invitava ad evitare i trattamenti chemioterapici, anziché sottoporsi alle terapie
ufficiali (trattamenti chemioterapici e intervento chirurgico di riduzione della massa tumorale) fortemente
invasive ma comunque capaci, quantomeno, di rallentare il decorso della malattia, decide di affidarsi alle “cure”
vegetariane e naturopate del sedicente “guaritore”. Sennonché, dopo alcuni mesi, avendo constatato un notevole peggioramento delle proprie condizioni fisiche (aumento delle dimensioni del tumore, emorragie abbondanti, etc.), la donna, dopo essersi rivolta ad un centro di
cura alternativa, finalmente decide di sottoporsi ai trattamenti chemioterapici e all’intervento chirurgico di riduzione della massa tumorale. Tuttavia, dopo una prima
fase di miglioramento, la donna muore a causa dello sviluppo della malattia.
Il sedicente “guaritore” al quale la donna si era affidata per la terapia alternativa viene tratto a giudizio e,
tra gli altri reati, viene riconosciuto responsabile della
morte della donna. In particolare, il G.u.p., dopo avere
escluso la possibilità di chiamare a rispondere il “guaritore” a titolo di omesso impedimento dell’evento, ai sensi
del combinato disposto degli artt. 40 comma 2 e 575
c.p., lo condanna per omicidio doloso mediante azione
ai sensi dell’art. 575 c.p. Più precisamente, secondo il
giudice tra la condotta del sedicente “guaritore”, consi-
stita nell’avere impedito alla donna di sottoporsi ai trattamenti terapeutici ufficiali, e la morte per carcinoma
mammario sussiste il nesso di causalità previsto dall’art.
40 c.p. Inoltre, il giudice ritiene che la morte della “paziente” sia ascrivibile al “guaritore” a titolo di dolo diretto, in quanto pur non avendo agito con l’intenzione di
cagionarne la morte, ma solamente al fine di conseguire
un illecito profitto, tuttavia questi si sarebbe rappresentato come certa conseguenza della propria condotta l’accelerazione del decorso della malattia e la conseguente
morte.
Va detto subito che la sentenza in esame appare
senza dubbio condivisibile nella parte in cui esclude la
possibilità di ricondurre il comportamento del “guaritore” nell’ambito della responsabilità per omesso impedimento dell’evento ai sensi del combinato disposto di cui
agli artt. 40 cpv. e 575 c.p.
Qualche perplessità, invece, suscita la sentenza in
commento tanto nella parte in cui ritiene riconducibile
eziologicamente alla condotta del “guaritore” la morte
della “paziente” quanto in quella in cui afferma la configurabilità del c.d. dolo diretto.
La sentenza in esame appare interessante, non solo
in quanto si occupa di un fenomeno purtroppo di ormai
grande attualità e che suscita sempre maggiore allarme
sociale, ma soprattutto perché offre l’occasione per riflettere sui limiti di estendibilità di alcuni importanti
istituti penalistici come il nesso di causalità e il dolo. Per
un verso, infatti, il caso in esame mette in evidenzia le
difficoltà con le quali occorre misurarsi nell’accertamento dei limiti di estensione del nesso di causalità allorquando i termini della relazione causale non sono rappresentati da eventi naturalistici bensì da comportamenti umani (c.d. causalità psichica) (2). In questo caNote:
(1) Sul fenomeno dei c.d. “maghi-guaritori”, in generale, v. M. Bifulco,
Maghi, imbonitori, occultisti e sette: giro di vite e pene più severe, in Dir. giust.
2004, 13 ss. Sui problemi di qualificazione giuridica posti dall’attività illecita dei c.d. maghi guaritori v., di recente, M. Marraffino, L’attività illecita dei c.d. “maghi guaritori”: un’ipotesi al confine tra truffa ed estorsione, in
questa Rivista 2004, 983 ss.
(2) Sulla c.d. causalità psichica v., G. Fiandaca-E. Musco, Diritto penale,
Parte generale, Bologna, 2004, 466; M. Romano, Commentario sistematico
del codice penale, I, Milano, 2004, 367. Inoltre v. A. Sereni, Istigazione al
reato e autoresponsabilità. Sugli incerti confini del concorso morale, Padova,
2000, 7 ss.; F. Stella, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale,
Milano, 2000, 102 ss. e 313 ss.; L. Cornacchia, Il problema della c.d. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali, in AA.VV., Nuove esigenze di tutela nell’ambito dei reati contro la persona, a cura di S. Canestrari-G.
Fornasari, Bologna, 2001, 198 ss.; O. Di Giovine, Lo statuto epistemologico della causalità penale tra cause sufficienti e condizioni necessarie, in Riv. it.
dir. e pen. proc., 2002, 678 ss.; M. Ronco, Le interazioni psichiche nel diritto
penale: in particolare sul concorso psichico, in Ind. pen., 2004, 815 ss. Nella
letteratura straniera v. K. Engisch, Das problem der psychischen Kausalität
(segue)
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1153
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
so, come è noto, l’impossibilità di accedere alla “scatola
nera” degli avvenimenti psichici unitamente alla difficoltà di reperire vere e proprie leggi scientifiche in grado
di esprimere una regolarità di successione tra i comportamenti umani (3) mette in discussione la stessa possibilità di ricondurre la c.d. causalità psichica al paradigma
della causalità naturalistica (4). Per un altro verso, la
sentenza in commento si rivela interessante perché, oltre a riproporre le ben note difficoltà che pone l’accertamento processuale del dolo, invita a riflettere su quali
siano i parametri che orientano la giurisprudenza nella
individuazione delle diverse forme di manifestazione del
dolo (5).
La natura della responsabilità del “guaritore”:
condizioni e limiti degli obblighi di garanzia
ex contracto
Prima di passare ad analizzare le questioni inerenti
al nesso di causalità e alle forme di manifestazione del
dolo, che costituiscono indubbiamente il cuore della
sentenza in commento, mette conto interrogarsi circa la
possibilità di configurare nei confronti del “guaritore”, in
luogo di una responsabilità commissiva, una responsabilità per omesso impedimento dell’evento (6).
Come abbiamo detto, pienamente condivisibile è
la sentenza quando esclude la possibilità di ricondurre la
responsabilità del “guaritore” nell’ambito della responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento.
È noto che, ai sensi dell’art. 40 comma 2 c.p., il reato omissivo improprio è configurabile quando il soggetto non impedisce un evento che aveva l’obbligo giuridico di impedire. Secondo l’opinione prevalente, gli obblighi di impedimento dell’evento (c.d. obblighi di garanzia), oltre che dalla legge e dagli atti normativi a
questa equiparati (7), possono nascere anche dal contratto (8).
Il fondamento giuridico della rilevanza degli obblighi di garanzia ex contracto viene individuato, da un lato,
nel generale diritto dei privati di proteggere i propri beni giuridici, e, dall’altro, nell’art. 1372 c.c. che riconosce
al contratto forza di legge tra le parti (9).
È opinione condivisa che per la costituzione negoziale dell’obbligo di garanzia sono necessarie almeno due
condizioni: da un lato, occorre che la parte stipulante sia
il titolare del bene da proteggere, dall’altro lato, è necessario che sia avvenuto il concreto affidamento del bene
stesso al garante (10).
Più controversa è, invece, la questione relativa alla
necessità che il contratto costitutivo di una nuova posizione di garanzia sia valido sotto il profilo civilistico.
Secondo una prima opinione (11), che muove
dall’idea che l’obbligo di garanzia deve essere espressamente stabilito da una fonte normativa valida, la soluzione della questione va mutuata dalla disciplina civilistica delle patologie negoziali. In questa prospettiva,
si distinguono le ipotesi in cui il contratto è nullo da
quelle in cui è annullabile. Nel primo caso, poiché il
1154
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
contratto nullo non è in grado di produrre effetti, l’invalidità impedisce anche che possa nascere l’obbligo
di impedimento dell’evento rilevante ex art. 40 comma 2 c.p. Nel secondo caso, poiché il contratto annullabile è in grado di produrre effetti fino alla pronuncia
giudiziale di annullamento, almeno fino a questo momento, è in grado di far sorgere anche l’obbligo di garanzia.
Sennonché, questa impostazione va incontro almeno ad una decisiva obiezione. Più precisamente, si è detto che facendo dipendere l’insorgenza dell’obbligo di garanzia dalla disciplina civilistica delle patologie negoziali ci si espone al rischio di lasciare il bene privo di tutela
in tutte le ipotesi di contratto nullo in cui vi è stata l’effettiva presa in carico del bene tutelato (12).
Note:
(continua nota 2)
beim Betrug, in Festschrift für Hellmuth von Weber, Bonn, 1963, 247 ss.; G.
Jakobs, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Die Grundlagen und Die Zurechnungslehre, 2ª ed., Berlin-New York, 1993, 194 ss.; F.Dencker, Kausalität und
Gesamttat, Berlin 1996, 29 ss.; C. Roxin, Strafrecht. Allgemeiner Teil. B.I.
Grundlagen Aufbau der Vebrechenslehre, 3ª Auf., München, 1997, par. 1130, 305; H.L.A. Hart-A.M. Honoré, Causation in the Law, Oxford, 1985.
(3) Cfr. l. Cornacchia, Il problema della c.d. causalità psichica, cit., 200 ss.;
O. Di Giovine, Lo statuto epistemologico della causalità penale, cit., 678 ss.
(4) In questo senso v. H.L.A. Hart-A.M. Honoré, Causation in the law,
cit., 51 ss.; O. Di Giovine, Lo statuto epistemologico, cit., 678 ss.; M. Ronco, Le interazioni psichiche nel diritto penale, cit., 815 ss.
(5) Cfr. P. Veneziani, Dolo eventuale e colpa cosciente, in Studium Iuris,
2001, 74 ss.
(6) Sulla responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento nella manualistica v. F. Mantovani, Diritto penale, Parte generale, Padova,
2001, 166 ss.; G. Fiandaca-E. Musco, Diritto penale, cit., 546 ss.; F. Palazzo, Il fatto di reato, Torino, 2004,73 ss.; M. Romano, Commentario sistematico del codice penale, cit., 378. Inoltre v. F. Sgubbi, Responsabilità penale per
omesso impedimento dell’evento, Padova, 1975, passim; G. Fiandaca, Il reato commissivo mediante omissione, Milano, 1979, passim; G. Grasso, Il reato omissivo improprio, Milano, 1983, passim; I. Leoncini, Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza, Torino, 1999, passim; F. Giunta, La posizione di garanzia nel contesto della fattispecie omissiva impropria, in
questa Rivista, 1999, 625 ss.; F. Mantovani, L’obbligo di garanzia ricostruito
alla luce dei principi di legalità, di solidarietà, di libertà e di responsabilità personale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 337. Nella letteratura tedesca v. per
tutti H.H. Jescheck-T.Weigend, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner
Teil, 5ª Aufl, Berlin, 1996, 605 ss.
(7) Sulle fonti dell’obbligo di garanzia v. per tutti I. Leoncini, Obbligo,
cit., 180 ss.
(8) In questo senso v. G. Grasso, Il reato, cit., 263 ss.; I. Leoncini, Obbligo,
cit., 223 ss.; F. Mantovani, Diritto penale, cit., 173 ss.; Id., L’obbligo di garanzia, cit., 345 ss.; F. Palazzo, Il fatto, cit., 78. Manifesta perplessità circa
l’idoneità del contratto di costituire obblighi di garanzia diversi ed ulteriori da quelli previsti dalla legge F. Sgubbi, La responsabilità penale, cit.,
195 ss.
(9) Cfr. I. Leoncini, Obbligo, cit., 229 ss.; F. Mantovani, L’obbligo, cit., 345;
F. Palazzo, Il fatto, cit., 78.
(10) Cfr. G. Grasso, Il reato, cit., 263 ss.
(11) Per una puntuale ricostruzione della tesi c.d. pancivilistica, v. I.
Leoncini, Obbligo, cit., 247 ss.
(12) I. Leoncini, Obbligo, cit.,251; G. Fiandaca-E. Musco, Diritto penale,
cit., 566 ss.
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
Per una seconda impostazione (13), in base alla
quale la fonte degli obblighi di garanzia risiede essenzialmente nell’assunzione fattuale della posizione di garanzia, la configurabilità della responsabilità penale per
omesso impedimento dell’evento prescinde totalmente
dalla validità giuridico-formale del contratto (14).
Sennonché, anche questa impostazione va incontro ad alcune insuperabili obiezioni. Da un lato, privando l’obbligo di garanzia di qualsiasi fondamento giuridico-formale si pone in aperto contrasto con il principio di
legalità; e, dall’altro lato, non tiene conto del fatto che
talune cause di nullità e di annullabilità del contratto
possono far venire meno gli stessi requisiti penalistici
dell’obbligo di garanzia (15).
Più convincente pare l’opinione secondo la quale il
problema della insorgenza dell’obbligo di garanzia in presenza di un contratto invalido dal punto di vista civilistico deve essere risolto avendo riguardo all’incidenza che
la causa di invalidità ha sui requisiti penalistici dell’obbligo di garanzia (16). Da questo punto di vista, si è osservato che se, da un lato, la maggior parte delle cause di
annullabilità del contratto non impedisce l’insorgenza
dell’obbligo di garanzia, dall’altro lato, non tutte le cause di nullità impediscono l’insorgenza dell’obbligo di garanzia (17). Così, ad esempio, l’impossibilità della prestazione oggetto del contratto, oltre a produrre la nullità
del negozio, ai sensi del combinato disposto di cui agli
artt. 1418-1346 c.c., impedisce anche l’insorgenza dell’obbligo di garanzia per mancanza del requisito della
possibilità dell’adempimento (18). Invece, la contrarietà
a norme imperative, pur comportando la nullità del contratto, ai sensi dell’art. 1418 c.c., non è detto che faccia
venire meno anche qualche requisito penalistico dell’obbligo di garanzia: così, ad esempio, si pensi alla vendita abusiva di materiali esplodenti vietata dall’art. 678
c.p. in cui, pur essendo nullo il contratto dal punto di vista civilistico, l’obbligo di garanzia di controllo va considerato insorto in capo all’acquirente che ne ha assunto
la custodia (19).
Orbene, nel caso oggetto della sentenza in esame,
come giustamente ha rilevato il G.u.p. di Savona, il contratto stipulato dal “guaritore” potrebbe essere ricondotto nell’ambito del contratto di prestazione d’opera professionale disciplinato dall’art. 2229 c.c. Infatti, il “guaritore” si era impegnato a curare la “paziente” attraverso la
somministrazione di terapie e trattamenti (impacchi di
argilla, succhi di carote, ecc.) alternativi a quelli della
medicina ufficiale in cambio di ingenti somme di denaro. Tuttavia, questo contratto non è in grado di costituire un obbligo di protezione nei confronti della “paziente”, rilevante ai sensi dell’art. 40 comma 2 c.p., in quanto la causa di nullità che lo vizia incide su un fondamentale requisito dell’obbligo di garanzia: la possibilità fattuale e giuridica di impedimento dell’evento. In effetti,
la prestazione oggetto del contratto stipulato dal “guaritore” è impossibile e illecita, dal momento che il “guaritore” non ha né la possibilità materiale né quella giuridi-
ca di esercitare l’attività medica. Non ha la possibilità
giuridica di esercitare l’attività medica oggetto del contratto, in quanto non è né laureato in medicina né tantomeno specializzato in oncologia; e non ha quella materiale, in quanto non è titolare di poteri capaci di curare la malattia della “paziente”. In breve: dal contratto stipulato tra la “paziente” e il “guaritore” non può nascere
un obbligo di garanzia rilevante ai sensi dell’art. 40 comma 2 c.p., in quanto quest’ultimo non è titolare dei necessari poteri fattuali e giuridici di impedimento dell’evento. Infatti, il reato omissivo improprio, come correttamente ha affermato il giudice nella sentenza in esame,
costituisce un reato “proprio” (20), realizzabile solamente da specifiche categorie di soggetti a cui l’ordinamento
attribuisce, da un lato, obblighi di impedimento dell’evento, e, dall’altro, effettivi poteri di impedimento. Ed è
appunto l’esistenza di autentici poteri fattuali e giuridici
impeditivi che consente l’equiparazione del mancato
impedimento dell’evento alla sua attiva causazione. Se,
infatti, il legislatore chiamasse a rispondere per il mancato impedimento di un evento colui che non è titolare
di autentici poteri di impedimento dell’evento, finirebbe
per configurare una ipotesi di responsabilità per fatto altrui in aperto contrasto con il principio di personalità
della responsabilità penale sancito dall’art. 27 Cost. (21)
Il nesso di condizionamento tra la condotta
del “guaritore” e la morte del “paziente”:
la c.d. “causalità psichica”
Qualche perplessità suscita, invece, la sentenza nelNote:
(13) Cfr. F. Sgubbi, Responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento, cit., 118 ss.; G. Fiandaca, Il reato commissivo mediante omissione, cit., 21
ss. e 83 ss. che sostituiscono i tradizionali criteri giuridico-formali di individuazione degli obblighi di garanzia con criteri materiali desunti dalla
funzione della responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento.
(14) Sul punto v. G. Fiandaca-E. Musco, Diritto penale, cit., 567.
(15) Cfr. I. Leoncini, Obbligo, cit., 251.
(16) Cfr. I. Leoncini, I rapporti tra contratto, reati-contratto e reati in contratto, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 997 ss.; Id., Obbligo, cit., 256; F. Mantovani, L’obbligo, cit., 347.
(17) Cfr. F. Mantovani, Diritto penale, cit., 176 ss.; Id., L’obbligo, cit., 347.
(18) Cfr. I. Leoncini, Obbligo, cit., 261 ss.; F. Mantovani, L’obbligo, cit.,
347.
(19) Cfr. I. Leoncini, Obbligo, cit., 258 ss.; F. Mantovani, L’obbligo, cit.,
347.
(20) Sulla configurazione dei reati omissivi impropri come reati “propri”,
v. A. Alessandri, voce Impresa (Responsabilità penali), in Dig. disc. pen.,
VI, 1992, 200 ss.; G. P. De Muro, Il bene giuridico proprio quale contenuto
dei reati a soggettività ristretta, cit., 886; I. Leoncini, Obbligo, cit., 13; M. Zanotti, Il reato omissivo, in AA.VV, Introduzione al sistema penale, Torino,
2001, II, 84; A. Gargani, Ubi culpa, ibi omissio. La successione di garanti in
attività inosservanti, in Ind. pen., 2000, 590; F. Mantovani, L’obbligo, cit.,
341; F. Cingari, Sul concorso dell’extraneus nel reato proprio, in Ind. pen.,
2004, 946; M. Romano, Commentario, cit., 379.
(21) Cfr. I. Leoncini, Obbligo, cit., 70 ss.; F. Mantovani, L’obbligo, cit.,
346; F. Palazzo, Il fatto, cit., 78.
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1155
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
la parte in cui sostiene la riconducibilità eziologica della
morte della donna alla condotta del “guaritore”consistita nell’avere - attraverso un complesso di attività destinate ad incidere sulla psiche della donna e ad operare
una trasformazione (o un rafforzamento) della sua volontà - impedito alla “paziente” il ricorso alle terapie della medicina ufficiale.
Le argomentazioni addotte dalla sentenza in esame
a fondamento delle proprie affermazioni sono sostanzialmente due. Da un lato, si osserva che, come risulta dalle
perizie medico-legali, se la donna si fosse sottoposta ai
trattamenti chemioterapici e al successivo intervento
chirurgico anziché affidarsi alle “cure” del “guaritore”,
anche se non è possibile affermare con certezza che la
morte sarebbe stata scongiurata, è altamente probabile
che si sarebbe verificata in un momento consistentemente differito. Dall’altro lato, il giudice ritiene che le
dichiarazioni della donna assunte durante l’incidente
probatorio e le testimonianze rese durante il giudizio abbreviato - dalle quali emerge la circostanza che, prima di
affidarsi alle “cure” del “guaritore”, la “paziente” non
aveva ancora deciso di sottrarsi alle terapie della medicina ufficiale - dimostrino che la decisione della donna di
sottrarsi alle terapie, che l’avrebbero salvata o che comunque le avrebbero prolungato la vita, sia stata determinata dalla condotta del “guaritore”.
La prima delle argomentazioni addotte dal G.u.p. di
Savona pare condivisibile. In effetti, per stabilire se la
morte della “paziente” è riconducibile eziologicamente
alla condotta attiva del “guaritore” occorre, anzitutto,
chiedersi se i trattamenti terapeutici della medicina ufficiale (chemioterapia e intervento chirurgico di riduzione della massa tumorale) avrebbero impedito la morte
nel tempo e nel modo in cui si è verificata. Infatti, ai fini dell’accertamento del nesso di causalità occorre avere
riguardo non già all’evento astrattamente descritto dalla
norma incriminatrice, ma all’evento concreto, hic et
nunc, così come si è verificato (22). Pertanto, per stabilire se tra la condotta attiva del “guaritore” e la morte della “paziente” sussiste il nesso di causalità previsto dall’art.
40 c.p., ciò che occorre innanzitutto chiedersi non è se la
morte per tumore mammario sarebbe stata scongiurata
da tempestivi trattamenti chemioterapici e chirurgici,
ma è se la tempestiva sottoposizione ai trattamenti della
medicina ufficiale avrebbe, con elevata credibilità razionale o probabilità logica, impedito la morte della donna
nel modo e nel tempo in cui si è verificata.
Meno convincente appare, invece, l’affermazione
del giudice secondo la quale la condotta del “guaritore”
avrebbe determinato la “paziente” a sottrarsi alle terapie
della medicina ufficiale. In effetti, l’accertamento della
relazione causale tra il comportamento del “guaritore” e
la morte della “paziente” è tutt’altro che agevole. Infatti,
l’individuazione del nesso di causalità si complica, e di
molto, quando i termini del rapporto causale, anziché essere costituiti dal comportamento dell’agente e da un
evento “esterno” del mondo fisico, sono costituiti da un
1156
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
evento fisico “finale” e da un evento psichico “intermedio”, cioè quando si tratta di accertare la c.d. causalità
psichica (23). Nel caso in esame poi l’individuazione del
nesso di causalità è complicata ulteriormente dal fatto
che non si tratta di stabilire la relazione causale tra una
condotta umana e una determinazione ad agire ma tra
una condotta umana e una mancata decisione di agire.
Secondo alcuni (24), la c.d. “causalità psichica”
non può essere ricondotta al paradigma della causalità
naturalistica, che indica una regolarità di successione tra
un antecedente ed un conseguente, in quanto tra le azioni umane non sarebbe possibile riscontrare una sequenza regolare come tra gli eventi del mondo fisico. Pertanto, la spiegazione dei comportamenti umani, non potendo essere ricavata secondo il metodo nomologico-deduttivo (25) per l’assenza di un paradigma nomologico sotto il quale sussumere il singolo caso di condizionamento
psichico, deve necessariamente essere fornita attraverso
un giudizio “individualizzante” (26) diretto ad accertare
perché nel singolo caso un determinato soggetto ha agito in un dato modo. Così, ad esempio, per stabilire se Tizio ha agito in un certo modo perché minacciato da
Note:
(22) Cfr. F. Stella, La descrizione dell’evento, Milano, 1970, 87 ss.; Id., Leggi scientifiche, cit., 260 ss.; G. Fiandaca-E. Musco, Diritto penale, cit., 206;
F. Palazzo, Il fatto, cit., 57ss.; M. Romano, Commentario, cit., 370 ss.
(23) Il tema della c.d. causalità psichica, che è stato analizzato soprattutto con riferimento alla partecipazione nel morale nel reato, viene in gioco anche i in tema di truffa, violenza privata mediante minaccia, estorsione, concussione mediante induzione, provocazione nonché nelle ipotesi in cui ad una condotta difensiva o di fuga determinata dalla minaccia
o dall’aggressione altrui segue la lesione o la morte del soggetto aggredito
o minacciato. Per una panoramica della dottrina in tema di “causalità
psichica” v. L. Cornacchia, Il problema della c.d. causalità psichica, cit.,198
ss.; M. Ronco, Le interazioni psichiche nel diritto penale, cit., 821 ss.
(24) Cfr. H.L.A. Hart-A.M. Honoré, Causation in the law, cit., 51 ss.
(25) Per l’individuazione della causa penalmente rilevante attraverso il
metodo della sussunzione sotto leggi scientifiche v., in dottrina, nella manualistica, G. Fiandaca-E. Musco, Diritto penale, cit., 207 ss.; G. Marinucci-E. Dolcini, Manuale di diritto penale, Milano, 2004, 116 ss. Inoltre v. F.
Stella, La nozione penalmente rilevante di causa: la condizione necessaria, in
Riv. it. dir. e proc. pen., 1988, 1217 ss.; Id., Scienza e norma nella pratica dell’igiene industriale, in ivi, 1999, 382 ss.; Id., Leggi scientifiche e spiegazione
causale nel diritto penale, Milano, 2000, 88 ss.; Id., Giustizia e modernità, Milano, 2001, passim; Id., Etica e razionalità nel processo penale nella recente
sentenza sulla causalità delle Sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione,
in Riv. it. dir. e proc. pen., 2002, 767 ss.; Id., Verità, scienza e giustizia: le frequenze medio-basse nella successione di eventi, ibidem, 1215 ss.; Id., Fallacie e
anarchia metodologica in tema di causalità, ivi, 2004, 23 ss.; Id., L’allergia alle
prove della causalità individuale, ibidem, 379 ss.; M. Romano, Commentario,
cit., 367 ss. In giurisprudenza v. Cass., Sez. IV, 13 febbraio 2002, Covili, in
Riv. it. dir. e proc. pen., 2002, 737; Cass., Sez. IV, 16 gennaio 2002, Sgarbi, ibidem, 737 ss.; Cass., Sez. IV, 29 novembre 2000, Musto, ivi, 2001, 277
ss.; Cass., Sez. IV, 28 novembre 2000, Di Cintio, ibidem, 277 ss.; Cass.,
Sez. IV, 28 settembre 2000, Baltrocchi, ibidem, 227 ss.; Cass., Sez. IV, 17
dicembre 1993, Ianieri, in Riv. pen. ec., 1996, I, 56 ss.; Cass., Sez. IV, 27
maggio 1993, Rech, in Cass. pen., 1995, 2898; Cass., Sez. IV, 6 dicembre
1990, Bonetti, in Foro it., 1992, II, 36 ss.
(26) In senso contrario al metodo “individualizzante” di spiegazione causale del diritto penale v. G. Fiandaca-E. Musco, Diritto penale, cit., 207 ss.;
F. Stella, Leggi scientifiche, cit., 102 ss.; Id., Fallacie e anarchia metodologica,
cit., 47 ss.
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
Caio, non potendosi fare riferimento a generalizzazioni
(del tipo in presenza di determinate condizioni tutti gli
uomini o la maggior parte di essi agisce in un dato modo), si dovrà fare riferimento esclusivamente alle dichiarazioni degli eventuali testimoni o della stessa persona
minacciata e ad ogni altra circostanza che consenta al
giudice di comprendere le ragioni del comportamento
della vittima (27).
Secondo l’opinione prevalente (28), invece, i casi
di c.d. “causalità psichica” sono riconducibili nell’ambito della causalità naturalistica. Infatti, si osserva che anche tra i fenomeni psichici è possibile ricostruire una regolarità di successione analoga a quella dei fenomeni fisici, dal momento che si tratta di fenomeni reali che si
svolgono nel tempo. Pertanto, anche nei casi riconducibili alla c.d. causalità psichica in cui si tratta di stabilire
la relazione eziologica tra comportamenti umani non solo è possibile ma è necessario far leva sul metodo generalizzante della sussunzione sotto leggi scientifiche.
Da questo punto di vista, per stabilire se tra la condotta del “guaritore” e la decisione della “paziente” di
non sottoporsi ai trattamenti terapeutici della medicina
ufficiale vi è un legame eziologico occorrerà, anzitutto,
verificare, sulla base di una legge scientifica di copertura
e tenendo conto delle condizioni presenti nella situazione concreta, se eliminando mentalmente la condotta
del “guaritore” la “paziente” si sarebbe sottoposta alle terapie chemioterapiche e chirurgiche. E nell’ipotesi in cui
ciò risulti probabile o anche solamente possibile, occorrerà dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che
la decisione di sottrarsi alle terapie della medicina ufficiale non è stata determinata da una causa diversa dalla
condotta del “guaritore” (29). In particolare, andrà
escluso, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la decisione della “paziente” sia riconducibile ad altri fattori
causali come, ad esempio, la paura o la sfiducia per la
chemioterapia e per l’intervento chirurgico, oppure lo
stato di minorata capacità psichica (circostanza, peraltro, acclarata attraverso le perizie medico-legali).
Orbene, nei casi di c.d. causalità psichica, pur riconoscendo la possibilità di effettuare generalizzazioni e di
ravvisare l’operatività di reali meccanismi causali, non
c’è dubbio che il reperimento di vere e proprie leggi
scientifiche sia comunque alquanto difficile. Inoltre,
l’impossibilità di accedere alla “scatola nera” degli avvenimenti psichici fa sì che il ricorso alle assunzioni tacite
sia particolarmente consistente e che le leggi scientifiche sotto le quali sussumere il singolo caso di condizionamento psichico abbiano carattere per lo più statistico
e a contenuto non elevatissimo (30).
Queste difficoltà, insieme ad un probabile scetticismo rispetto alla possibilità di adottare parametri obiettivi in sede di accertamento dei condizionamenti psichici, spiegano probabilmente la ragione per la quale nella
sentenza in esame nella individuazione del nesso di causalità viene abbandonando il modello “generalizzante”
della sussunzione sotto leggi scientifiche a vantaggio di
quello “individualizzante”. Infatti, l’accertamento del
nesso di causalità tra la condotta del “guaritore” e la morte della donna viene compiuto, non già avendo riguardo
a generalizzazioni dotate di dignità scientifica, ma attraverso la ricostruzione indiziaria del fatto storico. In particolare, l’efficacia eziologia della condotta del guaritore
viene individuata assumendo come parametro fondamentale l’esperienza psichica della donna e, conseguentemente, le risultanze probatorie costituite dalle dichiarazioni rese da questa durante l’incidente probatorio e da
quelle di alcuni testimoni, dalle quali emerge la circostanza che prima dell’incontro con il guaritore la “paziente” non aveva ancora deciso di sottrarsi alle terapie
ufficiali.
Sennonché, il modello di accertamento causale
“individualizzante” che fa leva essenzialmente sui elementi che emergono dalla ricostruzione empirica della
singola vicenda storica utilizzato nella sentenza in esame
presenta seri inconvenienti. Anzitutto, rischia di portare a confondere due piani che debbono rimanere rigorosamente distinti: la dimostrazione del nesso di causalità e
la sua prova (31). Infatti, mentre la prova del nesso di
causalità, intesa come conferma processuale di una ipotesi causale scientificamente fondata, alla stessa stregua
di quello che avviene per tutti gli altri elementi del reato, non può che dipendere dalla libera valutazione che il
giudice compie delle emergenze probatorie, la dimostrazione (individuazione del nesso di causalità) non può
prescindere dall’ancoraggio ad un parametro obiettivo
come quello nomologico. Inoltre, il riferimento al paradigma indiziario come criterio di accertamento del nesso
di causalità rischia di frustrare sia le esigenze di legalitàtassatività espresse dall’art. 40 comma 1 c.p. sia quelle di
personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27
Cost. (32) Quelle di legalità-tassatività, in quanto l’indiNote:
(27) Cfr. H.L.A. Hart-A.M. Honoré, Causation in the law, cit., 48 ss.
(28) Cfr. F. Dencker, Kausalität und Gesamttat, cit., 26 ss.; K. Engisch, Das
problem der psychischen Kausalität, cit., 247 ss.; S. Seminara, Riflessioni sulla condotta istigatoria come forma di partecipazione al reato, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1983, 1123 ss.; C. Roxin, Strafrecht, cit., 305; M. Romano,
Commentario, cit., 367; F. Stella, Leggi scientifiche, cit., 102 ss. e 313-314.
(29) Cfr. Cass., Sez. Un., 10 luglio 2002, Franzese, in Foro it., II, 2002, 601
ss., con nota di O. Di Giovine, Causalità omissiva in campo medico-chirurgico al vaglio delle Sezioni Unite; in questa Rivista, 2003, 50 ss., con nota di
A. Di Martino, Il nesso causale attivato da condotte omissive tra probabilità,
certezza e accertamento; in Cass. pen., 2003, 1176, con nota di R. Blaiotta, Con una storica sentenza le Sezioni unite abbandonano l’irrealistico modello nomologico deduttivo di spiegazione causale di eventi singoli. Un nuovo inizio per la giurisprudenza.
(30) Cfr. F. Stella, Leggi scientifiche, cit., 313 che, pur non escludendo la
possibilità di formulare leggi universali, tuttavia riconosce che nessuna di
esse sembra essere comunemente disponibile.
(31) Cfr. Sulla necessità di distinguere tra il piano della dimostrazione del
nesso di causalità che attiene alla nozione sostanzialistico-penale di causalità e quello della prova v. O. Di giovine, Lo statuto, cit., 669 ss.
(32) Cfr. F. Stella, Leggi scientifiche, cit., 101 ss.; Id., Fallacie e anarchia metodologica, cit., 47 ss.; G. Fiandaca-E. Musco, Diritto penale, cit., 207 ss.
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1157
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
viduazione del nesso di causalità, alla stessa stregua degli
altri elementi di fattispecie legalmente previsti, non si
può basare sulle convinzioni o sulle libere valutazioni del
giudice ma su parametri oggettivi e controllabili come le
leggi scientifiche (33). Quelle di personalità della responsabilità penale, in quanto per stabilire che un evento è “opera” di un determinato soggetto non è possibile
rimettersi alla libera valutazione del giudice, ma occorre
utilizzare parametri conoscitivi controllabili e obiettivi
come quelli nomologici (34).
La responsabilità soggettiva del “guaritore”:
dolo diretto, dolo eventuale o colpa con previsione?
Ma la sentenza in esame appare interessante anche
perché consente di riflettere sulle straordinarie difficoltà
che pone l’accertamento processuale dell’elemento soggettivo del reato ed in particolare sul fatto che non sempre risultano chiari i parametri che orientano la giurisprudenza nell’accertamento delle diverse forme di manifestazione del dolo.
Secondo la sentenza in commento, il sedicente
“guaritore” pur non avendo agito allo scopo di cagionare
la morte della “paziente”, tuttavia si sarebbe rappresentato la morte di quest’ultima come certa conseguenza
della sua complessa attività di persuasione a sottrarsi alle
terapie della medicina ufficiale. Infatti, si afferma che
«ogni cittadino, anche di livello culturale non elevato
nell’attuale contesto storico-sociale-culturale è a conoscenza del fatto che per una donna alla quale sia stato
diagnosticato un tumore al seno, le uniche speranze di
guarigione o di prolungamento delle aspettative di vita
sono affidate, in via esclusiva, alla sottoposizione a trattamenti di chemio o radio-terapia, preceduti o seguiti da
eventuale intervento chirurgico finalizzato all’asportazione della massa tumorale». In particolare, si ritiene che
il comportamento del “guaritore” potrebbe essere paragonato a quello di colui che, al fine di conseguire il premio assicurativo per l’incendio della propria abitazione,
appicca il fuoco alla stessa pur sapendo che all’interno
del locale si trova una persona anziana invalida impossibilitata a mettersi in salvo.
Sennonché, a nostro avviso, occorre prestare particolare cautela nel ricondurre alla figura del dolo diretto
l’atteggiamento psicologico del “guaritore”. Infatti, il dolo diretto si configura quando il soggetto agente si rappresenta come certa conseguenza della propria condotta
la realizzazione dell’evento accessorio rispetto a quello
intenzionalmente perseguito (35). Pertanto, per potere
affermare che il “guaritore” si è rappresentato la morte
della donna come conseguenza certa della propria condotta, non è sufficiente sostenere che non poteva non
sapere che le “terapie” che proponeva erano inutili e
inefficaci, e che le uniche speranze di guarigione o di
prolungamento delle aspettative di vita erano affidate,
in via esclusiva, alla sottoposizione ai trattamenti di chemio o radio-terapia e, eventualmente, all’intervento chirurgico finalizzato all’asportazione della massa tumorale,
1158
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
oppure che aveva un interesse economico ad impedire
alla “paziente” la sottoposizione alle terapie della medicina ufficiale. Ma occorre potere affermare che il “guaritore” si è rappresentato con certezza il legame eziologico
tra la propria condotta e la morte della donna. Circostanza questa da escludere, da un lato, nell’ipotesi in cui
il “guaritore” abbia agito nella convinzione (o nel dubbio) che ormai la donna era già decisa a non sottoporsi ai
trattamenti chemioterapici e all’intervento chirurgico di
riduzione; e dall’altro, nel caso in cui abbia agito nella
convinzione (o nel dubbio) che la chemioterapia e l’intervento chirurgico non avrebbero con certezza potuto
salvare la vita della “paziente” o quantomeno rallentare
il decorso della malattia.
Qualora, dunque, sussistano elementi per pensare
che il “guaritore”, pur essendo perfettamente consapevole dell’inutilità delle “cure” che proponeva (impacchi di
argilla, succhi di carote, ecc.), abbia agito ritenendo che
le terapie ufficiali erano effettivamente inutili oppure
pensando che la donna ormai era comunque decisa (omnimodo factura) a non sottoporsi ai trattamenti terapeutici ufficiali, il suo atteggiamento psicologico non si potrebbe ricondurre alla figura del dolo diretto. Infatti, pur
essendosi rappresentato come certa la morte della donna
non se l’è rappresentata come certa conseguenza della
propria condotta. Il caso in esame, dunque, a ben vedere, non sembra paragonabile al classico esempio di scuola di colui che, allo scopo di conseguire il prezzo dell’assicurazione contro l’incendio del proprio appartamento,
appicca il fuoco allo stesso pur sapendo che all’interno
del locale si trova una persona anziana invalida impossibilitata a mettersi in salvo. Infatti, in questo caso l’indubbia riconducibilità eziologica della morte della persona anziana alla condotta dell’agente insieme alla consapevolezza che questi ha della sua presenza nel locale consentono di inferire che l’agente si è rappresentato come
certa conseguenza della propria condotta la morte della
vittima.
Pertanto, a nostro avviso, pare più prudente ricondurre l’atteggiamento psichico del guaritore nell’ambito
del dolo eventuale (36). Infatti, da un lato, dalla consaNote:
(33) Cfr. F. Stella, Leggi scientifiche, cit., 101 ss.; Id., Fallacie e anarchie, cit.,
47; F. Palazzo, Il fatto, cit., 65; G. Fiandaca-E. Musco, Diritto penale, cit.,
208.
(34) Cfr. F. Stella, Fallacie e anarchie, cit., 47.
(35) Cfr. L. Eusebi, Il dolo nel diritto penale, in Studium Iuris, 2000, 1076 ss.;
G. Fiandaca-E. Musco, Diritto penale, cit., 328 ss.; F. Palazzo, Il fatto, cit.,
108 ss.; M. Romano, Commentario, cit., 440 ss. In giurisprudenza, v. Cass.,
Sez. Un., 14 febbraio 1996, Mele, in Cass. pen., 1996, 1419, 2505 ss.;
Cass., Sez. VI, 15 aprile 1998, Pelato, ivi, 1999, 3423 ss.
(36) In argomento v., nella manualistica, F. Mantovani, Diritto penale,
cit., 324; G. Fiandaca-E. Musco, Diritto penale, cit., 329 ss.; F. Palazzo, Il
fatto, cit., 110 ss. Inoltre v. G.A. De Francesco, Dolo eventuale e colpa cosciente, in Riv. dir. proc. pen., 1988, 113 ss.; S. Prosdocimi, Dolus eventualis. Il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie penali, Milano, 1993,
(segue)
GIURISPRUDENZA•DIRITTO PENALE
pevolezza del “guaritore” che la “paziente” era affetta da
una grave forma di tumore curabile solamente con il ricorso alle terapie proposte dalla medicina ufficiale, e dal
fatto che egli versava nella completa ignoranza delle regole che disciplinano l’arte medica (37), forse non è possibile desumere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che
questi abbia agito rappresentandosi come certa conseguenza della propria condotta la morte della “paziente”.
Dall’altro lato, è ben possibile pensare che sul suo “schermo mentale” sia apparsa quantomeno la possibilità/probabilità della morte come evento accessorio rispetto al
risultato che intendeva perseguire.
Ad ogni modo, è evidente come la conclusione che
il reo si è rappresentato come certo piuttosto che come
probabile/possibile la realizzazione di un determinato
evento (collaterale rispetto a quello verso il quale è
orientata la condotta) sia connotata da un qualche margine di arbitrarietà. Da questo punto di vista, è comprensibile che nella prassi applicativa accanto al dato
oggettivo riguardante il quantum di probabilità della
condotta di cagionare l’evento oggetto di rappresentazione del soggetto agente, la giurisprudenza sia condizionata anche da ulteriori parametri che non sempre però
emergono in modo evidente dalle motivazioni delle sentenze (38). Nel caso in esame, ad esempio, non pare del
tutto peregrino pensare che nella qualificazione dell’evento come oggetto di rappresentazione certa dal parte
del “guaritore” abbiano assunto rilevanza anche il contesto di illiceità penale nel quale quest’ultimo ha agito ed,
in particolare, la riprovevolezza dello scopo perseguito.
In fine, va osservato come la riconducibilità dell’atteggiamento psicologico del “guaritore” nell’ambito del
dolo eventuale pare abbastanza agevole a condizione
che questa forma di manifestazione del dolo venga concepita, con una parte della dottrina (39) e la giurisprudenza prevalente (40), come accettazione del rischio
della realizzazione dell’evento, cioè come semplice rappresentazione di probabilità positive e negative di realizzazione del reato. Meno agevole, infatti, risulterebbe ricondurre l’atteggiamento psichico del guaritore nell’ambito del dolo eventuale, qualora si ritenesse che accanto
alla accettazione del rischio, cioè alla rappresentazione
delle probabilità positive e negative di realizzazione dell’evento, debba essere dimostrata anche l’esistenza di
una approvazione interiore alla realizzazione dell’evento
preveduto, e cioè l’accettazione dell’evento (41). Infatti,
per potere verificare l’esistenza di questo quid pluris occorrerebbe, secondo la c.d. “formula di Frank” (42),
chiedersi se il “guaritore” avrebbe ugualmente agito per
la realizzazione del risultato perseguito (il profitto ricavato dalle “cure”) se si fosse rappresentato come certa la
realizzazione dell’evento accessorio (la morte della donna). Ebbene, anche ammesso che sia possibile sostituire
un atteggiamento psichico ipotetico a quello reale (43),
data la difficoltà di individuare gli elementi sui quali
fondare la convinzione che il “guaritore” si sarebbe comportato nello stesso modo se si fosse rappresentato come
certa la morte della “paziente”, forse non rimarrebbe che
ricondurre la fattispecie nell’ambito della colpa con previsione, che, come è noto, sussiste quando il soggetto
agente non vuole commettere il reato, ma si rappresenta
la realizzazione del fatto tipico come probabile o possibile (44).
Note:
(continua nota 36)
passim; S. Canestrari, Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra dolo e
colpa nella struttura delle tipologie delittuose, Milano, 1999, passim; G. Forte,
Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?, in Riv. it. dir. e
proc. pen., 1999, 228 ss.; Id., Dolo eventuale tra divieto di interpretazione analogica e incostituzionalità, ivi, 2000, 820 ss.; P. Veneziani, Dolo eventuale,
cit., 70 ss.; M. Romano, Commentario, cit., 440 ss.
(37) Cfr. R. Bartoli, Colpevolezza: tra personalismo e prevenzione, Torino,
2005, 181 secondo il quale le ipotesi in cui il soggetto agente intraprende
una attività nella completa ignoranza delle regole che la disciplinano, alla stessa stregua di quelle di chi intraprende un’attività pericolosa nella
consapevolezza che rispetto ad essa non sono configurabili regole che
consentono di contenere il rischio (come, ad es., nel caso del lancio dei
sassi da un cavalcavia), non possono essere ricondotte nell’ambito della
c.d. colpa per assunzione ma nell’ambito del dolo eventuale.
(38) Cfr. P. Veneziani, Dolo eventuale, cit., 76 ss.
(39) Cfr. F. Mantovani, Diritto penale, cit., 323.
(40) Cfr. Cass., Sez. III, 23 ottobre 1997, Held, in Riv. pen., 1998, 342;
Cass., Sez. I, 8 novembre 1995, Piccolo, in Cass. pen., 1997, 991; Cass.,
Sez. I, 24 febbraio 1994, Giordano, ivi, 1995, 1837; Cass., Sez. I, 28 gennaio 1991, Caporaso, ivi, 1992, 1804.
(41) Cfr. L. Eusebi, Il dolo come volontà, Brescia, 1993, 178 ss.; Id., Il dolo
nel diritto penale, cit., 1077; F. Palazzo, Il fatto, cit., 111 ss.
(42) Cfr. L. Eusebi, Il dolo come volontà, Brescia, 1993, 178 ss.; Id., Il dolo
nel diritto penale, 1077.
(43) Cfr. G. Fiandaca-E. Musco, Diritto penale, cit., 330, nota 74; F. Palazzo, Il fatto, cit., 112; M. Romano, Commentario, cit., 443.
(44) In argomento v., nella manualistica, F. Mantovani, Diritto penale,
cit., 348 ss.; G. Fiandaca-E. Musco, Diritto penale, cit., 329 ss. e 523 ss.; F.
Palazzo, Il fatto, cit., 149 ss. Inoltre v. M. Gallo, voce Colpa penale, in Enc.
dir., VII, 1960, 628 ss.; G.A. De Francesco, Dolo eventuale e colpa cosciente, in Riv. dir. e proc. pen., 1988, 113 ss.; F. Mantovani, voce Colpa, in Dig.
disc. pen., II, 1988, 304 ss.; T. Padovani, voce Circostanze del reato, in Dig.
disc. pen., II, 1988, 217; S. Canestrari, Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai
confini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose, Milano, 1999,
passim; P. Veneziani, Dolo eventuale, cit., 71 ss.; M. Romano, Commentario, cit., 443 ss.
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1159
OPINIONI•DIRITTO PENALE
Diritto penale militare
Missioni militari all’estero, regole
di ingaggio e cause di non punibilità
codificate nella legislazione
penale comune e militare
di LUIGI D’ANGELO
Tracciare una linea di demarcazione tra condotte lecite e penalmente significative - legate all’utilizzo delle
armi - in astratto realizzabili dai militari italiani impegnati in missioni internazionali, appare operazione di
non facile attuazione, ciò in considerazione delle molteplici fonti normative, interne ed internazionali, cui
risultano assoggettati gli appartenenti alle Forze Armate all’estero. A ciò, inoltre, deve aggiungersi la commistione - non sconosciuta all’ordinamento militare - tra fonti esterne e fonti interne (circolari, direttive,
pacchetti di ordini, ecc.), a volte causa di “malintesi” sulla stessa operatività del principio di legalità, come
sembra avvenire per le c.d. regole d’ingaggio (R.O.E.), ovvero quelle regole disciplinanti l’uso e l’impiego
delle armi nelle missioni militari e che, a causa dei cennati “malintesi”, rischiano di operare quali cause
di non punibilità.
La natura giuridica delle R.O.E.
Con le riflessioni che seguono si intende soffermare l’attenzione sull’individuazione dei limiti all’uso della forzautilizzo delle armi cui sono assoggettati i militari italiani
impegnati in missioni pacificatrici (e similari) all’estero.
Indagine, che, senza pretese di completezza, appare utile
per tentare di tracciare una linea di demarcazione tra
condotte lecite e penalmente significative - legate all’utilizzo delle armi - in astratto realizzabili dagli appartenenti alle Forze Armate italiane nell’adempimento dei
propri doveri di servizio nelle operazioni de quibus.
Tematica, questa, che si intreccia - ma che in questa sede vuol mantenersi sullo sfondo - con quella più ampia
relativa al ripudio della guerra-uso della forza come contemplato dall’art. 11 Cost. e dal diritto internazionale
pattizio e consuetudinario e che sovente, anche in occasione dell’invio del contingente militare italiano in Iraq
nonché della proroga della relativa missione, produce
contrapposti indirizzi ermeneutici (1).
Nota:
(1) Può essere rammentato che a fronte di recenti interventi normativi
introduttivi di “surrogati” del concetto di guerra (cfr. art. 165 del codice
penale militare di guerra come modificato dall’art. 2, l. n. 15 del 27 febbraio 2002), certa dottrina è stata indotta a paventare il ricorso all’uso
della forza bellica quale evento non eccezionale e quindi affrancato dal
dictum costituzionale, oramai desueto o comunque da considerarsi implicitamente abrogato. In particolare, pare porsi in tale prospettiva, G. De
Vergottini, Guerra e attuazione della Costituzione, Relazione presentata al
convegno “Guerra e Costituzione”, Università Roma Tre, 12 aprile 2002,
in www.associazionedeicostituzionalisti.it; l’A., analizzando la recente normativa afferente ai concetti sostitutivi di guerra, affronta la questione di
una «radicale riconsiderazione di un postulato dogmatico che si era affermato per quasi mezzo secolo: la assoluta prevalenza del valore della pace
e la limitazione della partecipazione italiana a sole guerre difensive» soggiungendo che «con la guerra nel Golfo ma soprattutto con la crisi del
Kosovo e poi, nella stretta attualità, con la catastrofe dell’Afghanistan …
è maturata progressivamente la consapevolezza della presenza del fenomeno bellico e il tentativo di elaborare dei concetti sostitutivi. Si tratta
di conflitti che hanno posto in evidenza come sia stato superato il regime
della messa al bando della guerra, legittimando il ricorso dello ius ad bellum con evidente abbandono della convinzione della assolutezza di principi che sembravano consolidati nel diritto internazionale e di riflesso in
quello costituzionale». In realtà, paventare l’abrogazione tacita di una
norma contemplata in una Costituzione rigida appare assunto giuridicamente insostenibile ed anzi, con precipuo riferimento all’art. 11 Cost.,
non sembra seriamente ipotizzabile neppure un’abrogazione espressa da
parte di una norma di pari rango, ciò poiché la disposizione non può che
collocarsi nell’ambito di quei principi supremi dell’ordinamento non modificabili nel loro contenuto essenziale nemmeno da leggi di revisione costituzionale (cfr., Corte cost. 29 dicembre 1988, n. 1146, in www.giurcost.it). Parlare poi di abrogazione per desuetudine di un precetto giuridico
imponente un divieto appare un non senso. Se infatti la condotta vietata non viene mai posta in essere ciò è garanzia di effettività della disposizione. Viceversa se il divieto è ripetutamente e sistematicamente inosservato, non per questo, e tralasciando la natura costituzionale dello stesso,
si realizza la sua estinzione; salvo ritenere che l’imposizione di un divieto
giuridico rafforzi la naturale repulsa ad un comportamento, con la conseguenza che il riproporsi diffuso e sistematico dello stesso porta all’estinzione per desuetudine del divieto. Ma, a ben vedere, «i divieti giuridici e
morali vengono prodotti non per consolidare tendenze generali spontanee a “non fare” qualcosa, ma, al contrario, per contrastare tendenze fortissime a “fare” proprio ciò che la norma intende vietare. Il comportamento “naturale” non è l’astensione dal comportamento vietato, ma, ap(segue)
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1161
OPINIONI•DIRITTO PENALE
I limiti all’uso della forza e delle armi, da parte dei militari italiani all’estero, risultano dalle cosiddette regole
d’ingaggio (R.O.E.) ovvero quelle disposizioni “che specificano le circostanze e i limiti entro cui le forze possono iniziare o continuare il combattimento con quelle
contrapposte” (2).
Appare interessante, allora, interrogarsi sui rapporti intercorrenti tra tali regole d’ingaggio ed altre disposizioni
dell’ordinamento italiano, applicabili ai militari all’estero, con particolare riferimento a quelle codificanti cause
di non punibilità a fronte della commissione di fatti di
reato.
In particolare, la problematica che si pone è: possono le
R.O.E. prevedere un uso della forza più “elastico” (3) rispetto a quello consentito - ricorrendo determinate condizioni - dalla normativa penale in materia di uso legittimo di armi, legittima difesa individuale, etc. (4)? Oppure vi è coincidenza, con la conseguenza che soltanto al
ricorrere dei presupposti previsti dalle norme penalistiche ed alle condizioni dalle medesime stabilite, i soldati
italiani, nel caso di uso della forza armata, non sconfineranno nell’area del penalmente rilevante?
Evidentemente, la risposta agli interrogativi presuppone
una previa indagine sulla natura giuridica delle R.O.E.,
ciò per valutare la loro “posizione” nell’ambito delle fonti dell’ordinamento.
Soltanto, infatti, nell’ipotesi in cui le R.O.E. risultassero
rivestire il grado di una fonte normativa pari a quella della legislazione sulle cause di non punibilità, potrebbe in
astratto essere ritenuta ammissibile una regolamentazione derogatoria, con l’effetto che le regole d’ingaggio sarebbero idonee, in sostanza, a scriminare condotte che,
invero, non ricadrebbero nell’ambito operativo delle già
codificate cause di esenzione dalla pena.
Diversamente, però, qualora le R.O.E. venissero configurate quali fonti subordinate alla legge, non potendosi
evidentemente ammettere deroghe alla stessa da parte di
una fonte sottordinata, le regole d’ingaggio non potranno che “doppiare”, quanto ad ampiezza e limiti, gli elementi contenutistici previsti dalle varie cause di non punibilità codificate, ricadendo, dunque, nell’area del penalmente apprezzabile, tutte quelle condotte criminose
in queste ultime non “ricomprese”.
Sembra maggiormente condivisibile la seconda opzione
interpretativa, configurandosi le R.O.E., in realtà, quali
atti amministrativi-ordini gerarchici.
Per la dimostrazione di tale assunto occorre brevemente
richiamare la normativa disciplinante l’invio all’estero
dei contingenti militari italiani.
Al proposito devono essere menzionate due fondamentali previsioni legislative.
Si tratta, in particolare, dell’art. 1, comma 1, l. 14 novembre 2000, n. 331, rubricato “Compiti delle Forze Armate”, che menziona, tra gli altri, il compito di “operare
al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in
conformità alle regole del diritto internazionale ed alle
determinazioni delle organizzazioni internazionali delle
1162
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
quali l’Italia fa parte” e dell’art. 1, comma 1, lett. a), della l. 18 febbraio 1997, n. 25, a norma del quale il Ministro della Difesa “attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sottoposte all’esame del Consiglio Supremo di difesa e approvate dal Parlamento”.
Occorre evidenziare, inoltre, che la Commissione Difesa della Camera dei Deputati, con la risoluzione n. 71007 del 16 gennaio 2001, ha apportato ulteriori elementi di precisazione al vigente quadro normativo specificando, con riferimento all’indicato procedimento decisionale, la necessità di quattro passaggi procedurali: 1)
una deliberazione governativa con conseguente informativa alle Camere; 2) l’approvazione da parte delle due
camere della deliberazione governativa; 3) seguito governativo alla delibera parlamentare tramite presentazione di un disegno di legge o emanazione di un decretolegge contenente la copertura finanziaria della missione;
4) adozione delle disposizioni attuative da parte della
amministrazione militare.
A rigore, pertanto, il Ministro della Difesa, nell’ambito
delle proprie attribuzioni nella materia concernente
l’invio all’estero dei militari italiani - per le finalità previste dalla legge suddetta - provvede ad eseguire, in via
amministrativa, le deliberazioni dell’Esecutivo sottoposte all’esame del Consiglio Supremo di Difesa, approvate dall’assemblea parlamentare (nella prassi mediante un atto non legislativo), necessitando a monte,
in ogni caso, che l’adottanda decisione sia conforme al
diritto internazionale e alle determinazioni di quelle
Note:
(continua nota 1)
punto, quel comportamento stesso» (M. Dogliani, Il valore costituzionale
della pace e il divieto della guerra, Relazione presentata al convegno “Guerra e Costituzione, cit.). In altri termini, le tesi che sostengono la decostituzionalizzazione tacita dell’art. 11 alla luce di una evoluzione normativa
che ha attualizzato ed aggiornato il concetto di guerra sulla scorta del dato fattuale, operano un’inaccettabile inversione logico-giuridica dei termini della questione prospettando una opinabile trasfigurazione delle
violazioni in “fatti normativi”.
(2) Definizione fornita dal Ministro della Difesa nella seduta del 7 novembre 2001 - Senato della Repubblica, 63^ seduta pubblica - concernente le “Comunicazioni del Governo sull’impiego di contingenti militari italiani all’estero in relazione alla crisi internazionale in atto e conseguente discussione” (in www.parlamento.it).
(3) La possibilità di un mutamento delle R.O.E. nel senso di una loro
maggiore elasticità così da non costringere i militari italiani ad un atteggiamento eccessivamente arrendevole, si trova prospettata nell’intervento in Parlamento del Ministro della Difesa in data 18 luglio 2004 a seguito della morte del Caporale Vanzan (in www.difesa.it).
(4) Oltre alle esimenti previste dal codice penale del ‘30, si pensi all’art.
41, c.p.m.p. - Uso legittimo di armi - “Non è punibile il militare, che, a fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso, ovvero ordina di far uso
delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla
necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza”; art. 44,
c.p.m.p. - Casi particolari di necessità militare - “Non è punibile il militare, che ha commesso un fatto costituente reato, per esservi stato costretto della necessità di impedire l’ammutinamento, la rivolta, il saccheggio, la devastazione, o comunque fatti tali da compromettere la sicurezza del posto, della nave o dell’aeromobile”; etc.
OPINIONI•DIRITTO PENALE
organizzazioni internazionali cui lo Stato Italiano appartiene (5).
Ora, essendo il Ministro della Difesa il massimo organo
gerarchico e disciplinare preposto all’Amministrazione
militare, come sancito dall’art. 1, l. n. 25/1997 (6), appare indiscutibile che i provvedimenti dallo stesso adottato in materia di missioni all’estero rappresentino ordini
gerarchici.
Più nel dettaglio va specificato che le R.O.E., verosimilmente elaborate dall’Autorità politica nell’ambito del
primo passaggio procedurale sopra indicato (deliberazione governativa), è vero che necessitano di essere approvate dall’assemblea parlamentare, ma siffatta approvazione non è disposta con un atto legislativo, bensì con
un atto di indirizzo (risoluzione) (7).
Successivamente, pertanto, sarà il Ministro della Difesa
(ed il relativo staff) a tradurre, anche tecnicamente, dette R.O.E. in provvedimenti vincolanti per le truppe, sotto forma, appunto, di ordini gerarchici vincolanti.
Ma se così è, allora, dovendo gli ordini gerarchici essere
conformi alla legge, come previsto dall’art. 4, l. n.
382/1978 (8), appare chiaro che le R.O.E. non potranno
derogare ai presupposti ed ai limiti contenuti nelle disposizioni in materia di esimenti codificate.
Così, ad esempio, quanto all’utilizzo legittimo delle armi,
non potrà essere ipotizzato un impiego di armamenti a
scopo preventivo, unilaterale ed offensivo, dovendosi
invece rispettare il disposto dell’art. 41 c.p.m.p. che postula la “necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza”.
Allo stesso modo, l’operatività della norma sulla legittima difesa ex art. 52 c.p., nel caso di commissione di
reati comuni (non militari) nell’ambito di quelle missioni assoggettate al codice penale militare di pace (9),
sarà subordinata al ricorrere di una situazione “aggressiva” (il presentarsi di un pericolo attuale di un’offesa ingiusta) che rende necessario difendere un diritto proprio od altrui e sempre che la difesa sia proporzionata
all’offesa.
Ne consegue che l’adozione di regole d’ingaggio autorizzanti, ad esempio, un uso delle armi anche in termini più
ampi di quelli previsti dall’art. 41 c.p.m.p. ovvero in termini sproporzionati a fronte di pericoli non attuali, etc.,
non sarebbe ipotizzabile, pena la violazione del principio
di legalità, con tutte le conseguenze in termini di legittimità o meno degli ordini gerarchici impartiti in tal senso, fonte di “conflitti” di doveri in capo al singolo militare. Si rammenta, infatti, che l’art. 4, l. 11 luglio 1978, n.
382, contempla, nel caso di ordine manifestamente criminoso o rivolto contro le Istituzioni dello Stato (rectius
contro i precetti fondamentali della carta costituzionale), un’ipotesi di disobbedienza proprio quale strumento
per ottemperare al fondamentale dovere di fedeltà.
In definitiva, l’esecutore di un ordine conforme a regole
d’ingaggio di tipo “elastico”, rischierebbe di vedersi imputato un fatto di reato in concorso con il superiore gerarchico, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 25, comma 2,
Note:
(5) Può essere altresì rilevato che la procedimentalizzazione configurata
dalla l. n. 25/1997 dovrebbe trovare applicazione anche qualora venga in
questione la necessità di decidere una proroga di una missione internazionale già oggetto di precedente e preventivo avallo parlamentare; d’altronde, è soltanto con l’adozione dell’anzidetto procedimento ex lege - il
quale, secondo parte della dottrina, avrebbe realizzato «un vera e propria
integrazione in via legislativa del complesso di norme costituzionali in
tema di difesa militare e di ricorso alla forza armata» (M. Franchini, Le risoluzioni parlamentari sulla lotta al terrorismo internazionale, in Giorn. dir.
amm., 2002, 321) - che si garantisce il rispetto del principio di apoliticità
delle Forze Armate (art. 4, l. 11 luglio 1978, n. 382 ed art. 98, comma 3,
Cost.), ciò in considerazione del fatto che la proroga della missione, se
decisa con l’adozione del procedimento anzidetto, diventerebbe oggetto
di una preventiva ed obbligata discussione avanti alle assemblee rappresentative del popolo, con rispetto della riserva parlamentare istituita con
la normativa de qua, e sarebbe a sua volta preceduta da un intervento del
Presidente della Repubblica, in ossequio alla sua veste, costituzionalmente prevista, di Comandante delle Forze Armate (art. 87, comma 9, Cost.).
La prassi fino ad oggi seguita che vede, invero, l’Esecutivo adottare un decreto legge “autorizzante” la proroga della missione, sembra pertanto contrastare in primo luogo con la ratio ispiratrice del procedimento deliberativo disegnato dalla l. n. 25/1997, ciò poiché verrebbe a realizzarsi un aggiramento della catena decisionale qui prefigurata stante l’immediata
precettività del decreto legge a seguito della sua pubblicazione, con violazione, dunque, della predetta riserva parlamentare in materia (in tal
senso, P. Carnevale, Il ruolo del Parlamento e l’assetto dei rapporti fra Camere e Governo nella gestione dei conflitti armati. Riflessioni alla luce della prassi
seguita in occasione delle crisi internazionali del Golfo persico, Kosovo e Afghanistan, Relazione presentata al convegno “Guerra e Costituzione”,
Università Roma Tre, 12 aprile 2002, in www.associazionedeicostituzionalisti.it). Realizzandosi, peraltro, una elusione delle esigenze di trasparenza
ed attenta ponderazione che dovrebbero caratterizzare le deliberazioni in
argomento, così favorendosi, invero, la prassi del “fatto compiuto”. In secondo luogo la tesi sembra cozzare con la “disciplina di dettaglio” contenuta nella risoluzione n. 7-1007 la quale distingue nettamente il momento del previo consenso parlamentare sulla opportunità della missione manifestato con appositi atti di indirizzo da quello del suo finanziamento (rifinanziamento) mediante atto avente forza di legge. Assunto
confermato dalla circostanza che detta risoluzione contempla l’ipotesi di
una attuazione ministeriale delle deliberazioni del Governo, in materia di
difesa e sicurezza, anche nel corso dell’approvazione del provvedimento
legislativo (di copertura finanziaria) da parte delle Camere, ciò «a testimonianza del fatto che il circuito decisionale di cui all’art. 1, comma 1,
lett. a) della l. n. 25 cit. si perfeziona al momento del primo intervento
parlamentare» (P. Carnevale, Il ruolo del Parlamento, cit.), con conseguente necessità di “riattivazione” del procedimento suddetto al fine di
rendere possibile una nuova valutazione, da parte di tutti i soggetti e organi istituzionali a ciò preposti, relativamente alla proroga dell’operazione militare, anche alla luce di sopravvenute circostanze.
(6) Cfr. altresì art. 12, d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, rubricato “Doveri attinenti alla dipendenza gerarchica”, secondo cui “Dal principio di gerarchia derivano per il militare … il dovere di obbedienza nei confronti del
Ministro della Difesa”.
(7) Ad esempio l’attuale missione in Iraq è stata autorizzata con risoluzioni
della maggioranza n. 6-00065 e n. 6-00046 approvate il 15 aprile 2003 dalla Camera (308 voti a favore, 31 voti contrari e 159 astenuti) e dal Senato
(153 voti a favore, 26 voti contrari e 2 astenuti), in www.parlamento.it.
(8) Art. 4, comma 4, l. 11 luglio 1978, n. 382, “Gli ordini devono, conformemente alle norme in vigore, attenere alla disciplina, riguardante il servizio e non eccedere i compiti di istituto”.
(9) Il riferimento alle missioni di pace è indotto dalla circostanza che
l’art. 47 c.p.m.g., come recentemente novellato, considera reati militari
un gran numero di reati comuni e pertanto nelle missioni in cui opera la
disciplina del codice penale militare di guerra dovrà essere applicato, il
luogo dell’art. 52 c.p., l’art. 42 c.p.m.p., come sancito dalla norma medesima (ammesso che le scriminanti codificate dalla legislazione militare di
pace si applichino ai militari impegnati in missioni regolamentate dal codice penale militare di guerra stante il crisma di eccezionalità-temporaneità di tale ultimo corpus normativo, ma vedi infra).
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1163
OPINIONI•DIRITTO PENALE
d.P.R. n. 545/1986 (10) o, più in generale, la ricorrenza
di un error facti (11) o iuris (12) e ferma restando, in questo ultimo caso, la possibilità di attribuire il fatto a titolo
di colpa sempreché il reato sia previsto anche nella forma colposa.
Come si è tentato altrove di prospettare (13), è, probabilmente, al contesto necessariamente “non bellico” (ex art.
11 Cost.), all’interno del quale i militari si trovano ad operare, da imputare l’assoggettamento dell’appartenente alle
Forze Armate ad uno statuto penale che paradossalmente
lo espone a conseguenze di non poco momento.
In altri termini, è proprio il precetto costituzionale anzidetto che, imponendo un uso della forza militare in termini non di offesa/aggressione, inibisce, a monte, una regolamentazione derogatoria (utilizzo degli armamenti
anche in chiave preventiva), invece paventabile, o meglio, necessitata, in una situazione di emergenza bellica
laddove si agisce in ottemperanza del sacro dovere di difesa della Patria ex art. 52, comma 1, Cost.
Più nel dettaglio, è la ricorrenza dell’emergenza bellica
che consente l’abbattimento dei consueti limiti all’uso
della forza, anche individuale, da parte dei militari, senza che vengano in discussione problemi legati alla rilevanza penale di condotte poste in essere non soltanto
per autodifesa (14).
In contesti non bellici, invece, continua a trovare applicazione lo statuto penale “ordinario” con le possibili
conseguenze sopra ipotizzate (15).
Missioni all’estero assoggettate
alla novellata legislazione penale di guerra:
il problema dell’applicabilità delle esimenti
previste dal codice penale militare di pace
e l’alternativa della “riespansione”
delle esimenti del codice Rocco
Risolto nel senso della “coincidenza” il problema dei limiti contenutistici delle R.O.E., occorre ora affrontare
un ulteriore problema: ai militari impegnati in missioni
all’estero ed assoggettati al codice penale militare di
guerra (16), possono essere applicate le esimenti previste
dal codice penale militare di pace?
Il quesito è non privo di risvolti applicativi, soprattutto
se si considera che alcune delle cause di non punibilità
previste dalla legislazione di pace (artt. 41 e 44 c.p.m.p.)
possono trovare un’applicazione ampia poiché riferibili
anche alla commissione di reati comuni (non militari)
realizzati da un appartenente alle Forze Armate (17).
Così, ad esempio, l’esimente dell’uso legittimo di armi,
che come visto circoscrive l’ambito dell’utilizzo della forza al ricorrere di determinate circostanze, qualora venisse
ritenuto non applicabile ai militari impegnati nelle missioni da ultimo ipotizzate, produrrebbe come conseguenza una “restrizione” delle cause di non punibilità concernenti il personale militare, con riduzione dei casi di legittimo uso della forza, poiché, pur potendosi paventare una
riespansione dell’esimente di diritto penale comune (art.
53 c.p.), l’operatività della stessa sarebbe tuttavia preclu-
1164
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
sa dalla mancanza della qualità di pubblico ufficiale in capo agli appartenenti alle Forze Armate (18).
Il problema è che sul punto si fronteggiano differenti ricostruzioni: quella secondo cui l’applicazione della legge
penale militare di guerra determinerebbe la temporanea
sospensione della legge penale di pace (19), e quella per
cui, stante il carattere di complementarietà della prima
rispetto alla seconda, ravvisa una contemporanea vigenza dei due complessi normativi, uno dei quali, quello di
guerra, contenente norme prevalenti perché speciali rispetto a quelle contenute in quello di pace e disciplinanti la stessa materia (20).
Siffatta seconda ricostruzione appare, a ben vedere, magNote:
(10) Disposizione che recita: “Il militare al quale venga impartito un ordine che non ritenga conforme alle norme in vigore deve, con spirito di
leale e fattiva partecipazione, farlo presente a chi lo ha impartito dichiarandone le ragioni, ed è tenuto ad eseguirlo se l’ordine è confermato”; come ha precisato attenta dottrina, D. Brunelli, Diritto penale militare, III
ed., 2002, 83, l’adozione della cautela, da parte dell’inferiore, dell’invito a
ri-badire l’ordine ricevuto e ritenuto di dubbia legittimità, consentirebbe
l’applicabilità dell’art. 51, ultimo comma, c.p., codificante una causa di
non punibilità.
(11) Cfr. art. 51, comma 3, c.p., “Risponde del reato altresì chi ha eseguito l’ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un
ordine legittimo”.
(12) Evidenzia D. Brunelli, Diritto penale militare, op. cit., 81, che in tema
di error iuris sulla legge penale, per il disposto dell’art. 5 c.p., come corretto dalla Corte costituzionale, «l’errore o l’ignoranza sul precetto rilevano
solo quando siano inevitabili, sicché al militare che non si rappresenti per
errore o ignoranza inevitabili la qualificazione giuridico-penale del proprio comportamento il fatto sarà imputato a titolo di dolo, sia pure sulla
base di un giudizio di rimproverabilità assimilabile a quello posto a fondamento dell’imputazione colposa».
(13) Sia consentito un richiamo a L. D’Angelo, Ordinamento militare, esimente dello stato di necessità e dovere di rischiare la vita, in questa Rivista,
2005, 109 ss.
(14) Fatta salva, in ogni caso, l’applicabilità delle disposizioni sullo ius in
bello concernente le regole che gli Stati devono rispettare nell’esercizio
della violenza bellica.
(15) Si pensi alla “battaglia dei ponti” svoltasi a Nassjria il 7 aprile 2004
per la quale sembrerebbe essere stato aperto un fascicolo presso la Procura Militare del Tribunale di Roma a seguito di esposti (cfr. Interrogazione
Parlamentare n. 3-03274 del 20 aprile 2004 e relativa risposta, in
www.parlamento.it).
(16) Ai militari impegnati nella missione in Iraq, in virtù del d.l. 10 luglio 2003, n. 165, convertito in l. 1° agosto 2003, n. 219, si applica il codice penale militare di guerra e l’art. 9 del d.l. 1° dicembre 2001, n. 421
convertito, con modificazioni, dalla l. 31 gennaio 2002, n. 6.
(17) Cfr. D. Brunelli, Diritto penale militare, op. cit., 84 ss., il quale osserva con
proprio con riferimento all’art. 41 c.p.m.p. che la norma riguarda più lo «statuto penale» del militare, che la specifica materia del diritto penale militare.
(18) Proprio la non configurabilità della qualità di pubblico ufficiale in
capo al personale militare, a meno di incarichi che attribuiscano specificatamente tale status (es. incarichi di polizia militare), ha indotto il legislatore militare del 1941 alla formulazione dell’art. 41 c.p.m.p.; in tal senso Brunelli, op. cit., 84-85.
(19) Venditti, Il diritto penale militare nel sistema penale italiano, I, Milano,
1995, 1 ss., tesi elaborata prima delle recenti modifiche al codice penale
militare di guerra le quali, ai fini dell’applicazione del medesimo, non richiedono più la dichiarazione dello stato di guerra.
(20) D. Brunelli, op. cit., 29 ss.
OPINIONI•DIRITTO PENALE
giormente condivisibile, ciò alla luce del diritto positivo
ed in particolare in forza dell’art. 19 c.p.m.p., a norma
del quale “Le disposizioni di questo codice si applicano
anche alle materie regolate dalla legge penale militare di
guerra e da altre leggi penali militari, in quanto non sia
da esse stabilito altrimenti”.
Pare potersi concludere, allora, che sia nel caso di applicazione del codice penale militare di pace, sia nell’ipotesi di applicazione di quello di guerra, per il tramite della
disciplina delle esimenti codificate, risulta possibile deli-
RIVISTE
neare il confine contenutistico delle R.O.E. ed, in particolare, la loro effettiva efficacia “esimente” (21), ciò in
relazione alla commissione di fatti di reato - anche di natura non militare - nell’ambito delle missioni all’estero.
Nota:
(21) In pratica valutando in concreto, anche alla luce delle indicazioni
giurisprudenziali offerte in sede di applicazione delle esimenti del codice
Rocco, l’ampiezza e la ricorrenza dei singoli elementi costitutivi delle varie cause di non punibilità.
Azienditalia
Mensile per gli enti locali e loro aziende
Coordinatore scientifico: Giuseppe Farneti
Periodicità: mensile
Azienditalia è il primo mensile che ha affrontato con taglio aziendale le problematiche gestionali degli enti locali, fornendo
le risposte più adeguate alle esigenze
informative degli operatori pubblici e dei
loro consulenti. Punto di forza della Rivista è l’estrema operatività dei contenuti:
la ricchezza dei casi pratici e delle soluzioni, gli esempi e i modelli presentati
consentono di affrontare e di risolvere
concretamente i problemi quotidiani della
gestione dell’Ente.
Bilancio e contabilità - Contabilità e bilanci secondo le regole dell'ordinamento finanziario e contabile.
Programmazione e controllo. Indicazioni
e strumenti per una corretta ed efficiente
programmazione, gestione e controllo dell’attività dell’ente.
Organizzazione - Strutture organizzative,
metodologie e procedure, norme, sistemi
di direzione: queste le leve per un efficace
funzionamento organizzativo dell'ente.
Servizi - Analisi, valutazioni e confronti delle diverse alternative di gestione dei servizi in termini di economicità, di efficienza
e di efficacia.
Revisione dei conti - Procedure di revisione e controllo, documenti, ruolo e responsabilità dei revisori.
Esperienze in...comune - Casi ed esperienze significative commentati dai più qualificati operatori del settore per verificare e
confrontare scelte e soluzioni nuove.
Documenti in sintesi - Rassegna ragionata delle principali novità legislative e di
prassi.
Adempimenti e scadenze - Il memo degli
appuntamenti mensili.
Quesiti - Il prestigioso pool di esperti
Azienditalia risponde ai quesiti dei lettori
attraverso le pagine della rivista.
Azienditalia - il Personale
Supplemento gratuito ad Azienditalia sulla
gestione e l’amministrazione del personale degli enti locali.
Il Personale affronta con regolarità i temi:
• Aspetti giuridico-contrattuali del rapporto di lavoro negli enti locali
• Trattamento economico, previdenziale e
contributivo
• Metodologie di valutazione e incentivazione
• Gestione delle risorse umane
• Novità normative, amministrative e giurisprudenziali
La formula Azienditalia Più
Un servizio esclusivamente riservato agli
abbonati della rivista Azienditalia che si
abbonino o convertano il loro abbonamento in questo particolare tipo di formula. Con la formula Azienditalia Più l’abbonato si assicura i fascicoli di Azienditalia –
I Corsi.
Azienditalia - I Corsi
Supplemento per gli abbonati ad Azienditalia Formula Più, I Corsi è un periodico di
aggiornamento e di formazione professionale sui temi più dibattuti e complessi della gestione degli enti locali.
Strutturato in lezioni, costituisce lo strumento più efficace per conoscere o approfondire la propria preparazione su specifiche tematiche grazie anche alla proposta di esempi e casi.
Il nuovo servizio on-line, riservato agli abbonati e compreso nel presso dell’abbonamento, è disponibile all’indirizzo
www.ipsoa.it/azienditalia.
Abbonamento annuale € 104,00
Abbonamento annuale Formula Più
€ 140,00
Per informazioni
• Servizio Informazioni Commerciali
(tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)
• Agente Ipsoa di zona (www.ipsoa.it/agenzie)
• www.ipsoa.it
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1165
OPINIONI•PROCESSO PENALE
Soggetti
Il regime dell’incompatibilità
a testimoniare nel processo
a carico degli enti
di ALESSANDRO DIDDI
Nel processo a carico degli enti la capacità di testimoniare del legale rappresentante è sottoposta ad una
speciale disciplina che, tuttavia, non copre l’intera casistica delle possibili situazioni nelle quali può trovarsi il soggetto che, al momento della acquisizione delle sue dichiarazioni, riveste la carica di amministratore
della società. Benché in tali ipotesi - in quanto non espressamente richiamate dalla norma che disciplina
l’incompatibilità a testimoniare - si possa ritenere che il legale rappresentante abbia il dovere di rispondere, ciononostante il diritto a non rendere dichiarazioni autoincriminanti sembrerebbe ostacolare una generalizzata applicazione di tale obbligo. La ricerca del punto di equilibrio tra le opposte esigenze, tuttavia, non
può prescindere dal differente modello di imputabilità della responsabilità dell’ente per il fatto dell’amministratore e per quello del dipendente da chi svolge funzioni apicali.
Le situazioni non comprese nell’art. 44
d.lgs. n. 231 del 2001
L’art. 44 d.lgs. n. 231 del 2001 stabilisce che non può assumere la qualità di testimone, oltre la persona imputata
del reato da cui dipende l’illecito amministrativo, anche
la persona che rappresenta l’ente e lo rappresentava al
momento del fatto.
Tale disposizione ha dato luogo ad alcune perplessitá interpretative in quanto se si selezionano le varie situazioni alle quali essa può trovare applicazione emergono alcuni casi che si pongono apparentemente fuori da suo
campo applicativo.
In effetti, da un esame anche superficiale la norma in
questione sembra applicarsi a due casi specifici.
Il primo, che non dà luogo ad eccessive difficoltà interpretative, è quello del rappresentante dell’ente che sia
sottoposto ad indagini per il reato da cui dipende l’illecito amministrativo contestato all’ente.
Tale situazione, richiamata anche dall’art. 39 come impeditiva alla costituzione dell’ente nel procedimento,
appare coerente con l’impianto del sistema se si considera che l’incompatibilitá di cui si tratta è certamente spiegabile come conseguenza del piú generale principio del
nemo tenetur se detegere che spetta all’imputato ai sensi
degli art. 64 e 197 c.p.p.. Infatti, quella dell’ente, pur
configurandosi come la responsabilità di un soggetto terzo rispetto a quella addebitata alla persona da cui dipende l’illecito amministrativo, è a questa strettamente connessa, comune essendo il nucleo fattuale (1), con la conseguenza che nel caso di specie deve trovare piena applicazione la disciplina della incompatibilità a testimonia-
1166
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
re prevista dal codice di procedura penale non potendosi costringere il legale rappresentante imputato del fatto
- reato da cui dipende la responsabilità amministrativa a
rendere una dichiarazione che avrebbe certamente un
contenuto autoaccusatorio (2).
La seconda situazione che si ricava immediatamente da
una lettura superficiale dall’art. 44 è quella del legale rappresentante non imputato che rivesta tale carica al momento della dichiarazione di cui all’art. 39. Rispetto ad
essa la norma prevede una estensione del principio del
nemo tenetur se detegere introducendo un’autonoma causa di incompatibilità a testimoniare che si aggiunge a
quelle previste dall’art. 197 c.p.p..
Tale disposizione, definita un autentico «rompicapo»
normativo (3), non appena si supera l’approccio della
interpretazione letterale, lascia trasparire una serie di difficoltá in quanto dalla griglia delle ipotesi disciplinate
dall’art. 44 d.lgs. n. 231 del 2001 restano fuori una serie
Note:
(1) P. Ferrua, Il processo penale contro gli enti: incorenze e anomalie nelle regole di accertamento, in AA.VV., Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reati, a cura di G. Garuti, Padova, 2002, 286.
(2) Secondo G. Paolozzi, Vademecum per gli enti sotto processo. Addebiti
“amministrativi” da reato (d.lgs. n. 231 del 2001), Torino, 2005, 158, la persona fisica autrice del reato si colloca in una posizione corrispondente a
quella del coimputato nel medesimo reato.
(3) A. Bernasconi, I profili della fase investigativa e dell’udienza preliminare,
in AA.VV., Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi, cit., 286.
Critiche a tale disposizione sono state sollevate un po’ da tutti gli autori
che si sono soffermati si tale disposizione. Cfr., recentemente, G. Paolozzi, op. cit., 157
OPINIONI•PROCESSO PENALE
di casi rispetto ai quali, in base all’argomento dell’ubi lex
noluit tacuit, si dovrebbe affermare l’obbligo di testimoniare.
La prima di tali ipotesi, è quella del legale rappresentante indicato nella dichiarazione di costituzione ex art. 39
che non rivestiva alcuna carica al momento del fatto.
Tale caso, che si ricava, come detto, a contrario da entrambe le cause di incompatibilità disciplinate dall’art.
44 cit., ricorre allorquando sia chiamato a rispondere il
soggetto che, dopo la commissione del fatto da cui dipende la responsabilità amministrativa dell’ente, sia subentrato a quello che rivestiva la qualifica di legale rappresentante al momento del fatto. Esso, però, si può concretamente applicare a due differenti situazioni: al legale
rappresentante che sia stato avvicendato in quanto imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo;
ovvero al legale rappresentante che subentra nella funzione di altro non imputato.
Stando al suo tenore letterale, l’art. 44, infatti, stabilisce
che il rappresentante legale (e, per il suo tramite, l’ente)
perde la facoltá di non rispondere (che discenda da
quanto prevede l’art. 44 comma 2) non essendo configurabile nei suoi confronti alcuna situazione di incompatibilità (4). Ad un primo esame tale previsione non sembra priva di conseguenze sul piano della tutela dei diritti
di difesa che, in altri momenti, paiono attentamente salvaguardati dal legislatore e che non potrebbero non essere affermati rispetto ad un soggetto che partecipa alla
vicenda processuale come destinatario di un possibile
trattamento sanzionatorio.
Dall’esame dell’ambito di operatività dell’art. 44 emerge
che vi sono almeno altre due situazione da considerare.
La prima, è quella del legale rappresentante al momento
del fatto, non imputato nel reato da cui dipende la responsabilità amministrativa dell’ente, che, tuttavia, non
ricopra piú la carica al momento della dichiarazione di
costituzione ex art. 39.
È da chiedersi se tale soggetto conservi la facoltá di non
rispondere ovvero, se, per effetto del venir meno del suo
rapporto organico con l’ente, perda la facoltá di non rispondere.
La seconda, infine, è quella del legale rappresentante il
quale, pur essendo stato imputato nel reato da cui dipende la responsabilità amministrativa, abbia definito (perché ad esempio abbia chiesto l’applicazione della pena)
la sua vicenda processuale con sentenza definitiva. Mentre, infatti, l’art. 197 c.p.p. (sempre che al dichiarante sia
stato rivolto in precedenza l’avviso ex art. 64 comma 3
c.p.p.) sembrerebbe escludere la sussistenza di una causa
di incompatibilità, l’art. 44 parrebbe ammetterne una
autonoma che, in virtù del principio di specialità, prevarrebbe sulla prima.
In sintesi, debbono essere considerate le seguenti situazioni con riferimento alle quali ricostruire il regime di dichiarazione: a) legale rappresentante che abbia sostituito quello imputato per il fatto dal quale dipende la responsabilità dell’ente; b) legale rappresentante che su-
bentri nella funzione di altro non imputato; c) legale
rappresentante al momento del fatto non imputato del
reato da cui dipende la responsabilità amministrativa
dell’ente e che non ricopra più la carica al momento della dichiarazione di costituzione e, infine, d) legale rappresentante imputato per il fatto da cui dipende la responsabilità amministrativa che abbia definito la sua posizione.
La posizione del nuovo legale rappresentante
che abbia sostituito quello precedente imputato
La prima situazione sulla quale si deve concentrare l’attenzione e sulla quale si è principalmente soffermata la
dottrina è quella dell’ente che abbia sostituito il proprio
legale rappresentante dopo la consumazione del fatto reato da cui dipende la sua responsabilità amministrativa.
Le ragioni per le quali tale situazione desta alcune perplessità vanno ravvisate nel fatto che poiché l’incompatibilitá discende dalla duplice condizione che il soggetto
fosse legale rappresentante al momento del fatto e lo sia
all’atto della dichiarazione di costituzione ex art. 39,
stando alla lettera dell’art. 44 d.lgs. n. 231 del 2001, in
tutti i casi di sostituzione dell’organo rappresentativo (a
prescindere dalle ragioni per le quali ció sia avvenuto)
verrebbe meno la prevista causa ostativa all’obbligo di
testimonianza.
La ratio ispiratrice della norma è certamente chiara e risponde alla esigenza di impedire manovre elusive dell’obbligo di testimonianza attraverso il conferimento di
opportuni incarichi rappresentativi a chi sia a conoscenza di circostanze rilevanti per la ricostruzione del fatto da
cui dipende l’illecito e, dunque, sia destinato ad assumere la veste di testimone nel processo.
Ciò non ostante, occorre chiedersi se tutto ciò non provochi una frattura nei diritti di difesa che sono riconosciuti all’ente il quale compare sulla scena processuale
come soggetto necessario del contraddittorio, che si aggiunge all’imputato e che, ai sensi dell’art. 35, gode dei
suoi stessi diritti (5).
Al riguardo, infatti, si deve considerare che poiché l’art.
39 impedisce all’ente rappresentato dal soggetto imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo di
costituirsi nel procedimento, l’ente medesimo, per poter
esercitare il diritto di essere parte nel processo, sarebbe
obbligato a nominare un soggetto che, potenzialmente,
in quanto non più assistito dalla garanzia dell’incompatibilità, sarebbe testimone della responsabilità dell’ente.
Ancorché rispetto a tale fenomenologia si possano rinNote:
(4) A. Scalfati, Le norme in materia di prova e di giudizio, in AA.VV., Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi, cit., 353.
(5) Ritengono discutibile lo schema in questione un po’ tutti gli A. che si
sono soffermati su tale disposizione. Cfr. P. Ferrua, op. cit., 234 e ss.; A.
Scalfati, op. cit., 353 e, da ultimo, G. Paolozzi, op. cit., 160 il quale preconizza, sul punto, un intervento della Corte costituzionale.
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1167
OPINIONI•PROCESSO PENALE
venire pregiudizi per il diritto di difesa, in quanto l’ente
sarebbe in concreto posto nella situazione di rinunziare
a difendersi o di perdere il privilege against self incrimination (6), a ben guardare le regole che si ricavano dall’art.
39 e 44, rispettivamente in tema di costituzione dell’ente e di incompatibilità a testimoniare, rispondono esattamente al medesimo principio che riflette il peculiare
regime di responsabilità che deriva, nel caso in cui l’ente sia chiamato a rispondere di responsabilità amministrativa per un fatto commesso dal proprio legale rappresentante, dal combinato disposto degli artt. 5 e 6
d.lgs. n. 231 del 2001.
A differenza, infatti, della responsabilitá per fatto
commesso dalle persone sottoposte al potere di direzione e vigilanza nel quale l’esistenza e l’idoneitá del
modello organizzativo, ai sensi dell’art. 7, costituisce
un elemento della fattispecie e che, secondo le normali regole di distribuzione dell’onere probatorio, deve
essere dimostrato dall’accusa, lo schema di responsabilità delle persone che rivestono una posizione apicale
(e, dunque, che rivestono la posizione di cui agli artt.
39 e 44 d.lgs. n. 231 del 2001) è, invece, strutturato in
termini opposti in quanto l’art. 6 prevede che l’ente si
puó liberare dalla sua responsabilità se prova che il responsabile legale ha commesso la violazione contestata in quanto, pur in presenza di adeguato modello organizzativo, lo abbia fraudolentemente violato (così,
art. 6 lett. c).
È, allora, del tutto ovvio che l’ente non si possa costituire con il suo legale rappresentante imputato del reato dal
quale dipende l’illecito amministrativo in quanto costui,
per “liberare” l’ente da responsabilità, dovrebbe provare
la sua stessa responsabilità dimostrando che il fatto è stato commesso in quanto egli non ha dotato la struttura di
un valido modello organizzativo ovvero in quanto lui
stesso lo ha fraudolentemente violato. Siffatta dichiarazione, evidentemente, non gli sarà impedita anche se,
stante il contenuto sostanzialmente confessorio, la veste
con la quale essa può manifestarsi nel processo non è certamente di carattere testimoniale.
Del resto, si deve tenere conto del fatto che gli amministratori sono nominati dall’assemblea e che se essa, di
fronte ad un’azione illecita che determina conseguenze
pregiudizievoli sul patrimonio dell’ente e, dunque, di riflesso su quello dei soci, non ritiene di sostituire la persona che ha coinvolto, con la sua condotta, l’ente medesimo nel procedimento, quest’ultimo non puó certamente dolersi per il fatto di non potersi costituire in giudizio in quanto, con il mantenimento dell’amministratore nella sua carica, l’assemblea finisce per ribadire fiducia al soggetto che riveste la posizione apicale rimettendosi alla sua difesa, in sostanza, per andare esente da
responsabilità.
In sintesi, se il legale rappresentante che è espressione
dell’organo sociale, non è sostituito, ció significa che
l’ente, come soggetto autonomo, non ha interesse a fornire la prova impeditiva della propria estraneitá e, dun-
1168
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
que, subirá gli effetti della decisione che verrá adottata
nei confronti dell’imputato.
Tornando, allora, al problema della applicabilità dell’incompatibilitá a testimoniare ex art. 44 al legale rappresentante subentrato a quello imputato del fatto reato da
cui dipende la responsabilitá amministrativa dell’ente, si
può osservare come, alla luce di tali considerazioni, possano ritenersi superati tutti i dubbi manifestati con riferimento alla compatibilità della disciplina adottata dal
legislatore ora con l’inviolabilità del diritto di difesa, ora
con il principio di ragionevolezza.
Al riguardo, occorre tornare al profilo già richiamato, in
quanto se il soggetto che è subentrato era a conoscenza,
prima dell’assunzione della carica, di circostanze rilevanti
per la ricostruzione del fatto - reato e per quello da cui
dipende la responsabilità dell’ente, è ovvio che costui sarebbe stato un dichiarante contro l’ente in ogni caso (a
prescindere cioè dal suo ruolo all’interno dell’azienda) e,
dunque, appare del tutto coerente che quella qualitá esso continui a mantenere anche laddove assumesse su di
sé, oltre a quella di testimone, anche la carica di legale
rappresentante dell’ente.
Il secondo, è che se l’ente ha sostituito il legale rappresentante in quanto imputato del fatto da cui dipende la
sua imputabilità amministrativa ponendosi nella condizione di potersi costituire nel procedimento, vuol dire
che, in concreto, l’ente stesso non solo ha deciso di prendere le distanze dal precedente organo amministrativo,
ma vuole trovarsi nella situazione di poter fornire l’unica
prova impeditiva che, ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 231 del
2001, gli consente di liberarsi dalla responsabilità ed è
dunque coerente che, rispetto alla posizione del precedente amministratore, il nuovo non possa godere dei diritti che spettano all’imputato.
Viceversa, è da chiedersi cosa accada se il legale rappresentante abbia appreso circostanze o fatti dopo l’investitura nella carica. Si tratta, infatti, di una situazione diversa
dalla precedente e che sembra potersi risolvere facendo
riferimento, piuttosto che alla disciplina della testimonianza, a quella dell’imputato.
Sebbene, in concreto, rispetto alla responsabilità amministrativa, il caso da ultimo richiamato potrebbe non
prospettarsi in quanto, secondo lo schema di imputabilitá concepito dal legislatore, in relazione al fatto del dirigente, l’ente che si costituisce nel processo è chiamato
a dare la prova di una responsabilità del precedente legale rappresentante per elusione del modello organizzativo
e per il conseguimento di un vantaggio personale e,
Nota:
(6) Anche rispetto all’art. 39, infatti, si potrebbe adombrare un momento di frattura nei diritti di difesa dell’ente, salvo concepirsi, come sembrerebbe desumersi dalla Relazione allo schema di decreto legislativo recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società
e delle associazioni anche prive di personalità giuridiche, par. III, 15.2, una nomina ad acta per la costituzione di cui all’art. 39, secondo un modello, peraltro, adottato da altri ordinamenti come quello svizzero (cfr. art. 100quinquies comma 3 c.p.).
OPINIONI•PROCESSO PENALE
dunque, di un fatto non autoincriminante, non si puó,
comunque, non osservare che l’equiparazione ente - imputato contenuta nell’art. 35 d.lgs. n. 231 del 2001, comporti l’estensione degli stessi diritti e delle stesse garanzie
a chi nel processo rappresenta l’ente (7). Se, dunque, il
nuovo legale rappresentante ha appreso notizie dopo il
fatto e per effetto del suo rapporto organico con l’ente,
stante la posizione di parte che quest’ultimo assume nel
processo, ad esso non potrebbe non essere riconosciuto il
privilege against self incrimination.
La posizione del nuovo legale rappresentante
che abbia sostituito quello precedente non imputato
Come evidenziato in premessa, dal quadro normativo è
possibile enucleare anche un’altra situazione: quella cioè
del legale rappresentante subentrato a quello che, non
imputato, è sottoposto al regime di incompatibilità di
cui all’art. 44. Infatti, poiché l’incompatibilitá spetta solo a chi rivestiva la funzione al momento del fatto ed a
chi la riveste al momento della dichiarazione di cui all’art. 39, ció sta a significare che, se prima dell’apertura
del procedimento vi è stata una successione nelle cariche sociali, nessuno potrebbe cumulare su di sé le due
condizioni da cui dipende l’incapacità di testimoniare
con la conseguenza che il legale rappresentante successivamente nominato perderebbe in ogni caso la facoltá riconosciuta dalla legge di avvalersi della facoltá di non rispondere.
Così circoscritto, il problema potrebbe essere, in concreto, particolarmente rilevante rispetto alla responsabilità
dell’ente per le persone che non rivestono una posizione
apicale e, dunque, per il modello di responsabilità di cui
all’art. 7 d.lgs. n. 231 del 2001.
In effetti, in questo caso, la prova della carenza della
struttura organizzativa spetta al pubblico ministero e
questi potrebbe rinvenire nella dichiarazione del legale
rappresentante, dunque di una persona intranea all’ente,
gli elementi per sostenere la prova costitutiva della responsabilità amministrativa.
In una simile situazione, dunque, se al legale rappresentante non fosse riferibile alcuna causa di incompatibilitá,
costui potrebbe essere obbligato a rendere dichiarazioni
contro l’ente.
Tuttavia, anche in questo caso, se si considerano i precedenti rilievi, il fatto che possa testimoniare il nuovo legale rappresentante non dovrebbe destare particolari
perplessità.
Ancora una volta, infatti, è dirimente osservare che se la
persona che ha assunto la carica era testimone contro
l’ente prima della nomina a legale rappresentante, poiché nei suoi confronti non esisteva, prima di quella investitura, alcuna situazione di incompatibilità non puó
essere certamente la sopravvenuta acquisizione di un potere di rappresentanza a modificarne il regime di dichiarazione fermo restando, ovviamente, quanto precisato in
precedenza con riferimento al soggetto che sia succeduto nella carica a quello direttamente coinvolto nella vi-
cenda processuale per il fatto da cui dipende l’illecito
amministrativo.
Nonostante il silenzio della legge, infatti, si deve ammettere che siccome l’ente gode, ai sensi dell’art. 35, dei
diritti riservati dell’imputato, il legale rappresentante
successivamente nominato non potrà essere obbligato a
rispondere su fatti diversi da quelli appresi allorquando
non era amministratore.
La posizione del legale rappresentante
(non imputato) al momento del fatto
che non ricopra più la carica
al momento dell’apertura del procedimento
Qualche difficoltà, invece, fa sorgere la terza situazione
evidenziata, quella cioè del legale rappresentante che
non sia piú tale al momento dell’instaurazione del procedimento e che non abbia mai rivestito la qualità di imputato. Costui deporrebbe nel processo per fatto del dipendente (e pertanto dovrebbe essere considerato dotato di capacità a testimoniare); al contempo, avendo dismesso la carica prima del procedimento non potrebbe
fare la dichiarazione di costituzione ex art. 39 e pertanto
non si troverebbe nella condizione prevista dall’art. 44
comma 1 lett. b d.lgs. n. 231 del 2001.
Stando alla lettera del disposto testè richiamato, egli
non si potrebbe avvalere della causa di incompatibilità e
verrebbe privato della facoltá di non rispondere con possibili ripercussioni personali legate alla sua responsabilità
nei confronti dell’ente da lui in precedenza rappresentato (8).
Tuttavia, basta pensare che quest’ultimo, dovendo rispondere ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 231 del 2001 sulla
idoneità del modello organizzativo adottato e delle misure per garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge, verrebbe chiamato a deporre su carenze
organizzative che lui stesso avrebbe dovuto eliminare e,
dunque, su un fatto proprio, per rendersi conto come siffatta soluzione non appaia ragionevole. Rispetto a tale
situazione pare necessario procedere ad un’interpretazione estensiva di quanto previsto dall’art. 44 anche perché
non è giustificabile che l’incompatibilitá venga ad essere
collegata ad una situazione di fatto, il rivestire la qualitá
di legale rappresentante al momento della dichiarazione
ex art. 39, del tutto casuale dipendente dalla iniziativa
del pubblico ministero di aprire un procedimento a carico dell’ente.
Posizione del legale rappresentante
che abbia definito il processo a suo carico
Deve, da ultimo, essere considerata la situazione dell’imNote:
(7) P. Ferrua, op. cit., 234 e M. Ceresa Castaldo, L’accertamento dell’illecito, in S. Vinciguerra-M. Ceresa Castaldo-A. Rossi, La responsabilitá dell’ente per il reato commesso nel suo interesse (d.lg.vo231/2001), Padova,
2004, 122.
(8) In questo senso, G. Paolozzi, op. cit., 164.
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1169
OPINIONI•PROCESSO PENALE
putato, legale rappresentante dell’ente, il quale abbia definito il suo processo con sentenza definitiva e, dunque,
venga chiamato a rendere dichiarazioni nel processo separato a carico dell’ente.
La situazione si puó verificare per varie ragioni in quanto, benché il d.lgs. n. 231 del 2001 abbia previsto che, in
linea di massima, il processo a carico dell’ente e quello a
carico dell’imputato si celebrino simultaneamente, varie
sono le ragioni che possono determinare una separazione (basti pensare, tra le tante, alla sospensione in attesa
dell’attuazione delle condotte riparatorie; alla impossibilità di eseguire le notifiche nei confronti dell’ente ovvero alla scelta da parte dell’imputato di un rito alternativo).
L’art. 197 c.p.p., al riguardo, stabilisce che, nel caso in
cui l’imputato venga raggiunto da decisione irrevocabile, cessa la situazione di incompatibilità a testimoniare.
Appare ovvio però che, in questo caso, poiché il soggetto sarebbe comunque chiamato a rispondere per un fatto proprio, in quanto da quest’ultimo dipende l’illecito
amministrativo e, dunque, il nesso tra i due illeciti è riconducibile allo schema di cui all’art. 12 lett. a c.p.p., allo stesso non potrebbero non essere assicurate le garanzie
di cui all’art. 197-bis s.c. tra le quali, appunto, la previsione della facoltà di non rispondere sui fatti per i quali è
stata pronunziata sentenza di condanna se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione (9).
Conclusioni
Per ricomporre il mosaico delle diverse situazioni contemplate dall’art. 44, emerge, anzitutto, che le due diverse cause di incompatibilità sono inscindibilmente legate
al differente modello da cui, secondo gli artt. 6 e 7 d.lgs.
n. 231 del 2001, dipende la responsabilità amministrativa dell’ente e, segnatamente, quello per il fatto del legale rappresentante e quello per il fatto del soggetto dipendente da colui il quale svolge funzioni apicali.
La previsione di incompatibilità a testimoniare per l’imputato del fatto-reato da cui dipende l’illecito amministrativo, è essenzialmente posta a tutela di quest’ultimo
ed è legata alla considerazione che l’ente, per andare
esente da responsabilità, deve sostanzialmente dimostrare che il fatto non è avvenuto nel suo interesse (e, dunque, che l’amministratore lo ha fatto per conseguire un
suo vantaggio personale) o che l’amministratore ha fraudolentemente eluso il modello organizzativo. In un simile contesto di dinamiche probatorie, è ragionevole che
l’imputato per il fatto da cui dipende l’illecito amministrativo non sia obbligato a rendere una dichiarazione
contra se.
La previsione di incompatibilità a testimoniare del legale rappresentante al momento del fatto, invece, è posta a
tutela dell’ente in quanto, siccome l’affermazione della
responsabilità per illecito amministrativo postula la dimostrazione della carenza del modello organizzativo
adottato dall’amministrazione dell’ente, si è inteso impe-
1170
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
dire che la persona che svolge una posizione apicale debba essere obbligato a rendere dichiarazioni “autoincriminanti”.
Identica la disciplina delle situazioni, non immediatamente riconducibili alle due previsioni espressamente
disciplinate, vale a dire: a) quella del legale rappresentante che sia succeduto nella carica al posto di quello
imputato; b) quella del legale rappresentante che sia subentrato a quello imputato (e che dunque è chiamato a
testimoniare sul fatto del dipendente da chi riveste una
posizione apicale). In entrambi i casi, infatti, il soggetto
che viene chiamato a ricoprire la carica se era a conoscenza di circostanze o fatti utili per la ricostruzione della responsabilità dell’ente prima dell’assunzione della
funzione e, dunque, era un potenziale teste a carico dell’ente, non è irragionevole che quella veste conservi anche dopo l’assunzione della stessa. Se, invece, nessuna
circostanza conosceva prima, è chiaro che la sua posizione riflette quella (equiparata all’imputato) che assume
l’ente nel processo.
Restano, tuttavia, alcuni vuoti nella disciplina di cui all’art. 44 d.lgs. n. 231 del 2001 non tutti agevolmente colmabili.
Il primo, è quello dell’imputato che, avendo definito la
sua posizione con sentenza definitiva, abbia perso la incompatibilità a testimoniare. In questo caso, la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 231 del 2004 sembra poter essere integrata con quella di cui all’art. 197-bis c.p.p.
Il secondo, è quello del legale rappresentante che abbia
acquisito notizia del fatto in seguito e per effetto del suo
rapporto organico con l’ente. Nonostante il silenzio della legge, in tale ipotesi la disciplina applicabile potrebbe
essere quella dell’art. 64 c.p.p. applicabile, ai sensi dell’art. 35, all’organo che rappresenta la parte nel processo.
L’ultimo caso da considerare è quello del legale rappresentante (evidentemente non imputato) che abbia perso la carica prima della dichiarazione ex art. 39. Si tratta
della situazione più delicata perché, a meno di una interpretazione analogica dell’art. 44, l’ente, senza alcuna
giustificazione, verrebbe a perdere qualsiasi garanzia
contro dichiarazioni autoincriminati.
Nota:
(9) In senso sostanzialmente analogo, G. Paolozzi, op. cit., 158 e 165 e P.
Ferrua, op. cit., 234.
GIUSTIZIA SOVRANAZIONALE•OPINIONI
Corte di giustizia delle Comunità europee
Il ne bis in idem e Corte di giustizia:
ancora un chiarimento sulla nozione
di “sentenza definitiva”
di ANNA FABBRICATORE
Il principio del ne bis in idem, sancito dall’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, non si applica ad una decisione dell’autorità giudiziaria di uno Stato membro che dichiara chiusa una
causa dopo che il pubblico ministero ha deciso di non proseguire l’azione penale per il solo motivo che è stato avviato un procedimento penale in un altro Stato membro a carico dello stesso imputato e per gli stessi
fatti, senza alcuna valutazione di merito.
Nel merito: i problemi interpretativi legati alla nozione
di ne bis in idem internazionale
Con la sentenza del 10 marzo 2005 (1) i giudici della
Corte di giustizia CE hanno fornito un importante contributo chiarificatore circa la nozione di “sentenza definitiva”, ai fini dell’applicazione del principio del ne bis in
idem comunitario.
Il principio in questione individua, com’è noto, il caratteristico effetto preclusivo del giudicato penale in forza
del quale una persona, che sia stata oggetto di una sentenza irrevocabile, non può essere sottoposta ad un nuovo procedimento per lo stesso fatto.
Quasi tutti gli ordinamenti - sia di common law sia di civil law - riconoscono l’operatività del ne bis in idem in ambito interno (2); al contrario, nei rapporti tra tribunali di
Stati diversi, il giudicato straniero non gode della stessa
efficacia preclusiva; questo perché ciascun ordinamento
giuridico è autonomo ed indipendente rispetto agli altri
e tale autonomia implica che non vi sia la necessità di
evitare un contrasto tra giudicati (3).
Se queste considerazioni godono di un qualche pregio, occorre tuttavia ricordare che vi sono numerose
convenzioni che prevedono espressamente l’applicazione del principio del ne bis in idem anche al di fuori
dei confini territoriali (4). In particolare, per quanto
riguarda l’area europea, l’art. 54 della Convenzione di
applicazione dell’Accordo di Schengen (5), stabilisce
che una persona giudicata con sentenza definitiva in
uno Stato aderente alla citata convenzione non può
essere sottoposta a procedimento penale, per i medesimi fatti, in un altro Paese contraente (6). In altre
Note:
(1) CGCE, Sez. V, 10 marzo 2005, C-469-03, Miraglia. Per il testo integrale della sentenza, v. www.ipsoa.it/cnf/upload/P42_cortedigiustizia-
CE100305_469.pdf e, per una breve sintesi, v. in questa Rivista, 2005,
520.
(2) Occorre precisare che nei Paesi di tradizione continentale il passaggio
in giudicato della sentenza segna il momento a partire dal quale si verifica l’effetto preclusivo. Al contrario, nei sistemi di common law, il divieto
di double jeopardy è opponibile a prescindere dal completo esaurimento
dei ricorsi. Si veda G. Fletzer, La garanzia del ne bis in idem ed il divieto della double jeopardy, in Ind. pen., 1970, 123 ss.
(3) Il principio del ne bis in idem internazionale non è considerato un
principio di diritto internazionale generalmente riconosciuto. In questo
senso si è espressa Corte cost. 18 aprile 1967, n. 48, in Giur. cost., 1967,
301 ss., con nota di M. Chiavario, La compatibilità del “ne bis in idem” previsto dall’art. 11 comma primo c.p. con il diritto internazionale generalmente
riconosciuto ed, altresì, nella sentenza Corte cost. 8 aprile 1976, n. 69, in
Foro it. 1976, I, 1451. Inoltre, con la decisione del 2 novembre 1987 (in
Ind. pen. 1988, 124 ss.) lo stesso Comitato dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite ha precisato che il divieto del ne bis in idem, espresso all’art.
14 par. 7 Patto int. dir. civ. e pol., considera esclusivamente «i rapporti interni tra le decisioni giudiziarie di un medesimo Stato e non tra quelle di
Stati diversi».
(4) A questo proposito, tra i più importanti accordi che disciplinano il
principio del ne bis in idem a livello internazionale, si segnalano: la Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra nel 1951; la Convenzione
unica sugli stupefacenti del 1961; la Convenzione europea sulla validità
internazionale dei giudizi repressivi del 1970; la Convenzione europea sul
trasferimento dei procedimenti penali del 1972.
(5) La Convenzione applicativa dell’Accordo di Schengen fa parte dell’acquis di Schengen. Il Consiglio europeo, con le decisioni 1999/435/CE
e 1999/436/CE, ha definito nei dettagli il contenuto del suddetto acquis e
ne ha individuato la base giuridica in alcune disposizioni del Titolo VI
Trattato UE. Pertanto, per effetto del Trattato di Amsterdam, l’acquis di
Schengen è stato integrato nell’ambito dell’Unione europea. V. anche la
pubblicazione del Consiglio, L’acquis di Schengen. Raccolta delle decisioni e
delle dichiarazioni adottate dal Comitato esecutivo nel quadro intergovernativo
di Schengen ed integrate nell’UE, Bruxelles 1999, consultabile in
http://ue.eu.int/jai/schengen/SCH.ACQUIS-it.pdf.
(6) Si riporta di seguito il testo dell’art. 54 della Convezione di applicazione di Schengen: «una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente a condi(segue)
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1171
GIUSTIZIA SOVRANAZIONALE•OPINIONI
parole questa disposizione fa si che, nel contesto politico - geografico di Schengen, una sentenza definitiva
pronunciata dall’autorità giudiziaria di uno Stato
membro è idonea a produrre un effetto preclusivo
analogo a quello della sentenza emessa da un giudice
nazionale.
Come avremo modo di precisare in seguito il riconoscimento del principio del ne bis in idem in ambito europeo
è significativo per la costruzione di uno spazio giudiziario
unitario e rappresenta indubbiamente una garanzia per
la libera circolazione delle persone. Allo stesso tempo
però occorre tenere presente che l’art. 54 della Convenzione di Shenghen non indica esattamente quale significato si debba attribuire a nozioni quali «identità del fatto» (7), ovvero «sentenza definitiva». Questi concetti,
che sono essenziali per definire concretamente l’ambito
applicativo del principio del ne bis in idem, sono suscettibili di essere interpretati in maniera diversa all’interno
dell’ordinamento in cui si è formato il giudicato ed, altresì, nel Paese destinato a subire l’effetto preclusivo della sentenza straniera.
Queste pur brevi considerazioni fanno da sfondo alla vicenda processuale che ha dato origine alla pronuncia
della Corte di giustizia e sulla quale pare opportuno
spendere qualche parola al fine di comprendere meglio i
termini della problematica in oggetto.
Nel 2001 le autorità italiane e quelle olandesi hanno avviato un’indagine nei confronti di un cittadino italiano,
il Sig. Miraglia, accusato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. In seguito a tali fatti il tribunale di
Bologna ha disposto il rinvio a giudizio del predetto imputato.
In conseguenza di questo provvedimento la procura di
Amsterdam ha archiviato il procedimento penale nei
confronti di Miraglia, appunto perché - per i medesimi
fatti - era già stata intrapresa in Italia un’azione penale.
Un anno dopo, nel novembre 2002, le autorità italiane hanno presentato all’Olanda una richiesta di assistenza giudiziaria, che però è stata respinta sulla base
dell’art. 552 comma 1 c.p.p. olandese, il quale consente di rifiutare una rogatoria, allorché l’accoglimento di questa contrasti con l’art. 255 c.p.p. olandese e
cioè riguardi «un’istruttoria concernente fatti relativamente ai quali l’imputato è già stato perseguito nei
Paesi Bassi» (8).
Il caso in esame costituisce un chiaro esempio di come
un contrasto interpretativo intorno alla nozione di “sentenza definitiva” sia suscettibile di determinare un empasse nello svolgimento di una inchiesta condotta dalle
autorità giudiziarie di Stati diversi. Il tribunale di Bologna, infatti, qualora avesse accolto l’interpretazione del
principio del ne bis in idem fornita dalla procura di Amsterdam, avrebbe dovuto rinunciare all’assistenza giudiziaria di questo paese e, il che è lo stesso, a perseguire penalmente il Sig. Miraglia.
D’altra parte, la chiusura del procedimento - pur in assenza di una valutazione nel merito - è considerata dal-
1172
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
l’art. 255 c.p.p. olandese equivalente ad una decisione
“definitiva”, che impedisce la collaborazione con le autorità straniere che abbiano instaurato dei processi penali nei confronti dello stesso imputato e per i medesimi
fatti (9).
In questo contesto la decisione della Corte di giustizia
delle comunità europee, resa a titolo pregiudiziale sulla
base del Titolo VI del Trattato sull’Unione europea, si
apprezza in tutta la sua importanza. I giudici di Lussemburgo - in un’ottica di salvaguardia delle legittime pretese punitive dei diversi Paesi - hanno infatti rigettato l’interpretazione del principio del ne bis in idem prospettata
dall’Olanda ed hanno chiarito che l’art. 54 della Convenzione di Shengehen non può trovare applicazione
«allorché le autorità giudiziarie di uno Stato membro dichiarino chiusa la causa dopo che il Pubblico Ministero
ha deciso di non proseguire l’azione penale per il solo
motivo che è stato avviato un procedimento penale in
un altro Stato membro a carico dello stesso imputato e
Note:
(continua nota 6)
zione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato
contraente di condanna, non possa più essere eseguita».
(7) Sulla nozione di «identità del fatto» si appuntano problemi interpretativi di non poco momento. In particolare, ci si chiede se tale concetto
debba essere inteso in senso materiale o in senso giuridico. L’art. 54 della
Convenzione di Shenghen, nelle diverse traduzioni ufficiali, consente di
ritenere legittime entrambe queste interpretazioni. Nel testo inglese si
parla, infatti, di divieto del doppio processo per le medesime “offences”.
Al contrario, nei testi ufficiali francese, italiano, olandese e tedesco viene fatto riferimento ai medesimi “fatti”. Per un maggiore approfondimento del tema v. Ch. Van den Wyngaert-G. Stessens, The International
Non Bis In Idem Principle: resolving some of unanswered questions, in International and Comparative Law Quarterly, 1999, 779 ss.
(8) Vale la pena di precisare che la Convenzione europea di assistenza
giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile del 1959,
non pone un collegamento diretto fra cooperazione giudiziaria e divieto di rinnovamento del processo in idem, così come previsto, ad esempio, da alcuni accordi bilaterali quali quello tra Italia e Australia del
1985, ovvero, tra Italia e Brasile del 1989. Tuttavia alcuni Paesi europei
aderenti alla Convenzione hanno dichiarato di rifiutare la propria collaborazione tutte le volte in cui questa risulti incompatibile con il principio del ne bis in idem. In particolare il Regno dei Paesi Bassi si è riservato di non dar luogo ad una domanda di assistenza giudiziaria (…)
«nella misura in cui essa riguarda un’accusa o un procedimento penale
incompatibile con il principio del “ne bis in idem”» ovvero «nella misura in cui essa riguarda un’indagine su fatti per i quali la persona accusata di reato è perseguita nei Paesi Bassi». Cfr. M. Pisani-F. Mosconi-D.
Vigoni, Codice delle Convenzioni di estradizione e di assistenza giudiziaria in
materia penale, Milano, 2004, 588 ss. L’art. 552 comma 1 c.p.p. olandese è evidentemente collegato a questa riserva formulata dall’Olanda in
sede di ratifica.
(9) L’art. 255 c.p.p. olandese dispone che «L’imputato, dopo l’archiviazione del procedimento a suo carico, dopo la notifica dell’ordinanza con
la quale si dichiara che la causa è chiusa, o dopo la notifica nei suoi confronti della cessazione di ogni ulteriore procedimento, non può nuovamente essere oggetto di azione penale per lo stesso fatto, salvo che non
emergano nuovi elementi a suo carico». In sostanzia, per il diritto processuale penale olandese, la chiusura del procedimento, pur in assenza di
valutazione sul merito, equivale ad una sentenza definitiva ed è idonea a
produrre un effetto preclusivo in idem.
GIUSTIZIA SOVRANAZIONALE•OPINIONI
per i medesimi fatti, senza alcuna valutazione nel merito» (10).
Questo significa che l’effetto preclusivo del giudicato
straniero, a prescindere da ogni eventuale diversa qualificazione degli ordinamenti interni, si verifica solo quando vi sia stata una valutazione effettiva sulla penale responsabilità dell’imputato.
I precedenti giurisprudenziali. La nozione europea
di “sentenza definitiva”
La sentenza in esame è la seconda pronuncia della
Corte resa a titolo pregiudiziale sulla base del Titolo
VI Trattato UE. Si tratta della competenza prevista
dall’art. 35 Trattato UE, ai sensi del quale la Corte di
giustizia è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale «sulla validità o l’interpretazione delle decisioniquadro e delle decisioni, sull’interpretazione di convenzioni stabilite ai sensi del presente titolo e sull’interpretazione delle misure di applicazione delle stesse» (11).
In passato i giudici di Lussemburgo sono stati investiti di
un rinvio interpretativo riguardante ugualmente la nozione di “sentenza definitiva” ai fini dell’applicazione
dell’art. 54 della Convenzione di Shenghen (12). In particolare, la Corte era stata chiamata a decidere se, nella
nozione di “decisione finale”, dovessero essere compresi
anche i provvedimenti per mezzo dei quali il pubblico
ministero dispone la chiusura di un procedimento penale senza l’intervento di un giudice, in virtù di un accordo
con l’imputato ed a seguito dell’adempimento degli obblighi previsti dalla legge (c.d. mediated settlement in criminal matters) (13).
In quella occasione, è stata fornita una interpretazione
tendente ad estendere il più possibile l’ambito di efficacia del ne bis in idem. La Corte sentenziò infatti che l’applicazione dell’art. 54 della Convenzione di Shenghen
prescinde dalle particolarità dei diversi sistemi giuridici;
pertanto, qualsiasi provvedimento emanato dalla autorità giudiziaria di uno degli Stati membri, il quale comporti l’estinzione definitiva dell’azione penale, deve essere equiparato ad una sentenza definitiva «anche laddove
il ricorso al proprio diritto nazionale condurrebbe a soluzioni diverse» (14).
Nella seconda pronuncia del marzo 2005 i giudici europei hanno, viceversa, prestato una maggiore attenzione
al bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco: da
un lato, infatti, è stato considerato il diritto dell’imputato a non subire una pluralità di giudizi; dall’altro - in
un’ottica di salvaguardia delle legittime pretese punitive dei vari paesi - è stata sottolineata la necessità dell’accertamento sul merito, affinché una decisione pronunciata all’estero possa precludere un nuovo accertamento in idem ed eventualmente un rifiuto di assistenza
giudiziaria.
Tale interpretazione risulta coerente con le categorie
elaborate dalla dottrina processual penalistica italiana
(15), ma soprattutto è funzionale ad evitare che il divie-
to del ne bis in idem si trasformi in uno strumento per garantire ai rei l’impunità.
In conclusione, sulla base delle indicazioni fornite dai
giudici di Lussemburgo possiamo ritenere che la nozione di «sentenza definitiva» di cui all’art. 54 della Convenzione di Shenghen comprende i provvedimenti che
chiudono un procedimento penale, con accertamento
nel merito in ordine alla responsabilità dell’imputato. A
tali provvedimenti devono equipararsi le decisioni preNote:
(10) Cfr. CGCE, Sez. V, 10 marzo 2005, C-469/03, Miraglia, cit., punto
35.
(11) Per ulteriori approfondimenti sul tema v., I. Ingravallo, La Corte di
giustizia e il terzo pilastro dell’Unione europea, in Comun. intern., 2000, 477
ss.; G.L. Tosato, Atti giuridici vincolanti e competenze della Corte comunitaria
nell’ambito del “Terzo pilastro”, in Id., L’Italia e la politica internazionale, Bologna, 2000, 331 ss.; N. Fennelly, The area of “freedom, security and justice”
and the European Court of Justice - A personal view, in International and
Comparative Law Quarterly, 2000, 1 ss.
(12) Cfr., CGCE, 11 febbraio 2003, cause riunite C-187/01 e C-385/01.
Molteplici sono i commenti a questa decisione, tra i tanti v.: A. Ciampi,
La nozione di “persona giudicata con sentenza definitiva” e le “condanne patteggiate” in Int’I Lis, 2003, 115 ss.; I. Ingravallo, Il ne bis in idem nel processo penale secondo una recente sentenza della Corte di Giustizia, in Dir. UE,
2003, 497 ss.; E. Selvaggi, Il principio del ne bis in idem in ambito europeo,
in Cass. pen., 2003, 1688 ss.; Court of Justice, Joined Cases C - 187/01 and
C-385/01, Criminal proceeding against Hüseyin Gözütok and Klaus Brügge,
con nota di J.A.E. Vervaele, in Common Market Law Review, XLI, 2004,
3, 795 ss.
(13) La pronuncia della Corte di giustizia è stata originata da due domande pregiudiziali distinte, presentate dall’Oberlandesgericht (Corte di
appello di Colonia) e dal Rechtbank van Eerste Aanleg (Tribunale di primo
grado) di Furnes, aventi entrambe ad oggetto l’interpretazione dell’art. 54
Convenzione di Schengen. In particolare, la prima decisione ha coinvolto un cittadino turco, perseguito nei Paesi Bassi ed in Germania per commercio di sostanze stupefacenti. Il procedimento avviato nei Paesi Bassi si
era concluso con l’accettazione da parte dell’imputato di una proposta di
estinzione dell’azione penale avanzata dal pubblico ministero ed il versamento di una somma di denaro. Successivamente si è aperto in Germania un procedimento avente ad oggetto il medesimo reato ed è stato
quindi necessario stabilire se, ai sensi art. 54 della Convenzione di Shenghen, la decisione adottata in Olanda - pur in assenza della approvazione
di un giudice - poteva venire equiparata ad una sentenza definitiva. Analoga situazione ha avuto per protagonista Mr. Klaus Brügge, cittadino tedesco accusato di aver causato lesioni volontarie ad una donna. In questo
caso il Tribunale belga ha chiesto l’intervento della Corte, poiché l’imputato aveva accettato il patteggiamento con il pubblico ministero presso la
procura di Bonn, con conseguente estinzione dell’azione penale per quel
fatto di reato, previo versamento di una somma di denaro. In merito a
questa questione la Corte di giustizia delle comunità europee ha sentenziato che «il principio del ne bis in idem, sancito dall’art. 54 Convenzione
di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a
Schengen il 19 giugno del 1990, si applica anche nell’ambito di procedure di estinzione dell’azione penale, quali quelle di cui trattasi nelle cause
principali, in forza delle quali il p.m. di uno Stato membro chiude, senza
l’intervento di un giudice, un procedimento penale promosso in questo
Stato, dopo che l’imputato ha soddisfatto certi obblighi e, in particolare,
ha versato una determinata somma di denaro stabilita dal p.m». Il testo
della sentenza, dal quale è tratta la massima, è rintracciabile sul sito web:
http://curia.eu.int/en/actu/communiques/cp03/aff/cp0307en. htm.
(14) Cfr. CGCE, 11 febbraio 2003, cause riunite C-187/01 e C-385/01,
punto 35, in Cass. pen., 2003, 1688 ss.
(15) Per la dottrina italiana, v. ad es., N. Galantini, Il principio del “ne bis
in idem” internazionale nel processo penale, Milano, 1984, 59 ss.
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1173
GIUSTIZIA SOVRANAZIONALE•OPINIONI
se a seguito di “mediazione penale” (mediated settlement), purché ovviamente presentino il carattere dell’irrevocabilità. Ragionando a contraris, quindi, né le
sentenze istruttorie di proscioglimento e neppure, a nostro avviso, la sentenza di non luogo a procedere (16)
possono essere poste a fondamento di una exceptio rei
iudicatae. Questo perché tali decisioni, ancorché divenute inoppugnabili, possono sempre essere revocate;
pertanto, alla situazione processuale di incertezza presente nell’ordinamento in cui è stata pronunciata la
sentenza, conseguirebbe una parallela situazione di precarietà nello Stato che accolga il dispositivo della sentenza.
Il ne bis in idem comunitario. Prospettive future
Ad oggi il principio del ne bis in idem in ambito europeo
risulta regolato esclusivamente dalle disposizioni contenute negli artt. 54 ss. della Convenzione di Schengen
(17). Tuttavia, da diverso tempo si discute in merito alla
possibilità di migliorare l’applicazione del principio de
quo, al fine di realizzare un autentico spazio giudiziario
europeo (18).
In questa prospettiva, le due decisioni della Corte di giustizia CE, di cui si è dato brevemente conto, non rappresentano semplicemente l’epilogo di un complesso dibattito giurisprudenziale, ma al contrario possono considerarsi il punto di partenza verso sviluppi futuri molto più
ambiziosi.
Pur non essendo questa la sede per svolgere una riflessione approfondita sull’argomento, occorre tuttavia segnalare che l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ha esteso il campo di applicazione territoriale del ne bis in idem a tutto il territorio dell’Unione,
realizzando così un significativo progresso rispetto al protocollo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, che ne prevedeva il riconoscimento solo in ambito interno.
Inoltre, è attualmente allo studio un progetto, presentato dalla Repubblica ellenica, che si propone di modificare il contenuto degli art. 54-57 della Convenzione di
Shenghen (19). In particolare, il progetto in questione
prevede l’introduzione di criteri di competenza uniformi; tali criteri dovrebbero servire ad individuare un unico foro competente, nel caso in cui più procedimenti,
relativi allo stesso reato, siano pendenti dinanzi alle autorità giudiziarie di stati diversi (c.d. litispendenza internazionale). Parallelamente, al fine di evitare pericolose
difformità nell’applicazione del ne bis in idem, viene specificato il significato che deve essere attribuito a nozioni quali «identità del fatto» (20), ovvero «sentenza definitiva» (21).
Da queste pur brevi considerazioni si deduce che il principio del ne bis in idem assume un significato del tutto peculiare all’interno dell’Unione europea. Esso rappresenta, infatti, un aspetto fondamentale del programma diretto all’attuazione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie, il quale, a sua volta,
1174
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
viene considerato la ”pietra angolare” della cooperazione giudiziaria in materia penale.
Ad ogni buon conto, tanto la tematica relativa all’applicazione del ne bis in idem, tanto quella relativa ai conflitti di competenza, saranno oggetto di un Libro verde della Commissione nel 2005 e successivamente di una proposta legislativa nel 2006.
Note:
(16) Vale la pena di segnalare che nella giurisprudenza italiana vi sono
pronunzie che riconoscono l’effetto preclusivo del ne bis in idem anche nel
caso di sentenze di non luogo a procedere. In particolare si è detto che
laddove manchino le condizioni per una eventuale revoca della sentenza, come ad esempio in caso di estinzione del reato, l’effetto preclusivo è
irreversibile al pari di quello di cui all’art. 649 c.p.p.. In questo senso
Cass., Sez. VI, 8 novembre 1996, Privitera, in Cass. pen., 1998, 838;
conf., Cass., Sez. VI, 13 luglio 2001, Calcagno, in C.E.D. Cass., n.
220734.
(17) Vale la pena di segnalare che nell’ambito della Comunità europea è
stata stipulata nel 1987, anche la Convenzione di Bruxelles sul ne bis in
idem. Tuttavia, tale convenzione non essendo stata ratificata da tutti i
Paesi dell’Unione europea deve ritenersi ormai superata dalla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, il cui art. 54 riproduce
testualmente l’art. 1 della predetta Convenzione del 1987.
(18) Tale discussione si inserisce all’interno del dibattito relativo all’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie. Questo principio, già dal vertice di Tampere del 1999, è stato indicato come la”chiave di volta” nella costruzione dello spazio giudiziario
europeo. Nel 2001 il Consiglio dei ministri dell’Unione europea ha elaborato un programma di misure relativo all’attuazione del principio del
mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie (n. 2001/C12/02), in
G.U.C.E., 15 gennaio 2001, C-12. Quasi 5 anni dopo l’adozione di questo programma, la Commissione ha presentato una comunicazione contenente una serie di riflessioni sull’argomento ed ha indicato i possibili
sviluppi futuri, COM (2005) 195 def. del 19 maggio 2005. Nei documenti appena menzionati il principio del ne bis in idem viene indicato come un momento fondamentale per l’attuazione del principio del mutuo
riconoscimento delle decisioni giudiziarie.
(19) Si tratta del Iniziative of the Hellenic Republic with a view to adopting a
Council Framework decision concerning the application of the “ne bis in
idem” principle, (2003/C100/12), in Official Journal of the European
Union, C 100/24 del 26 aprile del 2003.
(20) Si riporta il contenuto dell’art. 1 lett. a ed e del Initiative of the Hellenic Republic concerning the application of “ne bis in idem” principle, cit: «Ai
fini della presente decisione quadro di intende per: a) “illeciti penali”: gli
atti considerati reati ai sensi della legislazione di ciascuno Stato membro;
gli atti considerati illeciti amministrativi o infrazioni ai regolamenti punibili da una autorità amministrativa con una pena pecuniaria, conformemente alla legislazione nazionale di ciascuno Stato membro, a condizione che rientrino nella giurisdizione dell’autorità amministrativa e che
l’interessato abbia la possibilità di adire un tribunale penale. (…) e)
“idem”: un secondo illecito penale derivante esclusivamente dagli stessi
fatti o da fatti sostanzialmente identici, indipendentemente dalla sua natura giuridica».
(21) L’art. 1 lett. b del Initiative of the Hellenic Republic concerning the application of “ne bis in idem” principle, definisce “sentenza” ogni «decisione definitiva pronunciata da un tribunale penale di uno Stato membro a conclusione di un procedimento penale, che può essere una sentenza di condanna o di proscioglimento dell’imputato, o una sentenza che termina
definitivamente l’azione penale, conformemente alla legislazione nazionale di ciascuno Stato membro, nonché la mediazione extragiudiziale in
materia penale; è considerata definitiva ogni sentenza passata in giudicato ai sensi della legislazione penale».
GIUSTIZIA SOVRANAZIONALE•OSSERVATORI
Osservatorio della Corte europea
dei diritti umani
a cura di GIULIO GARUTI
Diritto ad un processo equo
CONDANNATA L’ITALIA PER NON AVERE POSTO
L’IMPUTATO IN CONDIZIONE DI PARTECIPARE
AL GIUDIZIO DI APPELLO
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI, Sez. IV, 28 giugno
2005 - Pres. Bratza - Hermi c. Italia
(Art. 6 comma 1 Conv. eur. dir. umani)
Hermi è un cittadino tunisino attualmente ristretto nel
carcere di Frosinone.
Nel 1999 egli è stato arrestato perché in possesso di 485
grammi di eroina e di conseguenza accusato del reato di
spaccio di sostanze stupefacenti.
Il 24 marzo 2000, Hermi è stato condannato, in sede di
rito abbreviato, alla pena di anni sei di reclusione e circa
21 mila euro di multa. Successivamente Hermi ha proposto appello avverso la decisione di condanna.
Nell’attesa che venisse fissato il giudizio di secondo grado davanti alla Corte di appello di Roma, il difensore di
Hermi ha avanzato richiesta di scarcerazione del proprio
cliente. La suddetta richiesta è stata rigettata ed il 3 novembre del 2000 la Corte di appello ha confermato la
decisione di primo grado. Il ricorso per cassazione proposto avverso quest’ultima decisione non ha sortito alcun
effetto favorevole ad Hermi.
In tale contesto, Hermi ha deciso di adire la Corte europea dei diritti umani - per violazione dell’art. 6 comma 1
Conv. eur. diritti umani - dolendosi del fatto di non avere potuto partecipare all’udienza che si è svolta davanti
alla Corte d’appello di Roma.
Nell’esaminare il ricorso, la Corte europea ha ricordato
che nel caso in cui un giudice di secondo grado sia chiamato a vagliare un caso e ad esprimere un giudizio in
punto di innocenza o colpevolezza dell’imputato, egli
non può procedere a valutare la questione senza prima
avere sentito la versione dei fatti oggetto del processo
fornita dall’imputato stesso. Quest’ultimo potrebbe comunque rinunciare ad esercitare tale diritto, a patto che
tale rinuncia sia manifestata in modo inequivocabile e
non si ponga in contrasto con alcun importante interesse pubblico.
Quando la Corte d’appello di Roma era stata chiamata ad
esaminare il caso in esame e ad esprimersi circa la conferma o meno della decisione pronunciata dal giudice di
primo grado nei confronti del ricorrente, quest’ultimo
aveva il diritto di partecipare all’udienza e difendersi.
Al riguardo, i giudici europei hanno osservato che il ricorrente, per sua stessa ammissione, aveva detto di avere ricevuto l’avviso che lo informava del fatto che era
suo diritto richiedere di partecipare all’udienza, ma che
tale avviso, da un lato non gli era stato consegnato in
una lingua da lui conosciuta - arabo o francese -, e dall’altro lato non gli era risultato, anche dal punto di vista
del contenuto, di agile comprensione. Inoltre, il ricorrente ha affermato che, avendo egli partecipato all’udienza di primo grado senza avere dovuto avanzare alcuna richiesta, si sarebbe ragionevolmente aspettato la ripetizione della medesima situazione anche nel corso del
giudizio di appello.
Secondo la Corte europea, la valutazione congiunta di
tutti questi elementi ha fatto sorgere seri dubbi in ordine alla circostanza che il ricorrente avesse realmente
compreso il contenuto dell’avviso notificatogli e le possibili conseguenze derivanti dal fatto che egli avesse
omesso di avvisare le autorità giudiziarie della sua volontà di partecipare al processo. In ogni caso, egli aveva
espresso, attraverso il proprio difensore, in modo chiaro
ed inequivocabile, il desiderio di partecipare al giudizio
di appello.
Su questo sfondo, i giudici europei non hanno potuto affermare che il ricorrente avesse rinunciato al proprio diritto di partecipare all’udienza tenutasi davanti al giudice di appello e, di conseguenza, hanno concluso, a maggioranza - sussistendo tre dissenting opinions - che vi è stata una violazione dell’art. 6 comma 1 Conv. eur. dir.
umani ed hanno proceduto alla liquidazione, in favore
del ricorrente, di mille euro per il risarcimento dei danni
morali e di 4 mila euro per le spese legali.
Di recente, in punto di assenza dell’imputato dal processo in relazione all’esercizio del diritto di difesa, cfr. C. eur.
dir. umani, Sez. I, 8 luglio 2004, Pronk c. Belgio, in questa Rivista, 2004, 1177.
Diritto ad un processo equo
LE SITUAZIONI DI EMERGENZA PREVISTE
DALL’ART. 41-BIS ORD. PENIT.
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI, Sez. IV, 28 giugno
2005 - Pres. Bratza - Gallico c. Italia
(Artt. 3, 6 comma 1, 8 Conv. eur. dir. umani)
Gallico è un cittadino italiano, condannato alla pena
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1175
GIUSTIZIA SOVRANAZIONALE•OSSERVATORI
dell’ergastolo nel 1994, attualmente detenuto nel carcere di Spoleto.
In forza di un provvedimento del Ministro della giustizia,
il 20 luglio 1992, nei confronti di Gallico era stato attivato il regime di sospensione delle regole di trattamento
e degli istituti previsti previsto dall’art. 41-bis ord. penit.
(«Situazioni di emergenza»). Questo regime è stato successivamente prolungato, per ben diciannove volte, fino
al dicembre 2001.
Gallico ha proposto reclamo contro alcuni dei provvedimenti emessi dal Ministro della giustizia, ma il tribunale
di sorveglianza chiamato a decidere in ordine alle vicende carcerarie del suddetto imputato ha dichiarato inammissibili tali impugnazioni, perché ogni volta il provvedimento contestato veniva superato dall’emissione di un
provvedimento successivo.
In tale contesto, Gallico ha deciso di adire la Corte europea dei diritti umani sulla base di un duplice presupposto: da un lato, sul presupposto che l’applicazione del regime di cui all’art. 41-bis ord. penit. per un periodo di
tempo superiore ai dodici anni costituisse un comportamento contrario agli artt. 3 e 8 Conv. eur. dir. umani,
mentre, dall’altro lato, sul presupposto che il ritardo con
il quale il tribunale di sorveglianza vagliava i reclami
proposti avverso i provvedimenti emessi dal Ministero
della giustizia si ponesse in contrasto con le garanzie sancite dall’art. 6 comma 1 Conv. eur. dir. umani.
Nel prendere in esame il ricorso, la Corte europea ha anzitutto osservato che gli argomenti addotti dal Ministro
della giustizia a sostegno delle limitazioni riconducibili al
regime di cui all’art. 41-bis ord. penit. erano sicuramente
proporzionati ai reati per i quali Gallico era stato condannato, avendo egli subito pene severe per la commissione di reati molto gravi. Le sofferenze o le umiliazioni
che il ricorrente avrebbe potuto subire non sono andate
oltre quella soglia di sofferenza o umiliazione collegata a
una forma di trattamento - in questo caso prolungata - o
di punizione legittima. Inoltre, Gallico non ha fornito ai
giudici europei prove in grado di dimostrare il fatto che
la durata eccessiva del trattamento speciale impostogli
non fosse manifestamente giustificata. Per tali motivi, la
Corte europea ha concluso che il comportamento tenuto dalle autorità giudiziarie italiane non è risultato contrario all’art. 3 Conv. eur. dir. umani.
Sotto altro profilo, i giudici europei hanno poi osservato
che il regime speciale previsto dall’art. 41-bis ord. penit.
risulta non solo compatibile in generale con l’art. 8
Conv. eur. dir. umani, ma anche in particolare, poiché
nel caso di specie il Ministro della giustizia ha giustificato il mantenimento prolungato del trattamento speciale,
facendo riferimento, nell’ambito di ogni ordine, ai vari
cambiamenti derivanti dalle situazioni personali del ricorrente.
Infine, la Corte europea ha notato che tre reclami proposti dal ricorrente avverso i provvedimenti emessi dal
Ministro della giustizia erano stati dichiarati inammissibili perché già superati dall’emissione di un provvedi-
1176
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
mento successivo. Ciò ha indotto a ritenere che la mancanza di una valutazione circa il merito del reclamo aveva annullato l’effetto della decisione dell’autorità giudiziaria circa i provvedimenti emessi dal Ministero della
giustizia.
Inoltre, se la legge prevede che sul reclamo proposto avverso il provvedimento emesso dal Ministro della giustizia il tribunale di sorveglianza debba decidere entro dieci giorni, ciò significa, secondo i giudici europei, che esiste un diritto, in capo al ricorrente, di vedersi valutare,
da parte dell’autorità giudiziaria, la serietà dei motivi posti a fondamento del provvedimento emesso dal Ministro stesso. Di conseguenza, la Corte europea ha ritenuto
che l’assenza di una valutazione di merito del reclamo
proposto avverso il provvedimento emesso dal Ministro
della giustizia abbia violato il diritto del ricorrente di vedersi il proprio caso valutato, sotto il profilo sostanziale,
da un’autorità giudiziaria.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte europea ha ritenuto violato l’art. 6 comma 1 Conv. eur. dir. umani, ma
non ha proceduto alla liquidazione, in favore del ricorrente, di alcuna somma, reputando sufficiente, per una
giusta riparazione del danno derivante dalla violazione
del suddetto diritto, l’accertamento della violazione medesima.
Di recente, sul regime di cui all’art. 41-bis ord. penit., cfr.
C. eur. dir. umani, Sez. IV, 11 gennaio 2005, Musumeci
c. Italia, in questa Rivista, 2005, 381; C. eur. dir. umani,
Sez. I, 14 ottobre 2004, Ospina Vargas c. Italia, ivi, 2004,
1569; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 6 luglio 2004, Madonia
c. Italia, ibidem, 1307.
Divieto di tortura
DISERZIONE, ESPULSIONE DA UNO STATO RICHIESTO
DI ASILO E RISCHIO DI TRATTAMENTI INUMANI
E DEGRADANTI A SEGUITO DI RIENTRO IN PATRIA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI, Sez. II, 5 luglio 2005
- Pres. Baka - Said c. Paesi Bassi
(Art. 3 Conv. eur. dir. umani)
In data 8 maggio 2001, Said - cittadino dell’Eritrea - è
giunto nei Paesi Bassi ed il 21 maggio dello stesso anno
ha richiesto asilo nella cittadina di Schiphol, presso il
centro deputato a vagliare tali istanze.
Per sostenere la propria richiesta, Said ha affermato di
avere operato, in qualità di soldato, in una unità specializzata nella lotta ai carri armati e di avere combattuto la
guerra contro l’Etiopia. Sebbene la guerra fosse terminata il 13 giugno del 2000, in seguito le truppe non sono
state smobilitate per un periodo sufficientemente lungo
perché le autorità eritree temevano ulteriori incursioni
militari da parte dell’esercito dell’Etiopia.
Nell’agosto del 2000 si è svolto un incontro con il bat-
GIUSTIZIA SOVRANAZIONALE•OSSERVATORI
taglione al quale apparteneva Said e, nell’ambito di tale incontro, i comandanti del battaglione stesso hanno
contestato ai soldati il fatto di non avere combattuto
bene durante la guerra. In risposta a queste critiche,
Said ha espresso, senza paura, la propria opinione, affermando che i comandanti del battaglione avevano forzato i soldati - i quali erano affamati, assetati e stanchi - a
persistere nel combattere e ciò aveva provocato una situazione disastrosa. Inoltre, Said ha detto che la sua
unità operativa, durante il combattimento, avrebbe dovuto essere riposizionata e rinforzata. Anche altri soldati presenti all’incontro hanno condiviso le affermazioni
di Said.
Per un periodo di tempo successivo a questo incontro,
Said ha sospettato che i capi dell’esercito al quale egli
apparteneva lo stessero controllando e lo facessero seguire.
Il 5 dicembre 2000, egli è stato accusato di avere incitato i soldati, obbligato a consegnare le armi dell’esercito
che aveva in dotazione e ristretto in una cella sotterranea per circa cinque mesi. Durante questo periodo egli
non è mai stato interrogato dall’autorità giudiziaria, imputato formalmente di alcun reato o portato davanti ad
un tribunale militare.
Il 20 aprile del 2001, Said è stato caricato - senza manette o alcuna altra limitazione - su una vettura militare insieme all’autista e ad una guardia armata. Poco dopo l’inizio del tragitto, lungo il percorso essi hanno notato un’altro veicolo militare che aveva appena subito
un incidente. A fronte di tale situazione, l’autista dell’auto sulla quale viaggiava Said ha fermato la propria
marcia e, unitamente alla guardia armata, è sceso dall’auto nel tentativo di prestare soccorso al conducente
dell’auto coinvolta nell’incidente. Lasciato solo sul
veicolo, Said è scappato dirigendosi verso il Sudan e,
dopo avere attraversato vari stati, è giunto a Breda nei
Paesi Bassi.
Il 23 maggio 2001, un rappresentante del Ministro della
giustizia, dando attuazione ad una procedura d’urgenza,
ha rigettato la richiesta di asilo avanzata da Said. Tale
decisione è stata motivata sulla base dell’assenza di documenti in grado di stabilire con certezza l’identità del richiedente e la sua nazionalità. Il rappresentante del Ministro della giustizia ha inoltre ritenuto che la versione
dei fatti offerta da Said circa le motivazione inerente la
sua fuga non potesse risultare plausibile. Qualsiasi doglianza avanzata da Said avverso questa decisione si è rivelata inutile.
In tale contesto, Said, prima di essere espulso, ha ritenuto opportuno adire la Corte europea dei diritti umani,
dolendosi del fatto che una sua eventuale espulsione dai
Paesi Bassi al fine di agevolare il suo ritorno in Eritrea
avrebbe potuto determinare una situazione in contrasto
con l’art. 3 Conv. eur. dir. umani, chiamato a tutelare il
«Divieto della tortura».
Nel prendere in esame il ricorso, i giudici europei hanno
in primo luogo osservato che le affermazioni riportate da
Said nella propria richiesta di asilo erano state consistenti ed in secondo luogo sottolineato che egli aveva
fornito informazioni non prive di fondamento quando il
Governo aveva rigettato l’istanza di asilo sul presupposto
che la sua versione dei fatti mancava di credibilità. Una
parte della versione dei fatti rilasciata da Said risultava
peraltro corroborata dalle affermazioni di uno specialista
dei Paesi Bassi del Corno d’Africa militante nell’associazione pacifista denominata Amnesty International. Sebbene le informazioni sottoposte all’attenzione del Governo per ottenere asilo fossero molto generiche, risultava comunque difficile capire quali altri prove avrebbe
potuto Said produrre per legittimare la propria versione
dei fatti.
La Corte europea ha ritenuto un’indicazione molto importante, al fine di considerare Said un falso disertore, il
fatto che egli aveva richiesto asilo nei Paesi Bassi nel
maggio del 2001, ovvero un anno dopo che era iniziata
la smobilitazione delle truppe. Infatti, nonostante la
guerra fosse terminata nel giugno del 2000, le informazioni disponibili erano nel senso che le autorità eritree
non avevano provveduto a smobilitare le proprie truppe
velocemente. Da un rapporto relativo ai diritti umani riguardante l’Eritrea, fornito dal Dipartimento degli Stati
Uniti il 28 febbraio 2005, si evinceva che il Governo
dell’Eritrea era solito predisporre, lungo le strade, dei posti di blocco militari nonché effettuare verifiche di casa
in casa al fine di trovare i disertori. Inoltre, le autorità
eritree erano assai desiderose di tenere il loro esercito in
assoluta efficienza.
In queste circostanze risultava difficile immaginare quale altro motivo potesse avere il ricorrente per lasciare l’esercito, se non quello suffragato dalla volontà di disertare. Anche se la sua versione circa la fuga poteva apparire qualcosa di riprovevole, i giudici europei hanno ritenuto che essa non potesse mettere in dubbio il fatto che
Said si fosse comportato da disertore.
La questione, allora, è verificare se il ritorno in Eritrea di
Said porti con sé il rischio di un possibile cattivo trattamento dello stesso da parte delle autorità militari del suo
Paese.
In tale contesto, i giudici europei hanno preso nota, tra
le altre cose, del rapporto di Amnesty International laddove descriveva il trattamento riservato in Eritrea ai disertori: esso prevedeva la detenzione in isolamento, l’esposizione prolungata al sole ad altissime temperature, la
legatura di mani e piedi in posizioni assai dolorose. Non
vi erano dunque dubbi che questi comportamenti avrebbero costituto trattamenti inumani.
Va peraltro ricordato che avendo Said espresso, senza
paura, la propria opinione davanti alle autorità militari egli aveva affermato che i comandanti del battaglione
avrebbero forzato i soldati affamati, assetati e stanchi a
persistere nel combattere -, nessuna possibilità egli
avrebbe avuto di passare inosservato rispetto alle autorità dell’Eritrea una volta che venisse espulso dai Paesi
Bassi e rimpatriato. Ciò ha dunque indotto la Corte eu-
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1177
GIUSTIZIA SOVRANAZIONALE•OSSERVATORI
ropea a ritenere che un’eventuale espulsione dai Paesi
Bassi in favore di un rientro in Eritrea avrebbe comportato il rischio reale, per Said, di venire assoggettato a
torture o trattamenti inumani e degradanti in violazione
dell’art. 3 Conv. eur. dir. umani.
Di recente, sugli episodi di tortura e di trattamenti inumani o degradanti, cfr. C. eur. dir. umani, Sez. II, 5 aprile 2005, Nevmerzhitsky c. Ucraina, in questa Rivista,
2005, 780; C. eur. dir. umani, Sez. I, 27 gennaio 2005,
Ramirez Sanchez c. Francia, ibidem, 382; C. eur. dir.
umani, Sez. I, 20 gennaio 2005, Mayzit c. Russia, ibidem,
383; C. eur. dir. umani, Sez. II, 12 ottobre 2004, Bursuc
c. Romania, ivi, 2004, 1570; C. eur. dir. umani, Sez. I, 30
settembre 2004, Krastanov c. Bulgaria, ibidem, 1445; C.
eur. dir. umani, Sez. I, 19 maggio 2004, Toteva c. Bulgaria, ibidem, 916; C. eur. dir. umani, Sez. I, 1° aprile 2004,
Rivas c. Francia, ibidem, 783; C. eur. dir. umani, Sez. I,
11 marzo 2004, B. c. Turchia, ibidem, 650.
Osservatorio della Corte di giustizia
delle Comunità europee
a cura di SILVIO RIONDATO
Posizione della vittima nel processo penale
INTERPRETAZIONE CONFORME
AL DIRITTO COMUNITARIO, DECISIONI QUADRO,
“EQUO PROCESSO”, MODALITÀ DI AUDIZIONE
DI MINORI IN QUALITÀ DI TESTIMONI
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Grande
Sezione, 16 giugno 2005, C-105/03 - Pres. Skouris - Proc.
pen. Pupino
(Decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001,
2001/220/GAI)
La Signora P. viene sottoposta a procedimento penale
dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze per aver abusato dei mezzi di disciplina e cagionato lesioni personali aggravate nei confronti di taluni
bambini che le erano stati affidati quale insegnante di
scuola materna.
Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero formula istanza di incidente probatorio al fine di assumere la testimonianza delle persone offese che, all’epoca
della richiesta, avevano cinque anni di età. Nell’istanza,
il pubblico ministero chiede che la prova sia assunta secondo modalità protette, in una struttura specializzata
ed in condizioni tali da tutelare la dignità, la riservatezza
e la serenità dei bambini, eventualmente con l’intervento di un esperto di psicologia infantile, a causa della
delicatezza e gravità dei fatti nonché della difficoltà di
approccio delle persone da esaminare dovuta alla loro
tenera età.
Il diritto processuale penale italiano, tuttavia, consente
una siffatta modalità di assunzione della prova solo nei
procedimenti penali riguardanti i delitti indicati dall’art.
398 comma 5-bis c.p.p., delitti tra i quali non figurano i
1178
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
reati di abuso dei mezzi di disciplina e di lesioni personali.
Secondo il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Firenze - cui era indirizzata l’istanza di incidente probatorio - siffatta limitazione potrebbe presentare profili di tensione con la decisione quadro
2001/220/GAI relativa alla posizione ed alla tutela della
vittima nel procedimento penale: secondo il giudice del
rinvio, infatti, la decisione quadro imporrebbe di applicare speciali modalità di assunzione della testimonianza
- quali quelle previste dall’art. 398 comma 5-bis c.p.p. in ogni caso in cui il minore, persona offesa dal reato,
possa ritenersi una «vittima particolarmente vulnerabile».
Ritenendo di dover interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo delle disposizioni comunitarie - pur riconoscendo la mancanza di “effetti diretti” delle decisioni quadro ai sensi dell’art. 34 n.
2 lett. b Trattato UE - e nutrendo dubbi sulla compatibilità delle norme di diritto interno con la decisione quadro, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Firenze ha deciso di sospendere il giudizio e di
chiedere alla Corte se gli artt. 2, 3 e 8 della decisione
quadro debbano essere interpretati nel senso che un giudice nazionale deve avere la possibilità di autorizzare
bambini in età infantile che, come nella causa principale, sostengano di essere stati vittime di maltrattamenti a
rendere la loro deposizione secondo modalità che consentano loro di assicurare un livello di tutela adeguato,
al di fuori e prima dell’udienza pubblica.
È la prima volta che la Corte di giustizia è chiamata ad
interpretare, ai sensi dell’art. 35 Trattato UE, una decisione quadro. Le decisioni quadro sono strumenti normativi di “terzo pilastro” vincolanti per gli Stati membri
solo riguardo al risultato da ottenere, mentre la forma ed
GIUSTIZIA SOVRANAZIONALE•OSSERVATORI
i mezzi di attuazione restano di competenza di ciascuna
autorità nazionale. Il modello normativo di riferimento
è quello delle direttive comunitarie: nella stesura del
trattato di Amsterdam, tuttavia, venne espressamente
esclusa la diretta efficacia delle decisioni quadro al fine
(se non di impedire quantomeno) di limitare il rischio di
una elaborazione giurisprudenziale simile a quella, sotto
certi aspetti imprevista, sviluppatasi negli ultimi quarant’anni in tema di direttive.
Il primo nodo interpretativo posto alla Corte riguarda
l’esclusione dell’efficacia diretta delle decisioni quadro:
secondo il Giudice a quo, infatti, la clausola di esclusione non impedirebbe di ritenere applicabile anche alle
decisioni quadro il principio di interpretazione conforme, ossia il principio che impone al giudice nazionale di
interpretare il proprio diritto nazionale alla luce di quello comunitario, onde conseguire il risultato prescritto
dalla norma comunitaria (cfr. CGCE 13 novembre
1990, causa C-106/89, Marleasing, in Raccolta, 1990,
4135, punto 8).
La Corte di giustizia - nel concordare con l’opinione del
giudice a quo - rileva, per un verso, che se i singoli non
avessero il diritto di far valere le decisioni quadro al fine
di ottenere un’interpretazione conforme del diritto nazionale dinanzi ai giudici degli Stati membri, la propria
competenza pregiudiziale sarebbe privata del suo effetto
utile. Per altro verso, prosegue la Corte, il fatto che il
Trattato sull’Unione europea non preveda espressamente un obbligo analogo a quello previsto all’art. 10 Trattato CE non sarebbe argomento decisivo ad escludere l’applicazione del principio. La Corte, pur riconoscendo che
la propria elaborazione giurisprudenziale del principio di
interpretazione conforme è stata in parte fondata proprio su tale norma, ritiene che il principio di leale cooperazione sia necessariamente implicato anche nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia
penale; sarebbe, infatti, difficile ipotizzare - osserva la
Corte - che l’Unione possa efficacemente segnare una
nuova tappa nel processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa, sulla cui base organizzare in modo coerente e solidale le relazioni tra gli
Stati membri e tra i loro popoli (art. 1 Trattato UE), ove
non vi fosse una cooperazione leale e giuridicamente
corretta tra gli Stati membri e tra questi e le istituzioni.
In linea di principio, dunque, la Corte afferma che il
giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto interno, per quanto possibile alla luce della lettera e dello
scopo della decisione quadro, al fine di conseguire il risultato perseguito da questa. Ma il vincolo incontra, secondo la Corte, due ordini di limiti.
In primo luogo, la Corte afferma come il principio di interpretazione conforme non possa comunque condurre
ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale
nei casi in cui non sia possibile ricavare dal diritto nazionale - che il giudice nazionale è tenuto a valutare nel sul
complesso - alcuna soluzione esegetica compatibile la
decisione quadro.
In secondo luogo, la Corte ribadisce come l’interpretazione conforme resti comunque vincolata al rispetto dei
principi che derivano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri: a tal proposito la Corte ha colto l’occasione di affermare, anche riguardo alle decisioni
quadro, che i principi fondamentali della certezza del diritto e di non retroattività escludono che la responsabilità penale possa essere fondata (o anche solo aggravata)
sulle sole norme sopranazionali e indipendentemente da
una legge adottata per la loro attuazione (vide, in materia di direttive comunitarie, CGCE 8 ottobre 1987, causa 80/86, Kolpinghuis Nijmegen Bv, in Raccolta, 1987,
3969; CGCE, 12 dicembre 1996, cause riunite C-74/95
e C-129/95, proc. pen. X, ivi, 1996, 6609; cfr. Cass., Sez.
III, 28 ottobre 1997, Aprà, in questa Rivista, 1998, 608,
con commento di S. Riondato, Legalità penale comunitaria in materia di rifiuti pericolosi).
Il secondo, e più centrale, nodo esegetico cui la Corte è
chiamata a dare soluzione, riguarda il contenuto della
decisione quadro 2001/220/GAI ed i suoi rapporti con il
diritto nazionale ed i principi fondamentali dell’Unione
nel settore del diritto penale processuale.
La Corte afferma che la decisione quadro impone agli
Stati membri di prevedere condizioni di particolare protezione dallo strepitus fori per la testimonianza di soggetti processuali particolarmente vulnerabili quali le persone offese nel procedimento a quo: al tal fine il giudice nazionale deve poter ricorrere ad una procedura speciale,
come l’incidente probatorio, e a modalità particolari di
assunzione della prova, come quelle previste dall’art. 398
comma 5-bis c.p.p.: tuttavia, sottolinea la Corte, le particolari modalità con cui rendere testimonianza debbono
essere compatibili con i principi fondamentali dell’ordinamento dello Stato membro interessato.
La Corte rileva, inoltre, come, anche ricorrendo al principio di interpretazione conforme, debbano essere rispettati i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali e che risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto: la decisione quadro deve essere
interpretata rispettando, in particolare il diritto ad un
processo equo, così come sancito all’art. 6 della Convenzione e interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Secondo la Corte spetta al giudice nazionale accertare
se una interpretazione conforme del diritto nazionale
che conduca ad applicare istituti di assunzione anticipata della prova e di audizione protetta di talune vittime
di reato, non renda il procedimento penale, considerato nel suo complesso, “iniquo” ai sensi dell’art. 6 della
Convenzione, quale interpretato dalla Corte europea
dei diritti dell’uomo ovvero contrario ai principi fondamentali dell’ordinamento dello Stato membro interessato.
La Corte ha così concluso affermando che: «gli artt. 2, 3
e 8, n. 4, della decisione quadro del Consiglio 15 marzo
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1179
GIUSTIZIA SOVRANAZIONALE•OSSERVATORI
2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima
nel procedimento penale, devono essere interpretati nel senso
che il giudice nazionale deve avere la possibilità di autorizzare
bambini in età infantile che, come nella causa principale, sostengano di essere stati vittime di maltrattamenti a rendere la
loro deposizione secondo modalità che permettano di garanti-
re a tali bambini un livello di tutela adeguato, ad esempio al di
fuori dell’udienza e prima della tenuta di quest’ultima. Il giudice nazionale è tenuto a prendere in considerazione le norme
dell’ordinamento nazionale nel loro complesso e ad interpretarle, per quanto possibile, alla luce della lettera e dello scopo
della detta decisione quadro».
Osservatorio dei Tribunali penali
internazionali
a cura di GABRIELE DELLA MORTE
Corte penale internazionale
NESSUN ITALIANO (ANCORA) TRA GLI AVVOCATI
AMMESSI ALLA CORTE
CORTE PENALE INTERNAZIONALE, Lista dei difensori abilitati a patrocinare dinanzi alla Corte, Ufficio della Cancelleria, 29 luglio 2005
(Artt. 21 comma 2 R.p.p. CPI)
Nel corso del mese di gennaio 2004, l’ufficio del Cancelliere della Corte penale internazionale ha invitato
coloro che si ritenessero interessati a presentare una domanda per poter patrocinare dinanzi ai giudici internazionali. Avanzando tale richiesta, il Cancelliere si
conformava al dettato dell’art. 21 comma 2 R.p.p., che
esplicitamente prevede che quest’ultimo «provveda alla
creazione ed al mantenimento di una lista di difensori
che soddisfino i criteri» successivamente specificati all’art. 22. Se in linea generale ciascun accusato può liberamente scegliere il proprio difensore da tale lista, l’apparato normativo della Corte sancisce altresì il diritto di
difendersi da soli e ancora quello di scegliere un proprio
difensore di fiducia purché soddisfi criteri di garanzia atti a consentire l’inclusione di quest’ultimo nella predetta lista.
Con l’adozione del “Regolamento interno” della Corte
(Regulations), nel corso del mese di maggio 2004 (cfr.
Fanchiotti, Varate le Regulations della corte penale internazionale, in questa Rivista, 2004, 1172-1176), la proposta di istituire una lista provvisoria è divenuta effettiva.
Il 29 luglio 2005 il Cancelliere ha reso quindi pubblica
la scelta sino ad oggi effettuata: delle centosessantasette
persone che hanno espresso la propria intenzione di divenire avvocati dinanzi la Corte penale internazionale,
ne sono state selezionate ottantotto. Tra questi si contano, nel dettaglio: tredici difensori di origine francese e
altrettanti di provenienza statunitense (il fatto che gli
1180
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
USA non siano parte al Trattato istitutivo della Corte
non rappresenta infatti una condizione ostativa all’esercizio della funzione difensiva); nove di estrazione inglese; otto di origine congolese; cinque australiani e un
uguale numero di olandesi e di belgi; quattro tedeschi;
tre camerunesi; due canadesi e altrettanti provenienti
dalla Macedonia, dalla Serbia Montenegro, dalla Svizzera e dal Uganda, ed infine uno proveniente dall’Algeria, dall’Argentina, dall’Austria, dalla Croazia, dalla Danimarca, dall’Irlanda, dal Kenya, dal Mali, dalla Mauritiana, dalla Norvegia, dalla Slovenia, dalla Sierra Leone
e dalla Romania.
Dalla provenienza di questo primo gruppo di difensori è
possibile dedurre alcune osservazioni di massima. Innanzitutto, la predominanza è chiaramente degli avvocati di madrelingua anglo/francofona, dal momento che
francese e inglese rappresentano le lingue ufficiali di lavoro del Tribunale. La compatta presenza di avvocati
originari di alcune determinate aree africane, come ad
esempio la Repubblica Democratica del Congo, è dovuta inoltre alla maggiore conoscenza delle inchieste attualmente in corso (che interessano appunto crimini
presuntivamente compiuti in questi Paesi). La significativa rappresentanza di difensori provenienti dalle regione balcaniche (Macedonia, Serbia Montenegro, Croazia), ancora, è ragionevolmente collegata all’esperienza
che questi ultimi hanno acquisito dinanzi al Tribunale
penale internazionale ad hoc per l’ex Jugoslavia nel corso dell’ultima decade. Un’osservazione in parte analoga
va presentata anche per difensori di altre nazionalità,
che vantano precedenti esperienze dinanzi al Tribunale
penale internazionale per il Ruanda. Inoltre, non si può
trascurare che su ottantotto avvocati selezionati solo
dieci siano donne. La percentuale, benché non insignificante, soddisfa solo in parte coloro che sono attenti alle istanze paritarie. E questo specialmente se si tiene in
debito conto l’impegno generalmente profuso in seno
alle istituzioni internazionali per assicurare, anche ai fi-
GIUSTIZIA SOVRANAZIONALE•OSSERVATORI
ni di una testimonianza esemplare, un maggiore egualitarismo (gli avvisi pubblicati nel sito ufficiale della Corte - www.icc-cpi.int - incoraggiano appunto candidature
femminili).
Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 22 comma 1
R.p.p. e 67 Reg. interno CPI, gli avvocati difensori, siano essi nominati d’ufficio tra quelli inclusi nella lista oppure scelti personalmente dai singoli accusati, devono
rispondere, come accennato in precedenza, ad alcuni requisiti: a) una provata competenza in diritto internazionale o in diritto penale e in tema di procedura; b) una
necessaria esperienza del processo penale sviluppata attraverso l’esercizio della funzione di giudice, di procuratore, d’avvocato o di altra funzione analoga [detta esperienza è quantificata in almeno dieci anni di esperienza
nelle Regulations]; c) un’eccellente conoscenza e una
parlata corrente in almeno una delle lingue di lavoro
della Corte; e infine d) un’esperienza priva di ambiguità:
la normativa richiede espressamente che i candidati
non siano stati condannati a sanzioni penali o disciplinari considerati incompatibili con l’ufficio di difensore
dinanzi ad un’istituzione internazionale.
La condotta professionale degli Avvocati, oltre che dalle norme statutarie e da quelle regolamentari, sarà governata dal Codice deontologico in corso di redazione
presso l’ufficio della Cancelleria (cfr. la Proposal for a
draft Code of Professional Conduct for counsel before the International Criminal Court [Doc. ICC-ASP/3/11/Rev.1],
la cui relativa bozza, approvata il 27 agosto 2004, è in attesa di approvazione definitiva da parte dell’Assemblea
degli Stati parte). Sul medesimo ufficio (Cancelleria)
gravano altri importanti obblighi concernenti la difesa:
oltre alla redazione di quest’ultimo e alla pubblicazione
e all’aggiornamento della lista di cui si è detto in precedenza, vanno ricordate: le norme in tema di salvaguardia del diritto alla riservatezza nei rapporti tra l’assistito
e il difensore, e ancora l’istituzione di un Ufficio pubblico della difesa i cui diversi compiti (dall’informazioni
sull’interpretazione delle norme, all’assistenza tecnica in
tema di investigazioni condotte dalla difesa, cfr. art. 77
Reg. interno CPI) assolvono l’esigenza di istituire un organo in grado di tutelare un duplice interesse: particolare (di categoria) e generale (a tutela dell’equo processo).
Un’ultima osservazione ci sembra meritevole di un breve approfondimento. In questo primo gruppo di difensori sono del tutto assenti avvocati di origine o formazione
italiana. Benché il nostro Paese abbia, almeno inizialmente, contribuito in modo rilevante alla creazione della Corte e come se la nostra classe forense, che pure vanta antiche e nobile tradizioni, testimoniasse una certa
impermeabilità dinanzi alle sfide poste da questi istituzioni. Eppure i Tribunali e le Corti penali internazionali
(occasionali o permanenti) rappresentano un formidabile osservatorio per esaminare da vicino quei fenomeni
di contaminazione normativa che già segnano nel
profondo l’evoluzione della legislazione e della prassi
giurisprudenziale dei singoli Paesi. Per quale ragione al-
lora gli avvocati italiani (eccetto un solo caso dinanzi al
Tribunale per il Ruanda, per quanto è a nostra conoscenza) disertano le difese dinanzi a tali istituzioni? Alcune ragioni sono intelligibili, e su queste s’intende presentare, in conclusione, alcune riflessioni.
Innanzitutto, la questione della lingua. Quelle di lavoro
dei Tribunali ad hoc delle Nazioni Unite come della
Corte penale internazionale sono l’inglese e/o francese a
cui occorre ragionevolmente aggiungere quella in cui
interloquire con il proprio assistito. Ma quest’ultima
non rappresenta necessariamente un problema insolubile, dal momento che in ogni caso si avrà diritto ad un
servizio di traduzione (come d’altronde per l’accusa), e
dal momento che in ogni caso in questo tipo di processi
non sono rari gli esempi di difese esercitate in modo
congiunto, in cui accanto ad un leading counsel non madrelingua collabora un co-counsel madrelingua o viceversa.
In secondo luogo, la questione della sede, o della distanza dal centro principale dei propri interessi. I processi dinanzi ai Tribunali ad hoc per il Ruanda e l’ex Jugoslavia, e ancora quelli che si celebreranno dinanzi alla Corte penale internazionale per fermarsi a questi soli
esempi, si svolgono nelle rispettive sedi istituzionali:
Arusha (Tanzania) per il primo e l’Aja (Olanda) per i
successivi altri due. È ben vero che l’impegno richiesto,
dal momento dell’assegnazione dell’incarico sino al termine del processo in primo o secondo grado (con in
mezzo dei dibattimenti spesso lunghi e impegnativi nel
corso dei quali la presenza del difensore è chiaramente
insostituibile) può durare anni. Ma è anche vero che
oggi un gran numero di studi forensi può contare su di
una pluralità di collaboratori e che dunque, con una
certa capacità di organizzazione, quest’ultima circostanza non rappresenta necessariamente un ostacolo insormontabile.
Infine, ma in fondo in primis, la questione delle competenze. Le singole procedure che compongono il procedimento dinanzi alla Corte penale internazionale divergono profondamente da quelle fissate dai codici nazionali,
e specialmente dai codici, come il nostro, di ispirazione
giusromanistica/civil law (basti pensare al ruolo attivo
che l’Avvocato è chiamato ad assolvere nel corso della
fase, preliminare al dibattimento, della raccolta probatoria). La sensazione di incertezza che ne può derivare è
forte, e forse è proprio intorno tale circostanza che occorre ascrivere l’apparente indifferenza della nostra classe forense. Ma anche su tale ultima questione è possibile un contrappunto. Alcune tra le nostre università, attraverso dei corsi o dei seminari di specializzazione, stanno svolgendo un vero lavoro su questo fronte, forti anche di una tradizione giuridica che comincia a consolidarsi (per limitarci alla sola nomina dei giudici non bisogna dimenticare che l’accademia italiana ha già fornito un Presidente e un Vice-Presidente al Tribunale per
l’ex Jugoslavia, e ancora un giudice al Tribunale per il
Ruanda e un altro alla Corte penale internazionale).
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1181
GIUSTIZIA SOVRANAZIONALE•OSSERVATORI
Una certa competenza è in corso di formazione e di quest’ultima potrebbero senz’altro beneficiare eventuali
consiglieri della difesa. Ad esempio, l’art. 22 comma 1
R.p.p. CPI riconosce esplicitamente il diritto degli Avvocati ad essere (a loro volta) assistiti da altri soggetti dotati di una rilevante esperienza - «ivi inclusi professori di
diritto». Nello stesso senso sembra orientarsi il “progetto
di sistema di aiuto giudiziario” (cfr. la bozza approvata il
CD-ROM
17 agosto 2004, doc. ICC-ASP/3/16) che innova il metodo di remunerazione precedentemente istituito per i
Tribunali ad hoc passando da un sistema di tariffazione
oraria ad uno forfetario (in modo da facilitare eventuali
occasioni di collaborazione).
Le sinergie in questo campo sono quindi ben possibili
(oltre che augurabili). A quando il primo avvocato italiano alla Corte?
La Legge dell’Unione Europea
Normativa e giurisprudenza annotata e coordinata
La Legge dell’Unione Europea è la nuova
banca dati Ipsoa, disponibile nelle versioni DVD-Rom e on-line, che offre al professionista il panorama completo sul diritto
dell’Unione Europea.
Finalmente uno strumento informativo
che garantisce la razionale organizzazione ed il coordinamento della vasta produzione legislativa e giurisprudenziale
comunitara.
I testi legislativi, raggruppati in 32 voci di
classificazione, aggiornati e coordinati con
la giurisprudenza e la normativa nazionale
e regionale, sono riportati integralmente:
nelle versioni vigenti e previgenti.
La giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di I grado è coordinata con la normativa di riferimento. Tutte
le sentenze sono riportate nel testo integrale e collegate alle rispettive massime.
LE VOCI DI CLASSIFICAZIONE
Agricoltura •Ambiente • Appalti pubblici • Cittadinanza europea • Concorrenza • Cultura e istruzione • Diritto
doganale • Energia • Finanza e bilancio • Giustizia • Imprese • Industria •
Informazione • Istituzioni • Legislazione sanitaria • Libera circolazione delle
merci • Libertà di circolazione dei lavoratori • Libertà di circolazione delle
persone • Libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi • Libertà e
sicurezza • Mercato interno • Pesca •
Politica economica e monetaria • Politica estera e di sicurezza comune • Politica tributaria • Regioni e coordinamento degli elementi strutturali • Relazioni esterne • Scienza • Trasporti •
Trattati • Tutela dei consumatori • Tutela e sicurezza dei lavoratori.
IL PIANO DELL’OPERA
1182
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
Legislazione
Trattati istitutivi, Accordi internazionali,
Diritto derivato e altri Atti
Giurisprudenza
Sentenze, Ordinanze, Pareri, Conclusioni
dell’Avvocato generale
Corte di giustizia CE • Tribunale di I grado
CE
L’INTEGRAZIONE CON LA LEGGE PLUS
La Legge dell’Unione Europea in versione
DVD-Rom è perfettamente integrabile nel
sistema informativo Ipsoa La Legge plus: il
più evoluto strumento di documentazione
ed aggiornamento utilizzato ed apprezzato
da migliaia di professionisti. La Legge plus
è l’unica banca dati in grado di offrire il panorama completo sulla normativa nazionale, regionale, comunitaria ed internazionale
e la relativa giurisprudenza.
L’integrazione consente di disporre in un
unico DVD-Rom di più banche dati autonome in grado di interagire durante la consultazione dei provvedimenti.
Aggiornamento bimestrale
Prezzo Abbonamento:
€ 330,00 + IVA 20% comprensivo
di un anno di aggiornamento
Canone annuo di aggiornamento:
€ 165,00 + IVA 20%
Speciale offerta per gli abbonati
a La Legge: soli € 165,00 + IVA 20%
anziché € 330,00 + IVA 20%
Per informazioni
• Servizio Informazioni Commerciali
(tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)
• Agente Ipsoa di zona (www.ipsoa.it/agenzie)
• www.ipsoa.it
INDICI
INDICE DEGLI AUTORI
Bartoli Roberto
Sanzione punitiva e garanzie (a proposito della sentenza costituzionale sulla decurtazione dei punti della
patente) ..........................................................................
1094
Cingari Francesco
“Maghi-guaritori” e morte del paziente: profili oggettivi e soggettivi di responsabilità penale.......................
1153
Corbetta Stefano
Osservatorio della Corte di cassazione - Diritto penale...
1078
Legislazione
Legge 31 luglio 2005, n. 155 .........................................
Decreto legge 17 agosto 2005, n. 162...........................
1067
1068
Giurisprudenza
D’Angelo Luigi
Missioni militari all’estero, regole di ingaggio e cause
di non punibilità codificate nella legislazione penale
comune e militare .........................................................
1161
Della Morte Gabriele
Osservatorio dei Tribunali penali internazionali.........
1180
Di Chiara Giuseppe
Osservatorio della Corte costituzionale .......................
1069
Diddi Alessandro
Il regime dell’incompatibilità a testimoniare nel processo a carico degli enti .................................................
1166
Fabbricatore Anna
Il ne bis in idem e Corte di giustizia: ancora un chiarimento sulla nozione di “sentenza definitiva”...............
1171
Febbrai Roberta
Estorsione: la minaccia come fatto eziologicamente
collegato all’azione volontaria e cosciente dell’agente
1122
Garuti Giulio
Osservatorio della Corte europea dei diritti umani.....
1175
La Regina Katia
Partecipazione all’udienza di riesame: scelta del detenuto o del giudice? .........................................................
1132
Leo Guglielmo
Osservatorio dei contrasti giurisprudenziali .................
1086
Lorusso Sergio
La persona offesa tra garanzie individuali e class actions .................................................................................
1061
Montagna Alfredo
Osservatorio della Corte di cassazione - Sezioni Unite .....................................................................................
1075
Peroni Francesco
Osservatorio della Corte di cassazione - Processo penale..................................................................................
1082
Riondato Silvio
Osservatorio della Corte di giustizia delle Comunità
europee............................................................................
1178
Vallini Antonio
Omesso versamento di ritenute ed appropriazione indebita .............................................................................
1184
INDICE CRONOLOGICO
DEI PROVVEDIMENTI
1107
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
Corte penale internazionale
29 luglio 2005, Lista dei difensori abilitati al patrocinio ...................................................................................
1180
Corte di giustizia delle comunità europee
16 giugno 2005, C-105/03, Proc. pen. Pupino ............
1178
Corte europea dei diritti umani
5 luglio 2005, Said c. Paesi Bassi...................................
28 giugno 2005, Hermi c. Italia ....................................
28 giugno 2005, Gallico c. Italia ..................................
1176
1175
1175
Corte costituzionale
24 gennaio 2005 (12 gennaio 2005), n. 27..................
15 luglio 2005 (7 luglio 2005), n. 278..........................
19 luglio 2005 (7 luglio 2005), n. 291..........................
22 luglio 2005 (7 luglio 2005), n. 307..........................
22 luglio 2005 (7 luglio 2005), n. 299..........................
Corte di cassazione (Sezioni unite)
19 gennaio 2005 (u.p. 27 ottobre 2004), n. 1327........
22 giugno 2005 (u.p. 22 marzo 2005), n. 23428, B. ...
20 luglio 2005 (c.c. 28 giugno 2005), n. 26798, V. ....
Corte di cassazione (Sezioni semplici)
23 settembre 2004 (u.p. 16 giugno 2004), n. 37526,
G. ed altro.......................................................................
13 gennaio 2005 (u.p. 19 novembre 2004), n. 275,
C. ..................................................................................
25 maggio 2005 (u.p. 3 febbraio 2005), n. 19797, M.
M. ...................................................................................
30 maggio 2005 (u.p. 17 maggio 2005), n. 20391, P.G.
in c. T.F. ..........................................................................
6 giugno 2005 (u.p. 29 aprile 2005), n. 21045, S. ......
8 giugno 2005 (c.c. 15 febbraio 2005), n. 21400,
P.S. .................................................................................
14 giugno 2005 (u.p. 28 aprile 2005), n. 22496, P.m.
in c. B.G. ........................................................................
23 giugno 2005 (u.p. 28 aprile 2005), n. 23663, P.m.
in c. S. ............................................................................
24 giugno 2005 (u.p. 8 giugno 2005), n. 23799, B. ....
28 giugno 2005 (c.c. 15 giugno 2005), n. 24380,
D’A. ...............................................................................
1° luglio 2005 (u.p. 3 febbraio 2005), n. 24527, P. A.
4 luglio 2005 (u.p. 28 aprile 2005), n. 24586, P. .........
4 luglio 2005 (c.c. 18 maggio 2005), n. 24643, P. ......
6 luglio 2005 (u.p. 14 giugno 2005), n. 24894, D. C.
A. ....................................................................................
14 luglio 2005 (c.c. 5 luglio 2005), n. 26031, C. ........
2 agosto 2005 (c.c. 20 giugno 2005), n. 29157, I. ......
1089
1070
1069
1070
1071
1103
1075
1076
1117
1129
1079
1080
1085
1078
1078
1084
1082
1082
1080
1084
1083
1081
1083
1083
INDICI
Tribunale
Savona, 22 dicembre 2004 (u.p. 24 settembre 2004),
n. 352, L. ........................................................................
1143
INDICE ANALITICO
Diritto penale
Beni culturali
– Omessa denuncia del trasferimento di proprietà o
di detenzione di beni culturali (Cass., Sez. III, 8
giugno 2005-15 febbraio 2005, n. 21400, P.S.)........
Codice della strada
– Sanzione punitiva e garanzie (a proposito della
sentenza costituzionale sulla decurtazione dei punti della patente) (Corte cost. 24 gennaio 2005-12
gennaio 2005, n. 27) con commento di Roberto
Bartoli .........................................................................
Esecuzione della pena
– Incostituzionale il divieto di accesso all’“indultino” per i condannati in misura alternativa alla detenzione (Corte cost. 15 luglio 2005-7 luglio 2005,
n. 278) .......................................................................
Estinzione del reato
– Reato continuato: da quando decorre il termine
prescrizionale (Cass., Sez. V, 1° luglio 2005-3 febbraio 2005, n. 24527, P. A.).....................................
Fede pubblica (delitti contro la)
– Falsa attestazione dell’autenticità della firma apposta in calce ad un ricorso per cassazione (Cass.,
Sez. V, 14 giugno 2005-28 aprile 2005, n. 22496,
P.m. in c. B.G.).........................................................
Incolumità pubblica (delitti contro la)
– Somministrazione di liquido per lavastoviglie al
posto di acqua minerale (Cass., Sez. I, 30 maggio
2005-17 maggio 2005, n. 20391, P.g. in c. T.F.)....
Lavoro (Diritto penale del)
- Omesso versamento di ritenute ed appropriazione
indebita (Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2005-27 ottobre
2004, n. 1327, L. C.) con commento di Antonio Vallini ...................................................................................
Militare (Diritto penale)
– Missioni militari all’estero, regole di ingaggio e
cause di non punibilità codificate nella legislazione
penale comune e militare di Luigi D’Angelo............
Patrimonio (Delitti contro il)
– Estorsione: la minaccia come fatto eziologicamente collegato all’azione volontaria e cosciente dell’agente (Cass., Sez. II, 23 settembre 2004-16 giugno
2004, n. 37526, G. ed altro) con commento di Roberta Febbrai ...............................................................
Persona (delitti contro la)
– “Maghi-guaritori” e morte del paziente: profili oggettivi e soggettivi di responsabilità penale (G.i.p.
Trib. Savona, 22 dicembre 2004-24 settembre 2004,
n. 352, L.) con commento di Francesco Cingari.....
– Sinistro stradale causato da veicolo militare: le de-
1078
1089
1070
1080
1078
1080
1107
1161
1117
1143
roghe al codice della strada consentite (Cass., Sez.
IV, 25 maggio 2005-3 febbraio 2005, n. 19797, M.
M.) ........................................................
Sanzioni sostitutive
– Applicabile al minorenne la pena pecuniaria come
sanzione sostitutiva (Cass., Sez. V, 6 luglio 2005-14
giugno 2005, n. 24894, D. C. A.) ....................
Giustizia sovranazionale
Corte europea dei diritti umani
– Condannata l’Italia per non avere posto l’imputato in condizione di partecipare al giudizio d’appello (C. eur. dir. umani, Sez. IV, 28 giugno 2005, Hermi c. Italia)................................................
– Diserzione, espulsione da uno stato richiesto di asilo e rischio di trattamenti inumani e degradanti a
seguito di rientro in patria (C. eur dir. umani, Sez.
II, 5 luglio 2005, Said c. Paesi Bassi) ..................
– Le situazioni di emergenza previste dall’art. 41-bis
ord. penit. (C. eur. dir. umani, Sez. IV, 28 giugno
2005, Gallico c. Italia) ..................................
Corte di giustizia delle Comunità europee
– Il ne bis in idem e Corte di giustizia: ancora un chiarimento sulla nozione di “sentenza definitiva” di
Anna Fabbricatore .......................................
– Interpretazione conforme al diritto comunitario,
decisioni quadro, “equo processo”, modalità di audizione di minori in qualità di testimoni (CGCE,
Grande Sezione, 16 giugno 2005, C-105/03, Proc.
pen. Pupino) ..............................................
Corte penale internazionale
– Nessun italiano (ancora) tra gli avvocati ammessi
alla Corte (Corte penale internazionale, Lista dei difensori abilitati a patrocinare dinanzi alla Corte, 29 luglio 2005) .................................................
Processo penale
Atti
– La nuova disciplina dei termini soggetta al principio tempus regit actum (Cass., Sez. I, 28 giugno
2005-15 giugno 2005, n. 24380, D’A.)..............
– Non è irreperibilità l’assenza temporanea dal domicilio dichiarato (Cass., Sez. I, 24 giugno 2005-8
giugno 2005, n. 23799, B.) ............................
– Rito camerale per la decisione sulla restituzione in
termini (Cass., Sez. VI, 2 agosto 2005-20 giugno
2005, n. 29157, I.) .....................................
Esecuzione
– Irrevocabilità della sentenza e sua impugnazione
tardiva (Cass., Sez. I, 4 luglio 2005-18 maggio
2005, n. 24643, P.) .....................................
– Quale soluzione al conflitto di decisioni in executivis? (Cass., Sez. I, 14 luglio 2005-5 luglio 2005, n.
26031, C.) ...............................................
Impugnazioni
– Inammissibilità del ricorso per cassazione e preclusione alla dichiarazione di estinzione per prescrizione (Cass., Sez. Un., 22 giugno 2005-22 marzo
2005, n. 23428, B.) ..................................................
1079
1081
1175
1176
1175
1171
1178
1180
1083
1082
1083
1083
1083
1075
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
1185
INDICI
– Sulla legittimazione ad impugnare del vice-procuratore onorario ..........................................................
Indagini preliminari
– Esame del D.N.A. e diritto al contraddittorio
(Cass., Sez. VI, 4 luglio 2005-28 aprile 2005, n.
24586, P.) ..................................................................
– L’effetto preclusivo dell’archiviazione (Cass., Sez.
I, 23 giugno 2005-28 aprile 2005, n. 23663, P.m. in
c. S.)...........................................................................
– Termini per le indagini e ritardata iscrizione del
nome dell’indagato nel registro generale delle notizie di reato (Corte cost. 22 luglio 2005-7 luglio
2005, n. 307).............................................................
Misure cautelari
– Misure cautelari personali: omesso deposito dell’ordinanza applicativa ed interrogatorio di garanzia (Cass., Sez. Un., 20 luglio 2005-28 giugno 2005,
n. 26798, V.).............................................
– Partecipazione all’udienza di riesame: scelta del detenuto o del giudice? (Cass., Sez. IV, 13 gennaio
2005-19 novembre 2004, n. 275, C.) con commento di Katia La Regina...............................
RIVISTE
1086
1084
1084
1070
1076
1129
– Regresso del procedimento, computo dei termini
di fase e rilevanza della custodia cautelare sofferta
in fasi o gradi non omogenei (Corte cost. 22 luglio
2005-7 luglio 2005, n. 299).......................................
– Sul momento di decorrenza del termine di durata
massima della custodia cautelare ............................
Penitenziario (Diritto)
– Liberazione anticipata, procedimento de plano e
contraddittorio differito eventuale (Corte cost. 19
luglio 2005-7 luglio 2005, n. 291) .............................
Procedimenti speciali
– Opposizione al decreto penale e modifica dell’imputazione nel procedimento conseguente...............
Soggetti
– Il difensore dell’irreperibile comunque abilitato al
patrocinio in cassazione (Cass., Sez. I, 6 giugno
2005-29 aprile 2005, n. 21045, S.) ..........................
– Il regime dell’incompatibilità a testimoniare nel
processo a carico degli enti di Alessandro Diddi ......
– La persona offesa tra garanzie individuali e class actions di Sergio Lorusso.................................................
1071
1087
1069
1087
1085
1166
1061
Il Fallimento e le altre procedure
concorsuali
Mensile di giurisprudenza e dottrina
Direzione scientifica: Umberto Apice, Aldo Aponte, Giuseppe Bozza,
Aldo Ceccherini, Antonino Dimundo, Massimo Fabiani, Lino Guglielmucci,
Giovanni Lo Cascio, Giuseppe Millozza, Luciano Panzani, Adriano Patti,
Alberto Russo Libertino, Giorgio Tarzia
Periodicità: mensile
La Rivista consente di seguire puntualmente l’evoluzione giurisprudenziale e
normativa di uno dei settori più significativi del diritto commerciale. È l’unico periodico che pubblica tutte le decisioni della
Corte di cassazione, dando anche conto
delle decisioni innovative della magistratura di merito, il tutto corredato da commenti o annotazioni ricchi di riferimenti e
di raffronti. La Rivista è completata da un
Massimario di merito, che propone un panorama nazionale delle decisioni più recenti.
Riservato agli abbonati, il primo portale
italiano in materia fallimentare consulta-
1186
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005
bile all’indirizzo internet www.fallimentonline.it fornisce un aggiornamento
tempestivo e completo sulla documentazione legislativa e giurisprudenziale più
recente.
Abbonamento annuale € 175,00
Per informazioni
• Servizio Informazioni Commerciali
(tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)
• Agente Ipsoa di zona (www.ipsoa.it/agenzie)
• www.ipsoa.it