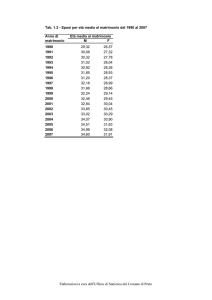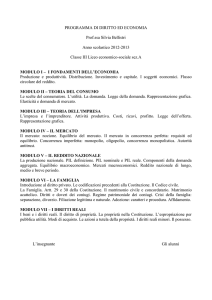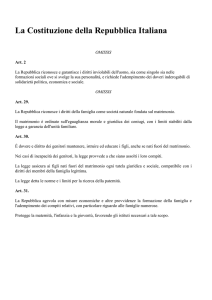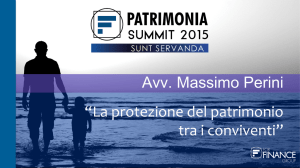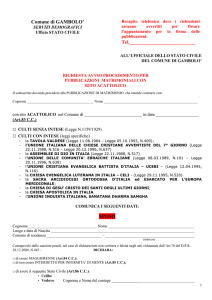caricato da
common.user21645
Diritto Oggettivo e Soggettivo: Appunti di Diritto Privato

SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO Lezione 1 diritto privato mod. B DIRITTO OGGETTIVO E DIRITTO SOGGETTIVO Il diritto oggettivo l’abbiamo definito come il sistema ordinamentale nel suo complesso, l’ordinamento giuridico ovvero l’insieme di regole e principi diretti a dirimere le controversie tra i consociati. Ibi societas ibi ius, laddove vi è una società di persone e di individui là deve esserci fisiologicamente il diritto, in quanto è quell’insieme di norme che serve a regolare conflitti. Sono strumenti attraverso i quali noi risolviamo i conflitti di interesse tra individui, il complesso di queste norme è il diritto oggettivo. Le norme vengono poste dalle fonti, ovvero atti e fatti idonei a produrre norme giuridiche. Il diritto soggettivo è invece quella soggettivazione dell’ordinamento. Bisogna immaginare l’ordinamento con il suo complesso di regole e principi che si individualizza fornendo una certa posizione al soggetto. Dal diritto oggettivo si giunge al diritto soggettivo. Se A=B, è diritto oggettivo, fattispecie astratta. La soggettivazione passa dalla fattispecie concreta. Più precisamente il diritto soggettivo segna il passaggio dalla volontà astratta della norma alla volontà concreta del soggetto che di quella norma si avvale per giustificare il suo potere. Il diritto soggettivo è infatti la prima e più importante situazione soggettiva, ovvero la posizione di un soggetto nei confronti di un altro soggetto o di un bene. È IL POTERE DI AGIRE DI UN SOGGETTO PER SODDISFARE UN PROPRIO INTERESSE PROTETTO DALL’ORDINAMENTO. Passiva= debitore, attiva= creditore, anche se non sono mai solo attive o solo passive. Anche creditore ha situazione passiva perché se non coopera incorre nella mora del creditore. Idem il debitore può avere interesse a liberarsi come rinunciare alla remissione. Soggettointeresseoggetto IL SOGGETTO Il soggetto è il titolare del diritto soggettivo, è legato alla situazione soggettiva dalla titolarità. Possono essere titolari di situazioni soggettive sia persone fisiche che persone giuridiche, anche se ovviamente cambia la disciplina (ad esempio cambia la durata dell’usufrutto). Oppure possono essere soggetti pubblici o privati, tendenzialmente i privati non avranno vincoli. Oppure può essere assente (concepito) L’INTERESSE Tensione del soggetto verso un bene, è il cuore della situazione soggettiva, è un interesse da perseguire, desiderio di un bene da realizzare. Interesse a conservare per i diritti reali e interesse a conseguire per i diritti di credito. L’OGGETTO Porzione del mondo esteriore sul quale il titolare esercita il potere. Può essere: - Una res, allora si parla di diritti assoluti Un comportamento, allora si parla di diritti relativi I diritti assoluti sono i diritti reali (proprietà e diritti reali minori) e della personalità (alla salute, al nome, alla vita, alla riservatezza). Possono essere fatti valere nei confronti di chiunque indistintamente. Hanno come situazione correlata l’obbligo. SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO Nel caso della proprietà non c’è una situazione giuridica soggettiva correlata direttamente, perché chiunque non deve ledere la proprietà altrui; si può dunque parlare di rapporto giuridico solo in chiave eventuale tutte le volte che un soggetto viola l’obbligo o entra in rapporto col proprietario. I diritti reali sono un numerus clausus, dunque sono legati al principio di tipicità. Possono inoltre esistere dei diritti reali su cosa altrui, dei diritti reali di godimento e dei diritti reali di garanzia. Tutte le azioni collegate ai diritti reali sono dette petitorie e sono: negatoria, di rivendicazione, di regolamento dei confini, di apposizione dei termini, talvolta poi si aggiunge l’azione di accertamento della proprietà. I diritti della personalità sono particolari perché l’oggetto esterno non c’è, bensì è lo stesso soggetto. Il titolare e il punto di riferimento oggettivo dell’interesse sono coincidenti. Hanno particolari caratteristiche: - - - - - Assolutezza, far valere il diritto nei confronti di tutti, è però tendenziale, si pensi alle molteplici cessioni di credito operate dallo stesso cedente. Sulla base del principio consensualistico l’unica cessione valida dovrebbe essere la prima; invece, la regola è che prevale colui che notifica per primo al debitore o che ha ottenuto l’accettazione se prevista. Quindi astrattamente il diritto può essere fatto valere nei confronti di chiunque ma questa regola si mescola con criteri legati all’apparenza, in questo caso accanto al principio del consenso traslativo opera che prevalgono criteri di inopponibilità. Ad esempio, nella doppia alienazione immobiliare, se un soggetto vende a più soggetti un immobile vince chi per primo ha trascritto nei pubblici registri immobiliari, non il primo che ha stipulato il contratto di compravendita per primo; quindi, avrà un diritto di proprietà non opponibile e non assoluto. Quindi quei diritti che mancano di assolutezza sono i diritti di proprietà inopponibile. Immediatezza, comporta che l’interesse del soggetto venga soddisfatto direttamente dal rapporto con la cosa, cioè l’interesse, il bisogno viene soddisfatto subito. Ad esempio, la proprietà, viene soddisfatto con la compravendita. Alcuni diritti reali però mancano di questa immediatezza, come la servitù negativa. La servitù è un peso imposto ad un fondo per maggiore utilità di un altro fondo vicino. Nelle servitù negative l’interesse del titolare del fondo dominante viene soddisfatto attraverso un comportamento negativo del titolare del fondo servente. (≠affermative, che consentono di fare una determinata azione tipo servitù di passaggio). Questa è una eccezione, dunque, al requisito della immediatezza, perché devono passare dal comportamento di un altro soggetto. Così come nell’ipoteca, manca l’immediatezza, l’interesse dell’ipotecario deve passare dall’iscrizione nei registri e dall’autorità giudiziaria che deve vendere il bene per dare il ricavato all’interessato. Diritti di seguito e inerenza passiva, particolare rapporto tra il diritto e il bene. Il diritto resta appiccicato al bene, tipo ipoteca e pegno. Segue il bene in tutti i suoi passaggi, quindi è un nesso particolare tra diritto e res. Infatti, il proprietario può rivendicare la sua proprietà da chiunque possegga il bene, quindi può andare a prenderlo da chiunque si trovi TRANNE che il possessore l’abbia usucapito. Numero chiuso o tassativi: il privato non può costituire diritti reali diversi da quelli che sono stati stabiliti dalla legge. L’autonomia del privato cioè non arriva a poter creare nuovi diritti reali, questo è detto principio del numero chiuso o tassatività dei diritti reali. Tipicità: indica che il privato non può mutare il contenuto di diritti reali già esistenti; quindi, non può né inventarsi diritti nuovi né modificare quelli già esistenti. La ratio rinviene nella circostanza che il diritto reale è da sempre considerato un impedimento al principio di massima circolazione dei beni e al principio di più intenso sfruttamento della ricchezza, che sarebbe compromesso dalla stratificazione di più diritti reali sullo stesso bene. Sarebbe un impedimento alla circolazione, dunque viene inteso con sfavore dall’ordinamento. SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO Questo però appartiene ad una impostazione piuttosto risalente, il problema di tipicità e numero chiuso è legato a concetti storicamente determinati, non è più una cultura giuridica nella quale noi ci troviamo. Oggi la proprietà immobiliare che era il fulcro delle costruzioni concettuali precedenti e che era la principale ricchezza dell’ordinamento non lo è più, oggi la ricchezza si è spostata verso la proprietà mobiliare, dunque, queste limitazioni non hanno più ragione di essere. Nascono infatti vincoli reali sui beni (Esempio: regolamento condominiale contrattuale predisposto dal costruttore o dall’originario proprietario e poi approvato singolarmente da ciascun condomino). I diritti relativi sono invece diritti di famiglia e diritti di credito. Diritti che possono essere esercitati nei confronti di uno o più soggetti determinati. Ai diritti di credito corrisponde l’obbligazione, a quelli di famiglia corrisponde l’obbligo. I diritti relativi hanno due caratteristiche: - - - Relatività, ci sono però dei diritti di credito assoluti. Ad esempio, la locazione (ultranovennale trascritta) permane nonostante la vendita del bene, la vendita non estingue la locazione. Eppure, la locazione è un contratto ad effetti obbligatori nel quale non ci sono trasferimenti di diritto ma solo situazioni credito-debitorie. Così come il contratto preliminare Mediatezza, ovvero il contrario dell’immediatezza. Implica che l’interesse può essere soddisfatto solo dal comportamento del soggetto passivo e non dal semplice rapporto con la res. Si attende quindi il comportamento di un altro soggetto. Eccezioni: il conduttore di un immobile soddisfa l’interesse solo attraverso il rapporto con la cosa essendo lo stesso un diritto di credito. Diritti di seguito e inerenza passiva sono assenti OBBLIGAZIONI PROPTER REM E ONERI REALI Vi sono poi delle situazioni intermedie tra diritti reali e diritti di credito ovvero le obbligazioni propter rem e gli oneri reali. Le prime sotto il profilo dell’identità sono delle obbligazioni, la particolarità è che il titolare passivo dell’obbligazione viene individuato di volta in volta nel titolare di un certo bene. È un’obbligazione attaccata ad una res, come se fosse un diritto reale. È una particolare forma di obbligazione che si individua nel profilo del soggetto; dunque, accessoria ad una situazione reale ed è ambulatoria ovvero il titolare varia in base al variare del proprietario. Ad esempio, spese di un bene comune, sono spese quindi debiti legati alla proprietà. Sono caratterizzate da occasionalità e danno luogo ad un’azione personale e non reale, in quanto sono obbligazioni vere e proprie (2740 cc) Gli oneri reali sono prestazioni periodiche di denaro o di altre cose fungibili, generiche, che devono essere effettuate in relazione ad un immobile. La differenza rispetto alle obbligazioni propter rem è che si tratta di prestazioni periodiche e che danno diritto ad un’azione reale sul bene, con altresì causa legittima di prelazione sul bene stesso. Lezione 2 diritto privato mod. b I BENI MATERIALI Art. 810 cc “Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti” Per cose dobbiamo intendere le entità materiali e immateriali e i criteri per valutare se queste siano idonee a soddisfare un bisogno umano per capire se sono beni. L’utilità non deve essere necessariamente individuale o patrimoniale, purché sia espressione di un interesse individuabile meritevole di tutela. Quindi si sta trattando di un bene quando si parla di una cosa, in grado di soddisfare un bisogno umano e quando quest’ultima può formare oggetto di diritti. SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO Le cose intese come beni sono dunque porzioni della materia; quindi, che possono essere percepite con i sensi, ma anche non come l’energia o le onde elettromagnetiche e che possono essere oggetto di diritto. Può formare un oggetto di diritto solo un oggetto su cui sia prospettabile un conflitto di interessi. Dobbiamo dunque escludere i beni comuni a tutti, acqua, aria, e devono essere suscettibili di valutazione economica ai sensi del 1174 cc. Classificazioni: - Beni materiali/immateriali Beni privati/pubblici, si distinguono in ragione della titolarità, non riguarda la natura dell’oggetto. Vi sono due requisiti: quello soggettivo che prevede che il bene pubblico sia di proprietà dello stato o di un ente pubblico, quello oggettivo che invece implica che il bene soddisfi un interesse collettivo. Distinguiamo tre categorie di beni pubblici: De magno pubblico: appartengono allo stato e fanno parte del de magno pubblico il lido del mare, i fiumi, le strade, gli immobili di interesse storico ecc. Detti beni demaniali art. 822 cc e sono taluni ad appartenenza necessaria, cioè che non possono che appartenere allo stato come il lido del mare, i porti e i fiumi, mentre altri che fanno parte del de Magno SOLO se di appartenenza dello Stato. Ciò significa che sono posti a questo regime del de magno solo se appartenenti allo stato come strade, autostrade e immobili di interesse storico, che possono anche essere di privati ed essere ricompresi nella legge 42 del 2004 che ne disciplina i modi di utilizzo. La disciplina dei beni demaniali è che sono inalienabili (no vendita), inespropriabili (no azione terzi vittoriose), non usucapibili, non ipotecabili. Beni patrimoniali indisponibili: art. 826 fa lungo elenco come foreste, miniere, cave, cose di interesse storico che non rientrino nel de magno ecc. molto dettagliata. Dobbiamo esaminare però la disciplina, poiché hanno la caratteristica di essere nella proprietà dello Stato o di enti pubblici territoriali e dell’essere stati oggetto di destinazione a interesse pubblico o pubblico servizio. In presenza di queste caratteristiche: titolarità, manifestazione della volontà e destinazione allora il bene appartiene al patrimonio pubblico indisponibile, con la conseguenza che i beni non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge, in particolare dalle singole leggi che li riguardano. Tutti gli altri beni non destinati a finalità di pubblico interesse, dunque, che non siano demaniali e appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato sono considerati disponibili. Beni patrimoniali disponibili: non hanno finalità di pubblico interesse, dunque, lo Stato si comporta come un titolare qualunque, vigono le regole di diritto comune. Esiste poi un particolare regime per i beni culturali - - Beni divisibili/indivisibili, ovvero quei beni la cui suddivisione non è possibile materialmente o giuridicamente. I divisibili sono frazionabili in parti omogenee, ciascuna parte deve conservare un valore economico proporzionale al tutto. Sono non frazionabili invece quei beni non divisibili o meglio che non possono essere frazionati in parti omogenee o che non possono essere frazionati senza perdere utilità economica. Tipo mucca non è frazionabile o una macchina, ma un immobile può essere divisibile o meno, dipende da come è strutturato. Un immobile su tre piani ciascuno identico all’altro è divisibile, ciò conta in sede di divisione, oppure una cascina con cortile che non può essere divisa senza ledere pregio economico o divisa in parti uguale. Quindi la frazionabilità deve essere concepita in chiave economico-funzionale. Abbiamo già visto delle ricadute nelle obbligazioni, a seconda che fossero divisibili o meno c’era regime differente. Beni consumabili/inconsumabili: i primi sono quelli che si trasformano per effetto dell’uso, quindi perdono la loro originaria funzione. Sono invece inconsumabili quelli che si prestano ad una utilizzazione perpetua restando sostanzialmente inalterati. Questa distinzione acquista valore SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO - - - anch’essa sotto il profilo della qualificazione del rapporto, solo i beni inconsumabili e fruttiferi possono formare oggetto di usufrutto. Beni fungibili (denaro)/infungibili, ovvero quelli non sostituibili indifferentemente con altri beni, sono determinati e unici. Quelli fungibili possono essere quantificati in peso, numero e misura. Il denaro è il bene fungibile per eccellenza, ma la banconota può anche essere un bene infungibile, tipo se ci fosse sopra un autografo. I beni mobili sono generalmente infungibili. Beni mobili (carattere residuale) /immobili (art. 812 cc) /mobili registrati: i beni immobili sono tutti i beni naturalmente o artificialmente incorporati al suolo (immobili per natura o per destinazione). Hanno un trattamento differente, per i beni immobili esistono il catasto e i pubblici registri immobiliari che accertano la loro esistenza e la loro appartenenza necessaria, è una sorta di individuazione attraverso l’erario, la loro circolazione è vincolata da diverse formalità, sono soggetti ad un regime di pubblicità. I beni mobili possono non essere di appartenenza a qualcuno, res nullius. Diverso è il discorso dei beni mobili registrati, che presentano delle caratteristiche simili agli immobili, come l’iscrizione nei pubblici registri. I beni immobili vacanti appartengono allo Stato, sono diverse poi le discipline di possesso e usucapione. Per le universalità di beni si fa riferimento a un complesso di beni appartenenti ad una stessa persona che hanno una destinazione unitaria. Hanno diverse modalità di circolazione i mobili sono oggetto di pegno, immobili di ipoteca. Beni fruttiferi/infruttiferi: alcuni beni, detti fruttiferi, ne producono altri, detti frutti. I frutti naturali provengono direttamente dalla cosa senza che operi l’uomo (raccolto di un campo), quelli civili invece si ottengono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia, sono ad esempio i canoni di locazione di un immobile o interessi dei capitali. La differenza sta in particolare nell’acquisto, i frutti naturali appartengono al proprietario della cosa principale sino alla separazione, nella vendita dei frutti fin quando questi non si staccano la proprietà non passa. I civili si acquistano di giorno in giorno quindi con il passare del tempo il proprietario dell’immobile acquista il credito per il canone della locazione. Per certi rapporti si porranno delle distinzioni, ad esempio solo i beni fruttiferi potranno formare oggetto di usufrutto. Le pertinenze: viene ora in considerazione il rapporto tra cosa accessoria e principale, la prima è dunque posta al servizio della seconda. Necessari sono l’elemento oggettivo di strumentalità e complementarità e l’elemento soggettivo ovvero la volontà del proprietario di destinarla al servizio della principale. Nelle cose composte invece viene meno l’individualità della cosa se separata, ad esempio, il motore dell’autovettura. Le universalità di beni invece riguardano beni con destinazione unitaria di appartenenza dello stesso soggetto, anche se non perdono l’utilità individuale se separate. Lezione 3 diritto privato mod. b IL DIRITTO DI PROPRIETÀ Articolo 42 Costituzione, è nella sezione dell’economia, è un mezzo con il quale l’individuo afferma la sua volontà. “La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.” Accanto a questo articolo collochiamo l’articolo 17 della CEDU, dunque, le fonti internazionali che riconoscono il diritto di proprietà. Art. 832 “Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico” La Costituzione italiana esplicita che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dall’ordinamento e dalla legge, e ne assicura la funzione sociale disciplinandone l’acquisto, il godimento e i vari limiti. SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO La proprietà privata non può dunque essere abrogata dal legislatore ordinario, questi può solo confermare il contenuto della proprietà per garantire la rilevanza della sua finalità sociale. La proprietà presenta 3 importanti caratteristiche: - - Elasticità: alcuni poteri appartenenti al proprietario devono essere elastici ovvero tollerare la presenza di altri eventuali diritti reali minori sullo stesso bene, come le servitù. Imprescrittibilità: la proprietà non può essere persa per uso, ma solo per usucapione. Il proprietario potrebbe abbandonarlo, non usarlo, salvo che altri invece non entrino in possesso del medesimo bene, lui rimane proprietario. Perpetuità: non può essere limitata dal tempo LA FACOLTÀ DI GODIMENTO E DISPOSIZIONE, LA PIENEZZA E L’ESCLUSIVITÀ DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ Il proprietario ha la facoltà di godere delle cose, cioè di utilizzarle o meno, di decidere come utilizzarle, di trasformarle, di distruggerle… stessa cosa per le cose fruttifere e i relativi frutti. La facoltà di godimento indica la disposizione materiale della cosa, che è diversa da quella giuridica, da questo punto di vista il proprietario ha la facoltà di vendere o meno il bene, di donarlo o non donarlo, di lasciarlo per testamento eccetera. Con dei limiti però: Art. 838, già prima della costituzione, pone la regola della espropriabilità dei beni in alcune circostanze, trascurato da proprietario. “Salve le disposizioni delle leggi penali e di polizia, nonché le norme dell'ordinamento corporativo e le disposizioni particolari concernenti beni determinati, quando il proprietario abbandona la conservazione, la coltivazione o l'esercizio di beni che interessano la produzione nazionale, in modo da nuocere gravemente alle esigenze della produzione stessa, può farsi luogo all'espropriazione dei beni da parte dell'autorità amministrativa, premesso il pagamento di una giusta indennità.” Il proprietario può godere e disporre in modo pieno, ciò significa che il proprietario può fare tutto ciò che desidera con il bene a meno che non gli venga imposto da una legge di fare o non fare qualcosa. La pienezza viene meno soltanto nel caso in cui sul bene si costituisca un diritto reale altrui, il proprietario sarà dunque detto nudo proprietario. In questo caso la pienezza non viene realmente meno, perché qualora si estingua il diritto reale altrui sulla cosa per il concetto di elasticità il nudo proprietario riprende la pienezza. Infine, il diritto di proprietà è esclusivo, cioè il proprietario può escludere chiunque altro dal godimento del bene, anche tramite offendicula (tipo filo spinato, basta che non crei tranelli e sia visibile). Questo implica che la proprietà sia tutelata da norme di diritto penale, ad esempio in caso di violazione. I LIMITI AL DIRITTO DI PROPRIETÀ I limiti sono previsti dalla legge e dal codice per correggere i caratteri di esclusività e pienezza del diritto di proprietà. Vi sono dunque dei limiti e degli obblighi imposti al proprietario; per quanto riguarda i limiti imposti al godimento del bene si suole distinguere i limiti imposti per ragioni di pubblico interesse e limiti previsti per la salvaguardia di concorrenti diritti degli altri soggetti. La ratio è quella di equilibrare due interessi contrapposti vedi libro. Il primo limite deriva dall’articolo 42 primo comma, il legislatore può confermare o meno il contenuto della proprietà per garantire la sua funzione sociale. Intanto in diritto è riconosciuto e tutelato in quanto il godimento e l’uso siano congruenti con l’interesse che anima la situazione. Non deve pertanto avere come contenuto un esercizio contro funzionale che si possa interpretare con abuso di diritto. Prima era consentito qualunque uso del bene tranne quando vietato, vi era un’epoca nella quale la proprietà sentiva ancora la sua origine, essendo un diritto nato dal sentimento egoistico dell’uomo di riconoscere se stesso SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO nel potere da esercitare su una cosa. L’uomo era libero ed eguale in quanto proprietario, era dunque un potere assoluto. Poi la proprietà diventa strumento di iniziativa economica, si inserisce nella produzione, dunque, dall’individualismo proprietario si passa ad una solidarietà produttivistica, tipica dell’epoca fascista. Proprietà come strumento di iniziativa economica (ecco il perché del 838). Il terzo passaggio storico della proprietà è segnato dalla Costituzione con la prospettiva solidaristica e non più produttivistica dell’art. 42. L’uomo è protetto non per ciò che ha ma per ciò che è. La proprietà non viene più garantita come diritto fondamentale ma viene tutelata in ragione della funzione sociale e della potenziale accessibilità a tutti per la realizzazione di equi rapporti sociali. La proprietà viene quindi riletta in chiave solidaristica e personalistica. Ed è in questa chiave che tutti gli istituti del diritto di proprietà devono essere riletti. La prima norma generale è quella che vieta gli atti di emulazione, ovvero quegli atti che il proprietario compie per non altro che recare molestia o nuocere altri (art. 833 cc). “Il proprietario non può fare atti, i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri” Gli atti emulativi possiedono tre elementi fondamentali: un atto di esercizio della proprietà, lo scopo di arrecare un pregiudizio, l’inutilità dell’atto. Si ritiene che la ratio di questo divieto si rinvenga nell’abuso del diritto, una figura non codificata che si ritrova nell’uso del diritto per il raggiungimento di interessi ritenuti non meritevoli, non l’interesse di godere e disporre. Bisogna fare una valutazione comparativa degli interessi del proprietario e del vicino. Sentenza 1209 del 2013 I LIMITI IMPOSTI PER RAGIONI DI PUBBLICO INTERESSE: - Espropriazione (art. 834): nessuno può essere privato della proprietà se non per ragioni di pubblico interesse legalmente dichiarate e contro il pagamento di una giusta indennità. L’espropriazione viene generalmente indicata come espropriazione traslativa, ovvero il trasferimento della proprietà del bene dal proprietario al beneficiario. Esistono però dei limiti espropriativi che non implicano il trasferimento della proprietà, ma lo svuotamento di essa. L’espropriazione si può verificare in caso di un interesse generale oppure di una previsione legislativa. Vi sono poi importanti criteri per la quantificazione dell’indennizzo, deve essere un serio ristoro del pregiudizio subito dal proprietario a seguito dell’espropriazione. Non deve essere un indennizzo né simbolico né irrisorio, più che altro un serio ristoro: Per l’area non edificabile coltivata si deve tenere conto del valore agricolo del terreno+colture praticate+manufatti sul terreno Per l’area edificabile il valore venale Per i casi di limite espropriativo si calcola il danno effettivamente cagionato Se il privato concede il bene allora è previsto un indennizzo superiore. Un’ipotesi particolare è l’acquisizione sanante (art. 42 bis del DPR 327/2001), cioè una fattispecie ai confini del comportamento abusivo della pubblica amministrazione. I presupposti sono che un’autorità amministrativa utilizzi in concreto, di fatto un bene senza preventivo provvedimento autorizzativo o disposizione di legge che preveda l’espropriazione. Allora può disporre di acquisire il bene al suo patrimonio disponibile per un interesse pubblico con un indennizzo pari al 10% del valore del bene. È un comportamento con il quale bypassando tutte le procedure legate all’esproprio di fatto si sottrae la proprietà e ci si appropria con una sanatoria ex post. La giurisprudenza civile è molto critica su questo e dice che deve essere utilizzata solo in caso di concrete ed eccezionali motivazioni di interesse pubblico, quali la restituzione al proprietario o la sua acquisizione consensuale, dunque deve essere estrema ratio. Prima si deve valutare l’eventualità di restituire il bene dopo averlo utilizzato o aver avuto la cessione del proprietario, deve essere ultima possibilità dopo queste e deve essere motivata nella sua ragione di interesse SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO pubblico. Si noti che la Cassazione si è pronunciata in merito alla natura irrisoria di questo indennizzo, non vi è un deficit di tutela delle parti, perché il legislatore ha previsto una clausola di salvaguardia ovvero l’articolo 42 bis comma 3 seconda parte che fa salva la prova di una diversa entità del danno che dunque può essere rimodulato dal giudice in meglio o in peggio in ogni caso così correggendo la quantificazione forfettaria operata dalla legge. - - Requisizione: quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili può essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili con giusta indennità al proprietario. È prevista da leggi speciali. Per i beni mobili si perde la proprietà del bene, quindi espropriazione, per gli immobili invece vi è un carattere temporaneo della requisizione. Limiti alla proprietà edilizia: Quando ci riferiamo alla proprietà edilizia ci riferiamo ad un certo aspetto del diritto di proprietà che concerne la materia regolata dai piani regolatori. È molto complessa, noi troviamo al suo interno l’intersecarsi di più fonti. Va a toccare l’assolutezza del godere e disporre: La prima è la legge urbanistica del 1942 numero 1150, qui troviamo le regole che servono per formare il piano regolatore generale, che è lo strumento principale della pianificazione urbanistica comunale. Questo piano prevede sulla base dell’accertamento dello stato di fatto e delle previsioni di sviluppo di un comune la destinazione delle varie aree, con connesse possibilità di sfruttamento edificatorio, di interventi realizzabili e di aree da destinare a servizi pubblici. (se sono proprietario di un fondo che è indicato come fondo agricolo non potrò costruire) Le norme di indirizzo sulla formazione del piano ed ogni altra norma relativa ai procedimenti è affidata invece a leggi regionali. Vi sono poi piani particolareggiati redatti per specifiche porzioni del territorio comunale ai fini di una più conveniente sistemazione urbanistica. In chiave attuativa delle disposizioni di legge vi è il dpr 380 del 2001. Questo dpr contiene una serie di prescrizioni cioè gli adempimenti che occorre eseguire qualora sul bene in proprietà si vogliano operare degli interventi. In generale vi sono degli adempimenti legati all’attività edilizia: avere il permesso di costruire (in caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni), segnalazione certificata di inizio dell’attività detta SCIA (come interventi di restauro), attività edilizia libera in alcuni casi (non serve titolo abilitativo per eliminare barriere architettoniche ad esempio) previa comunicazione, per interventi residuali basta una comunicazione di inizio lavori. Vi sono poi diverse sanzioni penali per l’abuso edilizio, in difformità o violazione delle norme citate: Risarcimento per chi abbia subito un danno per effetto della violazione, fatta salva la possibilità di riduzione in pristino in caso di violazione di norme sulle distanze. (art. 872 comma 2 cc) Nullità di atti tra vivi in forma pubblica o privata con oggetto il trasferimento, costituzione, scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni privi di certificato di destinazione urbanistica. (art. 30 comma 2, dpr 380/2001) Atti di cui sopra la cui costruzione sia iniziata dopo il 17 marzo 1985 e riguardi edifici o loro parti privi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, con possibilità di integrazione successiva. (art. 46, applicabile anche alla SCIA, solo ai contratti con effetti reali, inapplicabile al contratto preliminare di compravendita, altri contratti ad effetti obbligatori e costituzione, modificazione ed estinzione dei diritti reali di garanzia e servitù, poi integrazione successiva che riporti l’adempimento omesso) LIMITI IMPOSTI PER SALVAGUARDARE I CONCORRENTI DIRITTI DI ALTRI SOGGETTI: - Le distanze legali: art. 873 ss cc; il primo limite è quello delle distanze nelle costruzioni, il proprietario di un fondo finitimo deve costruire a non meno di tre metri (per prevenzione SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO temporale il primo che costruisce è favorito, il confinante che costruisce per primo condiziona la scelta del vicino). Si può costruire in aderenza o rispettando i 3 metri. La sanzione nel caso di abuso è quella di rimozione della costruzione realizzata abusivamente e risarcimento del danno. Gli strumenti urbanistici locali possono anche prevedere distanze superiori a tre metri, la sanzione qui sarà differentemente modulata e analizzata dall’interprete, se si tratta di un limite posto a tutela dell’interesse privato (stessa sanzione) oppure limite posto a tutela dell’interesse generale (unico strumento è risarcimento del danno). Una particolare disciplina è prevista per il muro di confine, tra due fondi o edifici: 1) Presunzione di comunione, il muro che serve da divisione tra due fondi o edifici si presume comune fino a prova contraria. 2) Possibilità di acquisire la comproprietà, pagando metà del suo valore+metà del valore del suolo, con sentenza costitutiva in caso di diniego da parte del proprietario del fondo dominante. È un tipico diritto potestativo. Le stesse regole si applicano in caso di innalzamento del muro. Tutto ciò predispone che le proprietà siano sempre delimitate, sia orizzontalmente (rappresentate dai confini del fondo, in quei confini il proprietario è sovrano. Anche qua ci sono però delle limitazioni, il proprietario ha diritto di chiudere il fondo in qualunque tempo ma non può impedire l’accesso al fondo da parte di chi eserciti la caccia salvo che non ci siano delle coltivazioni suscettibili di danno oppure l’accesso a chi ha necessità di costruire muro o opera. È vero che il diritto è pieno ed esclusivo ma è vero anche che in talune circostanze il proprietario deve consentire l’accesso al fondo) sia verticalmente (verticalmente non vale più il principio usque ad sidera usque ad inferos. Tendenzialmente appartiene al proprietario del fondo tutta la colonna d’aria sovra e sottostante, ma il proprietario non può opporsi all’attività di terzi che si ponga a tale altezza o profondità che egli non abbia interesse ad escludere. La chiave dunque è ancora la rilevanza dell’interesse proprietario, si può opporre solo se tale comportamento compromette il suo interesse proprietario). La disciplina del muro che non è posto sul confine è la seguente: - - 1) Se il muro non è sul confine ma si trova ad una distanza inferiore ad un metro e mezzo dal confine il proprietario può chiedere la comunione solo per fabbricare in aderenza. A quel punto sarà costretto a pagare il valore di metà del muro e il valore del suolo. È onere preventivo interpellare il proprietario che può però scegliere di estendere il muro sino al confine, così che non debba cedere il terreno. 2) L’ordinamento pone anche una serie di disposizioni di distanze minime di pozzi, cisterne, piantagioni, fossi ecc. Luci e vedute: sono entrambe aperture sul fondo del vicino. Le luci consentono il passaggio di luce e aria ma non l’affaccio, le vedute danno possibilità di affaccio frontale o obliquo. Il codice si premura di disciplinare le distanze tra luci e vedute con il fondo vicino. Vi è la possibilità di richiedere la regolarizzazione o la chiusura delle luci irregolari; il giudice può accogliere la domanda e ingiungere al confinante di rendere le luci conformi alle prescrizioni dell’articolo 901. Per le vedute esistono alcune prescrizioni che riguardano le distanze rispetto al fondo del vicino. Infine, una norma regola la distanza delle costruzioni da fabbricare dalle vedute. Lo stillicidio e le acque: il proprietario deve fare in modo che le acque piovane dai tetti non scolino nel fondo del vicino. In presenza di pubblici scolatoi il proprietario deve farveli affluire. Tutte le acque costituiscono attualmente un bene pubblico quindi l’utilizzazione su fondo privato è considerata come concessione amministrativa. Il proprietario ha diritto di utilizzo e godimento delle acque nel suo fondo, ma deve adempiere al dovere di non sviare le acque a danno di altri fondi. Può inoltre utilizzare anche le acque che costeggiano il suo fondo e non può rifiutarsi di ricevere le acque dei fondi che si trovano a monte. In generale sarà il giudice a valutare gli interessi delle parti SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO - in rapporto all’agricoltura ed eventuale indennità. Vi sono stati tantissimi casi portati in corte di cassazione. Il divieto di immissioni: art. 844; “il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.” Le immissioni sono dunque afflusso sul proprio fondo di elementi di disturbo quali fumo, rumore ecc. la normale tollerabilità bisogna assimilarla ad una tollerabilità della persona media, secondo anche la cosiddetta coscienza sociale. Bisogna sempre avere riguardo alle circostanze del caso concreto, in ogni caso bisogna valutare mediamente, non si tengono in considerazione iper o iposensibilità dei singoli. Il giudice dovrà anche compiere altre considerazioni, in particolare riguardo alle condizioni dei luoghi, ovvero morfologia del territorio e dei luoghi ed eventuale destinazione urbanistica e sociale di quel territorio. Valgono come criteri tutti i parametri indicati dalla legislazione speciale, in cui troviamo individuate talune soglie di tollerabilità ad esempio nell’inquinamento acustico. L’interpretazione tradizionale è quella secondo cui qualora vi siano delle esigenze della produzione (impianti industriali) questi prevalgono sull’interesse individuale (art. 844, comma 2). Oggi però il diritto alla salute è superiore alle esigenze della produzione, secondo la cassazione le immissioni superiori alla normale tollerabilità che compromettono il diritto alla salute non sono giustificate neppure se derivano esigenze produttive. Quando si riesce ad affermare ciò il giudice deve condannare a porre in essere accorgimenti tecnici che facciano cessare o riducano l’immissione oppure condanna alla cessazione dell’attività, in ogni caso salvo il risarcimento del danno. Bisogna infine ricordare come l’azione abbia carattere negatorio e sia dunque imprescrittibile. GLI OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO Gli obblighi del proprietario sono previsti sia dal Codice civile che da svariate leggi speciali. Il proprietario secondo l’art. 843 cc deve consentire l’accesso e passaggio sul proprio fondo laddove ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare muro o altra opera propria del vicino o opera comune. Il proprietario è tenuto a pagare alcune imposte sui beni, come quelle sulla casa. I MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ Si può diventare proprietari nei modi previsti dalla legge in particolare all’articolo 922 cc. “La proprietà si acquista per occupazione, per invenzione, per accessione, per specificazione, per unione o commistione, per usucapione, per effetto di contratti, per successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge.” I nove modi si distinguono in modi di acquisto a titolo originario o a titolo derivativo. - L’acquisto della proprietà a titolo derivativo si hanno quando si acquista la proprietà da un precedente proprietario. La particolarità sta nel fatto che l’avente causa acquista la proprietà solo e solo come il dante causa ne era proprietario. Individuiamo il dante causa che è il precedente titolare, cioè chi dà titolo alla trasmissione del diritto, e l’avente causa che subentra nello stesso diritto del proprietario. (nemo plus iuris in alium trasferre potest, quam ipse habet). Con il contratto di compravendita, ad esempio, il bene è trasferito dal venditore al compratore; oppure con la morte del de cuius i beni del suo patrimonio diventano di proprietà degli eredi. La caratteristica sta nel fatto che chi acquista la proprietà l’acquista solo e solo come il dante causa ne era proprietario, con eventuali vizi annessi. SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO - L’acquisto a titolo originario invece comporta l’indipendenza dal precedente proprietario. La proprietà in questo caso, dunque, si libera da tutti gli eventuali diritti altrui che gravavano il bene del precedente proprietario. Sorge un diritto nuovo ed indipendente dalla titolarità precedente. Ad esempio, con l’usucapione si perdono tutti gli eventuali diritti. La differenza quindi si coglie nella presenza di diritti reali minori di terzi gravanti sul bene, nell’acquisto a titolo derivativo si trasmettono nell’altro no. L’acquisto a titolo originario, dunque, comporta non solo l’estinzione del diritto del precedente proprietario, ma anche eventuali diritti reali minori e di garanzia che gravavano il bene. I modi di acquisto a titolo originario sono: - Usucapione Occupazione Invenzione Accessione (unione, commistione, specificazione) Occupazione Modo di acquisto a titolo originario che riguarda esclusivamente i beni mobili che siano res nullius, cioè cose di nessuno, abbandonate, e gli animali che formano oggetto di caccia e pesca. Si deve anche in questo caso dimostrare la circostanza che il bene sia abbandonato. L’abbandono possiamo definirlo come una volontaria dismissione del bene. Non si deve trattare di uno smarrimento poiché è involontario e rientra nell’invenzione. L’occupazione consiste nell’impossessamento materiale del bene, che determina l’acquisto della proprietà immediato a titolo originario, in presenza dei presupposti (cosa abbandonata, anche animali oggetto di caccia e di pesca, gli sciami d’api e gli animali sfuggiti al proprietario secondo leggi speciali del cc). Si applica solo ai beni mobili perché i beni immobili non ammettono abbandono, i beni immobili abbandonati appartengono allo stato (vedi lezione 2). Invenzione La linea di confine con l’occupazione riguarda lo smarrimento e non il volontario abbandono. Non c’è la volontà del vecchio proprietario di rinunciare al diritto, questi ha colpevolmente o meno smarrito il suo bene. Non è sufficiente l’appropriazione, si deve attivare una procedura che comporta la restituzione innanzitutto al sindaco del comune, se non si conosce ovviamente il proprietario, il quale pubblicherà nell’albo pretorio il ritrovamento del bene. L’avviso deve rimanere fisso per due domeniche consecutive per tre giorni almeno. È un albo utile per tutti gli atti necessitanti di pubblicazione come il matrimonio. Quindi se ho smarrito qualcosa devo recarmi a vedere l’albo per controllare un eventuale ritrovamento. Qualora il proprietario lo trovi reclama il suo bene, lo riprende e dà un premio al ritrovatore della misura di un decimo del valore. Se invece trascorre un certo periodo di tempo di un anno senza che il proprietario reclama il ritrovatore acquista la proprietà. Una disciplina particolare è prevista per il tesoro (cosa mobile di pregio sotterrata o nascosta). Il caso del ritrovamento del tesoro dice il 932 cc che salvo che non si tratti di beni di interesse storico, artistico, archeologico, paletnologico, paleontologico ecc. tutti ambiti per i quali opera il codice dei beni culturali, il tesoro appartiene al proprietario del fondo, con l’unica particolarità del caso in cui il ritrovatore sia una persona diversa dal proprietario del fondo. In tal caso la proprietà è divisa per metà al proprietario del fondo e metà al ritrovatore. Accessione Innanzitutto, è un principio tecnico generale che si giustifica in ragione del fenomeno espansivo della proprietà. Il principio vuole che per fatti naturali o umani cose appartenenti a proprietari diversi sono attratte in un’unica situazione, per cui vi è una proprietà che si amplia e una che si restringe. Quindi la regola è quella del necessario bilanciamento tra due situazioni proprietarie, nell’ambito delle quali si è SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO verificato un allargamento della proprietà da una parte e un restringimento consequenziale dall’altra parte. La ratio legata alla regola dell’accessione è quella di evitare che su singole porzioni di beni gravino più situazioni reali e che ogni bene possa avere un razionale godimento, che sarebbe pregiudicato dalla concorrenza di diritti. Per cui l’ordinamento sceglie di attribuire la proprietà alla situazione che considera prevalente e all’altra situazione che viene ridotta viene attribuito un indennizzo. Queste sono le linee generali dell’accessione che ha delle applicazioni concrete e pratiche: la regola del 934 cc dice che qualunque piantagione, costruzione o opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario del suolo. Quindi qualunque opera o costruzione venga fatta sopra o sotto il fondo appartiene per attrazione al proprietario del fondo. La situazione maggiore, prevalente è quella del proprietario del fondo, l’ordinamento poi indennizzerà chi ha perso la proprietà (applicazione del principio della proprietà in verticale, che si estende dalle stelle agli inferi). L’accessione prevede tre modulazioni: - - - Accessione di immobile a immobile: è il fenomeno di attrazione che si ha tra due beni immobili. È il caso dell’alluvione e dell’avulsione. La prima è l’incremento progressivo di un fondo per il distacco da un altro fondo di detriti trasportati dall’acqua corrente. Ipotesi di due fondi limitrofi lambiti da un corso d’acqua. La seconda invece è l’incremento di un fondo per distacco di parte considerevole e riconoscibile di un altro fondo, determinato da un’azione improvvisa dell’acqua; solo per l’avulsione è presente un’indennità per l’altra parte commisurato al valore dell’incremento del proprio fondo. Qui c’è la stessa situazione di fatto ma il distacco non è progressivo, è di una parte considerevole ed è improvviso. In entrambi i casi la proprietà viene accordata al fondo che riceve, ma nel secondo caso vi è concessa una somma di denaro a titolo di indennizzo per chi perde la proprietà. Accessione di mobile a immobile: in questo caso vengono compiute delle opere sul fondo di un soggetto con materiale di un altro soggetto. Quindi l’immobile è il fondo di un soggetto, il mobile è il materiale utilizzato per il compimento dell’opera. La disciplina copre l’ipotesi nella quale il proprietario costruisca un’opera con materiali altrui (prende mattoni del vicino e costruisce capanno) oppure soggetto terzo che con materiali propri costruisce su fondo altrui. L’attrazione è tra proprietà del fondo e del materiale. Qui l’ordinamento si occupa solo di capire di chi è il bene, ciascuna ipotesi ha una particolare disciplina da utilizzare. Basta sapere che i criteri per capire di chi è la proprietà sono vari e sono: Proprietà può essere rimossa, se no la proprietà spetta al proprietario del fondo che dovrà di volta in volta il valore dei materiali e della manodopera oppure pagare l’aumento di valore che il fondo ha tratto dalla nuova opera. Accessione di mobile a mobile: unione e commistione e specificazione. Si tratta dell’unione o della mescolanza di cose mobili appartenenti a proprietari diversi, mescolanza in guisa da formare un sol tutto. Esempio la creazione di un anello nel quale il cerchio d’oro è di tizio e il diamante di caio. La regola generale è che se c’è una cosa principale e una cosa secondaria la principale attrae la secondaria nella proprietà. Se non c’è una cosa principale e una cosa secondaria entrambi possono chiedere la separazione del bene, se non è possibile si crea una comunione dei diritti. La specificazione invece contrariamente all’unione e alla commistione è la creazione di un nuovo bene con materiale altrui. Quello che si unisce nella specificazione è il materiale con il lavoro, cioè si uniscono materiale e lavoro, manodopera non due materiali. La regola generale è quella che prevede che la proprietà spetti al lavoratore purché il valore del lavoro risulti prevalente rispetto al valore della manodopera. L’interesse più meritevole, dunque, è il lavoro se può considerarsi prevalente rispetto al valore della materia. Ovviamente il lavoratore deve pagare il valore della materia. È la meritevolezza dell’interesse che guida la proprietà anche se colui che perde deve essere indennizzato. SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO ECCEZIONI ALL’ACCESSIONE: Una prima eccezione è l’accessione invertita, ovvero l’ipotesi nella quale un proprietario occupi in buona fede una porzione di fondo attivo per costruirvi un’opera o un edificio. Ovverosia sconfini sulla proprietà limitrofa in buona fede nel compimento di lavori di costruzione. Qui accade che l’occupante possa acquistare la proprietà del suolo se decorrono tre mesi dall’inizio della costruzione senza che vi sia stata opposizione da parte del proprietario del fondo occupato, previo pagamento del doppio della superficie del suolo occupato. È detta invertita perché la costruzione dovrebbe a regola andare ad appartenere al proprietario del suolo. Qui invece succede che chi costruisce l’opera acquisisce anche la proprietà del fondo; ovviamente ci vogliono dei presupposti molto rigorosi: occupazione in buona fede, non deve esserci opposizione da parte del proprietario del fondo che ha diritto di opporsi entro tre mesi. AZIONI A TUTELA DELLA PROPRIETÀ Sono le azioni che vengono riconosciute e attribuite al proprietario per far valere il proprio diritto. Sono le cosiddette azioni petitorie, dal latino peto che significa chiedere per ottenere, reclamare, pretendere. Sono volte a reclamare la proprietà e sono azioni di natura reale perché sono gli strumenti per far valere il diritto reale. Si tratta dell’azione di rivendicazione, dell’azione negatoria, di regolamento di confini e apposizione dei termini e azione di mero accertamento della proprietà. Azione di rivendicazione È prevista dal 948 ed è diretta all’accertamento della qualità di proprietario in prima battuta ed è volta ad ottenere poi la restituzione del bene verso chiunque lo detenga o lo possegga. L’azione di rivendicazione, infatti, vede il conflitto tra il proprietario e il possessore e si realizza allorché il proprietario abbia quindi perso il possesso della cosa che invece ha un altro soggetto. L’azione sarà quindi diretta a far accertare che chi agisce è il vero proprietario e compiuto ciò che il bene sia restituito. È dunque un’azione che spetta al proprietario come tutte le azioni petitorie, ma che può essere esercitata nei confronti di chiunque detenga o possegga il bene anche qualora questo soggetto che aveva posseduto si sia disfatto del bene; a quel punto qualora soccomba nell’azione di rivendica l’ex possessore o detentore deve recuperare il bene oppure corrisponderne il valore. Proprio perché è un’azione che vede lo scontro tra proprietà e possesso e dunque vi è una situazione di fondo nella quale taluno si afferma proprietario ma nella realtà il bene è di un altro, l’ordinamento chiede una prova molto forte a chi si afferma proprietario: la cosiddetta probatio diabolica, deve essere in grado di superare ogni elemento di eventuale incertezza, quindi il proprietario che reclama non può soltanto mostrare il titolo d’acquisto o l’atto di accettazione dell’eredità, bensì deve dimostrare un acquisto a titolo originario, perché per il caso in cui il proprietario che agisce in rivendicazione abbia acquistato a non domino (da un soggetto che non era proprietario) questi non ha acquistato nulla (nemo plus iuris ecc, non si può trasferire una situazione che non si ha). A chi agisce in rivendica si chiede una prova forte del diritto di proprietà che non si limiti solo al titolo di acquisto ma che tramite gli istituti di successione e accessione nel possesso riesca a consolidare il titolo d’acquisto a titolo originario. Quindi conflitto tra proprietà e mero possesso di un altro soggetto. Si richiede una certezza assoluta per chi reclama il bene. Successione e accessione nel possesso: art. 1146: “Il possesso continua nell’erede con effetto dall’apertura della successione. Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti.” Quindi chi agisce in rivendica deve sommando il proprio possesso a quello del precedente venditore o utilizzando il possesso del de cuius se si tratta dell’erede, deve conseguire il tempo necessario per l’acquisto a titolo di usucapione (originario), quandanche avesse acquistato a non domino in ogni caso tra il suo possesso e quello del precedente raggiunge il tempo necessario per acquisto a titolo originario per SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO usucapione. L’ordinamento cerca di prevenire che colui che abbia il possesso sia scardinato da un eventuale non proprietario. Si tratta di sommare il proprio possesso a quello del precedente titolare (tipo possessore precedente l’ha tenuto 15 anni, io l’ho tenuto 15 anni quindi per forza per usucapione è mio). La successione mortis causa richiede lo stesso meccanismo, è possibile che l’erede si avvalga del possesso del de cuius per raggiungere il tempo necessario per usucapire. La differenza tra accessione e successione nel possesso è solo una differenza tecnica, nel senso che si verifica l’accessione nel possesso negli acquisti a titolo particolare sia inter vivos che mortis causa (tipo compravendita) e in questo caso si tratta di sommare il proprio possesso a quello del precedente titolare, ma è necessario che l'avente causa si impossessi realmente del bene, cioè che il possesso sia effettivo, e ogni pezzettino di possesso avrà le sue caratteristiche, ad esempio di buona malafede, ogni pezzettino è autonomo semplicemente la legge consente che siano sommati laddove sia utile sommarli. La successione di possesso si attua solo nella successione a titolo universale quindi solo mortis causa. In questo caso non è necessario l’impossessamento perché l’erede continua il possesso del defunto anche se non se ne è realmente impossessato. Le caratteristiche del possesso sono quelle originariamente attribuite al possesso del defunto, cioè se era di buona fede il possesso del defunto sarà di buona fede il possesso dell'erede, se era di mala fede il possesso del defunto sarà di mala fede. Se la rivendica ha oggetto dei beni immobili operano le regole dell’usucapione, quindi si deve mostrare acquisto a titolo originario per usucapione. Se il bene è mobile vige il possesso vale titolo (1153 cc), il quale richiede che ci siano la trasmissione del possesso, la buona fede e il titolo astrattamente idoneo per far sorgere in capo all'acquirente un diritto di proprietà a titolo originario; se cioè io acquisto un bene mobile (il famoso anello o anche un telefonino) da chi non è proprietario è sufficiente che io mi impossesso del bene che sia in buona fede al momento del passaggio del possesso e che ci sia un titolo astrattamente idoneo, ovvero un titolo che sarebbe idoneo se quello fosse il proprietario ma non è idoneo perché quello non è il proprietario, quindi titolo astrattamente idoneo buona fede possesso determina il sorgere del diritto di proprietà anche se chi vende non è il proprietario ed è un acquisto titolo originario tanto che si chiama usucapione a tempo zero, l'acquisto è immediato non servono i 20 anni dell’usucapione. Non va confusa con l’azione di restituzione che ha carattere personale e suppone che il titolare vanti un diritto alla restituzione. Azione negatoria L’actio negatoria servitutis serve a far dichiarare l’inesistenza di diritti che altri affermano di avere sulla cosa. Si tratta quindi di turbative o molestie che il proprietario subisce. In questo caso il proprietario è anche possessore, non ha perso il possesso. L’importante è che ci siano turbative e molestie e che il proprietario abbia il possesso della cosa. L’azione è diretta a far cessare le turbative con condanna al risarcimento del danno; è imprescrittibile ma a differenza della precedente non deve dimostrare molto perché è già possessore, deve dimostrare solo valido titolo d’acquisto (Atto di compravendita ad esempio). Azione di regolamento dei confini e apposizione dei termini Sono molto vicine tra loro. La prima è volta ad accertare il confine incerto tra due fondi. Tra i fondi c’è rapporto di contiguità ma non è chiaro il confine. È imprescrittibile (proprio perché lo è il diritto di proprietà). Mira all’accertamento, in primo luogo, e in secondo luogo alla eventuale restituzione di una porzione di genere all'altro se il confine, per esempio, è stato spostato e quindi ho bisogno di restituire. La prova può essere fornita con ogni mezzo e ovviamente anche le mappe catastali saranno idonea fonte. Nella seconda i confini non sono incerti ma sono venuti meno i lapidei tra due confini certi. Venuti meno questi segni occorre ripristinare il confine. La differenza sta nel fatto della certezza e incertezza. Anche questa imprescrittibile. SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO Azione di mero accertamento della proprietà È una creazione della giurisprudenza, non si trova nel Codice civile. Copre tutte le ipotesi che le altre azioni non possono coprire. Mira a tutte le azioni di proprietà su un bene e le rimozioni di incertezza che sussiste sulla proprietà di quel bene ma non c’è la perdita del possesso. È volta ad accertare la proprietà di un oggetto ad un certo soggetto, senza che sia venuto a mancare il possesso. È stata ad esempio utilizzata nell’ambito dello scioglimento del matrimonio tra due soggetti per accertare se un bene rientrasse o meno nella comunione o fosse di proprietà individuale. Lezione 4 diritto privato mod. b I DIRITTI REALI DI GODIMENTO Le situazioni reali di godimento si collocano idealmente nell’elasticità del diritto di proprietà, una delle caratteristiche del diritto di proprietà. Proprietà si comprime quando sullo stesso bene sorgono altri diritti reali e si espande quando questi cessano. Tra le due situazioni si intravede un rapporto giuridico: da un lato proprietario che dispone e gode in modo pieno ed esclusivo e dall’altra parte il titolare della situazione reale minore che avrà interesse corrispondente alla situazione di cui si tratta (godere del bene e ricavare i frutti, godere della superficie ecc.) 1) Diritto di superficie NOZIONI E CONTENUTO: Definita proprietà orizzontale o superficiaria. Seconda deroga al principio dell’accessione (tutto ciò che viene costruito sopra e sotto il fondo è attratto dal proprietario del fondo, la prima deroga era l’accessione contraria). Il proprietario concede ad un soggetto il diritto di fare e mantenere, o solo mantenere se la costruzione è già esistente, una costruzione al di sopra o sotto il fondo, acquistandone la proprietà in maniera separata dal suolo; il titolare di tale diritto viene detto proprietario superficiario. Dunque, abbiamo il proprietario del fondo e della costruzione che sono due soggetti separati. Quindi due varianti: - - Diritto di fare e mantenere (ius aedificandi), il superficiario ha il diritto di costruire il bene del quale diviene poi proprietario e diviene proprietario a titolo originario. Non è usucapibile ed ha prescrizione di 20 anni. Diritto di mantenere. Se costruzione è già esistente l’acquisto è a titolo derivativo. È imprescrittibile e usucapibile. Questa distinzione è importante per quanto riguarda la disciplina che ne ricaviamo. COSTITUZIONE: 1) Contratto (se a tempo determinato allo scadere del termine rivive il principio dell’accessione, quindi, rientra nella proprietà del soggetto proprietario del fondo). Può essere a tempo determinato o indeterminato. Forma ad substantiam. 2) Testamento (se a tempo determinato allo scadere del termine rivive il principio dell’accessione, quindi, rientra nella proprietà del soggetto proprietario del fondo). Può essere a tempo determinato o indeterminato. 3) Usucapione (solo per diritto di mantenere, quindi per costruzioni già in essere) ESTINZIONE: L’estinzione avviene in diversi modi: SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO - Scadenza del termine. Alla fine del termine il proprietario del fondo diventa proprietario anche della costruzione Rinunzia o prescrizione ventennale per diritto di fare e mantenere. È l’istituto corrispondente alla remissione. Consolidazione ovvero riunione nella medesima persona delle qualità di proprietario e superficiario. Corrisponde alla confusione in ambito di situazioni debito creditorie. Il perimento del bene salvo patto contrario non determina l’estinzione del diritto. Esempio: parcheggi sotterranei, ad esempio, hanno diritto reale minore di superficie. Una applicazione del diritto di superficie è quella che viene operata dal condominio il quale concede a titolo oneroso il lastrico solare per consentire l’installazione di infrastrutture e impianti. È un diritto temporaneo. Distinzione tra costruzione e impianto e lastrico solare che resta di proprietà del condominio. Così le serre fotovoltaiche installate sui terreni agricoli sono ricondotte a diritto di superficie. La corte d’appello di Napoli nel 2020 dichiara che sia ammissibile l’usucapione del diritto di superficie a seguito di uso ripetitivo e continuativo ultraventennale di uno dei condomini del lastrico con costruzioni. 2) Diritto di enfiteusi NOZIONI E CONTENUTO: È un istituto ormai desueto, era molto usato nel 1800 soprattutto nell’Italia meridionale. È stata superata dalla disciplina dei contratti agrari. Mentre la superficie è proprietà orizzontale l’enfiteusi è proprietà in senso sostanziale. È il diritto che attribuisce al suo titolare, l’enfiteuta, il potere di godere di un fondo dietro corrispettivo di un canone e con l’obbligo di miglioramento. Quindi sussiste diritto di godimento come se fosse proprietario ma ha due obblighi ovvero pagare il canone e migliorare il fondo. COSTITUZIONE: 1) Contratto (se a tempo determinato non inferiore a 20 anni per tutela degli investimenti che ha fatto). Può essere a tempo determinato o indeterminato. 2) Testamento (se a tempo determinato non inferiore a 20 anni per tutela degli investimenti che ha fatto). Può essere a tempo determinato o indeterminato. 3) Usucapione ESTINZIONE: - Scadenza del termine Rinunzia o prescrizione ventennale Consolidazione Perimento del bene (se solo parziale ma consistente è prevista la possibilità di ridurre il canone o rinunziare al diritto) Affrancazione e devoluzione. La prima è uno dei diritti potestativi, è il diritto dell’enfiteuta di diventare proprietario pagando una somma pari a 15 volte il valore del canone. La devoluzione è esercitabile solo dal proprietario e si può esercitare solo in caso di deterioramento o inadempimento agli obblighi di miglioramento o pagamento mancato per 2 annualità. Il proprietario si libera dell’enfiteuta. 3) Diritto di usufrutto NOZIONI E CONTENUTO: SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO È il diritto reale minore che attribuisce al suo titolare, detto usufruttuario, il potere di godere della cosa e di far propri i frutti con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica. Quindi godere della cosa, acquisire i frutti con l’obbligo di non mutare la destinazione economica. I beni che hanno ad oggetto il diritto di usufrutto sono quindi detti fruttiferi, l’eccezione è costituita dal quasi usufrutto. Il quasi usufrutto ha ad oggetto dei beni deteriorati con l’uso o che non producono frutti, sono detti beni consumabili, in tal caso l’usufruttuario può servirsi dei beni con l’obbligo poi di pagarne il valore al termine dell’usufrutto. Mentre l’usufrutto ha ad oggetto beni fruttiferi inconsumabili. Può avere ad oggetto beni mobili, immobili, titoli di credito, aziende, universalità di beni, prodotti dell’ingegno. L’usufruttuario è il soggetto titolare del diritto ha doveri e obblighi, si contrappone all’usufruttuario il soggetto titolare di diritto di proprietà. In questo modo la proprietà va a frantumarsi in più aspetti: con la costituzione dell’usufrutto avremo che il titolare del diritto di proprietà diventa titolare della cosiddetta nuda proprietà, l’altro diventa titolare del diritto di usufrutto. Per poter godere e utilizzare il bene l’usufruttuario deve conseguirne il possesso, per questo motivo grava sull’usufruttuario l’obbligo di redigere l’inventario, prima di entrare nel possesso del bene deve redigerlo previo avviso al proprietario, a meno che nel contratto non sia fatta dispensa (art. 982); poi deve prestare idonea garanzia (nel contratto di donazione o di vendita si può riservare al donante il diritto di usufrutto). Deve utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia, obblighi di custodia e amministrazione e di pagamento delle spese ordinarie, pagamento di imposte sul reddito, infine ha il potere di disposizione solo inter vivos e per la durata originaria. Il nudo proprietario deve pagare le spese straordinarie e pagare le tasse sulla nuda proprietà. Il proprietario invece deve effettuare le riparazioni straordinarie ed è tenuto a pagare le imposte che gravano sulla proprietà. COSTITUZIONE: 1) Contratto, la durata non può eccedere la vita dell’usufruttuario (“vita natural durante”, quindi tutta la vita) oppure termine minore. Per le persone giuridiche invece il termine non può superare i 30 anni 2) Testamento, Divieto di usufrutto successivo, ovvero doppia concessione, concessione a catena di usufrutto ovvero usufruttuario lascia usufrutto ad un altro ecc. Questa disposizione ha valore soltanto a favore di quelli che alla morte del testatore sono i primi chiamati a goderne. È concesso però l’usufrutto congiuntivo, ovvero costituito a favore di più persone congiuntamente. 3) Usucapione 4) Legge, vi sono due ipotesi di usufrutto ex lege: - la prima è all’articolo 324 del Codice civile, si tratta dell’usufrutto legale che la legge prevede a favore dei genitori dei figli minori. Anche se i beni sono collegati a interessi della famiglia e del mantenimento della stessa. - l’altra ipotesi è all’articolo 194 del Codice civile, nella comunione legale qualora vi sia una separazione, il giudice può costituire a favore di uno dei coniugi l’usufrutto su una parte dei beni spettante all’altro coniuge. La durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario (vita natural durante) e quello costituito a favore di una persona giuridica non può durare per più di 30 anni. La preoccupazione del legislatore era infatti quella che senza limite si andasse a creare una eccessiva limitazione del diritto di proprietà. ESTINZIONE: - Scadenza del termine Rinuncia o prescrizione 20ennale se il titolare non esercita Per consolidazione Per perimento del bene SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO - Per morte dell’usufruttuario Per abuso, questa estinzione è tipica del diritto di usufrutto, non è presente in tutti gli altri diritti reali minori. Nel caso in cui questo bene venga alienato o grave deterioramento Il diritto di usufrutto può essere oggetto di pignoramento, ha a che fare con la responsabilità patrimoniale, tra i vari mezzi per riprendersi il valore equivalente è messo a pignoramento il bene da parte del giudice. È vincolato alla vendita così se ne ricava il valore. Producendo dei frutti può essere pignorato. Non accade così per il diritto di uso e abitazione. 4) Diritto di uso e abitazione NOZIONI E CONTENUTO: Diritto di servirsi del bene e raccoglierne i frutti limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia, il secondo invece è il diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia; quindi, è ancora più circoscritto del primo. È strettamente legato ai bisogni primari, non come l’usufrutto. Sono personalissimi, impignorabili, non cedibili e non locabili. Il titolare del diritto d’uso o di abitazione è tenuto a pagare le spese di coltura, le riparazioni ordinarie e dei tributi come l’usufruttuario. COSTITUZIONE: La disciplina è molto scarna e rimanda alla disciplina dell’usufrutto per costituzione ed estinzione (tranne abuso). Vi è una particolarità che riguarda sempre il diritto di famiglia, prevista dall’articolo 540 del codice, quando un soggetto muore si prevede che aldilà di quanto disposto nel testamento, verrà riservato al coniuge il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e uso dei mobili collegati. (costituzione ex lege prevista per il coniuge del de cuius) 5) Diritto di servitù NOZIONI E CONTENUTO: Le servitù prediali consistono nel peso imposto su un fondo per utilità di un altro fondo di un altro proprietario. Non è legato come i precedenti al soggetto titolare, ma il vantaggio è previsto a favore di un fondo. Bisogna distinguere innanzitutto a seconda dell’utilità dei fondi il fondo dominante dal fondo servente: il primo ne trae vantaggio, il secondo sopporta il peso. Si ammettono anche se non espressamente previste dal codice le cosiddette servitù reciproche, in questo caso accade che diversi proprietari di aree edificabili costituiscano reciprocamente delle servitù di identico contenuto (generalmente limitazioni del diritto di costruire). In tal modo ciascuno assume la duplice veste del fondo servente e dominante. Esistono tre caratteristiche necessarie per far esistere un diritto di servitù - I fondi devono essere contigui, vicini, confinanti. Può non esserci vicinanza quando la servitù riguarda più fondi. Sul fondo servente deve esistere un comportamento passivo (non fare, sopportare) Vi sono tre tipologie, due a seconda del vincolo: - Affermative/negative, nelle prime il titolare del fondo dominante può espletare dei comportamenti come passarci sopra e l’altro non deve far nulla se non sopportare (pati in latino). Quelle negative SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO - impongono al titolare l’obbligo di non fare, non è astensione ma non fare, rientrano ad esempio la servitù di non sopraelevare, diritto di non concorrenza anche. Apparenti/non apparenti, le prime manifestano espressamente l’utilità, come quella di passaggio (viene costruito sentiero oppure tubature), quelle non apparenti non sono visibili, tipo passaggio in cui non vi sia la costruzione. La servitù di veduta è apparente, perché servono che si erigano delle opere che ne determinano il nascere come una sorta di osservatorio. Una a seconda delle modalità di esercizio: - Continue/discontinue, la differenza sta nell’attività esercitata dal titolare del fondo in questo senso, nelle servitù continue non si richiede l’attività dell’uomo, esiste e si mantiene la servitù senza che si debba fare qualcosa, come quella di non edificare o acquedotto. Discontinua è invece quella di passaggio Le obbligazioni principale consistono generalmente nel non fare o sopportare, tenere un comportamento passivo. Vi sono poi delle prestazioni accessorie alla servitù (ad esempio si prevede in un contratto costitutivo della servitù di dover tagliare l’erba sulla strada di passaggio). COSTITUZIONE: 1) Contratto 2) Testamento 3) Legge, si tratta della servitù coattiva, costituita con la forza del giudice o pubblica autorità. La più classica è quella di passaggio prevista dal 1051 cc, prevede che si può formare anche contro la volontà del proprietario del fondo servente. Vi sono tre ipotesi: interclusione assoluta, relativa e ampliamento coattivo. La prima riguarda il fatto che un fondo è completamente circondato da un altro fondo e non abbia accesso alla strada, la seconda concede nell’ipotesi che il fondo sia semi intercluso, quindi il passaggio sia troppo ristretto. Nella terza ipotesi vi è una già una strada ma c’è bisogno che venga ampliata, in questo caso è previsto un indennizzo al proprietario del fondo dominante per i danni causati al passaggio e che sia consegnata la somma di riduzione del fondo destinato al passaggio. Le servitù coattive possono istituirsi attraverso un contratto, attraverso una sentenza costitutiva oppure attraverso un atto dell’autorità amministrativa. Altre servitù coattive sono quella di acquedotto coattivo, elettrodotto coattivo o di passaggio coattivo delle linee teleferiche. 4) Usucapione 5) Destinazione del padre di famiglia, solo per servitù apparenti, serve che questi fondi siano appartenuti in origine allo stesso proprietario e che tra questi due vi fosse un rapporto di servizio. Si estinguono per: - - Scadenza del termine Rinuncia o prescrizione (nella prescrizione si comincia a contare dal giorno di violazione del divieto in quelle negative, mentre nelle affermative continue si conta dal momento in cui si verifichi un fatto contrario al suo esercizio, in quelle discontinue dall’ultimo momento di esercizio. Consolidazione La tutela giurisdizionale è promossa da: - Actio confessoria, in cui si richiede il riconoscimento del diritto, la cessazione degli atti molesti. Necessaria la prova dell’esistenza della situazione di godimento Azioni possessorie Lezione 5 diritto privato mod. b SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO LA COMUNIONE Situazione di contitolarità, non è un diritto reale minore. Si tratta della contitolarità di un diritto reale per quote ideali. Anche chiamata comunione pro-indiviso, anche definita romanistica. Classificazione: - - Costituzione: volontaria, incidentale, forzosa. La prima è costituita tramite accordo delle parti, la seconda è costituita senza la volontà dei partecipanti ma è possibile scioglierla quindi ci si può sottrarre ad essa, come la successione, nella terza uguale ma non si può sciogliere, non ci si può sottrarre, come il condominio. Disciplina: ordinaria, speciale, atipica. La prima è quella prevista dal Codice civile, derogabile dal titolo sulla volontà delle parti come contratto o testamento. La seconda riguarda fattispecie peculiari autonomamente previste dalla legge. (comunione ereditaria, comunione legale fra coniugi e condominio. Quella atipica riguarda l’applicazione della disciplina ordinaria in via analogica, come comunione di titoli di credito. Ciascun partecipante è titolare del diritto reale sull’intero bene, tuttavia ognuno è titolare pro quota del diritto: la quota è una frazione ideale, determinata aritmeticamente che segna la misura di partecipazione di ciascuno alla comunione (sostanzialmente la proporzione). È una frazione disponibile ed espropriabile, la sua estinzione comporta l’aumento delle altre. Generalmente si presume l’uguaglianza delle quote. Il contenuto della comunione è la facoltà di godimento e disposizione del bene, si prevede uso e amministrazione da parte dei titolari. L’uso della cosa comune attiene a ciascuno separatamente, senza chiedere il permesso senza alterare la destinazione economica del bene e concedere ad altri di utilizzarlo allo stesso modo. Non è sempre possibile però l’utilizzo individuale del bene, si pensi ad un appartamento in comproprietà. I singoli contitolari possono applicare delle modifiche purché non si alteri la destinazione economica del bene o si impedisca il diritto di godimento degli altri partecipanti. L’amministrazione della cosa comune invece spetta collettivamente ai partecipanti alla comunione. Per l’amministrazione della cosa comune si prevede il principio della maggioranza legata alle quote non ai soggetti che partecipano e l’atto con cui si esprime la volontà della maggioranza dei partecipanti è detto deliberazione. Bisogna distinguere però per quanto riguarda il calcolo della maggioranza tra atti di ordinaria amministrazione e atti di straordinaria amministrazione: - - - Per gli atti di ordinaria amministrazione, cioè quelli diretti alla normale conservazione, utilizzazione e godimento del bene) è sufficiente il consenso di tanti contitolari le cui quote rappresentino più della metà del valore comune. Può anche essere formato un regolamento per l’ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione invece (quindi quegli atti diretti all’innovazione per miglioramento della cosa) occorre una maggioranza qualificata, ovvero la deliberazione ci tanti contitolari le cui quote rappresentino i due terzi del valore complessivo della cosa comune. Ciascuno dei componenti della minoranza può però impugnare davanti all’autorità giudiziaria le deliberazioni della maggioranza in diversi casi (se la deliberazione crea grave pregiudizio alla cosa comune, se non è stata rispettata la norma che prevede la preventiva informazione dei partecipanti, se le deliberazioni sono in contrasto con l’articolo 1108 comma 2). L’impugnazione deve essere proposta entro 30 giorni dalla deliberazione. Infine per l’alienazione/ costituzione di “diritti reali” sul fondo comune/ locazioni ultra novennali è richiesta l’unanimità. IMPUGNAZIONE: la possibilità di impugnare le delibere è entro trenta giorni dalla data della deliberazione o dalla comunicazione per gli assenti ed è prevista nei seguenti casi: SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO - Mancata preventiva informazione sull’oggetto della deliberazione Atti di ordinaria amministrazione pregiudizievoli per la cosa comune Idem per quelli di straordinaria amministrazione pregiudizievoli per l’interesse delle parti Innovazioni non dirette al miglioramento o pregiudizievoli per l’interesse delle parti La domanda di scioglimento della comunione spetta a ciascuno dei partecipanti, ma vi sono tre limiti: dilazione da parte del giudice, patti di indivisibilità maggiori di 10 anni e cose indivisibili. La divisione ha luogo in natura quando è possibile dividere la cosa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti. Qualora non sia possibile si seguiranno altre strade come l’assegnazione dell’esclusività ad uno dei partecipanti che risarcisca gli altri ecc, oppure la vendita del bene. Una norma di chiusura prevede che sia applicabile la disciplina sulla divisione dell’eredità. Lezione 6 diritto privato mod. b IL CONDOMINIO Ci troviamo all’interno del libro terzo dedicato alla proprietà, capo secondo. Il condominio è una forma di comunione forzosa, come disciplina ha una disciplina speciale. La disciplina del condominio è stata ampliata da una legge del 2012, n. 220. Quindi codice+legge 2012 fa disciplina del condominio. Il condominio va definito come una particolare forma di comunione su di un bene immobile; questa definizione implica che vi siano degli edifici composti in cui siano presenti i singoli appartamenti di proprietà individuale e aree di proprietà comune (come suolo, scale, ingressi ecc, ma anche eventuali parcheggi, portineria ed infine le opere e le installazioni come pozzi e ascensori). Il regolamento del condominio è obbligatorio se ci sono più di 10 condomini, se più di 8 serve amministratore. L’articolo che detta la definizione di condominio è il 1117, già da questo articolo si evince la fattispecie speciale del condominio, che infatti è composto da unità immobiliari che sono di proprietà esclusiva di singoli condomini e da altre parti comuni. “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo…” Nella nozione di condominio rientrano anche altre tre fattispecie: - Condominio parziale, abbiamo soltanto alcune aree che sono comuni. C’è un bene comune che non è destinato a tutto il condominio ma solo una parte di esso. Super condominio, 1117 bis, più condomini con una parte in comune; più edifici hanno tra loro alcune cose in comune Condominio orizzontale, 1117 bis, vi sono singole unità abitative di proprietà individuale (tipo villette) con parti in comune. Le aree comuni sono strumentali ad un razionale e miglior sfruttamento delle proprietà individuali, devono essere indivisibili. La divisione delle parti può avvenire solo in due casi: - Divisione deve essere agevole, non deve rendere incomodo l’uso della cosa Deve esserci consenso di tutti i partecipanti Il diritto delle parti comuni è irrinunciabile e si calcola proporzionalmente alle parti condominiali. LA NATURA GIURIDICA DEL CONDOMINIO ED I SUOI ORGANI: Il condominio dal punto di vista della natura giuridica non persegue nessuno scopo, non ha un proprio patrimonio separato da quello dei singoli condomini. Non può essere quindi considerato un ente, se mai un SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO ente di gestione (destinatario di una certa disciplina) privo di soggettività giuridica. Gli organi del condominio sono l’assemblea e l’amministratore (+8). La Cassazione riconosce al condominio una limitata autonomia patrimoniale; la riforma del 2012 ha poi introdotto delle innovazioni che hanno accentuato ancora di più l’indipendenza del condominio rispetto a quella dei singoli condomini sotto diversi profili: - Art. 70 disposizioni attuative Codice civile, prevede l’istituzione di un fondo di cui dispone l’amministratore Art. 23 prevede l’istituzione di un fondo inerente alle liti tra condomini e condominio Art. 1129 comma 7 istituisce uno specifico conto corrente gestito dall’amministratore Art. 2659 necessaria indicazione per i condomini di denominazione, ubicazione e codice fiscale. All’assemblea dei condomini sono tenuti a partecipare tutti i condomini, eventualmente anche attraverso un rappresentante e i conduttori. Le principali competenze dell’assemblea sono le seguenti: - Nomina e revoca dell’amministratore, decisioni anche riguardo alla sua retribuzione Nomina di un consiglio di condominio, con funzioni di consulto e controllo composto da almeno tre condomini Nomina di un revisore che verifichi la contabilità Adozione del regolamento condominiale Approvazione del preventivo delle spese occorrenti Approvazione del rendiconto annuale Deliberazione in ordine alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni Modifica della destinazione d’uso delle parti comuni Promozione di azioni giudiziarie o deliberazione di resistere ad un giudizio intrapreso contro il condominio. L’assemblea è convocata dall’amministratore con avviso di almeno cinque giorni prima della data fissata. L’assemblea è validamente costituita se vi è il cosiddetto quorum costitutivo, ovvero devono essere presenti i condomini che rappresentino almeno due terzi del valore del condominio; in presenza del quorum costitutivo le deliberazioni di verificano solo in presenza del quorum deliberativo. Le deliberazioni dei condomini sono oggetto di processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall’amministratore, dove viene anche indicato chi ha votato a favore, che abbia l’elenco dei condomini presenti eccetera. DELIBERAZIONI ANNULLABILI E NULLE: Alcune deliberazioni sono annullabili, sono annullabili quelle deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio. Ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può chiedere l’annullamento entra 30 giorni. Bisogna distinguere però le deliberazioni nulle da quelle annullabili, queste sono quelle prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito oppure con oggetto che non rientra nelle competenze dell’assemblea; così come quelle che incidono sui diritti individuali dei condomini. L’azione di nullità può essere promossa da chiunque abbia interesse e non è sottoposta a termini di prescrizione o decadenza. L’AMMINISTRATORE: L’amministratore come abbiamo detto è nominato dall’assemblea, dura circa un anno ma può essere revocato in assemblea in ogni momento. L’amministratore piò anche non essere una persona fisica ma una società lucrativa di persone o capitali. Salvo diversamente disposto in assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito è esigibile. Alla cessazione dell’incarico è tenuto alla consegna di tutta la documentazione afferente al condominio. SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO I compiti principali dell’amministratore oltre quelle del 1129 cc sono: - Eseguire le deliberazioni dell’assemblea Disciplinare l’uso delle cose comuni Riscuotere i contributi ed erogare le spese Compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni Eseguire gli adempimenti fiscali Curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale Curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di contabilità e di nomina e revoca dell’amministratore. Conservare tutta la documentazione riguardante la propria gestione Fornire al condomino che ne faccia richiesta un’attestazione relativa alo stato dei pagamenti degli oneri Redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro 80 giorni. L’amministratore ha la rappresentanza del condominio e può agire in giudizio e contro giudizio verso terzi. I provvedimenti presi dall’amministratore entro i suoi poteri sono obbligatori per i condomini, contro i provvedimenti dell’amministratore, tuttavia, è concesso ricorso all’assemblea senza pregiudizio del ricorso all’autorità giudiziaria nei casi previsti. DIRITTI, OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONDOMINI: All’interno del condominio i condomini vantano di diritti, obblighi e hanno dei divieti. Diritti: - - - Il singolo condomino può utilizzare le parti comuni, in proporzione all’entità dell’immobile di cui sono proprietari, senza alterare la destinazione economica. L’articolo 1102 prevede che ciascun partecipante può usufruire senza alterare la destinazione e che anche gli altri partecipanti ecc. Il condomino può procedere con l’installazione di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva, per la produzione di energia di fonti rinnovabili. Il proprietario dell’ultimo piano ha diritto di sopraelevazione, salvo che risulti altrimenti dal titolo. Gli altri condomini possono opporsi se questa pregiudica l’architettura dell’edificio. Infine, chi sopraeleva deve indennizzare gli altri condomini per il valore dell’area da occuparsi. Il condomino può procedere con la rinuncia all’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento. In questo caso deve solo concorrere con le spese di mantenimento e manutenzione straordinaria. Doveri e obbligazioni: - - Ogni condomino è tenuto al pagamento spese necessarie per conservazione, godimento parti comuni e per le innovazioni, in misura proporzionale al valore della proprietà. Se si tratta di cose destinate a servire in misura diversa, spese ripartite in misura diversa. Una particolare disciplina riguarda il pagamento delle spese relative a scale ed ascensori, che spettano solo a coloro che sono proprietari delle unità immobiliari a cui servono (se ascensore non si ferma al 3 piano, quelli non pagano spese perché non lo usano). Il pagamento degli oneri condominiali spetta al condomino, al conduttore o a chi abiti l’unità anche senza esserne il proprietario. I condomini sono tenuti a pagare le spese. Se uno dei condomini non paga le spese il creditore non può richiedere i soldi agli altri condomini. La giurisprudenza oscilla nel considerare queste obbligazioni parziarie o solidali. Il condomino non può procedere con una rinuncia al suo diritto sulle parti comuni. Ogni condomino non può sottrarsi alle spese per la conservazione delle parti comuni. SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO - In capo al condomino infine sono previste alcune limitazioni in ordine al compimento delle opere su parti di proprietà o uso individuale (no opere che rechino danno agli altri). IL REGOLAMENTO CONDOMINIALE: Il regolamento condominiale è un contratto plurilaterale la cui adesione avviene al momento del rogito notarile. Nello specifico il regolamento può essere: - - Assembleare, atto collettivo con forma scritta ad substantiam, approvazione obbligatoria se condomini >10. Il regolamento condominiale contiene le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese. Possono essere previste dal regolamento sanzioni pecuniarie in violazione di esso. Ove non sia precisato nel titolo il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in apposita tabella allegata al regolamento. La tabella ha valore millesimale e la sua utilità è legata ai fini della ripartizione delle spese e conteggio dei quorum costitutivi e deliberativi. I valori proporzionali possono essere modificati solo con l’unanimità oppure con la volontà di un singolo condomino con la maggioranza prevista nei seguenti casi: errore o mutamento delle condizioni dell’unità, come sopraelevazione o anche diminuiscono. Dalla violazione ne derivano solo sanzioni pecuniarie non penali. Contrattuale, sono anche ammessi i regolamenti contrattuali che stabiliscano limitazioni della proprietà esclusiva o diritti maggiori o minori di quelli che avrebbero per legge. Viene predisposto dal costruttore-originario proprietario e sottoscritto da ciascuno all’atto di acquisto (contratto plurilaterale). Lezione 7 diritto privato mod. b IL POSSESSO Disciplinato dagli articoli 1140 e seguenti. L’ordinamento vuole evitare che nel caso in cui un soggetto si trovi in possesso di un bene gli altri possano privarlo; ci si accerta dunque di questo possesso. È un problema di pacifica convivenza e autotutela, dall’altro lato all’ordinamento interessa molto colui il quale pone a frutto i beni, e non coloro che si disinteressano di questo. All’ordinamento in questa fase non interessa se il rapporto sia giustificato o meno da un titolo. Il possesso è una situazione di fatto, il nostro ordinamento lo disciplina sia per garantire la pacifica convivenza tra gli associati, poi per l’ordinamento c’è una situazione di favore per colui che sia il possessore di qualcosa, si prevede un’autonoma tutela in capo al possessore. L’ordinamento presume che il soggetto che possegga un bene sia legittimato a vantarne un diritto, previa esibizione di documenti. Art. 1140, il possesso è il potere sulla cosa, che si manifesta in attività corrispondente all’esercizio della proprietà o altro diritto reale. (IMPORTANTISSIMA!!!) Non è un diritto come la proprietà, è una situazione di fatto e un potere. Per l’ordinamento rileva solo il comportamento materiale, svincolato e a prescindere dal diritto al godimento e uso del bene. La situazione di fatto è diversa dalla situazione di diritto, poiché in questa a giustificare il comportamento c’è il titolo, come la vendita. La situazione del possesso pieno si traduce nello stesso comportamento dell’esercizio del diritto di proprietà, possesso minore invece corrisponde all’esercizio di un diritto reale minore. Il soggetto può essere titolare del possesso sulla cosa con la cosa l’apprensione e uso del bene, oppure se l’abbia acquisito con un titolo che poi si è rivelato invalido. CHE COSA COMPONE LA SITUAZIONE POSSESSORIA? SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO Abbiamo un elemento materiale oggettivo, il corpus, che è appunto il potere sulla cosa. All’elemento materiale si aggiunge quello immateriale soggettivo, ovvero l’animus possidendi. Quest’ultimo è lo stato soggettivo di chi intende comportarsi come proprietario o titolare di un diritto reale minore; è un elemento intenzionale che deve manifestarsi all’esterno, deve essere esteriormente percepibile. I comportamenti possono essere l’esclusione di ogni altro soggetto dal godimento del bene, il compimento di atti di disposizione. L’importanza dell’animus sta nel fatto che è questo che fa differire il possesso dalla detenzione; quest’ultima è la situazione di chi riconosce l’altruità del diritto, in parole povere il possesso privato dall’animus. Non esiste nella detenzione l’intenzione di manifestarsi come proprietario. Solitamente la detenzione viene esercitata in base ad un titolo. Esempio classico: conduttore di un immobile che paga il canone, il titolare del contratto di locazione non è possessore ma detentore, non si vuole riconoscere come proprietario. Pagando il canone riconosce l’altruità della cosa. La detenzione può mutare in possesso attraverso l’istituto dell’interversione del possesso, ci sono due modi: - - Mutamento del titolo, ovvero l’intervento di un titolo che modifichi lo stato soggettivo, tipo al detentore viene venduta la casa, diventa proprietario (se titolo si rivelerà invalido diventa possessore) Opposizione, consiste in una dichiarazione esplicita o un comportamento che sia percepibile al proprietario che deve rendersi conto del mutamento dello stato soggettivo del detentore. Sorta di ribellione al proprietario per comportamento di buona o mala fede. Dopo 15 anni, che pago canone chiamo proprietario e dico che oggi sono proprietario (fatto non coperto dal diritto), questo comportamento è opposizione al proprietario, da questo momento in poi inizia ad essere possessore. Se il proprietario non fa nulla e lascia decorrere 20 anni perde la proprietà del bene che viene usucapita da ex detentore. La disciplina del possesso, quindi, rileva solo per il possessore, non per il detentore. Vi sono poi delle differenze tra possesso diretto ed indiretto. Il possesso diretto è quando il possessore ha l’immediato potere sulla cosa, mentre è indiretto quando avviene attraverso un’altra persona che ha la detenzione della cosa. La rilevanza del possesso si manifesta in tre peculiari fattispecie: - La posizione probatoria La possibilità di acquistare il diritto corrispondente al comportamento (possesso vale titolo o usucapione) Le azioni possessorie LE PRESUNZIONI POSSESSORIE, POSIZIONE PROBATORIA DEL POSSESSORE: Il legislatore ha previsto una regola presuntiva che semplifica l’accertamento concreto sul tipo di potere di fatto che si ha sul bene. Questa regola concerne la fattispecie di soggetti che si impossessano ed esercitano il potere con l’animus del proprietario. Questi soggetti hanno una posizione probatoria agevolata. Anche in questo caso l’ordinamento tende a facilitare questa apparenza creata dal possessore. Chi viene convenuto dal vero proprietario può avvalersi di questi tre: 1) Presunzione di possesso, secondo cui davanti alla presenza di un potere di fatto del soggetto si presume il possesso e non la detenzione; sarà chi reclama il bene che deve provare che il soggetto SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO è detentore e non possessore. Infatti, si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto quando non si prova che ha cominciato ad esercitarlo come semplice detenzione. 2) Presunzione di possesso intermedio chi possiede ora e nel tempo più risalente si presume che abbia posseduto anche in un tempo intermedio; sarà onere della controparte dimostrare che ci sia stata una cessazione del possesso intermedia. 3) Presunzione di possesso anteriore, il possesso attuale non fa presumere quello anteriore, a meno che non ci sia un titolo (caso in cui l’attuale possessore abbia un titolo che si sia rivelato nullo) Secondo questa presunzione il possesso attuale dobbiamo reputarlo iniziato dalla data del titolo, anche se questi era nullo e non ha potuto trasferire la proprietà o il diritto. Allo stesso ambito di posizioni probatorie appartengono successione e accessione nel possesso (vedi lezione 3). POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE IL TITOLO CORRISPONDENTE AL COMPORTAMENTO ESERCITATO Art. 1153 Quest’articolo individua una regola di acquisto a titolo originario valevole per i soli beni mobili, non si applica a immobili, universalità e beni mobili registrati, per cui è applicabile solo la disciplina dell’usucapione. È un articolo che viene definito usucapione a tempo zero, determina l’immediato sorgere del diritto di proprietà. La ratio è evitare che si paralizzi la circolazione dei beni mobili, perché se si dovesse essere sempre certi che chi vende è il vero proprietario nessuno comprerebbe; per beni immobili e gli altri c’è la sicurezza tramite registro (?). Abbiamo prematuramente detto che non è permesso l’acquisto a non domino. Esiste un’importante eccezione però che rileva nella regola del cosiddetto possesso vale titolo. Secondo tale regola infatti è previsto che colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non è proprietario ne acquista la proprietà tramite il possesso, purché sia di buona fede. La proprietà si acquista libera da vincoli e diritti altrui, così come si acquista il diritto di usufrutto, di uso e pegno. Le condizioni necessarie sono le seguenti: - - Consegna del bene dal dante causa all’avente causa e impossessamento da parte dell’avente causa Buona fede dell’avente causa. C’è un caso in cui la buona fede viene a mancare e quindi non si verificano i presupposti del sorgere della proprietà: è l’ignoranza di ledere l’altrui diritto non deve derivare da colpa grave, caso dell’incauto acquisto. Chi ignora l’altruità l’avrebbe potuta conoscere usando l’ordinaria diligenza. Diverso dall’incauto acquisto è la ricettazione poiché in questo caso vi è dolo eventuale, oltre a sospetto di illecita provenienza c’è accettazione del rischio. La buona fede si presume sempre, la prova della mala fede è carico della controparte; infine, la buona fede si valuta al momento dell’acquisto. Titolo astrattamente idoneo a determinare il passaggio della proprietà, ovvero un atto negoziale che sia idonea causa giustificativa dell’acquisto. Come contratto di compravendita, non locazione e comodato. Non sono idonei quelli in cui il passaggio della proprietà è conferito da un soggetto non idoneo, se chi acquista è in buona fede e acquisisce il possesso del bene l’ordinamento applica un rimedio e determina il sorgere del diritto di proprietà anche se l’alienante non era proprietario; è un acquisto a titolo originario, quindi la proprietà sorge. Regole di risoluzione dei conflitti nella circolazione dei beni: Art. 1155 regola il conflitto tra più aventi causa dello stesso dante causa. Il medesimo soggetto aliena lo stesso bene mobile a più soggetti. Secondo il criterio dovrebbe vincere il primo in ordine cronologico; invece, il nostro ordinamento coniuga alcuni indici di circolazione col principio consensualistico; bilancia le due regole e differisce: SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO - Per beni mobili fa prevalere chi per primo ha acquistato il possesso Crediti prevale chi per primo ha notificato al debitore o ha ricevuto dal debitore l’accettazione con atto di data certa Immobili vale la prima trascrizione eseguita La dottrina ha cercato di spiegare in tanti modi la ragione tecnica sulla base della quale prevale chi ha trascritto in buona fede o chi ha trascritto prima eccetera. La più accreditata è quella che individua nel primo acquisto un acquisto valido ed efficace ma condizionato risolutivamente all’eventualità di un secondo acquisto con consegna o trascrizione. Il primo è un acquisto sottoposto a condizione risolutiva che non ci sia un altro acquisto con consegna o trascrizione precedente. Opera come una condizione, retroagisce e scioglie il primo acquisto. RILEVANZA DEL POSSESSO DI BUONA FEDE L’ordinamento tutela anche il possesso in mala fede, con delle sfumature, poiché nel possesso in buona fede ci sono vantaggi ulteriori. Il possesso di buona fede è quello in cui colui che possiede ignora di ledere l’altrui diritto. Lo stato di buona fede è escluso dalla colpa grave; quindi, è da considerarsi in mala fede colui che ignorava il fatto che la cosa fosse di proprietà altrui ma avrebbe potuto saperlo usando l’ordinaria diligenza. Agli effetti della qualificazione del possesso si applica la regola per cui il possesso continua nell’erede al momento d’apertura della successione (successione nel possesso). Nella successione a titolo particolare invece non c’è l’automatica continuazione del possesso, ovvero si ha l’accessione nel possesso. Solo con il possesso in buona fede vale il 1153. E ci sono altri vantaggi per quanto riguarda la posizione del possessore che subisca la rivendica del bene: - - - Restituzione dei frutti; il possessore in buona fede ha diritto a fare propri i frutti fino al giorno della domanda di rivendicazione. Il possessore in mala fede deve restituire tutti i frutti dal giorno in cui è iniziato il possesso, salvo rimborso spese per mantenimento dei frutti. Miglioramenti e riparazioni: il possessore di buona fede ha diritto ad una indennità per le riparazioni e i miglioramenti in misura superiore a quella spettante al possessore in mala fede. L’indennità deve consistere nel caso di possessore in buona fede nell’aumento del valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, per quello in mala fede la minor somma tra l’importo della spesa e l’aumento di valore. Diritto di ritenzione, solo il possessore di buona fede può non restituire il bene finché non gli vengono rimborsate spese sostenute o date le garanzie pattuite. AZIONI POSSESSORIE Se le azioni petitorie erano quelle a difesa della proprietà, le azioni possessorie sono quelle a tutela del possesso. Il possessore che sia stato spossessato del bene o molestato nel suo possesso può rivolgersi al giudice. - - Azione di reintegrazione o di spoglio, art. 1168 cc. Il caso è quello nel quale chi possiede un bene viene spogliato da questo. Il possessore è stato violentemente o clandestinamente (occultamente) spogliato del bene mobile o immobile. Lo spoglio violento è quello fatto con minaccia, quello occulto è quello fatto di nascosto. L’azione deve essere fatta entro un anno dallo spoglio o dalla scoperta. Decorso l’anno si matura quel termine per l’interruzione del possesso ai fini dell’usucapione. La funzione è quella della reintegrazione del possesso a prescindere dall’accertamento della titolarità. Colui che è legittimato a chiedere l’azione di reintegrazione è sicuramente il possessore che sia proprietario o meno, ma anche il detentore della cosa (tranne per ragioni di servizio o ospitalità) e il convivente more uxorio. Azione di manutenzione. Quest’azione riguarda chi è stato molestato nel possesso di un bene immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un’universalità di mobili. I presupposti sono SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO non la sottrazione del possesso ma una molestia di fatto o di diritto che impedisce al possessore il godimento del bene. L’azione si prescrive in un anno dalla turbativa. La molestia può essere di fatto o di diritto. La funzione di quest’azione è la cessazione delle molestie e una funzione residuale, poiché la giurisprudenza precisa che sia esercitabile quando è presente il cosiddetto animus turbandi ovvero l’intento di recare pregiudizio ad altri. La legittimazione è sulla base di un possesso continuo e ininterrotto da almeno un anno, acquistato in modo non violento né clandestino; se il possesso è stato acquistato in modo violento e clandestino deve passare almeno in anno dal giorno in cui la violenza o clandestinità siano cessate. L’azione possessoria può anche essere esercitata nei confronti del proprietario del bene, lo si ricava dal 705 “il convenuto del giudizio possessorio non può opporre giudizio petitorio, finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita.” Il rapporto tra azione petitoria e possessoria è sempre stato piuttosto controverso. La giurisprudenza ha ritenuto che il proprietario potesse agire in rivendica solo dopo la fine del giudizio possessorio, attendere quindi eventualmente la restituzione del bene in capo al possessore per poter attivare l’azione di rivendica. La corte è intervenuta con la sentenza 25 del ’92, è vero che il proprietario deve attendere il giudizio possessorio, ma con eccezione ovvero salvo che l’attesa della conclusione del giudizio possa comportare un giudizio irreparabile al proprietario soccombente, come far sparire il bene. - Azioni di nunciazione. Il proprietario non possessore, il titolare di un diritto reale minore o il possessore possono inoltre procedere con delle azioni dette di nunciazione: denunzia di nuova opera o denunzia di danno temuto. Sono norme di chiusura del sistema. La prima deriva da una nuova opera da altri intrapresa su proprio o altrui fondo che crei pericolo di danno alla cosa che forma oggetto del proprio diritto entro un anno dall’inizio. L’autorità giudiziaria assunta una sommaria cognizione del fatto, può vietare la continuazione dell’opera o permetterla utilizzando le opportune cautele. Quest’azione vieta il risarcimento se l’opposizione è infondata oppure lo consente quando opposizione è fondata e condannerà alla demolizione e risarcimento del danno. Carattere dell’immediatezza rispetto ad opere in costruzione che rischiano di danneggiare qualcosa altrui. La seconda invece procede per chi ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa si crei pericolo di danno alla cosa che forma oggetto del proprio diritto. La pubblica autorità provvede per ovviare al pericolo e prevede una eventuale idonea garanzia per i danni che potrebbero essere causati. USUCAPIONE Modo di acquisto a titolo originario della proprietà o altri diritti reali tranne le servitù negative, basato sul possesso. Viene definito prescrizione acquisitiva, decorso del tempo che fa sorgere il diritto. L’ordinamento si preoccupa di tutelare la circolazione dei beni e assicurare la certezza delle situazioni giuridiche soggettive; altrimenti si dovrebbe dimostrare tutte le volte che si acquista un bene che l’acquirente sia il vero proprietario della cosa e così via, si paralizzerebbe la circolazione della ricchezza. È la strada con cui l’ordinamento fa corrispondere la situazione di fatto del possesso alla situazione di diritto. Fa sì che situazione di fatto e di diritto coincidano. Vi sono però dei presupposti: - Possesso non vizioso, né violento (impossessamento contro la volontà altrui) né clandestino (trovo rolex e me lo metto in tasca). Il termina inizia dalla cessazione del termine della violenza o clandestinità. Equilibrio tra interesse del possessore attuale e del vecchio proprietario, si fonda sul presupposto del disinteresse del vecchio proprietario, quindi se c’è violenza o clandestinità non c’è disinteressamento del vecchio proprietario; deve essere pacifico ed esplicito “alla luce del sole”. SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO - Tempo, deve essere continuo e non deve essersi interrotto. Si considera interrotto qualora il possessore abbia perso il possesso per oltre un anno, qualora vi sia stato un riconoscimento della titolarità altrui oppure quando si applicano le cause di interruzione e sospensione della prescrizione. Nel primo caso può essere che il possessore sia privato da un altro soggetto oppure che la perdita deriva da elementi naturali, salvo che il possessore abbia posto in essere azioni per recuperarlo, in questo caso non si conta l’interruzione del possesso. Esiste poi anche la sospensione, alla ripresa della quale non si riparte dal numero degli anni standard, ma si procede col conto. Il tempo necessario per poter usucapire varia soprattutto in base alla specie di beni: Beni immobili, universalità di mobili, diritti reali di godimento 20 anni. Anche per i mobili non registrati in mala fede Beni mobili registrati 10 anni Fondi rustici 15 anni Esiste poi l’usucapione abbreviata in caso il possesso sia accompagnato dalla buona fede. Beni mobili registrati 3 anni dalla trascrizione e con titolo astrattamente idoneo Immobili 10 anni Mobili non registrati usucapione a tempo zero Per i beni mobili quando ricorrono le condizioni per l’acquisto immediato della proprietà si applicano le regole del possesso vale titolo. Lezione 10 diritto privato mod. b LA FAMIGLIA Se i diritti reali li abbiamo percepiti come un argomento un po’ stantio, la famiglia è molto più dinamica. È un ambito nel quale l’ordinamento ha vissuto le più importanti trasformazioni. La disciplina della famiglia negli ultimi decenni ha subito un’importantissima evoluzione che rispecchia esattamente l’evoluzione della nostra società. Sino agli anni ’80 il diritto di famiglia era legato a modelli preistorici, ci sono degli aspetti sconvolgenti: soltanto con la legge 442 del 1981 è stato abrogato il delitto d’onore e l’abbandono di minore per causa d’onore, così come il matrimonio riparatore, ovvero quel matrimonio che sanava lo stupro della donna (sanatoria di un reato). La pena era ridotta nel diritto d’onore per chi uccidesse il coniuge, la sorella ecc nell’atto ci congiunzione con altri ecc. sempre nel 1981, tardissimo. La famiglia è il nucleo essenziale e fondante di ogni comunità umana. Basti pensare ai tempi presenti caratterizzati spesso da un modello di famiglia nucleare. Ancora agli inizi del Novecento era predominante la famiglia estesa, allargata a causa delle esigenze della società agricola. SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO Il diritto di famiglia di oggi è considerato moderno, perché molto più evoluto rispetto a quello precedente. Dal punto di vista delle fonti questa disciplina si basa su: - - - Articoli 29, 30, 31 della Costituzione, in aggiunta all’articolo 2. I primi tre sono i pilastri fondanti il moderno sistema del diritto di famiglia, anche se si trova qualche profilo di criticità nella loro lettura, essendo un testo normativo del 1948. Articolo 2 indica personalismo e individualismo. Articolo 29 dice che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società fondata dal matrimonio. Il matrimonio è basato su uguaglianza morale e giuridica dei coniugi ecc. Articolo 30 è dovere e diritto del genitore mantenere ed istruire i figli anche nati al di fuori del matrimonio, se non lo fa è la legge ad agire. Articolo 31 la repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi eccetera… Questi tre articoli sono dunque i pilastri, sebbene anche per percezione istintiva vi sono aspetti che stridono. Innanzitutto, la famiglia è fondata sul matrimonio e i figli nati fuori dal matrimonio hanno tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. Dal 48 molte cose sono cambiate Accanto alla costituzione e ispirati dalla costituzione la nostra esperienza giuridica ha fatto significativi passi avanti a partire dal ’70 e ’75 con l’istituzione del divorzio, con cui il matrimonio ha perso la sua sacralità del principio di indissolubilità. Cinque anni dopo si è dato l’avvio ad una riforma sistematica del diritto di famiglia dando corpo soprattutto all’istanza che era stata dettata dalla costituzione di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Da qua in avanti vengono meno tutte le disuguaglianze e la figura dell’uomo come patriarca. I coniugi diventano membri paritari di questa comunione di vita. Con queste riforme tale è stata la spinta di parificazione che c’è stato anche qualche eccesso nella percezione del coniuge (?). Ancora più dirompente è stato l’aspetto più recente evolutivo del diritto di famiglia. Riforma della filiazione (legge n. 219/2012 e d. lgs. 154 del 2013) e introduzione delle unioni civili (legge n.76 del 2016): l’importanza è fondamentale perché con questi due interventi è stata rimossa ogni residua diversità di trattamento tra figli nati dal matrimonio e quelli fuori dal matrimonio. Fino al 2012 e 2013 ancora persisteva diversità perché fin qua ancora non era riconosciuta la parentela naturale, il figlio naturale non acquisiva legami di parentela con i parenti del genitore. Poi vi è stata perfetta parificazione della filiazione matrimoniale e non matrimoniale (si è tolto il termine legittimo e naturale). Dal punto di vista successorio il figlio naturale non aveva gli stessi diritti. La legge sulle unioni civili ancora non è stata accolta pienamente. È stata introdotta senza chiamare matrimonio e in sede di disciplina sono stati eliminate alcune disposizioni normative. No adozione Il panorama in cui ci muoviamo è dunque questo, ancora in evoluzione. Questo panorama ci permette di guardare alla famiglia superando anche i piccoli incisi stridenti della costituzione. La famiglia viene da queste fonti definita come una formazione sociale, uno strumento di realizzazione della persona, nella sua componente affettiva improntata alla reciproca assistenza morale e materiale, non necessariamente fondata sul matrimonio, ma derivante da una pluralità di modelli. Può essere fondata sul matrimonio, sull’unione civile della legge 76, ma anche sull’unione di fatto. Il fatto che non ci sia la copertura del matrimonio o dell’unione civile non fa venire meno l’essenza della famiglia. Al di là dei problemi di struttura della fattispecie per individuare la famiglia bisogna individuale la funzione. LA FAMIGLIA NUCLEARE E QUELLA ESTESA La famiglia nucleare è la cosiddetta famiglia in senso stretto ovvero le persone tra loro conviventi, coniugi e figli. È un dato tecnico formale che richiama i conviventi coniugi e figli o coniugi componenti l’unione civile e figli. La famiglia in senso ampio invece, estesa, allora ricomprende anche i parenti e gli affini. SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO La parentela è molto semplice ed è il vincolo che unisce le persone discendenti da uno stesso stipite. La riforma della filiazione ha riconosciuto la parentela naturale riformando gli articoli 74 e 258. Art. 74 dice che la parentela è il vincolo tra le persone che discendono dallo stesso stipite sia nel caso di filiazione nel matrimonio, sia fuori, sia per figlio adottivo. L’unico caso in cui non sorge il vincolo di parentela è in caso di adozione di persone di maggiore età. Anche l’articolo 258 risponde alle medesime finalità, di costruzione di un rapporto di parentela tra figlio e famiglia del genitore. Secondo cui il riconoscimento produce gli effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso. Secondo alcuni oltre ad escludere il vincolo di parentela nei casi di adozione di figli che superino la maggiore età, l’articolo 74 esclude anche il vincolo di parentela nelle cosiddette adozioni in casi particolari. Il carattere innovativo di questa nuova disciplina ha spinto il legislatore a disciplinare il diritto transitorio, dichiarando che la nuova disciplina sulla filiazione è applicabile anche alle successioni già aperte. Si distingue inoltre in ambito di parentela la parentela in linea retta da quella collaterale: i parenti in linea retta sono le persone di cui una discende dall’altra, i parenti in linea collaterale non discendono l’uno dall’altro tipo zio e nipote. Il grado di parentela è l’intervallo generazionale che separa tra loro due o più soggetti: nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente sempre restando escluso lo stipite. La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, ma a volte anche meno (ad esempio richiesta di inabilitazione entro il quarto grado). Infine, bisogna distinguere i fratelli germani dai fratelli unilaterali. I primi sono coloro che discendono dagli stessi genitori, entrambi, mentre coloro che hanno in comune un solo genitore sono detti unilaterali, questa distinzione rileva nell’obbligo alimentare e nelle successioni. Per definire invece l’affinità, questa è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. Quindi si costituisce per effetto del matrimonio. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente di uno dei coniugi, è affine dell’altro coniuge. Quindi anche il rapporto di affinità si differenzia per linea retta o collaterale e per grado, ma bisogna avere come riferimento sempre il rapporto di parentela dell’altro coniuge. Gli affini di ciascun coniuge non sono affini tra loro. Lezione 9 diritto privato mod. b IL MATRIMONIO 1 Disciplina molto dettagliata. Disciplina dell’atto ovvero il fatto storico del comportamento dei futuri coniugi e il documento che ne deriva. L’atto è proprio del matrimonio e dell’unione civile. Studieremo prima la celebrazione, gli impedimenti e le eventuali invalidità poi la disciplina del rapporto quindi effetti personali, patrimoniali ed effetti nei confronti dei figli. In ultimo studieremo la crisi quindi separazione o divorzio. Ricordiamo che a differenza della disciplina fondata su matrimonio e sull’unione la disciplina dell’unione di fatto è assente o molto scarna. DISCIPLINA DELL’ATTO: LA CELEBRAZIONE, GLI IMPEDIMENTI E L’INVALIDITÀ Promessa di matrimonio articolo 81 cc: “La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti. SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro.” Il nostro ordinamento lascia molto liberi, i nubendi possono sino ad un attimo prima la libertà di non contrarre il matrimonio. La promessa di matrimonio non obbliga a contrarre e non obbliga neanche qualora i nubendi abbiano previsto eventuali conseguenze di mancato adempimento. Non è un’obbligazione coercibile quella assunta in sede di promessa. L’unica obbligazione è la restituzione dei doni fatti a causa della promessa. Il caso è quello dell’anello di fidanzamento, l’unica conseguenza. Questa disciplina si applica a prescindere dal motivo della rottura della promessa. Qualora vi sia stata una rottura ingiustificata si producono effetti restitutori ma anche limitatamente effetti risarcitori. Tutte le volte in cui l’uno abbia dato causa giusta per lo sciogliersi della promessa come ad esempio infedeltà. Ci vuole però una promessa che abbia una certa validità (atto pubblico o richiesta pubblicazione di scrittura privata) e la richiesta deve avvenire da un soggetto di maggiore età o minore concesso a matrimonio. Se si dimostra ha diritto a vedersi risarcite obbligazioni contratte e spese fatte in vista del matrimonio. Devono essere spese e obbligazioni ragionevoli e proporzionate in base alla condizione delle parti. La prescrizione è quella di un anno dalla rottura della promessa. L’articolo 81 permette di escludere altri danni risarcibili come quelli morali. Vi sono tre modelli per la celebrazione di matrimonio: 1) Matrimonio concordatario. Quello celebrato davanti al ministro del culto cattolico, sulla base dei patti lateranensi del ‘29 e sulla revisione di questi del ‘84. Il procedimento è molto simile al matrimonio civile, vi sono aspetti prettamente religiosi ed aspetti civili. Le norme del diritto canonico che regolano tale matrimonio prevedono: - Pubblicazione sulla porta della chiesa parrocchiale e sulla porta della casa comunale (albo pretorio online) - Viene fatta davanti al ministro del culto cattolico con due testimoni. Il ministro del culto darà lettura a degli articoli 143,144,147 che disciplinano i diritti e i doveri dei coniugi, condensano gli aspetti personali dei coniugi dal punto di vista del diritto privato. Poi raccoglie i consensi e dichiara che i nubendi si vogliono riconoscere come marito e moglie infine dichiarando che sono uniti in matrimonio. Questo è il momento nel quale si perfeziona l’atto. A seguire il ministro del culto redige l’atto di matrimonio in doppio originale uno trasmesso entro cinque giorni all’ufficiale dello stato civile che lo deve trascrivere nei registri dello stato civile. Con la trascrizione si producono però gli effetti civili del matrimonio ma sono retroattivi al momento della celebrazione. Le norme di diritto canonico prevedono degli impedimenti alla trascrizione, simili ma più ristretti rispetto a quelli del diritto civile. Per diritto canonico non si può procedere alla trascrizione (impedimenti) se sussiste minore età o impedimento inderogabile come interdizione, delitto, affinità in linea retta e libertà di stato. Sotto il profilo della giurisdizione, nell’ambito dei patti lateranensi, si è stabilito, decisione valida ancora oggi, che il matrimonio concordatario può essere impugnato per nullità davanti ai tribunali ecclesiastici. Diverso è invece tutto ciò che riguarda il rapporto conseguente, il matrimonio come rapporto resta disciplinato dalla giurisdizione dello stato (rapporto con i figli, tra coniugi eccetera). L’eventuale sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico dovrà essere delibata dal giudice italiano. La corte d’appello dovrà dare esecuzione ed efficacia, stesso procedimento che si fa per sentenze decise fuori dal territorio italiano. Valuterà la competenza, che sia stato assicurato il contradditorio tra le parti, se sussistono le altre condizioni come la non contrarietà all’ordine SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO pubblico, se sussistono queste la corte d’appello deliberà la sentenza, facendo sì che abbia efficacia nel nostro ordinamento. 2) Matrimonio davanti al ministro del culto acattolico. La sua disciplina ci interessa marginalmente. Bastano due precisazioni: ci sono culti ammessi nello stato italiano nel nostro ordinamento, in questo caso l’atto di matrimonio è interamente regolato dalle norme del Codice civile. è necessario ottenere l’autorizzazione dell’ufficiale dello stato civile e poi la trascrizione nei registri dello stato civile. è una disciplina piuttosto residuale, perché vi sono molti accordi che lo stato ha fatto con varie confessioni religiose, con la maggior parte sono state stipulate delle intese che regolano anche la possibilità di celebrazione con riti differenti (evangelisti, buddisti, comunità ebraica, comunità valdese, luterani). Le più importanti e numerose hanno stipulato delle intese. Laddove non ci siano intese allora opera la disciplina residuale. 3) Matrimonio civile. È quello celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile. Dal punto di vista storico il matrimonio è stato disciplinato dalle norme del Codice civile solo tardi dopo la Rivoluzione francese, prima era solo un affare religioso. Abbiamo le medesime fasi del matrimonio concordatario, non a caso sovrapponibili. - Pubblicazione sulla sola casa comunale dei comuni di residenza dei coniugi per almeno otto giorni. A seguire la celebrazione avviene davanti all’ufficiale dello stato civile. - Lettura degli articoli, consensi, dichiara che i nubendi si prendono come marito e moglie e li dichiara uniti in matrimonio. La mancanza delle pubblicazioni e la mancata lettura degli articoli o l’assenza dei testimoni si traduce in sanzioni amministrative, che in caso di mancanza di pubblicazioni riguarderanno anche i coniugi se non solo l’ufficiale. Non è motivo di invalidità. La funzione delle pubblicazioni è quella di pubblicità notizia, cioè rendere edotta la comunità, informare della circostanza che si sta per celebrare un matrimonio tra due persone, serve per dare la possibilità ad alcuni soggetti di opporsi alla celebrazione di matrimonio. Possono opporsi qualora vi siano degli impedimenti allo stesso i genitori o in mancanza gli ascendenti, i collaterali entro il terzo grado oppure il PM, se consta esistenza di impedimento o infermità di mente. Questi soggetti fanno ricorso al presidente del tribunale del luogo della pubblicazione per sospendere celebrazione, se non avviene ufficiale dello stato civile sospende la trascrizione fino all’esito del giudizio. Svolge una unzione di controllo preventivo dando la possibilità a taluni soggetti di impedire che si celebri un matrimonio laddove vi siano impedimenti. Primo controllo in sede di pubblicazione poi in sede di trascrizione. Il secondo problema è il matrimonio celebrato dall’apparente ufficiale dello stato civile. l’ordinamento si occupa davanti a situazioni di apparenza di salvare la validità del vincolo che i coniugi hanno stretto. Articolo 113 dice che qualora i coniugi si trovino ad aver celebrato il matrimonio con un ufficiale che invece non aveva i poteri per celebrarlo, ma ciò non di meno esercitava pubblicamente le funzioni di ufficiale dello stato civile ma aveva creato un’apparenza, allora i coniugi se entrambi o almeno uno in buona fede si considerano validamente sposati. Perché l’ordinamento bilancia l’interesse dei nubendi se in buona fede con l’interesse alla regolarità formale, è il punto di equilibrio che ci sia l’esercizio pubblico della funzione che crei un affidamento in coloro che sono stati parte della celebrazione. Caso più frequente è quello dell’ufficiale che abbia ricevuto delega poi risultata invalida. Redazione dell’atto di matrimonio spetta all’ufficiale dello stato civile va composto dopo la celebrazione. Va inserito nel registro dello stato civile. La natura di questo atto è un contratto? Un atto di autonomia negoziale? SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO Vi sono una serie di elementi che inducono a farci dubitare della natura pienamente contrattuale dell’atto di matrimonio: - - - - Il contratto gestisce un contenuto patrimoniale, nel matrimonio il contenuto è personale. Gli effetti che sorgono in conseguenza sono personali, solo di riflesso in via mediata ci sono riflessi anche patrimoniali Presenza dell’ufficiale dello stato civile, in assenza del quale non può essere contratto matrimonio. Actus legitimus, non ammette termini e condizioni, si hanno per non apposti Atto personalissimo, non è consentita ai nubendi la possibilità di farsi sostituire, eccezionalmente è possibile la presenza di un nuncius (il rappresentante partecipa all’atto anche con la propria volontà stati soggettivi si presentano anche sul rappresentante, nuncius non partecipa con la propria volontà, è un portavoce della volontà altrui). I casi di matrimonio per procura sono caso di militare al tempo di guerra oppure matrimonio di colui che risiede all’estero e in presenza di gravi motivi può chiedere al presidente del tribunale un’autorizzazione a contrarre matrimonio per procura, il tribunale in presenza di gravi motivi con decreto non impugnabile può farlo. Tipicità del contenuto e impossibilità per le parti di modificare lo schema legale. C’è un margine minimo, i coniugi potranno soltanto in minima parte nei limiti del 144. I diritti e i doveri dei coniugi sono immodificabili, non si può cambiare obbligo di fedeltà di collaborazione eccetera. Il 144 rende concordabile l’indirizzo della vita familiare e la residenza della famiglia, poi spetta al singolo coniuge il potere di attuare l’indirizzo concordato. Inderogabilità degli effetti espressamente sancita dall’articolo 160. Non possono i coniugi liberamente derogare dal reciproco obbligo di fedeltà, di assistenza morale, alla contribuzione e collaborazione. Tutti questi elementi ci fanno intendere che l’atto di matrimonio non si tratti puramente di un contratto, né come atto di autonomia. Lo dobbiamo qualificare come atto giuridico complesso nel quale alla volontà dei nubendi si somma l’accertamento costitutivo dell’ufficiale dello stato civile, che è là in chiave di garanzia e accerta l’esistenza della volontà conferendo all’incontro dei consensi gli effetti del sorgere del vincolo. L’effetto costitutivo del vincolo è dato da presenza dell’ufficiale e dal suo accertamento. Senza la volontà dei nubendi il matrimonio è inesistente ma anche senza l’accertamento costitutivo. L’atto di matrimonio che incorpora le dichiarazioni sottoscritto dall’ufficiale civile non è costitutivo dello status, ma rappresenta la valida prova della celebrazione e la valida prova dello status coniugale. Validità probatoria: - Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio senza l’estratto dell’atto civile dai registri. Solo in caso di distruzione o smarrimento dei registri allora l’esistenza del matrimonio può essere provata con ogni mezzo, come testimoni. In caso di difetti di forma dell’atto si può dimostrare lo status coniugale con il cosiddetto possesso di stato coniugale. Portare lo stesso cognome, riconoscersi reciprocamente e come tali essere percepiti in un contesto sociale. Il matrimonio come atto è diverso dal rapporto che è tutto ciò che viene dopo l’atto. IMPEDIMENTI Gli impedimenti sono le condizioni per contrarre matrimonio, ovvero le condizioni in presenza delle quali si può giungere a contrarre matrimonio. Si distinguono in assoluti e relativi e dispensabili e non dispensabili. SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO Una terza distinzione che riguarda gli impedimenti ha rilevanza sotto il profilo dell’invalidità, è quella tra impedimenti dirimenti o impedienti. Sono condizioni che a monte impediscono di contrarre matrimonio, ma se il matrimonio viene comunque celebrato, questi impedimenti ex post diventano cause di invalidità. Sono cause che l’ufficiale civile dovrebbe controllare ex ante, ma avvenuta la celebrazione nonostante questi impedimenti questi si trasformano in cause di invalidità. Gli impedimenti sono assoluti o relativi a seconda che impediscano al soggetto di contrarre matrimonio con chiunque oppure che impediscano di contrarre matrimonio solo con alcuni soggetti e con altri no. Poi distinguiamo dispensabili ovvero quelli che possono essere superati da un provvedimento giurisdizionale in forza del quale viene meno l’impedimento da quelli indispensabili. La terza distinzione invece, ovvero la ricaduta in chiave di validità, sono dirimenti se si risolvono in nullità mentre impedienti se si risolvono in una mera irregolarità. Gli impedimenti: - - - - La minore età, è un impedimento assoluto per cui il minore d’età non può contrarre matrimonio con nessuno, ma dispensabile cioè superabile. Può essere superato se il tribunale sentito il PM e i genitori con decreto pronunciato in camera di consiglio e su istanza dell’interessato può autorizzare il minore purché maggiore di 16 anni a contrarre matrimonio se ne accerti la maturità psicofisica e la fondatezza delle ragioni addotte. Quindi si applica la disciplina dell’emancipazione. Interdizione per infermità di mente, è un impedimento assoluto e non dispensabile. L’interdetto non può sposarsi e non vi è modo per superare questo divieto. Mancanza della libertà di stato, cioè l’esistenza di un precedente matrimonio ancora non annullato né sciolto. È un impedimento assoluto e non dispensabile. Colui che è già sposato non si può risposare con nessun altro in costanza del matrimonio precedente e non si può aggirare la regola. Il rapporto di parentela, ovvero un impedimento relativo ma dispensabile in alcuni casi. L’articolo 87 dice che non possono contrarre matrimonio tra loro i discendenti e ascendenti in linea retta, sia legittima che naturale. Non possono contrarre matrimonio i fratelli e le sorelle che siano germani o unilaterali, la zia e il nipote o lo zio e il nipote, gli affini in linea retta o in linea collaterale di secondo grado (i cognati), l’adottato e i discendenti e altre ipotesi… Il tribunale su ricorso degli interessati sempre su decreto emesso da camera del consiglio e sentito il PM (che c’è sempre nell’ambito di famiglia a tutela dell’interesse generale), può autorizzare il matrimonio tra questi soggetti ma non tra tutti. Le ipotesi sono lo zio e la nipote e la zia e il nipote, gli affini in linea collaterale e altresì gli affini in linea retta se l’affinità deriva da un matrimonio poi dichiarato nullo. Impedimentum criminis, è relativo e non dispensabile. È relativo perché è un impedimento che opera rispetto ad una certa persona e non rispetto a chiunque altro, secondo questo impedimento non possono sposarsi le persone delle quali una sia stata condannata per omicidio o tentato omicidio del coniuge dell’altra. È un impedimento, dunque, che vige solo nel rapporto tra quelle due persone ed è insuperabile. Questi impedimenti sono i più gravi e condurranno alla nullità. Sono quindi impedimenti dirimenti. Sono invece impedimenti impedienti quelli che conducono ad una mera irregolarità: - Lutto vedovile, è un istituto antichissimo, impedirebbe alla sola donna di sposarsi se non siano decorsi 300 giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, salvo che lo scioglimento o la cessazione non siano intervenuti a SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO seguito di separazione o se si tratta di matrimonio non consumato o se la nullità è stata dichiarata per impotenza anche solo generandi del marito. Serviva ad eliminare ogni equivoco rispetto ad una eventuale gravidanza della donna perché prima di questi 300 giorni l’eventuale figlio concepito dalla donna era incerto se fosse figlio del primo coniuge o del successivo. Oggi è superato questo problema, sembra una norma preistorica ma esiste ancora, anche se non è una regola così insuperabile. È possibile ottenere dal tribunale l’autorizzazione a sposarsi anche prima del decorso dei 300 giorni, sentito PM e in camera di consiglio, darà l’autorizzazione se risulterà del tutto esclusa la gravidanza della donna che intende sposarsi. È un impedimento impediente che non condurrà alla nullità del matrimonio contratto prima dei 300 ma ad una sanzione amministrativa pecuniaria per il celebrante e per i coniugi. Questi impedimenti danno diritto ad opporsi al matrimonio, ai genitori agli ascendenti e ai collaterali fino al terzo grado. Questi impedimenti rilevano altresì nella fase della trascrizione, qualora questo non si sia verificato quindi celebrante non ha verificato, nessuno si è opposto e ufficiale civile in sede di trascrizione non ha verificato questi casi si trasformano in nullità dell’atto di matrimonio. Qualora tutto ciò non si sia verificato questi impedimenti si trasformano in disciplina di invalidità si trasformano in nullità dell’atto di matrimonio. Con la precisazione che i dirimenti rappresentano cause di nullità, gli impedienti non toccano la validità, ma determinano l’insorgere di una responsabilità amministrativa in capo al celebrante e ai coniugi. La disciplina dell’invalidità matrimoniale è particolare; in ambito del diritto di famiglia non tutte le categorie sono riconducibili a quelle studiate nel diritto delle obbligazioni e dei contratti. Sebbene alcuni termini siano i medesimi non possiamo ricorrere allo stesso tipo di categoria. Qua gli interessi sono non patrimoniali. Nel codice spesso si parla di nullità o annullabilità, ma non sempre alla nullità segue il principio che abbiamo visto applicabile nel mondo del diritto dei contratti (tipo imprescrittibile e fatta valere da chiunque) qui è sanabile e relativa, non tutti possono farla valere. Stessa cosa con l’annullabilità a volte non è relativa ecc. è un regime misto di invalidità che talvolta assume le caratteristiche della nullità relativa e talvolta dell’annullabilità assoluta. Regime misto differente dalla disciplina dei contratti e delle obbligazioni. Se parliamo di matrimonio non applichiamo le stesse categorie, così come nelle successioni non applichiamo le stesse categorie. Abbiamo nell’ambito matrimoniale ipotesi di invalidità con aspetti di nullità e aspetti di annullabilità talvolta sanabile talvolta non sanabile. Impedimenti dirimenti: (nullità) - - La minore età Dispensabilità ex ante Legittimazione media (coniugi+genitori+pm+ minore entro un anno dalla maggiore età) Dopo un anno dalla maggiore età qualora nessuno lo abbia impugnato il matrimonio resta intatto, si verifica cioè una causa di sanabilità. Se la domanda è proposta da genitori e PM deve essere spinta se c’è stato concepimento o procreazione e minore abbia superato la maggiore età e risulti la volontà di rimanere coniugato. A monte può essere dispensata come impedimento, se non viene dispensata può essere invalidità. Si può impugnare ma è sanabile. Interdizione per infermità di mente SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO - - - A monte non poteva essere sanato in nessun modo. Se si celebra nonostante l’interdizione il matrimonio invalido può essere impugnato su istanza del tutore del pubblico ministero e di chiunque ne abbia interesse. Vi è una possibilità di sanatoria perché l’invalidità si sana con la coabitazione di almeno un anno dal momento della cessazione dell’interdizione. Mancanza della libertà di stato Quest’ipotesi è quella della bigamia, si giunge al secondo matrimonio quando ce n’è già uno valido, né invalido né sciolto. A monte era assoluta e non dispensabile, allo stesso modo ha una legittimazione assoluta (coniugi, ascendenti pubblico ministero e chiunque ne abbia interesse) è insanabile Rapporto di parentela Legittimazione assoluta, ma così come c’erano delle ipotesi di dispensabilità ce ne sono altre di sanabilità, che sono le stesse ipotesi. Nei casi nei quali i coniugi avrebbero potuto ottenere la dispensa in quei medesimi casi l’invalidità si sana decorso un anno dalla celebrazione. Impedimentum criminis Legittimazione assoluta, insanabile. Sotto il profilo degli impedimenti impedienti invece c’è solo il lutto vedovile che non dà invalidità ma solo irregolarità amministrativa. Ma l’invalidità non riguarda solo le ipotesi di impedimenti, abbraccia gli impedimenti ma anche altre ipotesi. Altri presupposti sono: - I vizi del consenso. Incapacità naturale, violenza, errore. Incapacità naturale di intendere e di volere, situazione di fatto anche eventualmente temporanea (soggetto drogato, ubriacato, shock). L’incapacità di intendere e di volere può anche essere uno stato di infermità mentale durevole che non è ancora stata accertata con tutto il procedimento che giunge all’interdizione. Prima che si giunga all’interdizione tutta la fase precedente è regolata dall’incapacità naturale. Il matrimonio in questo caso potrà essere impugnato da quello dei coniugi che dimostri di essersi trovato nello stato di alterazione dell’aspetto volitivo o ??, quindi dall’incapace stesso che dovrà solo dimostrare di essersi trovato in condizione di incapacità al momento del matrimonio. Non dovrà dimostrare dunque nessun altro presupposto per ottenere l’annullamento, né la conoscibilità in capo all’altro coniuge, né il grave pregiudizio per sé stesso che dovevano essere dimostrati in ambito contrattuale. In ambito matrimoniale non opera il principio dell’affidamento, si tutela l’integrità del consenso. L’interesse dell’ordinamento è tutelare la volontà del soggetto che giunge a contrarre matrimonio non tutti gli altri principi come l’affidamento che operano in ambito matrimoniale. Si tutela la purezza della volontà di chi giunge a sposarsi. Per la violenza il matrimonio può essere impugnato qualora sia frutto di violenza, cioè qualora il consenso del coniuge sia stato estorto con la minaccia di un male ingiusto o sia stato determinato da timore di eccezionale gravità anche derivante da cause esterne allo sposo. Sulla violenza in ambito matrimoniale bisogna precisare innanzitutto che i caratteri della violenza necessari per impugnare l’atto sono i medesimi del 1435, male ingiusto e notevole che si rivolge contro la persona contraente, i propri beni e i congiunti e i loro beni, si aggiunge però anche la possibilità di impugnazione per un timore di eccezionale gravità anche derivante da cause esterne allo sposo. Tipo donne che sono state costrette a sposarsi per ottenere cognome non ebraico per timore della persecuzione. Questa disposizione conserva ancora una sua importanza, a volte fatti in cui esiste ancora questa pratica del matrimonio per timore. Si tratta di violenza morale e non fisica, il matrimonio è inesistente. SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO Per l’errore anche qua dobbiamo distinguerlo da quello dei contratti, il problema della riconoscibilità non esiste. Proviene dall’altra persona tendenzialmente, è un matrimonio annullabile quando: Errore sull’identità del coniuge. Non si tratta del matrimonio sotto falso nome, è un errore sulla individuazione della persona, lo scambio di persone Errore essenziale sulle qualità personali. Ipotesi tipiche di ignoranza, poste dall’ordinamento, ovvero: malattia fisica o psichica dell’altro coniuge, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale, esistente al momento della celebrazione e non conosciuta. Impotenza generandi o coeundi. Condanna per gravi reati o dichiarazione di delinquenza abituale o professionale. Reati gravi in considerazione sono reati con pena di reclusione con pena di cinque anni e più. Condanna per delitti concernenti la prostituzione, puniti con pena non inferiore a due anni. Dello stato di gravidanza della donna, cagionato da un terzo, purché ci sia stato disconoscimento della paternità se la gravidanza è portata a termine. Gli altri casi tipo esistenza di una malattia celata che non sia nell’elenco delle malattie tipiche non è che il matrimonio non si può annullare, comunque si può sciogliere tramite separazione o divorzio, non si può annullare con sentenza di nullità. In tutti questi casi la legittimazione ad impugnare spetta solo ai coniugi. Manca la disciplina del dolo perché le ipotesi dell’errore quasi corrispondono con quelle del dolo, se si nasconde malattia è quasi un dolo, si coglie nelle trame dell’errore. La sanabilità in questi casi è prevista con un anno di coabitazione, dopo che sia cessata l’incapacità naturale, si è scoperto l’errore, è celato il timore o la violenza morale. - Il ritorno del presunto morto. Tra le cause di invalidità c’è il ritorno del presunto morto. La dichiarazione di morte presunta consente la produzione di effetti parificabili quanto a importanza alla morte effettiva. La sentenza che dichiara la morte presunta trasforma in definitivi quegli effetti finora temporanei, come chi era stato messo nel possesso temporaneo dei beni acquista la libera disponibilità e così viene liberato dalle obbligazioni il debitore che aveva debiti nei confronti del presunto morto. Sotto il profilo della libertà matrimoniale succede che il coniuge può contrarre altro matrimonio, accade lo stesso che accade sotto il profilo degli aspetti patrimoniali del presunto morto. Perché se questi ritorni nonostante la sentenza allora quel soggetto ha diritto ad ottenere i suoi beni assegnati ad altri anche se nello stato in cui si trovano, così come si trovano dopo tutti gli anni di gestione da parte di altri, anche le obbligazioni rivivono, allo stesso modo il coniuge del presunto morto che abbia contratto nuovo matrimonio ma qualora ritorni il presunto morto il matrimonio contratto è nullo. Anche qua vi è una piccola clausola di salvezza perché la nullità non può essere pronunciata se è accertata la morte effettiva del presunto morto; persino se la morte sia successiva al matrimonio. Ciò significa che se anziché tornare il morto se ne accerti il reale decesso anche se questo è avvenuto dopo che il coniuge ha contratto un secondo matrimonio non è causa di nullità, il secondo matrimonio potrebbe essere viziato da bigamia formalmente, in ogni caso però non si può impugnare per nullità. L’ordinamento sceglie di salvare il secondo matrimonio. In tutte le ipotesi in cui opera la nullità il matrimonio viene dichiarato nullo con effetto retroattivo tra le parti. C’è la necessità di tutelare l’interesse di coloro che sono stati parte di questo rapporto. Si applica un temperamento dato dalla disciplina del matrimonio putativo per l’effetto retroattivo della sentenza. SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO Secondo questa disciplina la sentenza ha effetto retroattivo ma non riguardo ai figli. I figli nati in costanza di un matrimonio anche se dichiarato nullo saranno considerati figli matrimoniali, cioè su di essi si produrranno gli effetti di un matrimonio valido. Per loro la nullità opererà con efficacia ex nunc, con piena operatività anche delle presunzioni di paternità nell’ambito della filiazione matrimoniale. Se i coniugi sono in buona fede la nullità opera retroattivamente. Ciò rileva a fini successori, il coniuge anche se separato senza debito fa parte dei soggetti successibili ed anche legittimari. La sentenza di nullità facendo venire meno il vincolo farebbe venire meno anche questo ruolo del coniuge che perderebbe i suoi diritti successori. Due particolarità: quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad entrambi i coniugi il giudice adotta i provvedimenti riguardo ai figli e può anche disporre a carico di uno e a vantaggio di altro un obbligo di corresponsione di una somma periodica, se l’altro non abbia redditi adeguati e se non è passato a nuove nozze. È parificabile all’obbligo di mantenimento per un certo periodo di tempo che ci sarebbe nell’ambito di un matrimonio valido, ma qui è sciolto quindi provvedimento similare circoscritto nel tempo ovvero tre anni. Se il coniuge ha dato causa all’invalidità come la violenza perpetrata da uno a danno dell’altro allora può anche essere condannato ad una indennità corrispondente al mantenimento per tre anni ed è inserito tra i soggetti che hanno l’obbligo alimentare se non ci sono altri obbligati. IL MATRIMONIO SIMULATO Il libro lo mette nelle cause di invalidità, tuttavia il matrimonio simulato è circostanza diversa dal vizio nel matrimonio. Il matrimonio simulato non è tanto diverso dalla simulazione studiata in ambito contrattuale; qui abbiamo le parti che pongono in essere una apparenza diversa dalla reale volontà che li anima. Pongono in essere una apparenza, una finzione, contraggono un matrimonio non voluto, rispettando tutte le formalità necessarie. Formalmente l’involucro è reale ed è inappuntabile, non presenta vizi di invalidità, le parti però si accordano per non rispettare alcuno degli obblighi e non assumere i diritti derivanti dal matrimonio; quindi, fingono di realizzare un matrimonio svuotandolo dei contenuti. Si fa soprattutto per ragioni di cittadinanza. È un matrimonio però invalido sotto il profilo della idoneità a produrre effetti, ma questa inidoneità a produrre effetti può essere eccepita solo dai coniugi e può essere eccepita solo entro l’anno dalla celebrazione. Superato l’anno questa apparenza di matrimonio si sana e si converte in una sostanza e nessuno dei due coniugi potrà più eccepire la simulazione del matrimonio, così come non potrà essere eccepita se ci sia stata convivenza successiva alla celebrazione, anche per un periodo più breve dell’anno. Lezione 10 diritto privato mod. b IL MATRIMONIO 2 I RAPPORTI PERSONALI Discipliniamo ora il rapporto quindi effetti personali, patrimoniali ed effetti nei confronti dei figli. Le conseguenze personali che derivano dalla celebrazione del matrimonio le rinveniamo agli articoli 143 e seguenti, l’ufficiale civile o il celebratore del culto li leggono. L’articolo 143 precisa in ossequio a quanto previsto dalla costituzione, che con il matrimonio i coniugi acquistano i medesimi diritti e assumono i medesimi doveri. Sembra una banalità ma prima del ’75 non c’era neanche una parità dal punto di vista delle dichiarazioni formali, tipo adulterio moglie diverso da quello del marito; oggi almeno la formalità è alla pari. I diritti e doveri sono chiariti dal secondo comma: con il matrimonio i coniugi hanno SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO - - - - - Obbligo reciproco alla fedeltà, sulla fedeltà bisogna precisare l’evoluzione che il concetto di fedeltà ha assunto che non è soltanto esclusività dal punto di vista sessuale, è un’esclusività sia fisica che spirituale. Per cui viola l’obbligo anche chi senza intrattenere una relazione sessuale offenda il decoro e la reputazione del coniuge intrattenendo relazioni e rapporti intimi anche dal profilo soltanto spirituale e morale. È la violazione dell’esclusività legata alla figura del coniuge. Mentre tendenzialmente si esclude un danno risarcibile ex 2043 in presenza di tradimento, la sanzione tendenzialmente è solo l’addebito della separazione; la giurisprudenza ammette anche il danno da tradimento quando la violazione della fedeltà leda anche altri interessi esistenziali, come il diritto alla salute e alla dignità del coniuge. Obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale, si traduce nel sostengo e nella vicinanza spirituale e materiale. Entrambi devono impegnarsi per il soddisfacimento dei bisogni del coniuge sia sotto il profilo morale sia sotto il profilo materiale, fornendo ove occorra le risorse economiche all’altro coniuge. Per esempio, viola questo obbligo quel coniuge che si arricchisca con il proprio lavoro oltre misura ma non faccia partecipare l’altro coniuge al medesimo tenore di vita, lasciandolo al minimo della collaborazione al mantenimento della famiglia. Obbligo alla collaborazione nell’interesse dei figli, sposta il focus dalla dimensione di coppia, dal rapporto tra i coniugi alla dimensione comunitaria della famiglia. Questi devono collaborare all’interesse della famiglia nel senso che entrambi devono cooperare all’assunzione delle scelte legate alla famiglia, entrambi devono cooperare nel portare avanti il ménage familiare e precisa la giurisprudenza in posizione di parità. Viola l’obbligo di collaborazione sia il coniuge che si disinteressi completamente della vita familiare sia quello che autoritativamente le assuma. È necessaria la cooperazione in posizione di parità, gestione democratica. Obbligo alla coabitazione, la coabitazione è l’obbligo dei coniugi di vivere sotto lo stesso tetto, ma questo dovere di coabitazione subisce dei temperamenti. Il primo è quello legato all’articolo 45, ovvero secondo cui ciascun coniuge può anche avere un domicilio autonomo quando esigenze di vita soprattutto lavorativa lo esigano. Vivere sotto lo stesso tetto in modo che esista una residenza familiare, ma ciascuno può avere domicilio autonomo. Il secondo posto dal 144, per accordo tra le parti i coniugi possono disciplinare questo aspetto legato alla residenza comune secondo le esigenze di entrambi; quindi, è uno di quegli aspetti che le parti possono derogare di comune accordo. Infine, l’obbligo di coabitazione cessa sempre quando vi è una giusta causa e viene meno quando la convivenza diviene intollerabile dando così luogo ai presupposti per la separazione. Obbligo alla contribuzione ai bisogni della famiglia, l’ultimo dei doveri è quello di contribuzione che analizziamo nell’ambito dei rapporti patrimoniali. Questo obbligo rappresenta il regime primario sotto il profilo patrimoniale. Proseguiamo con l’articolo 144, che è servente rispetto al 143, ed è una disposizione particolare ovvero si dice che i coniugi concordano l’indirizzo della vita familiare e stabiliscono concordemente la residenza secondo le esigenze di entrambi. Ciascuno dei due ha diritto ad attuare le scelte concordate. Secondo alcuni rappresenta l’unico momento nel quale entra nel matrimonio un po’ di autonomia negoziale. Il 143 pone i diritti e i doveri in maniera tassativa, le parti non potrebbero disapplicarli o cambiarli; si ritiene però che nel 144 secondo cui i coniugi concordano l’indirizzo consente di modulare diversamente questi diritti e doveri. Qualcuno più liberista ritiene che esista un margine anche ampio di modulazione, i coniugi potrebbero con il 144 disapplicare qualcuno dei doveri come scelte di libertà di coppia sessuale in ambito matrimoniale; in realtà è un’interpretazione un po’ estrema. Di certo però si può personalizzare e caratterizzare questi diritti e doveri purché ne sia rispettato il nucleo essenziale; cioè i diritti e i doveri nel loro nucleo essenziale più profondo non possono essere derogati o disapplicati, solo leggermente modulati. Non ci si potrebbe spingere fino alla libertà sessuale eccetera, ma si può modulare. SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO Questi aspetti a volte non arrivano neanche alla giurisprudenza, a volte le famiglie fanno tali cose nella loro intimità, senza dire nulla o far emergere. La famiglia è un ambito molto problematico perché protetto, l’intimità della famiglia non consente di fare venire a galla spesso nodi problematici. Quando si ritiene che il 144 abbia anche contenuto patrimoniale la dottrina ritiene che questi accordi siano anche vincolanti, sebbene non assurgano a rango di veri e propri contratti si ritiene comunque che abbiano natura vincolante. Se i coniugi sono in conflitto e non risolvono concordemente l’indirizzo familiare, non modulando gli obblighi e i doveri del 143, si fa ricorso all’intervento giudiziale. È possibile cioè che qualora le parti non siano riuscite a mettersi d’accordo allora possono fare ricorso al giudice, secondo due piani: - - Primo livello di intervento è un intervento meramente conciliativo, il 145 dice che sentiti i coniugi e i figli conviventi che abbiano compiuto i 16 anni il giudice cerca di trovare una soluzione. Al giudice ciascuno dei due coniugi può fare ricorso senza formalità e questi compie un primo intervento conciliativo, di mediazione. Qualora la mediazione non sia possibile il giudice può operare con un intervento autoritativo cioè imponendo una decisione ma in questo caso si deve trattare della fissazione della residenza o di altri affari essenziali per la famiglia, ma soprattutto i coniugi devono richiedere al giudice espressamente e congiuntamente l’intervento autoritativo. Devono essere almeno d’accordo sull’intervento giudiziale. La violazione di questi obblighi del 143 come sanzione comporterà solo l’addebito della separazione, l’unica conseguenza della violazione di questi obblighi è che in sede di separazione tra i coniugi la separazione verrà addebitata al coniuge che avrà violato gli obblighi, salvo il caso che ci sia anche una responsabilità extracontrattuale come tradimento, quindi non solo violazione degli obblighi ma anche lesione di un altro interesse. Diversa dall’ipotesi degli obblighi previsti dal 143 è l’ordine di protezione degli obblighi familiari. È una disciplina fondamentale da non confondere con i diritti e di doveri dei coniugi; posta nel 2001 per far fronte all’emergenza della violenza domestica. Ha tentato di reagire ai frequenti casi dei maltrattamenti in famiglia, si è rivelata completamente insufficiente ma ha la sua importanza. È posta dagli articoli 342 bis e ter, prevede che in presenza di una condotta gravemente pregiudizievole di un coniuge o di un convivente nei confronti dell’integrità fisica o morale, o nei confronti della libertà dell’altro, su istanza di parte si possa fare ricorso per ottenere un decreto di cessazione della condotta. Con questo decreto il tribunale ordina la cessazione e l’allontanamento da casa di chi ha posto in essere il comportamento, ove occorra con ordine di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla parte istante per una durata inizialmente di 6 mesi poi un anno (nel 2009); con il medesimo decreto si può disporre l’eventuale intervento di servizi sociali o centro di mediazione familiare e si può condannare la persona del cui allontanamento si tratta al pagamento di somme periodiche di denaro se allontanatosi il soggetto l’istante e i familiari restano privi di mezzi di sostentamento (se chi si allontana era l’unica fonte di reddito della famiglia dovrà mandare denaro). Tutto questo è tutela civilistica che fa salva tutta la tutela penalistica, è un tassello che si aggiunge alla disciplina penalistica e dovrebbe rafforzare chi subisce violenza anche se serve a poco. Ultimo aspetto legato agli obblighi matrimoniali è il 147, ovvero quell’articolo che impone di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità e aspirazioni (è letto anche questo dal prete o ufficiale). Quindi riguarda i doveri di entrambi nei confronti dei figli, è un ponte che porta ad approfondire i rapporti dei coniugi nei confronti dei figli. SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO Ultimo aspetto disciplinato è l’assunzione del cognome, aspetto che ancora appartenga ad una visione maschilista e patriarcale della famiglia, è una concessione che l’ordinamento ancora fa alla disparità di trattamento. Giustifica dicendo che si deve assicurare l’individuazione unitaria dei componenti della stessa famiglia. L’articolo 145 ci dice che con la celebrazione del matrimonio la moglie acquista il diritto e anche l’obbligo, solo secondo la dottrina, di usare il cognome del marito. Questo diritto permane anche durante lo stato vedovile, si perde col divorzio; la moglie deve aggiungere il cognome del marito al proprio. La giurisprudenza di merito ha autorizzato la moglie a non usare il cognome del marito, sembra una cosa non attuale ma sino a qualche decennio fa la moglie aggiungeva e sostituiva il cognome del marito al proprio. I RAPPORTI PATRIMONIALI Negli effetti patrimoniali distinguiamo il regime patrimoniale primario della famiglia dal regime patrimoniale secondario. Il regime primario è quello al quale abbiamo già fatto cenno del 143 comma 3, ovvero entrambi i coniugi ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo è tenuto a contribuire ai bisogni della famiglia. Ciò significa che innanzitutto il problema degli effetti patrimoniali è un problema strettamente legato agli aspetti personali, cioè l’ordinamento guarda all’aspetto patrimoniale come l’altro lato dell’aspetto personale; quindi, cerca anche sotto il profilo patrimoniale di stabilire una parità tra i coniugi come lo faceva nell’aspetto personale. Devono contribuire in relazione alle proprie sostanze, ovvero tutti i beni di cui sono titolari; quindi, ciascuno è tenuto in proporzione in relazione a tutto quello di cui è titolare e in relazione alle proprie capacità di lavoro, quindi in relazione alla propria attitudine, professionale o casalinga. Viene valorizzata anche l’attività domestica che uno dei due coniugi dovesse svolgere. Il dubbio è: il coniuge che non vuole lavorare può essere costretto a porre in essere un’attività produttiva di reddito? L’argomento è discusso, di certo si dice che il coniuge può essere costretto quanto meno all’impiego di tutti i suoi beni, quindi, che la costrizione riguardi i beni di cui è proprietario che magari non intende mettere a reddito in favore della famiglia. Il regime secondario si aggiunge al regime primario ed è quello degli acquisti, cioè è la disciplina che riguarda gli acquisti che vengono compiuti dai coniugi. Quindi riguarda la disciplina di ciò che viene acquistato dopo il matrimonio dai coniugi; nell’ambito di questo regime secondario distinguiamo: - La comunione legale (scelta primaria dell’ordinamento), la comunione legale è il regime cosiddetto legale proprio perché con la riforma del 75 si è cercato anche dal punto di vista della filosofia di sposare una nuova visione del matrimonio, il matrimonio improntato all’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi ha una sua ricaduta anche in chiave patrimoniale; da un lato con la contribuzione paritaria dall'altro con la comunione legale degli acquisti. Quindi la comunione è ispirata dalla stessa filosofia di parità fra coniugi, perché la comunione altro non è che compartecipazione dei coniugi agli acquisti, all’arricchimento della famiglia. Pertanto, la comunione è il regime legale e quindi in difetto di annotazione a margine dell’atto di matrimonio del regime di separazione la scelta è in favore della comunione e la comunione è efficace ed opponibile a terzi. La comunione come regime patrimoniale dei coniugi si caratterizza per una particolare elasticità, cioè dal momento della sua instaurazione si estende automaticamente a tutti gli acquisti fatti dai coniugi, sia congiuntamente che separatamente. È diversa dalla comunione ordinaria che si appunta su un preciso titolo, il comunista inoltre può autonomamente disporre della sua quota. Nella comunione legale tra coniugi la quota è indisponibile. In quella ordinaria ciascuno dei comunisti può chiedere in qualunque momento lo scioglimento, nella comunione legale tra coniugi lo scioglimento può aversi solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Nella comunione legale tra coniugi vi sono particolari regole di amministrazione che sono anche parzialmente inderogabili in sede di comunione convenzionale. In ultimo la comunione legale presenta particolari regole di responsabilità che non troviamo in quella ordinaria. SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO L’oggetto della comunione è rappresentato dai beni acquistati successivamente al matrimonio dai coniugi con esclusione dei beni personali, su questi beni su questi beni la comunione opera immediatamente, si chiama comunione immediata e opera con questa elasticità di cui abbiamo detto cioè automaticamente si estende a tutti gli acquisti con eccezione dei cosiddetti beni personali. I beni personali sono: i beni di cui il coniuge era proprietario prima del matrimonio, i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione se non specificato che sono attribuiti alla comunione, i beni di uso strettamente personale, i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa, i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopra elencati o col loro scambio. Questi beni restano dunque nella proprietà esclusiva del singolo, invece in comunione cosiddetta de residuo cadono altri beni, qualora siano ancora sussistenti al momento dello scioglimento della comunione. La categoria della comunione del residuo è una categoria diversa dalla comunione immediata, tanto che qualcuno ritiene che non si tratti neanche di una comunione ma di una particolare forma di credito di un coniuge nei confronti dell’altro, ma la sistematica tradizionale qualifica come comunione di residuo quella che sorge su certi beni solo al momento dello scioglimento. Sono i frutti dei beni propri e i proventi dell’attività separata di ciascun coniuge ovvero i loro risparmi accumulati nell’attività lavorativa se ci sono si dividono al momento dello scioglimento (si presume che sono beni che il coniuge avrebbe speso per la famiglia se non si fosse giunti allo scioglimento della comunione); ma anche i beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa costituita precedentemente; questi beni cadono in comunione solo al momento dello scioglimento. La differenza tra comunione immediata e de residuo con riferimento all’azienda si coglie sotto il seguente aspetto: nel primo caso si tratta di aziende gestite da uno soltanto se gestita da uno soltanto e costituita dopo il matrimonio cadono i beni destinati all'impresa e cadono gli incrementi se invece costituita precedentemente, ma in entrambi i casi viene gestita da uno solo. Quando invece l’azienda è gestita da entrambi la disciplina è diversa, cadono in comunione immediata, se costituita dopo il matrimonio tutta l’azienda, altrimenti se apparteneva ad uno prima e la gestiscono insieme dopo cadono solo l’incremento, i miglioramenti. Si congiunge la libertà di reddito individuale e il principio di solidarietà familiare. L’esistenza della comunione non impedisce al coniuge di arricchirsi, basta che lo renda disponibile anche alla famiglia. Chiarito che la comunione ha questo oggetto (immediato ma con aspetto residuale) è poi caratterizzata da un regime peculiare che riguarda gli acquisti, l’amministrazione e lo scioglimento. Posto che cadono automaticamente in comunione tutti gli acquisti successivi che non abbiano carattere personale allora è necessario che ci siano delle formalità particolari per escludere un bene dalla comunione. Per i beni immobili e mobili registrati è necessario che l’esclusione del bene risulti dall’atto di acquisto, di cui deve essere stato parte anche l’altro coniuge; deve risultare una dichiarazione di personalità del bene ad opera anche dell’altro coniuge. Inoltre, l’acquisto deve anche essere trascritto come acquisto personale ai fini della opponibilità ai terzi. Per evitare frodi la giurisprudenza precisa che non basta la dichiarazione del codice magari compiacente per l’esclusione del bene dalla comunione, l’acquisto deve comunque obiettivamente avere carattere personale quindi rientrare nelle categorie numerate. È necessaria però la pubblicità perché a seconda che il bene sia in comunione o non in comunione cambia il regime della responsabilità patrimoniale. Per i mobili non registrati il regime è meno severo ma più incerto perché vige la presunzione di comunione, qualunque acquisto di bene mobile cade in comunione presuntivamente, saranno poi coniugi in sede di scioglimento a dover provare che è invece personale. Se non riescono a darne prova cade in comunione. L’amministrazione dei beni in comunione si distingue in ordinaria e straordinaria. La prima è tutto ciò che riguarda gestione conservativa di un bene; quindi, il godimento e la conservazione dello SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO stesso; per questi atti è prevista l’amministrazione disgiunta e ciascuno ha la legittimazione attiva e passiva in giudizio. L'ipotesi dell'amministrazione straordinaria invece riguarda gli atti e in particolare concessione dei diritti reali di godimento, atti di disposizioni di beni, per questi atti è necessaria una amministrazione congiunta dei coniugi. È necessario cioè che convergano le volontà. Se viene compiuto un atto di amministrazione straordinaria senza il consenso di uno dei due coniugi occorrerà distinguere tra beni immobili e mobili registrati e poi i mobili non registrati In caso di beni immobili e mobili registrati l’atto posto in essere può essere annullato entro un anno dalla conoscenza che l’altro coniuge abbia dell’avvenuto compimento e comunque entro un anno dalla trascrizione, termine massimo è un anno dallo scioglimento della comunione se manca la trascrizione; la legittimazione è del solo coniuge leso. Per i beni mobili invece il regime è più fluido, per il caso nel quale vi sia un atto di disposizione senza il consenso dell'altro coniuge l'unica previsione in questo senso è l'obbligo di ricostituire in natura o per equivalente la comunione; non vi sono termini se non entro lo scioglimento della comunione. È possibile che l’atto si riveli utile e necessario e quindi venga meno per il coniuge l’interesse di impugnare l’atto di disposizione. In caso di rifiuto del coniuge a prestare il proprio consenso qualora invece l'atto sia necessario per l'interesse della famiglia l'altro coniuge può fare ovviamente ricorso al giudice per ottenere l'autorizzazione, ancora se uno dei due coniugi è lontano e/o sia impedito a fornire il proprio consenso al compimento degli atti necessari può rilasciare la procura all'altro coniuge ma se non rilascia la procura all'altro coniuge il compimento degli atti necessari può sempre essere richiesto al giudice; questo vale se è impedito in maniera non permanente, perché se lo è in maniera permanente si applica l’esclusione giudiziale (per il coniuge che abbia male amministrato, sia impedito in maniera permanente quindi minore, interdetto). La comunione non si scioglie per mera volontà di uno dei due come nella comunione ordinaria, qui lo scioglimento si ha solo nei casi previsti dalla legge ovvero quelli del 191, cioè morte, interdizione e inabilitazione, assenza, morte presunta, fallimento, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili, separazione personale, mutamento volontario ma congiunto del regime. La comunione che si scioglie e si scioglie già in sede di separazione, già in sede di udienza presidenziale, da quel momento in poi le regole della comunione si disapplicano e per il futuro non opererà più questo regime di automatica con proprietà degli acquisti. Opera lo scioglimento ex nunc, non retroattivamente. Ma questo non determina lo scioglimento del patrimonio, si ritiene che si determini un mutamento di titolo da comunione legale a comunione ordinaria e che quella comunione ordinaria vada poi divisa consensualmente o giudizialmente dai coniugi. Previe restituzioni e previ rimborsi, cioè ciascuno dovrà restituire alla comunione quello che abbia preso da questa e dovrà prendere quello di cui sia eventualmente creditore. Esauriti questi rapporti il patrimonio viene diviso. È una particolare applicazione delle regole della responsabilità patrimoniale 2740 e 2741. Le regole di responsabilità ci spiegano proprio come opera il concorso dei creditori quando c'è una comunione legale rispetto alle obbligazioni contratte. La regola diversa dal 2740 è che il patrimonio comune, il patrimonio che si è costituito con la comunione. I beni rispondono in via diretta e illimitata dei pesi e degli oneri gravanti sui beni al momento dell'acquisto quindi eventuali tasse gravanti su questo immobile o un mutuo che abbia ipoteca su questo immobile per queste obbligazioni la comunione risponde invia diretta e illimitatamente. Risponde anche delle obbligazioni contratte anche disgiuntamente per i bisogni della famiglia ed ancora le obbligazioni contratte congiuntamente anche per un interesse personale. Questi creditori possono agire direttamente sui beni della comunione, in via immediata. Se i beni della comunione non bastano in via sussidiaria per le medesime obbligazioni rispondono anche i beni personali, ma per la metà del credito. Seconda regola di responsabilità è che i beni della comunione rispondono invece in via sussidiaria e limitatamente alla quota del coniuge per tutte le obbligazioni personali del coniuge, cioè quelle contratte da ciascuno separatamente per bisogni estranei a quelli della famiglia. Quindi per metà dei beni SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO Un regime differente può essere scelto dai coniugi tramite le convenzioni matrimoniali. Per optare per un altro regime è necessaria l’adozione di un atto pubblico e l’attuazione di formalità pubblicitarie. La scelta, infatti, perché sia pienamente efficace deve essere annotata a margine dell’atto di matrimonio e trascritta nei pubblici registri immobiliari se ha ad oggetto beni immobili. Qui c’è un concorso di regimi pubblicitari, annotazione a margine e trascrizione nei pubblici registri; vige la regola dell’assorbimento ai fini dell’opponibilità ai terzi del regime prescelto è sufficiente l’annotazione a margine, mentre la trascrizione ai pubblici registri degrada a pubblicità notizia. La convenzione matrimoniale è un vero e proprio contratto che rientra nel 1321. Poiché siamo nell’ambito del matrimonio è soggetta la convenzione ad un regime di stretta tipicità. Le parti possono adottare solo convenzioni già previste dalla legge, non possono modulare a proprio piacimento il contenuto della convenzione matrimoniale, nel rispetto per altro di talune norme inderogabili. Il primo limite è rappresentato dall’inderogabilità dell’obbligo di contribuzione primario, possono incidere i coniugi sul regime secondario. Se i coniugi non intendono scegliere la comunione legale possono scegliere: la separazione dei beni o … - - La separazione dei beni, i coniugi scelgono di conservare la titolarità esclusiva, il godimento e l’amministrazione di tutti i propri beni anche e soprattutto di quelli acquistati durante il matrimonio. Con la separazione quindi si disapplica completamente la regola che abbiamo visto vigente in materia di comunione secondo la quale tutto cade in comunione. La separazione non è un regime implicito che scatta autonomamente, i coniugi lo devono scegliere espressamente con una dichiarazione resa all’ufficiale dello stato civile o al ministro del culto cattolico, quindi in sede di celebrazione del matrimonio. Questa scelta viene inclusa nell’atto di matrimonio. Possono operare anche con una convenzione anteriore o successiva al matrimonio con atto pubblico scritto sempre a margine dell’atto di matrimonio. Può essere allora scelta al momento della celebrazione ma anche subentrare in un secondo momento e subentra automaticamente il regime della separazione quando si scioglie la comunione legale. Al momento dello scioglimento della comunione nei casi previsti dalla legge la separazione subentra in automatico. È previsto che ciascuno dei coniugi possa godere dei beni dell’altro in proprietà esclusiva dell’altro, ma secondo gli obblighi dell’usufruttuario. Cioè sarebbe tenuto a prestare garanzia e a fare l’inventario, deve restituire il bene alla scadenza, ed è tenuto alla manutenzione ordinaria. Ultima regola che vige in materia di separazione è che ciascuno dei coniugi potrà provare con riferimento ai beni mobili la proprietà esclusiva di essi, altrimenti si presumono in comunione e per pari quota. La comunione convenzionale, la particolarità è che le parti apportano al regime puro di comunione delle modifiche. Le modifiche possono essere effettuate nei limiti indicati dall’ordinamento. Ci sono delle norme inderogabili. In particolare, le norme sull’amministrazione e quelle sull’eguaglianza delle quote. Non possono essere compresi beni di uso strettamente personali, beni relativi all’attività professionale (salvo azienda facente parte della comunione) oppure i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno o la pensione relativa alla perdita della capacità lavorativa. Fa sì che siano ricompresi i beni di cui si era titolari prima, oppure che alcuni acquisti che ricadrebbero in comunione restano invece di proprietà esclusiva. Questo regime secondario riguarda il futuro, gli acquisti non i beni già aventi, come i coniugi costruiranno la ricchezza della famiglia. Indice di coercibilità dell'ordinamento cioè l'ordinamento è un complesso di regole coercitive e il singolo viene costretto a adempiere con le sanzioni e le sanzioni sono sanzioni pecuniarie come il 2043 e il 1218 e sanzioni quali quelle dell'addebito che vedremo avere delle connotazioni particolari. FONDO PATRIMONIALE SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO È un patrimonio destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. La destinazione è la predeterminazione di un interesse oggettivo, ovvero quello della famiglia, e l’asservimento a questo interesse oggettivo di un patrimonio, di un complesso di beni, con delle ricadute in termini di circolazione dei beni e responsabilità patrimoniale. (?) Limitazione della responsabilità alla stregua di un patrimonio parzialmente separato. L’interesse al quale questi beni vengono asserviti è l’interesse della famiglia, si parla tecnicamente di bisogni della famiglia. Con questo termine si intende un ambito molto vasto. Si fanno rientrare tutte le esigenze primarie della famiglia, mantenimento istruzione educazione, ma anche le esigenze non strettamente primarie purché concorrano al pieno sviluppo della famiglia. Con il fondo patrimoniale un coniuge o entrambi i coniugi o un terzo vincolano un complesso di beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia così descritti. è necessaria l’adozione dell’atto pubblico, o si può costituire anche per testamento purché ci sia sempre il consenso dei coniugi. Può essere costituita con uno dei due coniugi, entrambi o un terzo con il consenso dei coniugi. SI AFFIANCA AL REGIME PATRIMONIALE SCELTO E LA VALIDITÀ È SOTTOPOSTA ALL'ANNOTAZIONE A MARGINE DELL'ATTO DI MATRIMONIO Non tutti i beni possono rientrarvi, solo alcuni ovvero immobili, mobili registrati e i titoli di credito resi nominativi. Questa limitazione è legata al fatto che questi beni sono beni soggetti a pubblicità nella loro circolazione. Le regole di amministrazione sono le stesse della comunione, ma il regime dei beni è vincolato. Nell’ambito del fondo patrimoniale i beni e i loro frutti possono essere impiegati soltanto per i bisogni della famiglia. I coniugi cioè non possono distrarre beni per soddisfare interessi diversi. Viene perlopiù costituito dagli imprenditori, per mettere al riparo certi beni per ripararli dai creditori, ma i coniugi non possono farne quello che vogliono, devono essere impiegati per i bisogni della famiglia anche se rientra quasi tutto tranne attività professionali e imprenditoriali dei singoli. La seconda limitazione è che i coniugi non possono alienare ipotecare e dare in pegno beni del fondo patrimoniale se non vi sia l’accordo di entrambi, per i figli minori è necessario consenso giudice che darà consenso solo in casi di necessità). La seconda limitazione è legata alla responsabilità patrimoniale perché il rafforzamento della destinazione si rinviene sotto questo profilo. Questo complesso di beni non può essere aggredito dai creditori che sapevano che l’obbligazione era estranea ai bisogni della famiglia. Sono aggredibili solo dai creditori della famiglia e sono del tutto esclusi i creditori personali secondo un criterio oggettivo e soggettivo della estraneità dell’obbligazione ai bisogni della famiglia e della consapevolezza del creditore. Per la cessazione serve l’annullamento, lo scioglimento, il divorzio (se in presenza di figli minori con il raggiungimento della loro maggiore età). SI AZIONE DI RIDUZIONE SE ABUSO IN FRODE AI CREDITORI Lezione 14 diritto privato mod. b I RAPPORTI CON I FIGLI OBBLIGHI GENERALI Con l’evoluzione del diritto di famiglia c’è stata una evoluzione del rapporto tra genitori e figli, l’articolo 30 della costituzione prevede che sia dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni anche se nati fuori dal matrimonio. Con la riforma del 2012 c’è stata una piena equiparazione tra i figli matrimoniali ed extra matrimoniali, non si usa più naturali e legittimi. Lo status di figlio è unico. Questa riforma diede luogo ad un cambiamento significativo dei rapporti sociali. Questo è ciò che dice anche l’articolo 147 nella nuova formulazione susseguente al 2012. Gli articoli rilevanti sono l’articolo 30 della Costituzione e il 147 del Codice civile. SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO I diritti dei figli nei confronti dei genitori, dunque, trovano spiegazione negli articoli 315 bis e 317 bis (nuove formulazioni del 147 cc) del nostro cc. Il primo comma del 315 bis afferma che il figlio ha diritto ad essere mantenuto educato ecc, comma 2 si ha diritto a crescere in famiglia e mantenere rapporti significativi con i parenti poi al terzo comma vi è il diritto di ascolto del minore, il figlio minore che abbia compiuto 12 anni oppure minore di 12 ove capace di discernimento ha diritto ad essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano (attività della vita quotidiana ma anche procedure giuridiche come divorzio e separazione). L’articolo 147 è rubricato doveri verso i figli, ritroviamo quelli del 315 e 317 bis, gli obblighi sono mantenimento, assistenza morale, educazione e istruzione: - - - il mantenimento del figlio deve riguardare il vitto, le spese sanitarie, scolastiche, ricreative, sportive, per mantenere un equilibrio materiale e morale. Si parla infatti sempre di inclinazioni naturali e aspirazioni. Il mantenimento deve essere adeguato alle sostanze della famiglia e il figlio ha diritto di convivere nell’abitazione familiare, incombe però in capo al maggiorenne anche un obbligo di contribuzione alle spese della famiglia a seconda delle capacità reddituali. L’assistenza morale implica il diritto ad essere amati e ad avere cure amorevoli Educazione implica esempi di vita, che tenga conto delle inclinazioni naturali, che gli permetta di seguire gli esempi di vita offerti ma di essere libero nelle sue scelte. Abuso dei mezzi di correzione (art. 571 del Codice penale) è reato che un soggetto abusi delle facoltà quali la responsabilità genitoriale con strumenti di correzione, si fa riferimento a strumenti fisici o violenza. Il diritto ad essere istruito del figlio non riguarda soltanto la scuola dell’obbligo, ma anche tutte le spese inerenti agli studi successivi (università ad esempio o master, dottorato, specializzazione). Si insiste sempre nelle aspirazioni e inclinazioni naturali del figlio. La natura di questi obblighi è di natura non patrimoniale, e la violazione fa riferimento al risarcimento di un danno non patrimoniale ex 2059 cc. Si tratta dell’illecito endofamiliare, commesso all’interno della famiglia. L’articolo 316 bis individua chi deve adempiere a questi obblighi: - Genitori, dopo la riforma non si fa più il riferimento ai coniugi, perché il termine stava a dimostrare la famiglia fondata sul matrimonio Possibilità di soccorso degli ascendenti (genitori dei genitori ovvero nonni in ordine di prossimità). Devono dare ai genitori i mezzi necessari per adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli. Nel caso di inadempimento vi è la possibilità di ricorso al tribunale, il presidente del tribunale con decreto ordina il versamento di un assegno periodico sul conto del genitore che deve sopportare le spese di mantenimento e educazione. È l’ipotesi di inadempimento dell’altro coniuge in caso di separazione o divorzio o ascendenti che si rifiutano. OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE NEI CONFRONTI DEI FIGLI MAGGIORENNI L’articolo 337 septies si domanda se in presenza di figlio che svolge attività lavorativa genitori devono ancora contribuire. Per i figli maggiorenni portatori di handicap si ha una completa comparazione al figlio minorenne per il mantenimento. Per il figlio maggiorenne vi sono due orientamenti diversi: Prima della riforma del 2006 vi è l’obbligo di mantenimento fino al raggiungimento dell’autonomia economica, salvo colpa del figlio. Post-riforma invece è il giudice che valutate le circostanze può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Secondo questa interpretazione non sono tenuti all’assegno di contribuzione i genitori del figlio che abbia iniziato un’attività lavorativa, ancorché momentaneamente privo di mezzi economici di sostentamento, questo obbligo non rivive successivamente (produce reddito poi viene licenziato, l’obbligo di contribuzione SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO non rivive). Se la capacità di guadagno non si associa alle sue inclinazioni e aspirazioni l’obbligo di mantenimento non cessa, esempio delle aspettative formative del figlio. In sintesi, il figlio può avere riconosciuto un assegno, non esiste più dopo la riforma il principio della colpa, ma il figlio che abbia raggiunto una capacità reddituale perde definitivamente il contributo al mantenimento del genitore (no reviviscenza del diritto successiva). Se invece gli eventuali introiti si pongono su una linea di formazione progressiva e tendenzialmente sempre maggiore (come introiti dottorato) quest’obbligo non viene meno (giurisprudenza del 2017 riguardo alla borsa del dottorato di ricerca). LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE DEI GENITORI SUI FIGLI MINORENNI ED IL CONTROLLO GIUDIZIALE La responsabilità genitoriale ha più volte cambiato nome nel corso delle riforme, precedentemente si chiamava patria potestà perché esercitata dal padre, poi potestà genitoriale perché era un potere, stavolta esercitato da entrambi (potere unilaterale e dispositivo che non teneva conto della personalità del figlio). Oggi si parla di responsabilità genitoriale, non è più un potere; quest’ultima la troviamo all’interno dell’articolo 316 del Codice civile, è un ufficio privato legalmente attribuito ai genitori, con riferimento alla cura personale e patrimoniale dei figli e che consente di ravvisare in capo ai genitori poteri e doveri che hanno natura sia personale sia patrimoniale. In sostanza è un ufficio misto con doveri di cura, poteri di rappresentanza e con poteri e doveri personali e patrimoniali. Questi riguardano il mantenimento, l’educazione eccetera, in generale gli obblighi generali personali. I poteri patrimoniali invece riguardano la rappresentanza legale dei figli (no volontaria), è la legge a prevedere che siano i genitori i rappresentanti legali dei figli, gestiscono i suoi interessi e affari (come iscrizioni scolastiche, acquisti o figlio titolare di immobili o patrimoni). La gestione e la rappresentanza del figlio come detto è dettata dal 316 dove si legge che la responsabilità genitoriale è esercitata congiuntamente, in comune accordo che tiene conto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza del figlio minore, detta residenza abituale, altrimenti ricorso al giudice. Si deve trattare di questioni di particolare importanza, in cui il giudice decide secondo l’interesse del figlio e dell’unità familiare, nella sua decisione vige il diritto di ascolto del figlio minore. L’esercizio della responsabilità genitoriale prevede un concorso negli oneri che sia proporzionale alle sostanze dei genitori e alle capacità di lavoro professionale e casalingo. Nonostante le vicende che colpiscono la famiglia come crisi, divorzio e separazione, la responsabilità non cessa a seguito di questi fenomeni. Persiste, ma può capitare che a causa di impedimento, lontananza o incapacità di uno dei due, la responsabilità genitoriale venga esercitata in modo esclusivo solo da uno dei due (art. 317 cc). L’articolo 318 poi prevede un divieto a carico del figlio, ovvero quello di abbandonare il tetto familiare, ovvero quello dei genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, sino alla maggiore età. I genitori altrimenti possono ricorrere al giudice tutelare. Altro obbligo dei genitori è consentire i rapporti con gli ascendenti, altrimenti ricorso al giudice tutelare. I poteri che sono attribuiti ai genitori per l’adempimento dei loro obblighi sono poteri disciplinari, senza l’abuso, e dei poteri rappresentativi, in tutti i negozi che lo riguardano. Nell’ipotesi di genitori non sposati la responsabilità genitoriale segue il riconoscimento. I controlli del tribunale sono effettuati nel seguente modo: il tribunale competente è quello del luogo in cui risiede il minore e agisce nella figura di tribunale per i minorenni. Risponde invece l’articolo 38 delle disposizioni attuative del codice, che la competenza è del tribunale per i minorenni per i provvedimenti in caso di condotta pregiudizievole per i figli. Invece giudice ordinario se si tratta di giudizio di separazione, divorzio, giudizi che riguardano la famiglia (competenza per attrazione). SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO AMMINISTRAZIONE DEI BENI DEL MINORE E CURA DEL MINORE (atti patrimoniali e personali) L’articolo 320 prevede una distinzione per gli atti patrimoniali di ordinaria amministrazione e quelli di straordinaria. I primi possono essere compiuti disgiuntamente dai genitori, i secondi solo congiuntamente. Con riferimento all’usufrutto teniamo a mente la distinzione di usufrutto ordinario come diritto reale minore e quello legale costituito ex lege a favore dei genitori. In questo caso tra usufrutto ordinario e legale intercorrono alcune differenze: (importante per esame) differentemente dall’usufrutto ordinario l’usufrutto legale è previsto a favore dei genitori sui beni dei figli, i frutti naturali e civili che vengono ritenuti dalla cosa non possono essere utilizzati a piacimento, ma destinati al mantenimento della famiglia. Se viene meno l’usufrutto di un genitore si accresce quello dell’altro e vi sono alcuni beni esclusi dall’usufrutto legale come i beni acquistati dai figli con i proventi del proprio lavoro oppure donati a favore del figlio per la sua carriera, espressamente esclusi dal donante o accettati dal figlio contro la volontà del genitore. Usufrutto non è espropriabile, disponibile o trasmissibile, rimane sempre a favore dei figli. Con riferimento alla cura può essere richiesta la tutela sulla base dell’articolo 343. Con mancanza di cure la responsabilità genitoriale decade, per trascuratezza o inadempimento dei doveri. Vi è la possibilità di una successiva reintegrazione quando vengono meno le condizioni di disagio che creano pregiudizio al figlio. È disposto l’ascolto del figlio minore. LA FILIAZIONE Innanzitutto, dall’articolo 231 del Codice civile ricaviamo la presunzione legale di paternità che implica che il marito sia il padre del figlio che sia concepito o nato durante il matrimonio. Quindi se nasce un figlio durante il matrimonio il padre non dovrà riconoscerlo. Questa presunzione opera anche con riferimento all’articolo 232 che afferma che si presume concepito durante il matrimonio quel figlio che sia nato quando non sono ancora trascorsi 300 giorni dalla data dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ciò significa che anche in questi casi la presunzione continua ad operare sino a 300 giorni dall’evento. (presunzione di concepimento in costanza di matrimonio) Non si considera il figlio del marito quando i coniugi al momento della separazione giudiziale o consensuale sono stati autorizzati a vivere separatamente. Al momento della nascita viene formato già all’interno della struttura sanitaria l’atto di nascita, in cui vengono indicate le generalità della madre se vuole essere nominata e non anonima, e del marito. La legge prevede che se un figlio nasce dopo i 300 giorni i coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio che sia nato decorso tale lasso di tempo sia stato concepito in costanza di matrimonio o durante la convivenza nel caso in cui i coniugi siano stati autorizzati a vivere separatamente. I soggetti legittimati a fornire questa prova sono il coniuge ed i loro eredi. LA PROVA DELLO STATO DI FIGLIO 1. La filiazione si prova con l’atto di nascita, che è un atto di accertamento amministrativo che da conto delle informazioni inerenti alla nascita della persona e al suo stato di figlio. L’efficacia di questo atto è esclusiva e la dichiarazione dell’avvenuta nascita viene resa dai genitori o da chi abbia assistito al parto (oggi raccolte all’interno della struttura sanitaria stessa dove vi è l’ufficiale dello stato civile). Per i genitori non sposati vale la disciplina del riconoscimento, per i coniugi la disciplina sopra citata. Ricordiamo la volontà di non essere nominata della madre. SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO 2. Possesso dello stato di figlio, previsto dall’articolo 236 secondo comma cc, viene dato da tre requisiti: trattamento, fama, riconoscimento. Si intendono con possesso dello stato di figlio tutti quei fattori che sono questi tre fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare la relazione di filiazione e parentela. 3. Se mancano i due precedenti la prova dello stato di figlio può essere fornita con qualsiasi mezzo. AZIONI DI STATO Sono quelle azioni che sono volte a modificare tramite pronuncia giudiziale il contenuto dell’atto di nascita. Il contenuto può essere contestato in casi tassativamente indicati dalla legge. In particolare, le azioni di stato sono delle azioni di titolarità di pre-individuati soggetti legittimati a farle valere in giudizio che mirano a modificare il contenuto dell’atto di nascita. Questa modifica data importanza, sensibilità delle informazioni che va ad investire, è consentita soltanto mediante una pronuncia giudiziale. Abbiamo quindi un atto di nascita che data la sua pregnanza probatoria non può essere modificato in ogni caso ma solo in casi previsti tramite un’azione di stato con pronuncia giudiziale: (importanti per esame) - Azione di disconoscimento di paternità Azione di reclamo dello stato di figlio Azione di contestazione dello stato di figlio Azione di impugnazione del riconoscimento del figlio extramatrimoniale Dichiarazione giudiziale di maternità e paternità Le prime tre vanno a modificare lo stato di figlio all’interno del matrimonio, il primo ha a che fare con le presunzioni di paternità e concepimento in costanza di matrimonio. Le ultime due invece hanno a che fare con la modifica dello stato di figlio che sia nato fuori dal matrimonio, extraconiugale. AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITÀ Articolo 243 bis del Codice civile. La finalità di quest’azione è dimostrare che il figlio che sia nato in costanza di matrimonio non è stato concepito dal marito della madre del figlio. Quest’azione può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo. I presupposti sono la nascita del figlio all’interno del matrimonio e la mancanza di previgenti come adulterio, impotenza, non coabitazione. L’oggetto della prova è dimostrare l’insussistenza del rapporto di filiazione tra figlio e marito della madre (la dichiarazione della madre non costituisce elemento idoneo a provare). Vi sono poi dei termini (!!!) per quest’azione: 6 mesi per la madre dalla nascita o dalla conoscenza dell’impotenza del marito, padre entro un anno dalla nascita o dalla scoperta dell’impotenza o adulterio della moglie o ritorno o dalla notizia della sua nascita. Per la fecondazione artificiale dalla certezza del ricorso a tali tecniche. In ogni caso non oltre i 5 anni dalla nascita per l’interesse del figlio ad una situazione di stabilità. Per il figlio è imprescrittibile, principio giuridico essenziale in materia di stati personali, favor veritatis. I termini vengono sospesi in caso di interdizione o grave infermità. La trasmissibilità è prevista in caso di morte dei titolari Dal punto di vista degli effetti l’azione rimuove con effetto retroattivo lo stato di figlio rispetto al presunto padre. Cadono tutti i diritti e i doveri tra genitori e figli. Tutti i provvedimenti dettati dal giudice in tema di mantenimento mantengono il loro effetto fino al passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento, quindi fino alla certezza. Tutte le prestazioni di mantenimento già eseguite non devono essere restituite. Il SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO figlio che dunque non sia il figlio del padre non dovrebbe più mantenere il cognome del presunto padre, ma ha diritto a farlo se vuole. Lo stato di figlio viene preservato nei confronti della madre. AZIONE DI RECLAMO DELLO STATO DI FIGLIO Articolo 239. Diversamente dalla precedente si vuole per l’appunto reclamare per il figlio che sia nato in costanza di matrimonio uno stato diverso, si vuole cioè provare che quel figlio non sia effettivamente il figlio della coppia. I presupposti per esperire l’azione sono le ipotesi di supposizione di parto e sostituzione di neonato. Nella prima viene attribuito un nato ad una donna che in realtà non ha partorito. Nella seconda si scambia il figlio. L’oggetto di quest’azione è provare che vi sia stata una supposizione o una sostituzione. Inoltre può essere esercitata quando il figlio nasce all’interno del matrimonio ma viene scritto come figlio di ignoti oppure quando vi sia nell’atto di nascita una iscrizione non conforme con le presunzioni di paternità. I soggetti legittimati sono il figlio anche nel caso di genitori ignoti, salvo adozione è imprescrittibile. AZIONE DI CONTESTAZIONE DELLO STATO DI FIGLIO 240 del Codice civile. Stesso contenuto e oggetto del 239 ma in questo caso i soggetti legittimati sono chi risulti genitore dall’atto di nascita e chiunque ne abbia interesse anche per loro è imprescrittibile. LA FILIAZIONE EXTRAMATRIMONIALE La riforma del 2012 ha introdotto importanti novità tra cui l’unicità dello status di figlio. Non vi è più la differenza tra figli legittimi e naturali. L’unica distinzione è quella di figlio matrimoniale ed extramatrimoniale. I figli che nascono al di fuori del vincolo matrimoniale oggi sono parificati per tutto agli altri; la differenza sta nella creazione del vincolo giuridico di filiazione. Nella filiazione matrimoniale il vincolo nasce automaticamente e opera la presunzione di paternità nella filiazione extramatrimoniale vi è la necessità di creare il vincolo giuridico della filiazione mediante un atto di iniziativa personale. Il fatto della procreazione assume rilevanza per l’ordinamento dal momento in cui venga esperito l’atto di riconoscimento del figlio e la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità esercitata dal figlio. All’interno della filiazione extramatrimoniale una ulteriore azione di stato è l’impugnazione del riconoscimento del figlio, nel caso in cui l’atto di riconoscimento sia stato viziato per violenza, interdizione ecc, sarà possibile impugnare il riconoscimento. L’atto di riconoscimento è un atto solenne mediante il quale entrambi i genitori, nella filiazione extramatrimoniale, congiuntamente al momento della nascita o successivamente o separatamente, trasformano il fatto della procreazione in uno stato rilevante per diritto che è quello della filiazione. Le caratteristiche di questo atto sono: - - Atto unilaterale volontario e facoltativo Atto personalissimo che non tollera la rappresentanza Atto irrevocabile Actus legitimus, puro non può essere posto a termine o condizione Non può contenere l’indicazione delle generalità dell’altro, qualora vengano indicate si hanno per non apposte e rimangono senza effetto. Addirittura il 258 del codice civile prevede la condanna ad una sanziona amministrativa per il pubblico ufficiale che le trascriva nei registri Forma vincolata, atto pubblico o scrittura privata davanti all’ufficiale dello stato civile, spesso all’interno delle struttre sanitarie. Può essere contenuto all’interno del testamento SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO Perché il genitore possa riconoscere un figlio deve avere almeno 16 anni. Il figlio che non sia già stato riconosciuto deve prestare il proprio assenso al riconoscimento se abbia già compiuto i 14 anni. Se è già stato riconosciuto dall’altro genitore vi è necessità anche del suo consenso se minore di 14 anni. Al momento del riconoscimento derivano delle conseguenze, si instaura un legame giuridico. Prima conseguenza tra tutte è il fatto che il genitore che abbia riconosciuto assume doveri nei confronti dei figli, art. 147 cc. Deriva la responsabilità genitoriale e il legame di parentela con il genitore stesso e i parenti di lui. Derivano i diritti successori e l’assunzione del cognome, la regola è di assumere il congome del genitore che effettui per primo il riconoscimento. Si prevede che in caso di riconosciemnto contestuale il figlio assuma il cognome del padre. Ad oggi in ogni caso è prevista la possibilità di aggiungere il secondo cognome, per questione patriarcale e articolo 3 uguaglianza. Ultima conseguenza è l’inserimento del figlio all’interno della famiglia del genitore che lo abbia riconosciuto, il giudice può dettare particolari condizioni che tengono conto delle necessità del figlio. AZIONE DI IMPUGNAZIONE DEL RICONOSCIMENTO Difetto di veridicità, violenza o interdizione giudiziale determinano la legittimazione a questa azione. Queste tre ipotesi fanno venire meno il rapporto di filiazione che si è venuto ad instaurare. Nel difetto di veridicità si vuol far venire meno il riconoscimento che non corrisponde al vero, ad un effettivo rapporto di procreazione con il figlio. Possono esperire quest’azione per difetto di veridicità l’autore del riconoscimento stesso entro un anno dalla annotazione del riconoscimento o dalla scoperta dell’impotenza e in ogni caso entro 5 anni dall’annotazione. Nei confronti del figlio quest’azione è imprescrittibile e può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse in 5 anni massimo. La violenza deriva da coercizione fisica o morale, ha le stesse caratteristiche della precedente. Si applicano le caratteristiche della violenza nel matrimonio e contrattuale. Può essere impugnato da ascendenti, discendenti e eredi entro il termine impugnatorio (?). Oppure per interdizione giudiziale quando il soggetto sia sottoposto a incapacità. Può agire l’autore del riconoscimento dopo un anno dalla revoca dell’interdizione e ascendenti, discendenti e eredi in caso in cui il termine impugnatorio (?). DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ Mentre per la precedente i legittimati sono generlamente i genitori, per questa il soggetto legittimato è il figlio. Si tratta di un’azione che viene promossa dal figlio che vuole instaurare un rapporto giuridico di filiazione tra genitori e figli nel caso in cui sia ammesso il riconoscimento. (!!!) no figli incestuosi se non c’è autorizzazione del giudice I soggetti legittimati a promuovere quest’azione sono il figlio (imprescrittibile), i discendenti del figlio entro due anni dalla morte, il genitore esercente la responsabilità genitoriale, il tutore autorizzato dal giudice o il curatore speciale previo consenso del figlio maggiore di 14 anni. La prova che si vuole fornire è la dimostrazione del fatto naturale della procreazione da parte del soggetto nei cui confronti si agisce. Si vuole dimostrare un rapporto di filiazione tra il soggetto che agisce e il soggetto nei cui confronti si agisce. Questa prova può essere fornita con ogni mezzo. Così come previsto nel tema di filiazione matrimoniale non basta la dichiarazione della madre o i rapporti tra la madre e il padre al tempo del concepimento. Gli effetti che derivano sono gli stessi del riconoscimento. Può esserci infine una pronuncia del giudice sull’affidamento, il mantenimento, l’istruzione, l’educazione. SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO I FIGLI INCESTUOSI: Questi sono figli nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela o affinità. Per quei figli che sono parenti di persone collegati in linea retta oppure figli di parenti in linea collaterale di secondo grado e quindi figli di fratelli tra loro o affinità in linea retta quindi figli tra la nuora e il suocero il genero e la suocera tutte queste persone non possono essere riconosciute autonomamente. In questi casi per riconoscere il figlio serve l’autorizzazione del giudice che deve tenere conto dell’interesse del figlio per evitargli pregiudizi. (articolo 251 cc) Esiste una norma di chiusura che prevede la possibilità di ottenere mantenimento istruzione e educazione nel caso in cui non sia possibile esperire l’azione per la dichiarazione giudiziale di maternità o paternità. Il legittimato è il figlio nato fuori dal matrimonio. Esiste poi un legato ex lege in favore dei figli riconoscibili o non riconoscibili. È un’attribuzione particolare, dal momento che il figlio non potrà succedere al genitore avrà diritto ad un riconoscimento vitalizio per il suo mantenimento. Il figlio incestuoso può chiedere gli alimenti qualora sia in stato di bisogno o non abbia diritto al mantenimento. L’ADOZIONE È l’instaurazione del rapporto di filiazione che non avviene in maniera naturale, non vi è la procreazione. Risale al diritto romano, è un istituto molto antico. Riguardava le persone maggiori d’età. Oggi ce ne sono quattro: - - Adozione di persone maggiori d’età. Non molto diffusa, serve per creare una discendenza qualora non esistano altri discendenti soprattutto per l’attribuzione del cognome. Vi è la necessità di un consenso tra l’adottante, qualora non sia coniugato, e l’adottato, qualora questo non abbia altri genitori. Se coniugato e ci sono genitori serve il consenso anche di loro. È il tribunale a pronunciarsi se viene negato il consenso contro l’interesse delle parti o qualora uno sia lontano. L’adottato prende il cognome e lo antepone al proprio. Vi deve essere una differenza d’età tra 35 e 18 anni Innanzitutto si crea una discendenza elettiva, si sceglie l’erede, segue l’attribuzione del cognome che sarà quello del marito se l’adozione avviene ad opera dei due coniugi, quello della famiglia della donna sposata se avviene da parte sua. Non avviene la nascita di rapporti di parentela e si conservano i legami con la famiglia di origine. Sono vietati con la famiglia adottante i matrimoni come previsti dagli impedimenti. L’adottante non acquista alcun diritto successorio salvo che non l’abbia scritto il figlio nel testamento, ma viceversa l’adottato è equiparato ai figli. Adozione di persone minori d’età. Legge 184 del 1983 prevede che il minore ha diritto a crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia. L’articolo 31 della Costituzione prevede infatti misure a sostegno della famiglia e il 79bis prevede la necessità attraverso i servizi sociali di segnalare le situazioni di indigenza dei nuclei familiari che non consentono di educare il minore in un ambiente sereno ed adatto. Questa legge sull’adozione intende supplire un’incapacità definitiva della famiglia, per casi temporanei vige l’affidamento. La repubblica protegge l’infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo art. 31 secondo comma. L’effetto di tutto ciò è andare a recidere definitivamente il legame con la famiglia d’origine. La legge detta alcuni requisiti per gli adottati, meno di 18 e situazione di abbandono, gli adottanti devono essere due coniugi in matrimonio da almeno 3 anni e che non versino in stato di separazione personale neppure di fatto, devono inoltre essere idonei e capaci di educare, istruire, mantenere e assistere il figlio. Deve esserci tra i due uno scarto di età tra 18 e 45 anni. No conviventi di fatto o uniti civilmente ad oggi. Il procedimento di adozione si svolge in tre fasi: la prima culmina con la sentenza di dichiarazione di adottabilità dichiarata dal tribunale dopo aver compiuto tutte le verifiche del caso. La seconda è quella dell’affidamento preadottivo scegliendo tra le coppie più idonee in considerazione alle condizioni personali ed economiche. Si inizia un periodo di convivenza che dura un anno ma può SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO - - essere prorogato fino ad un altro anno. Se la convivenza ha esito positivo si apre un’ultima fase che è la dichiarazione di adozione che va trascritta nei registri dello stato civile. Per quanto riguarda gli effetti dell’adozione l’adottato acquista lo stato di figlio e gli adottanti la reponsabilità genitoriale. Questo prende anche il cognome e il rapporto di parentela, ha i diritti successori che la legge prevede per tuti gli altri figli recidendo ogni legame con la famiglia d’origine. L’adottato può conoscere le informazioni riguardo alla sua origine al compimento dei 25 anni, oppure 18 se sussistono motivi di salute gravi oppure per i minori di 18 anni possono farlo genitori adottivi su autorizzazione tribunale minorenni per gravi e comprovati motivi. Adozioni in casi particolari, questo tipo di adozione riguarda persone unite al minore entro il sesto grado di parentela, dal coniuge in caso del figlio minore anche adottivo dell’altro coniuge, quando il minore sia handicappato e orfano di padre e madre, quando sia stata constatata l’impossibilità di affidamento preadottivo ad esempio i due non sono coniugati (no usufrutto legale, dibattito sui diritti successori, alcuni casi revoca). Gli obblighi sono gli stessi dell’adozione del minore e anche gli effetti. Adozioni internazionali, è improntata sul principio di sussidiarietà, quindi quando non sia possibile una soluzione locale. Le fonti che la prevedono sono la convenzione internazionale per la tutela dei minori dell’Aia del 1993. Il procedimento prevede una dichiarazione di disponibilità dei genitori, l’idoneità dichiarata dal giudice, il deposito in carico ad enti autorizzati a seguire la situazione, dichiarazione dello stato di adottabilità del paese d’origine precedentemente o successivamente all’ingresso del minore in Italia. L’AFFIDAMENTO DEI MINORI L’affidamento dei minori è un rimedio a favore del minore temporaneamente privo di un ambiente idoneo ad assicurargli mantenimento, educazione, istruzione, relazioni affettive. Le differenze con l’adozione stanno nel carattere temporaneo dell’affidamento e nella permanenza del legame con la famiglia d’origine. I soggetti affidatari sono una famiglia con figli minori, una persona singola, una coppia omosessuale. Sono stati eliminati nel 1983 gli istituti di assistenza. L’affidamento può essere richiesto dai servizi sociali del comune ed è disposto con decreto del giudice tutelare. Deve essere presente il consenso di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, la durata non può essere maggiore di due anni. Tempo oltre il quale se non sussistono le condizioni per il rientro in famiglia è possibile agire per adozione. Lezione 11 diritto privato mod. b IL MATRIMONIO 3 LA SEPARAZIONE I rimedi per far fronte alla crisi della famiglia sono separazione e divorzio. La separazione non scioglie il vincolo coniugale, che si scioglie solo con il divorzio. Nella separazione, infatti, noi troviamo non il venir meno dei diritti e dei doveri dei coniugi ma una attenuazione di questi e una sorta di stato di quiescenza, nei limiti del possibile. Come viene meno il dovere alla coabitazione, che cessa già con la domanda di separazione, mentre gli altri si rimodulano: il dovere di fedeltà non viene del tutto meno ma si trasforma in un più ampio dovere di rispetto, come necessità di tenere un comportamento non lesivo della dignità e del decoro dell’altro coniuge. L’assistenza morale cessa col cessare della coabitazione non cessa il dovere di assistenza materiale e l’obbligo di contribuzione. La collaborazione resta in piedi soprattutto come collaborazione nei confronti dei figli. 1. Separazione giudiziale, art. 151 post-riforma le parti giungono alla separazione in presenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole. In questo articolo si evince che il passaggio dalla famiglia come SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO portatrice di interessi super individuali alla famiglia invece come luogo di piena promozione e realizzazione della persona che ha portato con sé il passaggio dalla separazione per colpa alla separazione legata alla sola circostanza della intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Oggi si può giungere alla separazione a prescindere da qualunque comportamento colposo dell’uno e dell’altro. - Il normale procedimento contenzioso avviene attraverso ricorso, tentativo di conciliazione, provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse dei coniugi e dei figli. Se uno decide di chiedere la separazione l’altro non può far nulla, il ricorso è un atto di iniziativa dell’uno nel quale si richiede la separazione, a cui l’altro risponde con una sua comparsa ovvero un atto col quale prende posizione sulle circostanze addotte, ma non può opporsi. Favor matrimoni: l’ordinamento tenta in tutti i modi di far sì che non si addivenga allo scioglimento del rapporto (come in materia di nullità e annullabilità). Il contenuto della sentenza di riparazione riguarda da un lato il rapporto tra genitori e figli dall’altro il rapporto dei coniugi tra loro. Nonostante la separazione i diritti e i doveri dei coniugi nei confronti dei figli rimangono inalterati, quindi i genitori conservano l’obbligo di concorrere al mantenimento dei figli proporzionalmente al proprio reddito. I criteri di riferimento per la quantificazione del contributo in favore dei figli sono: il mantenimento del tenore di vita uguale, le esigenze del figlio, i tempi di permanenza del figlio dall’uno o dall’altro coniuge, le risorse economiche dell’uno o dell’altro e anche la cura e l’assistenza domestica che eventualmente uno solo dei due presti. Il secondo problema è quello dell’affidamento, nella sentenza di separazione il giudice oltre a quantificare la somma periodica da versare per il figlio si preoccupa dell’affidamento. C’è stata una importante evoluzione, perché prima del 2006, in sede di separazione l’affidamento era esclusivo perlopiù in favore della madre. Chi aveva l’affidamento inoltre esercitava la potestà genitoriale, era previsto il concorso di entrambi solo per le decisioni di maggiore importanza e il coniuge non affidatario poteva vigilare sull’istruzione e sull’educazione al più potendosi rivolgere al giudice se reputava che le scelte fossero pregiudizievoli per il figlio. Importanti provvedimenti che hanno riformato la filiazione sono stati la legge 54/2006 e il d. lgs. 154/13, l’articolo 337 ter sancisce il diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori; ciò che deve guidare le decisioni in materia di affidamento è esclusivamente l’interesse morale e materiale del minore che può essere ascoltato se maggiore di 12 anni ed anche se minore di 12 purché abbia capacità di discernimento. A seguito di questo anziché l’affidamento esclusivo oggi si propende per l’affidamento condiviso. Il primo resta una scelta solo residuale qualora il condiviso sia pregiudizievole per i figli, il condiviso significava in una prima fase come collocazione fisica alternata, questo sistema per alcuni è destabilizzante per il figlio. Affidamento condiviso non significa necessariamente collocamento alternato fisico, il significato profondo vuol dire compartecipazione dei genitori in egual misura alla vita del figlio, rappresenta l’attuazione piena della cosiddetta bigenitorialità, perché non si incorra in quella che è stata riscontrata spesso dell’alienazione parentale. Tale era la conflittualità tra i due che uno impediva la partecipazione dell’altro alla vita del figlio che si staccava dall’altro genitore e difficilmente si recuperava il rapporto nel tempo. Il contenuto della sentenza dal punto di vista del rapporto tra i coniugi, questi ricevono l’autorizzazione formale a vivere separati, già il deposito del ricorso rappresenta una giusta causa di allontanamento e viene meno l’obbligo di coabitazione. Viene però formalizzato con la sentenza di separazione, in cui vi è anche l’indicazione della sospensione di tutti gli altri obblighi che sono incompatibili con lo stato di separazione. Viene meno dunque l’assistenza morale, non viene meno la collaborazione nell’interesse dei figli e si attenua ma non si estingue l’obbligo di fedeltà. Il coniuge ha comunque diritto ad usare il cognome del marito salvo espressa inibizione del giudice, ma il più importante tra i provvedimenti che riguardano il SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO rapporto tra i coniugi è l’obbligo di mantenimento. È anche l’aspetto su cui i coniugi esprimono la massima conflittualità, sul se sia dovuto ed eventualmente quanto sia dovuto. Il matrimonio non è sciolto, questa quiescenza può sfociare nello scioglimento definitivo che si attua col divorzio o nella riconciliazione dei coniugi, è uno stato intermedio. È per questo che i parametri sulla base dei quali viene commisurato l’assegno di mantenimento sono molteplici e tengono conto proprio della permanenza di questo legame. Innanzitutto, i presupposti sono: il coniuge beneficiario non deve aver posto in essere condotte in violazione degli obblighi matrimoniali, ha diritto al mantenimento solo il coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, il coniuge al quale sia invece addebitabile perde il diritto al mantenimento. Secondo l’ordinamento essendo stato la causa della rottura non deve beneficiare degli effetti. Il secondo presupposto è che il coniuge beneficiario non deve avere adeguati redditi propri, i criteri e i parametri per valutare il quantum del mantenimento tengono come riferimento: in particolare il giudice deve commisurare l’assegno al tenore di vita che i coniugi godevano in costanza di matrimonio o comunque si deve guardare al tenore di vita che le sostanze e le potenzialità economiche del coniuge consentono. Quindi l’ordinamento si impegna per far mantenere lo stesso tenore di vita, è il primo criterio più tradizionale, ma a questo criterio si accostano una serie di altri criteri soprattutto a seguito della giurisprudenza che si è formata in materia di assegno divorzile, oggi la giurisprudenza accanto al tenore di vita utilizza anche il criterio del contributo fornito dal coniuge alla realizzazione della vita familiare e del contributo fornito alla formazione del patrimonio dell’altro. Si deve altresì guardare nel caso concreto anche alla durata del matrimonio e quando si tratterà di operare la quantificazione sarà opportuno anche una esatta valutazione dei redditi del coniuge che richiede l’assegno. Quindi il giudice dovrà guardare al tenore di vita che teneva la coppia precedentemente ecc. dovrà guardare quello che il coniuge guadagna ma anche capacità di lavoro e risorse patrimoniali, molto recentemente si guarda anche il reddito di cittadinanza. Bisogna che il giudice si cali nel caso concreto prima di obbligare l’uno al versare il mantenimento all’altro. I coniugi devono mantenere le stesse condizioni che avevano prima della separazione, si tratta di un assegno integrativo, prima questa regola era rispettata alla lettera. A questo criterio si aggiunge l’assegnazione eventuale della casa familiare, alla quantificazione dell’assegno di mantenimento si deve tenere conto anche della disponibilità che il coniuge ha della casa familiare e del fatto che l’altro coniuge lasciata la casa coniugale si debba trovare un’altra sistemazione con altri esborsi. Per quanto riguarda la casa familiare assegna la casa nella quale si è svolta la vita della famiglia ad uno solo dei due, la scelta ricadrà sul coniuge affidatario dei figli, perché l’interesse legato all’assegnazione della casa familiare è quello dei figli, alla continuità abitativa dei figli, tanto è vero che l’assegnazione della casa familiare perderà efficacia se non vi si abiti più o anche in caso di nuovo matrimonio o di convivenza more uxorio, ma non automaticamente. Bisognerà infatti revocare il provvedimento solo se la revoca non leda gli interessi dei figli. Il provvedimento di assegnazione si trascrive ai fini dell’opponibilità ai terzi, ha un regime di opponibilità molto forte tanto che è opponibile anche se non trascritto per nove anni. La ratio è proprio la forza connessa all’interesse familiare, questa volta prevalentemente della prole. È importante tenere distinto il mantenimento dal diritto agli alimenti previsto dall’articolo 433 cc. (vedi capitoletto libro) Il mantenimento è la trasposizione in sede di separazione dell’obbligo di assistenza materiale che non cessa e si trasforma nell’obbligo di mantenimento. Non c’entra con l’obbligo nei confronti dei figli, riguarda il rapporto tra i coniugi e serve per colmare le eventuali differenze reddituali tra uno e l’altro. SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO GLI ALIMENTI Gli alimenti hanno una ratio che rinveniamo nella solidarietà familiare in senso ampio, non riguarda solo i coniugi reciprocamente, ma riguarda anche altri soggetti ed ha un presupposto diverso: l’obbligo alimentare è lo stato di bisogno di un soggetto, l’incapacità di provvedere anche alle più elementari esigenze di vita. Il soggetto in questione deve essere impossibilitato a far fronte alle essenziali esigenze. Non c’è solo il coniuge tra gli obbligati: il primo soggetto obbligato a versare gli alimenti è il donatario, colui cioè che ha ricevuto una donazione da chi si trova in stato di bisogno. (esempio tipo marito che dona casa all’amico e rimane povero, poi amico dovrà versare alimenti) È moralmente tenuto secondo l’ordinamento a supportare il soggetto che muore di fame, è tenuto moralmente. Il donatario è il coniuge, poi i figli, genitori, in mancanza gli ascendenti, generi e nuore, suocero e suocera e fratelli e sorelle. L’obbligo alimentare può essere adempiuto sia denaro, versando un assegno alimentare ma anche in natura accogliendo presso la propria abitazione l’alimentando (colui che ne ha diritto), lo si prende in casa e lo si mantiene. Qui la quantificazione dell’assegno tiene conto solo del bisogno dell’alimentando ma tiene conto anche delle condizioni economiche di chi deve alimentare. Infine, l’obbligo alimentare in capo al coniuge sussiste anche in caso di separazione con addebito, è una particolarità da ricordare perché avrà delle ricadute in chiave successoria, il coniuge separato con addebito non ha diritto al mantenimento, ma pur essendogli stata addebitata la separazione se è in stato di bisogno ha diritto agli alimenti nei confronti del coniuge. ADDEBITO È l’ascrizione della responsabilità della rottura del legame all’uno o all’altro coniuge, su richiesta della parte interessata il giudice nel disporre la separazione può dichiarare a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione. L’addebito consegue all’accertamento di un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Il giudice accerta ciò, ma non basta, accerta che questa violazione sia stata causa della rottura (nesso di causalità) tra violazione e intollerabilità della convivenza. La violazione non rileva in sé stessa ma solo se sia stata causa efficiente della rottura. Per fare ciò il giudice deve valutare il comportamento tenuto da entrambe le parti ed accertare se eventualmente il comportamento dell’uno trovi giustificazione nel comportamento dell’altro. Cioè se la violazione compiuta da uno non sia giustificabile alla luce di altre violazioni compiute dall’altro, nella specie non basterà accertare la violazione del dovere di fedeltà ma si valuterà ad esempio nel fatto che non trovi giustificazione nel fatto che l’altra parte è venuta meno l’assistenza morale e materiale. È giustificata da un’altra violazione. Qualora giunga alla conclusione che un coniuge sia stato responsabile con le sue violazioni allora gliela addebita. A questa ascrizione conseguiranno effetti solo patrimoniali, non c’è la condanna al pagamento della somma di denaro, non è un illecito da risarcire, semplicemente è una responsabilità alla quale consegue come primo effetto la perdita del diritto al mantenimento, ed eventualmente restano fermi gli alimenti, e poi la perdita dei diritti successori. Finché non subentra l’addebito il coniuge anche separato giudizialmente non perde i suoi diritti successori, si perderanno solo col divorzio e in caso di addebito. - Separazione consensuale senza conflittualità. I coniugi si accordano su tutti gli aspetti che riguardano figli e diritti reciproci, ma anche doveri reciproci. Aldilà del procedimento che anche in questo caso prevede il ricorso e il tentativo di conciliazione, se non riesce, si giunge molto più velocemente alla conclusione di omologare un accordo che le parti hanno già raggiunto. In sede di omologazione il giudice non può sindacare le ragioni che hanno condotto le parti a separarsi ma deve soltanto valutare la rispondenza dell’accordo omologato all’interesse dei figli. Qualora valuti che non corrisponde all’interesse dei figli suggerisce le modifiche da apportare. In sede di separazione molto spesso le parti scelgono di soddisfare le ragioni economiche non mediante pagamenti periodici di somme di denaro ma mediante assegnazione, attribuzione di beni mobili SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO - o immobili, accade cioè frequentemente che in sede di separazione soprattutto consensuale le parti si accordano perché l’uno trasferisca all’altro un bene mobile o immobile ci si è molto a lungo interrogati sulla causa di questa attribuzione. Il problema è che qual è l’interesse che viene soddisfatto? È una vendita? Ha funzione solutoria dell’obbligo di mantenimento? Lo sostituisce? È una causa liberale, una donazione? Dopo varie discussioni si è risoluto che la causa è una nuova causa, ovvero il fatto che la causa tipica è quella di sistemazione dell’assetto patrimoniale in ragione della crisi del rapporto. Quindi trova causa nell’esigenza di sistemare i rapporti dare/avere tra coniugi in ragione della crisi. Separazione di fatto, ha una rilevanza marginale nel nostro ordinamento. Allontanamento dall’abitazione che senza giusta causa integra la violazione del dovere di coabitazione. Ha una rilevanza marginale nel nostro ordinamento, è rilevante nell’adozione di minorenni laddove la impedisca (anche la separazione giudiziale la impedisce) ed ancora se si prolunga per lungo tempo attenua i doveri coniugali. La scelta condivisa di vivere separati attenua ai doveri, sicché poi sarà considerata diversamente la valutazione dell’addebito quando si giungerà alla separazione legale. RINCONCILIAZIONE Primo desiderio dell’ordinamento, è il superamento delle ragioni del conflitto. La riconciliazione è la cessazione degli effetti della sentenza di separazione giudiziale o omologazione del decreto. È il superamento delle ragioni del conflitto, può essere espressa o tacita (comportamento concludente). È una dichiarazione di natura negoziale ed è incompatibile con lo stato di separazione. È necessario però che ci sia anche un ripristino della comunione spirituale e materiale; la dichiarazione espressa di natura negoziale secondo la normativa sull’ordinamento dello stato civile deve essere annotata a margine dell’atto di matrimonio, ai fini della opponibilità ai terzi. Ovvero la riconciliazione produce il ripristino della comunione legale tra i coniugi; quindi, per questo è opponibile ai terzi. Era cessata la comunione legale ora si ricompone, con tutti gli effetti sulla responsabilità patrimoniale. L’importante è che viene meno la rilevanza di tutti i comportamenti che fino a quel momento i coniugi avevano tenuto, è una sorta di sanatoria rispetto al passato. È possibile anche che poi vi sia di nuovo una separazione, ma non possono addurre le ragioni a quelle precedenti alla riconciliazione che vi è stata perché ha sanato. L’efficacia è infatti una efficacia ex nunc, quindi la riconciliazione non retroagisce, ma interrompe i termini del divorzio. IL DIVORZIO Con il divorzio si produce lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Noi utilizziamo semplificando il termine divorzio, ma il più adatto sarebbe scioglimento o cessazione degli effetti civili. Si parla di scioglimento se il matrimonio è stato un matrimonio civile, di cessazione se è stato un matrimonio concordatario. La fonte della disciplina è la legge 898 del ’70. Anche nel divorzio c’è il tentativo di riconciliazione e i provvedimenti immediati nei confronti dei figli. Mentre la separazione sul presupposto ampio della tollerabilità fa rientrare semplici cause, il divorzio fa ricomprendere delle cause tipiche e tassative. - Condanna penale per determinati reati, che prevedano l’ergastolo o la pena superiore a 15 anni, come incesto (reati previsti dall’articolo 3 della legge 898 del ’70 che disciplina il divorzio) La separazione legale per 12 mesi in caso di separazione contenziosa o 6 mesi in caso di consensuale che sia ininterrotta dall’udienza presidenziale Divorzio o annullamento di un matrimonio ottenuto all’esterno Matrimonio non consumato SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO - Rettifica di attribuzione del sesso, questa è l’unica causa di divorzio automatico, è il cosiddetto divorzio imposto, cioè la normativa prevede che alla sentenza di rettifica del sesso consegua automaticamente lo scioglimento del matrimonio, ma in verità questo problema è stato oggetto di interesse da parte della giurisprudenza, che si interessa delle vicende umane quando ci sono bisogni da soddisfare. Questa disciplina del 70 è stata prima modificata per effetto di una pronuncia della Corte costituzionale del 2014 (sentenza 170) la quale con riferimento al problema della rettifica del sesso e del divorzio imposto ha dichiarato illegittimi gli articoli 2-4 della legge del 82 attuativa del divorzio imposto, nella parte in cui questi non prevedono che sia consentito ai coniugi di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato da altra forma di convivenza registrata. La Corte costituzionale comincia ad affermare che non è detto che due persone dello stesso sesso non possano comunque vivere con comunione di vita spirituale e che vi sia una disciplina analoga del matrimonio. Devono poter vivere secondo un’altra forma di convivenza registrata, invita il legislatore a prevedere una disciplina per questa ipotesi; è stata la base per l’unione civile. A questa sentenza segue la giurisprudenza della corte di cassazione che dice addirittura, in attesa che il legislatore provveda a regolamentare la convivenza registrata tra persone dello stesso sesso, comunque i soggetti mantengono gli stessi diritti e gli stessi doveri che avevano in costanza di matrimonio. Disattiva la normativa del 70 sul divorzio imposto, ammettendo che alla rettifica del sesso di uno non si scioglieva il matrimonio automaticamente. Poi al comma 27 dell’articolo 1 delle unioni civili (legge 76/2016) dice che dopo il giudizio che rettifica il sesso i coniugi possono manifestare la volontà di instaurare un regime di unione civile. La legge 76 attua quello che la Corte aveva sentenziato e la cassazione applicato e consente che si passi dal regime del matrimonio tra persone di sesso diverso al regime dell’unione civile. Anche se non è operante la regola contraria, perché il comma 26 precisa invece che se la sentenza di rettifica del sesso interviene tra due uniti civilmente non diventa matrimonio, ma l’unione si scioglie, non si può manifestare la volontà di passare al regime matrimoniale. EFFETTI DEL DIVORZIO Nell’ambito del procedimento vi è anche la possibilità di provvedere ad un assegno divorzile a carico di uno dei due coniugi in favore dell’altro. La ratio è la permanenza dopo lo scioglimento del vincolo…, deve essere commisurato ad una serie di criteri: le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico fornito per la conduzione della vita familiare e per la formazione del patrimonio, il reddito di entrambi, la durata del matrimonio. La più recente giurisprudenza chiarisce che la funzione dell’assegno divorzile è una funzione composita, cioè ha una funzione al contempo assistenziale, compensativa e perequativa e deve dunque essere quantificato comparando le condizioni economiche di entrambi e se esiste una sperequazione, cioè una differenza tra le due condizioni economiche, si deve valutare se questa è stata causata dal contributo che un coniuge ha dato all’altro nella formazione del patrimonio e nella conduzione della vita. Ovverosia se si guarda alla condizione economica dei due coniugi e uno è completamente nullatenente perché ha immolato la sua esistenza per consentire all’altro di arricchirsi allora ha diritto ad un assegno molto alto. Ci sarà un tentativo di riequilibrare le sostanze se il reddito della parte svantaggiata non è adeguato al contributo che ha fornito. Inoltre, tra gli effetti che conseguono alla sentenza vi è altresì la perdita dei diritti e doveri coniugali, la cessazione dell’obbligo di utilizzare il cognome, la perdita dei diritti successori, il mantenimento inalterato dei doveri verso i figli e la conferma se c’è già stata separazione o comunque la separazione ex novo della casa coniugale. (stessi criteri della separazione) DIVORZIO BREVE Accordo davanti a ufficiale civile e negoziazione assistita, sono due forme brevi del divorzio, della separazione o modifica delle condizioni di separazione e divorzio. SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO Nell'accordo davanti all'ufficiale civile questo deve innanzitutto verificare l'identità delle parti, come verificare che non siano incapaci e verificare la sussistenza di uno dei presupposti quindi la presenza di una precedente sentenza di separazione giudiziale o consensuale. vi sono poi moltissimi accertamenti da parte del giudice nel caso della presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci ovvero economicamente non autosufficienti, poiché è necessario un controllo degli interessi degli stessi. l'ufficiale dello Stato civile riceve da ciascuno la dichiarazione che vogliono separarsi o fare cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenere lo scioglimento. quando i coniugi perfezionano l'accordo di separazione davanti all'ufficiale di Stato civile una domanda di divorzio può essere proposta dei corsi sei mesi, l'accordo inoltre non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. ultimamente però sono consentiti alcuni accordi che riguardino la previsione di un assegno di separazione o di divorzio. Nel caso della negoziazione assistita, una parte fa pervenire all’altra l’invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, utilizzando l’aiuto degli avvocati per risolvere la controversia in via amichevole. Il contenuto della convenzione è la separazione personale, la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento. In mancanza di figli minori, con handicap o maggiorenni incapaci, il curatore della Repubblica comunica il nullaosta. Il pubblico ministero in generale svolge dei controlli di regolarità nell’interesse delle parti o dei figli. Lezione 12 diritto privato mod. b L’UNIONE CIVILE FONTI NORMATIVE La disciplina dell’unione civile è difficile da decodificare perché ha molti rinvii. Le fonti normative sono quindi: - - La legge 76 del 2016 è una legge intervenuta dopo anni di silenzio del legislatore ed è molto complicata e problematica. Questa detta tutte le norme da applicare Titolo VIII del dpr 396 del 2000, che è l’ordinamento dello stato civile, che ha istituito un registro delle unioni civili. Decreti attuativi del 2017 A queste previsioni espresse e a questo innesto diretto che viene operato dalla legge sull’ordinamento civile e quindi la creazione del registro dobbiamo aggiungere una norma generale di rinvio che troviamo nella legge 76. Si legge che al fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile la parola coniuge deve essere letta anche riguardo all’unione civile ovunque ricorra nelle leggi, atti aventi forza di legge ecc. non vale per le norme del cc non espressamente dichiarate e per le disposizioni in materia di adozione (stepchild adoption, non si poteva neanche procedere all’adozione del figlio dell’altro coniuge, tanto meno alla classica adozione). Ultimo criterio è l’interpretazione analogica, si può nei restanti casi applicare la disciplina per analogia, non in materia di adozione causa divieto esplicito. Quindi si applica la disciplina esistente per una fattispecie ad un’altra fattispecie sprovvista di normativa. Si deve quindi trattare di due fattispecie simili o perlomeno deve esserci la stessa ratio, come rapporto tra associazioni riconosciute e non riconosciute (queste ultime hanno tre norme) DISCIPLINA Innanzitutto, per quanto riguarda la celebrazione se il matrimonio conosce tre forme di celebrazione (concordatario, davanti al ministro del culto acattolico, davanti all’ufficiale dello stato civile) nell’unione civile si conosce solo la forma davanti all’ufficiale dello stato civile, scelto dalle parti, con due testimoni. SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO L’unione civile è l’unione tra due persone maggiorenni dello stesso sesso. Vi sono tre fasi: la richiesta di costituzione dell’unione, l’istruttoria conclusa dall’ufficiale su presupposti e impedimenti, la raccolta dei consensi e la dichiarazione dell’ufficiale di avere unito civilmente i richiedenti. Tale dichiarazione deve essere trasposta in un documento sottoscritto dalle parti, dall’ufficiale civile e dai testimoni e poi viene trascritto nel registro delle unioni civili. La dichiarazione delle parti di voler costituire un’unione civile è il momento in cui si perfeziona l’unione, anche se ciò non è chiarito dalla legge 76, ma applichiamo analogicamente dal matrimonio. Il momento in cui si perfeziona è la dichiarazione delle parti, perché l’iscrizione da parte dell’ufficiale dello stato civile che pure ha efficacia costitutiva retroagisce. IMPEDIMENTI Impedimenti comuni a matrimonio e unione civile, ampliati o riadattati: - Minore età Interdizione per infermità di mente Mancanza di libertà di stato, anche se questa in questo ambito va letta come preesistenza di un’unione civile sia di matrimonio. Rapporto di parentela, va ampliato anche questo, va riletto perché si devono calcolare anche le persone dello stesso sesso (genero e suocero, zio e nipote eccetera) Impedimentum criminis Non vi è il divieto temporaneo di nuove nozze per cui la donna non poteva sposarsi se non decorsi eccetera… per la certezza della paternità. Può essere impugnato dai coniugi stessi, dagli ascendenti prossimi, dal pm o da chiunque ne abbia interesse. La legge 76 è sotto tanti aspetti criticabile, ma ha degli aspetti di pregio ovvero ha degli aspetti di maggiore semplificazione, mentre la disciplina matrimoniale era piena di piccole sfumature, questa è molto più moderna e spedita. In materia di legittimazione ad impugnare il matrimonio viziato la legittimazione è sempre quella, mentre nel caso del matrimonio avevamo soggetti diversi e fattispecie diverse. Mentre qua coniugi, ascendenti, PM e chiunque ne abbia interesse. La disciplina del ritorno del presunto morto e dell’incapacità naturale e violenza/errore è la stessa. Unica piccola sfumatura sull’errore è che nelle unioni civili il matrimonio può essere impugnato per errore sull’identità della persona e sull’errore sulle qualità personali, tra le ipotesi tipiche ha escluso l’impugnabilità per malattia fisica o psichica tale da impedire lo svolgimento della vita matrimoniale (facendo intendere che l’omosessualità rientrasse tra queste, quindi non si poteva impugnare). Nella legge 76 non si parla mai di famiglia. Non c’è il riferimento allo stato di gravidanza della donna. Si applica la disciplina del matrimonio putativo, salvo il riferimento ai figli. EFFETTI PERSONALI Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano i medesimi diritti e doveri ecc… hanno tolto la fedeltà e la collaborazione all’interesse della famiglia. Non si può che integrare con l’elenco dei diritti e doveri dei coniugi del matrimonio, la coppia è funzionalmente e strutturalmente identica a quella del matrimonio. Quanto non espressamente detto si integra analogicamente. Si applica il 144 ovvero l’accordo sulla vita familiare ma non c’è menzione del 145 che è il ricorso al giudice in caso di disaccordo sulla decisione dell’indirizzo della vita familiare. Infine, riguardo all’assunzione del cognome nella legge 76 si precisa che al momento di prestare la dichiarazione di voler costituire unione SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO civile le parti scelgono uno dei due cognomi come cognome comune da anteporre o posporre al proprio. Non importa la modificazione delle schede anagrafiche e non è trasmissibile agli eredi. Palesemente discriminatorio è la mancata previsione del legislatore dell'obbligo di fedeltà accanto all'eliminazione della stepchild adoption. Dibattito molto attuale è la sostituzione dell'obbligo di fedeltà con quello di lealtà intesa come il sacrificio di alcune scelte e interessi individuali per la vita coniugale. Altro obbligo eliminato dal legislatore è quello della collaborazione nell'interesse della famiglia, nel concreto questo obbligo non viene a mancare, ma spesso in attesa di altre leggi si fa rientrare nell'obbligo di assistenza morale. Al regime patrimoniale si applicano le disposizioni del matrimonio, con l’unica eccezione che nelle convenzioni matrimoniali l’opponibilità a terzi deriva dall’annotazione a margine dell’atto dell’unione civile della data del contratto/notaio rigante e generalità dei contraenti/dichiarazione di scelta per la separazione. Il coniuge può anche disgiuntamente richiedere lo scioglimento della unione davanti all'ufficiale dello stato civile. Decorsi tre mesi si divorzia. Passo avanti rispetto al patriarcato, non c’è la separazione nelle unioni civili, perché la separazione è l’illusione del legislatore legata allo stato d’attesa che ritornino insieme. Il legislatore ha capito che il legame è rotto quindi i tempi sono brevi. Ora gli uniti civili non si separano, si sciolgono, divorziano, hanno capito che la separazione non serve a niente. L'ufficiale dello stato civile può inoltre ricevere l'accordo di scioglimento delle parti e può procedere applicando la procedura della negoziazione assistita. Per il divorzio in tribunale si applica la medesima disciplina del matrimonio ad esclusione delle due cause di matrimonio non consumato e separazione di 12 mesi. No disciplina inversa del divorzio imposto. Può essere anche qui previsto un assegno divorzile. L'UNIONE DI FATTO La convivenza di fatto è prevista per le coppie eterosessuali e omosessuali attraverso una disciplina basata sui legami affettivi di coppia e la reciproca assistenza morale e materiale. La convivenza di fatto vede come documento funzionare la dichiarazione anagrafica in cui è dichiarata la coabitazione, ma con il mutato assetto della società non ci si può basare soltanto su questa. La disciplina è del tutto assente in ambito di celebrazione e invalidità. La legge si occupa di estendere ai conviventi di fatto alcuni diritti previsti per i coniugi: quelli previsti dall’ordinamento penitenziario, in caso di malattia o ricovero hanno diritti reciproci di assistenza, visita ecc, ciascuno può designare l’altro come suo rappresentante o tutore. Alla morte del proprietario della casa di convivenza: il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare per 2 anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a 2 anni e comunque non oltre i 5 anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo mai inferiore a 3 anni. In caso di morte o recesso del conduttore il convivente ha la facoltà di succedere nel contratto. iI conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza l'ho redatto in forma scritta ai fini dell’opponibilità a terzi iscritto all'anagrafe. Il contratto di convivenza come contenuto può indicare la residenza, le modalità di contribuzione alla vita comune, il regime patrimoniale della comunione dei beni. Tale contratto è nullo si concluse in presenza di un vincolo matrimoniale o in presenza di un presupposto che impedisca l'unione di fatto come minore età, interdizione, impedimentum criminis. Il contratto si risolve per accordo, recesso unilaterale, matrimonio o Unione civile oppure morte di uno dei contraenti. SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO La crisi dell’unione di fatto si tramuta in una cessazione della convivenza. In caso di cessazione della convivenza di fatto il giudice può stabilire gli alimenti in favore di uno dei due MA In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza, al bisogno dell’alimentando e alle condizioni di chi deve prestarli. Lezione 13 diritto privato mod. b LE SUCCESSIONI PRINCIPI GENERALI La successione è il fenomeno del subentro di un soggetto, successore o avente causa, ad un altro soggetto, autore o dante causa, in una o più situazioni giuridiche. È una vicenda modificativa della titolarità che può riguardare sia situazioni attive di vantaggio, come nella cessione del credito e qua nel passaggio della proprietà, ma anche situazioni passive di svantaggio quindi, come accollo e lo vedremo nella successione nei debiti ereditari. L’espressione successione come subentro di un soggetto ad un altro in una o più situazioni soggettive va inteso qui in senso atecnico, nella successione mortis causa non c’è solo il subentro di un soggetto ma può anche esserci una vicenda costitutiva o estintiva. Il testatore, per esempio, costituisce un usufrutto a vantaggio di qualcuno, creando così una situazione che prima non c’era; oppure il medesimo mediante legato può estinguere un’obbligazione preesistente, perché il legato è lo strumento con cui il testatore può adempiere o rimettere un debito. Tutto ciò può trovare fonte nel testamento, quindi non sempre si passa una situazione già esistente, non è sempre e solo subentro. Il diritto successorio in senso oggettivo è il complesso di norme che disciplinano la trasmissione del patrimonio del de cuius, colui della cui successione si tratta. Dal punto di vista soggettivo il diritto successorio individua il diritto degli eredi o/e dei legatari a succedere ai rapporti patrimoniali del defunto. La regola generale è che sono oggetto di trasmissione i soli diritti patrimoniali del defunto, in aggiunta gli atti precontrattuali irrevocabili (proposta irrevocabile), gli atti dell’imprenditore nell’esercizio dell’impresa e anche il diritto di accettare l’eredità. Questi sono i diritti non patrimoniali che vengono conferiti. Non si trasmettono invece i diritti della personalità, quei diritti che si estinguono con la morte come usufrutto o abitazione; non si trasmettono i rapporti patrimoniali intuitu personae (mandato), ancora i rapporti patrimoniali legati agli status familiari (diritto e obbligo a mantenimento o alimentare), il diritto morale d’autore, le rendite vitalizie, le sanzioni amministrative e penali. CLASSIFICAZIONE La successione può essere classificata in diversi modi: a titolo universale o a titolo particolare. Sono a titolo universale le disposizioni che attribuiscono la qualità di erede e comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario. Dunque, è eredità l’intero patrimonio del defunto o una frazione di questo, ed è pertanto erede colui che subentra nella totalità del patrimonio e dei rapporti del defunto o in una quota. Il legato invece è l’attribuzione di un bene determinato e specifico, come diritto di proprietà su un singolo bene, un diritto di credito. È dunque legatario il destinatario di questa attribuzione a titolo particolare, il quale subentrerà solo in quella singola specifica situazione. L’erede dunque è un successore a titolo universale, mentre il legatario è un successore a titolo particolare. Il trattamento giuridico che l’ordinamento riserva all’erede o al legatario è diverso; l’erede subentra in tutte le situazioni attive e passive del defunto potendo altresì rispondere con tutto il suo patrimonio per i debiti ereditari se non accetta con beneficio di inventario (divisione patrimoni). La successione è in tutte le situazioni attive e passive, anche in quelle che non conosce, perché l’erede è il continuatore della SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO personalità del defunto sia dal punto di vista patrimoniale ma anche morale e ideale. L’ordinamento vuole che ci sia sempre un erede anche per le eredità completamente vuote o passive. Il carattere principale della successione a titolo universale è la potenzialità di espandersi anche a quei rapporti che non sono noti al momento della successione, anche ai beni sopravvenuti, questa è detta vis expansiva. Il patrimonio al momento dell’apertura potrebbe non essere uguale al momento della lettura del testamento. Il legatario riceve invece solo quel bene. Proprio però perché non è detto che la posizione dell’erede sia vantaggiosa, sia perché ci sono anche ragioni etiche o morali (figlio sempre in conflitto col genitore), l’eredità richiede sempre l’accettazione, con degli specifici rimedi per l’accettazione delle eredità passive. Si può quindi anche non accettare; diversamente è il legato che è un’attribuzione vantaggiosa, si ritiene che il legato possa solo procurare un vantaggio al legatario. Per tale ragione il legato non ha bisogno di essere accettato, può essere rifiutato però si acquista in maniera automatica. Vi è la possibilità di assoggettare l’acquisto del legato sia a termine iniziale che a termine finale solo nella successione a titolo particolare, mentre a titolo universale vi è questa impossibilità. Per il legatario opera l’accessione nel possesso (somma il possesso con quello del de cuius) mentre l’erede continua automaticamente con quello del defunto, con le stesse caratteristiche. L’articolo 588 dice che ci sono attribuzioni a titolo universale o a titolo particolare, ma dice anche che qualora dall’interpretazione del testamento si ricavi che il bene attribuito è implicitamente rappresentativo di una frazione il beneficiario dovrà intendersi come beneficiario non di un’attribuzione a titolo particolare ma a titolo universale, perché quel bene viene in rilievo come quota del patrimonio. Nell’ambito dell’autonomia testamentaria il testatore può scegliere di attribuire un bene determinato non a titolo di legato, ma a titolo universale, come cioè bene indicativo di una quota di patrimonio. Il bene viene cioè in rilievo come frazione dell’asse, del patrimonio ereditario. Questo istituto è denominato “institutio ex re certa”. Bisognerà poi comprendere se quel bene sia stato inteso dal testatore come rappresentativo di una quota o oggetto di legato, si deve evincere dalla scheda testamentaria. Ciò si valuterà mettendo in rapporto la cosa oggetto di institutio con tutto il resto del patrimonio. Per i beni sopravvenuti si individuano gli eredi di tutto il patrimonio, quindi beneficiario ex certa re, eredi testamentari o altri di successione legittima, e tutti i beni che non sono stati ricompresi nella successione e non sono oggetto di specifica attribuzione saranno ripartiti in proporzione alle rispettive quote. PROCEDIMENTO SUCCESSORIO Si tratta dell’iter che dall’apertura della successione conduce sino all’acquisto dell’eredità. Nel mezzo c’è la vocazione e la delazione (libro dice solo delazione). APERTURA DELLA SUCCESSIONEVOCAZIONEDELAZIONEOFFERTA E ACCETTAZIONE DELL’EREDITA L’apertura della successione è prevista dal 456 cc, si apre al momento della morte nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto. La vocazione è la fase immediatamente successiva all’apertura della successione, è la fase nella quale si individuano astrattamente i successori, è la chiamata astratta all’eredità. Mentre la delazione è l’attribuzione concreta ai primi chiamati del diritto di accettare; per fare un esempio la successione legittima individua i successibili tra figli e coniuge e parenti entro il sesto grado, sono tutti vocati, ma la delazione viene fatta ai più vicini, se ci sono figli e coniuge delazione va a loro, gli altri sono solo vocati, chiamati astrattamente. Fino a quando non ci sarà l’esclusione dei più vicini non avranno l’attribuzione del diritto di accettare. Anche il nascituro e il concepito possono succedere, quindi sono vocati, ma la loro delazione è subordinata alla nascita. SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO La delazione ha due fonti, l’articolo 457 cc dice che l’eredità si devolve per legge o per testamento. Individua: - - - da un lato la successione testamentaria, ovvero quella che ha fonte nella volontà del de cuius, e dall’altro quella legittima. Nella successione testamentaria il de cuius ha disciplinato secondo la propria autonomia negoziale la sua successione, determinando le sorti del suo patrimonio. Il testamento è il luogo nel quale il testatore può esprimere la sua autonomia ma non pienamente, perché è limitato dalla successione necessaria. La successione necessaria è un complesso di norme che servono per correggere eventuali distorsioni della successione testamentaria ed anche della successione legittima, che è la seconda forma di delazione. È l’individuazione dei successori operata dalla legge. È una disciplina di tipo suppletivo. Si apre cioè quando un soggetto non abbia fatto testamento, autonomamente provveduto a disporre delle proprie sostanze per il tempo successivo alla morte. Ma può anche accadere che la successione legittima vada a colmare alcune lacune della successione testamentaria, operano in maniera combinata. Può succedere quando il testatore ha istituito eredi in una quota inferiore all’intero, come la metà. Per l’altra metà si apre la successione legittima; oppure quando il testatore con il suo testamento disponga solo di legati non nominando eredi, magari esaurisce completamente l’asse ma manca l’erede e si apre la legittima. Invece quando il testatore istituisce eredi nell’universalità del patrimonio quindi anche tanti eredi pro quota purché il totale sia l’intero non si apre la legittima. Successione può essere testamentaria, legittima, un po’ e un po’. La successione necessaria interviene solo quando ci sono delle lesioni, degli effetti distorti o dell’una o dell’atra, è solo una successione legittima potenziata che serve per tutelare alcuni soggetti detti legittimari che sono i figli e il coniuge e se non ci sono i figli gli ascendenti, mira a tutelarli affinché questi abbiano necessariamente una quota di patrimonio. Il testatore non può attribuire come vuole i beni, se non ha prima soddisfatto le ragioni di questi soggetti. Questa opera nella successione testamentaria, ma può capitare anche nella legittima. Non è una autonoma delazione dell’eredità. I PATTI SUCCESSORI Salvo per le norme poste a tutela dei legittimari, la libertà del testatore riceve nel nostro ordinamento tutela ampia, in particolare troviamo il divieto dei patti successori. Questi si collocano nella tutela della libertà testamentaria. Articolo 458 ci dice che fatto salvo il patto di famiglia, è nulla qualsiasi convenzione con cui taluno dispone della propria successione, dei diritti che gli possano spettare su una successione non ancora aperta, rinunzia ai medesimi diritti. Si tratta dei patti istitutivi, dispositivi o rinunciativi. I patti istitutivi sono accordi con i quali taluno si impegna a nominare erede un altro soggetto o legatario; quindi, è il futuro testatore che si accorda per nominare qualcuno erede o legatario. Il fenomeno è piuttosto frequente, tipo con i figli decide fuori dalla sede del testamento con un contratto bilaterale un erede o un legatario e liquida in vita gli altri. È un patto nullo, sarebbe un contratto mortis causa. Secondo la dottrina prevalente è prevista la nullità perché in questo modo si viola la libertà del testatore che invece l’ordinamento tutela fino all’ultimo istante di vita del soggetto, il testamento può essere revocato fino all’ultimo istante di vista. L’accordo con il futuro erede o legatario vincolerebbe. Secondo altri la ratio è diversa, perché anche se le parti convengono che l’accordo potrebbe essere liberamente revocato sarebbe nullo egualmente, la ratio sta nella tipicità del negozio testamentario. Che sia una ratio o l’altra o entrambe, l’accordo è nullo in ogni caso anche se revocabile. Con i patti dispositivi un soggetto attribuisce a terzi diritti che potrebbero derivargli da una futura successione. Si dispone in anticipo di diritti che si potrebbero acquisire, vendita di futura eredità che SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO riceverà dal proprio genitore o vende un bene di una futura eredità. Tra le critiche poste a questo divieto non si vede perché non si possa disporre di un bene che un giorno giungerà, vendita di cosa futura esiste. La linea tra accordo lecito e illecito è sottile, è illecito il patto quando il bene viene considerato parte di un’eredità, se invece è considerato cosa altrui o cosa futura è lecito. Non posso dire ti vendo la cosa che erediterò da mia madre, ma posso dire ti vendo la casa di mia madre. La ratio di questo divieto è ballerina, non è chiara, secondo alcuni il patto è nullo perché non si devono creare scelte vincolanti che ingenerano l’affidamento di terzi su scelte suscettibili di modificarsi in ogni momento. La ratio che probabilmente ha dato origine alla disposizione è di tipo morale, la ripugnanza sociale che ingenera la speculazione sull’altrui morte. Cioè stipulare un contratto di questo genere si risolve in una sorta di auspicio di chi contrae per la morte di un’altra persona. I patti rinunciativi infine riguardano rinunzie a diritti che potrebbero derivare da una futura successione, anche questi sono oggetto della medesima oscillante giustificazione fondante. La dottrina riconduce i rinunciativi alla stessa ratio, cioè chi ha l’aspettativa di ricevere i beni o ne dispone prima del tempo con i dispositivi o ne rinuncia, in entrambi i casi c’è principio affidamento su scelte suscettibili e ripugnanza di speculazione su morte. Il tentativo della dottrina è quello di cercare di superare il rigore di questi divieti, soprattutto perché non in tutti i paesi europei esiste questa disciplina. Ci sono molti dibattiti. A questo si aggiunge che il regolamento 650 del 2012 ha aperto all’ammissibilità di un patto successorio tra un cittadino italiano e un cittadino di un paese ove questi siano previsti, scegliendo come legge applicabile la legge del paese nel quale è consentito compiere e svolgere il patto successorio. Esiste una apertura verso i patti successori che deriva dall’appartenenza all’UE, la dottrina cerca di scardinare questi divieti soprattutto per i dispositivi e rinunciativi. I PRESUPPOSTI DELLA DELAZIONE La delazione è l’attribuzione concreta ad un soggetto del diritto di accettare. I presupposti della delazione sono: - La morte di colui di cui l’eredità si tratta La sopravvivenza dell’erede o del legatario La capacità di succedere Gli eredi o il legatario devono innanzitutto sopravvivere al momento della delazione, cioè se al momento della disposizione testamentaria questi risultano morti si prende come non scritta. Inoltre, questi devono essere capaci di succedere; sono capaci di succedere tutti coloro che sono stati concepiti o nati al tempo dell’apertura della successione (si presume concepito colui che nasce entro 300 giorni dalla morte del de cuius) in questo caso l’amministrazione del patrimonio spetterà ai genitori, eccezionalmente sono capaci di succedere i nascituri, ovvero coloro che non sono nemmeno stati concepiti, ovvero figli di persona vivente al momento della morte del testatore (anticipazione della capacità giuridica) l’amministrazione spetterà alla persona determinata. Ultimi soggetti considerati capaci sono le organizzazioni di qualsiasi genere, gli enti, se non si tratta di società devono accettare con beneficio di inventario. Sono esclusi dalla successione, quindi incapaci di succedere gli indegni. L’indegnità è una forma di esclusione dalla successione non di incompatibilità come l’incapacità relativa. Si verifica ex post rispetto all’apertura della successione e per essa vige il brocardo “indignus potest capere sed non retinaere”. L’indegno può ricevere l’eredità ma non può trattenerla. È una reazione sanzionatoria dell’ordinamento rispetto a certe condotte gravi che un soggetto abbia posto in essere nei confronti del testatore. Ripugna alla coscienza collettiva che chi abbia posto in essere nei confronti del testatore condotte grave possa poi beneficiare del suo patrimonio o addirittura essere continuatore della sua persona. È un elenco tassativo: SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO - - L’indegno può essere colui che ha volontariamente ucciso o tentato di il de cuius, il coniuge, l’ascendente o il discendente (colpa grave dell’indegno) Istigazione di questi al suicidio (colpa grave dell’indegno) Calunnia o falsa testimonianza per reati di una determinata gravità (colpa grave dell’indegno). Nel 2005 a queste tre ipotesi si è aggiunta una quarta ipotesi ovvero Colui che essendo decaduto dalla responsabilità genitoriale non è stato più reintegrato e quindi non risulta reintegrato alla data dell’apertura della successione, è connessa alla decadenza della responsabilità genitoriale. (colpa grave dell’indegno) chi ha condotto con dolo o violenza il de cuius (violazione della libertà di testare) chi ha soppresso celato o alterato il testamento oppure chi ha formato un testamento falso e ne abbia fatto uso. L’indegno può essere riabilitato espressamente o tacitamente. È diversa dall’indegnità l’incapacità relativa a succedere che riguarda l’incapacità di certi soggetti a succedere in determinati rapporti è infatti incapace a succedere: l’amministratore di sostegno rispetto alla successione dell’incapace, il tutore o protutore, notaio o testimone dell’interprete nel testamento pubblico, colui che ha scritto o ricevuto il testamento segreto, qualunque disposizione testamentaria fatta nei confronti di questi soggetti o fatta a madre, discendenti, coniuge dei medesimi soggetti sono disposizioni nulle. La ratio di queste incompatibilità è legata alla circostanza che i rapporti tra incapace e amministratore o tutore o protutore e così i rapporti tra colui che riceve il testamento e il testatore o colui che scrive il testamento altrui sono tali che potrebbero aver determinato un’alterazione della volontà del testatore. Per evitare il rischio di alterazione della volontà del testatore questi soggetti non possono essere parte della successione testamentaria, salvo che non si tratti di conviventi, coniugi o parenti che intervengono nella successione come eredi legittimi e non testamentari. DISCIPLINA DELL’INDEGNITÀ: Sentenza che accerti la condotta dell’indegno con anche sentenza costitutiva di esclusione. L’azione diretta all’esclusione dell’indegnità è disponibile per l’interessato che può anche rinunziarvi o transigere entro il termine di prescrizione per farla valere di dieci anni (possono averne interesse i chiamati di grado ulteriore che facendolo escludere se di grado inferiore subentrano). Vedi Pietro maso, nessuno ha esperito l’azione, quindi ha ereditato, ma non perché era legittimario, perché indegnità vince anche sui legittimari. Vi sono solo delle ipotesi in cui l’azione non è esercitata dall’interessato, come reati sessuali e sessuali di gruppo oppure adescamento o corruzione di minore, perde i diritti successori. L’indegnità è una condizione strettamente personale che vale nei rapporti tra defunto e indegno, i discendenti possono succedere per rappresentazione di quello (indegno non ha usufrutto ex lege se minori o amministrazione dei beni). Per quanto riguarda l’efficacia retroattiva l’esclusione dell’indegno dalla successione determina la delazione del chiamato ulteriore; la disciplina assimila queste condizioni all’ipotesi risolutiva (intanto acquisisce ma intervenuta la sentenza che dichiara l’indegnità decade). L’indegno è possessore di mala fede, deve consegnare i frutti maturati dopo l’apertura della successione. È per questo che sono state introdotte altre tre discipline: - La sospensione della successione fino al decreto di archiviazione o sentenza definitiva per coniuge indagato per omicidio dell’altro. Introdotta nel 2018. La diseredazione è una disposizione testamentaria, l’esclusione per volontà del testatore di escludere un erede. L’indegnità era una esclusione ex lege. È ammessa soltanto per gli eredi SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO - legittimi ma non legittimari. Gli eredi legittimi sono coloro ai quali viene devoluta l’eredità in mancanza di testamento o qualora il testamento non abbia provveduto integralmente al patrimonio. Gli eredi legittimi sono il coniuge, i parenti entro il sesto grado e lo stato. È necessario che se nessuno c’è o accetta. I legittimari sono una cerchia ristretta: il coniuge e i figli, se non ci sono i figli allora gli ascendenti cioè i genitori. Ai legittimari in virtù del cosiddetto principio solidaristico endofamiliare l’ordinamento pretende che il defunto lasci una quota di patrimonio. I figli e il coniuge devono obbligatoriamente ricevere una quota di patrimonio, se non lo fa il de cuius lo fa la legge. La diseredazione è ammissibile solo per gli eredi legittimi non i legittimari. È anche valido il testamento con sola clausola di diseredazione. C’è però una piccola apertura però, anche se il libro delle successioni è il più statico, su una forma di diseredazione che comprende anche i legittimari. Il 448bis dice che il figlio può diseredare il genitore decaduto dalla responsabilità e quindi diseredare un legittimario anche per fatti diversi da quelli che indicano l’indegnità. Secondo qualcuno apre alla possibilità che per fatti gravi pur non di indegnità si possa procedere per diseredazione di un legittimario. È l’elaborazione della dottrina che lo dice, non il testo. La preterizione questa è diversa dalla diseredazione perché prevede che il testatore inserisca nella determinati soggetti escludendone altri che rimangono omessi e quindi esclusi. Lezione 15 diritto privato mod b ACCETTAZIONE E ACQUISTO DELL’EREDITÀ L’acquisto dell’eredità interviene con l’accettazione. In attesa che il delato accetti si configura uno stato di incertezza e di giacenza cioè questo complesso di beni, patrimonio, si trova in uno stato di attesa del suo titolare. Ha quindi bisogno di essere gestito, per comprendere come viene gestito e quali sono le regole di amministrazione e di gestione dobbiamo distinguere a seconda che il delato sia o meno nel possesso dei beni ereditari. - - Se il delato è nel possesso dei beni ereditari allora l’amministrazione spetta a lui, avrà l’onere di compiere entro tre mesi l’inventario ed entro 40 giorni dovrà dichiarare di accettare con beneficio di inventario, altrimenti sarà erede puro e semplice. Il delato in possesso dei beni può esercitare le azioni possessorie e compiere atti conservativi, addirittura essere autorizzato a vendere i beni se mantenimento è dispendioso. Se invece il delato non è nel possesso dei beni ereditari potrà accettare in un termine di dieci anni l’eredità e su di lui in realtà non grava un onere di gestione e amministrazione ma sarà necessario nominare un curatore e sarà in uno stato di giacenza. L’eredità in questa condizione è detta vacante; questa si presenta come un patrimonio avente la sua individualità nei confronti degli altri soggetti di diritto. In questo momento di incertezza in cui non si sa se il titolare sarà il figlio delato o il coniuge eccetera opera la disciplina della giacenza. La giacenza dell’eredità viene innanzitutto disciplinata: il tribunale su istanza di chi vi abbia interesse o d’ufficio nomina un curatore dell’eredità giacente. La nomina del curatore sotto il profilo effettuale comporta come conseguenza la privazione degli ordinari poteri di amministrazione che spetterebbero al chiamato che non ha ancora accettato, il quale potrà comunque in casi eccezionali di urgenza o per evitare un danno compiere personalmente alcuni atti ove occorra appellandosi alla gestione di affari altrui del 2028 o comunque gli atti di vigilanza. I poteri di amministrazione e di gestione si spostano sul curatore. Da questa nomina, inoltre, si verifica un effetto di separazione del patrimonio ereditario che diventa patrimonio autonomo aggregato intorno alla funzione di liquidazione, come era il fondo patrimoniale un patrimonio aggregato intorno all’interesse della famiglia. Il curatore provvede al pagamento dei debiti ereditari e dei legati previa autorizzazione del giudice. SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO Alla fine del mandato dovrà rendere conto della gestione, la fine dell’incarico coincide con l’accettazione dell’eredità. Per evitare i tempi lunghi che possono derivare dai termini di accettazione allora chiunque abbia interesse può chiedere la fissazione di un termine: actio interrogatoria. La fissazione del termine è nei confronti del delato affinché manifesti l’intenzione di accettare o meno l’eredità. Se non presta la dichiarazione presta il diritto di accettare e scattano i chiamati di grado ulteriore. La forma dell’accettazione è un negozio unilaterale, recettizio, puro, irrevocabile, indivisibile e con efficacia retroattiva erga omnes. Si può impugnare entro 5 anni per violenza ma non per errore. Il presupposto è quello della capacità di agire, non si possono dunque accettare le eredità devolute ai minori non emancipati e agli interdetti, se non da chi esercita la responsabilità genitoriale con beneficio di inventario. Per minori emancipati e inabilitati serve il consenso del curatore. Esistono tre forme di accettazione: espressa, tacita, presunta. La prima è la dichiarazione di accettazione oppure l’assunzione della qualità di erede in atto pubblico o scrittura privata, per il beneficio di inventario serviranno rafforzate formalità. Tacita invece quando non c’è un’assunzione espressa del titolo ma si compie un atto che presuppone la volontà di accettare. È un atto che non ha il contenuto meramente di gestione conservativa, ma un atto dispositivo di un bene dell’eredità o di diritto dell’eredità. L’accettazione presunta invece coincide con la vendita/donazione/cessione dei diritti successori, oppure la rinunzia verso corrispettivo o a favore di alcun soltanto. Queste comportano accettazione presunta (detta acquisto legale dell’eredità) perché la rinunzia a titolo gratuito o verso tutti gli altri è già un effetto legale coincidente con l’accrescimento che non ha bisogno della volontà del disponente. Mentre nell’accettazione tacita si può provare che l’atto aveva una finalità diversa dall’accettazione come l’evitare un danno al patrimonio ereditario, nella presunta lasciano intendere l’accettazione assoluta, non c’è margine di prova contraria. GLI EFFETTI DELL’ACCETTAZIONE E LA RINUNCIA DELL’EREDITÀ Con l’accettazione pura e semplice dell’eredità si verifica la fusione del patrimonio personale dell’erede con quello del defunto. Si parla dunque di consolidazione, sulla base della disciplina della confusione per le obbligazioni presenti. L’erede risponde anche dei debiti ereditari oltre l’attivo dell’eredità quindi i creditori del defunto diventato creditori dell’erede. La rinuncia all’eredità invece, detta anche rinuncia abdicativa è l’atto con cui il delato respinge la sua qualità di erede. Occorre la capacità di agire, per il minore decide dunque il genitore o negli altri casi è il curatore. La rinuncia deve farsi con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale dove si è aperta la successione. La rinuncia si presume quando a termine fissato il delato non risponda. I caratteri della rinuncia ricalcano in gran parte quelli dell’accettazione: pura, assoluta, indivisibile. Non è però sempre irrevocabile. La rinuncia dell’eredità opera retroattivamente quindi chi è stato chiamato si considera come mai chiamato. Nelle successioni legittime la parte di colui che rinuncia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunciante. Nelle testamentarie si apre la delazione successiva. Il chiamato all’eredità nel possesso dei beni ereditari può rinunciare entro tre mesi dall’apertura della successione, termine decorso il quale dovrà considerarsi erede puro e semplice. Se uno rinuncia a danno dei suoi creditori questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità al suo posto per soddisfare i loro crediti. Lezione 16 diritto privato mod b LA SUCCESSIONE LEGITTIMA SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO Ai sensi dell’articolo 457 del Codice civile l’eredità si devolve per legge o per testamento. I soggetti che la legge designa per ricevere l’eredità sono detti successibili. La successione legittima ha quindi titolo nella legge mentre quella testamentaria ha titolo nel testamento, queste sono le fonti che determinano i delatari nei due casi, perché la disciplina di apertura eccetera è sempre la stessa prevista dal codice. La successione legittima ha luogo quando manca per tutto o in parte la successione testamentaria. Quindi bisogna alla morte del soggetto verificare se questi abbia lasciato o meno il testamento, se non l’ha lasciato si apre la legittima che devolve interamente il patrimonio del de cuius. Quindi l’esclusione della successione legittima avviene quando il testatore devolve tutto il patrimonio all’erede a titolo universale. Altre ipotesi è quando le disposizioni a titolo universale siano nulle, annullabili o rinunziate se non ci sono i presupposti per la delazione successiva, quando testamento è costituito solo da legati. La successione legittima è quindi composta da norme giuridiche dispositive e prende anche il nome di successione ab intestato o intestata. Questa opera nel caso in cui il testamento sia nullo o inefficace, qualora sia prescritto il diritto del chiamato o sia indegno ecc. La successione legittima opera a titolo universale, soltanto in alcuni casi particolari vengono attribuiti legati legittimi che realizzano una successione a titolo particolare. Il legato legittimi non è un vero e proprio legato perché non è destinatario di una disposizione negoziale di ultima volontà, ma si applica la disciplina del legato. Esempi di legato ex lege sono (1) l’attribuzione della casa coniugale al coniuge superstite e l’utilizzo dei mobili. La corte dice che è da considerarsi come prelegato quindi il valore va stralciato a monte dal patrimonio. La seconda categoria (2) è l’assegno vitalizio del coniuge separato che abbia diritto agli alimenti anche con addebito con sentenza passata in giudicato se no si tratta come coniuge. Altra ipotesi (3) è quella del coniuge divorziato che ha diritto ad assegno divorzile e sia in stato di bisogno. Ultimo (4) è vitalizio figlio non riconoscibile. LE CATEGORIE DEI SUCCESSIBILI L’articolo 565 del codice individua le categorie dei successibili: coniuge, discendenti, ascendenti, collaterali, altri parenti e allo stato. Prescindendo dalla posizione del coniuge si distinguono in genere tre ordini successori: - I figli Gli ascendenti con i fratelli e le sorelle Gli altri parenti in linea collaterale sino al sesto grado, in cui il grado più prossimo esclude il successivo La logica è che la chiamata dei figli esclude quella degli ascendenti e così via. IL CONIUGE: Prima della riforma del 75 il coniuge concorreva con i figli per una quota di usufrutto sull’eredità. Ad oggi il coniuge si trova in una posizione privilegiata rispetto ai figli, a questo è devoluta una porzione dell’eredità non inferiore ad un terzo. In generale se il de cuius non ha figli, ascendenti o fratelli e sorelle il patrimonio è completamente devoluto al coniuge, in presenza invece il coniuge concorre. Se ha un solo figlio metà al figlio e metà al coniuge se ha più figli un terzo al coniuge e il resto diviso. Se invece non ci sono figli il coniuge concorre con gli altri e mantiene i due terzi del patrimonio del de cuius. Resta in ogni caso il diritto di abitazione. Tutti questi diritti spettano anche al coniuge separato a condizione che non gli sia stata addebitata la separazione. Se gli è stata addebitata invece ha solo diritto ad un assegno vitalizio se godeva degli alimenti. In caso di divorzio vengono meno i diritti successori. SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO IL CONVIVENTE MORE UXORIO: La legge non menziona il convivente more uxorio nella categoria dei successibili e la figura del convivente non è equiparabile a quella del coniuge. La corte ha giustificato dicendo che il diritto successorio individua i rapporti giuridici tra i parenti e il de cuius e gli altri soggetti; pertanto, il rapporto di mera convivenza non dà luogo a un rapporto giuridico è un semplice rapporto di fatto e non dà luogo a diritti successori. Gli unici casi di riconoscimento del convivente more uxorio sono la successione nel contratto di locazione e l’abitazione in caso di morte del proprietario già citati in ambito di unione di fatto. I PARENTI: I parenti come detto si dividono in tre ordini. Il primo ovvero quello dei figli comprende tutti anche quelli nati fuori dal matrimonio e quelli adottivi. I figli succedono al padre e alla madre in parti uguali e conseguono l’intera eredità in assenza del coniuge. Per quelli non riconosciuti invece si prevede un vitalizio pari alla rendita se la filiazione fosse stata riconosciuta. I soggetti appartenenti al secondo ordine cioè gli ascendenti, i fratelli e le sorelle succedono in assenza dei figli. Se mancano persino i genitori e i fratelli succedono gli ascendenti entro il sesto grado per metà della linea paterna e metà di quella materna. I fratelli consanguinei o uterini perseguono solo la metà della quota che prendono i fratelli germani. Ai parenti collaterali entro il sesto grado si devolve l’eredità in assenza di genitori o ascendenti, fratelli e sorelle e i loro discendenti. LO STATO: In mancanza di successibili l’eredità è devoluta allo Stato. La ratio è la necessità che l’eredità non rimanga vacante. Questa non ha bisogno di accettazione ma opera di diritto, automaticamente. Lo sato è erede necessario, succede al de cuius ex lege senza però rispondere dei debiti ereditari. Questo è possibile quando il de cuius muoia senza lasciare chiamati per legge o per testamento oppure che quelli rimasti siano indegni. Se invece lo stato viene nominato come erede opera come tutti gli altri eredi. SUCCESSIONE LEGITTIMA E SUCCESSIONE NECESSARIA La categoria degli eredi legittimi è diversa da quella dei legittimari. I presupposti della successione legittimaria trovano applicazione solo quando siano lese le quote legittime, ovvero quando il testatore non abbia destinato o abbia destinato meno di quanto spetti al legittimario. I legittimari sono quei soggetti che la legge riserva anche contro la volontà del de cuius una quota di eredità e sono il coniuge, i figli e gli ascendenti. IL CONCORSO TRA DELAZIONE LEGITTIMA E DELAZIONE TESTAMENTARIA Quando su uno stesso patrimonio si aprono sia la successione legittima che la testamentaria si aprono due delazioni. Tendenzialmente il chiamato per testamento deciderà se accettare o meno l’eredità e allo stesso modo il chiamato ex lege. È possibile però che uno stesso soggetto venga chiamato a succedere sia per legge sia per testamento (esempio testatore lascia un sesto del patrimonio al figlio, non specifica per i restanti cinque sesti e rimangono in vita coniuge e figlio stesso). Si pone quindi il problema di determinare se in favore del chiamato a doppio titolo operino due distinte delazioni o la stessa. Se la delazione è considerata come una unica il chiamato con la rinuncia rinuncerà ad entrambe così come nell’accettazione. In dottrina si è quindi sviluppata la teoria che si tratti di un’unica delazione complessa ma anche di due delazioni distinte. Si tende però a far prevalere la teoria dell’unicità e il fatto che se il chiamato accetta l’eredità per delazione legittima e poi si scopre il testamento allora si considera accettata anche la delazione testamentaria. L’erede sarà tenuto a pagare i legati solo intra vires ereditatis (?). SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO Bisogna invece tenere distinte le delazioni a titolo universali con quelle a titolo particolare, queste non hanno titolo diverso sulla base della legge o del testamento come le precedenti, sono indipendenti. Se il testatore ha lasciato ad un soggetto successibile ex lege un legato le due delazioni rimangono distinte. LA COINCIDENZA TRA DELAZIONE LEGITTIMA E DELAZIONE TESTAMENTARIA Diversa dall’ipotesi del concorso tra le due delazioni è quella della coincidenza tra queste due. Questa si verifica quando il de cuius con testamento designi eredi dei soggetti che siano anche suoi legittimi successibili nelle stesse identiche quote che la legge devolverebbe loro in assenza di testamento. Esempio: Tizio per testamento devolve la metà del patrimonio al figlio unico e la metà alla moglie. Ci si chiede dunque se in questi casi operi la successione legittima o testamentaria. La disciplina delle due, trovandosi in libri diversi del Codice civile, non è la stessa, sebbene il contenuto non vari indipendentemente da quale delle due operi. La giurisprudenza più recente sostiene che si tratti di successione testamentaria poiché tendenzialmente si fa luogo alla legittima solo quando manchi la testamentaria. Se invece il de cuius dichiari semplicemente che la sua volontà è che i beni siano ripartiti secondo quanto previsto dalla legge allora ci si domanda se questa sia una successione legittima oppure una disposizione di volontà del testatore. Essendo pur sempre una manifestazione della volontà del de cuius la vocazione dovrebbe considerarsi testamentaria. Lezione 17 diritto privato mod b LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA Il testamento è l’atto revocabile con il quale un soggetto dispone per il tempo in cui avrà cessato di vivere di tutte le proprie sostanze o parti di esse (articolo 587 cc) È un atto gratuito mortis causa, revocabile e unilaterale. Il testamento deve essere revocabile ad arbitrio del testatore in quanto ha rilevanza l’espressione dell’ultima volontà dello stesso. È un carattere essenziale del testamento e si considera tale solo quell’atto che sia revocabile. Il testamento inoltre è un atto essenzialmente unipersonale. È nullo il testamento collettivo ossia quello fatto da due o più persone in un unico testo a vantaggio di un terzo (testamento congiuntivo) o per disposizione reciproca (testamento mutuo). Non è un atto recettizio perché i suoi effetti non dipendono dalla ricezione dell’atto da parte di terzi. L’interpretazione del testamento deve essere improntata al rispetto della volontà del testatore. Per i giudici di legittimità la volontà di quest’ultimo va individuata con riferimento ad elementi intrinseci nella scheda testamentaria stessa. L’oggetto delle disposizioni testamentarie è il complesso di rapporti patrimoniali facenti capo al testatore. Il testatore può decidere di disporre tutte le sostanze o solo parti di esse, in quanto i beni non compresi sono devoluti per successione legittima. La successione testamentaria può designare eredi e/o legatari. Il testamento può avere poi contenuto atipico, cioè quando ha ad oggetto un contenuto non patrimoniale come il riconoscimento del figlio. Il testamento deve essere fatto da persona capace di testare, altrimenti è annullabile su impugnazione di chiunque ne abbia interesse. La capacità di testare deve essere presente nel momento in cui si è fatto testamento, dunque, non rileva una eventuale incapacità sopravvenuta. Sono dunque incapaci di testare: - I minorenni Gli interdetti SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO - Incapaci di intendere e di volere anche temporaneamente Il maggiorenne inabilitato è invece capace di testare senza l’intervento del curatore perché è un atto personalissimo. All’incapacità di ricevere per testamento si applicano invece le regole dell’incapacità a succedere e il testamento può essere fatto solo ad un capace di ricevere. Vi sono poi alcune incapacità relative come il testamento di persona sottoposta a tutela in favore del tutore quando sia stato fatto dopo la nomina di questo. Sono però valide le disposizioni fatte a favore del tutore che sia ascendente, discendente, coniuge, fratello o sorella del testatore. Sono nulle le disposizioni a favore della persona che abbia redatto il testamento segreto e quelle a favore del notaio a cui siano state consegnato in plico non sigillato. Gli incapaci non possono ricevere neanche sotto il nome di interposta persona, si tratta di una questione di incompatibilità che vige solo nella successione testamentaria e non anche nella legittima come l’indegnità. LE FORME DEL TESTAMENTO Il testamento può essere ordinario oppure speciale. I testamenti ordinari si dividono in testamento olografo e testamento notarile, mentre quelli speciali costituiscono forme semplificate del testamento pubblico consentiti in determinate circostanze. Il testamento verbale in generale detto nuncupativo è considerato inesistente, DEVE ESSERE REDATTO PER ISCRITTO. IL TESTAMENTO OLOGRAFO: il testamento olografo deve essere redatto per iscritto per intero, datato (giorno mese e anno) e sottoscritto di mano del testatore. Non è previsto l’intervento del pubblico ufficiale, la scrittura è l’unica prova di autenticità del testamento. Non deve però essere indicato il luogo. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni e non deve per forza indicare nome e cognome. La mancanza di data determina l’annullamento e la prova della non verità della data è ammessa solo per dimostrare l’incapacità del testatore o della priorità di data tra più testamenti. È indifferente il tipo di substrato e di inchiostro o altro materiale con cui questo si scrive. Chi non sa scrivere ma sa leggere può fare testamento segreto. Un inconveniente è il fatto che questo non essendo custodito dal notaio è soggetto a smarrimento. IL TESTAMENTO NOTARILE: Il testamento notarile si è detto può essere pubblico o segreto. - - Nel testamento pubblico il notaio riceve direttamente le dichiarazioni di volontà dal testatore e le mette per iscritto. Questo deve essere ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni, il testatore dichiara la sua volontà e il notaio scrive. Il testamento deve indicare il luogo, la data, l’ora, la sottoscrizione del testatore dei testimoni e del notaio. Se incapace di leggere quattro testimoni, se sordo o muto si applica disciplina relativa. In questo caso il notaio riceve solamente la scheda in cui il testatore dichiara che il contenuto sia il suo testamento. Questo testamento detto segreto o in passato mistico può essere redatto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore è sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni mentre se scritto da altri o meccanicamente deve essere firmato ad ogni mezzo foglio unito o separato. La segretezza sta nel fatto che la carta su cui è scritto deve essere sigillata con un’impronta in guisa che questo non possa essere estratto senza rottura o alterazione. Vi sono poi altre formalità come la consegna del testamento sigillato in presenza di due testimoni o il farlo sigillare in presenza dei testimoni dal notaio. Dopo la morte del testatore il testamento olografo e quello segreto vanno pubblicati, la pubblicazione non è un requisito per l’efficacia ma è indispensabile per produrlo in giudizio. Per il testamento olografo chiunque ne sia in possesso al momento della morte deve presentarlo ad un notaio, per quello segreto è SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO invece il notaio che al momento della morte lo pubblica. Il notaio, dunque, comunica la pubblicazione agli eredi e ai legatari di cui conosce il domicilio o la residenza. TESTAMENTI SPECIALI I testamenti speciali sono forme di testamento pubblico con una particolare semplificazione che riguarda sia l’abilitazione a riceverlo sia le formalità previste. Ve ne sono tre tipi: - - - Il testamento redatto in presenza di malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni. In questi casi il testatore non può avvalersi delle forme ordinarie allora il testamento è valido se ricevuto da un notaio, dal sindaco, da un ministro di culto in presenza di due testimoni. Il testamento è redatto e sottoscritto da chi lo riceve, dal testatore e dai testimoni. Perde di efficacia entro tre mesi dalla cessazione della causa di impedimento della redazione classica. Il testamento durante viaggio per mare ricevuto a bordo della nave dal suo comandante o a bordo di un aeromobile. È redatto in duplice copia e al momento di arrivo devono entrambe essere consegnato all’autorità marittima locale. Perde efficacia in tre mesi dallo sbarco in luogo in cui sia possibile fare testamento nelle forme ordinarie Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello stato. Questo può essere ricevuto da un ufficiale da un cappellano, da un ufficiale in Croce Rossa in presenza di due testimoni. Possono testare solo coloro che si trovino in zone belliche o sono prigionieri presso il nemico. Perde efficacia dopo il ritorno del testatore in luogo dove sia possibile fare testamento secondo le modalità ordinarie. NULLITÀ E ANNULLABILITÀ DEL TESTAMENTO PER DIFETTO DI FORMA I concetti di nullità e di annullamento non sono esattamente sovrapponibili a quelli contrattuali. Il testamento è nullo quando manchi l’autografia o la sottoscrizione in caso di testamento olografo, ove manchi la redazione per iscritto da parte del notaio delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell’uno o dell’altro in caso di testamento per atto di notaio. Il testamento segreto che manchi di un requisito suo proprio ha validità come testamento olografo qualora ne abbia i requisiti. L’azione di nullità spetta a chiunque ed è imprescrittibile. L’azione di annullamento è prevista per ogni altro difetto di forma e si prescrive in cinque anni. Altre cause di annullamento sono l’incapacità o i vizi della volontà del testatore. IL CONTENUTO DEL TESTAMENTO Innanzitutto, vi sono una serie di norme comuni all’eredità e al legato: la designazione dell’erede o del legatario, il motivo delle disposizioni testamentarie e gli elementi accidentali. La designazione dell’erede e del legatario (detto anche onorato) deve essere fatta con certezza, è nulla qualsiasi che non possa essere determinata. Le disposizioni a favore dell’anima sono valide qualora siano determinati i beni o la somma da impiegarsi a tal fine (tipo messe mensili in memoria). Anche le disposizioni a favore dei poveri sono valide anche se non si designi l’istituto e si prendono per beneficiari i poveri del luogo in cui il testatore aveva domicilio al tempo della morte. L’ordinamento invece vede con sfavore le disposizioni rimesse all’arbitrio del terzo, cioè quelle disposizioni con cui si fa dipendere dall’arbitrio dell’erede o del legatario la determinazione della quota dell’eredità o l’oggetto del legato. Vi è poi il cosiddetto divieto di prova della fiducia, cioè quando viene fatto un accordo segreto tra erede e testatore che preveda che il fiduciario possa portare la volontà del testatore e nominare un altro erede o legato chiamato fedecommissario. SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO I motivi di disposizioni testamentarie sono le ragioni soggettive che hanno condotto il testatore a designare un erede e non hanno di solito rilevanza giuridica. Tuttavia, il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria qualora si tratti dell’unico motivo per cui il testatore ha disposto. Il motivo illecito riguarda la singola disposizione a cui si riferisce. In generale la disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque qualora vi sia stato errore, violenza o dolo. Per quanto riguarda il dolo ci si riferisce anche alla cosiddetta captazione cioè la suggestione del testatore. L’errore sul motivo è causa di annullamento quando sia l’unico per cui il testatore abbia deposto. Azione si prescrive in cinque anni. Gli elementi accidentali infine sono la condizione e l’onere. Ogni disposizione testamentaria può essere fatta sotto condizione sospensiva o risolutiva. Si pensi ad esempio all’istituzione della condizione che l’erede presti assistenza fino alla morte del testatore. Il codice però detta alcune norme riguardo alla pendenza della condizione. Se la condizione è risolutiva l’autorità giudiziaria può imporre all’erede o al legatario di prestare idonea garanzia a favore di coloro ai quali l’eredità dovrebbe devolversi nel caso in cui la condizione si avverasse. Vale poi il principio della retroattività della condizione. La condizione infine è illecita se contraria a norme imperative, ordine pubblico o buon costume. Sono inoltre illecite: la condizione di reciprocità e la condizione che impedisce le nozze. Nelle successioni testamentarie si considerano come non apposte le condizioni impossibili e quelle illecite. L’onere invece dà semplicemente luogo ad una disposizione modale. IL CONTENUTO DEL TESTAMENTO: LE REGOLE DEI LEGATI Il legato è qualunque attribuzione patrimoniale che non comporti la designazione di un erede. È un atto di liberalità ma è diverso dalla donazione perché oltre all’arricchimento del donatario sono imposti oneri che determinano in capo al legatario un sacrificio non inferiore al guadagno. I soggetti del legato possono essere chiamati legatari o onorati e quello che lo presta l’onerato o il gravato e quello che lo ordina il testatore. L’onorato del legato può essere chiunque abbia la capacità di ricevere per testamento. Nel caso di prelegato il legatario è anche erede, ha diritto di conseguire per l’intero quanto previsto a suo favore dalla disposizione a titolo particolare, ha diritto anche alla propria quota ereditaria. Si considera però prelegato solo quando la disposizione è a carico dell’eredità. L’onerato è l’erede. Il testatore però può imporre la prestazione anche ad uno o più legatari (sublegato). Quando il testatore non ha disposto alla prestazione sono tenuti tutti gli eredi in proporzione alla propria quota. L’oggetto del legato è un diritto su un bene, una condotta obbligatoria o un beneficio consistente nella liberazione da una obbligazione. Il legato è nullo quando la cosa sia incerta o quando si lascia all’arbitrio dell’onerato. Il legato di specie (efficacia reale) attribuisce il diritto di proprietà su una cosa determinata o un altro diritto esistente nel patrimonio del testatore. Può esserci poi il caso in cui il legato sia di cosa appartenente solo in parte al testatore, questi può consegnare tramite legato solo la sua parte. Il legato di credito (efficacia reale) infine è quello con cui il testatore lascia un credito al legatario che ha verso un terzo, cessione di credito mortis causa. La stessa disciplina si applica per il legato di liberazione del debito (effetti reali, remissione mortis causa) con cui libera il legatario da un debito che ha verso di lui. Infine, il legato di debito, adempimento mortis causa. Esistono poi i legati ad effetti obbligatori, all’apertura della successione sorge un’obbligazione in capo all’onerato, come il legato di contratto (obbligo di stipulare) o legato di cosa dell’onerato o del terzo, lega una cosa che non è sua. Nel legato di genere invece si ha ad oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili esistenti o meno nel patrimonio del de cuius. Il legatario acquista anche SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO l’eventuale diritto ai frutti naturali e civili. Nel legato alternativo poi la scelta spetta all’onerato a meno che il testatore non l’abbia lasciata al legatario o al terzo. Per quanto riguarda la revoca e l’estinzione del legato sussistono le cause generali di revoca del testamento e delle disposizioni testamentarie. Esistono però anche delle cause specifiche di revoca del legato. - L’alienazione che il testatore faccia della cosa legata o parte di essa revoca il legato. Lo stesso avviene se il testatore abbia trasformato la cosa legata in un’altra. Il perimento totale della cosa. LA SOSTITUZIONE, LA RAPPRESENTAZIONE ED IL DIRITTO DI ACCRESCIMENTO Può succedere che l’erede o il legatario non possano o non vogliano raccogliere l’eredità o il legato. Il primo meccanismo previsto dall’ordinamento è quello della delazione successiva. - - - - La sostituzione. Occorre subito differenziare tra sostituzione diretta e indiretta. La prima detta anche volgare, si ha quando un testatore dopo aver designato l’erede si preoccupa di nominare un’altra persona qualora la prima non accetti l’eredità. Questa si può definire come un’istituzione condizionale ed è sempre ammessa nei casi in cui l’erede non possa o non voglia accettare l’eredità. La sostituzione può prevedere anche più persone oppure può prevedere che colui che sostituisce sia già uno dei coeredi. È possibile questo tipo di sostituzione anche per il legato Quella indiretta invece detta anche fedecommissaria comporta due successioni in sequenza tra loro. Sono richieste però tre condizioni: una duplice successione, l’imposizione all’erede da parte del testatore di conservare e trasmettere i beni all’altra persona e la previsione che il trasferimento avvenga alla morte del primo erede. L’istituito può essere soltanto un figlio, un discendente o il coniuge interdetto, i sostituiti invece sono coloro che hanno cura dell’interdetto. Sui beni che formano oggetto della sostituzione l’istituto ha una proprietà vincolata: questo ha il pieno godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione. Sono applicabili le norme dell’usufrutto. Queste norme sono applicabili anche per i legati. La successione per rappresentazione. Questa disciplina è anche denominata delazione successiva. Questa accade quando non vi sia testamento. È richiesto in particolare che vi siano determinati rapporti di parentela in particolare si deve trattare del figlio o del fratello, devono poi sussistere dei rapporti di parentela tra il primo chiamato e i soggetti che succedono per rappresentazione al suo posto si deve trattare dei discendenti o del primo chiamato. L’indicazione è tassativa. Questa opera anche per il legato. L’accrescimento. Il primo presupposto è che il soggetto da sostituire sia stati chiamato con altri coeredi. In questo caso la sua quota viene attribuita agli altri coeredi. Le altre condizioni sono che i coeredi siano stati chiamati per quote uguali e con lo stesso testamento. L’accrescimento ha luogo anche nel caso di più collegatari. L’applicazione della successione legittima. Il sistema la prevede come una disciplina di chiusura che permetta di assicurare una sorte all’eredità mancante che si devolve in questo caso agli eredi legittimi. Nel caso del legato va a profitto dell’onerato. L’ESECUTORE TESTAMENTARIO E LA REVOCAZIONE DEL TESTAMENTO Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari e può anche autorizzarli a sostituire altri a sé stessi. L’esecutore deve curare che siano eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto. A tal fine questi devono amministrare la massa ereditaria prendendo possesso dei beni che ne fanno parte; devono SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO amministrare come buon padre di famiglia e compiere gli atti di gestione. Il testatore può predisporre che l’esecutore che non sia erede o legatario proceda con la divisione dei beni dell’eredità. L’esecutore deve rendere conto della sua gestione al termine della stessa. È un ufficio gratuito ma il testatore può prevedere una retribuzione a carico dell’eredità. Il testamento è revocabile come già detto fino all’ultima espressione di volontà del testatore. La revoca espressa può avvenire con un testamento posteriore o uno speciale atto notarile. La revocazione fatta con testamento posteriore deve essere fatta in presenza di due testimoni. Il codice prevede anche la revocazione della revocazione. La revoca tacita avviene in tre casi: quando il testamento posteriore contenga disposizioni incompatibili con il precedente, quando il testatore ritiri dalle mani del notaio il testamento segreto NON QUELLO OLOGRAFO, per quello olografo deve avvenire la distruzione. Il codice infine prevede alcune ipotesi di revoca di diritto, ad esempio, le disposizioni fatte a ascendenti o discendenti perdono valore quando vi sia stato un successivo riconoscimento del figlio. Lezione 18 diritto privato mod b LA SUCCESSIONE NECESSARIA Nella successione necessaria bisogna anzitutto sottolineare la rilevanza del vincolo familiare in modo più assoluto: al coniuge, ai figli e agli ascendenti è devoluta anche contro la volontà del testatore parte del suo patrimonio. Sono i legittimari o successori necessari. Si deve distinguere la quota disponibile da quella indisponibile. Si qualifica porzione legittima la parte che spetta a loro anche contro la volontà dell’ereditando mentre si discute di porzione indisponibile quando si guarda dalla parte dell’ereditando e si vede esclusa dalla disponibilità una porzione di patrimonio. È ammessa invece la cautela sociniana… I legittimari sono il coniuge, i figli, gli ascendenti 536 cc. Cominciando dal coniuge che non abbia altri concorrenti questi ha diritto a metà del patrimonio se non gli sia stata addebitata la separazione, altrimenti ha diritto ad un assegno vitalizio alimentare nel caso in cui godeva degli alimenti. Oltre alla quota legittima al coniuge superstite sono riservati i diritti di abitazione della casa familiare. Passando ai figli se il genitore lascia un figlio solo a questo è riservato metà del patrimonio se non ha concorrenza di altri legittimari. È stata abrogata la disciplina sul diritto di commutazione secondo cui i figli all’interno del matrimonio potevano soddisfare in denaro la porzione dei figli naturali. Se c’è anche coniuge un quarto a lui, metà ai figli e l’altro quarto rimane disponibile. Giungendo agli ascendenti a questi è riservato un terzo del patrimonio. Nel caso del concorso fra più di queste figure: - - Nel concorso tra coniuge e figli se chi muore lascia oltre che al coniuge un solo figlio allora questo ha diritto ad un terzo del patrimonio e un terzo spetta al coniuge. Se sono più di uno spetta la metà e l’altra metà al coniuge. Nel concorso tra coniuge e ascendenti in mancanza di figli il coniuge ha diritto a metà del patrimonio e gli ascendenti ad un quarto. È escluso il concorso tra figli e ascendenti perché in presenza di figli questi non hanno diritto alla legittima. IL CALCOLO DELLA LEGITTIMA SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO Non si può affermare che la legittima sia stata lesa se non si conosce l’entità della stessa. Il calcolo deve considerare anche eventuali donazioni del de cuius in vita. Il procedimento è il seguente: si determina il relictum cioè il valore patrimoniale netto lasciato dal de cuius, al relictum, togliendo i debiti, poi si sommano le donazioni fatte dal de cuius in vita ovvero il donatum. Questa operazione è detta riunione fittizia, poiché compiuta virtualmente. Al valore risultante si calcola la quota che spetta in base ai vari concorsi tra legittimari. Se la donazione però viene fatta al legittimario quando il de cuius è in vita questa si considera un’anticipazione della legittima quindi si parla di imputazione ex se ovvero si somma il valore della donazione a quanto il legittimario riceve per successione. In generale bisogna tenere come riferimento la situazione esistente al momento dell’apertura della successione. La successione necessaria è intangibile quindi non è toccata da eventuali pesi posti dal testatore e le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari. Il rimedio che l’ordinamento prevede è l’azione di riduzione. L’AZIONE DI RIDUZIONE PER LESIONE DELLA LEGITTIMA Il legittimario che lamenti la lesione della sua legittima ha diritto all’azione di riduzione. I soggetti che possono chiedere la riduzione sono i legittimari, i loro eredi o gli aventi causa. Esiste un ordine per l’azione di riduzione, sono colpite in primo luogo le quote legali ab intestato, poi le disposizioni testamentarie, le quali vengono diminuite proporzionalmente. Qualora queste non bastino si procede alla riduzione delle donazioni cominciando dall’ultima e risalendo alle anteriori. L’azione si prescrive in dieci anni. Qualora l’azione venga accolta gli effetti sono quelli di restituzione in tutto o in parte del bene. Una specifica disciplina è dettata per la riduzione del legato e della donazione di immobili in questi casi la riduzione si fa separando dall’immobile stesso la parte per integrare la quota riservata. (?) Entro i limiti stabiliti dal codice la restituzione può essere chiesta anche nei confronti degli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione. In realtà la disciplina è stata modificata nel 2005 ed è stato stabilito un particolare diritto per il coniuge che ha atto di opposizione alla donazione. I terzi invece hanno la facoltà di liberarsi dall’obbligo di restituire pagando in denaro l’equivalente. IL LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA ED IL LEGATO IN CONTO DI LEGITTIMA Nell’ipotesi in cui il legittimario sia beneficiario di un legato la posizione è diversa a seconda che sia un legato in sostituzione o in conto di legittima. Per il legato in sostituzione di legittima questo viene dichiarato dal testatore stesso. Il legato così perde il diritto alla legittima. Per quello invece in conto di legittima il legatario può conservare il legato e chiedere in più la legittima, viene data per scontato. POSSIBILE ASSENZA DELLA QUALITÀ DI EREDE IN CAPO AI LEGITTIMARI Vi sono delle ipotesi in cui i legittimari siano anche eredi: - Il legittimario è pretermesso cioè non viene considerato nel testamento ma con azione di riduzione acquista la qualità di erede Il testatore nomina il legittimario come erede, quindi è erede testamentario oppure legatario Il legittimario non diventa erede e neppure successore a titolo particolare, questo può avvenire nel caso in cui le donazioni in vita abbiano sostituito la sua legittima oppure quando il patrimonio del de cuius sia inesistente a causa delle donazioni fatte in vita dallo stesso. SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO Lezione 19 diritto privato mod b I RAPPORTI TRA L’EREDE E I TERZI i rapporti tra l’erede e i terzi vanno inquadrati secondo la seguente suddivisione: rapporti tra eredi e i possessori, rapporti tra eredi e i creditori dell’eredità e i legatari. RAPPORTI TRA EREDI E POSSESSORI Quando i diritti dell’erede sono lesi da colui che possieda i beni l’erede ha diritto alla petizione di eredità cioè chiede il riconoscimento giudiziale della sua qualità ereditaria contro chiunque possieda allo scopo di ottenere la restituzione. Ha alcuni tratti comuni con l’azione di rivendicazione, una volta accolta il convenuto deve restituire il bene. L’erede può rivolgere l’azione anche contro i terzi in alcuni casi però l’ordinamento protegge il terzo acquirente: se ha acquistato a titolo oneroso, da erede apparente in buona fede e se abbia acquistato beni mobili non registrati o beni immobili e mobili registrati e sia stata rispettata la trascrizione (cioè trascrizione deve essere anteriore alla nascita del titolo di erede). RAPPORTI TRA EREDI E CREDITORI Nel caso di accettazione pura e semplice avviene la confusione dei patrimoni ereditari e la consolidazione dei diritti reali eventuali. La legge consente all’erede di accettare l’eredità con beneficio di inventario cioè di tenere separato il suo patrimonio dagli eventuali debiti che acquista, distinzione e separazione dei patrimoni, l’erede conserva i diritti e gli obblighi nei confronti del defunto e li avrà nei confronti dell’eredità. È obbligatoria per persone giuridiche ad eccezione delle società e incapaci. Questa facoltà spetta all’erede legittimo ma anche al testamentario, nonostante qualunque divieto del testatore. Il codice prevede alcune formalità essenziali per l’accettazione con beneficio di inventario. Serve una dichiarazione dal notaio o dal cancelliere del tribunale dove si è aperta la successione entro un mese dall’inserziona la dichiarazione deve essere trascritta. La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario. È previsto dunque che il chiamato all’eredità quando a qualsiasi titolo sia nel possesso di beni ereditari debba fare l’inventario entro 6 mesi dall’apertura ed entro 40 giorni deve decidere se accettare o meno, per coloro che invece non siano nel possesso finché il diritto di accettare non sia prescritto. Gli effetti sono la distinzione tra patrimonio dell’erede e patrimonio del defunto: l’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e obblighi che aveva verso il defunto, l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni a lui pervenuti, i creditori dell’eredità hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede. Intra vires paga i creditori, con le sole sostanze dell’eredità e nei limiti di queste. L’erede con beneficio di inventario ha l’obbligo di amministrare i beni ereditati e pagare creditori e legatari. Questi decade dal beneficio di inventario se aliena o ipoteca i beni ereditati senza l’autorizzazione, qualora vi sia colpa o dolo oppure denunci passività inesistenti con mala fede. Uno dei principali benefici è il pagamento dei creditori ereditari. L’erede ha a disposizione tre possibilità per liquidare il patrimonio: - Dopo un mese dalla trascrizione l’erede quando i creditori e i legatari non si oppongono paga i creditori e legatari a misura che si presentano, ovviamente i creditori ipotecari e pignoratizi hanno la precedenza. Se arriva un creditore per ultimo e non c’è più niente si attacca. SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO - - Se c’è opposizione entro un mese egli non può eseguire i pagamenti ma deve liquidare l’eredità, liquidazione concorsuale che garantisce che salve le cause legittime di prelazione i creditori chirografari vengono soddisfatti in par condicio creditorum. Attuata a mezzo di notaio e con invito formale a tutti i creditori di fare dichiarazione di credito Ultima possibilità è quella di rilasciare i beni a creditori e legatari, nomina di curatore che si comporterà come l’erede quindi dichiarazioni di credito, liquidazione, attribuzione delle somme I creditori dell’eredità hanno diritto a far separare il patrimonio dell’erede da quello del de cuius al fine di soddisfarsi sul patrimonio di questo con preferenza rispetto ai creditori dell’erede, che possono soddisfarsi sui beni del defunto solo quando sono soddisfatti i creditori dell’eredità. Per evitare il concorso i primi hanno il beneficio della separazione. Questa corrisponde a ragioni di giustizia. Dal punto di vista creditorio il diritto alla separazione deve essere esercitato entro tre mesi dall’apertura della successione e l’erede non può impedirlo. Può essere esercitato sempre sia per soddisfarsi prima nel caso di accettazione semplice sia per decadenza del beneficio. L’oggetto non è l’intero patrimonio ereditario ma i singoli beni che lo compongono. Il diritto alla separazione dei beni mobili si esercita tramite domanda giudiziale proposta con ricorso al tribunale. Per i beni immobili si procede con l’iscrizione del credito sui beni stessi. Comunque, i creditori dell’erede possono soddisfarsi sui beni ereditari del defunto dopo i creditori separatisti sui beni separati, i creditori separatisti e non del defunto si soddisfano anche sui beni dell’erede, l’effetto principale è che i creditori e i legatari separatisti si soddisfano sul patrimonio separato con preferenza rispetto ad ogni altro creditore o legatario. I creditori come regola generale sono preferiti ai legatari. È uno schermo rispetto ai creditori dell’erede Per possessore entro 40 giorni, per non possessore entro 3 mesi ma entro 40 giorni dall’inventario. Lezione 20 diritto privato mod b I RAPPORTI TRA COEREDI Fra coeredi si instaura rispetto ai beni facenti parte dell’eredità una comunione incidentale finché non avviene la divisione ereditaria. La comunione non riguarda però i beni ereditari che si dividono automaticamente tra gli eredi in proporzione alle quote. Quanto ai crediti invece questi rientrano nella comunione ereditaria quindi ciascun erede può agire direttamente sui debitori per la porzione che rappresenti la sua quota o per l’intero. Nei rapporti interni vale la regola per cui i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti, mentre nei rapporti esterni ciascuno può essere costretto a pagare solo la sua parte del debito. Il coerede che sia creditore del de cuius conserva la qualità di chiedere il pagamento del suo credito sottratta la parte che deve sopportare come erede. Quanto al coerede debitore del de cuius invece al fine di assolvere la sua obbligazione può sottrarre la quota che riceve come erede. La donazione del coerede avente ad oggetto un bene indiviso è nulla così come la vendita che è inefficace. IL DIRITTO DI PRELAZIONE DEI COEREDI I coeredi sono titolari del diritto di prelazione. Quando uno di essi voglia alienare un bene deve procedere con denuntiatio e i coeredi hanno diritto di prelazione per l’acquisto rispetto a terzi. Se questo non viene esercitato entro due mesi dall’ultima notificazione, o in mancanza della notificazione in ogni caso hanno tale diritto fino allo scioglimento della comunione ereditaria (retratto successorio). Non è soggetta a prelazione o retratto successorio l’alienazione dell’esito divisionale, si fa riferimento qui a ciò che viene SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO attribuito all’esito della divisione ereditaria all’alienante; quindi, è già stata sciolta la comunione incidentale. IMPEDIMENTI E SOSPENSIONE DELLA DIVISIONE E I TIPI DI DIVISIONE I coeredi possono sempre domandare la divisione dell’eredità. Il testatore può disporre però che la divisione non abbia luogo se non prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età se presente un erede minore. Oppure può disporre che debba passare del tempo dopo la sua morte non oltre i cinque anni. Vi sono dei casi però di impedimento alla divisione dell’eredità, questa non può avvenire: - Prima della nascita del concepito se erede Durante la pendenza di un giudizio sulla filiazione Per il diritto d’autore se il testatore non ha disposto diversamente per tre anni dalla morte La sospensione della divisione invece può avvenire su istanza del giudice se l’immediata esecuzione può recare pregiudizio ad uno dei coeredi. LA DIVISIONE CONVENZIONALE: La divisione convenzionale può essere ad opera del testatore oppure contrattuale: - - Nella divisione ad opera del testatore è il testatore stesso a indicare come sono divisi i beni ai vari eredi. Quella che non abbia compreso i legittimari è nulla. Si può escludere la costituzione di una vera e propria comunione ereditaria poiché se disposta dal testatore la divisione opera facendo entrare nel patrimonio degli eredi direttamente i beni al momento dell’apertura della successione, senza che avvenga la divisione vera e propria. Il testatore inoltre può dare direttive sulla divisione stabilendo particolari norme vincolanti per gli eredi. Oppure può disporre che la divisione avvenga secondo la stima di persona da lui designata. La divisione contrattuale. Questa prevede tra i coeredi un vero e proprio contratto di divisione che se riguarda beni registrati è soggetto a trascrizione. Questo contratto è soggetto alla disciplina generale con alcune particolarità: la divisione può essere annullata per violenza o dolo, può essere rescissa quando uno dei coeredi provi di essere stato leso oltre il quarto quindi si deve procedere ad una stima dei beni. Le parti possono dare mandato ad un notaio per far sì che questi predisponga un progetto divisionale. LA DIVISIONE GIUDIZIALE: Mancando un accordo fra i coeredi gli stessi possono ricorrere alla divisione giudiziale. La domanda deve essere proposta nei confronti di tutti gli eredi e si procede nel seguente modo: innanzitutto si procede con una stima dei beni, successivamente si procede con la formazione delle porzioni. Le porzioni devono essere formate comprendendo una quantità di beni mobili, immobili e crediti in proporzione all’entità di ciascuna quota. L’ineguaglianza delle quote si compensa con un conguaglio ovvero in denaro e a garanzia del pagamento di questo si prevede l’ipoteca legale del condividente. Le porzioni sono quindi formate dal giudice o dal notaio delegato dal giudice, che non richiede il consenso dei condividenti. Si procede con estrazione a sorte se le quote sono uguali o all’attribuzione se non sono uguali. GLI EFFETTI DELLA DIVISIONE E LA GARANZIA TRA I COEREDI La divisione ha effetto retroattivo e il coerede è considerato dal codice come l’immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o i beni pervenuti per successione. Vi sono poi alcune regole particolari per la costituzione dell’ipoteca sui beni indivisi. Il coerede può costituire ipoteca sulla quota a lui spettante SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO oppure sui beni che riceverà a seguito della successione, in questo caso se i beni ipotecati non gli vengono assegnati si ha il trasporto di ipoteca. I coeredi devono garantire fra loro per le molestie e evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione. Se uno dei coeredi subisce l’evizione il valore del bene deve essere ripartito tra tutti i coeredi in proporzione. LA COLLAZIONE Accade di sovente che il de cuius abbia fatto delle donazioni in vita ai più stretti congiunti quindi coniuge e discendenti. In questo caso le donazioni vengono considerate come delle anticipazioni della quota ereditaria dovuta. Per questi motivi la legge prevede l’obbligo della collazione cioè conferimento, i coniugi e i discendenti che concorrono come eredi devono conferire tutto ciò che hanno ricevuto dal de cuius per donazione a meno che il de cuius non li abbia dispensati (dispensa dalla collazione, in atto separato dalla donazione). I soggetti che hanno diritto ad esigere la collazione sono i coeredi che essendo anch’essi figli o coniuge avrebbero diritto a prestarla. Oggetto della collazione invece sono le donazioni dirette ma anche quelle indirette. Quanto ai modi di esecuzione essa si fa in natura o per imputazione (prende dalla massa tanti beni in meno quanto è il valore di quelli donati che mantiene). La collazione di un bene immobile si fa per natura o per imputazione a scelta di chi conferisce mentre quella dei beni mobili si fa solo per imputazione. Il problema della giurisprudenza riguardo alla collazione è quello delle donazioni indirette di immobili, se si ritiene che oggetto della donazione sia un bene immobile il donatario deve imputare alla propria quota il valore del bene al momento dell’apertura della successione. Se diversamente si ritiene che l’oggetto sia il denaro allora questi è tenuto a conferire solo l’importo ricevuto. Infine, per quanto riguarda la differenza tra collazione e riduzione riconosciamo che la collazione opera soltanto tra i coeredi discendenti e il coniuge mentre la riduzione comprende solo la possibilità di salvare la quota legittima. IL PATTO DI FAMIGLIA Il patto di famiglia è stato introdotto nel corpus del codice al fine di consentire al titolare dell’impresa di anticipare il momento del trasferimento dell’azienda a quei discendenti meritevoli o con più attitudini alla gestione di impresa. Questa sembrerebbe da un lato una disposizione dell’eredità precedentemente alla morte ovvero un patto dispositivo o rinunciativo. È stata dunque operata una deroga dall’ordinamento. Innanzitutto, il patto di famiglia è un contratto redatto per atto pubblico a pena di nullità con cui l’imprenditore conferisce ai discendenti in parte o per tutto le proprie quote in materia di impresa familiare o delle sue partecipazioni sociali. Sul concetto delle partecipazioni sociali le interpretazioni sono diverse, alcuni ritengono che ne facciano parte tutti i trasferimenti altri comprendono solo i trasferimenti di controllo o gestione dell’impresa. Gli assegnatari possono essere soltanto i discendenti anche se i legittimari potrebbero contestare la lesione della loro quota. Quindi la legge prevede che al contratto debbano partecipare anche i legittimari, la non partecipazione determina nullità. È possibile che rinuncino. Qualora comunque non vi sia una rinuncia i partecipanti al contratto che non siano assegnatari hanno diritto di essere liquidati con il pagamento corrispondente al valore delle quote di cui sono titolari. La liquidazione può avvenire anche in natura. Può succedere infine che con il patto il disponente oltre che trasferire la gestione d’azienda ad un discendente, assegni ad altri determinati beni che sono imputati alla quota della legittima. Ciò che è stato ricevuto dai contraenti non è soggetto a riduzione o collazione, finisce per essere cristallizzato. Anche se i legittimari possono chiedere ai beneficiari il pagamento della somma prevista SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO aumentata degli interessi. Questa norma si riferisce ai legittimari sopravvenuti come la seconda moglie, non quelli che devono prendere parte al contratto. Questo patto può essere sciolto o modificato mediante diverso contratto oppure mediante recesso se previsto da contratto stesso. Lezione 21 diritto privato mod b COGNOME FAMILIARE L’unica fonte che riguarda l’attribuzione del cognome è quella consuetudinaria. Risale al diritto romano e al medioevo, in fondo alla gerarchia delle fonti. Viene utilizzato per individuare ascendenza e discendenza del soggetto, è patrilineare, cioè per consuetudine si attribuisce il cognome del padre. Sebbene la fonte sia una fonte non scritta in molte disposizioni del codice questa consuetudine viene confermata. La disciplina del cognome riguarda l’identità della persona e la personalità. Articoli 2, 3, 29, 117. Convenzione del 2005 che riguarda le discriminazioni nei confronti delle donne. Nel 2021 la questione è stata rimessa alla Corte costituzionale, il tribunale di Bolzano sottopone alla corte una questione di legittimità dell’articolo 262 cc, che prevede che al figlio si attribuisce il cognome di chi lo abbia riconosciuto e se lo riconoscono insieme quello del padre. A Bolzano un tedesco e un’italiana volevano dare al figlio il cognome solo della madre, in Germania è possibile. L’ufficiale dello stato civile rifiuta di trascrivere l’atto perché contrario all’ordine pubblico italiano, il tribunale allora rinvia la questione alla Corte e ritiene che l’acquisizione del cognome alla nascita avvenga unicamente sulla base di una discriminazione fondata sul sesso dei genitori anche in presenza di una diversa volontà comune. Questa questione era già stata sollevata più volte. Il giudice ha sempre dichiarato l’inammissibilità di giudizi su tali argomenti, dicendo che fosse così delicato da lasciare spazio al legislatore, è una questione politica. Il legislatore non è mai intervenuto, la Corte allora con una sentenza nel 2016 si è pronunciata sulla illegittimità di questi articoli, li dichiarano incostituzionali nella parte in cui non prevedono la possibilità di attribuire il cognome materno anche di comune accordo. La disciplina sul cognome ha quindi subito una lieve innovazione: rimane la consuetudine del cognome paterno ma è possibile con comune accordo attribuire anche il cognome materno. In altri paesi si può scegliere il cognome. I diritti tutelati sono il diritto a tramandare le proprie origini e la dignità. In seguito all’azione di disconoscimento il figlio perde il cognome del padre, in realtà vi è un bilanciamento tra il favor veritatis e l’interesse del figlio alla conservazione dell’identità personale che può scegliere di mantenere il cognome. Vi era un disegno di legge del governo Letta, che prevedeva che i genitori potevano attribuire secondo la loro volontà il cognome del padre, della madre o di entrambi. In caso di mancato accordo si attribuivano entrambi in ordine alfabetico. La disciplina matrimoniale cioè il diritto di porre il cognome del coniuge non comporta modifiche anagrafiche, così come nelle unioni civili. LE DONAZIONI La donazione è il contratto con cui per spirito di liberalità una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. Il donante può avere l’usufrutto dei beni donati o riservarlo a suoi successori. SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO La donazione pur essendo un contratto è disciplinata dopo le successioni nel Codice civile. Nelle donazioni la particolarità è che non si deve consegnare un corrispettivo per l’arricchimento. Però non ogni atto di liberalità è una donazione; lo spirito di liberalità è l’assenza di costrizione giuridica o morale di chi dispone. È possibile però che le liberalità non corrispondano con uno spirito umanitario cioè possono esserci donazioni remunerative, è comunque liberalità perché il donante è libero nel suo gesto. Non sono invece liberalità le elargizioni che si fanno in conformità agli usi, come i regali tra familiari. L’ubbidienza agli usi, infatti, fa escludere la liberalità. Nella stessa categoria delle liberalità appartengono anche alcuni atti unilaterali come la remissione del debito o altri contratti come fideiussione prestata per pura liberalità. Infine, esistono anche le liberalità non donative, dette donazioni indirette. Le caratteristiche riguardano la gratuità dell’atto, cioè la causa, anche se non tutti gli atti gratuiti sono atti di liberalità ovviamente come socio che rinuncia al suo credito verso la sua società. Negli atti gratuiti vi è un interesse patrimoniale. Quindi le caratteristiche di una donazione sono: - Liberalità dell’atto, cioè assenza di costrizione Natura non patrimoniale dell’interesse Contratto LE DISPOSIZIONI GENERALI Le prime due norme previste sono la definizione del contratto di donazione e l’azione remuneratoria, cioè donazione che viene posta in essere per motivi di riconoscenza, per i meriti del donatario, o per speciale remunerazione. Rilevanza importante ha poi la donazione di beni futuri, questa è nulla salvo che si tratti di frutti non ancora separati. Quando l’oggetto è una universalità di cose si considerano parte anche quelle trattenute presso il donante che si aggiungono successivamente. È nulla la donazione di beni altrui. La donazione che ha per oggetto prestazioni periodiche si estingue alla morte del donante e quella fatta a favore di più donatari si intende fatta per parti uguali. La capacità di donare trova il suo presupposto nella capacità di disporre pienamente i propri beni. La persona fatta da incapace di disporre dei propri beni è nulla. Quella fatta dall’inabilitato può essere annullata. I genitori e i tutori non possono donare per la persona incapace ed è nullo il mandato a donare. È nulla la donazione al tutore o protutore del donante. Per la capacità di riceverla può essere fatta a favore di chi sia stato concepito o figli non ancora concepiti di una persona vivente al momento della donazione. Sono capaci di ricevere ovviamente anche le persone giuridiche. LA FORMA DELLA DONAZIONE La donazione richiede una particolare forma ovvero atto pubblico a pena di nullità. È richiesta la presenza di due testimoni. L’accettazione può essere fatta nell’atto stesso oppure atto pubblico posteriore, notificata al donante. Deve dunque essere scritta se non per il caso della donazione di modico valore per cui basta la traditio. La donazione poi può essere posta a condizione. La disciplina più particolare è quella della donazione obnuziale ovvero quella fatta per un futuro matrimonio. La nullità del matrimonio comporta la nullità della donazione. Altra condizione è il patto di ritorno o condizione di reversibilità, cioè si stabilisce che i beni tornino al donante allorché muoia il donatario. La donazione modale invece riguarda la presenza di un onere o modo, il donatario è vincolato a adempiere all’onere previsto; quello illecito o impossibile si considera non apposto. SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO L’inadempimento del donante è sottoposto a regole meno stringenti rispetto a quelle della disciplina generale del contratto cioè in caso di inadempimento si è responsabili solo per dolo o colpa grave. Anche per l’evizione la disciplina è meno gravosa, il donante è tenuto a garanzia solo se l’ha espressamente proposta, se dipende da dolo o dal fatto personale di lui o se si tratta di una donazione che impone un onere al donatario o remuneratoria. INVALIDITÀ E REVOCA La donazione è invalida quando vi sia un errore sul motivo della donazione o il motivo sia illecito. La donazione può essere revocata per ingratitudine o sopravvivenza dei figli, ha un carattere personale, quindi, non può essere revocata dai creditori del donante. La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere prevista se non per ingiuria, rifiutato di dare alimenti o creato grave pregiudizio verso di lui. Esempio classico è la relazione adulterina del beneficiario. Quanto ai termini e alla legittimazione ad agire questa deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi entro un anno dalla conoscenza. Le donazioni compiute da chi non aveva o ignorava di avere figli possono essere revocate per sopravvivenza dei figli o la loro esistenza. Deve essere proposta entro il termine di 5 anni dalla nascita dell’ultimo figlio o dalla notizia, cioè il riconoscimento. Per quanto concerne gli effetti della revocazione questi impongono che il donatario debba restituire i beni in natura e i frutti a partire dal giorno della domanda. Quanto ai terzi la revoca non pregiudica gli acquisti con data anteriore alla trascrizione. LE DONAZIONI REMUNERATORIE E QUELLE PER MATRIMONIO SONO IRREVOCABILI Lezione 22 diritto privato mod b LA PUBBLICITÀ IMMOBILIARE E LE TRASCRIZIONI Gli atti generalmente soggetti a trascrizione hanno la caratteristica comune di produrre effetti costitutivi, modificativi, traslativi, estintivi della proprietà o di altri diritti relativi a beni immobili. Tipo atti che costituiscono ecc usufrutto o superficie, i diritti dell’enfiteuta eccetera previsti all’articolo 2643 cc. Questi atti servono a rendere conoscibili ai terzi l’avvenuto compimento dell’atto secondo una funzione che prende il nome di pubblicità dichiarativa. Questa se mancata non rende l’atto nullo (costitutiva), ha la funzione di opponibilità ai terzi. È il modo più rilevante per la pubblicità cioè il rendere noto a terzi alcuni fatti, atti o negozi giuridici o provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Vi sono una pluralità di strumenti come gli archivi informatici dello stato civile i registri immobiliari, delle persone giuridiche eccetera. I registri immobiliari permettono di dare pubblicità a fatti estintivi, costitutivi e traslativi della proprietà e altri diritti reali (esclusione della locazione ultranovennale trascritta) I caratteri sono i seguenti: natura dichiarativa + base personale, poiché gli atti sono trascritti sotto il cognome e nome delle persone interessate. La pubblicità dichiarativa serve a risolvere il conflitto tra più aventi causa dello stesso bene, non ha rilevanza la data antecedente dell’acquisto ma la data antecedente della trascrizione. La trascrizione viene utilizzata non per dare efficacia costitutiva all’atto ma per comprendere e far comprendere ai terzi chi ha acquistato quel diritto. SOFIA FLOCCO, A.A. 2021/2022, APPUNTI PROF. MIGLIACCIO Al fine di provvedere all’esigenza di ordine pubblico economico i registri immobiliari sono costituiti sulla base del principio di continuità delle trascrizioni. Nel caso in cui l’acquisto sia soggetto a trascrizione tutte le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell’acquirente non producono effetti se non è stato scritto l’atto anteriore di acquisto. Ogni trascrizione è contro o a favore di una persona. Tipo ipoteca contro Mario Rossi sull’immobile… Casi importanti in cui avviene la trascrizione: - - - Contratti preliminari, funzione prenotativa Atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela, ovvero quegli atti che destinano alcuni beni mobili o immobili a persona con disabilità, pubbliche amministrazioni o altri enti. (?) Vincoli di uso pubblico, pubblicità notizia, discussa Divisioni Rapporti patrimoniali tra coniugi, di natura dichiarativa, ma con effetti di pubblicità notizia a volte, devono essere trascritti atti relativi a beni immobili, fondo patrimoniale, beni esclusi dalla comunione legale. Atto d’acquisto dell’eredità e del legato Cessione dei beni ai creditori Domande giudiziali, alcune tassativamente indicate come risoluzione dei contratti o esecuzione in forma specifica di contrarre ecc, funzione prenotativa Ha pubblicità costitutiva e non dichiarative la trascrizione quando avviene in relazione all’acquisto di un bene immobile tramite l’usucapione abbreviata formata da titolo astrattamente idoneo, buona fede e trascrizione. (!!!)