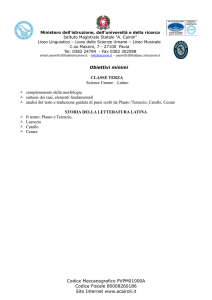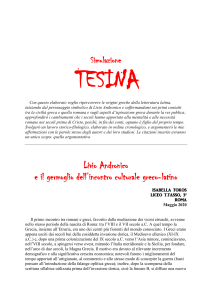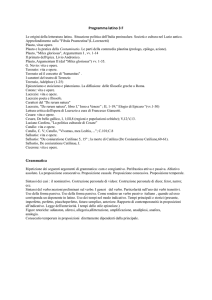caricato da
Isabella Tokos
Livio Andronico e l'influenza greca sulla letteratura latina

Simulazione TESINA Con questo elaborato voglio ripercorrere le origini greche della letteratura latina, iniziando dal personaggio simbolico di Livio Andronico e soffermandomi sui primi contatti tra la civiltà greca e quella romana e sugli aspetti d’ispirazione greca durante la res publica; approfondirò i cambiamenti che i secoli hanno apportato alla mentalità e alle necessità romane nei secoli prima di Cristo, poiché, in fin dei conti, ognuno è figlio del proprio tempo. Svolgerò un lavoro storico-filologico, elaborato in ordine cronologico, e argomenterò le mie affermazioni con le parole stesse degli autori e dei loro studiosi. Le citazioni inserite avranno un unico scopo: quello argomentativo. Livio Andronico e il germoglio dell’incontro culturale greco-latino ISABELLA TOKOS LICEO T.TASSO, 3° ROMA Maggio 2020 Il primo incontro tra romani e greci, favorito dalla mediazione dei vicini etruschi, avvenne nello stesso periodo della nascita di Roma: tra l’VIII e il VII secolo a.C. A quel tempo la Grecia, insieme all’Etruria, era uno dei centri più fiorenti del mondo conosciuto. I Greci erano appena usciti dai secoli bui della cosiddetta invasione dorica, il Medioevo ellenico (XI-IX a.C.) e, dopo una prima colonizzazione del IX secolo a.C. verso l’Asia minore, cominciavano, nell’VIII secolo, a spingersi verso ovest, mirando l’Italia meridionale e la Sicilia, per fondare, nell’arco di due secoli, la Magna Grecia. Il motivo era dovuto al rilevante incremento demografico e alla significativa crescita economica; notevoli furono i miglioramenti del tempo apportati all’artigianato, al commercio e allo stesso modo di concepire la guerra (basti pensare all’introduzione della falange oplitica greca); inoltre, dopo la scomparsa della scrittura sillabica utilizzata prima dell’invasione dorica, cioè la lineare B, si diffuse una nuova scrittura alfabetica, derivata dall’alfabeto (già in uso dal XIII secolo a.C.) dei Fenici, con cui la Grecia si trovava in contatto per motivi commerciali: “Nel corso dell’VIII secolo, quando lasciarono le loro terre per conquistare nuovi spazi in Italia e in Sicilia, i Greci avevano già un alfabeto, mutuato da quello fenicio ma molto più complesso, con cinque vocali e un numero di lettere ancora non omogeneo, che variava da 24 a 26 a seconda delle regioni. La stessa discrepanza continuò ai tempi della Magna Grecia, quando ogni colonia sviluppò un proprio alfabeto per le stesse ragioni per cui coniò una propria moneta: affermare, difendere e mantenere la propria autonomia.” (Alberto Angela, Alexis, un mercante in Magna Grecia, pagina 120) Fu a partire dall’VIII secolo a.C., poi, che si cominciarono a delineare le prime caratteristiche delle πόλεις, le città-stato. La Grecia stava ormai manifestando sempre di più la sua mancata unità politica e linguistica, diventando un territorio frammentato dominato da una miriade di διάλεκτοι. “Dai secoli bui le testimonianze della lingua passano quasi di botto dall’indoeuropeo ai vari dialetti greci. Cosa sia accaduto in mezzo, si può sintetizzare così: conquiste, mutamenti della società, lotte di potere, invasioni, cambio di classi intellettualmente egemoni.” (Andrea Marcolongo, La lingua geniale – 9 ragioni per amare il greco, pagina 14) E nonostante ciò, il popolo greco era unificato, seppure non formalmente, da una mentalità simile, dallo stesso pantheon, così come dalle stesse abitudini: simposi, olimpiadi panelleniche in onore degli Dei e, soprattutto, una letteratura comune. Inizialmente, una letteratura orale comune, affidata a personaggi chiave all’interno delle società greche, i detentori della cultura greca: gli aedi. Essi avevano il compito di intrattenere con le loro storie, spesso a suon di cetra (ma anche di altri strumenti musicali) un pubblico, che fosse il popolo o dei simposiasti; a seconda del proprio uditorio, erano in grado di variare i loro racconti, facendo affidamento su un vasto bagaglio culturale nonché sui miti preesistenti dei luoghi dell’esecuzione; la diversità dei dialetti era superata dall’impiego di una lingua artificiale, una fusione di più dialetti (principalmente lo ionico, misto a elementi eolici e/o attici). Durante le pubbliche festività, in particolare, ad essere cantati erano i poemi epici. Opere molto complesse in esametri, i poemi epici avevano una buona presa sul pubblico, rispecchiandone la società: celebrando tramite vari miti, spesso intrecciati, gesta eroiche del popolo greco o di eroi greci, gli interventi delle divinità a favore o contro i protagonisti,… e di tanto in tanto inserendo qualche favola (un genere letterario trasversale, presente cioè in molti generi letterari e che non trova la sua indipendenza prima di Esopo), allo stesso tempo fungevano da modello educativo: essi erano, infatti, fonte di esempio per il retto agire, sancendo le regole del comportamento per un buon cittadino greco: in una comunità come quella greca, in cui la società e il parere dei concittadini aveva un peso enorme, entrava in scena il ‘culto della vergogna’ (shame culture): “Per shame culture, alla luce anche delle successive indagini, devono intendersi le società nelle quali il rispetto delle regole non viene ottenuto attraverso l’imposizione di divieti. […] Nelle «culture di vergogna» l’osservanza delle regole è ottenuta attraverso la proposizione di modelli positivi di comportamento, e coloro che non si adeguano a questi modelli incorrono nel biasimo sociale («vergogna» in senso oggettivo) e in una sensazione di inadeguatezza («vergogna» in senso soggettivo).” (Eva Cantarella, “Sopporta, cuore…” – La scelta di Ulisse, pagina 9-10) I poemi epici insegnavano, quindi, cosa fare e cosa non fare. Offrivano esempi positivi di eroi coraggiosi e guerrieri, che non si abbandonavano alla codardia ma affrontavano con convinzione il loro destino, e anche di anti-eroi, come, ad esempio la figura di Tersite, l’antitesi di un onorevole combattente greco, “αἴσχιστος δὲ ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον ἦλθε” cioè “il più spregevole, fra tutti i venuti all’assedio di Troia” [Iliade, II, v. 216. Traduzione: Giovanni Cerri], in evidente contrasto con la concezione greca del καλὸς καὶ ἀγαθός, ‘bello e buono’. Ma, tramite i poemi epici, ai Greci veniva detto anche di combattere e morire piuttosto che scappare ed essere additati, se stessi e i famigliari, come vigliacchi per il resto della vita, come si può notare nell’Iliade, nel discorso tra il principe troiano Ettore e sua moglie Andromaca: Ἠ καὶ ἐμοὶ τάδε πάντα μέλει γύναι· ἀλλὰ μάλ᾽ αἰνῶς αἰδέομαι Τρῶας καὶ Τρῳάδας ἑλκεσιπέπλους, αἴ κε κακὸς ὣς νόσφιν ἀλυσκάζω πολέμοιο· οὐδέ με θυμὸς ἄνωγεν, ἐπεὶ μάθον ἔμμεναι ἐσθλὸς αἰεὶ καὶ πρώτοισι μετὰ Τρώεσσι μάχεσθαι ἀρνύμενος πατρός τε μέγα κλέος ἠδ᾽ ἐμὸν αὐτοῦ. [Iliade, VI, vv. 441-446] “Donna, anch’io, sì, penso a tutto questo; ma ho troppo rossore dei Teucri, delle Troiane lungo peplo, se resto come un vile lontano dalla guerra. Né il mio cuore vuole, perché ho appreso a essere forte sempre, a combattere in mezzo ai primi Troiani, al padre procurando grande gloria e a me stesso.” [Iliade, VI, vv. 441-446. Traduzione: Rosa Calzecchi Onesti] L’onore e la gloria, infatti, si conquistavano con la guerra, tornando, come dicevano gli Spartani, con lo scudo o sullo scudo: “Τέκνον, ἢ τὰν ἢ ἐπὶ τᾶς.” (Ἀποφθέγματα Λακωνικά, Plutarco), una frase anonima che secondo lo scrittore bizantino Giovanni Stobèo (Ἀνθολόγιον, III, 7, 30) era stata pronunciata dalla regina spartana Gorgo mentre porgeva lo scudo al figlio, ricordandogli il suo dovere da guerriero e cittadino spartano e ribadendogli di dover ritornare o vivo, con lo scudo in mano, o morto e, quindi, trasportato sopra lo scudo, ma mai vivo e senza scudo, segno evidente di diserzione. Erano questi i principali messaggi inviati con l’ascolto di poemi come i poemi omerici (l’Iliade e l’Odissea, i primi a noi giunti e quelli meglio conservati) o come i restanti sei poemi del Ciclo epico (chiamato anche troiano, a causa della tematica intorno alla quale si svolgono la maggior parte delle azioni: la guerra di Troia, il casus belli, gli avvenimenti posteriori così come le vicissitudini di vari eroi coinvolti). Ma non esistevano soltanto questo tipo di poemi, spesso di autori leggendari o anonimi (e/o, forse, di un intero popolo), dedicati esclusivamente alla guerra: entrambi poemi didascalici, la Teogonia e le Opere e i giorni di Esiodo (il primo autore greco di nostra conoscenza, vissuto tra l’VIII e il VII secolo a.C., ad aver ‘firmato’ le sue opere dichiarando nei suoi versi il proprio nome e descrivendo la sua investitura poetica durante l’incontro con le Muse sul Monte Elicone) sono un evidente esempio. Il primo è la declinazione della genealogia divina, una descrizione della cosmogonia e della teogonia, come attesta lo stesso titolo; il secondo, invece, dalla struttura molto più complessa, causato, forse, dalla moltitudine di tematiche affrontate, è una serie di miti, storie e consigli di ogni genere. Secondo la tradizione, i poemi erano stati per la prima volta messi per iscritto in modo ufficiale sotto il regno di Pisistrato, il tiranno illuminato, nel VI secolo a.C., ma chiaramente, era molto probabile che gli aedi si servissero anche prima della scrittura per annotare i propri versi nella fase della composizione. VI secolo a.C. Quello stesso secolo, quindi, in cui la Magna Grecia era al massimo della sua espansione e del suo splendore, mentre per Roma si era appena conclusa (nel 509 a.C.) l’età regia a favore della res publica. Ed è tramite le colonie, principalmente, che Romani e Greci si incontrarono, scambiandosi merci ma anche racconti (come la leggenda di Evandro o quella di Enea, che sarà poi alla base del mito sull’origine divina dei Romani, discendenti secondo la leggenda da Venere, madre di Enea, e da Marte, padre di Romolo), usi e costumi. Come i Greci, infatti, anche i Romani ponevano al di sopra dell’individualità la collettività, il bene comune, in una chiave forse più pragmatica e conservatrice. Alla res publica (Polibio avrebbe definito questa forma di governo mista dei Romani, che “più di ogni altro popolo, sono pronti a cambiare i loro usi e costumi e a imitare quelli che ritengono migliori” [Ἱστορίαι, VI, 25, 11], la forma di governo ideale: allo stesso tempo una monarchia, per la presenza dei due consoli, un’aristocrazia, a causa del senato e una democrazia per le assemblee comiziali) seguiva la famiglia, o meglio dire la gens di appartenenza, e soltanto dopo l’individuo. L’onore più grande, per un cittadino romano era essere un cittadino all’interno di una società, di una civitas, con diritti e doveri; per un Romano era fondamentale la fedeltà al mos maiorum, (il ‘costume degli avi’), la pietas (rispetto verso gli altri e devozione verso gli Dei), la gravitas (l’austerità del comportamento) e la fides (il mantenimento della parola data). E fu nel 240 a.C., subito dopo la Prima guerra punica (264-241 a.C.), che Livio Andronico giunse come schiavo greco a Roma, una città in cui la vita dei cittadini roteava esclusivamente intorno alle faccende di Stato, alla politica, alla guerra e a tutte le rimanenti attività che venivano denominate negotia; l’otium, invece, il tempo libero dedito allo svago, soprattutto letterario, era destinato solo agli schiavi stranieri o di umili origini, i cosiddetti scribae, in quanto ritenuta un’attività indegna per un cittadino o un magistrato romano. Non sarebbe stato un caso, infatti, che la prima letteratura latina fu nelle mani di stranieri come Livio Andronico (greco della Magna Grecia), Nevio (campano), Pacuvio (osco), Ennio (di Lecce, una zona influenzata da romani, oschi e greci), Plauto (umbro), Terenzio (africano), Cecilio Stazio (gallo)… L’età ellenistica (323 a.C, anno della morte di Alessandro Magno – 31 a.C., anno della battaglia di Azio) era già cominciata da circa un secolo e i filologi alessandrini avevano ormai intrapreso la loro attività di intenso studio letterario dei testi, non più orali ma interamente scritti. È in questo periodo che si cominciano a diffondere i libri, che cominciano a crearsi e ad arricchirsi grandi biblioteche; la più imponente fu la Biblioteca reale di Alessandria (d’Egitto), costruita nel 305 a.C., un importantissimo centro culturale antico. La letteratura greca, raffinatissima, era l’oggetto di maggiore studio presso i filologi alessandrini, e non conosceva pari. È questo, quindi, il contesto storico-culturale in cui spicca la figura di Livio Andronico, un grammaticus greco affrancato per i suoi meriti culturali, maestro di latino e di greco, autore di opere fondamentali, tra drammi (tra cui il primissimo dramma in lingua latina), carmina (ad esempio il carmina propitiatorum in onore di Iuno Regina, per placare la Dea prima dello scontro finale e decisivo del 207 a.C. al fiume Metauro contro i Cartaginesi nella Seconda guerra punica), poemi epici (basti pensare alla traduzione romanizzata, artistica, dell’Odissea)... Il suo non è semplicemente un ruolo di passaggio, ma Livio Andronico rappresenta l’origine stessa della letteratura latina legata a doppio filo da quella greca: con le sue traduzioni dal greco al latino (di drammi e della stessa Odissea) non pedisseque come potrebbe sembrare, ma sottoposte a un processo di aemulatio, di adattamento al gusto romano, ha permesso uno sbocco fondamentale sulla cultura greca, che ha decisamente offerto la spinta necessaria alla letteratura latina per sollevarsi, offrendo la dignità di chiamarsi poetae ai precedenti scribae. Fu Livio Andronico, quindi, che diede il via al dramma e all’epos in lingua latina. Ma, seguendo le sue orme, anche altri autori avrebbero contribuito in modo eccezionale a offrire alla cultura romana nuove opere prettamente latine, indipendenti, almeno in parte, dalle storie e dai miti greci, tra cui Gneo Nevio e Quinto Ennio. Gneo Nevio era un cittadino romano libero ma di condizione plebea, e presumibilmente sine suffragio (ossia senza diritto di voto), che (tra tutti i suoi mala carmina, cioè invettive contro alcune prestigiose famiglie della nobilitas romana, che lo portarono in carcere sancendo la sua morte) si impegnò a celebrare la prima vittoria sui Cartaginesi per mezzo di un poema epico-storico, il Bellum Poenicum, opera che descrive, fino alla guerra a cui lo stesso Nevio aveva partecipato, i fatti precedenti e successivi alla fondazione di Roma: la cosiddetta ‘archeologia’, che comprendendo anche i viaggi di Enea e la fine tragica del suo rapporto amoroso con Didone, la regina di Cartagine, forniva il casus belli della guerra tra le due città e, allo stesso tempo, legittimava Roma e la sua potenza come voluta dalle divinità. Mentre Nevio si era concentrato su un singolo evento della storia romana, Quinto Ennio, un poeta dalle tre anime, come egli stesso si definiva a causa del suo trilinguismo (parlava il greco, l’osco e il latino), scelse di impiegare le sue energie per un progetto molto più ampio, gli Annales. Il titolo, che indicherà lungo i secoli numerose opere, si rifà agli Annales (pontificis) maximi, cronache pubbliche in cui venivano annottati anno per anno, gli eventi più significativi che accadevano nella urbs (non solo in ambito sociale o politico, ma anche fenomeni naturali, come eclissi, epidemie…). In effetti, gli Annales di Ennio, un poema strutturato in ben 18 libri che tratta dettagliatamente la storia di Roma (spingendosi fino all’anno 178 a.C. con la guerra istrica), sfidano persino i canoni alessandrini della brevitas, esibendo al pubblico più di 15000 versi in continua espansione. Anche i contemporanei dei tre poeti cardine della letteratura latina riconoscevano il loro formidabile valore, tanto che la res publica cercò di ripagare i favori letterari con l’assegnazione di molti onori, tra cui quello di abitare sull’Aventino dove, durante la vita di Livio Andronico, venne istituito il collegium scribarum historiumque. Esso era un’associazione particolare che apriva le sue porte ad artisti come poeti o attori. La presenza di una vera e propria sede di cultura finanziata dallo Stato dimostra come la letteratura si fa sempre più spazio all’interno della società romana e come la res publica sente la necessità di trovare mezzi di controllo su forme di espressione come possono essere le opere letterarie e quelle teatrali. Soprattutto le ultime, quelle più a contatto con il popolo, rappresentavano un insostituibile strumento per comunicare con la plebs romana, permettendole, attraverso il teatro, strategici momenti di divertimento e di svago (per le commedie) o di riflessione (per le tragedie). Come per l’epos romano, anche il teatro romano guarda al mondo greco come a un modello. “I greci furono sempre amanti dei cortei. Ogni anno organizzavano solenni processioni in onore di Dioniso, il dio del vino . In Grecia tutti bevevano vino (l’acqua era ritenuta utilesolo per nuotarci o per navigarci), perciò Dioniso godeva di grande popolarità. E siccome si pensava che vivesse nei vigneti, circondato da un’allegra schiera di satiri (strani esseri per metà uomini e per metà capre), la gente che partecipava alla processione indossava pelli di capra e si metteva a belare. In greco, ‘capra’ si diceva tragos e ‘cantore’ oidos: e chi ‘cantava’ imitando il belato della capra veniva quindi chiamato tragos-oidos. Fu questo strano nome che si trasformò nella moderna parola ‘tragedia’, che nel senso teatrale indica un dramma a conclusione dolorosa o luttuosa, mentre la commedia indica un pezzo teatrale a lieto fine (e infatti in origine significava il cantare qualcosa di comos, cioè di ‘allegro’.” [Hendrik Willem van Loon, Storia dell’umanità, capitolo 17 – Il teatro greco, pagine 92-93] Come continua a spiegare nelle pagine successive l’autore Hendrik Willem van Loon, presto l’usanza del belare cominciò ad annoiare la folla che si radunava per assistere al rituale, così un giovane poeta attico propose uno scambio di battute: un membro del coro avrebbe dovuto staccarsi dal corteo e avrebbe dovuto dare avvio, gesticolando, a un dialogo sulla storia di Dioniso o di qualche altro Dio con il capo dei musicisti in testa al corteo, mentre i rimanenti membri del corteo avrebbero continuato a cantare. Il piano del giovane poeta ebbe successo e presto si spostò (anche su argomenti di tipo mitologico) in strutture erette appositamente per questa prima forma di spettacolo pubblico. “La tragedia divenne una parte essenziale della vita dei greci; la gente la prendeva con grande serietà e non si recava a teatro per semplice divertimento. La rappresentazione di un nuovo dramma costituiva un evento importante quanto le elezioni, e a un drammaturgo che aveva successo venivano riservati onori maggiori di quelli concessi a un generale di ritorno da una grande vittoria.” [Hendrik Willem van Loon, Storia dell’umanità, capitolo 17 – Il teatro greco, pagina 94] Certamente, non tutti i greci erano dello stesso parere. Filosofi come Platone, ad esempio, consideravano l’arte “l’imitazione di un’imitazione (μίμησις μιμήσεως) di tre gradi lontana dal vero” [Πολιτεία, 602c]: infatti riproducono elementi del mondo sensibile a loro volta copie delle idee dell’iperuranio. Per questa ragione, quindi, l’arte, anziché aiutare l’anima ad avvicinarsi al mondo delle idee, al mondo intellegibile, la incatena alle passioni e la corrompe sia mostrando ad essa individui abbandonati a istinti bassi e incontrollati (come nel caso della commedia), sia rappresentandole la realtà come soggetta esclusivamente al volere divino e al fato (come nelle tragedie). Di parere opposto, invece, era il suo allievo Aristotele. Per il filosofo greco, la tragedia era: “imitazione di un’azione seria e compiuta in se stessa, che abbia una certa ampiezza, un linguaggio ornato in proporzione diversa a seconda delle diverse parti, si svolga a mezzo di personaggi che agiscano sulla scena, e non che narrino, e infine produca, mediante casi di pietà o di terrore, la purificazione di tali passioni.” [Περὶ ποιητικῆς, 6, 1449b 20] Per Aristotele, quindi, la tragedia ha una funzione catartica, ovvero di purificazione dell’anima, oltre che, ovviamente, a un ruolo educativo e formativo. “Alcuni di quelli che sono dominati dalla pietà, dal timore o dall’entusiasmo, quando odono canti orgiastici come quelli religiosi, si calmano come per effetto di una medicina e di una catarsi. È necessario perciò che siano sottoposti a tale azione coloro che vanno soggetti alla pietà, al timore e in generale alle passioni, in modo conveniente a ciascuno, sicché in tutti si generi una catarsi e un alleggerimento piacevole.” [Περὶ ποιητικῆς,VIII, 7, 1342a] Con l’arrivo di Livio Andronico, anche Roma conosce in forma ufficiale il teatro. Ma è da presumere, secondo molte testimonianze, anche se tante controverse, che i Romani fossero già entrati in contatto con il mondo teatrale prima del 240 a.C. Tito Livio, ad esempio, narra (Ab Urbe condita, VII, 2) che nel 364 a.C. a causa di una pestilenza, alcuni ballerini etruschi furono chiamati per danzare “al suono di un flauto con movimenti armoniosi”, con lo scopo di onorare le divinità irate. Ciò di cui parlava Tito Livio erano le saturae, per gli studiosi difficili da inquadrare in precisi canoni. La denominazione viene solitamente fatta derivare dall’aggettivo satur, cioè ‘abbondante, farcito’. In effetti, l’etimologia del termine potrebbe rispecchiare questo tipo di ludus scaenicus: le satire erano, infatti, uno spettacolo misto, comprendendo danze, canti e musiche. E, “sebbene le satire fossero uno degli spettacoli prediletti dagli Etruschi (da qui, fra l’altro, deriverebbero anche i fescennini romani: messinscene in cui gli attori, mascherati, si scambiano battute e oscenità di vario genere), non erano certo l’unico. Molto amate erano anche le danze in costume e soprattutto le tragedie, in particolare quelle del drammaturgo greco Euripide (485-407 a.C.).” (Alberto Angela, La civiltà perduta degli etruschi, pagina 148) In ogni caso, prima di conoscere il teatro scritto greco, la cultura romana risente di moltissime influenze vicine: i Fescennini (motti giocosi ma a volte osceni, violenti e sfrenati, tipici delle feste per il raccolto o indirizzati a sposi durante le loro nozze), i già citati ludi scaenici etruschi, così come anche l’Atellana campana (spettacolo improvvisato e buffonesco, con personaggi stereotipati) e la farsa fliacica (chiamata anche ‘ilarotragedia’; era una parodia dei miti tragici, o di scene di vita quotidiana). Con l’avvento del vero e proprio teatro romano, i drammi cominciarono a essere messi in scena in occasione delle feste pubbliche (i cosiddetti ludi). Sin dall’inizio, a differenza del teatro greco, si presentano come una delle tante forme di intrattenimento, come ludus (che in latino significa appunto ‘momento di pausa, evasione’), insieme a giochi circensi, combattimenti tra gladiatori… E, essendo il teatro un ottimo mezzo di espressione, lo Stato lo finanziava e lo sorvegliava a tal punto da censurare qualsiasi allusione politica o civile. I temi affrontati, quindi, sarebbero stati miti ben noti al pubblico o momenti di vita quotidiana, in cui il popolo si poteva immedesimare. Come diceva anche Cicerone, d’altronde, “Comoedia est imitatio vitae, speculum consuetudinis, imago veritatis.” “La commedia è imitazione della vita, specchio dei costumi e immagine della realtà.” [Cicerone, De re publica, IV, 11] Il primo autore a specializzarsi in un unico genere letterario, nel suo caso la commedia palliata, commedia di ambientazione greca, fu Titus Maccius Plautus. Con Plauto si concretizza la forma teatrale della commedia scritta e messa in scena senza alcun fine se non quello di far divertire. Dai toni scherzosi, ricche di abilissimi giochi di parole, neologismi carnevaleschi, disseminate da numeri innumeri (una gamma sorprendente di metri), le palliatae di Plauto dimostrano la sua singolare padronanza della lingua e della metrica latina. I suoi personaggi stereotipati e privi di ogni caratterizzazione psicologica accompagnano e coinvolgono il pubblico con una serie di ‘a parte’ e di riferimenti al teatro all’interno dell’opera stessa (metateatro), in storie in cui lo stesso svolgimento della trama non ha importanza: quel che conta veramente è ridere. Perché per Plauto il teatro è liberatorio: per un giorno, il giorno dei ludi, la società romana viene rovesciata, gli schiavi sono padroni, i figli hanno la meglio sugli sciocchi padri, la sfrontatezza verso i padroni non ha alcuna conseguenza negativa, semmai viene premiata. I modelli principali di ispirazione per Plauto sono principalmente gli autori greci della commedia nuova: Menandro, Difilo, Filemone, Alessi, Demofilo. Plauto non si fa scrupoli nell’utilizzare la tecnica della contaminatio, anzi, in molte occasioni non sente nemmeno la necessità di dichiarare i suoi modelli. E nel suo processo di contaminatio Plauto rielabora le tematiche, eliminando il coro, riducendo all’essenziale i personaggi poco rilevanti, cambiando il nome dei personaggi e scambiando tra loro le scene. La sua più grande innovazione rispetto ai suoi maestri greci è l’aggiunta di elementi buffoneschi e di veri e propri ‘giochi di prestigio’ in campo linguistico. Ammirevoli, nelle commedie a due argumenta, l’acrostico presente in uno di essi, in cui le iniziali dei versi formano il titolo stesso dell’opera, ad esempio: “Meretricem Athenis Ephesum miles avehit. Id dum ero amanti servos nuntiare volt Legato peregre, ipsus captust in mari Et eidem illi militi dono datust. Suom arcessit erum Athenis et forat Geminis communem clam parietem in aedibus, Licere ut quiret convenire amantibus. Obhaerentis custos hos videt de tegulis, Ridiculis autem, quasi sit alia, luditur. Itemque impellit militem Palaestrio Omissam faciat concubinam, quando ei Senis vicini cupiat uxor nubere. Ultro abeat orat, donat multa. Ipse in domo Senis prehensus poenas pro moecho luit.” [Plauto, Miles Gloriosus, Argumentum I] “Un soldato si porta a Efeso una cortigiana che ha prelevato ad Atene. Il servo dell’innamorata della ragazza, Palestrione. Volendo riferire ciò al padrone che è partito per una missione diplomatica, si mette in viaggio per mare ma viene catturato dai pirati e dato da essi in dono proprio a quel soldato. Si preoccupa allora di far venire il suo padrone da Atene e pratica intanto di nascosto un foro tra la parete della casa in cui abita e quella contigua, in modo che i due amanti possano incontrarsi. Lo schiavo addetto alla custodia della ragazza vede dal tetto i due abbracciati, ma viene gabbato in modo spassoso e costretto a credere che la ragazza sia un’altra. È sempre Palestrione che spinge il soldato a liberarsi della concubina, convincendolo che la moglie del vecchio vicino desidera sposarlo. Il soldato prende allora l’iniziativa di invitare la ragazza ad andarsene, coprendola di doni. Ma poi, acchiappato nella casa del vecchio, sconta la pena riservata agli adulteri.” [Plauto, Miles Gloriosus, Argumentum I. Traduzione: Giovanna Faranda] Se Plauto focalizzava le sue commedie sulla risata, non faceva altrettanto Publius Terentius Afer. Per Terenzio, una commedia doveva concentrarsi sull’aspetto realistico e verosimile delle scene e dei contenuti. Per tale cagione, i personaggi terenziani perdono la stereotipia plautina, acquisendo una dimensione psicologica in cui si mescolano drammi, gioie, malintesi e che mostrano con chiarezza l’evoluzione di personaggi altrimenti statici. Il linguaggio usato dal commediografo, più pacato e decoroso, è il sermo familiaris, in grado di offrire ai dialoghi la naturalezza necessaria. Le commedie non vengono scritte per il semplice gusto della commedia, ma hanno sempre un intento moralistico ed educativo, soprattutto per quanto riguardavano tematiche a quel tempo discusse come l’educazione dei figli. Terenzio ebbe la possibilità di compiere un viaggio di studio in Grecia dove entrò sin da subito in contatto con la commedia nuova di Menandro. E, proprio come accadde per Plauto, Menandro, con i suoi temi quotidiani di natura privata (ad esempio l’amore, il lavoro, l’amicizia) a discapito di quelli politici e civili e con le sue conclusioni morali e pedagogiche a lieto fine, divenne il principale esempio seguito da Terenzio, tanto che il commediografo di origini africane fu soprannominato da Cesare “Menander dimidiatus” (cioè: ‘Menandro dimezzato’). Nonostante le opere di Terenzio acquisirono una tale importanza da essere introdotto come obbligatorio nel curriculum latino del periodo neoclassico, al suo tempo egli non ebbe successo dal primo istante, anzi, molte furono le dicerie sul suo conto, tra cui, la più pesante, quella che metteva in dubbio il fatto che lui fosse veramente l’autore delle sue opere. Queste malignità vennero poi confermate dalle parole di Svetonio nell’autobiografia che compone in onore di Terenzio: “Non obscura fama est adiutum Terentium in scriptis a Laelio et Scipione, eamque ipse auxit numquam nisi leviter refutare conatus, ut in prologo ‘Adelphorum’. […] Videtur autem se levius defendisse, quia sciebat et Laelio et Scipioni non ingratam esse hanc opinionem; quae tamen magis et usque ad posteriora tempora valuit.” “Non era pettegolezzo celato che Terenzio fosse aiutato nei suoi scritti da Lelio e Scipione, maldicenza ch’egli contribuì ad alimentare, limitandosi a qualche timida smentita, come nel prologo degli ‘Adelphoe’. […] Il suo eludere è evidentemente dovuto alla consapevolezza che tale pettegolezzo – accresciutosi col tempo fino a sopravvivere nella posterità – non risultava sgradito né per Lelio né per Scipione.” [Svetonio, Vita Terentii, III] Parimenti, Terenzio dovette difendersi anche da accuse come quella di aver praticato la contaminatio: “Poeta cum primum animum ad scribendum adpulit, id sibi negoti credidit solum dari populo ut placerent quas fecisset fabulas; verum aliter evenire multo intellegit. Nam in prologis scribundis operam abutitur, non qui argumentum narret, sed qui malevoli veteris poetae maledictis respondeat. Nunc quam rem vitio dent quaeso animum advortite: […] id isti vituperant factum atque in eo disputant contaminari non decere fabulas. Faciuntne intellegendo ut nihil intellegant? Qui cum hunc accusant, Naevium, Plautum, Ennium accusant; quos hic noster auctores habet, quorum aemulari exoptat neglegentiam potius quam istorum obscuram diligentiam.” [Terenzio, Andria, Prologo; vv. 1-8, 15-21] “Quando lo colse la vena poetica, l’Autore si impegnò anima e corpo a far commedie gradite al suo pubblico. Ma diversamente vanno le cose, e lui perde tempo a scriver prologhi: non sunti, ma risposte ai colpi bassi di un vecchio e invidioso poeta. Di grazia, ascoltate le sue accuse. […] E quello lo biasima e gli rimbrotta: «Che vergogna contaminar commedie!». Son queste forse arguzie da arguti? Accusi allora Nevio, Plauto, Ennio, gli amati modelli dell’Autore: la ‘nonchalance’ di questi egli imita, non quell’ingloriosa pedanteria.” [Terenzio, Andria, Prologo; vv. 1-8, 15-21. Traduzione: Laura Pepe] Vissuto cronologicamente tra Plauto e Terenzio, Cecilio Stazio fu uno tra i più importanti commediografi di palliatae in lingua latina. Come fece Plauto prima di lui e come avrebbe fatto Terenzio dopo di lui, anche Cecilio prese come fonte d’ispirazione la commedia nuova greca di Menandro. A differenza, però, di altri autori latini, soprattutto di Plauto, Cecilio fu influenzato in misura maggiore dal mondo greco, scegliendo di mantenere, tra l’altro, i titoli greci delle opere prese d’esempio. A tal proposito, il nome di Cecilio non venne nemmeno citato tra gli autori che praticavano la contaminatio: egli, infatti, preferiva rispettare il modello preso in considerazione senza fonderlo con altri. Cecilio si distinse dal suo predecessore Plauto anche per quanto riguarda la figura predominante all’interno delle sue commedie: anziché approfondire il personaggio del servus callidus, pronto in qualsiasi momento a escogitare un inganno per risolvere la difficile situazione solitamente del giovane padrone, egli optò per quello della meretrix dal cuore d’oro, nobile e disinteressata, una figura già trattata da Menandro e che sarebbe stata poi ripresa da Terenzio (ad esempio nell’Hecyra). Le somiglianze tra Cecilio e Terenzio, in effetti, sono notevoli: basti pensare all’accurata indagine psicologica nei propri personaggi che però, in Cecilio, pur conquistando una propria personalità, non cadono nella ‘staticità’ a cui lo stesso Terenzio accenna con riferimento alla sua commedia. Per quanto riguarda il rapporto tra Terenzio e Cecilio, Svetonio affermava nel suo Vita Terentii, che Terenzio: “Scripsit comoedias sex, ex quibus primam "Andriam" cum aedilibus daret, iussus ante Caecilio recitare, ad cenantem cum venisset, dictus est initium quidem fabulae, quod erat contemptiore vestitu, subsellio iuxta lectulum residens legisse, post paucos vero versus invitatus ut accumberet cenasse una, dein cetera percucurrisse non sine magna Caecilii admiratione.” “Scrisse sei commedie, sulla prima della quali, l’Andria, si racconta che, dovendola sottoporre agli edili, fu costretto a leggerla dinanzi a Cecilio; Terenzio lo andò a trovare all’ora di pranzo; gli fu chiesto, giacché vestito di abiti decisamente non adatti all’occasione e al contesto, di leggere il principio della commedia seduto su uno sgabello accanto al triclinio; ma poi, dopo pochi versi, fu invitato ad accomodarsi alla tavola per consumare il pasto insieme, e quindi a completare la lettura, non senza grande ammirazione di Cecilio.” [Svetonio, Vita Terentii, II] L’importanza di Cecilio, oltre alle notevoli capacità linguistiche, si manifesta anche nei concetti trasmessi da lui attraverso le sue opere; in particolare il concetto di humanitas, un valore greco che sarà ripreso anche da autori posteri tra cui i membri del circolo scipionico, Cicerone e anche scrittori vissuti dopo Cristo come Aulo Gellio (125 d.C. - 180 d.C.) che, infatti, scriverà: “Qui verba Latina fecerunt quique his probe usi sunt […] «humanitatem» appellaverunt id propemodum, quod Graeci «paideian» vocant, nos eruditionem institutionemque in bonas artes dicimus.” “Quelli che crearono le parole latine e di esse si servirono correttamente […] chiamarono ‘humanitas’ pressappoco ciò che chiamano ‘paideia’ i Greci, noi cultura e disposizione alle buone arti.” [Aulo Gellio, Noctes Atticae, 13, 17] Cecilio, quindi, risulta molto emancipato nel suo avvicinamento al valore greco dell’humanitas; tanto da sentirsi in dovere di replicare alla frase di Plauto dell’Asinaria (v.495): “Lupus est homo homini, non homo, quom qualis sit non novit.” (= “L’uomo è un lupo per l’uomo, non un uomo, quando si ignora chi sia.”) con: “Homo homini deus est, si suum officium sciat.” (= “L’uomo è come un Dio per l’uomo, se conosce il suo dovere.”), concetto che sarà ripreso e rimodellato anche da Terenzio nel suo Heautontimorumenos: “Homo sum, humani nihil a me alienum puto.” (= “Sono umano, niente di ciò che è umano mi è estraneo.”). Cecilio Stazio, di origine gallica, è il primo a introdurre l’humanitas a Roma, in una società di guerrieri, insegnando ai Romani che, oltre alla guerra, esistono ideali più alti per cui valga la pena combattere. Le parole del commediografo rappresentano, quindi, un invito al rispetto, un invito a piantare “gli alberi, che possano giovare a un’altra generazione.”: “Serit arbores, quae saeclo prosint alteri.” Mentre Plauto, Cecilio Stazio e Terenzio ottennero la loro fama con le commedie, altri autori come Pacuvio e Accio lo fecero attraverso le proprie tragedie. Ormai il legame tra Grecia e Roma creato da Livio Andronico stava diventando sempre più indissolubile, tanto che, rispettivamente circa 40 e 90 anni dopo la prima rappresentazione teatrale in lingua latina, Pacuvio e Accio sentirono il bisogno, per le trame delle loro opere, di prelevare proprio episodi da quei miti dell’epos greco che ormai circolavano liberamente con parole latine, focalizzandosi principalmente sugli aspetti meno noti delle storie greche. Pacuvio, poeta doctus (come veniva definito da Orazio), imitato poi da Accio, si indirizzò verso lo stile di Euripide (nonostante la carriera letteraria del tragediografo greco fosse stata perlopiù oscurata dalla figura contemporanea di Sofocle), uno stile dominato da approfondimenti psicologici, da scontri tra la razionalità richiesta e necessaria per lo svolgimento delle vicende, delle quali l’unico sovrano è la capricciosa Sorte, e l’irrazionalità, dettata dagli impulsi e dalle passioni, che fa immergere i personaggi in una dimensione di dubbi e che li porta alla rovina. Così, anche Pacuvio si orientò tra i miti greci, cogliendo gli episodi più malinconici o avventurosi; ma, a differenza dei suoi predecessori, tra cui anche il latino Ennio, dimostrò un palese interesse verso gli aspetti più macabri delle sue storie: “Mater, te appello, tu quae curam somno suspensam levas neque te mei miseret, surge et sepeli natum <tuum> prius quam ferae volucresque… neu reliquias semiesas sireisndenudatis ossibus per terram sanie delibutas foede divexarier.” “T’invoco, o madre, tu che nel sonno dai sollievo all’angosciosa pena, e non hai compassione di me: alzati e da’ sepoltura a tuo figlio, prima che le fiere e gli uccelli [mi divorino] e non lasciare che le mie spoglie semidivorate, con le ossa messe a nudo, siano orribilmente disperse per terra, grondanti di putredine.” (Pacuvio, Iliona, vv. 197-201) Pacuvio modellò il suo linguaggio per raggiungere il suo scopo più alto: commuovere il pubblico, anche a costo di sfruttare la retorica. Il suo stesso percorso fu successivamente esplorato da Accio, che, tra i suoi studi filologici della letteratura greca e latina, si dedicò a porre maggior accento all’interno delle sue tragedie sulle scene violenti e cruenti: “concoquit partem vapore flammae, veribus in foco lacerta tribuit.” “parte [della carne] cuoce al vapore della fiamma, i muscoli li sistema sul fuoco infilzati negli spiedi.” (Accio, Atreus, frammento 10) “Ipsus hortatur me frater ut meos malis miser manderem natos.” “Proprio mio fratello invita me, misero, a masticare con queste mascelle i miei figli!” (Accio, Atreus, frammento 14) L’insieme di tutti i primi poeti commediografi e tragediografi latini costituì un punto di partenza della letteratura latina inequivocabilmente indirizzato verso il mondo greco. «ambigitur quotiens, uter utro sit prior, aufert Pacuvius docti famam senis, Accius alti, dicitur Afrani toga convenisse Menandro, Plautus ad exemplar Siculi properare Epicharmi, vincere Caecilius gravitate, Terentius arte.» «Quando poi ci si chiede quale sia il maggiore [dei poeti], si definiscono Pacuvio 'il vecchio erudito', Accio 'il sublime', Afranio 'togato, ma dotato della sensibilità di Menandro', Plauto 'estroso come il suo modello, il siciliano Epicarmo', Cecilio 'il più profondo', Terenzio 'il più fine'.» (Orazio, Epistulae, II, 1, 59.) Dopo la battaglia di Pidna del 168 a.C. contro il re macedone Perseo, Lucio Emilio Paolo, vincitore dello scontro, ebbe l’occasione di portare a Roma la ricchissima biblioteca di Perseo: ancora una volta, membri della società romana entravano in contatto con la cultura ellenica e, in particolare, il figlio Publio Cornelio Scipione Emiliano. Uomo di spicco nella politica romana del tempo, Scipione Emiliano fu il fondatore del circolo scipionico. Il circolo scipionico era fortemente filo-ellenico, a differenza di ambienti più conservatori, antiellenici e vicini a Catone. Si diceva, tra i coevi così come anche tra i posteri, che l’ambiente scipionico fosse stato uno tra i più fiorenti circoli culturali, letterari e filosofici, aperto a personaggi latini tanto quanto greci o stranieri: Terenzio, Polibio, Panezio, Gaio Lelio, Scevola, Lucilio e molti, molti altri. Anche Cicerone ne parla con grande stima nella sua opera ‘Laelius de amicitia’, un dialogo filosofico immaginario tra Scevola, Gaio Lelio e Gaio Fannio Strabone sul valore e sulle varie tipologie di amicizia, in cui viene ricordato Scipione Emiliano, nel libro, un personaggio a quel tempo da poco defunto. Pur non essendo l’unico punto di contatto tra Grecia e Roma, intorno all’ambiente scipionico ruotarono alcuni tra i più importanti e indiscutibili ‘ambasciatori’ del mondo greco: in primis Polibio (storico greco che divenne amico intimo di Scipione Emiliano), ma anche Cratete di Mallo, Carneade, Panezio di Rodi… Fu merito di Cratete di Mallo, filologo e grammatico illustre dell’epoca, se giunse e si diffuse a Roma la corrente filologica della scuola pergamena, secondo cui le lingue sono frutto naturale dello scorrere del tempo, costantemente soggette a variazioni, e contengono forme irregolari suggerite dalla consuetudo che non andrebbero eliminate ma preservate, a differenza di quanto sostenevano gli alessandrini, che consideravano le lingue uno strumento di comunicazione convenzionale, basato su antichi accordi e sulla ratio, per cui ogni anomalia del sistema linguistico andrebbe rimossa. Allo stesso tempo, tanti furono i filosofi che compirono viaggi diplomatici verso Roma, badando, durante il loro soggiorno, a divulgare tra i Latini le loro dottrine; e altrettanto tanti furono quelli banditi da Roma da personaggi conservatori come Catone con l’accusa di corruzione giovanile. Gli epicurei Alcio e Filisco, lo stoico Diogene, il peripatetico Critolao, l’accademico Carneade (che fece due discorsi degni di un sofista sulla giustizia come valore assoluto e sulla giustizia come valore relativo)… In particolare, però, fu più vicino al circolo scipionico lo stoico Panezio di Rodi, che contribuì alla formazione di una mentalità nuova e compatibile con le occorrenze della nuova società romana: seppe proporre, accanto al concetto di dovere assoluto, quello di dovere relativo in una società ormai cosmopolita e antropocentrica, dominata dal perpetuo conflitto tra sfera pubblica e sfera privata, che con Panezio trovò finalmente una risoluzione: il filosofo, infatti, introdusse la distinzione tra la persona communis, ovvero il contenitore di tutti i valori unanimemente accettati e appartenenti all’humanitas, e la persona ‘ingenium’, che distingue un essere umano da un altro per caratteristiche personali di ogni tipo. Accanto ai generi dell’epos e del dramma, a partire dal II secolo a.C., con Lucilio, si cominciò a diffondere un nuovo genere letterario: la satura. Secondo Orazio, Lucilio apparteneva all’ambiente scipionico; ma, a differenza di altri membri del circolo, egli non era né schiavo né di umili origini né straniero: appartenente a una famiglia ricchissima del ceto equestre, era il primo esempio di poeta di nobili natali. Inoltre, la sua fu una predilezione: egli ebbe la possibilità di manifestare appieno il suo libero arbitrio e optò di non intraprendere il classico percorso del cursus honorum, ma di imboccare la strada dell’otium. ‘Doctus et perurbanus’, cioè ‘colto e dai gusti raffinati’ (Cicerone, De oratore, III, 171), la sua classe sociale gli permise indipendenza finanziaria ma, soprattutto, indipendenza intellettuale; il suo rapporto con i membri più di spicco di Roma era alla pari. Egli affermò nei suoi versi che le sue opere sbocciano dal profondo del suo cuore, ex praecordiis. La necessità di schiettezza lo spinse a privilegiare temi più soggettivi, che erano diventati ormai i temi del circolo scipionico: non più temi celebrativi e collettivi condivisi dai poemi epici o dalle tragedie, non più gli aspetti fantastici dei miti, i somnia facta, ma veri e propri temi realistici che riescono a cogliere tutte le sfumature della vita quotidiana attraverso memorie personali, idee, polemiche, decisioni… “nisi portenta anguisque volucris ac pinnatos scribitis. Nunc itidem populo <placere nolo> hic cum scriptoribus” “voi credete di non interessare al popolino, se non gli descrivete degli esseri straordinari, come per esempio dei serpenti alati o dei draghi volanti. Ma io non aspiro a piacere al popolino, come questi scrittori” (Lucilio, Saturae, vv. 587-588) Lucilio intraprese una vera e propria rivoluzione razionalistica. Tuttavia, la sua scelta di scrivere su temi individuali, soggettivi, non andava assolutamente in contrasto con la mentalità del suo tempo, ancora focalizzata sulla comunità e sul rispetto verso la res publica: “Virtus, Albine, est pretium persolvere verum quis in versamur, quis vivimus rebus potesse, virtus est homini scire id quod quaeque habeat res, virtus scire homini rectum, utile quid sit, honestum, quae bona, quae mala item, quid inutile, turpe, inhonestum, virtus, quaerendae finem rei scire modumque, virtus divitiis pretium persolvere posse, virtus, id dare quod re ipsa debetur honori, hostem esse atque inimicum hominum morumque malorum, contra, defensorem hominum morumque bonorum, hos magni facere, his bene velle, his vivere amicum, commoda praeterea patriai prima putare, deinde parentum, tertia iam postremaque nostra.” “Virtù, o Albino, è essere in grado di assegnare il giusto valore alle cose fra cui ci troviamo e fra cui viviamo, virtù è sapere quale valore abbia ciascuna cosa per l'uomo, virtù è sapere cosa sia giusto, utile, onesto quali cose sono buone e quali cattive, cosa sia inutile, vergognoso, disonesto; virtù è saper porre fine e moderazione al profitto, virtù è essere in grado di assegnare il giusto valore alle ricchezze, virtù è conferire agli onori ciò che realmente si deve ad essi: essere avversario e nemico degli uomini e dei costumi corrotti, e, al contrario, difensore degli uomini e dei costumi puri, stimare costoro, apprezzarli, essere loro amico, mettere al primo posto il bene della patria, poi quello dei genitori, per terzo e ultimo il nostro.” (Lucilio, Saturae, vv. 1326-1338) Lucilio fu l’inventore della satira, maestro negli attacchi ad personam; egli non aveva alcun motivo di temere le conseguenze delle sue taglienti parole: la sua classe sociale gli permetteva una certa libertà di espressone che nessun autore prima di lui aveva avuto. Dalle sue opere traspare un’evidente malcontento verso atteggiamenti romani che, man mano che la res publica si avvicinava alla sua fine, stavano radicalmente cambiando. Invettive contro personaggi di spicco, invettive contro tutti gli abitanti di Roma… per la franchezza di Lucilio non faceva la minima differenza. E il poeta latino, con il suo concilium deorum, non avrebbe avuto alcuno scrupolo ad utilizzare (e, forse, a minimalizzare) addirittura gli Dei come capro espiatorio per poter denunciare, attraverso una parodia, il senato romano: la parodia di un topos letterario, quello del concilio degli Dei, di antiche origini, già presente nell’epos greco di Omero, ma anche nel nuovo epos di Ennio; con una sola freccia, quindi, Lucilio colpisce due bersagli: la religione e la politica. Per il suo carattere in certi momenti piuttosto moralistico, Lucilio sarebbe stato ricordato anche come laudator temporis acti (‘lodatore del tempo passato’). Attraverso le sue saturae, egli avrebbe saputo offrire uno specchio critico della sua società e del suo tempo: “famam inhonestam autem turpemque odisse popinam praetextae ac tunicae, Lydorum opus, sordidulum omne, psilae atque amphitapae, villis ingentibus, molles miracla ciet tylyphantas porro «clinopodas» «lychnos»que ut diximus semnos ante «pedes lecti» atque «lucernas» «arutaenae»que, inquit, aquales.” “Gli antenati erano soliti odiare una brutta fama e le vergogne della taverna, mentre le nostre matrone vanno in visibilio per le toghe preteste e le tuniche prodotte da donne della Lidia, e disprezzano ogni prodotto nostrano; di tappeti semplici e doppi, dal pelo folto e morbido […] il materassaio fa veri prodigi. E mentre un tempo si diceva «i piedi del letto» e «le lucerne», ora si sono messi a dire con enfasi «i clinopodi» e «i licni» […] e chiamano «arutene» comuni brocche per l’acqua.” (Lucilio, Saturae, vv. 11-17) “nunc vero a mani ad noctem, festo atque profesto totus item pariterque die populusque patresque iactare indu foro se omnes, decedere nusquam; uni se atque eidem studio omnes dedere et arti, verba dare ut caute possint, pugnare dolose, blanditia certare, bonum simulare virum se, insidias facere, ut si hostes sint omnibus omnes.” “Ora, dalla mattina fino a notte inoltrata, sia nei giorni feriali sia in quelli festivi, cittadini e senatori hanno tutti un gran da fare nel foro, da dove non si allontanano mai; e tutti hanno un solo identico scopo, quello di imbrogliarsi a vicenda – ma con circospezione! – , di lottare con inganno, di vincere con blandizie, di fingersi uomini per bene e di tramare insidie, come se tutti fossero nemici a tutti.” (Lucilio, Saturae, vv. 1228-1234) Lucilio, però, si concesse anche versi d’amore, più colloquiali, per una donna chiamata Collyra; secondo molti studiosi, è probabile che fu proprio Lucilio, con le sue poesie erotiche latine, ad aprire la strada ai poetae novi del I secolo a.C. Infine, è certo che alcune sue caratteristiche si ritrovano addirittura in Alceo (VII-VI secolo a.C.), le cui opere, come afferma lo stesso Camillo Neri nella sua Breve storia della lirica greca, sono caratterizzate “da un tono sprezzante persino verso gli eroi del mito”. Tuttavia, non si sa con certezza quale fosse esattamente il modello di Lucilio. La risposta di alcuni studiosi è Aristofane, che con la sua commedia antica del V secolo a.C., fonde alla perfezione commedia e satira politica, attraverso toni invettivi unici. Altri studiosi, però, si allontanano ancor di più nel tempo, fino al VII secolo a.C., secolo in cui visse Archiloco di Paro. Archiloco di Paro era un poeta-soldato, molto probabilmente mercenario, nato, secondo il mito, da un aristocratico, Telesicle, e da una schiava, Enipò. Egli “fu un grande sperimentatore: dagli spunti sarcastici (fr. 115 W.2) alle violente invettive (“Hippon.” fr. 115 W.2), dalle riflessioni sapienziali (frr.13,122 W.2) al crudo erotismo (frr. 42,43, 119 W.2), dalle allocuzioni (fr. 109 W.2) all’introspezione (fr. 128 W.2), dalle vinose ispirazioni (fr. 120 W.2) alla passione d’amore (fr. 118 W.2), dall’imitatio di Omero (cui è associato nelle antiche erme bifronti) al più volgare realismo.” (Camillo Neri, Breve storia della lirica greca, pagina 103). Tuttavia, ciò che più di ogni altra cosa distingue Archiloco da altri autori è sicuramente il suo anticonformismo: la profondità del suo pensiero introspettivo e, allo stesso tempo, la noncuranza per le tradizioni e le norme da seguire nella sua società della vergogna, sono entrambe peculiarità che, in fondo, si ritrovano nelle sue leggendarie origini: Archiloco era un ibrido, per metà nobile, poeta, dai pensieri alti e raffinati, e per l’altra nato da una schiava, soldato, polemico nel linguaggio basso e volgare. Il suo ideale di eroismo si distacca completamente da quello dei suoi contemporanei. Ciò che veramente offre la gloria è una visione profonda esistenziale e non la vittoria o la morte in battaglia: “Ἄσπίδι μὲν Σαΐων τις ἀγάλλεται, ἣν παρὰ θάμνῳ, ἔντος ἀμώμητον,‖ κάλλιπον οὐκ ἐθέλων· αὐτὸν δ' ἐξεσάωσα. τί μοι μέλει ἀσπὶς ἐκείνη; ἐρρέτω· ἐξαῦτις ‖ κτήσομαι οὐ κακίω.” “Qualcuno dei Sai si vanta dello scudo che presso un cespuglio, arma impeccabile, ho abbandonato non volendo; ma ho salvato me stesso. Che mi importa quello scudo? Vada in malora! Di nuovo ne avrò uno non peggiore.” (Archiloco, fr. 115 W.2) Il poeta-soldato, poi, si dimostra un elevato pensatore, quel che oggigiorno si potrebbe chiamare un positivista, un ottimista che, con la sua pragmatismo, affronta vittoriosamente gli scogli, le avversità della vita senza perdersi in rimpianti o ripensamenti, disperazione o abbattimento: “Θυμέ, θύμ', ἀμηχάνοισι κήδεσιν κυκώμενε, ἀνάδευ δυσμενῶν δ' ἀλέξευ προσβαλὼν ἐναντίον στέρνον ἐνδοκοισιν ἐχθρῶν πλησίον κατασταθεὶς ἀσφαλέως· καὶ μήτε νικέων ἀμφάδην ἀγάλλεο, μήτε νικηθεὶς ἐν οἴκῳ καππεσὼν ὀδύρεο, ἀλλὰ χαρτοῖσίν τε χαῖρε καὶ κακοῖσιν ἀσχάλα μὴ λίην, γίνωσκε δ' οἷος ῥυσμὸς ἀνθρώπους ἔχει.” “Cuore, cuore, agitato da mali inesorabili, riemergi e dagli avversari difenditi opponendo contro il petto, nelle insidie dei nemici arrestandoti vicino senza paura; e non vantarti apertamente quando vinci, non lamentarti abbattendoti in casa quando sei stato vinto, ma delle gioie godi e dei mali affliggiti non troppo, e sappi quale ritmo domina gli uomini.” (Archiloco, fr. 128 W.2) Allo stesso modo, le invettive del poeta-soldato greco, piene di riferimenti realistici, crudi, osceni, rispecchiano la sua concezione di vita secondo cui: “Ἕν δ᾽ ἐπίσταμαι μέγα, τὸν κακῶς <μ᾽ ἔ>ρδοντα δεινοῖσ᾽ ἀνταμείβεσθαι κακοῖς.” “Una sola cosa so, importante: ricambiare con mali terribili chi mi fa del male.” (Archiloco, fr. 126 W.) Altrettanto anticonformisti risultano essere pure i versi erotici archilochei, che arrivano addirittura a destare scalpore a causa della loro esplicitazione immorale. Archiloco sarebbe stato uno dei tanti modelli dei poetae novi, i neoteroi. Con l’arrivo del I secolo a.C., anche a Roma cominciò a diffondersi la poesia lirica, su modello greco. Per la prima volta si trattava di una lirica individuale, che poneva al centro l’‘io’ anziché il ‘noi’. Non aveva più alcuna importanza esaltare la virtus o il glorioso destino romano, perché i tempi erano cambiati, e lo stesso valeva anche per le mentalità. Il cittadino romano esigeva ormai il riconoscimento della sua sfera privata, rompendo il legame precedente che si era istaurato fra individualità e vita politica, cioè i negotia. Man mano che l’età della tarda repubblica si avvicinava verso la sua fine, crebbe il prestigio dell’otium fino a essere portato sullo stesso livello del negotium. La nuova società, quindi, si rispecchiò totalmente nei ‘poeti più giovani, moderni’, traduzione dell’appellativo poetae novi, o, usando un grecismo, νεώτεροι, che Cicerone avrebbe utilizzato per definirli per la prima volta, condendo il soprannome di un pizzico di sarcasmo senile verso la nuova e giovane generazione di poeti; ma il famoso oratore romano non si sarebbe limitato a un solo epiteto: avrebbe utilizzato per le nuove comparse anche espressioni come cantores Euphorionis, ‘imitatori di Euforione’. Epigrammi, epicedi, carmina, poemi e poemetti, opere filologiche, epilli… l’attenzione dei neoteroi, che, come aveva fatto un secolo prima Lucilio, avevano scelto di spontanea volontà una carriera letteraria, si era spostata ormai su una vasta gamma di generi e i temi erano in primis focalizzati sull’amore, sui propri interessi, e non tanto sulle lotte politiche. La poesia rappresentava un lusus (ovvero un ‘gioco’, uno ‘scherzo’), un momento di condivisione con i propri sodales, i compagni che nel mondo greco si sarebbero chiamati ἑταῖροι, da cui si era legati da vincoli di amicizia e rispetto reciproco. I poetae novi si rifacevano parecchio a modelli greci come Callimaco di Cirene (del III secolo a.C.), il quale fornì i parametri cardine alessandrini da seguire nel componimento di un’opera: la brevitas, ovvero la concisione, l’essenzialità; la doctrina, ossia l’erudizione; il labor limae, lavoro raffinato, perfetto, privo di parti ridondanti e oggetto alla limatura, proprio come accade per le statue. Fu merito di Partenio di Nicea, un letterato greco ammiratore di Callimaco e preso prigioniero dai Romani nel 73 a.C., se i canoni callimachei giunsero nella capitale latina. Il primo autore di poesia lirica a noi noto fu Lutazio Càtulo, il cui circolo ricordava quello scipionico, non solo per le modalità ma anche per le visioni protese verso il concetto di humanitas. Importanti furono anche Furio Bibaculo (il più anziano dei poetae novi, autore di un poema epico-storico intitolato Annales o Pragmatia belli Gallici e di qualche epigramma), Varrone Atacino (autore del poema epico-storico Bellum Sequanicum e di due poemetti didascalici, uno geografico, il Chorographia, e uno astronomico, forse intitolato Ephemeris), Valerio Catone (esperto filologo, autore di alcuni epilli e, si suppone, una raccolta di poesie), Elvio Cinna (autore di un poemetto geografico, di versi d’amore e dell’epillio Zmyrna) e Licinio Calvo (autore di epigrammi satirici, epitalami, componimenti amorosi e un epicedio). Ma forse il massimo esponente della corrente dei poetae novi fu proprio l’amico migliore di Licinio Calvo, Catullo. Catullo, proprio come Archiloco, era un personaggio anticonformista per la sua epoca. All’interno dei suoi versi, disseminati di momenti introspettivo-emotivi, ci sono sempre riferimenti, anche se a volte indiretti, ai suoi sodales. Tuttavia, le sue poesie sono principalmente il frutto di una competizione, una sfida con se stesso che Catullo accetta senza titubanze. La sua bravura nell’esprimere i suoi sentimenti raggiunse livelli talmente alti, da spingere a cercare ispirazione presso il poeta latino molti autori posteri, tra cui Ugo Foscolo (1778-1827); quest’ultimo, per scrivere il suo sonetto In morte del fratello Giovanni, farà riferimento al carmen CI di Catullo: “Multas per gentes et multa per aequora vectus advenio has miseras, frater, ad inferias, ut te postremo donarem munere mortis et mutam nequiquam alloquerer cinerem, quandoquidem fortuna mihi tete abstulit ipsum, heu miser indigne frater adempte mihi. Nunc tamen interea haec prisco quae more parentum tradita sunt tristi munere ad inferias, accipe fraterno multum manantia fletu, atque in perpetuum, frate, ave atque vale.” (Catullo, Liber, CI) “Trasportato attraverso molti genti e molti mari sono giunto, o fratello, a [recarti] queste tristi offerte funebri, per tributarti l’estremo omaggio di morte e parlare invano alla muta cenere dal momento che la sorte mi ha portato via te, proprio te, ahimè, infelice fratello, ingiustamente strappatomi. Ora intanto comunque accogli queste [offerte] grondanti di pianto fraterno, che io, secondo l’antico costume degli avi, ho portato quale triste dono per le esequie, e per sempre, fratello, addio!” «Un dì, s'io non andrò sempre fuggendo di gente in gente, mi vedrai seduto su la tua pietra, o fratel mio, gemendo il fior de' tuoi gentili anni caduto: la madre or sol, suo dì tardo traendo, parla di me col tuo cenere muto: ma io deluse a voi le palme tendo; e se da lunge i miei tetti saluto, sento gli avversi Numi, e le secrete cure che al viver tuo furon tempesta; e prego anch'io nel tuo porto quiete: questo di tanta speme oggi mi resta! straniere genti, l'ossa mie rendete allora al petto della madre mesta.» (Ugo Foscolo, In morte del fratello Giovanni) Nel suo Liber, Catullo riunì molte tematiche; e, pur sfruttando gli attacchi ad personam contro gli amici che lo avevano tradito, seguendo l’esempio di Alceo, e pur scrivendo invettive tipiche di Archiloco, con cui attaccava i personaggi politici di rilievo a Roma e in generale la società romana che si era degradata a tal punto da abbandonarsi alla corruzione, all’immoralità, ai favoritismi e alla volgarità, il poeta dimostra una vera e propria propensione verso la tematica dell’amore, dell’eros, intorno al quale ruota tutto il resto. Catullo, infatti, impiegherà molte delle sue energie nella relazione con una donna, vedova di Metello, che nelle sue opere denominò Lesbia (probabilmente un’allusione alla poetessa Saffo, vissuta nel VII secolo a.C. sull’isola di Lesbo) e il cui vero nome era, secondo Cicerone (nel Pro Caelio), Clodia, una donna dai costumi scandalosi. Il suo rapporto, però, si opponeva palesemente contro i costumi e le leggi del tempo: avere un legame amoroso con una donna sposata, una matrona nupta, equivaleva all’adulterio, adulterium, mentre, se la donna era vedova, vidua, come nel caso di Lesbia alias Clodia, la relazione veniva comunque considerata illecita e disonorevole e veniva chiamata col termine stuprum. In ogni caso, per Catullo, l’amore era basato non su leggi, ma esclusivamente su un patto sacro, il foedus, che garantiva la fides e la pietas; ed è proprio questa mentalità che dimostra che Catullo, nel suo anticonformismo, manteneva pur sempre la sua educazione pragmatica e conservatrice romana, spostando semplicemente i valori del mos maiorum dalla sfera pubblica, etica e religiosa a quella privata. L’amore catulliano, poi, era anche oggetto di gelosia, proprio come l’amicizia. E, visto l’incostante rapporto di Catullo con la sua amata che traspare dai suoi carmina, Catullo riveste spesso il ruolo di amante deluso, in preda a rimpianti e nostalgie, disperazione e sdegno, che sovente lo portò a scrivere dure invettive contro Lesbia (così come farà anche contro le infrazioni dei suoi amici), ritrovandosi, in qualche circostanza, a chiedere l’aiuto degli Dei per riuscire a dimenticare il suo amore simile a un’orribile malattia, taeter morbus. Saranno tante le volte in cui Catullo dirà nei suoi versi addio a Lesbia: “Miser Catulle, desinas ineptire, et quod vides perisse perditum ducas. Fulsere quondam candidi tibi soles, cum ventitabas quo puella ducebat amata nobis quantum amabitur nulla. Ibi illa multa tum iocosa fiebant, quae tu volebas nec puella nolebat. Fulsere vere candidi tibi soles. Nunc iam illa non volt: tu quoque, impotens, noli, nec quae fugit sectare, nec miser vive, sed obstinata mente perfer, obdura. Vale, puella. Iam Catullus obdurat. nec te requiret nec rogabit invitam. At tu dolebis, cum rogaberis nulla. Scelesta, vae te! Quae tibi manet vita? Quis nunc te adibit? Cui videberis bella ? Quem nunc amabis? Cuius esse diceris? Quem basiabis? Cui labella mordebis? At tu, Catulle, desinatus obdura.” “Infelice Catullo, smetti di vaneggiare, e quel che vedi perduto, stimalo perduto. Splendettero un tempo per te radiosi giorni, quando accorrevi là dove la tua donna ti conduceva, amata da noi [plurali maiestatis = me]e quanto nessun’altra mai sarà stata. Là, allora, avvenivano quei tanti giochi amorosi, che tu volevi e che la tua donna non rifiutava. Davvero splendettero un tempo per te radiosi giorni. Ora lei non vuole più: anche tu, [per quanto] incapace di dominarti, cessa di volere, e non inseguire [lei] che fugge, e non essere infelice, ma con animo irremovibile sopporta, resisti. Addio, mia cara. Ormai Catullo è deciso, e non tornerà a cercarti né chiederà amore, se tu non vuoi. Ma tu soffrirai, quando non sarai più desiderata. Scellerata, guai a te! Che vita ti resta? Chi ora verrà con te? A chi sembrerai bella? Chi amerai tu ora? Di chi si dirà che tu sei? Chi bacerai? A chi morderai le labbra? Ma tu, Catullo, ostinato, resisti.” (Catullo, Liber, VIII) Nel carmen LXVIII, Catullo scelse di impiegare un inserto mitologico, un exemplum, con cui allude alla sua biografia, al suo rapporto infelice: il poeta pose in antitesi il mito di Peleo e Teti, che descrive un amore legittimo e felice, con quello di Arianna e Teseo, in cui Teseo (similmente a Lesbia) tradisce Arianna (equivalente al ruolo di Catullo), lasciandola tormentata dalle pene d’amore. Catullo si avvale frequentemente della tecnica della imitatio unita a quella della aemulatio, inserendo all’interno delle sue opere evidenti allusioni ai modelli greci, che cerca di omaggiare, secondo lo stile dell’‘arte allusiva’: egli non teme, infatti, i riferimenti diretti ai suoi preferiti greci, cioè Alceo, Archiloco, Ipponatte (da cui eredita l’invettiva e l’eros violento) e, specialmente, Saffo. È Saffo la sua maggiore fonte di ispirazione sia per il metro che per le tematiche (ad esempio quella dei sintomi dell’innamoramento). Saffo, vissuta nel VII secolo a.C., era stata la prima poetessa europea. “Segnata da rapporti con la Lidia […], tale attività fruttò a Saffo fama e ricchezza e caratterizzò la sua poesia: dalla prece ad Afrodite (fr.16 V.) al carme per Anattoria (fr. 16 V.), dall’ode sui sintomi della sofferenza amorosa (fr. 31 V. imitatissima e tradotta da Catullo) ai poèmes d’adieu per le compagne (fr.94 V.),dal malinconico elogio di Attide (fr. 96 V.) sino agli epitalami, dove è palese il riuso – tra fioriti omerismi – di elementi popolari /fr. 44 V.).” (Camillo Neri, Breve storia della lirica greca, pagina 89) I suoi carmina ruotano intorno al tiaso, una tipo di collegio greco con funzione educativoreligiosa dell’epoca, dedicato alla dea Afrodite e in cui le giovani e abbienti fanciulle venivano mandate dalle loro famiglie prima del matrimonio per essere educate alla vita matrimoniale. I temi dei suoi versi, quindi, erano quelli di un’‘io’ condiviso da tutti i membri del tiaso e, sostanzialmente, quello dell’amore, un amore spesso malinconico, presumibilmente omosessuale, visto da una dimensione sacra e destinato a una fine certa, una volta concluso l’apprendimento all’interno del tiaso. “Φαίνεταί μοι κῆνος ἴσος θέοισιν ἔμμεν᾽ ὤνηρ, ὄττις ἐνάντιός τοι ἰσδάνει καὶ πλάσιον ἆδυ φωνείσας ὐπακούει καὶ γελαίσας ἰμέροεν, τό μ᾽ ἦ μὰν καρδίαν ἐν στήθεσιν ἐπτόαισεν, ὠς γὰρ ἔς σ᾽ ἴδω βρόχε᾽ ὤς με φώνησ᾽ οὐδ᾽ ἒν ἔτ᾽ εἴκει, ἀλλὰ κὰδ μὲν γλῶσσα ἔαγε, λέπτον δ᾽ αὔτικα χρῷ πῦρ ὐπαδεδρόμακεν, ὀππάτεσσι δ᾽ οὐδὲν ὄρημμ᾽, ἐπιβρόμεισι δ᾽ ἄκουαι, ψῦχρα δ᾽ ἴδρως κακχέεται, τρόμος δὲ παῖσαν ἄγρει, χλωροτέρα δὲ ποίας ἔμμι, τεθνάκην δ᾽ ὀλίγω ’πιδεύης φαίνομ’ ἔμ᾽ αὔτᾳ· ἀλλὰ πὰν τόλματον, ἐπεί κ[†]” “A me pare uguale agli dei chi a te vicino così dolce suono ascolta mentre tu parli e ridi amorosamente. Subito a me il cuore si agita nel petto solo che appena ti veda, e la voce si perde sulla lingua inerte. Un fuoco sottile affiora rapido alla pelle, e ho buio negli occhi e il rombo del sangue alle orecchie. E tutta in sudore e tremante come erba patita scoloro: e morte non pare lontana a me rapita di mente.” (Saffo, fr. 31 V.; traduzione: Salvatore Quasimodo) Il linguaggio e le immagini proposte da Saffo furono di enorme successo lungo i secoli: la poetessa greca venne imitata da molti autori tra cui, oltre a Catullo, anche Ovidio. L’età della tarda repubblica vede concludersi il processo di contaminazione che la cultura greca apportò alla letteratura romana per ben otto secoli. Questo periodo, denominato anche ‘età di Cesare’ o ‘età di Cicerone’ pone un brusco punto fermo al rapporto intellettuale unidirezionale. Nella ruota, che continua a girare senza sosta, ininterrotta, si rimescolano le carte: l’allievo supera il maestro, il quale, adesso, lo guarda compiaciuto. Il dramma latino aveva superato i suoi anni più fiorenti; l’epos si era radicato nella cultura celebrativa; la satira non smetteva di intromettersi con prepotenza, colpendo nelle più svariate occasioni i rivali politici; la poesia lirica aveva fatto con successo la sua comparsa, prendendo il suo posto riservato nella letteratura latina; la storiografia, aveva già avuto il suo avvio con gli Annales dei vari autori precedenti e nel I secolo a.C. ricevette una spinta notevole con autori come Cesare e Sallustio; l’oratoria aveva già conosciuto Cicerone, il quale sarebbe diventato un avvocato che non avrebbe conosciuto pari. I cittadini romani necessitavano di ordine e tranquillità, che nell’ultimo secolo della res publica erano stati loro negati. La società, sempre più ricca, si era rifugiata nella corruzione, nell’avidità e nella ricerca del lusso. “Haec iuventutem, ubi familiares opes defecerant, ad facinora incendebant: animus inbutus malis artibus haud facile lubidinibus carebat; eo profusius omnibus modis quaestui atque sumptui deditus erat.” “Impoverivano tali vizi la gioventù, e quindi ai delitti la spingevano. Male avvezzi quei guasti animi, non potevano i loro desideri frenare oramai: onde vieppiù smoderati si davano ad ogni guadagno e allo spendere.” (Sallustio, De coniuratione Catilinae, XIII, traduzione tratta dal libro Civiltà del passato II di Armando Saitta) Il periodo finale della res publica era un momento di crisi; le guerre erano state numerose e i cittadini romani erano stanchi; le congiure erano all’ordine del giorno, trovando il loro esponente maggiore in Catilina, acerrimo nemico di Cicerone. “I due si affrontarono in una campagna elettorale senza precedenti: mentre Catilina cercava di guadagnarsi con fine demagogia l’appoggio di plebe e schiavi, forse davvero meditando un colpo di Stato, Cicerone dipingeva l’avversario come depravato, incestuoso e assassino.” (Alberto Angela, Roma, la repubblica delle acque, pagina 140) A Catilina, poi, seguiva una congiura ancor peggiore, quella che avrebbe velato uno spargimento di sangue con l’illusione di una ripresa dello stato romano: la congiura del 15 marzo 44 a.C., giorno delle Idi di Marzo e dell’assassinio di Cesare. “Il fatto che colpisce di più è che in pochi istanti non è stata assassinata una sola persona ma tante… In effetti, gran parte dei principali congiurati morirà di morte violenta nel giro di pochi mesi o pochi anni. Senza contare le migliaia di persone che perderanno la vita nelle battaglie terrestri o navali, o a causa delle liste di proscrizione.” (Alberto Angela, Cleopatra, la regina che sfidò Roma e conquistò l’eternità, pagina 103). Ormai la res publica era finita, e con essa il periodo di apprendimento per la città di Roma; la Grecia aveva svolto il suo ruolo nel migliore dei modi possibili, aiutando Roma ad alzarsi sulle proprie gambe. L’età imperiale stava cominciando. Isabella Tokos, 3A BIBLIOGRAFIA: Giancarlo Pontiggia, Maria Cristina Grandi, Bibliotheca Latina – Storia e testi della letteratura latina, Principato, ISBN 9788841622124 Antonietta Porro, Walter Lapini, Claudia Laffi, KTEMA ES AIEI –La letteratura greca dalle origini a Erodoto, Loescher Editore, ISBN 9788858326800 Maurizio Bettini, Mario Lentano, Donatella Puliga, Il fattore umano – corso di storia e geografia 1, dalla preistoria all’età di Cesare, Pearson, ISBN 9788869101847 Daniella Ciocca, Tina Ferri, Narrami o musa, seconda edizione, Mondadori Education, ISBN 9788824744805 Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, Con-Filosofare 1A – dalle origini ad Aristotele, Pearson, ISBN 9788839528025 Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, Con-Filosofare 1B – dall’ellenismo alla scolastica, Pearson, ISBN 9788839528025 Stefano Bove, Rita Alosi, Piera Pagliani, La lingua delle radici 2, Petrini, ISBN 9788849415698 Hendrik Willem van Loon, Storia dell’umanità, Salani Editore, ISBN 9788877829153 Eva Cantarella, “Sopporta, cuore…” – La scelta di Ulisse, Economica Laterza, ISBN 9788858109106 Plauto, Miles Gloriosus, Aulularia, a cura di Giovanna Faranda, Mondadori, ISBN 9788804680307 Terenzio, Andria, Hecyra, a cura di Laura Pepe, Mondadori, ISBN 9788804711506 Cicerone, De senectute, De amicitia, a cura di Guerino Pacitti, Mondadori, ISBN 9788804431763 Camillo Neri, Breve storia della lirica greca, Carocci Editore, ISBN 9788843053414 Alberto Angela, La civiltà perduta degli etruschi, la Repubblica, ISBN 9771826868327 / 90001 Alberto Angela, Alexis, un mercante in Magna Grecia, la Repubblica, ISBN 9771826868327 / 90002 Alberto Angela, Roma, la repubblica delle acque, la Repubblica, ISBN 9771826868327 / 90003 Alberto Angela, Cleopatra, la regina che sfidò Roma e conquistò l’eternità, Harper Collins, ISBN 9788869053924 Andrea Marcolongo, La lingua geniale – 9 ragioni per amare il greco, Editori Laterza, ISBN 9788858125250 Armando Saitta, Civiltà del passato II – Sansoni Vittorio d’Agostino, La versione latina, Editrice Il Girasole, ISBN 9788885906211 Guglielmo Ferrero, Grandezza e decadenza di Roma 1 – La conquista dell’impero, Fratelli Treves Editore, Milano, 1906 Indro Montanelli, Roberto Gervaso, Storia d’Italia 1 - Dalla fondazione di Roma alla distruzione di Cartagine, Fabbri Editore