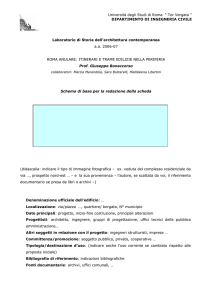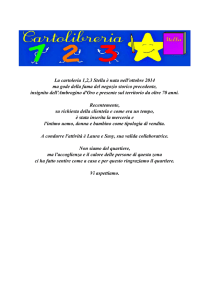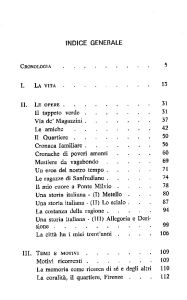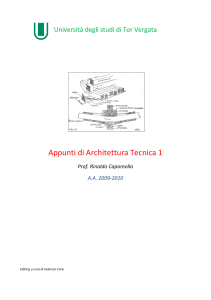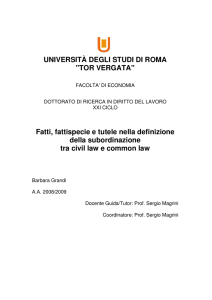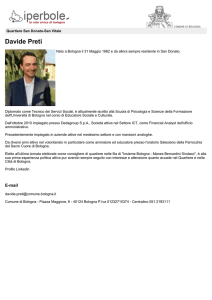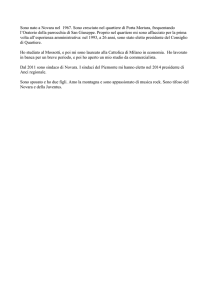caricato da
Isabella Tokos
Al Palo della Morte: Analisi del libro sull'immigrazione

SCRIVI UNA RELAZIONE DETTAGLIATA SUL LIBRO “AL PALO DELLA MORTE” “Di Shahzad si é scritto molto poco, qualche notizia in cronaca di Roma e poi un paio di trafiletti via via che la storia processuale andava consumandosi.” (pg. 169) Shahzad nasce nel 1986 a Bagh nel Kashmir. Egli è il primogenito di una famiglia pakistana contadina e molto povera. Il suo nome, ‘Shahzad’, che “significa proprio ‘Principe’, letteralmente vuol dire, ‘figlio del sovrano’” (pg. 45), nel suo mondo non viene accompagnato da alcun cognome: in Pakistan non si dà importanza a questo aspetto laterale tanto quanto la data o il mese di nascita; basta solo il nome, il nome e l’anno. A 21 anni Shahzad è giunto a Roma, in aereo. Ha evitato quel stancante viaggio via terra e mare per cui i suoi connazionali “ci impiegano sei mesi. I più sfortunati fino a due anni. Dal Pakistan arrivano all’Iran in pullman. Dall’Iran approdano alla Turchia dove capita che al confine ti sparino addosso. Dalla Turchia alla Grecia e poi in Italia.” (pg. 61) Egli è stato in un certo modo costretto ad abbandonare la sua terra nativa, “la campagna dell’Azad Kashmir, il ‘Kashmir libero’ che in realtà è terra contesa e a cavallo tra l’India e il Pakistan. […] per (andare nella) città eterna per fuggire alla miseria economica, per mandare alla fine del mese a casa una cifra che dalle sue parti vale circa dieci volte tanto.” (pg. 90) Sulla sua carta d’identità, nello spazio della data di nascita è segnato il 28 aprile del 1986, mentre per il suo cognome, lui ha scelto ‘Khan’: si tratta del nome della sua casta di appartenenza, un nome particolarmente comune per i cittadini pakistani emigrati che ha inoltre un secondo significato: costituisce anche una specie di titolo nobiliare, simile all’italiano ‘signore’; appellativo usato, d’altronde, pure dall’illustre Gengis Khan. Shahzad non è il primo della sua famiglia ad essersi avventurato tanto lontano da casa, in Italia. Lo precede suo zio, che ha trovato l’impiego di cuoco a Roma. Grazie alla sua presenza, Shahzad riesce ad ottenere presto il permesso di soggiornare in Italia. Ma da questo punto di vista è stato più fortunato di altri: il testo sull’immigrazione firmato da Umberto Bossi e Gianfranco Fini, la cosiddetta ‘Bossi-Fini’ “vincola fortemente l’ingresso nel paese alla stipula di un contratto di lavoro e, di fatto, costringe i migranti a entrare clandestinamente, accettare lavori a nero senza garanzie e sperare che prima o poi questi si trasformino in impieghi regolari.” (pg. 61) Una legge che sembra drastica, che “pare fatta a posta per reclutare mano d’opera ricattabile e clandestina. […] Il razzismo di questa legge lo sperimentano Shahzad e quelli che come lui arrivano in Italia: una legge tanto restrittiva non serve ad impedire l’arrivo di migranti, ma a facilitare lo sfruttamento.” (pg. 63) Per Shahzad e per gli sciagurati come lui, dunque, i confini sono destinati ad aprirsi “a singhiozzo, selezionando i migranti per renderli docili. Il razzismo non serve a eliminare ma a segregare, a rendere ricattabile con la forza lavoro. Le frontiere operano come i riflettori dei media: illuminano soltanto quando occorre creare un’emergenza.” (pg. 139) Lo zio deve abbassare per sempre le serrande del suo ristorante. Da questo momento in poi, a Shahzad risulterà sempre più difficile trovare i soldi necessari per tornare in patria, a casa sua, o per trovare un nuovo lavoro. Le sue “condizioni di povertà sempre maggiori lo inducono a rivolgersi sempre di più alla religione islamica” (pg. 67) nella quale si immergerà. Nella tasca tiene un volantino firmato ‘Musulmani per la lealtà’. Pian piano deve rinunciare anche alla sua stanza, al tetto sopra la testa. Ma troverà asilo al centro di accoglienza Astalli, numero di matricola 26348, dove lascerà la sua valigia con qualche vestito e i suoi pochi soldi accumulati, circa 250 euro. Shahzad è sposato da circa un anno con Ulfat Jan. Egli è tornato nella sua patria provvisoriamente proprio per le nozze. Un anno dopo, nella fatidica sera del 18 settembre 2014, Shahzad si aggira “in quella città che ha inseguito come una porta verso la libertà e che sta diventando una gabbia per troppa gente.” (pg. 100) “Sono le 22:30 della sera in cui Shahzad incontra la morte. Dal ristorante (Taj Mahal, numero 500 di via Casilina) esce Faheem, ventinovenne pakistano di Poonch, nel Kashmir.” (pg. 82). Sono tre mesi che Faheem e Shahzad hanno stretto amicizia. Faheem conosce la sua situazione economica e quella sera nota la sua particolare igiene, dovuta al suo profondo credo nell’Islam. Alle 23:45 “c’è un cadavere riverso sull’asfalto all’altezza del numero civico 78 di via Ludovico Pavoni, a pochi metri da un palo della luce. A Tor Pignattara, periferia sud est” (pg. 19-20) dove è appena stato commesso un omicidio, l’omicidio di Shahzad, che non manca di testimoni: “Un uomo sulla quarantina che chiameremo Ruggero […] ha già visto quell’uomo […] tre ore prima. Alle 20:30 […] assieme alla sua compagna […] Fiorenza, e alla loro figlioletta di un anno. […] L’uomo ripete una cantilena che a lui pare una preghiera.” (pg. 20) Il tempo passa e da via Perestrello, Shahzad va sulla Casilina, incontra il suo amico e poi torna indietro, imboccando via Ludovico Pavoni. “Il canto risuona in via Pavoni altre tre volte. […] La prima volta […] dalle finestre accanto (a quelle dei due testimoni, Fiorenza e Ruggero) parte un insulto indirizzato allo straniero; […] al secondo […] (Fiorenza) osserva che lo straniero non indossa le scarpe. Al terzo […] (una) bottiglietta […] dal quarto piano di un edificio confinante […] rimbalza sul corpo dell’uomo, che smette la sua cantilena […] (mentre) vede due ragazzi in bici avanzare verso di lui. […] Dalla stessa finestra […] una voce maschile (quella di Enzo, padre del diciassettenne Sergio, l’assassino) intona: «Picchialo, ammazzalo!». […] (Sergio) sferra il primo pugno. L’uomo della cantilena cade subito a terra. Ruggero protesta. Il ragazzo infierisce con dei calci. […] Arrivano due carabinieri di pattuglia. […] il corpo (è) steso a terra (con la) faccia sull’asfalto. Solo in un secondo momento viene disposto in posizione supina, dopo l’arrivo dell’ambulanza, dal personale medico […] (che constata) il decesso di Shahzad.” (pg. 22-23) A Ulfat Jan, in dolce attesa, è stata inizialmente riferita la morte del marito come incidente stradale. Intanto si arresta Sergio, “il ragazzo che ha sferrato i colpi. […] La morte di Shahzad, sostengono i carabinieri, è stata «cagionata a titolo di dolo alternativo» […] Incorre in ‘dolo alternativo’ chi si ‘raffigura mentalmente’ le conseguenze di un gesto ‘ma non in forma univoca’.” (pg. 23) Durante la scrittura del verbale e durante il processo, tutti alludono allo stato di ebbrezza di Shahzad prima di morire, in particolare Sergio, che lo descrive come un “signore (che) barcollava in strada visibilmente ubriaco e (che) ad un certo punti mi ha sferrato un calcio alla bicicletta” (pg. 68) E, secondo Sergio, da qui proviene la sua violenta reazione. Ma “Shahzad non è ubriaco, quando cammina per Tor Pignattara pregando ad alta voce. Shahzad non è neanche un senza fissa dimora. Shahzad vive per strada la maggior parte della giornata, certamente. Non ha più una casa e dorme in un centro d’accoglienza, anche questo è vero. Ma non è tecnicamente un ‘barbone’.” (pg. 119) Sergio, in quanto minorenne, viene valutato “vittima inconsapevole di un sistema che tende comunque ad approfittarsi dei più deboli.”(pg. 72) Ma la questione è: “Si era ‘raffigurato mentalmente’ la morte di Shahzad, il giovane Sergio? E suo padre, urlando dalla finestra di casa «Picchialo, ammazzalo!» ha fatto ricorso a un’iperbole da linguaggio della strada […] o ha davvero istigato suo figlio a commettere un omicidio?” (pg. 23) L’operatore telefonico chiamato da Fiorenza sente chiaramente gli insulti che Enzo, il padre, rivolge a lei e al suo compagno, Ruggero: “«A Cretino! A comunista si merda! A comunista di merda»”, addirittura ‘zecche’, traditori che se ne devono tornare ai Parioli, in un ingiustificabile “ribaltamento […] del rapporto tra centro e periferia” (pg. 47) all’interno di “un quartiere che ha preso parte attiva alla Resistenza, nel quale le destre raccolgono tutt’ora percentuali di voto minori che nel resto di Roma, in cui è tutt’ora presente un tessuto di attivismo politico e impegno sociale” (pg. 47) Dopo la morte di Shahzad “circola una busta di plastica, si raccolgono soldi per mandare la salma di Shahzad al suo paese. Alla fine della giornata si contano quasi duemila euro.” (pg. 97). Ed è assurdo quanto poco valore si dà ai giorni nostri a un uomo in vita, alle sue necessità, ai suoi bisogni e ai suoi sogni e speranze e quante forze si impiegano per un cadavere. “Di Shahzad si é scritto molto poco, qualche notizia in cronaca di Roma e poi un paio di trafiletti via via che la storia processuale andava consumandosi.” (pg. 169) Ed è all’interno di questi testi, tra queste righe innocue che sono protetti e occultati demoni della stampa: “tra le pieghe delle parole si nascondono trappole retoriche, automatismi linguistici e tic culturali che partecipano alla costruzione del nemico. Ci sono quattro artifici retorici, sottili e ricorrenti, che vengono usati in questo genere di notizie. Prima regola: usare più aggettivi che sostantivi. Seconda regola: prediligere il linguaggio astratto. Terza regola: meglio i verbi passivi. Quarta regola: scegliere la metafora giusta.” (pg. 10) Leggendo un qualsiasi articolo, a partire da quelli sulla morte di Shahzad, si possono spesso veder applicate facilmente queste regole, che ispirano spesso messaggi subliminali: • “Non bisogna andare a vivere in un quartiere che confina con una Torre […] nella ‘giungla delle torri’ può accadere che ci si debba far giustizia da sé. E che questo comporti dei rischi e degli eccessi.” (pg. 10) • “Gli aggettivi indicano una singola proprietà di un soggetto. I nomi tendono a definire un insieme, a generalizzare. Marcano una differenza tra ‘noi’ e ‘loro’. Un aggettivo aggiunge un dettaglio. Un sostantivo traccia un confine. E la nostra storia è fatta di confini invisibili e arbitrari. Riverso sull’asfalto a Tor Pignattara c’è un ‘pakistano’. L’aggressore è un ‘ragazzo’.” (pg. 11) • “La posizione dell’extracomunitario già di per sé pare fornire un’attenuante all’aggressore italico. Viene descritta con linguaggio astratto, cioè con due aggettivi. L’azione del giovane romano è narrata concretamente, con verbi descrittivi. Il pakistano è provocatorio, il ragazzo lo colpisce. Nel primo caso, ancora una volta, il racconto di una vicenda tende ad allontanarci dal contesto e a generalizzare (gli stranieri tendono ad essere ‘provocatori’). Nel secondo caso, i verbi descrittivi si riferiscono all’azione precisa, delimitano il campo. È stata un’azione circoscritta e non ha a che fare con la natura di chi l’ha compiuta.” (pg. 11) • “Il verbo è impiegato in forma passiva […] nel caso della forma passiva si sottintende […] che (la vittima) condivida una qualche responsabilità della vittima. La forma passiva viene utilizzata più di frequente quando l’autore del reato è italiano, dicono gli studi sul linguaggio dei media.” (pg. 11-12) • “Per i migranti viene utilizzata più spesso (la metafora) della ‘bestia’ (per) alludere all’essere sub-umano del diverso. […] Per gli italiani si parla più spesso di ‘esplosione’ di un litigio, di un raptus, della violenza improvvisa e imprevedibile. Nel primo caso si tratta di una tendenza naturale, a maggior ragione ripetibile in quanto attinente alla natura del carnefice. Il raptus invece è al di fuori del controllo di chi lo compie, non interroga la responsabilità del carnefice ma allude a un episodio o a circostanze particolari che hanno indotto l’aggressore a comportarsi in un certo modo.” (pg. 12) Solitamente in questi ultimi casi, quando l’autore del crimine ha la cittadinanza italiana si tende a creare un contesto favorevole, giustificante a certi tratti, magari lasciando spazio anche “per la mamma dell’aggressore, che racconta fra le lacrime ai cronisti «è un ragazzo che ha sofferto», «non è cattivo»” (pg.12-13) o, al contrario di come accade con gli stranieri, descritti come belve, si concede allo stesso colpevole di scusarsi personalmente: “Non so cosa mi sia preso. ‘È stato un raptus’.” (pg.13) È stato dimostrato tramite esperimento, il cosiddetto ‘weapon paradigm’, che una persona che legge un qualsiasi articolo intriso di pregiudizi tende a porsi sulla difensiva davanti al ‘diverso’. Questo esperimento consisteva nel far leggere a due campioni di persone scelte casualmente due articoli: uno oggettivo e l’altro ‘di parte’. Dopo la lettura, i lettori venivano sottoposti a una piccola prova: tra una serie di foto che scorrevano, scattate a oggetti inoffensivi e ad armi, avrebbero dovuto individuare quelle che contenevano armi; tra le fotografie vere e proprie venivano inserite foto di persone dalla pelle chiara e dalla pelle scura. Si è notato che il cervello dei lettori dell’articolo ‘macchiato’ di pregiudizi verso lo straniero tendeva a riconoscere più facilmente le foto con armi se precedute da un volto nero. In queste circostanze, quindi, l’Italia diventerà devastata “da un’immigrazione insostenibile, […] è ormai terra di conquista da (parte di) persone indesiderate che hanno soltanto pretese, […] che abusano della nostra ospitalità per pugnalarci alle spalle.” (pg. 15) mentre gli italiani, invece, “popolo di migranti che deve comprendere, capire, giustificare chiunque entri in Italia, sono delle amenità tirate in ballo dai radical chic e dalla sinistra che non pagano mai il conto e da chi non vuole affrontare il problema.” (pg. 17) Non poche saranno le lamentele: “Noi italiani siamo abbandonati, per quelli là invece è tutto garantito.” (pg. 111), le ritorsioni dell’accusa di razzismo: “(Questo è) razzismo nei confronti degli italiani che non hanno gli alberghi pagati” (pg. 112), oltre all’ignoranza di sarcastici consigli: “Consigliamo ai cittadini italiani di dichiararsi profughi. È l’unico modo per ottenere tutele, vitto e alloggio gratis.” (pg. 15) Secondo l’etimologia, ‘profugo’ è colui che ‘cerca scampo’ per motivi politici, economici, etnici, sociali, geografici... Ed è stato proprio un profugo, un migrante residente a Tor Pignattara a spiegare: “Se la gente sapesse come viviamo qua, in che case siamo, in quante persone, quanto lavoriamo... Non ci crederebbero, non ci verrebbero.” (pg. 129) Le preoccupazioni continuano nel tempo: “L’immigrazione sta distruggendo la nostra coesione e la nostra identità. Non sappiamo chi ha architettato questa ‘invasione’, sicuramente c’è dietro una mano che ha la volontà precisa di voler distruggere la nostra società.” (pg. 108) e qualche volta vengono affiancate dalla paura: “Siamo molto preoccupati per l’eventualità della propagazione di malattie che […] in Italia ormai erano praticamente inesistenti.” (pg. 14) E proprio a questo proposito, “Foad Aodi, presidente dell’Associazione Medici di origine Straniera in Italia e Comunità del Mondo Arabo in Italia, invita i politici «a non creare allarmismi non giustificati creando fobie nei confronti degli immigrati». Gli esperti parlano di ‘effetto migrante sano’ […] per cui decide di emigrare solo chi è in buone condizioni di salute. Una volta in Italia gli immigrati […] vedono progressivamente depauperare il loro patrimonio di salute, a causa della continua esposizione ai fattori di rischio della povertà.” (pg. 17) È chiaro dunque che il fattore principale che scaturisce la diffidenza verso il ‘diverso’ è la “manipolazione del contesto” (pg. 13), creando vere e proprie leggende metropolitane in grado di mettere in evidenza la “paura di un’invasione silenziosa e inesorabile, ad opera di truppe all’apparenza innocue ma capaci di insediarsi sopra le nostre teste.” (pg. 129) Con lo speaker di Rtr9, Luca Casciani, abbiamo un buon esempio di quel che pian piano nel tempo ha preso una sfumatura sempre più vicina all’odio: “Quello che servirebbe è il matto, uno che in macchina ha una mitragliatrice e ne fa secchi trentaquattro. Se ne sono salvati sei, ecco il problema è quello, che se ne sono salvati sei... Quando i selvaggi si appropriano di una cosa tua, tu sei costretto a non chiamarli selvaggi, se no vieni denunciato, se no vieni chiamato razzista. Tu mantieni i selvaggi che distruggono la tua città e la tua civiltà e se provi a ribellarti ti chiamano razzista, se provi ad organizzare delle ronde ti chiamano fascista. Qualcuno mi ha detto: “Secondo te che cosa bisogna fare per vedere gli italiani che si ribellano, che scendono in piazza?” […] Ecco bisogna attendere che qualcuno muoia […] Se ti permetti di distruggere un mezzo che fa parte della collettività, la stessa collettività che ti mantiene, brutta sanguisuga schifosa, e qualcuno ti ammazza, io dico che ha fatto bene…” (pg. 113-114); E questo odio verrà trasmesso, verrà tramandato di generazione in generazione, in un ciclo senza fine se si continua a non aprire gli occhi, a non riconoscere nell’altro un nostro fratello o una nostra sorella, che va aiutato/a e che ci dovrà aiutare a propria volta. Non è una guerra tra chi è il più forte, la terra non è di nessuno. Siamo tutti di passaggio, e la vita di tutti noi è un insieme di montagne russe. Questa civiltà dell’odio ormai non è più soltanto agli inizi, ma ha già intrapreso con fermezza il suo cammino e le conseguenze potrebbero essere terribili se non fermata in tempo. “Questi ragazzi hanno già qualcosa di tremendo nelle loro mani: i semi dell’odio e della violenza. E il prete, il prete che è lì a loro servizio, dice loro che devono acquistare una coscienza di classe nella lotta contro i padroni, e che l’arma di questa lotta è la rivoluzione interna” (pg.106) È colui di cui ci si fida il miglior insegnante di noi tutti, e se egli abusa del suo ‘potere’, se incita e fa il giocoliere rovesciando i valori, solo la testa di ciascuno di noi, il nostro buon senso, se ce l’abbiamo ancora, può salvare una società verso la rovina.“Se è l’odio che l’ha portata a prendere la parola, non diamole l’antidoto dell’amore, perché quello che voi chiamate odio, in realtà è amore e quello che voi chiamate amore è il più subdolo degli odi” (pg. 104) È la politica, in fin dei conti, il burattinaio di tutti i tempi, nostri e quelli dei nostri antenati: è capace di smuovere masse intere a proprio piacimento, di governarle, di sottometterle. “La capacità leghista di recitare la parte dell’uomo comune per abbassare il livello della discussione, e di simulare rozzezza al fine di usare i media, affonda le radici nella storia stessa del partito.” (pg. 118) Con l’avvento della tecnologia e dell’informatica, poi, niente è stato più facile che diffondere informazioni e messaggi, di qualsiasi tipologia: “L’esperto e il suo team si avvalgono del contributo di ‘app’ che diffondono viralmente il Salvini-pensiero moltiplicandone la condivisione automaticamente.” (pg. 159). Approfittando del momento, il New York Times ha onorato il capo-leghista Matteo Salvini del secondo posto dopo il grillino Di Battista nella sua classifica di maggiori “spacciatori di notizie ‘fake’” (pg. 160) Chiusa parentesi. Chiaramente i “mass media e politici raramente analizzano i grandi numeri, che dimostrerebbero che i migranti delinquono meno degli italiani o che non vi è nessuna ‘invasione’ in corso. Vengono mostrati casi singoli, strumentalizzati eventi isolati.” (pg. 140) Un esempio ‘frappante’ è il primo censimento del 569 a.C.: vennero censiti tutti tranne gli schiavi; se fosse stato altrimenti, gli schiavi si sarebbero resi conto della loro forza numerica (il triplo dei liberi) e avrebbero avuto più possibilità di ribellarsi. Ritornando al mondo moderno, purtroppo “gli italiani si rapportano a questi fenomeni, pronti ad abboccare a qualsiasi bufala, a trasformare la frustrazione in aggressione e la diversità in allarme.” (pg. 39) Al riguardo, l’autore Giuliano Santoro fa riferimento all’esperienza vissuta da un giornalista che durante la notte si ritrova nel mezzo di un’operazione di controllo. Un ragazzo pakistano emette all’improvviso un grido. Si trova insieme a un uomo in divisa che viene accusato dal ragazzo di avergli tubato durante la perquisizione dei quattrini, abusando del suo potere. Il superiore fa finta di non sentire. “Al palo della morte si dipana il contesto attorno a quell’assassinio che pare casuale […] con le storie che l’omicidio di Shahzad evoca” (pg. 28) Prima di tutto però, ritengo opportuno specificare l’origine dell’espressione ‘al palo della morte’ che d’altronde funge anche da titolo al libro: ‘Palo della morte’ è il nome dato dal personaggio interpretato da Carlo Verdone in ‘Un sacco bello’ alla periferia romana. E, in un certo senso, Il quartiere dove Shahzad ha trovato la morte si trova al palo della morte. Tor Pignattara è un “quartiere multietnico che ospita cittadini provenienti da oltre sessanta nazionalità” (pg. 26) in una “città schizofrenica, che oscilla tra aggressività e calore umano” (pg. 30) Secondo una visione più interna, “in quel quartiere, pur senza la retorica utopia di un popolare pacificato, ‘pulito’, che si vorrebbe al Pigneto, si incontra e si scontra ogni giorno un popolo ben più ruvido ma reale, fatto di giovani precari, vecchi abitanti, nuovi migranti.” (pg. 96) Sulle strade si possono salutare “volti di cinesi, subsahariani, nordafricani, bengalesi. Parlano tutti romanesco.” (pg. 27) I muri di questo quartiere, nei giorni precedenti alla morte di Shahzad, sono ‘infestati’ dal “testo di una ‘lettera alla dottoressa Rossella Matarazzo’ […] (che) porta la firma ‘Cittadini di Tor Pignattara e ha (come) titolo […]: ‘I cittadini si ribellano’ […] al ‘finto buonismo’ e alla ‘finta integrazione’, ‘che di fatto non è che un’occupazione abusiva del quartiere’, visto che ‘i cittadini non hanno più una dignitosa vivibilità’. […] Chi legge riconosce il riferimento all’esperimento multietnico della scuola elementare Carlo Pisacane.” (pg. 21-22) La scuola elementare Carlo Pisacane, in particolare, è una scuola storica del quartiere in cui si cercano di far convivere e fraternizzare i bimbi delle tante nazionalità presenti a Tor Pignattara. Purtroppo però la scuola “è disertata dagli italiani, che preferiscono di allontanarsi pur di non mescolarsi ai migranti” e che quindi puntano il dito “contro i luoghi dell’istruzione meticcia” (pg.107) Questi stessi bambini della Pisacane spesso hanno testimoniato di aver visto quelli che una volta erano loro compagni ora cresciuti e diventati picchiatori. I piccoli conoscono già alla loro giovane età la dinamica, che “è sempre la stessa: si chiede una sigaretta o del fuoco e poi giù botte.” Comunque sia, le tensioni del quartiere non sono giovani come i bambini della Pisacane, ma hanno anni e anni di ‘vecchiaia’, bensì dopo la morte di Shahzad le posizioni xenofobe si siano intensificate. Ma già quando “(nella) sala dell’ex consiglio municipale […] gli amministratori del Municipio hanno consentito si tengano gli incontri di preghiera dei musulmani di zona, scatenando la campagna islamofoba di ‘Libero’: nel quartiere che è già un ‘suk’ di concedono spazi ai reclutatori dell’Isis!” (pg. 25) la diffidenza era radicata negli animi, diffidenza che, come si deduce dalla citazione di sopra, porta a generalizzare. Tuttavia, già da qualche anno prima di questo evento, Tor Pignattara si riempì di manifesti in lingua urdu che “testimoniano una comunità musulmana attraversata da conflitti e inquietudini, […] (quindi) generalizzare, raffigurare una moltitudine che si muove come un sol uomo, associare all’aggettivo relativo al paese di provenienza o alla fede di appartenenza descrizioni totalizzanti e semplificatorie, è l’anticamera della paranoia identitaria del razzismo e della guerra al diverso.” (pg. 97) Nell’inverno del 2012, a gennaio, “c’è stato il duplice omicidio di Zhou Zheng e della piccola Joy ad opera di alcuni balordi alla caccia dell’incasso del bar che Zheng gestiva.” (pg. 26) Un ragazzo bengalese, Rinku, che gestisce un negozio di generi alimentari riguardo a questo fatto specifica che i rapinatori “vengono sempre a quest’ora, quando stiamo per chiudere e abbiamo l’incasso della giornata […] La polizia viene sempre quando si tratta di farmi rispettare i regolamenti. Ma in queste situazioni non si vede mai.” (pg. 33). In onore di Zheng e di sua figlia, gli abitanti di Tor Pignattara hanno fatto una manifestazione, durante la quale “tutti […] avevano interpretato il silenzio composto che aveva accompagnato le candele di quella manifestazione come annuncio appena velato di una minaccia di vendetta spietata, più che come espressione di un dolore estremo e riservato.” (pg. 44). E infatti, dopo qualche giorno, “il corpo di Mohammed Nasiri, cittadino marocchino trentenne, penzolava da tre metri di altezza. Nasiri era ricercato […] dopo il delitto, (e dopo essersi liberato) frettolosamente di una busta con 16 mila euro sottratti al cinese con la figliuola in braccio dopo averli uccisi.” Andando a ritroso, a maggio del 1990, “in piazza Santi Apostoli compare uno striscione che ricorda i diciotto operai morti in quattro mesi. […] Tra le vittime di Italia ‘90 ci sono anche i migranti. […] Si rinnova il rito dei poveri scacciati dal centro, degli impresentabili spediti ‘ai pali della morte’ verso la periferia estrema.” (pg. 36) In questi anni gli italiani sembrano essere “oggetto di uno stress test. In concomitanza con le prime campagne xenofobe l’immaginario collettivo e l’emozione pubblica sono messi sotto torchio.” (pg. 36) Nel 1991, “al Pilastro, quartiere di Bologna […] la Banda della Uno Bianca […] semina il terrore tra gli immigrati. […] In effetti è impressionante l’escalation di attentati, colpi di pistola nel buio, bottiglie incendiarie contro le baracche, pestaggi e aggressioni, attacchi a rom e migranti. […] Roberto Sapio ipotizza apertamente che dietro le azioni criminali della banda ci siano membri delle forze dell’ordine: «Potrebbero essere persone che indossano una divisa o che, all’occorrenza, possono mostrare un tesserino». Tre anni dopo verranno arrestati i poliziotti membri della banda, alcuni dei quali con un passato di estrema destra.” (pg. 37) Nello stesso anno, “in molti paesi, sindaci e abitanti insorgono: «Non vogliamo stranieri.» […] A Roma, il cui Comune ha attribuito la cittadinanza onoraria a Nelson Mandela, esistono ormai i ghetti, e l’‘apartheid’ è un dato di fatto, senza bisogno di leggi” (pg. 41) “Il 19 aprile del 1979 un altro abitante del quartiere viene ucciso all’interno della sezione del Partito comunista proprio su via di Tor Pignattara, proprio sull’uscio di quella sezione che oggi è passata al Partito democratico.” (pg. 48) Il suo nome è Ciro Principessa, un ventitreenne assassinato da Claudio Minetti, abitante del quartiere vicino, Appio Tuscolano. Quest’ultimo, il giorno dell’assassinio, si presenta alla sezione Pci di Tor Pignattara. Passa per gli scaffali della biblioteca e prende il libro ‘I Vivi e i Morti’ di Konstantin. Ma per prendere un qualsiasi libro servono le generalità che lui non vuole dare; dunque scappa con in mano il libro. Viene inseguito da Ciro e da un compagno. Minetti si volta verso Ciro e lo accoltella. La madre dell’assassino Minetti si chiamava Leda Pagliucca ed era convivente del leader di Avanguardia Nazionale Stefano Delle Chiaie. Il fratello suicida di Claudio, Riccardo, si era tolto la vita nella prigione Regina Coeli. Al processo Minetti viene dichiarato ‘incapace di intendere e di volere’ e viene ricoverato nel manicomio giudiziario ‘per un periodo non inferiore ai dieci anni’. Intanto “gli autori della controinchiesta […] si accorgono che Mario Merlino (anarchico del gruppo 22 marzo) è un provocatore fascista, infiltrato tra gli anarchici.” (pg. 51) Quest’ultimo ha per amici Pio D’Auria, sosia del ballerino anarchico su cui la polizia indagava di nome Pietro Valpeda, Stefano Delle Chiaie, boss del neofascismo della capitale e, infine, la madre di Minetti, Leda Pagliucca. Nel libro l’argomento si approfondisce alle pagine 48-51. Ancora più indietro nel tempo, dopo la caduta del fascismo, i fascisti continuano a sopravvivere, pur mantenendo la loro “caratteristica costante nel tempo: si presentano come una rivoluzione ma operano una restaurazione. I fascisti hanno nel loro Dna l’attitudine, sospesa tra gangsterismo e opportunismo, di inseguire il denaro, di infilarsi nei posti di comando e cercarne la benevolenza. Trovare gli appoggi di qualche potente promettendogli conservazione, sicurezza, stabilità.” (pg. 50) Successivamente, negli anni Settanta a Roma, furono “ghettizzati, incapaci di agire al di fuori della dimensione di sparuta, e spesso violentissima minoranza. Vivevano braccati, in sezioni blindate, frequentavano scuole private, organizzavano eventi semi-clandestini.” (pg. 55) Già a partire dal suo periodo più ‘splendente’ “il fascismo, con la sua ossessione per il decoro, l’ordine e la pulizia, manifesta tutto il suo odio verso la gente delle borgate e le periferie in generale.” (pg.143) per il suddetto motivo, quindi, si occuperà di far allontanare e nascondere i poveri. In questo periodo i ricchi cominciano a non voler più abitare accanto ai lavoratori della capitale d’Italia, e perciò cominciano a nascere i quartieri dei ferrovieri, dei tranvieri, degli addetti ai servizi, dei lavoratori, nella trasformazione alimentare e dell’edilizia che costituiscono classi sociali a parte. Si tratta di quartieri come San Lorenzo, Testaccio, Porta Maggiore, Santa Croce in Gerusalemme (pg.141,142). È in questa atmosfera che nascono le prime borgate “pezzi di città che non hanno neppure la completezza e l’organizzazione per chiamarsi ‘quartiere’.”(pg.142) Più volte nella storia verranno menzionate proposte incentrate su “posti riservati agli extracomunitari” (pg.118) a partire dal nazista Hermann Göring (la cui proposta venne rifiutata perché non conveniente per i nazisti) per arrivare allo stesso leghista Matteo Salvini. E il razzismo e la discriminazione del periodo fascista non si riversano soltanto sugli stranieri, ma anche sui poveri, per cui nasce “la clandestinità forzata per rendere i poveri più ricattabili. Nel 1939 si approvano le leggi contro l’urbanesimo che privano i poveri che si accalcano alle mura della città di ogni diritto.” (pg. 148) In pratica, queste leggi sanciscono che “se sei povero non puoi venire a Roma, pena la clandestinità.” (pg.149). L’unico modo per ottenere la residenza dal Comune era farti approvare un contratto di lavoro stabile nella città da parte dell’Ufficio del lavoro. Nel 1949 però, “la cosa diventa un circolo vizioso quando si decide che l’Ufficio del lavoro possa concedere documentazione solo a chi sia già provvisto di residenza.” (pg.149) Spesso capitava che appresso alle mura di una città risiedessero clandestinamente un numero eccessivo di persone, per cui si venne nel tempo ad associare a questo problema uno ancora maggiore, quello dei centri di accoglienza, dei ‘barboni domestici’ e delle “grandi battaglie per il diritto all’abitare” (pg.121) e, soprattutto, sugli “abusi dei proprietari di casa che estorcono denaro con la classica truffa condominiale attuata da decine di migliaia di proprietari a Roma. Io ti affido un appartamento, poi ti riverso anche le spese straordinarie di condominio, poi mi metto pure d’accordo con l’amministratore per gonfiare ancora le rate (tanto con l’amministratore ci parlo io, non tu) , poi, se non paghi ti minaccio di sfratto e infine ti caccio di casa. E così o stai alla truffa o te ne vai.” (pg.124) Questo libro fa parte di una collana, iniziativa della Wu Ming 1 (incorporata in Wu Ming Foundation). È un progetto il cui nome è una metafora: ‘Quinto tipo’, che in ufologia significa ‘incontri ravvicinati’. Nel suo libro ‘Al Palo della morte’, quindi, Giuliano Santoro cerca di spiegare tramite un’indagine sociale e politica che arriva fino al periodo fascista quei motivi che hanno spinto il diciassettenne Sergio a far partire i tre colpi verso il suo ‘fratello’ Shahzad. L’autore stesso scrive riguardo al suo libro: “Questo racconto può giovarsi della libertà propria di strumenti come la digressione perché ha un altro scopo: mette in relazione cose differenti perché cerca di evocare ciò che ci è familiare allo scopo di turbare le aspettative, stimolare l’attenzione su quello che la realtà nasconde, individuare discordanze più che affinità. Non abbiamo bisogno di addomesticare la realtà, come hanno il compito di fare gli uomini con la legge. Si tratta di raccontare quello che è accaduto per scovarvi le possibilità.” (pg.109) Ogni umano è perfetto nel suo essere umano, perciò imperfetto. Lo stesso vale per ciò che un umano fa. Anche questo libro, quindi, ha i suoi ‘talloni di Achille’: • Parto da una frase in cui c’è un errore lessicale: “Alcuni migranti hanno edificato un altare alla dea Kalì. La statua attira il sarcasmo benevolo dei romani («la dea Kalì, che magna riso e caca supplì»)” (pg. 35) sarcasmo s. m. [dal lat. tardo sarcasmus, gr. σαρκασμός, der. di σαρκάζω «lacerare le carni» (da σάρξ σαρκός «carne»)]. – 1. Ironia amara e pungente, ispirata da animosità e quindi intesa a offendere e umiliare, che a volte può anche essere espressione di profonda amarezza rivolta, più che contro gli altri, contro sé stessi: parole, frasi, osservazioni piene di s.; parlare, rispondere con s.; fare del sarcasmo; sento del s. nelle tue parole; sentì la rabbia dentro di sé, qualcosa di molto vicino all’odio che avrebbe voluto esplodere contro quel s. assurdo e cattivo (Ugo Riccarelli). 2. Frase, espressione sarcastica: non risparmia a nessuno i suoi s.; i tuoi s. mi lasciano indifferente; il disgraziato imperatore tedesco, che Bonaparte ha tramutato da un giorno all’altro in imperatore d’Austria, è oggetto qui a Berlino di feroci s. (Alessandro Barbero). benèvolo (ant. benìvolo) agg. [dal lat. benevŏlus, comp. di bene «bene1» e tema di velle «volere»]. – Che sente o dimostra benevolenza, cioè buona disposizione e affettuosa simpatia, o più semplicem. disponibilità: padrone b. verso i suoi dipendenti; critico b.; considerare, giudicare con animo b.; prendere in b. considerazione (una richiesta, una proposta, un’offerta); giudizio, consiglio b.; sorriso benevolo. ◆ Manca il superl. regolare, cui si supplisce talvolta con benevolentìssimo (v. benevolente). ◆ Avv. benevolménte, con benevolenza, con simpatia, con favorevole disposizione: guardare, trattare benevolmente; accogliere benevolmente una richiesta. Quindi, dire ‘sarcasmo benevolo’ va al di là di ogni ossimoro, è contraddittorio. Non va bene nemmeno come ossimoro. ‘Amore odiato’ può esistere, ‘Odio amato’ ci può stare (al di là del significato bruttino), ma ‘Sarcasmo benevolo’ no. • Per un ultimo punto, che a dire il vero è quello che più mi sta a cuore vista la mia cittadinanza, è un tantino più delicato. Io sono romena, anche se nata in Italia e di varie origini. È strano come in un libro che chiaramente prova a trovare un’origine alla xenofobia di Tor Pignattara e che quindi cerca di analizzare il tutto oggettivamente (dando sempre almeno un esempio positivo, o comunque, non sfavorevole ai popoli citati) e in cui all’inizio si sono dimostrate un’evidente conoscenza e un’altrettanto evidente padronanza di quelle tecniche usate dai mass media per insinuare al cervello umano sfumature minime che però cambiano tanto, dicevo quindi, è strano come in un tale libro l’autore si sia lasciato andare a una certa negligenza nei confronti del popolo romeno. È... particolare, la tecnica delle mezze verità che utilizza, mezze verità qualche volta imbrattate di imprecisioni o ricerche superficiali che tuttavia macchiano un popolo intero. E queste imprecisioni, purtroppo, rendono il valore storico che avrebbe potuto avere questo libro così interessante un po’ dubbioso. Il perché è presto detto. Un libro storico è valido dal punto di vista storico se ogni dettaglio ha una corrispondenza precisa ben approfondita. Ma se l’autore non distingue tra un’etnia e una cittadinanza, la cosa si aggrava: c’è un’enorme differenza tra questa frase presente all’interno del libro: “Il 30 ottobre di quel 2007. Una donna di 47 anni, Giovanna Reggiani, viene brutalmente violentata e assassinata da un cittadino romeno: Romulus Nicolae Mailat, 24 anni.” (pg. 64) e la frase corretta: ‘il 30 ottobre di quel 2007. Una donna di 47 anni, Giovanna Reggiani, viene brutalmente violentata e assassinata da un cittadino romeno di etnia rom: Romulus Nicolae Mailat, 24 anni’ Una ricerca qualsiasi avrebbe ovviamente aiutato l’autore del libro a fare la differenza tra l’etnia rom (migrata anni e anni fa dal nord India e sparsasi e stanziatasi nel mondo intero, attualmente presente nella gran parte degli Stati UE, inclusa l’Italia, e oltre l’oceano; un popolo che pur essendo tanto sparso e sbriciolato e pur avendo una cultura orale è riuscito comunque a mantenere le proprie tradizioni e i propri costumi e la propria lingua inalterati e che continuano a ereditare e a tramandare; fa eccezione una piccolissima minoranza che li ha gradualmente abbandonati per farsi accogliere più facilmente) e il popolo romeno (presente nella terra dacica, della Dacia, accanto alla Pannonia e al Mar Nero e sopra ai Balcani verso gli Urali, ancor molto prima di Cristo, già a partire dal Neolitico; un popolo che, secondo i reperti storici datati a più di 6500 anni fa, custodisce una cultura - Cucuteni - che si estendeva su più di 350.000 km2 iniziali, e un’altra ancor più antica, datata a oltre 7500 anni fa secondo altri reperti archeologici - le tavolette di Tărtăria -, presumibilmente imparentata alla cultura di Vinca e dei Sumeri; quindi una cultura così antica che lascia ancora spazio ai dibattiti tra i ricercatori perché fino ad oggi nessuno è stato in grado di esprimersi con certezze scientifiche al riguardo); una differenza, quindi, che fa la differenza. Due popoli con due storie completamente diverse che però spesso e volentieri vengono interscambiati. Gli unici riferimenti al popolo romeno (di etnia romena) sono tutti negativi: • “C’erano i rumeni che acquistano la birra a buon mercato alle botteghe asiatiche.” (pg. 26) —> uso del solo sostantivo che porta a una generalizzazione stereotipata + il confronto tra: i cinesi impegnati (participio passato, quindi allora, in quella circostanza) a comunicare al telefono e con le forze dell’ordine riguardo all’assassinio di Shahzad; i pakistani, i bengalesi e gli indiani lavoratori perché gestori e imprenditori, gli italiani che vivono da sempre o che hanno scelto di vivere; e poi ci sono i romeni, che acquistano (indicativo presente, quindi un’altra generalizzazione ancora che significa ‘lo facevano allora, come lo fanno pure adesso, indifferenti a quel che succede loro intorno’). • “Voci roche di birra dei rumeni” (pg. 76) —> altro riferimento all’alcool, come se i romeni non avessero altro da fare nella vita, come se non fossero lavoratori pure loro, e anche di valore! • “Un gruppo di rumeni consuma delle birre in un locale gestito da bengalesi e si rifiuta di pagare” (pg. 79) —> riferimento all’alcol seguito da atto incivile; ci sarà pur stato il non avvenuto pagamento, ma l’insistere soltanto sui presunti aspetti negativi o su aspetti presumibilmente negativi, non è oggettivo. Guardando esclusivamente i ramoscelli secchi si perde di vista la foresta. • “Il giorno prima degli scontri di Tor Sapienza, una giovane donna ha denunciato il tentativo di stupro ad opera di due uomini riconosciuti come ‘romeni’.” (pg. 111) —> l’ennesimo esempio negativo, questa volta ancor più grave. • Due cittadini rumeni si salvano dalle fiamme gettandosi dal terzo piano.” (pg. 122) —> neutro • “A Tor Pignattara fanno scalpore e danno fastidio i capannelli di rumeni che bevono birra.” (pg.153) —> l’autore stesso riconosce la negatività nell’atto, e nonostante ciò continua a insisterci sopra. Secondo me, lettore, il pregio più importante di questo libro, voluto o soltanto conseguenza fortuita, è l’insegnamento notevole delle dinamiche di certe mentalità e gruppi sociali intorno alle varie dottrine politiche, potrei dire nemmeno di momento perché alla fine si ritrovano in quasi tutti i periodi storici più rilevanti. Roma, 03/01/2020 Isabella Tokos, 3A