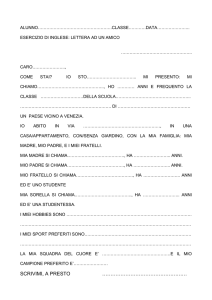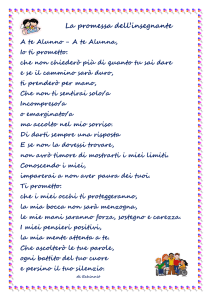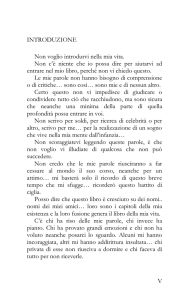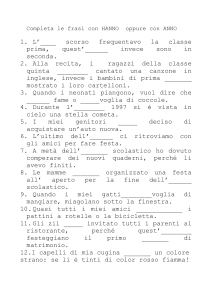caricato da
common.user7315
Tagore: Poesie Gitanjali e Il Giardiniere (Newton Classici)

7 Titolo originale: Gitanjali - The Gardener Prima edizione ebook: luglio 2012 © 1971, 2007 Newton Compton editori s.r.l. Roma, Casella postale 6214 ISBN 978-88-541-4285-5 www.newtoncompton.com Edizione elettronica realizzata da Gag srl Rabindranath Tagore Poesie Gitanjali – Il Giardiniere Introduzione di Alessandro Bausani Traduzione integrale di Girolamo Mancuso Edizione integrale Newton Compton editori Tagore visto da un non-tagoriano Introduzione di Alessandro Bausani Il mio primo contatto con Tagore risale all’adolescenza, quasi all’infanzia. Ero ancora un bambino (avrò avuto 11-12 anni) quando lessi per caso l’esile, simbolico dramma di Rabindranath, L’Ufficio Postale, nelle benemerite, e, ora, credo, introvabili, edizioni del Carabba. L’impressione che mi fece fu fortissima: fu forse il mio primo contatto col simbolo e, per me, animo inguaribilmente religioso, il primo contatto con un modo d’essere religioso diverso, più libero del rigido dogmatismo cattolico tomista in cui già cominciavo a venire educato. Da allora in poi tutte le mie successive letture di Tagore avvennero, per così dire, sotto il segno di quella prima impressione. Tagore cioè rimase per me qualcosa di bello, di dolce, di addirittura trepidamente pauroso e affascinante assieme, ma, anche, sempre, qualcosa di immaturo, di infantile, di esile. È per questo che parlare ora di Tagore si identifica quasi a un parlare di un malioso, sì, ma quasi irreale, quasi non serio, sogno lontano. Non starò a ripetere i dati, che dovrebbero essere noti a ogni italiano ed europeo colto, della vita del Poeta. Ricordo solo i punti essenziali, pel legittimo sospetto che qualcuno li abbia dimenticati. Tagore1 è indiano, questo tutti lo sanno, ma è anche nativo della forse più vivace zona dell’India, il Bengala. (Nacque a Calcutta il 6 maggio 1861 e morì nella stessa città, ottantenne, il 7 agosto 1941). Scrisse soprattutto in due lingue, l’inglese, la lingua franca della intellighenzia indiana di allora e di ora, e in bengalese, una delle più melodiose lingue arie del subcontinente, che qualcuno chiama «l’italiano dell’india». È noto che molte sue opere furono, anzi, scritte da lui due volte, in bengalese e in inglese. Di pochi autori in lingue esotiche abbiamo quindi traduzioni più autentiche di quelle di certe opere tagoriane, dato che le curò l’autore stesso. Altro dato di fatto importante: Tagore apparteneva a una delle più ricche e influenti famiglie del Bengala. il nonno Dwarkanath fu un attivo partecipante a quel movimento religioso noto come Brahmo-Samaj (Congregazione, o Società, di Dio) fondata nel 1828 da Raia Rammobun Roy, che aveva lo scopo di conciliare il principio monoteistico del Cristianesimo e dell’islam con il panteismo indù, purificando l’induismo dagli aspetti idolatrici, ritualistici, castali. Il padre di Tagore, Devendranath, fu anzi il capo di un ramo, da lui riformato, della «Società di Dio»: fu lui che, a un centinaio di chilometri da Calcutta, fondò il famoso eremo, poi trasformato da Rabindranath in università di tipo nuovo, di Shanti Niketan, «Asilo di Pace». Di primo piano nella vita intellettuale e spirituale del Bengala furono anche i fratelli del poeta, il filosofo Dvijendranath, il pittore Abanindranath, mentre altri Tagore eccelsero nella musica, nello studio delle letterature straniere e in altri campi. Un essere fortunato dunque, in tutti gli aspetti, il nostro Tagore, immerso fin dalla nascita negli agi e nella più raffinata cultura, con possibilità di viaggiare (già diciassettenne andò a studiare a Londra), e che del dolore conobbe solo gli aspetti «privati» (suicidio della cognata cui lo legava un tenero affetto, morte della moglie e di due figli in tenera età). Ma fortunato anche nel senso che questa sua serenità concessagli dal fato la mise al servizio degli altri, specialmente nella sua grandiosa opera educativa, la già menzionata università di Shanti Niketan, dove, all’aperto, si insegnavano (e si insegnano) il sanscrito, il bengali, l’inglese, le matematiche, le scienze fisiche e naturali, la storia, la geografia, la musica, le belle arti, e dove, all’ombra stormente dei grandi alberi, gli allievi si esercitavano nell’agricoltura, nel lavoro manuale, nella ginnastica. Ritmavano la vita della scuola la recitazione di drammi, conferenze religiose, meditazioni, preghiere. Il famoso libretto Sadhana, la «presa di coscienza» della vita, pubblicato a Londra per la prima volta nel 1913 e poi più volte ripubblicato e tradotto in varie lingue, è appunto la raccolta di una parte delle conferenze fatte da Tagore a Shanti Niketan. Non gli mancarono nemmeno la fortuna e la fama letteraria: come è noto nel 1913 ottenne il premio Nobel. Altro dato di fatto: la sua diffidenza e non approvazione per il programma rivoluzionario - seppur non violento - di Gandhi e questo non tanto per simpatia particolare verso gli inglesi (che pure Tagore considera i migliori fra gli europei e utili all’India) ma per un istintivo disgusto per quella rottura di una serenità interiore, per quella agitazione «fanatica», per quel pericolo di idolatria di una patria quasi deificata, sentimenti che mette in bocca, per esempio, al principe Nikhil, l’eroe del suo romanzo The Home and the World. L’Oriente per lui ha molto da imparare dall’Occidente (libertà individuali e sociali, progresso civile ecc.) e l’Occidente dall’Oriente (la serenità, la pace dello spirito, il gusto della meditazione e del silenzio). Non sembri una malignità il dire che quando Tagore fu, nel 1925 e nel 1926, in Italia, ebbe parole di ammirazione per il regime che allora vi dominava, anche se, al ritorno, smentì in parte quelle sue impressioni. Lo ricordiamo non certo per condannarlo ma per mostrare un piccolo esempio concreto della sostanziale ingenuità della sua ideologia. Ma quale era questa «ideologia»? Per comprenderla non si può non meditare un poco sulle condizioni dell’india dell’800. Tre elementi contribuivano a formare l’atmosfera così singolare di quelle regioni in quel periodo: la cultura inglese, l’islam, e l’induismo. Nella prefazione alle sue interessanti Lettres sur l’Inde, scritte nel 1888, il grande orientalista francese James Darmesteter così si esprimeva sui funzionari inglesi in india: «Je ne crois pas qu’il soit possible de trouver dans un gouvernement étranger plus de conscience, d’honnêteté professionnelle, de désir sincère de faire son devoir et de faire le bien que n’en montre en général le fonctionnaire anglais dans l’inde... Malgré les quelques scandales qui éclatent de temps en temps il n’y a jamais eu dans les provinces romaines, même sous les Antonins, tant de pouvoir et de tentations avec si peu d’abus. Mais à ces maîtres honnêtes manque le don suprême, le seul qui fasse pardonner les supériorités écrasantes: la sympathie». Forse meno onestà e più fraternità ignara di divisioni razziali avrebbero reso più simpatici i dominatori, rigidamente separati dall’elemento indigeno e che solo riuscirono a formare una classe colta indiana parlante inglese, ma nel contempo, priva di reale partecipazione agli elementi vitali profondi che la cultura inglese forgiarono: cristianesimo di un certo tipo, senso della home e della privacy ecc. L’islam indiano, abbracciante una popolazione che era allora sui sessanta milioni (ora fra india e Pakistan quasi centocinquanta!), fecondo di sette moderniste e innovatrici, in certi ambienti non ancora dimentico dei generosi tentativi universalistici di pacificazione fra le religioni di Akbar (XVI sec.) o di un Dara Sbikob (m. 1659) lo sfortunato principe sincretista allievo di sufi musulmani e di bramini indù, reso invece in altri ambienti particolarmente rigido dalla vita comune con i «pagani» indù e i bellicosi sikh, non dimenticava di esser stato per secoli, cioè dai secc. X-XI fino alla venuta degli inglesi, la classe di governo dell’india, il nemico delle caste e dell’idolatria, l’elemento di unità politica, l’unica forma di stato unitario e, relativamente, moderno che l’india - ricca di profondi pensatori e metafisici e asceti ma ignara della spiritualmente organizzata mondanità dell’islam - avesse mai avuto. E, ancora, il mare magnum dell’induismo, miracolosa permanenza fin in epoca moderna di una religione di tipo arcaico, come l’antico paganesimo grecoromano, complesso inestricabile di riti superstiziosi alla base, di altissime meditazioni panteistiche nei suoi vertici più alti, religiosità più che religione, abbracciante e il sistema delle caste e le arditissime affermazioni nichilistiche di certi suoi sistemi filosofici e l’evangelicità un po’ vaga dei movimenti bhakti (devozionali) di filiale adorazione di un dio «unico» scelto fra i tanti del pantheon, che libera per l’amore che gli si porta e per l’amore universale che si esercita amandolo. L’alta società indù, liberata dal dominio musulmano degli imperatori Moghul per opera degli inglesi, fu all’inizio più disposta di quella musulmana ad assorbire la cultura «straniera», anche per la sua maggiore flessibilità e la sua disposizione assimilativa. inoltre, proprio in quella seconda metà dell’Ottocento che ci interessa, l’Europa «riscopriva» la cultura indiana antica. Gli intellettuali europei si entusiasmano per il sanscrito, di cui si creano numerose cattedre nelle università, si domandano se in fondo l’antico panteismo indiano e le sue filosofie non siano più adatte al mondo moderno, non siano più liberatrici che la religione «semitica» ebraico-cristiana, monoteistica, da loro (ufficialmente) praticata. E, cosa curiosa, è proprio per influenza di questa riscoperta europea che in India si guarda di nuovo con occhi di ammirazione all’antico passato. E un fatto - che probabilmente pochi conoscono in Europa - che il dominio musulmano in India, durato per tanti secoli, aveva quasi convinto gli indiani stessi del contrario di quello che l’Europa andava riscoprendo: di una certa superiorità - più o meno coscientemente confessata -, dell’etica monoteistica, che fra l’altro portava a risultati sociali liberanti (l’Islam per esempio non conosce caste) sul «paganesimo» tradizionale indù. Chi visiti un antico tempio indù e vi veda certe singolari sculture dove l’eros, anche nei suoi tratti più aberranti, viene plasticamente rappresentato (l’infinita ricchezza del simbolo... dicono gli ammiratori), resta stupefatto paragonando questa libertà espressiva antica alla pruderie degli indù moderni. È un piccolo esempio pratico della influenza musulmana che ha cambiato l’«atmosfera» indiana molto più di quanto non si creda. Nasce da tutto questo quell’India «moderna» di alto livello (diversa è la situazione dei villaggi) nella quale, a prescindere dalle «filosofie» e dalle religioni ufficialmente professate, si è creata una inestricabile miscela di costumi etici inglesi, di tendenza alla venerazione dei Maestri e dei Santi, di tenace attaccamento alle forme della tradizione, di un vago idealismo che identifica l’India madre come patria della spiritualità e l’Occidente come patria del materialismo. Ma accanto alle alte classi brulica la immensa maggioranza degli affamati. Per colpa di chi? È di moda ora sia in India che fuori, di attribuire tutte le colpe al «colonialismo». Ma sarebbe difficile minimizzare la tirannia e l’ingiustizia dei regimi indiani cui il colonialismo inglese si sostituì, meglio ancora la loro arcaicità. Sono note le parole di Marx, non sospettabile di filo-colonialismo, nel suo noto articolo sulla «Dominazione britannica in India», ma vale la pena di rileggerle ancora una volta: «Ora, per quanto sia sentimentalmente deprecabile lo spettacolo di queste miriadi di laboriose comunità sociali, patriarcali e inoffensive, disorganizzate e dissolte nella loro unità, gettate in un mare di lutti e i loro membri singoli privati ad un tempo della forma di civiltà tradizionale e dei mezzi ereditari di esistenza, non si deve dimenticare che queste idilliche comunità di villaggio, sebbene possano sembrare innocue, sono sempre state la solida base del dispotismo orientale... Non si deve dimenticare che queste piccole comunità erano contaminate dalla divisione in caste e dalla schiavitù; che assoggettavano l’uomo alle circostanze esterne invece di erigerlo a loro sovrano e, trasformando uno stato sociale autoevolventesi in un destino naturale immutabile, alimentavano un culto degradante della natura il cui avvilimento si esprime nel fatto che l’uomo, il signore della natura, si prostra adorando ai piedi di Hanuman la scimmia e di Sabbala la vacca. È vero: nel promuovere una rivoluzione sociale in Indostan la Gran Bretagna era animata dagli interessi più vili e il suo modo di imporli fu idiota. Ma non è questo il problema. Il problema è: può l’umanità compiere il suo destino senza una profonda rivoluzione nei rapporti sociali dell’Asia? Se la risposta è negativa, qualunque sia il crimine perpetrato dall’Inghilterra essa fu, nel provocare una simile rivoluzione, lo strumento inconscio della storia». (In K. Marx - F. Engels, India, Cina, Russia, a cura di B. Maffi, Milano 1960, p. 61). Idoleggiare le comunità di villaggio indiane di cui parla Marx è molto di moda ora in India, sulla falsariga proprio di certe tendenze di Tagore, di Gandhi e anche di certi membri della élite, ormai stanca, di quelle stesse nazioni europee che quelle comunità hanno distrutto per il loro interesse. Tagore e altri indiani di alta classe, come lui addolorati per la situazione dei «poveri» loro connazionali, non mi sembra siano andati molto a fondo nello studio delle radici del problema: erano forse inconsciamente spaventati dal fatto che, se tale studio essi avessero compiuto senza pietà, avrebbero dovuto giungere alla conclusione che «era sbagliato» insistere proprio sulla loro «tradizione» nazionale. Così distaccarono dal tutto compiuto della tradizione certi aspetti più vagamente e romanticamente generalizzabili, accettabili (e accettati dal filo-esotismo occidentale) cioè la religiosità panteisteggiante (ignari che di fatto quello significava anche «caste»), la meditativa dolcezza (ignari che di fatto quello significava anche rassegnazione sterile), persino il «puro» e primitivo «socialismo» agricolo (ignari che l’arcaica cooperazione contadina di villaggio significava anche, come ben dice Marx nello stesso articolo poc’anzi citato, «un egoismo barbarico che, concentrandosi tutto su un misero lotto di terreno, aveva assistito inerte alla rovina di imperi, alla perpetuazione di crudeltà indicibili, al massacro della popolazione di grandi città»). L’atteggiamento del ricco intellettuale indiano verso «i poveri» del suo paese è ottimamente espresso in un libro illuminante sull’india moderna, quello di R. Segal The crisis of India (la prima edizione inglese del 1965 fu «bandita» in india, ma poi il libro si ripubblicò a Bombay nel 1968). L’autore, dopo aver detto che da principio fu stupito del fatto che i nuovi dirigenti indiani potessero tanto attivamente discutere della povertà dell’india senza mai riferirsi concretamente ai poveri, aggiunge che solo quando ebbe occasione di parlare con un industriale indiano (l’autore non lo dice, ma quell’industriale poteva benissimo, da esperienze analoghe avute da me, dichiararsi un attivo «socialista») capì il mistero: «Stavo parlando di un grosso, fetido quartiere di baracche a solo tre o quattro miglia di distanza dalla casa del mio ospite, quando egli mi interruppe dicendomi con voce sorpresa: "Ma come, c’è ancora? Credevo che lo avessero tolto mesi fa!”. Sono sicuro che l’industriale non solo non aveva mai sentito alcun motivo per visitare quel quartiere, ma che anzi era passato là accanto nella sua auto parecchie volte nei mesi precedenti. Il fatto era che semplicemente non lo aveva notato. Improvvisamente mi venne alla mente quanto egli fosse simile a un bianco sudafricano (N.B.: l’autore è egli stesso sudafricano). Infatti i bianchi sudafricani sono spesso sorpresi e increduli quando si parla loro dello squallore e della malattia che si trovano ad appena poche miglia di distanza dalle loro stesse case. Non notano la sofferenza nella loro stessa cucina, perché in realtà non vedono letteralmente i non-bianchi che lavorano per loro... Senza questo camuffamento psicologico si sentirebbero assediati e la sopravvivenza stessa diverrebbe per loro una questione tormentosa invece che un presupposto automatico. In India, come in Sud Africa, molto più che la intoccabilità, è l’invisibilità che sta alla base di un governo comodo» (Op. citv p. 133). E, a proposito della «dolce idillicità» delle comunità agricole di villaggio vale la pena di riferire l’agghiacciante inchiesta del sociologo indiano Kusum Nair nel suo libro Blossoms in the Dust (Fiori nella polvere). Egli durante un anno, nel 1958-1959, visitò villaggi indiani in differenti stati. In un villaggio presso Madras egli pose a un gruppo di contadini poverissimi, che riuscivano miracolosamente a sopravvivere con molto meno delle calorie sufficienti per un normale essere umano, la seguente domanda: «Se il governo vi offrisse quanta terra volete, del tutto gratis, quanto chiedereste?»... «Samu è il primo a parlare. È un vecchio che non ha mai posseduto terra. La sua famiglia è composta di cinque membri, ma vuole solo poco più di un acro di terra (N.B.: un acro è meno di mezzo ettaro). È preciso nella sua richiesta, anzi, dopo un breve calcolo mentale, aggiunge che anche da quello gli sembra giusto di dare il 50% del prodotto al padrone. Rangarajan è di mezza età, esile e emaciato. Anche lui ha da nutrire cinque membri della famiglia e si accontenterebbe di due acri (ancor meno di un ettaro)». Le risposte di molti altri non superano le quantità precedenti (op. cit. pp. 30-31). Altri contadini poverissimi dissanguati dagli usurai e che lavorano a salari di fame come manovali e servi a giornata, interrogati sulla possibilità di distribuzione ai contadini di almeno parte della terra risposero allo stesso intervistatore: «No, non mi piacerebbe una simile legge. Per principio. Ritengo moralmente sbagliato distribuire gratis terra altrui». Solo uno, alle insistenze dell’intervistatore, che gli dice che, comunque, i proprietari sarebbero indennizzati risponde: «Be’, in questo caso accetterei di prendere della terra, ma solo col consenso del padrone. Io, per me, prenderei solo un acro (0,40 ettari!!!). Mi basterebbe. Ma se sapessi che la terra è presa con la forza e distribuita ai poveri non la prenderei». La morale è in questo caso, in lingue indiane, il dharma, la «legge» sacra, quello stesso dharma cui inneggiano (seppure sotto altri aspetti) i romantici lodatori della spiritualità indiana, incluso Tagore e i filo-esotisti europei. Ognuno ha il suo dharma: è dharma del povero fare bene il povero, è dharma del ricco fare bene il ricco, assicurandosi così una «rinascita» positiva. Potrà sembrare strano a qualcuno che io abbia preso metà delle pagine assegnatemi per questa introduzione parlando di cose che sembrano così lontane dalla fascinosa poesia di Tagore. Il fatto è che ho sempre sentito necessario - e mi scusino gli amici indiani, ma è proprio per affetto verso di loro che lo dico - quando si parla della pura e tradizionale e sublime spiritualità dell’india, di mostrare anche il rovescio della medaglia, di mostrare cioè che una «tradizione», una cultura completa non può ignorare anche l’altro lato del composto umano, la tanto bistrattata «carne». Ma va ora detto qualcosa sulla struttura estetica della poesia tagoriana. Alla sua formazione, ancora, non contribuisce solo la tradizione letteraria indiana, e in particolare bengalese, ma anche una certa atmosfera estetica europea e soprattutto inglese del periodo in cui l’arte di Tagore si formò, cioè la seconda metà dell’800. Uno dei motivi per cui Tagore, e in filosofia politica Gandhi tanto piacciono agli europei è anche il fatto che hanno parlato in forme non del tutto indiane, ma hanno presentato la cultura indiana in moduli espressivi comprensibili a un europeo colto. Gandhi non sarebbe forse esistito se la cultura indiana si fosse sviluppata in modo totalmente indipendente, per esempio, dal pensiero cristiano. Egli stesso ammette di non aver mai studiato il sanscrito e di aver letto il Vangelo prima della Bhagavadgita. Così Tagore non è quello che sarebbe stato poeticamente se la letteratura bengali si fosse sviluppata senza alcun contatto con la letteratura inglese dell’800. Provate a leggere un testo indiano autentico, precoloniale (la Gita stessa, per dirne uno dei più accessibili, o il Gitagovinda del bengalese Jayadeva) e vedrete quanto più difficile vi riuscirà di portarli a termine con piacere estetico (sottolineo estetico, non parlo di piacere filosofico-intellettuale) senza una lunga preparazione. Nel caso della poesia di Tagore, poi, il fatto che egli conoscesse così bene l’inglese e che traducesse e adattasse egli stesso i suoi versi in quella lingua, in certo senso complica il problema anziché facilitarlo. Infatti così facendo il Tagore anglofono crea verso la comprensione estetica dell’originale una intercapedine forse più grande di quella di una qualsiasi traduzione diretta. Traduzione che ogni generazione può fare secondo il suo gusto estetico. Potrà così esistere un Tagore rivissuto con mezzi espressivi del ’900 o, in futuro, del XXI, XXIl secolo. Ma siccome Tagore ha egli stesso interpretato il suo originale in moduli inglesi dell’800 si ha la tentazione di sentirsi legati a quella interpretazione, che, se pur originata dall’autore, resta sempre una interpretazione. Ed è, per di più, l’interpretazione di un indiano colto dell’800 che cerca di immaginare quello che - a suo parere - può più piacere, dello spirito indiano, a un inglese colto suo contemporaneo o che può essere a lui meglio adattabile. Ricordo la singolare impressione che ebbi quando, dopo aver letto le solite traduzioni di versi di Tagore dall’inglese, mi accadde di sentir cantare da un piccolo coro indiano una semplice ode del poeta in bengalese. Mi parve qualcosa di totalmente diverso da quello che credevo fosse Tagore: anziché fare accostamenti istintivi con Wordswortb, Keats o altri europei pensavo alle antiche doha bengali, alla poesia strofica popolare di altre lingue indiane, così «autentica» e saporosa di villaggio, ingenua sì, ma non così teosoficamente pseudo-ingenua come talora qualche poesia di Tagore appare in inglese. Perché il lettore possa toccar con mano la differenza, vorrei riprodurre qui, nel testo originale trascritto in caratteri latini con traduzione interlineare e letterale in italiano una poesia della collana Gitanjali, contenuta in questo volume. Credo infatti che la pretesa «difficoltà» strutturale delle lingue orientali sia un mito (mito d’altronde molto comodo per noi orientalisti...): il bengalese è certo più facile del greco e del latino e anche di una lingua europea moderna come il tedesco o il russo. Per la pronuncia di questa trascrizione si leggano grosso modo le consonanti all’inglese e le vocali all’italiana: megher pore megh jomeche, di-nube sopra nubi si-sono-ammassate andhar kore ashe; -tenebra fatta viene amay keno boshe rakho me perché seduto tieni eka ddarer pashe? solo della-porta presso? kajer dine nana kaje del-lavoro nel-giorno vario in-lavoro thaki nana loker majhe rimango varia di-gente in-mezzo aj ami je boshe achi oggi io che seduto sono tomari ashshashe di-te nella-consolazione amay keno boshe rakho me perché seduto tieni eka ddarer pashe? solo della-porta presso? turnì jodi na dekha dao tu se non visione dai koro amay hela fai me trascuratezza kemon kore kate amar come facendo trascorre mio emon badol bela? tale nuvoloso tempo? durer pane mele ankhi di-distanza in-direzione aprendo occhi kebol ami cheye thaki, solitario io mirando sto poran amar kende beray anima mia piangendo vaga duronto batashe crudele in-vento amay keno boshe rakho me perché seduto tieni eka ddarer pashe? solo della-porta presso? Kh e jh si pronunciano come k + h, j + h, cioè come le occlusive c italiana in casa e g italiana in genio seguite da aspirazione. La traduzione interlineare è strettamente letterale e darà facilmente al lettore una idea elementarissima della grammatica e della sintassi bengalese. Vi noterà così che -er o -r è un genitivo (megh = nuvola, megher = della nuvola), che -e può essere una specie di locativo, che esistono verbi composti (tenebra fatta viene = si vien facendo scuro, ecc.). Eccone una traduzione in linguaggio corrente: Nubi su nubi si accumulano, stanno oscurando il cielo. Perché mi tieni seduto solo accanto alla porta? Nel giorno del lavoro in varie faccende resto occupato in mezzo a svariate persone, ma oggi, se me ne sto seduto, nell’attesa di te... Perché dunque mi tieni seduto solo accanto alla porta? Se tu non ti fai vedere e di me non ti curi come potrò trascorrere un tempo sì pieno di nubi? Con gli occhi aperti verso lo spazio lontano me ne sto solo, a guardare; l’anima mia vaga piangendo nel vento crudele. Perché dunque mi tieni seduto solo accanto alla porta? Si noterà intanto, dal testo originale, la agile varietà delle rime e dei ritornelli, del tutto perduta nella traduzione. Non va dimenticato che le poesie tagoriane, come del resto molte o tutte le poesie non solo indiane ma asiatiche in genere, sono fatte per essere cantate, non dette, o, peggio ancora, intellettualisticamente pensate. E si tratta di un canto che il mondo attuale, molto più nervoso e agitato del tradizionale, chiama in genere «monotono» e sente come tale, perché è pacificante, tranquillizzante, non agitato. Tagore stesso chiamava la musica occidentale «troppo definita, materiale, concreta». Per meglio intendere almeno il ritmo si tenga presente che il bengali possiede un accento ritmico sulla prima sillaba. Così, per quanto riguarda la prima parte della prima strofe, essa va letta così: mégher pore mégh jomeche àndhar kòre àshe àmay keno bòshe rakho éka ddàrer pàshe... Tagore fu un maestro riconosciuto nella creazione dei più svariati schemi metrici, inventandone di nuovi e adattando ritmi e metriche tradizionali. La poesia tradizionale bengalese è, infatti molto meno ricca di varianti ritmiche e di rime di quella tagoriana. In questo Tagore (ma è un merito che è difficile cogliere in traduzione e per di più senza conoscere la poesia tradizionale indiana in genere e la bengalese in particolare) rappresenta qualcosa di fondamentale nello sviluppo della letteratura del suo paese. Abbiamo già detto che egli era anche musicista, oltre a tante altre cose: e compose egli stesso i motivi musicali, semplici e orecchiabili, delle sue poesie, delle quali noi, lo ripeto, attraverso la doppia traduzione, riusciamo a captare solo l’aspetto discorsivo-intellettuale. Per quanto riguarda il contenuto, poi, si noti la vaghezza espressiva del testo. Non è chiaro, e vuole esser lasciato non chiaro, se chi parla è un uomo o una donna, non esistendo (salvo certi casi) in bengali il genere grammaticale. Quindi canto d’amore o canto religioso? Ambedue, forse. È l’anima che aspetta il suo Dio, o la sposa che aspetta il marito lontano? Quello della sposa in attesa è infatti un motivo che si ritrova nelle più diverse letterature popolari indiane e che è ignoto, per esempio, nella persiana classica che molto influenzò in India certe forme di espressione soprattutto hindi-urdu. I versi cioè sono messi in bocca a donne. Per non fare che un esempio lontanissimo dal Bengala, sia geograficamente sia religiosamente, il poeta musulmano in lingua sindhi Shab Abdullatif (morto nel 1752) nella sua raccolta di versi ha moltissimi esempi di canti di una sposa che, nella stagione delle piogge, attende il marito lontano. Il motivo dunque, non è affatto, in sé, originale. (Ecco un altro punto che va considerato leggendo certa poesia orientale che sembra a noi occidentali originale perché non ne conosciamo abitualmente che qualche esempio isolato). E piace proprio perché originale non è, perché il Vate sa ridire in modi belli motivi «accettati», eterni. Tagore è maestro nell’esprimere con sfumature nuove motivi che sono in fondo «popolari». Come molti aristocratici delle società tradizionali quando ancora funzionavano armonicamente, egli non dà solo il pane fisico alla sua famiglia patriarcale, ma anche il pane spirituale. (Per l’Europa tradizionale si pensi a un raffinatissimo aristocratico come Góngora che riesce a creare squisiti bozzetti popolari, coplas e romances perfetti). Per l’India in particolare va sottolineata questa importante funzione culturale della poesia. Anche degli analfabeti conoscono e cantano i versi di Tagore: la cultura è ancora in buona parte parlata, i poeti sono ancora qualcosa di simile ai giornalisti da noi, e c’è ancora (forse per poco) una osmosi culturale fra classi alte e classi basse, malgrado gli abissi, già visti e deprecati, delle caste. Nel caso di Tagore abbiamo un poeta che si fa educatore imbevendosi della dottrina tradizionale in cui è nato, amalgamandola con echi europee, semplificandola, togliendovi elementi ormai superati e ridonandola al popolo in semplici canti. Ma quel dono, ci si può chiedere, che effetto pratico avrà? Positivo certamente per la classe media in formazione, già in parte liberata dai pregiudizi di un induismo troppo greve; ma sorge il ragionevole dubbio che il «popolo» degli affamati del tipo dei Samu e dei Rangarajan intervistati da Kusum Nair, si senta semplicemente confortato, da quel tipo di poesia, nella sua fedeltà a un dharma buono in antico ma che nella società moderna diventa anziché incentivo alla spiritualità, incentivo alla materialità degli altri. Quanto all’effetto che la poesia di Tagore fa o può fare sugli occidentali, sarà positivo, se essa farà loro capire che esiste qualcosa oltre il danaro e «la civiltà dei consumi» (un qualcosa che del resto essi hanno anche nella loro tradizione, ma lo hanno spesso dimenticato), o sarà addormentante, incoraggiando una spiritualità panteistico-mistica. Viene naturale paragonare l’ispirazione mistica della poesia tagoriana con quella di una religiosità attivistico-volontaristica, a forte carica evolutiva, aperta verso impensati mutamenti futuri, propria del suo contemporaneo musulmano Muhammad Iqbal (1873-1938). Alla morte di Iqbal Tagore stesso del resto dichiarò che «la sua morte creava nelle letterature indiane un vuoto che, come una ferita mortale, ci vorrà molto tempo a guarire». Si confronti questa breve poesia iqbaliana con quelle di Tagore raccolte in questo volume: No! Questo mondo decrepito deve diventar giovane ancora, e una sua pagliuzza dev’essere dura e greve qual monte! Quel pugno di terra che onniveggente sguardo possiede nel [petto2 abbisogna di grida impastate di cuore! Questo vecchio sole, questa vecchia luna camminano senza [meta ciechi stelle nuove ci vogliono per ricostruire il mondo! Ogni bella fanciulla che mi si presenti allo sguardo è bella, sì, ma più bella dev’essere ancora! Iddio mi dice: «Così è, e tu non dir più parole!» Ma risponde l’uomo: «Così è, ma altrimenti deve essere, [e meglio!» (M. Iqbal, Il Poema Celeste, a cura di A. Bausani, Bari, 1965, p. 248). È lo storicismo religioso del «dover essere» (Iqbal) di fronte alla mistica della «fusione con l’Essere» (Tagore), la linea retta e aperta verso il futuro, di fronte al circolo, al ciclo eterno della maya. Ambedue le tendenze ci sono familiari nella nostra tradizione occidentale, già da antico: è in fondo l’eterno contrasto Parmenide-Eraclito che continua in forme diverse. Il mondo moderno sembra abbia scelto Eraclito, spogliandolo delle valenze religiose. L’India li ha continuati ambedue ma con una notevole preferenza per Parmenide: e non è questa l’ultima ragione per la quale gli occidentali sembrano preferire un Tagore, più apparentemente lontano da loro, e che per di più sa esprimersi in una forma comprensibile all’Europa, a un Iqbal, che ricanta, in forme tradizionali di non facile traduzione formale, idee che ci sembrano (a torto) «scontate». Ma ora qualche parola va detta sulla prosa tagoriana, sebbene si tratti qui di un libro di poesia. Anche in questo campo Tagore fu un innovatore, trasformando il romanzo e la novella bengalesi anteriori a lui e troppo spesso intrise di elementi didascalici e insopportabilmente moralistici, in qualcosa di più simile alla narrativa «moderna», realistica. Questo della prosa moderna è del resto il problema estetico più difficile delle nuove letterature asiatiche, problema riducibile a questo: come inserire il realismo moderno in tradizioni letterarie essenzialmente «platoniche» per le quali quel che conta è l’eterno e non il fatto puntuale e transitorio, e il simbolo è più importante, anzi più reale della realtà? È in dubbio che la letteratura bengalese fu, nella prosa, all’avanguardia delle altre letterature indiane, ma mentre il romanzo, come dicemmo, assume toni didascalicomoralistici per noi europei difficilmente apprezzabili, la novella spesso scade a bozzetto (pseudo) realistico. Romanzi tagoriani come Gora (Viso pallido, nome che si dava in India agli europei), Ghore bahire (The Home and the World, in bengali, «A casa e fuori») o Noukadubi (Il naufragio) sono certo più leggibili dei romanzi fiume di Bankim Chatterji (1838-1894). La tecnica di Ghore bahire, per esempio, è piuttosto nuova per l’India. Si tratta di eventi visti dai vari protagonisti che parlano uno dopo l’altro in prima persona e rendono il romanzo piacevole a leggersi, non privo persino di una certa suspense: memorie e presente - si è detto - «vi si amalgamano insieme nei colori bruciati di un dormiveglia tropicale». Ma migliori dei romanzi sono le novelle brevi di Tagore, relativamente poco note in Europa, e nelle quali la tecnica matura di una narrativa che conosce tutti i sistemi dello stile occidentale si fonde con il solito esile misticismo tagoriano dando talora dei risultati di un - direi - simbolismo realistico di trasognata efficacia. Enorme fu l’influenza stilistico-letteraria di Tagore non solo sulla letteratura bengalese - nella quale lo ammirano ugualmente, e lo imitano, sia indù sia musulmani - ma anche su altre letterature indiane moderne. Influenza tuttavia che si fa sentire più sulla prosa che sulla poesia: se infatti la prosa fu continuata ed evoluta divenendo strumento agile ed efficace per l’espressione di problematiche più moderne, la poesia sembra sia restata (è il caso parallelo anche per Iqbal nella letteratura urdu) difficilmente «continuabile». Si esita ora fra una poesia ultra-libera di un realismo in qualche caso semi-pornografico (di imitazione occidentale) che si ritiene rivoluzionaria, e una imitazione più o meno ben riuscita dello stile tagoriano. Del resto è questa la crisi di tutta la poesia indiana e forse in generale asiatica: il peso della bellezza formale della tradizione letteraria rende estremamente difficile la introduzione di uno stile che sia poeticamente realistico. In Europa Dante, comparato con certi classici asiatici, già si potrebbe chiamare un «realista», nel suo (per un asiatico classico pressoché inconcepibile) interesse poetico per la politica spicciola del suo tempo e per i nomi e i fatti del mondo. Ma come innestare lo stile nervoso della poesia moderna europea, evolutasi naturalmente dalla nostra tradizione, sul ceppo della tradizione platonica asiatica? È un problema teorico che solo la realtà futura potrà risolvere, e già lo ha risolto meglio proprio in quelle letterature che hanno una tradizione poetica classica piuttosto povera (vedi ad esempio la poesia indonesiana contemporanea, che può vantare qualche prodotto che non sfigurerebbe in un’antologia mondiale). Per ora contentiamoci di ascoltare - con la venerazione che la vera poesia sempre merita - il canto sommesso, e forse agli orecchi di qualcuno di noi un po’ monocorde, del vate del Bengala. Anche noi forse non disdegneremo di ricontemplare le infinite varianti dell’«Eterno Sogno» che sgorga dalle ali senza età di quella luce che straccia il velame dell’indistinto, ed attraversa il Tempo tessendo i motivi sempre nuovi dell’Essere3. ALESSANDRO BAUSANI (1971) 1 Forma europeizzata del bengali Thakur che significa Padrone, Principe, Signore, titolo che si dava al ricchissimo nonno del nostro poeta. 2 Cioè l’uomo. 3 Da Naivedya, una raccolta di cento sonetti di Tagore, cit. in V. Pisani, L. P. Mishra, Le Letterature Indiane, Firenze-Milano 1970, p. 281. Nota biobibliografica LA VITA Rabindranath Tagore (forma anglicizzata di Thakur) nacque a Calcutta il 6 maggio 1861 da una famiglia di antica nobiltà e di illustri tradizioni letterarie. Il padre, Debendronath Tagore, ebbe una grande importanza nella storia religiosa del Bengala. I fratelli erano già, o dovevano diventare, scrittori, musicisti, artisti. Una delle sorelle è la prima scrittrice bengalese, autrice di numerosi romanzi, racconti e saggi. Il giovane Rabindranath ebbe così modo di maturare in un ambiente letterario e culturale molto ricco, aperto a tutte le correnti filosofiche e letterarie indiane e occidentali. Quando aveva soltanto quattordici anni, nel 1875, pubblicò le sue prime poesie in una celebre rivista letteraria di Calcutta. Non ancora ventenne, pubblicò la raccolta di poesie Prabhat Sangit («Canti del mattino»), subito seguita da Sandhya Sangit («Canti della sera»). «L’età contemporanea della poesia bengali s’intende aperta con la pubblicazione del suo volumetto Naivedya, una raccolta di cento sonetti ispirati da una quantità di stimoli diversi, primo fra tutti il concetto upanishadico della manifestazione cosmica di Dio» (Laxman Prasad Mishra, Le letterature moderne dell’india). Nel 1877 fu mandato dal padre in Inghilterra per studiare legge. A Londra frequentò l’University College, si interessò un po’ di tutto, ma specialmente della letteratura e della musica europea; vi restò per quattordici mesi, ma ritornò in patria senza essersi laureato. Rientrato in India, continuò a scrivere poesie e saggi. Il 9 dicembre 1883 si sposò con Mrinalini Devi. Nel 1890 fece un secondo viaggio in Europa, passando per l’Italia, la Francia e l’Inghilterra. Nel 1891 venne nominato vicepresidente dell’Accademia di Lettere del Bengala. Da questo momento Tagore, che nei primi quarant’anni della sua vita si era dedicato quasi esclusivamente all’attività letteraria, prende a interessarsi all’istruzione dei giovani e a dedicarsi attivamente alla vita politica del suo paese. Nel 1901 fondò a Shanti Niketan (già aperta dal padre come ritiro per coloro che volevano meditare su Dio) una scuola, che successivamente diventerà l’Università Internazionale Visvabharati. Negli anni immediatamente successivi fu colpito da una serie di lutti che lasciarono una traccia profonda nella sua vita e nel suo pensiero: nel novembre del 1902 gli morì la moglie; nel 1904 la figlia; nel 1905 il padre; nel 1907 il figlio primogenito (al capezzale della figlia morente, Tagore scrisse Sisu, «Il bambino», che poi tradusse in inglese sotto il titolo Crescent Moon). Tra il 1909 e il 1912 scrisse il Gitanjali, una raccolta di poemi religiosi alla quale è legata la sua fama. Poi partì per un giro di conferenze negli Stati Uniti e da qui, nel 1912, passò in Inghilterra, dove incontrò Ezra Pound e William Butler Yeats, i due poeti che lo fecero conoscere alla cultura occidentale. Durante il viaggio, Tagore aveva tradotto in inglese alcune sue poesie; il quadernetto di queste traduzioni capitò tra le mani di W. B. Yeats, che ne rimase entusiasta. Nel novembre del 1912 queste poesie vennero pubblicate in un libro sotto il titolo di Gitanjali, con la prefazione di Yeats, per il quale gli fu conferito, nel 1913, il premio Nobel. Nel 1915 il Governo inglese gli conferì il titolo di Sir (titolo che Tagore restituirà nel 1919 per protesta contro la strage compiuta nel Punjab dalla polizia inglese). Nel 1916 visita il Giappone e nel 1917 gli Stati Uniti per un altro giro di conferenze. Viene eletto presidente del Congresso Nazionale Indiano a Calcutta. In questi anni Tagore desidera allargare la scuola di Shanti Niketan: per la realizzazione di questo progetto ha già dato la somma ricevuta per il premio Nobel, i diritti d’autore dei suoi libri e la proprietà di Shanti Niketan, ma la cifra non è ancora sufficiente; allora Tagore parte per un giro di quattordici mesi attorno al mondo cercando altri finanziamenti. Nel 1921 può finalmente inaugurare l’Università Internazionale Visvabharati (questo nome deriva da un versetto sanscrito che Tagore scelse come motto dell’Università: Yatra Visvam bharaty ekanidam, «Là dove tutto il mondo si unisce in un nido»). Nel 1922 visita la Francia, l’Inghilterra, la Danimarca, la Svezia e la Germania; nel 1924 la Malesia, la Cina e il Giappone; nel 1925 è in Italia, ospite del governo italiano. È nominato presidente del Congresso Filosofico delle Indie. Tra il 1926 e il 1931 compie numerosi viaggi attraverso il mondo: Svizzera, Austria, Francia (dove è ospite di Romain Rolland), Inghilterra, Norvegia, Jugoslavia, Bulgaria, Romania, Turchia, Grecia, Egitto, Malesia, Cina, Giappone, Canada, Indocina, Danimarca, Russia, Stati Uniti. Durante tutti questi viaggi propaganda le proprie idee e raccoglie fondi per l’Università Visvabharati. In Europa e negli Stati Uniti espone anche le sue pitture, rivelando un altro aspetto della sua molteplice attività. Tagore ha ormai settant’anni; la sua fibra robusta è spossata dall’intensa attività. A parte un breve, trionfale viaggio a Ceylon nel 1933, non lascerà più l’India, passando la maggior parte del suo tempo a Shanti Niketan. Qui la sua malattia si aggrava; Tagore viene condotto a Calcutta, dove muore a ottant’anni nella sua casa natale, il 7 agosto 1941. LE OPERE A differenza di altri poeti indiani suoi contemporanei, che hanno scritto prevalentemente in inglese, Tagore si servì per la propria produzione letteraria della sua lingua natale, il bengali (scrisse direttamente in inglese solo alcuni saggi). La sua fama internazionale è tuttavia legata alle traduzioni in lingua inglese, in gran parte fatte da lui stesso o con la sua diretta collaborazione. Nell’elencare le sue opere, riportiamo quindi i titoli in inglese (come del resto viene ormai fatto abitualmente). Luogo e data di pubblicazione si riferiscono ovviamente a queste traduzioni, non alle opere originali: Gitanjali, Londra, 1912 (tr. it., Gitanjali, Lanciano 1914). Glimpses of Bengal Life, Madras 1913. The Gardener, Londra 1913 (tr. it., Il giardiniere, Lanciano 1915). Sadhana, Londra, 1913 (tr. it., Sadhana, Lanciano 1915). The Crescent Moon, Londra 1913 (tr. it., La luna crescente, Firenze 1915). Chitra, Londra 1913 (tr. it., Chitra, Lanciano 1916). The King of the Dark Chamber, Londra 1914 (tr. it., Il re della camera buia, Lanciano 1916). The Post Office, New York 1914 (tr. it., L’ufficio postale, Lanciano 1917). Fruit-Gathering, Londra 1916 (tr. it., Raccolta votiva, Lanciano 1917). Hungry Stones and Other Stories, Londra 1916 (Il malefizio delle pietre e altre novelle, Lanciano 1920). Stray Birds, New York 1916 (tr. it., Uccelli migranti, Lanciano 1918). My Reminiscences, Londra 1917 (tr. it., Ricordi, Lanciano 1928). Sacrifice and Other Plays, Londra 1917 (comprende i drammi Sanyasi or the Ascetic, Malini, Sacrifice, The King and the Queen, Karna and Kunti; i primi quattro sono tradotti in italiano in Sannyasi, o l’asceta; Malini, Lanciano 1927 e Sacrificio, Il re e la regina, Lanciano 1927). The Cycle of Spring, Londra 1917. Nationalism, Londra 1917 (tr. it., Nazionalismo, Lanciano 1923). Personality, Londra 1917 (tr. it., Personalità, Lanciano 1948). Lover’s Gift and Crossing, Londra 1918 (tr. it., Il dono dell’amante; Passando all’altra riva, Lanciano 1920). Mashi and Other Stories, Londra 1918 (tr. it., Mashi ed altri racconti, Lanciano 1922). The Parrot’s Training, Londra 1918. The Home and the World, Londra 1919 (tr. it., La casa e il mondo, Lanciano 1924). The Runaway and Other Poems, Calcutta 1919. Greater India, Madras 1921. The Wreck, Londra 1921. Glimpses of Bengal, Londra 1921 (tr. it., Visioni bengalesi, Lanciano 1938). Throught Relics, New York 1921. Creative Unity, Londra 1922 (tr. it., Unità creative, Lanciano 1929). The Visva-bharati, Madras 1923. Letters from Abroad, Madras 1924 (tr. it., Lettere di viaggio, Lanciano 1927). Gora, Londra 1924 (tr. it., Gora, Lanciano 1935). The Curse of Farewell, Londra 1924. Talks in China, Calcutta 1925. Red Oleanders, Londra 1925 (tr. it., Oleandri rossi, Lanciano 1926). Broken Ties and Other Stories, Londra 1925 (tr. it., Vincoli infranti e altre novelle, Lanciano 1932). Lectures and Adresses, Londra 1928. Fireflies, New York 1928. Letters to a Friend, Londra 1928. The Child, Londra 1931. The Religion of Man, Londra 1931 (tr. it., La religione dell’uomo, Firenze 1961). The Golden Boat, Londra 1932. Mahatmaji and the Depressed Humanity, Calcutta 1932. East and West, Parigi 1935. My Boybood Days, Shanti Niketan 1940. Crisis in Civilisation, Shanti Niketan 1941. Two Sisters, Calcutta 1945. Farewell, My Friend, Londra 1946. Three Plays (Mukta-Dhara, Natir Puja, Chandalika), Bombay 1950. A Flight of Swans, Londra 1955. The Herald of Spring, Londra 1957. Our Universe, Londra 1958. Binodini, New Delhi 1959. Wings of Death, Londra 1960 (tr. it., Le ali della morte, Parma 1961). Poems of Puravi, Shanti Niketan 1960. Letters from Russia, Calcutta 1960. A Visit to a Japan, New York 1961. Devouring Love, New York 1961. (Una scelta di scritti di argomento politico, pedagogico e culturale è stata pubblicata in Italia in occasione del centenario della nascita di Tagore sotto il titolo La cività occidentale e l’India, Torino 1961). BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE SU TAGORE Ezra Pound, Rabindranath Tagore, in «Fortnightly Review», Londra, marzo 1913. B. K. Roy, Rabindranath Tagore, The Man and His Poetry, New York 1915. W. Rothenstein, Six Portraits of Sir Rabindranath Tagore, Londra 1915. E. Rhys, Rabindranath Tagore: A Biograpbical Study, New York 1915. K. S. R. Sastri, Rabindranath Tagore: His Life, Personality and Genius, Madras 1916. S. Radhakrishnan, The Philosophy of Rabindranath Tagore, Londra 1918. E. Engelhardt, Rabindranath Tagore als Mensch, Dichter und Philosoph, Berlin 1921. J. M. Jensen, Rabindranath Tagore, Copenhagen 1925. M. Sykes, Rabindranath Tagore, Londra 1943. H. Kabir, Rabindranath Tagore, Londra 1962. K. Kripalani, Rabindranath Tagore: a Biograpby, Londra 1962. B. Chandra Chakravorty, Rabindranath Tagore: his mind and art: Tagore’s contribution to English literature, New Delhi 1971. M. Sarada, Rabindranath Tagore: A Study of Women Characters in His Novel, New Delhi 1988. Rabindranath Tagore: perspectives in time, edited by Mary Lago and Ronald Warwick, Houndmills, Basingstoke 1989. B. Datta, Rabindranath Tagore on the Ramayana & the Mahabharata, Calcutta 1995. B. Chatterjee, Rabindranath Tagore and modern sensibility, Delhi 1996. K. Gupta, The philosophy of Rabindranath Tagore, Aldershot, Burlington 2005. In italiano E. Castelnuovo, Rabindranath Tagore: un poeta indiano, Venezia 1914. E. Belloni-Filippi, Rabindranath Tagore, Roma 1920. Centenario di Tagore 1861-1961 a cura dell’iSMEO, Roma 1962. E. Gasco Contell, Rabindranath Tagore, Madrid 1970. G. Delfino, L’ideale di Rabindranath Tagore, Genova 1972. G. Ottonello, Rabindranath Tagore: principi educativi e scuole nuove in Oriente, Roma 1977. G. Ottonello, Vita e pensiero di Rabindranath Tagore, Milano 1978. A. Pezzali, Profilo di Rabindranath Tagore, Bologna 1982. R. Ferrari, L’amore infinito e lo spirito che torna: lettere d’amore in prosa lirica e poesie dell’oltre limite di Rabindranath Tagore, Milano 1989. Nota alla traduzione «Se si dovesse tradurre in inglese il detto tradizionale italiano: traduttore, traditore, con “the translator is a traitor”, si toglierebbe all’epigramma il suo valore paronomastico. Di qui un atteggiamento conoscitivo che ci obbligherebbe a svolgere questo aforisma in una proposizione più esplicita, e a rispondere a queste domande: traduttore di quali messaggi? traditore di quali valori?» (Roman Jakobson «Aspetti linguistici della traduzione», in Saggi di linguistica generale, p. 64). Trattandosi qui di una traduzione di testi poetici, saremmo tentati di accogliere l’incitamento di Ezra Pound a «tradurre la poesia, non le parole», che implicitamente risponde a questi interrogativi. Il caso è tuttavia più complesso e complicato da alcuni fatti circostanziali: 1) i testi poetici qui pubblicati non sono tradotti direttamente dagli originali in bengali, ma da una versione inglese; sono quindi traduzione di una traduzione; 2) le versioni in inglese sono opera dello stesso Tagore e, in un certo senso, si devono considerare come opere «originali», tanto più che: 3) l’edizione inglese del Gitanjali non è traduzione dell’opera in bengali dallo stesso titolo, ma di poesie pubblicate in tre libri, Naivedya, Kheya e Gitanjali, e di qualche componimento pubblicato isolatamente in riviste; 4) nella prefazione a The Gardener, Tagore scrive che «la traduzione non è sempre letterale e l’originale è spesso accorciato e parafrasato»; 5) le versioni inglesi di entrambi i testi non sono in versi ma in prosa. Nelle versioni inglesi, inoltre, Tagore fece un’opera di mediazione fra i testi originali e la sensibilità occidentale; ed è soprattutto questo loro carattere che ne fa dei testi «originali», con una propria funzione e un proprio valore autonomi (e che ne giustifica anche una traduzione in italiano). Restano quindi da giustificare (o, meglio, da spiegare) alcuni particolari; in primo luogo, la decisione di volgere in versi la prosa inglese di Tagore. Non so in che misura abbia influito sulla decisione dell’autore di tradurre in prosa le proprie poesie una non perfetta padronanza della lingua inglese, e in che misura invece egli si sia sentito, in qualche modo, paralizzato e impotente di fronte al modello perfetto che aveva dinnanzi (per il quale egli ha meritato di essere chiamato vakpati, «signore della lingua»). Resta il fatto che si tratta di una «prosa» del tutto particolare, al di sotto della quale traspare, a tratti come un’eco remota, a tratti con maggiore immediatezza, la tensione di una intelligenza abituata a plasmare poeticamente la lingua, a esprimere in versi e in canti il proprio pensiero. Una «prosa» che, anche nella traduzione letterale, si organizza in versi naturalmente e quasi «da sola». Io non ho fatto altro che recepire questa tensione, abbandonandomi ad essa e lasciando che il ritmo emergesse dal «materiale» stesso che stavo traducendo, senza fare il minimo tentativo (che del resto sarebbe stato in partenza destinato al fallimento) di ricalcare i metri originali, e tantomeno di costringere il discorso nello schema rigido di una materia fissa. Per lo stesso motivo ho conservato alcune asprezze e forzature presenti nella versione inglese: perché Tagore forza costantemente la lingua, non l’accetta passivamente come uno strumento morto, ma la riplasma, la rinnova in un atto creativo, che in definitiva è l’essenza stessa del mestiere di poeta. G. M. Gitanjali I Mi hai fatto senza fine questa è la tua volontà. Questo fragile vaso continuamente tu vuoti continuamente lo riempi di vita sempre nuova. Questo piccolo flauto di canna hai portato per valli e colline attraverso esso hai soffiato melodie eternamente nuove. Quando mi sfiorano le tue mani immortali questo piccolo cuore si perde in una gioia senza confini e canta melodie ineffabili. Su queste piccole mani scendono i tuoi doni infiniti. Passano le età, e tu continui a versare, e ancora c’è spazio da riempire. II Quando mi comandi di cantare, il mio cuore sembra scoppiare d’orgoglio e fisso il tuo volto e le lacrime mi riempiono gli occhi. Tutto ciò che nella mia vita vi è di aspro e discorde si fonde in dolce armonia, e la mia adorazione stende l’ali come un uccello felice nel suo volo a traverso il mare. So che ti diletti del mio canto, che soltanto come cantore posso presentarmi al tuo cospetto. Con l’ala distesa del mio canto sfioro i tuoi piedi, che mai avrei pensato di poter sfiorare. Ebbro della felicità del mio canto dimentico me stesso e chiamo amico te che sei il mio signore. III Non so come tu canti, mio signore! Sempre ti ascolto in silenzioso stupore. La luce della tua musica illumina il mondo. Il soffio della tua musica corre da cielo a cielo. L’onda sacra della tua musica irrompe tra gli ostacoli pietrosi e scorre impetuosa in avanti. Il cuore anela di unirsi al tuo canto, ma invano cerco una voce. Vorrei parlare, ma le mie parole non si fondono in canti e impotente grido. Hai fatto prigioniero il mio cuore nelle infinite reti della tua musica. IV Vita della mia vita, sempre cercherò di conservare puro il mio corpo, sapendo che la tua carezza vivente mi sfiora tutte le membra. Sempre cercherò di allontanare ogni falsità dai miei pensieri, sapendo che tu sei la verità che nella mente mi ha acceso la luce della ragione. Sempre cercherò di scacciare ogni malvagità dal mio cuore, e di farvi fiorire l’amore, sapendo che hai la tua dimora nel più profondo del cuore. E sempre cercherò nelle mie azioni di rivelare te, sapendo che è il tuo potere che mi dà la forza di agire. V Concedi ch’io possa sedere per un momento al tuo fianco. Le opere cui sto attendendo potrò finirle più tardi. Lontano dalla vista del tuo volto non conosco né tregua né riposo e il mio lavoro diventa una pena senza fine in un mare sconfinato di dolori. Oggi l’estate è venuta alla mia finestra con i suoi sussurri e sospiri, le api fanno i menestrelli alla corte del boschetto in fiore. Ora è tempo di sedere tranquilli a faccia a faccia con te e di cantare la consacrazione della mia vita in questa calma straripante e silenziosa. VI Cogli questo piccolo fiore e prendilo. Non indugiare! Temo che esso appassisca e cada nella polvere. Non so se potrà trovare posto nella tua ghirlanda, ma onoralo con la carezza pietosa della tua mano - e coglilo. Temo che il giorno finisca prima del mio risveglio e passi l’ora dell’offerta. Anche se il colore è pallido e tenue è il suo profumo serviti di questo fiore finché c’è tempo - e coglilo. VII Il mio canto ha deposto ogni artificio. Non sfoggia splendide vesti né ornamenti fastosi: non farebbero che separarci l’uno dall’altro, e il loro clamore coprirebbe quello che sussurri. La mia vanità di poeta alla tua vista muore di vergogna. O sommo poeta, mi sono seduto ai tuoi piedi. Voglio rendere semplice e schietta tutta la mia vita come un flauto di canna che tu possa riempire di musica. VIII Il bambino adorno di vesti principesche con al collo monili ingemmati, perde ogni piacere nel gioco, la sua veste lo impaccia a ogni passo. Per paura che si possa stracciare o che s’imbratti di polvere si tiene appartato dal mondo e ha timore persino di muoversi. Madre, a che vale tutta questa eleganza se ci tiene lontani dalla salutare polvere di questa terra, se ci priva del diritto d’entrare nella grande festa del mondo? IX O stolto, che cerchi di portare te stesso sulle tue spalle! Mendicante, che vieni a mendicare alla porta della tua casa! Deponi ogni fardello in queste mani che tutto sanno sopportare, non voltarti mai indietro a guardare il passato con rimpianto. Il desiderio subito spegne la fiamma d’ogni lampada che sfiora. È empio - non prendere doni dalle sue mani impure. Accetta soltanto quello ch’è offerto dall’amore. X Qui è il tuo sgabello e qui riposa i tuoi piedi dove vivono i più poveri, i più umili, i perduti. Quando a te io cerco d’inchinarmi, la mia riverenza non riesce ad arrivare tanto in basso dove i tuoi piedi riposano tra i più poveri, i più umili, i perduti. L’orgoglio non si può accostare dove tu cammini, indossando le vesti dei più poveri, dei più umili e dei perduti. Il mio cuore non riesce a trovare la strada per scendere laggiù dove tu ti accompagni a coloro che non hanno compagni, tra i più poveri, i più umili, e i perduti. XI Smettila di cantare i tuoi inni, di recitare le tue orazioni! Chi adori in quest’angolo buio e solitario d’un tempio le cui porte sono tutte chiuse? Apri i tuoi occhi e guarda: non è qui il tuo Dio. È là dove l’aratore ara la dura terra, dove lo spaccapietre lavora alla strada. È con loro nel sole e nella pioggia, la sua veste è coperta di polvere. Levati il manto sacro e scendi con lui nella polvere. Liberazione? Dove credi di poter trovare liberazione? Il tuo stesso signore ha preso su di sé lietamente i legami della creazione è legato a noi tutti per sempre. Lascia le tue meditazioni, abbandona l’incenso e i tuoi fiori! Che male c’è se le tue vesti diventano sporche e stracciate? Va incontro a lui, sta presso di lui nel lavoro e nel sudore della fronte. XII A lungo durerà il mio viaggio e lunga è la via da percorrere. Uscii sul mio carro ai primi albori del giorno, e proseguii il mio viaggio attraverso i deserti del mondo e lasciai la mia traccia su molte stelle e pianeti. Sono le vie più remote che portano più vicino a te stesso; è con lo studio più arduo che si ottiene la semplicità d’una melodia. Il viandante deve bussare a molte porte straniere per arrivare alla sua, e bisogna viaggiare per tutti i mondi esteriori per giungere infine al sacrario più segreto all’interno del cuore. I miei occhi vagarono lontano prima che li chiudessi dicendo: «Eccoti!» Il grido e la domanda: «Dove?» si sciolgono nelle lacrime di mille fiumi e inondano il mondo con la certezza: «Io sono!» XIII Il canto che venni a cantare non ho ancora cantato. Tutto il mio tempo ho passato a tendere e ad allentare e corde del mio strumento. Il tempo non è venuto giusto, Le parole non sono state disposte correttamente. Nel mio cuore c’è solamente un’agonia di desideri. Il fiore non è sbocciato e il vento passa sospirando. Non ho veduto il suo volto, la sua voce non ho ascoltato ho udito soltanto i suoi passi sulla strada davanti alla mia casa. Un giorno intero ho passato lungo come una vita a stendere in terra il tappeto dov’egli possa sedersi. Ma la lampada non è stata accesa, e non posso invitarlo ad entrare. Vivo nella speranza di poterlo alfine incontrare, ma non l’ho ancora incontrato. XIV Molti sono i miei desideri e il mio pianto è pietoso, ma tu mi hai sempre salvato opponendomi un duro rifiuto. Giorno per giorno tu mi rendi degno dei grandi e semplici doni che, non richiesto, mi hai dato Questo cielo e la luce, questo corpo e la mente e la vita salvandomi dai pericoli dei miei molti desideri. A volte pigramente indugio, a volte mi desto e mi affretto affannandomi verso la meta ma tu crudelmente ti nascondi. Di giorno in giorno mi rendi degno d’essere accettato, rifiutandomi costantemente, salvandomi dai pericoli del debole, incerto desiderio. XV Sono qui a cantarti canzoni. In questa tua sala ho soltanto un piccolo posto in un canto. Nel tuo mondo non ho nessun lavoro da fare la mia inutile vita può soltanto sgorgare in melodie senza scopo. Quando batte l’ora della tua silenziosa adorazione nell’oscuro tempio della notte, Comandami, signore, di stare davanti a te, e cantare. Quando nell’aria del mattino l’arpa d’oro è accordata, concedimi l’onore di ordinare che io sia presente. XVI Ho ricevuto il mio invito alla festa di questo mondo; la mia vita è stata benedetta. I miei occhi hanno veduto, le mie orecchie hanno ascoltato. In questa festa dovevo soltanto suonare il mio strumento: ho fatto come meglio potevo la parte che mi era stata assegnata. Ora chiedo: è venuto alfine il momento di entrare e guardare il tuo volto e offrirti il mio silenzioso saluto? XVII Attendo soltanto l’amore per abbandonarmi alfine nelle sue mani. Per questo è così tardi e mi sono macchiato di tante colpe e omissioni. Vengono con le loro leggi e i loro codici a legarmi; ma io sempre li eludo; perché attendo soltanto l’amore per abbandonarmi alfine nelle sue mani. M’incolpano e mi chiamano sventato e non ho dubbi che l’accusa è fondata. Trascorso è il giorno del mercato, i lavori sono stati terminati. Coloro che invano son venuti a chiamarmi, sono tornati delusi. Io attendo soltanto l’amore per abbandonarmi alfine nelle sue mani. XVIII Nubi su nubi s’addensano e si fa buio Amore mio, perché mi lasci tutto solo ad attendere fuori della porta? Io sono tra la folla a mezzogiorno, quando ferve il lavoro, ma in questo giorno buio e solitario sei tu la mia sola speranza. Se non mi mostri il tuo volto, se solo mi lasci in disparte, come potrò sopportare queste lunghe ore di pioggia? Lo sguardo si perde lontano nell’oscurità del cielo, e il mio cuore vaga gemendo col vento che soffia incessante. XIX Se tu non parli colmerò il mio cuore del tuo silenzio e lo sopporterò. Pazientemente, a testa china, resterò muto e attenderò come la notte, in veglia stellata. Certamente il mattino verrà, svaniranno le tenebre, e la tua voce verserà per il cielo raggi dorati. Allora le tue parole prenderanno ali in canzoni da tutti i miei nidi d’uccelli; le tue melodie fioriranno in tutte le mie foreste. XX Il giorno in cui il loto fiorì, ahimé, la mia mente vagava distratta e non me ne accorsi. Vuoto rimase il mio canestro, il fiore rimase negletto. Solo, di tanto in tanto, scendeva in me la tristezza; dal sonno mi destavo all’improvviso, e sentivo la dolce traccia d’una strana fragranza nel vento del sud. Quella vaga dolcezza mi faceva soffrire e mi pareva che fosse l’ardente soffio dell’estate che cercava il suo compimento. Allora non sapevo che era tanto vicino, che era mio, e che questa perfetta dolcezza era sbocciata nel profondo del mio stesso cuore. XXI Devo varare la mia barca. Sulla riva languide trascorrono l’ore - ahimé! Primavera ha sbocciato i suoi fiori e ha preso commiato. E ora attendo col mio vano carico di fiori appassiti. Le onde si son fatte rumorose e sulla riva, nell’ombroso sentiero, le foglie gialle tremano e cadono. In quale vuoto fissi lo sguardo? Non senti un fremito passare nell’aria, con le note d’un canto che lontano si leva dall’altra riva? XXII Nell’ombra fonda del luglio piovoso cammini con passi segreti silenzioso come la notte eludendo ogni vigilanza. Il mattino ha chiuso i suoi occhi incurante degli insistenti richiami del vento dell’est, e un velo pesante è stato steso sull’insonne azzurro del cielo I boschi hanno cessato i loro canti, tutte le porte sono state chiuse. Tu sei il viandante solitario di questa strada deserta. Mio solo, mio migliore amico, aperta è la porta della mia casa non passare come un sogno. XXIII Sei uscito in questa notte tempestosa nel tuo viaggio d’amore, amico mio? il cielo geme disperato. La mia notte è insonne. Di tanto in tanto apro la mia porta e guardo nel buio, amico mio. Davanti a me non vedo nulla e mi chiedo dove si trovi il tuo sentiero. Per quale oscura riva del nero fiume, per quale lontano margine dell’oscura foresta, attraverso quale buio labirinto cammini per venire da me, amico mio? XXIV Se il giorno è finito, se gli uccelli non cantano più, se il vento stanco si posa, stendi il pesante velo delle tenebre sopra di me, come hai avvolto la terra nella coltre del sonno e hai chiuso teneramente i petali del fiore di loto che languono nell’imbrunire. Dal viandante la cui bisaccia è vuota prima che il viaggio sia finito, le cui vesti sono stracciate e coperte di polvere, le cui forze sono esaurite allontana la vergogna e la miseria e rinnova la sua vita come un fiore sotto la coltre della tua tenera notte. XXV Nella notte della stanchezza lascia che mi abbandoni al sonno senza lottare confidando solamente in te. Non lasciarmi forzare il mio spirito stanco e intorpidito a prepararsi indegnamente per la tua adorazione. Sei tu che stendi il velo della notte sugli occhi stanchi del giorno per ristorare la vista con la fresca letizia del risveglio. XXVI Venne e sedette al mio fianco, ma non mi destai. Che sonno sciagurato fu quello, o me miserabile! Venne nel silenzio della notte; teneva in mano la sua arpa e i miei sogni risuonarono delle sue melodie. Ahimé, perché le mie notti così sono sempre perdute? Perché manco sempre la visione di colui il cui alito sfiora il mio sogno? XXVII Luce, oh, dov’è la luce? Accendila con il fuoco ardente del desiderio! La lampada è pronta ma dov’è la fiamma? È questo il mio destino, cuore? Oh, la morte sarebbe di gran lunga migliore per te. La miseria bussa alla mia porta e dice: Il tuo signore è insonne e t’invita al convegno d’amore nell’oscurità della notte. Il cielo è coperto di nubi, la pioggia cade incessante. Non so quel che s’agita in me, non comprendo cosa significhi. Il bagliore improvviso d’un lampo fa scendere un buio più fondo e il mio cuore cerca brancolando il sentiero che porta ove m’invita l’armonia della notte. Luce, oh, dov’è la luce? Accendila con il fuoco ardente del desiderio! Tuona la bufera e soffia il vento fischiando nel vuoto. La notte è scura come pietra nera. Non lasciare che l’ore passino nel buio Accendi con la tua vita la lampada dell’amore. XXVIII Tenaci sono le catene, ma mi duole il cuore quando cerco d’infrangerle. Libertà è il mio solo desiderio, ma di sperarla mi vergogno. Sono certo che ricchezze inestimabili sono in te, che il mio migliore amico sei tu, ma non trovo il coraggio di gettare gli orpelli di cui è piena la mia stanza. Sono come avvolto in un sudario di polvere e morte - lo detesto eppure lo abbraccio con amore. I miei debiti sono numerosi, gravi sono le mie colpe, la mia onta segreta è pesante - ma quando vengo a chiedere il mio bene tremo di paura al pensiero che la mia preghiera sia esaudita. XXIX Colui che rinchiudo col mio nome sta piangendo in questa prigione. Sono sempre intento a costruire questo muro tutt’intorno e via via che giorno per giorno questo muro sale verso il cielo perdo di vista il mio vero io nella sua ombra oscura. Mi vanto di questo grande muro, lo intonaco con polvere e sabbia per timore che un ultimo spiraglio possa rimanere in questo nome; e per tutta la cura che mi prendo perdo di vista il mio vero io. XXX Uscii solo per venire al tuo convegno. Ma chi è costui che mi segue nella silenziosa oscurità? Mi traggo da parte per evitare la sua compagnia, ma non riesco a sfuggirgli. Con la sua andatura spavalda solleva la polvere di terra; a ogni parola che pronuncio aggiunge la sua voce chiassosa. È il mio piccolo io, mio signore, senza paura e senza vergogna; ma io mi vergogno di venire alla tua porta in questa compagnia. XXXI «Prigioniero, dimmi, chi è stato che ti ha avvinto in catene?» «È stato il mio signore» il prigioniero rispose. «Credevo di poter superare per ricchezza e potenza chiunque al mondo, e così ammassai nel mio tesoro il denaro dovuto al mio re. Quando il sonno mi vinse, mi stesi sul letto destinato al mio signore; e al risveglio mi trovai prigioniero nel mio stesso tesoro». «Prigioniero, dimmi, chi è stato a forgiare questa catena?» «Io stesso», rispose, «ho forgiato questa catena che nulla può spezzare. Credevo che la mia forza invincibile avrebbe fatto prigioniero il mondo, lasciandomi libero e indisturbato. Notte e giorno lavorai alla catena con grandi fuochi e colpi crudeli e quando il lavoro fu finito, quando l’ultimo anello fu saldato, mi accorsi ch’essa mi stringeva nella stretta che nulla può spezzare». XXXII In questo mondo coloro che m’amano cercano con tutti i mezzi di tenermi avvinto a loro. Il tuo amore è più grande del loro, eppure mi lasci libero. Per timore che io li dimentichi non osano mai lasciarmi solo. Ma i giorni passano l’uno dopo l’altro e tu non ti fai mai vedere. Non ti chiamo nelle mie preghiere, non ti tengo nel mio cuore eppure il tuo amore per me ancora attende il mio amore. XXXIII Quando era giorno vennero a casa mia e dissero: «Occuperemo soltanto la tua stanza più piccola». Dissero: «Ti aiuteremo nel culto del tuo Dio e accetteremo umilmente quel po’ di grazia che ci spetta». Poi si misero a sedere in un cantuccio, e stettero umili e tranquilli. Ma nel buio della notte li scopro che irrompono nel mio santuario, forti e turbolenti, e strappano con empia bramosia le offerte dall’altare di Dio. XXXIV Lasciami solo quel poco con cui possa chiamarti il mio tutto. Lasciami solo quel poco con cui possa sentirti in ogni luogo e venire a te in ogni cosa e offrirti il mio amore ogni momento. Lasciami solo quel poco con cui non possa mai nasconderti. Lasciami solo la catena con cui possa legarmi al tuo volere e il tuo fine sia realizzato nella mia vita e che è la catena del tuo amore. XXXV Dove la mente non conosce paura e la testa è tenuta ben alta; dove il sapere è libero; dove il mondo non è stato frammentato entro anguste mura domestiche; dove le parole sgorgano dal profondo della verità; dove lo sforzo incessante tende le braccia verso la perfezione; dove il limpido fiume della regione non ha smarrito la via nell’arida sabbia del deserto delle morte abitudini; dove tu guidi innanzi la ragione verso pensieri e azioni sempre più ampi in quel cielo di libertà, Padre, fa che il mio paese si desti. XXXVI Di questo ti prego, signore: colpisci colpisci alla radice la miseria che è nel mio cuore. Dammi la forza di sopportare serenamente gioie e dolori. Dammi la forza di rendere il mio amore utile e fecondo al tuo servizio. Dammi la forza di non rinnegare mai il povero, di non piegare le ginocchia davanti all’insolenza dei potenti. Dammi la forza di elevare il pensiero sopra le meschinità della vita d’ogni giorno e dammi la forza di arrendere con amore la mia forza alla tua volontà. XXXVII Credevo che il mio viaggio fosse giunto alla fine, all’estremo delle mie forze, che la via davanti a me fosse sbarrata, che le provviste fossero finite e fosse giunta l’ora di ritrarmi nel silenzio e nell’oscurità. Ma ho scoperto che la tua volontà non conosce fine per me. E quando le vecchie parole sono morte, nuove melodie sgorgano dal cuore; dove i vecchi sentieri son perduti, appare un nuovo paese meraviglioso. XXXVIII Io desidero te, soltanto te il mio cuore lo ripeta senza fine. Sono falsi e vuoti i desideri che continuamente mi distolgono da te. Come la notte nell’oscurità cela il desiderio della luce, così nella profondità della mia incoscienza risuona questo grido: «Io desidero te, soltanto te». Come la tempesta cerca fine nella pace, anche se lotta contro la pace con tutta la sua furia, così la mia ribellione lotta contro il tuo amore eppure grida: «Io desidero te, soltanto te». XXXIX Quando il mio cuore è duro e inaridito scendi come una pioggia di misericordia. Quando la grazia è perduta nella vita vieni come un improvviso scoppio di canti. Quando il lavoro tumultuoso da ogni parte leva il suo fragore escludendomi dall’al di là, scendi, signore del silenzio, con la tua pace e il tuo riposo. Quando il mio misero cuore siede in disparte come un mendicante, spalanca la porta, mio re, e fa il tuo ingresso trionfale. Quando le passioni acciecano la mente con polvere e con delusione o tu Santo, o tu Desto, vieni con folgori e tuoni. XL Per giorni e giorni, mio Dio, la pioggia non è scesa nel mio arido cuore. L’orizzonte è nudo e spietato: non il più sottile velo di nubi non il più vago indizio d’una fresca pioggia lontana. Manda la tua irata tempesta, nera di morte, se questa è la tua volontà, e con la sferza della folgore spaventa da un capo all’altro tutto il cielo. Ma richiama, signore, richiama questo calore silenzioso che tutto pervade, che immobile e intenso e crudele brucia il mio cuore con nera disperazione. Lascia che la nube della grazia s’inchini dall’alto del cielo come il triste sguardo della madre nel giorno dell’ira paterna. XLI Dietro a tutti, nell’ombra Dove ti nascondi, amore mio? Nella strada polverosa, ti spingono, ti passano avanti, prendendoti per uno che non conta. Io attendo qui lunghe ore tediose, spargendo per te le mie offerte, mentre i passanti vengono e prendono i miei fiori, a uno a uno, finché il mio canestro è quasi vuoto. Il mattino è passato, e il meriggio. Nell’ombra della sera i miei occhi son grevi di sonno. Gli uomini, tornando alle lor case, mi guardano ridendo, e mi sento morire di vergogna. Siedo come una mendicante, tirandomi la gonna sulla faccia, e quando mi domandano che voglio abbasso gli occhi e non rispondo. Come potrei dire che sei tu colui che attendo e che hai promesso di venire? Come potrei dire, senza vergognarmi, che ti porto in dote la mia povertà? Serro questo orgoglio nel più segreto del cuore. Siedo sull’erba e guardo il cielo, e sogno l’improvviso splendore del tuo arrivo: tutte le luci sono accese, i pennoni dorati ondeggiano sopra il tuo carro - ed essi, al bordo della strada, che restano stupiti a bocca aperta quando vedono che scendi dal tuo carro per rialzarmi dalla polvere e porre al tuo fianco questa cenciosa mendicante che trema di vergogna e d’orgoglio come una pianta rampicante nella brezza estiva. Ma il tempo passa, e non odo il rumore delle ruote del tuo carro. Molti cortei sono passati con suoni e grida e strepito di gloria. Soltanto tu rimani silenzioso, dietro a tutti, nell’ombra? Son io soltanto che devo aspettare e piangere e consumare il mio cuore in questa vana attesa? XLII Allo spuntare del giorno si sussurrò che avremmo veleggiato in una barca, soli tu ed io, e nessun altro al mondo avrebbe saputo di questo nostro pellegrinaggio verso nessun paese e senza meta alcuna. In quell’oceano senza rive, al tuo sorriso intento e silenzioso, i miei canti eromperebbero in melodie libere come le onde, libere dalla schiavitù delle parole. Quel tempo non è ancora venuto? Vi sono ancora opere da compiere? Guarda, la sera è scesa sulla riva e nella luce che piano svanisce gli uccelli marini volando tornano ai loro nidi. Chi sa quando gli ormeggi saran tolti e la barca nella notte svanirà come l’ultimo bagliore del tramonto? XLIII Era il giorno quando non ero preparato a riceverti; entrando nel mio cuore, non invitato e non conosciuto, imprimesti il segno dell’eternità su molti istanti fugaci della mia vita. Quando oggi, per caso, faccio lume su di essi, e vedo il tuo sigillo, mi accorgo che si sono confusi, col ricordo di gioie e dolori dei miei futili giorni scordati. Non ti sei mai scostato sprezzante dal mio giocare puerile tra la polvere, e i passi che udii un giorno nella mia stanza dei giuochi sono gli stessi che echeggiano di stella in stella. XLIV Questa è la mia gioia, attendere e guardare il bordo della strada, dove l’ombra insegue la luce, e la pioggia cade nella vigilia dell’estate. Messaggeri mi portano novelle di cieli sconosciuti, mi salutano e s’affrettano lungo la via. Il mio cuore è lieto, e soave è il respiro della brezza che passa. Dall’alba fino all’imbrunire siedo qui davanti alla mia porta, e so che all’improvviso arriverà il momento in cui potrò vedere. E intanto sorrido e tutto solo canto. E intanto l’aria si riempie del profumo della promessa. XLV Non hai udito i suoi passi silenziosi? Egli avanza, avanza, sempre avanza. Ogni istante e ogni età, ogni giorno e ogni notte, Egli avanza, avanza, sempre avanza. Molte canzoni ho cantato con vari accenti e pensieri ma i miei versi hanno sempre proclamato: «Egli avanza, avanza, sempre avanza». Nei giorni fragranti dell’aprile assolato, attraverso i sentieri della verde foresta Egli avanza, avanza, sempre avanza. Nel buio piovoso delle notti di luglio, sul carro tuonante delle nubi, Egli avanza, avanza, sempre avanza. In tutti i miei dolori e le mie pene sono i suoi passi a premere il mio cuore, è la carezza dorata dei suoi piedi che fa brillare tutte le mie gioie. XLVI Non so da qual tempo lontano ti sei avvicinato a me. Il sole e le stelle non possono tenerti nascosto per sempre. Quante volte, di sera e di mattina, si sono uditi i tuoi passi e il tuo messo è entrato nel mio cuore e m’ha chiamato in segreto. Non so perché oggi la mia vita è tutta in agitazione e un senso di trepida gioia attraversa il mio cuore. È come se fosse venuto il tempo di finire il mio lavoro, sento tenue nell’aria il profumo della tua dolce presenza. XLVII La notte è quasi passata attendendolo invano. Temo che al mattino venga alla mia porta all’improvviso, quando, vinto dalla fatica, mi sarò alfine addormentato. Amici, lasciatelo entrare, non sbarrategli la strada. Se il rumore dei suoi passi non mi desta, non cercate di svegliarmi, vi prego, non voglio essere destato dal chiassoso coro degli uccelli, dal tumulto del vento alla festa della luce del mattino. Lasciatemi dormire indisturbato, anche se il mio signore verrà all’improvviso alla mia porta. Oh, il sonno, il mio prezioso sonno, che attende soltanto la carezza della sua mano per svanire! Oh, i miei occhi chiusi, che vorrebbero aprire le palpebre solo alla luce del suo sorriso, quando egli mi starà davanti come un sogno che emerge dalle tenebre del sonno! Lasciate ch’egli appaia ai miei occhi come la prima di tutte le luci e di tutte le forme. Lasciate che il primo fremito di gioia mi giunga all’anima destata dal suo sguardo. E lasciate che il ritorno a me stesso sia l’immediato mio ritorno a lui. XLVIII Il mare di silenzio del mattino s’infranse in un mormorio di canti d’uccelli. Sul bordo della strada i fiori eran tutti felici e la ricchezza dell’oro si spargeva attraverso una schiarita delle nubi, mentre affaccendati andavamo per la nostra strada senza prestarvi attenzione. Non cantammo liete canzoni, né suonammo; non andammo al villaggio per acquisti; non dicemmo nemmeno una parola, né sorridemmo o indugiammo sulla via. Sempre più affrettammo il nostro passo mentre il tempo passava veloce. Il sole era alto in mezzo al cielo, le tortore tubavano nell’ombra. Foglie secche danzavano roteando nella calda aria del meriggio. All’ombra d’un banano un pastorello dormiva sognando. Mi sdraiai nei pressi d’un ruscello e nell’erba stesi le mie stanche membra. I miei compagni mi derisero sprezzanti; a testa alta s’affrettarono innanzi; non si volsero indietro a guardare, non si fermarono per riposare; svanirono lontano nell’azzurra foschia. Attraversarono campi e colline, passarono per strani paesi lontani. Onore a voi, eroica schiera dell’interminabile cammino! Rimprovero e scherno mi pungolavano ad alzarmi: ma invano. Mi diedi per perduto nell’abisso d’una lieta umiliazione, nell’ombra d’una gioia oscura. La quiete della verde ombra ricamata dal sole lentamente si diffuse sul mio cuore. Dimenticai lo scopo del mio viaggio e mi arresi senza lottare all’intrico d’ombre e canzoni. Quando infine mi destai dal mio torpore e apersi gli occhi, ti vidi ritto presso di me, inondando il mio sonno con il tuo sorriso. Quanto avevo temuto che il cammino fosse lungo e faticoso! che fosse dura la lotta per giungere a te! XLIX Scendesti dal tuo trono e ti fermasti alla porta della mia capanna. Stavo cantando, tutto solo, in un angolo, e la melodia giunse al tuo orecchio. sei sceso e ti sei fermato. alla porta della mia capanna. Nel tuo palazzo sono molti i maestri, e i canti risuonano a tutte le ore ma la semplice carola di questo novizio ha colpito il tuo amore. Una piccola, triste melodia s’univa alla gran musica del mondo con un fiore come ricompensa sei sceso e ti sei fermato alla porta della mia capanna. L Ero andato mendicando d’uscio in uscio lungo il sentiero del villaggio, quando il tuo cocchio dorato apparve in lontananza come un magnifico sogno e mi chiesi chi fosse questo Re di tutti i re! Le mie speranze crebbero, e pensai che i brutti giorni fossero passati, e rimasi in attesa di doni non richiesti, di ricchezze profuse da ogni parte. Il tuo cocchio si fermò vicino a me. Mi guardasti e scendesti sorridendo. Sentivo che alfine era arrivata la fortuna della mia vita. Poi, all’improvviso mi stendesti la mano chiedendo: «Che cos’hai da darmi?» Quale gesto regale fu il tuo! stendere la mano a un mendicante per mendicare! Rimasi indeciso e confuso. Poi estrassi dalla mia bisaccia il più piccolo chicco di grano e te lo offersi. Ma quale non fu la mia sorpresa quando, finito il giorno, vuotai la mia bisaccia per terra e trovai un granellino d’oro nel mio povero mucchio! Piansi amaramente e desiderai di aver avuto il coraggio di donarti tutto quello che avevo. LI Scese la notte. I nostri lavori quotidiani erano finiti. Pensammo che l’ultimo ospite fosse arrivato per la notte e tutte le porte del villaggio furono chiuse. Uno soltanto disse che il Re doveva arrivare: ridendo rispondemmo: «No, non può essere!» Sembrò che picchiassero alla porta, e dicemmo: non è altro che il vento. Le lampade furono spente e ci coricammo per dormire. uno soltanto disse: «È il messaggero!» Ridendo rispondemmo: «No, dev’essere il vento!» Ci fu un rumore nel cuore della notte. Pensammo, assonnati, che fosse il tuono lontano. La terrà tremò, i muri vacillarono, e questo ci turbò nel nostro sonno. Uno soltanto disse che era un rumore di ruote. Assonnati mormorammo: «No, dev’essere il tuono!» La notte era ancora fonda quando rullò il tamburo. Si udì una voce: «Sveglia! Affrettatevi!» Tremando di paura ci prememmo le mani sul cuore. Uno disse: «Guardate! E la bandiera del Re!» Balzammo in piedi gridando: «Presto, non c’è tempo da perdere!» Il Re è venuto - ma dove sono le lampade, dove sono le ghirlande di fiori? Dov’è il trono per farlo sedere? Oh, vergogna, estrema vergogna! Dov’è la sala, le decorazioni? Uno disse: «Vano è il tuo grido! Accoglietelo a mani vuote, conducetelo nelle vostre sale tutte spoglie!» Aprite le porte! Suonate le conchiglie! Nel cuore della notte il Re è venuto nella nostra casa oscura e tetra. Il tuono brontola nel cielo. Le tenebre fremono di lampi. Porta fuori la stuoia stracciata e stendila nel tuo cortile. Con la tempesta è giunto all’improvviso il nostro Re, nella notte terribile. LII Pensavo di chiederti la corona di rose che portavi al collo - ma non osai. Così attesi il mattino, quando sei partito, per cercarne qualche petalo nel letto. Come una mendicante all’alba cercai soltanto qualche petalo appassito. Ahimé, che è questo che trovo? Quale pegno in ricordo del tuo amore? Non è un fiore, non sono spezie, non è un’anfora d’acqua profumata. È la tua spada possente, scintillante come una fiamma, terribile come una folgore. La giovane luce del mattino penetra attraverso la finestra e si spande sul letto. L’uccello del mattino cinguetta e chiede: «Donna, che hai trovato?» No, non è un fiore, non sono spezie, non è un’anfora d’acqua profumata: è la tua terribile spada. Siedo confusa e rifletto: che dono è mai questo? Non so dove nasconderla, a indossarla ho vergogna, fragile come sono mi ferisce quando la stringo al mio petto. Porterò nel mio cuore questo dono come un fardello doloroso. D’ora innanzi nulla a questo mondo potrò temere, e sarai vittorioso in tutte le mie lotte. Mi hai lasciato la morte per compagna e la incoronerò con la mia vita. La tua spada è con me perch’io possa recidere tutti i legami. D’ora innanzi lascio i futili ornamenti. Signore del mio cuore, non più ci saranno per me attesa e pianto negli angoli, non più timidezza nel mio portamento. Non più ornamenti da bambola per me! LIII Bello è il tuo braccialetto ornato di stelle, sapientemente lavorato con gemme di mille colori. Ma più bella per me è la tua spada, con la sua curva di folgore, simile alle ali distese del divino uccello di Vishnù, Perfettamente sospese nella rossa luce del tramonto. Essa palpita come l’ultima risposta della vita in dolorosa estasi all’estremo colpo della morte; come pura fiamma risplende che brucia i sensi terreni in una vampata rovente. Bello è il tuo braccialetto, ornato di gemme stellate; ma la tua spada, o signore del tuono, è forgiata con suprema bellezza, terribile a vedersi e a pensarci. LIV Nulla ti chiesi, al tuo orecchio il mio nome non ho sussurrato. Quando prendesti commiato rimasi in silenzio. Ero sola presso il pozzo, dove l’ombra degli alberi cadeva obliquamente, alle lor case le donne eran tornate con le anfore colme fino all’orlo. Mi chiamarono gridando: «Vieni, il mattino è finito, è mezzogiorno». Ma pigramente indugiavo, perduta in un vago fantasticare. Quando sei venuto, non udii i tuoi passi; i tuoi occhi erano tristi quando si posarono su di me; la tua voce era stanca quando mi dicesti a bassa voce: «Sono un viandante assetato». Mi scossi dal mio sogno ad occhi aperti e dalla brocca l’acqua ti versai nelle tue palme giunte a coppa. Sopra noi stormivano le foglie, nell’ombra un cuculo cantava, e dalla curva in fondo alla strada veniva un profumo di fiori di babla. Quando chiedesti il mio nome rimasi senza parole per la vergogna. Che mai avevo fatto per te per meritare il tuo ricordo? Ma il pensiero che avevo potuto offrirti acqua per calmare la tua sete resterà nel mio cuore e lo colmerà di dolcezza. L’ora del mattino è tarda, l’uccello canta in stanche note; sopra il mio capo stormiscono le foglie del neem e io siedo a pensare e pensare. LV Il tuo cuore è pieno di languore, i tuoi occhi sono ancora assonnati. Non ti è giunta voce che il fiore regna in splendore tra le spine? Destati, oh, destati! Non lasciare che il tempo passi invano! Alla fine del sentiero sassoso, nel paese della vergine solitudine, il mio amico siede tutto solo. Non deluderlo. Destati, oh, destati! Che importa se il cielo freme e trema nel calore del sole del meriggio; che importa se la sabbia rovente stende il suo manto di sete? Non c’è gioia in fondo al tuo cuore? A ogni tuo passo l’arpa della strada non suonerà una dolce musica di dolore? LVI È per questo che la tua gioia ha raggiunto in me la sua pienezza È per questo che sei sceso in me. O signore di tutti i cieli, dove sarebbe il tuo amore se io non esistessi? Hai diviso con me tutta questa ricchezza, Nel mio cuore è l’infinito gioco del tuo diletto. Nella mia vita la tua volontà sta sempre prendendo forma. Ed è per questo che tu, che sei il Re dei re, ti sei ornato di bellezza per sedurre il mio cuore. E per questo il tuo amore si perde nell’amore del tuo amante e là tu appari nell’unione perfetta di due esseri. LVII Luce, mia luce, luce che riempi il mondo, luce che baci gli occhi, luce che addolcisci i cuori! La luce danza, amore mio, al centro della mia vita; la luce suona, amore mio, gli accordi del mio amore; s’aprono i cieli, il vento soffia selvaggio, una risata passa sulla terra. Le farfalle stendono le loro vele sul mare della luce. Gigli e gelsomini si levano in alto sulla cresta delle onde della luce. La luce si rifrange in oro sopra ogni nube, amore mio, e sparge gemme in profusione. Di foglia in foglia, amore mio, gioia e felicità senza misura. Il fiume del cielo è straripato e ha inondato il mondo di gioia. LVIII Tutti i miei versi di gioia si mescolino nei miei ultimi canti la gioia, che fa straripare la terra nel rigoglio sfrenato dell’erba, la gioia che fa danzare per il mondo le due gemelle, la vita e la morte; la gioia che irrompe come una tempesta, scuotendo e destando tutta la vita col suo riso; la gioia che siede silenziosa con il suo pianto sul dischiuso rosso fior di loto del dolore; e la gioia che getta nella polvere tutto quello che ha e non conosce parole. LIX Sì, lo so, non è nient’altro che il tuo amore questa luce dorata che danza sulle foglie, queste pigre nubi che veleggiano nel cielo, questa brezza che passa lasciando la sua freschezza sulla mia fronte. La luce del mattino m’ha inondato gli occhi: è questo il tuo messaggio al mio cuore. Chini il viso, i tuoi occhi fissano i miei occhi, e il mio cuore ha toccato i tuoi piedi. LX I bambini s’incontrano sulla spiaggia di mondi sconfinati. Su di loro l’infinito cielo è silenzioso, l’acqua s’increspa. Con grida e danze s’incontrano i bambini sulla spiaggia di mondi sconfinati. Fanno castelli di sabbia e giocano con vuote conchiglie. Con foglie secche intessono barchette e sorridendo le fanno galleggiare sull’immensa distesa del mare. I bambini giocano sulla riva dei mondi. Non sanno nuotare, non sanno gettare le reti. I pescatori si tuffano a pescare le perle dal fondo del mare, nelle navi viaggiano i mercanti, mentre raccolgono i bambini sassolini che poi gettano via. Non cercano tesori nascosti, non sanno gettare le reti. Il mare s’increspa di sorrisi e la spiaggia dolcemente risuona. Le onde che portano la morte cantano ai bambini nenie senza senso, come fa la madre quando culla la sua creatura. Il mare gioca coi bambini e la spiaggia dolcemente risuona. S’incontrano i bambini sulla riva di mondi sconfinati. Vaga la tempesta per il cielo dai molti sentieri, naufragano navi nell’acqua dai molti sentieri, la morte è in giro e giocano i bambini. C’è un grande convegno di bambini sulla spiaggia di mondi sconfinati. LXI Nessuno sa di dove viene il sonno che aleggia sugli occhi dei bambini? Sì. Si dice che abiti laggiù, in un villaggio incantato, dove, tra le ombre d’una fitta foresta fiocamente illuminata dalle lucciole, splendidi pendono due timidi fiori. Ecco di dove viene il sonno a baciare il sonno dei bambini. Nessuno sa dove nacque il sorriso che ondeggia sulle labbra dei bambini che dormono? Sì, si dice che un giovane pallido raggio di luna crescente abbia sfiorato il lembo d’una leggera nuvola autunnale; e così, nel sogno di un mattino bagnato di rugiada, per la prima volta nacque il sorriso che ondeggia sulle labbra dei bambini che dormono. Nessuno sa dove a lungo nascose la dolce e tenera freschezza che fiorisce sulle membra dei bambini? Sì. Quando la madre era ancor giovinetta la portava nel cuore colmo del mistero delicato e silenzioso dell’amore: là sbocciò la dolce e tenera freschezza che fiorisce sulle membra dei bambini. LXII Quando ti porto balocchi variopinti, bambino mio, comprendo perché ci sono tanti colori nelle nubi e nell’acqua, e perché i fiori son colorati tanto vagamente quando ti regalo balocchi variopinti. Quando canto per farti danzare, bambino mio, comprendo perché nelle foglie c’è musica, e le onde mandano il coro delle loro voci fino al cuore della terra che ascolta quando canto per farti danzare. Quando verso dolci nelle tue mani, bambino mio, comprendo perché c’è il miele nel calice dei fiori, perché i frutti si riempiono in segreto di tanti gradevoli succhi quando verso dolci nelle tue mani. Quando ti bacio per farti sorridere, amore mio, comprendo il perché della gioia che si spande dal cielo nella luce del primo mattino, della carezza del vento dell’estate che mi sfiora per tutte le membra quando ti bacio per farti sorridere. LXIII Mi hai fatto conoscere ad amici che non conoscevo. Mi hai fatto sedere in case che non erano la mia. Mi hai portato vicino il lontano, e reso l’estraneo un fratello. In fondo al cuore mi sento a disagio quando abbandono l’abituale rifugio; scordo che il vecchio dimora nel nuovo, e là tu stesso hai dimora. Attraverso la nascita e la morte, in questo oppure in altri mondi, ovunque mi conduci, sei tu, lo stesso, unico compagno della mia vita senza fine, che unisci con legami di gioia il mio cuore a ciò che non è familiare. Quando uno ti conosce, nessuno è un estraneo, nessuna porta è chiusa. Oh, esaudisci la mia preghiera: ch’io non perda mai la carezza dell’uno nel gioco dei molti. LXIV Sulla riva del fiume desolato fra le alte erbe le chiesi: «Dove vai, fanciulla, riparando la tua lampada con il mantello? La mia casa è buia e solitaria prestami il tuo lume!» Lei sollevò per un istante gli occhi bruni, e fissò il mio volto nella luce incerta del tramonto. Disse: «Sono venuta al fiume per far galleggiare la mia lampada sulla corrente quando la luce del giorno piano svanisce ad occidente». Rimasi solo fra le alte erbe a osservare la timida fiamma della sua lampada, che inutilmente galleggiava nella corrente. Nel silenzio della notte, le chiesi: «Fanciulla, le tue luci sono tutte accese, dove te ne vai con la tua lampada? La mia casa è buia e solitaria prestami il tuo lume!» Lei sollevò i suoi occhi bruni sul mio viso, e per un momento rimase incerta; e infine disse: «Sono venuta a dedicare la mia lampada al cielo». Io rimasi a guardare il suo lume consumarsi nel vuoto inutilmente. A mezzanotte, nel buio senza luna, le chiesi: «Fanciulla, che cerchi portando la lampada stretta al cuore? La mia casa è buia e solitaria prestami il tuo lume!» Lei si fermò un istante a pensare, e fissava il mio volto nel buio. «Ho portato il mio lume», rispose, «A unirsi alla Festa delle lampade». Io rimasi a guardare la sua piccola lampada, inutilmente perduta fra i lumi. LXV Quale divina bevanda vorresti, mio Dio da questa coppa straripante della mia vita? Mio poeta, la tua gloria è vedere la tua creazione attraverso i miei occhi e ascoltare attraverso i miei orecchi la tua stessa eterna armonia? Il tuo mondo tesse parole nella mia mente, e la tua gioia le mette in musica. Ti sei dato a me con amore e senti in me tutta la tua dolcezza. LXVI Lei, ch’era sempre rimasta nel profondo del mio essere, nel crepuscolo di bagliori e visioni; lei, che mai non aprì i suoi veli alla luce del mattino, sarà il mio ultimo dono, mio Dio, avvolto nel mio ultimo canto. Le parole l’hanno corteggiata ma non hanno saputo conquistarla; invano la persuasione ha steso bramosa le braccia. Ho vagato di paese in paese serbandola nel fondo del cuore, e intorno a lei sorsero e caddero le vicende della mia vita. Sui miei pensieri e sulle mie azioni, sui miei sonni e sui miei sogni, lei regnava, oppure dimorava in disparte e da sola. Molti uomini bussarono, per chiederla, alla mia porta, e tornarono via disperati. Mai nessuno al mondo la vide a faccia a faccia, e lei rimase nella sua solitudine, in attesa del tuo riconoscimento. LXVII Tu sei il cielo e sei anche il nido. O tu bella, là nel nido è il tuo amore che imprigiona l’anima con colori e suoni e odori. Ecco viene il mattino tenendo in mano il suo canestro d’oro, portando il serto della bellezza per incoronare in silenzio la terra. Ed ecco che viene la sera sopra i prati solitari abbandonati dalle greggi attraverso sentieri non tracciati, portando fresche sorsate di pace dall’oceano occidentale del riposo nella sua brocca d’oro. Ma là, dove si stende l’infinito cielo in cui l’anima prende il suo volo, regna lo splendore bianco e immacolato. Non c’è giorno né notte, né forma né colore, né mai una sola parola. LXVIII Scende il tuo raggio di sole sulla mia terra a braccia aperte e si ferma alla mia porta un giorno lungo come una vita, per riportare ai tuoi piedi nuvole fatte di lacrime, sospiri e canzoni. Con ardente gioia t’avvolgi attorno al petto stellato questo manto di nubi nebbiose, mutandolo in forme e pieghe innumerevoli e tingendolo di sempre cangianti colori. E tanto leggero e fugace, tenero e triste e oscuro; è per questo che l’ami, o tu immacolato e sereno. E per questo ch’esso può coprire la tua terribile luce bianca con le sue ombre patetiche. LXIX La stessa corrente di vita che scorre nelle mie vene, notte e giorno scorre per il mondo e danza in ritmica misura. È la stessa vita che germoglia gioiosa attraverso la polvere negli infiniti fili dell’erba e prorompe in onde tumultuose di foglie e di fiori. È la stessa vita che viene cullata nella cuna oceanica di nascita e morte nel flusso e riflusso della marea. Sento le mie membra diventare splendide al tocco di questo mondo pieno di vita. E il mio orgoglio viene dall’eternità che danza nel mio sangue in questo istante. LXX Non sei capace d’essere felice con la felicità di questo ritmo? di lanciarti e perderti e spezzarti nel vortice di questa terribile gioia? Tutte le cose avanzano impetuose, non si fermano, non guardano indietro, nessun potere può trattenerle, esse scorrono impetuose in avanti. Seguendo il ritmo veloce di questa musica incessante, le stagioni vengono danzando e se ne vanno colori, melodie, profumi si versano in cascate senza fine nella gioia straripante che si spande, e cessa, e muore ogni momento. LXXI Ch’io vada superbo di me stesso volgendomi intorno da ogni parte, gettando ombre colorate sul tuo splendore questa è la tua maya. Tu erigi una barriera nel tuo stesso essere, e poi con mille note richiami il tuo io diviso, che si è rivestito del mio corpo. Echeggia per il cielo un canto triste in lacrime di molti colori e sorrisi e timori e speranze; onde si levano e ricadono, sogni si formano e s’infrangono. In me è la tua stessa sconfitta dell’io. Lo schermo che hai alzato è dipinto d’innumerevoli figure col pennello della notte e del giorno; dietro ad esso il tuo trono è tessuto in meravigliosi misteri di curve da cui la linea retta è bandita. Il nostro grande scenario ha ricoperto tutto il cielo. Tutta l’aria è vibrante delle nostre melodie e tutte le ere passano con il nostro nasconderci e cercarci. LXXII È lui che desta il mio essere con le sue carezze nascoste. È lui che incanta questi occhi e suona lietamente gli accordi del mio cuore in svariate cadenze di dolori e di gioie. È lui che tesse la rete di maya con evanescenti colori d’oro e d’argento, di verde e d’azzurro, e lascia intravvedere tra le pieghe i suoi piedi, alla cui carezza dimentico me stesso. Vengono i giorni e passano le ere, ed è sempre lui che mi commuove il cuore in molti nomi, sotto molte guise, in molte estasi di gioia e di dolore. LXXIII La mia liberazione non è nella rinuncia. Sento l’abbraccio della libertà in mille vincoli di gioia. Sempre versi per me il fresco sorso del tuo vino fragrante e di vari colori colmando questo vaso fino all’orlo. Il mio mondo accenderà alla tua fiamma centinaia di lampade diverse e le offrirà all’altare del tuo tempio. No. Non chiuderò le porte dei miei sensi. Le gioie della vista e dell’udito porteranno impressa la tua gioia. Sì, tutte le mie illusioni bruceranno in una luminaria di gioia e tutti i miei desideri matureranno in frutti d’amore. LXXIV Il giorno è finito, l’ombra scende sulla terra. E tempo che vada a riempire la mia brocca al ruscello. Si sente nell’aria della sera la triste musica dell’acqua, che m’invita ad uscire nel buio. Nel sentiero solitario non passa nessuno; il vento si è levato, s’increspa l’acqua del fiume. Non so se tornerò a casa, non so chi potrò incontrare. In una barchetta presso il guado uno sconosciuto suona il liuto. LXXV I doni che tu dai a noi mortali appagano tutti i nostri bisogni e pure ritornano a te senz’esserne diminuiti. Il fiume ha il suo lavoro giornaliero e s’affretta per campi e villaggi, e pure la sua corrente incessante scorre a bagnare i tuoi piedi. Il fiore rende dolce l’aria con il suo profumo, e pure il suo ultimo servizio è quello di offrirsi a te. Il tuo culto non impoverisce il mondo. Dalle parole del poeta gli uomini traggono il senso che loro più piace, e pure il loro ultimo significato è diretto a te. LXXVI Un giorno dopo l’altro, o signore della mia vita, starò davanti a te a faccia a faccia. A mani giunte, o signore di tutti i mondi, starò davanti a te a faccia a faccia. Sotto il grande cielo in solitudine e silenzio, con cuore umile, starò davanti a te a faccia a faccia. In questo tuo mondo operoso, nel tumulto del lavoro e della lotta, tra la folla che s’affretta, starò davanti a te a faccia a faccia. E quando il mio lavoro in questo mondo sarà compiuto, o Re dei re, solo e senza parole, starò davanti a te a faccia a faccia. LXXVII Ti conosco come mio Dio e me ne sto in disparte non ti conosco come mio e vengo più vicino. Ti conosco come mio padre e mi prostro ai tuoi piedi non stringo la tua mano come quella d’un amico. Non sono dove tu scendi e ti riconosci mio, a stringerti sul mio petto e prenderti come compagno. Tu sei il Fratello tra i miei fratelli, ma non mi curo di loro, non divido con loro i miei guadagni, dividendo così con te tutto quello che ho. Nel piacere e nella pena, non sto al fianco degli uomini, e così sto accanto a te. Rifuggo dal lasciare la mia vita, e così non m’immergo nelle grandi acque della vita. LXXVIII Quando il mondo era appena creato e le stelle risplensero nel loro primo splendore, gli dèi tennero assemblea nel cielo e cantarono: «Oh, l’immagine della perfezione! la gioia che non ha eguali!» Ma uno gridò all’improvviso: «Sembra che in qualche luogo la catena della luce sia interrotta e una stella sia stata smarrita». La corda d’oro della loro arpa si ruppe, il loro canto s’interruppe, e gridarono costernati: «Sì, quella stella perduta era la più bella, la gloria di tutti i cieli!» Da quel giorno la cercano ancora e ripetono l’un l’altro gridando che con essa il mondo ha perduto la sua unica gioia. Ma nel più fondo silenzio della notte le stelle sorridono e bisbigliano tra loro: «Vana è questa ricerca! La perfezione inviolata abbraccia l’intero universo!» LXXIX Se non mi è dato d’incontrarti in questa vita fa allora ch’io sempre mi ricordi che non ti ho veduto che non lo dimentichi un solo momento, che porti la stretta di questo dolore nei miei sogni e nelle mie ore insonni. Mentre i miei giorni passano nell’affollato mercato di questo mondo e le mie mani si riempiono dei miei guadagni quotidiani, fa ch’io sempre mi ricordi che non ho guadagnato nulla che non lo dimentichi un solo momento, che porti la stretta di questo dolore nei miei sogni e nelle mie ore insonni. Quando siedo sul bordo della strada, stanco e dolente, quando stendo il mio letto nella polvere, fa ch’io sempre ricordi che un lungo viaggio ancora mi attende che non lo dimentichi un solo momento, che porti la stretta di questo dolore nei miei sogni e nelle mie ore insonni. Quando le mie stanze sono tutte addobbate e i flauti suonano e le risate echeggiano alte, fa ch’io sempre mi ricordi che nella mia casa non ti ho invitato che non lo dimentichi un solo momento, che porti la stretta di questo dolore nei miei sogni e nelle mie ore insonni. LXXX Sono come il residuo d’una nube d’autunno che vaga inutilmente per il cielo, o mio sole sempre glorioso! La tua carezza non ha ancora sciolto i miei vapori, facendomi diventare una sola cosa con la tua luce, e così conto i mesi e gli anni separato da te. Se questa è la tua volontà, se questo è il tuo trastullo, prendi questa errante vuotezza, dipingila con i tuoi colori, adornala d’oro; trasportala nel vento vagabondo e sperdila in svariate meraviglie. E quando ti piacerà finire questo gioco, mi scioglierò e svanirò nell’oscurità o forse in un sorriso del bianco mattino, in una fresca e trasparente purezza. LXXXI In molti giorni oziosi ho pianto sul tempo perduto. Ma non è mai perduto, signore. Hai preso ogni istante della mia vita nelle tue mani. Nascosto nel cuore del creato, tu nutri i semi in germogli, le gemme in bocciuoli, i fiori in frutti maturi. Ero stanco e dormivo pigramente nel mio letto, e immaginavo che ogni lavoro si fosse fermato. Al mattino mi destai e trovai il mio giardino tutto pieno d’un miracolo di fiori. LXXXII Il tempo è senza fine nelle tue mani, mio signore. Non c’è nessuno che conti le tue ore. Passano i giorni e le notti, le stagioni sbocciano e appassiscono come fiori. Tu sai attendere. I tuoi secoli si susseguono per perfezionare un piccolo fiore di campo. Noi non abbiamo tempo da perdere, e non avendo tempo dobbiamo affannarci per non perdere le nostre occasioni. Siamo troppo poveri per arrivare in ritardo. E così il tempo passa, mentre io lo dono a ogni uomo querulo che lo richiede, e il tuo altare è del tutto vuoto. Alla fine del giorno m’affretto per paura che la tua porta sia chiusa; e invece c’è ancora tempo. LXXXIII Madre, con le lacrime del mio dolore ti farò una collana di perle. Le stelle hanno forgiato i loro bracciali di luce per ornare i tuoi piedi, ma i miei penderanno sul tuo petto. Fama e ricchezza provengono da te, e spetta a te donarle o rifiutarle. Ma questo dolore è solamente mio, e quando te lo porto come la mia offerta mi ricompensi con la tua grazia. LXXXIV Il dolore della separazione si spande per tutto il mondo e fa nascere innumerevoli forme nel cielo infinito. La tristezza della separazione fissa in silenzio per tutta la notte di stella in stella, e diventa canto tra le foglie fruscianti nella piovosa oscurità di luglio. Questa pena che tutto pervade s’infonda in amori e desideri, in sofferenze e gioie nelle case umane; ed è la stessa che sempre si fonde e sgorga in canti nel mio cuore di poeta. LXXXV Quando per primi uscirono i guerrieri dalla casa del loro signore dove avevano nascosto la loro potenza? Dove avevano le corazze e le spade? Sembravano poveri e indifesi, e su loro piovvero le frecce il giorno in cui uscirono dalla casa del loro signore. Quando i guerrieri tornarono marciando alla casa del loro signore, dove avevano nascosto la loro potenza? Avevano deposto la spada, deposti l’arco e le frecce, la pace era sulle loro fronti e s’erano lasciati alle spalle i frutti della loro vita il giorno in cui tornarono marciando alla casa del loro signore. LXXXVI La morte, tuo servo, è alla mia porta. Ha attraversato un mare sconosciuto e mi ha portato il tuo richiamo. La notte è buia e il mio cuore è pieno di paura, eppure prenderò il mio lume, aprirò la porta, e inchinandomi le porgerò il benvenuto. È il tuo messaggero che sta alla mia porta. L’adorerò a mani giunte, e in lacrime. L’adorerò ponendo ai suoi piedi il tesoro del mio cuore. Assolto il suo incarico, ripartirà lasciando un’ombra oscura sul mio mattino; e nella mia casa desolata solo il mio corpo abbandonato resterà come mia ultima offerta. LXXXVII In disperata speranza la vado cercando in ogni angolo della mia casa, ma non la trovo. La mia casa è piccola e ciò che una volta è andato via non può mai più essere ripreso. Ma infinito è il tuo palazzo, signore, e cercando lei sono giunto alla tua porta. Son sotto la canopia d’oro del tuo cielo vespertino e levo ansioso gli occhi verso il tuo viso. Sono venuto sull’orlo dell’eternità da cui nulla può svanire nessuna speranza, né felicità, né la visione d’un volto intravisto tra le lacrime. Oh, immergi la mia vuota vita in quell’oceano, tuffala nel suo abisso più profondo. Lasciami per una volta sola sentire quella dolce carezza perduta nella totalità dell’universo. LXXXVIII Divinità del tempio in rovina! Le rotte corde della vina non cantano più le tue lodi. Non più le campane della sera annunciano l’ora del tuo culto. Intorno a te l’aria è ferma e silenziosa. Nella tua desolata dimora entra vagabonda la brezza della primavera. Porta novelle di fiori quei fiori che per il tuo culto non sono più offerti. Il tuo fedele d’un tempo vaga sempre in attesa d’una grazia sempre rifiutata. A sera, quando i fuochi e l’ombre si confondono nel buio di polvere, egli stancamente ritorna nel tempio in rovina con la brama nel cuore. Molti giorni di festa passano per te silenziosi, divinità del tempio in rovina. Molte notti di adorazione passano con lampade spente. Molte nuove immagini sono fabbricate da maestri esperti nell’arte e portate al sacro fiume dell’oblio quando è giunta la loro ora. Solo la divinità del tempio in rovina rimane eternamente negletta e non adorata. LXXXIX Non più parole chiassose questa è la volontà del mio signore. Parlerò soltanto bisbigliando. Continuerò il discorso del mio cuore nel mormorio di canzoni. Gli uomini s’affrettano al mercato del Re. Tutti i venditori e i compratori son là. Io ho il mio congedo prematuro nel mezzo del giorno, nel pieno del lavoro. Lasciate quindi che i fiori sboccino nel mio giardino anche se non è il loro tempo; lasciate che le api nel meriggio levino il loro pigro ronzio. Molte lunghe ore ho passate nella lotta del bene e del male, ma ora il mio compagno di giochi dei miei giorni vani desidera attirare a sé il mio cuore; e non comprendo a quale inutile fine questo improvviso richiamo. XC Il giorno che la morte busserà alla tua porta, cosa le offrirai? Porgerò alla mia ospite la coppa colma della mia vita - non lascerò che se ne vada a mani vuote. Tutta la dolce vendemmia di tutti i miei giorni d’autunno, di tutte le notti d’estate, tutto quello che ho guadagnato, tutto quello che ho spigolato nella mia vita operosa, lo porgerò a lei, quando alla fine dei miei giorni la morte busserà alla mia porta. XCI O Morte, mia morte, ultimo compimento della vita, vieni a parlarmi sussurrando! Di giorno in giorno ti ho attesa, per te ho sopportato i dolori e le gioie della vita. Tutto quello che sono, tutto quello che ho, tutto quello che spero, e tutto quello che amo a te sono sempre affluiti in profondo mistero. Un ultimo sguardo dei tuoi occhi, e la mia vita sarà per sempre tua. I fiori sono stati intrecciati ed è pronta la ghirlanda per lo sposo. Dopo le nozze la sposa lascerà la sua casa, e sola andrà incontro al suo signore nella solitudine della notte. XCII So che il giorno verrà in cui la visione di questo mondo per me sarà perduta e la mia vita in silenzio prenderà commiato, stendendo sui miei occhi l’ultimo velo. Eppur le stelle veglieranno a notte, e il mattino sorgerà come sempre, e le ore si gonfieranno come le onde del mare contando i piaceri e le pene. Quando penso alla fine dei miei giorni la barriera del tempo s’infrange, e vedo, alla luce della morte, il tuo mondo con i suoi tesori. Prezioso è anche il più umile posto, anche la vita più umile è preziosa. Le cose che invano ho sospirato e le cose che ho ottenuto lasciamole passare. Mi sia ora concesso di possedere veramente soltanto le cose che ho sempre respinto e trascurato. XCIII Ho ricevuto il mio congedo. Ditemi addio, fratelli miei! M’inchino a voi tutti e prendo commiato. Ecco, rendo le chiavi della mia porta rinuncio a ogni diritto sulla mia casa. Vi chiedo soltanto ultime parole gentili. Per molto tempo fummo vicini di casa, ma ho ricevuto più di quello che potevo dare. Ora si fa giorno, e la lampada che rischiarava il mio buio cantuccio s’è spenta È giunto un richiamo e sono pronto al mio viaggio. XCIV È giunta l’ora della mia partenza; amici, auguratemi buona fortuna! L’aurora ha tinto il cielo di rosa, e bello si stende il mio sentiero. Non chiedetemi cosa porto con me. Parto pel mio viaggio a mani vuote e col cuore pieno di speranza. Mi cingerò della mia corona nuziale. L’abito rossobruno del viandante non mi si addice, e anche se vi sono pericoli per via, non ho paura. La stella della sera sorgerà quando il mio viaggio sarà terminato e le tristi melodie del crepuscolo echeggeranno dalle porte reali. XCV Non mi accorsi del momento in cui varcai per la prima volta la soglia di questa vita. Quale fu la potenza che mi schiuse in questo vasto mistero come sboccia un fiore in una foresta a mezzanotte? Quando al mattino guardai la luce, subito sentii che non ero uno straniero in questo mondo, che l’inscrutabile senza nome e forma mi aveva preso tra le sue braccia sotto l’aspetto di mia madre. Così, nella morte, lo stesso sconosciuto m’apparirà come sempre a me noto. E poiché amo questa vita so che amerò anche la morte. Il bimbo piange quando la madre dal seno destro lo stacca, ma subito dopo si consola succhiando da quello sinistro. XCVI Quando me ne andrò lontano da qui questa sarà la mia ultima parola: ciò che ho visto è insuperabile. Ho assaggiato il miele segreto di questo loto che si espande sull’oceano di luce la mia vita è stata benedetta questa sarà la mia ultima parola. In questo teatro d’infinite forme ho recitato la mia parte e qui ho intravisto colui che è senza forma. Tutto il mio corpo e tutte le mie membra fremettero al tocco di colui che è intangibile; e se qui mi coglie la mia fine, lasciatela venire e questa sarà la mia ultima parola. XCVII Quando giocavo con te non chiesi mai chi eri. Non conoscevo né paura né vergogna, la mia vita era chiassosa. Di primo mattino mi destavi come un compagno e mi guidavi correndo di radura in radura. In quei giorni non mi curavo di comprendere il senso dei canti che tu mi cantavi. Solo la mia voce riprendeva le melodie, e il mio cuore danzava alla loro cadenza. Ora che il tempo dei giochi è passato, quale visione improvvisa mi si presenta? Il mondo china timoroso gli occhi verso i tuoi piedi con tutte le sue stelle silenziose. XCVIII Ti incoronerò di trofei, ghirlande della mia sconfitta. Non posso mai sfuggirti senza prima essere vinto. So certamente che il mio orgoglio cederà il passo nel dolore infinito la mia vita spezzerà i suoi vincoli, il mio cuore svuotato in musica singhiozzerà come una canna cava, e le pietre si scioglieranno in lacrime. So certamente che i cento petali del loto non rimarranno chiusi per sempre, e il recesso segreto del suo miele verrà aperto. Dal cielo azzurro un occhio mi fisserà e mi chiamerà in silenzio. Nulla mi sarà lasciato, nulla di nulla, e ai tuoi piedi riceverò l’estrema morte. XCIX Quando abbandono il timone so ch’è giunto il momento che tu lo regga. Ciò che si deve fare sarà subito fatto. Vana è la tua lotta. Ritrai perciò le tue mani, e accetta in silenzio la tua sconfitta, e pensa che sei fortunato di sedere perfettamente immobile nel posto che ti è stato assegnato. Queste mie lampade si spengono al più piccolo soffio di vento nel tentativo di tenerle accese dimentico sempre tutto il resto. Ma questa volta sarò saggio e attenderò al buio, stendendo per terra la mia stuoia; e ogni qual volta ti piaccia, mio signore, vieni silenziosamente e siediti al mio fianco. C Mi tuffo nell’oceano delle forme sperando di trovare la perla perfetta del senza forma. Non più andrò veleggiando di porto in porto con questa mia barca battuta dalle intemperie. Da molto son passati i giorni in cui mi dilettavo d’essere cullato sulle onde. E ora sono impaziente di morire nel senza morte. Nella sala delle udienze, presso l’abisso insondabile ove risuona la musica di corde senza suono porterò quest’arpa della mia vita. L’accorderò alle note del per sempre, e quando singhiozzando avrà detto la sua ultima frase, deporrò la mia arpa muta ai piedi di colui che tace. CI Sempre nella mia vita ho cercato te con i miei canti. Mi guidarono di porta in porta, e con essi mi tastai intorno cercando e accarezzando il mio mondo. Sono stati i miei canti che mi hanno insegnato tutto quello che ho imparato, mi indicarono i sentieri segreti, molte stelle portarono nell’orizzonte del mio cuore. Per tutto il giorno mi guidarono fino ai misteri del paese della gioia e del dolore; e, ora, alla porta di quale palazzo mi hanno portato nella sera alla fine del mio viaggio? CII Tra gli uomini mi vantai di averti conosciuto. Vedono il tuo ritratto in tutte le mie opere. Vengono a chiedermi: «Chi è?» E non so cosa rispondere. Dico: «Davvero non saprei». Mi deridono e vanno via pieni di disprezzo. E tu siedi là sorridendo. Racconto le tue storie in canti durevoli. Il segreto mi trabocca dal cuore. Vengono e mi chiedono: «Spiegami quello che vuoi dire». E non so cosa rispondere. Dico: «Oh, chissà cosa vogliono dire!». Sorridono e se ne vanno pieni di disprezzo. E tu siedi là sorridendo. CIII In un saluto a te, mio Dio, tutti i miei sensi si effondano e sfiorino questo mondo ai tuoi piedi. Come una nube di luglio, bassa, sospesa col suo carico di piogge non versate, tutti i miei pensieri s’inchinino alla tua porta in un saluto a te. Come uno stormo di gru che nostalgiche fanno ritorno volando notte e giorno ai loro nidi montani, così tutta la mia vita intraprenda il suo viaggio verso l’eterna dimora in un saluto a te. Il Giardiniere I Servo. Abbi mercé del tuo servo, mia regina! Regina. La riunione è finita, e tutti i miei servi sono andati via. Perché tu vieni a questa tarda ora? Servo. Quando hai finito con gli altri, allora viene la mia ora. Vengo a chiederti cosa rimane per il tuo ultimo servo. Regina. Che speri di ottenere, quando è troppo tardi? Servo. Fammi giardiniere del tuo giardino di fiori. Regina. Che follia è questa? Servo. Rinuncerò a ogni altro mio lavoro. Getterò nella polvere le mie lance e le mie spade. Non inviarmi in Corti lontane; non ordinarmi di compiere nuove conquiste. Ma fammi giardiniere del tuo giardino di fiori. Regina. Quali saranno i tuoi doveri? Servo. Servirti nei tuoi giorni d’ozio. Manterrò fresco il sentiero erboso dove tu cammini al mattino, dove a ogni passo i tuoi piedi saranno salutati con lodi da fiori anelanti di morire. Ti dondolerò su un’altalena tra i rami del saptaparna, dove la prima luna della sera lotterà tra le foglie per baciarti l’orlo della gonna. Riempirò d’olio profumato la lampada che arde accanto al tuo letto, e ornerò lo sgabello dove posi i piedi con meravigliosi disegni, fatti con impasto di sandalo e zafferano. Regina. E cosa chiedi come ricompensa? Servo. Di poter stringere i tuoi piccoli pugni simili a teneri bocciuoli di loto e intrecciare ai tuoi polsi ghirlande di fiori; di tingerti le piante dei piedi col rosso succo dei petali di ashoka e togliere con i miei baci i granelli di polvere che potranno posarvisi. Regina. Le tue preghiere sono esaudite, mio servo, sarai il giardiniere del mio giardino di fiori. II Oh, poeta, la sera s’avvicina; i tuoi capelli diventano grigi. Nel tuo meditare solitario odi il messaggio dell’aldilà? «È sera», rispose il poeta, «e sto in ascolto perché dal villaggio qualcuno potrebbe chiamarmi, sebbene l’ora sia tarda. Osservo se i giovani cuori vagabondi s’incontrano, e due paia d’occhi supplicanti chiedono che la mia musica rompa il loro silenzio e parli per loro. Chi tesserà i loro canti appassionati, se io siedo sulla riva della vita contemplando la morte e l’aldilà?» «Già tramonta la stella della sera. Il fuoco d’una pira funeraria muore lentamente presso il fiume silenzioso. Dal cortile d’una casa deserta gli sciacalli urlano in coro alla luce della luna sfinita. Se un viandante, lasciando la casa, viene qui a contemplare la notte e ad ascoltare a testa china il mormorio dell’oscurità, chi gli sussurrerà i segreti della vita se io, chiudendo le mie porte, cercassi di liberarmi dai legami mortali?» «Poco importa se i miei capelli diventano grigi. Sono sempre giovane e vecchio come il più giovane e il più vecchio di questo villaggio. Alcuni hanno negli occhi sorrisi semplici e dolci, alcuni un furbesco ammiccare. Alcuni piangono alla luce del giorno, altri piangono in segreto nel buio. Hanno tutti bisogno di me, e non ho tempo di rimuginare sull’eternità. Ho la stessa età di ciascuno, e cosa importa se i miei capelli diventano grigi?» III Al mattino gettai la mia rete nel mare. Trassi dall’oscuro abisso cose di strano aspetto e di strana bellezza alcune brillavano come un sorriso, alcune luccicavano come lacrime, e alcune erano rosee come le guance d’una sposa. Quando, alla fine del giorno, tornai a casa con il mio bottino, il mio amore sedeva nel giardino sfogliando oziosamente un fiore. Esitante deposi ai suoi piedi tutto quello che avevo pescato. Lei guardò distrattamente e disse: «Che strani oggetti sono questi? Non capisco a che possano servire». Chinai il capo, vergognoso, pensando: «Non ho lottato per conquistarli, non li ho comperati al mercato; non sono doni degni di lei». E per tutta la notte li gettai a uno a uno sulla strada. Al mattino vennero dei viaggiatori; li raccolsero e li portarono in paesi lontani. IV Ahimé, perché costruirono la mia casa sulla strada che porta al mercato? Essi ormeggiano i loro battelli carichi presso i miei alberi. Essi vengono e vanno e passeggiano a loro piacere. Io siedo e li osservo; il mio tempo passa lentamente. Scacciarli non posso. E così passano i miei giorni. Notte e giorno i loro passi risuonano davanti alla mia porta. Invano grido: «Io non vi conosco». Alcuni d’essi son noti alle mie dita, alcuni alle mie narici, il sangue delle mie vene sembra conoscerli, e alcuni son noti ai miei sogni. Scacciarli non posso. Li chiamo e dico: «Venga a casa mia chiunque vuole. Sì, venite». Al mattino la campana suona nel tempio. Essi vengono reggendo in mano i loro canestri. I loro piedi sono rosso-rosati. I loro volti sono illuminati dalla prima luce dell’alba. Scacciarli non posso. Li chiamo e dico: «Venite a cogliere fiori nel mio giardino. Venite». A mezzogiorno il gong risuona al cancello del palazzo. Non capisco perché lasciano il lavoro e gironzolano intorno alla mia siepe. I fiori nei loro capelli sono pallidi e appassiti; le note dei loro flauti son languide. Scacciarli non posso. Li chiamo e dico: «L’ombra è fresca sotto i miei alberi. Amici, venite». A notte i grilli friniscono nei boschi. Chi viene lentamente e bussa gentilmente alla mia porta? Il viso intravvedo vagamente, nessuna parola viene pronunciata, il silenzio della notte è tutto intorno. Scacciare il mio muto ospite non posso. Osservo il suo volto nell’oscurità, e passano ore di sogno. V Sono irrequieto. Sono assetato di cose lontane. La mia anima esce anelando di toccare l’orlo dell’oscura lontananza. O Grande Aldilà, oh, l’acuto richiamo del tuo flauto! Dimentico, sempre dimentico, che non ho ali per volare. Sono impaziente e insonne, sono straniero in una terra straniera. Il tuo alito mi giunge sussurrando una impossibile speranza. Il mio cuore comprende il tuo linguaggio come fosse lo stesso ch’egli parla. O Lontano-da-cercare, oh, l’acuto richiamo del tuo flauto! Dimentico, sempre dimentico, che non conosco la strada, che non ho il cavallo alato. Non c’è nulla che desti il mio interesse, sono un vagabondo nel mio cuore. Nella nebbia assolata delle languide ore, quale visione grandiosa prende forma nell’azzurro del cielo! O Meta Lontanissima, oh, l’acuto richiamo del tuo flauto! Dimentico, sempre dimentico, che tutti i cancelli sono chiusi nella casa dove vivo solitario! VI L’uccello prigioniero nella gabbia, l’uccello libero nella foresta: quando venne il tempo s’incontrarono, questo era il decreto del destino. L’uccello libero grida al compagno: Amore mio, voliamo nel bosco!» L’uccello prigioniero gli sussurra: «Vieni, viviamo entrambi nella gabbia». Dice l’uccello libero: «Tra sbarre, dove c’è spazio per stendere l’ali?» «Ahimé», grida l’uccello nella gabbia, «Non so dove appollaiarmi nel cielo». L’uccello libero grida: «Amore mio, canta le canzoni delle foreste». L’uccello in gabbia dice: «Siedi al mio fianco, t’insegnerò il linguaggio dei sapienti». L’uccello libero grida: « No, oh no! I canti non si possono insegnare». L’uccello nella gabbia dice: « Ahimé, non conosco i canti delle foreste». Il loro amore è intenso e struggente, ma non possono mai volare assieme. Attraverso le sbarre della gabbia si guardano e si guardano, ma è vano il loro desiderio di conoscersi. Scuotono ansiosamente le ali e cantano: «Vieni vicino a me, amore mio!». L’uccello libero grida: «È impossibile, temo le porte chiuse della gabbia». L’uccello in gabbia sussurra: «Ahimé, le mie ali sono morte e impotenti». VII Mamma, il giovane Principe passerà davanti alla nostra porta; come posso badare al lavoro stamane? Mostrami come devo acconciarmi i capelli, dimmi quali vesti devo indossare. Mamma, perché mi guardi sgomenta? Lo so che non alzerà gli occhi alla mia finestra; so bene che sparirà in un baleno dalla mia vista; solo la svanente melodia del flauto mi giungerà singhiozzando da lontano. Ma il giovane Principe passerà davanti alla nostra porta, e per l’occasione voglio indossare i miei vestiti più belli. Mamma, il giovane Principe passò davanti alla nostra porta, e il sole del mattino splendeva dal suo cocchio. Mi tolsi il velo dal viso, strappai la collana di rubini dal mio collo e la gettai sul suo cammino. Mamma, perché mi guardi sgomenta? Lo so che non raccolse la collana; so che venne schiacciata dalle ruote lasciando una macchia rossa sulla polvere, e nessuno sa quale fu il mio dono né a chi era destinato. Ma il giovane Principe è passato davanti alla nostra porta, e io gettai davanti al suo cammino il gioiello che portavo sul petto. VIII Quando la lampada accanto al mio letto si spense, mi destai con gli uccelli mattinieri. Sedetti alla finestra aperta, con un fresco serto di fiori tra i capelli sciolti. Il giovane viandante venne per la strada nella nebbia rosata del mattino. Al collo aveva una collana di perle, sulla sua corona cadevano i raggi del sole. Si fermò davanti alla mia porta e mi chiese con voce impaziente: «Dove è lei?» Non seppi dire, per la gran vergogna, «Lei sono io, giovane viandante, sono io». Era all’imbrunire e la lampada non era ancora accesa. Svogliatamente m’intrecciavo i capelli. Il giovane giunse sul suo cocchio nel bagliore del sole al tramonto. La sua veste era coperta di polvere, i cavalli avevano la schiuma. Egli discese alla mia porta, e chiese con voce stanca: «Dove è lei?» Non potei dire, per la gran vergogna, «Lei sono io, stanco viaggiatore, sono io». È una notte d’aprile. La lampada arde nella mia stanza. La brezza del sud spira gentilmente. Il pappagallo ciarliero dorme nella sua gabbia. Il mio corsetto ha il colore del collo del pavone e il mio mantello è verde come l’erba novella. Siedo per terra alla finestra e guardo la strada deserta. Nell’oscurità della notte continuo a mormorare: «Lei sono io, disperato viandante, sono io». IX Quando a notte vado sola al mio convegno d’amore, gli uccelli non cantano, il vento non soffia, le case ai lati della strada sono silenziose. Sono i miei bracciali che risuonano a ogni passo, e io sono piena di vergogna. Quando siedo al balcone e ascolto per sentire i suoi passi, le foglie non stormiscono sui rami, e l’acqua del fiume è immobile come la spada sulle ginocchia d’una sentinella addormentata. È il mio cuore che batte selvaggiamente e non so come acquietarlo. Quando il mio amore viene e si siede al mio fianco, quando il mio corpo trema e le palpebre s’abbassano, la notte s’oscura, il vento spegne la lampada, e le nuvole stendono veli sopra le stelle. È il gioiello al mio petto che brilla e risplende. E non so come nasconderlo. X Lascia stare il tuo lavoro, sposa. Ascolta, l’ospite è venuto. Senti? scuote gentilmente la catena che chiude la porta. Bada che i tuoi bracciali non facciano troppo rumore, e che i tuoi passi non gli corrano incontro. Lascia stare il tuo lavoro, sposa. Ascolta, l’ospite è venuto. Non avere paura, sposa, no, non è il vento spettrale. È la luna piena in una notte d’aprile; nel cortile l’ombre sono pallide; in alto il cielo è luminoso. Tirati il velo sul viso, se credi, metti la lampada alla porta, se hai paura. No, non aver timore, sposa, non è il vento spettrale. Se hai vergogna, non dirgli parola; rimani a un lato della porta quando gli vai incontro. Se ti chiede qualcosa, e se vuoi, abbassa gli occhi in silenzio. Non far tintinnare i bracciali quando, con la lampada in mano, lo farai entrare. Se hai vergogna, non dirgli parola. Non hai ancora finito il tuo lavoro? Ascolta, l’ospite è arrivato. Non hai acceso la lampada nella stalla? Non hai preparato il cesto delle offerte per le preghiere della sera? Non hai posto il rosso segno di fortuna alla scriminatura dei capelli, e ti sei abbigliata per la notte? O sposa, non senti? l’ospite è arrivato. Lascia stare il tuo lavoro! XI Vieni come sei, non indugiare a farti bella. Se la treccia s’è sciolta dei capelli, se la scriminatura non è dritta, se i nastri del corsetto non sono allacciati, non badarci. Vieni come sei, non indugiare a farti bella. Vieni sull’erba con passi veloci. Se il rossetto si disfà per la rugiada, se gli anelli che tintinnano ai tuoi piedi si allentano, se le perle della tua collana cadono, non badarci. Vieni sull’erba con passi veloci. Non vedi le nubi che coprono il cielo? Stormi di gru si levano in volo dall’altra riva del fiume e improvvise raffiche di vento passano veloci sulla brughiera. Le greggi spaurite corrono agli ovili. Non vedi le nubi che coprono il cielo? Invano accendi la lampada della tua toilet la fiamma vacilla e si spegne nel vento. Chi può accorgersi che le tue palpebre non sono state tinte d’ombretto? I tuoi occhi sono più neri delle nubi. Invano accendi la lampada della tua toilet. Vieni come sei, non indugiare a farti bella. Se la ghirlanda non è stata intrecciata, che importa; se il braccialetto non è chiuso, lascia fare. Il cielo è coperto di nuvole - è tardi. Vieni come sei; non indugiare a farti bella. XII Se vuoi riempire la tua brocca, vieni, oh vieni al mio lago. L’acqua si stringerà intorno ai tuoi piedi e ti sussurrerà il suo segreto. Sulla sabbia è l’ombra della pioggia imminente, le nuvole pendono basse sopra il profilo azzurro degli alberi, come i folti capelli sopra i tuoi occhi. Ben conosco il ritmo dei tuoi passi, essi battono nel mio cuore. Vieni, oh vieni al mio lago, se devi riempire la tua brocca. Se vuoi startene oziosa e sedere indolente e lasciare che la tua brocca galleggi sull’acqua, vieni, oh vieni al mio lago. Il declivio erboso è verdeggiante e i fiori di campo sono innumerevoli. Dagli occhi bruni i tuoi pensieri vagheranno come uccelli fuori dai nidi. Il tuo velo cadrà ai tuoi piedi. Vieni, oh vieni al mio lago, se vuoi sedere indolente. Se vuoi lasciare il tuo gioco e tuffarti nell’acqua, vieni, oh vieni al mio lago. Lascia il tuo mantello azzurro sulla riva; l’acqua azzurra ti coprirà nascondendoti. Le onde si leveranno in punta di piedi per baciarti il collo e mormorare ai tuoi orecchi. Vieni, oh vieni al mio lago, se vorresti tuffarti nell’acqua. Se vuoi essere folle e cercare la morte nell’acqua, vieni, oh vieni al mio lago. Esso è freddo e molto profondo. È scuro come un sonno senza sogni. Nei suoi abissi notti e giorni sono eguali, e i canti sono silenzio. Vieni, oh vieni al mio lago, se vuoi tuffarti in braccio alla morte. XIII Non chiesi nulla, soltanto mi fermai sul limitare del bosco, nascosto dietro un albero. Gli occhi dell’alba erano ancora languidi e nell’aria c’era ancora la rugiada. Il pigro profumo dell’erba bagnata aleggiava nella nebbia sottile sulla terra. Sotto un banano mungevi la vacca con le tue mani tenere e fresche come il burro. Io me ne stavo immobile a guardarti. Non dissi una sola parola. Era l’uccello che cantava, non visto, dal cespuglio. Il mango lasciava cadere i suoi fiori sulla strada del villaggio, e le api venivano ronzando a una a una. Sul bordo dello stagno, il cancello del tempio di Shiva era aperto e il fedele aveva iniziato i suoi canti. Con il secchio sul grembo, mungevi la vacca. Io rimasi con il mio barattolo vuoto. Non ti venni vicino. Il cielo si destò al suono del gong del tempio. Gli zoccoli delle bestie condotte al pascolo sollevavano la polvere nella strada. Con le anfore gorgoglianti posate sull’anca, alcune donne vennero dal fiume. I tuoi braccialetti tintinnavano, e la schiuma traboccava dal secchio. Il mattino passò, e non ti venni vicino. XIV Camminavo lungo la strada, non so perché. Mezzogiorno era passato e i bambù stormivano al vento. Le ombre prone con le braccia stese s’allacciavano ai piedi della luce fuggente. I koels erano stanchi dei lor canti. Camminavo lungo la strada, non so perché. La capanna sulla riva del fiume è ombreggiata da un albero spiovente. Qualcuna era intenta al suo lavoro, e udivo la musica dei suoi braccialetti. Mi fermai vicino a quella capanna, non so perché. La stretta strada serpeggiante costeggia molti campi di senape e molte foreste di manghi. Passa presso il tempio del villaggio e il mercato sull’approdo del fiume. Mi fermai vicino a quella capanna, non so perché. Era un giorno ventoso di marzo, molti anni fa, quando il mormorio era languido della primavera, e i fiori di mango cadevano a uno a uno nella polvere. L’acqua increspata lambiva la brocca di bronzo sul gradino dell’approdo. Penso a quel giorno ventoso di marzo, non so perché. Le ombre s’infondano, le greggi fanno ritorno ai loro ovili. La luce è grigia sui campi solitari, e i contadini aspettano il traghetto. Lentamente ritorno sui miei passi, non so perché. XV Corro come un cervo muschiato che pazzo del suo stesso profumo corre nell’ombra della foresta. La notte è notte di maggio, la brezza è brezza del sud. Smarrisco la strada e cammino, cerco ciò che non posso ottenere e ottengo quello che non cerco. Dal mio cuore esce e danza l’immagine del mio desiderio. La fulgida visione fugge via. Cerco di afferrarla saldamente, ma essa mi elude e mi svia. Cerco ciò che non posso ottenere e ottengo quello che non cerco. XVI Le mani si stringono alle mani e gli occhi indugiano sugli occhi: così comincia la storia dei nostri cuori. È la notte della luna di marzo; nell’aria un dolce profumo di henna; il mio flauto giace per terra e la tua ghirlanda di fiori non è terminata. Questo amore fra me e te è semplice come una canzone. Il tuo velo color zafferano inebria i miei occhi, la corona di gelsomini che tu intrecci mi commuove come una lode. È un gioco di dare e trattenere, di svelare e di nuovo velare; di sorrisi e di timidezze, e di dolci inutili lotte. Questo amore fra te e me è semplice come una canzone. Nessun mistero al di là del presente; nessuna lotta per l’impossibile; nessuna ombra dietro l’incanto; nessuna ricerca nel buio. Questo amore fra te e me è semplice come una canzone. Non vaghiamo oltre le parole per cercare l’eterno silenzio; non leviamo le mani nel vuoto per cose al di là della speranza. Ciò che diamo e otteniamo ci basta. La gioia non abbiamo schiacciata per spremerne il vino del dolore. Questo amore fra te e me è semplice come una canzone. XVII L’uccello giallo canta sul loro albero e fa danzare di gioia il mio cuore. Viviamo entrambi nello stesso villaggio e questo ci rende felici. La sua coppia d’agnelli favoriti viene a pascolare sotto l’ombra degli alberi del nostro giardino. Se si sperdono nel nostro campo d’orzo, li prendo tra le mie braccia. Il nostro villaggio ha nome Khanjana e Anjana si chiama il nostro fiume. Tutto il villaggio conosce il mio nome e lei si chiama Ranjana. Che ci separa c’è soltanto un campo. Le api che hanno fatto il loro alveare nel nostro bosco volano a cercare miele tra i fiori dei loro cespugli. I fiori lanciati dal loro approdo scendono galleggiando sul ruscello fino al luogo dove noi ci bagnamo. Canestri di fiori secchi di kusm vengon dai lor campi al nostro mercato. Il nostro villaggio ha nome Khanjana e Anjana si chiama il nostro fiume. Tutto il villaggio conosce il mio nome e lei si chiama Ranjana. Il sentiero che va alla loro casa a primavera è fragrante di fiori di mango. Quando il loro lino è maturo pel raccolto, nel nostro campo la canapa è in fiore. Le stelle che sorridono sulla loro casetta ci mandano lo stesso sguardo ammiccante. La pioggia che riempie la loro cisterna rallegra la nostra foresta di kadam. Il nostro villaggio ha nome Khanjana e Anjana si chiama il nostro fiume. Tutto il villaggio conosce il mio nome e lei si chiama Ranjana. XVIII Quando le due sorelle vanno ad attingere acqua vengono da questa parte e sorridono. Devono sapere che c’è qualcuno dietro agli alberi tutte le volte che vanno ad attingere acqua. Quando passano da questa parte le due sorelle bisbigliano tra loro. Devono aver indovinato il segreto di colui che spia dietro gli alberi tutte le volte che vanno ad attingere acqua. Quando giungono da questa parte le loro anfore oscillano e l’acqua si versa. Devono aver scoperto che il cuore batte a qualcuno che spia dietro gli alberi tutte le volte che vanno ad attingere acqua. Quando vengono da questa parte le due sorelle si guardano e sorridono. C’è come un riso nei loro passi rapidi che confonde la mente di qualcuno dietro gli alberi tutte le volte che vanno ad attingere acqua. XIX Camminavi sulla riva del fiume con l’anfora colma posata sull’anca. Perché girasti a un tratto la testa e mi sbirciasti tra il velo fluttuante? Quello sguardo splendente dal buio giunse su di me come una brezza che manda un fremito per l’acqua increspata e corre via all’ombrosa sponda. Giunse a me come l’uccello della sera che attraversa la stanza senza lampada volando in fretta da un balcone all’altro e poi scompare nella notte buia. Dietro al velo, nell’ombra sei nascosta, come una stella dietro le colline, e io sono un passante sulla strada. Ma perché ti fermasti un momento e mi guardasti attraverso il tuo velo, mentre camminavi sulla riva del fiume con l’anfora colma posata sull’anca? XX Giorno per giorno viene e va via. Va’ e dagli un fiore dai miei capelli. Se ti chiede chi è che lo manda, ti supplico: non dirgli il mio nome perché egli solo viene e va via. Sotto l’albero siede per terra. Fagli un sedile di fiori e foglie. I suoi occhi sono tristi e portano nel mio cuore la malinconia. Non svela mai i suoi pensieri; egli soltanto viene e va via. XXI Perché ha scelto di venire alla mia porta, sul far del giorno, il giovane errabondo? Uscendo ed entrando gli passo accanto, e i miei occhi son presi dal suo viso. Non so se devo parlargli o tacere. Perché ha scelto di venire alla mia porta? Le notti nuvolose in luglio sono oscure; il cielo in autunno è d’un pallido azzurro; i giorni chiari della primavera sono agitati dal vento del sud. Egli tesse le sue canzoni ogni volta con nuove melodie. Mi distolgo dal mio lavoro e i miei occhi sono pieni di nebbia. Perché ha scelto di venire alla mia porta? XXII Quando mi passò accanto con passi veloci, l’orlo della sua gonna mi sfiorò. Dall’ignota isola d’un cuore venne improvviso un caldo alito di primavera. Il tremito d’un tocco fugace mi sfiorò e svanì in un momento, come petalo d’un fiore reciso trasportato sull’ali della brezza. Si posò sul mio cuore come un sospiro del suo corpo e un sussurro del cuore. XXIII Perché te ne stai seduta là facendo tintinnare i braccialetti così, soltanto per gioco? Riempi la tua brocca. È ora che tu venga a casa. Perché muovi l’acqua con le mani e ogni tanto guardi la strada per vedere se viene qualcuno così, soltanto per gioco? Riempi la brocca e vieni a casa. Le ore del mattino passano l’acqua scorre scura. Le onde ridono e bisbigliano tra loro così, soltanto per gioco. Le nubi vaganti si sono raccolte sull’orlo del cielo sopra una lontana altura. Indugiano, ti guardano in viso, sorridono, così, soltanto per gioco. Riempi la tua brocca e vieni a casa. XXIV Non celare il segreto del tuo cuore, amico mio. Dillo a me, solo a me, in segreto. Tu che sorridi tanto gentilmente, sussurralo sommessamente, il mio cuore l’udrà, non le mie orecchie. La notte è fonda, la casa è silenziosa, i nidi degli uccelli son coperti di sonno. Dimmi tra lacrime esitanti, tra sorrisi titubanti, tra dolore e dolce vergogna, il segreto del tuo cuore! XXV «Vieni, giovane, dicci sinceramente, perché c’è follia nei tuoi occhi?» «Non so quale vino di papavero selvatico ho bevuto, e ora c’è questa follia nei miei occhi». «Vergogna!» «Bene, alcuni sono saggi e altri sono sciocchi, alcuni stanno attenti e altri sono sbadati. Vi sono occhi che ridono e vi sono occhi che piangono e la follia è nei miei occhi». «Giovane, perché te ne stai immobile sotto l’ombra d’un albero?» «I miei piedi sono stanchi pel peso del mio cuore, e me ne sto immobile nell’ombra». «Vergogna!» «Bene, alcuni marciano per la loro strada, altri indugiano e si fermano; alcuni sono liberi e altri sono incatenati e i miei piedi sono stanchi pel peso del mio cuore». XXVI «Prendo quello che viene dalle tue mani generose. Altro non chiedo». «Sì, sì, ti conosco, modesto mendicante; tu chiedi tutto quello che si ha». «Se c’è un fiore smarrito, lo porterò nel mio cuore». «Ma se ci fossero spine?» «Le sopporterò». «Sì, sì, ti conosco, modesto mendicante; tu chiedi tutto quello che si ha». «Se una volta sola tu levassi sul mio viso i tuoi occhi amorevoli, renderesti dolce la mia vita, dolce al di là della morte». «Ma se invece ci fossero soltanto sguardi crudeli?» «Li terrei a trafiggermi il cuore». «Sì, sì, ti conosco, modesto mendicante; tu chiedi tutto quello che si ha». XXVII «Confida nell’amore anche se fa soffrire. Non chiudere il tuo cuore». «Oh, no, amico mio, le tue parole sono oscure, io non posso comprenderle». «Il cuore, amore mio, esiste solo per donarlo con una lacrima e una canzone». «Oh, no, amico mio, le tue parole sono oscure, io non posso comprenderle». «Il piacere è fragile come una goccia di rugiada: mentre ride, muore. Ma il dolore è forte e durevole. Lascia che un triste amore si desti nei tuoi occhi». «Oh, no, amico mio, le tue parole sono oscure, io non posso comprenderle». «Il loto fiorisce al sole, e perde tutto quello che ha. Non vorrebbe rimanere in fiore nella nebbia eterna dell’inverno». «Oh, no, amico mio, le tue parole sono oscure, io non posso comprenderle». XXVIII I tuoi occhi m’interrogano tristi. Vorrebbero sapere i miei pensieri come la luna che scandaglia il mare. Dal principio alla fine ho denudato la mia vita davanti ai tuoi occhi, senza nulla celarti o trattenere. Ed è per questo che non mi conosci. Se fosse soltanto una gemma, la romperei in cento pezzi e con essi farei una catena da mettere attorno al tuo collo. Se fosse soltanto un fiore, rotondo e piccolo e dolce, lo coglierei dallo stelo per metterlo nei tuoi capelli. Ma è il mio cuore, mia diletta. Dove sono le sue spiagge e il suo fondo? Di questo regno tu ignori i confini e tuttavia sei la sua regina. Se fosse solo un momento di gioia fiorirebbe in un facile sorriso, lo potresti capire in un momento. Se fosse soltanto un dolore si scioglierebbe in limpide lacrime, rivelando il suo più intimo segreto senza dire una sola parola. Ma è il mio cuore, amore mio. Le sue gioie e i suoi dolori sono sconfinati, e infiniti i suoi desideri e le sue ricchezze. Ti è vicino come la tua stessa vita, ma non puoi conoscerlo interamente. XXIX Parlami, amor mio! dimmi a parole quel che cantasti. La notte è buia. Le stelle son nascoste tra le nubi. Il vento soffia e fischia tra le foglie. Scioglierò i miei capelli, il mio mantello turchino mi circonderà come la notte. Stringerò la tua testa sul mio petto; e là nella dolce solitudine sospirerò sopra il tuo cuore. Socchiuderò i miei occhi e ascolterò. Quando le tue parole cesseranno, siederemo immobili in silenzio. Solo gli alberi bisbiglieranno nel buio. La notte impallidirà. Spunterà l’alba. Noi ci guarderemo negli occhi per un’ultima volta. E poi ciascuno andrà per la sua strada. Parlami, amore mio! Dimmi a parole quel che cantasti. XXX Tu sei la nube della sera che vaghi nel cielo dei miei sogni. Io ti dipingo e ti modello con i miei desideri d’amore. Tu sei mia, soltanto mia, abitatrice dei miei sogni infiniti! I tuoi piedi son rosso-rosati per la fiamma del mio desiderio, spigolatrice dei miei canti del tramonto! Del sapore del mio vino di dolore le tue labbra sono dolci-amare. Tu sei mia, soltanto mia, abitatrice dei miei sogni solitari! Con l’ombra della mia passione ho oscurato i tuoi occhi, frequentatrice degli abissi del mio sguardo! T’ho presa e ti stringo, amore mio, nella rete della mia musica. Tu sei mia, soltanto mia, abitatrice dei miei sogni immortali! XXXI Il mio cuore, uccello del deserto, ha trovato il suo cielo nei tuoi occhi. Essi sono la culla del mattino, essi sono il regno delle stelle. Nei loro abissi il mio canto si perde. Lascia solo ch’io mi libri in quel cielo, nella sua solitaria immensità. Lascia solo ch’io fenda le sue nubi, e stenda le mie ali nel suo sole. XXXII Dimmi se questo è vero, amore mio, dimmi se questo è tutto vero. Quando questi occhi scagliano i lor lampi le oscure nubi nel tuo petto danno risposte tempestose. È vero che le mie labbra son dolci come il boccio del primo amore? Che le memorie di mesi svaniti di maggio indugiano nelle mie membra? Che la terra, come un’arpa, vibra di canzoni al tocco dei miei piedi? È poi vero che gocce di rugiada cadono dagli occhi della notte al mio apparire e la luce del giorno è felice quando avvolge il mio corpo? È vero, è vero che il tuo amore viaggiò per ere e mondi in cerca di me? Che quando finalmente mi trovasti il tuo secolare desiderio trovò una pace perfetta nel mio gentile parlare nei miei occhi e nelle mie labbra e nei miei capelli fluenti? E dimmi infine se è proprio vero che il mistero dell’infinito è scritto sulla mia piccola fronte. Dimmi, amor mio, se tutto questo è vero. XXXIII Io ti amo, amor mio, perdona il mio amore. Son presa come un uccello che smarrisce la via. Quando il mio cuore fu scosso perse il suo velo e rimase nudo. Coprilo con la pietà, amore mio, e perdona il mio amore. Se non puoi amarmi, amor mio, perdona il mio dolore. Non guardarmi sdegnoso da lontano. Tornerò al mio cantuccio e siederò al buio. Con entrambe le mani coprirò la mia nuda vergogna. Volgi il tuo sguardo, amor mio, perdona il mio dolore. Se mi ami, amor mio, perdona la mia gioia. Quando il mio cuore è trascinato via dal vortice della felicità non sorridere del mio abbandono. Quando siedo sul mio trono e ti tiranneggio col mio amore, quando come una dea ti concedo il mio favore, sopporta il mio orgoglio, amor mio, e perdona la mia felicità. XXXIV Non andartene, amore, senza avvertirmi. Ho vegliato tutta la notte, e ora i miei occhi sono pesanti di sonno. Ho paura di perderti mentre dormo. Non andartene, amore, senza avvertirmi. Mi sveglio e stendo la mano per toccarti. Ti sento e mi domando: «È forse un sogno?» Oh, se potessi stringere i tuoi piedi con il mio cuore e tenerli stretti al mio petto! Non andartene, amore, senza avvertirmi. XXXV Per paura che troppo facilmente ti conosca, tu giochi con me. Per nascondere le tue lacrime, mi acciechi con scoppi di riso. Conosco, conosco la tua arte. Non dici mai le parole che vorresti. Per paura che io non ti apprezzi mi eludi in mille modi. Per paura che ti confonda con la folla, ti metti in disparte. Conosco, conosco la tua arte. Non cammini mai per la strada che vorresti. Tu chiedi più di tutti gli altri, per questo sei silenziosa. Poi con scherzosa indifferenza rifiuti tutti i miei doni. Conosco, conosco la tua arte. Tu non accetti mai ciò che vorresti. XXXVI Sussurrò: «Amore, alza i tuoi occhi». Lo rimproverai aspramente e dissi: «Va’ via!» Ma lui non si mosse. Stette davanti a me e mi tenne le mani. Gli dissi: «Lasciami!» Ma lui non se ne andò. Accostò il suo volto al mio orecchio. Lo guardai e gli dissi: «Vergogna!» Ma lui non si mosse. Mi sfiorò la guancia con le labbra. Tremando gli dissi: «Come osi?» Ma lui non ebbe vergogna. Mi mise un fiore nei capelli. Gli dissi: «È inutile!» Ma lui non si commosse. Prese la ghirlanda dal mio collo e senza parlare se ne andò. Ora piango e chiedo al mio cuore: «Perché non ritorna?» XXXVII Bella, vuoi mettere la tua ghirlanda di fiori freschi intorno al mio collo? Sappi però che la mia ghirlanda l’ho intrecciata per molte, per coloro che si vedono in visioni fugaci, o abitano in paesi inesplorati, o vivono nei canti dei poeti. È troppo tardi per domandare il mio cuore in cambio del tuo. Ci fu un tempo incui la mia vita era come un bocciuolo e il suo profumo era tutto racchiuso nel suo cuore. Ora è profuso da ogni parte. Chi conosce l’incantesimo per raccoglierlo e chiuderlo di nuovo? A molte ho donato il mio cuore: ormai non posso darlo a una soltanto. XXXVIII Amor mio, una volta il tuo poeta varò un grande poema epico nella sua mente. Ahimé, non fui prudente e andò a cozzare contro i bracciali che tintinnano ai tuoi piedi e fece naufragio. Si ruppe in frammenti di canti, che si sparpagliarono ai tuoi piedi. Tutto il mio bastimento carico di storie d’antiche guerre fu preda dell’onde ridenti, si riempì di lacrime e affondò. Amore mio, di questa perdita mi devi compensare. Se le mie pretese alla fama immortale dopo la morte sono andate in frantumi, da vivo rendimi immortale e non rimpiangerò la mia perdita, né ti rimprovererò. XXXIX Tutta la mattina tento d’intrecciare una ghirlanda, ma i fiori mi sfuggono di tra le dita e cadono per terra. Tu siedi là, osservandomi in segreto con l’angolo dei tuoi occhi curiosi. Chi fu il colpevole chiedilo a quegli occhi che tramano malizie nell’oscurità. Invano tento di cantare una canzone. Un nascosto sorriso ti trema sulle labbra; del mio insuccesso chiedi a lui la ragione. Domanda alle tue labbra sorridenti come la mia voce si perse nel silenzio, come un’ape ebbra in un fiore di loto. È sera, ed è tempo che i fiori chiudano le loro corolle. Lascia che mi sieda al tuo fianco e comanda alle mie labbra di fare ciò che si può fare in silenzio nella debole luce delle stelle. XL Un incredulo sorriso aleggia sui tuoi occhi quando vengo da te per prendere commiato. L’ho fatto tante volte che tu pensi che ben presto a te farò ritorno. E a dire il vero, ho anch’io lo stesso dubbio. Perché i giorni della primavera ogni anno fanno ritorno; la luna piena s’accomiata e torna a visitarci nuovamente; ogni anno i fiori ritornano e arrossiscono sui rami, ed è probabile che io mi allontani solo per ritornare da te. Ma serba l’illusione per un poco, non affrettarti a scacciarla. Quando dico che ti lascio per sempre, accettalo come se fosse vero, e lascia che un velo di lacrime oscuri per un momento il cerchio scuro dei tuoi occhi. Poi sorridi maliziosamente quanto vuoi quando torno da te. XLI Vorrei dirti le parole più profonde, ma non oso per timore che tu rida. Ecco perché rido di me stesso e volgo in scherzo il mio segreto. Prendo alla leggera il mio dolore per paura che tu faccia lo stesso. Vorrei dirti le parole più sincere, ma ho paura che tu non mi creda. Ecco perché le nascondo e ti dico il contrario di quello che penso. Faccio sembrare assurdo il mio dolore per paura che tu faccia lo stesso. Vorrei usare le parole più preziose che ho in serbo per te, ma non oso per paura che tu le disprezzi. Ecco perché ti parlo con durezza. Ti ferisco, per paura che tu non conosca mai nessun dolore. Vorrei sedere silenzioso al tuo fianco, ma temo che il cuore mi salga alle labbra. Ecco perché continuo a chiacchierare e mi nascondo dietro le parole. Tratto crudelmente il mio dolore per paura che tu faccia lo stesso. Vorrei allontanarmi da te, ma non oso per paura che la mia codardia sia svelata. Ecco perché tengo alta la mia testa e mi presento a te con aria indifferente. Le continue stoccate dei tuoi occhi tengono sempre vivo il mio dolore. XLII O pazzo, splendidamente ebbro! Se apri a calci le tue porte e fai il buffone in pubblico; se vuoti la tua borsa in una notte e te ne ridi della prudenza; se cammini per vie stravaganti e giochi con cose inutili; non curarti della rima e del senso; se spiegando le vele alla tempesta spezzi in due il tuo timone; allora ti seguirò, compagno, mi ubriacherò e andrò in malora. Ho sprecato i miei giorni e le mie notti in compagnia di valentuomini e sapienti. La scienza ha incanutito i miei capelli, il vegliare ha indebolito la mia vista. Per anni ho raccolto e accumulato pezzetti e frammenti d’oggetti: calpestali e danzaci sopra e disperdili ai quattro venti. Perché so che è massima saggezza ubriacarsi e andare in malora. Che svaniscano gli scrupoli contorti, e smarrisca la mia via senza speranza. Che una ventata di vertigine selvaggia mi strappi via dagli ormeggi. Il mondo è pieno di uomini valenti, laboriosi, utili e sapienti. Vi sono uomini che facilmente primeggiano e altri che li seguono decentemente. Che siano felici e che prosperino, e lasciatemi essere futile e demente. Perché so che la fine di ogni lavoro è ubriacarsi e andare in malora. Giuro di rinunciare da questo momento a far parte delle persone dabbene. Abbandonerò l’orgoglio del sapere e la conoscenza del male e del bene. Manderò in frantumi il vaso dei ricordi, versando l’ultima lacrima. Con la spuma del vino rosso come bacca bagnerò e rischiarerò la mia risata. Per l’occasione farò in cento pezzi il distintivo del civile e del posato. Faccio il sacro voto di essere indegno, di ubriacarmi e di andare in malora. XLIII No, amici, non sarò mai un asceta, qualunque cosa voi diciate. Non diventerò mai un asceta se lei non prende i voti con me. È mio fermo proposito che, se non troverò un riparo ombroso e una compagna della mia penitenza, non diventerò mai un asceta. No, amici, giammai lascerò il mio focolare e la mia casa, né mi ritirerò nella solitudine della foresta, se non suoneranno allegre risate nella sua ombra echeggiante e se l’orlo d’un mantello zafferano non fluttuerà nel vento, se teneri sospiri non faranno ancor più fondo il suo silenzio. Non sarò mai un asceta. XLIV Reverendo signore, perdona questa coppia di peccatori. Oggi i venti della primavera soffiano in vortici selvaggi portando via le foglie morte e con esse le tue lezioni sono tutte perdute. Non dire, padre, che la vita è vanità. Ché per il momento abbiamo fatto un patto con la morte, e per poche ore fragranti siamo stati resi immortali. Anche se l’esercito del re venisse e ci piombasse addosso con la violenza, scuoteremmo tristemente la testa dicendo: «Fratelli; ci state disturbando. Se proprio volete continuare questo gioco chiassoso, andate altrove a far risuonare le vostre armi: solo per pochi attimi fuggenti siamo stati resi immortali». Se persone amiche venissero affollandosi intorno a noi, ci inchineremmo umilmente dicendo: «È per noi un imbarazzo questa eccessiva fortuna. C’è poco spazio nell’infinito cielo dove abitiamo. Perché a primavera i fiori vengono in ressa, le ali delle api operose s’urtano tra di loro. Il piccolo paradiso ove abitiamo soltanto noi due immortali è troppo, assurdamente ristretto». XLV Agli ospiti che devono partire augura buona fortuna, e poi cancella le orme dei loro passi. Stringi al petto con un sorriso ciò che è facile, semplice e vicino. Oggi è la festa dei fantasmi che non sanno quando moriranno. La tua risata sia soltanto una insensata allegria come scintille di luce sulle onde. La tua vita danzi lievemente sul limitare del Tempo come la rugiada sulla punta d’una foglia. Sulle corde della tua arpa suona fuggenti melodie. XLVI Mi lasciasti e seguisti la tua via. Pensai che t’avrei pianta, e conservata la tua immagine solitaria nel mio cuore, scolpita in una canzone dorata. Ma, ahimé, il tempo è breve. Anno per anno gioventù sfiorisce; i giorni di primavera sono fuggitivi; i fragili fiori muoiono per nulla, e il saggio m’avverte che la vita non è che una goccia di rugiada sopra una foglia di loto. Dovrei trascurare tutto questo per una che mi ha abbandonato? Sarebbe sciocco e infantile, perché il tempo è breve. Venite, allora, mie notti piovose, con rapidi piccoli passi; sorridi, mio autunno dorato; vieni, aprile spensierato, spargendo intorno i tuoi baci! Tu vieni, e tu, e anche tu? Amori miei, sapete che siamo mortali. È saggio spezzarsi il cuore per una che il suo m’ha sottratto? Perché il tempo è breve. È dolce sedere in un canto e meditare e scrivere in versi che tu sei tutto il mio mondo. È eroico attaccarsi al proprio dolore rifiutando di lasciarsi consolare. Ma un visetto fresco spia dalla porta e fissa i suoi occhi nei miei. Non posso che asciugarmi le lacrime e cambiare il tono del mio canto. Perché il tempo è breve. XLVII Se vuoi così, smetterò di cantare. Se fa sussultare il tuo cuore, distoglierò i miei occhi dal tuo volto. Se ti fa trasalire all’improvviso mentre passeggi, mi trarrò in disparte e prenderò un’altra strada. Se ti confonde mentre intrecci i fiori, eviterò il tuo giardino solitario. Se troppo agita l’acqua, non vogherò vicino alla tua spiaggia. XLVIII Liberami dai lacci della tua dolcezza, amore mio! Non più questo vino di baci. Questa greve nebbia d’incenso fa soffocare il mio cuore. Apri le porte, fa entrare la luce del mattino. Sono perduto in te, prigioniero delle tue carezze. Liberami dai tuoi incantesimi, ridonami la forza d’offrirti il mio cuore liberato. XLIX Afferro le sue mani e la stringo al mio petto. Tento di riempire le mie braccia della sua bellezza, di depredare con i baci il suo dolce sorriso, di bere i suoi bruni sguardi con i miei occhi. Ma dov’è? Chi può spremere l’azzurro dal cielo? Cerco di afferrare la bellezza; essa mi elude lasciando soltanto il corpo nelle mie mani. Stanco e frustrato mi ritraggo. Come può il corpo toccare il fiore che soltanto lo spirito riesce a sfiorare? L Amore, giorno e notte il mio cuore si strugge d’incontrarsi con te nell’incontro che è simile alla morte che tutto divora. Spazzami via come una tempesta; prendimi tutto quello che ho; spalanca il mio sonno e saccheggia i miei sogni. Derubami del mio mondo. In quella desolazione, nell’assoluta nudità dello spirito, uniamoci nella bellezza. Ahimé, che vano desiderio! Che speranza c’è d’essere uniti se non in te, mio Dio? LI Finisci allora quest’ultima canzone e separiamoci. Scorda questa notte ora che la notte è finita. Chi cerco di serrare tra le braccia? I sogni non si possono fare prigionieri. Con mani avide stringo al mio cuore il vuoto, ed esso mi ferisce il petto. LII Perché la lampada si spense? La coprii col mantello per ripararla dal vento, ecco perché la lampada si spense. Perché il fiore appassì? Con ansioso amore me lo strinsi al petto, ecco perché il fiore appassì. Perché il ruscello inaridì? Lo sbarrai con una diga per averlo solo per me, ecco perché il ruscello inaridì. Perché la corda dell’arpa si spezzò? Tentai di trarne una nota al di là delle sue possibilità, ecco perché la corda si spezzò. LIII Perché il tuo sguardo mi copre di vergogna? Non sono venuto come un mendicante. Soltanto per un’ora fuggente rimasi sul limitare del tuo cortile, fuori dalla siepe del giardino. Perché il tuo sguardo mi copre di vergogna? Non colsi nemmeno una rosa dal tuo giardino, nemmeno un frutto. Umilmente presi riparo sotto l’ombra al bordo della strada, dove ogni viandante può fermarsi. Non colsi nemmeno una rosa. Sì, i miei piedi erano stanchi, e la pioggia cadeva a dirotto. I venti urlavano tra i rami e le canne ondeggianti dei bambù. Le nubi correvano per il cielo come in fuga dopo una disfatta. I miei piedi erano stanchi. Non so che pensavi di me, né chi stavi aspettando alla tua porta. I lampi abbagliavano i tuoi occhi. Come immaginare che potevi vedermi nel buio dov’ero? Non so che pensavi di me. Il giorno è finito, e la pioggia è cessata per un momento. Lascio l’ombra dell’albero al limitare del tuo giardino questa panca sull’erba. S’è fatto buio; chiudi la tua porta; io riprendo il mio cammino. il giorno è finito. LIV Dove corri col tuo cesto a quest’ora della sera quando il mercato è finito? Tutti sono rincasati con i loro fardelli; la luna sta spiando di sopra gli alberi del villaggio. Gli echi delle voci che chiamano il traghetto, attraversano l’oscura acqua fino alla palude dove dormono le anatre selvatiche. Dove corri col tuo cesto quando il mercato è finito? Il sonno ha passato le sue dita sopra gli occhi della terra. I nidi delle cornacchie si sono fatti silenziosi, e tacciono le foglie dei bambù. I contadini rincasati dai campi stendono le stuoie nei cortili. Dove corri col tuo cesto quando il mercato è finito? LV Era mezzogiorno quando sei partito. Il sole era alto nel cielo. Avevo terminato il mio lavoro e sedevo sola al mio balcone, quando tu sei partito. A tratti, folate di vento venivano, portando il profumo di molti campi lontani. Le tortore tubavano nell’ombra, e un’ape entrò nella mia stanza mormorando novelle di molti campi lontani. Nella calura del meriggio il villaggio dormiva. La strada si stendeva deserta. A tratti sorgeva e moriva il fruscio delle foglie. Guardavo il cielo e tessevo nell’azzurro le lettere d’un nome che avevo conosciuto, mentre il villaggio dormiva nella calura del meriggio. Avevo scordato d’intrecciarmi i capelli. La languida brezza giocava con essi sul mio viso. Sotto la riva ombrosa il fiume scorreva tranquillo. Le pigre nuvole bianche erano immobili nel cielo. Avevo scordato d’intrecciarmi i capelli. Era mezzogiorno quando sei partito. La polvere della strada era infocata e i campi palpitavano. Le tortore tubavano tra il denso fogliame. Ero sola al mio balcone quando sei partito. LVI Ero una fra tante donne occupate nelle umili faccende domestiche. Perché mi scegliesti e mi portasti via dal fresco rifugio della vita comune? L’amore non espresso è sacro. Esso splende come gemme nel buio del cuore nascosto. Alla luce curiosa del giorno esso sembra pietosamente oscuro. Oh, tu forzasti le difese del mio cuore e trascinasti il mio tremante amore all’aperto, distruggendo per sempre l’angolo ombroso ove celava il suo nido. Le altre donne sono le stesse di sempre. Nessuno ha spiato nel più intimo del loro essere, ed esse stesse non conoscono il proprio segreto. Leggermente sorridono, e piangono, e chiacchierano, e lavorano. Ogni giorno si recano al tempio, accendono le loro lampade, e attingono l’acqua al fiume. Speravo che al mio amore fosse risparmiata la tremante vergogna di coloro che sono senza riparo, ma tu volgesti altrove il tuo viso. Sì, la tua strada è aperta innanzi a te, ma a me tagliasti la via del ritorno, e mi lasciasti nuda innanzi al mondo con i suoi occhi senza palpebre che mi fissano notte e giorno. LVII Colsi il tuo fiore, oh cielo! Lo strinsi al cuore e la spina mi punse. Quando il giorno svanì e si fece buio, scopersi che il fiore era appassito ma il dolore era rimasto. Altri fiori verranno a te, con profumo e con fasto, oh cielo! Ma per me è passato il tempo di cogliere fiori; nella notte buia non ho più la mia rosa, solo il dolore è rimasto. LVIII Un mattino una fanciulla cieca venne a offrirmi una ghirlanda di fiori avvolta in una foglia di loto. Me la misi intorno al collo, e mi vennero le lacrime agli occhi. La baciai e le dissi: «Sei cieca proprio come sono ciechi i fiori. Tu stessa non sai quanto è bello il tuo dono». LIX Donna, non sei soltanto l’opera di Dio ma anche degli uomini, che sempre ti fanno bella con i loro cuori. I poeti ti tessono una rete con fili di dorate fantasie; i pittori danno alla tua forma sempre nuova immortalità. Il mare dona le sue perle, le miniere il loro oro, i giardini d’estate i loro fiori per adornarti, per coprirti, per renderti sempre più preziosa. Il desiderio del cuore degli uomini ha steso la sua gloria sulla tua giovinezza. Per metà sei donna, e per metà sei sogno. LX O Bellezza, scolpita nella pietra, tra la furia e l’urlo della vita te ne stai immobile e muta, solitaria e appartata. Il grande Tempo siede innamorato i tuoi piedi, e sussurra: «Parla, parlami, amore; parla, mia sposa!». Ma le tue parole sono chiuse nella pietra, o immobile Bellezza! LXI Pace, cuor mio, che il tempo dell’addio sia dolce. Che non sia morte ma completamento. Che l’amore si sciolga nel ricordo, e il dolore in canzoni. Che il volo attraverso il cielo abbia fine nel piegarsi delle ali sopra il nido. Fermati un istante, O Bellissima Fine, e in silenzio dimmi le tue ultime parole. Mi inchino a te e sollevo la lampada per illuminarti lungo il tuo cammino. LXII Nel fosco sentiero d’un sogno andai a trovare l’amore che fu mio in una vita precedente. La sua casa era in fondo a una via desolata. Nella brezza della sera il suo pavone favorito sonnecchiava sul trespolo, e i colombi erano tranquilli in un angolo. Lei depose la sua lampada presso la porta rimase in piedi davanti a me. Levò i suoi grandi occhi sul mio viso e chiese mutamente: «Come stai, amico mio?». Tentai di rispondere, ma il nostro linguaggio era andato perduto e dimenticato. Pensavo e pensavo; i nostri nomi non mi venivano in mente. Lacrime brillarono nei suoi occhi. Mi tese la sua destra. La presi e rimasi in silenzio. La lampada oscillò nella brezza della sera, e si spense. LXIII Viandante, devi partire? La notte è calma, e sopra la foresta l’oscurità s’affievolisce. Le lampade brillano nel nostro balcone, i fiori sono ancora freschi, e gli occhi giovanili sono ancora desti. È giunto il tempo della tua partenza? Viandante, devi partire? Non abbiamo legato i tuoi piedi con le nostre braccia supplicanti. Le tue porte sono tutte aperte. Il tuo cavallo è sellato al cancello. Se abbiamo tentato di sbarrarti il passo fu solo con le nostre canzoni. Se mai ti abbiamo trattenuto, fu soltanto con i nostri occhi. Viandante, non possiamo trattenerti. Non abbiamo che le nostre lacrime. Quale inestinguibile fuoco brilla nei tuoi occhi? Quale febbre irrequieta scorre nel tuo sangue? Quale richiamo t’incalza dal buio? Quale terribile incantesimo hai letto fra le stelle del cielo, che, con un segreto messaggio, la notte entrò nel tuo cuore, strana e silenziosa? Se non ti curi di lieti convegni, se cerchi la pace, stanco cuore, spegneremo le nostre lampade, faremo tacere le nostre arpe. Siederemo silenziosi nel buio, fra lo stormire delle foglie, e la luna stanca verserà pallidi raggi sulla tua finestra. O viandante, quale spirito insonne ti ha toccato nel cuore della notte? LXIV Tutto il giorno passai nella polvere infuocata della strada. Ora, nel fresco della sera, busso alla porta della locanda. È deserta e in rovina. Un arcigno albero di ashath stende le sue affamate radici serpeggianti tra le fessure del muro. Sono passati i giorni quando i viandanti venivano qui a lavare i loro piedi stanchi. Stendevano le loro stuoie nel cortile, nella debole luce della prima luna, e sedevano a parlare di terre straniere. Al mattino, ristorati, si destavano al canto gioioso degli uccelli e i fiori, dal bordo della strada, li salutavano amichevolmente. Ma quando io giunsi non c’era nemmeno una lampada accesa ad attendermi. Nere macchie di fumo, lasciate da molte lampade dimenticate, come occhi ciechi mi fissavano dal muro. Lucciole volavano tra i cespugli presso lo stagno inaridito, e i rami dei bambù gettavano ombre sul sentiero invaso dalle erbe. Io sono l’ospite di nessuno, alla fine della mia giornata. La lunga notte m’attende, e sono stanco. LXV È ancora il tuo richiamo? La sera è scesa. La stanchezza mi circonda come le braccia d’un amore supplicante. Mi chiami? Ti ho dato tutto il mio giorno, crudele signora, vuoi togliermi anche la notte? Tutto deve avere una fine, e la solitudine del buio ci appartiene. Deve la tua voce interromperla e ferirmi? La sera non reca alla tua porta la musica del sonno? Le stelle dalle ali silenziose non volano mai al cielo sopra la tua torre spietata? I fiori non cadono mai con dolce morte nella polvere del tuo giardino? Devi proprio chiamarmi, anima irrequieta? Allora veglino e piangano invano i tristi occhi dell’amore. Arda la lampada nella casa solitaria. Porti a casa il traghetto gli stanchi lavoratori. Mi lascio alle spalle i miei sogni, e corro al tuo richiamo. LXVI Un pazzo vagabondo cercava la pietra filosofale; coi capelli arruffati, bruni, coperti di polvere, il corpo ridotto ad un’ombra, le labbra serrate come le porte chiuse del suo cuore, gli occhi ardenti come il lume della lucciola che cerca il suo compagno. Davanti a lui rumoreggiava l’oceano infinito. Le garrule onde parlavano incessanti di tesori nascosti, burlandosi dell’ignoranza che non conosce il loro segreto. Forse ora non gli restava più nessuna speranza, e pure non voleva fermarsi perché quella ricerca era diventata la sua vita Proprio come l’oceano per sempre leva le sue braccia al cielo, per raggiungere l’impossibile Proprio come le stelle girano in tondo cercando una meta che non può mai essere raggiunta Proprio così sulla spiaggia solitaria il pazzo dai capelli bruni e polverosi vagava in cerca della pietra filosofale. Un giorno, un ragazzo del villaggio si avvicinò e gli chiese: «Dimmi, dove hai trovato questa catena d’oro che ti cinge la vita?». Il pazzo trasalì: la catena che una volta era di ferro era proprio diventata d’oro; non era un sogno, ma lui non sapeva quando il mutamento era avvenuto. Si colpì con violenza la fronte dove, oh dove, senza saperlo, aveva raggiunto la sua meta? Si era ormai abituato a raccogliere pietre e toccare con esse la catena, e poi gettarle via senza guardare se la trasformazione era avvenuta; così il pazzo aveva trovato la pietra filosofale, e l’aveva perduta. Il sole calava a occidente, il cielo era d’oro. Il pazzo ritornò sui suoi passi per cercare di nuovo il perduto tesoro, ma ormai privo di forze, il corpo ricurvo, il cuore nella polvere, come un albero sradicato. LXVII Sebbene la sera giunga a lenti passi e abbia dato il segnale di cessare tutte le canzoni; sebbene i tuoi compagni siano andati a riposare, e tu sia stanco; sebbene la paura covi nel buio e la faccia del cielo sia velata; pure, ascoltami uccello, mio uccello, non chiudere le tue ali. Non è l’ombra delle foglie del bosco, quello è il mare che si gonfia come un oscuro serpente nero. Non è la danza del gelsomino in fiore, quella è la spuma biancheggiante. Oh, dov’è la verde riva assolata, dov’è il tuo nido? Uccello, o mio uccello, ascoltami, non chiudere le tue ali. La notte solitaria giace lungo il tuo cammino, l’alba dorme dietro le scure colline. Le stelle trattengono il respiro contando le ore la flebile luna nuota nella notte profonda. Uccello, o mio uccello, ascoltami, non chiudere le tue ali. Non c’è speranza né paura per te. Non c’è parola, sospiro, né grido. Non c’è casa né letto per riposare. Vi sono soltanto le tue ali e il cielo senza sentieri. Uccello, o mio uccello, ascoltami, non chiudere le tue ali. LXVIII Nessuno vive per sempre, fratello, e nulla dura in eterno. Tieni ciò a mente e godi. La nostra vita non è il solo vecchio fardello, il nostro cammino non è il solo lungo viaggio. Un solo poeta non ha da cantare una sola antica canzone. Il fiore appassisce e muore; ma chi porta il fiore non deve piangerlo per sempre. Fratello, tieni ciò a mente e godi. Per tessere la perfezione la musica deve avere una pausa. La vita va verso il tramonto per immergersi nell’ombre dorate. L’amore dev’essere distolto dal suo gioco per bere il dolore e conoscere il paradiso di lacrime. Fratello, tieni ciò a mente e godi. Ci affrettiamo a cogliere i fiori per timore che siano strappati dal vento che passa. Arde il nostro sangue, lampeggiano i nostri occhi, per ghermire baci che l’attesa ci farebbe perdere per sempre. La nostra vita è impaziente, intensi i nostri desideri, perché il tempo suona la campana della partenza. Fratello, tieni ciò a mente e godi. Non c’è tempo per noi di afferrare una cosa, e spezzarla, e gettarla nella polvere. Le ore passano rapidamente, celando i sogni nei lor veli. La nostra vita è breve; ci dona soltanto pochi giorni per amare. Se fosse solo un duro lavorare sarebbe lunga senza fine. Fratello, tieni ciò a mente e godi. La bellezza ci è dolce, perché danza assieme alle nostre vite sulla stessa melodia fuggente. Il sapere ci è prezioso, perché mai avremo il tempo di poterlo completare. Tutto è compiuto e finito nell’eterno Cielo. Ma i fiori terreni dell’illusione son tenuti eternamente freschi dalla morte. Fratello, tieni ciò a mente e godi. LXIX Vado alla caccia del cervo dorato. Potete sorridere, amici, ma inseguo questa visione che mi elude. Corro per valli e per colline, vago per paesi senza nome, perché vado a caccia del cervo dorato. Voi andate a far compere al mercato e tornate a casa carichi di merci, ma l’incanto dei venti senza dimora mi ha colpito, non so quando né dove. Non ho cura nel mio cuore; tutti i miei averi ho lasciato lontano dietro di me. Corro per monti e per valli, vago per paesi senza nome perché inseguo il cervo dorato. LXX Ricordo un giorno della mia infanzia quando feci galleggiare nel fossato una barchetta di carta. Era un umido giorno di luglio; ero solo e felice del mio gioco. Facevo galleggiare nel fossato la mia barchetta di carta. D’improvviso le nubi tempestose s’addensarono, i venti vennero a folate, e la pioggia cadde a torrenti. Torrenti d’acqua fangosa scorsero e gonfiarono il ruscello e fecero affondare la mia barca. Dentro di me pensai amaramente che la tempesta fosse giunta apposta per privarmi della mia felicità. La nuvolosa giornata di luglio sembra oggisenza fine e ho meditato su tutti quei giochi della vita in cui sono stato sconfitto. Maledicevo il mio destino per i molti scherzi che mi ha giocato, quando all’improvviso ricordai la barchetta di carta affondata nel fossato. LXXI Il giorno non è terminato, la fiera non è finita, la fiera sulla riva del fiume. Temevo che il mio tempo fosse stato sprecato e di aver perduto il mio ultimo soldo. Ma no, fratello, mi rimane ancora qualcosa. Il destino non mi ha spogliato di tutto. Le vendite e gli acquisti sono terminati. Tutte le partite sono state saldate, ed è tempo ch’io ritorni, a casa. Guardiano del cancello, chiedi il tuo pedaggio? Non temere, mi è rimasto ancora qualcosa. Il destino non mi ha spogliato di tutto. La pausa del vento minaccia tempesta; le nuvole basse all’occidente non promettono nulla di buono. L’acqua immota attende il levarsi del vento. Mi affretto ad attraversare il fiume prima che la notte mi raggiunga. Barcaiolo, vuoi la ricompensa? Sì, fratello, mi è rimasto ancora qualcosa. Il destino non mi ha spogliato di tutto. Sotto l’albero al bordo della strada siede un mendicante. Ahimé, mi guarda con una timida speranza! Crede ch’io sia ricco dei guadagni della giornata. Sì, fratello, mi è rimasto ancora qualcosa. Il destino non mi ha spogliato di tutto. La notte si fa buia, la strada solitaria. Lucciole brillano tra le foglie. Chi sei tu che mi segui con furtivi passi silenziosi? Sì, capisco, vuoi rubarmi tutti i miei guadagni. Non ti deluderò! Perché mi è rimasto ancora qualcosa, e il destino non mi ha spogliato di tutto. A mezzanotte arrivo a casa. Le mie mani son vuote. Tu stai aspettando con ansiosi occhi alla mia porta, insonne e silenziosa. Come un uccello spaurito voli al mio petto piena d’amore. Sì, sì, mio Dio, molto mi rimane ancora. Il mio destino non mi ha spogliato di tutto. LXXII Con giorni di duro lavoro eressi un tempio. Non aveva porte né finestre, le sue spesse mura erano costruite con pietre massicce. Dimenticai ogni altra cosa, evitai tutto il mondo: fissavo rapito contemplando l’immagine che avevo posto sull’altare. All’interno era sempre notte, e soltanto le lampade ardevano piene d’olio profumato. L’incessante fumo dell’incenso avvolgeva il mio cuore nelle sue grevi spire. Insonne scolpii sui muri fantastiche figure in un labirinto di linee sconcertanti cavalli alati, fiori con volti umani, donne con corpi di serpenti. Non un pertugio fu lasciato per il quale potesse entrare il canto degli uccelli, il mormorio delle foglie, o il rumore del villaggio operoso. L’unico suono che echeggiava sotto la cupola buia era quello dei miei incantesimi. La mia mente divenne immobile e acuta come una fiamma appuntita, i miei sensi si smarrivano nell’estasi. Scordai il passare del tempo, fino a quando una folgore colpì il mio tempio e un dolore mi trafisse il petto. La lampada sembrava pallida e confusa; come sogni incantenati, le sculture sulle pareti fissavano insensate la luce come se desiderassero nascondersi. Guardai l’immagine sull’altare. La vidi sorridente e viva del tocco vivente di Dio. La notte che avevo imprigionata aveva steso le sue ali ed era svanita. LXXIII Infinita non è la tua ricchezza, paziente e oscura madre terra! Ti affanni a nutrire i tuoi figli, ma il cibo è sempre troppo scarso. La gioia che ci doni non è mai perfetta. I giocattoli che crei per i tuoi figli sono sempre troppo fragili. Non puoi saziare le nostre speranze, ma dovrei abbandonarti per questo? Il tuo sorriso oscurato dal dolore è dolce ai miei occhi, il tuo amore che non conosce adempimento è caro al mio cuore. Dal tuo seno della vita ci desti il nutrimento, a non dell’immortalità; ed è per questo che i tuoi occhi sono sempre vigili. Da secoli tu stai lavorando con colori e con canti, e tuttavia il tuo cielo non è edificato, ma solo la sua triste illusione. Sulle tue creazioni di bellezza ’è una nebbia di lacrime. Verserò i miei canti nel tuo muto cuore, e il mio amore nel tuo amore. Ti adorerò con il lavoro. Ho veduto il tuo tenero volto e amo la tua polvere dolorosa, o Madre Terra. LXXIV Nella sala delle udienze del mondo la semplice foglia d’erba è seduta sullo stesso tappeto del raggio di sole e le stelle della mezzanotte. Così i miei canti condividono il posto nel cuore del mondo con la musica delle nubi e delle foreste. Ma tu, uomo ricco e potente, la tua ricchezza non ha nessuna parte nella semplice grandiosità del gioioso oro del sole e del tenero riflesso della luna. La benedizione del cielo che tutto abbraccia non è versata su di essa. E quando compare la morte, essa impallidisce e appassisce e si sbriciola in polvere. LXXV A mezzanotte l’aspirante asceta annunciò: questo è il tempo di lasciare a mia casa e andare in cerca di Dio. Ah, chi mi trattenne tanto a lungo in questa illusione? Dio sussurrò: «Io» ma l’uomo aveva le orecchie turate. Con un bimbo addormentato al suo seno sua moglie dormiva placidamente su un lato del letto. L’uomo disse: «Chi siete voi che mi avete ingannato per tanto tempo?». Ancora la voce mormorò: «Essi sono Dio» ma egli non intese. Il bimbo pianse nel sonno e si strinse accanto alla madre. Dio comandò: «Fermati, sciocco, non abbandonare la tua casa» - ma ancora non udì. Dio disse tristemente sospirando: «Perché il mio servo mi abbandona per andare in cerca di me?». LXXVI C’era fiera davanti al tempio. Aveva piovuto dall’alba e il giorno stava per finire. Più lieto di tutta l’allegria della folla era il lieto sorriso d’una fanciulla che aveva comprato per un soldo un fischietto di foglia di palma. L’acuta gioia di quel fischietto sovrastava il chiasso e le risate. Una folla immensa si accalcava. La strada era fangosa, il fiume in piena, i campi erano inondati sotto la pioggia incessante. Più grande di tutti i dolori della folla era il dolore d’un bambino che non aveva un soldo per comprare un bastoncino colorato. I suoi occhi mesti che fissavano la bancarella rendevano meschina tutta quell’accolta di gente. LXXVII L’operaio e sua moglie venuti da un paese d’occidente scavano per fare mattoni per la fornace. La loro figlioletta va all’approdo del fiume, e mai non finisce di lavare e strofinare pentole e vasi. Il fratellino, con la bruna testa rasata, nudo, coperto di fango, la segue e attende pazientemente sull’alta ripa del fiume. Lei rincasa con la brocca colma posata sulla testa, il vaso di rame splendente nella sinistra, tenendo con la destra il bambino lei, la minuscola servetta della madre, grave sotto il peso delle cure domestiche. Un giorno vidi questo bimbo nudo seduto con le gambe distese. La sorella sedeva presso l’acqua lustrando un vaso per bere con una manciata di sabbia, girandolo e rigirandolo. Lì vicino un agnello dal morbido pelo pascolava lungo la riva. Si accostò al bambino seduto e improvvisamente belò forte: il bambino si alzò strillando. La sorella smise di pulire il vaso, e gli corse incontro. Prese il fratellino in un braccio, e l’agnello nell’altro, e dividendo le sue carezze tra di loro legò in un solo vincolo d’affetto la progenie della bestia e dell’uomo. LXXVIII Era in maggio. L’afoso meriggio sembrava lungo senza fine. La terra riarsa si fendeva nel gran caldo, assetata. Dalla riva del fiume udii una voce che chiamava: «Vieni, tesoro!». Chiusi il mio libro e aprii la finestra per guardare. Vidi un grande bufalo coperto di fango, fermo presso il fiume, con i placidi occhi pazienti, e un ragazzo, nell’acqua fino al ginocchio, che lo chiamava a fare il bagno. Sorrisi divertito, e avvertii un senso di dolcezza dentro il cuore. LXXIX Spesso mi chiedo ove siano nascosti i confini del riconoscimento fra l’uomo e la bestia, il cui cuore non ha il dono della parola. In quale paradiso primevo, in un remoto mattino di creazione, correva il semplice sentiero che legava i loro cuori? Le tracce dei loro passi non sono mai state cancellate, sebbene la loro parentela sia da molto tempo scordata. Ma all’improvviso l’oscura memoria si desta in una musica senza parole, e la bestia guarda in viso l’uomo con una tenera fiducia, e l’uomo la guarda negli occhi con divertito affetto. Sembra quasi che i due amici s’incontrino mascherati, e attraverso il travestimento vagamente si riconoscano. LXXX Donna leggiadra! Con uno sguardo dai tuoi occhi potresti depredare tutta la ricchezza dei canti suonati sulle arpe dei poeti. Ma non ascolti le loro lodi, perciò io vengo a lodarti. Potresti umiliare ai tuoi piedi le più orgogliose teste del mondo. Ma sono i tuoi cari, sconosciuti alla fama, che preferisci adorare, perciò io ti adoro. La perfezione delle tue braccia aggiungerebbe gloria allo splendore d’un re, con la loro carezza. Ma le usi per spazzare la polvere e pulire la tua umile casa, e perciò sono pieno di stupore. LXXXI Perché sussurri così piano ai miei orecchi, O Morte, mia Morte? Quando i fiori languono nella sera e le bestie ritornano alle stalle, furtivamente vieni al mio fianco e mormori parole incomprensibili. È in questo modo che intendi conquistarmi con l’oppiato sonnolento mormorio e freddi baci, o Morte, mia Morte? Non vi sarà nessuna cerimonia fastosa per le nostre nozze? Non legherai con una ghirlanda i tuoi bruni capelli intrecciati? Non c’è nessuno a portare il tuo stendardo davanti a te, e la notte non sarà incendiata dalla rossa luce delle torce, o Morte, mia Morte? Vieni al suono delle tue conchiglie, vieni nella notte insonne. Vestimi col mantello cremisi, afferra la mia mano e prendimi. Il tuo carro sia pronto alla mia porta con i cavalli che nitriscono impazienti. Alza il mio velo e guardami in faccia con orgoglio, o Morte, mia Morte! LXXXII Questa notte la mia sposa ed io giocheremo al gioco della morte. La notte è nera, le nuvole nel cielo sono capricciose, e le onde infuriano sul mare. Abbiamo lasciato il nostro letto di sogni, abbiamo spalancate le porte e siamo usciti, la mia sposa ed io. Ci sediamo su un’altalena, e il vento tempestoso ci sospinge. La mia sposa si leva con gioia e timore, trema e si stringe al mio petto. A lungo l’ho servita teneramente. Per lei ho fatto un letto di fiori, le porte ho chiuso per tener lontana la cruda luce dai suoi occhi. L’ho baciata gentilmente sulle labbra, le ho mormorato dolcemente all’orecchio finché quasi sveniva dal languore. Era perduta in un vapore senza fine di vaga dolcezza. Non rispondeva alla mia carezza, i miei canti non riuscivano a destarla. Questa notte dalla foresta ci è giunto il richiamo della tempesta. La mia sposa si è levata tremante, mi ha preso per mano ed è uscita. I suoi capelli volano nel vento, il velo s’agita, la ghirlanda di fiori fruscia sopra il suo petto. La spinta della morte l’ha tuffata nella vita. Siamo a faccia a faccia, a cuore a cuore, la mia sposa ed io. LXXXIII Abitava sul fianco della collina, ai margini d’un campo di grano, vicino alla sorgente che scorre in ridenti ruscelli sotto l’ombra solenne degli antichi alberi. Le donne vi andavano a riempire le loro anfore, e i viandanti sedevano a riposare conversando. Lei lavorava e sognava ogni giorno al suono del torrente gorgogliante. Una sera, uno straniero scese dalla vetta nascosta tra le nubi; i suoi capelli erano arruffati come serpenti sonnacchiosi. Gli chiedemmo stupiti: «Chi sei?». Ma non rispose e sedette in disparte presso il torrente rumoroso, guardando silenziosamente la capanna dove lei abitava. I cuori ci tremarono impauriti, e quando scese la notte tornammo alle nostre case pensierosi. L’indomani, quando le donne vennero ad attingere l’acqua alla sorgente sotto l’ombra degli alberi di deodar, le porte della capanna erano aperte, ma la sua voce non s’udiva e dov’era il suo volto sorridente? L’anfora vuota giaceva per terra, la lampada consunta era spenta. Nessuno seppe dov’era fuggita prima che spuntasse il giorno e lo straniero era partito. In maggio il sole divenne cocente, sulle colline si sciolse la neve; noi sedevamo presso la sorgente e piangendo ci chiedevamo: «Ci sarà un ruscello nel paese dov’è andata, in cui possa riempire la sua brocca per dissetarsi in queste calde giornate?». Ci chiedevamo l’un l’altro sgomenti: «Ma ci sarà un paese al di là di queste colline dove viviamo?». Era una sera d’estate; la brezza soffiava dal sud; ed io sedevo nella sua stanza deserta, dove la lampada era ancor spenta. Quando ad un tratto davanti ai miei occhi le colline sparirono, come tende tirate da parte. «È lei che viene. Come stai, bambina? Sei felice? Dove puoi trovare un riparo sotto questo cielo scoperto? Ahimé, non c’è più la nostra sorgente per mitigare la tua sete!». Ma lei rispose: «Qui è lo stesso cielo, soltanto è libero dalle colline che al vostro paese fanno da siepe questo è lo stesso torrente diventato un grande fiume questa è la stessa terra diventata un’ampia pianura». «Qui c’è tutto», dissi sospirando, «soltanto noi non ci siamo». Lei disse sorridendo tristemente: «Voi siete qui nel mio cuore». Mi destai e udii il mormorio del torrente, il frusciare dei deodar nella notte. LXXXIV Sopra le risaie verdi e gialle passano le ombre delle nubi autunnali inseguite dal sole rapido incalzante. Le api dimenticano di suggere il miele; ebbre di luce, ronzano come impazzite. Le anatre, sulle isolette del fiume, starnazzano allegre senza motivo. Nessuno torni a casa stamattina, fratelli, nessuno vada a lavorare. Prendiamo d’assalto l’azzurro del cielo, deprediamo lo spazio nella corsa. Le risate vagano nell’aria come spuma sulle onde del mare. Fratelli, in futili canzoni sperperiamo il nostro mattino. LXXXV Chi sei tu, lettore, che leggi le mie poesie tra un centinaio d’anni? Non posso inviarti un solo fiore dalla ricchezza di questa primavera, una sola striatura d’oro dalle nubi lontane. Apri le porte e guardati intorno. Dal tuo giardino in fiore cogli i ricordi fragranti dei fiori svaniti un centinaio d’anni fa. Nella gioia del tuo cuore possa tu sentire la gioia vivente che cantò in un mattino di primavera, mandando la sua voce lieta attraverso un centinaio d’anni. Indice Tagore visto da un non-tagoriano. Introduzione di Alessandro Bausani Nota biobibliografica Nota alla traduzione GITANJALI I. «Mi hai fatto senza fine» II. «Quando mi comandi di cantare, il mio cuore» III. «Non so come tu canti, mio signore!» IV. «Vita della mia vita» V. «Concedi ch’io possa sedere» VI. «Cogli questo piccolo fiore» VII. «Il mio canto ha deposto ogni artificio.» VIII. «Il bambino adorno di vesti principesche» IX. «O stolto, che cerchi di portare» X. «Qui è il tuo sgabello» XI. «Smettila di cantare i tuoi inni» XII. «A lungo durerà il mio viaggio» XIII. «Il canto che venni a cantare» XIV. «Molti sono i miei desideri» XV. «Sono qui a cantarti canzoni» XVI. «Ho ricevuto il mio invito» XVII. «Attendo soltanto l’amore» XVIII. «Nubi su nubi s’addensano» XIX. «Se tu non parli colmerò il mio cuore» XX. «Il giorno in cui il loto fiorì» XXI. «Devo varare la mia barca.» XXII. «Nell’ombra fonda del luglio piovoso» XXIII. «Sei uscito in questa notte tempestosa» XXIV. «Se il giorno è finito» XXV. «Nella notte della stanchezza» XXVI. «Venne e sedette al mio fianco» XXVII. «Luce, oh, dov’è la luce?» XXVIII. «Tenaci sono le catene» XXIX. «Colui che rinchiudo col mio nome» XXX. «Uscii solo per venire al tuo convegno.» XXXI. «Prigioniero, dimmi, chi è stato» XXXII. «In questo mondo coloro che m’amano» XXXIII. «Quando era giorno vennero a casa mia» XXXIV. «Lasciami solo quel poco» XXXV. «Dove la mente non conosce paura» XXXVI. «Di questo ti prego, signore: colpisci» XXXVII. «Credevo che il mio viaggio» XXXVIII. «Io desidero te, soltanto te -» XXXIX. «Quando il mio cuore è duro e inaridito» XL. «Per giorni e giorni, mio Dio» XLI. «Dietro a tutti, nell’ombra» XLII. «Allo spuntare del giorno» XLIII. «Era il giorno quando non ero» XLIV. «Questa è la mia gioia, attendere e guardare» XLV. «Non hai udito i suoi passi silenziosi?» XLVI. «Non so da qual tempo lontano» XLVII. «La notte è quasi passata» XLVIII. «Il mare di silenzio del mattino» XLIX. «Scendesti dal tuo trono e ti fermasti» L. «Ero andato mendicando d’uscio in uscio» LI. «Scese la notte.» LII. «Pensavo di chiederti la corona di rose» LIII. «Bello è il tuo braccialetto» LIV. «Nulla ti chiesi, al tuo orecchio» LV. «Il tuo cuore è pieno di languore» LVI. «E per questo che la tua gioia» LVII. «Luce, mia luce» LVIII. «Tutti i miei versi di gioia» LIX. «Sì, lo so, non è nient’altro che il tuo amore» LX. «I bambini s’incontrano» LXI. «Nessuno sa di dove viene il sonno» LXII. «Quando ti porto balocchi variopinti» LXIII. «Mi hai fatto conoscere» LXIV. «Sulla riva del fiume desolato» LXV. «Quale divina bevanda vorresti, mio Dio» LXVI. «Lei, ch’era sempre rimasta» LXVII. «Tu sei il cielo e sei anche il nido.» LXVIII. «Scende il tuo raggio di sole» LXIX. «La stessa corrente di vita» LXX. «Non sei capace d’essere felice» LXXI. «Ch’io vada superbo di me stesso» LXXII. «E lui che desta il mio essere» LXXIII. «La mia liberazione» LXXIV. «Il giorno è finito» LXXV. «I doni che tu dai a noi mortali» LXXVI. «Un giorno dopo l’altro» LXXVII. «Ti conosco come mio Dio LXXVIII. «Quando il mondo era appena creato» LXXIX. «Se non mi è dato d’incontrarti in questa vita» LXXX. «Sono come il residuo» LXXXI. «In molti giorni oziosi» LXXXII. «Il tempo è senza fine nelle tue mani» LXXXIII. «Madre, con le lacrime del mio dolore» LXXXIV. «Il dolore della separazione» LXXXV. «Quando per primi uscirono i guerrieri» LXXXVI. «La morte, tuo servo, è alla mia porta.» LXXXVII. «In disperata speranza la vado cercando» LXXXVIII. «Divinità del tempio in rovina» LXXXIX. «Non più parole chiassose -» XC. «Il giorno che la morte busserà» XCI. «O Morte, mia morte» XCII. «So che il giorno verrà» XCIII. «Ho ricevuto il mio congedo.» XCIV. «E giunta l’ora della mia partenza» XCV. «Non mi accorsi del momento in cui varcai» XCVI. «Quando me ne andrò lontano da qui» XCVII. «Quando giocavo con te» XCCiII. «Ti incoronerò di trofei» XCIX. «Quando abbandono il timone» C. «Mi tuffo nell’oceano delle forme» CI. «Sempre nella mia vita» CII. «Tra gli uomini mi vantai» CIII. «In un saluto a te, mio Dio» IL GIARDINIERE I. II. «Oh, poeta, la sera s’avvicina» III. «Al mattino gettai la mia rete nel mare.» IV. «Ahimè, perché costruirono la mia casa» V. «Sono irrequieto.» VI. «L’uccello prigioniero nella gabbia» VII. «Mamma, il giovane Principe passerà» VIII. «Quando la lampada accanto al mio letto si spense» IX. «Quando a notte vado sola al mio convegno d’amore» X. «Lascia stare il tuo lavoro, sposa.» XI. «Vieni con me, non indugiare a farti bella.» XII. «Se vuoi riempire la tua brocca» XIII. «Non chiesi nulla» XIV. «Camminavo lungo la strada» XV. «Corro come un cervo muschiato» XVI. «Le mani si stringono alle mani» XVII. «L’uccello giallo canta sul loro albero» XVIII. «Quando le due sorelle vanno ad attingere acqua» XIX. «Camminavi sulla riva del fiume» XX. «Giorno per giorno viene e va via.» XXI. «Perché ha scelto di venire alla mia porta» XXII. «Quando mi passò accanto con passi veloci» XXIII. «Perché te ne stai seduta là» XXIV. «Non celare il segreto del tuo cuore» XXV. «“Vieni, giovane, dicci sinceramente» XXVI. «“Prendo quello che viene» XXVII. «“Confida nell’amore» XXVIII. «I tuoi occhi m’interrogano tristI.» XXIX. «Parlami, amor mio! dimmi a parole» XXX. «Tu sei la nube della sera» XXXI. «Il mio cuore, uccello del deserto» XXXII. «Dimmi se questo è vero, amore mio» XXXIII. «Io ti amo, amor mio» XXXIV. «Non andartene, amore, senza avvertirmi» XXXV. «Per paura che troppo facilmente» XXXVI. «Sussurrò: “Amore, alza i tuoi occhi”.» XXXVII. «Bella, vuoi mettere la tua ghirlanda» XXXVIII. «Amore mio, una volta il tuo poeta varò» XXXIX. «Tutta la mattina tento d’intrecciare» XL. «Un incredulo sorriso aleggia sui tuoi occhi» XLI. «Vorrei dirti le parole più profonde» XLII. «O pazzo, splendidamente ebbro!» XLIII. «No, amici, non sarò mai un asceta» XLIV. «Reverendo signore, perdona» XLV. «Agli ospiti che devono partire» XLVI. «Mi lasciasti e seguisti la tua via.» XLVII. «Se vuoi così, smetterò di cantare.» XLVIII. «Liberami dai lacci della tua dolcezza» XLIX. «Afferro le sue mani» L. «Amore, giorno e notte il mio cuore» LI. «Finisci allora quest’ultima canzone» LII. «Perché la lampada si spense?» LIII. «Perché il tuo sguardo mi copre di vergogna?» LIV. «Dove corri col tuo cesto» LV. «Era mezzogiorno quando sei partito.» LVI. «Ero una fra tante donne occupate» LVII. «Colsi il tuo fiore, oh cielo!» LVIII. «Un mattino una fanciulla cieca» LIX. «Donna, non sei soltanto l’opera di Dio» LX. «O Bellezza, scolpita nella pietra» LXI. «Pace, cuor mio, che il tempo» LXII. «Nel fosco sentiero d’un sogno» LXIII. «Viandante, devi partire?» LXIV. «Tutto il giorno passai» LXV. «E ancora il tuo richiamo?» LXVI. «Un pazzo vagabondo cercava» LXVII. «Sebbene la sera giunga a lenti passi» LXVIII. «Nessuno vive per sempre, fratello» LXIX. «Vado alla caccia del cervo dorato» LXX. «Ricordo un giorno della mia infanzia» LXXI. «Il giorno non è terminato, la fiera non è finita» LXXII. «Con giorni di duro lavoro eressi un tempio» LXXIII. «Infinita non è la tua ricchezza» LXXIV. «Nella sala delle udienze del mondo» LXXV. «A mezzanotte l’aspirante asceta» LXXVI. «C’era fiera davanti al tempio.» LXXVII. «L’operaio e sua moglie» LXXVIII. «Era in maggio. L’afoso meriggio» LXXIX. «Spesso mi chiedo ove siano nascosti» LXXX. «Donna leggiadra! Con uno sguardo» LXXXI. «Perché sussurri così piano ai miei orecchi» LXXXII. «Questa notte la mia sposa ed io» LXXXIII. «Abitava sul fianco della collina» LXXXIV. «Sopra le risaie verdi e gialle» LXXXV. «Chi sei tu, lettore, che leggi»