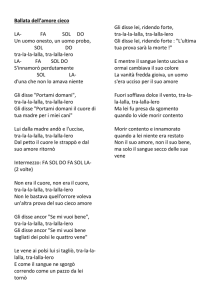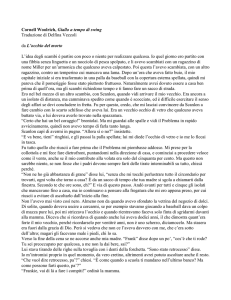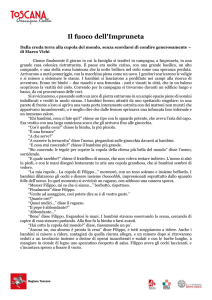caricato da
common.user5324
Charles Dickens: I Grandi Romanzi - Edizioni Integrali

I grandi romanzi Charles Dickens ISBN: 9788854141780 Questo libro è stato acquistato su Bookrepublic Store Copyright © 2010, Newton Compton Editori Il presente file può essere usato esclusivamente per finalità di carattere personale. Tutti i contenuti sono protetti dalla Legge sul diritto d'autore. BookRepublic declina ogni responsabilità per ogni utilizzo del file non previsto dalla legge. 380 Titoli originali: Oliver Twist, trad. di M. Martino; David Copperfield, trad. di F. Prattico; Hard Times, trad. di M. Martino; A Tale of Two Cities, trad. di S. Spaventa Filippi; Great Expectations, trad. di M.F. Melchiorri, A Christmas Carol - The Bells - The Cricket on the Earth - The Battle of Life - The Haunted Man and the Ghost’s Bargein, trad. di E. Grazzi Prima edizione ebook: maggio 2012 © 2011 Newton Compton editori s.r.l. Roma, Casella Postale 6214 ISBN 978-88-541-4178-0 www.newtoncompton.com Edizione elettronica realizzata da Gag srl Charles Dickens I grandi romanzi Oliver Twist, David Copperfield, Tempi difficili, Le due città, Grandi speranze, Racconti di Natale Introduzioni di Vanni De Simone, Mario Martino, Marisa Sestito Edizioni integrali Newton Compton editori Nota biobibliografica CRONOLOGIA DELLA VITA E DELLE OPERE 1812. Charles Dickens nasce a Portsmouth il 7 febbraio. 1815. John Dickens, padre di Charles, impiegato all'ufficio paghe della Marina, viene trasferito a Londra. 1817. John Dickens è trasferito a Chatham, dove il piccolo Charles trascorre il periodo più felice della propria infanzia. 1821. Scolaro alla William Giles's School, Charles scrive, "alla matura età di 8-10 anni", la tragedia Mìsnar, the Sultan of India. 1822. John Dickens è di nuovo trasferito a Londra, e va ad abitare al 16 di Bayham Street, Camden Town. 1824. Mentre la sorella Fanny è iscritta alla Royal Academy of Music, il piccolo Charles, anche su pressioni della madre, viene "abbandonato" al lavoro in una fabbrica di lucido da scarpe, Warren, sulle sponde del Tamigi. Questo gli dà il senso di una contaminazione col mondo "basso" e criminale. Il padre è rinchiuso nella prigione per debitori di Marshalsea. Charles alloggia presso una famiglia di amici, prima a Camden Town e poi a Lant Street, più vicino alla prigione del padre. Dopo pochi mesi, uscito John Dickens di prigione, la famiglia si trasferisce a Somers Town. 1825. Charles Dickens si iscrive alla Wellington House Academy. 1826. John Dickens ottiene un impiego giornalistico. 1827. Charles si impiega presso lo studio legale Ellis e Blackmore. Per evadere dalla routine degli impieghi legali, studia stenografia da autodidatta. 1830. Si invaghisce di Maria Beadnell, la cui famiglia tratta snobisticamente il giovane e lo induce ad interrompere il rapporto, nel 1833. Ottiene l'impiego di reporter parlamentare grazie anche allo zio. 1832. Tenta il mestiere dell'attore. 1833. «The Monthly Magazine» pubblica il suo primo racconto: A Dinner at Poplar Walk. 1834. Giornalista al «The Morning Chronicle». Conosce la futura moglie, Catherine Hogarth. Pubblica altri "bozzetti" su «The Monthly Magazine». 1836. Escono Sketches by Boz, First Series, e Sketches by Boz, Second Series, i suoi primi volumi. Si sposa e conosce John Forster che rimarrà forse il suo più fedele amico e primo, importantissimo biografo. Inizia a pubblicare Pickwick Papers in parti mensili, metodo a cui rimarrà sostanzialmente fedele per il resto della sua opera. 1837. Inizia la pubblicazione in 20 fascicoli, mensili, di Oliver Twist. 1838. Inizia la pubblicazione in 20 fascicoli, mensili, di Nicholas Nickleby. 1840. Assunta la direzione di una nuova rivista, «Master Humphrey's Clock», su di essa inizia la pubblicazione, in 40 puntate, settimanali, di The Old Curiosity Shop. 1841. Su «Master Humphrey's Clock», inizia la pubblicazione, in 40 puntate, di Barnaby Rudge. 1842. Esce American Notes, risultato del suo primo viaggio negli Stati Uniti, e inizia la pubblicazione di Martin Chuzzlewit. 1843. Scrive il racconto natalizio, archetipo di un genere, A Christmas Carol (a cui seguono, fino al 1848: The Chimes, The Cricket on the Hearth, The Battle of Life, e The Haunted Man). 1844-5. Visita l'Italia. 1846. Esce Pictures from Italy. Prende avvio Dombey and Son, in 20 puntate, che dà inizio alla sua fase matura dopo la crisi produttiva degli anni precedenti. 1849. Inizia la pubblicazione di David Copperfield (in 20 puntate). 1850. È direttore di una nuova rivista, «Household Words», che attraverserà tutti gli anni Cinquanta. 1852. Inizia la pubblicazione di Bleak House (in 20 puntate). 1854. Esce Hard Times, in numeri settimanali. 1855. Inizia la pubblicazione di Little Dorrit (in 20 puntate). 1855. Acquista la casa di Gads Hill, nei pressi di Chatham, ammirata nelle passeggiate dell'infanzia assieme al padre. I giri di letture delle proprie opere, iniziati per beneficenza e poi trasformati in vere e proprie iniziative commerciali, acquistano ritmi più intensi. 1859. Assume la direzione della nuova rivista «All The Year Round», dove pubblica A Tale of two Cities. 1860. Su «All The Year Round» inizia la pubblicazione di Great Expectations. 1864. Inizia la pubblicazione di Our Mutual Friend (in 20 puntate), ultimo suo romanzo concluso. 1865. Coinvolto in un incidente ferroviario, rischia che sia scoperta la sua relazione extraconiugale con l'attrice Ellen Ternan. 1868. Pubblica su «The Atlantic Monthly» il racconto George Silverman's Explanation. 1870. Inizia la pubblicazione di The Mistery of Edwin Drood, del quale solamente sei numerisono pubblicati, dei dodici previsti. Provato da una serie di stressanti letture pubbliche,muore a Gad's Hill, il 9 giugno. BIBLIOGRAFIA GENERALE Rassegne bibliografiche: PKLIP COLLINS, Charles Dickens in The New Cambridge Bibliography, Cambridge, Cambridge UP, 196977; JOHN FENSTERMAKER, Charles Dickens, 1940-1975: An Analytical Subject Index to Periodical Criticism of the Novels and Christmas Books, London, Prior, 1979. Su The Old Curiosity Shop: Priscilla e Paul Schlicke, The Old Curiosity Shop: an annotated bibliography, New York, Garland, 1988. Per una rassegna della critica si veda, a cura di C. PAGETTI e M.T. CKALANT, Dickens e la critica, in iid., La città e il teatro. Dickens e l’immaginario vittoriano, Roma, Bulzoni, 1988, pp. 13-39. Si vedano inoltre ADA NISBET Ch. Dickens, in L. STEVENSON (a cura di), Victorian Fiction: A Guide to Research, Cambridge, Harvard up, 1964 e PHILIP COLLINS, pp. 34-113, Ch. Dickens, in g.h. forD (a c. di), pp. 34-113 Victorian Fiction: A Second Guide to Research, New York, mLAA, 1978. La biografia di Dickens più accreditata è quella di EDGAR JOHNSON, Charles Dickens: His Tragedy and Triumph, London, Allen, 1977 (19521); la prima in assoluto è Life of Dickens, di JOHN FORSTER (London, Chapman, 1872-4, 3 voll). Inestimabili per gli studi dickensiani le Letters of Charles Dickens, volumi 1-12, a c. di M. HOUSE, G. STOREY, K. TILLOTSON, K.J. FiELDiNg, Oxford, Oxford u.p., 1965-2002. Studi critici BAUMGARTEN M. e DALESKI H.M., Homes and Homelessness in the Victorian Imagination, New York, AMS, 1998. BLOOM, HAROLD (a cura di), Charles Dickens: Modem Critical Views, New York, Chelsea House, 1987. BLOOM, HAROLD (a cura di), Victorian Fiction, New York, Chelsea House, 1989. BOLTON, PHILIP H., Dickens Dramatized, London, Mansell, 1987. BROWN, JAMES M., Dickens: Novelist in the Marketplace, London, Macmillan, 1982. BUTT J. e K. TILLOTSON, Dickens at Work, London, Methuen, 1957. CAREY, JOHN, The Violent Effigy, London, Faber, 1973. COCKSHUT, A. o. J., The Imagination of Charles Dickens, London, Collins, 1961. COLLINS, PHILIP, Dickens and Crime, London, Macmillan, 1962. COLLINS, PHILIP, Dickens and Education, London, Macmillan, 1963. COLLINS, PHILIP (a cura di), Dickens: The Critical Heritage, London, Routledge, 1971. CONNOR, STEVEN, Charles Dickens, Oxford, Blackwell, 1985. DALDRY, GRAHAM, Charles Dickens and the Form of the Novel, London, Croom Helm, 1987. DYOS H.J. e M. WOLFF (a cura di) The Victorian City, 2 voli., London, Routledge, 1973. DYSON, ANTHONY EDWARD (a cura di), Dickens: Modem Judgements, London, Macmillan, 1968. EGAN, JOHN M., Stereotyped Jew: in English Literature, Philadelphia, Xlibris, 2002. FIELDING, KENNETH JOSHUA, Charles Dickens: A Critical Introduction, London, Longmans, 1958. FORD, GEORGE, Dickens and his Readers: Aspects of NovelCriticism Since 1836, Princeton, Princeton U.P., 1955. GAGER, VALERIE, Shakespeare and Dickens: The Dynamics of Influence, Cambridge, Cambridge U.P., 1966. GARIS, ROBERT, The Dickens' Theatre: A Reassessment of the Novels, Oxford, Clarendon, 1965. GROSS J. e G. PEARSON (a cura di), Dickens and the Twentieth Century, London, Routledge, 1962. HARDY, BARBARA, The Moral Art of Dickens, London, Athlone Press, 1970. HERST, BETH F., The Dickens Hero, London, Weidenfeld, 1990. HILLIS MILLER, J., Charles Dickens: the World of His Novels, Cambridge, Mass., Harvard U.P., 1958. HILLIS MILLER, J., The Fiction of Realism: 'Sketches by Boz', 'Oliver Twist', and Cruikshank's Illustrations, Clark Library Seminar, California U.P., 1971. HOBSBAUM, PHILIP, A Reader's Guide to Charles Dickens, London, Thames, 1972. HOLLINGTON, MICHAEL, Dickens and the Grotesque, London, Croom Helm, 1984. HORSMAN, ALAN, The Victorian Novel, Oxford, Oxford U.P., 1990. HOUSE, HUMPHRY, The Dickens' World, London, Oxford U.P., 1941. JAFFE, AUDREY, Vanishing Points: Dickens, Narrative, and the Subject of Omniscience, Berkeley, California U.P., 1991. JOHN, JULIET, Charles Dickens's Oliver Twist: a Sourcebook, New York, Routledge, 2005. LEAVIS, F.R. e Q.D., Dickens the Novelist, London, Chatto, 1970. LITVAK, JOSEPH, Caught in the Act, Berkley and Los Angeles, California U.P., 1992. LUCAS, JOHN, The Melancholy Man: A Study of Dickens'Novels, London, Methuen, 1970. MARCUS, STEVEN, Dickens: from Pickwick to Dombey, London, Chatto, 1965. PRICE, MARTIN (a cura di), Dickens: Twentieth Century Views, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1967. MONOD, SYLVÈRE, Dickens the Novelist, Oklahoma, Oklahoma U.P., 1968. MORRIS, PAM, Dickens's Class Consciousness: A Marginal View, London, MacMillan, 1991. NISBET A. e BLAKE N. (a cura di), Dickens Centennial Essays, Berkeley, California U.P., 1971. ORWELL, GEORGE, "Charles Dickens", in ID., Inside the Whale, London, 1940 (ora in Collected Essays, Harmondsworth, Penguin, 1970). RODENSKY, LISA, Crime in Mind: Criminal Responsibility and the Victorian Novel, New York, Oxford U.P., 2003. ROSS, H. DABNEY, Love and Property in the Novels of Charles Dickens, Berkeley, California U.P., 1967. SCHLICKE, PAUL, Dickens and Popular Entertainment, London, Allen, 1985. SCHWARZBACH, F.S., Dickens and the City, London, Athlone, 1979. SLATER, MICHAEL (a cura di), Dickens 1970: Centenary Essays, London, Chapman and Hall, 1970. STOEHR, TAYLOR, Dickens: The Dreamer's Stance, Ithaca, N.Y., Cornell U.P., 1965. STONE, HARRY, Dickens and the Invisible World: Fairy Tales, Fantasy, and Novel Making, Bloomington, Indiana U.P., 1979. VAN GHENT, DOROTHY, "The Dickens World: A View from Todgers", in Sewanee Review, 58 (1950). WALL, STEVEN (a cura di), Charles Dickens, «Penguin Critical Anthologies», Harmondsworth, Penguin, 1970. WELSH, ALEXANDER, The City of Dickens, Oxford, Oxford U.P., 1971. WESTBURGH, BARRY, The Confessional Fictions of Charles Dickens, Dekalb, Illinois U.P., 1977. WILLIAMS, RAYMOND, The English Novel: from Dickens to Lawrence, London, Hogarth Press, 1984. WILSON, ANGUS, The World of Charles Dickens, London, Martin Seeker & Warburg, 1970. WILSON, EDMUND, The Wound and the Bow, Boston, Mass., Houghton, 1941. WORTH, GEORGE, Dickensian Melodrama: A Reading of the Novels, Lawrence, University of Kansas, 1978. Studi in italiano su Dickens: BONADEI, ROSSANA, Paesaggio con figure. Intorno all'Inghilterra di Charles Dickens, Milano, Jaca Book, 1996. CHIALANT M.T. e PAGETTi C., La città e il teatro. Dickens e l'immaginario vittoriano, Roma, Bulzoni, 1988. CHIALANT, MARIA TERESA, Ciminiere e cavalli alati. Strategie contrastive nella narrativa di Charles Dickens, Napoli, Istituto Universitario Orientale, 1988. FRAIOLI F. e BAIANO A., Dickens e il suo tempo: il pensiero utilitaristico in 'Hard Times'e l'analisi delle figure femminili in David Copperfield, Napoli, Liguori, 1998. IZZO, CARLO, Autobiografismo di Charles Dickens, Venezia, Neri Pozza, 1954. MARRONI, FRANCESCO, Disarmonie vittoriane, Roma, Carocci, 2002. MARTINO, MARIO, Dickens e la crisi della scrittura, Bari, Adriatica, 1996. PAGANELLI, MARINA BONDI, Dickens e il discorso politico, Bologna, Cappelli, 1989. PRAZ, MARIO, La crisi dell'eroe nel romanzo vittoriano, Firenze, Sansoni, 1981 (1952). RUNCINI, ROMOLO, Illusione e paura nel mondo borghese. Da Dickens a Orwell, Bari, Adriatica, 1968. SPINA, GIORGIO, Charles Dickens. L'uomo e la folla, Genova, E.R.S.U.,1985. Oliver Twist Premessa Oliver Twist1 è la conferma di un genio precoce giacché questo classico della letteratura universale ci viene da un Dickens di appena venticinque anni. Privato di una istruzione superiore per le difficoltà finanziarie in cui presto precipita la sua famiglia, dopo una iniziale illusione di benessere e di signorilità, tipico vittoriano che s'è fatto da sé, Dickens da autodidatta si avvia per gradi all'arte attraverso la pratica del giornalismo, e dapprima è corrispondente parlamentare, grazie a una formidabile capacità stenografica; poi, invia a riviste, trepidante e nell'anonimato, quei primi racconti (o "bozzetti ") che successivamente riunirà col titolo di Sketches by Boz e che incontrano da subito il favore del pubblico. Per quanto giovane e "ineducato", quando inizia a scrivere Oliver Twist, Dickens ha già al suo attivo non solo il successo di questi racconti ma anche quello del suo primo, anomalo e grandissimo romanzo, Pickwick Papers, iniziato nel 1836 e sviluppato in forma di fascicoli pubblicati mensilmente. Anzi, l'epopea picaresca dell'attempato e angelico Pickwick e dello scaltro e spiritoso servo Sam Weller non è ancora conclusa quando si avvia questa nuova avventura e sfida narrativa, che subordina la vena comica ad un ritratto della società e del suo tempo in cui predominano le tinte fosche. Dickens scrive i numeri mensili di The Adventures of Oliver Twist per la pubblicazione sulla «Bentley's Miscellany» (dal febbraio del '37 all'aprile del '39), in perfetta, giovanilmente temeraria sintonia con tale forma di pubblicazione a scadenza periodica, che atterrirebbe qualsiasi artista di ambito modernista. Tant'è che il primo numero deve essere posticipato rispetto alla scadenza del gennaio '37: un'influenza impedisce la stesura del manoscritto, il che vuol dire che Dickens non ha nemmeno una minima riserva di lavoro svolto in anticipo sulle scadenze di pubblicazione: la quindicina di pagine di ogni numero passa quasi direttamente dalla sua penna e dalla sua scrivania al tavolo del compositore. L'arte di Oliver Twist è innovativa anche in questo senso, e comunque, non corrispondendo ai criteri più moderni di accurata ponderazione e meditazione di tutto l'impianto narrativo, passa oltre le incongruenze di tempo, le implausibilità o arbitrarietà dell'intreccio. Ma, alla luce di questa storica rivoluzione editoriale, vai la pena chiedersi quanto ci fosse di programmato, di già pensato e pianificato nella successione dei vari fascicoli. Se infatti, più avanti nella sua carriera, Dickens lascia prove evidenti di tale meditazione e programmazione, nel caso presente si hanno solo indizi sparsi, o le prove interne che vengono dal testo stesso. Ne risultano tanto le argomentazioni di chi sostiene che dietro l'apparente episodicità della scrittura c'è una lunga gestazione e meditazione preparatoria; quanto quelle di chi sostiene che se un piano originario c'è, questo avrebbe contemplato uno sviluppo molto più breve, quasi di racconto, successivamente ampliato alla misura del romanzo. Questa relativa duplicità di visione si trova ancora irrisolta, diremmo, nel "Progress " del sottotitolo alla prima edizione, The Parish Boy's Progress, che comunque salda le picaresche "Adventures " in un piano unitario. Se colleghiamo infatti il termine, come consuetudine, ad una tradizione satirica hogarthiana (Hogarth, con le sue mirabili, graffanti incisioni, è stato uno dei grandi riferimenti per l'arte di Dickens, e non a caso il testo di Oliver Twist trova quasi un naturale complemento nelle illustrazioni di George Cruickshank, ovvero Phiz), allora il percorso di Oliver sarebbe dovuto essere limitato ai bassifondi, risolvendosi in una linea di caduta del piccolo eroe dall' ospizio-asilo, alla criminalità, alla deportazione. A voler scorgere invece nel sottotitolo l'influenza del Pilgrim's Progress (la celebre allegoria secentesca del puritano John Bunyan è ugualmente fondamentale per il macrotesto dickensiano), l'intreccio narrativo è ampliato ad includere una forte dimensione borghese che consenta il "lieto fine", il percorso di ritorno alle origini nascoste di Oliver e la sua salvezza in un diverso ambito sociale da quello in cui lo vediamo collocato all'inizio. Nonostante i tratti di continuità con Pickwick Papers (pubblicazione a puntate, linea narrativa picaresca, innocenza angelica del protagonista, ambientazione londinese), Oliver Twist si caratterizza soprattutto per alcuni tratti di profonda diversità. Va perciò spiegato che cosa possa aver spinto Dickens, che non ha ancora consolidato il suo successo, al rischio di un cambiamento così netto della precedente formula narrativa. La prima spiegazione di ciò va individuata nel rapporto più intimo che Oliver Twist istituisce col passato dell'autore, sicché un disegno quasi autobiografico viene a celarsi dietro le sue molte cifre, dietro la linea quasi allegorica della narrazione. Anticipando i romanzi "confessionali ", in cui questo intento è più consapevole (le narrazioni in prima persona del David Copperfield o di Great Expectations), qui Dickens comincia a fare i conti col proprio passato traumatico, segreto, persino inconscio: nato nel febbraio del 1812 nei pressi della città portuale di Portsmouth, nel Sud dell'Inghilterra quasi di fronte alla Francia agitata ancora dagli sviluppi della Rivoluzione e dal turbine napoleonico - egli vive infatti i primi e sereni anni nella tranquilla cittadina di Chatham, assorbendo la vivificante libertà e promessa del mare. Ma questi anni, che nel ricordo dello scrittore resteranno di originaria felicità, sono bruscamente interrotti dalla decadenza economica della famiglia, dal trasferimento a Londra, dall'arresto per debiti del padre, dall'essere mandato a lavorare in una desolante fabbrica di lucido da scarpe sulla riva del Tamigi, e dal dover vivere letteralmente solo nella sterminata metropoli, separato dalla famiglia: il bambino, come Oliver nel periodo cruciale delle sue avventure, ha appena una decina d'anni, ed è anche perciò che quel periodo buio, di pochi mesi, sembra di estensione infinita nella sua percezione e resta indelebile nella sua psiche matura. Come Oliver, Dickens si è sentito orfano nell'abbandono (ammette, molto più tardi, di non aver potuto mai perdonare la madre di aver insistito perché non fosse tolto dal suo degradante lavoro). Il senso di ingiustizia provato allora è troppo grande perché possa trovare espressione diretta, anche a distanza di molti anni Dickens proverà a scrivere una autobiografia ma troverà impossibile proseguire oltre l'adolescenza. Tanto più si fa urgente invece la trasposizione indiretta, letteraria, di quella esperienza di abbandono. Dunque, Oliver non solo orfano, ma addirittura nato in una "workhouse", un ospizio di mendicità, la sua unica dimora fino, appunto, ad una età di circa dieci anni; e fuggito a Londra, preda di delinquenti, concretizza nell'esperienza di fantasia la paura, sofferta realmente dal ragazzo Dickens, di essere rapito da delinquenti e diventare lui stesso un delinquente. E la parte irrimediabile di quella sofferenza, al di là dell' esorcismo che si conclude in "happy ending" e nella salvezza di Oliver, trova espressione simbolica nell'unico bambino dell'ospizio che Oliver saluti prima di partire e che cerca ancora quando infine ritorna al luogo natale, per apprendere che è morto: per questo, è una sorta di suo alter ego, e non a caso quel bimbo risponde al nome di Dick, abbreviando il cognome dello stesso Dickens. Ma naturalmente la qualità biografica non esaurisce il romanzo. Vanno considerati i tratti tipici che su di essa si innestano: basti accennare, ad esempio - per approfondire l'aspetto psicologico - a come nella definizione di orfano del protagonista, e del suo incontro con una serie di altri genitori sostitutivi, buoni o cattivi, trovi rispondenza un dato pressoché permanente della psiche infantile: quello di cui si occupano le favole, con le quali il linguaggio di Oliver Twist in parte coincide, finanche in quella che - ad un primo livello di lettura - è elementare contrapposizione di agenti del Bene e del Male (personaggi: Oliver/Monks, Brownlow/Fagin, Rose/Nancy; luoghi: casa/workhouse, Londra/ campagna; classi sociali: borghesia/proletariato delinquenziale). Oliver Twist va letto poi su un piano di attualità storica più precisa, sicché potremmo definirlo anche romanzo "impegnato ", come risulta evidente in particolare dai primi sette capitoli. In questi si presenta l'ambiente in cui nasce e viene educato Oliver, un ospizio di mendicità, contiguo ad una cittadina dell'Inghilterra che il narratore «s'astiene prudentemente dal menzionare». La anonima, e quindi tipizzata, città di provincia è mostrata come spazio applicativo di una legge di riforma sul lavoro, la disoccupazione, la povertà, collegata a una più ampia legislazione di riforma della società inglese, avviata nei primi anni Trenta col "Reform Act". Col "Reform Act" la classe politica inglese tenta di regolare i fenomeni sociali prodotti dal primo sviluppo industriale, affrontando in primo luogo il problema della rappresentanza politica in Parlamento e ridefinendo le circoscrizioni elettorali in modo da riconoscere il peso politico della borghesia, enormemente accresciuto rispetto a quello dell'aristocrazia. Come sua propaggine, il "Poor Law Amendment Act", promulgato nel 1835 (si vede, dalle date, come Dickens scrivesse "a caldo", quasi giornalisticamente), istituisce le workhouse, luoghi in cui confinare e contenere l'emarginazione sociale e regolare brutalmente il lavoro. Le ragioni istitutive, il concreto funzionamento delle workhouse sono oggetto di ampio dibattito sociale e parlamentare in quegli anni, e il punto di vista di Dickens non è rivoluzionario, che ambizione dello scrittore vittoriano è quella di identificarsi con il suo pubblico, di esserne il portavoce. Ma è il punto di vista di una critica radicale, e che ancor più radicale diventa nell' esser formulata non in termini astrattamente ideologici ma attraverso la scrittura letteraria: è qui che il dato storico, realistico, è poi trasceso nella dimensione simbolica: la workhouse, in cui la legge del profitto e dello sfruttamento è divenuta parola d'ordine di tutta la società, anticipa così lo spazio meccanizzato e statalizzato di Coketown che, nel successivo Hard Times, del 1854, si configura come nucleo originario della letteratura anti-utopica. Anche in tal senso, lo spazio-prologo della "workhouse" ha come suo presupposto quello dirigenziale-nazionale della metropoli. Difatti, la parte più consistente della narrazione, a partire dal capitolo ottavo, è ambientata a Londra (spazio canonico dickensiano fin dagli esordi di Sketches by Boz). È la Londra della vita malfamata, innanzi tutto, in cui continua l'atmosfera cupa dell'inizio del romanzo, e in cui il percorso di violenza sul bambino raggiunge il culmine. È la Londra dell'"East End", quella malfamata che si collega alla tradizione del cosiddetto "Newgate novel"; ma anche, e in subordine, quella del suo opposto, la Londra del "West End", alto-borghese e signorile. La metropoli vive in questa netta contrapposizione che sottintende in qualche modo la complementarità delle due parti. E se, secondo un criterio morale, viene dato rilievo alla seconda, è la prima ad essere più da vicino indagata, a catturare visceralmente l'attenzione, e ad essere, in definitiva, più credibile. Il dato simbolico si intreccia sempre con quello realistico. Dickens, del resto, conosce benissimo la metropoli, perché la esplora incessantemente, in lunghissime passeggiate, e a ritmi quasi da maratoneta, facendo tesoro di ogni angolo, di ogni strada, di ogni tipo umano o scena cui assista. Non sorprende perciò che il lettore abbia l'impressione di poter stendere una mappa della città a partire dal testo, e se la precisione con cui sono rappresentate le sue vie, le sue piazze, i suoi punti nodali e luoghi tipici, gli angoli e i vicoli più nascosti fa pensare al lavoro di un pionieristico cartografo o sociologo (pensiamo alla indagine di H. Mayhew sulla parte indigente della capitale: London Labour and the London Poor). Valga l'esempio di quando Oliver è condotto per la prima volta a Londra, guidato da Dodger, con un percorso non casuale ma che ricalca quello che si seguiva solitamente nell'Ottocento provenendo dal Nord-Est; percorso che comunque è qui graduato in funzione di una progressiva immissione nell'orrore della città (cap. VIII). Ma l'esempio ci fa afferrare forse un'altra cifra del senso di realtà che avvertiamo: il movimento. Diverse volte, innanzi tutto, percorriamo la città, come nel bellissimo episodio del pedinamento notturno di Nancy da parte di Noah Claypole, anticipatore delle atmosfere del romanzo poliziesco; o la spedizione notturna per compiere il furto a Chertsey, che segue all'attraversamento di buona parte della città (cap. XXI). E diverse volte ancora avvertiamo la città stessa come movimento, continua trasformazione spaziale e flusso sociale. In tal senso, la trasformazione della città è in primo luogo verso la decadenza in quanto il suo ipotetico sviluppo produce, come un'onda devastatrice, «desolazione e abbandono»: troviamo, ad esempio, l'edificio in cui riparano i ladri dopo la fuga dal nascondiglio iniziale (una dimora nobiliare, prima di diventare covo); la zona, e il capannone industriale dismesso, in cui Monks incontra i coniugi Bumble per farsi consegnare e distruggere le prove dell'identità di Oliver (cap. XXXVIII); o Jacob 's Island (cap. L) teatro della morte di Sikes. Questo spazio in movimento ci immette in un tempo corrispondente: un tempo storicamente preciso, datato e attuale (Dickens ha perfino legami di parentela con Walter Scott, iniziatore del romanzo storico) che è però, soprattutto, un tempo di trasformazione continua, della società e delle leggi che la regolano, dei modi di vita e dei bisogni. Così, se la "Poor Law" rimanda a un recente ordine preesistente, quando la parrocchia si occupava più umanamente di povertà, disoccupazione ed emarginazione, essa sottintende anche la necessità di un futuro in cui si ponga rimedio alle ipocrisie e alla inumanità di questo sistema - frutto tipico del cosiddetto "compromesso " vittoriano - violentemente denunciate in queste pagine. In ciò, anche, è la dimensione tipicamente moderna di Oliver Twist. Secondo criteri estetici a noi più vicini, è consuetudine scorgere limiti nella caratterizzazione dickensiana in termini di sviluppo psicologico del personaggio. In questa ottica diversi personaggi in Oliver Twist risulterebbero "piatti", non "a tutto tondo" (secondo la distinzione di E.M. Forster in Aspects of the Novel). Ma è più utile ammettere che il genere "romanzo " consente diversi modi di caratterizzare. Oliver, ad esempio, è per alcuni aspetti piuttosto evanescente, conservando inalterata la sua natura incorrotta dall'inizio alla fine e reagendo relativamente poco con l'ambiente: è soprattutto il filo che tiene insieme i diversi episodi narrativi. Eppure, impone una prospettiva di giudizio straniata sulla società, criticamente efficace proprio perché ingenua e radicale allo stesso tempo. Oliver è poi una sorta di allegoria, è un principio di Innocenza e di Bene: rappresenta la possibilità del riscatto per una società, e forse per una Storia, che il romanzo ci fa scorgere quasi caduti. E infatti persino per il criminale Fagin, al quale sembra preclusa ogni possibilità di allontanarsi dalla sua vita malvagia, Oliver costituisce qualcosa di troppo sacro perché egli, vedendolo addormentato, non differisca l'esecuzione del suo disegno corruttore su di lui (cap. XIX); o perché non lo senta come ultima, allucinata speranza di scampare all'impiccagione. In tal senso, Dickens rende umanamente credibile questo personaggio, accreditandolo d'una pur minima capacità di ravvedimento: quasi nel momento stesso in cui fa riconoscere a Fagin che proprio Oliver è stato causa di tutta la rovina della banda, fa che proprio a lui egli si aggrappi per uscire dalla prigione, e solo a lui confessi una parte del male commesso rivelandogli il nascondiglio che prova la sua identità e i suoi autentici natali. Dei personaggi che si legano ai suoi primi anni, Bumble e Mrs Mann sono quelli più memorabili. Da "singoli ", il primo è identificato con le proprie insegne di Custode parrocchiale, nel ruolo sociale e di potere sul mondo chiuso dell'ospizio; la seconda è esempio della grettezza nella ricerca del profitto, esperta di come ridurre al minimo la dieta dei bambini dell'asilo per massimizzare il proprio guadagno. Sono esempi di come il personaggio è tanto più memorabile quanto più è semplice, osservato sempre dall' esterno e sempre uguale a se stesso. Dickens tuttavia ha suoi peculiari modi per approfondire la caratterizzazione, e per presentare i suoi personaggi non come figurine ritagliabili isolatamente ma come soggetti dialettizzati. Ecco quindi, pur nella fondamentale staticità del carattere dei personaggi, l'importanza assegnata ai momenti di crisi e di profonda trasformazione. Si veda, ad esempio, il fidanzamento di queste due anime gemelle, in coincidenza del quale Bumble, lasciato solo in casa Mann, si mette a perquisire ed esaminare minuziosamente tutte le proprietà della vedova pregustandone l'imminente possesso, e poi compie un solitario balletto che ne esprime tutta la sterile, ineffabile felicità (cap. XXVII). Un secondo momento di crisi è quando si decide della gerarchia, della dominanza e sottomissione nel rapporto matrimoniale: la scena è costruita sulla netta percezione che quello, e non altri, è il momento decisivo per tutto il futuro dei loro rapporti. Mrs Bumble ne è perfettamente consapevole; e fa ricorso a tutte le sue risorse per capovolgere una situazione che la vede sconfitta finché fa assegnamento sulle lacrime. Fin lì, infatti, Bumble la incoraggia piuttosto, raccomandandole il pianto perché: «Dilata i polmoni, idrata l'incarnato, spurga gli occhi, e molcisce il carattere, [...] Perciò, piangete pure (cap. XXXVII). Ma da questo ammonimento la ex vedova capisce di doversi volgere alla più aggressiva, e vincente, strategia di riserva (cap. XXXVII). Un terzo, nel ripudio di Bumble; un quarto, e ultimo, quando reclusi nell'ospizio, egli non sa ormai gioire nemmeno nell'essere separato da lei. Bumble e Mrs Mann sono una prima, fondamentale illustrazione del principio che un uomo o una donna non sono mai conosciuti a pieno se non se ne conosce la loro "metà ". Sono inoltre la fondamentale illustrazione di un interesse per la coppia in quanto micro-struttura sociale. All'interno di questa e altre coppie si vedono infatti all'opera avidità, sopraffazioni, angherie e rivalse sul più debole che caratterizzano anche la società nel suo complesso. Un 'altra coppia, più giovane ma non dissimile dalla prima nel suo antiromanticismo, è quella formata dal garzone di bottega Noah Claypole e dalla cameriera Charlotte; di nuovo, l'attaccamento tra i due risponde a tutt'altro che a sentimenti amorosi: Noah che, in quanto povero della parrocchia, subisce come Oliver le angherie del mondo, col matrimonio si trasforma, e trova nel rapporto di coppia la possibilità di rivalsa che ha vanamente cercata anche nei confronti di Oliver. Charlotte trova nel rapporto una soddisfazione alla sua dominante masochistica, espressa inizialmente con la soddisfazione vicaria che prova nutrendo e ingozzando Noah (le ostriche denunciano chiaramente anche la vittoriana equivalenza sessuale), e poi col pesante fardello che è costretta a portare invece del marito nella loro fuga a Londra. Nella metropoli, infine, le forme dello sfruttamento e dell'abuso della moglie da parte di Noah raggiungono il picco di malvagità e perversione. Sia Bumble che Noah, all'occasione, sono pronti a scaricare sulle consorti le proprie responsabilità maritali (amplificando il paradigma già accennato di inadeguato rapporto genitori-figli), per sfuggire alla punizione dei loro crimini. Diverso è il caso della coppia Sikes-Nancy. Pur nella sordidezza della loro vita, una passione autentica - se non proprio amore - è percepibile, e proprio per questo gli stessi personaggi sembrano uscire dalla prevalente staticità o convenzionalità della caratterizzazione per assumere proporzioni umane. Nancy, in alcune scene messa teatralmente di fronte al suo contrappunto sociale e morale, la borghese e pura Rose, spiega plausibilmente le ragioni della fedeltà e passione per il furfante Sikes, e perché ella sia disposta a rifiutare la prospettiva di redenzione che Rose e Brownlow le offrono: è la stupenda, cupa scena notturna, sul London Bridge, e sulle scalinate che conducono al fiume. Cruciale, nel caso di Nancy, la crisi che l'innocenza di Oliver porta alla sua vita perduta (emerge, ad esempio, una dimensione di memoria sconosciuta ad altri, quando ella ricostruisce e rinfaccia a Fagin il modo in cui è stata trascinata e incatenata nella propria condizione fin da bambina), anche se tale molla di redenzione può portarla non a cambiare la propria vita, ma soltanto ad avvertirla conflittuale, e infine ad espiarla con la morte. Sikes non ha tentennamenti di questo tipo, né mai si volge al suo passato. La profondità psicologica nel personaggio emerge però nel momento in cui, saputo del tradimento di Nancy, le pur malvagie certezze della sua vita sono sconvolte, ed è travolto dal furore omicida. Con lui, proviamo l'orrore del suo ultimo crimine mentre invece, rispetto ai precedenti, Sikes è sempre presentato privo di tentennamenti, ed emblema stesso della decisione e della coraggiosa irruenza. Seguiamo gli stati di allucinazione e di follia da esso prodotti, nel protrarsi della sua fuga e della caccia che gli viene data a Londra e nella campagna circostante, fino alla tremenda punizione che si procaccia da se stesso. Non è un caso se tali scene rimandano addirittura ad un modello shakespeariano: al Macbeth, per l'orrore e la follia che seguono all'assassinio, compresa l'allucinazione del sangue o degli onnipresenti occhi della vittima; e all'Othello, per come Sikes si lascia accecare da Fagin e indurre alla sua gelosia omicida; e non è un caso se queste scene, astratte dal loro contesto narrativo, diventino uno dei testi fondamentali nelle letture pubbliche in cui Dickens si produce nell'ultima parte della sua carriera, e abbiano un intenso effetto drammatico: se dal lato del pubblico si registravano persino svenimenti, da parte di Dickens il coinvolgimento negli "spettacoli " di lettura era tale da avere conseguenze deleterie su una salute già compromessa; sicché, sembra, esse hanno contribuito ad anticiparne la morte. Il cane di Sikes acquista dimensione di personaggio a sé stante, a testimonianza della capacità di Dickens di cogliere e stabilire una contiguità tra mondo umano e animale. La discriminante linguistica tra uomo e animale viene così eliminata, e Occhiodibove può esprimersi allo stesso modo degli altri personaggi; può intuire, e intendere, più chiaramente di loro (si pensi ancora una volta a Hard Times, alla stupenda creazione del cane Zampeallegre). Viceversa, Sikes metamorfizza spesso l'aspetto e il comportamento della bestia, come quando, inseguito da altri cani, vorrebbe avere il tempo di trovarsi in mezzo a loro, per sbranarli. Dato questo simultaneo avvicinamento, perciò, anche tra cane e padrone si dà una sorta di passionale, tragico amore, che fa da contrappunto al rapporto SikesNancy. Sikes tenta infine di ucciderlo perché pensa che potrebbe, seppure involontariamente, tradirlo. Ma Occhiodibove, a differenza di Nancy, si sottrae all'uccisione e diviene effettivamente agente della cattura di Sikes; il quale incontra, per contrappasso, una morte simile a quella che voleva riservare all'animale, una sorta di impiccagione e di annegamento insieme - e il parallelismo è sottolineato dal successivo suicidio dell'animale. Fagin (ispirato all'allora celebre ebreo e ladro Ikey Solomon) è un'altra, straordinaria creatura del romanzo, nei suoi tratti persino paradossali di pusillanime genio del male e di capo di una banda la cui principale attività sembra quella di rubare fazzoletti. Da un lato, le colpe virtuali di cui è disposto a macchiarsi (la soddisfazione di sapere che i suoi complici sono stati giustiziati e non possono più chiedere bottino da spartire né essere delatori nei suoi confronti, il suo compiaciuto contemplare la possibilità di essere delatore e mandare cinicamente a morte i suoi complici) sono tali da far inorridire, e da far considerare ben meritata la tremenda punizione del patibolo che subisce, e parzialmente nel giusto la critica lo ha inteso come una sorta di incarnazione diabolica; dall'altro, nei crimini in cui lo vediamo impegnato "in diretta ", e 'è una sorta di innocenza infantile-senile, che denuncia forse, anche nei suoi confronti, l'irresponsabilità della società nel suo complesso. Questo si intuisce in altri lati paradossali, giacché da un lato egli è per Oliver il cattivo padre, dal momento che vuole corromperlo e irretirlo nel crimine; dall'altro però, lo accoglie in una sorta di comunità, le cui regole di solidarietà sono ironicamente illustrate nel successivo adescamento di Noah Claypole. Due illustrazioni di Phiz - evidentemente collegate, centrate sul motivo del cibo - sottolineano questo secondo aspetto di Fagin: alla prima, in cui Oliver, in nome di tutti gli affamati ragazzi dell'ospizio, chiede un'altra scodella di brodaglia, provocando un'onda di reazione inorridita in tutto l"'establishment", corrisponde una seconda, che mostra Fagin con le braccia aperte, il sorrisoghigno e le salsicce liberalmente offerte a Oliver, allorché Dodger lo conduce per la prima volta nel covo dei ladri. Non è forse un caso se con Fagin vediamo Oliver ridere per la prima volta in vita sua. Accade quando Fagin e gli altri ragazzi, per istruire Oliver su come rubare fazzoletti, simulano la situazione del furto e si producono in una sorta di teatro satirico, uno spettacolo muto a beneficio di Oliver e loro proprio, in cui appare ridicolizzato il prototipo dell'uomo borghese; per i ladri - per questo negletto e rimosso sottobosco sociale - è l'unica rivalsa per la condizione di ingiustizia subita, e a nome di Dickens trasmettono questo sentimento al lettore. Prima che il senso morale prevalga, prima che la nostra attenzione sia indirizzata alla bontà, alla rettitudine, all'agio e alla tranquillità del borghese Brownlow, il romanzo lo presenta quasi esattamente negli stessi termini in cui, in astratto, lo ha già impersonato Fagin. L'illustrazione di Phiz, nella scena in cui Brownlow subisce il furto da parte di Dodger e Bates, lo coglie fermo alla bancarella di libri, perso nella lettura e cieco alla realtà che gli è intorno; coglie benissimo questo sottile battesimo di ridicolo per il Deus ex machina di tutto l'intreccio. In questi termini il romanzo rivela un palinsesto critico perfino rispetto a quella borghesia filantropa e illuminata che impone infine il suo ordine a conclusione del romanzo e si riappropria di Oliver. Vale la pena perciò sottolineare ancora la qualità teatrale della narrativa dickensiana, da un lato per raccoglierne la grande capacità di caratterizzare attraverso il linguaggio (si noti ad esempio il gioco comico del contrasto tra un codice di inglese standard e il gergo della malavita, su cui Dickens è accuratamente documentato) o, ugualmente importante, il gesto; dall'altro, per raccogliere la chiave critico-satirica cui si accennava in rapporto a Fagin, in diverse altre "scene ": la pantomima e il balletto di Bumble; il travestimento di Nancy da virtuosa sorella di Oliver quando si reca alla stazione di polizia per averne notizie; la sua scena quando, insieme a Sikes, incontra casualmente Oliver per strada; i tanti travestimenti di Noah Claypole (si finge vittima quando è sconfitto dall'indignazione e dalla rabbia del piccolo Oliver; si finge Morris Bolter per ingannare Fagin; si traveste per pedinare Nancy, o per avere notizie di Dodger). Persino l'aula di tribunale è interpretata come teatro tragico nel processo di Fagin; o trasformata in teatro comico nel caso del processo di Dodger, quando la esilarante esibizione di questo, oltre a costituirsi in sottile accusa contro l'apparato di giustizia scimmiottandone le forme, guadagna definitivamente a lui la nostra simpatia di lettori, simile a quella che suscitò nei lettori vittoriani i quali - veri e propri soggetti di un rapporto interattivo con l'autore poterono ancora chiedere "dipiù", ansiosi che la condanna in tribunale non coincidesse con la fine narrativa del personaggio. E teatrale è Monks sebbene in un senso ancora diverso: è uno dei personaggi da puro melodramma presenti in questo romanzo, nel quale anche il dosaggio di alternanza tra comico e tragico è consapevolmente difeso da Dickens sia in termini melodrammatici sia di aderenza al reale, come può leggersi in apertura del capitolo XVII: «È consuetudine del teatro, in tutti i buoni melodrammi con tanto di assassini, presentare scene tragiche e comiche in regolare alternanza, come gli strati bianchi e rossi in un pezzo di pancetta magra ben stagionata». Monks è il villain spregevole, il medievale Vice. È il cattivo senza compromessi, fratellastro e alter ego morale di Oliver, che trama nel buio (tanta parte del romanzo si svolge di notte, o in cupi ambienti chiusi, come il Macbeth: si veda ad esempio l'episodio da puro gotico, sebbene ambientato nelle rovine non di un castello ma di un edificio industriale, di quando incontra i coniugi Bumble per disfarsi delle prove dell'identità di Oliver, con tanto di botola e di baratro sui gorghi di un fiume); è una creatura così stilizzata nel segno del male, che questo erompe in maschera, sul viso, in una serie di segni corporei e nelle crisi epilettiche di cui è vittima. A Monks fa capo tutto il lato tenebroso legato alla ricca famiglia a cui il padre di Oliver è stato sacrificato in un matrimonio di interesse: a lui fa capo il lato più implausibile della trama di Oliver Twist quale possiamo seguire nella complicata ricostruzione che ne dà Brownlow in due distinti capitoli (XLIX e LI). Emergono in essi i dolorosi intrecci conseguenti a relazioni matrimoniali sbagliate - sicché si amplia il paradigma della disarmonia dei vari nuclei familiari, specchio della disarmonia dell'organismo sociale più ampio. Ciò che domina la complicata ricostruzione, e che ne costituisce l'aspetto più chiaro, è che il denaro si conferma la forza motrice di tutto, benché appaia nella forma arcaicizzante di ricchezza patrimoniale, trasmessa, aggregata o divisa, attraverso matrimoni e testamenti. Nei capitoli conclusivi un'altra cifra dell'Oliver Twist emerge, ancora sull'ampio sfondo paradigmatico di relazioni distorte. È il romanzo d'amore tra Rose e Harry Maylie che, nell'unione matrimoniale in cui sfocia, sembra riscattare tutti gli altri fallimenti. Ciò è tanto più vero in quanto è minacciato dalle stesse disparità di classe che hanno prodotto disastri nel passato familiare di Oliver. In tal senso la vera forza equilibratrice è quella di Rose (Dickens idealizza in lei la profondamente amata sorella della moglie, prematuramente morta all'età di tredici anni), contro l'irruenza giovanile di Harry che vorrebbe sposarla a dispetto dell'oscurità di nascita di lei. È Rose che, pur di non pregiudicarne le aspettative sociali, rifiuta l'amore del giovane; è lei che, per poter ricambiare quell'amore, attende il pieno disvelamento di una colpa sì non sua, ma consapevolmente accettata come peccato originale; è lei che implicitamente guida Harry a mutare le sue aspettative e la sua collocazione di classe, sicché il giovane, in un anno di apprendistato, rinuncia ad un percorso di ambizione sociale per assumere un ruolo di umile servizio nella società. In tal senso, alla trama amorosa, si associa la "formazione", la Bildung dei protagonisti. Harry deve disilludersi dalla presunzione, classista e sessista insieme, di poter cancellare il passato e la collocazione sociale di Rose semplicemente collocandola nella sua orbita; Rose si mortifica in una dolorosa rinuncia per non pregiudicare la possibilità di un rapporto non contaminato da sospetti di interesse. Non solo altri matrimoni, ma la società intera, paiono trovare riscatto in questa unione. Attorno ai due giovani si costruisce infatti un nucleo sociale più ampio che raduna la fascia signorile e di media borghesia del romanzo: Oliver, Brownlow, Grimwig, Losberne, May lie e relativi entourage domestici. L'armonia assoluta di questa società paga però un alto prezzo di credibilità nel suo collocarsi quasi fuori dal mondo, nel non intaccare minimamente il disordine di quanto è al di fuori dei suoi angusti confini. Diviene evidente allora anche la struttura spaziale di Oliver Twist, coincidente con le tre grandi partizioni del romanzo: il prologo in una provincia anonima e tipizzata; l'ampio corpo centrale occupato da Londra in tutte le sue ramificazioni periferiche; e infine il ritorno alla provincia, nella sua duplice accezione. C'è infatti da un lato il ritorno circolare al luogo natio di Oliver, compreso il viaggio che egli compie a ritroso rispetto al suo percorso di fuga; dall'altro, il ritorno ad una provincia, anonima come la precedente, che si costituisce come luogo del rinnovamento, in opposizione tanto alla metropoli quanto al mondo della workhouse. È questo il luogo dell'idillio, dove una nuova microsocietà può vivere e prosperare in armonia, ripulita del crimine ed emendata di colpe, ma definitivamente separata dal resto del mondo, espressione di quella visione manichea della realtà che da molti è stata riconosciuta nello scrittore vittoriano. È un luogo che corrisponde all'isolamento del celibe Brownlow, il quale, in conclusione, tira le fila della trama romanzesca, giudice supremo di una giustizia a tratti complementare, a tratti significativamente distinta, da quella esercitata in nome del meccanico ordine statuale. MARIO MARTINO 1 Per quanto riguarda il testo del romanzo abbiamo la prima versione apparsa settimanalmente sulla «Bentley's Miscellany» (2/37-4/39) pubblicata anche in tre volumi nel novembre del 1838; una seconda edizione è del '39; una terza edizione rivista è del 1846, pubblicata sia in dieci fascicoli mensili che in volume unico. La presente traduzione fa riferimento al testo del 1846 (a cura di Fred Kaplan, New York, Norton, 1993). Capitolo I. Tratta di dove nacque Oliver Twist e delle circostanze relative alla sua nascita Tra gli altri edifici pubblici di una certa cittadina, che per diverse ragioni sarà per me prudente astenermi dal menzionare e alla quale neanche assegnerò un nome fittizio, ve n'è uno familiare un tempo alla maggior parte delle città, grandi o piccole che fossero, e cioè un ospizio di mendicità. E in questo ospizio, in un certo giorno, mese e anno che non devo darmi pena di precisare, giacché il conoscerli non potrà riuscire di alcuna utilità al lettore - per lo meno allo stato attuale delle cose - nacque l'articolo di mortalità il cui nome compare nel titolo di questo capitolo. Per parecchio tempo, dopo che fu introdotto in questo mondo di dolore e sofferenza dal medico della parrocchia, si dubitò fortemente che il bambino sarebbe sopravvissuto per portare un nome qualsiasi; nel qual caso, è più che probabile che queste memorie non avrebbero mai visto la luce; o che, vedendola, e ridotte a poche pagine soltanto, avrebbero avuto l'inestimabile pregio di essere l'esempio di biografia più fedele e concisa nella letteratura di ogni età o paese. Sebbene io non intenda affatto sostenere che nascere in un ospizio costituisca di per sé la più fortunata e invidiabile circostanza che possa capitare ad un essere umano, affermo però che in questa particolare circostanza nulla di meglio sarebbe potuto capitare al giovane Oliver Twist. Fatto si è che vi furono notevoli difficoltà nell'indurre Oliver ad assumersi in prima persona l'incarico di respirare - gravoso esercizio, certo, ma che l'abitudine ha reso necessario al conforto della nostra esistenza - e per qualche tempo egli giacque annaspando su di un materasso di stracci, pericolosamente in bilico tra questo mondo e quell'altro, ma con la bilancia che pendeva decisamente verso il secondo. Ora, se in questo lasso di tempo Oliver fosse stato circondato da nonne premurose, da zie solerti, da infermiere esperte, e da dottori di profonda saggezza, senza dubbio alcuno ci avrebbe lasciato le penne in men che non si dica. Ma altri non trovandosi nei paraggi se non una povera vecchia, intontita da un'insolita dose di birra e, per dovere d'uffico, il medico della parrocchia, Oliver e la Natura sistemarono la questione tra loro due e il risultato fu che Oliver, dopo alcuni tentativi, respirò e starnutì, e passò poi a rendere edotti quelli dell'ospizio della circostanza che un nuovo fardello veniva a gravare sulla parrocchia col cacciare uno strillo così acuto quale mai ci si sarebbe ragionevolmente potuti attendere da un bambino di sesso maschile, dotato di quell'utilissimo attributo che è la voce da non più di tre minuti e un quarto. Mentre Oliver dava questa prima prova del libero e spontaneo funzionamento dei propri polmoni, la coperta rappezzata gettata negligentemente sul letto di ferro si smosse, il pallido viso d'una giovane si sollevò debolmente dal cuscino e una voce estenuata articolò imperfettamente le parole: «Lasciatemi vedere il bambino e poi morire». Il medico, che era rimasto seduto rivolto al fuoco e a turno si scaldava e fregava le mani, alle parole della giovane s'alzò e avvicinandosi a capo del letto disse, con più gentilezza di quanta ci si sarebbe potuta attendere da lui: «Oh! Non dovete parlare di morte, adesso». «Che Dio la benedica, no!», interloquì la vecchia infermiera, riponendo frettolosamente in tasca una bottiglia di vetro verde, del cui contenuto aveva gustato con evidente soddisfazione, in un angolo. «Che Dio la benedica, quando avrà campato come me, signore, e avrà avuto tredici figli - tutti morti tranne due, che sono rimasti con me nell'ospizio - non vedrà le cose allo stesso modo, che Dio la benedica! Pensa soltanto a cosa significa essere madre, agnellino mio!». Ma evidentemente questa consolante prospettiva sul suo futuro di madre non produsse l'effetto sperato. L'inferma scosse la testa e protese la mano verso il bambino. Il medico glielo pose in braccio. Appassionatamente, lei impresse le sue labbra fredde e bianche sulla fronte della creatura, si passò le mani sul volto, girò intorno uno sguardo angosciato, rabbrividì, ricadde giù e mori. Le massaggiarono il petto, le mani e le tempie; ma il suo sangue aveva cessato di fluire per sempre. Le mormorarono parole di consolazione e speranza, ma troppo a lungo le erano rimaste estranee. «Non c'è più niente da fare, signora Thingummy!», disse infine il medico. «Ah, povera cara. Non c'è più niente da fare!», assentì la vecchia infermiera, raccogliendo il tappo della bottiglia verde che le era caduto sul cuscino quando s'era chinata per riprendere il bambino. «Povero piccino!». «Non c'è bisogno che mi mandiate a chiamare se il bambino strilla, infermiera», disse il medico infilandosi con cura i guanti. «Darà un bel po' di fastidi, con tutta probabilità. In tal caso, dategli un po' di farinata». Indossò il cappello, e fermatosi accanto al letto mentre si avviava alla porta aggiunse: «Era anche una bella ragazza! Da dove veniva?» «L'hanno portata qui la notte passata per ordine del sorvegliante», rispose la vecchia. «È stata trovata stesa per strada. Doveva aver camminato parecchio, dato che le sue scarpe erano tutte rotte e logore, ma da dove veniva o dove andava, nessuno lo sa». Il medico si chinò sul corpo e sollevò il braccio sinistro. «La vecchia storia», disse scuotendo la testa: «niente fede al dito, a quanto vedo. Ah! Buona notte!». Il signor dottore se ne andò alla sua cena, e la vecchia, tirato qualche altro sorso dalla bottiglia verde, sedette su una seggiolina accanto al fuoco e procedette alla vestizione del bimbo. E che stupendo esempio della potenza dell'abito era il piccolo Oliver Twist! Avvolto nella coperta che fino ad allora aveva costituito il suo unico indumento, sarebbe potuto essere tanto il figlio di signori altolocati quanto di pezzenti, e anche il più arrogante, vedendolo per la prima volta, avrebbe avuto difficoltà ad attribuirgli un posto nella società. Ma ora, avvolto in una tela di cotone leggero, diventata gialla per quell'uso ripetuto, egli era etichettato e marchiato, ed era immediatamente collocato al suo posto: un poverello in carico alla parrocchia, un orfano per l'ospizio - l'umile e denutrito essere da fatica - spinto nel mondo a suon di ceffoni e sberle, da tutti disprezzato e da nessuno compatito. Oliver strillava a pieni polmoni. E se avesse saputo di essere un orfano, lasciato alle tenere cure dei custodi e dei sorveglianti della parrocchia, avrebbe forse strillato ancor più forte. Capitolo II. Tratta della crescita di Oliver Twist, della sua educazione, e di dove è alloggiato Per gli otto o dieci mesi seguenti Oliver fu vittima di una sistematica frode e inganno. Gli veniva dato pane e acqua. Le autorità dell'ospizio comunicarono puntualmente alle autorità parrocchiali la condizione di denutrizione e di abbandono dell'orfanello. Le autorità parrocchiali chiesero dignitosamente alle autorità dell'ospizio se in quella casa non si trovasse una qualche donna in grado di somministrare a Oliver Twist il conforto e il nutrimento di cui aveva bisogno. Le autorità dell'ospizio risposero umilmente che non c'era. Al che, le autorità parrocchiali, nella loro magnanimità e umanità, stabilirono che Oliver dovesse andare "in grangia", cioè, in altri termini, che lo si dovesse spedire in una sorta di asilo, a circa tre miglia di distanza, dove una ventina o trentina di giovani trasgressori della legge sui poveri si rotolavano per terra tutto il giorno, senza il gravame di troppo cibo o troppi indumenti, sotto la materna supervisione di un'anziana donna, disposta ad accogliere i trasgressori per un compenso in ragione di sette pence e mezzo a testa, a settimana. L'equivalente di sette pence e mezzo sarebbe pur sempre una bella dieta per un bambino; con quella cifra si potrebbero comprare un sacco di cose, da sovraccaricargli e imbarazzargli lo stomaco. L'anziana donna era persona saggia e d'esperienza; sapeva cosa andava bene per i bambini e aveva una nozione molto precisa di cosa andava bene per lei, sì che ella incamerava la maggior parte della dotazione settimanale per il proprio uso e consumo, lasciando alla gioventù della parrocchia in crescita una dotazione ancora più scarsa di quella ad essa assegnata in origine. Trovava in tal modo, in un già profondo abisso di miseria, un abisso ancora più fondo, e dimostrava con ciò una profonda filosofia sperimentale. Tutti conoscono la storia di quell'altro filosofo pratico il quale elaborò la teoria che un cavallo potesse vivere anche senza mangiare, e tanto bene la mise in pratica da giungere a nutrirlo con un solo filo di fieno al giorno e l'avrebbe reso senza alcun dubbio un animale di focosi spiriti non dandogli niente affatto, se quello non fosse morto anzitempo non più di ventiquattr'ore prima di ricevere la sua prima buona razione di aria fresca. Purtroppo per la filosofia sperimentale della donna alle cui sollecite cure era stato consegnato Oliver Twist, l'applicazione del di lei sistema sortiva di solito un simile effetto, giacché proprio quando si riusciva a fare in modo che un bambino si sostenesse con una ridottissima razione d'un cibo già di per sé quasi privo di sostanza, in otto casi e mezzo su dieci si dava il caso perverso che o quel bambino si ammalasse per gli stenti e il freddo, o cadesse nel fuoco per disattenzione o, per un incidente qualsiasi, restasse pressoché soffocato. In ciascuno di questi casi il piccolo infelice veniva di solito chiamato all'altro mondo, dove si riuniva a quei padri che non gli era stato dato di conoscere in questo. Ogni tanto, quando si apriva una inchiesta più interessante del solito su un bambino della parrocchia negligentemente fatto ruzzolare a terra nel rifare un letto, o inavvertitamente ustionato a morte quando capitava che si facesse il bucato (incidente rarissimo, questo, poiché raramente si faceva qualcosa che assomigliasse a un bucato nell'asilo), la giuria si piccava di porre domande imbarazzanti, oppure i parrocchiani esagitati apponevano la loro firma in calce a documenti di protesta. Impertinenze del genere, però, venivano facilmente neutralizzate dalle testimonianze del medico e del custode: il primo aveva immancabilmente aperto il cadavere senza trovarvi nulla (cosa, in effetti, probabilissima) e il secondo giurava immancabilmente qualsiasi cosa la parrocchia volesse, con assoluta devozione. La Direzione, inoltre, si recava in periodici pellegrinaggi all'asilo mandando sempre il custode il giorno innanzi per avvisare della visita. Quando arrivava, quindi, i bambini erano puliti e lindi; e cos'altro si pretendeva di più! Non ci si può attendere, naturalmente, che questo sistema di asilo dia frutti copiosi e belli. Il giorno del nono compleanno vide un Oliver Twist pallido e smagrito, di statura piuttosto bassa e decisamente scarso di circonferenza. Ma la natura o i caratteri ereditari avevano impiantato in petto a Oliver uno spirito saldo. Questo godeva di ampio spazio per espandersi grazie alla dieta risicata osservata tra quelle mura; e a tale circostanza si deve forse che Oliver fosse giunto a quel compleanno. Comunque, sia come sia, ricorreva il suo nono compleanno, ed egli lo festeggiava nel deposito del carbone, nella scelta compagnia di due altri ragazzi i quali, dopo aver con lui condiviso una buona dose di legnate, erano stati rinchiusi là dentro per aver manifestato una fame incontenibile. Fu in tali frangenti che la signora Mann, la buona sovrintendente di quella casa, trasalì per l'improvvisa apparizione del signor Bumble, il custode, che scuoteva il cancelletto del giardino per aprirlo. «Bontà divina! Siete voi, signor Bumble?», disse la signora Mann affacciandosi dalla finestra con ben simulata estasi di gioia. «(Presto, Susan, porta Oliver e quegli altri due monelli di sopra e lavali). Cuor mio diletto! Signor Bumble, come sono felice di vedervi, davvero!». Ma il signor Bumble era grasso e collerico; sì che, invece di rispondere a quel caldo saluto in eguale spirito, strattonò con violenza il cancelletto e vi assestò poi un tale calcio quale soltanto la gamba di un custode avrebbe potuto sferrare. «Oh Signore! E dire», esclamò la signora Mann precipitandosi fuori, dato che nel frattempo i tre ragazzi erano stati portati via, «e dire che mi sono completamente dimenticata che il cancelletto era chiuso dall'interno a cagione dei nostri cari ragazzi! Entrate, signore; entrate, vi prego, signor Bumble!». Ma sebbene l'invito fosse accompagnato da una riverenza che avrebbe potuto intenerire il cuore di un sagrestano, nulla potè per intenerire il custode. «Dite, signora Mann», domandò il signor Bumble stringendo il suo bastone, «vi pare condotta rispettosa o adeguata quella di far attendere al vostro cancelletto i funzionari parrocchiali che vengono in veste ufficiale, riguardo agli orfani della parrocchia? Vi rendete conto, signora Mann, d'essere voi stessa dipendente, se così posso esprimermi, e salariata della parrocchia?» «V'assicuro, signor Bumble! Stavo solo dicendo a uno o due di quei cari ragazzi a voi tanto affezionati che stavate venendo proprio voi», replicò la signora Mann con grande umiltà. Il signor Bumble aveva un alto concetto delle sue abilità oratorie e della sua importanza, e avendo profuso le prime e ribadito la seconda, s'addolcì. «Bene, bene, signora Mann», replicò in tono più calmo; «sarà come dite voi; sarà come dite voi. Fate strada, signora Mann, perché vengo in veste ufficiale, e ho qualcosa da dirvi». La signora Mann condusse il custode in un salottino col pavimento in mattoni, gli sistemò una sedia e con ogni premura depose il cappello a tricorno e il bastone su un tavolo innanzi a lui. Il signor Bumble si deterse il sudore della lunga camminata dalla fronte, rimirò compiaciuto il cappello e sorrise. Sorrise, sì. Dopo tutto, anche le guardie sono uomini: e il signor Bumble sorrise. «Ora, non ve la prendete per ciò che sto per dirvi», osservò la signora Mann con affabile dolcezza. «Avete fatto una camminata piuttosto lunga, altrimenti neanche mi permetterei: non gradireste un goccetto di cordiale, signor Bumble?» «Neanche un goccio; neanche un goccio», rispose il signor Bumble con un ampio movimento dignitoso e placido della mano destra. «Ma certo che gradite», ribatté la signora Mann, che aveva percepito sia il tono del rifiuto sia il peculiare gesto che l'aveva accompagnato. «Giusto un goccetto, con un poco d'acqua fredda e una zolletta di zucchero». Il signor Bumble tossì. «Su, solo un goccetto», ripetè persuasiva la signora Mann. «Che cos'è?», chiese il custode. «Ecco, mi tocca tenerne un po' in casa per poterlo aggiungere alla medicina dei bambini quando stanno poco bene, signor Bumble», replicò la signora Mann aprendo lo stipo d'angolo e prendendone una bottiglia e un bicchiere. «È gin. Non voglio mentirvi, signor Bumble. È gin». «E ai bambini date questa medicina, signora Mann?», chiese Bumble seguendo con occhi interessati la preparazione della miscela. «Ah, benedetti loro! Gliela do, anche se costa caro», ribatté la direttrice. «Sapete, signore; non ho cuore di vedermeli soffrire davanti agli occhi». «No», disse il signor Bumble assentendo; «no, non avete cuore. Siete una persona umana, signora Mann (al che ella posa il bicchiere). Alla prima occasione ne accennerò alla Direzione, signora Mann (lui lo avvicina). Il vostro sentimento è quello di una madre, signora Mann (mescola il gin con l'acqua). Bevo lietamente alla vostra salute, signora Mann» e ne ingolla d'un fiato mezzo bicchiere. «E ora veniamo agli affari», disse il custode estraendo un taccuino di pelle. «Oliver Twist, il bambino battezzato a mezzo1, oggi fa nove anni». «Dio lo benedica!», interloquì la signora Mann fregando con vigore l'occhio sinistro con un lembo del suo grembiule. «Non è bastato offrire una ricompensa di dieci sterline, poi elevata a venti sterline; e a dispetto degli sforzi superlativi e, se così posso dire, soprannaturali, da parte di questa parrocchia», disse Bumble, «non siamo riusciti a scoprire né chi fosse il padre, né dove vivesse la madre, né come si chiamasse, né di qual condizione fosse». La signora Mann alzò le mani come stupefatta; ma dopo un attimo di riflessione aggiunse: «E allora com'è che ha un nome?». Il custode, tutto impettito, affermò orgogliosamente: «L'ho inventato io». «Voi, signor Bumble?» «Io, signora Mann. Ai nostri trovatelli diamo un nome seguendo l'ordine alfabetico. L'ultimo era una S - e lo nominai Swubble. Questo era una T- e lo nominai Twist. Il prossimo che viene sarà Unwin, e il prossimo ancora Vilkins. Ci ho nomi beli'e pronti fino alla fine dell'alfabeto e poi anche per ricominciare daccapo quando arriviamo alla Z». «Dico, siete un vero poeta, signore!», fece la signora Mann. «Beh, beh!», esclamò il custode evidentemente lusingato dal complimento. «Forse, forse, signora Mann». Finì il gin con acqua e aggiunse: «Poiché ora Oliver è troppo vecchio per restare qui, la Direzione ha deciso di rimandarlo nell'ospizio. Sono venuto io stesso per portarcelo, e perciò fatelo venire qui immediatamente». «Vado subito a prenderlo», disse la signora Mann uscendo perciò dalla stanza. È Oliver, che ormai era stato disincrostato dello strato più superficiale di sporcizia che gli copriva il viso e le mani - per quanto ciò fosse possibile con un solo lavaggio - fu condotto nella stanza dalla sua benevola protettrice. «Fa' un inchino al signore, Oliver», fece la signora Mann. Oliver fece un inchino, all'indirizzo tanto del signor Bumble solennemente seduto quanto del tricorno sul tavolo. «Vuoi venire via con me, Oliver?», disse il signor Bumble con voce maestosa. Oliver stava per dire che sarebbe andato via immediatamente con chiunque quando, sollevando lo sguardo, notò la signora Mann che, collocatasi dietro la sedia del custode, gli agitava contro il pugno con espressione furente. Oliver comprese il gesto all'istante, giacché quel pugno gli era stato troppo spesso impresso sulla carne per non essergli rimasto impresso anche nella memoria. «Viene con me anche lei?», chiese il povero Oliver. «No, lei non può», replicò il signor Bumble. «Ma verrà a trovarti qualche volta». Non era, quella, una grande consolazione per il ragazzo. Tuttavia, per quanto giovane, aveva abbastanza buon senso per mostrare un profondo dispiacere all'idea di doversene andare, e non dovette faticar molto a farsi venire le lacrime agli occhi. La fame e i maltrattamenti recenti riescono di grande aiuto se volete piangere, e Oliver pianse davvero con grande naturalezza. La signora Mann gli dette abbracci in quantità e, cosa di cui aveva molto più bisogno, un poco di pane e burro, affinché non sembrasse troppo magro quando sarebbe rientrato all'ospizio. Con la fetta di pane in mano e il berretto parrocchiale di panno marrone in testa, Oliver fu portato dal signor Bumble via da quella sventurata dimora nella quale mai sguardo o parola gentile avevano illuminato la tristezza della sua infanzia. Tuttavia, ruppe in un pianto di infantile angoscia quando il cancello di quella povera casa si chiuse dietro di lui. Per quanto miserevoli fossero i compagni di sventura che stava lasciando, erano pur sempre i soli amici che avesse mai avuto; e il senso della propria solitudine nel vasto mondo minaccioso gli scese nel tenero cuore per la prima volta. Il signor Bumble camminava a gran passi; il piccolo Oliver, stringendo la sua manica listata d'oro, gli trotterellava accanto, domandando a ogni quarto di miglio quanto mancava. A queste domande il signor Bumble rispondeva secco e brusco, giacché la temporanea bonomia che il gin con acqua infonde in certuni era ormai del tutto svanita, ed egli era tornato il solito custode. Oliver non era stato tra le mura dell'ospizio neanche un quarto d'ora e aveva a malapena completata l'opera di demolizione di una seconda fetta di pane quando il signor Bumble, che l'aveva affidato alle cure di una vecchia, ritornò, e poiché quella era una delle sere in cui si riuniva la Direzione, informò il ragazzo che lo si voleva vedere senza indugio. Senza la più pallida idea di cosa fosse una Direzione in carne ed ossa, Oliver restò stupefatto a quella informazione e alquanto incerto se dovesse ridere o piangere. Ma non ebbe abbastanza tempo per pensarci, poiché il signor Bumble, per ridestarlo, gli assestò una botta in testa col bastone e un'altra sulle spalle per scuoterlo, e ingiungendogli di seguirlo, lo condusse in un gran camerone imbiancato a calce dove una decina di grassi signori sedevano attorno a un tavolo. A capotavola, su una poltrona più alta delle altre, sedeva un uomo particolarmente grasso, con una tondissima faccia rossa. «Fai un inchino alla Direzione», disse Bumble. Oliver si asciugò due o tre lacrime che erano lì lì per cadere, e ignorando cosa fosse la Direzione s'inchinò, fortunatamente, in direzione del tavolo. «Come ti chiami, ragazzo?», chiese il signore seduto al centro. Oliver, impaurito dalla presenza di tutte quelle autorità, restò tremante, e si mise a piangere quando il custode gli assestò un'altra botta alle spalle. Quelle due cause congiunte fecero poi sì che rispondesse con voce fioca ed esitante. Di conseguenza un tale in panciotto bianco lo dichiarò uno sciocco, e questo era certo il miglior modo per rincuorarlo e per metterlo a suo agio. «Ragazzo», disse il signore seduto al centro, «ascoltami. Sai di essere orfano, suppongo». «Cosa, signore?», chiese il povero Oliver. «È proprio uno sciocco! Come pensavo», ribadì il tale in panciotto bianco. «Silenzio!», ribatté il signore che aveva parlato per primo. «Sai di non avere né padre né madre, e che sei stato allevato dalla parrocchia, non è vero?» «Sì, signore», replicò Oliver piangendo amaramente. «Perché piangi?», domandò il signore in panciotto bianco, poiché, neanche a dirlo, era stranissimo che piangesse. Quale motivo aveva mai per farlo? «Reciti le preghiere ogni sera?», fece un altro con voce burbera, «e preghi per tutti coloro che ti nutrono e si prendono cura di te, da buon cristiano?» «Sì, signore», balbettò il ragazzo. Il tale che aveva parlato per ultimo aveva detto bene, senza saperlo. Sarebbe stato davvero da buon cristiano, anzi da buonissimo cristiano, se Oliver avesse pregato per tutti coloro che lo nutrivano e si prendevano cura di lui. Ma non l'aveva fatto, per il semplice motivo che nessuno glielo aveva insegnato. «Bene! Tu ora sei qui per ricevere un'educazione e per imparare un mestiere utile», disse quello seduto al centro. «E così comincerai a cernere la stoppa, domani mattina alle sei», aggiunse cupo quello del panciotto bianco. Dopo che i due doni dell'educazione e del mestiere furono riassunti nell'unico processo di cernere la stoppa, Oliver, pungolato dal custode, fece un profondo inchino, dopodiché fu guidato senza tanti complimenti in una vasta camerata; e qui, su un duro e ruvido giaciglio, pianse finché non s'addormentò. Quale nobile esempio delle soavi leggi inglesi! Permettono ai poveri persino d'andare a dormire! Povero Oliver! Mentre dormiva in felice ignoranza di tutto quanto lo circondava, non immaginava che quel giorno stesso la Direzione aveva preso una decisione che avrebbe avuto la più profonda e sostanziale influenza sulle sue future fortune. Tuttavia quella decisione era stata presa, e consisteva in ciò che segue. I membri della Direzione erano tutte persone sagge e di profonda filosofia, e quando misero al vaglio la condizione dell'ospizio scoprirono all'istante ciò che altri non avrebbero mai sospettato, e cioè che ai poveri piaceva! Era un vero e proprio parco dei divertimenti per le classi povere; una taverna dove non si pagava; colazione, pranzo, tè e cena a ognuno, tutto l'anno; un paradiso in calce e mattoni dove ci si doveva solo divertire e mai lavorare. «Oho!», fece la Direzione con aria saccente; «tocca a noi raddrizzare la cosa; questa pacchia ha da finire, immantinente». E così stabilirono la regola che i poveri potessero scegliere (poiché non era da loro costringere nessuno, no): o morire di fame in quella casa per via graduale, oppure fuori dalle sue mura, per via rapida. A tale scopo s'accordarono con una società di distribuzione per la fornitura d'una quantità illimitata di acqua, e con un mediatore di granaglie per la fornitura periodica d'una modica quantità di farina d'avena. Stabilirono poi la somministrazione di tre pasti al giorno di farinata leggera, con una cipolla due volte a settimana, e mezzo panino la domenica. Molte altre sagge e umanissime regole stabilirono in relazione alla sezione femminile, che non è necessario ripetere; e graziosamente provvidero a favore del divorzio dei poveri, tenendo conto delle enormi spese di un procedimento legale al Tribunale ecclesiastico, di modo che, invece di costringere il marito a sostenere la propria famiglia, com'era stato fino ad allora, gli tolsero la famiglia e lo resero scapolo! Inutile dire quanti, di ogni classe sociale, si sarebbero avvalsi di tali decreti se questi fossero stati disgiunti dall'ospizio, ma i membri della Direzione sapevano prevedere, e avevano predisposto il deterrente: quella concessione era inscindibile dall'ospizio e dalla farinata, e ciò bastava come deterrente. Per i primi sei mesi, da quando Oliver Twist fu trasferito, il sistema aveva marciato a pieno ritmo. All'inizio risultò piuttosto dispendioso, in conseguenza dell'aumento del conto dell'impresario delle pompe funebri e della necessità di restringere gli indumenti dei poveri, larghi e flosci sulle loro membra rinsecchite e smunte dopo appena una o due settimane a regime di farinata. Ma il numero dei residenti s'assottigliava come s'assottigliavano gli stessi poveri, e la Direzione andava in visibilio. Ai ragazzi il pasto veniva somministrato in un enorme camerone in pietra, a una estremità del quale stava un grande calderone di rame. Da questo il superiore, all'ora del pasto, indossato all'uopo un grembiule e assistito da una o due donne, dispensava mestoli di farinata. Di tale squisita miscela spettava la misura di un mestolo ciascuno, e non di più - tranne che in occasioni di pubblici festeggiamenti, quando in più veniva elargita un'oncia e un quarto di pane. Non c'era bisogno di lavare le scodelle. Ci pensavano i ragazzi armati di cucchiai a pulirle fino a che non tornavano a splendere, e conclusa quell'operazione (la quale non richiedeva in verità molto tempo, dato che i cucchiai erano grandi quanto le scodelle) restavano seduti a guardare il calderone con occhi così famelici che avrebbero divorato la stufa di mattoni sulla quale era collocato, presi, nel mentre, a succhiarsi accanitamente le dita allo scopo di asportarne ogni più piccolo residuo di farinata che vi fosse rimasto appiccicato. I ragazzi, di solito, hanno un appetito eccellente. Per tre lunghi mesi Oliver Twist e i suoi compagni furono ridotti alla fame; divennero infine tanto rabbiosi e famelici che uno di quei ragazzi, piuttosto cresciuto per la sua età e non aduso a quel genere di dieta (suo padre aveva gestito infatti un piccolo forno), fece oscuramente intendere ai compagni che, se non gli davano un'altra scodella di farinata per diem, una di quelle sere avrebbe potuto mangiarsi il ragazzino che gli dormiva accanto, un frugoletto piuttosto minuto e debole, per l'appunto. Aveva lo sguardo inferocito per la fame, cosicché non ebbero difficoltà a credergli. Si riunirono in consiglio, e si tirò a sorte per decidere chi, quella stessa sera, dopo cena, doveva alzarsi per avvicinarsi al superiore e chiedere un'altra scodella, e il caso volle che toccasse a Oliver Twist. Arrivò la sera; i ragazzi presero posto. Il superiore, in grembiule di ordinanza, si sistemò dietro il calderone, e le aiutanti si disposero di rincalzo; si servì la farinata, e su quelle misere razioni si recitò un lungo ringraziamento. La farinata scomparve e i ragazzi presero a bisbigliare tra loro facendo l'occhiolino a Oliver mentre quelli più vicini gli davano gomitate. Oliver, pur essendo solo un bambino, era tuttavia alla disperazione per la fame e i maltrattamenti; s'alzò dalla tavola e avanzando verso il superiore con in mano scodella e cucchiaio, e quasi spaventato dalla sua stessa temerarietà disse: «Di grazia, signore, ne vorrei ancora». Il superiore, pur grasso e in buona salute, sbiancò. Per alcuni secondi fissò muto e stupefatto quel piccolo ribelle, e quindi s'afferrò al calderone per sostenersi. Le assistenti erano paralizzate dallo stupore, e i ragazzi dalla paura. «Cosa?», disse infine con un filo di voce. «Di grazia, signore», ripetè Oliver, «ne vorrei ancora». Il superiore gli assestò un colpo di mestolo in testa e, afferrandolo stretto, urlò per chiamare il custode. La Direzione sedeva in solenne conclave quando il signor Bumble piombò nella stanza agitato come non mai e rivolgendosi al signor presidente esclamò: «Signor Limbkins, vi chiedo perdono, signore! Oliver Twist vorrebbe dell'altra farinata, ha detto!». Un sussulto generale percorse la stanza. Su ogni volto si dipinse l'orrore. «Dell'altra farinata!», allibì il signor Limbkins. «Ricomponetevi, Bumble, e rispondete esattamente alla mia domanda. Intendete dire che ne ha chiesto dell'altra dopo aver consumato la quantità prescritta dalla dieta?» «Proprio così, signore», replicò il custode. «Quel ragazzo finirà impiccato», sentenziò il tale in panciotto bianco. «Finirà impiccato, lo so». Nessuno contraddisse la profetica opinione di quel gentiluomo. Seguì un'animata discussione. Si decretò il confino immediato di Oliver, e l'affissione al cancello dell'ospizio, l'indomani, di un annuncio in cui si offriva il compenso di cinque sterline a chiunque volesse liberare la parrocchia del peso di Oliver Twist. In altre parole, si offriva la ricompensa di cinque sterline a qualsiasi uomo o donna volesse prenderlo come apprendista per un mestiere qualsivoglia. «In tutta la mia vita non sono mai stato più convinto di questo», affermò il tizio in panciotto bianco quando il mattino seguente suonò al cancello e lesse l'annuncio, «in tutta la mia vita non sono mai stato più convinto di questo, e cioè che quel ragazzo finirà impiccato». Poiché è mia intenzione mostrare più innanzi se quel tizio in panciotto bianco avesse ragione o no, arrecherei nocumento all'interesse di questa narrazione (supponendo che ne abbia affatto), se mi avventurassi a suggerire, fin da ora, qualche indizio sulla fine violenta o meno della vita di Oliver Twist. 1 Battezzato, cioè, con una funzione breve che non aveva luogo in chiesa e che veniva usata quando si riteneva sconveniente il battesimo tradizionale. Capitolo III. Narra di come Oliver Twist fosse sul punto di ottenere un lavoro che non sarebbe stato affatto una sinecura Per una settimana dopo aver commesso l'atto empio e profano di chiedere dell'altra farinata, Oliver rimase a stretto confino nella cella buia a cui era stato assegnato dalla saggezza e clemenza della Direzione. Non sembra irragionevole supporre, di prim'acchito, che, se egli avesse nutrito il dovuto senso di rispetto per la predizione del gentiluomo in panciotto bianco, avrebbe potuto consolidare una volta per tutte il carattere profetico di quel saggio individuo se avesse legato un capo del suo fazzoletto a un gancio fissato al muro e con l'altro si fosse poi fatto un cappio attorno al collo. C'era tuttavia un ostacolo alla messa in atto di questo disegno, e cioè la mancanza di un fazzoletto, articolo di indubbio lusso che era stato bandito dal naso degli orfani, allora e per tutti i tempi e le ere a venire, per espresso ordine della Direzione riunita in consiglio: ordine emanato e ratificato con tanto di firme e sigilli. Un altro e più notevole ostacolo era costituito dalla giovinezza e ingenuità di Oliver. Non faceva che piangere tutto il giorno e quando sopraggiungeva la notte, lunga e triste, si copriva gli occhi con le piccole mani come per allontanare le tenebre e raggomitolato in un angolo cercava di dormire. Di tanto in tanto si svegliava di soprassalto, e tremando si addossava quanto più poteva alla parete, come se persino quella superficie fredda e dura potesse in qualche modo proteggerlo nel buio e nella solitudine che lo circondava. Ma gli oppositori del "sistema" non pensino che durante quella solitaria incarcerazione fossero negati a Oliver i benefici dell'esercizio fisico e della socialità, né le consolazioni della religione. Per quanto riguarda l'esercizio fisico, anche se faceva abbastanza freddo, gli si consentiva di compiere le abluzioni mattutine sotto la pompa, nel cortile lastricato, alla presenza del signor Bumble il quale, ad un tempo, impediva che prendesse un raffreddore e gli procurava una sensazione di solletico per tutto il corpo, con ripetute applicazioni della sua verga. Per quanto riguarda invece la socialità, un giorno sì e un giorno no lo si conduceva nello stanzone dove i ragazzi cenavano e lì veniva socievolmente fustigato, a monito ed esempio. Né gli erano negate le consolazioni della religione giacché, all'ora della preghiera, lo si spingeva a calci ogni mattina in quello medesimo stanzone e, a edificazione del proprio spirito, gli si consentiva di ascoltare l'orazione recitata coralmente dai ragazzi. La quale orazione includeva una preghierina speciale, inserita per preciso ordine della Direzione, affinché essi fossero resi virtuosi, obbedienti e contenti, e immuni dai peccati e vizi di Oliver Twist, che veniva presentato come succube e schiavo delle forze del male, e come un soggetto uscito dalla fucina del diavolo in persona. Trovandosi dunque Oliver in questa promettente e confortevole posizione, accadde un giorno che il signor Gamfield se ne venisse giù lungo la via principale della cittadina, ruminando tra sé come poter pagare certi arretrati della pigione riguardo ai quali il suo affittuario s'era fatto piuttosto pressante. Le più floride stime delle sue liquidità, tuttavia, arrivavano al massimo a non meno di cinque sterline dalla cifra desiderata. In una sorta di aritmetica disperazione egli martellava perciò a turno il proprio cranio e quello dell'asino quando, passando innanzi all'ospizio, gli occhi gli caddero sull'avviso affisso al cancello. «Oooh-ho!», fece il signor Gamfield all'asino. L'asino, profondamente assorto, meditava molto probabilmente sulla possibilità di vedersi elargito un torso di cavolo o due quando avesse portato a destinazione i due sacchi di fuliggine caricati sul carretto, ragion per cui, ignorando il comando, continuò a trottare avanti. Il signor Gamfield, a denti stretti, cacciò una tremenda imprecazione, maledicendo l'asino in generale e i suoi occhi in particolare, e rincorsolo gli assestò poi un colpo di tale violenza sul capo che avrebbe fracassato qualsiasi cranio tranne quello d'un asino. Quindi, afferrate le briglie, dette un secco strattone alla mascella, per rammentargli gentilmente che non era padrone di se stesso e con tale mezzo riuscì a farlo girare. Gli assestò infine un altro colpo sul capo affinché rimanesse fermo lì stordito fino al suo ritorno. Disposte così le cose, s'avvicinò al cancello per leggere il cartello. Con le mani dietro la schiena, il gentiluomo in panciotto bianco stava là vicino, dopo aver dato sfogo ai suoi profondi sentimenti nell'ufficio della Direzione. Avendo assistito alla disputa tra il signor Gamfield e l'asino, gongolava soddisfatto quando il primo s'avvicinò per leggere l'avviso, poiché aveva compreso immediatamente che il signor Gamfield era proprio il tipo di padrone che faceva al caso di Oliver Twist. Anche il signor Gamfield gongolava nel leggere l'annuncio, perché cinque sterline erano proprio la somma che gli occorreva. Quanto al ragazzo che avrebbe dovuto accollarsi, edotto della dieta vigente nell'ospizio, non poteva che essere di corporatura alquanto minuta: appunto quello che gli serviva per le stufe con la ventilazione regolabile. Perciò ripassò l'annuncio da cima a fondo e poi, toccandosi il cappello di pelo in segno d'umiltà, s'avvicinò al gentiluomo in panciotto bianco. «Questo ragazzo qui, signore, che la parrocchia vuole dare apprendista», fece il signor Gamfield. «Sì, brav'uomo», disse il gentiluomo in panciotto bianco con un sorriso di condiscendenza. «Vi interessa?» «Se piacesse alla parrocchia fargli imparare un bel mestiere, attinente alla pregiata arte degli spazzacamini», disse il signor Gamfield, «io sto appunto cercando un apprendista, e sono disposto a prenderlo». «Entrate», rispose il gentiluomo in panciotto bianco. Il signor Gamfield, attardatosi un istante per assestare un altro colpo in testa e un altro strattone alla mascella dell'asino come monito a non scappare mentre s'assentava, seguì il gentiluomo in panciotto bianco nella stanza dove Oliver l'aveva visto per la prima volta. «È un mestiere duro», disse il signor Limbkins quando Gamfield ebbe ripetuta la sua richiesta. «Parecchi ragazzi sono morti asfissiati dal fumo su per i comignoli, in questi anni», disse un altro. «La colpa è di chi bagna la paglia prima di appiccarle il fuoco nei camini per farli scendere», disse il signor Gamfield. «Fa fumo senza fiamma, e il fumo serve a un bel niente se si vuole farli scendere; gli dà solo stordimento, che è proprio quello che cercano, quegli sfaticati. I ragazzi sono cocciuti e scansafatiche, e non c'è niente di meglio di una bella fiammata per farli venir giù di corsa. E poi, questa è bontà, signori miei, perché se puta caso restano incastrati nella canna del camino, i piedi arrosto gli mettono la fregola di districarsi». Il gentiluomo in panciotto bianco parve estremamente divertito dalla spiegazione, ma la sua allegria fu subito spenta da uno sguardo del signor Limbkins. Quindi i componenti della Direzione si consultarono per qualche minuto, ma in un tono così basso che si sentì soltanto «riduzione delle spese», «estrema attenzione al bilancio», e «possibilità di inchiesta sulla stampa», e anche queste espressioni solo perché furono ripetute più e più volte con grande enfasi. Alla fine quel mormorio cessò e quando i membri della Direzione ebbero ripresi i loro posti e il loro solenne contegno il signor Limbkins disse: «Abbiamo valutato con attenzione la vostra proposta, ma non acconsentiamo». «Per niente», ribatté il gentiluomo in panciotto bianco. «Per niente affatto», aggiunsero gli altri. E poiché sul signor Gamfield gravava la trascurabile accusa di aver già percosso a morte due o tre ragazzi, gli venne il sospetto che, per un qualche inspiegabile capriccio, nelle menti dei membri della Direzione si fosse insinuata l'idea di dover prendere in considerazione quella circostanza per il loro verdetto. Ciò sarebbe stato però in totale contrasto col loro modo consueto di condurre gli affari. E tuttavia, giacché egh non aveva alcuna intenzione di rinfocolare quelle maldicenze, torcendo il cappello tra le mani, s'allontanò dal tavolo. «Sicché non volete affidarmelo, signori?», disse il signor Gamfield fermandosi presso la porta. «No», rispose il signor Limbkins. «O almeno, trattandosi di un lavoro duro, pensiamo che dovreste accontentarvi di un premio minore di quello offerto». I tratti del signor Gamfield si rasserenarono immediatamente, mentre, lesto, si riavvicinò al tavolo e disse: «Quanto offrite, signori? Su, non siate troppo duri con un poveraccio. Quanto offrite?» «Mi pare che tre sterhne e dieci siano più che abbastanza», fece il signor Limbkins. «Dieci scellini di troppo», ribatté il gentiluomo in panciotto bianco. «Via, signori!», disse Gamfield, «facciamo quattro sterhne. Quattro sterhne e vi sbarazzate di lui una volta per tutte. To' !». «Tre sterline e dieci», ripetè con fermezza il signor Limbkins. «Via, signori! Si fa a metà della differenza. Tre sterline e quindici». «Neanche un penny di più», fu la ferma risposta del signor Limbkins. «Siete un fracco duri con me, signori», fece Gamfield incerto. «Tz! Tz! Sciocchezze», fece il gentiluomo in panciotto bianco. «Sarebbe svenduto anche senza premio in danaro. Prendete velo, sciocco che non siete altro! È proprio il ragazzo che fa al caso vostro. Gli ci vuole il bastone, di quando in quando, ma gli farà bene, e non avrete da spendere molto per il vitto giacché, da quando è nato, noi non s'è mai largheggiato con le cibarie. Ah! ah! ah!». Il signor Gamfield passò uno sguardo di disprezzo lungo il tavolo, ma vedendo un sorriso sulla bocca di ciascuno, a poco a poco cedette anche lui al sorriso. L'affare fu concluso. S'istruì immediatamente il signor Bumble a che Oliver Twist e i suoi documenti per l'apprendistato fossero portati quel pomeriggio stesso dal magistrato per l'approvazione e la ratifica. In ottemperanza alla decisione di cui sopra il piccolo Oliver, con sua estrema meraviglia, si ritrovò liberato dalla prigionia e con l'ingiunzione di indossare una camicia pulita. Aveva già portato a termine quell'insolito processo ginnico quando il signor Bumble gli portò, con le sue proprie mani, una scodella di farinata e la razione festiva di due once e un quarto di pane. A quella tremenda vista Oliver scoppiò in un pianto disperato e del tutto naturale, temendo, non senza motivo, che la Direzione volesse ucciderlo per qualche scopo di pubblica utilità: perché, altrimenti, metterlo all'ingrasso in quella maniera? «Non farti venire gli occhi rossi, Oliver, ma mangia, e sii grato di questo cibo», disse il signor Bumble con impressionante maestosità. «Stiamo per mandarti apprendista, Oliver». «Apprendista, signore?», ripetè il ragazzo tremando. «Sì, Oliver», rispose il signor Bumble. «Quei buoni e benedetti gentiluomini, ognuno come un padre per te che non ne hai nessuno, Oliver, pensano di mandarti apprendista, per aprirti una strada nella vita e per fare di te un uomo, anche se ciò costerà alla parrocchia ben tre sterline e dieci! - tre sterline e dieci, Oliver! - settanta scellini - ovvero centoquaranta volte sei pence! - e tutto questo per un orfanello selvatico a cui nessuno potrà mai voler bene». E mentre il signor Bumble riprendeva fiato, dopo questo discorso pronunciato con voce terribile, Oliver ruppe in un pianto dirotto e amaro. «Su!», fece il signor Bumble un po' meno maestosamente, lusingato al vedere quale effetto avesse prodotto la sua eloquenza. «Su, Oliver! Asciugati gli occhi con la manica della giacca, e non piangere nella farinata; è un'azione sciocca, Oliver!». E lo era di sicuro, perché di acqua ce n'era già abbastanza. Mentre andavano dal magistrato il signor Bumble istruì Oliver sul comportamento da tenere, ovvero cercare soltanto di sembrare felicissimo; e quando quel signore gli avesse chiesto se voleva andare apprendista, doveva rispondere di sì, che gli sarebbe piaciuto tantissimo; ingiunzioni alle quali Oliver promise di obbedire, tanto più che, come il signor Bumble fece gentilmente intendere, se non avesse ottemperato anche a una soltanto delle due, chissà cosa sarebbe potuto accadergli. Giunti all'ufficio, Oliver fu rinchiuso da solo in una stanzetta, ammonito da Bumble a restare lì buono finché non fosse tornato a prenderlo. Col cuore che batteva forte, lì Oliver rimase per una mezz'ora, allo scadere della quale il signor Bumble fece capolino, senza tricorno in testa, e chiamò ad alta voce: «Dunque, Oliver, piccolo mio, vieni dal magistrato». Nel dir questo però assunse un'espressione truce e minacciosa, e aggiunse in tono più basso: «Bada bene a quello che t'ho detto, furfantello!». A quella faccia del signor Bumble e allo stile in certo modo contraddittorio del suo discorso, Oliver sgranò innocentemente gli occhi ma quel brav'uomo prevenne ogni commento da parte sua col condurlo immantinente in una stanza attigua, la cui porta era aperta. Era una stanza grande, con un finestrone. Dietro una scrivania sedevano due signori con la testa incipriata, uno dei quali leggeva il giornale, mentre l'altro, con l'ausilio di un paio di occhiali di tartaruga, esaminava una piccola pergamena poggiata sulla scrivania. Da un lato, di fronte alla scrivania, stava il signor Limbkins, e dall'altro, con la faccia lavata quant'era stato possibile, stava il signor Gamfield; due o tre tipi rubicondi, con stivali alti, giravano a loro ozioso talento. Poco a poco il vecchio con le lenti s'appisolò sulla piccola pergamena, e ci fu una breve pausa quando Oliver fu piazzato dal signor Bumble di fronte alla scrivania. «Questo è il ragazzo, vostra eccellenza», disse il signor Bumble. Il vecchio che stava leggendo il giornale sollevò allora la testa un momento e tirò l'altro signore per la manica; al che, quest'ultimo si ridestò. «Oh, è questo il ragazzo?», osservò il vecchio. «È proprio lui, signore», rispose il signor Bumble. «Fa' un inchino a sua eccellenza, ragazzo». Oliver si scosse, e fece il migliore inchino di cui era capace. Con gli occhi fissi alla parrucca del magistrato, si stava chiedendo se tutti quelli della Direzione fossero nati con la parrucca, oppure se l'esser nati con quella roba bianca in testa li rendesse da quel momento in poi membri della Direzione. «Bene», fece il vecchio, «il mestiere di spazzacamino gli aggrada, presumo?» «Oh, ci va pazzo, vostra eccellenza», rispose Bumble, dando di nascosto a Oliver un pizzicotto per ammonirlo che avrebbe fatto bene a non contraddirlo. «E lui vuole assolutamente diventare uno spazzacamino, è così?», chiese il vecchio. «Se domani lo arruolassimo in qualsiasi altro mestiere, taglierebbe la corda quello stesso giorno, vostra eccellenza», replicò Bumble. «E quest'uomo, il suo futuro principale, arguisco - voi, signore - lo tratterete come si deve, e lo nutrirete e tutto quanto, non è vero?», disse il vecchio. «Se lo dico vuol dire che è così», replicò scontroso il signor Gamfield. «Siete brusco, di parole, amico mio, ma sembrate onesto e franco», fece il magistrato volgendo gli occhiali in direzione del candidato al premio di Oliver, i cui tratti ne rivelavano a chiare lettere la crudeltà. Ma il magistrato era tanto cieco quanto sprovveduto, sicché non ci si poteva attendere da lui che discernesse ciò che gli altri discernevano. «Signore, sono tale e quale a come dite», fece il signor Gamfield con un ghigno odioso. «E io non ne dubito, amico mio», replicò l'altro, sistemandosi le lenti sul naso e guardando attorno in cerca del calamaio. Fu il momento fatale per Oliver. Se il calamaio si fosse trovato dove il magistrato supponeva, egli vi avrebbe intinto la penna e avrebbe firmato le carte, dopodiché Oliver sarebbe stato condotto via all'istante. Ma poiché gli stava proprio sotto il naso ne seguì, come naturale conseguenza, che egli continuasse a guardare per tutta la scrivania senza trovarlo. Accadendo poi che nel corso delle sue ricerche guardasse dritto innanzi a sé, fu colpito dal volto pallido e atterrito di Oliver Twist il quale, a dispetto di tutte le occhiatacce di ammonimento e i pizzicotti di Bumble, fissava la ributtante fisionomia del suo futuro padrone con una espressione mista di paura e orrore, troppo evidente perché sfuggisse perfino a un magistrato mezzo cieco. Questo si fermò, depose la penna e guardò prima Oliver e poi Limbkins, il quale fece mostra di prendersi un pizzico di tabacco da fiuto nella massima tranquillità e bonomia. «Ragazzo mio!», fece il vecchio protendendosi sulla scrivania. A quelle parole Oliver ebbe un sussulto; scusabile, in verità, perché esse furono pronunciate con tono gentile, e i suoni inconsueti spaventano. Fu scosso da tremiti e ruppe in pianto. «Ragazzo mio!», ripetè il vecchio. «Sembri pallido e spaventato. Cosa c'è?» «Scostatevi un poco da lui, custode», disse l'altro magistrato mettendo da parte le carte e protendendosi anche lui sulla scrivania con espressione di interesse. «Dunque, ragazzo, dicci cosa c'è. Non avere timore». Oliver cadde in ginocchio e giungendo le mani li pregò che lo rimandassero nella cella buia - che non gli dessero nulla da mangiare - che lo battessero - che lo uccidessero, se volevano - ma che non lo mandassero con quell'uomo orribile. «Beh!», fece il signor Bumble levando in alto mani e occhi con la più impressionante solennità. «Di tutti gli orfani scaltri e maligni che ho visto in vita mia, Oliver, tu sei il più sfacciatamente sfacciato». «Silenzio, custode», rimbrottò l'altro magistrato quando il signor Bumble ebbe dato sfogo alla sua eloquenza in quel superlativo. «Chiedo venia a vostra signoria», disse il signor Bumble dubitando dei suoi orecchi. «Vostra signoria si rivolgeva a me?» «Sì! Fate silenzio». Il signor Bumble era letteralmente esterrefatto. Un custode tacciato di far silenzio! Quale sovvertimento della morale pubblica! Il vecchio con gli occhiali di tartaruga guardò il collega, che annuì significativamente. «Ci rifiutiamo di firmare queste carte», disse il vecchio scostando nel mentre il brandello di pergamena. «Le loro eccellenze», balbettò il signor Limbkins, «le loro eccellenze non vorranno credere che le autorità siano colpevoli di condotta impropria sulla base della semplice e sola testimonianza di un ragazzo, spero». «I magistrati non sono tenuti a pronunciarsi su quanto credono o non credono in proposito», tagliò secco il secondo gentiluomo. «Riportate il ragazzo nell'ospizio, e trattatelo con bontà. Sembra che ne abbia bisogno». Quella sera stessa, il gentiluomo in panciotto bianco affermò nel modo più netto e inequivocabile che Oliver non soltanto sarebbe finito impiccato ma che sarebbe anche stato squartato e trascinato nella polvere. Il signor Bumble scosse la testa con aria di profonda preoccupazione e s'augurò che il ragazzo potesse ravvedersi. Al che il signor Gamfield s'augurò pure di poterlo ravvedere di persona; il quale augurio però, sebbene egli concordasse in genere col custode, sembrava divergere totalmente dal primo. Il mattino seguente, il pubblico fu di nuovo informato che chiunque si fosse preso Oliver Twist avrebbe anche ricevuto un premio di cinque sterline. Capitolo IV. Oliver, con un altro lavoro, fa la sua prima comparsa sulla scena pubblica Nelle grandi famiglie, quando a un giovane alle soglie della maturità non si riesce a procurare un buon posto né per compravendita, né per trasferimento, né per passaggio o eredità, è prassi consueta mandarlo per mare. Ecco quindi che la Direzione, seguendo questo salutare e avveduto esempio, si riunì per valutare la possibilità di imbarcare Oliver Twist su qualche piccolo vascello diretto verso un qualche porto discretamente pestilenziale. Sembrava la miglior soluzione possibile del caso, dandosi la probabilità che un bel giorno, dopo cena e tanto per gradire, il capitano l'avrebbe frustato a morte, o gli avrebbe fracassato il cranio con una sbarra di ferro; poiché entrambe le cose, come è generalmente abbastanza noto, sono tra i divertimenti di gran lunga favoriti dai gentiluomini di quella risma. E più si valutava l'opportunità di quella soluzione, più se ne palesavano i molteplici vantaggi. La Direzione, pertanto, giunse a concludere che il modo più efficace per sistemare Oliver fosse il mandarlo per mare senza frapporre indugio. Il signor Bumble era stato mandato per delle indagini preliminari allo scopo di scovare un capitano al quale occorresse un aiuto mozzo senza vincoli d'amicizia al mondo. Bumble stava tornando all'ospizio per comunicare l'esito della missione quando, proprio di fronte al cancello, incontra nientedimeno che il signor Sowerberry, l'impresario di pompe funebri della parrocchia. Il signor Sowerberry era alto, allampanato, con le ossa prominenti, vestito d'un frusto abito nero, calzettoni di cotone dello stesso colore e scarpe pure in tinta. I suoi lineamenti non erano naturalmente propensi a un'espressione sorridente, e tuttavia egli indulgeva spesso alla giocosità tipica della sua professione. Con passo elastico, e con un volto che emanava una interiore gaiezza di spirito, s'avanzò verso il signor Bumble e gli strinse cordialmente la mano. «Ho preso le misure delle due donne morte la notte passata, signor Bumble», informò l'impresario. «Ci farete la vostra fortuna, signor Sowerberry», fece il custode mentre affondava pollice e indice nella tabacchiera che l'altro gli offriva: un ingegnosissimo modellino di una bara con tanto di brevetto. «Dico che ci farete la vostra fortuna, signor Sowerberry», ripetè il signor Bumble, battendo amichevolmente col suo bastone sulla spalla dell'impresario. «Dite?», ribatté l'impresario in un tono che a metà ammetteva e a metà contestava la probabilità di quell'esito. «Con quello che passa la Direzione, signor Bumble, posso cavarmela solo riducendo i prezzi al massimo». «E son ridotte al massimo anche le bare vostre», replicò il custode, tanto vicino ad indulgere in una risata quanto è consentito a chi ricopra cariche pubbliche. La battuta divertì parecchio il signor Sowerberry - non c'è da stupirsene - e rise a crepapelle per parecchio tempo. «Bene, bene, signor Bumble», disse infine, «inutile negarlo. Da quando è entrato in vigore il nuovo sistema di refezione, le bare sono più strette e basse di com'erano; ma noi pure dobbiamo ricavarci qualcosa, signor Bumble. Il legno ben stagionato costa parecchio, signore, e le finiture di metallo bisogna farle arrivare da Birmingham, lungo i canali». «Bene, bene», disse il signor Bumble, «ogni arte ha i suoi inconvenienti. Però ci si può sempre ricavare un certo profitto». «Naturale, naturale», replicò l'impresario. «E se non ho un profitto alto su questo o quell'articolo particolare, vuol dire che mi ripago sul lungo periodo. Eh, eh, eh!». «Già», ribadì il signor Bumble. «Anche se c'è da dire», continuò l'impresario riprendendo il filo del discorso interrotto dal custode, «anche se c'è da dire che c'è un serio inconveniente, signor Bumble, e cioè che quelli più pasciuti sono i primi ad andarsene. Quelli che se la passavano meglio e potevano pagare le imposte per tanti anni sono i primi a cedere quando arrivano all'ospizio. E lasciate che vi dica, signor Bumble, che una differenza di tre o quattro pollici nei calcoli scava un bel buco nei profitti, specialmente quando uno ha da mantenere una famiglia». E poiché il signor Sowerberry disse questo con la contenuta indignazione d'un uomo bistrattato, il signor Bumble l'avvertì come una possibile minaccia al buon nome della parrocchia. Pensò dunque che fosse consigliabile cambiare discorso, e avendo Oliver in cima ai suoi pensieri, ne fece il nuovo argomento di conversazione. «A proposito», esclamò il signor Bumble, «non conoscete per caso qualcuno che abbia bisogno di un ragazzo? Un apprendista della parrocchia, che al momento è un peso morto, una pietra da macina, per così dire, alla gola della parrocchia? A condizioni generose, signor Sowerberry, a condizioni generose!». Così dicendo il signor Bumble levò il suo bastone sull'annuncio affisso in alto e batté tre distinti colpi sulle parole «cinque sterline» stampate a lettere romane di dimensioni cubitali. «Santo cielo!», disse l'impresario prendendo il signor Bumble per il risvolto dorato del suo cappotto ufficiale. «Proprio di questo volevo parlarvi. Sapete... bontà del cielo, quant'è elegante questo bottone, signor Bumble! Non l'avevo mai notato prima». «Sì, è piuttosto grazioso, mi pare», disse il custode, guardando all'ingiù i larghi bottoni di ottone che gli abbellivano il cappotto. «L'effigie è la stessa del sigillo parrocchiale: il Buon Samaritano che soccorre l'infermo. È stato un regalo della Direzione per il primo dell'anno, signor Sowerberry. Ricordo d'averlo indossato per la prima volta all'inchiesta su quel negoziante fallito morto a mezzanotte sotto un portone». «Mi ricordo», disse l'impresario. «La giuria emise un verdetto di "morto di freddo e di stenti", non è così?». Il signor Bumble annuì. «Ma fu un verdetto particolare, mi sembra», continuò l'impresario, «perché aggiunsero qualche parola per significare che se il custode in servizio avesse...». «Tz! Sciocchezze», interloquì il custode. «Se i membri della Direzione dovessero prestare ascolto a tutte le sciocchezze e chiacchiere di giurati ignoranti avrebbero un bel da fare!». «Verissimo», soggiunse l'impresario, «avrebbero un bel da fare davvero!». «Le giurie», disse il signor Bumble stringendo forte il bastone, come era suo costume quando s'adirava, «le giurie sono fatte di persone 'gnoranti, volgari, stupide e abbiette». «Questo è vero», disse l'impresario. «Mettendole assieme tutte, non ci si caverebbe più filosofia o economia politica di tanto», disse il custode facendo schioccare sprezzantemente le dita. «Non di più, certo», assentì l'impresario. «Li disprezzo», disse il custode facendosi rosso in viso. «Anch'io», ribatté l'impresario. «Vorrei solo che queste giurie di spirito indipendente restassero in ospizio per una settimana o due!», disse il custode. «Le regole e i regolamenti della Direzione glielo farebbero scendere sotto i piedi, lo spirito». «Se è per questo, bisogna lasciarla stare!», replicò l'impresario. E lo disse con un sorriso di approvazione, così da calmare la collera montante dell'indignato custode parrocchiale. Il signor Bumble si levò il tricorno, ne prelevò dall'interno della corona un fazzoletto, si asciugò il sudore causatogli dall'arrabbiatura, si risistemò il tricorno e, rivolgendosi all'impresario, disse in tono più calmo: «Ebbene! Che dicevate del ragazzo?» «Oh!», rispose l'impresario. «Ecco, signor Bumble. Sapete, io verso regolarmente un certo contributo per i poveri dell'ospizio». «Hm!», fece Bumble. «E allora?» «E allora», replicò l'impresario, «stavo pensando che se do tanto per loro, è giusto che voglia ricavarci anche qualcosa, signor Bumble. E così..., e così..., potrei prendermi io il ragazzo». Il signor Bumble afferrò l'impresario per il braccio e lo condusse nell'edificio. Il signor Sowerberry rimase a colloquio riservato con la Direzione per cinque minuti strappando questo accordo: si sarebbe preso Oliver quella sera stessa "pro tempore", una formula che, nel caso di un apprendista proveniente dalla parrocchia, significa che se dopo un breve periodo di prova il maestro capiva di poter ricavare abbastanza dal ragazzo senza perderci molto in cibo per nutrirlo, allora avrebbe potuto tenerlo con sé per anni e farci più o meno quello che voleva. Quando Oliver fu condotto innanzi a quei "signori gentiluomini" e fu informato che quella sera avrebbe dovuto iniziare l'apprendistato presso un fabbricante di bare, e che se si fosse lamentato della sua situazione o fosse di nuovo ritornato alla parrocchia, sarebbe stato mandato per mare, dove sarebbe finito affogato o con la testa fracassata, a seconda dei casi, egli mostrò così poca emozione che essi lo apostrofarono come piccolo delinquente incallito e ordinarono a Bumble che lo portasse via immediatamente. Ora, sebbene fosse più che naturale che i componenti della Direzione, più di altri al mondo, dovessero sentirsi in uno stato di grande e virtuosa meraviglia al minimo accenno da parte di chiunque di aridità di sentimenti, in questo caso particolare rimasero piuttosto sconcertati. Fatto si è che Oliver, invece di essere arido di sentimenti, ne era semplicemente troppo ricco; era però sulla strada buona per trovarsi definitivamente ridotto a uno stato di bruta stupidità e inerzia per i maltrattamenti subiti. Ascoltò la notizia della sua nuova destinazione in perfetto silenzio, e quando gli fu messo in mano il suo bagaglio (non molto difficile da portare in quanto racchiuso nei limiti di un pacchetto di carta marrone di circa mezzo piede per mezzo piede di base per tre pollici d'altezza) si tirò il cappello sugli occhi e, ancora una volta attaccandosi ai risvolti delle maniche del cappotto di Bumble, fu condotto da questo funzionario verso una nuova scena di sofferenza. Bumble si trascinò dietro Oliver per un po' senza notarne o avvertirne la presenza, portando la testa molto eretta come un custode deve sempre fare, e poiché tirava un vento forte, il piccolo Oliver si trovava completamente avvolto dai lembi svolazzanti del cappotto di Bumble, i quali lasciavano in bella mostra il panciotto a risvolti e le brache al ginocchio in velluto. Avvicinandosi però alla loro destinazione il signor Bumble ritenne opportuno guardar giù per assicurarsi che il ragazzo fosse presentabile al suo nuovo padrone. E ciò fece, con l'aria di graziosa condiscendenza che gli si addiceva. «Oliver!», disse Bumble. «Sì, signore», rispose Oliver a voce bassa e tremante. «Tirati su quel cappello dagli occhi, e porta alta la testa, ragazzo». Sebbene Oliver eseguisse all'istante quell'ordine, e rapidamente si passasse sugli occhi il dorso della mano libera, una lacrima rimase in bilico quando egli alzò lo sguardo in su alla sua guida, e gli cadde giù lungo la gota quando Bumble abbassò su di lui lo sguardo severo. Un'altra la seguì, e un'altra ancora. Il ragazzo cercò di trattenerle come poteva, ma senza successo. Ritraendo l'altra mano da quella del signor Bumble, si coprì con entrambe il volto e pianse finché le lacrime non gli uscirono tra le dita scarne e ossute. «Beh!», esclamò il signor Bumble fermandosi di colpo e fulminando il piccolo con uno sguardo di intensa malignità. «Beh! Di tutti i ragazzi ingratissimi e più maldisposti che ho conosciuto in vita mia, Oliver, tu sei il più...». «No, signore, no!», singhiozzò Oliver aggrappandosi alla mano che stringeva il ben noto bastone. «No, signore, no! Farò il bravo, veramente, veramente, signore! È che sono solo un ragazzo, signore, e sono così... sono così...». «Così cosa?», chiese sorpreso il signor Bumble. «Sono così solo! Così solo!», singhiozzò il bambino. «Tutti mi odiano. Oh!, signore, vi prego, non adiratevi con me!». Il ragazzo si batté con la mano sul cuore e guardò il suo accompagnatore con lacrime di autentica angoscia. Il signor Bumble osservò meravigliato l'espressione smarrita e sgomenta di Oliver per qualche secondo. Si raschiò tre o quattro volte la gola e borbottando qualcosa a proposito di una "fastidiosa tosse", disse a Oliver di asciugarsi le lacrime e fare il bravo ragazzo. Poi, ripresagli la mano, camminò con lui in silenzio. L'impresario, che aveva appena chiuso le imposte della bottega, stava registrando le transazioni del giorno nel suo libro mastro alla luce di una lugubre candela, quanto mai appropriata, allorché fece il suo ingresso il signor Bumble. «Ah!», disse l'impresario sollevando gli occhi dal registro e lasciando una parola a mezzo. «Siete voi, Bumble?» «Proprio io, signor Sowerberry», replicò il custode. «Ecco! Vi ho portato il ragazzo». Oliver fece un inchino. «Oh! Sicché questo è il ragazzo?», disse l'impresario sollevando la candela sopra la testa per poterlo osservare meglio. «Signora Sowerberry! Mia cara, avresti la bontà di venire qui un momento?». La signora Sowerberry spuntò da una stanzetta sul retro della bottega, palesandosi come una donna bassa, smilza e rinsecchita, dall'aspetto bilioso. «Mia cara», disse reverente il signor Sowerberry, «questo è il ragazzo della parrocchia di cui ti ho parlato». Oliver fece un altro inchino. «Santo cielo!», osservò la moglie dell'impresario. «Com'è piccino!». «Eh sì! È piuttosto piccino», ribatté il signor Bumble guardando Oliver come se fosse colpa sua di non essere più grande. «È piccino. Non si può negarlo. Ma crescerà, signora Sowerberry, crescerà». «Ah! Lo credo bene!», ribatté la donna astiosa, «con tutto il mangiare e bere che bisognerà dargli. Non vedo come ci si possa guadagnare con i ragazzi della parrocchia, non so vederlo, io, dato che costa più mantenerli di quanto ci si possa ricavare. Ma comunque, gli uomini pensano di saperla sempre più lunga. Su! Va' giù da basso, sacchetto d'ossa». Con ciò la moglie dell'impresario aprì una porticina da un lato, e spinse Oliver giù per una ripida scala in uno stanzino coi muri di pietra, umido e buio, che costituiva l'anticamera del deposito di carbone, noto come "la cucina", dove era seduta una ragazza dall'aspetto sciatto, con scarpe sdrucite e calze di lana blu in estremo bisogno di restauro. «Su, Charlotte», disse la signora Sowerberry che aveva seguito Oliver da basso, «da' al ragazzo quegli avanzi di carne che avevamo messi da parte per Trip. È da stamani che è in giro e se non è ancora tornato a casa, vuol dire che può farne benissimo a meno. Voglio sperare che il ragazzo non sia tanto schizzinoso da rifiutarle... vero ragazzo?». Oliver, i cui occhi brillarono alla semplice menzione del cibo e che a stento si reggeva dalla fame, rispose negativamente, e gli fu messo innanzi un piatto di avanzi e rimasugli. Vorrei che qualche ben nutrito filosofo, a cui il mangiare e bere si volge in bile, il cui sangue è ghiaccio e il cui cuore è pietra, avesse potuto vedere Oliver buttarsi su quelle squisite vivande sdegnate dal cane; vorrei che avesse potuto osservare l'orribile avidità con la quale Oliver lacerava e smembrava quei resti con tutta la ferocia dell'affamato. E soltanto una cosa vorrei ancora di più: vorrei vedere quel filosofo consumare quello stesso genere di pasto, con lo stesso gusto. «Bene!», disse la moglie dell'impresario quando Oliver ebbe finito la sua cena - l'aveva guardato in silenzioso orrore, con terribili premonizioni circa il suo futuro appetito - «Hai finito?». Non essendovi nuli'altro di commestibile alla sua portata, Oliver rispose affermativamente. «Vieni con me, allora», disse la signora Sowerberry prendendo una lampada fioca e sporca e facendo strada su per le scale. «Il tuo letto è sotto il bancone. Niente in contrario a dormire tra le bare, suppongo? Ma non importa poi molto, se sì o no, dato che non c'è altro posto per dormire. Su! Non farmi star qui tutta la notte!». Oliver non indugiò oltre, e seguì mitemente la sua nuova padrona. Capitolo V. Oliver incontra nuovi compagni. Per la prima volta segue un funerale, e si fa un'idea sfavorevole degli affari del suo padrone Lasciato solo nella bottega dell'impresario, Oliver posò la lampada su una panca da lavoro e si guardò timidamente attorno con un sentimento di spavento e terrore che molte persone parecchio più grandi di lui non avranno difficoltà a comprendere. Una bara ancora da finire, su dei trespoli neri, al centro della bottega sembrava così lugubre e sinistra da dargli brividi freddi ogni volta che vi cadeva lo sguardo, ed egli quasi si aspettava di vedere qualche figura orrenda levare lentamente il capo da quel triste articolo per farlo ammattire di paura. Una quantità di tavole di legno d'olmo tagliate a misura erano appoggiate, in file regolari, contro il muro, sembrando, in quella luce fioca, come fantasmi dalle spalle squadrate con le mani ficcate nelle tasche dei pantaloni. Placche per bare, schegge di legno, chiodi a testa dorata e brandelli di panno grigio erano disseminati sul pavimento, e il muro dietro il bancone era adornato con una vivace raffigurazione di due muti in rigidi colletti inamidati che attendevano presso un ampio portone di casa, mentre a distanza s'avvicinava un catafalco tirato da quattro cavalli neri. C'era un'aria stantia e soffocante nella bottega, come pervasa da un sentore di bare. La nicchia sotto al bancone dov'era gettato un materasso di cascame di lana pareva una tomba. Né questi soltanto erano i cupi sentimenti che opprimevano Oliver. Egli era solo, in un luogo sconosciuto, e sappiamo tutti come anche i più coraggiosi, in una situazione simile, possano sentirsi gelare il sangue. Il ragazzo non aveva amici a cui badare o che badassero a lui. Non gli pesava il rammarico di alcuna separazione recente, né l'assenza e il ricordo di qualche persona amata gli opprimeva l'animo. Eppure si sentiva il cuore oppresso come da un macigno, e scivolando in quell'angusto lettuccio desiderò che fosse veramente la sua bara, e che lo seppellissero per un tranquillo e lungo riposo nel cimitero accanto alla chiesa, con l'erba alta a ondeggiargli mollemente sul capo e i rintocchi profondi della vecchia campana a consolarlo nel sonno. Il mattino seguente Oliver fu destato da una violenta scarica di calci alla porta della bottega; e si ripetè, veemente e rabbiosa, più di altre venti volte prima che potesse gettarsi addosso i suoi indumenti. Quando cominciò a togliere la catena i calci cessarono e s'udì una voce. «Ti decidi ad aprire, oh?», gridò quella voce, che apparteneva ai piedi che avevano tempestato la porta. «Apro subito, signore», rispose Oliver togliendo la catena e girando la chiave. «Tu devi essere il nuovo ragazzo, dico bene?», fece la voce attraverso il buco della serratura. «Sì, signore», rispose Oliver. «Quanti anni hai?», domandò la voce. «Dieci, signore», disse Oliver. «Allora appena son dentro ti picchio», ribatté la voce. «Vedrai se non lo faccio, il mio caro orfanello bastardo, vedrai!». E a questa allettante promessa la voce attaccò a fischiettare. Troppo spesso Oliver era stato soggetto alla procedura alla quale s'era testé molto espressivamente alluso per nutrire il minimo dubbio che, chiunque fosse la fonte di quella voce, potesse più che onorevolmente sciogliersi da quella promessa. Con la mano che gli tremava tirò i catenacci e apri la porta. Per un secondo o due Oliver scrutò la strada, da un lato e dall'altro, poi di fronte, con l'impressione che lo sconosciuto che gli aveva parlato attraverso il buco della serratura avesse fatto due passi per riscaldarsi, giacché non vedeva altri che un ragazzone con l'abito del meschino seduto su una colonnina di fronte alla casa che mangiava una fetta di pane e burro. Con un coltello a serramanico, la tagliava a cunei grandi quanto la sua bocca, e quindi ingoiava con grande destrezza. «Chiedo scusa, signore», disse infine Oliver, non vedendo apparire nessun altro cliente. «Avete bussato voi?» «Coi calci», ribatté il meschino. «Vi occorre una bara, signore?», chiese innocentemente Oliver. Al che il ragazzo, con un'espressione di mostruosa ferocia, disse che presto ne sarebbe servita una a Oliver se faceva lo spiritoso a quel modo con i suoi superiori. «Non sai chi sono io, vero, orfanello?», continuò il ragazzo mentre scendeva dalla colonnina con ostentata gravità. «No, signore», ribatté Oliver. «Sono Mastro Noah Claypole», disse il meschino. «E tu stai sotto di me. Togli gli scuri, ruffianello sfaticato che non sei altro!». Con ciò, somministrò a Oliver un calcio, ed entrò nella bottega con un'aria di dignità che gli si addiceva anziché no. Ma se risulta comunque difficile a un ragazzo tagliato con l'accetta, con un grosso testone, occhi minuti e andatura goffa, assumere un'aria di dignità in una circostanza qualsiasi, lo è ancor di più quando, ai succitati bei tratti della persona, si aggiungano un naso rosso e braghette gialle. Oliver, tolte le imposte e fracassato un vetro nel tentativo di portarle, pesanti com'erano per lui, in un cortiletto a lato della casa dov'erano conservate durante il giorno, fu graziosamente aiutato da Claypole il quale, consolatosi con la promessa che «l'avrebbe pagata», accondiscese a dargli una mano. Subito dopo scese il signor Sowerberry, e subito dopo ancora comparve la signora Sowerberry, sicché Oliver, «avendola pagata» secondo le anticipazioni di Claypole, scese da basso con quel giovane gentiluomo per la colazione. «Vieni accanto al fuoco, Noah», disse Charlotte. «Ho messo da parte per te un bel pezzetto di pancetta dalla colazione del padrone. Oliver, richiudi la porta quando entra il signor Claypole e mangia quei resti che ho lasciato sul coperchio della teglia del pane. Prendi pure il tè e appoggiati su quella cassa per berlo. Guarda di sbrigarti perché avranno bisogno di te per badare al negozio, capito?» «Capito, fanciullo?», disse Noah Claypole. «Bontà del cielo, Noah!», disse Charlotte. «Che cattivello che sei! Perché non lo lasci in pace quel ragazzo?» «Lasciarlo in pace!», replicò Noah. «Qualcun altro lo lascia in pace, se è per questo. Il padre e la madre non gli metteranno certo i bastoni tra le ruote, a lui, e pure tutti gli altri parenti lo lasciano in pace. Eh, Charlotte? Eh, eh, eh!». «Oh, discolaccio!», disse Charlotte scoppiando in una risata che fu prontamente assecondata da Noah. Dopodiché guardarono entrambi con espressione di sprezzo il povero Oliver Twist che sedeva tremante sulla cassa nell'angolo più freddo della stanza a mangiarsi quei bocconi stantii che erano stati messi da parte apposta per lui. Anche Noah era a carico della parrocchia ma non stava in un ospizio di mendicità. Neanche era un trovatello, perché si poteva far risalire la sua genealogia giù fino ai suoi genitori diretti, i quali vivevano piuttosto vicino, la madre essendo lavandaia e il padre soldato con un debole per l'alcol, congedato con una gamba di legno e una pensione giornaliera di ben due penny e mezzo e qualche frazione infinitesima. I garzoni del vicinato erano ormai adusi a bollarlo, sulla pubblica strada, con l'appellativo di "braghe di cuoio", "pezzente", e simili, e Noah aveva subito le ingiurie senza replicare. Ora però che la fortuna gli gettava sulla strada un orfanello senza nome, contro cui pure i più meschini potevano puntare l'indice con disprezzo, si rifece su di lui con tutti gli interessi. Ciò dà adito ad affascinanti spunti di meditazione, mostrandoci che bella cosa sia a volte la natura umana, e con quanta imparzialità le qualità più amabili trovino terreno fertile sia tra i più azzimati gentiluomini sia tra i più luridi orfanelli. Da poco meno d'un mese Oliver si trovava presso l'impresario di pompe funebri. Il signore e la signora Sowerberry, chiusa la bottega, stavano cenando nel salottino sul retro, quando il signor Sowerberry, dopo aver lanciato a più riprese sguardi sottomessi alla sua consorte, disse: «Cara...», e avrebbe proseguito, senonché la signora Sowerberry, squadrandolo con un aspetto caratteristicamente poco incoraggiante, frustrò il tentativo sul nascere. «Ebbene?», fece la signora Sowerberry recisa. «Niente, cara, niente», rispose il signor Sowerberry. «Oh! Che scostumato!», ribatté la moglie. «Niente affatto, mia cara», soggiunse umilmente il signor Sowerberry. «Pensavo soltanto che non volessi ascoltarmi. Stavo dicendo...». «Oh, non dirmi quello che stavi dicendo», lo interruppe la signora Sowerberry. «Non conto niente io; perché consultarmi? Io non voglio certo ficcare il naso nei tuoi segreti». E ciò dicendo la signora Sowerberry esplose in una risata isterica carica di minacciose implicazioni. «Ma, mia cara», fece il signor Sowerberry. «Io volevo proprio chiederti un parere». «No, no, non chiederlo a me», rispose la signora Sowerberry con affettazione. «Chiedilo a qualcun altro». E ci fu ancora la risata isterica, che lasciò atterrito il signor Sowerberry. È questa una procedura delle più consuete nelle relazioni matrimoniali, spesso di notevole efficacia. Ridusse all'istante il signor Sowerberry alla condizione di supplice, cui si consentiva di dire, come uno specialissimo favore, ciò che la signora Sowerberry era già di per sé curiosissima di sapere. Dopo un breve alterco, della durata di meno di tre quarti d'ora, il permesso fu graziosamente accordato. «Si tratta solo di Oliver Twist, mia cara», disse il signor Sowerberry. «È veramente un bel ragazzino, mia cara». «Bella scoperta, visto quello che mangia», osservò la moglie. «Ha una espressione così malinconica, mia cara», riprese il signor Sowerberry, «davvero molto accattivante. Farebbe un figurone come accompagnatore muto, amore mio». La signora Sowerberry levò lo sguardo con un'espressione di singolare meraviglia. Il signor Sowerberry lo notò, e senza concedere alla sua signora il tempo per ulteriori commenti continuò. «Non voglio dire un accompagnatore muto regolare, per i funerali degli adulti, ma solo per quelli dei bambini. Sarebbe un'innovazione simpatica avere un muto proporzionato al resto, cara, questo è certo. Avrebbe un effetto superbo». La signora Sowerberry, dotata di parecchio buon gusto per quanto riguarda le onoranze funebri, fu notevolmente impressionata da questa idea, ma poiché avrebbe nociuto alla sua dignità ammetterlo, date le circostanze, si limitò a chiedere molto recisamente al marito perché un'idea così ovvia non gli fosse venuta in mente prima. Il signor Sowerberry l'interpretò giustamente come un avallo alla sua proposta, e lì su due piedi si decise che Oliver dovesse essere immantinente iniziato ai segreti del mestiere e che, a tale scopo, egli dovesse accompagnare il padrone alla prima occasione utile. L'occasione non si fece attendere a lungo. Il giorno seguente, mezz'ora dopo colazione, entrò nella bottega il signor Bumble e, appoggiato il bastone al bancone, tirò fuori il suo grosso taccuino rilegato in pelle da cui estrasse un fogliettino che consegnò al signor Sowerberry. «Aha!», fece l'impresario scorrendo il foglietto con espressione soddisfatta. «Un ordine per una bara, eh?» «Per una bara parrocchiale innanzi tutto e poi per un funerale», replicò il signor Bumble stringendo la cinghia di chiusura del taccuino che, come lui, era alquanto voluminoso. «Bayton», disse l'impresario guardando dal foglietto al signor Bumble. «Mai sentito prima questo nome». Bumble scosse la testa replicando: «Gente ostinata, signor Sowerberry, molto ostinata. E credo anche orgogliosa, signore». «Orgogliosa, eh?», esclamò con un ghigno il signor Sowerberry. «Via, questo è troppo». «Oh, da voltastomaco», replicò il custode. «Come l'antimonio, signor Sowerberry!». «Proprio così», convenne l'impresario. «Abbiamo saputo di questa famiglia solo la notte scorsa», disse il custode, «e non ne avremmo saputo nulla affatto se una donna che abita nella stessa casa non avesse richiesto alla Direzione parrocchiale di mandare un medico per visitare una che stava malissimo. Il medico stava a cena fuori, ma un suo aiutante apprendista, un ragazzo parecchio sveglio, ha mandato una medicina in un flaconcino per lucido da scarpe preparata all'impronta». «Ah! Questo si chiama esser svelti», commentò l'impresario. «Svelto davvero!», ribatté il custode. «Ma qual è poi la conseguenza? In che modo ingrato si comportano questi ribelli, signore? Dunque, il marito manda a dire che la medicina non fa al caso della malattia della moglie, sicché lei non l'avrebbe presa signore, dice che non l'avrebbe presa! Una bella medicina, forte, e che era già stata somministrata con grande successo a due manovali irlandesi e a uno scaricatore di carbone solo una settimana prima - mandata gratis, dentro un flaconcino da lucido - e lui manda a dire che non l'avrebbe presa, signore». Quand'ebbe ben viva in mente tutta l'atrocità della cosa, il signor Bumble batté con la mazza un colpo secco sul banco e divenne paonazzo per l'indignazione. «Beh!», commentò l'impresario, «non m'è mai capitato...». «Non è mai capitato, signore!», esclamò il custode. «A nessuno è mai capitato! Ma adesso è morta, e dobbiamo seppellirla. Queste sono le istruzioni, e prima ci si spiccia meglio è». Così dicendo il signor Bumble, in un empito di agitazione parrocchiale, si mise in testa il tricorno al contrario e si precipitò fuori della bottega. «Perbacco, Oliver, era così arrabbiato che non ha neanche chiesto di te!», disse il signor Sowerberry seguendo con lo sguardo il custode che s'allontanava giù per la strada. «Sì, signore», replicò Oliver che durante il colloquio aveva preferito tenersi nascosto e che ora tremava da capo a piedi al solo ricordo della voce del signor Bumble. Ma non ci sarebbe stato affatto bisogno che si preoccupasse di tenersi nascosto agli occhi di Bumble in quanto quello stesso funzionario (sul quale così forte impressione aveva fatto la predizione del gentiluomo in panciotto bianco), ora che l'impresario s'era preso Oliver in prova, pensava fosse meglio evitare quell'argomento, almeno fin quando non fosse stata sottoscritta una ferma di sette anni e fosse stato definitivamente e legalmente scongiurato il pericolo che fosse riconsegnato nelle mani della parrocchia. «Bene», disse il signor Sowerberry prendendo il cappello, «prima sistemiamo questa faccenda e meglio è. Noah, bada tu alla bottega. Oliver, metti il cappello e vieni con me». Oliver obbedì, e seguì il padrone in quella spedizione professionale. Camminarono un po' per la parte più densamente popolata e affollata della città e poi, prendendo per una stradina più lercia e misera delle altre attraversate, si fermarono per cercare la casa dove dovevano recarsi. Grossi e alti caseggiati si ergevano da entrambi i lati della strada, ma erano vecchi, e occupati da persone del più infimo grado come avrebbe indicato chiaramente il loro squallido aspetto anche senza la concomitante testimonianza offerta dagli sguardi miserevoli dei pochi uomini e donne che, a braccia conserte e col corpo curvo e piegato, di tanto in tanto si trascinavano lungo la strada. Sulla maggior parte di questi edifici si aprivano ingressi di botteghe sprangati, muffiti e cadenti, poiché solo le stanze di sopra erano abitate. Alcuni di questi edifici, divenuti pericolanti per gli anni e lo stato di abbandono, restavano in piedi solo grazie a enormi travi di legno che, puntellate sulla strada, reggevano i muri; eppure perfino queste tane pazzesche erano state prescelte per rifugio notturno da sventurati senza casa, giacché parecchi di quei rozzi tavolacci che occupavano il posto di porte e finestre erano stati schiodati e scostati per ricavare un'apertura abbastanza ampia perché vi passasse un corpo umano. Le cunette di scolo erano stagnanti e intasate. Gli stessi topi che giacevano a putrefarsi in quella sozzura erano ridotti dalla fame a uno stato orribile. La porta aperta di fronte alla quale Oliver e il suo padrone si fermarono non aveva né battente né un tirante di campanello sicché, procedendo cautamente a tentoni lungo l'angusto e buio corridoio e intimando a Oliver di tenerglisi vicino e non aver paura, l'impresario salì in cima alla prima rampa di scale, e trovandosi davanti a una porta sul pianerottolo vi batté con le nocche. L'aprì una ragazza di tredici o quattordici anni. Dal primo sguardo alla stanza l'impresario capì che erano all'indirizzo cercato. Entrò, seguito da Oliver. Non c'era fuoco nella stanza ma un uomo, come per abitudine, stava piegato sulla stufa fredda. C'era anche una vecchia, che aveva tirato un basso sgabello accanto al focolare e gli sedeva accanto. In un altro angolo c'erano dei bambini cenciosi e in un cantuccio di fronte alla porta una forma giaceva sul pavimento, sotto una vecchia coperta. Oliver rabbrividì quando lo sguardo gli cadde da quella parte, e involontariamente si strinse ancor più al padrone, intuendo che, sotto quella copertura, si nascondeva un cadavere. Il viso dell'uomo era smunto e pallidissimo, capelli e barba arruffati e incolti, gli occhi iniettati di sangue. Quello della vecchia era tutto grinzoso, con due denti superstiti che s'appuntavano sul labbro inferiore e gli occhi lucidi e penetranti. Oliver aveva spavento di guardare all'uno o all'altra, tanto essi sembravano simili ai topi che aveva visto di fuori. «Che nessuno s'accosti a lei», disse l'uomo scattando in piedi con una espressione minacciosa quando l'impresario fece per avvicinarsi. «Indietro! Accidenti a voi, indietro, se ci tenete alla pelle». «Calmatevi, brav'uomo!», disse l'impresario che era piuttosto abituato al dolore in tutte le sue forme. «Calmatevi!». «Te lo dico chiaro e tondo», fece l'uomo stringendo i pugni e battendo con furia il piede sul pavimento. «Te lo dico chiaro e tondo: non la lascio seppellire in terra. Non avrebbe riposo. I vermi la tormenterebbero perché non avrebbero niente da mangiare, tanto è smagrita». L'impresario non replicò nulla a quelle parole sconvolte, ma prendendo dalla tasca una fettuccia s'inginocchiò un istante accanto al cadavere. «Ah!», esclamò l'uomo scoppiando in lacrime e accasciandosi in ginocchio ai piedi della donna morta. «Inginocchiatevi, inginocchiatevi, inginocchiatevi tutti attorno a lei e sentite quello che dico! Io dico che è stata fatta morire di fame. Io non mi sono accorto di quanto stesse male finché non è salita la febbre e non le sono spuntate le ossa dalla pelle. Non ci avevamo né fuoco né candele, ed è morta al buio, al buio. Non poteva neanche vedere la faccia dei suoi figli pure se è morta col nome loro sulle labbra. Sono andato a chiedere l'elemosina per lei sulla strada, e m'hanno arrestato. Quando sono ritornato era già in fin di vita e non mi restano più lacrime da piangere perché l'hanno fatta morire di fame!». S'afferrò i capelli tra le dita e, con un urlo, cadde rotolandosi sul pavimento, con gli occhi stralunati e la bava che gli usciva di bocca. I bambini, terrorizzati, piangevano pietosamente, ma la vecchia, che era rimasta fino ad allora assolutamente calma, come sorda a tutto quanto accadeva, li zittì minacciandoli, e avendo sciolto il nodo al fazzoletto da collo dell'uomo, avanzò malferma fino all'impresario. «Era mia figlia», disse la vecchia ciondolando la testa in direzione del cadavere, e continuò con un ghigno ebete più spettrale perfino della morte lì presente. «Dio mio! Dio mio! E come è strano che io che l'ho fatta nascere, ed ero giovane allora, adesso me ne sto bella viva e vegeta mentre lei è stesa morta, così fredda e rigida! Dio mio! Dio mio!... quando ci penso... è meglio di una recita... è meglio di una recita!». E mentre quella disgraziata creatura balbettava schioccando la lingua con rivoltante allegria, l'impresario si girò per andarsene. «Fermo, fermo», disse la vecchia in un sibilo. «Quando la seppellite? Domani, o domani l'altro? O l'altro giorno ancora? L'ho acconciata io, e devo venirci a piedi, sapete? Mandatemi un mantello, grande e caldo, perché fa un freddo cane. Ma dobbiamo assolutamente mangiare qualche pasticcino e bere un sorso di vino prima di andare! Oh, non fa niente, portate un poco di pane; una pagnotta di pane e una caraffa di acqua. Mangiamo un boccone di pane, caro?», disse invitante, mentre afferrava un lembo del cappotto dell'impresario che di nuovo stava avviandosi alla porta. «Sì, sì», rispose l'impresario, «certo. Una cosa qualsiasi, una cosa qualsiasi!». Si liberò dalla presa della vecchia e prendendo Oliver con sé si affrettò verso l'uscio. Il giorno seguente (la famiglia s'era nel frattempo ristorata con una pagnotta da mezzo quarto e un pezzetto di formaggio portati dallo stesso signor Bumble), Oliver e il padrone tornarono in quella misera dimora. Vi era già arrivato il signor Bumble accompagnato da quattro uomini dell'ospizio che dovevano essere i portatori. Un vecchio mantello nero era stato gettato sugli stracci che coprivano la vecchia e l'uomo, e quando le viti furono avvitate, i portatori sollevarono la bara sulle spalle e uscirono in strada. «Ora è necessario andare di buon passo, signora!», sussurrò Sowerberry all'orecchio della vecchia; «siamo piuttosto in ritardo, e non sta bene fare aspettare il parroco. Avanti, signori... facciamo alla svelta!». Così istruiti, i portatori trotterellarono sotto il loro leggero fardello e i due a lutto cercarono di star dietro meglio che potevano. Il signor Sowerberry e il signor Bumble camminavano davanti a passi svelti mentre Oliver, le cui gambe non erano altrettanto lunghe di quelle del padrone, correva al fianco di lui. Non c'era però tanta necessità di affrettarsi, come aveva sostenuto il signor Sowerberry, dato che, quando giunsero all'oscuro angolo del cimitero infestato di ortiche dov'erano scavate le fosse degli umili parrocchiani, l'officiante non era ancora arrivato e il chierico che sedeva accanto al focolare della sacrestia sembrava ritenere del tutto improbabile che potesse arrivare prima di un'ora o due. Misero quindi una specie di catafalco sull'orlo della fossa, e i due a lutto attesero pazientemente nel fango, sotto una pioggia sottile e fredda, mentre dei monelli coperti di stracci, attratti nel cimitero da quello spettacolo, si misero a giocare chiassosamente a guardia e ladri tra le lapidi, oppure, per variare il divertimento, scavalcavano le bare, saltando da un lato e dall'altro. Il signor Sowerberry e Bumble, amici personali del chierico, stettero con lui accanto al fuoco a leggersi il giornale. Alla fine, quando era passata poco più di un'ora, si videro il signor Bumble, Sowerberry e il chierico correre verso la fossa. Subito dopo apparve l'officiante, che vestì la cotta camminando. Il signor Bumble, tanto per mantenere il decoro, fece assaggiare il bastone a un paio di monelli, e il reverendo, dopo aver letto quanto del servizio funebre poteva comprimersi in quattro minuti, affidò la cotta al chierico e se ne andò. «E ora, Bill, riempi la fossa!», disse Sowerberry al becchino. Non fu un compito di soverchia difficoltà, poiché la fossa era così accatastata di bare che quella più alta arrivava a pochi piedi dalla superficie. Il becchino buttò giù la terra con la pala, la calcò alla meglio con i piedi, si mise la pala in spalla e se ne andò seguito dai ragazzi, i quali vociavano il loro disappunto per la repentina fine del divertimento. «Venite, amico mio!», disse Bumble posando la mano sulla spalla dell'uomo. «Devono chiudere il cimitero». L'uomo, che non s'era mosso da quando aveva preso il suo posto a lato della fossa, si riscosse e, sollevato il capo, fissò la persona che gli aveva parlato, fece pochi passi e cadde a terra svenuto. La vecchia sragionava ed era troppo occupata a piangere la perdita del mantello (l'impresario l'aveva già ripreso) per prestare attenzione all'uomo e così gli gettarono addosso una bacinella di acqua fredda. Quando rinvenne lo condussero fuori dal cimitero sorreggendolo, chiusero il cancello e s'allontanarono ciascuno per la propria strada. «Bene, Oliver», disse Sowerberry mentre camminavano verso casa, «cosa te ne sembra?» «Non male, signore, grazie», replicò Oliver con palese esitazione. «Insomma, non tanto, signore». «Ah, ti ci abituerai, Oliver», disse Sowerberry. «Una volta che ti ci sarai abituato, non farà più effetto, ragazzo mio». Oliver pensò tra sé quanto gli ci fosse voluto al signor Sowerberry per abituarsi, ma giudicò meglio non porgli la domanda e tornò alla bottega ripensando a tutto quanto aveva visto e sentito. Capitolo VI. Oliver, esasperato dagli scherni di Noah, passa all'azione, con grande sorpresa di quello Trascorso il mese di prova, Oliver fu formalmente dichiarato apprendista. Capitò che quella stagione fosse alquanto flagellata da malattie. Come si dice nel commercio, la vendita di bare offriva prospettive di sviluppo, e nel corso di alcune settimane Oliver acquisì una notevole esperienza. Il successo della trovata speculativa del signor Sowerberry sorpassò le sue più rosee previsioni. I più vecchi non ricordavano altri periodi di così virulenta epidemia di scarlattina, o che essa mietesse altrettante vittime tra i più piccini, e Oliver dovette precedere molti cortei funebri, con i nastri del cappello che gli scendevano fino alle ginocchia, per l'indescrivibile ammirazione e trasporto di tutte le mamme della città. E poiché Oliver accompagnava il padrone anche nella maggior parte dei servizi funebri di persone adulte per poter acquisire quell'imperturbabilità di contegno e pieno controllo dei nervi tanto essenziali a ogni compito imprenditore di pompe funebri, egli ebbe parecchie occasioni di osservare la bella rassegnazione e la fortezza d'animo con le quali le persone più composte sopportano le loro perdite e le loro afflizioni. Per esempio, quando a Sowerberry veniva affidata la sepoltura di qualche ricca signora o gentiluomo, circondati da un gran numero di nipoti d'ambo i sessi i quali erano stati assolutamente inconsolabili per tutta la durata della malattia e il cui dolore s'era mostrato incontenibile perfino nelle più pubbliche delle occasioni, accadeva che essi, in privato, fossero quanto mai gai, allegri e soddisfatti, e che conversassero tra loro con tale libertà e brillantezza come se nulla li avesse turbati. Anche i mariti sopportavano la perdita delle consorti con la calma più eroica. Le mogli, dal canto loro, s'abbigliavano in onore dei mariti come se, invece di portare il lutto con abiti neri, avessero in animo di renderlo quanto più attraente e leggiadro possibile. Si poteva inoltre osservare che le signore e i gentiluomini distrutti dal dolore per tutta la durata della cerimonia di sepoltura si riprendevano non appena mettevano piede a casa, e tornavano alla piena normalità prima che avessero finito di sorbire il tè pomeridiano. Tutto questo era molto piacevole ed edificante a vedersi, e Oliver non mancò di contemplarlo ammirato. Che Oliver fosse portato alla rassegnazione dall'esempio di questa brava gente, non ardisco affermarlo con un sufficiente grado di sicurezza, sebbene io sia il suo biografo; posso però sicuramente affermare che per diversi mesi egli continuò a sopportare mitemente le prepotenze e i maltrattamenti di Noah Claypole il quale, geloso ora perché il nuovo venuto era stato promosso al bastone nero e al cappello con i nastri mentre lui, più anziano, rimaneva fermo alla coppola di lana e alle braghe di pelle, lo trattava molto peggio di prima. Charlotte lo trattava male perché così faceva Noah, e la signora Sowerberry gli era nemica giurata perché il signor Sowerberry gli mostrava simpatia: perciò, tra questi tre da un lato e l'abbondanza di funerali dall'altro, Oliver non stava affatto altrettanto bene di quel maiale affamato che fu chiuso per sbaglio nel reparto granaglie di una birreria. E ora, giunto a un momento importantissimo nella storia di Oliver, mi compete registrare un evento in apparenza lieve e trascurabile ma che determinò invece sostanziali cambiamenti per quanto riguarda il suo futuro e le sue prospettive. Un giorno, all'ora solita per la cena, Oliver e Noah erano scesi in cucina per rifocillarsi con un bel pezzo di montone, una libbra e mezza della parte peggiore del collo, quando Charlotte fu chiamata di sopra. Nel breve intervallo che seguì, Noah Claypole, affamato e incattivito, pensò che non poteva votarsi a miglior proposito dell'insultare e tormentare il giovane Oliver Twist. Intento a quest'innocente passatempo, Noah poggiò i piedi sulla tovaglia, tirò i capelli di Oliver, gli torse le orecchie, e dichiarò di ritenerlo un "infiltrato". Gli annunciò inoltre l'intenzione d'essere presente alla sua impiccagione, non importa quando quell'auspicabile evento dovesse aver luogo, e ricorse poi a diversi altri argomenti per tormentare Oliver da quel dispettoso e maligno poverello di parrocchia che era. Poiché tuttavia nessuna di queste punzecchiature sortì l'effetto di far piangere Oliver, Noah tentò una carta ancora più graffiante, invadendo la sfera del privato, facendo ciò che tanti poveri di spirito, ingegni di più bassa levatura e più alta reputazione di Noah, tuttora fanno quando cercano di essere spiritosi. «Orfanello», disse Noah, «come sta tua madre?» «È morta», rispose Oliver, «ma tu non la devi nominare!». Così dicendo Oliver avvampò in viso, il suo respiro si fece ansimante, e labbra e narici ebbero uno strano fremito. Noah Claypole interpretò questi segni come immediati precursori d'un violento scoppio di pianto, ragion per cui tornò alla carica. «Di che cosa è morta, orfanello?», chiese Noah. «Di crepacuore, mi dissero delle vecchie dell'ospizio», rispose Oliver, ma più come se stesse parlando a se stesso che altro. «E credo di sapere cosa significa morire così!». «Trallalallero, trallarallà, orfanello», fece Noah mentre una lacrima scendeva lungo la guancia di Oliver. «Ti metti a frignare adesso, eh?» «Mica è per te», s'affrettò a ribattere Oliver asciugandosi la lacrima. «Non farti idee sballate». «Oh, perciò non è per me, eh?» «No. Non è per te», replicò Oliver secco. «Ecco; basta. Non nominarla più adesso, ti conviene!». «Ti conviene!», esclamò Noah. «Ma bene! Ti conviene! Non essere impudente, orfanello. E tua madre, poi! Bella roba che era. Santo Cielo!». E qui Noah scosse espressivamente il capo, e per l'occasione arricciò il piccolo naso rosso alla massima capacità dei suoi muscoli facciali. «Ce lo sai, orfanello», continuò Noah fattosi ardito perché Oliver taceva, con quel tono di falsa pietà che è la più irritante delle derisioni. «Ce lo sai, orfanello, che adesso non ci puoi fare niente, e non ci potevi fare niente neanche allora; ma mi dispiace... tanto...; ci dispiace a tutti. Ci dispiace di cuore. Ma ce lo saprai, orfanello, che tua madre era una poco di buono». «Che hai detto?», domandò Oliver alzando di scatto la testa. «Una poco di buono, orfanello, che è morta come è morta, altrimenti sarebbe finita ai lavori forzati a Bridewell, o deportata in colonia o impiccata, cosa questa che è pure più probabile delle altre due, non è così?». Oliver, paonazzo di rabbia, gli saltò addosso e rovesciando sedia e tavolo afferrò Noah alla gola, lo strattonò con furia fino a fargli battere i denti nel cranio e, raccogliendo tutta la forza di cui era capace in un sol pugno, lo stese a terra. Fino a un minuto prima, quel ragazzo era stato la mite, tranquilla e triste creatura che di lui aveva fatto l'aspra educazione ricevuta. Ma il suo animo s'era infine ridestato, e il crudele insulto alla madre morta gli aveva fatto ribollire il sangue. Il petto gli si gonfiò, gli occhi gli brillarono vividi e assunse una postura eretta. Tutta la sua persona cambiò, mentre dominava con lo sguardo il vile aguzzino steso ora ai suoi piedi e lo sfidava con una energia che gli era stata fino ad allora sconosciuta. «Mi ammazza!», farfugliò Noah. «Charlotte! Padrona! Il ragazzo mi ammazza! Aiuto! Aiuto! Oliver è ammattito. Char...lotte!». In risposta alle grida di Noah s'udì l'acuto grido di Charlotte seguito da un acuto ancora più forte della signora Sowerberry: la prima sbucò da una porticina laterale della cucina e la seconda si fermò sulle scale finché non fu assolutamente certa che lo scendere non andasse a discapito della sua vita. «O piccola canaglia che non sei altro!», strillò Charlotte afferrando Oliver con quanta forza aveva, il che era più o meno equivalente a quella d'un uomo abbastanza robusto e in ottima forma. «Oh, fur-fan-tel-lo in-gra-to, mo-struo-so e as-sas-si-no!». E Charlotte intercalava ogni sillaba assestando a Oliver un colpo con quanta forza aveva, accompagnandolo con uno strillo a beneficio dei presenti. Il pugno di Charlotte non era per nulla dei più leggeri, ma a scongiurarne una ridotta efficacia nel calmare i bollori di Oliver, la signora Sowerberry si precipitò in cucina e aiutò a reggerlo con una mano mentre con l'altra gli graffiava la faccia. In questa favorevole contingenza Noah si risollevò da terra e tempestò Oliver da tergo. Era però un esercizio troppo violento per durare a lungo, e quando tutti e tre furono sfiniti da quel pestaggio, trascinarono Oliver, che gridava e si dimenava per niente ammansito, nel deposito del carbone e là lo rinchiusero. Dopodiché la signora Sowerberry si lasciò cadere su una sedia e scoppiò a piangere. «Dio la benedica! Ora le piglia la crisi!», disse Charlotte. «Un bicchiere d'acqua, Noah caro; sbrigati». «Oh Charlotte», disse la signora Sowerberry, articolando imperfettamente, vuoi per una certa carenza respiratoria vuoi per l'abbondante acqua fredda che Noah le aveva rovesciato sulla testa e sulle spalle. «Oh, Charlotte, che fortuna che abbiamo avuto a non essere uccise nel sonno!». «Ah! Una fortuna davvero!», concordò l'altra. «Spero solo che questo insegnerà al padrone a non prendersi più in casa queste creature del demonio, assassini nati e ladri patentati fin dalla culla. Povero Noah! Era quasi già spacciato quando sono entrata». «Povero ragazzo», disse la signora Sowerberry guardando afflitta quel meschino. Noah, il cui più alto bottone del panciotto arrivava più o meno alla testa di Oliver, si strofinò gli occhi con l'interno dei polsi mentre veniva così commiserato, e si produsse in qualche commovente lacrima e singulto. «Cosa dobbiamo fare!», esclamò la signora Sowerberry. «Il padrone non è in casa, e non ci sono neanche altri uomini. In dieci minuti avrà abbattuto la porta a calci». I veementi assalti di Oliver contro le tavole della suddetta rendevano estremamente probabile quell'evenienza. «Oh poveri noi! Non lo so signora!», fece Charlotte. «A meno che non mandiamo a chiamare qualche guardia». «Oppure l'esercito», suggerì il signor Claypole. «No. No», disse la signora Sowerberry rammentandosi del vecchio mentore di Oliver. «Corri a chiamare il signor Bumble, Noah, e digli di venire subito qui senza perdere neanche un minuto. Lascia stare il cappello! Sbrigati! E mentre corri premi un coltello su quell'occhio nero. Terrà giù il gonfiore». Noah non stette lì a rispondere ma partì a tutta velocità. E molto stupirono, le persone a passeggio, nel vedere un poverello fiondarsi lungo le strade a scapicollo, senza cappello in testa e con la lama d'un coltello a serramanico sull'occhio. Capitolo VII. Oliver si ribella ancora Noah Claypole corse lungo le strade di gran carriera e non si fermò neanche una volta a riprender fiato finché non fu innanzi al cancello dell'ospizio. Dopo essersi riposato per circa un minuto, quanto bastava per poter simulare singhiozzi incontenibili, lacrime e spavento, picchiò forte al portoncino e presentò un viso così afflitto al vecchio pensionante venuto ad aprire che perfino questo, abituato a vedersi attorno solo visi afflitti nel migliore dei casi, ebbe un sussulto di meraviglia. «Ebbene, che c'è, ragazzo mio?», fece il vecchio. «Il signor Bumble! Il signor Bumble!», esclamò Noah, con ben simulato sgomento e con voce così acuta e agitata che non solo colpì l'orecchio del signor Bumble, il quale per caso era nei paraggi, ma lo allarmò a tal punto che si precipitò nel cortile senza il tricorno curiosa e notevole circostanza, questa, in quanto ci mostra che perfino un custode, sotto la spinta di un improvviso e potente impulso, possa essere vittima di una momentanea perdita di autocontrollo e di oblio della dignità personale. «Oh! Signor Bumble, signore!», disse Noah. «Oliver, signore... Oliver ha...». «Cosa? Cosa?», interloquì il signor Bumble, con un lampo di piacere negli occhi metallici. «Non sarà scappato? Non sarà scappato, eh, Noah?» «No, signore, no. Non è scappato via, ma è imbizzarrito», rispose Noah. «Ha cercato di ammazzarmi, signore, e poi ha cercato di ammazzare Charlotte e poi anche la padrona. Oh! Mi fa un male cane! Un male cane, signore, scusate!». E qui Noah, come fosse un'anguilla, piegò e contorse il corpo con tale varietà da far intendere al signor Bumble che il violento e sanguinario attacco di Oliver Twist gli aveva infetto profonde ferite interne e che in quello stesso istante esse gli davano il più acuto tormento. Quando Noah vide che le notizie portate avevano paralizzato del tutto il signor Bumble, conferì a quelle efficacia aggiuntiva dolendosi delle sue terribili ferite con lamenti dieci volte più acuti dei precedenti, e quando si accorse di un gentiluomo in panciotto bianco che attraversava il cortile dette ai lamenti un tono più tragico che mai, ritenendo giustamente che fosse quanto mai opportuno attirare l'attenzione e suscitare l'indignazione del detto gentiluomo. L'attenzione del gentiluomo fu subito attratta, poiché non aveva fatto tre passi che si voltò adirato e chiese perché mai quel piccolo bastardo strillasse così e perché mai il signor Bumble non gli somministrasse qualcosa per rendere l'emissione di quelle strida un processo indipendente dalla volontà del piccolo bastardo in questione. «È un poverello che frequenta la scuola di carità, signore», replicò il signor Bumble, «e stava sul punto di essere ammazzato... di essere ammazzato, signore... dal piccolo Oliver Twist». «Per Giove!», esclamò il gentiluomo in panciotto bianco fermandosi di colpo. «Lo sapevo! Fin dall'inizio ho avuto lo strano presentimento che quel piccolo selvaggio impertinente sarebbe finito impiccato!». «Non solo, ma ha anche cercato di ammazzare la serva», disse il signor Bumble, cinereo in viso. «E anche la padrona», s'interpose il signor Claypole. «E mi pare anche il padrone, non è vero, Noah?», aggiunse il signor Bumble. «No. Perché era fuori, altrimenti avrebbe cercato di ammazzare pure lui», rispose Noah. «Così ha detto». «Ah! Così ha detto, eh, ragazzo?», chiese il gentiluomo in panciotto bianco. «Sì, signore», rispose Noah. «E per piacere, signore, la padrona vuole sapere se il signor Bumble ha un attimo di tempo per venire subito da noi a frustarlo, perché il padrone è fuori». «Certo, ragazzo mio, certo», disse il gentiluomo in panciotto bianco sorridendo benevolmente e dando buffetti in testa a Noah che era più alto di lui di circa tre pollici. «Tu sei un bravo ragazzo... un bravissimo ragazzo. Eccoti mezzo penny. Bumble, fate una capatina da Sowerberry, col bastone, e regolatevi come credete. Non risparmiatelo, Bumble». «No, signore, non lo risparmierò», ribatté il custode sistemando la funicella attorta a un capo del bastone in previsione di fustigazioni parrocchiali. «Dite anche a Sowerberry di non risparmiarlo. Da lui non si otterrà mai nulla se non a forza di botte e scudisciate», disse il gentiluomo in panciotto bianco. «Ci penso io, signore», replicò il custode. E quando tricorno e bastone furono sistemati con piena soddisfazione del proprietario, il signor Bumble e Noah Claypole si diressero a tutta velocità alla bottega dell'impresario. Qui le cose non erano affatto migliorate rispetto a prima, giacché il signor Sowerberry non aveva ancora fatto ritorno e Oliver continuava a menare calci con intatto vigore alla porticina del ripostiglio. La relazione che la signora Sowerberry e Charlotte fecero della sua ferocia fu di una natura così allarmante che il signor Bumble ritenne prudente parlamentare prima di aprire la porta. A tal fine e a mo' di preludio, sferrò un calcio alla porta; dopodiché, messa la bocca al buco della serratura, in un tono basso che voleva impressionare, chiamò: «Oliver!». «Fatemi uscire di qui, capito?», replicò Oliver dall'interno. «Riconosci la mia voce Oliver?», fece il signor Bumble. «Sì», rispose Oliver. «E non hai paura, ragazzo? Non tremi mentre ti parlo?», disse il signor Bumble. «No!», replicò arditamente Oliver. La risposta, così diversa da quella che si attendeva e da quelle che era abituato a ricevere, sconcertò non poco il signor Bumble. S'allontanò dal buco della serratura, si risollevò in tutta la sua altezza e in muto sbigottimento guardò a turno i tre astanti. «Oh, vedete, signor Bumble, dev'essere impazzito», disse la signora Sowerberry. «Nessun ragazzo con del sale in zucca avrebbe il coraggio di parlarvi così». «Non è la pazzia, signora», replicò il signor Bumble dopo alcuni istanti di profonda meditazione. «È la carne». «Che?», esclamò la signora Sowerberry. «La carne, signora! La carne!», replicò il signor Bumble con severità. «Gli avete dato più cibo del dovuto, signora, e così facendo avete artificialmente destato in lui un animo, e uno spirito, che non si addicono per niente a uno della sua condizione. La Direzione, i cui membri sono tutti dei filosofi sperimentali, non mancherà di rimproverarvelo, signora Sowerberry. Che cosa hanno a che fare i poveri con l'animo e con lo spirito? È già abbastanza se li teniamo fisicamente in vita. Se l'aveste nutrito a farinata, signora, questo non sarebbe accaduto». «Oh povera me, povera me!», piagnucolò la signora Sowerberry volgendo gli occhi al soffitto della cucina. «Ecco quello che succede a essere magnanimi!». La magnanimità della signora Sowerberry era consistita nell'elargire al ragazzo tutti gli avanzi e gli scarti che nessun altro avrebbe mangiato, per cui ella assunse un'aria di profonda compunzione e umiltà nel sostenere volontariamente le pesanti accuse del signor Bumble; delle quali, a dire il vero, ella rimaneva del tutto innocente tanto in pensieri, quanto in parole o opere. «Ah!», disse il signor Bumble quando ella riabbassò lo sguardo. «Quello che possiamo fare ora, a mio modesto giudizio, è di lasciarlo nella buca un giorno o due per fargli patire un po' la fame, e poi lo tiriamo fuori e lo manteniamo a farinata per tutto il periodo di apprendistato. Viene da una cattiva famiglia, signora Sowerberry! Teste calde. Sia l'infermiera sia il dottore hanno detto che la madre è riuscita ad arrivare fino da noi superando ostacoli e patendo sofferenze che avrebbero ucciso qualsiasi altra donna di buona costituzione settimane prima». A questo punto del discorso di Bumble, Oliver, persuaso da quanto poteva sentire che malignavano ancora sul conto della madre, ricominciò a scalciare con una violenza tale da coprire ogni altro suono. Proprio in quel momento tornò anche il signor Sowerberry il quale, informato delle malefatte di Oliver con quella dovizia di esagerazioni che le signore ritennero necessarie per mandarlo su tutte le furie, aprì in un attimo la porticina e trascinò fuori il ribelle apprendista per il collo. Gli abiti di Oliver erano tutti strappati per la colluttazione precedente; il viso era pesto e lacero di graffi, e i capelli gli cadevano arruffati sulla fronte. Ma era ancora acceso di rabbia e quando lo tirarono fuori della prigione guardò in cagnesco Noah mostrandosi tutt'altro che ammansito. «Ora, farai il bravo ragazzo, non è vero?», disse il signor Sowerberry scuotendolo e assestandogli un pugno sull'orecchio. «Ha detto cattiverie sul nome di mia madre», ribatté Oliver. «Beh, e allora? Furfantello ingrato che non sei altro!», disse la signora Sowerberry. «Meritava questo e altro, la tua mamma». «No», disse Oliver. «Sì», disse la signora Sowerberry. «È una bugia!», fece Oliver. La signora Sowerberry scoppiò in pianto. Quel profluvio di lacrime non lasciava al signor Sowerberry alternative. Se per un istante egli avesse esitato a punire Oliver con la massima severità, ogni lettore d'una qualche esperienza capirà bene che, secondo tutti i precedenti in materia di dispute matrimoniali, egli sarebbe stato un bruto, un marito snaturato, l'insulto fatto persona, la vile imitazione d'un uomo, e varie altre cose di lodevole natura, troppo numerose per essere narrate negli angusti limiti di questo capitolo. A onor del vero, per quanto era in suo potere - non grande, in effetti - egli era piuttosto ben disposto verso il ragazzo, forse perché rientrava nel suo interesse, o forse perché stava antipatico alla moglie. Quelle lacrime, tuttavia, non gli lasciavano alternative, e così gli elargì all'istante una tale gragnola di botte da lasciare soddisfatta persino la signora Sowerberry e da rendere del tutto superflua la successiva applicazione del bastone da parte del signor Bumble. Per il resto del giorno rimase chiuso nel retrocucina in compagnia di una pompa e di una fetta di pane. A sera, la signora Sowerberry, dopo aver ulteriormente inveito niente affatto lodevolmente, attraverso la porta, sul conto della madre, si affacciò nella stanza e tra gli sghignazzi e le derisioni di Noah e Charlotte ordinò a Oliver di salire di sopra al suo lugubre giaciglio. Solo quando fu lasciato solo nel silenzio e nell'immobilità della cupa bottega dell'impresario Oliver dette libero sfogo a quei sentimenti che i maltrattamenti del giorno avevano potuto generare in lui, soltanto un bimbo, o poco più. Aveva respinto le loro parole di scherno con uno sguardo sprezzante; aveva sopportato la frusta senza un grido, sentendo il cuore gonfio di un orgoglio capace di fargli trattenere un gemito fino all'estremo, anche se fosse stato messo sui carboni ardenti. Ma ora che nessuno poteva sentirlo o vederlo, cadde a terra in ginocchio e nascondendosi il viso tra le mani, pianse le lacrime che Dio ci manda a prova della nostra migliore natura: e voglia che pochi altri piccoli abbiano ragione di piangerle al suo cospetto! Oliver rimase così per parecchio tempo, immobile. Sull'ultimo mozzicone di candela bruciava una debole fiammella quando si alzò. Dopo essersi guardato intorno con circospezione, teso l'orecchio, aprì senza far rumore l'uscio e scrutò di fuori. Era una notte fredda e tenebrosa. Le stelle, agli occhi del ragazzo, sembravano ancora più alte e distanti di come gli erano apparse altre volte. Non spirava alito di vento, e le cupe ombre che gli alberi gettavano in basso erano lugubri e sepolcrali nella loro fissità. Richiuse piano l'uscio e, sfruttando l'ultima luce della candela per farsi un fagotto dei pochi indumenti che gli restavano, sedette su una panca ad aspettare il mattino. Quando i primi raggi di luce filtrarono attraverso gli interstizi delle imposte Oliver si alzò e aprì di nuovo l'uscio. Un timido sguardo intorno, un momento soltanto di esitazione e, richiuso dietro di sé l'uscio, si trovò in strada. Guardò a destra e a sinistra, incerto sulla direzione da prendere. Ricordò di aver visto dei carri allontanarsi dalla città arrancando su per la collina. Prese quella stessa strada, e giunto a un sentiero conosciuto che si inoltrava nella campagna e che conduceva, dopo un po', sulla strada maestra, lo prese e camminò a passo rapido. Oliver ricordava bene che lungo quel sentiero aveva trottato accanto al signor Bumble quando l'aveva condotto dalla grangia all'ospizio. Doveva passare proprio davanti alla casa. Il cuore gli batté forte quando ci pensò, e fu sul punto di tornare indietro. Ma aveva già fatto parecchia strada, e avrebbe perso molto tempo in quel modo. E poi, era così presto che non c'era da aver paura di esser visti. E così andò innanzi. Raggiunse la casa. Niente rivelava che chi l'abitava fosse in piedi a quell'ora del mattino. Oliver si fermò e dette un'occhiata nel giardino. Vide un bambino che accudiva le piante in uno dei letti di fiori e lui, fermandosi, alzò un viso pallido, i cui tratti erano quelli di un suo vecchio compagno. Oliver fu contento di rivederlo prima di andarsene giacché gli era stato amico e compagno di giochi, anche se più piccolo. Tante e tante volte avevano patito insieme le punizioni, la fame, ed erano stati rinchiusi. «Zitto, Dick!», disse Oliver quando il ragazzo corse al cancello e protese i braccìni esili tra le sbarre per salutarlo. «C'è qualcuno alzato?» «Solo io», rispose il bambino. «Non dire a nessuno che mi hai visto, Dick», disse Oliver. «Sto scappando. Mi maltrattavano e mi picchiavano, Dick, e sto andando a cercare fortuna lontano di qui, non so dove. Ma come sei pallido, tu!». «Ho sentito il dottore dire che sarei morto», replicò il bambino con un lieve sorriso. «Sono tanto contento d'averti rivisto, caro Oliver; ma scappa, scappa!». «Sì, sì, subito, dopo averti salutato, Dick», replicò Oliver. «Ti rivedrò ancora, lo sento. E tu starai bene e sarai felice!». «Lo spero», rispose il bambino. «Ma dopo che sarò morto, non prima. Mi sa che il dottore ha ragione, Oliver, perché non faccio altro che sognare il cielo e gli angeli, e volti gentili, e non li vedo quando sono sveglio. Dammi un bacio», disse poi il bambino salendo sul basso cancello e gettando le braccia al collo di Oliver. «Addio, caro amico! Dio ti benedica!». Quella benedizione veniva dalle labbra di un bambino, ma mai ne era stata invocata alcuna sul capo di Oliver. Attraverso tutte le prove e sofferenze, tutte le lotte e cambiamenti seguenti, per il resto della sua vita, Oliver non la dimenticò mai. Capitolo VIII. Oliver si reca a Londra. Sulla strada incontra un curioso giovanotto Oliver arrivò alla fine del sentiero, segnalato da un palo all'incrocio, e fu di nuovo sulla strada maestra. Erano ormai le otto. Si mise a correre, benché si trovasse ora a quasi cinque miglia dalla cittadina, fino al mezzogiorno, ogni tanto nascondendosi dietro qualche cespuglio nel timore di poter essere inseguito e raggiunto. Infine, si sedette a riposare accanto a una pietra miliare e per la prima volta cominciò a pensare a dove andare e come guadagnarsi di che vivere. La pietra miliare accanto alla quale s'era seduto portava inscritta a grandi caratteri l'informazione che quel punto si trovava a settanta miglia esatte da Londra. Tanti pensieri gli si affollarono in mente a quel nome. Londra! Città immensa e sconfinata! Lì nessuno, neanche il signor Bumble, avrebbe mai potuto ritrovarlo. E poi, aveva spesso sentito dire dai vecchi dell'ospizio che a un ragazzo di spirito non poteva mancare nulla a Londra, e che in quella sterminata città c'erano modi di guadagnarsi da vivere di cui chi era cresciuto in campagna non aveva neanche l'idea. Era il posto giusto per un orfanello vagabondo che rischiava di morire in strada senza il soccorso di qualcuno. Rimuginando questi pensieri, si rimise in piedi e riprese il cammino. Aveva ridotto la distanza che lo separava da Londra di quattro miglia buone quando gli venne da pensare a ciò che l'attendeva, prima di poter sperare di giungere a destinazione. Perplesso sul da farsi, rallentò quindi il passo, e cominciò a pensare a come arrivarci. Nel fagottino c'era una crosta di pane, una camicia ruvida e due paia di calzini. Nel taschino aveva anche un penny, dono di Sowerberry per un funerale in cui Oliver aveva figurato meglio del solito. «Una camicia pulita», pensò Oliver, «sarà pure una bella cosa; e due paia di calzini, e un penny saranno pure una bella cosa, ma servono a poco quando si ha davanti una passeggiata di sessantacinque miglia, d'inverno». I pensieri di Oliver tuttavia, come quelli di tante altre persone, prontissimi a mostrargli tutte le difficoltà del caso, erano del tutto incapaci a indicargli un modo possibile per superarle e così, dopo aver riflettuto invano per un po', spostò il peso del suo piccolo fardello sull'altra spalla e riprese il faticoso cammino. Coprì venti miglia, quel giorno, mangiucchiando solo qualche boccone della crosta di pane e bevendo qualche sorso d'acqua supplicato alle umili case lungo la strada. Giunta la sera, entrò in un campo e infilatosi in un pagliaio decise di restarvi fino al mattino. Ebbe paura all'inizio, perché il vento ululava lugubremente sui campi deserti, era affamato e intirizzito, e più solo di quanto non fosse mai stato prima. Spossato dal lungo cammino, tuttavia, non tardò ad addormentarsi e a dimenticare tutti i suoi guai. Quando il mattino dopo si svegliò sentiva le membra rigide dal freddo, ed era così affamato che fu costretto a spendere il suo penny per una pagnottella nel primo paesetto che si trovò ad attraversare. Aveva fatto appena dodici miglia, quando la notte sopraggiunse di nuovo. I piedi gli dolevano e le gambe erano così deboli e malferme da reggerlo appena. Un'altra notte passata all'addiaccio, all'aria fredda e umida, peggiorò il suo stato, e quando il mattino seguente si rimise in cammino potè a malapena trascinarsi avanti. Attese alla base di una collina ripida che sopraggiungesse una carrozza per chiedere l'elemosina ai passeggeri seduti all'esterno, ma pochi gli badarono, e anche quelli l'invitarono prima ad aspettare finché la carrozza non fosse arrivata in cima e, poi, a far vedere quanto fosse capace di correre per mezzo penny. Per un po' il piccolo Oliver cercò di rimanere dietro alla carrozza, ma dovette desistere per la stanchezza e le piaghe ai piedi. Vedendo ciò, i passeggeri a cassetta rimisero il loro mezzo penny nel taschino, dichiarando che era uno scansafatiche e che non meritava nulla, mentre la carrozza s'allontanava fragorosamente lasciandosi dietro solo un nugolo di polvere. In qualche villaggio erano affissi avvisi che, a grandi caratteri dipinti, ammonivano a non chiedere l'elemosina in quel distretto, pena l'incarcerazione. Questo spaventò Oliver, contento se non altro di allontanarsene il più in fretta possibile. In altri, si metteva in piedi vicino ai cortili delle locande e guardava sconsolato chiunque passasse; procedura che in genere si concludeva con la padrona che ordinava a qualche giovane postiglione gironzolante nei paraggi di allontanare quello strano ragazzo, sospettato di voler rubare qualcosa. Se chiedeva l'elemosina alle fattorie, nove volte su dieci minacciavano di aizzargli contro il cane, e quando osava affacciarsi in qualche negozio, cominciavano a parlare del custode e a Oliver saltava il cuore in gola - la sola cosa che avesse in gola per parecchie ore di fila. In effetti, se non fosse stato per un compassionevole guardabarriere sulla strada e per una vecchia di buon cuore, i guai di Oliver avrebbero avuto rapido termine secondo le stesse modalità che avevano posto fine a quelli della madre; in altre parole, si sarebbe sicuramente accasciato lungo la strada maestra e lì sarebbe morto. Ma l'addetto al pedaggio gli dette da mangiare del pane e formaggio e la vecchia, che aveva un nipote incorso in un naufragio e che da allora andava vagabondo, a piedi nudi, da qualche parte del globo, s'impietosì del povero orfanello, e gli dette il poco che aveva - e forse anche più - con parole così tenere e gentili, e lacrime di compassione e pietà, che egli le sentì nel profondo dell'animo più delle sue stesse sofferenze presenti o passate. Il settimo giorno da quando aveva lasciato il suo luogo di nascita, di buon mattino, Oliver entrò zoppicante nella cittadina di Barnet. Le imposte delle finestre erano chiuse e le strade deserte; non un'anima era in piedi per iniziare il lavoro giornaliero. Il sole sorgeva in tutta la sua splendente bellezza ma la luce serviva solo a mostrare al ragazzo, seduto sul gradino di un uscio, i piedi sanguinanti, la polvere che lo copriva e tutta la sua miseria e desolazione. Poco a poco, le imposte furono aperte, le tendine alle finestre furono alzate, e la gente cominciò a scendere in strada. Alcuni si fermavano qualche istante per osservare Oliver, o si giravano per guardarlo mentre passavano di fretta, ma nessuno gli porgeva aiuto o si peritava di chiedergli da dove venisse. Oliver non aveva più coraggio di elemosinare, e restava seduto lì. Da un po' era accucciato su quel gradino, meravigliandosi delle numerosissime locande (una casa su due in Barnet era una locanda, grande o piccola), e guardando stupefatto le carrozze che passavano e pensando quanto fosse strano che in poche ore potessero fare agevolmente ciò che a lui aveva richiesto una intera settimana di coraggio e sopportazione, ben oltre i limiti di un ragazzo dei suoi anni, quando si riscosse al vedere che un ragazzo passatogli vicino qualche minuto prima, apparentemente senza badargli, era tornato indietro e lo squadrava con il massimo interesse dall'altro lato della strada. All'inizio non ci fece molta attenzione ma poi, giacché il ragazzo rimaneva fisso in quella stessa posizione, Oliver sollevò il capo e lo guardò attentamente a sua volta. Al che il ragazzo attraversò la strada e avvicinandosi a Oliver disse:«Salute, amico, come ti va?». Il ragazzo che aveva così interrogato il piccolo vagabondo era più o meno della sua stessa età, ma aveva l'aspetto più curioso che Oliver avesse mai visto. Aveva il naso a patata, la fronte bassa, una faccia piuttosto comune, ed era sporco quanto poteva essere uno grande come lui, ma aveva l'aria e i modi di un uomo vissuto. Era basso per la sua età, con gambe alquanto arcuate, e occhi piccoli appuntiti e biechi. Il cappello era poggiato in testa con tanta levità da far temere che potesse scivolare da un momento all'altro; e così sarebbe accaduto, piuttosto spesso, se il legittimo proprietario non avesse usato l'accortezza di scuotere bruscamente la testa di tanto in tanto, con quella mossa rimettendolo di nuovo a posto. Portava un cappottone che quasi gli arrivava alle calcagna. I risvolti delle maniche li aveva tirati su fino a metà braccio, in modo da consentire alle mani di spuntar fuori, con l'intenzione ultima, a quanto sembrava, di ficcarsele nelle tasche delle brache di fustagno, dove in effetti le teneva. Nell'insieme, era un bullette aitante quanto lo consentivano i suoi quattro piedi e sei pollici scarsi di statura, stivaletti compresi. «Salute, amico, come te la passi?», chiese a Oliver lo strano giovane. «Sono tanto affamato e stanco», replicò Oliver con le lacrime agli occhi. «Sono sette giorni che cammino». «Sette giorni a camminare!», ribatté il ragazzo. «Ah! Ho capito. Un gufo ha emesso sentenza, eh? Ma...», aggiunse notando lo sguardo di sorpresa di Oliver, «lo sai o no cos'è un gufo, collega?». Oliver rispose mitemente d'aver sentito così indicare un certo animale notturno. «Santo cielo, che allocco!», esclamò il ragazzo. «Un gufo è un giudice, e quando si va per la sentenza di un gufo non si procede in avanti, ma all'insù, e in basso non si scende. Sei mai stato alla macina?» «Come alla macina?» «Alla macina! Che vuol dire alla macina?... Alla macina! Quella piazzata in uno spazio così ristretto che potrebbe girare in un orcio di pietra e funziona meglio quando la gente è in strettezze anzi che no, datosi che allora non manca la manodopera. Ma andiamo», disse il ragazzo; «ti ci vuole qualcosa da mettere sotto i denti, e l'avrai. Ora come ora sono un poco a secco, soltanto uno scellino e mezzo penny, ma finché dura pago io. Su! Drizza i garretti. In gamba, dai! Forza!». Aiutato Oliver ad alzarsi, il ragazzo lo condusse in una bottega dove comprò un bel po' di prosciutto cotto e una pagnotta da mezzo quarto; o, com'egli disse, «una scura da quattro». Staccato un pezzo di crosta dalla pagnotta, mise poi il prosciutto al riparo dalla polvere usando l'ingegnosissimo espediente di ficcarcelo dentro, e sistemata la pagnotta sotto il braccio s'infilò in una piccola mescita facendo strada fino ad una saletta appartata sul retro. Qui, dietro ordine del misterioso ragazzo, portarono una caraffa di birra, e Oliver, invitato dal suo nuovo compagno, mangiò e bevve con gusto. Di tanto in tanto, mentre egli così si rifocillava, lo strano ragazzo lo guardava molto attentamente. «Vai a Londra?», chiese questo, quando Oliver ebbe finito. «Sì» «Hai dove stare?» «No». «Hai soldi?» «No». Il ragazzo emise un fischio e si ficcò le braccia in tasca per quanto glielo consentivano le larghe maniche del cappotto. «Tu vivi a Londra?», chiese Oliver. «Sì, quando sono a casa», replicò l'altro. «Penso che hai bisogno di un posto per dormire stanotte, non è così?» «Sì», rispose Oliver. «Non ho dormito sotto un tetto da quando ho lasciato il mio paese». «Non lambiccarti il cervello per questo», disse il ragazzo. «Devo essere a Londra stasera, e ci conosco un bravo signore che ti darà l'alloggio a gratis, senza chiederti nulla; ossia, se gli vieni presentato da qualcuno che conosce. E forse che non mi conosce, a me? Ah, no! Per niente! Per niente affatto. No di certo!». Il ragazzo sorrise, come a sottintendere che le ultime battute del discorso andavano intese in senso ironico, e nel mentre finì la sua birra. L'inattesa offerta di un riparo era troppo allettante per essere rifiutata, anche perché fu immediatamente seguita dall'assicurazione che il signore di cui sopra gli avrebbe certamente trovato un'occupazione in men che non si dica. Ciò dette luogo a un dialogo più amichevole e confidenziale, nel corso del quale Oliver scoprì che il nome del ragazzo era Jack Dawkins e che era un protetto, cioè nelle particolari grazie, del summenzionato anziano signore. L'aspetto di mastro Dawkins non costituiva la migliore raccomandazione dei vantaggi che le premure del padrone ottenevano per i suoi protetti. Ma poiché egli aveva uno stile di conversazione piuttosto brioso e malandrino e poiché inoltre ammetteva di esser meglio conosciuto tra i suoi amici intimi col nomignolo di "Dodger lo Svelto", Oliver concluse che, su quel carattere dissipato e strafottente, i precetti del suo benefattore erano andati completamente perduti. Con tale impressione, Oliver decise in segreto che avrebbe cercato di guadagnarsi i favori di quel gentiluomo al più presto e se avesse trovato che Dodger era assolutamente incorreggibile - nulla di più facile - allora avrebbe disconosciuto quell'amicizia. Poiché John Dawkins aveva certe riserve per entrare a Londra prima che facesse buio, erano circa le undici quando raggiunsero il posto di guardia a Islington. Passarono l'Angelo ed entrarono nella via St. John; presero la stradina che sbuca al Sadler's Wells Theatre, percorsero Exmouth Street e Coppice-row, poi giù fino alla piazzetta a fianco dell'ospizio, quindi attraverso l'ormai classico territorio un tempo rispondente al nome di Hockley-in-the-Hole, da lì a Little Saffron-hill e di conseguenza a Saffron-hill Superiore, che Dodger attraversò di fretta, raccomandando a Oliver di stargli attaccato alle calcagna. Sebbene Oliver avesse il suo daffare nel non perdere di vista la sua guida, non potè mancare di dare qualche occhiata da un lato e dall'altro della strada mentre l'attraversavano. Non aveva mai visto luoghi più sporchi e squallidi. La strada era angusta e infangata, e l'aria impregnata di odori nauseabondi. C'era una quantità di negoziucci, ma i soli articoli disponibili sembravano le frotte di ragazzi che, ancora a quell'ora di notte, entravano e uscivano dalle porte o si sentivano gridare dall'interno. I soli luoghi che sembravano prosperare in quella desolazione erano le locande, dove irlandesi della peggiore risma s'azzuffavano di santa ragione. Vicoli e cortiletti nascosti, qua e là diramanti dalla strada principale, mostravano mucchi di case in cui ubriachi e donne si rivoltavano letteralmente nella sporcizia, e da parecchi di quei varchi spuntavano furtivi grossi individui dall'aspetto poco raccomandabile, con propositi tutt'altro che innocui o edificanti. Quando Oliver stava già valutando l'opportunità di darsela a gambe, giunsero alla base della collinetta. Afferrandolo per il braccio, la sua guida aprì la porta di una casa vicino Field-lane, e tiratolo dentro al corridoio la richiuse subito. «Chi va là!», si sentì gridare una voce dal basso in risposta a un fischio di Dodger. «Batti e chiudi!», replicò. Si trattava evidentemente di una parola d'ordine o un segnale che tutto era a posto, poiché dalla parte opposta del lungo corridoio baluginò la fioca luce di una candela e la faccia d'un uomo spuntò dove la balaustra della scala della cucina s'era rotta. «Siete in due laggiù», fece quell'uomo avanzando ancor più la candela e riparandosi gli occhi con la mano. «Chi è l'altro?» «È uno nuovo», replicò John Dawkins spingendo innanzi Oliver. «Da dove viene?» «Dal paese della cuccagna. Fagin è di sopra?» «Sì, passa il bottino al setaccio. Sali!». La candela si ritirò e la faccia disparve. Oliver, con una mano che saggiava a tentoni la strada e l'altra nella ferma presa del compagno, saliva con grande difficoltà su per le scale buie e cadenti mentre la sua guida procedeva con una rapidità e una sicurezza che mostravano come gli fossero ben conosciute. Spalancò la porta d'una stanza sul retro, ed entrò tirandosi dietro Oliver. Le pareti e il soffitto della stanza erano così sporchi e vecchi da sembrare di un perfetto color nero. Innanzi al fuoco c'era un tavolo di pino, e su di esso una candela ficcata in una bottiglia di ginger, due o tre caraffe di peltro, una pagnotta di pane, del burro e un piatto. In una padella sul fuoco, assicurata da una cordicella alla mensola del camino, cuocevano delle salsicce, e curvo su di esse, con un forchettone da cucina in mano, c'era un ebreo molto avanti negli anni, il cui volto maligno e repulsivo era nascosto da una quantità di capelli rossi stoppacciosi. Aveva addosso una vestaglia di flanella unta, aperta al collo, e pareva dividere la sua attenzione tra la padella da una parte e un appendiabiti dall'altra, dal quale pendevano un gran numero di fazzoletti di seta. Sul pavimento erano ammucchiati diversi giacigli ricavati da sacchi vecchi, e seduti attorno al tavolo stavano quattro o cinque ragazzi, tutti più piccoli di Dodger, che fumavano da lunghe pipe di terracotta e bevevano liquori con l'aria di uomini vissuti. Si fecero tutti attorno al loro camerata mentre questi sussurrava qualcosa all'orecchio dell'ebreo. Poi si volsero con un ghigno in direzione di Oliver, come videro fare all'ebreo col forchettone in mano. «Fagin, questo è il mio amico Oliver Twist», disse John Dawkins. L'ebreo fece un ghigno, e stringendo la mano di Oliver, con un profondo inchino, disse che sperava nell'onore della sua amicizia. Al che tutti gli altri ragazzi con le pipe gli si radunarono intorno e gli strinsero tutt'e due le mani con vigore, in special modo quella che stringeva il fardello. Uno di quei giovanotti pareva stare sulle spine se non gli appendeva il cappello mentre un altro fu così premuroso da ficcargli le mani in tasca per risparmiare a Oliver, così stanco, il fastidio di svuotarsele prima di andare a letto. Questi atti di gentilezza si sarebbero probabilmente spinti parecchio più innanzi se non fosse stato per una generosissima applicazione del forchettone dell'ebreo sulle teste e le schiene di quei giovani tanto affezionati e solerti. «Siamo molto, molto contenti di vederti, Oliver», fece l'ebreo. «Dodger, togli le salsicce e sistema una tinozza accanto al fuoco come sgabello per Oliver. Ah! Ti meravigli di tutti quei fazzoletti, mio caro? Sono un bel po', non ti pare? Li abbiamo giusto tirati fuori per mandarli a lavare; proprio così, Oliver. Proprio così. Eh, eh, eh!». L'ultima parte di questo discorso fu salutata da uno scoppio di risa da parte di tutti i giovanotti di belle speranze al servizio dell'allegro vecchietto. Nel mentre, si misero tutti a tavola. Oliver mangiò di buon appetito, e poi l'ebreo gli versò un bicchiere di gin e acqua bollente, intimandogli di berlo subito, perché il bicchiere serviva per un altro signore. Oliver fece come gli si chiedeva, e immediatamente dopo si sentì sollevato di peso e deposto su uno dei giacigli; poi cadde in un sonno profondo. Capitolo IX. Contiene altri particolari relativi a un simpatico vecchietto e ai suoi promettenti ragazzi Era mattina tardi quando Oliver si svegliò da un sonno lungo e profondo. Nella stanza non c'erano altre persone oltre al vecchio ebreo, che scaldava il caffè per la colazione in un pentolino e fischiettava tra sé e sé mentre girava con un cucchiaio di ferro. Ogni tanto s'interrompeva tendendo l'orecchio per captare ogni minimo rumore proveniente dal basso; poi, rassicuratosi, continuava a girare e fischiettare, come prima. Sebbene Oliver avesse terminato il sonno, non era ancora però completamente desto. C'è uno stato di torpore, tra il sonno e la veglia, durante il quale si sogna di più in cinque minuti a occhi semiaperti, consapevoli di tutto ciò che avviene intorno, di quanto non si sognerebbe in cinque notti con gli occhi completamente chiusi e i sensi nella più totale incoscienza. In tali momenti, l'essere mortale comprende abbastanza del lavorio della sua mente per formarsi una idea, seppur vaga, del suo eccezionale potere: com'essa sia in grado di staccarsi da terra per superare spazio e tempo, libera dai legami con la sua controparte corporea. In questa precisa condizione si trovava Oliver. Vedeva l'ebreo con gli occhi semisocchiusi, udiva il suo basso fischiettare, e riconosceva il rumore del cucchiaio che sfregava contro il cilindro del pentolino; tuttavia, i suoi sensi erano simultaneamente presi nel ricordo di quasi tutte le altre persone incontrate in vita sua. Quando il caffè fu pronto, l'ebreo poggiò il pentolino sulla mensola al lato del camino e, rimasto lì incerto per qualche minuto come se non sapesse bene cosa fare, si voltò per dare un'occhiata a Oliver e lo chiamò per nome. Oliver non rispose, e sembrava davvero addormentato. Rassicuratosi su questo punto, l'ebreo si diresse piano all'uscio e lo serrò. Poi da una botola nel pavimento, come sembrò a Oliver, tirò fuori una cassettina, che con estrema cura depose sul tavolo. Mentre sollevava il coperchio e guardava all'interno, gli occhi gli brillavano. Avvicinata al tavolo una vecchia sedia, si sedette e trasse dalla cassettina un magnifico orologio d'oro, sfavillante di gemme. «Aha!», fece l'ebreo scuotendo le spalle e con un terribile ghigno che gli deformava il volto. «Brave canaglie! Brave canaglie! Spavaldi fino all'ultimo! Non hanno rivelato al vecchio parroco dove erano stati. Non hanno mai cantato sul conto del vecchio Fagin. E perché avrebbero dovuto? Mica gli avrebbe allentato il nodo scorsoio o ritardato neanche di un minuto il salto in alto. No, no, no! Galantuomini! Galantuomini!». Bofonchiando queste e altre simili riflessioni, l'ebreo depose di nuovo l'orologio nella cassettina in cui era custodito. Ne prelevò almeno un'altra dozzina, a uno a uno, e poi ancora orecchini, spille, braccialetti e altri gioielli, di materiali così preziosi e di così costose lavorazioni che Oliver non aveva la minima idea neanche di come si chiamassero. Rimessi a posto questi articoli, l'ebreo prese un altro astuccio, così piccolo che stava tutto nel palmo della mano. Sembrava che ci fosse una microscopica incisione sopra, poiché l'ebreo la depose sul tavolo e parandosi gli occhi con la mano l'esaminò a lungo con estrema attenzione. Alla fine la rimise a posto, come se ci fosse poco da fare, e appoggiatosi alla spalliera borbottò: «Che bella cosa è la pena di morte! I morti non si pentono mai; i morti non rinvangano mai vecchie storie. Ah! Questa è una bella cosa nel nostro mestiere. Cinque di loro sono stati appesi per il collo, in batteria, e non potranno più reclamare la loro parte di bottino né rischieranno di cantare per la fifa!». Mentre borbottava queste parole, gli occhi neri e vividi, che erano stati fissi nel vuoto, caddero sul viso di Oliver e ne incontrarono lo sguardo di muta curiosità. Fu solo un istante di mutuo riconoscimento, il più breve spazio di tempo concepibile, ma fu abbastanza perché il vecchio capisse di essere stato osservato. Riabbassò con uno scatto secco il coperchio della cassetta e afferrato un coltellaccio poggiato sul tavolo balzò in piedi furente. Il corpo era scosso da tremiti, e il povero Oliver, benché terrorizzato, vide il coltellaccio sollevato in aria, scosso dagli stessi tremiti. «Che c'è?», fece l'ebreo. «Che guardi a quel modo? Com'è che sei sveglio? E cos'hai veduto? Parla, ragazzo! Parla! Parla! Per la tua vita!». «Non avevo più sonno, signore», rispose timidamente Oliver. «Mi dispiace molto se vi ho disturbato, signore». «Eri sveglio un'ora fa?», disse l'ebreo guardando il ragazzo ferocemente. «No..., no..., davvero», replicò Oliver. «Ne sei sicuro?», gridò l'ebreo ancor più ferocemente, aggressivo e minaccioso. «Sulla mia parola, signore, non ero sveglio», replicò Oliver con foga, «davvero, non ero sveglio!». «Shhh! Zitto, mio caro!», fece l'altro, tornando repentinamente alle sue maniere consuete e trastullandosi un poco col coltello prima di posarlo, come a far vedere che l'aveva preso distrattamente per gioco. «Ma certo, ragazzo. Ci credo. Volevo solo vedere se ti spaventavi. Sei un ragazzo coraggioso. Ha! Ha! Sei un ragazzo coraggioso, Oliver!». L'ebreo si fregò le mani e schioccò le labbra; guardò tuttavia la cassetta con apprensione. «Hai visto qualcuna di queste belle cosette, mio caro?», disse dopo una breve pausa l'ebreo posando la mano sulla cassetta. «Sì, signore», rispose Oliver. «Ah!», fece l'ebreo impallidendo. «Sono mie, Oliver; è la mia piccola proprietà. È tutto quello che ho messo da parte per la mia vecchiaia. La gente dice che sono un taccagno, mio caro - solo un taccagno; questo è tutto». Oliver pensò che il vecchio dovesse essere veramente un taccagno per vivere in quel posto con tutti gli orologi di sua proprietà, ma supponendo che il prendersi cura di Dodger e degli altri ragazzi potesse costargli un bel po', si limitò a fargli un rispettoso inchino e gli chiese se poteva alzarsi. «Certo, mio caro, certo», replicò il vecchio. «Aspetta. C'è una brocca di acqua nell'angolo vicino alla porta. Portala qua, e ti do un bacile per lavarti, mio caro». Oliver si alzò, andò da quel canto della stanza e si curvò per prendere la brocca. Quando si girò vide che la cassetta era sparita. Aveva appena finito di lavarsi e di rimettere tutto in ordine, svuotando la bacinella dalla finestra così come gli aveva consigliato l'ebreo, quando Dodger tornò, accompagnato da un altro ragazzo piuttosto allegro, che Oliver aveva visto la sera innanzi fumare una pipa e che ora gli venne presentato come Charley Bates. I quattro si sedettero per la colazione, con del caffè, fagottini caldi e prosciutto che Dodger aveva portato a casa dentro il cappello. «Bene», disse l'ebreo rivolgendosi allo Svelto e ammiccando verso Oliver, «avete lavorato stamane, miei cari?» «Parecchio», rispose Dodger. «Alla grande», aggiunse Charley Bates. «Bravi ragazzi, bravi ragazzi!», disse l'ebreo. «E tu cosa porti a casa, Dodger?» «Un paio di taccuini», replicò quel signorino. «Rilegati?», chiese avidamente l'ebreo. «Piuttosto bene», replicò Dodger tirando fuori i due taccuini, uno verde e l'altro rosso. «Non troppo grandi», disse l'ebreo dopo averli esaminati all'interno, «ma puliti e ben fatti. Fattura pregevole, non è vero, Oliver?» «Molto, signore», rispose Oliver. Al che Charley Bates scoppiò in una fragorosa risata, con grande stupore di Oliver che non capiva il comico della cosa. «E tu cosa porti, mio caro?», chiese l'ebreo a Charley Bates. «Moccichini», replicò mastro Bates mentre tirava fuori due fazzoletti. «Bene!», fece l'ebreo esaminandoli accuratamente; «sono veramente belli... veramente belli. Quei ricami di letterine però non mi piacciono molto, Charley, sicché li toglieremo con l'ago, e insegneremo a Oliver come fare, non è vero Oliver? Ha, ha, ha!». «Volentieri, signore», rispose Oliver. «Ti piacerebbe saper fare fazzoletti con la stessa facilità di Charley Bates, non è così, Oliver?», disse l'ebreo. «Moltissimo, signore, se me lo insegnate». Mastro Bates trovò la risposta così esilarante che scoppiò in un'altra risata, la quale, scontrandosi col caffè ingollato e trascinandolo per qualche canale improprio, era sul punto di strozzarlo prematuramente. «Che allocco di primo pelo!», esclamò Charley Bates quando si fu ripreso, a mo' di scuse alla compagnia per il suo comportamento scortese. Dodger non disse nulla, ma lisciò i capelli di Oliver facendoglieli cadere sugli occhi, garantendogli che ben presto avrebbe capito. Al che il vecchio, osservando che Oliver arrossiva, cambiò argomento, chiedendo se parecchia gente fosse andata alle esecuzioni di quella mattina. Questo rese Oliver ancora più perplesso, poiché dalle risposte dei ragazzi fu chiaro che loro avevano presenziato entrambi, e ciò gli sembrava incompatibile con l'industriosità di cui avevano dato prova. Sparecchiata la colazione, il simpatico vecchietto e i due ragazzi cominciarono un gioco curioso e insolito, che consisteva in questo: il vecchietto si infilava una tabacchiera in una tasca dei pantaloni, un portafogli nell'altra, un orologio nel taschino del panciotto con una catenina di sicurezza al collo. Poi si appuntava alla camicia una spilla di diamanti fasulla, si abbottonava ben stretto il cappotto e, ficcate nelle tasche di quello l'astuccio degli occhiali e un fazzoletto, trotterellava avanti e indietro per la stanza con un bastone, imitando il modo di camminare dei vecchietti su e giù per la strada durante il giorno. A volte si fermava innanzi al camino, a volte vicino alla porta, scimmiottando chi fosse assorto nella contemplazione della vetrina di qualche negozio. In quelle occasioni, si guardava attorno in continuazione per paura dei marioli e continuava a battersi sulle tasche, una dopo l'altra, per accertarsi che non gli mancasse nulla, in un modo così goffo ed esagerato che a Oliver venivano le lacrime agli occhi dal ridere. Per tutto questo tempo i due ragazzi stavano alle costole del vecchio nascondendosi al suo sguardo con tale agilità ogni volta che si voltava che era impossibile seguirne i movimenti. Alla fine, Dodger gli acciaccava le dita dei piedi o gli inciampava sulle scarpe, mentre Charley Bates andava a sbattergli contro da dietro; e in quel momento lo alleggerivano, con stupefacente rapidità, di tabacchiera, portafogli, orologio e catenella, spilla da camicia, fazzoletto e persino custodia degli occhiali. Ogni volta che il vecchio si accorgeva che qualcuno gli infilava la mano in tasca lo smascherava con un grido, e allora il gioco ricominciava di nuovo. Avevano ripetuto questo giochetto più volte, quando un paio di giovani signorine, una delle quali si chiamava Bet e l'altra Nancy, vennero in cerca dei ragazzi. Portavano i capelli lunghi e folti malamente raccolti all'indietro, e scarpe e calze alquanto sporche. Forse non erano bellezze, ma erano parecchio colorite in faccia e piuttosto solide e vivaci. Essendo poi di modi piuttosto liberi e piacevoli, Oliver pensò che fossero delle ragazze davvero allegre. E non c'è dubbio che lo fossero. Le visitatrici si fermarono un bel po', e poiché una di loro si lamentava di sentirsi un poco di freddo addosso si tirarono fuori i liquori e la conversazione prese una piega di spiritosa convivialità. Alla fine Charley Bates manifestò l'idea che fosse tempo di rinfrescarsi l'ugola. Oliver l'interpretò come un'espressione francese che volesse dire andar fuori, poiché subito dopo, elargito loro del denaro da spendere dall'amabile vecchio, Dodger e Charley e le due ragazze uscirono insieme. «Ecco, mio caro», disse Fagin. «È una bella vita, questa, non è così? Ora possono andarsene in giro tutto il giorno». «Hanno finito il lavoro signore?», chiese Oliver. «Sì», rispose l'ebreo. «Ossia, se non ne trovano inaspettatamente dell'altro mentre se ne vanno in giro: in quel caso non se lo faranno sfuggire, puoi starne certo. Che ti siano di esempio, mio caro. Che ti siano di esempio», disse l'ebreo battendo con la paletta del carbone sul focolare per dar forza alle sue parole. «Fa' tutto quello che ti dicono, e in ogni cosa segui il loro consiglio, mio caro. Specialmente quello di Dodger. Diventerà un grand'uomo, e ci diventerai pure tu se seguirai il suo esempio». Poi, interrompendosi bruscamente: «C'è un fazzoletto che mi spunta dalla tasca, mio caro?» «Sì, signore», rispose Oliver. «Guarda se me lo puoi sfilare senza che io me ne accorga, come hai visto fare ai ragazzi quando giocavamo stamane». Sollevando delicatamente in su la tasca con una mano - una tecnica che aveva appena visto usare da Dodger - Oliver sfilò piano il fazzoletto con l'altra. «L'hai preso?», esclamò l'ebreo. «Eccolo, signore», disse Oliver mostrandoglielo. «Sei un ragazzo in gamba, mio caro», fece l'amabile vecchietto dandogli dei buffetti in testa in segno di approvazione. «Non ho mai conosciuto un ragazzo più sveglio. Ecco uno scellino per te. Se continui così, sarai il più grande di tutti. E ora, vieni qui; t'insegno a togliere le lettere dai fazzoletti». Oliver si chiedeva che rapporto potesse esserci tra lo sfilare il fazzoletto dalla tasca del vecchio e la possibilità di diventare un grand'uomo, ma pensando che l'ebreo, tanto più grande di lui, dovesse saperne di più lo seguì tranquillamente al tavolo e fu presto immerso nella sua nuova arte. Capitolo X. Oliver conosce meglio i suoi nuovi compagni, e paga l'esperienza a caro prezzo. È un capitolo breve, eppure importantissimo, di questa nostra storia Per molti giorni Oliver rimase nella stanza dell'ebreo togliendo le lettere dai fazzoletti (che venivano consegnati in gran numero), a volte prendendo parte al gioco già descritto, che l'ebreo e i ragazzi replicavano regolarmente ogni mattina. Infine, cominciò a illanguidire per mancanza d'aria fresca, e più volte supplicò il vecchio di mandarlo fuori al lavoro con i suoi due compagni. Oliver era ancor più desideroso d'essere attivamente utilizzato vedendo quanto fosse rigida la moralità del vecchio. Ogni qualvolta Dodger e Charley Bates tornavano a notte a mani vuote, egli li rampognava aspramente sugli effetti nefasti della pigrizia e della negligenza, e inculcava loro la necessità di una vita attiva con lo spedirli a letto senza mangiare. Una volta, arrivò a picchiarli fino a farli ruzzolare giù per una rampa di scale; ma questo fu un insolito eccesso di zelo in favore della virtù. Infine, un mattino, Oliver ottenne il permesso tanto agognato. Per due o tre giorni non c'erano stati fazzoletti da lavorare e le cene erano state piuttosto parche. Forse c'erano delle buone ragioni perché il vecchio avesse dato il suo assenso; comunque, che ci fossero o meno, disse a Oliver che poteva uscire e l'affidò alla custodia combinata di Charley Bates e del suo amico Dodger. I tre ragazzi partirono, Dodger con le maniche del cappotto rimboccate e il cappello a tre quarti, come al solito; mastro Bates, trotterellando con le mani ficcate in tasca e Oliver in mezzo a loro, che si chiedeva dove fossero diretti e quale sarebbe stata la prima fase del lavoro che avrebbe dovuto apprendere. Andavano però d'un passo così sospettosamente pigro e strascicato che Oliver cominciò subito a pensare che i compagni volessero ingannare il vecchio non recandosi per niente al lavoro. Dodger inoltre aveva la maligna propensione a togliere di testa il cappello ai bambini e a gettarglielo via lontano, mentre Charley Bates esibiva un'idea piuttosto personale dei diritti della proprietà privata con lo sgraffignare diverse mele e cipolle dalle bancarelle ai lati delle cunette di scolo, accantonandole poi in tasche così sorprendentemente capaci da sembrare mettere a repentaglio la foggia dei suoi abiti da ogni lato. Oliver ci rimase così male che fu sul punto di dichiarare la sua intenzione di tornare a casa il più rapidamente possibile, quando i suoi pensieri furono indirizzati altrove da una misteriosissima alterazione del comportamento di Dodger. Stavano sbucando da una stretta viuzza, non lontana dalla piazza di Clerkenwell, tuttora conosciuta, per una strana perversione, col nome di "Green", quando Dodger si fermò di colpo e portandosi il dito alle labbra tirò indietro i compagni con la massima cautela e circospezione. «Che cosa succede?», chiese Oliver. «Zitto!», replicò Dodger. «Vedi quel babbeo alla bancarella dei libri?» «Quel signore dall'altra parte della strada?», fece Oliver. «Sì, lo vedo». «Fa al caso nostro», ribatté Dodger. «Un bello stoccafisso», osservò mastro Charley Bates. Oliver guardava dall'uno all'altro sbigottito, ma non ebbe modo di fare domande poiché gli altri due attraversarono furtivamente la strada e scivolarono silenziosamente alle spalle del gentiluomo che gli era stato indicato. Oliver andò loro dietro di qualche passo ma poi, non sapendo se avanzare o tornare dov'era, rimase come inebetito a guardarli. L'anziano gentiluomo, con parrucca e occhiali in montatura d'oro, aveva un aspetto molto rispettabile. Indossava un soprabito d'un colore verde bottiglia con colletto di velluto nero e pantaloni bianchi; sotto il braccio reggeva un elegante bastone da passeggio di bambù. Aveva preso un libro dalla bancarella, ed eccolo lì, immobile, a leggere con tanta concentrazione come se fosse stato seduto in poltrona nel suo proprio studio. Ed è possibile che si immaginasse davvero là, giacché era chiaro che, perso nella lettura, non vedeva né la bancarella, né la strada, né i ragazzi, né, in breve, nient'altro se non il libro stesso; e lo leggeva senza perdersi una riga, girando pagina quando arrivava in fondo e riprendendo alla prima riga della seguente, procedendo regolarmente nell'interessata, avida lettura. Quale non fu lo spavento e l'orrore di Oliver allorché, con occhi sgranati fino all'inverosimile, vide Dodger ficcare la mano nella tasca del gentiluomo traendone un fazzoletto, passarlo di nascosto a Charley Bates e vide infine entrambi correre a gambe levate scomparendo dietro un angolo! Immediatamente, tutto il mistero dei fazzoletti, degli orologi, dei gioielli e dell'ebreo gli fu chiaro. Rimase di sasso un istante, col sangue che gli si precipitava lungo le vene per la paura e si sentì quasi ardere; poi, confuso e spaventato, se la dette a gambe e senza sapere cosa stesse facendo corse a più non posso. Tutto questo accadde nello spazio di un minuto. Nel medesimo istante in cui Oliver cominciò a correre l'anziano gentiluomo, ficcatasi la mano in tasca e sentendo che non c'era il fazzoletto, si voltò di scatto. Vedendo il ragazzo svignarsela con tanta fretta concluse, naturalmente, che fosse il ladro e gridando "Al ladro! Al ladro!" con quanto fiato aveva gli corse dietro, col libro in mano. Ma l'anziano gentiluomo non era il solo a gridare "Al ladro". Dodger e mastro Bates, per nulla desiderosi di attrarre l'attenzione generale con una corsa lungo la strada più frequentata, si erano limitati a trovare riparo nel vano di un portone subito dietro l'angolo. Ma non appena sentirono gridare e videro Oliver correre, afferrata al volo la situazione, si riversarono prontamente in strada gridando anche loro "Al ladro! Al ladro!" e s'unirono agli inseguitori come buoni cittadini. Benché Oliver fosse stato allevato nei precetti dei filosofi, era all'oscuro, dal punto di vista teoretico, del bell'assioma che l'autoconservazione è la prima legge di natura. Non l'avesse ignorato, sarebbe stato forse meglio preparato a quella situazione; ma poiché l'ignorava, sentì ancor più spavento e corse via come il vento, con l'anziano gentiluomo e i due compagni che gli strillavano dietro rincorrendolo. "Al ladro! Al ladro!", che magica espressione! Udendola, il commerciante lascia la cassa e il carrettiere il carro; il macellaio lascia il vassoio, il fornaio il cesto, il lattaio il paiolo, il fattorino i pacchetti, lo scolaro le biglie, il muratore la piccozza e il bambino la racchetta. E tutti a correre, a gambe levate, a tutta birra, a perdifiato, urtando, gridando, travolgendo i passanti a ogni angolo, aizzando i cani e spaventando pennuti di varia natura, mentre le strade, le piazze e i cortili rimandano l'eco di quel trambusto. "Al ladro! Al ladro!", il grido è ripreso da cento voci e la folla aumenta a ogni svolta. Corrono a precipizio, schizzando nel fango e scalpicciando sul selciato dei marciapiedi; le ghigliottine delle finestre si levano, le persone si precipitano fuori, la calca spinge innanzi; gli spettatori d'un teatrino di marionette lasciano Pulcinella nel bel mezzo dell'azione e unendosi alla calca lanciata in corsa amplificano lo schiamazzo e danno nuovo vigore al grido di "Al ladro! Al ladro!". "Al ladro! Al ladro!". Nel fondo dell'animo umano c'è un istinto di caccia, di qualsiasi preda si tratti. Un povero ragazzo senza più fiato, affannato ed esausto, lo sguardo atterrito, e grosse gocce di sudore che gli colano giù per il viso, non produce altro effetto se non quello d'eccitare gl'inseguitori; e questi, mentre ne seguono le tracce, guadagnando terreno ad ogni istante, esultano nel vedere le sue forze diminuire e gridano ancor più forte nel loro ebbro giubilo. "Fermate il ladro!". Già, fermatelo, per carità di Dio, soltanto per misericordia! Ed eccolo fermato. Un colpo ben assestato, ed egli giace steso sul marciapiede, con la folla che gli si accalca eccitata attorno. Chi sopraggiunge spinge e spintona gli altri per vedere qualcosa. «Fate largo!», «Lasciategli un po' d'aria!», «Sciocchezze! Non la merita!», «Dov'è quel gentiluomo?», «Eccolo laggiù, sta arrivando», «Fate passare il gentiluomo!», «È questo il ragazzo, signore?», «Sì, è lui!». Oliver giaceva a terra, coperto di fango e polvere, sanguinante dalla bocca, e girava lo sguardo atterrito sul mucchio di facce che lo circondavano, quando l'anziano gentiluomo fu rispettosamente tirato innanzi e spinto in mezzo dai più zelanti inseguitori. «Sì», disse il gentiluomo. «Temo che sia lui». «Come "temo"!», mormorò la folla. «Questa è buona!». «Povero ragazzo!», disse il gentiluomo. «È ferito». «Sono stato io, signore», fece avanzando un uomo grande e grosso, «e mi sono pure sbucciato le nocche sui suoi denti. L'ho fermato io, signore». L'uomo si toccò il cappello con un ghigno, aspettandosi qualcosa per ricompensa; ma l'anziano gentiluomo, osservatolo con un'espressione di disapprovazione, si guardò ansiosamente attorno, come desideroso di scappar via lui stesso; e forse sarebbe davvero scappato, innescando un altro inseguimento e un'altra caccia, se proprio in quel momento un poliziotto (che è di solito l'ultimo ad arrivare in simili casi) non si fosse fatto strada tra la folla e non avesse afferrato Oliver per il collo. «Su, in piedi», fece brusco l'agente. «Non sono stato io, signore, davvero. Davvero, davvero, sono stati quegli altri due ragazzi», esclamò Oliver, supplicando a mani giunte e guardando attorno. «Devono trovarsi qui, da queste parti». «Oh, no! Non da queste parti!», fece l'agente con una vena di ironia. Ma diceva il vero, in effetti, giacché Dodger e Charley Bates se l'erano nel frattempo filata per il primo vicolo utile. «Su, in piedi!». «Non fategli male», fece l'anziano gentiluomo mosso a compassione. «Oh, no, non gli faccio male», replicò l'agente, strattonandolo per la giacca quasi a conferma di ciò che aveva detto. «Vieni. Li conosco i tipi come te. Non funziona. Allora, ti decidi a stare in piedi, piccolo demonio?». Oliver, che a malapena era in grado di reggersi, si risollevò in qualche modo e fu immediatamente trascinato a passo di marcia lungo le strade, tenuto stretto per il collo della giacca. Il gentiluomo teneva il passo, a fianco dell'agente, e i più ardimentosi tra la folla cercavano di sopravanzarli in modo che, di tanto in tanto, potessero guardare Oliver in faccia. Così, tra le grida di trionfo dei ragazzi, il gruppo proseguiva. Capitolo XI. Tratta del signor Fang, il magistrato di polizia, con un piccolo esempio di come amministra la giustizia Il furto era stato commesso nel distretto di un famosissimo ufficio di polizia metropolitana, e anzi proprio nelle immediate vicinanze di questo. La folla aveva avuto la soddisfazione di accompagnare Oliver solo per due o tre strade, fino a un posto detto Mutton-hill poiché da qui, imboccato un basso passaggio ad arco e poi un vicoletto sudicio, egli fu condotto in questo dispensatoio di giustizia sommaria, passando dal retro. Girarono in una minuscola corte lastricata, dove incontrarono un omone con dei favoriti simili a cespugli, e un enorme mazzo di chiavi in mano. «Cosa succede adesso?», disse con aria annoiata. «Un ladruncolo di moccichini in erba», replicò il poliziotto che aveva preso in custodia Oliver. «E voi siete la persona derubata, signore?», chiese l'uomo con le chiavi. «Sì, esatto», replicò l'anziano gentiluomo «ma non sono sicuro che sia stato effettivamente questo ragazzo a rubarmi il fazzoletto. Io... io preferirei quindi non sporgere denuncia». «A questo punto deve per forza comparire innanzi al magistrato, signore», replicò l'uomo. «Vostra signoria si sarà tolta d'impaccio in meno di mezzo minuto. Forza, pendaglio da forca!». Era, questo, un invito affinché Oliver varcasse un uscio che egli aveva nel frattempo aperto e che conduceva in una angusta celletta di pietra. Qui fu perquisito e, dopo che niente gli fu trovato addosso, fu rinchiuso. Questa celletta, in forma e dimensioni, assomigliava a un'angusta cantina, ma con ancor meno luce. Dava la nausea per quanto era sporca, giacché era lunedì mattina, e fin dalla notte del sabato precedente era stata occupata da sei ubriaconi che erano stati poi trasferiti altrove. Ma questo è ancora poco. Ogni notte, nelle nostre stazioni di polizia, uomini e donne sono rinchiusi con le accuse più banali in antri (e uso la parola di proposito) in confronto ai quali le prigioni di Newgate, occupate dai criminali più feroci, processati, riconosciuti colpevoli e condannati a morte, sono veri e propri palazzi. E chi dubita di questo non ha che da fare il confronto di persona. Quando le chiavi serrarono l'uscio, un'espressione di sgomento, profondo quasi quanto quello di Oliver, si impadronì dell'anziano gentiluomo. Con un sospiro rimirò il libro, causa innocente di tutta quella confusione. «C'è qualcosa nel viso di quel bambino», disse egli tra sé mentre si allontanava lentamente e profondamente assorto si picchiettava il mento con la copertina del libro. «C'è qualcosa in quel viso che mi colpisce e mi incuriosisce. E se fosse davvero innocente? Sembrava... A proposito», esclamò l'anziano gentiluomo fermandosi all'improvviso e guardando su in cielo, «che Iddio mi benedica! Dove ho già visto uno sguardo simile al suo?». Dopo esser rimasto soprappensiero per un po', l'anziano gentiluomo, con il medesimo sguardo assorto, entrò dal retro in una anticamera comunicante con la corte. Là, ritiratosi in un angolo, evocò agli occhi della mente un'ampia cerchia di volti sulla quale, da molti anni ormai, era calato un buio sipario. «No», disse scuotendo la testa. «Forse è la mia immaginazione». Contemplò ancora quei volti. Li aveva risvegliati e ora non era semplice calare di nuovo una cortina come quella che per tanto tempo li aveva celati. C'erano volti di amici e nemici, e altri quasi estranei che si insinuavano commisti ai volti anonimi della folla; c'erano volti di giovani e fiorenti ragazze poi diventate vecchie; c'erano volti, irriconoscibili, su cui s'era chiusa la tomba e che la mente, tanto più potente di quella, rivestiva ancora della loro primitiva freschezza e bellezza, richiamando lo splendore degli occhi, la luminosità del sorriso, la radiosità dell'animo pur trapelante attraverso la maschera del corpo, testimone di una bellezza oltre la tomba, trasformatasi solo per farsi più pura, e strappata alla terra solo per divenir luce capace di illuminare un poco il sentiero che conduce al Cielo. Ma l'anziano gentiluomo non potè richiamare alla mente nessuna fisionomia di cui il viso di Oliver recasse traccia. Cacciò quindi un profondo sospiro sui ricordi che aveva suscitato e poiché, fortunatamente per lui, era un anziano gentiluomo parecchio distratto, li seppellì di nuovo nelle pagine di quel libro polveroso. Lo riscosse un tocco sulla spalla e l'invito da parte del signore con le chiavi a seguirlo nell'ufficio. Richiuse in fretta il libro e fu immediatamente introdotto alla soggiogante presenza del celebre signor Fang. L'ufficio era un salottino che dava sulla strada, con una parete a pannelli di legno. Il signor Fang sedeva dietro un banco opposto all'entrata, e da un lato della porta c'era una sorta di steccato di legno dietro il quale era stato già collocato il povero Oliver, tremante e impaurito da tutto quello spettacolo. Il signor Fang era un uomo di media altezza, smunto, con tronco allungato, collo rigido e non tanti capelli; quelli che aveva crescevano dietro e ai lati della testa. Aveva un viso arcigno e congestionato, e se, in effetti, non fosse stata sua abitudine bere più di quanto potesse giovare alla sua salute, avrebbe potuto citare la sua faccia per danni ottenendo un cospicuo risarcimento. L'anziano gentiluomo s'inchinò rispettosamente, e avanzando verso il banco, accompagnando l'azione alla parola, disse: «Questo è il mio nome e indirizzo, signore». Poi arretrò di un passo o due e con un altro educato e signorile inchino attese di essere interrogato. Fatto si è che proprio il quel momento il signor Fang stava scorrendo l'articolo di fondo di un giornale del mattino attinente a qualche sua recente sentenza, che per la trecentocinquantesima volta lo segnalava e raccomandava alla particolare attenzione del Ministro dell'Interno. Non era di buon umore e perciò sollevò uno sguardo di corrucciata ira. «E voi chi siete?», esclamò. L'anziano gentiluomo, piuttosto sorpreso, indicò il suo bigliettino da visita. «Guardia!», gridò il signor Fang scansando con disprezzo il bigliettino col giornale. «Chi è costui?» «Il mio nome, signore», fece l'anziano gentiluomo con rattenuta cortesia, «il mio nome è Brownlow. Consentitemi di chiedere il nome del magistrato che gratuitamente e senza provocazione alcuna si rivolge in modo così insultante a un rispettabile gentiluomo facendosi forte del seggio che occupa». E nel dir questo il signor Brownlow guardò attorno per l'ufficio, come in cerca di qualcuno che gli potesse fornire l'informazione richiesta. «Guardia!», esclamò il signor Fang buttando via il giornale dall'altro lato. «Di cosa è accusato costui?» «Non è accusato affatto, vostra eccellenza», replicò la guardia. «Sporge denuncia contro il ragazzo, vostra eccellenza». Sua eccellenza lo sapeva benissimo, ma si divertiva a fingere il contrario per tenere sulle spine le parti in causa. «Ah, sì? Sporge denuncia contro il ragazzo?», disse Fang scrutando con sprezzo il signor Brownlow da capo a piedi. «Fatelo giurare!». «Prima di giurare, chiedo di poter dire qualche parola», fece il signor Brownlow, «e cioè che io mai avrei potuto credere senza averlo visto con i miei occhi...». «Fate silenzio, signore!», interruppe perentoriamente il magistrato. «No, signore, non farò silenzio!», replicò l'anziano gentiluomo. «Silenzio all'istante, signore, o vi farò buttare fuori da quest'aula!», ribatté il signor Fang. «Siete insolente e impertinente. Come osate alzare la cresta contro un magistrato?» «Cosa?», esclamò l'anziano gentiluomo colorendosi. «Fatelo giurare subito!», fece Fang all'impiegato. «Non voglio sentire più neanche una parola. Fatelo giurare». Il signor Brownlow ribolliva di indignazione, ma pensando che se l'avesse sfogata avrebbe forse soltanto nuociuto al ragazzo, represse i suoi sentimenti e si sottopose alla procedura del giuramento senza altro indugio. «E ora», fece il signor Fang. «Di che cosa è accusato il ragazzo? Che cosa avete da dire voi, signore?» «Stavo presso una bancarella di libri...», cominciò il signor Brownlow. «Silenzio, signore!», disse il signor Fang. «Agente! Dov'è l'agente? Voi, fatelo giurare. Dunque, agente, chi è questo qui?». Con la dovuta umiltà, l'agente narrò come avesse preso in custodia l'accusato, l'avesse perquisito e non gli avesse trovato nulla addosso; e questo era tutto quello che sapeva. «E ci sono testimoni?», chiese il signor Fang. «Nessuno, vostra eccellenza», replicò l'agente. «Dunque, brav'uomo, avete intenzione di dichiarare qual è la vostra accusa a questo ragazzo oppure no? Siete sotto giuramento. Se perciò ve ne state lì rifiutandovi di dare le prove, state certo che vi condannerò per disprezzo alla corte, per...». Per cosa o per chi l'avrebbe condannato non si sa, giacché l'impiegato e il secondino tossirono forte proprio in quel momento, e il primo lasciò pure cadere a terra un hbro piuttosto pesante - del tutto casualmente, è chiaro - sicché non si potè udire il seguito. Con parecchie interruzioni e reiterati insulti, il signor Brownlow riuscì infine a dire quanto doveva, osservando che, nella sorpresa del momento, si era messo a correre dietro al ragazzo solo perché lo aveva visto scappare; e sperava che se il magistrato, nell' assolverlo per non aver commesso materialmente il fatto, lo riteneva tuttavia complice di una banda, volesse comunque essere clemente per quanto la giustizia lo consentiva. «È stato già ferito», fece l'anziano gentiluomo in conclusione. «E temo», aggiunse con veemenza rivolto alla corte, «temo che si senta parecchio male». «Oh! Già! Sfido io!», fece con un ghigno il signor Fang. «Via, questi trucchetti non servono qui, piccolo vagabondo; non servono. Come ti chiami?». Oliver cercò di rispondere, ma non sentiva più la lingua. Era bianco come uno straccio, e sembrava che tutto gli girasse attorno. «Come ti chiami, furfante matricolato?», chiese il signor Fang. «Guardia. Come si chiama?». La domanda fu rivolta a un tipo rotondetto, col panciotto a strisce, che stava accanto al banco. Questi si piegò su Oliver e ripetè la domanda, ma vedendo che non era neanche in grado di capirla e sapendo che il non rispondere avrebbe fatto infuriare ancor di più il giudice e inasprito la severità della condanna, azzardò un nome. «Dice di chiamarsi Tom White, vostra eccellenza», fece questo gentile custode. «Oh! E non è capace a dirlo forte, nevvero?», ironizzò Fang. «Molto bene. Molto bene. Dove abita?» «Dove può, vostra eccellenza», rispose l'impiegato, facendo di nuovo finta di riferire le parole di Oliver. «Ha genitori?», chiese il signor Fang. «Dice che sono morti quando era bambino, vostra eccellenza», replicò l'altro azzardando come al solito. A questo punto dell'inchiesta Oliver sollevò il capo e guardando attorno con occhi imploranti, e con un balbettio flebile pregò di poter avere un sorso d'acqua. «Emerite sciocchezze!», esclamò il signor Fang. «Vuoi forse prenderti gioco di me?» «Penso che si senta male davvero, vostra eccellenza», ribatté la guardia. «Lo so io come si sente», fece il magistrato. «Badate, agente», disse l'anziano gentiluomo protendendo istintivamente le mani. «Sta per cadere». «Indietro, agente», gridò il signor Fang. «Lasciatelo pure cadere, se vuole». Oliver approfittò della gentile concessione, e cadde pesantemente a terra, svenuto. Le persone nell'ufficio si guardarono reciprocamente, ma nessuno osò muoversi. «Lo sapevo che stava recitando», osservò il signor Fang, come se l'accaduto ne fosse una prova incontestabile. «Lasciatelo a terra. Si stancherà presto di restarci». «Come pensate di procedere, signore?», chiese l'impiegato a bassa voce. «Procedura sommaria», rispose il signor Fang. «È condannato a tre mesi... di lavori forzati, naturalmente. Sgombrate l'aula». S'aprì la porta a questo scopo, e un paio di uomini si accingevano a portare il ragazzo privo di sensi nella cella quando un signore anziano, di aspetto povero ma decoroso, in un vecchio abito nero, si precipitò nell'aula e avanzò verso il banco. «Fermi! Fermi! Non portatelo via! Fermatevi un momento!», gridò il nuovo arrivato col respiro corto per la corsa. Sebbene i Geni che presiedono agli uffici di questo genere esercitino un potere arbitrario e sommario sulle libertà, sul buon nome, sul carattere e quasi sulle vite stesse dei sudditi di sua Maestà, in specie delle classi più povere, e sebbene, entro queste mura, si consumino giornalmente raggiri tanto incredibili che gli angeli ne hanno gli occhi annegati dal pianto, questi restano inaccessibili al pubblico, se si eccettua ciò che ne riferisce la stampa quotidiana. Di conseguenza, il signor Fang s'indignò non poco nel vedere entrare qualcuno senza averne avuta licenza e in modo così brusco e irriverente. «Che succede! Che succede! Buttate fuori dall'aula quest'uomo! Sgombrate l'aula», urlò il signor Fang. «Devo parlare», gridò l'uomo. «Non mi farò buttare fuori. Ho visto tutto. Tengo la bancarella di libri. Fatemi giurare, dico. Non mi farò intimidire. Signor Fang, dovete ascoltarmi. Non mi rifiutate questo, signore». L'uomo aveva ragione. Aveva un modo di fare deciso e determinato, e la faccenda si faceva troppo seria per essere passata sotto silenzio. «Fatelo giurare», bofonchiò il signor Fang di malagrazia. «E ora, buon'uomo, cos'avete da dire?» «Ecco!», disse l'uomo. «Ho visto tre ragazzi; erano in due, e l'arrestato costì stava dall'altra parte della strada mentre questo signore leggeva al mio banco. È stato uno degli altri due a derubarlo. L'ho visto, e ho visto anche che questo ragazzo qui ci era rimasto di stucco dalla sorpresa». Avendo ripreso un po' di fiato, quel degno libraio continuò a raccontare, ora in forma più coerente, le circostanze esatte del furto. «Perché non siete venuto qui prima?», chiese il signor Fang dopo una breve pausa. «Non c'era un'anima che potesse badare alla bancarella», rispose l'uomo. «Quelli che avrebbero potuto darmi una mano s'erano fiondati tutti dietro gl'inseguitori. Non sono riuscito a trovare nessuno fino a cinque minuti fa, e sono corso qui senza mai fermarmi». «Sicché il derubato stava leggendo?», chiese dopo un po' il signor Fang. «Sì», rispose l'altro. «Proprio il libro che ha in mano». «Ah! Proprio quel libro?», disse Fang. «E l'ha pagato?» «No, signore», rispose l'uomo con un sorriso. «Oh, povero me; me n'ero completamente dimenticato!», esclamò innocentemente l'anziano e svagato gentiluomo. «Bel tipo, per denunciare questo povero ragazzo per furto!», disse il signor Fang con un patetico tentativo di mostrarsi umano. «Devo rilevare, signore, che vi siete appropriato di quel libro in circostanze molto dubbie e sospette, e potete ritenervi fortunato, molto fortunato, se il legittimo proprietario fa a meno di sporgere denuncia. Che vi sia di lezione, amico, o altrimenti la legge saprà raggiungervi ancora. Rilasciate il ragazzo. Sgomberate l'aula!». «Che io sia...!», gridò l'anziano gentiluomo facendo esplodere la collera tanto a lungo trattenuta. «Che io sia dannato se non...». «Sgomberate l'aula!», ripetè il magistrato. «Guardie! Avete sentito? Sgomberate l'aula!». L'ordine fu eseguito, e l'indignato signor Brownlow fu condotto di fuori, col libro in una mano e il bastone di bambù nell'altra, in un perfetto parossismo di indignazione e rabbia che si dissolse però all'istante non appena giunse nel cortile. Lì, sul lastricato, giaceva supino il povero Oliver Twist, con la camicia slacciata e le tempie cosparse d'acqua, mortalmente pallido in volto e il corpo scosso da tremiti. «Povero ragazzo! Povero ragazzo!», disse il signor Brownlow chinandosi su di lui. «Chiamate una carrozza! Qualcuno chiami una carrozza! Per favore, svelti!». La carrozza arrivò e dopo che Oliver fu premurosamente adagiato su un sedile l'anziano gentiluomo salì e sedette di fronte. «Posso accompagnarvi?», disse il libraio affacciandosi. «Santo cielo, amico mio», rispose sorpreso il signor Brownlow. «M'ero dimenticato di voi! Oh povero me! Ho ancora questo sventurato libro in mano. Saltate su. Povero amico! Non c'è tempo da perdere». Il libraio salì in carrozza, e partirono di gran carriera. Capitolo XII. Nel quale ci si prende miglior cura di Oliver di quanto non fosse avvenuto in precedenza e nel quale la narrazione torna all'anziano gentiluomo e ai suoi giovani amici La carrozza sferragliò via giù per Mount Pleasant e su per Exmouth Street, più o meno lungo lo stesso tragitto percorso da Oliver quando era entrato per la prima volta a Londra in compagnia di Dodger. Svoltando però per un'altra strada quando raggiunsero l'Angelo, a Islington, si fermarono infine di fronte a una linda dimora, in una via ombreggiata vicino Pentonville. In quella dimora si preparò senza indugio un letto dove Oliver fu amorevolmente adagiato sotto la sorveglianza del signor Brownlow, e qui il ragazzo fu curato e assistito con una premura e un affetto sconfinati. Per diversi giorni, comunque, Oliver rimase insensibile a tutta la bontà dei suoi nuovi amici. Il sole si levò e tramontò, si levò e tramontò ancora per diversi giorni di seguito, mentre il ragazzo giaceva malato in quel letto, deperendo e smagrendo per effetto d'una gran febbre, poiché il verme non compie più sistematicamente la sua opera su di un corpo morto di quanto non faccia il nascosto fuoco febbrile su di un corpo vivente. Infine però, sfinito, smunto e pallido, Oliver si svegliò da quello che sembrava essere stato un sonno lungo e inquieto. Ancor debole, sollevandosi un po' dal letto, con la testa poggiata su un braccio tremante, si guardò attorno smarrito. «Che stanza è questa? Dove mi avete portato?», disse. «Questa non è la stanza dove mi sono addormentato». Pronunciò queste parole con un filo di voce, per la debolezza e lo sfinimento, ma esse furono udite all'istante, poiché la tendina al capo del letto fu immediatamente tirata e una anziana signora dall'aspetto materno, vestita con cura e lindore, nel mentre scostava la tendina si alzò da una poltrona lì accosto, dov'era rimasta seduta a ricamare. «Non parlate, caro», disse piano l'anziana signora. «Dovete stare buono buono, o vi ammalerete di nuovo; e siete stato molto male... quanto peggio non si può, davvero. Mettetevi giù, da bravo!». Con queste parole l'anziana signora sistemò con dolcezza il capo di Oliver sul cuscino e scostandogli e lisciandogli i capelli sulla fronte lo guardò in viso con un'espressione così dolce e amorevole che egli non potè fare a meno di mettere la sua mano scarna in quella di lei e di portarsela al collo. «Cielo misericordioso!», disse l'anziana signora con le lacrime agli occhi, «quale riconoscenza in questo ragazzo. Povera creatura! Chissà cosa avrebbe provato sua madre se si fosse trovata qui seduta al mio posto vedendolo così!». «Forse lei mi vede», bisbigliò Oliver giungendo le mani, «forse m'è stata seduta vicino. Anzi, ne sono quasi sicuro». «È stato l'effetto della febbre, mio caro», disse con dolcezza l'anziana signora. «Forse sì», rispose Oliver. «Perché il cielo è tanto lontano e sono troppo felici là per scendere quaggiù accanto al letto di un povero ragazzo. Ma se sapesse che sono malato, mi compatirebbe anche da lassù, perché anche lei fu molto malata prima di morire. Però non può sapere tutto di me», aggiunse Oliver dopo un attimo di silenzio. «Se avesse visto che ero ferito ne avrebbe sofferto, mentre quando l'ho sognata aveva un viso dolce e sereno». L'anziana signora non replicò nulla, ma asciugandosi prima gli occhi e poi gli occhiali posati sulla coperta del letto come se questi ne fossero parte integrante, portò a Oliver qualcosa di caldo da bere e poi, carezzandolo sulla guancia, gli disse di rimettersi giù tranquillo perché altrimenti si sarebbe riammalato. E così Oliver rimase quasi immobile, in parte desiderando obbedire in tutto e per tutto all'anziana signora; in parte, a dire il vero, essendo completamente sfinito dallo sforzo del parlare. Cadde subito in un sonno dolce e leggero dal quale fu risvegliato dalla luce di una candela che, accostata al letto, gli rivelò un gentiluomo con un grande orologio d'oro in mano, che ticchettava forte: gli stava sentendo il polso, e disse che le sue condizioni erano migliorate parecchio. «Stai molto meglio, non è vero, ragazzo mio?», disse quel gentiluomo. «Sì, grazie signore», rispose Oliver. «È così, lo so», replicò l'altro. «E hai anche fame, non è vero?» «No, signore», rispose Oliver. «Hem!», fece quel gentiluomo. «Già, non ne hai, lo sapevo. Non ha fame, signora Bedwin», aggiunse, con sicumera. L'anziana signora chinò rispettosamente la testa, come a dire che riteneva il dottore competente al massimo. Il dottore, dal canto suo, sembrava nutrire la medesima opinione di sé. «Senti tanto sonno, non è vero, mio caro?», chiese il dottore. «No, signore», rispose Oliver. «No, non tanto», fece eco il dottore con una espressione saccente e compiaciuta. «Non tanto. E neanche hai sete, vero?» «Sì, signore, abbastanza», rispose Oliver. «Proprio come mi aspettavo, signora Bedwin», affermò il dottore. «Naturale che debba aver sete. Potete dargli un po' di tè, signora, e qualche fetta di pane tostato senza burro. Non tenetelo troppo caldo, signora; ma badate anche che non stia troppo freddo... va bene?». L'anziana signora fece una riverenza. Il dottore, dopo aver assaggiato la bevanda fresca e data una discreta approvazione, s'affrettò ad uscire, con gli stivali che scricchiolavano di importanza e benessere mentre scendeva le scale. Oliver ricadde in un sonno leggero, dal quale si svegliò che era quasi mezzanotte. Subito dopo l'anziana signora gli dette la buonanotte e lo lasciò alla custodia d'una vecchietta grassottella giunta proprio allora, recando con sé, in un fagottino, un libricino di preghiere e una abbondante cuffia da notte. Sistemata la cuffia in capo e il libricino sul tavolo, e informato Oliver che era venuta per vegliarlo, la vecchietta avvicinò una sedia al focolare e cominciò una serie di brevi sonnellini, frequentemente interrotti da improvvisi scarti in avanti, da gemiti e crisi respiratorie: il tutto, comunque, senz'altea conseguenza se non quella di doversi strofinare molto energicamente il naso prima di appisolarsi di nuovo. Così, lentamente, passò quella notte. Oliver ogni tanto si svegliava, e si metteva a contare i cerchietti di luce che il paralume proiettava sul soffitto, o seguiva con occhi languidi gli intricati disegni della carta da parati sul muro. Il buio e la quiete della stanza, nella loro profonda solennità, gli fecero tornare in mente che la morte vi aveva aleggiato per diversi giorni e notti e che essa poteva piombarvi di nuovo portandovi il suo cupo terrore; girò quindi il capo sul cuscino e indirizzò un'ardente preghiera al Cielo. A gradi, scivolò in quel sonno tranquillo che solo il sollievo da un recente patire può infondere; quel calmo, beato riposo, a confronto del quale lo svegliarsi è una sofferenza. E chi, se quello fosse la morte, vorrebbe svegliarsi di nuovo alle lotte e al travaglio della vita; a tutte le sue preoccupazioni per il presente, a tutte le sue ansie per il futuro e a tutte le penose memorie del passato! Da parecchie ore s'era fatto giorno quando Oliver apri gli occhi, e in quel momento egli si sentì rinvigorito e felice. La crisi della malattia era ormai definitivamente alle spalle, ed egli apparteneva di nuovo al mondo. Nel giro di tre giorni fu in grado di sedersi su una poltrona, ben sostenuto da cuscini, e poiché era ancora troppo debole per camminare la signora Bedwin lo fece portare giù per le scale fino alla cameretta del custode che era usata da lei. Qui, dopo averlo fatto sistemare accanto al focolare, la buona signora sedette lei pure, e per la grande contentezza di vederlo così migliorato, scoppiò subito in un profluvio di lacrime. «Non far caso a me, mio caro», disse l'anziana signora. «Che non ti vada di traverso il brodo; ed è tempo che tu lo beva, perché stamani, dice il dottore, può venire il signor Brownlow a trovarti, sicché è meglio avere l'aspetto migliore possibile perché lui sia più contento». E con ciò l'anziana signora si accinse a scaldare in un pentolino un brodo così ristretto che, se portato alla diluizione di prammatica, avrebbe potuto fornire un pasto abbondante a un trecentocinquanta orfanelli - e la stima era per difetto. «Ti piacciono i quadri, mio caro?», chiese l'anziana signora vedendo che Oliver fissava intensamente un ritratto appeso alla parete, di fronte alla poltrona in cui era seduto. «Non so bene, signora», rispose Oliver senza distogliere gli occhi dalla tela. «Non so, avendone visti così pochi. Com'è bello e gentile il viso di quella signora!». «Ah!», fece l'anziana signora, «gli artisti dipingono le signore più graziose di quello che sono, o non avrebbero clienti, bimbo mio. Quello che ha inventato la macchina per fare i ritratti avrebbe dovuto saperlo che era condannata all'insuccesso: è un po' troppo fedele. Un po' troppo!», fece l'anziana signora ridendo di cuore alla sua battuta. «E quello..., è un ritratto quello, signora?», chiese Oliver. «Sì», rispose la signora distogliendo per un momento lo sguardo dal brodo. «È un ritratto». «Di chi, signora?», chiese Oliver interessato. «Beh, veramente, mio caro, non lo so», rispose la signora giovialmente. «Non è il ritratto di qualcuno che io o te conosciamo, suppongo. Sembra che ti abbia colpito, caro». «È così grazioso», replicò Oliver. «Ma sei sicuro che non ti inquieta?», chiese l'anziana signora notando con sua grande sorpresa lo sguardo perplesso con cui Oliver guardava il quadro. «Oh, no, no», ribatté vivacemente Oliver; «ma gli occhi sembrano così tristi, e guardandoli da qui pare che mi fissino. Il cuore mi batte forte», aggiunse Oliver in tono basso, «come se lei fosse viva e volesse parlarmi, senza poterlo fare». «Signore misericordioso!», esclamò l'anziana signora trasalendo. «Non parlare in questo modo, bimbo mio. Sei ancora debole e nervoso a causa della malattia. Lascia che ti sposti la sedia dall'altro lato così non ti sta sotto gli occhi. Ecco!», disse l'anziana signora facendo seguire l'azione alle parole. «Ad ogni buon conto, adesso non ce l'hai davanti». Ma Oliver continuava a vederla tale e quale con l'occhio della mente come se non avesse affatto cambiato posizione; pensò che fosse meglio però non inquietare oltre quella amorevole donna, e le sorrise con gentilezza quando lei lo guardò. La signora Bedwin, contenta che Oliver fosse più tranquillo, mise il sale e spezzettò del pane tostato nel brodo, tanto alacremente quanto era compatibile con una sì solenne preparazione. Oliver sbrigò quel pasto con eccezionale rapidità ed aveva appena ingoiato l'ultimo boccone quando si sentì bussare piano alla porta. «Avanti!», disse l'anziana signora; ed ecco entrare il signor Brownlow. Ora, l'anziano gentiluomo era entrato a passo piuttosto vivace, ma aveva a malapena sollevato gli occhiali sulla fronte e portate le mani dietro i lembi della veste da camera per esaminare Oliver con attenzione, quando i suoi lineamenti subirono una incredibile varietà di strane contorsioni. Oliver aveva un aspetto smunto e smagrito a causa della malattia, e tentò inoltre, senza riuscirvi, di sollevarsi per rispetto al suo benefattore, ricadendo però indietro nella sua poltrona. Insomma, il fatto si è, a onor del vero, che il cuore del signor Brownlow, grande sei volte quello di una persona di media benevolenza - per un processo idraulico di cui noi, di disposizione non abbastanza filosofica, non siamo in grado di dare spiegazioni spinse fuori dai suoi occhi un profluvio di lacrime. «Povero, povero ragazzo!», disse il signor Brownlow raschiandosi la gola. «Ho un po' di raucedine stamani, signora Bedwin. Temo d'essermi preso un raffreddore». «Spero proprio di no, signore!», replicò la signora Bedwin. «Tutto quello che portavate addosso è stato ben arieggiato, signore». «Non so, signora Bedwin. Non so», fece il signor Brownlow. «Penso piuttosto al tovagliolo umido di ieri a cena; ma lasciamo perdere questo. Come ti senti, mio caro?» «Felicissimo, signore», rispose Oliver, «e tanto grato per la bontà verso di me, signore». «Bravo ragazzo», disse il signor Brownlow con orgoglio. «Gli avete dato qualcosa da mangiare, signora Bedwin? Qualche brodaglia, eh?» «Ha appena mandato giù una scodella d'un bel brodo ristretto, signore», replicò la signora Bedwin, sollevandosi leggermente dalla sua posizione e ponendo una forte enfasi sul "ristretto", a voler intendere che tra una brodaglia e un brodo di carne mista non sussisteva la benché minima affinità o il benché minimo rapporto. «Uh!», fece il signor Brownlow, rabbrividendo leggermente; «un paio di bicchierini di porto avrebbero giovato ancor di più, non è vero Tom White?» «Io mi chiamo Oliver, signore», rispose il malato con un'espressione di grande meraviglia. «Oliver», disse il signor Brownlow. «Oliver che? Oliver White, eh?» «No, Twist, signore. Oliver Twist». «Che nome curioso!», disse l'anziano gentiluomo. «Perché allora hai detto al magistrato di chiamarti Tom White?» «Ma io non l'ho detto, signore», ribatté Oliver sbigottito. Sembrava proprio una bugia, quella, tanto che l'anziano gentiluomo fissò severamente Oliver in viso. Ma era impossibile dubitare della sua parola, tanta verità scaturiva da ogni singolo tratto del suo viso. «Dev'esserci stato qualche errore», disse il signor Brownlow. Tuttavia, sebbene non avesse perciò più motivo di fissarlo, la vecchia idea di una rassomiglianza tra i lineamenti che aveva innanzi e altri a lui familiari gli si ripresentò con tale forza che non potè distogliere lo sguardo. «Spero che non siate arrabbiato con me, signore», disse Oliver levando verso di lui degli occhi imploranti. «No, no», replicò l'anziano gentiluomo. «Ma! È mai possibile? Bedwin, guardate là!». E così dicendo indicò concitato prima il quadro sulla testa di Oliver e poi il volto del ragazzo. Era la copia precisa. Gli occhi, la testa, la bocca, ogni tratto era identico. Per un istante l'espressione del volto fu così somigliante che ogni suo più minuto dettaglio sembrava copiato con sorprendente accuratezza. Oliver, non ancora abbastanza forte per reggere alle emozioni, non seppe il perché di quella improvvisa esclamazione dal momento che svenne. Una debolezza da parte sua, che dà modo a questa narrazione di soddisfare la curiosità in merito ai due giovani allievi del simpatico ebreo, riportando quanto segue. Quando Dodger e il suo degno amico, mastro Bates, si accodarono alla caccia data al povero Oliver in conseguenza della loro illecita manomissione relativa alla proprietà personale del signor Brownlow, come prima descritto, furono mossi dall'impulso, lodevolissimo, di salvaguardare la loro propria incolumità, e nella misura in cui la libertà del suddito e la libertà dell'individuo sono tra i primi e più conclamati vanti di ogni vero inglese, non ho quasi bisogno di richiamare l'attenzione del lettore sul fatto che questa azione dovrebbe piuttosto esaltarne l'immagine agli occhi d'un pubblico patriottico: quasi altrettanto di come una prova così tangibile della preoccupazione per la propria sicurezza e incolumità corrobora e conferma il particolare codice di leggi che certi filosofi profondi e saggi hanno posto a fondamento e origine di ogni opera e atto della Natura, dal momento che i detti filosofi hanno molto saggiamente ricondotto l'attività di quella a massime e teorie, e hanno reso prezioso omaggio alla sua superiore saggezza e comprensione mettendo da parte ogni considerazione di cuore, ogni sentimento e impulso alla generosità. Queste infatti sono cose troppo al di sotto di madama Natura che per universale ammissione è tanto superiore ai capricci e alle debolezze del suo sesso. Se dovesse esserci bisogno di un'ulteriore prova della qualità strettamente filosofica del comportamento di questi due giovani gentiluomini in tali delicatissimi frangenti, la troverei senz'altro nel fatto (già precedentemente riportato nel corso di questa narrazione) che i due abbandonarono l'inseguimento quando l'attenzione generale era ormai fissata su Oliver, e che tagliarono immediatamente verso casa per la via più breve. E sebbene io non intenda affermare che è pratica consueta di famosi e dotti saggi l'abbreviare la via a ogni grande conclusione, giacché il loro programma è invero piuttosto quello di allungarla con ogni sorta di divagazione e di deviazione del discorso, come quelle in cui incorrono gli ubriachi pressati da una copiosa sovrabbondanza di idee, intendo però affermare, e anzi lo affermo decisamente, che, nell'applicazione delle loro teorie, è pratica inderogabile di molti arditi filosofi dar prova di grande saggezza e acume nel pararsi da ogni circostanza che abbia una qualche probabilità di contraddirle. Allo stesso modo, è legittimo fare un piccolo torto se serve a qualcosa di grande e giusto, ed è lecito ogni mezzo se è giustificato dal suo scopo, e la quantità di giusto o ingiusto, e perfino se esista tra loro una differenza, è lasciata interamente ai filosofi interessati, affinché essi la stabiliscano in base alla loro chiara, completa e imparziale considerazione dei casi particolari. Non prima d'aver superato velocissimamente un intricatissimo labirinto di stradine e vicoli, i due ragazzi ardirono di fermarsi, all'unisono, sotto un basso e oscuro porticato. Rimasti là in silenzio il tempo bastante per riprendere fiato e poter parlare, mastro Bates se ne uscì in una esclamazione di divertimento e piacere, e scoppiando in una incontenibile risata si lasciò cadere sul gradino di un portone e vi si rotolò in un parossismo di esultanza. «Cosa ti prende?», chiese Dodger. «Ah, ah, ah!», proruppe Charley Bates. «Sta' zitto», lo rimbrottò Dodger guardandosi attorno guardingo. «Vuoi che ci acchiappino, stupido?» «Non posso farci nulla», fece Charley, «non posso farci nulla. Me lo vedo ancora alzare i tacchi a quella velocità, scantonare di gran carriera, andare a sbattere contro i pali e ricominciare a correre come se fosse fatto pure lui dello stesso ferro, e io, con i fazzoletti in saccoccia, a urlargli dietro... oh, mi vengono le lacrime agli occhi!». La vivida immaginazione di mastro Bates gli presentò innanzi la scena a colori troppo vivi, e giunto a questa apostrofe si rotolò di nuovo sullo scalino ridendo ancor più fragorosamente di prima. «T'immagini come sarà contento Fagin?», chiese Dodger approfittando d'un momento in cui l'amico rimase in apnea per rivolgergli la domanda. «Che?», ribatté Charley Bates. «Che?», replicò Dodger. «Perché non dovrebbe essere contento?», domandò Charley di colpo interrotto nella sua allegria dall'espressione seria di Dodger. «Perché non dovrebbe essere contento?». Il signor Dawkins fischiettò per un paio di minuti e poi, levatosi il cappello, si grattò la testa e annuì tre volte. «Cosa vuoi dire?», domandò Charley. «Trallallero, trallallà, occhio compare, becchino beccò», disse Dodger con un leggero ghigno sulla sua fisionomia intellettuale. Se spiegazione era, non era del tutto soddisfacente, come avvertì mastro Bates, che chiese ancora: «Cosa vuoi dire?». Dodger non rispose ma, rimettendosi il cappello e radunando sotto il braccio i lunghi lembi del suo cappotto, cacciò la lingua contro la guancia, si batté familiarmente ma espressivamente sul dorso del naso una mezza dozzina di volte e facendo dietro front prese per un vicoletto. Mastro Bates lo seguì, piuttosto preoccupato. Il calpestio dei passi sulle scale cigolanti, alcuni minuti dopo che ebbe luogo questa conversazione, ridestò l'attenzione del simpatico vecchietto seduto e curvato sul fuoco con un salsicciotto e una pagnottella nella sinistra, un coltello da tasca nella destra e un pentolino di peltro su un treppiede. Un sorriso canagliesco gli aleggiava sul viso quando si girò e, scrutando intensamente di sotto le folte e fulve sopracciglia, indirizzò l'orecchio verso la porta e rimase attento in ascolto. «Ma che è successo?», borbottò l'ebreo mutando espressione. «Perché solo in due? Dov'è l'altro? Impossibile che si siano cacciati nei guai. Senti!». I passi s'avvicinavano; raggiunsero il pianerottolo. La porta s'aprì lentamente e Dodger e Charley entrarono, richiudendola dietro di loro. Capitolo XIII. Al lettore intelligente sono presentati nuovi personaggi. Si narrano molti fatti piacevoli a loro connessi, di interesse per questa storia «Dov'è Oliver?», disse l'ebreo furioso, alzandosi con uno sguardo minaccioso. «Dov'è il ragazzo?». I due ladruncoli lo scrutarono di sottecchi come se temessero un suo scatto violento, si scambiarono uno sguardo apprensivo ma non risposero nulla. «Che cosa è successo al ragazzo?», disse l'ebreo afferrando al collo Dodger e minacciandolo con orribili bestemmie. «Parla, o ti strozzo!». Vedendo Fagin infuriato sul serio, Charley Bates - che in ogni caso riteneva prudente stare sempre dalla parte del più forte, e niente affatto improbabile che toccasse a lui essere strozzato subito dopo - cadde in ginocchio e cacciò un lamento alto e continuo... qualcosa a mezzo tra un toro impazzito e una tromba parlante. «Ti decidi a parlare?», tuonò l'ebreo scuotendo Dodger così forte che perfino il rimanere infilato dentro il cappotto sembrò un perfetto miracolo. «L'hanno pizzicato, l'hanno! Ecco tutto», disse Dodger scontroso. «Via! Lasciami adesso, lasciami!». E con uno scatto si liberò dal suo pastrano, che rimase in mano all'ebreo, e afferrato il forchettone dette un affondo verso l'ebreo che, se fosse andato a segno, gli avrebbe fatto zampillar fuori più allegria di quanta se ne sarebbe potuto facilmente rimpiazzare in un mese o due. In tale rischioso frangente l'ebreo scartò all'indietro con più agilità di quanta si sarebbe potuta sospettare in uno tanto decrepito, e afferrato un boccale si accingeva a scagliarlo contro la testa dell'assalitore quando Charley Bates richiamò la sua attenzione con un urlo assolutamente terrificante, ed egli mutò improvvisamente bersaglio indirizzando il proiettile dritto sul secondo. «Fulmini e saette!», bofonchiò una voce cupa. «Chi m'ha scagliato questa cosa addosso? Buon per lui che m'ha preso la birra invece del boccale, altrimenti l'avrebbe pagata. Ah, c'era da giurarlo! Solo un vecchio ebreo indemoniato, ricco e avido, poteva buttar via qualcosa che non fosse acqua, o forse neanche quella, a meno che non avesse l'abitudine di fregarla alla Compagnia Idrica. Che succede, Fagin? Che io sia dannato, se il mio fazzoletto da collo non s'è sporcato di birra! Vieni dentro, tu, cane rognoso! perché resti fuori, come se ti vergognassi del padrone! Vieni dentro!». L'uomo che così ringhiava era un tipo ben piantato, sui trentacinque anni, in cappotto di velluto nero, lerce braghe di fustagno, mezzi stivali allacciati con stringhe e calzettoni grigi di cotone, che fasciavano un paio di gambe massicce e polpacci muscolosi... un genere di gambe che, così agghindate, paiono incomplete e non finite se prive dell'ornamento di un paio di ceppi. Aveva un cappello marrone in testa e attorno al collo una sudicia sciarpetta allora di moda tra il popolino, con i lunghi e sfrangiati lembi della quale s'asciugava la birra in faccia mentre parlava. Quand'ebbe finito emerse un grosso faccione, con una barba di tre giorni e due occhi incattiviti uno dei quali mostrava, nella variegata colorazione, sintomi d'aver sostenuto colpi recenti. «Vieni dentro, ci senti?», grugnì questo amabile malandrino. Un cane bianco e setoloso, col muso segnato da una ventina di graffi e lacerazioni, ciondolò dentro di malavoglia. «Che aspettavi a entrare?», disse l'uomo. «Stai diventando così superbo che ti vergogni di me di fronte a una compagnia, eh? Giù!». Quest'ordine fu accompagnato da un calcio che spedì l'animale all'altro capo della stanza. Sembrava esserci però abbastanza abituato, perché si arrotolò tranquillamente in un canto senza emettere suono alcuno e, sbattendo le palpebre sugli occhi maligni una ventina di volte in un minuto, parve occupato a studiare l'appartamento. «Che stai combinando? Maltratti i ragazzi, vecchio furfante avido, avaro in-sa-zia-bi-le?», disse l'uomo sedendosi spavaldamente. «Mi meraviglio che non t'hanno già accoppato; io l'avrei fatto al loro posto. Se fossi stato un tuo apprendista, t'avrei accoppato da un pezzo e... no, perché altrimenti non t'avrei più potuto vendere. Sei buono soltanto a essere esposto come mostruosità di natura in una bottiglia di vetro, se solo ne soffiassero di grosse abbastanza per ficcartici dentro». «Zitto! Zitto! Signor Sikes», fece tremando l'ebreo, «non parlare così forte». «Che signore e signore! Fammi il piacere!», replicò il ruffiano. «Se arrivi a questo vuol dire che gatta ci cova. Ti sei dimenticato come mi chiamo? Dillo, allora! Farò onore al nome mio, quando verrà il tempo». «Bene, bene, allora... Bill Sikes», disse l'ebreo con abbietta umiltà. «Sembri di malumore, Bill». «Forse», replicò Sikes. «Tu piuttosto mi sembri fuori dai gangheri, o la testa ti dice che se lanci boccali di peltro fai meno male che con una denuncia e...». «Sei matto?», disse l'ebreo afferrando l'altro per la manica e indicando i ragazzi. Il signor Sikes si limitò allora ad annodare un immaginario nodo scorsoio sotto l'orecchio sinistro e a far penzolare la testa sulla spalla destra, una pantomima che l'ebreo sembrò comprendere alla perfezione. Chiese quindi un bicchierino di liquore, in un gergo di cui la conversazione era abbondantemente nutrita ma che risulterebbe del tutto inintelligibile se riportato qui. «E bada di non avvelenarlo», disse Sikes posando il cappello sul tavolo. Disse questo per scherzo, ma se egli avesse potuto vedere la smorfia maligna con cui l'ebreo si morse le pallide labbra mentre si girava per andare allo stipo, forse avrebbe pensato che quella raccomandazione non fosse del tutto superflua, o che in ogni modo il desiderio di aggiungere qualcosa ai processi fabbricativi della distilleria non fosse troppo lontano dal cuore del simpatico vecchietto. Dopo aver ingollato due o tre bicchierini riempiti fino all'orlo, il signor Sikes si degnò di riconoscere la presenza dei ragazzi, graziosa azione che condusse a una conversazione nel corso della quale s'ebbe un resoconto, fino al minimo dettaglio, della ragione e del modo della cattura di Oliver, con le alterazioni e gli abbellimenti della verità che, date le circostanze, sembrarono a Dodger più che opportune. «Ho paura che si possa lasciar sfuggire qualcosa di pericoloso per noi», disse l'ebreo. «Capacissimo», ribatté Sikes con un ghigno. «Sei fritto, Fagin». «E ho pure paura, perciò», continuò l'ebreo, come se non avesse notato l'interruzione, «ho pure paura che se il gioco finisce per noi, potrebbe finire anche per parecchi altri, e che potresti uscirne peggio tu che io, mio caro». Sikes ebbe uno scatto e si voltò ferocemente verso l'ebreo; il quale però s'era incassato nelle spalle fino alle orecchie e fissava con uno sguardo vuoto la parete di fronte. Ci fu un lungo silenzio. Ciascun membro di quella rispettabile compagnia apparve sprofondato nelle proprie riflessioni, finanche il cane il quale, a giudicare dal modo di leccarsi malignamente il muso, pareva contemplare un attacco contro le gambe del primo passante che incontrasse per strada alla prossima sortita. «Qualcuno deve scoprire cosa è successo dal giudice», disse Sikes in un tono parecchio più basso di quello con cui aveva iniziato. L'ebreo accennò di sì con la testa. «Se non ha cantato ed è in gattabuia, non c'è da temere fino a che non lo rimettono fuori», disse Sikes. «A quel punto però dobbiamo occuparcene. Bisogna riacciuffarlo, in tutti i modi». Di nuovo l'ebreo accennò di sì. Ovvia, invero, la prudenza di questa linea d'azione, ma sfortunatamente c'era qualche forte obiezione a che fosse adottata, e cioè che Dodger, Charley Bates, Fagin e William Sikes, tutti e ciascuno, avevano una violentissima e profonda refrattarietà a recarsi nelle vicinanze di un ufficio di polizia, qualunque ne fosse il motivo o la necessità. Per quanto tempo sarebbero potuti restare seduti a guardarsi l'un l'altro in quello stato di indecisione, non certo lusinghiero per nessuno, è difficile dire. Comunque sia, inutile congetturare in proposito giacché l'improvviso ingresso di due donne che Oliver aveva già incontrato in precedenti occasioni determinò un risveglio della conversazione. «Capitate a proposito!», fece l'ebreo. «Ci andrà Bet. Ci andrai tu, non è vero, Bet?» «E dove?», domandò la giovane donna. «Solo un salto alla stazione di polizia, mia cara», disse l'ebreo in tono affabile. Va detto per dovere d'onestà che quella giovane non oppose un "no" reciso, ma che si limitò ad esprimere enfaticamente un caloroso desiderio d'esser "dannata" se ci sarebbe andata: una gentile e delicata evasione della richiesta atta a dimostrare come la giovane donna possedesse quella naturale educazione per cui era incapace di opporre un rifiuto ai suoi simili in modo diretto e brutale. All'ebreo s'afflosciarono le guance; distolse allora lo sguardo da questa giovane, vivacemente, per non dire vistosamente vestita con una gonna rossa, stivaletti verdi e bigodini gialli, per volgerlo verso l'altra donna. «Nancy, mia cara», disse l'ebreo smielato. «Tu cosa ne dici?» «Che non funziona, sicché meglio non stare a provarci, Fagin», replicò Nancy. «Che vuoi dire?», domandò Bill Sikes guardandola torvo. «Quello che ho detto, Bill», replicò la donna senza scomporsi. «Ma se sei proprio la persona adatta a questa cosa!», argomentò Sikes. «Nessuno da queste parti sa chi sei». «E nemmeno voglio che lo scoprano», replicò Nancy sempre senza scomporsi. «Dico più di no che di sì, Bill». «Allora ci va, Fagin». «No, che non ci va, Fagin», disse Nancy. «Ci va, ci va, Fagin», disse Sikes. E il signor Sikes vedeva giusto. Per mezzo di minacce, promesse e future ricompense, la donna in questione fu infine convinta a tentare la missione. In realtà, non era trattenuta dalle stesse considerazioni che valevano per i suoi compari, dal momento che s'era da poco trasferita nella zona di Field-lane dal lontano e raffinato quartiere residenziale di Ratcliffe, e non aveva quella stessa paura di esser riconosciuta da qualcuno della sua vasta cerchia di conoscenze. Di conseguenza, indossato un capo immacolato sopra la gonna, e ficcati i bigodini sotto un cappelletto di paglia - articoli pescati entrambi dalla inesauribile riserva di Fagin - Miss Nancy si accinse ad uscire per la sua missione. «Ferma un istante, mia cara», disse l'ebreo porgendo un cestino coperto. «Tienilo in mano. Ti darà un'aria più rispettabile, mia cara». «Dalle pure una chiave da portare nell'altra, Fagin», disse Sikes. «Ci fa ancora migliore impressione». «Sì, sì, è vero, mia cara», disse l'ebreo appendendo una grossa chiave di portone all'indice della mano destra della donna. «Ecco qua! Benissimo! Benissimo davvero, mia cara», ribadì lisciandosi le mani. «Oh, il mio fratellino! Il mio povero, caro, dolce, innocente fratellino!», esclamò Nancy scoppiando a piangere e stringendo il cestino e la chiave in uno sfogo di apprensione. «Che gli sarà successo! Dove l'avranno portato! Oh, abbiate compassione e ditemi cosa gli hanno fatto, signori; per favore, signori, ditemelo!». Così pietosamente lamentandosi, come se le si spezzasse il cuore, per l'indicibile spasso del suo uditorio, Miss Nancy bruscamente s'interruppe, fece l'occhiolino alla compagnia, elargì un sorriso annuendo e spari. «Ah! Ecco una brava ragazza, miei cari», esclamò l'ebreo volgendosi ai suoi giovani amici e scuotendo gravemente la testa, come in muto ammaestramento affinché seguissero il luminoso esempio testé avuto innanzi agli occhi. «Fa onore al suo sesso», disse Sikes riempiendosi il bicchiere e picchiando fragorosamente l'enorme pugno sul tavolo. «Bevo alla sua salute, e auguro a tutti di essere come lei!». Mentre s'offrivano questi e altri encomi alle qualità di Nancy, quella giovane si recava il più speditamente possibile alla stazione di polizia dove poco dopo arrivò sana e salva, a dispetto di una naturale ritrosia a camminare per le strade da sola e senza protezione. Entrando dal retro, bussò piano con la chiave a una delle celle e rimase in ascolto. Nessun suono veniva dall'interno, sicché tossì e rimase di nuovo in ascolto. Non venendo alcuna risposta, usò la voce. «Nolly, caro?», mormorò Nancy gentilmente. «Nolly?». Dentro non c'era altri che un poveraccio di criminale senza scarpe, arrestato perché suonava il flauto. Riconosciuto colpevole senza alcun ragionevole dubbio di quel crimine contro la società, egli era stato opportunamente condannato dal signor Fang a un mese di Casa di Correzione, accompagnato dal giusto e divertente rimbrotto che, dal momento che aveva tanto fiato da perdere, poteva perderlo molto più proficuamente per azionare un mulino invece che per suonare uno strumento musicale. Nulla aveva replicato, occupato com'era nel piangere mentalmente la perdita del flauto, confiscato a vantaggio della contea. Così Nancy passò a bussare alla porta della cella successiva. «Sì?», s'udì da una fievole, debolissima voce. «C'è per caso dentro un ragazzo?», chiese Nancy dopo un singhiozzo di preliminare. «No», rispose quella voce. «Dio non voglia!». Era un vagabondo di un sessantacinque anni, che andava in prigione perché non suonava il flauto; ovvero, in altre parole, perché chiedeva l'elemosina per strada e non faceva nulla per guadagnarsi da vivere. Nella cella successiva c'era un altro che andava alla stessa prigione per aver venduto padelle di latta senza permesso, con ciò tentando sì di guadagnarsi da vivere ma ignorando l'autorità dell'Ufficio Licenze. Poiché tuttavia né l'uno né l'altro di questi criminali rispondeva al nome di Oliver, o sapeva alcunché di lui, Nancy si diresse decisamente verso la guardia col panciotto a strisce, e con pianti e lamenti pietosi alquanto, resi ancor più pietosi da un pronto ed efficace uso del cestino e della chiave chiese del suo povero fratellino. «Non l'ho io in custodia, mia cara», disse lui. «Ma dov'è?», gridò Nancy come sconvolta. «Se l'è portato via quel gentiluomo», replicò l'agente. «Quale gentiluomo? O santo cielo! Quale gentiluomo?», esclamò Nancy. In risposta alle sconnesse domande, l'uomo informò la sorella, in profonda ambascia, che Oliver era stato portato in ufficio in condizioni pietose, ed era stato discolpato dalla testimonianza di un tale che aveva dimostrato che il furto era stato commesso da un altro ragazzo, tuttora a piede libero, e che la parte lesa se l'era portato via, ancora svenuto, a casa propria, relativamente alla quale ultima tutto ciò che egli sapeva era che si trovava dalle parti di Pentonville, poiché l'aveva udito menzionare nelle indicazioni date al vetturino. In un terribile stato di ansia e incertezza, l'angosciata donna barcollò fino al cancello e quindi, mutando la sua andatura incerta in una rapida e regolare corsa, deviando e confondendo il percorso più che poteva, fece ritorno al domicilio dell'ebreo. Non appena udito il resoconto completo della spedizione, Bill Sikes chiamò in fretta il cane e ficcandosi in testa il cappello partì a tutta andatura, senza indugiare nella formalità di accomiatarsi dalla compagnia con un buon giorno. «Dobbiamo sapere dove si trova, miei cari; dobbiamo trovarlo», disse l'ebreo eccitatissimo. «Charley, non farti rivedere qua se non riporti qualche notizia! Nancy, mia cara, bisogna che lo trovi. Confido in te, mia cara... in te e in Dodger per ogni cosa! Aspetta, aspetta», aggiunse l'ebreo aprendo un cassetto con mano tremante. «Eccovi dei soldi, miei cari. Chiudo baracca, per stasera. Sapete dove trovarmi! Non c'è un minuto da perdere. Neanche un minuto, miei cari!». Con queste parole li spinse fuori della stanza e chiudendo accuratamente a doppia mandata e sbarrando la porta dietro di loro tirò fuori dal nascondiglio il cofanetto che aveva involontariamente fatto vedere a Oliver. Procedette quindi a nascondere orologi e gioielli sotto i propri indumenti. Nel mentre era così occupato, un rapido battere alla porta lo fece sussultare. «Chi è là?», strillò in tono acuto. «Io!», rispose la voce di Dodger attraverso il buco della serratura. «Che c'è allora?», gridò l'ebreo con impazienza. «Nancy vuole sapere se lo dobbiamo portare nell'altro covo», domandò Dodger. «Sì», rispose l'ebreo, «non importa dove lo pesca. Trovatelo, trovatelo e basta! So io cosa fare dopo, niente paura». Il ragazzo mormorò qualcosa in segno d'assenso e si precipitò di nuovo giù per le scale per raggiungere i compagni. «Non ha cantato, almeno per ora», disse l'ebreo continuando nella sua occupazione. «E se avesse intenzione di spifferare tutto con i suoi nuovi amici, siamo sempre in tempo a tappargli la bocca». Capitolo XIV. Contiene ulteriori particolari sul soggiorno di Oliver presso il signor Brownlow, assieme alla notevole predizione fatta da un certo signor Grimwig sul conto del ragazzo quando lo si mandò per una commissione Oliver si riprese presto dallo svenimento seguito alla improvvisa esclamazione del signor Brownlow, e sia l'anziano gentiluomo che la signora Bedwin evitarono accuratamente ogni altro riferimento al ritratto nelle successive conversazioni, s'astennero dal toccare argomenti relativi tanto al suo passato quanto al suo futuro, e si limitarono agli argomenti che potessero distrarlo e divertirlo senza eccitarlo. Era ancora troppo debole per alzarsi per la colazione, ma quando il giorno seguente scese nella stanza della governante, per prima cosa guardò ansiosamente alla parete dove sperava di poter vedere ancora il volto di quella bella signora. Questa sua attesa rimase però delusa, poiché il ritratto era stato tolto. «Ah!», disse la governante vedendo che direzione prendeva lo sguardo di Oliver. «Non c'è più, vedi?» «Sì, signora, non c'è più», replicò Oliver sospirando. «Perché l'hanno tolto?» «È stato tolto, figliolo, perché il signor Brownlow ha detto che siccome sembrava inquietarti avrebbe forse ritardato la tua guarigione, sai?», rispose l'anziana signora. «Oh, no davvero. Non m'inquietava affatto, signora», disse Oliver. «Mi piaceva guardarlo; proprio tanto». «Bene, bene!», disse amabilmente l'anziana signora. «Pensa a rimetterti più presto che puoi e vedrai che lo riappenderà di nuovo. Ecco! Te lo prometto! E ora parliamo di qualcos'altro». Queste, allora, furono tutte le informazioni che Oliver riuscì a ottenere sul quadro. E poiché l'anziana signora era stata così buona con lui durante tutta la sua malattia, egli, per il momento, cercò di non pensare più al ritratto. Ascoltò invece attentamente le tante storie che ella gli raccontava intorno a una sua adorabile e bella figliola, maritata ad un uomo altrettanto amabile e bello, stabilitasi in campagna; e su un suo figliolo, impiegato presso una ditta che commerciava con le Indie Occidentali: un bravissimo giovane anche lui, che quattro volte l'anno le scriveva delle lettere tanto amorevoli: al solo parlarne le venivano le lacrime agli occhi. Quando l'anziana signora ebbe spaziato a lungo sulle qualità dei suoi figli e sui meriti del marito, defunto, pace all'anima sua, or'è giusto ventisei anni, s'era fatta l'ora del tè. Preso il tè, cominciò a insegnare a Oliver il gioco del "cribbage", che egli in breve padroneggiò, sicché giocarono con grande interesse e impegno finché non fu tempo, per il convalescente, di prendere un po' di vino allungato con acqua bollente e una fetta di pane tostato e poi di mettersi al calduccio sotto le coltri. Furono giorni felici per Oliver, quelli della guarigione. Era tutto così tranquillo, pulito e ordinato, ed erano tutti così gentili e premurosi che, dopo il trambusto e l'agitazione in mezzo ai quali era sempre vissuto, gli sembrava un vero paradiso. Era a malapena abbastanza in forze per indossare da sé i propri abiti che il signor Brownlow gli fece portare un vestito nuovo di zecca, un cappello e un paio di scarpe nuove, e poiché gli fu detto che poteva disporre dei vecchi abiti come credeva li dette a una serva che era stata particolarmente gentile con lui pregandola di rivenderli a un ebreo e tenersi il ricavato. Il che lei fece speditamente e mentre Oliver stava a guardare fuori dalla finestra del salotto, vide un rigattiere ebreo sistemarli in un grosso fagotto e andar via e si sentì sollevato al pensiero di essersene disfatto e di essere libero dal pericolo di poterli indossare ancora. Si trattava di poveri stracci, a dire il vero, e Oliver non aveva mai avuto un vestito prima di allora. Una sera, circa una settimana dopo l'episodio del quadro, mentre sedeva a parlare con la signora Bedwin, arrivò un messaggio da parte del signor Brownlow, per dire che se Oliver Twist si sentiva abbastanza bene avrebbe avuto piacere di riceverlo nel suo studio e di parlargli un po'. «Santo cielo misericordioso! Lavati le mani, e lascia che ti pettini i capelli come si deve, piccolo mio», disse la signora Bedwin. «Anima mia! Se l'avessimo saputo, t'avremmo messo anche un bel colletto pulito e saresti stato più splendente di una moneta da sei pence!». Oliver fece come gli disse l'anziana signora, e sebbene lei si lamentasse e dolesse che non c'era neanche il tempo per sistemare il ricamo che orlava il colletto della sua camicia, egli aveva un aspetto così elegante e raffinato, a dispetto delle dette carenze, da farle esclamare che credeva impossibile poter ottenere, anche con un preavviso molto maggiore, un risultato migliore. Con tale incoraggiamento Oliver bussò alla porta dello studio. E quando il signor Brownlow lo invitò a entrare si trovò in una stanzetta che dava sul retro, piena zeppa di libri, con una finestra che guardava su dei graziosi giardini. Ad un tavolo, tirato fin sotto una finestra, c'era il signor Brownlow seduto a leggere. Non appena vide Oliver, mise da parte il libro e lo invitò ad avvicinarsi al tavolo e a sedersi. Oliver obbedì, chiedendosi meravigliato dove potesse trovarsi qualcuno in grado di leggere tutti quei libri scritti per rendere più saggio il mondo: una domanda che si pongono anche persone con più esperienza di Oliver, ogni giorno della propria vita. «Sono tantissimi libri, non è vero, ragazzo mio?», disse il signor Brownlow notando con quale curiosità Oliver osservasse gli scaffali che andavano dal pavimento al soffitto. «Veramente tanti, signore», rispose Oliver. «Non ne avevo mai visti tanti». «Li potrai leggere, se ti comporti bene», disse amabilmente l'anziano gentiluomo. «E ti piacerà più che guardarli dal di fuori... cioè, a volte, perché di certi libri la parte migliore è di gran lunga il dorso e la copertina». «Quelli che sembrano così pesanti, signore?», disse Oliver indicando qualche grosso volume dalla rilegatura vistosamente dorata. «Non sempre sono quelli», disse l'anziano gentiluomo sorridendo mentre accarezzava Oliver sul capo. «Ce ne sono di altrettanto pesanti, anche se di dimensioni notevolmente più piccole. Di', ti piacerebbe diventare una persona colta e scrivere libri?» «Credo che preferirei leggerli, signore», replicò Oliver. «Come, non vorresti essere uno scrittore?», disse l'anziano gentiluomo. Oliver rifletté un istante e alla fine disse che, tutto considerato, gli sembrava molto meglio fare il libraio. Al che l'anziano gentiluomo scoppiò in una risata, e dichiarò che Oliver aveva detto una cosa giustissima. Oliver ne fu assai contento, sebbene non capisse quale fosse. «Bene, bene», disse l'anziano gentiluomo ricomponendosi. «Non aver timore! Non faremo di te uno scrittore, almeno finché si potranno imparare mestieri onesti o ci si potrà dare a fabbricare mattoni». «Grazie, signore», rispose Oliver. A quella risposta così seria l'anziano gentiluomo rise di nuovo e disse qualcosa circa un certo istinto che Oliver non comprese, e che passò quindi inosservata. «Dunque!», disse il signor Brownlow parlando in un tono se possibile ancor più gentile ma allo stesso tempo molto più serio di quanto Oliver avesse mai sentito da lui fino ad allora. «Ti prego di prestare la massima attenzione, ragazzo mio, a quanto sto per dirti. Voglio parlarti senza riserva alcuna, perché sono sicuro che sei in grado di capirmi non meno di molti altri più grandi di te». «Oh, non ditemi che volete mandarmi via, signore, vi scongiuro!», esclamò Oliver allarmato dalla serietà di questo esordio. «Non scacciatemi di casa, a vagabondare per la strada come prima. Tenetemi qui con voi e sarò il vostro servo. Non rimandatemi a quel posto disgraziato da cui sono venuto. Abbiate compassione di un povero ragazzo, signore!». «Caro figliolo», disse l'anziano gentiluomo commosso dall'improvviso e accorato appello di Oliver. «Non c'è ragione di temere che io voglia abbandonarti, a meno che non me ne dia motivo tu stesso». «Ma io non ve ne darò, signore, mai!», interloquì Oliver. «Lo spero», replicò l'anziano gentiluomo. «Non credo che succederà mai. Mi sono ingannato, in passato, riguardo alle persone a cui ho tentato di far del bene, però mi sento fortemente incline a darti la mia fiducia, e più partecipe alla tua sorte di quanto io stesso riesca a spiegare. Le persone che ho amato e mi sono state più care sono ora nella tomba, ma anche se la gioia e la felicità della mia vita sono sepolte con esse, pure non ho fatto del mio cuore un sarcofago nel quale seppellire i miei migliori affetti. Anzi, il dolore li ha solo resi più forti e più puri». L'anziano gentiluomo disse questo a bassa voce, e più a se stesso che al suo giovane amico, e poiché dopo rimase in silenzio per un po', Oliver se ne stette seduto in attesa. «Bene, bene!», esclamò infine l'anziano gentiluomo in tono più sollevato, «dico questo perché il tuo cuore è giovane, e sapendo il dolore e le pene che ho patite, forse sarai più attento a non ferirmi di nuovo. Dici di essere orfano, senza amici al mondo. Tutte le indagini che ho potuto fare lo confermano. Ma raccontami tu stesso la tua storia: da dove vieni, chi ti ha allevato e come sei finito nella compagnia in cui ti ho trovato. Di' la verità, e non sarai più senza un amico, finché io vivo». Per qualche minuto, i singhiozzi strozzarono le parole in gola a Oliver. Quando poi fu sul punto di iniziare a narrare come fosse stato allevato nell'ospizio e successivamente condotto dal signor Bumble alla casa di lavoro, si sentì al portone un doppio battere di singolare impazienza, e la serva, correndo su per le scale, annunciò il signor Grimwig. «Sta salendo?», chiese il signor Brownlow. «Sì, signore», replicò la serva. «Ha chiesto se ci fossero in casa dei pasticcini, e quando gli ho detto di sì ha detto che si sarebbe fermato per il tè». Il signor Brownlow sorrise e volgendosi a Oliver disse che il signor Grimwig era un suo vecchio amico e non doveva far caso ai suoi modi bruschi, giacché aveva avuto prova che la sua burbera scorza nascondeva una degnissima persona. «Volete che scenda di sotto, signore?», chiese Oliver. «No», replicò il signor Brownlow. «Anzi, ho piacere che resti». Proprio in quel momento, sostenendosi a uno spesso bastone, entrò nella stanza un signore piuttosto tarchiato, leggermente zoppicante, vestito con un soprabito blu, panciotto a righe, braghe di velluto bruno, ghette di cotone gialle e un cappello bianco a larghe falde, con risvolti verdi. Gli spuntava dal panciotto la trina della camicia, a pieghettine minute; ne pendeva invece una lunga catena d'orologio di acciaio che ballava di qua e di là, e a un capo della quale non c'era altro che una chiave. I lembi della sua cravatta erano annodati in una palla dalle dimensioni pari a quelle di un'arancia; la varietà di espressioni che il suo volto poteva assumere supera ogni descrizione, e aveva un modo tutto suo di torcere la testa da un lato quando parlava, e contemporaneamente di guardare di sghimbescio, da richiamare all'osservatore l'immagine di un pappagallo. In tale attitudine egli si bloccò nel momento in cui fece il suo ingresso, e mostrando col braccio teso la buccia di arancia che aveva in mano esclamò borbottando burberamente: «Guardate qua! Vedete questa? È straordinario e stupefacente davvero che io non possa andare a trovare qualcuno in casa senza incappare per le scale in uno di questi alleati del povero chirurgo! Son diventato zoppo già a causa di una buccia di banana, e per la stessa causa ci lascerò anche le penne in conclusione, lo so. Sarà così, signore; le bucce d'arancia saranno la mia fine, o mi mangio la testa da me, giuro!». Con questo grazioso impegno il signor Grimwig confermava e rafforzava pressoché ogni affermazione che faceva, cosa ancor più singolare nel suo caso poiché anche ammettendo, per amor del vero, la possibilità che i progressi scientifici raggiungano un tale livello da mettere in grado un gentiluomo di mangiarsi la propria testa nel caso si senta a ciò disposto, la testa del signor Grimwig era così singolarmente grossa che la persona più sanguigna del mondo mai avrebbe potuto sperare di venirne a capo in una sola volta... senza contare minimamente l'ostacolo di uno spessissimo strato di talco sulla parrucca. «Mi mangio la testa, signore», ripetè il signor Grimwig battendo il bastone sul pavimento. «Ehi! Chi è costui?», chiese guardando Oliver e muovendo qualche passo indietro. «È quel giovane Oliver Twist di cui parlavamo», disse il signor Brownlow. Oliver fece un inchino. «Non vorrai dire che questo era il ragazzo ammalato, spero?», disse il signor Grimwig ritraendosi ancora un poco. «Aspetta un momento! Non parlare! Fermo...», continuò Grimwig bruscamente, perdendo ogni timore della febbre nel trionfo della sua scoperta. «Questo è il ragazzo che ha mangiato l'arancia! Se non è questo il ragazzo che ha mangiato l'arancia e ha buttato la buccia sulle scale, mi mangio la testa, e anche la sua per giunta». «No, no, non ne ha mangiato», disse ridendo il signor Brownlow. «Via! Metti giù il cappello e parlagli un po'». «Qui mi si tocca sul vivo, signore», disse l'anziano e irritabile gentiluomo levandosi i guanti. «Ora più, ora meno, ci sono sempre bucce d'arancia sul marciapiede della nostra strada e io so che ci sono state messe dal ragazzo del chirurgo all'angolo. Una giovane c'è scivolata sopra la sera passata, ed è finita addosso alla staccionata del mio giardino, e appena s'è alzata ho visto che guardava verso quell'infernale lanterna rossa, tipo pantomima natalizia, sulla porta del chirurgo. "Non andarci", ho gridato dalla finestra, "è un assassino! Una trappola anti-uomo!". Ed è così davvero. Se non è così...». E qui l'anziano e irascibile gentiluomo batté forte in terra col bastone; dal che gli amici inferivano il solito proponimento ogni volta che non era esplicitamente formulato in parole. Poi, sempre tenendo il bastone in mano, si sedette e aprendo un doppio occhiale, che portava legato a una larga fettuccia nera, esaminò attentamente Oliver; il quale, sentendosi sotto osservazione, arrossì e fece ancora un inchino. «Sicché questo è il ragazzo?», disse infine il signor Grimwig. «Questo è il ragazzo», replicò il signor Brownlow. «Come va, giovanotto?», disse il signor Grimwig. «Molto meglio, signore, grazie», rispose Oliver. Il signor Brownlow, sembrandogli di intuire che il suo eccentrico amico stava per dire qualcosa di sgradevole, chiese a Oliver di scendere da basso per informare la signora Bedwin che poteva servire il tè; il quale ordine Oliver, non piacendogli affatto le maniere dell'ospite, fu felicissimo di eseguire. «È un bel ragazzo, non è vero?», chiese il signor Brownlow. «Non so», replicò il signor Grimwig insinuante. «Non sai?» «No. Non so. Non distinguo un ragazzo dall'altro. So solo che ne esistono di due tipi. Quelli con la faccia da farinata e quelli con la faccia bovina». «E a quale tipo appartiene Oliver?» «Al tipo farinata. Un mio amico ha un figlio con la faccia bovina; un bel ragazzo, a dir loro, con una testa a palla e due guance rosse e occhi lucidi. Ragazzo tremendo, con corpo e membra che paiono fuoriuscire dalle cuciture dei suoi abiti blu, la voce di uno scaricatore e l'appetito di un lupo. Lo conosco bene, quello sciagurato!». «Via», fece il signor Brownlow, «non sono queste le caratteristiche del giovane Oliver, quindi non c'è bisogno che ti ci arrabbi». «Non lo sono», replicò il signor Grimwig, «ma potrebbe essere peggio». Al che il signor Grimwig tossicchiò nervosamente, e questo sembrò procurargli un indicibile piacere. «Potrebbe essere peggio, dico», ripetè il signor Grimwig. «Da dove viene? Chi è? Cosa fa? Ha avuto la febbre, va bene. E allora? La febbre non piglia solo le persone per bene, no? Piglia anche le persone cattive qualche volta, non è vero? Sapevo di un tale in Giamaica che è stato impiccato per aver ucciso il padrone. Aveva avuto sei attacchi di febbre, ma non per ciò è stato rimesso alla clemenza della corte. Pooh! È una sciocchezza!». Il fatto si è che nei più intimi recessi del cuore il signor Grimwig era fortemente incline ad ammettere che i modi e l'aspetto di Oliver erano insolitamente affabili; d'altro canto si distingueva per un forte spirito di contraddizione acuito, nella presente circostanza, dalla scoperta della buccia di arancia. Deciso poi a non subire imposizioni da nessuno su chi fosse un bel ragazzo e chi no, aveva fin dall'inizio deciso in cuor suo di contraddire l'amico. Quando il signor Brownlow ammise che su nessuno di quei punti poteva offrire una risposta soddisfacente e che aveva rinviato ogni indagine sul passato di Oliver a quando avesse ritenuto il ragazzo abbastanza in forze per sopportarlo, il signor Grimwig schioccò le labbra con maliziosa soddisfazione e chiese con un sorriso ironico se la domestica aveva l'abitudine di contare l'argenteria ogni sera; perché se un qualche radioso mattino avesse trovato mancanti uno o due cucchiai, beh, allora sarebbe stato soddisfatto... e così via. Il signor Brownlow, sebbene egli stesso a volte irruente, sopportò tutto questo con benevola pazienza poiché conosceva le capricciosità dell'amico, e siccome questo, prendendo il tè, manifestò tutto il suo grazioso e totale apprezzamento per i pasticcini, le cose fluirono molto tranquillamente, e Oliver, rimasto con loro, cominciò a sentirsi più a suo agio di quanto si fosse sentito fino ad allora in compagnia di quel burbero gentiluomo. «E quando ascolterai un resoconto fedele e particolareggiato della vita e delle avventure di Oliver Twist?», chiese il signor Grimwig all'amico a conclusione del rinfresco, guardando di sguincio Oliver mentre riapriva l'argomento. «Domattina», replicò il signor Brownlow. «Preferirei che egli fosse da solo con me, allora. Vieni nel mio studio domani mattina alle dieci, ragazzo mio». «Sì, signore», rispose Oliver. Lo fece con una certa esitazione, confuso dal duro sguardo che gli rivolgeva il signor Grimwig. «Ti dico io una cosa», sussurrò quel gentiluomo al signor Brownlow; «non verrà da te, domani mattina. Ho visto la sua esitazione. Ti sta ingannando, amico mio». «Sono certo che no», replicò il signor Brownlow accalorandosi. «Se viene...», fece il signor Grimwig, «io mi...», e giù col bastone. «Rispondo della sincerità di quel ragazzo con la mia vita!», disse Brownlow battendo sul tavolo. «E io della sua falsità con la mia testa!», ribatté Grimwig, battendo anch'egli sul tavolo. «Vedremo», disse il signor Brownlow sentendo la rabbia che montava. «Vedremo», replicò il signor Grimwig con un sorrisetto di sfida. «Vedremo». Come il fato volle, proprio in quel momento la signora Bedwin portò nella stanza un pacchetto di libri che quella stessa mattina il signor Brownlow aveva acquistato dal medesimo libraio già agli atti di questa storia, e poggiatolo sul tavolo si accingeva ad andarsene. «Dite al fattorino di aspettare, signora Bedwin!», fece il signor Brownlow; «devo rimandare indietro qualcosa». «È già andato via, signore», replicò la signora Bedwin. «Rincorretelo», disse il signor Brownlow; «è necessario. Non glieli ho ancora pagati, a quel pover'uomo. Poi ci sono anche dei libri da restituirgli». Il portone d'ingresso era aperto. Oliver si precipitò in una direzione e la ragazza dall'altra e la signora Bedwin si fermò sulla soglia a strillare per richiamare il ragazzo. Non si vedeva più nessuno, però. Oliver e la ragazza tornarono, trafelati, riferendo che non avevano potuto rintracciarlo. «Oh povero me, come mi dispiace», esclamò il signor Brownlow. «Desideravo proprio riconsegnargli quei libri entro stasera». «Mandaci Oliver», disse il signor Grimwig con un sorrisetto ironico. «Sarà capace a riportarglieli, no?» «Sì, glieli riporto io, signore, vi prego», disse Oliver. «Faccio una corsa, signore». L'anziano gentiluomo stava per dire che non avrebbe mandato Oliver, per nessun motivo, quando un colpetto di tosse di Grimwig, più malizioso del solito, gli fece cambiare decisione, con l'idea che il rapido disbrigo della commissione provasse immediatamente quanto fossero ingiusti i sospetti dell'amico, almeno sotto quel riguardo. «Allora ci vai tu, mio caro», disse l'anziano gentiluomo. «I libri sono sulla sedia accanto alla mia scrivania. Portali giù». Oliver, contentissimo di rendersi utile, portò giù i libri sottobraccio in tutta fretta e aspettò, cappello in mano, di sentire il messaggio da recare al libraio. «Devi dirgli», fece Brownlow fissando di sguincio l'amico, «devi dirgli che riconsegni i libri e che porti le quattro sterline e dieci scellini che gli dovevo. Questa è una banconota da cinque, sicché mi devi riportare un resto di dieci scellini». «Non ci metterò neanche dieci minuti, signore», rispose Oliver di slancio. Si abbottonò la banconota nella tasca della sua giacchetta e, stringendo i libri sotto il braccio, s'inchinò rispettosamente e lasciò la stanza. La signora Bedwin lo seguì fin sulla soglia di casa continuando a dargli informazioni sulla via più breve da seguire, il nome del libraio e il nome della strada, tutte cose che Oliver disse d'aver compreso benissimo; dopo essersi molto raccomandata di stare bene attento a tutto e a non prender freddo, l'anziana signora infine lo lasciò partire. «Benedetto quel bel visino!», disse l'anziana signora guardandolo allontanarsi. «Mi sento un poco in ansia a non averlo più sotto gli occhi». In quel preciso momento Oliver si voltò tutto raggiante e la rassicurò con un cenno della testa prima di svoltare l'angolo. Sorridendogli, l'anziana signora ricambiò il saluto e, chiusa la porta, tornò nella sua stanza. «Vediamo un po'... sarà di ritorno tra venti minuti al massimo», osservò il signor Brownlow tirando fuori il suo orologio e deponendolo sul tavolo. «Sarà buio, allora». «Oh! Allora ti aspetti veramente che ritornerà, eh?», domandò il signor Grimwig. «Tu no?», chiese il signor Brownlow sorridendo. In quel momento divampò lo spirito di contraddizione in petto al signor Grimwig, reso ancor più bruciante dal sorriso fiducioso del signor Brownlow. «No», disse battendo col pugno sul tavolo. «No che non ritorna. Quel ragazzo ha un completino nuovo addosso, qualche costoso libro sottobraccio e una banconota da cinque nel taschino. Tornerà dai suoi amici marioli, e si sganascerà dalle risate alle tue spalle. Se quel ragazzo fa ritorno a casa, mi mangio la testa». Al che, accostò la sedia più vicino al tavolo e lì rimase, seduto accanto all'amico aspettando in silenzio, con l'orologio tra di loro. Sarà bene osservare, a illustrazione dell'importanza da noi assegnata ai nostri giudizi e dell'orgoglio per le nostre più azzardate e frettolose conclusioni, che il signor Grimwig, niente affatto cattivo di cuore e pur sinceramente addolorato nel caso l'amico fosse stato ingannato e tradito, in quel momento sperava effettivamente, con tutto il cuore, che Oliver Twist non tornasse. Si fece così buio che a malapena si distinguevano le cifre del quadrante, ma i due gentiluomini seguitavano a star seduti in silenzio, con l'orologio tra di loro. Capitolo XV. Mostra come l'arzillo ebreo e Nancy stravedessero per Oliver Nel buio salottino di una bettola situata nella più sudicia zona di Little Saffron-Hill, una tana buia e cupa, dove d'inverno ardeva perennemente un lume a gas e dove d'estate non entrava mai raggio di sole, sedeva un uomo assorto sopra una brocchetta di peltro e un bicchierino con un forte sentore di liquore, in cappotto di velluto, braghe corte di cotone, mezzi stivali e calzettoni, che anche in quella fioca luce nessun agente di polizia avrebbe esitato un istante a riconoscere come William Sikes. Accucciato ai suoi piedi c'era il cane dal pelo bianco e gli occhi iniettati di sangue, occupato ora ad ammiccare al padrone calando entrambe le palpebre ora a leccarsi una larga ferita ancora fresca a un angolo del muso, risultato evidente di qualche recente conflitto. «Sta' buono, cane rognoso! Sta' buono!», disse Sikes rompendo improvvisamente il silenzio. O che le sue meditazioni fossero così intense da venir disturbate dall'occhieggiare del cane, o che il suo stato d'animo fosse così oppresso da quelle stesse meditazioni da richiedere il sollievo che solo può derivare dal prendere a calci un animale innocuo, è materia su cui si può solo congetturare. Ma quale che fosse la causa, l'effetto fu un calcio assestato al cane e una simultanea bestemmia. I cani non sono per solito propensi a vendicarsi delle offese inflitte loro dai padroni, ma il cane del signor Sikes avendo in comune col padrone disturbi caratteriali, e soffrendo forse in quel preciso momento della umiliazione subita, non ci pensò due volte a conficcare le zanne in una delle sue scarpe. Dopo una vigorosa strattonata si ritirò ringhiando sotto una panca, con ciò schivando appena in tempo la brocchetta di peltro che il signor Sikes gli aveva scagliato contro mirando alla testa. «Ti piacerebbe, eh?», disse Sikes afferrando in una mano l'attizzatoio e con l'altra facendo scattare un grosso coltello a serramanico che s'era cavato di tasca. «Vieni qua, cane indemoniato! Vieni qua! Mi senti?». Aveva sentito, senza alcun dubbio, poiché il signor Sikes aveva parlato nel tono più acuto di una voce già aspra; ma avendo qualche obiezione a farsi tagliare la gola, rimase dov'era ringhiando più ferocemente di prima mentre stringeva un capo dell'attizzatoio tra i denti, mordendolo come una belva infuriata. Alla resistenza dell'animale Sikes s'infuriò ancora di più; s'acquattò sulle ginocchia imbestialito e cominciò ad attaccare il cane. Questo saltava da un lato e dall'altro, facendo scattare le mascelle, ringhiando e abbaiando, mentre l'uomo portava i suoi affondi e i suoi colpi bestemmiando orribilmente. Il combattimento stava raggiungendo un punto di massima crisi per entrambi quando improvvisamente la porta si aprì e il cane si precipitò fuori lasciando Bill Sikes con l'attizzatoio in una mano e il coltello nell'altra. Ci vogliono almeno due contendenti per fare una lite, recita il vecchio adagio. Nello smacco dell'improvvisa ritirata del cane, egli trasferì immediatamente la sua aggressività sul nuovo venuto. «Perché diavolo vieni a intrometterti tra me e il mio cane?», disse Sikes con gesto minaccioso. «Che ne sapevo, mio caro, che ne sapevo?», replicò Fagin umilmente... giacché di lui e non altri si trattava. «Che ne sapevi, ladro smidollato che sei?», ringhiò Sikes. «Non sentivi lo strepito?». «Per niente, te lo giuro Bill, quant'è vero che son vivo», rispose l'ebreo. «E già, tu non senti mai niente, non è vero?», ribatté Sikes con un ghigno feroce. «E ti intrufoli di qua e di là quatto quatto senza farti sentire da nessuno! Come avrei voluto vederti al posto del cane mezzo minuto fa, Fagin». «E perché?», chiese l'ebreo con un sorriso forzato. «Perché al governo, che protegge la vita degli uomini come te, che non valgono nemmeno la metà di un cane, non gliene importa niente se uno uccide un cane a capriccio», replicò Sikes richiudendo il coltello con uno scatto e con uno sguardo pieno di sottintesi. «Ecco perché». L'ebreo si fregò le mani e sedendosi al tavolo fece finta di ridere alla facezia dell'amico ma era visibilmente a disagio. «Togli quel ghigno dal muso», disse Sikes rimettendo a posto l'attizzatoio e squadrandolo con furente disprezzo. «Togli quel ghigno. Con me c'è poco da ridere e da scherzare, a meno che non ti porti quel ghigno fin sotto il cappuccio dell'impiccato. Sono io che ti tengo in pugno, Fagin, non il contrario. E dannazione... Seguiterò a tenertici. Perciò! Se penzolerò io, penzolerai pure tu, sicché stai ben attento a quello che fai con me». «Bene, bene, mio caro», disse l'ebreo. «Lo so bene. Uno dipende dall'altro, Bill... Uno dipende dall'altro». «Umph!», fece Sikes come pensando che fosse più l'altro a dipendere da lui. «Allora! Cos'hai da dirmi?» «La fusione del bottino è andata bene», replicò Fagin, «e questa è la tua parte. È più di quello che ti toccherebbe, mio caro, ma io so che se in futuro avessi bisogno d'un favore da te e...». «Piantala con questa solfa», interloquì il mariolo impaziente. «Tira fuori il grano!». «Sì, sì, Bill. Un attimo, un attimo», replicò l'ebreo mellifluo. «Ecco qua! Tutto al sicuro!». Dicendo questo tirò fuori dal petto un fazzoletto di cotone annodato in un fagottino e sciogliendo il grosso nodo da un capo ne estrasse un piccolo involto di carta marrone. Strappandoglielo dalle mani, Sikes lo apri in fretta e si mise a contare le sovrane d'oro che conteneva. «Questo è tutto, vero?», domandò Sikes. «Tutto», replicò l'ebreo. «Per caso hai aperto l'involto e ne hai ingoiate un paio mentre venivi qui, eh?», domandò sospettosamente Sikes. «E non fingere d'offenderti se te lo chiedo; non sarebbe la prima volta che accade. Suona, forza». Queste parole, in chiaro inglese, trasmettevano l'ordine di scuotere il campanello, al richiamo del quale si presentò un altro ebreo, più giovane di Fagin ma dall'aspetto quasi altrettanto viscido e repulsivo. Bill Sikes si limitò a indicare la brocchetta vuota. L'ebreo, comprendendo immediatamente il gesto, andò a riempirla, non prima però d'aver indirizzato uno sguardo interrogativo a Fagin. Questo, come aspettandoselo, aveva sollevato gli occhi e scosse la testa in risposta, ma così impercettibilmente che un terzo difficilmente l'avrebbe notato anche a volerci far caso. Non lo notò Sikes, piegato in quel momento per riannodare il laccio della scarpa laceratogli dal cane. Forse, se avesse notato quello scambio di segnali, ne avrebbe concluso che non presagivano nulla di buono per lui. «C'è nessuno qui, Barney?», domandò Fagin mentre Sikes stava ancora curvo con gli occhi a terra. «Deadche ud'adima», rispose Barney le cui parole, se non proprio dal cuore, venivano certamente dal naso. «Nessuno nessuno?», chiese Fagin in un tono di sorpresa a indicare, forse, che nulla vietava a Barney di dire la verità. «Dessudo tradde la signorida Dadsy», replicò Barney. «Nancy!», esclamò Sikes. «Dove? Mi cecassero se non rispetto e ammiro il talento di quella ragazza». «Ha mangiato un piatto di bollito al banco», replicò Barney. «Mandala qui», disse Sikes versandosi un bicchiere di liquore. «Mandala qui». Barney guardò timidamente Fagin, come chiedendo il permesso, ma poiché l'ebreo rimase in silenzio e con gli occhi bassi, s'allontanò. Rientrò poco dopo, conducendo Nancy, ancora agghindata di tutto punto con cappellino, grembiule, cestino e chiave. «Hai fiutato la traccia, Nancy, non è vero?», chiese Sikes offrendo il bicchiere. «Sì, Bill, sì», replicò la giovane mandandolo giù, «e comincio ad averne abbastanza, per giunta. Quel piccolo bastardo s'è ammalato e ha trovato riparo in casa e...». «Ah! Nancy cara!», disse Fagin levando lo sguardo verso di lei. Ora, poco importa se fu un peculiare contrarsi delle sopracciglia rossicce dell'ebreo e un calare a metà delle palpebre sugli occhi incavati a dissuadere tacitamente la signorina Nancy dal divenire troppo loquace. Ciò che importa qui sono solo i fatti, e i fatti ci dicono che lei s'interruppe bruscamente e sorridendo civettuola a Sikes indirizzò la conversazione su altri argomenti. Dieci minuti dopo, all'incirca, il signor Fagin fu colto da un attacco di tosse, al che Nancy si tirò lo scialle sulle spalle e dichiarò che doveva andare. Il signor Sikes, sostenendo che doveva andare pure lui e più o meno dalla stessa parte, s'offri di accompagnarla. Uscirono insieme, seguiti a breve distanza dal cane, che sbucò dal cortile sul retro non appena vide il padrone sparire. Uscito Sikes, l'ebreo sbirciò fuori dalla porta della stanza, percorse il buio corridoio per accertarsi che fosse veramente uscito, gli agitò dietro un pugno minaccioso, borbottò una gran bestemmia e poi, ghignando orribilmente, tornò a sedere al tavolo, dove s'immerse all'istante nelle interessanti pagine della cronaca nera. Oliver Twist, nel frattempo, che mai avrebbe immaginato di trovarsi negli immediati paraggi del simpatico vecchietto, si stava recando dal libraio. Quando giunse a Clerkenwell svoltò per combinazione in una stradina laterale leggermente al di fuori del suo percorso, ma poiché non s'avvide dell'errore prima d'averla percorsa già a mezzo, e poiché sapeva che lo conduceva nella giusta direzione non credè opportuno fare marcia indietro e proseguì, il più speditamente possibile, con i libri sottobraccio. Mentre così andava, pensando a quanto dovesse sentirsi felice e grato e a quanto avrebbe dato per rivedere anche un solo istante il povero Dick che forse, proprio in quel momento, picchiato e lasciato senza cibo, piangeva amare lacrime, trasalì improvvisamente alle grida di una giovane: «Oh, il mio caro fratellino!». E non aveva fatto in tempo neanche a dare un'occhiata per rendersi conto di cosa stesse succedendo che fu bloccato da un paio di braccia che lo cingevano strettamente al collo. «No!», gridò Oliver dibattendosi. «Lasciatemi, lasciatemi! Chi siete? Perché mi fermate?». Non ebbe altra risposta se non altri acuti lamenti da parte della donna che l'aveva abbracciato con tutto il cestino e la chiave in mano. «Oh, il cielo sia lodato!», esclamò la donna. «L'ho trovato! Oh! Oliver! Oliver! Cattivaccio, a darmi tutte queste pene! Vieni a casa, caro, su. Oh, l'ho trovato. Grazie al cielo misericordioso, l'ho trovato!». Da queste incoerenti esclamazioni la giovane passò a un attacco di pianto così isterico che un paio di donne, nel frattempo avvicinatesi, ne furono spaventate e chiesero al garzone d'un macellaio dalla capigliatura impomatata con sugna di maiale, pure interessato allo spettacolo, se non volesse per caso correre a chiamare un dottore. Al che il garzone, evidentemente soggetto ad una certa pigrizia se non proprio all'indolenza, rispose che non ci teneva particolarmente. «Oh, no, no, non fa nulla», fece la giovane afferrando Oliver per la mano. «Sto meglio adesso. Vieni subito a casa, ragazzaccio crudele! Su!». «Cosa succede, signora?», chiese una delle donne. «Oh, signora», replicò la giovane, «quasi un mese fa è scappato dalla casa dei genitori, bravissime persone che s'ammazzerebbero di fatica, e s'è messo con una banda di ladruncoli e tipi poco raccomandabili, che alla madre quasi le si spezza il cuore». «Ragazzo sciagurato!», esclamò una delle donne. «Torna a casa, bruto irriconoscente che non sei altro», fece la seconda. «Non sono un bruto irriconoscente», replicò Oliver spaventato. «Non la conosco neanche questa giovane. E non ho né sorelle né padre né madre. Orfano sono, e vivo a Pentonville». «Oh! Ma sentitelo, come nega tutto, questo indisponente!», esclamò la giovane. «Ma... è Nancy!», esclamò Oliver vedendola ora in viso per la prima volta e arretrando di scatto per la meraviglia. «Vedete! Mi riconosce!», gridò Nancy rivolgendosi ai presenti. «Per forza, mi riconosce. Aiutatemi a farlo tornare a casa, brava gente, o finirà per uccidere la sua cara mamma e il papà, e spezzerà il cuore anche a me!». «Che succede, corpo d'un diavolo?», disse uno sbucato come un fulmine da una mescita di birra seguito da presso da un cane bianco. «Il giovane Oliver! Torna a casa da tua madre, piccolo bastardo! Dritto a casa, subito». «Non sono miei parenti. Io non li conosco. Aiuto! Aiuto!», gridò Oliver dimenandosi nella poderosa stretta dell'uomo. «Aiuto!», ripetè l'uomo. «Sì, t'aiuto io, ragazzaccio! Che sono questi libri? Li hai rubati, non è vero? Da' qua». Con queste parole gli strappò i libri dalle mani e lo colpì in testa. «Così si fa!», gridò uno dei curiosi dalla finestra di una soffitta. «Solo così righeranno dritto!». «Sicuro!», gridò un carpentiere dall'aspetto insonnolito guardando con approvazione alla finestra della soffitta. «È per il suo bene!», dissero le due donne. «E troppe ne piglierà, per il suo bene!», riprese l'uomo assestandogli un'altra sberla e afferrando Oliver per la collottola. «Vien via! Furfantello! Qua, Occhiodibove, badagli! Badagli!». Ancora debole per la recente malattia, stordito per i colpi ricevuti e dalla subitaneità dell'attacco, terrorizzato dal feroce ringhiare del cane e dalla brutalità dell'uomo, e scoraggiato per come i presenti lo credessero davvero l'incallito e sciagurato furfantello che era stato loro rappresentato, cosa mai poteva fare un povero bambino! Era già buio; si trovava in un quartiere della peggior specie e senza poter chiedere aiuto a nessuno: sarebbe stato inutile resistere. Subito dopo si vide trascinato in un labirinto di bui vicoletti, e spinto innanzi a un passo che rendeva i pochi tentativi di chiamare aiuto del tutto incomprensibili. Ma in verità poco importava che fossero comprensibili o meno, giacché non c'era nessuno in giro che se ne curasse. I lampioni a gas furono accesi; la signora Bedwin attendeva ansiosamente sull'uscio aperto; la serva era corsa una ventina di volte da un capo all'altro della strada per vedere se ci fossero tracce di Oliver; e i due gentiluomini perseveravano seduti nel salottino, al buio, con l'orologio tra di loro. Capitolo XVI. Racconta di cosa successe a Oliver Twist dopo che fu ripreso da Nancy Infine, stradine e vicoli terminarono in uno slargo intorno al quale si trovavano stalle e stai di animali e altri indizi di un mercato del bestiame. Quando vi giunsero, Sikes rallentò giacché la giovane non reggeva più il passo rapido che avevano tenuto. Volgendosi a Oliver, gli comandò rudemente di prendere la mano di Nancy. «Mi hai sentito?», ringhiò Sikes vedendo che Oliver esitava e si guardava attorno. Si trovavano in un angolo buio, lontano dagli itinerari più frequentati dai passanti. Oliver vide fin troppo chiaramente che ribellarsi sarebbe stato inutile. Protese la mano, e Nancy la strinse forte nella sua. «Dammi l'altra», disse Sikes afferrandogli la mano libera. «Qua, Occhiodibove!». Il cane levò gli occhi in su e ringhiò. «Guarda qua, cucciolo!», disse Sikes rivolto al cane mentre afferrava Oliver al collo con la mano libera. «Se prova a dire soltanto una parola, azzannalo, eh?». Il cane ringhiò ancora e leccandosi il muso lanciò un'occhiata a Oliver come se fosse ansioso di azzannargli la trachea senza inutili indugi. «Che mi cecassero, se non sta indicando che non gli dispiacerebbe affatto», disse Sikes contemplando l'animale con un sogghigno di feroce approvazione. «Ora sai cosa t'aspetta, padroncino, se scappi a rotta di collo per chiedere aiuto. Questo cagnolino metterà subito fine al gioco. Cammina, giovanotto!». Occhiodibove scodinzolò come per ringraziare di questo discorsetto insolitamente lusinghiero e con un altro ringhio d'ammonizione a beneficio di Oliver fece strada al gruppo. Stavano attraversando Smithfield, anche se, a giudizio di Oliver, sarebbe potuto essere benissimo Grosvenor Square. Era una notte buia e nebbiosa. La luce delle lampade dei negozi filtrava a malapena nella fitta nebbia che s'addensava vieppiù, avvolgendo strade e case in un manto tenebroso, rendendo quel luogo ancora più sconosciuto agli occhi di Oliver e i suoi dubbi ancor più deprimenti e cupi. Avevano mosso solo pochi, concitati passi innanzi quando la campana d'una chiesa batté l'ora. Al primo tocco la coppia che guidava s'arrestò, volgendo la testa in direzione della fonte del rintocco. «Le otto, Bill», disse Nancy quando quel battere cessò. «Che me lo dici a fare? Ci sento pure io, no?», ribatté Sikes. «Chissà se pure loro lo sentono», osservò Nancy. «Sicuro», replicò Sikes. «Fui messo dentro il giorno di San Bartolomeo, e potevo sentire ogni pe-pe-re-pé delle trombette da un penny suonate in fiera. Quella notte, in cella, il clamore e il trambusto che venivano da fuori rimbombavano così forte nel silenzio della vecchia prigione che quasi battevo di testa contro le lastre di ferro della porta». «Poveri diavoli!», disse Nancy ancora rivolta nella direzione da cui provenivano i rintocchi della campana. «Oh, Bill, quei bei giovani!». «Sì; a questo pensate, voi donne», ribatté Sikes. «Quei bei giovani! Beh, adesso sono beli'e morti, sicché importa poco». Con questo consolante pensiero Sikes parve soffocare una fitta di gelosia e serrando più forte il polso di Oliver gli intimò bruscamente di muoversi. «Aspetta un minuto!», disse la giovane. «Non passerei di fretta se a pendere dalla corda fossi tu, Bill, la prossima volta che suonano le otto. Continuerei a girare attorno a questo luogo fino a cadere esausta, anche se ci fosse la neve e non avessi neanche uno scialle per coprirmi». «E a che pro?», domandò il poco sentimentale Sikes. «A meno di non potermi lanciare una lima e venti iarde di buona corda, tanto varrebbe andarsene a spasso a cinquanta miglia da qui, o non camminare per niente, per quello che me ne verrebbe. Via, su, e non startene lì a pregare». La giovane scoppiò in una risata, si coprì meglio con lo scialle e proseguirono. Ma Oliver sentì che la mano le tremava e guardandola in viso mentre attraversavano la luce di un lampione a gas ne vide il pallore mortale. Continuarono a camminare per stradine sporche e poco frequentate per una mezz'ora buona, incontrando pochissime persone: tutte, all'aspetto, sembrando del medesimo ordine sociale di Sikes. Infine, girarono per una stradina angusta e più sudicia delle altre, piena di negozi di stracci e vestiti usati, quando il cane che trotterellava innanzi, come fosse consapevole che non c'era più bisogno ormai di sorvegliare Oliver, si fermò davanti all'uscio chiuso di una bottega apparentemente disabitata. L'edificio era in uno stato di completo abbandono e sulla porta era inchiodata una tavola con la scritta "Affittasi", con tutta l'aria di essere rimasta lì affissa per anni. «Tutto bene», fece Sikes guardandosi furtivamente attorno. Nancy si fermò sotto le imposte e Oliver udì il suono di un campanello. Attraversarono la strada, e rimasero per alcuni istanti sotto un lampione. S'udì un rumore, come se il telaio scorrevole d'una finestra fosse sollevato con cautela, e subito dopo la porta s'aprì piano. Allora Sikes, molto poco cerimoniosamente, afferrò Oliver per la collottola e tutti e tre entrarono lesti in casa. Il corridoio era in un buio pesto. Aspettarono finché la persona che aveva aperto non avesse di nuovo sbarrato e chiuso con una catena la porta. «C'è qualcuno?», chiese Sikes. «No», rispose una voce che a Oliver sembrò di avere già udita. «C'è il vecchio?», domandò il ladro. «Sì», rispose la voce, «e da un po' è rimasto muto come un pesce. Se sarebbe felice di vedervi? Ah! Per niente!». Lo stile di questa risposta, come pure la voce che l'aveva articolata, suonò familiare all'orecchio di Oliver, ma nel buio non si distingueva neanche la sagoma della persona. «Accendiamo un lumino o ci romperemo l'osso del collo», disse Sikes, «oppure inciamperemo sul cane! Se succede, attenti alle vostre zampe! Mi spiego?» «Aspettate un istante, che faccio un po' di luce», replicò la voce. Si sentirono dei passi allontanarsi, e un minuto dopo apparve la persona del signor John Dawkins, altrimenti detto Dodger. Nella mano destra reggeva una candela di sego, ficcata nello spacco di un pezzo di legno. Quel gentiluomo in erba, senza fermarsi per dare altri segni di essersi avveduto di Oliver a parte un ghigno divertito, si girò e fece segno ai visitatori di seguirlo giù per una rampa di scale. Passarono attraverso una cucina vuota e, aperta la porta di una stanza bassa che sapeva di terra, evidentemente ricavata da un cortiletto interno, furono accolti dallo scoppio di una risata. «Oh, per la parrucca di mio zio!», esclamò mastro Charley Bates, dai cui polmoni proveniva quella risata. «Chi si rivede! Oh, cribbio, chi si rivede! Oh, Fagin, guardalo! Non mi tengo. Guarda che bel piccioncino. Non mi tengo. Tenetemi voi, che scoppio dal ridere». Con questa incontenibile esplosione di allegria mastro Bates cadde steso sul pavimento e scalciò per cinque minuti buoni in un parossismo di gioia convulsa. Poi, balzando in piedi, strappò il pezzo di legno che reggeva la candela dalle mani di Dodger e avvicinatosi a Oliver lo squadrò per bene girandogli attorno. L'ebreo, nel frattempo, toltosi la cuffia da notte, si profondeva in una gran quantità di inchini allo sbigottito ragazzo, mentre Dodger, di disposizione piuttosto saturnina e di rado propenso a sfoghi di allegria se interferivano con gli affari, esaminava con meticolosità e scrupolo le tasche di Oliver. «Guarda che bei vestiti, Fagin», disse Charley avvicinando così la candela alla giacchetta nuova di Oliver che quasi vi appiccava fuoco. «Guarda che bei vestiti! Stoffa finissima e taglio da gran signore! Oh, occhi miei, che bel piccioncino! E guarda i libri; un gentiluomo sputato, Fagin!». «Felicissimo di trovarti così bene, mio caro», disse l'ebreo inchinandosi umilmente, beffardo. «Dodger ti darà un altro vestito, mio caro, così non ti rovini questo per la Domenica. Perché non ci hai scritto che arrivavi, mio caro? T'avremmo preparato qualcosa di caldo per cena». A questo, mastro Bates scoppiò in un'altra fragorosa risata; così fragorosa che lo stesso Fagin ne fu divertito e pure Dodger sorrise; ma poiché proprio allora sfilava da Oliver la banconota da cinque sterline, non è chiaro se il suo divertimento dipendesse dalla risata dell'amico oppure dalla sua scoperta. «Oilà! Cos'è questa?», chiese Sikes balzando innanzi mentre l'ebreo afferrava la banconota. «È mia, Fagin». «No, no, mio caro», disse l'ebreo. «È mia, Bill, mia. Tu ti prendi i libri». «Spetta a me!», disse Sikes con la massima determinazione mentre si metteva il cappello, «cioè, a me e a Nancy, altrimenti riporto indietro il ragazzo». L'ebreo trasalì; e trasalì Oliver, sebbene per un motivo completamente diverso, giacché sperava veramente che da quella disputa potesse seguire il suo ritorno a casa. «Su! Da' qua, per piacere», disse Sikes. «Questo non è per niente giusto, Bill, per niente giusto, non è vero Nancy?» «Giusto o non giusto», ribatté Sikes, «da' qua, ti dico! Che credi; che io e Nancy non s'abbia altro da fare che sprecare il tempo nostro a riacciuffare tutti i ragazzini pizzicati a causa tua? Da' qua, vecchio taccagno scheletrito; da' qua!». Con questa gentile rimostranza Sikes strappò la banconota che l'ebreo teneva tra il pollice e l'indice e, guardandolo in faccia con freddezza, la ripiegò a proporzioni minute e se l'infilò nel suo fazzoletto da collo. «Questa è per la nostra parte di fatica», disse Sikes, «e non è neanche la metà della spettanza. Ti puoi tenere i libri, se ti piace la lettura. O se no, rivenditeli». «Troppo graziosi, sono», disse Charley Bates, che con svariate smorfie fingeva di star leggendo uno dei volumi in questione. «Bella stampa, non è vero, Oliver?»; e vedendo lo sguardo sbigottito con cui Oliver osservava i suoi torturatori, mastro Bates, per avventura dotato d'uno spiccato senso del ridicolo, cadde in un altro parossismo di risa, più fragoroso del primo. «Sono del vecchio gentiluomo», esclamò Oliver torcendosi le mani. «Del vecchio gentiluomo, tanto buono e gentile, che m'ha portato a casa sua e m'ha assistito quando stavo quasi per morire di febbre. Oh, vi prego, rimandateglieli; rimandategli i libri e i soldi. Tenetemi qui per tutta la vita, ma vi prego, vi prego, rimandateglieli. Penserà che glieli ho rubati, e anche la signora, e tutti quelli che sono stati così buoni con me penseranno lo stesso. Oh, per carità, rimandateglieli!». Con queste parole, pronunciate con tutta l'energia di un'accorata sofferenza, Oliver cadde in ginocchio ai piedi dell'ebreo giungendo le mani disperato. «Il ragazzo ha ragione», osservò Fagin guardando attorno ammiccante e aggrottando le cespugliose sopracciglia in un duro nodo. «Hai ragione, Oliver, hai ragione. Penseranno che li hai rubati tu. Ah, ah!», fece l'ebreo schioccando le labbra e fregandosi le mani. «Non sarebbe potuto capitare più a fagiolo, neanche volendo!». «Certo che no», replicò Sikes. «L'ho capito appena l'ho visto venire per Clerkenwell con i libri sottobraccio. Le cose si son messe per il verso giusto. Quei tipi lì sono di cuore tenero e salmodiano preghiere, altrimenti non lo avrebbero accolto. E non faranno altre indagini per paura di doverlo denunciare e di causargli una condanna alla deportazione. È abbastanza al sicuro». Mentre venivano pronunciate queste parole, Oliver guardava dall'uno all'altro, come sgomento e assolutamente incapace di capire ciò che stava succedendo ma, quando Sikes terminò, scattò in piedi e si slanciò selvaggiamente fuori della stanza, gridando così forte che quella vuota dimora ne echeggiava fino al tetto. «Tieni il cane, Bill!», gridò Nancy balzando alla porta per chiuderla, dopo che l'ebreo e i suoi due apprendisti si furono lanciati all'inseguimento. «Tieni il cane, o sbranerà il ragazzo». «Ben gli sta!», urlò Sikes cercando di liberarsi dalla stretta della giovane. «Levati di torno, o ti sbatto la testa al muro». «Non me ne importa niente, Bill, non me ne importa niente», strillò la ragazza lottando violentemente con l'uomo. «Quel cane non lo sbranerà se non ucciderai prima me». «Ah, sì?», disse Sikes digrignando ferocemente i denti. «T'uccido sicuro, se non ti levi subito di torno». Il ladro si liberò della giovane scagliandola all'altro capo della stanza nel preciso istante in cui l'ebreo e i due ragazzi tornavano trascinandosi dietro Oliver. «Che succede qui?», disse Fagin guardando attorno. «La ragazza ha dato di testa, credo», replicò Sikes furente. «No, per niente», ribatté Nancy pallida e senza fiato per la lotta. «No, per niente, Fagin. Non dargli retta». «Allora stai buona, va bene?», disse l'ebreo con uno sguardo minaccioso. «Non sto buona per niente», ribatté Nancy gridando. «E allora?». Il signor Fagin era abbastanza edotto degli usi e costumi della particolare specie di umanità alla quale Nancy apparteneva per essere sufficientemente persuaso della pericolosità del prolungare oltre la conversazione con la giovane, almeno per quel momento. Allo scopo di distrarre l'attenzione della compagnia si volse quindi a Oliver. «E così volevi scappare, mio caro, non è così?», disse l'ebreo afferrando un bastone nodoso posato in un angolo del camino. «Non è così?». Oliver non rispose, ma seguì i movimenti dell'ebreo col respiro corto. «Cercavi aiuto da qualcuno, magari dalla polizia, vero?», ghignò l'ebreo ghermendo il ragazzo per un braccio. «Ti si fa passare noi la voglia, mastro Oliver». L'ebreo gli assestò una bastonata sulla schiena e stava per assestargliene una seconda quando la ragazza, con un balzo, gli strappò il bastone di mano e lo gettò nel fuoco, con una violenza tale da far schizzar via pezzi di brace per la stanza. «Non starò a guardarti con le mani in mano, Fagin», gridò la ragazza. «Hai il ragazzo, no? Cos'altro vuoi? Lascialo stare... lascialo stare, o vi lascio io qualche brutto segno addosso, dovesse costarmi la forca prima del tempo». Così minacciando la ragazza batté violentemente il piede a terra e, a labbra serrate, pugni stretti, e il volto pallidissimo per l'impeto di rabbia che mano a mano s'impadroniva di lei, guardava ora l'ebreo ora l'altro mariolo. «Ma Nancy!», disse l'ebreo in tono conciliante dopo una pausa durante la quale lui e Sikes s'erano guardati alquanto sconcertati. «Sei... sei più brava del solito, stasera. Ah, ah! Mia cara, reciti a meraviglia». «Già!», disse la ragazza. «Bada che non porti la recita troppo avanti o sarà peggio per te, Fagin, sarà peggio per te. Perciò t'avverto per tempo: lasciami stare». C'è qualcosa in una donna infuriata, specialmente se alle sue forti passioni aggiunge gli irrefrenabili impulsi della disperazione e della indifferenza, che pochi uomini osano provocare. L'ebreo vide che sarebbe stato inutile fingere ancora di non aver compreso quanto reale fosse la rabbia di Nancy, e indietreggiando involontariamente di qualche passo lanciò uno sguardo tra l'implorante e il pavido a Sikes, come a fargli intendere di ritenerlo nella fattispecie la persona più adatta a proseguire il dialogo. A questo muto appello Sikes, toccato forse nel suo orgoglio e avvertendo il suo carisma messo a repentaglio se non avesse immediatamente ricondotto Nancy alla ragione, fece partire una scarica di bestemmie e minacce, la cui varietà e bellezza andarono tutte a credito della sua forza inventiva. Poiché non produssero però alcun visibile effetto sul bersaglio in questione, egli ricorse a più tangibili argomentazioni. «Che mi significa?», fece Sikes accompagnando la domanda con un notissimo anatema contro il più nobile dei cinque sensi, che se fosse ascoltato lassù soltanto una volta per ogni cinquantamila che lo si sente pronunciato quaggiù renderebbe la cecità un malanno comune quanto il morbillo. «Che mi significa questo? Mi brucino vivo! Lo sai chi e che cosa sei?» «E chi se lo scorda!», replicò la ragazza ridendo istericamente e scuotendo la testa da una parte e dall'altra, tentando di fingere indifferenza. «Bene allora, sta' buona, oppure ti faccio stare buona io per un bel pezzo», ribatté Sikes ringhiando come quando si rivolgeva al cane. La ragazza rise ancora perfino più sguaiata di prima e gettando una rapida occhiata a Sikes nascose il viso voltandosi e s'addentò il labbro fino a farne uscire il sangue. «È proprio curioso», aggiunse Sikes squadrandola con disprezzo, «ora si mette a fare la pietosa e la gentile! Un bel soggetto per dichiararsi amica del bambino, come lo chiami tu!». «Il Signore onnipotente m'aiuti! Sono amica sua», gridò la ragazza appassionatamente. «E avrei voluto cadere morta in mezzo alla strada, o trovarmi al posto di quei poveri condannati accanto ai quali siamo passati stasera, pur di non aiutarvi a riportarlo qui. Ora è destinato a diventare un ladro, un bugiardo, un diavolo e tutto quanto c'è di peggio. Non gli basta a quel vecchio sciagurato, anche senza picchiarlo?» «Via, via, Sikes», disse l'ebreo appellandosi a lui quasi in tono di protesta e accostandosi ai ragazzi, i quali seguivano con la massima attenzione quanto succedeva. «Usiamo un linguaggio civile, Bill, un linguaggio civile!». «Un linguaggio civile!», esclamò la ragazza, tremenda a vedersi nella sua rabbia. «Un linguaggio civile, furfante che non sei altro! Sì, te lo meriti proprio, da me. Io ho rubato per te da quando avevo la metà degli anni suoi!», fece indicando Oliver. «Da allora, ho continuato quel mestiere sempre al tuo servizio per dodici anni. Lo sai, vero? Parla! Lo sai?» «Via, via», replicò l'ebreo tentando di rabbonirla. «Seppure fosse, ci hai campato!». «Già!», ribatté la ragazza non tanto parlando quanto buttando fuori le parole in un grido continuo e veemente. «Ci ho campato; e perciò le strade fredde, fradice e sporche sono state la mia casa, e tu, sciagurato, quello che mi ci ha messo tanto tempo fa e ancora mi ci tiene, giorno dopo giorno, finché non crepo!». «Guarda che me la paghi!», interruppe l'ebreo irritato da queste rimostranze. «Me la paghi, se dici ancora qualcosa!». La ragazza tacque, ma, strappandosi i capelli e lacerandosi le vesti in un parossismo di rabbia, balzò con tale impeto sull'ebreo che gli avrebbe lasciato sul volto i segni della sua furia se non fosse stata afferrata ai polsi da Sikes proprio in quel momento; al che, con un debole tentativo di divincolarsi, svenne. «Adesso è tranquilla», disse Sikes sistemandola in un angolo. «Quand'è infuriata a questo modo ha una forza nelle braccia eccezionale». L'ebreo s'asciugò la fronte e sorrise, come sollevato che quel parapiglia fosse finito, ma né lui, né Sikes, né il cane sembravano considerare la cosa altro che un comune incidente nei loro affari. «Non c'è di peggio dell'avere a che fare con le donne», disse l'ebreo rimettendo a posto il bastone. «Però sono abili, e non possiamo andare avanti nel mestiere senza di loro. Charley, accompagna Oliver a letto». «Penso ch'è meglio che non si metta i vestiti buoni, domattina, vero Fagin?», domandò Charley Bates. «Certo che no», replicò l'ebreo ricambiando il ghigno col quale Charley aveva accompagnato la domanda. Mastro Bates, evidentemente parecchio lusingato da questo incarico, prese il legnetto della candela e condusse Oliver in una cucina adiacente dove c'erano due o tre dei letti sui quali aveva in precedenza dormito e qui, con incontenibili esplosioni di riso, tirò fuori quello stesso abito vecchio che Oliver s'era rallegrato tra sé di non dover più indossare quando stava dal signor Brownlow, e che, casualmente mostrato a Fagin dall'ebreo che l'aveva acquistato, aveva costituito il primissimo indizio di dove si trovasse Oliver. «Togliti questi vestiti eleganti», fece Charley. «Li dò a Fagin, così ci pensa lui a conservarteli. Che spasso!». Il povero Oliver obbedì malvolentieri. Mastro Bates, arrotolati i vestiti e ficcatiseli sotto il braccio, uscì dalla stanza lasciando Oliver al buio e serrando la porta dietro di sé. Lo scroscio delle risate di Charley e la voce della signorina Betsy, opportunamente sopraggiunta per spruzzare un po' d'acqua sulla sua amica e per adoperarsi in quegli uffici tutti femminili volti al recupero dei sensi dopo uno svenimento, avrebbero potuto tener deste molte altre persone in più felici circostanze di quelle in cui si trovava Oliver. Ma egli era sfinito e indebolito, sicché cadde subito profondamente addormentato. Capitolo XVII. Il destino avverso di Oliver continua, e conduce a Londra un grand'uomo che ne macchia la reputazione È consuetudine del teatro, in tutti i buoni melodrammi con tanto di assassini, presentare scene tragiche e comiche in regolare alternanza, come gli strati bianchi e rossi in un pezzo di pancetta magra ben stagionata. In una scena vediamo l'eroe steso su un pagliericcio, schiacciato dalle sventure e incatenato; nella seguente, il suo ignaro e fedele paggio regala al pubblico una canzonetta comica. Col cuore che ci martella in petto, vediamo l'eroina nelle grinfie d'un barone spietato e superbo, la sua virtù e la sua vita ugualmente in pericolo; lei sfodera il pugnale per preservare l'una a spese dell'altra, e proprio quando la nostra tensione raggiunge il massimo si sente un fischio, e siamo immediatamente trasportati nel salone di un castello, dove un canuto siniscalco canta strofette comiche accompagnato in coro da un ancor più comico gruppo di vassalli, fuori da ogni contesto, dalle volte delle chiese ai palazzi signorili, perpetuamente in giro a gorgheggiar canzoni. Questi bruschi cambiamenti paiono assurdi, eppure non sono così innaturali come sembrerebbero a prima vista. Nella vita reale, la transizione da ambienti profumati e pavimenti cosparsi di erbe ai letti di morte, dagli abiti del lutto a quelli della festa, non è affatto meno sorprendente; soltanto che in quella noi siamo attori partecipi e non passivi spettatori, e questo fa parecchia differenza. Nel teatro, che è una imitazione della vita, gli attori sono ciechi alle transizioni subitanee e ai repentini impulsi della passione o del sentimento, ma quando noi li abbiamo invece innanzi ai nostri occhi, da semplici spettatori, allora li condanniamo immediatamente in quanto bizzarri e grotteschi. Poiché i cambiamenti improvvisi di scena, i rapidi spostamenti nello spazio e nel tempo sono non soltanto sanzionati da lungo tempo nella pratica della scrittura, ma son da molti ritenuti tratto distintivo della grande arte - tali critici reputano infatti che la perizia di un autore nella sua particolare arte debba valutarsi in relazione a come egli sappia lasciare i suoi personaggi nel mezzo di grandi ambasce alla fine di ogni sezione - questa breve introduzione al presente capitolo sembrerà forse superflua. Se questo è vero, la si consideri un delicato avvertimento da parte del cronista che egli si appresta a tornare, di punto in bianco, alla cittadina nella quale Oliver Twist nacque, e il lettore tenga per certo che ci sono solide e ben fondate ragioni per intraprendere questo viaggio; altrimenti non lo si inviterebbe a compierlo, per nessunissimo motivo. La mattina, di buon'ora, il signor Bumble uscì dal cancello dell'ospizio e con portamento maestoso e passo imponente percorse la strada principale. Era nel pieno dell'orgoglio e della pompa del suo ufficio di custode parrocchiale, col tricorno e il soprabito splendenti nel sole mattutino, e la mazza ufficiale tenuta in mano con la vigorosa stretta della opulenza e del potere. Il signor Bumble portava la testa sempre alta, ma quel mattino era più alta del solito. C'era poi un che di così vago nel suo sguardo, di così elevato nella sua aria, da indurre un acuto osservatore a pensare che egli seguisse in mente pensieri indicibilmente alti. Il signor Bumble non si fermava punto a conversare con i piccoli bottegai e quant'altri gli rivolgevano ossequiosamente la parola al suo passaggio. Si limitava a rispondere al loro saluto con un ondeggiare della mano, senza rallentare minimamente la solenne cadenza dei suoi passi finché non giunse alla grangia dove la signora Mann, con parrocchiale sollecitudine, si prendeva cura dei poveri orfanelli. «Accidenti al custode!», imprecò la signora Mann sentendo il caratteristico scuotere al cancello del giardino. «Chi altri potrebbe presentarsi a quest'ora del mattino!... Cielo, signor Bumble! Voi. Chi l'avrebbe immaginato? Beh, mi fa veramente tanto, tanto piacere. Venite in salotto, signore, favorite». La prima esclamazione era stata rivolta a Susan; le esternazioni di gioia andarono invece al signor Bumble mentre la brava signora apriva il cancelletto del giardino e, molto premurosamente e rispettosamente, faceva strada verso casa. «Signora Mann», disse il signor Bumble né sedendosi normalmente né lasciandosi cadere su una sedia come un qualsiasi pincopallino, ma adagiandovisi gradualmente e lentamente. «Signora Mann, madama, buon giorno a voi». «Ah! Buon giorno a voi, signore», rispose la signora Mann con più d'un sorriso. «Spero di trovarvi bene, signore». «Così così, signora Mann», rispose il custode. «La vita parrocchiale non è precisamente un letto di rose, signora Mann». «Ah! quant'è vero, signor Bumble», replicò la signora. E tutti gli orfanelli avrebbero potuto convenire in coro su quella replica - se avessero potuto sentirla - tanto più prontamente di lei. «La vita parrocchiale, signora», continuò il signor Bumble picchiando con la mazza sul tavolo, «è una vita d'ambasce, d'affanni e di preoccupazioni, anche se tutte le persone pubbliche sono preparate alla sopportazione». La signora Mann, non sapendo bene a cosa si riferisse il custode, levò in alto le mani con una espressione di simpatia e sospirò. «Ah! Avete ragione a sospirare, signora Mann!», disse il custode. Vedendo il suo gesto apprezzato la signora Mann sospirò ancora, con evidente soddisfazione del pubblico ufficiale il quale, reprimendo un sorriso di compiacimento con uno sguardo intento al tricorno, rimarcò: «Signora Mann, sto andando a Londra». «Cielo! Signor Bumble!», esclamò la signora Mann con un balzo indietro. «A Londra, signora», riprese l'inflessibile custode, «in carrozza. Io e due orfanelli, signora Mann! Sta per discutersi una causa riguardo a un affidamento e la Direzione ha dato incarico a me... a me, signora Mann... di testimoniare in merito nella seduta trimestrale della corte di Clerkinwell. E ho serie ragioni per ritenere che la Corte», aggiunse il signor Bumble impettito, «si troverà con le spalle al muro prima che io abbia concluso». «Oh, non bistrattateli troppo, signore», disse la signora Mann adulando. «La Corte di Clerkinwell se l'è voluta, signora», replicò il signor Bumble, «e se la Corte di Clerkinwell ne verrà fuori peggio di come si aspettava dovrà ringraziare soltanto se stessa». Il modo minaccioso con cui il signor Bumble pronunciò quelle parole sprizzava così tanta determinazione e saldezza di proposito che la signora Mann ne fu spaventata. Infine disse: «Andate in diligenza, signore? Pensavo che si facessero viaggiare gli orfanelli sui carretti, di solito». «Così è, quando sono malati, signora Mann», ribatté il custode. «Gli orfanelli malati li mettiamo sui carretti quando piove, dimodoché non prendono infreddature». «Oh!», disse la signora Mann. «La diligenza della ditta concorrente ha contrattato per questi due e li prende a poco prezzo», disse il signor Bumble. «Stanno tutti e due malissimo, e abbiamo calcolato che trasferirli ci costerebbe due sterline in meno che seppellirli... cioè se riusciamo a scaricarli a un'altra parrocchia, e penso che ci riusciremo se non schiattano prima per strada solo per far dispetto a noi. Ah, ah, ah!». Dopo aver riso ancora un po' gli occhi del signor Bumble caddero di nuovo sul tricorno e la sua espressione ridivenne grave. «Stiamo trascurando il dovere, signora», disse il custode. «Eccovi lo stipendio mensile della parrocchia». Il signor Bumble tirò fuori dal suo taccuino alcune monete d'argento arrotolate con della carta e chiese la ricevuta; la signora Mann gliela rilasciò. «Sarà un poco imbrattata, signore», disse l'allevatrice di pargoli, «ma è stesa a regola, spero. Grazie, signor Bumble, grazie. Vi sono molto obbligata, davvero». Con un blando cenno del capo il signor Bumble ricambiò la cortesia della signora Mann e chiese come stessero i ragazzi. «Benedette creaturine!», disse la signora Mann con trasporto, «stanno bene quanto si può, cari piccini! Eccetto quei due morti la settimana passata, naturalmente. E il povero Dick». «Non è migliorato per niente, quel ragazzo?», chiese il signor Bumble. La signora Mann scosse la testa. «È gracilino, ma indisponente e dispettoso verso la parrocchia, quello là», disse il signor Bumble irritato. «Dov'è?» «Un istante e lo faccio scendere, signore», replicò la signora Mann. «Dick, vieni qua!». Dopo ripetuti richiami si trovò infine Dick, e ficcatolo con la faccia sotto la pompa e asciugatolo con la veste della signora Mann, lo si condusse infine alla terribile presenza del signor Bumble, il custode. Il ragazzo era pallido e smagrito, con le guance incavate e gli occhi lucenti e dilatati. I miseri cenci della parrocchia - la livrea della sua miseria - gli cadevano giù flosci, appesi al gracile corpo, e le sue giovani membra erano rinsecchite, come quelle di un vecchio. Tale era il piccolo che stava tremante sotto lo sguardo del signor Bumble, non osando alzare gli occhi da terra e temendo finanche di udire la voce di lui. «Non sei forse capace di guardare questo gentiluomo, ragazzo ostinato?», disse la signora Mann. Il ragazzo alzò gli occhi il tanto necessario per incontrare quelli del signor Bumble. «E allora, cosa ti succede, orfanello Dick?», domandò il signor Bumble con una giocosità perfettamente adeguata all'occasione. «Niente, signore», replicò debolmente il bambino. «Me lo auguro», disse la signora Mann, avendo naturalmente riso parecchio allo spirito del signor Bumble. «Certo non ti manca niente qui». «Vorrei...», balbettò il bambino. «Ohilà!», interloquì la signora Mann. «Ora stavi per dire che ti manca effettivamente qualcosa, suppongo? Beh, piccolo sciagurato...». «Calmatevi, signora Mann, calmatevi!», disse il custode levando la sua mano in segno di autorità. «Vorresti che cosa, per esempio, giovanotto, eh?» «Vorrei che qualcuno capace a scrivere scrivesse alcune parole per me su un pezzo di carta, lo ripiegasse, lo sigillasse e lo conservasse per me finché non sarò sepolto». «Beh? E che significa questo?», esclamò il signor Bumble, su cui i modi seri e l'aspetto smunto del bambino avevano fatto una certa impressione, per quanto fosse aduso a simili cose. «Che significa?» «Vorrei dire a Oliver Twist che gli voglio bene», disse il bambino. «Vorrei fargli sapere quante volte sono rimasto seduto tutto solo a piangere pensando a come andava ramingo nelle notti buie, senza nessuno che potesse aiutarlo. E vorrei dirgli», aggiunse il bambino fervidamente, tormentandosi le mani, «che sono contento di morire così giovane perché se fossi diventato adulto e poi vecchio la mia sorellina che sta in cielo forse non m'avrebbe riconosciuto e sarebbe stata diversa da me; più felice sarà per noi se potessimo ritrovarci lassù entrambi bambini». Il signor Bumble osservò quel piccolo da capo a piedi con indescrivibile meraviglia e volgendosi alla sua compagna disse: «Tutti la stessa storia, signora Mann. Quell'indisponente di Oliver li ha sobillati tutti quanti!». «Chi l'avrebbe creduto, signore?», disse la signora Mann levando le mani e fissando torvamente Dick. «Non ho mai visto uno sciagurato pari a questo!». «Portatelo via, signora!», fece imperioso il signor Bumble. «La faccenda dev'essere riferita alla Direzione, signora Mann». «Spero che i lor signori comprenderanno che non ne ho colpa, vero?», disse la signora Mann flautando pateticamente. «Comprenderanno, signora, comprenderanno; avranno un resoconto assolutamente veritiero del caso», disse il signor Bumble. «Portatelo via. Non sopporto di vedermelo ancora innanzi». Dick fu portato via immediatamente e rinchiuso nella buca del carbone. Subito dopo il signor Bumble uscì per prepararsi al suo viaggio. Alle sei del mattino seguente il signor Bumble, separatosi dal suo tricorno per un cappello a cilindro e infilatosi in un cappotto munito di cappuccio, prese posto all'esterno della carrozza assieme ai due criminali della cui assegnazione si doveva decidere e, a tempo debito, giunse con loro a Londra. Lungo il viaggio non ebbe a patire altre sofferenze se non quelle derivanti dal comportamento perverso dei due orfanelli i quali insistevano a tremare e a lamentarsi del freddo a tal punto che - dichiarò il signor Bumble - battevano i denti, sicché rabbrividiva lui pure nonostante il cappotto che aveva addosso. Raggiunta la locanda di posta e sistemati per la notte quei cattivi ragazzi, il signor Bumble sedette a tavola per una modesta cenetta a base di bistecche, salsa d'ostriche e birra scura, dopodiché, sistematosi un bicchierino di gin e acqua bollente sulla mensola del camino, accostò la sedia al fuoco e, con svariate riflessioni edificanti sul diffusissimo peccato della scontentezza e dell'insoddisfazione, s'accinse a leggere il giornale. Il primissimo paragrafo sul quale caddero gli occhi del signor Bumble consisteva del seguente annuncio: RICOMPENSA DI CINQUE GHINEE Poiché un ragazzo di nome Oliver Twist è scappato dalla sua casa a Pentonville, o è stato rapito, giovedì sera scorso, e non ha dato più notizie di sé, la suddetta ricompensa sarà pagata a chiunque dia informazioni tali da portare al ritrovamento del detto Oliver Twist, o da far luce sulla sua storia passata alla quale chi pubblica questo annuncio, per svariate ragioni, è vivamente interessato. Seguiva un'accurata descrizione dei vestiti di Oliver, del suo aspetto, di come era stato trovato e di come era scomparso, con l'indirizzo completo della casa del signor Brownlow. Il signor Bumble sgranò gli occhi, lesse parecchie volte l'annuncio lentamente e attentamente, in tre riprese successive, e dopo cinque minuti o poco più era in cammino alla volta di Pentonville, senza aver neanche assaporato, nella sua eccitazione, il bicchiere di gin e acqua bollente. «È in casa il signor Brownlow?», chiese Bumble alla ragazza che aprì la porta. Alla domanda la ragazza rispose con la non inconsueta ma alquanto evasiva risposta di «Non so; voi da dove venite?». Ma il signor Bumble aveva appena pronunciato il nome di Oliver per spiegare le ragioni della sua venuta che la signora Bedwin, rimasta in ascolto presso la porta del salottino, s'affrettò per il corridoio. «Entrate... entrate», disse l'anziana signora. «Lo sapevo che avremmo avuto sue notizie. Povero caro! Lo sapevo. Ne ero certa. Il cielo lo benedica! L'avevo detto, l'avevo detto». Con queste parole la brava signora tornò in fretta nel salottino e sedendosi sul sofà scoppiò in pianto. La ragazza, evidentemente non altrettanto impressionabile, era nel frattempo corsa di sopra, e ne tornò recando l'invito al signor Bumble di seguirla immediatamente; la qual cosa egli fece. Fu introdotto nello studiolo dove sedevano il signor Brownlow e l'amico, signor Grimwig, con accanto bicchieri e caraffe. Il secondo sbottò d'un tratto: «Un custode! Un custode parrocchiale o mi mangio la testa». «Vi prego, non interrompeteci per il momento», disse Brownlow. «Sedetevi, per piacere». Il signor Bumble sedette, piuttosto confuso dalle strane maniere del signor Grimwig. Il signor Brownlow spostò la lampada in modo tale da avere pienamente visibile il volto di Bumble e chiese con una certa impazienza: «Dunque, signore, siete venuto dopo aver letto l'annuncio sul giornale?» «Sì, signore», disse Bumble. «E siete effettivamente un custode, o no?», domandò Grimwig. «Sono custode parrocchiale, signori», rispose orgogliosamente Bumble. «Naturalmente. Lo sapevo», interloquì Grimwig. «Un custode spiccicato!». Il signor Brownlow scosse leggermente la testa per intimare silenzio all'amico; quindi riprese: «Sapete dove si trova adesso questo povero ragazzo?» «Non più di quanto lo sappia qualcun altro», rispose Bumble. «Bene. Cosa sapete di lui allora?», chiese l'anziano gentiluomo. «Parlate, amico mio, se avete qualcosa da dire. Cosa sapete di lui?» «Non è che avete da dire qualcosa di poco di buono su di lui, per caso?», disse caustico il signor Grimwig dopo aver scrutato attentamente in volto il signor Brownlow. Il signor Bumble, raccogliendo al volo l'allusione, scosse la testa con portentosa solennità. «Vedete?», esclamò Grimwig guardando trionfante il signor Brownlow. Il signor Brownlow osservò apprensivamente l'espressione compiaciuta di Bumble e gli domandò di riferire quanto sapeva di Oliver evitando inutili lungaggini, se possibile. Il signor Bumble poggiò da una parte il cappello, si sbottonò il mantello, incrociò le braccia, inclinò la testa per meglio rammentare e dopo aver riflettuto qualche istante iniziò la sua storia. La quale risulterebbe noiosa se riferita con le stesse parole del custode, per essa occorrendo non meno di venti minuti di narrazione. Tuttavia il succo e la sostanza si riduceva a questo: che Oliver era un orfanello, nato da genitori di bassa condizione e dubbia reputazione; che fin dalla nascita non aveva mostrato altre qualità che l'inganno, l'ingratitudine e la malvagità; che aveva concluso la sua breve carriera nel luogo natio con un vile e sanguinoso attacco contro un pacifico ragazzo e con lo scappare nottetempo dalla casa del padrone. A prova della identità che aveva dichiarato depose sul tavolo le credenziali che aveva portato in città e incrociando di nuovo le braccia attese i commenti del signor Brownlow. «Temo che sia tutto fin troppo vero», disse tristemente l'anziano gentiluomo dopo aver esaminato le carte. «Questa non è gran ricompensa per le notizie portate, ma vi avrei dato volentieri tre volte tanto se fossero state favorevoli al ragazzo». Non è affatto improbabile che se il signor Bumble l'avesse saputo prima che il colloquio giungesse a quel punto avrebbe potuto colorare in modo diverso la sua breve storia. Era troppo tardi per poterlo fare adesso, ad ogni modo, sicché scosse gravemente la testa e intascando le cinque ghinee se ne andò. Il signor Brownlow camminò su e giù per la stanza per qualche minuto, così evidentemente scosso dal racconto del custode che perfino il signor Grimwig s'astenne dal provocarlo ulteriormente. Infine si fermò e scosse con veemenza il campanello. «Signora Bedwin», disse Brownlow quando comparve la governante, «quel ragazzo, Oliver, è un impostore». «È impossibile, signore, è impossibile», fece energicamente l'anziana signora. «Vi dico che lo è», ribatté l'anziano gentiluomo. «Cosa significa "è impossibile"? Abbiamo appena sentito un resoconto dettagliato di lui, a partire da quando è nato. È stato sempre un furfantello matricolato, tutta la sua vita». «Non posso crederlo, signore!», replicò con fermezza l'anziana donna. «Non lo crederò mai!». «Voi donne anziane credete soltanto ai guaritori ciarlatani e ai libri di fandonie», bofonchiò il signor Grimwig. «Io lo sapevo dall'inizio. Perché non m'hai dato ascolto allora? Suppongo che m'avresti dato ascolto se non avesse avuto la febbre, eh? Ah, ma incuriosiva, non è vero? Incuriosiva! Bah!». E il signor Grimwig stuzzicò il fuoco brandendo l'attizzatoio. «Era un caro ragazzo, gentile e riconoscente, signore», ribatté la signora Bedwin indignata. «Io li conosco i bambini, signore; da almeno quarantanni, e chi non può dire la stessa cosa non dovrebbe parlare affatto. Questo penso io!». Era un deciso affondo al signor Grimwig, rimasto scapolo, ma poiché non sortì in lui altro effetto che un sorrisetto ironico, l'anziana signora inalberò la testa e si lisciò la gonna come preludio a una ripresa del discorso allorché fu bloccata dal signor Brownlow. «Silenzio!», disse l'anziano gentiluomo simulando un'ira che era lontanissimo dal provare. «Non voglio più sentir pronunciare il nome di quel ragazzo. Vi avevo chiamato appunto per dirvelo. Mai, mai più, per nessun motivo, badate! Potete lasciarci ora, signora Bedwin. Ricordate. Dico sul serio». Tristi, quella sera, furono i cuori in casa Brownlow. E anche a Oliver si strinse il cuore in petto pensando ai suoi buoni e soccorrevoli amici, e fu meglio per lui ignorare ciò che avevano sentito, o altrimenti avrebbe potuto spezzarglisi. Capitolo XVIII. Come Oliver passava il tempo nella edificante compagnia dei suoi rispettabili amici A mezzogiorno circa del mattino seguente, quando Dodger e mastro Bates erano già andati ad assolvere ai loro consueti doveri, il signor Fagin colse l'occasione per impartire a Oliver una lunga lezione sull'odioso peccato dell'ingratitudine, dimostrando chiaramente come Oliver se ne fosse reso enormemente colpevole nel suo volontario sottrarsi alla compagnia dei suoi ansiosi amici e tanto più perché aveva tentato di fuggire dopo i tanti fastidi e le spese affrontati per ricondurlo tra loro. Il signor Fagin sottolineò particolarmente come avesse accolto e nutrito Oliver quando, senza il suo aiuto, sarebbe potuto morire di fame; gli narrò poi la triste e compassionevole storia di un giovanotto a cui egli, da buon filantropo, aveva dato aiuto in simili circostanze ma che, dimostratosi indegno della sua fiducia e propenso al dialogo con la polizia, un mattino, sventuratamente, era finito impiccato nella prigione di Old Bailey. Il signor Fagin non tentò di nascondere quanta parte avesse personalmente avuto in tale catastrofe, ma lamentò, con le lacrime agli occhi, che la condotta testarda e traditrice del giovane in questione aveva reso necessario che egli rimanesse incastrato da certe prove messe a disposizione dell'accusa, le quali, se non strettamente rispondenti a verità erano assolutamente indispensabili per la propria (di Fagin) sicurezza più quella di alcuni suoi amici scelti. Il signor Fagin concluse col rappresentare un'immagine piuttosto sgradevole dei disagi dell'impiccagione e con modi gentili e amichevoli espresse la sua viva speranza di non dover essere mai costretto a sottoporre Oliver al medesimo trattamento. Mentre ascoltava quelle parole e comprendeva seppure imperfettamente le oscure minacce che gli venivano rivolte, il piccolo Oliver sentì il sangue raggelarglisi nelle vene. Già aveva sperimentato a sue spese come la stessa giustizia potesse confondere l'innocente col colpevole se li coglieva in una pur casuale compagnia, e non riteneva affatto improbabile che accuratissimi piani fossero stati elaborati e messi in atto dal vecchio ebreo in più d'una occasione per distruggere persone troppo loquaci o troppo spiacevolmente informate, tenendo a mente gli alterchi tra lui e il signor Sikes in certo modo relativi, sembrava, a qualche passata cospirazione del genere. Quando Oliver, sollevando timidamente gli occhi, incontrò lo sguardo penetrante dell'ebreo, sentì che il proprio pallore e il tremito delle sue membra non passarono né inosservati né dispiacquero a quel premuroso vecchietto. L'ebreo sorrise orribilmente, e dando buffetti sul capo di Oliver disse che se avesse fatto il bravo e si fosse applicato al mestiere sarebbero ancora potuti essere buonissimi amici. Quindi, prendendo il cappello e coprendosi con un vecchio cappotto rattoppato uscì chiudendo a chiave dietro di sé la porta della stanza. Oliver rimase così rinchiuso tutto quel giorno e per la maggior parte di molti giorni seguenti, non vedendo nessuno dalla mattina presto fino a mezzanotte, per quelle lunghissime ore lasciato solo con i propri pensieri: i quali, tornando immancabilmente ai suoi buoni amici e all'opinione che dovevano ormai essersi formata di lui, erano invero tristissimi. Dopo una settimana circa l'ebreo lasciò la stanza aperta ed egli fu libero di girare per la casa. Era un luogo sporchissimo. Le stanze di sopra avevano altissimi camini in legno e porte larghissime, e mura pannellate in legno e cornicioni ai soffitti, sui quali, benché anneriti dalla polvere e dall'incuria, si scorgevano i ricercati ornamenti. Da tutti questi segni Oliver concluse che molto tempo prima, prima ancora che l'ebreo fosse nato, vi avesse abitato gente di classe più elevata e fosse stato bello e gioioso per quanto ora sembrasse spaventoso e cupo. Agli angoli tra le pareti e il soffitto i ragni avevano tessuto le loro tele e a volte, quando Oliver entrava piano in qualche stanza, i topi correvano sui pavimenti e si precipitavano atterriti alle loro tane. Ad eccezione di questo, non si vedeva o sentiva creatura vivente e spesso, quando faceva buio ed egli era stanco di passare da una stanza all'altra, si accucciava in un angolo del corridoio che dava sulla porta di entrata, sì da sentirsi il più vicino possibile alla gente di fuori e là restava, sentendo e contando le ore, finché non tornavano l'ebreo o gli altri ragazzi. In tutte le stanze le imposte marcescenti erano sprangate e le tavole che le reggevano erano saldamente avvitate nel legno, e la sola luce che filtrava, aprendosi un varco attraverso i buchi in alto, era soltanto in grado di rendere ancor più cupe le stanze e a popolarle di strane ombre. C'era una finestra in una soffitta sul retro munita d'una grata di sbarre arrugginite all'esterno ma priva di imposte; da qui, spesso, Oliver guardava con espressione malinconica per lunghe ore di seguito ma da lì non si scorgeva altro se non una massa confusa e affastellata di tetti, camini anneriti e abbaini. A volte, per la verità, si scorgeva una testa canuta e scarmigliata affacciarsi dal balconcino di qualche lontana casa ma subito scompariva e poiché i vetri dell'osservatorio di Oliver erano fissi, e sporchi per il fumo e la pioggia di anni e anni, era già tanto se riusciva a scorgere le sagome degli oggetti esterni, e inutile invece ogni tentativo di farsi vedere o sentire... cosa altrettanto probabile che se fosse vissuto all'interno della palla posta in cima alla cupola della cattedrale di San Paolo. Un pomeriggio, poiché Dodger e mastro Bates avevano un impegno per la sera, il primo si mise in testa di placarsi qualche ansia relativa al proprio abbigliamento (debolezza che, per rendergli giustizia, non era affatto solito provare) e a tal fine e scopo ordinò graziosamente a Oliver di assisterlo immediatamente nella toletta. Oliver fu fin troppo felice di potersi rendere utile e di poter vedere qualche faccia conosciuta, ancorché cattiva, ed era fin troppo desideroso di ingraziarsi onestamente chi gli stava intorno per obbiettare alcunché alla proposta. Prontamente, perciò, si dichiarò disposto e inginocchiandosi sul pavimento, mentre Dodger sedeva sul tavolo in modo tale da potergli tenere il piede in grembo, s'applicò all'operazione dal signor Dawkins designata come "strofinargli l'attrezzatura da passeggio", una frase che, resa in semplice inglese, significava "lustrargli le scarpe". Ora, fosse il senso di indipendenza e libertà ipotizzabile in un essere razionale quando siede comodamente su un tavolo a fumarsi una pipa e a dondolare un piede avanti e indietro mentre gli si puliscono le scarpe, senza neanche il recente fastidio di essersele tolte o l'incombenza futura di doversele rimettere a turbare le sue riflessioni; o fosse la bontà del tabacco che molceva i sentimenti di Dodger, oppure la leggerezza della birra che gli inteneriva i pensieri; fatto sta che una sfumatura di romanticismo e di simpatia, generalmente aliena alla di lui natura, sembrava in quel momento aleggiare sulla sua persona. Stette un po' a guardare dall'alto in basso Oliver e poi, rialzando la testa e cacciando un leggero sospiro, rivolto un po' a tutti e un po' a mastro Bates, disse: «Peccato che non sia un manolesta!». «Ah!», fece mastro Bates. «Non sa quello che è bene per lui». Dodger sospirò ancora e riprese, come Charley Bates, a spipacchiare. Fumarono in silenzio per qualche secondo. «Nemmanco sai che è un manolesta, suppongo?», disse Dodger compatendolo. «Penso di sì», rispose Oliver sollevando lo sguardo. «È un mar...; tu sei un manolesta, non è vero?», disse poi correggendosi a mezzo della parola. «Proprio», replicò Dodger. «E non vorrei essere altro». Nell'esprimere questo sentimento il signor Dodger si spostò con aria feroce il cappello sulle ventitré e guardò mastro Bates, come a comunicargli quanto piacere avrebbe tratto da una sua eventuale obiezione. «Proprio», ripetè Dodger. «E così è per Charley. Così è per Fagin. Così è per Sikes. Così è per Nancy. Così è per Bet. Così è per tutti quanti noi, giù fino al cane, che è l'ultima ruota del carro!». «Ed è quello che canta di meno», aggiunse Charley Bates. «Se lo portassero alla sbarra dei testimoni non abbaierebbe nemmeno per paura di tradirsi; no, non lo farebbe neanche a volerlo legare e lasciare lì senza sbobba per una mezza mesata», disse Dodger. «Manco per sogno», osservò Charley. «Ci ha del sale in zucca, quel cane. Forse che non guarda storto certi giovinotti che ridono o cantano se è in compagnia?», continuò Dodger. «O non ringhia se sente suonare un violino? O non odia i cani di razza diversa dalla sua? Ah, no! Mica!». «È un vero cristiano», fece Charley. Ciò fu detto come semplice tributo alle qualità del cane, ma la frase era appropriata anche in un altro senso, pur rimanendone mastro Bates inconsapevole, poiché ci sono parecchie gentildonne e gentiluomini, cristiani professi, che hanno marcati e singolari punti di somiglianza col cane del signor Sikes. «Bene, bene», disse Dodger tornando al punto del proprio ragionamento con quel riguardo alla propria professione che caratterizzava ogni suo gesto. «Ciò non ha niente a che vedere con questo pivello qui». «Per niente, mica!», disse Charley. «A proposito, perché non ti metti a lavorare per Fagin, Oliver?» «E non fai così la tua fortuna?», aggiunse Dodger con un ghigno. «Sicché potrai ritirarti con un bel gruzzolo e fare il signore, come io voglio fare il prossimo anno bisestile di 465 giorni, ossia giusto alle calende greche?», disse Charley Bates. «Non mi piace», replicò Oliver timidamente. «Se solo volessero lasciarmi andare, io... io... vorrei andarmene invece». «Ma Fagin non ti lascerebbe, invece!», interloquì Charley. Oliver lo sapeva fin troppo bene, e ritenendo pericoloso esprimere più apertamente i propri sentimenti si limitò a sospirare e riprese a pulire le scarpe. «Via!», esclamò Dodger. «Ma dov'è il tuo spirito? Dov'è il tuo orgoglio? Vuoi campare alle spalle dei tuoi amici?» «Oh, al diavolo!», esclamò mastro Bates tirando fuori dalla tasca due o tre fazzoletti e gettandoli in uno stipo; «sarebbe da vigliacchi, sarebbe!». «Io almeno non potrei farlo», disse Dodger con un'aria di superbo disprezzo. «Già! Però sei capace di lasciare i tuoi amici a pagarla per te», disse Oliver accennando un sorriso. «Ma questo è stato solo per riguardo a Fagin», riprese Dodger agitando in aria la pipa. «Perché i piedipiatti ce lo sanno che lavoriamo assieme, e avrebbe potuto passare i guai se non ce la fossimo svignata; ecco il perché di quella mossa, non è così, Charley?». Mastro Bates assentì con la testa e avrebbe voluto dire qualcosa, senonché il tentativo di fuga di Oliver gli tornò in mente così improvviso che il fumo che stava inalando si scontrò con una risata in uscita, gli salì in testa e gli ripiombò in gola, generando uno spasimo di tosse e di calci in terra della durata di cinque minuti buoni. «Guarda qua!», disse Dodger tirando fuori una manciata di scellini e mezzi soldi. «Questa è una bella vita! Che t'importa da dove vengono? Dai, prendili; ce n'è parecchi altri dove sono stati presi. E allora, non t'alletta, eh? Pivellino che non sei altro!». «È cattivo, non è vero Oliver?», chiese Charley Bates. «Finirà appeso, giusto?» «Non capisco cosa significa», replicò Oliver. «Qualcosa del genere, compare», disse Charley; e nel dirlo mastro Bates afferrò un capo del suo fazzoletto da collo, dette uno strattone verso l'alto e fece cadere la testa di scatto su una spalla, emettendo uno strano suono tra i denti, con ciò significando, con una viva rappresentazione pantomimica, che essere appesi o impiccati erano la stessa e medesima cosa. «Ecco che significa», fece Charley. «Guarda come spalanca gli occhi, Jack! Mai visto un allocco come questo qui; ci schiatterò dal ridere, lo so». E mastro Charley Bates, dopo aver riso di nuovo di cuore, riprese a fumare la pipa con le lacrime agli occhi. «Il guaio è che hai avuto una cattiva educazione», disse Dodger esaminando soddisfatto le scarpe quando Oliver ebbe finito di pulirle. «Ma Fagin riuscirà a combinare qualcosa con te, o saresti il primo dei suoi a non rendere nulla di nulla. Perciò faresti meglio a cominciare subito, giacché sarai del mestiere molto prima di quanto pensi; stai solo perdendo tempo, Oliver». Il signor Bates accompagnò il consiglio con diverse ammonizioni di natura morale, terminate le quali lui e l'amico Jack Dawkins si lanciarono in una colorita descrizione dei numerosi piaceri inerenti la vita che conducevano, intervallata da ripetuti accenni a beneficio di Oliver tendenti a ribadire che la miglior cosa che potesse fare sarebbe stata quella di guadagnarsi i favori di Fagin senz'altro indugio, con i mezzi da loro stessi usati in precedenza. «E ficcati questo bene in zucca, Nolly», disse Dodger mentre si sentiva già l'ebreo aprire la serratura della porta di sopra. «Se non ci vai tu a pizzicare moccichini e padelle...». «A che pro gli parli a quel modo, se lui non ti capisce?», interloquì mastro Bates. «Se non ci vai tu a procurarti fazzoletti e orologi», fece Dodger portando la conversazione al livello di comprensione di Oliver, «ci andrà qualche altro... fanciullo, e chi si tira indietro peggio per lui, e peggio pure per te, e nessuno ci guadagnerà mezzo soldo bucato tranne quelli che ci avranno dato dentro... e tu ci hai diritto quanto loro». «Ma certo! Ma certo!», disse l'ebreo che era entrato non visto da Oliver. «Sta tutto in un guscio di nocciola, mio caro, in un guscio di nocciola, senti quello che dice Dodger. Ah, ah! Lui conosce bene la dottrina dell'arte nostra». Il vecchio si fregò le mani soddisfatto mentre avvalorava in tali termini le argomentazioni di Dodger e schioccò le labbra di piacere vedendo quanto profitto avesse tratto il suo allievo. La conversazione non andò oltre in quel momento poiché l'ebreo era tornato a casa accompagnato da Betsy e da un gentiluomo che Oliver non aveva mai visto prima, salutato da Dodger come Tom Chitling, il quale, dopo esser rimasto indietro sulle scale per avere agio di qualche galanteria con quella signora, fece ora il suo ingresso. Il signor Chitling era maggiore d'età di Dodger, poiché aveva forse passato i diciotto inverni, ma una certa misura di deferenza nel suo contegno verso quel giovane sembrava indicare la consapevolezza di una sua leggera inferiorità sia per quanto riguarda il genio personale che le abilità professionali. Aveva occhietti appuntiti, e una faccia butterata; portava un cappello di pelo, una giacchetta di velluto, pantaloni di cotone bisunti e un grembiule. Per la verità il suo guardaroba era piuttosto in disarmo, ma egli si scusò di fronte alla compagnia affermando che non era passata neanche un'ora dal suo "rilascio" e che, avendo dovuto indossare la tenuta d'obbligo per le sei settimane passate, non aveva avuto tempo di pensare ai suoi vestiti civili. Il signor Chitling aggiunse, con forti segni di irritazione, che la nuova procedura di fumigazione degli abiti in quel quartiere era maledettamente incostituzionale, giacché lasciava bruciacchiature e buchi, e la contea declinava ogni responsabilità. Le stesse osservazioni, a suo modo di vedere, si applicavano anche al nuovo regolamento sul taglio dei capelli, che considerava assolutamente illegale. Il signor Chitling concluse le sue osservazioni affermando che non aveva mandato giù un goccio di alcunché per quarantadue lunghissimi giorni di lavoro massacrante e che «lo cecassero se non era più secco di un cestino di limoni». «Da dove pensi che viene questo signore, Oliver?», domandò l'ebreo con un ghigno mentre alcuni altri ragazzi deponevano una bottiglia di liquore sul tavolo. «Io...io... non so, signore», replicò Oliver. «Chi è?», chiese Tom Chitling con uno sguardo di disprezzo all'indirizzo di Oliver. «Un mio giovane amico, mio caro», replicò l'ebreo. «È fortunato allora», disse quel giovane con uno sguardo di intesa a Fagin. «Non importa se non sai da dove vengo, ragazzo mio, lo capirai ben presto quando ci andrai da te, ci scommetto una corona!». A questa battuta i ragazzi si misero a ridere, e dopo altre spiritosaggini sullo stesso argomento confabularono un po' con Fagin e si ritirarono. Fagin e il nuovo arrivato, dopo aver scambiato qualche parola tra loro, avvicinarono le sedie al fuoco. L'ebreo invitò quindi Oliver a sedergli accanto e portò la conversazione su argomenti di sicuro interesse per i presenti, ovvero i grandi vantaggi di quel mestiere, la grande abilità raggiunta da Dodger, l'amabilità di Charley Bates e la liberalità di Fagin stesso. Infine, la discussione dette segni di stanchezza, e altrettanto dette a intendere per sé il signor Chitling, poiché la casa di correzione risulta faticosa dopo una settimana o due di soggiorno. Di conseguenza la signorina Betsy si ritirò e lasciò la compagnia al suo riposo. Da quel giorno Oliver fu rarissimamente lasciato solo. Ebbe invece la pressoché costante compagnia dei due ragazzi che, ogni giorno, non mancavano di eseguire il vecchio esercizio assieme all'ebreo: e chi se non lui sapeva se servisse più per il loro perfezionamento o per istruzione di Oliver? Altre volte quel simpatico vecchietto raccontava loro storie di furti da lui compiuti nei giorni andati, infarcendoli di tali curiosità e balordaggini che Oliver non poteva trattenersi dal ridere di cuore, e dal mostrarsi divertito a dispetto dei suoi sentimenti migliori. In breve, quel furbo vecchietto avviluppava così il ragazzo nelle sue spire. Dopo averne predisposto la mente a preferire una compagnia qualsiasi al rimuginare i suoi tristi pensieri da solo in quel luogo tetro, tenendolo in un lugubre confino, gli stava ora instillando nell'animo il veleno che, sperava, l'avrebbe annerito e ne avrebbe cancellato il candore per sempre. Capitolo XIX. Dove s'elabora e s'approva un piano di tutto rispetto Era una notte fredda, umida e ventosa quando l'ebreo, abbottonandosi il cappotto attorno al corpo smunto e tirandosi il bavero fin sopra le orecchie in modo da coprirsi completamente la parte bassa del viso, uscì dalla sua tana. Si fermò un attimo sul gradino di ingresso per accertarsi che dietro di lui l'uscio venisse serrato e incatenato, e che i ragazzi avessero ben assicurato ogni cosa, e quando non potè più udire i loro passi che s'allontanavano, scivolò lungo la strada più in fretta possibile. La casa dove era stato portato Oliver si trovava nelle vicinanze di Whitechapel. L'ebreo si fermò un attimo all'angolo della strada, e guardando sospettosamente in giro attraversò e prese in direzione di Spitalfields. Uno spesso strato di fango s'addensava sulle pietre e una nebbia fuligginosa gravava sulle strade. Cadeva una pioggia insistente ed ogni cosa era fredda e viscida. Sembrava proprio la notte adatta a qualcuno come l'ebreo per andarsene in giro. Mentre scivolava furtivamente lungo le strade, strisciando al riparo di mura e portoni, quell'essere odioso sembrava un rettile schifoso, generato dalla fanghiglia e dall'ombra nelle quali si muoveva, strisciando nottetempo a caccia di rimasugli per sfamarsi. Mantenne la sua direzione attraverso molte stradine tortuose finché non giunse a Bethnal Green. Poi, svoltando di colpo a sinistra, s'inoltrò nell'intrico di quelle lerce straducole, così numerose in quel quartiere soffocato e sovraffollato. L'ebreo, tuttavia, conosceva evidentemente a menadito la zona che stava attraversando per essere minimamente impressionato dalla oscurità della notte o dal labirintico percorso. S'affrettò attraverso molte stradine e vicoletti e infine svoltò in una viuzza illuminata soltanto da un lampione all'altra sua estremità. Qui bussò alla porta d'una casa e, dopo aver mormorato qualcosa alla persona che aveva aperto, salì di sopra. Quando strinse la maniglia d'una porta s'udì il ringhio d'un cane, e la voce d'un uomo chiedere «chi è là». «Sono io Bill, soltanto io, mio caro», disse l'ebreo facendo capolino. «Vieni dentro allora», fece Sikes. «E tu a cuccia, stupidissima bestia! Non riconosci il diavolo se ha un cappotto addosso?». Il cane era stato evidentemente ingannato dall'indumento che copriva il signor Fagin poiché, nel momento in cui egli si sbottonò e gettò il cappotto sulla spalliera d'una sedia, si ritirò nel cantuccio da dove s'era alzato, agitando nel mentre la coda, come a far intendere che era tanto soddisfatto quanto poteva consentirlo la sua natura. «Bene!», disse Sikes. «Bene, mio caro», replicò l'ebreo. «Ah! Nancy». Questo secondo segno di riconoscimento fu pronunciato con appena quel tanto di imbarazzo da implicare qualche riserva su come sarebbe stato accolto poiché il signor Fagin e la sua giovane amica non s'erano più incontrati da quando lei s'era intromessa in difesa di Oliver. I dubbi a riguardo, se mai ne aveva, furono prontamente dissipati dal comportamento della giovane: tirò via i piedi dal parafuoco, spinse indietro la sedia e invitò Fagin ad accostare la sua, senza ulteriori commenti, giacché non v'era dubbio che fosse una notte gelida. «Fa veramente freddo, Nancy cara», disse l'ebreo scaldandosi al fuoco le mani scarnite. «Sembra entrarti nelle ossa», aggiunse il vecchio toccandosi il fianco. «Dev'essere ben pungente, per penetrare un cuore come il tuo», rimarcò Sikes. «Dagli qualcosa da bere, Nancy. Fuoco d'inferno, spicciati. A vedere questa vecchia carcassa secca tremare a quel modo, come uno spettro appena uscito dalla tomba, ci si può buscare una febbre». Nancy prese subito una bottiglia da uno stipo che ne conteneva parecchie, e di diverso genere di alcolici a giudicare dalla varietà del loro aspetto. Sikes versò un bicchiere di brandy e invitò l'ebreo a scolarselo. «Ne hai messo tanto, Bill, grazie», fece l'ebreo posando il bicchiere dopo avervi soltanto appoggiato le labbra. «Che? Hai paura che ti vogliamo imbrogliare, è così?», domandò Sikes fissando l'ebreo. «Uh!». Con un grugnito sprezzante Sikes prese lui stesso il bicchiere e buttò nella cenere il contenuto residuo quale cerimonia prolusiva al riempirselo per sé: il che fece poi prontamente. Mentre il socio ingollava un secondo bicchiere, l'ebreo dette uno sguardo alla stanza, ma non per curiosità, poiché c'era stato prima diverse volte, ma in quel modo sospettoso e inquieto che gli era caratteristico. Era un ambiente piuttosto spoglio, con nient'altro a parte il contenuto dello stipo che potesse indurre a ritenere che l'abitasse qualche operaio o giù di lì, e in giro soltanto qualche articolo sospetto, quali due o tre pesanti mazze posate in un angolo e uno sfollagente appeso alla mensola del camino. «Ecco», disse Sikes schioccando le labbra. «Ora sono pronto». «Veniamo agli affari?», domandò l'ebreo. «Veniamo agli affari», rispose Sikes. «Sicché di' quello che hai da dire». «A proposito della casa di Chertesy, Bill?», disse l'ebreo abbassando al massimo la voce mentre accostava la sedia. «Sì. A proposito di quella», intimò Sikes. «Ah! Sai cosa ne penso, mio caro», fece l'ebreo. «Sa cosa ne penso, nevvero, Nancy?» «No, non lo sa», ghignò Sikes. «O non l'immagina, il che è la stessa cosa. Sputa fuori, e chiama le cose col loro nome. Non startene là seduto a fare occhiolini e a parlare cifrato come se non fossi stato tu il primo a ideare il furto. Che vuoi dire?» «Zitto, Bill! Zitto!», disse l'ebreo che aveva tentato invano di bloccare questo scoppio di indignazione. «Finirà che ci sente qualcuno, mio caro. Finirà che ci sente qualcuno». «E lascialo sentire!», disse Sikes. «Non me ne importa». Ma poiché, pensandoci bene, al signor Sikes pure importava, a quel punto egli abbassò la voce e si calmò alquanto. «Via, via», disse conciliante l'ebreo. «Te lo volevo solo ricordare... niente di più. E ora, mio caro, riguardo a quella casa di Chertesy... quand'è che si fa, Bill? Eh? Quand'è che si fa? Che argenteria, miei cari, che argenteria!», disse l'ebreo fregandosi le mani e sollevando le sopracciglia in un'estasi anticipatrice. «Non se ne fa nulla!», replicò Sikes freddamente. «Come, non se ne fa nulla!», ripetè l'ebreo reclinandosi sulla spalliera. «Già, nulla!», ribatté Sikes. «O almeno, non sarà facile come pensavamo». «Qualcosa è andato storto nella preparazione, allora», disse l'ebreo impallidendo di rabbia. «Non mi dire». «Eppure te lo dico», replicò Sikes. «Chi sei tu, che non te lo devono dire? Toby Crackit ci ha gironzolato intorno per una quindicina di giorni, e non ha potuto ungere nessuno della servitù». «Mi stai dicendo, Bill», disse l'ebreo placandosi nella misura in cui l'altro si riscaldava, «mi stai dicendo che non s'è potuto adescare nessuno dei due servi di casa?» «Già! Proprio questo ti sto dicendo», replicò Sikes. «Hanno servito quella padrona per vent'anni, e anche se gli dessi cinquecento sterline non abboccherebbero». «Ma mi stai dicendo, mio caro», ribatté l'ebreo «che non s'è potuto ungere neanche le domestiche?» «Macché!», rispose Sikes. «Non c'è riuscito neanche quell'elegantone di Toby Crackit?», disse incredulo l'ebreo. «Pensa a come sono le donne, Bill». «No, neanche Toby Crackit c'è riuscito. Dice che ci ha gironzolato intorno parecchio e per tutto il tempo s'è fatto vedere con i basettoni finti e un panciotto giallo canarino, ma senza risultato». «Avrebbe dovuto provare coi mustacchi e con un paio di pantaloni militari, mio caro», disse l'ebreo. «L'ha fatto», ribatté Sikes, «ma non è servito a niente uguale». Un'espressione perduta calò sul volto dell'ebreo a questa notizia. Dopo aver ruminato la cosa per qualche minuto col mento affondato in petto, sollevò la testa e tirando un profondo sospiro disse che se le informazioni di Toby Crackit erano giuste, allora, temeva, bisognava lasciar perdere. «È triste però», disse il vecchio lasciando cadere le mani sulle ginocchia, «perdere tutto questo bendidio quando uno ci ha quasi fatto la bocca». «Già!», disse Sikes. «Una sfortuna maledetta!». Seguì un lungo silenzio, durante il quale l'ebreo rimase profondamente assorto, con sul volto rugoso un'espressione canagliesca, da perfetto demonio. Sikes lo guardava di sottecchi di tanto in tanto, mentre Nancy, temendo di irritare il ladro, sedeva con gli occhi fissi al fuoco come se fosse sorda a tutto quanto avveniva. «Fagin», disse Sikes rompendo improvvisamente il silenzio che era calato, «sborseresti cinquanta sterline in più per lo scasso se possiamo tentarlo senza correre troppi pericoli?» «Sì», disse l'ebreo come se improvvisamente si ridestasse. «Allora siamo d'accordo?», chiese Sikes. «Sì, mio caro, sì» ribatté l'ebreo con lo sguardo ravvivato e i muscoli facciali rimessi in moto da quella allettante proposta. «Allora», disse Sikes scostando con un certo sprezzo la mano di Fagin, «prima si fa e meglio è. Toby e io abbiamo scavalcato il muro del giardino due notti fa per saggiare la solidità di porte e finestre. Di notte, quella casa è barricata come una prigione, ma c'è un punto che si può tranquillamente forzare senza far rumore». «E qual è, Bill?», chiese interessato l'ebreo. «Beh! Attraversi il prato e...». «Sì, sì», disse l'ebreo protendendo la testa con gli occhi che quasi gli uscivano fuori dalle orbite. «Uff!», esclamò Sikes fermandosi di colpo quando la giovane, muovendo appena la testa, si guardò improvvisamente intorno e per un attimo accennò in direzione dell'ebreo. «Non importa qual è il punto. Non puoi fare a meno di me, lo so, ma è meglio guardarsi le spalle quando si tratta con uno come te». «Come vuoi, mio caro, come vuoi», replicò l'ebreo. «Non avete bisogno d'altro aiuto, tu e Toby?» «No», disse Sikes. «Tranne un piediporco e un ragazzo. Di piediporco ce ne abbiamo uno a testa. Il secondo ce lo devi trovare tu». «Un ragazzo!», esclamò l'ebreo. «Oh, allora bisogna passare per un cunicolo, eh?» «Lascia perdere dove bisognerà passare!», replicò Sikes. «Mi serve un ragazzo e piuttosto smilzo. Cribbio!», fece Sikes pensando, «se solo avessi il ragazzo di Ned lo spazzacamino! Lo manteneva piccolo apposta, e lo affittava un tanto a lavoretto. Ma poi ti sobillano contro il padre, arriva la Società contro la Delinquenza Giovanile e leva dal mestiere quel ragazzo che si guadagnava da vivere, gli insegnano a leggere e scrivere e dopo un po' lo piazzano apprendista. E vai così!...», disse Sikes sempre più adirato al pensiero di questi torti. «E vai così!... E se guadagnassero abbastanza (ed è opera della Provvidenza se non succede) in un anno o due non ci sarebbe più neanche una mezza dozzina di ragazzi per il nostro mestiere». «Già, non più di mezza dozzina», convenne l'ebreo che era rimasto assorto durante questo discorso e aveva sentito solo l'ultima frase. «Bill!». «Cosa?», domandò Sikes. L'ebreo accennò con la testa in direzione di Nancy sempre assorta sul fuoco, suggerendo con ciò che avrebbe preferito se ella lasciava la stanza. Sikes, spazientito, fece spallucce, come se ritenesse superflua quella precauzione, e tuttavia raccolse il suggerimento e chiese alla signorina Nancy di portargli un bicchiere di birra. «Ma che birra e birra», disse Nancy incrociando le braccia e restando seduta senza scomporsi. «Ho sete, ti dico!», ribatté Sikes. «Sciocchezze», replicò la giovane con freddezza. «Vai avanti, Fagin. Tanto lo so perché Bill vuole la birra; ma non dovete preoccuparvi di me». L'ebreo tuttavia esitava. Sikes guardò sorpreso dall'uno all'altra. «Non avrai da ridire su Nancy! No, Fagin?», chiese infine. «La conosci da parecchio per poterti fidare di lei, oppure c'è lo zampino del diavolo. Non è una bocca aperta. Non è vero, Nancy?» «Direi di no!», replicò la giovane avvicinando la sua sedia al tavolo e appoggiandosi coi gomiti su quello. «No, no, mio caro, per niente!», disse l'ebreo. «Però...», e di nuovo il vecchio si fermò. «Eh?», chiese Sikes. «Va' a sapere se poi non perde la testa, mio caro, com'è successo la notte passata, sai?», ribatté l'ebreo. A questa confessione la signorina Nancy scoppiò in una sonora risata e ingollando un bicchiere di brandy scosse la testa con aria di sfida, uscendosene con varie esclamazioni del tipo: «Quando si è in ballo!», «Chi dispera è perduto!». Queste sembrarono sortire l'effetto di rassicurare entrambi gli uomini, giacché l'ebreo annuì con la testa soddisfatto e si rimise a sedere, e Sikes fece altrettanto. «Dunque, Fagin», disse Nancy con una risata. «Digli subito di Oliver!». «Ah! Brava, mia cara. Sei la ragazza più perspicace che ho mai incontrata!», disse l'ebreo dandole dei buffetti sul collo. «Effettivamente avevo intenzione di parlargli di Oliver, certo. Ah, ah, ah!». «Che dici del ragazzo?», chiese Sikes. «È il ragazzo che fa per te, mio caro», replicò l'ebreo in un rauco bisbiglio, appoggiando un dito a lato del naso e ghignando spaventosamente. «Lui!», esclamò Sikes. «Prendi lui, Bill!», disse Nancy. «Io lo prenderei, al tuo posto. Forse non è esperto, come gli altri ragazzi, ma non è l'esperienza che serve, se ti deve aprire solo una porta. Con lui vai sul sicuro, Bill, stanne certo». «Io ne sono certo», interloquì Fagin. «Ha avuto una buona scuola queste ultime settimane ed è ora che cominci a guadagnarsi il pane. E poi, gli altri sono troppo grossi». «Beh, se è per questo, è proprio della grandezza giusta», disse Sikes ruminando. «E farà tutto quello che gli dici, Bill, mio caro», osservò l'ebreo. «Non è capace a disobbedire. Cioè, se lo spaventi abbastanza». «Spaventarlo!», fece eco Sikes. «Non ci sarà bisogno di fingere, t'assicuro. Se tanto tanto fa una mossa strana mentre è con me, sia per un penny o per una sterlina, t'assicuro che non lo vedrai più vivo, Fagin! Pensaci, prima di affidarmelo. Tieni a mente cosa t'ho detto!», fece il ladro posando il piediporco tirato fuori di sotto il letto. «Ho valutato tutto per bene», disse l'ebreo energicamente. «Gli ho tenuto... gli ho tenuto gli occhi bene addosso, miei cari, ben addosso. Fagli sentire che è uno di noi; ficcagli in mente che si può già chiamare un ladro, ed è dei nostri! Dei nostri per sempre! Oho! Le cose non potevano mettersi meglio!». Il vecchio, incrociate le braccia sul petto e incassata la testa nelle spalle, contrasse il corpo in una sagoma indistinta, e si strinse da sé in un abbracciò di gioia incontenibile. «Dei nostri!», disse Sikes. «Dei tuoi, vuoi dire». «Forse, mio caro, sì», disse l'ebreo con uno schiocco maligno delle labbra. «Mio, se ti fa piacere, Bill». «Ma perché quella faccia di gesso ti sta tanto a cuore», disse Sikes in un ringhio feroce al suo amabile amico, «quando ogni notte una cinquantina di altri furfanti in erba smoccolano dalle parti di Common Garden, che basta solo fargli un fischio?» «Perché quelli non mi servono, mio caro», replicò l'ebreo tradendo un certo nervosismo, «non vale la pena prenderli. Se si cacciano nei guai basta che li guardano in faccia che li arrestano, e allora li perdo tutti. Con questo ragazzo, invece, se lo si governa bene, miei cari, ci faccio quello che non potrei fare con venti di quegli altri. Senza contare», disse l'ebreo riacquistando sicurezza, «che se ci sfuggisse dalle grinfie saremmo spacciati. Perciò dobbiamo tenerlo sulla nostra stessa barca. Non importa come ci è salito; e mi basta solo renderlo complice in un furto per poterlo governare a dovere. Non mi serve altro. Ora, questo è molto meglio di essere obbligati a tenere nascosto il ragazzo per forza, che sarebbe pericoloso e ci priverebbe del suo aiuto». «A quando il furto, allora?», chiese Nancy bloccando qualche improperio da parte del signor Sikes indice del disgusto con cui aveva accolto la manifestazione di buoni sentimenti di Fagin. «Ah, ecco», disse l'ebreo, «a quando, Bill?» «Avevamo deciso con Toby per dopodomani notte», riprese Sikes in tono seccato, «se non ha nuove da me». «Bene», disse l'ebreo, «non c'è luna». «No», fece Sikes. «È tutto predisposto per sistemare il bottino, vero?», chiese l'ebreo. Sikes annuì. «E per...». «Oh, ah, è tutto predisposto», interloquì Sikes troncandogli la frase. «Lasciamo stare i particolari. Meglio se porti il ragazzo qui domani sera; si parte un'ora dopo il crepuscolo. Poi tu bada di tenere la lingua a freno e ogni cosa pronta per la fusione; questo è tutto quello che devi fare». A seguito di una discussione in cui tutti e tre presero parte attiva, decisero che Nancy, scesa la notte, dovesse nascondersi dall'ebreo portando con sé Oliver; Fagin aveva all'uopo astutamente osservato che, qualora il ragazzo si fosse mostrato poco disponibile al lavoro, avrebbe più volentieri seguito la giovane che l'aveva difeso di recente che non qualsiasi altra persona. Inoltre si stabilì solennemente che il povero Oliver, agli effetti della prevista spedizione, dovesse restare sotto la stretta e incondizionata custodia e sorveglianza del signor William Sikes e, ancora, che il detto Sikes dovesse trattarlo a sua discrezione e non fosse imputabile da parte dell'ebreo di alcuna responsabilità per qualsiasi disgrazia o incidente potesse capitare al ragazzo, né per punizioni che dovessero rendersi necessarie, con l'intesa, al fine di rendere tale accordo più cogente, che eventuali resoconti di Sikes, al ritorno, dovessero trovare puntuale conferma, in ogni minimo dettaglio, nella testimonianza dell'elegante Toby Crackit. Sistemati questi preliminari, il signor Sikes cominciò a bere brandy a un ritmo forsennato e ad agitare il piediporco in maniera allarmante, mentre storpiava brani di canzoni niente affatto melodiose, intercalandoli a tremende bestemmie. Infine, in un parossismo di entusiasmo professionale, insistette per mostrare la sua valigetta di strumenti da scasso, ma non appena cercò di aprirla per spiegare la natura e le proprietà dei vari strumenti ivi contenuti e le particolari bellezze della loro fattura, ci inciampò sopra, cadde a terra e lì stesso s'addormentò. «Buona notte, Nancy», disse l'ebreo intabarrandosi come prima. «Buona notte». I loro sguardi s'incontrarono e l'ebreo la scrutò attentamente. Nessuna esitazione da parte della ragazza. Così serio e totale il suo coinvolgimento nella faccenda come era quello dello stesso Toby Crackit. L'ebreo le augurò di nuovo la buona notte e, assestando abilmente un calcio alla sagoma inerte di Sikes mentr'ella non lo vedeva, scese le scale a tentoni. «Sempre così!», borbottò l'ebreo tra sé mentre svoltava dirigendosi verso casa. «Il peggio delle donne è che basta un'inezia a risvegliare qualche sentimento sepolto, e il meglio è che non dura mai a lungo. Ah, ah! L'uomo contro il bambino per una borsa d'oro!». Ingannando il tempo con tali piacevoli riflessioni, il signor Fagin procedette, attraverso le pozze e la fanghiglia, fino alla sua lugubre dimora, dove Dodger, seduto, aspettava impazientemente il suo ritorno. «Oliver è a letto? Ho bisogno di parlargli», fu la prima cosa che gli disse mentre scendevano da basso. «Già da qualche ora», replicò Dodger spalancando una porta. «Eccolo!». Il ragazzo, profondamente addormentato, giaceva su un pagliericcio steso sul pavimento, così pallido per l'angoscia, i patimenti, e il regime di ferrea prigionia da sembrare morto; ma non con l'aspetto che i morti assumono nel sudario e nella bara, sebbene con quello che hanno quando l'anima s'è appena sciolta; quando essa è salita al cielo da un istante appena, e la greve aria del mondo non ha avuto ancora tempo di soffiare sulla polvere mutevole del corpo privo di vita. «Non ora», disse l'ebreo volgendosi senza far rumore. «Domani. Domani». Capitolo XX. Dove Oliver è consegnato al signor William Sikes Quando il mattino Oliver si svegliò fu alquanto sorpreso nel trovare che un nuovo paio di scarpe, con una suola molto spessa e robusta, gli era stato messo accanto al letto e che le sue gli erano state portate via. All'inizio fu contento della cosa, nella speranza che preludesse alla sua liberazione, ma questi pensieri si dissolsero subito allorché si sedette a colazione con l'ebreo, il quale gli disse, con un tono e maniere che accrebbero il suo allarme, che quella sera sarebbe stato portato a casa di Bill Sikes. «Ma... ci devo rimanere, signore?», domandò Oliver apprensivamente. «No, no, mio caro. Non devi rimanerci», replicò l'ebreo. «Noi non vogliamo perderti. Non temere, Oliver, ritornerai qui da noi. Ah, ah, ah! Non saremo così crudeli da mandarti via, mio caro. Oh, no! No!». Il vecchio, curvo sul fuoco per abbrustolirsi una fetta di pane, si voltò mentre così andava ammaestrandolo, e schioccò le labbra come a significare che sapeva che Oliver sarebbe stato felicissimo di tagliare la corda se avesse potuto. «Forse vorresti sapere cosa ci vai a fare da Bill, eh, mio caro?», disse l'ebreo fissando gli occhi su Oliver. Vedendo che il vecchio ladro gli aveva letto nel pensiero, Oliver colori in viso, senza volerlo, ma facendosi coraggio disse che sì, voleva saperlo. «E tu che pensi?», chiese Fagin schivando la domanda. «Non lo so proprio, signore», replicò Oliver. «Bah!», fece l'ebreo con un aspetto di affettata delusione dopo aver scrutato attentamente il volto del ragazzo. «Aspetta allora, te lo dirà Bill direttamente». L'ebreo sembrò perplesso dal fatto che Oliver non esprimesse ulteriore curiosità su quell'argomento, ma la verità è che il ragazzo, benché parecchio inquieto, era troppo confuso dall'aspetto scaltro e infido di Fagin e dai suoi stessi pensieri per domandare altro in quel momento. Non ebbe un'altra opportunità, poiché l'ebreo rimase chiuso in un cupo silenzio fino al calar della sera, quando cominciò a prepararsi per uscire. «Puoi accenderti la candela», disse l'ebreo collocandogliene una sul tavolo. «E puoi leggerti questo libro, finché non vengono a prenderti. Buona notte!». «Buona notte!», replicò Oliver con un filo di voce. L'ebreo si avviò alla porta, nel mentre voltandosi a guardare il ragazzo dietro le spalle. Poi, fermandosi di colpo, lo chiamò per nome. Oliver sollevò lo sguardo verso di lui e l'ebreo, indicando la candela, gli fece segno di accenderla. Oliver obbedì, e mentre posava il candeliere sul tavolo vide che l'ebreo lo guardava fissamente dall'altro capo della stanza, con le sopracciglia aggrottate. «Bada, Oliver! Bada!», disse il vecchio agitando innanzi a sé la mano destra a mo' di avvertimento. «È un bruto, e non ci pensa due volte a cavarti il sangue, se gli va alla testa il suo. Qualunque cosa accada, non dire niente e fa' come dice lui. Bada!». Con una forte enfasi sull'ultima parola allentò gradualmente i tratti del volto in un ghigno spettrale e annuendo con la testa lasciò la stanza. Quando fu scomparso, Oliver poggiò il capo sulla mano e con cuore tremante meditò sulle parole che aveva appena udito. Più pensava all'avvertimento dell'ebreo più perplesso era sul suo vero significato e scopo. Nell'essere inviato da Sikes non riusciva a pensare a scopi malvagi che non potessero fargli perseguire altrettanto bene lasciandolo da Fagin, e dopo aver riflettuto a lungo concluse che era stato scelto per assolvere a qualche compito di poco conto per lo scassinatore finché non si fosse trovato qualche altro ragazzo più adatto allo scopo. Era troppo aduso alla sofferenza, e troppo aveva sofferto dove si trovava allora per dolersi eccessivamente di un eventuale cambiamento. Per qualche minuto rimase perso nei suoi pensieri; poi, con un profondo sospiro, smoccolò la candela, e prendendo il libro lasciatogli dall'ebreo, iniziò a leggere. Girò le pagine dapprima senza prestarvi attenzione. Poi, cadendogli lo sguardo su un passo che l'incuriosì, sprofondò nella lettura. Quelle pagine, sudicie per l'uso e le numerose impronte, trattavano delle vite e dei processi di grandi criminali. Vi lesse di crimini così terribili da gelargli il sangue nelle vene; di nascosti assassini perpetrati al margine di strade solitarie e di corpi nascosti agli occhi degli uomini in profondi pozzi e antri i quali, profondi com'erano, non avevano voluto tenerli sepolti e li avevano infine rigettati in superficie, dopo molti anni, facendo impazzire alla loro vista gli assassini; e questi, atterriti, avevano confessato la loro colpa e urlando imploravano che la forca ponesse fine alla loro agonia. Qui, ancora, lesse di uomini che nel cuore della notte, sul loro giaciglio, erano stati istigati a perpetrare spargimenti di sangue tanto terribili che solo pensarli faceva accapponare la pelle e tremare le membra. Queste tremende descrizioni erano così vivide e reali che le pagine bisunte di grasso sembravano rosse di sangue raggrumato e le parole che vi erano scritte suonavano alle sue orecchie come vi fossero sussurrate in cupi mormorii dagli spiriti dei morti. In un parossismo di terrore il ragazzo richiuse il libro e lo spinse via da sé. Poi, cadendo in ginocchio, pregò il cielo di salvarlo da quelle cattive azioni e di fargli preferire piuttosto una morte immediata al dover perpetrare crimini tanto tremendi e orribili. Grado a grado si calmò, e a voce bassa e rotta pregò di essere salvato dai pericoli presenti, e se qualche aiuto meritava un povero reietto come lui, vissuto senza mai conoscere l'affetto di amici o l'amore della famiglia, che lo potesse ricevere in quel momento, quando stava solo e abbandonato in mezzo alla malvagità e alla colpa. Finita la preghiera, continuò a rimanere col volto nascosto nelle mani quando un fruscio lo scosse. «Cos'è!», gridò scattando in piedi mentre intravedeva una sagoma accanto alla porta. «Chi è?» «Io. Solo io», replicò una voce tremante. Oliver sollevò la candela più in alto della testa e scrutò verso la porta. Era Nancy. «Abbassa la luce», disse la giovane girando il capo. «Mi fa male agli occhi». Oliver vide che era pallidissima e le chiese gentilmente se si sentisse male. La ragazza si lasciò cadere su una sedia volgendogli le spalle e si tormentò le mani ma non rispose nulla. «Dio mi perdoni!», esclamò dopo un poco. «A questo non avevo pai pensato». «È successo qualcosa?», chiese Oliver. «Posso aiutarti? Lo farò, se posso, veramente». Lei dondolò avanti e indietro, s'afferrò la gola e con un gorgoglio roco annaspò, come stesse soffocando. «Nancy», gridò Oliver. «Cosa c'è?». La ragazza si batté le ginocchia con le mani e pestò i piedi in terra. Poi, smettendo di colpo, si strinse nello scialle e fu scossa da un tremito di freddo. Oliver attizzò il fuoco. Lei, avvicinando la sedia, vi rimase seduta accanto per un po', senza parlare. Infine, sollevò il capo e si guardò attorno. «Non so cosa mi piglia a volte», disse, facendo mostra di essere occupata a sistemarsi le vesti. «Forse è questa stanza sporca e umida. Allora, Nolly caro, sei pronto?» «Devo venire con te?», chiese Oliver. «Sì. Mi manda Bill», replicò la ragazza. «Devi venire con me». «Perché?», chiese Oliver. «Perché!», fece eco la ragazza levando gli occhi e poi distogliendoli di nuovo non appena incontrarono il viso del ragazzo. «Oh! Per nulla di male». «Non ci credo», disse Oliver che l'aveva guardata attentamente. «Come vuoi tu, allora», riprese la ragazza con una risata falsa. «Per nulla di buono». Oliver si rese conto d'un qualche suo potere sui migliori sentimenti della ragazza e per un istante pensò di fare appello alla compassione di lei. Ma poi gli balenò in mente l'idea che erano appena le undici e che tra le molte persone ancora in strada qualcuno forse avrebbe potuto prestar fede alla sua storia. Mentre così pensava, avanzò di qualche passo e con una certa precipitazione disse di essere pronto. Ma né quel momento di riflessione né il suo scopo passarono inosservati: la ragazza lo fissò attentamente e gli indirizzò uno sguardo per fargli capire che aveva compreso le sue intenzioni. «Zitto!», disse Nancy curvandosi verso di lui e indicando la porta mentre si guardava cautamente attorno. «Non puoi farci nulla. Ci ho provato io per te, con tutte le mie forze, ma senza risultato. Sei circondato da ogni lato, e se mai riuscirai a scappare da qua, non è questo il momento». Impressionato dalla veemenza dei suoi modi Oliver la guardò in viso alquanto sorpreso. Sembrava che lei dicesse la verità; era pallida e agitata e tremava per la tensione. «Ti ho salvato dalle botte una volta, e ti proteggerò ancora, così come ti sto proteggendo ora», continuò la ragazza ad alta voce. «E quelli che volevano riacciuffarti sarebbero stati ben più rudi di me, se non fossi venuta io. Ho dato la mia parola che te ne starai buono e quieto, e se così non sarà, farai solo del male a te stesso e a me e sarai forse causa della mia morte. Guarda qua! Ho già sopportato questo per te, quant'è vero che mi vede Iddio». Indicò frettolosamente lividi e ferite su collo e braccia e continuò con grande agitazione. «Ricordati questo! E fa' che non debba ancora patire io per te, proprio adesso. Se potessi aiutarti ti aiuterei; ma non posso. Non vogliono farti del male, e qualsiasi cosa ti impongano di fare la colpa non è tua. Zitto! Ogni tua parola è una ferita per me. Dammi la mano. Svelto! La mano!». Afferrò la mano che istintivamente Oliver aveva posto nella sua e smorzando la candela lo guidò su per le scale. La porta fu rapidamente aperta da qualcuno nascosto nel buio e fu altrettanto rapidamente richiusa quando furono passati. Una carrozza l'aspettava. Con la stessa foga mostrata nel parlare a Oliver, la ragazza lo tirò su con sé e chiuse le tendine. Il vetturaio non aveva bisogno di indicazioni ma senza attendere un istante frustò il cavallo che partì a tutta velocità. La ragazza teneva sempre stretta la mano di Oliver e continuò a sussurrargli all'orecchio avvertimenti e rassicurazioni. Tutto si svolse così in fretta e furia che, quando la carrozza si fermò innanzi alla casa alla quale l'ebreo aveva diretto i suoi passi la sera innanzi, ricordava appena dove si trovasse e come ci fosse arrivato. Per un breve istante Oliver gettò uno sguardo rapido lungo la strada vuota e un grido d'aiuto gli rimase sulle labbra. Ma sentiva all'orecchio la voce della ragazza che lo supplicava di ricordarsi di lei, e non ebbe il coraggio di gridare. In quella esitazione, l'opportunità sfumò, e si trovò in un batter d'occhio in quella casa, con la porta già chiusa dietro di lui. «Di qua», disse la ragazza, per la prima volta allentando la stretta. «Bill!». «Oilà!», rispose Sikes comparendo in cima alle scale con una candela. «Oh! Alla buon'ora. Salite!». Era, quella, una manifestazione di lode quasi sperticata, un insolito e cordialissimo benvenuto per una persona del temperamento del signor Sikes. Mostrando di esserne molto gratificata, Nancy lo salutò cordialmente. «Occhiodibove è andato con Tom», osservò Sikes quando giunsero di sopra. «Ci sarebbe stato di impaccio». «Giusto», replicò Nancy. «Sicché hai portato il ragazzo», disse Sikes, richiudendo la porta, quando raggiunsero la stanza. «Sì, è qua», replicò Nancy. «È stato quieto?», domandò Sikes. «Come un agnellino», ribatté Nancy. «Contento di sentirlo», fece Sikes guardando in cagnesco Oliver. «Per amore della sua giovane carcassa; altrimenti ne avrebbe sofferto parecchio. Vieni qua, giovanotto, e lascia che ti dica qualcosa, che prima è meglio è». Così rivolgendosi al suo nuovo discepolo, Sikes gli prese il cappello e lo gettò in un angolo e poi, afferrandolo per la spalla, se lo piazzò innanzi, sedendosi accanto al tavolo. «Ora, prima cosa, sai cos'è questa?», chiese Sikes prendendo dal tavolo una pistola da taschino. Oliver rispose affermativamente. «Bene. Allora guarda qua», continuò Sikes. «Questa è la polvere, quella lì una pallottola e quello lì uno straccetto di cappello vecchio per spingerla nella canna». Con un mormorio Oliver fece intendere che aveva compreso la funzione dei diversi elementi di cui sopra e Sikes procedette a caricare la pistola con grande cura e concentrazione. «Ora è carica», disse Sikes quand'ebbe finito. «Sì, lo vedo, signore», replicò Oliver. «Bene», disse il ladro, e stringendo il polso di Oliver gli accostò la canna alla tempia e gliela premette contro. In quel momento Oliver non riuscì a reprimere un sussulto. «Se ti lasci scappare una sola parola quando siamo di fuori, a meno che non sono io a interrogarti, ti ficco questa pallottola in testa senz'altri avvisi. Sicché, se pensi comunque di parlare di testa tua, di' prima le tue preghiere». Con un ringhio all'indirizzo del destinatario di tali avvertimenti, per renderli più efficaci, il signor Sikes continuò. «Per quello che ne so io, a nessuno importerebbe un fico secco di te, anche se ti ci provassi, sicché se mi prendo questo fastidio del diavolo a spiegarti tutto punto per punto, è solo per il tuo bene. Mi capisci?» «Insomma, per tagliar corto», fece Nancy con enfasi e aggrottando leggermente le sopracciglia a Oliver, come a sollecitarne la massima attenzione verso quanto si diceva, «se ti fa arrabbiare in questa faccenda che hai per le mani farai in modo che non possa andare a raccontarlo sparandogli in testa, e correrai il rischio di pagarla con la forca così come lo corri tante altre volte a motivo della tua professione, ogni mese della tua vita». «Proprio così!», osservò con approvazione Sikes. «Le donne sanno dire le cose col minor numero di parole possibile. Tranne quando danno di testa, e allora sproloquiano parecchio. E adesso che gli è stato spiegato tutto per bene, mangiamo un boccone e schiacciamo un pisolino prima di avviarci». In pronta ottemperanza a tale richiesta, Nancy apparecchiò la tavola e, scomparendo per alcuni minuti, tornò subito dopo con una caraffa di birra scura e un piatto di stinco di maiale che fornì lo spunto per parecchie divertenti spiritosaggini da parte del signor Sikes, basate sulla curiosa corrispondenza tra lo stinco di maiale altamente apprezzato dalla compagnia e il piediporco, strumento così essenziale al loro mestiere. Invero, quel degno gentiluomo, forse stimolato dalla prospettiva della imminente azione, era parecchio su di giri e di buonumore. A prova di ciò vai la pena osservare qui che si divertì a mandar giù la birra tutta d'un fiato e, a un calcolo sommario, non bestemmiò più d'una ottantina di volte nel corso dell'intero pasto. Finita la cena - e si può immaginare che Oliver non avesse molto appetito - il signor Sikes ingollò un paio di bicchieri di gin e acqua e si buttò sul letto, ordinando a Nancy di svegliarlo alle cinque in punto, con svariate imprecazioni atte a prevenire l'eventualità contraria. Sotto comando della medesima autorità Oliver, coi vestiti addosso, s'allungò su un pagliericcio sul pavimento e la ragazza, dopo aver attizzato il fuoco, vi sedette innanzi pronta a svegliarli all'ora stabilita. Oliver restò sveglio a lungo pensando che Nancy potesse approfittare di qualche occasione per sussurrargli altri consigli. La ragazza però rimase immobile e curva sul fuoco, meditabonda, scuotendosi solo, ogni tanto, per aggiustare la candela. Infine, stanco per quell'angosciosa veglia, s'addormentò. Quando si svegliò, la tavola era preparata col necessario per il tè, Sikes ficcava oggetti vari nelle tasche del cappotto che pendeva dalla spalliera di una sedia e Nancy era indaffarata a preparare la colazione. Non s'era fatto ancora giorno, poiché la fiamma della candela ardeva vivida. Fuori era buio fitto. Una pioggia insistente picchiava sui vetri delle finestre e il cielo era coperto di una nuvolaglia nera. «E allora!», ruggì Sikes facendo balzare in piedi Oliver. «Sono le cinque e mezza! Sveglia, o salti la colazione; è già abbastanza tardi». Oliver non ci mise molto a fare toletta e, mandato giù qualche boccone, rispose a quel brutale invito dicendo che era prontissimo. Nancy, a malapena guardando il ragazzo, gli lanciò un fazzoletto affinché se lo legasse al collo e Sikes gli dette una giacca larga e ruvida perché ci si coprisse le spalle. Così conciato egli dette la mano al ladro e questo, fermatosi per mostrargli, con un gesto minaccioso, che aveva la pistola in una tasca interna del cappotto, la strinse nella propria; quindi, scambiato un saluto con Nancy, lo condusse via. Per un istante, quando furono sulla porta, Oliver si voltò sperando di incontrare lo sguardo della ragazza. Ma lei era tornata a sedere innanzi al fuoco dove rimase, a lungo, perfettamente immobile. Capitolo XXI. La spedizione Era mattina quando uscirono in strada; un mattino triste, col vento che soffiava forte, la pioggia che cadeva a dirotto, e nuvole dall'aspetto cupo e tempestoso. Aveva piovuto molto durante la notte, e sulla strada si erano formate grosse pozze d'acqua e i canali di scolo erano intasati. Nel cielo, il debole barlume del giorno che s'appressava accentuava piuttosto l'oscurità della scena, poiché quel fioco chiarore aveva il solo effetto di sbiadire il barlume dei lampioni senza trarre colori più vivi dai tetti bagnati delle case e dalle lugubri strade. Nessuno sembrava essersi alzato in quel quartiere della città, poiché le finestre delle case erano tutte sbarrate e le strade erano silenziose e vuote. Quando svoltarono in Bethnal-Green Road, si stava facendo giorno. Molte lampade erano state già spente, qualche carro proveniente dalla campagna arrancava lentamente verso Londra e di tanto in tanto una carrozza di posta coperta di fango transitava sferragliando frettolosa col conducente che, nel passare, faceva schioccare la frusta a mo' d'ammonimento per il greve carraio che, tenendosi sul lato sbagliato della strada, l'esponeva al rischio di giungere in stazione in ritardo di una quindicina di secondi. I locali pubblici, con le lampade a gas accese all'interno, erano già aperti. A grado a grado anche gli altri negozi venivano aperti, e si incontrava qualche sparuta persona. Poi, comparvero isolati gruppetti di operai che si recavano al lavoro, e poi ancora uomini e donne con cesti di pesce in testa, carretti trainati da asini carichi di verdura, carri stracarichi di bestiame vivo oppure di carcasse intere di animali; lattaie con i loro paioli e un ininterrotto confluire di persone, col passo appesantito e cariche di derrate varie, verso i sobborghi orientali della città. Avvicinandosi alla City il frastuono e il traffico aumentarono gradualmente, ma quando percorsero le strade tra Shoreditch e Smithfield si erano già trasformati in un rombo incessante e cupo. V'era tanta luce quanta poteva esservene in simili condizioni - almeno finché non fosse calata di nuovo la sera - e metà della popolazione londinese aveva già iniziato la sua frenetica giornata. Svoltando giù per Sun-street e Crown-street, attraversando Finsbury square, tagliando per Chiswell-street Sikes emerse a Barbican, e da qui prese per Long-lane per sbucare poi a Smithfield. Il tumulto di suoni discordanti che da qui si levava riempì Oliver di sorpresa e meraviglia. Era giorno di mercato. In terra, s'affondava fino all'anca negli escrementi e nel fango, e un vapore denso, esalando in perpetuo dalle carcasse degli animali, si mischiava alla nebbia che sembrava appoggiata ai comignoli delle case e ristagnava pesantemente in aria. Tutte le stalle al centro di quella vasta superficie, e le altre, provvisorie, che potevano stringersi nello spazio restante, erano zeppe di pecore. Legate ai pali vicino ai canali di scolo c'erano lunghe file di bestiame e vacche affiancate a tre a tre o a quattro a quattro. Contadini, macellai, mandriani, venditori ambulanti, ragazzi, ladri, nullafacenti e vagabondi del grado più infimo s'ammucchiavano in una densa massa; il fischio dei mandriani, l'abbaiare dei cani, il muggire delle vacche, il belare delle pecore, il grugnire e lo strepito dei maiali, il grido dei ciarlatani, le urla, le bestemmie, e i litigi da ogni parte; il suono dei campanacci e la fragorosa ridda di voci provenienti da ogni locale pubblico, l'accalcarsi, lo spingere, il tirare, il picchiare; e i comandi, le imprecazioni; tutto l'orribile e discordante frastuono che echeggiava da ogni angolo del mercato, e le tante persone né lavate né rasate, squallide e sporche, in perenne moto da una parte e dall'altra, che si tuffavano nella calca o ne emergevano, rendevano quella scena tremenda e folle, una confusione totale dei sensi. Sikes, trascinandosi dietro Oliver, s'apriva un varco a spintoni tra la più fitta calca e badava poco alla ridda di sensazioni sonore e visive che tanto impressionavano il ragazzo. Due o tre volte, incrociando qualche amico, fece un cenno con la testa e, resistendo a diversi inviti a scolarsi un goccetto mattutino, tirò dritto innanzi finché non furono fuori da quella tremenda confusione e non raggiunsero Holborn passando per Hosier-lane. «È ora, giovanotto!», disse Sikes guardando in alto l'orologio della chiesa di St. Andrew. «Quasi le sette! Bisogna che ti muovi. Forza coi garretti! Devo già trascinarti io, razza di lumaca?». Sikes accompagnò questo discorso con uno strattone al polso di Oliver il quale, sveltendo il proprio passo fino a una specie di trotto, a mezzo tra la camminata veloce e la corsa, si mantenne al passo delle rapide falcate del ladro meglio che potè. Mantennero quell'andatura finché non oltrepassarono l'angolo di Hyde Park diretti verso Kensington, allorché Sikes rallentò il passo in attesa che fossero raggiunti da un carretto vuoto che, ancora a qualche distanza indietro, stava avanzando alla loro volta. Vedendo che portava la scritta "Hunslow" chiese al conducente, con la cortesia di cui era capace, se non potesse dar loro uno strappo fino a Isleworth. «Saltate su», disse l'uomo. «E quello è il vostro ragazzo?» «Sì, è il mio ragazzo», replicò Sikes con un'occhiataccia a Oliver e poggiando come per caso la mano sul taschino dove teneva la pistola. «Tuo padre cammina un po' troppo veloce per te, non è vero, ragazzo?», chiese il conducente vedendo che Oliver era senza fiato. «Per niente», interloquì Sikes. «C'è abituato. Reggiti stretto alla mia mano e salta su, Ned!». Così rivolgendosi a Oliver l'aiutò a salire sul carretto e il conducente, indicandogli un mucchio di sacchi, lo invitò a distendercisi sopra per riposarsi. A ogni pietra miliare che passavano Oliver si chiedeva con crescente meraviglia dove Sikes intendesse portarlo. Passarono Kensington, Hammersmith, Chiswick, Kew Bridge, Brentford, e ancora tiravano decisamente innanzi come se avessero appena allora iniziato il viaggio. Alla fine giunsero in una locanda che si chiamava "Carrozze e cavalli", poco oltre la quale sembrava che diramasse un'altra strada. Qui il carretto si fermò. Sikes smontò in fretta e furia, senza lasciare la presa della mano di Oliver e tirandolo giù a volo assieme a lui gli lanciò un'occhiataccia e col pugno si batté eloquentemente il taschino. «Arrivederci, ragazzo», disse l'uomo. «È un musone», replicò Sikes dandogli uno strattone. «È un musone. Un monello! Non ve ne curate». «Io no di certo», ribatté l'altro risalendo sul carretto. «Dopotutto è una bella giornata». E ripartì. Sikes aspettò finché non si fu allontanato abbastanza e poi, dicendo a Oliver che poteva guardarsi intorno a suo talento, riprese il cammino con lui al fianco. Un poco oltre la locanda, svoltarono a sinistra e poi, prendendo per una strada sulla destra, continuarono a camminare per un bel tratto, superando molti ampi giardini e case signorili da entrambi i lati della strada e non fermandosi mai se non per bere un goccio di birra finché non raggiunsero una cittadina. Qui, scritto a grandi lettere sul muro di una casa, Oliver lesse "Hampton". Vagarono per qualche ora in mezzo ai campi per fare infine ritorno alla cittadina. Entrati in una vecchia locanda con un'insegna sbiadita, ordinarono una cena frugale accanto al fuoco della cucina. La cucina era una stanza dal soffitto basso, sostenuto nel mezzo da una spessa trave, con delle panche a spalliera alta poste accanto al fuoco, sulle quali sedevano diverse persone dall'aspetto rozzo avviluppate in palandrane, a bere e a fumare. Non fecero affatto caso a Oliver e poco badarono anche a Sikes. Sikes, a sua volta, non badò affatto a loro e sedette in disparte col giovane compagno senza darsi troppo pensiero della compagnia. Per cena mangiarono della carne fredda, e rimasero lì seduti così a lungo, con Sikes a fumarsi placidamente tre o quattro pipe, che Oliver ne trasse la conclusione che quasi certamente non sarebbero andati oltre. Parecchio provato per il lungo camminare e per essersi svegliato così di buon'ora, egli dapprima cadde in dormiveglia, ma poi, sopraffatto dalla fatica e dai fumi del tabacco, s'addormentò del tutto. Era buio quando fu svegliato da Sikes con uno scossone. Abbastanza sveglio per reggersi seduto e guardarsi attorno, vide quel grand'uomo discutere in amabile compagnia con un contadino mentre si scolavano una pinta di birra chiara. «Sicché andate a Lower Halliford, vero?», chiese Sikes. «Sì», rispose l'uomo, che sembrava piuttosto alterato dal bere se in meglio o in peggio, dipende dal punto di vista. «E pure piuttosto alla svelta. Il mio cavallo non ha da tirare un carico pesante come stamani all'andata, e non ci impiegherà molto. Un brindisi alla sua salute! Perdinci, se non è un bell'animale!». «Potreste darci un passaggio fin là a me e al mio ragazzo?», domandò Sikes spingendo il boccale verso la nuova conoscenza. «Sì, se venite subito», rispose l'uomo guardandolo di sopra al boccale. «Siete diretto a Halliford?» «Arrivo fino a Shepperton», replicò Sikes. «Fin dove arrivo, posso portarvi», ribatté l'altro. «Il conto, Becky?» «È tutto a posto, ha pagato quel signore», rispose la ragazza. «Come?», fece l'uomo risentito e già alticcio. «Questo non va, sapete?» «Perché no?», ribatté Sikes. «Voi siete così gentile da darci un passaggio, e perché io non dovrei offrirvi una pinta o due in contraccambio?». Lo sconosciuto rifletté sulla motivazione con aspetto profondamente assorto. Dopo un poco, afferrò Sikes per la mano, dichiarando che era veramente una persona a modo. A questo Sikes replicò che voleva forse scherzare; e davvero, se fosse stato sobrio, non ci sarebbe stato motivo per dubitarne. Dopo qualche altro complimento del genere augurarono la buona notte alla compagnia e uscirono; la ragazza, nel frattempo, radunò boccali e bicchieri e, fermatosi sull'uscio tenendoli ancora in mano, stette oziosamente a guardarli mentre si preparavano a partire. Di fuori, già attaccato al carretto, c'era il cavallo alla cui salute si era bevuto in precedenza. Oliver e Sikes balzarono su senza altre formalità e l'uomo che ne era il proprietario, soffermatosi un minuto o due a vantarne le qualità e a sfidare lo stalliere e il mondo intero a trovarne uno uguale, saltò su lui pure. Poi disse allo stalliere di mollare le briglie, e non appena il cavallo sentì libera la testa ne fece sgradevolissimo uso, impennandola in alto con furia e gettandosi contro le finestre d'un salottino dall'altra parte della strada; dopo queste gesta e dopo essersi mantenuto per un po' dritto sulle zampe posteriori partì a tutta birra e baldanzosamente sferragliando uscì dalla città. Era una notte tenebrosa. La densa nebbia che s'alzava dal fiume e dal terreno paludoso attorno s'allargava sulla cupa campagna. Il freddo era pungente, e ovunque era buio pesto. Nessuno ruppe il silenzio, poiché il conducente s'era appisolato e Sikes non era affatto dell'umore d'avviar conversazioni. Oliver sedeva rincantacciato in un angolo del carretto, sgomento e spaventato, immaginando strane forme negli alberi spogli, i rami dei quali ondeggiavano qua e là, come fossero grottescamente felici della desolazione della scena. Mentre passavano accanto alla chiesa di Sunbury l'orologio batté le sette. C'era luce alla finestra della casupola del traghettatore dall'altro lato, ed essa, illuminando la strada, gettava in un'ombra ancor più cupa l'oscuro albero di tasso che copriva le tombe. Non lontano s'udiva un sordo gorgogliare di acque, e le foglie del vecchio albero stormivano piano al vento serale: sembrava una pacata musica per il riposo dei defunti. Passarono Sunbury e si trovarono di nuovo sulla strada solitaria. Dopo altre due o tre miglia il carretto si fermò. Sikes smontò tenendo per mano Oliver; quindi, proseguirono a piedi. Neanche a Shepperton era la casa in cui dovevano recarsi, come lo stanchissimo ragazzo aveva sperato; continuarono invece a camminare nel fango e nell'oscurità, lungo bui sentieri e attraverso campi desolati, finché non videro le luci di una cittadina a non grande distanza. Scrutando attentamente innanzi a sé Oliver vide dell'acqua appena sotto di loro e vide che si stavano avvicinando a un ponte. Sikes proseguì dritto finché non furono a ridosso del ponte e poi svoltò bruscamente giù per una scarpata sulla sinistra. «L'acqua!», pensò Oliver sentendosi venir meno dalla paura. «Mi ha portato in questo posto solitario per uccidermi!». Stava per gettarsi a terra pronto a difendere la sua giovane vita meglio che poteva quando notò che erano giunti di fronte a una casupola solitaria, cadente e in rovina. Su ciascun lato della porta sgangherata s'apriva una finestra; c'era anche un piano superiore, ma neanche lì si vedeva alcuna luce. Era una casa abbandonata e, a ogni apparenza, del tutto disabitata. Sikes, sempre stringendo la mano a Oliver, s'avvicinò cauto al basso portico e sollevò il chiavistello. La porta cedette alla leggera spinta, ed entrambi entrarono. Capitolo XXII. Il furto «Oilà!», gridò forte una voce roca non appena misero piede nel corridoio. «Non fare tutto questo baccano, Toby», disse Sikes serrando la porta. «Porta un moccolo». «Aha! Il mio compare», esclamò la stessa voce; «un moccolo, Barney, un moccolo; fa' strada a questi gentiluomini, Barney, ma svegliati prima, se ti sembra il caso». A quanto parve, chi aveva parlato gettò un calzascarpe, o altro simile articolo, all'indirizzo della persona cui s'era rivolto per favorirne il risveglio, poiché si sentì il rumore d'un oggetto legnoso cadere pesantemente e poi un borbottio indistinto, come di chi è tra il sonno e la veglia. «Sentito?», disse la medesima voce. «C'è Bill nel corridoio senza nessuno a dargli il benvenuto e tu te ne stai lì a dormire come se avessi cenato a base di laudano. Ti senti rinfrescato adesso o preferisci il candeliere di ferro per svegliarti del tutto?». A questo interrogativo si sentì un precipitoso strascicare di piedi in pantofole sul nudo impiantito della stanza e da una porta sulla destra spuntò dapprima il fioco lume d'una candela e poi la sagoma del medesimo individuo precedentemente descritto come soggetto all'infermità di dover parlare col naso e cameriere officiante alla locanda di Saffron Hill. «Bisder Sikes!», esclamò Barney con finta o sincera gioia; «Eddrate, eddrate». «Qui! Vai prima tu!», disse Sikes spingendo Oliver innanzi a sé. «Più svelto! O ti calpesto i talloni». Borbottando una bestemmia per la lentezza di Oliver, Sikes lo spintonò innanzi. Entrarono in una stanza bassa e buia con un fuoco che cacciava fumo, due o tre sedie rotte, un tavolo e una vecchissima branda, disteso sulla quale un uomo riposava fumando una lunga pipa di terracotta, con i piedi sollevati molto più in alto della testa. Indossava una giacchetta dal taglio elegante, con grossi bottoni d'ottone, un fazzoletto da collo arancione, un ruvido panciotto e braghe al ginocchio. Il signor Crackit (poiché non di altri si trattava) non aveva capigliatura folta, né sul capo né sul volto, ma i pochi capelli che aveva erano d'una tinta rossiccia, piegati a forza in lunghe ciocche ritorte, a mo' di cavatappo, attraverso le quali egli infilava di tanto in tanto le sue dita sudice ornate da grossi anelli falsi. Era alto appena un'inezia sopra la media e, a quanto sembrava, piuttosto esilino di gambe, ma questa circostanza nulla detraeva all'ammirazione che portava ai suoi stivali, i quali rimirava, così sollevati in alto, con viva soddisfazione. «Bill, ragazzo mio!», disse costui volgendo la testa in direzione della porta. «Felice di rivederti. Cominciavo quasi a pensare che tu avessi rinunciato; nel qual caso avrei tentato la sorte da solo. Oilà!». Con tale esclamazione di allarmata sorpresa quando gli occhi gli caddero su Oliver, il signor Toby Crackit si tirò su a sedere chiedendo chi fosse quello lì. «Il ragazzo! Soltanto il ragazzo!», replicò Sikes avvicinando una sedia al fuoco. «Udo dei ragazzi di Bisder Fagid», esclamò Barney con un ghigno. «Fagin, eh?», esclamò Toby squadrando Oliver. «Riuscirà preziosissimo questo ragazzo, applicato alle borsette delle signore in chiesa. Con quel musetto farà fortuna». «Su...su, basta!», interloquì Sikes con impazienza; e curvatosi sul suo compare gli sussurrò qualche parola all'orecchio. Al che il signor Crackit esplose in una sonora risata e onorò Oliver di una lunga occhiata di meraviglia. «Ora, se vuoi darci qualcosa da mangiare e da bere mentre aspettiamo», disse Sikes, «ci rincuori tutti; o almeno rincuori me. Siediti vicino al fuoco, marmocchio, e riposati, perché dovrai uscire ancora con noi stanotte, anche se non si va molto lontano». Oliver guardò Sikes con muta, timida meraviglia e accostando un trespolo vicino al fuoco vi sedette, appoggiando la testa che gli doleva sulle mani, rendendosi a malapena conto di dove si trovasse o di cosa gli succedesse attorno. «Qui», disse Toby mentre il giovane ebreo posava sul tavolo qualche avanzo di cibo e una bottiglia. «Al successo del furto!». S'alzò per un brindisi solenne e, posando con cautela la pipa vuota in un angolo, avanzò verso il tavolo, riempì un bicchiere di liquore e se lo scolò, imitato dal signor Sikes. «Un goccio al ragazzo», disse Toby riempiendo a metà un bicchiere da vino. «Manda giù, angioletto». «Veramente...», disse Oliver guardando pietosamente l'uomo in viso. «Veramente io...». «Manda giù!», ripetè Toby. «Credi che non so cosa ti fa bene e cosa no? Digli di mandarlo giù, Bill». «Sarà meglio per lui!», disse Sikes picchiandosi con la mano sul taschino. «Mi cecassero, se non ci dà più grattacapi di un'intera squadra di Dodger. Bevilo, marmocchio snaturato, bevilo!». Atterrito dai gesti minacciosi dei due uomini Oliver s'affrettò a mandar giù il contenuto del bicchiere e fu subito colto da un violento attacco di tosse che deliziò Toby Crackit e Barney e strappò un sorriso perfino allo scontroso Sikes. Poi, quando Sikes ebbe soddisfatto il suo appetito (Oliver non potè mangiare altro se non la crosta di pane che lo costrinsero a ingoiare) i due uomini si allungarono sulle sedie per schiacciare un pisolino. Oliver rimase sul suo sgabello accanto al fuoco, e Barney, avvolto in una coperta, s'allungò sul pavimento accosto al parafuoco. Per un po' dormirono, o così sembrava, e nessuno si mosse tranne Barney, che una o due volte s'alzò per buttare altro carbone sul fuoco. Oliver cadde in un pesante torpore, e immaginò di vagare lungo viottoli bui o attraverso tenebrosi cimiteri, o di rivivere l'una o l'altra delle vicende di quel giorno, allorché fu svegliato da Toby Crackit saltato su a proclamare che era l'una e mezza. In un istante balzarono in piedi anche gli altri due, e tutti furono attivamente indaffarati nei frenetici preparativi. Sikes e compagni s'avvilupparono collo e mento in larghi scialli scuri abbottonandoci poi sopra i cappotti mentre Barney, aperto un armadietto, ne tirava fuori diversi strumenti che si ficcava frettolosamente nelle tasche. «Passami qualche rivoltella, Barney», disse Toby Crackit. «Ecco qua», rispose Barney porgendo un paio di pistole. «Le hai caricate tu stesso». «A posto!», replicò Toby riponendole via. «I randelli?» «Ce li ho», replicò Sikes. «Fazzoletti neri, chiavi, perforatore, lanterne schermate... dimenticato nulla?», domandò Toby assicurando un piccolo piediporco a un laccio sotto il risvolto del giaccone. «Bene», ribatté il suo compagno. «Porta quei legni, Barney. È arrivata l'ora». Con queste parole prese un grosso bastone dalle mani di Barney il quale, avendone consegnato un altro a Toby, allacciò con cura la giacchetta a Oliver. «Allora!», disse Sikes porgendogli la mano. Oliver, completamente stordito dall'insolito esercizio, dall'aria aperta e da ciò che era stato costretto a bere, dette meccanicamente la mano a Sikes. «Prendigli l'altra mano, Toby», disse Sikes. «Da' un'occhiata, Barney». L'uomo andò alla porta e tornò dicendo che era tutto tranquillo. I due ladri uscirono fuori con Oliver tra di loro e Barney, dopo aver serrato di nuovo tutto, si riavvolse come prima e si riaddormentò subito. A quell'ora, era buio pesto. La nebbia era molto più fitta di quanto fosse stata nella prima parte della notte e l'aria era così umida che, sebbene non piovesse, i capelli e le sopracciglia di Oliver erano rigidi per l'acquerugiola di cui erano intrisi, ghiacciata quasi completamente. Attraversarono il ponte e continuarono a camminare verso le luci che avevano viste prima. Non erano molto distanti e poiché camminavano piuttosto lestamente, furono presto a Chertsey. «Passiamo per la città», bisbigliò Sikes. «In una notte simile nessuno va in giro e non c'è pericolo d'esser visti». Toby assentì ed essi percorsero speditamente la strada principale della cittadina, a quell'ora completamente deserta. A intervalli, una fioca luce trapelava da qualche finestra di camere da letto e di tanto in tanto il roco abbaiare dei cani rompeva il silenzio della notte. Ma le strade erano deserte e quando l'orologio della chiesa batté le due erano già fuori della città. Sveltendo il passo svoltarono su per una strada a sinistra. Dopo un quarto di miglio si fermarono davanti a una casa isolata circondata da un muro che Toby Crackit, senza quasi neanche una pausa per prender fiato, scalò in un batter d'occhio. «Adesso il ragazzo», disse Toby. «Sollevamelo, che lo afferro io». Prima che Oliver avesse tempo di guardarsi attorno fu sollevato di peso da Sikes per le ascelle, e dopo altri tre o quattro secondi si trovò acquattato sull'erba dall'altra parte assieme a Toby. Sikes seguì subito dopo, e insieme strisciarono cautamente verso la casa. E ora, per la prima volta, con sgomento e terrore, Oliver si rese conto che lo scopo della spedizione, se non l'assassinio, era il furto e la rapina. Mentre gli sfuggiva una involontaria esclamazione di orrore si strinse le mani. Gli occhi gli si annebbiarono e un sudore freddo gli bagnò il viso cinereo; le forze l'abbandonarono e si piegò sulle ginocchia, cadendo. «Alzati!», mormorò Sikes fremendo di rabbia e tirando fuori la pistola dal taschino. «Alzati o ti faccio schizzare le cervella sull'erba». «Oh! Per carità di Dio, lasciatemi andare!», supplicò Oliver. «Lasciatemi scappare e morire nei campi. Non m'avvicinerò mai più a Londra, mai, mai! Oh! Vi prego, abbiate compassione di me! Non costringetemi a commettere un furto. Per amore degli angeli radiosi che stanno in cielo, abbiate compassione di me!». L'uomo al quale questo appello fu rivolto cacciò una terribile bestemmia e aveva già caricato la pistola quando Toby l'afferrò, mise la mano sulla bocca del ragazzo e lo trascinò fino alla casa. «Zitto!», esclamò. «Ma che angeli e angeli, moccioso. Se dici un'altra parola ti spacco la testa e così t'accontento subito, senza tanto strepito. Il risultato è lo stesso, ma raggiunto con più eleganza. Qua, Bill, scassa la finestra. Starà buono adesso, ci scommetto. In nottate fredde come questa, ho visto tipi molto più vecchi di lui perdere il controllo allo stesso modo, per un minuto o due». Sikes, imprecando orrendamente sulla testa di Fagin per avergli affibbiato Oliver in quella missione, armeggiò vigorosamente col piediporco ma senza far rumore, e dopo qualche resistenza e con l'aiuto del compare le imposte testé menzionate da Toby cedettero. Era la finestrella munita di grata, a circa cinque piedi e mezzo di altezza dal suolo, sul retro della casa, d'uno stanzino o un bugigattolo adibito alla fermentazione della birra, che dava sull'altra estremità del corridoio d'ingresso. L'apertura era così piccola che i proprietari avevano probabilmente ritenuto superfluo munirla di migliore difesa; tuttavia era larga abbastanza per lasciar passare un ragazzo della corporatura di Oliver. All'esperto Sikes bastò armeggiare ancora un poco per aver ragione dei fissaggi della grata e svellerla del tutto. «Ora stammi a sentire, marmocchio», bisbigliò Sikes tirando fuori dalla tasca una lanterna cieca e indirizzando il fascio di luce dritto sul viso di Oliver. «Io adesso t'aiuto a ficcarti là. Tu prendi questa lampada, sali piano i gradini che ti troverai davanti e vai dritto fino al disimpegno della porta d'ingresso, togli la serratura e ci apri». «C'è un chiavistello in alto, che tu non ci arrivi», s'intromise Toby. «Sali su una delle sedie dell'ingresso. Ce ne sono tre, Bill, con su disegnate una bella e grossa cornucopia blu e una forca dorata, che sono l'insegna della vecchia signora». «Piantala, adesso!», ribatté Sikes con un'occhiataccia minacciosa. «La porta della stanza è aperta, sì?» «Spalancata», replicò Toby dopo aver sbirciato dentro per assicurarsene. «Il bello della cosa è che la lasciano sempre aperta tenendola con un fermo dimodoché il cane che ha la cuccia in questo stanzino può trotterellare liberamente su e giù se non ha voglia di dormire. Ah, ah! Ci ha pensato Barney, stanotte, a toglierlo di mezzo. Un lavoretto sbrigativo!». Sebbene il signor Crackit parlasse in un bisbiglio appena udibile e ridesse senza far rumore, Sikes gli ordinò sbrigativamente di fare silenzio e mettersi al lavoro. Toby obbedì tirando fuori dapprima la sua lanterna e posandola a terra e poi piantandosi saldamente con la testa appoggiata al muro sotto la finestra e le mani sulle ginocchia in modo che la sua schiena fungesse da base. Quindi Sikes, salendogli sopra, spinse piano Oliver attraverso la finestra a piedi in avanti e, tenendolo per il colletto, lo lasciò infine atterrare sano e salvo a terra dalla parte interna. «Prendi questa lanterna», disse Sikes guardando nella stanza. «Vedi le scale davanti a te?». Più morto che vivo, Oliver bisbigliò «Sì». Puntando alla porta d'ingresso con la canna della pistola, Sikes l'ammonì con poche parole a tenere a mente che sarebbe stato sempre sotto tiro e che se esitava sarebbe stato ucciso all'istante. «Roba d'un minuto», disse Sikes sempre bisbigliando piano. «Appena te lo dico, datti da fare. Zitti!». «Cosa c'è?», sussurrò l'altro. Ascoltarono attentamente. «Niente», disse Sikes lasciando andare Oliver. «Adesso!». Nel poco tempo trascorso per riprendersi il ragazzo aveva preso la ferma risoluzione di gettarsi all'improvviso su per le scale dell'ingresso e dare l'allarme alla famiglia anche se avesse dovuto pagare il tentativo con la vita. Con tale risoluzione, s'avviò immediatamente e furtivamente innanzi verso la porta d'ingresso. «Torna indietro!», gridò all'improvviso Sikes. «Indietro, indietro!». Spaventato da quell'improvvisa violazione del mortale silenzio di quel luogo e dalle grida che seguirono Oliver lasciò cadere la lanterna senza sapere più se proseguire o fuggir via. Si sentirono altre grida... comparve una luce... la visione di due uomini semisvestiti e terrorizzati in cima alle scale gli fluttuò innanzi agli occhi... un lampo... un fragore secco... del fumo... il lacerarsi di qualcosa, da qualche parte, senza che riuscisse a capire dove... e barcollò all'indietro. Per un istante Sikes disparve ma rispuntò subito di sopra, afferrandolo per il colletto prima che il fumo si fosse dissipato. Con la sua pistola fece fuoco su quegli uomini che già stavano indietreggiando e tirò su il ragazzo. «Tieniti stretto al braccio», disse Sikes mentre lo tirava attraverso la finestra. «Datemi uno scialle. L'hanno colpito. Presto, dannazione. Il ragazzo sta perdendo parecchio sangue!». Poi s'udirono i rintocchi potenti di una campana misti al fragore di armi da fuoco e a grida, e Oliver ebbe la sensazione di essere trasportato a passo rapido su un terreno accidentato. Poi i rumori si confusero nella distanza. Il ragazzo sentì come un gelo di morte in cuore; poi non sentì né seppe più nulla. Capitolo XXIII. Contiene, in sostanza, l'amena conversazione tra il signor Bumble e una signora, e mostra che persino un custode parrocchiale ha i suoi punti deboli Quella notte faceva un freddo cane. Sulla neve caduta s'era formata una spessa crosta di ghiaccio, sicché soltanto i mucchi sospinti nei vicoli e agli angoli delle strade potevano esser preda dei venti che ululavano da ogni parte: i quali, come se la loro furia crescesse scovando quelle esigue prede, le ghermivano furiosamente e, sollevando nugoli turbinanti, le disperdevano in aria in mille soffi nebulosi; era una notte, quella, desolata, buia e gelida, e chi aveva una bella casa e la pancia piena poteva far cerchio attorno al fuoco ringraziando Dio di avere un tetto, e chi non l'aveva e pativa la fame poteva accasciarsi a terra e crepare. In un tempo simile, parecchi vagabondi sfiniti dalla fame chiusero gli occhi per sempre e, quali che fossero stati i loro crimini, difficilmente li avrebbero riaperti in un mondo più amaro. Così si presentavano le cose all'esterno quando la signora Corney, la direttrice dell'ospizio già noto al lettore come il luogo di nascita di Oliver Twist, si sedette innanzi a un allegro focherello nel suo piccolo salottino e guardò con non poco compiacimento un tavolinetto tondo sul quale era posato un vassoio ad esso proporzionato, fornito di tutto l'occorrente per il più delizioso spuntino che una direttrice possa concedersi. Difatti, la signora Corney s'accingeva a gustarsi una tazza di tè. E mentre il suo sguardo andava dal tavolinetto al fuoco, dove la più minuta delle teiere cantava una canzoncina in voce di falsetto, la sua intima soddisfazione evidentemente s'accrebbe, tanto che ella, in effetti, sorrise. «Bene!», disse la direttrice poggiando il gomito sul tavolo e guardando riflessiva il fuoco. «Sono sicura che noi tutti abbiamo parecchio di cui esser contenti e grati! Parecchio, se solo ce ne rendessimo conto. Ah!». La signora Corney scosse la testa con aria afflitta, come rammaricandosi della cecità di quegli spiantati che non arrivavano a comprenderlo, e immergendo un cucchiaino d'argento (di sua proprietà) nei più profondi recessi di una scatoletta di latta da tè da due once procedette alla preparazione della bevanda. Ma come, a volte, basta una sciocchezza a turbare l'equanimità delle nostre fragili menti! Quella nera teiera, piccola e presto ricolma, traboccò proprio quando la signora Corney così moraleggiava e l'acqua le ustionò leggermente la mano. «Accidenti alla teiera!», disse la degna direttrice posandola in fretta sulla mensola del caminetto. «Una stupida cosuccia che basta a malapena per due tazze! Sarebbe inutile a tutti», fece la signora Corney interrompendosi, «tranne che a una creatura povera e abbandonata come me. Povera me!». Con queste parole la direttrice si abbandonò sulla sedia e, poggiando ancora una volta il gomito sul tavolo, rifletté sul suo destino solitario. La piccola teiera e la tazza singola avevano ridestato in lei mesti ricordi del signor Corney (morto da non più di venticinque anni) e ne fu sopraffatta. «Ma non ce n'è l'eguale...!», fece la signora Corney con sentimento. «Non ce n'è l'eguale...!». Se, però, questa osservazione fosse riferita al marito o alla teiera è dubbio; forse alla seconda, poiché ad essa guardava nel dirlo la signora Corney, e poiché subito dopo la sollevò. Ma aveva appena dato un sorso dalla sua prima tazza quando fu disturbata da un leggero bussare alla porta della stanza. «Oh! Entrate, che vi venga un bene!», esclamò aspra la signora Corney. «Una delle vecchie in punto di morte, suppongo. Muoiono sempre quando io siedo a tavola. Non statevene lì impalata a far entrare l'aria fredda, forza! Che succede?» «Niente, signora, niente», replicò una voce maschile. «Oh santo cielo!», esclamò la direttrice in un tono parecchio più dolce, «voi, signor Bumble?» «Al vostro servizio, signora», disse il signor Bumble che, fermatosi di fuori per pulirsi le scarpe e spazzarsi via la neve dal cappotto, col tricorno in una mano e un fagottino nell'altra fece ora il suo ingresso. «Devo chiudere la porta, signora?». La matrona con modestia esitò a rispondere, nel timore che un colloquio col signor Bumble a porte chiuse fosse disdicevole. Il signor Bumble, sfruttando quella indecisione e parecchio infreddolito lui stesso, chiuse la porta senza attendere ulteriori inviti. «Che tempaccio, signor Bumble», disse la direttrice. «Un tempaccio davvero, signora», replicò il signor Bumble. «È un tempo anti-parrocchiale, signora. Abbiamo distribuito, signora Corney, abbiamo giusto distribuito qualcosa come una ventina di pagnotte da un quarto, una forma e mezza di cacio, solo questo benedetto pomeriggio, ma i poveri sono ancora scontenti». «Certo, signor Bumble. E quando mai si accontentano, signor Bumble?», disse la direttrice sorseggiando il tè. «Davvero, signora. Quando mai si accontentano?», ribadì Bumble. «Prendiamo ad esempio un tale che, in considerazione d'una moglie e d'una famiglia numerosa a carico, riceve una pagnotta da un quarto e una libbra di cacio, peso netto. Vi è forse riconoscente, signora? Vi è forse riconoscente? Ma neanche per idea! Quello che fa, signora, è chiedere un po' di carbone, solo quanto basta a riempire un fazzoletto, dice! Carbone! Per che farci? Abbrustolire il formaggio, e poi tornare a chiederne dell'altro. Così fa questa gente, signora. Dategli un grembiule pieno di carbone oggi e tornano a chiederne un altro dopodomani, con una faccia più tosta del bronzo più tosto». La direttrice approvò incondizionatamente l'ardito paragone, e il custode proseguì. «Mai», fece il signor Bumble, «mai le cose erano giunte fino a questo punto. Avantieri un altro... voi siete stata sposata, signora, e solo perciò mi permetto di menzionarlo... un altro che non aveva neanche uno straccio per coprirsi le spalle (al che la signora Corney abbassò pudicamente lo sguardo) va a bussare alla porta del nostro soprintendente mentre lui ha degli ospiti a cena e dice che ha bisogno di aiuto, signora Corney. E siccome non pensa neanche minimamente ad andarsene e imbarazza alquanto gli ospiti, il nostro soprintendente gli manda una libbra di patate e mezza di farina d'avena. "Anima mia!", fa quell'ingrato villano, "e che ci faccio con questo? È come se avessi chiesto un paio di occhiali e me li aveste dati di ferro!". "Benissimo", gli risponde il nostro soprintendente piccato, "allora qui non avrete niente di niente". "Ma così morirò sulla strada", fa quel vagabondo. "Oh, no che non morirete", replica il nostro soprintendente». «Ah, ah! Bellissima. Tipico del signor Grannett, non è vero?», interloquì la direttrice. «Ebbene, signor Bumble?» «Ebbene, signora», riprese il custode «lui ti va via e ti muore veramente sulla strada. Quando si dice un mendicante caparbio!». «Supera ogni immaginazione», osservò con enfasi la direttrice. «Ma non pensate che il soccorso esterno sia comunque deleterio, signor Bumble? Siete persona d'una certa esperienza e nessuno può saperlo meglio di voi». «Signora Corney», disse il custode sorridendo come sorridono gli uomini consapevoli di saperla più lunga degli altri, «il soccorso esterno usato con proprietà, con proprietà, signora, è la salvezza della parrocchia. Il principio primo del soccorso esterno è di dare ai poveri esattamente ciò di cui non hanno bisogno, di modo che son dissuasi dal venire a chiedere». «Oh cielo!», esclamò la signora Corney. «Be'. Anche questa è una bella trovata!». «Sì. Che resti tra noi, signora», replicò il signor Bumble, «quello è il principio primo, e quella è la ragione per cui, se guardate qualche caso del genere sulla stampa che ficca il naso ovunque, sempre noterete che le famiglie povere hanno ricevuto delle fette di cacio. In tutto il paese, questa è ora la regola, signora Corney. Comunque sia», disse il custode curvandosi per sciogliere il fagottino, «questi sono segreti di ufficio, signora, e non bisogna parlarne se non, come posso dire, tra noi funzionari parrocchiali. Questo, signora, è il vin di porto che la Direzione aveva ordinato per l'infermeria; vero, fresco e genuino vin di porto, spillato appena stamane dalla botte, limpido come un rintocco di campana, e senza sedimenti!». Dopo aver sollevato la prima bottiglia alla luce e averla rigirata ben bene per saggiarne l'eccellenza, il signor Bumble la depose assieme all'altra sopra un cassettone, ripiegò il fazzoletto in cui erano state avvolte, se lo ficcò in tasca con cura e prese il cappello, come per andarsene. «Vi farete una camminata nel gelo, signor Bumble», esclamò la direttrice. «C'è un vento così tagliente, signora», replicò il signor Bumble tirandosi su il bavero, «da staccarvi le orecchie». La direttrice guardò dalla piccola teiera al custode che si dirigeva alla porta, ma nel momento in cui il custode tossì, come preliminare al commiato di buona notte, ella chiese timida se... se non gradisse una tazza di tè? Immediatamente il signor Bumble si tirò giù il bavero, posò cappello e bastone su una sedia e avvicinò un'altra sedia al tavolo. Mentre lentamente si accomodava, guardava la matrona. Lei fissò gli occhi sulla piccola teiera. Il signor Bumble tossì di nuovo e sorrise leggermente. La signora Corney s'alzò per prendere un'altra tazza e un piattino dallo stipo. Poi, sedendo, i suoi occhi incontrarono di nuovo quelli del galante custode; lei arrossì, e armeggiò per servirgli il tè. Di nuovo il signor Bumble tossì, ma questa volta più forte che in precedenza. «Dolce, signor Bumble?», chiese la matrona prendendo la zuccheriera. «Molto dolce, sì», replicò il custode, fissando nel mentre la signora Corney, e se mai un custode sembrò intenerito, tale era il signor Bumble in quel preciso istante. Il tè fu approntato e offerto in silenzio. Il signor Bumble, allargatosi il fazzoletto sulle ginocchia di modo che le briciole non gli macchiassero lo splendore delle braghe, cominciò a mangiare e bere; di tanto in tanto, intercalava tali azioni con un profondo sospiro, il quale, comunque, non aveva effetti deleteri sul suo appetito; al contrario, sembrava piuttosto facilitargli le operazioni concernenti il tè e pane tostato. «Avete un gatto, vedo, signora», disse il signor Bumble adocchiandone uno che - centro della di lei famiglia - si crogiolava innanzi al fuoco. «E anche gattini, oserei dire». «Li adoro così tanto, signor Bumble, che neanche immaginate», replicò la direttrice. «Sono così allegri, così gai, così vivaci, che son proprio una compagnia». «Bellissimi animali, signora», replicò il custode con approvazione, «così assolutamente domestici». «Oh, sì», riprese la direttrice con entusiasmo, «e così affezionati alla loro casa che ti riempiono di gioia, veramente». «Donna Corney, signora», disse il signor Bumble lentamente, battendo a tempo col cucchiaino, «io dico questo, signora, che se un gatto, o anche un gattino, vivesse con voi senza affezionarsi alla casa, sarebbe un vero asino, signora!». «Oh, signor Bumble!», protestò la signora Corney. «Inutile nascondere la verità, signora», disse il signor Bumble agitando lentamente in aria il cucchiaino con una sorta di amorosa dignità che lo rendeva due volte solenne; «l'affogherei io stesso con piacere». «Allora siete un uomo crudele», disse la direttrice civettuola mentre allungava la mano per riprendere la tazza del custode; «e avete anche un cuore di pietra». «Un cuore di pietra, signora?», disse lui. «Di pietra!». Il signor Bumble restituì la tazza senza altre parole, ma esercitò una leggera pressione sul ditino della signora Corney mentr'ella la prendeva, assestò due sonore pacche sul suo panciotto allacciato, cacciò un sospiro poderoso e indietreggiò impercettibilmente con la sedia, scostandosi dal fuoco. Il tavolo era tondo, e siccome la signora Corney e il signor Bumble erano seduti accanto ad esso, non molto discosti l'uno dall'altra ed entrambi di fronte al fuoco, apparirà chiaro che il signor Bumble, nel retrocedere senza discostarsi dal tavolo, accresceva la distanza che lo separava dalla signora Corney: una procedura che qualche prudente lettore senza dubbio sarà disposto ad ammirare e a considerare atto di grande eroismo da parte del signor Bumble, in qualche modo tentato dal tempo, dal luogo e dall'occasione a esprimere certe dolci frivolezze che, per quanto le si consideri adeguate sulle labbra d'una persona leggera e sconsiderata, sembrano infinitamente al di sotto di un giudice, di un membro del parlamento, d'un ministro, d'un sindaco di Londra e altri importanti funzionari pubblici, e particolarmente al di sotto della dignità e della importanza di un custode; il quale, come ben si sa, dovrebbe essere il più severo e controllato di tutti. Quali che fossero le intenzioni del signor Bumble, comunque - e senza dubbio erano delle migliori fatto si è, come è stato già ripetuto, che il tavolo era tondo; di conseguenza, spostando il signor Bumble a poco a poco la sedia e continuando il suo periplo, la distanza che lo separava dalla direttrice ad un certo punto cominciò a diminuire, talché la sua sedia giunse vicina a quella in cui sedeva la direttrice. Per la verità le due sedie si toccarono, e quando ciò accadde il signor Bumble si fermò. Ora, se la direttrice avesse spostata la sua sedia sulla destra si sarebbe scottata; se invece l'avesse spostata sulla sinistra sarebbe caduta tra le braccia di Bumble. Perciò la direttrice, prevedendo all'istante quelle conseguenze, rimase pudicamente dov'era e porse al signor Bumble un'altra tazza di tè. «Cuore di pietra, signora Corney?», disse il custode girando il tè e guardando dritto in viso la direttrice. «E voi, siete dura di cuore, signora Corney?» «Oh povera me!», esclamò la direttrice, «che domanda indiscreta da parte di uno scapolo. Perché mai lo volete sapere, signor Bumble?». Il custode bevette il suo tè fino all'ultima goccia, finì un pezzetto di pane tostato, spazzò via dalle ginocchia le briciole, s'asciugò le labbra e assestò un deciso bacio alla direttrice. «Signor Bumble», protestò quella discreta signora in un sussurro, poiché era così confusa da aver perso completamente la voce. «Signor Bumble, ora mi metto a gridare!». Il signor Bumble non replicò ma con dignitosa lentezza passò un braccio attorno alla vita della direttrice. Poiché la signora aveva dichiarato di voler gridare, a questa ulteriore impertinenza ella avrebbe naturalmente fatto seguire l'azione alle parole se ciò non fosse stato reso inutile da un concitato bussare alla porta; udito il quale il signor Bumble, con sorprendente agilità, si precipitò alle bottiglie di vino e cominciò a spolverarle col massimo vigore, mentre la direttrice chiedeva con voce recisa chi fosse. Val la pena osservare, come un curioso esempio fisico dell'efficacia d'una improvvisa sorpresa nel controbilanciare gli effetti d'una acutissima paura, che la voce aveva del tutto recuperato la sua asprezza ufficiale. «Scusate, padrona», disse una vecchia dell'ospizio, tanto vizza e brutta da fare spavento, facendo capolino dalla porta. «La vecchia Sally se ne sta andando». «E allora? Cosa dovrei farci?», chiese irata la direttrice. «Posso forse tenerla in vita io?» «No, no, padrona», replicò la vecchia. «Nessuno potrebbe nello stato in cui è. Ho visto morire molte persone, bambini appena nati e uomini grandi e forti, e riconosco abbastanza bene quando arriva la morte. Ma qualcosa le pesa sulla coscienza, e quando riprende conoscenza - rare volte, perché è ormai in agonia - dice che ha da rivelarvi qualcosa che dovete assolutamente sapere. Non morirà in pace se prima non venite a vederla, padrona». A questa notizia la degna signora Corney borbottò un discreto numero di improperi contro le vecchie incapaci di morire senza prima arrecar fastidio di proposito ai propri superiori, e avvoltasi in una spessa mantellina ghermita in fretta invitò con poche parole il signor Bumble ad aspettare il suo ritorno nel timore di altri inconvenienti; poi, ordinando alla messaggera di sbrigarsi senza star tanto a zoppicare per le scale, la seguì con parecchia malagrazia, inveendo contro di lei per tutto il percorso. La condotta del signor Bumble, lasciato solo, fu piuttosto inesplicabile. Apri lo stipo, contò i cucchiaini da tè, soppesò le molle da zucchero, ispezionò attentamente un bricco d'argento per il latte onde accertarsi che il metallo fosse genuino, e soddisfatta punto per punto la sua curiosità si mise in testa il tricorno di sghimbescio e con molta gravità roteò danzando attorno al tavolo per quattro volte. Compiuta questa straordinaria evoluzione, si tolse di nuovo il tricorno e allungandosi innanzi al fuoco, di spalle, sembrò mentalmente occupato a redigere un meticoloso inventario della mobilia. Capitolo XXIV. Tratta di umilissimo argomento. Ma è breve, e potrà forse risultare di qualche importanza per il prosieguo della storia Alla donna che aveva turbato la quiete della stanza della direttrice calzava perfettamente il ruolo di messaggera di morte. Col corpo piegato dagli anni, le membra scosse da tremiti e i tratti del viso distorti in una smorfia di rancore, sembrava più la forma grottesca tracciata da qualche folle matita che non un essere plasmato dalle mani della natura. Ahimè! Quanti pochi volti la natura lascia, dopo un po', a dar gioia con la loro bellezza! I dolori, gli affanni e i patimenti del mondo li mutano, così come mutano il cuore, ed è soltanto quando le passioni si spengono e non tormentano più che le oscure nubi che prima li offuscavano si dissolvono e lasciano affiorare il volto celeste. Accade sovente che il volto dei morti, perfino in quella condizione di fissa rigidità, si distenda e riprenda l'espressione di un bimbo addormentato e della sua prima età; riprenda di nuovo una tale placidità e una tale pace che chi lo conobbe nella sua felice infanzia s'inginocchia accanto alla bara con un sentimento di reverenza, ritrovando quasi il volto di un angelo in terra. La vecchia megera trotterellò lungo i corridoi e su per le scale, borbottando indistinte risposte ai rimproveri dell'altra, e poiché dovette infine fermarsi per riprender fiato le consegnò il lume e rimase indietro, seguendola meglio che poteva, mentre la più agile matrona si dirigeva alla stanza dove giaceva la moribonda. Era una nuda soffitta, con una luce fioca che ardeva in un angolo. C'era un'altra vecchia che vegliava accanto al letto e l'aiutante del farmacista della parrocchia stava in piedi accanto al camino intento a ricavare uno stuzzicadenti da una penna. «Notte fredda, signora Corney», disse questo giovane gentiluomo quando entrò la direttrice. «Molto fredda davvero, signore», replicò la direttrice, mentre faceva una riverenza, nel tono più educato che le riuscì. «Dovreste farvi dare del carbone migliore dai vostri fornitori», disse l'aiutante del farmacista rompendone un blocco sul fuoco con un attizzatoio arruginito. «Non fa per una sera così fredda, questa roba qui». «È la Direzione che appalta, signore», ribatté la direttrice. «Ma potrebbero sprecarsi a tenerci almeno caldi, perché in questo posto è già dura abbastanza». La conversazione fu a quel punto interrotta da un lamento della moribonda. «Oh!», disse il giovane volgendo il viso verso il letto come se prima si fosse completamente dimenticato della paziente. «Ormai è spacciata, signora Corney». «Spacciata, signore?», chiese la direttrice. «Mi sorprenderebbe molto se passasse le prossime due ore», disse l'aiuto del farmacista assorto sulla punta dello stuzzicadenti. «È tutto il sistema che è saltato. È assopita, signora?». La vecchia che vegliava si curvò sul letto per accertarsene e annuì. «Allora, forse spirerà in questo modo, se non l'agitate», osservò il giovane. «Posate il lume a terra. Lì non le darà fastidio». La vecchia fece come le era stato detto, scotendo intanto la testa per ammonire che la vecchia non sarebbe morta così tranquillamente; poi riprese il suo posto accanto all'altra assistente giunta nel frattempo. La direttrice si strinse la mantellina con un gesto di impazienza e sedette ai piedi del letto. Completata l'opera dello stuzzicadenti, l'aiutante si piantò di fronte al fuoco e armeggiò con quello strumento per una decina di minuti; poi, sopraffatto dal tedio, augurò alla signora Corney buona guardia e se ne andò in punta di piedi. Le due vecchie, rimaste per qualche tempo in silenzio, ad un certo punto s'alzarono e allontanandosi dal letto andarono ad accovacciarsi accanto al fuoco, piegandovisi sopra e con le mani vizze protese a cercarne il calore. Così sedute, con le fiamme che gettavano una luce spettrale sui loro volti decrepiti e rendevano la loro bruttezza assolutamente orribile, cominciarono a parlottare a bassa voce. «Ha detto qualche altra cosa mentr'ero via, Anny cara?», domandò la messaggera. «Neanche una parola», replicò l'altra. «Ha provato a pizzicarsi e battersi le braccia, ma io le ho tenuto le mani ferme, e subito ha smesso. Non le sono rimaste molte forze, sicché non m'è stato difficile tenerla buona. Non sono mica tanto debole per essere una vecchia, anche se vivo di quello che mi dà la parrocchia... no, no!» «Ha bevuto il vino che il dottore aveva detto si doveva farle bere?», chiese la prima. «Ho cercato di farglielo mandar giù», riprese l'altra. «Lei però serrava i denti stretti, e stringeva il boccale così forte che è già tanto essere riuscita a strapparglielo dalle mani. Così l'ho bevuto io, e m'ha giovato di più!». Guardandosi cautamente intorno per assicurarsi che nessuno ascoltasse, le due vegliarde si strinsero ancor più al fuoco e ridacchiarono di cuore. «Mi ricordo di quando lei avrebbe fatto lo stesso», disse la prima, «e poi sai lo spasso a ricamarci sopra!». «Già, proprio così», interloquì l'altra. «Era una burlona. E quanti, quanti ne ha sotterrati! Cadaveri composti per benino come pupazzi di cera. Li ho veduti con questi vecchi occhi... sì, e li ho toccati con queste vecchie mani anche, giacché l'ho aiutata dozzine di volte». Così dicendo, quella decrepita creatura, protese le dita tremanti, e gliele agitò esultante innanzi al volto; poi, rovistando nella tasca, ne cavò una vecchia tabacchiera di latta scolorita dal tempo dalla quale lasciò cadere qualche pizzico di tabacco nel palmo della compagna e qualche altro nel suo. Mentre erano così occupate la direttrice, che attendeva con impazienza che la moribonda riprendesse conoscenza, si avvicinò al fuoco e chiese loro con asprezza quanto ancora dovesse aspettare. «Non molto, padrona», replicò la seconda vecchia guardandola in viso. «Nessuna di noi dovrà aspettare la morte a lungo. Pazienza, pazienza! Arriverà abbastanza presto per noi tutte!». «Tacete, vecchia rimbambita!», disse la direttrice irritata. «Tu, Martha, dimmi: è già stata in queste condizioni prima d'ora?» «Spesso», rispose la prima. «Ma non ci starà mai più», aggiunse la seconda. «Cioè, si sveglierà ancora soltanto una volta, e attenta, padrona, non durerà molto». «Molto o poco», replicò la direttrice seccamente, «non mi troverà qui quando si sveglierà e badate, tutte e due, di non venirmi ancora a seccare per niente. Non fa parte dei miei doveri assistere tutte le vecchie che muoiono in questa casa... e per giunta non ne ho punto voglia. Tenetelo a mente, vecchie megere impudenti che non siete altro. Se provate a prendermi in giro ancora una volta v'aggiusto io, v'aggiusto! Ve lo garantisco!». Stava per dirigersi alla porta quando un grido delle vecchie, avvicinatesi al letto, le fece volgere il capo. La moribonda s'era sollevata e protendeva le braccia verso di loro. «Chi è quella?», esclamò con voce cupa. «Zitta, zitta!», disse una delle donne curvandosi su di lei. «Mettetevi giù, mettetevi giù!». «Mai più mi metterò giù viva!», disse la donna dimenandosi. «Devo dirglielo! Venite qui! Avvicinatevi! Una parola all'orecchio». Afferrò la direttrice per il braccio e tirandola su una sedia accanto al letto era sul punto di parlare quando, girando lo sguardo intorno, si accorse che le due vecchie tendevano l'orecchio bramose. «Mandatele via», disse torpidamente la donna. «Sbrigatevi, sbrigatevi!». All'unisono, le due vecchie megere cominciarono a profondere pietosi lamenti che la loro povera compagna era troppo sconvolta per riconoscere le sue migliori amiche e continuavano a protestare che non l'avrebbero abbandonata, quando la direttrice le spinse fuori dalla stanza, chiuse a chiave la porta e tornò accanto al letto. Vedendosi estromesse, le megere mutarono tono e attraverso il buco della serratura gridarono che la vecchia Sally era ubriaca; il che, per la verità, non era affatto improbabile giacché in aggiunta alla moderata dose di oppio prescrittale dal farmacista ella si trovava sotto gli effetti d'un ultimo goccio di gin e acqua che, nella loro bontà di cuore, le due donne le avevano segretamente somministrato. «Ascoltatemi ora», disse la moribonda alzando la voce come nel tentativo estremo di trarre da sé un'ultima scintilla di energia. «Proprio in questa stanza... in questo stesso letto... ho assistito un tempo una graziosa giovane che era stata portata all'ospizio con i piedi coperti di ferite e piaghe per il lungo camminare, e tutta sporca di polvere e di sangue. Dette alla luce un bimbo e morì. Lasciatemi pensare... che anno era?» «Non vi curate dell'anno», disse l'impaziente ascoltatrice. «Che sapete della giovane?». «Già», mormorò la moribonda ricadendo nello stato di torpore di prima, «che so di lei?... Che so?... Ecco!», esclamò, saltando su con furia, il volto congestionato e gli occhi che le uscivano dalle orbite... «l'ho derubata, ecco cosa! Non era ancora fredda... non era ancora fredda, vi dico, quando gliel'ho rubato». «Rubato cosa, santissimo cielo?», esclamò la direttrice, con un gesto che sembrava supplicare aiuto. «Il medaglione!», replicò la donna chiudendole la bocca con la mano. «L'unica cosa che aveva. Le mancavano vestiti per riscaldarsi e cibo per sfamarsi, ma se lo teneva in seno. Era d'oro, vi dico! Oro zecchino che avrebbe potuto salvarle la vita!». «Oro!», fece eco la matrona curvandosi bramosa sulla donna che si riaccasciava. «Va' avanti, va' avanti... sì... che ne è stato? Chi era la madre? Quando è stato?» «M'ha supplicato di custodirlo al sicuro», replicò la donna con un gemito, «fidandosi di me perché ero la sola donna che le stesse accanto. In cuor mio glielo avevo rubato già dalla prima volta che me lo mostrò appeso al collo, e forse è pure colpa mia la morte del bambino! L'avrebbero trattato meglio se avessero saputo tutto!». «Saputo cosa?», chiese l'altra. «Parla!». «Il bambino crebbe così somigliante alla madre», disse la donna nel suo parlare sconnesso senza far caso alla domanda, «che il ricordo mi tormentava ogni volta che vedevo il suo volto. Povera ragazza, povera ragazza! Così giovane! Un agnellino così giovane! Aspettate! C'è dell'altro! Non vi ho detto ancora tutto, no?». «No, no», replicò la direttrice volgendo il capo per afferrare le parole sempre più fioche della moribonda. «Sbrigatevi, prima che sia troppo tardi!». «La madre», disse la donna con uno sforzo estremo, «quando cominciò l'agonia, la madre mi sussurrò all'orecchio che se il suo bambino fosse nato vivo e fosse diventato grande, forse un giorno non avrebbe provato tanta vergogna a sentir pronunciare il nome di lei. "E..., oh, cielo misericordioso!", disse giungendo le mani smagrite, "bimba o bimbo che sia, fa' che trovi qualche amico in questo mondo di sofferenza che abbia compassione di questa povera creatura abbandonata, abbandonata alla tua pietà!"». «Qual è il nome del ragazzo?», domandò la direttrice. «Lo chiamarono Oliver», rispose flebile la donna. «L'oro che rubai era...». «Sì, sì, che cosa?», gridò l'altra. Si chinò ansiosa sulla donna per sentirne la risposta, ma si tirò istintivamente indietro mentr'ella si risollevava lentamente e rigidamente a sedere; poi, afferrando il lenzuolo con entrambe le mani, emise qualche indistinto suono gutturale e ricadde sul letto senza vita. «Morta stecchita!», disse una delle vecchie precipitandosi nella stanza non appena la porta fu aperta. «E senza che avesse niente da dire, dopo tutto», interloquì la direttrice marciando fuori con aria indifferente. Le due vegliarde, troppo prese, a quanto sembrava, dai preparativi al terribile compito che le attendeva per replicare, furono lasciate sole col cadavere. Capitolo XXV. Nel quale questa narrazione torna a Fagin e compagnia Mentre nell'ospizio, in campagna, accadevano queste cose, il signor Fagin sedeva nella vecchia tana, la stessa dalla quale la ragazza aveva portato via Oliver, ruminando assorto accanto a un fuoco fumoso. Sul ginocchio aveva un soffietto a mantice con il quale aveva evidentemente cercato di sollecitare il fuoco ad una azione più vivace, ma sprofondando nei propri pensieri ci si era poggiato sopra con le braccia conserte, il mento appuntato sui pollici, e fissava uno sguardo vacuo sulle barre rugginose. Al tavolo dietro di lui sedevano Dodger lo Svelto, Mastro Charley Bates e il signor Chitling impegnati in una partita di whist, con Dodger che giocava da solo contro Charley e il signor Chitling. L'espressione del primo gentiluomo, singolarmente intelligente in ogni occasione, tanto più lo era mentre seguiva attentamente il gioco e rifletteva sulle giocate del signor Chitling, al quale di tanto in tanto gettava, a seconda delle occasioni, tutta una vasta gamma di sguardi penetranti, accortamente regolando le carte da giocare in base alla osservazione di quelle del suo vicino. Poiché era una notte gelida, Dodger teneva il cappello in testa, quella invero essendo la sua abitudine anche al coperto. Stringeva pure una pipa di creta tra i denti, togliendola solo per il breve spazio di tempo che riteneva necessario per concedersi un goccio da una brocchetta da un quarto poggiata sul tavolo, opportunamente riempita di gin e acqua per il conforto della compagnia. Anche il signor Bates seguiva il gioco; però, di più eccitabile natura rispetto al suo esperto amico, egli ricorreva con più frequenza al gin e acqua, e indulgeva inoltre in spiritosaggini e commenti irrilevanti, tutti altamente disdicevoli ai fini di una gestione scientifica delle partite. Per la verità lo Svelto, confidando sulla loro amicizia di lunga data, più d'una volta aveva colto l'occasione per argomentare col compagno riguardo a tali improprietà, ma Charley Bates accoglieva tutte queste rimostranze con estremo buonumore, invitando semplicemente l'amico a "morire ammazzato" o ficcarsi la testa in un sacco, o altre ben tornite repliche di pari spiritosaggine, della cui felice formulazione in cuor suo il signor Chitling restava considerevolmente ammirato. Era notevole che questo secondo gentiluomo e il suo compagno perdevano sistematicamente e che tale circostanza, lungi dall'irritare il signor Bates, sembrava offrirgli occasione di estremo divertimento, giacché scoppiava in fragorosissime risate alla fine di ogni partita dichiarando che non gli era capitato un gioco così spassoso da quando era nato. «Sono due doppie e la bella», disse il signor Chitling col muso lungo tirando fuori mezza corona dal taschino del panciotto. «Mai visto un tipo come te, Jack; vinci sempre. Anche se ci vengono buone carte, io e Charley non siamo capaci a sfruttarle». Fosse la maniera o la sostanza di questa assai risentita osservazione, Charley Bates ne fu così estasiato che la sonora risata che ne seguì scosse l'ebreo dai suoi pensieri e l'indusse a chiedere cosa stesse succedendo. «Che succede, Fagin?», esclamò Charley. «Se avessi visto la partita! Tommy Chitling non ha fatto neanche un punto, e io e lui eravamo compagni contro Dodger e il morto. «Ah, sì?», fece l'ebreo con un ghigno che esprimeva a sufficienza come non avesse alcuna difficoltà a comprenderne il motivo. «Riprovaci, Tom, riprovaci». «Non ci ricasco, Fagin. Tante grazie», replicò Chitling. «M'è bastato. Quel Dodger ha una tale fortuna che non c'è storia con lui». «Ah, ah! Caro mio! Devi essere sveglio ben presto la mattina, per vincere contro lo Svelto». «La mattina!», disse Charley Bates. «Conviene che t'infili le scarpe già di notte, e guardare con un telescopio per occhio e un binocolo da teatro per coprirti le spalle, se vuoi spuntarla con lui». Il signor Dawkins accolse questi bei complimenti con molta filosofia e sfidò qualsiasi gentiluomo di quella compagnia a tagliamazzo, a uno scellino a botta. Poiché nessuno accettò la sfida e la sua pipa era già consumata, seguitò il divertimento disegnando uno schizzo della prigione di Newgate sul tavolo tracciandolo col pezzo di gesso che prima gli era servito da segnapunti, mentre intanto fischiava in tono singolarmente vivace. «Come sei abbacchiato, Tommy!», disse Dodger interrompendosi bruscamente dopo una lunga pausa di silenzio, rivolto al signor Chitling. «Cosa pensi che stia rimuginando, Fagin?» «E come faccio a saperlo, mio caro?», replicò l'ebreo volgendo il capo mentre soffiava coi mantici. «Forse pensa alla perdita, oppure alla magione di campagna che ha da poco lasciato, eh? Ah, ah! È così, mio caro?» «Neanche per sogno», replicò Dodger, anticipando e bloccando la risposta del signor Chitling. «Tu che dici, Charley?» «Io dico», replicò mastro Bates con un ghigno, «che è cotto per Betsy. Guardate come arrossisce! Occhi miei, muoio dal ridere! Che buffo cascamorto! Tommy Chitling invaghito! Oh, Fagin, Fagin, che spasso». Completamente sopraffatto dall'idea che il signor Chitling nutrisse in segreto teneri sentimenti, mastro Bates si buttò indietro sulla sedia con tale violenza che perse l'equilibrio e si rovesciò sul pavimento e, senza che l'incidente sottraesse alcunché al suo divertimento, lì rimase steso fino a totale esaurimento della risata. Quindi si rimise a sedere e subito scoppiò in un'altra. «Non far caso a lui, mio caro», disse l'ebreo facendo l'occhiolino a Dawkins e assestando a mastro Bates una bottarella di rimprovero col becco del mantice. «Betsy è una ragazza in gamba. Tientela cara, Tommy, tientela cara!». «Insomma, Fagin», replicò il signor Chitling tutto rosso in viso, «la cosa non vi riguarda, a nessuno». «Certo che no», replicò l'ebreo. Charley parla troppo. Non far caso a lui, mio caro, non far caso a lui. Betsy è una ragazza in gamba. Segui i suoi consigli, Tommy, e la tua fortuna è fatta». «Io li seguo i suoi consigli, diciamo così», replicò il signor Chitling. «Non sarei stato ai lavori forzati se non le avessi dato ascolto. Quel lavoretto è tornato a tuo vantaggio, comunque, non è vero, Fagin! A confronto cosa sono sei settimane di gattabuia? Prima o poi ci tocca, e allora perché non durante l'inverno, quando a nessuno piace starsene troppo in giro, eh, Fagin?» «Ah, proprio così, mio caro», replicò l'ebreo. «Non ti dispiacerebbe rifarlo, Tom», domandò Dodger strizzando l'occhio a Charley Bates e all'ebreo, «sempreche torni utile a Betsy?» «Diciamo di no», replicò Tom con rabbia. «Ecco ! E trovatemi qualcuno che farebbe la stessa cosa. Trovatemelo, eh, Fagin?» «Impossibile, mio caro», replicò l'ebreo. «Impossibile, Tom. Non conosco nessuno che lo farebbe, a parte te; nessuno, mio caro». «Non sarei finito in gattabuia se l'avessi tirata in ballo, non è vero, Fagin?», proseguì arrabbiato quel povero tontolone. «Mi bastava dire qualche parola, non è così Fagin?» «Assolutamente, mio caro», replicò l'ebreo. «Ma io non ho cantato, no, Fagin?», disse Tom accavallando molto volubilmente una domanda sull'altra. «Certo, no, no», ribatté l'ebreo. «Hai troppo fegato per far questo. Hai troppo fegato, mio caro!». «Forse ho troppo fegato», riprese Tom guardando intorno. «E se è così, cosa c'è da ridere, eh, Fagin?». Avvertendo che il signor Chitling era sensibilmente contrariato, l'ebreo s'affrettò a rassicurarlo che nessuno aveva da ridere, e per dimostrargli la serietà di tutti si rivolse a mastro Bates, il principale imputato. Sfortunatamente però Charley Bates, sul punto di protestare che mai era stato più serio in vita sua, non seppe trattenere un altro scoppio di risa, così violento che l'offeso signor Chitling, senz'altre cerimonie, attraversò di scatto la stanza e mollò una botta al colpevole; il quale però, con l'abilità acquisita nello sfuggire agli inseguimenti, lo schivò, chinandosi con una scelta di tempo così accorta che la botta calò in petto al vecchio facendolo barcollare fino al muro; e lì quello rimase annaspando, mentre Chitling lo guardava con espressione di profondo sgomento. «Zitti!», esclamò il quel momento Dodger. «Ho sentito il campanello». Preso il lume, strisciò silenziosamente di sopra. Il campanello suonò di nuovo con una certa impazienza. Gli altri attendevano al buio. Dopo qualche tempo Dodger tornò e sussurrò misteriosamente all'orecchio di Fagin. «Cosa?», esclamò l'ebreo. «Da solo?». Dodger annuì e schermando la fiamma della candela con la mano intimò discretamente a Charley, con muta pantomima, che avrebbe fatto meglio ad astenersi da altre spiritosaggini in quel momento. Assolto questo obbligo di amicizia, guardò fisso l'ebreo e attese i suoi ordini. Il vecchio si mordicchiò le dita ingiallite e stette a pensare per alcuni secondi, col viso stravolto dall'agitazione, come se avesse paura di qualcosa e temesse notizie peggiori. Alla fine sollevò il capo. «Dove si trova lui?», domandò. Dodger indicò il soffitto di sopra e accennò se dovesse andar su. «Sì», disse l'ebreo rispondendo alla muta domanda. «Portalo qui. Silenzio. Zitto, Charley! Tranquillo, Tom! Sparite! Sparite!». Charley Bates e il suo recente antagonista obbedirono silenziosamente e immediatamente al secco comando. Non v'era traccia di dove fossero quando Dodger scese le scale col lume in mano, seguito da un uomo in un grezzo camiciotto. Questi, dopo aver gettato un rapido sguardo intorno alla stanza, si tolse una larga sciarpa che aveva nascosto la parte inferiore del viso. Emersero così i lineamenti sfatti e sudici e la barba lunga del bel Toby Crackit. «Come te la passi, Fagin?», disse questo benemerito con un cenno all'ebreo. «Ficca quella sciarpa nel mio berretto di castoro, Dodger, dimodoché so dove trovarla quando me la squaglio, a tempo debito! Tu sarai un giovane mariolo più in gamba di quelli della vecchia guardia». Con queste parole si tirò su il camicione, se lo legò in vita, avvicinò una sedia al fuoco e sistemò i piedi sugli alari. «Guarda là, Fagin», disse indicando sconsolatamente i suoi stivali. «Neanche un goccio per toglierci la polvere e per lubrificarci l'ugola, da quando sai tu; neanche un goccio, corpo di...! E non guardarmi in quel modo, compare. Tutto a tempo debito. Non posso parlare d'affari prima d'essermi sfamato e dissetato, sicché fammi portare qualcosa di commestibile e lascia che mi sazi in pace per la prima volta in questi ultimi tre giorni!». L'ebreo accennò a Dodger di portare sul tavolo quello che c'era di commestibile e sedendosi di fronte al ladro rimase in attesa. A giudicare dalle apparenze, Toby Crackit non era affatto desideroso di aprire la conversazione. Dapprima l'ebreo s'accontentò di guardarlo pazientemente in viso, come a voler trarre dalla sua espressione qualche indizio sulle informazioni che portava; invano, però. Sembrava stanco e provato, eppure mostrava in viso quella stessa compiaciuta tranquillità che è così comune ai suoi pari, e sotto la sporcizia, la barba lunga e i basettoni, splendeva pur sempre, intatto, il compiaciuto sogghigno del bel Toby Crackit. L'ebreo perciò, angosciato e tormentato, osservava ogni suo boccone, andando nel frattempo avanti e indietro per la stanza, in una incontenibile agitazione. Ma non servì a nulla. Toby continuò a mangiare ostentando la massima indifferenza finché non ci fu più nulla da mettere sotto i denti; dopodiché, ordinando a Dodger di sgomberare, chiuse la porta, si versò un bicchiere di gin e acqua e si predispose al colloquio. «Prima cosa, Fagin», disse Toby. «Sì, sì!», interloquì l'ebreo accostando la sedia. Il signor Crackit fece una pausa per prendere un sorso della sua bevanda e per dichiarare che il gin era eccellente. Quindi, poggiando i piedi sulla bassa mensola sì da portare gli stivali più o meno all'altezza degli occhi, riprese tranquillamente. «Prima cosa, Fagin», disse lo scassinatore. «Come sta Bill?» «Cosa?», strillò l'ebreo saltando dalla sedia. «Perché, non mi dirai...», esclamò Toby impallidendo. «Non ti dirò!», ripetè l'ebreo calpestando furiosamente il pavimento. «Dove stanno, Sikes e il ragazzo? Dove stanno? Dove sono andati? Dove si nascondono? Perché non sono venuti qua?» «Il furto è fallito», disse Toby con un filo di voce. «Questo lo so», replicò l'ebreo indicando un giornale che aveva tirato fuori della tasca. «Che altro?» «Hanno sparato e hanno beccato il ragazzo. Ce la siamo data a gambe attraverso i campi sul retro, dritti filati senza far caso a pozzanghere o siepi, reggendolo tra noi due. Ci hanno dato la caccia. Dannazione! S'è destato tutto il circondario, e i cani ci stavano addosso». «Il ragazzo!», annaspò l'ebreo. «Se l'era incollato Bill, e pistava come il vento. Ci fermammo per portarlo in due. La testa gli ciondolava ed era freddo. Ma quelli ci stavano ormai alle calcagna, e perciò decidemmo che ognuno andasse per sé per scampare al patibolo! Ci separammo e lasciammo il ragazzo steso in una fossa, non so neanche se vivo o morto». L'ebreo non stette a sentire altro ma cacciando un grido acuto e strappandosi i capelli si precipitò fuori della stanza e della casa. Capitolo XXVI. Nel quale appare sulla scena un misterioso personaggio e accadono molte cose inseparabili da questa storia Il vecchio aveva raggiunto l'angolo della strada, prima che cominciasse a riprendersi dagli effetti delle notizie di Toby Crackit. Non aveva minimamente rallentato la sua andatura, insolitamente rapida, e proseguì allo stesso modo come confuso e cieco quando l'improvviso sferragliare di una carrozza e l'urlo dei passanti che videro il pericolo che correva lo riportarono sul marciapiede. Evitando, per quanto possibile, tutte le strade principali, e passando furtivo solo per vicoli e stradine secondarie, giunse infine a Snow Hill. Camminò ancora più svelto di prima, senza fermarsi finché non arrivò in un vicolo. Qui riprese il suo solito passo strascicato e, come avvertendo di trovarsi nel suo elemento, sembrò respirare più liberamente. Vicino al punto in cui si incontrano Snow Hill e Holborn Hill, dal lato destro uscendo dalla città, si diparte una stradina stretta e squallida che conduce a Saffron Hill. Nelle sue sozze botteghe sono esposti in vendita enormi mucchi di fazzoletti di seta di seconda mano, di ogni misura e disegno, giacché qui si trovano i negozianti che li acquistano dai marioli. A centinaia questi fazzoletti pendono dagli appendiabiti, fuori dalle finestre, o svolazzano appesi agli stipiti delle porte; dentro, ve ne sono scaffali pieni zeppi. Per angusti che siano i limiti di Field Lane, vi si trova il barbiere, il caffè, la birreria e la friggitoria del pesce. È una colonia commerciale a tutti gli effetti, un emporio del piccolo furto, visitato la mattina presto e sul calar della sera da commercianti silenziosi, che contrattano in bui retrobottega e che si dileguano tanto segretamente come sono venuti. Qui il venditore di abiti usati, il calzolaio, lo straccivendolo mettono in mostra la loro merce come fosse un'insegna per il ladruncolo; qui depositi di ferro vecchio e ossa e mucchi muffosi di stracci di lana e di lino marciscono e si disfano in umide cantine. In codesto luogo l'ebreo svoltò. Egli era ben noto ai loschi cittadini di quella stradina, poiché, mentre passava, quelli di loro che si guardavano attorno per vendere o comprare gli accennavano familiarmente col capo. Rispondeva ai loro saluti allo stesso modo, senza concedere segni di maggiore intimità, finché non arrivò all'altro capo della stradina, allorché si fermò per rivolgersi a un negoziante di bassa statura che s'era ficcato in una seggiola da bambino fino al massimo consentitogli dalle sue dimensioni e fumava una pipa sulla soglia della sua bottega. «Ma guarda chi si vede, il signor Fagin. Tornerebbe il lume degli occhi a un cieco», disse quel rispettabile commerciante rispondendo all'ebreo che chiedeva come stesse. «C'era aria piuttosto pesante nel vicinato, Lively», disse Fagin inarcando le sopracciglia e incrociando le braccia sul petto. «Beh! Qualcuno se ne è già lamentato in passato una volta o due», replicò il commerciante, «ma poi le cose si rimettono subito a posto, non trovate?». Fagin accennò di sì col capo. Poi, indicando in direzione di Saffron Hill, chiese se quella sera si fosse fatto vivo qualcuno, da quelle parti. «Dove, ai Tre Storpi?», chiese l'altro. L'ebreo annuì. «Dunque vediamo», continuò il mercante riflettendo. «Sì, saranno una mezza dozzina, a quanto ne so, ma non c'è l'amico tuo, mi pare». «Sikes non c'è?», domandò l'ebreo con espressione di disappunto. «Irreperibile, come dicono gli avvocati», replicò quell'ometto scuotendo la testa e con una espressione stupefacentemente sagace. «Avete per caso qualche affaruccio per me stasera?». «Niente stasera», disse l'ebreo girandosi per andar via. «State andando ai Tre Storpi, Fagin?», gli gridò dietro l'ometto richiamandolo. «Aspettate. Non mi dispiacerebbe per niente scolarmi un goccetto con voi!». Ma poiché l'ebreo, voltandosi, agitò la mano per intimargli che preferiva restar solo e poiché, inoltre, all'ometto non riuscì di districarsi agevolmente dalla sedia, all'insegna dei Tre Storpi dovettero fare a meno della presenza del signor Lively per quella volta. Prima che si mettesse in piedi, l'ebreo era già sparito, sicché il signor Lively, invano sollevatosi in punta di piedi nella speranza di scorgere Fagin, si calcò di nuovo nella seggiola e, scrollando la testa all'unisono con la signora della bottega dirimpetto - gesto in cui erano manifesti dubbio e diffidenza - riprese a fumare la pipa atteggiato a solenne gravità. "I Tre Storpi", ovvero "Three Cripples", l'insegna sotto cui andava nota ai suoi avventori quella certa istituzione, era la medesima locanda nella quale abbiamo già incontrato il signor Sikes e il suo cane. Rivolto appena un cenno all'uomo dietro al banco, Fagin salì di sopra, aprì la porta d'una stanza, s'introdusse cautamente nella camera e, riparandosi gli occhi con la mano, si guardò ansiosamente attorno come se cercasse qualcuno in particolare. La stanza era illuminata da due lampade a gas, la cui luce era invisibile dall'esterno perché trattenuta dalle imposte serrate e da tende chiuse d'un colore rosso sbiadito. Il soffitto era stato tinto di nero, per evitare che il colore patisse a causa della combustione delle lampade e c'era un fumo di tabacco così denso che all'inizio era quasi impossibile discernere alcunché. Man mano però che il fumo usciva dalla porta aperta, divenne visibile un ammasso di teste, confuso come il frastuono che allietava l'orecchio, e man mano che l'occhio si abituava alla scena il nuovo arrivato distinse la numerosa compagnia di uomini e donne lì convenuta, accalcata attorno a un lungo tavolo a un capo del quale sedeva un principale col martello di sua spettanza in mano, mentre in qualche angolo nascosto un musicante di professione, con un naso bluastro e un fazzoletto legato in testa per alleviare il mal di denti, strimpellava a un pianoforte. Mentre Fagin entrava silenziosamente, il musicante, con una velocissima scala sui tasti, a mo' di preludio, sollevò una generale acclamazione in richiesta di qualche canzone. Quando si fu placata, una giovane donna si dispose a intrattenere la compagnia con una ballata di quattro versi in tutto, col pianista che, al termine di ciascuno, suonava tutto quanto il ritornello più forte che poteva. Quando finì, il principale propose un brindisi, dopodiché i due gentiluomini alla sua sinistra e alla sua destra, rispettivamente, s'offrirono di cantare un duetto, e l'esecuzione strappò una valanga di applausi. Era curioso osservare i volti che spiccavano in quel gruppo. Per cominciare, il principale stesso e proprietario del locale, un individuo rozzo e ben piantato che, mentre tutti cantavano, girava lo sguardo di qua e di là e, pur sembrando totalmente partecipe al divertimento generale, teneva un occhio aperto su ogni minimo gesto o azione, e un orecchio teso a carpire ogni parola pronunciata... molto ben teso. Vicino a lui c'erano le cantanti, le quali ricevevano i complimenti della compagnia con professionale indifferenza e a turno si concedevano dozzine di bicchierini di gin e acqua loro offerti dai più chiassosi ammiratori, le fisionomie dei quali, esprimenti pressoché ogni tipo di vizio in ogni sua possibile gradazione, attiravano immancabilmente l'attenzione in virtù della loro stessa abiezione. Lì erano di casa l'inganno, la violenza e l'ubriachezza al loro grado estremo e in tutti quelli intermedi; e le donne - alcune delle quali, con un ultimo residuo della loro freschezza d'un tempo, sembravano imbruttire sotto i vostri stessi occhi, mentre altre, da cui la violenza aveva cancellato ogni indizio e traccia di femminilità, e le cui vuote espressioni tradivano soltanto l'odioso aspetto del vizio e del crimine (certe, non più che bambine e certe altre appena ragazze, non ancora passata la pubertà) - costituivano la parte più disgustosa e triste di questo squallido quadro. Niente affatto turbato da tale spettacolo, Fagin scrutava ogni volto rapito nel divertimento, senza però incontrare, evidentemente, quello cercato. Riuscendo infine ad attirare lo sguardo del principale, gli rivolse un lieve cenno e, silenziosamente com'era entrato, uscì dalla stanza. «Cosa posso fare per voi, signor Fagin?», domandò l'uomo seguendolo sul pianerottolo. «Non volete unirvi a noi? Ne sarebbero entusiasti, tutti quanti». L'ebreo scosse la testa con impazienza e disse bisbigliando: «C'è lui!» «No», replicò l'altro. «E nessuna notizia di Barney?», domandò Fagin. «Nessuna», rispose nientemeno che il proprietario dei Tre Storpi, in persona. «Non si muoverà finché le acque non si sono calmate. Saranno sulle sue tracce laggiù, potete giurarci, e se si muovesse manderebbe tutto all'aria. È al sicuro, Barney, altrimenti avrei avuto sue notizie. Mi ci gioco quello che volete che sa come cavarsela. Su questo non ci piove». «E quell'altro verrà qui stasera?», chiese l'ebreo calcando sul pronome come in precedenza. «Volete dire Monks?», chiese esitante il proprietario. «Zitto!», intimò l'ebreo. «Sì». «Certo», fece l'altro tirando fuori un orologio d'oro dal taschino. Doveva essere già qua. Se volete aspettare una decina di minuti, sarà...». «No, no», disse l'ebreo come se, pur ansioso di vedere quella persona, avvertisse comunque un sollievo nel saperlo assente. «Ditegli che sono passato per incontrarlo, e che venga da me stanotte. Anzi, dite domattina. Se non è venuto qua, va bene domattina». «Bene!», fece il proprietario. «Nient'altro?» «Neanche una parola, per ora», disse l'ebreo scendendo le scale. «Ehi!», fece l'uomo sporgendosi dalla balaustra e parlando in una sorta di sussurro roco. «Questa è una magnifica occasione per una soffiata! Di là c'è Philip Barker, così ubriaco che potrebbe arrestarlo perfino un bambino». «Aha! Però non è ancora suonata l'ora di Phil Barker», disse l'ebreo con lo sguardo verso l'alto. «Phil ha ancora qualche servizietto da sbrigare prima che noi ci si possa permettere di congedarlo; perciò tornate alla compagnia, mio caro, e raccomandate loro di godersi la vita... finché dura. Ah, ah, ah!». Il proprietario rise di rimando e tornò ai suoi ospiti. Sul volto di Fagin, appena solo, tornò a stamparsi la stessa espressione di preoccupazione e angoscia di prima. Dopo qualche attimo di riflessione chiamò una vettura e dette ordine al conducente di portarlo verso Bethnal Green. Scese quando furono a circa un quarto di miglio dalla abitazione del signor Sikes, e percorse a piedi la distanza restante. «Dunque», borbottò l'ebreo bussando alla porta, «se qualcosa di losco bolle in pentola, cara la mia ragazza, te lo farò sputare fuori a dispetto della tua furbizia». Era nella sua stanza, gli disse una donna. Fagin salì furtivamente di sopra ed entrò senza altre cerimonie. La ragazza era sola con la testa china sul tavolo e i capelli che le cadevano sciolti. "Ha bevuto", pensò con freddezza l'ebreo, "oppure si sente soltanto parecchio giù". Riflettendo, l'ebreo si girò per chiudere la porta e il rumore che fece svegliò la ragazza; lei, chiestogli se ci fossero novità, mentre ascoltava il resoconto di quanto aveva raccontato Toby Crackit, lo scrutò attentamente in viso. Terminato il racconto ricadde nella condizione di prima, senza pronunciar parola. Allontanò con impazienza la candela e una volta o due, cambiando posizione, strascicò irrequieta i piedi sul pavimento, ma questo fu tutto. In quel silenzio l'ebreo guardava inquieto la stanza, dappertutto, come per accertarsi che non ci fossero segni della segreta presenza di Sikes. Evidentemente soddisfatto dalla sua ispezione tossì due o tre volte, e altrettante tentò d'avviare la conversazione ma la ragazza non gli badò più che se fosse stato di pietra. Dopo un po' fece un ultimo tentativo e lisciandosi le mani osservò nel suo tono più suadente: «E dove pensi che si trovi ora Bill, mia cara?». A malapena comprensibile, gemendo, la ragazza rispose che non sapeva dirlo, mentre mal soffocati singulti lasciavano intuire che stesse piangendo. «E anche quel ragazzo», disse l'ebreo aguzzando gli occhi per cogliere l'espressione del viso. «Povero piccolo! Abbandonato in una fossa! Pensa, Nancy». «Il bambino», disse la giovane sollevando lo sguardo, «sta meglio dove sta che in mezzo a noi, e se non compromette Sikes, spero che sia steso morto in quel fosso e che le sue giovani ossa possano marcire là». «Cosa?», esclamò stupefatto l'ebreo. «Sì, è così!», ribatté la ragazza fissando lo sguardo su di lui. «Sarò contenta di non averlo più sotto gli occhi, così potrò credere che il peggio è passato. Non sopporto di vedermelo attorno. Mi odio da me stessa, se mi sta davanti, e mi riuscite odiosi pure voi». «Pfui!», disse l'ebreo sprezzante. «Sei ubriaca». «Ubriaca?», esclamò amaramente la ragazza. «Non è colpa tua se non lo sono. È sempre così che mi vorresti, se dipendesse da te; a parte adesso... Non sono dell'umore giusto, non è vero?» «No. Affatto», ribatté infuriato l'ebreo. «Mettimi di buon umore tu, allora!», rispose la ragazza con una risata. «Di buon umore!», esclamò l'ebreo esasperato oltre ogni limite dall'inattesa ostinazione della sua complice e dalle tante contrarietà della serata. «Sicuro, di buon umore! Ascoltami, sgualdrina! Ascoltami, perché mi basta qualche parolina sussurrata a chi so io perché il collo taurino di Sikes si trovi stretto con altrettanta forza che se lo avessi tra le mie mani in questo preciso momento. Se fa tanto da tornare indietro senza il ragazzo... se la fa franca senza riportarmi indietro il ragazzo, vivo o morto, uccidilo tu stessa se vuoi risparmiargli la forca, e fallo appena mette piede in questa stanza o altrimenti, bada bene, sarà troppo tardi!». «Che significa questo?», protestò d'impulso la ragazza. «Che significa?», continuò Fagin cieco di rabbia. «Puta caso che il ragazzo valga per me qualche centinaio di sterline, dovrei forse lasciarmi sfuggire l'occasione di guadagnarmele senza fatica per l'incompetenza di una banda di ubriaconi che potrei spacciare con un semplice fischio? E per giunta trovarmi compare d'un diavolo nato, al quale manca la volontà ma non la forza di, di...». Il vecchio, ansimando, s'interruppe cercando la parola, e in quell'istante represse l'impeto della sua ira e cambiò totalmente atteggiamento. Un istante prima agitava il pugno in aria, con gli occhi fuori dalle orbite e il volto livido di rabbia; adesso, piombava su una sedia, accasciato e tremante al pensiero di essersi tradito e di aver rivelato il suo inganno. Dopo un attimo di silenzio prese coraggio per volgere lo sguardo verso la complice. Parve rassicurato, in qualche modo, quando vide che era di nuovo nello stato di insensibilità dal quale l'aveva prima riscossa. «Nancy cara», gracchiò l'ebreo con la sua voce solita, «hai fatto caso a quello che ho detto, mia cara?» «Ora non mi seccare, Fagin!», replicò la ragazza sollevando languidamente la testa. «Se questa volta a Bill non è andata per il verso giusto, ci andrà un'altra volta. Ha fatto diversi bei lavoretti per te, e ne farà ancora parecchi, se potrà, e se invece non potrà, allora ciccia! Punto e basta». «E riguardo a questo ragazzo, mia cara», insistette l'ebreo fregandosi nervosamente le mani. «Correva i suoi rischi come gli altri», interruppe Nancy precipitosamente, «e spero che sia morto, ti dico, scampando da altri guai, e dalla tua... ossia, se non compromette Sikes. E se l'ha scampata Toby, sarà al sicuro pure lui; vale sempre due volte un Toby qualsiasi, questo è certo». «E riguardo a quello che dicevo, mia cara?», insistette l'ebreo tenendole l'occhio lucido puntato addosso. «Ripetimelo un'altra volta se si trattava di qualcosa che devo fare per te. Ma se è così, faresti meglio ad aspettare domani. Mi ero riscossa un attimo, ma ora mi sento di nuovo stordita». Fagin le fece parecchie altre domande per accertarsi che la ragazza non avesse recepito quanto gli era involontariamente uscito di bocca. Lei però rispose così prontamente e rimase così impassibile sotto gh' sguardi scrutatori di Fagin che questo ebbe la piena conferma della sua prima impressione, e cioè che ella era ubriaca. Nancy, invero, non era esente da quella pecca tanto diffusa tra le discepole dell'ebreo e alla quale esse erano piuttosto incoraggiate ad indulgere. Il suo aspetto scarmigliato e il forte sentore di gin a buon mercato che impregnava la stanza dettero all'ebreo la prova evidente della giustezza delle sue supposizioni e quando ella, dopo essere esplosa nelle manifestazioni di violenza sopra ricordate, ripiombò prima nello stordimento e poi in un misto di sentimenti sotto l'influenza dei quali passava dal pianto a esclamazioni del tipo «Finché c'è vita c'è speranza!» e diverse altre considerazioni su quante probabilità di vivere felici avessero un signore e una signora perbene, il signor Fagin in base alla considerevole esperienza accumulata in materia ai suoi tempi, concluse con grande soddisfazione che la ragazza era davvero piuttosto onnubilata. Messosi così il cuore in pace, e avendo raggiunto il suo duplice scopo di informare la ragazza su quanto aveva sentito quella sera e di accertarsi coi suoi propri occhi che Sikes non fosse tornato, il signor Fagin volse di nuovo i suoi passi verso casa lasciando la sua giovane amica addormentata, con la testa rovesciata sul tavolo. Mancava un'ora alla mezzanotte e poiché era buio pesto e il freddo era pungente non fu affatto tentato di andare all'ambio. Il vento tagliente che spazzava le strade sembrava aver portato via i passanti così come la polvere e il fango, dato che in giro si vedevano pochissime persone e tutte quante frettolosamente dirette, si capiva, alle rispettive dimore. Il vento comunque soffiava alle spalle dell'ebreo, sicché egli procedette spedito, seppure tremando e rabbrividendo alla rude spinta di ogni nuova folata. Giunto all'angolo della sua strada stava già rovistandosi in tasca in cerca della chiave quando la sagoma scura di qualcuno sbucò da un portone immerso nella tenebra, e attraversando la strada gli si accostò senza farsi scorgere. «Fagin!», gli sussurrò all'orecchio una voce. «Ah!», fece l'ebreo volgendosi di scatto. «Sei...». «Sì!», interruppe con asprezza l'estraneo. «Sono stato qui due ore ad aspettare. Dove diavolo sei stato?». «Al lavoro per te, mio caro», replicò l'ebreo scrutando nervosamente il compagno e rallentando l'andatura. «Al lavoro per te tutta la sera». «Oh! Ma sicuro!», esclamò l'estraneo ghignando. «E con quale risultato?» «Niente di buono», disse l'ebreo. «Niente di grave, spero!», disse l'estraneo fermandosi bruscamente con uno sguardo sorpreso al compagno. L'ebreo scosse la testa e stava per rispondere quando l'estraneo, interrompendolo, fece un cenno in direzione della casa innanzi alla quale, nel frattempo, erano giunti, osservando che sarebbe stato meglio ragguagliarlo sotto un tetto giacché gli si era gelato il sangue ad aspettare fuori così a lungo e il vento gli era entrato nelle ossa. Fagin pareva incline piuttosto a scusarsi di non poter introdurre un estraneo in casa a quell'ora di notte e infatti borbottò qualcosa a proposito del fuoco spento... ma poiché il compagno ribadì la richiesta in tono perentorio, aprì la porta e gli chiese di richiuderla senza far rumore mentre lui andava a prendere un lume. «È buio come una tomba qui», disse l'altro muovendo qualche passo a tentoni. «Sbrigati!». «Chiudi la porta», bisbigliò Fagin dall'altro lato del corridoio. In quel mentre essa sbatté fragorosamente. «Non sono stato io», disse l'altro avanzando a tentoni. «È stato il vento, oppure s'è chiusa da sola, non lo so. Sta' attento e fa' un po' di luce, o mi rompo il cranio contro qualcosa in questo dannato buco». Fagin scese circospetto le scale della cucina. Dopo una breve assenza tornò con una candela accesa e la notizia che Toby dormiva nella stanza di sotto sul retro e i ragazzi in quella sul davanti. Facendo segno all'altro di seguirlo salì di sopra. «Possiamo dirci qui quello che abbiamo da dire, mio caro», disse l'ebreo spalancando una porta al primo piano. «Siccome ci sono buchi nelle imposte e non vogliamo far vedere luci ai vicini mettiamo la candela sulle scale. Così!». Con queste parole, chinandosi, l'ebreo posò la candela su un'altra rampa di scale, proprio di fronte alla porta della stanza. Fatto questo, lo precedette nella stanza, dove non c'era altra mobilia se non una poltrona sfasciata e un vecchio sofà o divano senza fodere piazzato dietro la porta. Su questo articolo del mobilio si gettò l'estraneo, con l'aria di un uomo parecchio provato e l'ebreo, accostando la poltrona, gli sedette di fronte. Non era completamente buio poiché la porta era parzialmente aperta e la candela posata di fuori gettava un pallido riflesso sul muro di fronte. Parlarono a bisbigli per un po'. E sebbene la conversazione, ad eccezione di qualche parola sconnessa qua e là, fosse del tutto incomprensibile ad un eventuale ascoltatore esterno, quest'ultimo pure avrebbe facilmente percepito che Fagin sembrava difendersi dalle rimostranze dell'estraneo e che il secondo era in uno stato di notevole agitazione. Avevano discusso in questa maniera per un quarto d'ora o poco più quando Monks - con quel nome infatti l'ebreo apostrofò l'estraneo più volte nel corso del colloquio - alzando leggermente la voce disse: «Ripeto, il piano non andava. Perché non l'hai tenuto qui con gli altri costringendolo a diventar subito un ladruncolo?» «Oh, ma sentitelo!», esclamò l'ebreo con una scrollata di spalle. «Beh? Vuoi dire che non saresti stato capace se l'avessi voluto?», domandò Monks piccato. «Non t'è già riuscito con altri ragazzi decine di altre volte? Se avessi portato pazienza per una dozzina di mesi al massimo, avresti potuto farlo arrestare e spedire tranquillamente all'estero, magari a vita, no?» «E a chi avrebbe giovato questo, mio caro?», chiese l'ebreo con ostentata umiltà. «A me», replicò Monks. «Ma non a me», disse l'ebreo mansueto. «E io invece volevo ricavarci qualcosa. È ragionevole che dove ci sono due parti interessate in un affare si tenga conto del vantaggio di entrambe, non è vero, amico caro?» «E quindi?», domandò Monks con disappunto. «Ho visto che non era facile iniziarlo all'arte», replicò l'ebreo. «Non è come gli altri ragazzi nella sua stessa situazione». «Maledetto lui, no!», borbottò l'altro, «o sarebbe diventato ladro già da parecchio». «Il mio potere su di lui non era abbastanza forte da costringerlo al peggio», continuò l'ebreo scrutando ansiosamente l'espressione del compagno. «Non era ancora abbastanza impelagato, e io non avevo niente in mano per spaventarlo, cosa indispensabile all'inizio, altrimenti è fatica sprecata. Cosa potevo fare? Mandarlo fuori con Dodger e Charley? Ci siamo scottati abbastanza la prima volta, mio caro, e ho tremato per tutti noi». «Io non c'entro per niente in quella faccenda», osservò Monks. «No, no, mio caro!», riprese l'ebreo. «E non voglio litigare per questo adesso, perché se non fosse andata come è andata tu non ti saresti imbattuto proprio in chi stavi cercando. Bene. Io te l'ho riportato indietro con l'aiuto della ragazza, anche se poi lei si mette in testa di volerlo proteggere». «Al diavolo la ragazza; strozzala!», disse Monks esasperato. «Adesso non possiamo permettercelo, mio caro», replicò l'ebreo sorridendo; «e poi, non è da noi; o chissà che non mi decida, uno di questi giorni. Ma le conosco bene queste ragazze, Monks, bene! Appena il pupo ci farà il callo, lei non si curerà di lui più di quanto si curi di un ciocco di legno. Tu vuoi che diventi un ladro. Se è vivo, mi incarico io della cosa, da subito, e se.... se... - ma non è affatto probabile, bada... - se le cose stanno peggio di così e lui è già morto...». «Non voglio responsabilità se è morto!», interloquì l'altro con lo sguardo terrorizzato e afferrando il braccio dell'ebreo con mani tremanti. «Ricordatelo, Fagin! Io non c'entro. Qualsiasi cosa tranne la morte, te lo avevo detto dall'inizio. Non voglio sangue versato. Si è sempre braccati e scoperti. Se il colpo l'ha ucciso, non ne sono stato io la causa, mi senti? Fiamme d'inferno su questa tana! Cos'è stato?» «Cosa!», esclamò l'ebreo, con entrambe le braccia afferrando alla vita quel codardo che era balzato in piedi. «Dove?» «Laggiù!», replicò l'altro fissando il muro dall'altra parte. «Un'ombra! Ho visto l'ombra d'una donna in cuffia e mantello dileguare lungo il muro!». L'ebreo allentò la presa ed entrambi si precipitarono fuori della porta. La candela, consumata dagli spifferi, stava dove era stata messa. Mostrò loro solo le scale vuote e i loro visi sbiancati. Restarono in ascolto, ma per tutta la casa regnava un profondo silenzio. «È la tua immaginazione», disse l'ebreo prendendo il lume e volgendolo verso il compagno. «Giuro che l'ho vista!», replicò Monks tremante. «Quando mi sono curvato in avanti l'ho vista, e appena ho parlato è sgattaiolata via». L'ebreo scrutò con un'espressione di disprezzo il volto pallido del compare e dicendogli che poteva seguirlo, se voleva, salì le scale. Guardarono in tutte le stanze; stanze fredde, nude e vuote. Scesero giù nel corridoio e da lì nello scantinato. Una muffa verde s'allargava sulle basse pareti e le tracce di chiocciole e lumache rilucevano alla luce della candela, ma dappertutto regnava un silenzio di tomba. «Allora, che ti sembra adesso?», disse l'ebreo quando furono tornati nel corridoio. «Non c'è anima viva in casa tranne noi, Toby e i ragazzi, e di loro mi fido abbastanza. Guarda qua!». E a riprova del fatto l'ebreo tirò fuori dalla tasca due chiavi, spiegando che quando prima era sceso li aveva chiusi dentro perché non disturbassero la conversazione. Tutti questi argomenti confusero in effetti il signor Monks. Mentre ancora cercavano, senza però scoprire nulla, le sue proteste s'erano gradualmente affievolite e sfogò quindi la tensione in una sinistra risata, ammettendo che poteva trattarsi solo della sua immaginazione eccitata. Per quella sera, comunque, rinunciò ad ulteriori tentativi di riaprire il discorso, e ricordando improvvisamente che era l'una passata, quell'amabile individuo si accomiatò dal suo degno compare. Capitolo XXVII. Fa ammenda della scortesia del capitolo precedente che ha abbandonato a se stessa una signora, senza troppe cerimonie Poiché urterebbe contro le più elementari convenienze che un umile autore faccia aspettare un personaggio così importante come un custode, con le spalle al fuoco e i lembi del cappotto sollevati sotto le braccia fino al momento in cui egli ritenga opportuno andare in suo soccorso; e poiché urterebbe ancor più le convenienze relative alla sua condizione e alla sua galanteria includere nella medesima dimenticanza una signora che quel medesimo custode aveva guardato con occhio di affetto e tenerezza e nell'orecchio della quale egli aveva sussurrato dolci parole, le quali, provenendo da una tal fonte, ben possono agitare il petto di una giovane o matrona di qualsivoglia grado e condizione, lo storico la cui penna traccia queste righe, ben consapevole del posto che gli spetta e di nutrire il dovuto rispetto per quegli esseri cui è delegata un'importante e alta autorità, si affretta a rendere l'omaggio dovuto alla loro posizione e a offrire loro le doverose attenzioni che il loro rango elevato e di conseguenza le loro alte virtù reclamano perentoriamente da parte sua. A tal fine, per la verità, egli aveva posticipato l'introduzione, a questo punto, di una dissertazione concernente il diritto divino dei custodi parrocchiali, esplicativa della tesi che un custode non erra mai; la quale non avrebbe mancato di risultare sia dilettevole sia proficua per l'assennato lettore. Egli tuttavia, per mancanza di tempo e spazio, si vede costretto a posticiparla ulteriormente a tempo e luogo più convenienti. Allora egli sarà pronto a mostrare che un custode propriamente detto, ovvero un custode parrocchiale, incaricato all'ospizio della parrocchia e, nell'ufficialità delle sue funzioni, addetto alla chiesa parrocchiale, è in possesso, in virtù del suo ufficio, di tutte le più alte ed eccellenti qualità umane; e che nessuna di tali qualità un custode di compagnie, o di corte di giustizia o perfino di cappella può legittimamente rivendicare a sé. Il signor Bumble aveva contato di nuovo i cucchiaini da tè, soppesato di nuovo le mollette dello zucchero, portato di nuovo a termine la scrupolosa ispezione del bricco del latte, e s'era di nuovo sincerato col massimo scrupolo delle condizioni del mobilio, fin nella qualità del crine di cavallo dell'imbottitura delle sedie, ripetendo ciascun esame una mezza dozzina di volte almeno, prima di cominciare a pensare che il ritorno della signora Corney fosse imminente. Pensiero porta pensiero; e il signor Bumble, poiché non avvertì suono alcuno che annunciasse l'avvicinarsi della signora Corney, rifletté che sarebbe stato un modo innocente e virtuoso di passare il tempo se avesse ulteriormente appagato la sua curiosità con un rapido sguardo all'interno del cassettone della signora Corney. Dopo essersi assicurato, con l'orecchio al buco della serratura, che nessuno si stesse avvicinando alla stanza, il signor Bumble procedette a rendersi edotto del contenuto di tre profondi cassetti, cominciando dal basso; i quali, riempiti di vari indumenti di foggia e materiale buoni, accuratamente conservati tra due strati di vecchi giornali cosparsi di piantine di lavanda secca, sembrarono offrirgli motivo di estrema soddisfazione. Giungendo infine al cassetto nell'angolo destro - che aveva la chiave - e in esso notando una cassetta dotata di lucchetto che, scossa, dette un gradevole suono di monete tintinnanti, il signor Bumble tornò impettito accanto al camino, e riprendendo la sua posizione precedente, con tono grave e convinto, disse: «Si farà!». E a questa rimarchevole osservazione accodò un faceto scrollar di testa d'una decina di minuti, come se riprendesse se stesso per essere un tipo così spiritoso, e quindi dette un'occhiata estremamente interessata al profilo delle sue gambe, sembrando trarne indicibile soddisfazione. Era ancora placidamente assorto in questo esame quando la signora Corney, precipitandosi nella stanza, si gettò ansimante su una sedia presso il focolare e, copertasi gli occhi con una mano mentre l'altra si posava sul cuore, annaspò come se le mancasse il respiro. «Signora Corney», esclamò Bumble curvandosi sulla direttrice. «Cosa c'è, signora? È successo qualcosa, signora? Vi prego, rispondetemi. Sono sui... sono sui...», e poiché al signor Bumble nel suo allarme, non veniva «sui carboni ardenti», se ne uscì con «sui cocci di bottiglia». «Oh, signor Bumble!», esclamò la donna. «Mi hanno terribilmente sconvolta!». «Sconvolta, signora?», esclamò il signor Bumble. «Ma chi ha osato?... Lo so!», disse il signor Bumble contenendosi con la sua innata maestà. «Sono stati quei pezzenti perversi!». «È spaventoso a pensarci!», fece la signora rabbrividendo. «E allora non pensateci, signora», ribatté Bumble. «Non ci riesco», pigolò la signora. «Prendete almeno qualcosa, signora!», disse Bumble consolandola. «Un poco di quel vino?» «Per niente al mondo», replicò la signora Corney. «Non potrei. Oh... sullo scaffale in alto, nell'angolo destro... oh!». Pronunciando queste parole la buona signora indicò distrattamente la credenza e fu violentemente scossa da convulsioni e interni spasmi. Il signor Bumble si precipitò allo stipo e ghermendo dallo scaffale la bottiglia di vetro verde da una pinta, così incoerentemente indicata, riempì del suo contenuto una tazza di tè e la avvicinò alle labbra della donna. «Sto meglio adesso», disse la signora Corney reclinandosi sulla sedia dopo averne bevuto la metà. Il signor Bumble sollevò piamente gli occhi al soffitto in segno di gratitudine e, riportandoli di nuovo in basso fino a cadere sull'orlo della tazza, se la avvicinò al naso. «Menta piperita», spiegò la signora Corney con voce flebile e un pallido sorriso all'indirizzo del custode. «Assaggiate! C'è l'aggiunta di un poco, ma giusto un poco, di qualcos'altro». Il signor Bumble assaggiò la medicina con espressione dubbiosa, schioccò le labbra, sorseggiò di nuovo e posò giù la tazza vuota. «È molto corroborante», disse la signora Corney. «Molto davvero, signora!», disse il custode, e nel mentre tirò una sedia accanto alla direttrice e chiese teneramente cosa fosse successo per sconvolgerla così. «Niente», replicò la signora Corney. «Sono una creatura sciocca, impressionabile e debole». «Non debole, signora», replicò il signor Bumble accostando ancor più la sedia. «Siete una creatura debole, signora Corney?» «Siamo tutti creature deboli», disse la signora Corney esponendo un principio generale. «Proprio così», disse il custode. Per il buon minuto o due che seguirono, nessuno aggiunse altro. Allo scadere di quel tempo il signor Bumble aveva comprovato la sua convinzione col togliere il suo braccio sinistro dalla spalliera della sedia della signora Corney, dov'era rimasto precedentemente, per portarlo sulle stringhe del grembiule della medesima signora, nelle quali finì grado a grado per intrecciarsi. «Siamo tutti deboli creature», disse il signor Bumble. La signora Corney sospirò. «Non sospirate, signora Corney», disse il signor Bumble. «Non ci riesco», disse la signora Corney, sospirando di nuovo. «Questa è una stanza molto accogliente, signora», disse il signor Bumble volgendo lo sguardo attorno. «Se a questa si aggiungesse un'altra stanza, signora, la cosa sarebbe completa». «Sarebbe troppo, per una persona sola», mormorò la donna. «Ma non per due, signora», obbiettò il signor Bumble con voce carezzevole. «Eh, signora Corney?». Quando il custode disse così la signora Corney abbassò il capo; il custode abbassò il suo per poter guardare la signora Corney. La signora Corney, con grande proprietà, si voltò da un'altra parte, e liberò la sua mano per prendere un fazzoletto; poi, come inconsapevolmente, la rimise in quella del signor Bumble. «Il carbone ve lo passa la Direzione, non è vero signora Corney?», chiese il custode premendole affettuosamente la mano. «E anche le candele», replicò la signora Corney ricambiando leggermente quella pressione. «Carbone, candele, e casa senza affitto da pagare», disse il signor Bumble. «Oh, signora Corney! Che angelo siete!». La signora non fu insensibile a questo empito di sentimento. Cadde tra le braccia di Bumble e quel gentiluomo, nella sua agitazione, impresse un bacio appassionato sul casto naso di lei. «Che perfezione parrocchiale!», esclamò rapito il signor Bumble. «Sapete che il signor Slout è peggiorato stasera, mio incantatore?» «Sì», replicò il signor Bumble vergognoso. «Non supererà la settimana, dice il dottore», continuò. «È il direttore del complesso. La sua morte causerà un vuoto che sarà necessario riempire. Oh, signora Corney! Che prospettive di promozione si aprono così! Che occasione per unire cuori e doveri direttivi!». La signora Corney singhiozzò. «Una parolina?», disse il signor Bumble piegandosi verso la bella ritrosa. «Quella piccola, piccola parolina, mia adorata Corney?». Due volte la signora Corney tentò di parlare senza riuscirvi. Alla fine, facendosi coraggio, gettò le braccia al collo del signor Bumble dicendo che sarebbe andata in porto non appena avrebbe voluto lui e che era "un papero irresistibile". Sistemate così le cose in modo amichevole e con reciproca soddisfazione, il contratto venne solennemente ratificato con un'altra tazza colma della mistura alla menta piperita, resa tanto più necessaria per l'acuto scombussolamento e agitazione degli spiriti della signora. Mentre la consumavano ella informò il signor Bumble della morte della vecchia. «Molto bene», disse quel gentiluomo sorseggiando la sua menta piperita. «Passerò da Sowerberry andando a casa, e gli dirò di mandare qualcuno domattina. Questo vi ha spaventata, tesoro?». «Non è stato niente in particolare, caro», rispose evasivamente la signora. «Qualcosa dev'esser stato, tesoro», insistette il signor Bumble. «Non vuoi dirlo al tuo B.?» «Non ora», replicò la signora. «Uno di questi giorni. Dopo che saremo sposati, caro!». «Dopo che saremo sposati!», esclamò il signor Bumble. «Non sarà stata qualche impudenza di quei pezzenti a...». «No, no, amore», interloquì precipitosamente la signora. «Se dovessi credere», continuò il signor Bumble, «se dovessi credere che uno di loro abbia osato levare i suoi occhi volgari alla leggiadra figura...». «Non avrebbero osato farlo, caro», rispose la donna. «È meglio per loro!», disse il signor Bumble stringendo il pugno. «Fatemi vedere soltanto uno che abbia questo ardire, della parrocchia o di fuori, e gli assicurerei che non l'avrebbe una seconda volta!». Senza l'orpello di una violenta gesticolazione, questo sarebbe potuto sembrare un non eccelso complimento alle grazie della signora, ma accompagnando il signor Bumble quella minaccia con gesti pugnaci, ella fu alquanto toccata da una tale prova di devozione e, ammirata oltre ogni dire, esclamò che era davvero un bel piccioncino. Il piccioncino a quel punto si tirò su il bavero del cappotto, si mise in capo il tricorno e, scambiato un lungo e affettuoso abbraccio con la futura consorte, sfidò ancora una volta il vento gelido della sera fermandosi soltanto per alcuni minuti nella camerata maschile dell'ospizio per maltrattare un po' quei poveracci e sincerarsi di poter assolvere al compito di direttore con la dovuta severità. Accertatosi d'avere le carte in regola il signor Bumble lasciò l'edificio con un cuore più lieve e con la luminosa visione della sua futura promozione, la quale gli tenne la mente occupata finché non giunse alla bottega dell'impresario di pompe funebri. Ora, poiché i coniugi Sowerberry erano andati fuori per il tè e a cena e poiché il signor Claypole era poco propenso in genere a un'attività fisica che andasse oltre lo stretto necessario per espletare le funzioni del mangiare e del bere, la bottega era stata lasciata aperta, benché l'ora di chiusura fosse passata. Più volte il signor Bumble batté col bastone sul banco, ma non ricevendo risposta e vedendo una luce attraverso la porta a vetri del salottino sul retrobottega, prese l'ardire di affacciarsi per vedere cosa succedesse di dentro, e quando lo vide restò non poco sorpreso. Era stata messa la tovaglia per la cena e il desco era imbandito con pane e burro, piatti, bicchieri, una caraffa di birra scura e una bottiglia di vino. Dalla parte opposta del tavolo il signor Noah Claypole si dondolava negligentemente in una sedia con le gambe a sghimbescio su uno dei braccioli, con un coltello a serramanico aperto in una mano e una stozza di pane e burro nell'altra. Accosto a lui c'era Charlotte intenta a prelevare e aprire da un bariletto ostriche che il signor Claypole si degnava di inghiottire con notevole voracità. Un arrossamento più accentuato del solito dalle parti del naso di quel gentiluomo e una sorta di assonnato tic all'occhio destro lo tradivano sotto l'effetto di una leggera intossicazione, e questi sintomi erano confermati dal gusto smodato con cui ingollava le ostriche che soltanto il forte apprezzamento delle loro virtù rinfrescanti in casi di febbre nascosta avrebbe potuto giustificare in qualche modo. «Eccone una carnosa che è una delizia, Noah caro!», disse Charlotte. «Mangia, su! Solo questa». «Che cosa squisita le ostriche!», notò il signor Claypole dopo averla inghiottita. «Peccato che mangiarne più di qualcuna ti faccia venire un'indisposizione, non è vero Charlotte?» «È una vera crudeltà!», fece Charlotte. «Proprio così!», confermò il signor Claypole. «Tu non ci vai matta?» «Non troppo», replicò Charlotte. «Mi piace più vederti mangiarle, Noah, che mangiarle io stessa». «Oh Signore!», esclamò Noah pensoso. «Che stranezza!». «Prendine un'altra», disse Charlotte. «Guarda che bell'orlo delicato ha questa qui!». «Mi dispiace parecchio, ma non ce la faccio proprio più», disse Noah. «Vieni qui, Charlotte. Voglio darti un bacio». «Cosa?», disse il signor Bumble irrompendo nella stanza. «Ripetetelo, signore!». Charlotte cacciò un urlo e si nascose il viso nel grembiule mentre il signor Claypole, senza peraltro mutare di posizione a parte il poggiare i piedi in terra, fissava terrorizzato il custode. «Ripetetelo, razza di furfante impudente!», disse il signor Bumble. «Come osate soltanto pronunciare quella parola, signore? E come osate voi incoraggiarlo, spudorata che non siete altro? Darle un bacio!», esclamò l'indignatissimo signor Bumble. «Pfui!». «Non volevo darglielo veramente!», farfugliò Noah. «È lei che mi bacia sempre, anche se io non voglio». «Oh Noah!», esclamò Charlotte in tono di rimprovero. «È così! È così, lo sai!», ribatté Noah. «Ci prova sempre, ci prova, signor Bumble. M'accarezza sotto il mento, col vostro permesso, signore, e pomicia sempre!». «Silenzio!», esclamò il signor Bumble con durezza. «Voi scendete da basso, signorina. E tu, Noah, chiudi la bottega. E se ti scappa un'altra parola prima che torni il padrone, è a tuo rischio e pericolo. E quando torna riferisci che il signor Bumble ha detto che deve mandare una cassa per una vecchia domattina, dopo colazione. Avete capito, signore? Un bacio!», esclamò il signor Bumble levando le mani in alto. «È spaventoso il peccato e la perversione che si trova negli strati bassi di questo distretto parrocchiale! Se il Parlamento non si decide a prendere provvedimenti contro questi abominevoli costumi, il paese va in malora, e il carattere dei contadini è rovinato per sempre!». Con queste parole il custode, altezzoso e rattristato, s'allontanò a gran passi dalla bottega dell'impresario di pompe funebri. E avendolo accompagnato fin qui nella strada verso casa e avendo predisposto il necessario per i funerali di quella vecchia, interroghiamoci ora su Oliver Twist e accertiamoci se giace ancora nel fosso dove Toby Crackit l'aveva lasciato. Capitolo XXVIII. Si occupa di Oliver e continua con le sue avventure «Vi possano sbranare i lupi!», borbottò Sikes serrando i denti. «Magari stessi in mezzo a voi; vi farei abbaiare ancora più rochi». E latrando questa imprecazione con la massima ferocia di cui era capace, adagiò il corpo del ragazzo ferito appoggiandolo al suo ginocchio e girò la testa un attimo per guardare indietro gli inseguitori. Non si distingueva quasi nulla in quella nebbia e in quella oscurità ma le grida acute degli uomini vibravano nell'aria e il latrare dei cani più vicini, eccitati dalle campane a distesa, risuonava tutt'intorno. «Fermati! Bastardo senza fegato!», gridò il ladro a Toby Crackit il quale, facendo buon uso delle gambe, era già piuttosto avanti. «Fermati!». Quella ingiunzione ripetuta determinò l'immediato bloccarsi di Toby poiché egli non era del tutto sicuro di essere già fuori portata di pistola, e con un Sikes di quell'umore non c'era da scherzare. «Dammi una mano col ragazzo», ruggì Sikes con un cenno furioso al compare. «Torna indietro!». Toby fece mostra di obbedire ma a voce bassa e rotta, annaspando mentre lentamente tornava indietro, accennò a protestare timidamente le sue obiezioni. «Muoviti!», gridò Sikes adagiando il ragazzo in un fosso ai suoi piedi e tirando fuori la pistola dalla tasca. «Non fare il furbo con me». In quel momento il baccano aumentò. Guardando di nuovo intorno, Sikes potè distinguere gli inseguitori che, preceduti da un paio di cani, stavano già scavalcando il cancello del campo nel quale si trovavano. «È finita, Bill!», esclamò Toby. «Lascia il ragazzo e dartela a gambe». Con questo consiglio di congedo il signor Crackit, preferendo il rischio di essere colpito dall'amico alla certezza di essere catturato dai suoi nemici, girò sui tacchi e partì a tutta velocità. Sikes digrignò i denti, si guardò intorno, gettò sul corpo prostrato di Oliver il mantello in cui l'aveva frettolosamente avvolto, scappò lungo il bordo della siepe per distrarre l'attenzione degli inseguitori dal luogo in cui giaceva il ragazzo, si fermò per un secondo davanti a un'altra siepe che l'incrociava ad angolo retto, e lanciata in aria la pistola saltò oltre e sparì. «Qua! Qua!», gridò una voce tremante di dietro. «Lampo! Pluto! Venite qua! Qua!». I cani che, come i loro padroni, non sembravano entusiasti dell'esercizio nel quale erano impegnati, risposero prontamente al comando e tre uomini, che nel frattempo s'erano inoltrati nel campo, si fermarono a consulto. «Il mio consiglio, o dovrei piuttosto dire il mio ordine», fece il più grasso del gruppo, «è che noi si torni immediatamente a casa». «Io sono d'accordo con tutto quello che sta bene al signor Giles», disse un uomo più basso ma per niente esile, sbiancato in viso e gentile come lo è di solito chi è spaventato. «Non vorrei sembrare scortese, signori», disse il terzo che aveva richiamato indietro i cani. «Il signor Giles sa il fatto suo». «Sicuro», replicò quello più basso, «e qualunque cosa dica il signor Giles, non spetta a noi contraddirlo. No, no, so bene qual è il mio posto. Grazie al cielo, so bene qual è il mio posto!». Per la verità l'ometto sembrava saperlo bene davvero, e sembrava sapere altrettanto bene che non era affatto invidiabile, perché batteva i denti dalla paura mentre parlava. «Tu hai paura, Brittles», disse il signor Giles. «No», fece Brittles. «Sì», fece Giles. «È una bugia, signor Giles», dichiarò Brittles. «È una menzogna, Brittles», ribatté il signor Giles. Ora, queste quattro repliche nacquero dall'accusa del signor Giles, e l'accusa del signor Giles nasceva dalla sua indignazione al vedersi forzato alla decisione di tornare a casa sotto quella copertura adulatoria. Il terzo uomo portò a conclusione la disputa molto filosoficamente. «Vi dico io cos'è, signori», disse. «Abbiamo tutti paura». «Parlate per voi, signore», disse Giles che era il più pallido del gruppo. «Infatti», replicò l'uomo. «È più che normale e naturale avere paura in queste circostanze. Io ho paura». «E io pure», disse Brittles. «Però non sta bene spiattellarlo così in faccia, di punto in bianco». Queste franche ammissioni addolcirono il signor Giles il quale concesse all'istante d'aver paura anche lui; al che tutti e tre girarono sui tacchi e corsero indietro in totale sintonia finché il signor Giles che aveva meno fiato di tutti e che per giunta era appesantito da un forcone - col maggior garbo possibile insistè perchè si fermassero per aver modo di scusarsi delle sue parole avventate. «Ma è straordinario», disse il signor Giles dopo essersi spiegato, «di cosa è capace un uomo quando ha il sangue in subbuglio, Brittles. Sarei stato capace di uccidere se avessi preso uno di quei furfanti, lo sento». Poiché gli altri due avvertivano la medesima sensazione e poiché il loro sangue, come il suo, aveva smaltito i bollori, s'avventurarono in alcune riflessioni circa la causa d'una così improvvisa variazione di stato d'animo. «So da che dipende», fece il signor Giles. «Dipende dal cancello». «Non me ne meraviglierei affatto», esclamò Brittles afferrando l'idea. «È come se il cancello avesse sbarrato la strada al sangue in subbuglio», disse il signor Giles. «Ci potete giurare. Ho sentito il mio raffreddarsi nel momento stesso in cui lo scavalcavo». Per una singolarissima coincidenza, anche gli altri due dichiararono di aver avvertito la stessa spiacevole sensazione in quell'istante medesimo. Pareva addirittura ovvio perciò che dovesse dipendere dal cancello, specialmente perché non sussisteva alcun dubbio circa il momento in cui quella trasformazione aveva avuto luogo, in quanto tutti e tre ricordavano distintamente come fosse coincisa col loro scorgere i fuggiaschi. Questo dialogo aveva luogo tra i due che avevano sorpreso i ladri e lo stagnaio ambulante che s'era fermato a dormire in un casotto di campagna e che, destato dall'allarme assieme ai suoi due cani bastardi, s'era unito agli altri nell'inseguimento. Il signor Giles ricopriva il doppio incarico di fattore e maggiordomo per la vecchia padrona della magione e Brittles era un dipendente tuttofare il quale, assunto in servizio da bambino, era ancora trattato come un ragazzo promettente benché avesse superato la trentina. Con tali parole incoraggiandosi l'un l'altro, tenendosi tuttavia sempre stretti in gruppo e guardandosi apprensivamente intorno ogniqualvolta una raffica di vento agitava i rami, i tre raggiunsero in fretta un albero dietro il quale avevano lasciato la loro lanterna per tema che la luce di quella indicasse ai ladri in che direzione far fuoco. Dopo averla recuperata, s'affrettarono quanto potevano verso casa trotterellando a un buon ritmo, e ancora parecchio dopo che le loro scure sagome cessarono di esser visibili si poteva vederla luccicare e oscillare in lontananza, come fosse un'esalazione dell'aria tenebrosa e umida attraverso la quale veniva rapidamente portata. Il freddo si faceva più pungente man mano che s'approssimava lentamente il giorno, e la nebbia s'avviluppava sulla campagna come una densa cortina di fumo. L'erba era bagnata; i sentieri e gli avvallamenti erano tutti fango e acqua e umidi soffi d'un vento malsano scivolavano languidi con un lamento sordo. Oliver giaceva ancora, immobile e privo di sensi, nel punto in cui l'aveva lasciato Sikes. Il mattino s'avvicinava a grandi passi. Nell'aria che si faceva più secca e tagliente, la sua prima pallida tinta, fine della notte piuttosto che nascita del giorno, rischiarava debolmente il cielo. Ciò che prima, nelle tenebre, era parso sbiadito e indistinto definiva man mano i propri contorni e riacquistava l'aspetto abituale. Cadeva una pioggia battente che picchiettava sui cespugli senza foglie. Ma Oliver non la sentiva su di sé, giacendo a terra, privo di forze e di conoscenza, in un letto di fango. Alla fine un soffocato gemito di dolore ruppe il silenzio che regnava incontrastato e nell'emetterlo il ragazzo si ridestò. Il braccio sinistro, fasciato alla beli'e meglio in uno scialle, era steso inerte lungo il fianco con la fasciatura intrisa di sangue. Era così debole che potè appena sollevarsi a sedere, e quando ci riuscì e provò a guardarsi intorno in cerca d'aiuto, gemette di dolore. Rabbrividendo in tutto il corpo per il freddo e la spossatezza tentò di sollevarsi in piedi ma poi, con un tremito più forte, ripiombò pesantemente a terra. Precipitò ancora, per un po', nello stato di insensibilità nel quale era rimasto così a lungo; in qualche modo ammonito però da una debole palpitazione del cuore, che se fosse rimasto lì sarebbe sicuramente morto, Oliver si sollevò in piedi e tentò di muovere qualche passo. La testa gli girava e barcollava avanti e indietro come un ubriaco ma si resse in piedi e con la testa che gli ciondolava languida sul petto, continuò ad avanzare incespicando, ma verso dove non sapeva. Una congerie di immagini confuse e inquietanti gli si affollarono allora in mente. Gli sembrava di camminare ancora tra Sikes e Toby Crackit che litigavano, giacché le parole dette gli risuonavano all'orecchio e quando, per così dire, fece caso a sé, con uno sforzo violento per impedirsi di cadere, si rese conto di parlare a loro. Poi marciava ancora da solo con Sikes, come tutto il giorno prima, e ogni volta che sagome indistinte di persone passavano accanto egli sentiva il ladro stringergli il polso. Improvvisamente, scattava all'indietro allarmato da armi da fuoco e sentiva levarsi in aria grida e urla; luci gli baluginavano innanzi agli occhi; concitazione e tumulto, e una mano sconosciuta che l'afferrava e lo portava via in fretta. Queste rapide immagini erano permeate dalla indefinita e tormentosa consapevolezza di un dolore che lo spossava e lo fiaccava senza dargli requie. Così barcollava innanzi, infilandosi quasi meccanicamente tra le sbarre di un cancello o attraverso varchi nelle siepi in cui si imbatteva, finché non sbucò su una strada. A quel punto la pioggia cominciò a cadere così forte da ricondurlo in sé. Guardandosi attorno vide non lontano una casa che forse avrebbe potuto raggiungere. Se le sue condizioni avessero impietosito coloro che l'abitavano, questi avrebbero potuto soccorrerlo; altrimenti, pensò, meglio comunque morire vicino a degli esseri umani piuttosto che nella solitudine dell'aperta campagna. Radunò tutte le sue forze per quest'ultimo tentativo e a quella casa indirizzò i suoi passi barcollanti. Mentre s'avvicinava, ebbe l'impressione d'averla vista prima. Non ne ricordava i dettagli, ma la forma e l'aspetto della dimora gli sembrarono familiari. Il muro di recinzione del giardino! Sull'erba al di là di quello la notte prima era caduto in ginocchio e aveva pregato i due ladri che avessero pietà di lui. Era la stessa casa dove avevano tentato di rubare. Oliver sentì una tale paura invaderlo quando riconobbe quel luogo che per un istante dimenticò il dolore della ferita e pensò solo di fuggire. Fuggire! Ma se appena si reggeva in piedi! E se anche, con la sua giovane ed esile costituzione, fosse stato nel pieno delle forze, dove sarebbe potuto fuggire? Spinse il cancello del giardino. Non era chiuso e cedette ruotando sui cardini. Barcollò sul prato, salì i gradini, bussò debolmente alla porta e stremato s'accasciò contro una delle colonne del piccolo portico. Caso volle che in quello stesso momento il signor Giles, Brittles e lo stagnino si stessero rifocillando nella cucina, con tè e pasticcini, dopo le fatiche e i terrori della notte. Non che fosse costume del signor Giles dar confidenze ai servitori di rango inferiore, verso i quali gli era piuttosto consueto assumere un contegno di altera affabilità che, mentre li gratificava, non mancava di rammentar loro la propria superiore posizione sociale. Ma la morte, e anche gli incendi e i furti, rendono gli uomini tutti uguali, sicché il signor Giles sedeva con le gambe allungate sul parafuoco della cucina, col braccio sinistro poggiato sul tavolo mentre il destro coadiuvava la dettagliata e minuziosa ricostruzione del furto, che il suo uditorio (ma specialmente il cuoco e la cameriera, anch'essi del gruppo) ascoltava trattenendo il respiro. «Potevano essere all'incirca le due e mezza», disse il signor Giles, «o forse un po' più vicino alle tre, non potrei giurarlo, quando mi svegliai, e rigirandomi nel letto, grosso modo così - e qui il signor Giles si girò nella sedia tirando a sé l'angolo della tovaglia come si fosse trattato delle coperte - mi parve di sentire un rumore». A questo punto del racconto il cuoco sbiancò e chiese alla cameriera di chiudere la porta; lei, a sua volta, lo chiese a Brittles e questi allo stagnino, il quale fece finta di non aver sentito. «...Mi parve di sentire un rumore», continuò il signor Giles. «Sul momento mi dissi "sarà una mia illusione" e stavo giusto per rimettermi a dormire quando sentii di nuovo quel rumore, distintamente». «Che genere di rumore?», chiese il cuoco. «Una sorta di trambusto», replicò il signor Giles guardando intorno. «Somigliava di più allo stridere di un pezzo di ferro su una grattugia da noce moscata», suggerì Brittles. «Questo, quando l'avete sentito voi, signore!», ribatté il signor Giles. «Ma quando dico io pareva una sorta di trambusto. Tolsi via le coperte», continuò il signor Giles scansando la tovaglia, «mi misi a sedere sul letto e rimasi in ascolto». Il cuoco e la cameriera esclamarono simultaneamente, «Oh Signore!», e accostarono di più le sedie. «Ora potevo sentirlo con estrema chiarezza», riprese il signor Giles. «"Qualcuno", mi dico, "sta forzando una porta o una finestra. Cosa faccio? Devo svegliare Brittles, povero ragazzo, e salvarlo prima che sia trucidato nel suo stesso letto. Capace", mi dico, "che gli taglino la gola da un orecchio all'altro senza che lui neanche se ne accorga"». A questo punto tutti gli occhi si appuntarono su Brittles il quale, rimasto a bocca aperta e con sul viso dipinto un orrore senza limiti, sgranò i propri e li appuntò sul narratore. «Gettai via le coperte», disse Giles togliendosi energicamente di dosso la tovaglia e guardando con durezza il cuoco e la cameriera, «mi alzai piano dal letto, m'infilai un paio...». «Di pantofole, signor Giles», mormorò lo stagnino. «Di scarpe, signore», seguitò Giles volgendosi verso di lui e sottolineando con forza quella parola, «afferrai la pistola carica che portiamo sempre di sopra assieme al cestello dell'argenteria e andai in punta di piedi fino alla sua stanza. "Brittles", dico appena lo sveglio, "Niente paura!"». «È così», osservò Brittles a bassa voce. «Brittles, saremo forse spacciati», continuò Giles, «ma niente paura». «E lui aveva paura?», domandò il cuoco. «Neanche l'ombra», replicò il signor Giles. «Dette prova di fermezza... ah, quasi quanto me». «Sarei morta all'istante se mi ci fossi trovata io, quest'è certo», osservò la cameriera. «Ma voi siete donna», ribatté Brittles riprendendosi un poco. «Brittles ha ragione», disse il signor Giles annuendo in segno di approvazione. «Non ci si può aspettare altro da una donna, ma noi, essendo uomini, prendemmo una lanterna cieca dall'appendiabiti di Brittles e scendemmo le scale a tentoni in una oscurità nera come la pece... più o meno così». Il signor Giles s'era alzato dalla sedia e aveva mosso due passi a occhi chiusi per accompagnare il suo racconto con un'azione appropriata, allorché sussultò violentemente assieme al resto della compagnia e riguadagnò in fretta la sua sedia. Il cuoco e la cameriera strillarono. «Hanno bussato», disse il signor Giles assumendo un'aria di perfetta serenità. «Qualcuno vada ad aprire». Nessuno si mosse. «Molto strano sentir bussare alla porta a quest'ora del mattino», disse il signor Giles osservando il pallore dei volti che lo circondavano, lui stesso bianco come un cencio. «Ma bisogna pur aprire. Qualcuno mi sente, qui?». Così dicendo il signor Giles guardò Brittles ma quel giovane, modesto per natura, si considerava forse un nessuno e quindi ritenne che quella interrogazione non potesse essere rivolta a lui. Ad ogni modo, non offrì nessuna risposta. Il signor Giles rivolse uno sguardo interrogativo allo stagnino, il quale però s'era improvvisamente addormentato. Le donne erano fuori questione. «Se Brittles volesse almeno aprire la porta in presenza di testimoni, io sono pronto ad accompagnarlo», disse il signor Giles dopo un breve silenzio. «E io pure», aggiunse lo stagnino destandosi altrettanto improvvisamente di quando s'era addormentato. A queste condizioni Brittles capitolò e il gruppo, alquanto rassicurato dalla scoperta che fosse ormai pieno giorno (fatta spalancando le imposte della finestra), si avviò di sopra, con i cani innanzi e le due donne, che avevano timore a restare giù, in retroguardia. Su suggerimento del signor Giles, si misero tutti a parlare ad alta voce sì da segnalare, a eventuali malintenzionati all'esterno, il loro cospicuo numero. Inoltre, con una trovata magistrale per sagacia e accortezza partorita dall'ingegnoso cervello del medesimo gentiluomo, acciaccarono la coda ai cani nell'ingresso di casa di modo che abbaiassero forsennatamente. Prese queste precauzioni, il signor Giles si tenne forte al braccio dello stagnino (per impedirgli di scappare, come osservò facetamente) e dette solennemente l'ordine di aprire la porta. Brittles obbedì e tutti, facendo timidamente capolino da dietro le spalle degli altri, contemplarono uno spettacolo non più terribile del povero, piccolo Oliver, esausto e incapace di parlare, che sollevava gli occhi plumbei e supplicava muto la loro compassione. «Un ragazzo!», esclamò il signor Giles spingendo valorosamente lo stagnino nelle retrovie. «Come sarebbe un...? Caspita, Brittles... guardate... non lo riconoscete?». Brittles, che s'era messo dietro la porta per aprirla, appena vide Oliver cacciò un grido acuto. Il signor Giles, afferrato il ragazzo per una gamba e un braccio - per fortuna non quello rotto - lo trascinò nell'ingresso lasciandolo lungo disteso sul pavimento. «Eccolo!», tuonò Giles su per le scale in un parossismo di agitazione. «Ecco uno dei ladri, signora! È un ladro, signorina! Ferito, signorina! Gli ho sparato io, mentre Brittles faceva luce, signorina». «Con una lanterna, signorina», gridò Brittles accostando la mano a lato della bocca affinché la voce giungesse più chiara. Le donne salirono di sopra per portare la notizia che il signor Giles aveva catturato un ladro e lo stagnino si adoperò a che Oliver riprendesse conoscenza per timore che morisse prima di essere impiccato. In mezzo a tutta questa agitazione e trambusto s'udì una dolce voce femminile che ebbe l'effetto di placarli all'istante. «Giles», sussurrò una voce dalla cima delle scale. «Sono qui, signorina», replicò il signor Giles. «Non spaventatevi. Non ho praticamente ferite. La resistenza opposta non è stata strenua, signorina. L'ho sopraffatto subito da solo». «Shhh!», ribatté la giovane. «Spaventate la zia quasi quanto i ladri. È ferita gravemente quella povera creatura?» «Ferita molto seriamente», replicò Giles con indicibile compiacimento. «Sembra quasi che stia per andarsene, signorina», tuonò come prima Brittles. «Non volete scendere a dargli un'occhiata, signorina, in caso debba veramente andarsene?» «Shhhh! Zitto per favore. Siate buono», interloquì la giovane. «Aspettate un istante mentre vado a parlare con la zia». Con un passo delicato e gentile quanto la voce, la giovane scivolò via per tornare subito con la richiesta che si portasse il ferito di sopra nella stanza del signor Giles con la massima cautela e che il signor Brittles sellasse il pony e corresse immediatamente a Chertsey, da dove doveva subito mandare un sergente e un dottore. «Ma non volete dargli prima un'occhiata, signorina?», domandò il signor Giles, orgoglioso come se Oliver fosse stato un uccello dal raro piumaggio da lui abilmente abbattuto. «Neanche un'occhiata, signorina?» «Per niente al mondo, adesso», replicò la giovane. «Povero piccino! Oh, trattatelo con gentilezza, Giles, fatelo per me!». Con lo sguardo orgoglioso e ammirato, quasi come d'un figlio, il vecchio servitore seguì la giovane mentre s'allontanava. Poi, chinatosi su Oliver, aiutò a portarlo di sopra con la cura e l'attenzione d'una donna. Capitolo XXIX. Con un resoconto introduttivo su chi abitava la casa dove Oliver si rifugiò In una bella stanza, ancorché i mobili avessero l'aria di un conforto antiquato piuttosto che d'una eleganza moderna, accanto a una tavola apparecchiata per una buona colazione, sedevano due signore. Le accudiva il signor Giles, vestito con estrema cura, in abito nero. Egli aveva preso posizione a metà strada tra la dispensa e la tavola, e con il corpo dritto e impettito, la testa all'indietro e inclinata di una inezia da un lato, la gamba sinistra in avanti, la mano destra ficcata nel panciotto e la sinistra al fianco che reggeva un vassoio, sembrava tutto compreso dalla piacevolissima consapevolezza dei suoi meriti e della sua importanza. Delle due signore, una era piuttosto avanzata negli anni, eppure l'alta spalliera della sedia di quercia in cui sedeva non era più dritta di lei. Vestita con la massima cura e precisione, in una curiosa commistione di fogge passate e di lievi concessioni al gusto corrente che sembravano piuttosto sottolineare graziosamente il vecchio stile che non attenuarlo, ella sedeva regalmente con le mani giunte in avanti sul tavolo. I suoi occhi, la cui luminosità gli anni avevano appena appena velato, fissavano attenti la sua giovane compagna. Questa era nel primo fiore della sua leggiadra giovinezza; una giovinezza che, se mai gli angeli, per imperscrutabili disegni divini, dovessero incarnarsi in spoglie mortali, sarebbe da loro scelta a terrena dimora, non meno sacra della celeste. Non aveva ancora compiuto diciassette anni, ed era modellata in forme d'una squisita leggiadria, così soavi e gentili, così pure e belle, che la terra non sembrava il suo elemento né le altre più comuni creature sembravano degne compagne sue. L'intelligenza che sprizzava dagli occhi d'un azzurro intenso e impressa sul nobile viso era troppo viva per la sua età e per questo mondo, e tuttavia la mobile espressione di dolcezza e gaiezza, le alterne luminosità del viso, scevro da ombre, e soprattutto il sorriso gioioso e felice sembravano fatti per la pace del focolare e la beatitudine domestica. Ella era occupata negli ultimi ritocchi alla tavola, e caso volle che sollevasse gli occhi proprio mentre la vecchia signora l'osservava. Con un movimento aggraziato si scostò indietro i capelli che le cadevano sulla fronte e con un solo, radioso sguardo profuse una tale pienezza di affetto e sincero amore che anche gli spiriti celesti, contemplandola, le avrebbero sorriso. «Brittles è partito da più di un'ora, vero?», domandò l'anziana signora dopo una pausa. «Da un'ora e dodici minuti, signora», rispose il signor Giles consultando un orologio d'argento che aveva estratto per mezzo di un nastrino nero. «È sempre lento», osservò l'anziana signora. «È sempre stato lento, fin da quand'era ragazzo», replicò il servitore. E osservando, a proposito, che Brittles era rimasto un ragazzo lento per più di trent'anni, e che non sembrava molto probabile che diventasse mai un campione di sveltezza. «Peggiora invece di migliorare, mi sembra», osservò l'anziana signora. «Sarebbe imperdonabile da parte sua se si fermasse a giocare con altri ragazzi», disse la giovane sorridendo. Il signor Giles stava evidentemente considerando se gli si addicesse indulgere lui stesso in un rispettoso sorriso quando al cancello del giardino venne a fermarsi un calesse. Ne saltò giù un grasso gentiluomo che corse dritto alla porta e che, entrato in casa con una rapidità piuttosto misteriosa, irruppe nella stanza da pranzo, quasi travolgendo il signor Giles e la tavola apparecchiata insieme. «Mai sentita una cosa simile!», esclamò il grasso gentiluomo. «Mia cara signora Maylie... sull'anima mia... e per giunta nel cuore della notte... mai sentita una cosa simile!». Con tali espressioni di condoglianza il gentiluomo strinse le mani a entrambe le donne e, accostando una sedia, chiese loro come stavano. «Potevate morire di spavento, letteralmente morire di spavento», esclamò. «Perché non m'avete mandato a chiamare? Santo cielo, il mio domestico sarebbe arrivato in un minuto e io pure, e anche per il mio assistente - o per chiunque altro, date le circostanze - sarebbe stato un enorme piacere; santo cielo, santo cielo! Così all'improvviso! E poi nel cuore della notte!». Il dottore sembrava particolarmente scosso dal fatto che il tentato furto avesse avuto luogo all'improvviso e per di più nel cuore della notte, come se i ladri fossero gentiluomini e fosse loro consolidata abitudine sbrigare gli affari alla luce del sole, fissando un appuntamento uno o due giorni prima, per posta celere. «E voi, signorina Rose, io...», disse il dottore volgendosi alla giovane. «Oh, assolutamente, è proprio così», disse Rose interrompendolo, «ma ora c'è di sopra quella povera creatura e la zia vi prega di visitarla». «Ah, certo! Senza dubbio», replicò il dottore. «È stata opera vostra, Giles, mi par di capire?». Il signor Giles, febbrilmente occupato a risistemare le tazze da tè, avvampò in viso, e ammise che aveva avuto quell'onore. «Onore, eh?», disse il dottore. «Beh, non lo so. Forse è altrettanto onorevole colpire un ladro in un retrocucina quanto l'avversario in un duello, a dodici passi. Immaginatevi che lui abbia sparato ed è come aver combattuto un duello, Giles». Ritenendo questo trattar la cosa tanto alla leggera un ingiusto tentativo di sminuire la sua gloria, il signor Giles rispose rispettosamente che non toccava a lui giudicare in merito, ma che però l'avversario non sembrava aver voglia di scherzarci sopra. «Dio mio! È vero», disse il dottore. «Dov'è? Fatemi strada. Quando ridiscendo mi fermerò da voi, signora Maylie. Quella è la finestra da cui è entrato, eh? Beh, non l'avrei mai creduto!». Continuando a parlare, salì seguendo il signor Giles; e nel mentre è ancora per le scale il lettore sappia che il signor Losberne, medico chirurgo condotto, conosciuto in un raggio di dieci miglia come "il dottore", era ingrassato più in virtù del suo costante buonumore che per essere buona forchetta, e che era un vecchio scapolo più generoso e cordiale, ancorché eccentrico, di quanti un esploratore vivente possa trovare in un'area cinque volte più estesa. Il dottore rimase di sopra più a lungo di quanto sia lui sia le signore si sarebbero aspettati. Mandò a prendere dal calesse una cassetta piatta e piuttosto ampia; il campanello della camera da letto suonò svariate volte; e i servitori correvano su e giù per le scale: dai quali segni s'inferì giustamente che qualcosa di molto importante stava accadendo di sopra. Alla fine ridiscese, e in risposta all'ansiosa domanda circa lo stato di salute del paziente assunse un'espressione molto misteriosa e chiuse accuratamente la porta. «È una cosa veramente incredibile, signora Maylie», disse il dottore, con le spalle contro la porta come a volerla tenere chiusa. «Non è in pericolo, spero?», disse l'anziana signora. «Beh, questo non sarebbe poi così incredibile date le circostanze», replicò il dottore, «anche se non penso che sia in pericolo. Avete visto il ladro?» «No», rispose l'anziana signora. «Né v'è stato detto niente di lui?» «No». «Perdonatemi, signora», intervenne il signor Giles, «ma stavo per parlarvene io quando è entrato il dottor Losberne». Fatto si è che il signor Giles non si capacitava ancora che il bersaglio a cui aveva sparato altro non era che un ragazzo. Tali erano state le lodi profuse al suo coraggio che neanche a costo della vita avrebbe potuto fare a meno di ritardare la spiegazione anche di pochi, esaltanti minuti, durante i quali egli potesse risplendere glorioso, allo zenit d'una effimera reputazione d'indomito coraggio. «Rose voleva che lo vedessi, ma io non me la sentivo», disse la signora Maylie. «Uhm!», fece il dottore. «Non c'è niente di particolarmente allarmante nel suo aspetto. Avete nulla in contrario a vederlo con me presente?» «Certo che no, se è necessario», replicò l'anziana signora. «Sì, è necessario, credo», disse il dottore. «Ad ogni modo, sono assolutamente sicuro che se rinviaste il momento ve ne pentireste assai, giacché ora riposa assolutamente tranquillo. Permettetemi... signorina Rose, mi consentite? Nessun motivo di temere, sul mio onore». Capitolo XXX. Riferisce ciò che i nuovi ospiti pensavano di Oliver Con ripetute assicurazioni che sarebbero rimaste piacevolmente sorprese dall'aspetto del ladro, il loquace dottore prese a braccetto la giovane, offrì la sua mano libera alla signora Maylie e, cerimonioso e solenne, le condusse di sopra. «Dunque», sussurrò il dottore mentre apriva piano la porta di una stanza da letto, «vediamo cosa ve ne pare. Non s'è rasato di recente, ma ciononostante non ha affatto un aspetto feroce. Ferme un attimo, però! Lasciatemi prima accertare che sia in condizioni di ricevere una visita». Andò innanzi e scrutò nella stanza. Fece segno di entrare, richiuse la porta dietro di loro e scostò delicatamente le tendine del letto. Al che, invece dell'incallito e truce furfante che s'aspettavano di trovare, videro sul letto, spossato dalla sofferenza e dagli stenti, profondamente addormentato, solo un bambino. Il braccio ferito, fasciato e immobile, gli era posato sul petto e la testa era reclina sull'altro braccio, mezzo nascosto dai lunghi capelli che ricadevano sul cuscino. L'onesto dottore resse la tendina per un minuto o due guardando il ragazzo in silenzio. Mentre così osservava il paziente, l'anziana signora gli venne silenziosamente accanto e sedendosi su una sedia a lato del letto scostò i capelli dal viso di Oliver. Poi, si chinò su di lui, e qualche lacrima gli cadde sulla fronte. Il ragazzo si scosse, e sorrise nel sonno, come se questi segni di pietà e compassione avessero ridestato il bel sogno di un amore e di un affetto mai conosciuti, così come una dolce melodia, il mormorio di acque in un luogo silenzioso, il profumo di un fiore, o persino il suono di una parola familiare risvegliano a volte vaghi ricordi di scene non appartenenti a questa vita, le quali, labili come il respiro, paiono giungere da un'esistenza più felice da tempo trascorsa, pur se nessuna operazione volontaria della mente è in grado di richiamarle in vita. «Ma cosa significa questo?», esclamò l'anziana signora. «Questo povero ragazzo non può esser complice di una combriccola di ladri!». «Il vizio dimora in molti bei templi», sospirò il chirurgo richiudendo la tenda. «E chi può escludere che si nasconda anche dietro queste belle forme?» «Ma in così tenera età?», insistette Rose. «Mia cara giovane», ribatté il dottore scuotendo tristemente la testa, «così come la morte, il crimine non è appannaggio esclusivo dei vecchi decrepiti. Alligna anche tra i più giovani e leggiadri». «Ma come potete... oh signore, come potete credere che questo bambino delicato si sia volontari amante associato alla peggiore feccia della società?». Il dottore scosse la testa, come a far intendere che lo riteneva purtroppo possibile; quindi, temendo di poter disturbare il paziente, le invitò a seguirlo in una stanza adiacente. «Ma anche se avesse commesso dei crimini», continuò Rose, «pensate a come è piccolo; pensate che forse non ha mai conosciuto l'amore di una madre o il conforto di una casa e che le percosse e i maltrattamenti, o la mancanza di pane possono averlo spinto a unirsi a uomini che l'hanno costretto al male. Zia, zia cara, per carità, pensate a questo prima di consegnare questo piccino ammalato al carcere, dove tutte le sue speranze di ravvedimento sarebbero definitivamente sepolte. Oh, se mi volete bene - e sapete che la vostra bontà e affetto mai mi fecero sentire priva dei genitori che pure tanto mi sono mancati, o derelitta e senz'altro aiuto al mondo, come è questo povero bambino - abbiate pietà di lui prima che sia troppo tardi». «Mia cara bambina», disse l'anziana signora stringendosi al seno la ragazza in lacrime, «pensi che sarei capace di torcergli anche un solo capello?» «Oh no!», si affrettò a rispondere Rose. «No», echeggiò l'anziana signora con il labbro tremante. «I miei giorni volgono al termine, e perciò spero nella misericordia divina, se ne ho io per il prossimo. Cosa posso fare per salvarlo, dottore?» «Lasciatemi pensare, signora», rispose quello. «Lasciatemi pensare». Il signor Losberne si ficcò le mani in tasca e andò su e giù parecchie volte per la stanza, spesso fermandosi per sollevarsi sulla punta dei piedi e aggrottare severamente la fronte. Dopo diverse esclamazioni di "Ci sono" e "No, non ci sono", ogni volta riprendendo a camminare in su e in giù e aggrottando la fronte, d'un tratto si fermò dichiarando: «Se mi date carta bianca per mettere del sale sulla coda a Giles e quell'altro ragazzo, Brittles, penso di riuscirci. È un vostro vecchio e fedele servitore, lo so, ma voi avete mille modi per consolarlo e anche ricompensarlo della sua buona mira. Avete qualche obiezione a questo?» «Se non c'è altro modo per salvare il ragazzo...», replicò la signora Maylie. «Non c'è», replicò il dottore. «Non c'è, ve lo dico io». «Allora mia zia vi dà carta bianca», disse Rose piangendo e ridendo a un tempo, «ma vi prego di non essere più duro dello stretto necessario con quei due poveretti». «Forse credete che tutti siano decisi a esser duri verso gli altri quest'oggi, a parte voi, signorina Rose. Spero soltanto, per la gioventù di sesso maschile in genere, che il primo giovane degno che faccia appello alla vostra compassione vi trovi in uno stato d'animo tenero e vulnerabile; anzi vorrei essere io quel giovane per approfittare all'istante di questa favorevolissima opportunità». «Voi siete un altro ragazzo cresciuto, come Brittles», replicò Rose arrossendo. «Bene», fece il dottore ridendo di cuore. «Non è affatto improbabile. Ma per tornare al ragazzo, c'è ancora un punto cruciale da definire per il nostro accordo. Fra un'ora o due si sveglierà, credo, e sebbene io abbia raccomandato a quella testa di legno dello sceriffo, giù, che non va portato via né interrogato per non metterne la vita a repentaglio, penso che noi potremo parlargli un po' senza pericolo. Ora, vi propongo questo patto: io l'esaminerò in vostra presenza e se ciò che dirà vi dimostrerà, a mente fredda, che egli è un vero reprobo e furfante incallito (cosa altamente probabile), lo abbandoneremo al suo destino e, almeno da parte mia, non mi intrometterò ulteriormente». «Oh, no, zia», interloquì Rose. «Oh, sì, zia», ribatté il dottore. «D'accordo?» «È impossibile che sia malvagio», fece Rose. «È impossibile». «Benissimo», ribatté il dottore. «A maggior ragione va accettata la mia proposta». Stabilirono infine l'accordo e le parti interessate si misero sedute ad aspettare, con una certa impazienza, che Oliver si svegliasse. La pazienza delle signore era destinata ad essere messa a più dura prova di quanto il dottor Losberne avesse loro anticipato, poiché le ore passavano, una dopo l'altra, e Oliver continuava a dormire sodo. S'era fatta sera, in verità, prima che il buon dottore recasse loro la notizia che finalmente era tornato in sé e s'era ripreso abbastanza per poter sostenere un colloquio. Il ragazzo stava ancora molto male ed era estremamente debole a causa del sangue perduto, ma tale era la sua ansia di rivelare qualcosa che il dottore ritenne più conveniente lasciargli quella opportunità piuttosto che insistere affinché restasse tranquillo fino al giorno dopo, come avrebbe altrimenti fatto. Fu un lungo colloquio, poiché Oliver raccontò loro tutta la sua storia e dovette spesso interrompersi per le fitte di dolore e la debolezza. Fu qualcosa di commovente e solenne ascoltare in quella stanza buia la voce fievole del ragazzo ferito raccontare tutto il triste catalogo dei crimini e delle nefandezze a cui uomini malvagi l'avevano trascinato. Oh! Se opprimendo e corrompendo i nostri simili ponessimo mente appena ai neri effetti dell'errore umano già provati, che si addensano in alto come pesante nuvolaglia lentamente, è vero, ma non per questo meno inesorabilmente - per piombarci poi sul capo a darci la loro ricompensa; se, nella nostra immaginazione, dessimo soltanto un istante ascolto alle testimonianze di uomini defunti, che nessun potere può tacitare e nessun orgoglio può scacciare, cosa accadrebbe delle offese e delle ingiustizie, delle sofferenze e dell'infelicità, delle crudeltà e dei torti che ciascun giorno della nostra vita reca con sé! Quella sera il cuscino di Oliver fu accarezzato da mani gentili, e bellezza e virtù vegliarono mentre lui, addormentato, sentiva una tale calma e felicità che avrebbe potuto morire senza un gemito. Questo cruciale colloquio s'era appena concluso e Oliver s'era riaddormentato quando il dottore, asciugatisi gli occhi umidi - del che dava la colpa a un improvviso affaticamento - scese giù per affrontare il signor Giles. Non trovando però nessuno dalle parti del salotto, pensò che avrebbe potuto ottenere risultati migliori in cucina, e lì si recò. In quella camera bassa del parlamento domestico erano riuniti le serve, il signor Brittles, il signor Giles, lo stagnino (che aveva ricevuto la regalia di un invito speciale valevole per tutto il resto del giorno in considerazione dei suoi servigi) e lo sceriffo. Questo, dotato d'un enorme bastone, d'una enorme testa, d'un corpo massiccio e di grossi scarponi, a giudicare dall'aspetto, pareva aver ingerito una quantità di birra proporzionata alle sue dimensioni; e così era, in effetti. Si discuteva ancora delle avventure della notte precedente, poiché quando entrò il dottore, il signor Giles spaziava sulla sua presenza di spirito e il signor Brittles, con un boccale di birra chiara in mano, confermava ogni cosa ancor prima che il suo superiore aprisse bocca. «Sedete», l'invitò il dottore con un gesto della mano. «Grazie signore», fece il signor Giles. «Le signorine desideravano un poco di birra, e siccome non mi sentivo incline a restarmene nella mia stanza e desideravo piuttosto la compagnia, son venuto qui a berne un goccio assieme a loro». Un basso mormorio di Brittles espresse la gratificazione che le signore e i signori indistintamente sentivano per la condiscendenza del signor Giles. Il signor Giles girò intorno lo sguardo con aria di magnanima superiorità, come a voler dire che, finché si comportavano bene, non aveva alcun motivo per togliere loro la sua benevolenza. «Come sta il malato stasera, signore?», chiese il signor Giles. «Così e così», replicò il dottore. «Ma riguardo a questo, temo che vi siate cacciato in un brutto pasticcio, signor Giles». «Non vorrete dire che è in fin di vita, spero, signore», disse tremando il signor Giles. «Se l'avessi sulla coscienza non potrei più sentirmi felice. Io non sparerei a dei ragazzi, signore, nemmeno a Brittles, neanche per tutto l'oro dell'Inghilterra». «Non è questo il punto», fece il dottore misteriosamente. «Siete cristiano, signor Giles?». «Sì, signore, lo spero bene», balbettò il signor Giles sbiancando. «E voi, cosa siete, ragazzo?», disse il dottore rivolgendosi improvvisamente a Brittles. «Il cielo m'aiuti, signore», ribatté Brittles sussultando. «Lo stesso del signor Giles, signore». «Allora ditemi questo, tutt'e due», fece il dottore, «tutt'e due! Ve la sentite di assumervi la responsabilità di giurare che il ragazzo di sopra è lo stesso che è stato fatto passare dalla finestrella la notte passata? Forza, su! Dite! Stiamo aspettando». Il dottore, da tutti considerato una delle persone più miti al mondo, pose la domanda in un tono così serio e minaccioso che Giles e Brittles, già poco lucidi a causa della birra e dell'eccitazione, si guardarono l'un l'altro sconcertati. «Di grazia, attenzione alla risposta, sceriffo», ammonì il dottore agitando gravemente l'indice, col quale si picchiettò poi sulle narici, come a voler sollecitare il massimo acume da parte di quel degno ufficiale. «Ci saranno delle conseguenze, di qui a poco». Lo sceriffo assunse l'aria più perspicace che poteva e riprese il bastone d'ordinanza rimasto indolentemente appoggiato all'angolo del camino. «Tutto dipende dalla identificazione, badate bene», disse il dottore. «Esattamente, signore», replicò lo sceriffo tossendo violentemente poiché aveva trangugiato in fretta la birra e parte di questa gli era andata giù per la strada sbagliata. «Da un lato abbiamo il tentato furto in una casa», chiari il dottore, «e un paio di persone intravedono per un istante un ragazzo tra il fumo di un colpo sparato e la confusione dell'allarme e dell'oscurità; dall'altra abbiamo un ragazzo che il giorno dopo bussa a quella stessa casa, e poiché ha il braccio fasciato, questi due uomini lo agguantano - mettendo la sua vita a repentaglio - e giurano trattarsi del ladro. Ora la domanda è se il loro comportamento è giustificato dai fatti e, se no, in che posizione questi uomini si sono cacciati?». Lo sceriffo annuì solennemente. Se non era materia penale quella, avrebbe voluto sapere quale altra lo era. «Ripeto la domanda», tuonò il dottore. «Siete assolutamente certi di poter identificare il ragazzo, sotto solenne giuramento?». Brittles guardò incerto il signor Giles, e il signor Giles guardò incerto Brittles; lo sceriffo portò la mano all'orecchio per meglio sentire la risposta; le due donne e lo stagnino si protesero in ascolto; e il dottore volse intorno uno sguardo inquisitivo, quando improvvisamente s'udì il suono di un campanello al cancello e, contemporaneamente, uno sferragliare di ruote. «È la celere!», esclamò Brittles visibilmente sollevato. «La che?», esclamò il dottore stupefatto a sua volta. «Gli agenti di Bow-street, signore», replicò Brittles prendendo una candela, «stamattina io e il signor Brittles li abbiamo mandati a chiamare». «Cosa?», esclamò il dottore. «Sì», replicò Brittles. «Ho affidato un messaggio al postiglione, e mi chiedevo come mai non fossero ancora arrivati, signore». «Ah sì, eh? Che il diavolo vi si... si porti le carrozze di posta lente, ecco tutto», disse il dottore andandosene. Capitolo XXXI. Implica una situazione critica «Chi è?», chiese Brittles socchiudendo l'uscio con la catena agganciata e affacciandosi, mentre con la mano schermava la candela. «Aprite», replicò uno di fuori. «Siamo gli agenti di Bow-street che avete mandato a chiamare stamane». Parecchio sollevato da questa assicurazione, Brittles spalancò la porta e si trovò di fronte ad un uomo ben piantato, in paltò, che entrò senza aggiungere altro e si pulì tranquillamente le scarpe sul tappeto come se fosse stato a casa sua. «Mandate qualcuno ad aiutare il mio collega al calesse per rigovernare il cavallo; volete, giovanotto?», disse l'agente. «Avete costì una rimessa dove si possa lasciarlo cinque o dieci minuti?». Rispondendo Brittles affermativamente e indicato un edificio, quel massiccio individuo tornò al cancello del giardino e aiutò il collega a metter dentro il calesse, mentre Brittles faceva loro luce, assolutamente estasiato. Ciò fatto, rientrarono in casa, e i due agenti, condotti in un salotto si tolsero cappotti e cappelli e si mostrarono così com'erano. L'uomo che aveva bussato alla porta era un tipo ben piantato, di media altezza, di circa cinquantanni, capelli neri lucenti tagliati cortissimi, mezzi basettoni, un faccione tondo e occhi appuntati. L'altro era un tipo ossuto, coi capelli rossi e stivali, un'espressione piuttosto sgradevole e un naso inquietante, con la punta all'insù. «Mi fate il favore di informare il comandante, qua, che ci sono Blathers e Duff?», disse quello ben piazzato ravviandosi all'ingiù i capelli e posando un paio di manette sul tavolo. «Oh, buona sera, capo. Permettete una parola o due a quattr'occhi, per favore?». Questo fu detto al signor Losberne entrato proprio in quel momento. Il quale gentiluomo, accennando a Brittles di lasciarli, fece entrare le due donne e chiuse la porta. «Questa è la padrona di casa», disse il signor Losberne indicando la signora Maylie. Il signor Blathers fece un inchino. Invitato a sedere, posò il cappello a terra e, presa una sedia, accennò al collega di fare lo stesso. Il secondo, che non sembrava altrettanto abituato alla buona società o che non ci si sentiva altrettanto a suo agio - l'una o l'altra delle due cose - sedette assai teso e contratto, ficcandosi il pomo del bastone in bocca, in manifesto imbarazzo. «Ora, per quanto riguarda questo furto, capo», disse Blathers, «quali sono i particolari?». Il signor Losberne, che sembrava ansioso di guadagnar tempo, glieli riferì, dilungandosi parecchio, mentre i signori Blathers e Duff, assunta un'aria professionale, si scambiavano di tanto in tanto un cenno. «Naturalmente non posso pronunciarmi con sicurezza finché non esamino il posto», disse il signor Blathers, «ma la mia opinione è che... e non temo di sbilanciarmi troppo... è che non è opera d'un villano, eh Duff?» «Certamente no», replicò Duff. «E volendo tradurre la parola villano a beneficio delle signore, mi par di capire che secondo voi il tentato furto non è opera di uno di qua?», disse il signor Losberne sorridendo. «Proprio così, capo», replicò Blathers. «E per quanto riguarda il furto questo è tutto, non è vero?» «È tutto», replicò il dottore. «Ora, cos'è questo ragazzo di cui parla la servitù?», domandò Blathers. «Ah, niente», rispose il dottore. «Qualcuno di loro per lo spavento s'è messo in testa di collegarlo al tentativo di furto in casa; ma è assurdo; totalmente privo di senso». «Se è così sarà una bazzecola provarlo», osservò Duff. «Giustissimo», confermò Blathers con cenni di assenso e giocherellando con le manette come se fossero un paio di castagnette. «Chi è il ragazzo? Che storia vi ha raccontato? Da dove viene? Non sarà mica caduto dalle nuvole, nevvero capo?» «Certamente no», replicò il dottore con uno sguardo nervoso alle due signore. «So tutta la sua storia; ne parleremo subito. Ma prima vorrete esaminare il luogo dove i ladri hanno tentato lo scasso, penso?»«Certamente», interloquì il signor Blathers. «Meglio dare prima un'occhiata al posto e poi ci occuperemo della servitù, secondo la procedura». S'andarono a prendere dei lumi e i signori Blathers e Duff, accompagnati dalla guardia locale, Brittles, Giles e, in breve, da tutti gli altri, si recarono nella stanzetta in fondo al corridoio ed esaminarono la finestrella; quindi girarono dietro la casa passando per il prato e guardarono attraverso la finestrella dall'altra parte; poi si fecero passare una candela per poter ispezionare le imposte; poi ancora una lanterna per seguire le impronte, dopodiché si fecero dare una forca per affondarla nei cespugli. Fatto questo, con gli astanti che trattenevano il respiro dalla curiosità, rientrarono in casa e il signor Giles e il signor Brittles ebbero modo di esibirsi in una melodrammatica rappresentazione della parte da loro avuta nelle avventure della notte precedente. La replicarono sei volte, contraddicendosi l'un l'altro in non più d'un aspetto importante la prima volta e in non più d'una dozzina l'ultima. Arrivati a questo punto, i signori Blathers e Duff lasciarono la stanza ed ebbero un lungo colloquio, al cui confronto, per segretezza e solennità, il consulto di luminari della medicina sui punti più spinosi della loro scienza sarebbe sembrato un gioco da ragazzi. Frattanto, il dottore passeggiava molto nervosamente su e giù nella stanza accanto e la signora Maylie e Rose tradivano una espressione ansiosa. «Parola mia», fece fermandosi improvvisamente dopo parecchi, frenetici su e giù, «non so proprio cosa bisogna fare». «Di certo, se ripetiamo fedelmente a questi signori la storia di quel povero piccolo, lo scagioneremo senz'altro». «Ne dubito, mia cara giovane», disse il dottore scuotendo la testa. «Non credo che sarà sufficiente a scagionarlo, né ai loro occhi né a quelli di funzionari di più alto grado. Di chi si tratta, dopo tutto, direbbero? Di un fuggiasco. Per come vanno le cose al mondo, e in base alla mera probabilità, la sua storia non è affatto convincente». «Ma certo voi ci credete?», interruppe Rose. «Io ci credo, per quanto strana sia, e forse sembrerò tanto più pazzo per questo», riprese il dottore. «Ma non credo che sia esattamente una storia che possa soddisfare un ufficiale di polizia d'una certa esperienza». «Perché no?», chiese Rose. «Perché, mia cara inquisitrice», replicò il dottore, «perché dal loro punto di vista contiene molti punti oscuri, e lui può provare solo circostanze imputabili a suo danno; viceversa, neanche una che vada a suo favore. Accidenti a loro, vorranno sapere il perché e il percome di tutto, e non daranno niente per scontato. Vedete, per sua stessa ammissione è stato in una banda di ladri qualche tempo fa, ed è comparso innanzi a un magistrato di polizia con l'accusa di aver rubato dalla tasca di un signore; è stato rapito di forza dalla casa di quel signore e condotto in un luogo che non può né indicare né descrivere, né ha la più pallida idea di dove all'incirca possa trovarsi; è stato portato a Chertsey da persone che in qualche modo si sono incapricciate di lui, checché ne dica; ed è stato fatto passare in casa attraverso la finestra; e poi, proprio quando sta per dare l'allarme, e cioè l'unica cosa che lo avrebbe riscattato di tutto, ecco che si intromette un maggiordomo inferocito e ignorante e gli spara, quasi apposta per impedirgli di scagionarsi. Non capite?» «Naturalmente, capisco», replicò Rose sorridendo alla foga del dottore. «Però continuo a non vederci nulla che possa incriminare il povero ragazzo». «No», replicò il dottore. «Certo che no! Benedetti gli occhi del vostro sesso! Nel bene o nel male, vedono sempre soltanto un lato della questione e cioè sempre quello che si presenta per primo». Manifestata questa summa della sua esperienza, il dottore si infilò le mani in tasca e camminò su e giù per la stanza ancor più freneticamente di prima. «Più ci penso», disse il dottore, «più vedo che mettere questi uomini al corrente della vera storia del ragazzo ci porterà infinite complicazioni e difficoltà. Sono certo che non la crederanno vera e anche se alla fine non gli faranno nulla, il trascinare a lungo la cosa esponendo alla pubblica piazza tutti i punti oscuri che sussistono a riguardo non potrà non interferire sostanzialmente con la vostra benevola intenzione di salvarlo dalla condanna». «Oh, che dobbiamo fare?», esclamò Rose. «Santo cielo. Perché li hanno mandati a chiamare?» «Già! Perché?», esclamò la signora Maylie. «Non avrei voluto averli qui per niente al mondo». «Tutto quello che so», disse infine il signor Losberne sedendosi con una sorta di calma disperata, «è che dobbiamo cercare di uscirne fuori usando la faccia tosta, ecco tutto. Il motivo è più che buono, e questo ci scuserà. Il ragazzo ha i sintomi di una febbre molto alta e non è nelle condizioni di sostenere un altro colloquio; questo va a nostro favore. Dobbiamo sfruttare questa situazione per il meglio, e se il meglio in questo caso coincide col peggio non è colpa nostra. Entrate!». «Ebbene, capo», disse Blathers entrando nella stanza seguito dal collega e chiudendo bene la porta prima di dire altro. «Non c'è traccia di basista». «E cosa diavolo vuol dire basista?», domandò il dottore spazientito. «Un furto col basista, signore», disse Blathers rivolgendosi a loro come se compatisse la loro ignoranza ma avesse in disprezzo quella del dottore, «è quando c'è implicata la servitù». «Ma nessuno ha sospettato di loro in questo caso», disse la signora Maylie. «Possibilissimo, signora», replicò Blathers, «ma nondimeno, pure la possibilità che fosse implicata restava». «Anzi, a maggior ragione perché nessuno li sospetta», disse Duff. «È la mano di un ladro cittadino, pensiamo», disse Blathers continuando il suo rapporto, «giacché lo stile è di prim'ordine». «Un lavoretto pulito davvero», osservò Duff in tono più sommesso. «Sono stati in due», continuò Blathers, «e avevano con sé un ragazzo, il che risulta dalla dimensione della finestra. Questo è tutto ciò che si può dire al momento. Dunque, vediamo subito questo ragazzo che sta di sopra, se permettete». «Forse vorranno prima prendere qualcosa da bere, signora Maylie?», disse il dottore col viso che gli s'illuminò come se gli fosse venuta qualche nuova idea. «Oh, certamente», esclamò subito Rose. «Vi porto subito qualcosa, se lo gradite». «Beh, molte grazie, signorina!», disse Bill passandosi la manica del cappotto sulla bocca. «Questo mestiere fa venire la gola secca. Qualsiasi cosa abbiate a portata di mano, signorina. Non datevi troppa briga per noi». «Cosa desiderate?», chiese il dottore seguendo la giovane alla dispensa. «Una goccia di liquore, capo, fa lo stesso», replicò Blathers. «È una bella sgroppata da Londra a qui al freddo, signora, e un liquore riscalda sempre i sentimenti, a mio avviso». Questa interessante opinione fu comunicata alla signora Maylie, che l'accolse molto graziosamente. Nel mentre, il dottore scivolava fuori dalla stanza. «Ah!», disse il signor Blathers, reggendo il bicchiere a calice non dallo stelo ma dalla base, stretta tra il pollice e l'indice della mano sinistra, e accostandoselo al petto, proprio in mezzo. «Tempo fa, ho seguito parecchi lavoretti di questo tipo, signore». «Quel furto con scasso nel vicolo di Edmonton, Blathers», fece il signor Duff venendo in aiuto alla memoria del collega. «Già, fu un lavoretto sulla falsariga di questo, non è vero?», interloquì il signor Blathers. «È stata opera di Conkey Chickweed, è stata». «Hai sempre pensato che ci fosse il suo zampino», replicò Duff. «Ma è stato Family Pet, ti dico. Conkey non c'entrava più di quanto ci entrassi io». «Ma va là!», replicò il signor Blathers. «So quel che dico. E ti ricordi di quella volta, quando rubarono a Conkey? Che storia, quella lì! Meglio di qualsiasi romanzo in commercio!». «Cos'è accaduto?», domandò Rose, ansiosa di favorire ogni indizio di buonumore negli indesiderati ospiti. «È stato un furto, signorina, che nessun altro tranne Chickweed avrebbe potuto tentare», disse Blathers. «Dunque questo Conkey Chickweed...». «Conkey significa ficcanaso, signora», s'intromise Duff. «Naturalmente la signora lo sa bene, non è vero?», ribatté il signor Blathers. «Interrompi in continuazione, collega! Dunque questo Conkey, signorina, teneva una taverna sulla via di Battlebridge, e aveva una cantina dove ci andavano parecchi giovanotti della nobiltà a vedere i combattimenti di galli e le gare coi cani per snidare i tassi, e così via, e tutti questi divertimenti mettevano alla prova l'intelligenza, ve lo dico io che li ho veduti spesso. A quel tempo non era ancora uno della confraternita, e una notte fu derubato di trecentoventisette ghinee in una borsa di tela che gli fu soffiata dalla stanza da letto nel cuore della notte da uno spilungone con una benda su un occhio che s'era nascosto sotto il letto, che poi dopo aver commesso il furto saltò fuori dalla finestra che era solo al primo piano. Sbrigato il lavoro in un batter d'occhio. Però anche Conkey è stato svelto perché, svegliato da qualche rumore, è saltato giù dal letto, gli ha sparato dietro col fucile a canne mozze e ha dato l'allarme al vicinato. Organizzarono subito un bell'inseguimento, e quando esaminarono i dintorni trovarono che Conkey aveva colpito il ladro, giacché c'erano tracce di sangue fino a una staccionata poco lontano, dove si perdevano definitivamente. Comunque sia, quello se la squagliò col bottino, e di conseguenza il nome di Chickweed, oste patentato, apparve sulla «Gazette» tra altre vittime di bancarotta, e s'organizzarono ogni sorta di collette e sottoscrizioni e non so cos'altro, per quel pò ver'uomo, e lui si sentiva a terra a motivo del furto e per tre o quattro giorni andò su e giù per le strade strappandosi i capelli con tanta disperazione che molti avevano paura che volesse farla finita con la vita. Un giorno arrivò tutto trafelato alla stazione di polizia, ed ebbe un colloquio privato col magistrato, il quale, dopo molto confabulare, suona il campanello, fa venire Jem Spyers (Jem è un agente in gamba) e gli dice di accompagnare il signor Chickweed ad arrestare l'uomo che gli aveva rubato in casa. "Spyers, l'ho visto passare davanti casa mia ieri mattina", disse Chickweed. "Perché non l'hai bloccato subito?", domandò Spyers. "Perché ero così sorpreso, all'improvviso, che son rimasto di stucco", rispose il poveretto. "Però lo prenderemo sicuramente perché ieri notte, tra le dieci e le undici, è ripassato di nuovo". Non appena sentì questo, Spyers si mise in tasca qualche capo di biancheria pulita e un pettine e partì spedito, andandosi a piazzare dietro le tendine rosse di una delle finestre della locanda, ma col cappello in testa pronto a scattar fuori al minimo preavviso. Stava fumando la sua pipa lì, a tarda notte, quando d'un tratto sente gridare Chickweed "Eccolo! Al ladro! Assassino!". Jem Spyers si precipita fuori e vede Chickweed correre in mezzo alla strada sgolandosi. Spyers parte all'inseguimento, Chickweed corre innanzi; la folla si volta, tutti che gridano "Al ladro!" e lo stesso Chickweed, tutto quel tempo, continua a gridare come un ossesso. Spyers lo perde di vista un istante mentre svolta l'angolo; svolta a tutta velocità anche lui, vede una piccola folla, ci si fionda in mezzo, "Chi è?". "Accidenti!", risponde Chickweed, "l'ho perduto di nuovo". Incredibile, ma non ce n'era più traccia da nessuna parte, sicché tornarono alla locanda e l'indomani Spyers riprese il suo posto dietro le tendine, aguzzando lo sguardo in cerca di uno spilungone con una benda, finché non gli dolsero gli occhi un'altra volta. Alla fine non potè fare a meno di chiuderli un istante per dar loro un po' di sollievo ma in quel preciso momento sente Chickweed gridare "Eccolo!". Si precipita di nuovo fuori, con Chickweed già avanti a lui lungo la strada e dopo una corsa due volte più lunga di quella del giorno prima, di nuovo perdono le tracce! Questo si ripetè una o due volte ancora, finché una metà del vicinato cominciò a diffondere la voce che il signor Chickweed era stato derubato dal diavolo, e che questo si divertiva ora a giocargli brutti scherzi; secondo l'altra metà invece il povero Chickweed era impazzito dal dolore». «E che disse Jem Spyers?», domandò il dottore che era rientrato nella stanza subito dopo l'inizio del racconto. «Jem Spyers», riprese l'agente, «non disse neanche una parola per parecchio tempo ma ascoltava ogni cosa senza darlo a vedere, il che mostra che sapeva il fatto suo. Una mattina però entrò nella locanda e prendendo la sua tabacchiera da fiuto fece: "Chickweed, ho scoperto chi ha commesso il furto". "Sì?", disse Chickweed. "Oh, caro Spyers, lascia che mi vendichi e poi muoio contento! Oh, mio caro Spyers, dov'è quel farabutto?". "Via!", disse Spyers offrendogli una presa di tabacco, "poche storie! Sei stato tu". Era stato lui, in effetti, e ci aveva ricavato pure un bel gruzzolo, e nessuno l'avrebbe mai scoperto, per giunta, se non avesse avuto le fregole di seminare falsi indizi!», disse il signor Blathers posando il suo bicchiere e facendo tintinnare le manette. «Davvero molto curioso», osservò il dottore. «Ora, vogliamo salire di sopra?» «Se voi volete, signore», ribatté il signor Blathers, e tallonando il signor Losberne i due agenti salirono nella stanza da letto di Oliver, col signor Giles che precedeva il gruppo reggendo una candela. Oliver sonnecchiava, ma sembrava che fosse peggiorato rispetto a prima, e che la febbre fosse salita. Assistito dal dottore riuscì a sedere sul letto per un minuto o due guardando gli estranei senza avere la minima idea di cosa stesse succedendo, anzi, sembrando non ricordare neanche dove fosse o cosa fosse accaduto. «Questo», disse il signor Losberne parlando a voce bassa ma ferma, «questo è il ragazzo che è stato ferito accidentalmente da un fucile piazzato contro i cacciatori di frodo quando è sconfinato nel campo di come si chiama, qui dietro, come son soliti fare i ragazzi. Quando poi stamani ha bussato qui per essere soccorso è stato immediatamente agguantato e maltrattato da quel perspicace gentiluomo con la candela in mano che ha messo la sua vita a repentaglio, come posso certificare in virtù della mia competenza di medico». I signori Blathers e Duff guardarono il signor Giles fatto oggetto della loro attenzione, e l'esterrefatto maggiordomo guardò prima loro, poi Oliver, e poi il signor Losberne, con una espressione di paura e sgomento alquanto comica. «Non vorrete negarlo, suppongo?», disse il dottore riadagiando delicatamente Oliver nel letto. «L'ho fatto a fin di bene... a fin di bene, signore!», rispose Giles. «È certo... è certo che con loro c'era un ragazzo». «Bene! E siete ancora fermo nella vostra convinzione?», domandò Blathers. «Quale convinzione?», replicò Giles, con uno sguardo assente. «Siete ancora convinto che si tratti dello stesso ragazzo, zuccone?», ribatté il signor Blathers spazientito. «Non lo so. Davvero non lo so», disse Giles accigliato. «Non potrei giurarci». «Ma cosa pensate?» «Non so cosa pensare», replicò il povero Giles. «Non credo che sia lo stesso ragazzo; anzi, sono quasi sicuro che non è lo stesso. Voi sapete che non può essere». «Quest'uomo ha forse bevuto, signore?», domandò Blathers rivolgendosi al dottore. «Che prezioso zuccone siete!», disse Duff rivolgendosi al signor Giles con supremo disprezzo. Durante questo breve dialogo il signor Losberne aveva controllato il polso del paziente, ma a quel punto si alzò dalla sedia accanto al letto e osservò che se gli agenti avevano ancora dubbi sulla faccenda forse preferivano recarsi nella stanza adiacente per interrogare Brittles. Raccogliendo il suggerimento, si aggiornarono nella stanza accanto dove fu convocato il signor Brittles, il quale si impelagò in un così meraviglioso labirinto di nuove contraddizioni e impossibilità in relazione al suo superiore da non gettar luce su nient'altro che non il proprio abbaglio, fatta salva l'ammissione che non avrebbe saputo riconoscere il ragazzo neanche se l'avesse avuto in quel momento innanzi agli occhi, e che aveva creduto si fosse trattato di Oliver solo perché l'aveva detto il signor Giles, e che cinque minuti prima, in cucina, il signor Giles stesso aveva cominciato a manifestare il serio timore d'essere stato un po' troppo avventato nelle sue conclusioni. Tra le altre ingegnose ipotesi, si sollevò anche la questione se il signor Giles avesse effettivamente colpito qualcuno e da un esame comparativo con la pistola gemella di quella che aveva sparato si scoprì che la sua carica si limitava a polvere da sparo e pallini di carta da imballaggio, scoperta che fece notevole impressione su tutti tranne il dottore, che circa dieci minuti prima ne aveva tolto la pallottola. Su nessuno tuttavia fece più impressione di quanta ne fece sullo stesso signor Giles il quale, avendo sofferto per ore nella convinzione di aver ferito mortalmente un suo simile, s'attaccò prontamente a questa idea e la sposò appieno. Alla fine gli agenti, senza darsi eccessivo pensiero di Oliver, lasciarono nella casa lo sceriffo di Chertesy e si cercarono un alloggio per la sera in città con la promessa che sarebbero tornati l'indomani. L'indomani, giunse la voce che due uomini e un ragazzo erano stati fermati a Kensington e avevano passato la notte sotto custodia per circostanze sospette. A Kensington, dunque, i signori Blathers e Duff si diressero. Poiché però dopo qualche indagine le circostanze sospette si rivelarono consistere soltanto nell'essere stati scoperti addormentati in un pagliaio; la qual cosa, sebbene di per sé costituisca un crimine, è passibile soltanto di detenzione, e agli occhi clementi della legge inglese, nel suo vasto amore per tutti i sudditi del re, non è ritenuta, in assenza di ulteriori indizi, prova sufficiente che colui o coloro che avevano dormito illegalmente avessero commesso anche un furto con scasso e si fossero perciò resi passibili di condanna a morte, i signori Blathers e Duff fecero ritorno sapendone non più di quanto sapevano quand'erano arrivati. In breve, dopo qualche ulteriore esame e molto discutere, un magistrato del posto fu presto convinto ad accettare la malleveria congiunta della signora Maylie e del signor Losberne che Oliver sarebbe comparso davanti al giudice se convocato, e Blathers e Duff, compensati con un paio di ghinee, tornarono in città con opinioni discordanti in merito alla loro missione, il secondo dei due, dopo uno scrupoloso vaglio di tutte le circostanze, incline a credere che il tentativo di furto era stato opera di Family Pet e il primo propenso piuttosto ad attribuirne tutto il merito al grande Conkey Chickweed. Nel frattempo Oliver andava gradualmente riprendendosi sotto le cure congiunte della signora Maylie, di Rose e del buon Losberne. Se le fervide preghiere che sgorgano da cuori colmi di gratitudine sono mai udite in cielo - ma, in caso contrario, che preghiere sono! le benedizioni che il ragazzo invocò su di essi scesero giù nell'animo loro, spandendo pace e contentezza. Capitolo XXXII. Sull'inizio di vita felice di Oliver con i suoi buoni amici Le sofferenze di Oliver non erano né poche né lievi. Oltre al dolore causatogli dal braccio rotto, c'era la febbre alta portatagli dalla sua prolungata esposizione al freddo e alla pioggia, che gli restò addosso per molte settimane riducendolo al lumicino. Ma poco a poco cominciò a migliorare, e fu infine in grado di esprimere con poche parole e qualche lacrima la propria gratitudine alle due signore per la loro bontà, e quanto ardentemente sperasse, una volta guarito e rimessosi in forze, di poter fare qualcosa per dimostrargliela; appena qualcosa, per mostrare loro tutto il suo affetto e la sua devozione, qualcosa che, pur trascurabile di per sé, provasse che la loro bontà non era andata perduta, ma che il ragazzo che il loro spirito di carità aveva salvato dalla miseria, se non addirittura dalla morte, era ansioso di servirle, con tutto il suo cuore. «Povero piccino!», esclamò Rose quando un giorno Oliver tentò di esprimere tutte le parole di gratitudine che gli affioravano sulle labbra pallide. «Avrai tante occasioni per esserci d'aiuto, se vorrai. Fra poco andremo in campagna, e mia zia desidera che tu venga con noi. Il luogo tranquillo, l'aria pura, e tutte le bellezze e le amenità della primavera ti ridaranno salute in pochi giorni, e ci potrai aiutare in tantissimi modi, se te la sentirai». «Se me la sentirò!», esclamò Oliver. «Oh! Cara signora, se solo potessi lavorare per voi; se solo potessi darvi piacere annaffiando i vostri fiori, curando i vostri uccellini, o correndo su e giù tutto il giorno al vostro servizio, darei non so che cosa!». «Non dovrai dar nulla», disse la signorina Maylie sorridendo, «perché come già t'ho detto ci potrai aiutare in cento modi diversi, e se avrai cura di darci la metà del piacere che hai promesso, ci renderai davvero felici». «Felici, signora!», esclamò Oliver. «Come siete buona a dir così!». «Mi renderai più felice di quanto possa esprimere», replicò la giovane. «Pensare che la mia cara zia sia stata lo strumento per la salvezza di qualcuno da una vita miserevole come quella che ci hai descritto sarebbe già una soddisfazione inesprimibile; ma sapere che l'oggetto della sua bontà e compassione le è perciò sinceramente grato e affezionato mi riempirebbe di gioia, più di quanto tu possa immaginare. Mi capisci?», domandò, notando il volto pensoso di Oliver. «Oh, sì, signora, sì!», replicò il ragazzo con trasporto. «Stavo solo pensando a come sono ingrato, proprio ora». «Ingrato a chi?», domandò la giovane. «A quel signore buono, e a quella cara governante che con tanta bontà si son presi cura di me», riprese Oliver. «Ma se sapessero come sono felice, anche loro sarebbero contenti, ne sono sicuro». «Ne sono sicura anch'io», disse l'amica di Oliver. «E il signor Losberne è stato già così gentile da promettere che non appena sarai in grado di affrontare il viaggio ti porterà a trovarli». «Davvero, signora?», esclamò Oliver col volto che gli si illuminava di piacere. «Non so cosa farò per la gioia quando rivedrò i loro volti buoni!». In poco tempo Oliver si ristabilì abbastanza da poter sopportare la fatica di quel viaggio, sicché un giorno, accompagnato dal signor Losberne, partì in una carrozza a due di proprietà della signora Maylie. Quando giunsero al ponte di Chertsey, Oliver impallidì di colpo e gridò dalla sorpresa. «Cos'ha questo ragazzo», chiese il dottore, con la sua solita foga. «Hai visto, udito, o sentito qualcosa, eh?» «Là, signore!», gridò Oliver indicando fuori dal finestrino. «Quella casa!». «Sì? E allora? Ferma, conducente. Accostate qui», gridò il dottore. «Che ha quella casa, eh, giovanotto?» «Il ladri! È dove m'hanno portato i ladri», bisbigliò Oliver. «Corpo del diavolo!», esclamò il dottore. «Ehilà, fatemi scendere!». Ma prima che il conducente potesse smontare da cassetta, egli era riuscito non si sa come a precipitarsi fuori della carrozza, e raggiunto quell'edificio abbandonato cominciò a scalciare alla porta come un pazzo furioso. «Ehilà!», fece un ripugnante ometto gobbo aprendo la porta così improvvisamente che il dottore, con lo slancio dell'ultimo calcio, finì quasi per cadere nel corridoio. «Cosa succede?» «Cosa succede?», esclamò il dottore afferrandolo alla gola senza pensarci un istante. «Diverse cosette. È un furto, succede!». «E succederà pure un omicidio», replicò il gobbo senza scomporsi, «se non mi levi le mani di dosso. Mi senti?» «Ti sento», disse il dottore scrollandolo energicamente. «Dov'è... accidenti a quel furfante, come si chiama... Sikes, ecco. Dov'è Sikes, mariolo che non sei altro?». Il gobbo sgranò gli occhi dalla meraviglia e dall'indignazione e, liberatosi con una mossa scaltra dalla presa del dottore, gli ringhiò addosso una bordata di terribili bestemmie e si ritirò in casa. Prima che potesse chiudere la porta però il dottore, senza altri preamboli, era entrato nel corridoio. Si guardò intorno agitato: nessun articolo del mobilio, nessun indizio d'una qualsiasi cosa, animata o inanimata, nemmeno la posizione degli stipi, corrispondeva alla descrizione di Oliver! «Allora», fece il gobbo che l'aveva osservato attentamente, «cosa significa questo entrare di forza a casa mia? Vuoi derubarmi, o vuoi uccidermi? Quale delle due cose?» «Hai mai visto qualcuno con tali intenzioni andarsene in giro in una carrozza a due cavalli, vecchio vampiro scimunito?», disse l'irascibile dottore. «Allora cosa vuoi?», domandò il gobbo. «Te ne vuoi andare, prima che t'accarezzi le ossa, dannazione?» «Quando lo riterrò opportuno», replicò il signor Losberne guardando nell'altro salottino che, come il precedente, non corrispondeva affatto alla descrizione di Oliver. «Un giorno o l'altro ti aggiusto io, amico». «Davvero?», ghignò il ripugnante sciancato. «Se hai bisogno di me mi trovi qui. Non ho campato da solo come un pazzo recluso per venticinque anni solo per farmi impaurire da te. Te la farò scontare, te la farò scontare». E così dicendo quel demonietto storpio lanciò un grido acuto e si mise a saltellare sul posto come pazzo di rabbia. «Ridicolo», borbottò il dottore tra sé. «Il ragazzo dev'essersi sbagliato. Tieni! Intasca questo e richiuditi dentro». Con queste parole gettò una moneta allo storpio e tornò alla carrozza. L'uomo lo seguì fino allo sportello, imprecando e bestemmiando come un forsennato, ma quando il signor Losberne si voltò per parlare al conducente gettò l'occhio all'interno della carrozza e scrutò Oliver con un'espressione così attenta e seria, e al tempo stesso così stravolta e vendicativa, che, sveglio o addormentato, il ragazzo non potè dimenticarlo per parecchi mesi. Continuò a lanciare i più terribili improperi finché il conducente non risalì al suo posto, e quando furono partiti lo videro in lontananza picchiare i piedi in terra e strapparsi i capelli in un accesso di follia. «Sono un asino!», esclamò il dottore dopo un lungo silenzio. «Te ne eri già accorto, Oliver?» «No, signore». «Allora non te ne dimenticare, un'altra volta». «Un asino», ripetè il dottore, dopo qualche minuto di silenzio ancora. «Anche se fosse stato quello il posto, e dentro ci fossero stati i ladri, cosa avrei potuto fare, da solo? E anche con l'aiuto di qualcuno, non avrei ottenuto risultato migliore del farmi scoprire e del dover ammettere che avevo colpevolmente tenuta nascosta questa faccenda. Ma me lo sarei meritato, perché mi caccio sempre in qualche guaio agendo secondo il primo impulso; e mi sarebbe stato di lezione». Ora, è un fatto che in tutta la sua vita quell'eccellente dottore non aveva mai agito altrimenti, e non depone per nulla a sfavore della natura di quell'impulso che lo dominava il fatto che, lungi dall'essersi tirato addosso guai o sventure particolari, egli godesse del rispetto e della stima più profonda da parte di tutti coloro che lo conoscevano. A dire il vero, per un minuto o due aveva perso le staffe nel disappunto di non aver potuto trovare le prove della veridicità della storia di Oliver alla prima occasione che gli si era presentata. Subito si ricompose, però, e vedendo che le risposte di Oliver alle sue domande erano sempre immediate e coerenti, e come sempre sembravano franche e sincere, decise di dar loro, di lì in poi, totale credito. Poiché Oliver sapeva il nome della strada in cui abitava il signor Brownlow, poterono recarvisi immediatamente e quando la carrozza svoltò nella strada il cuore gli batté così violentemente che riusciva appena a respirare. «Dunque, ragazzo mio, qual è la casa?», chiese il signor Losberne. «Quella! Quella!», rispose Oliver affrettandosi ad indicare fuori dal finestrino. «La casa bianca. Oh! Svelto! Svelto, vi prego! Mi sento come morire e tremo tutto». «Su, su!», disse il buon dottore con qualche colpetto sulla spalla. «Li vedrete subito, ed essi non staranno in sé dalla gioia quando vedranno te sano e salvo». «Oh! Lo spero!», esclamò Oliver. «Sono stati così buoni con me, così buoni». La carrozza accostò e si fermò. No. Non era quella, la casa. La prossima. Avanzò ancora qualche metro e si fermò di nuovo. Oliver guardò alle finestre, con lacrime d'impaziente attesa che gli scendevano sul viso. Ahimè! La casa era disabitata, e c'era un cartello alla finestra: «Affittasi». «Bussa all'altra porta», esclamò il dottor Losberne prendendo sotto braccio Oliver. «Sapete per caso dove si trovano i signori che abitavano nella casa a fianco?». Il servitore non sapeva, ma sarebbe andato a chiedere. Tornò immediatamente, con la notizia che il signor Brownlow aveva venduto i suoi beni ed era partito per le Indie sei mesi prima. Oliver si strinse le mani, sentendosi mancare. «Anche la governante ha lasciato la casa?», chiese il signor Losberne dopo un istante. «Sì, signore», replicò l'altro. «Il vecchio gentiluomo, la governante, e un altro signore amico del signor Brownlow; sono andati via assieme». «Allora si torna a casa», disse il signor Losberne al conducente. «E senza fermarsi a foraggiare i cavalli finché non ci siamo lasciati alle spalle questa dannata Londra!». «E il libraio, signore?», replicò Oliver «So la strada per arrivarci. Andiamoci, signore, vi prego!». «Caro piccino mio, abbiamo avuto già abbastanza delusioni per oggi», disse il dottore. «Abbastanza delusioni, tutti e due. Se andassimo da questo libraio, sicuramente troveremmo che è morto, o che gli è bruciata la casa, o che è scappato. No, subito a casa, via!». E obbedendo all'impulso del dottore, partirono diretti a casa. Quest'amara disillusione addolorò parecchio Oliver pur nella sua nuova felicità, poiché tante volte durante la sua malattia gli era stato di consolazione il pensiero di ciò che il signor Brownlow e la signora Bedwin gh' avrebbero detto, e di quanta gioia avrebbe provato a raccontar loro dei lunghi giorni, e notti, passati a ricordare ciò che essi avevano fatto per lui, e a dolersi di quella crudele separazione. Nelle recenti, dure prove che egli aveva sostenuto, la speranza di poter infine spiegar loro tutto, di raccontare come fosse stato rapito gli aveva dato conforto e coraggio; e ora, l'idea che essi fossero andati così lontano, persuasi ormai che egli fosse un ladro e un impostore - e nulla, forse, fino alla morte, avrebbe contraddetto quella persuasione -, questa idea gh era quasi insopportabile. Quella circostanza tuttavia non alterò in nulla la disposizione dei suoi benefattori verso di lui. Quando furono trascorse altre due settimane circa e iniziò il bel tempo, e su ogni albero e ogni fiore spuntavano tenere foglioline e boccioli, fecero i loro preparativi per lasciare la casa di Chertsey per qualche mese. Affidata quell'argenteria che aveva suscitato la cupidigia dell'ebreo alla custodia di una banca e affidata a Giles e ad un altro domestico la custodia della casa, partirono per una casetta di campagna a qualche distanza portando Oliver con loro. Chi può descrivere la gioia e il piacere, la pace dell'animo e la dolce tranquillità che il ragazzo sentì in quell'aria salubre, tra le verdi colline e i meravigliosi boschi d'un villaggio di campagna! Chi può dire come scene di pace e tranquillità possano penetrare nell'animo dei tormentati abitanti di luoghi angusti e rumorosi, e come la loro freschezza possa trasfondersi nei loro cuori affranti! Uomini che hanno vissuto tutta una vita d'affanni in strade chiuse e affollate senza desiderio di mutar condizione; uomini per i quali l'abitudine è divenuta come una seconda natura e che son giunti quasi ad amare ciascun singolo mattone e pietra con cui è delimitato lo stretto confine dei loro passi giornalieri, persino coloro sui quali incombeva l'artiglio della morte, si dice abbiano agognato un ultimo sguardo allo spettacolo della Natura e, portati lontano dalle scene delle loro sofferenze e dei loro piaceri, pare siano entrati all'istante in una nuova condizione, e giorno dopo giorno, trascinandosi a stento per raggiungere qualche luogo ameno, verde e soleggiato, alla semplice contemplazione del cielo, delle colline, dei prati, dell'acqua luccicante, si sono ridestate in loro tali memorie che quella sorta di anticipazione del cielo ha lenito il loro rapido declino, ed essi sono scesi nella tomba placidamente, come il sole, il cui tramonto avevano contemplato dalla finestra della loro stanza solitaria appena qualche ora prima, quasi sfocasse alla loro debole vista! Le memorie richiamate a noi dalle tranquille scene della campagna non sono di questo mondo, come non lo sono le speranze e i pensieri che vi si associano. La loro benigna influenza può insegnarci a intrecciare fresche ghirlande per la tomba di coloro che abbiamo amato; può render più puri i nostri pensieri, cancellando al loro cospetto vecchi odi e rancori. Ma al di là di tutto questo, persino nella mente meno consapevole, rimane il senso, pur vago e indistinto, di aver albergato questi pensieri da tempi immemori; e questo evoca solenni pensieri d'un lontano tempo a venire, e vince ogni orgoglio e attaccamento al mondo. S'erano ritirati in un luogo incantevole. Oliver, i cui giorni erano trascorsi in mezzo a squallide folle, in mezzo al frastuono e ai litigi, sembrò entrare in una nuova esistenza. La rosa e il caprifoglio s'arrampicavano lungo i muri della casetta; l'edera s'abbarbicava attorno al tronco degli alberi, e i fiori profumavano l'aria di odori deliziosi. Vicinissimo, c'era un piccolo cimitero, in cui non si vedevano alte e sgradevoli lapidi affastellate, ma dimessi tumuli, coperti d'erba fresca e di muschio, sotto i quali riposavano in pace i defunti del villaggio. Qui Oliver si aggirava spesso, e a volte, pensando alla tomba in cui giaceva sua madre, sedeva e piangeva non visto. Quando però levava gli occhi al cielo profondo che lo sovrastava non pensava più a lei come sepolta nella terra, e piangeva sì per lei tristemente, ma senza dolore. Fu un tempo felice. I giorni trascorrevano tranquilli e sereni; le notti, non chiuso in una squallida prigione né in compagnia di ladri sciagurati, non portavano né affanni né angosce; nient'altro se non pensieri quieti e belli. Ogni mattina andava a trovare un vecchio dai capelli bianchi che viveva presso la chiesetta e che gli insegnava a leggere e scrivere parlandogli con tale gentilezza e prendendosi tale cura di lui che Oliver non poteva non fare del suo meglio per compiacerlo. Dopo faceva una passeggiata con la signora May lie e con Rose e le sentiva discutere di libri; oppure sedeva accanto a loro in qualche angoletto ombroso e ascoltava la giovane mentre leggeva - cosa di cui ormai sarebbe stato capace anch'egli - finché era possibile distinguere le lettere. Dopo, c'erano i compiti per l'indomani da svolgere, ed egli vi si applicava con passione, in una stanzetta che guardava sul giardino, finché non scendeva la placida sera: allora le signore uscivano di nuovo, e lui con esse, e ascoltava con tale piacere tutto quanto dicevano, ed era così felice quando desideravano un fiore che poteva cogliere per loro arrampicandosi, o quando avevano dimenticato qualcosa che poteva correre a prendere, che eseguiva tutto in un baleno. Quando faceva proprio buio e tornavano a casa, la giovane sedeva al piano e suonava qualche aria melodiosa o cantava soavemente a bassa voce qualche vecchia canzone che piaceva alla zia. In tali occasioni non si accendevano candele e Oliver sedeva, estasiato di quella musica, presso una delle finestre. E quando veniva la domenica, come diversamente la trascorreva rispetto al passato, e quanto più felicemente, come tutti gli altri giorni di quel tempo felice! Al mattino si recava nella chiesetta, con le verdi foglie che ondeggiavano alle finestre, gli uccelli che cantavano di fuori, e l'aria soave e profumata che si spandeva ovunque dal basso porticato, riempiendo tutto il rustico edificio della sua fragranza. Quella povera gente era così composta e decorosa e s'inginocchiava con tale ardore nella preghiera che il loro ritrovarsi in chiesa sembrava un piacere, non un tedioso dovere; e benché il canto riuscisse stonato, era però vero e suonava più armonico, all'orecchio di Oliver almeno, di quanti ne avesse mai sentiti prima in chiesa. E poi c'erano le consuete passeggiate, e le numerose visite alle linde dimore dei contadini; e a sera Oliver leggeva un capitolo o due dalla Bibbia, di quelli studiati nella settimana: un dovere che egli espletava sentendo più piacere ed orgoglio che se fosse stato lui il parroco. Al mattino, Oliver era già fuori per le sei, esplorando i campi in lungo e in largo e saccheggiando le siepi per fare mazzolini di fiori selvatici; ne tornava carico a casa, e qui poneva la massima cura nel disporli per adornare al meglio il tavolo della colazione. Portava anche fresche erbette per gli uccellini della signorina Maylie, con le quali, avendo studiato la materia sotto la competente guida del segretario del villaggio, decorava le gabbie nel gusto più raffinato. Quando gli uccellini erano lindi e azzimati per la giornata, l'attendevano le piccole opere di carità da eseguire nel villaggio; o, in mancanza di quelle, qualche rara partita a cricket sul prato; oppure, c'erano le tante cosette da fare in giardino, o attorno alle piante, alle quali Oliver, avendo studiato anche quella scienza sotto lo stesso maestro, che era un giardiniere esperto, si applicava col massimo impegno e con la massima dedizione, finché non sopraggiungeva Rose che spandeva lodi a profusione sul suo operato. Trascorsero tre mesi, tre mesi che sarebbero stati di imperturbata felicità anche per i più fortunati dei mortali, ma che per Oliver furono di autentica beatitudine. Con la più pura e amabile generosità da un lato, e la più sincera e sentita gratitudine dall'altro, non c'è da meravigliarsi se, alla fine di quel breve periodo, Oliver era divenuto assolutamente devoto all'anziana signora e alla nipote, e se il fervido attaccamento del suo cuore giovane e sensibile era ampiamente ricompensato dall'orgoglio e dall'affetto che esse provavano per lui. Capitolo XXXIII. Dove la felicità di Oliver e dei suoi amici è bruscamente interrotta Rapida passò la primavera e subito venne l'estate e se il villaggio era stato bello già prima, era adesso nel pieno splendore della sua lussureggiante ricchezza. I grandi alberi, che erano parsi così nudi e spogli nei mesi precedenti, erano ora nel pieno della vita e del vigore e allargando le loro verdi braccia sulla terra assetata trasformavano aride chiazze in invitanti angoletti d'ombra fitta e piacevole, dai quali godere la vista di ampie prospettive immerse nella luce del sole, a perdita d'occhio. La terra vestiva il suo mantello del verde più luminoso e spandeva intorno i suoi ricchi profumi. Era la vigorosa giovinezza dell'anno, e ogni cosa aveva un aspetto lieto e fiorente. Nella nostra casetta continuava la stessa vita quieta e chi l'abitava godeva della stessa gaia serenità. Da tempo Oliver aveva riacquistato salute ed energie, ma la salute o la malattia non avevano alcuna influenza - come invece tanto spesso accade - sui sentimenti che provava verso chi gli stava accanto. Egli era sempre la stessa creatura gentile, affezionata e devota che era stata quando il dolore e la sofferenza l'avevano lasciato privo di forze e quando per ogni minimo sollievo e conforto era totalmente dipendente da chi l'assisteva con tanto amore. Una bellissima sera avevano camminato più a lungo del solito, poiché quel giorno era stato insolitamente caldo e poiché una vivida luna splendeva in cielo e s'era levata una brezza particolarmente rinfrescante. Anche Rose era stata di ottimo umore ed essi avevano continuato a camminare in allegra conversazione, proseguendo molto oltre i loro limiti consueti. Poiché la signora Maylie era stanca tornarono a casa più lentamente. Qui la giovane, togliendosi soltanto la semplice cuffia, si sedette al piano come al solito, e dopo aver eseguito distrattamente delle scale a salire e scendere per alcuni minuti, attaccò un'aria mesta e molto solenne, suonando la quale la si udì singhiozzare, come se piangesse. «Rose, mia cara!», esclamò l'anziana signora. Rose non rispose nulla, ma suonò con un poco più di brio, come se le parole l'avessero destata da qualche pensiero doloroso. «Rose, tesoro!», esclamò la signora Maylie alzandosi rapidamente e chinandosi su di lei. «Cosa c'è? Piangi! Mia cara bambina, cosa ti turba?» «Niente, zia, niente», replicò la giovane. «Non so cosa sia. Non so descriverlo, ma mi sento...». «Non ti sentirai male, mia cara?», interloquì la signora Maylie. «Oh no! No, non mi sento male!», replicò Rose proprio allora rabbrividendo, come invasa da un gelo mortale. «Starò subito meglio. Chiudete la finestra, vi prego». Oliver s'affrettò ad obbedire. La giovane, con un visibile sforzo per tornare alla sua gaiezza consueta, provò a suonare qualche aria più vivace. Le dita però rimasero inerti sulla tastiera sicché, nascondendosi il volto tra le mani, si lasciò cadere sul divano e versò lacrime che non riusciva ormai a trattenere. «Figlia mia!», disse l'anziana signora cingendola tra le sue braccia. «Non t'avevo mai veduta così prima d'ora». «Non avrei voluto agitarvi se fosse stato in mio potere evitarlo», interloquì Rose, «ma non mi è possibile. Temo proprio di star male, zia». E così era, in effetti, perché quando portarono le candele videro che nel breve tempo trascorso da quando erano tornate a casa aveva perduto ogni colore, e il viso era bianco come il marmo. Non che fosse scomparsa la bellezza; ma era una bellezza diversa, con un'ansia e un'angoscia mai conosciute prima visibili sul volto gentile. Un minuto dopo avvampò e una sorta di fuoco soffocato sembrò accendere i dolci occhi azzurri. Poi anche questo svanì, come l'ombra gettata da una nuvola fuggevole, e tornò di nuovo mortalmente pallida. Oliver, che scrutava con attenzione l'anziana signora, osservò che ella sembrava allarmata da quegli indizi, e per la verità lo era lui stesso, ma vedendo che lei cercava di non mostrarlo, seguì il suo esempio, riuscendovi a tal punto che quando Rose fu convinta dalla zia a ritirarsi per la notte era già più sollevata e sembrava persino star meglio, e assicurava tutti che sicuramente il giorno dopo si sarebbe alzata completamente ristabilita. «Spero che non abbia nulla», disse Oliver quando la signora Maylie tornò. «Non aveva un bell'aspetto stasera, ma...». Con un cenno l'anziana signora gl'intimo di non parlare e sedendosi in un angolo buio della stanza rimase lì in silenzio per un po'. Infine, con voce rotta dall'emozione disse: «Spero di no, Oliver. Sono stati anni molto felici, questi pochi trascorsi con lei; troppo felici, forse. Forse ci toccherà qualche sventura, adesso, ma spero che non debba...». «Cosa?», domandò Oliver. «Sopportare un colpo così tremendo come quello di perdere la cara fanciulla che per tanto tempo è stato il mio conforto e la mia felicità», disse l'anziana signora. «Oh, Dio non voglia!», esclamò Oliver. «Così sia, bambino mio!», disse l'anziana signora giungendo le mani. «Ma certo non c'è pericolo d'una cosa tanto terribile?», chiese Oliver. «Due ore fa stava bene». «Ora sta molto male», affermò la signora Maylie, «e peggiorerà, ne sono sicura. Mia cara, cara Rose! Oh, come potrei vivere senza di lei!». E sfogò una pena così profonda che Oliver, soffocando le proprie emozioni, osò rimproverarla e la supplicò, proprio per amore della giovane, di calmarsi. «Pensate, signora», disse Oliver mentre le lacrime gli sgorgavano dagli occhi nonostante cercasse di trattenerle. «Pensate quanto è giovane e buona, e quanta gioia e conforto ella dà a chi le sta vicino. Son sicuro... certo, assolutamente certo... che per amor vostro e della vostra bontà, per amor suo e per amore di tutti coloro che ella rende felici, non morirà. Il cielo non permetterà che muoia così giovane». «Zitto!», disse la signora Maylie posandogli una mano sul capo. «Questo può crederlo un bambino, ragazzo mio. Comunque, mi rammenti i miei doveri. Per un momento me ne ero dimenticata, Oliver, ma spero di essere perdonata, perché sono vecchia e perché ho visto tante malattie, tante morti, e conosco il dolore della perdita delle persone che amiamo. Ho visto anche abbastanza per sapere che spesso non le migliori e le più giovani sono risparmiate per chi le ama. Ma questo dovrebbe darci conforto nel nostro dolore, poiché il cielo è giusto, e c'insegna così che c'è un mondo più splendido di questo, e che dobbiamo presto passare dall'uno all'altro. Sia fatta la volontà di Dio! Il cielo sa quanto bene le voglio!». Oliver fu sorpreso al vedere che, mentre diceva queste parole, la signora Maylie dovette soffocare un gemito, e che, subito riprendendosi, tornò di nuovo ferma ed energica. Ancora più sorpreso fu al vedere che quella fermezza non l'abbandonò più, e che rimase vigile e pronta nell'estremo bisogno di vegliare e di assistere, assolvendo ai compiti - che, sapeva, toccavano a lei sola di buon animo e, a giudicare dalle apparenze, perfino allegramente. Ma era soltanto un bambino, e non sapeva ancora di cosa sono capaci spiriti forti in circostanze di gravità eccezionale. E come avrebbe potuto saperlo, quando così spesso essi per primi lo ignorano? Seguì una notte di angoscia, e al mattino le previsioni della signora Maylie s'erano, purtroppo, puntualmente avverate. A Rose era scoppiata una febbre altissima, e la sua vita era in pericolo. «Dobbiamo reagire, Oliver, e non rassegnarci al dolore», disse la signora Maylie accostando un dito alle labbra mentre lo guardava con espressione grave. «Questa lettera deve essere spedita al signor Losberne prima possibile. Bisogna portarla in città, a non più di quattro miglia da qui, prendendo il sentiero attraverso la campagna e di là, con un corriere espresso, al galoppo fino a Chertsey. Qualcuno della locanda accetterà l'incarico, e so di poter fare totale affidamento su di te affinché tutto vada a buon fine». Oliver non disse nulla, ma si mostrò quanto mai ansioso di partire all'istante. «Qui c'è un'altra lettera», disse la signora Maylie riflettendo un attimo. «Ma non so se spedirla subito o se aspettare di vedere come evolve la malattia di Rose. Vorrei spedirla solo nell'eventualità che peggiori». «Anche questa va consegnata a Chertsey, signora?», chiese Oliver impaziente di eseguire la commissione e protendendo la mano tremante per prendere la lettera. «No», replicò l'anziana signora affidandogliela meccanicamente. Oliver la guardò e vide che era indirizzata al Cav. Harry Maylie, presso qualche villa di campagna aristocratica; ma da che parte fosse non potè capire. «Posso andare, signora?», chiese Oliver impaziente guardandola dal basso in alto. «Meglio di no», replicò la signora Maylie riprendendo la lettera. «Aspetterò sino a domattina per spedirla». Con queste parole consegnò a Oliver la sua borsa ed egli partì senz'altro indugio, a tutta velocità. Corse rapido attraverso i campi e lungo i viottoli che a volte li attraversavano, a tratti quasi nascosto in mezzo al grano alto, a tratti sbucando nella campagna aperta dove i contadini erano intenti al lavoro, falciando e raccogliendo il fieno, né si fermò mai se non per qualche secondo, ogni tanto, giusto per riprender fiato, finché accaldato e tutto coperto di polvere non giunse nella piazzetta del mercato della cittadina. Qui si fermò e guardò intorno cercando la locanda. C'era una banca di colore bianco, una birreria rossa e un municipio giallo e da un canto c'era una grande casa con le travi dipinte tutte di verde innanzi alla quale pendeva l'insegna "The George". Appena la vide, vi si diresse in fretta. Domandò a un postiglione che sonnecchiava sull'uscio e che, sentito ciò che Oliver voleva, lo rinviò allo stalliere il quale, alla stessa richiesta, lo rinviò al proprietario della locanda che era un signore alto con un fazzoletto blu al collo, cappello bianco, pantaloni di panno e stivaloni alti abbinati, appoggiato ad una pompa presso la porta della stalla a piluccarsi i denti con uno stuzzicadenti d'argento. Questo signore si diresse verso il bar a grandi falcate per calcolare il prezzo di tutto, il che prese un bel po' di tempo. Fatto il totale, e dopo esser stato pagato, fece sellare un cavallo e preparare qualcuno, il che prese altri dieci minuti buoni. Frattanto Oliver era in uno stato di tale agitazione e impazienza che quasi avrebbe voluto saltare lui stesso in groppa al cavallo e partire al galoppo, ventre a terra, fino alla stazione successiva. Infine, tutto fu pronto e, ricevuto il pacchetto con molte raccomandazioni e preghiere affinché lo recapitasse con la massima rapidità, l'uomo dette di sprone al cavallo, scalpitò sull'irregolare acciottolato della piazzetta, uscì dalla città, e dopo un paio di minuti circa galoppava lungo la strada a pedaggio. La certezza d'aver mandato a chiedere aiuto senza perder tempo era già qualcosa. Oliver s'affrettò a tornare nel cortile della locanda con cuore più lieve, seppure non di molto, e stava sbucando dal corridoio quando s'imbattè accidentalmente in un uomo alto, avvolto in un mantello, che proprio in quel momento usciva dalla porta della locanda. «Ah!», esclamò quello fissando gli occhi su Oliver e indietreggiando. «Che diavolo significa?» «Vi chiedo scusa, signore», disse Oliver. «Avevo tanta fretta di tornare a casa e non vi ho visto». «Crepa!», borbottò l'uomo tra sé, strabuzzando gli occhi grossi sul ragazzo. «È incredibile! Che lo possano stritolare! Rispunterebbe fuori da un sarcofago di pietra solo per venirmi ancora tra i piedi!». «Mi dispiace», balbettò Oliver, confuso dall'espressione furente dell'uomo. «Spero di non avervi fatto male!». «Un cancro alle tue ossa!», mormorò a denti stretti l'uomo orribilmente sconvolto. «Avessi avuto il coraggio di dire una parola, mi sarei potuto sbarazzare di lui in una notte. Che tu sia maledetto! Ti si schianti il cuore, demonio! Cosa ci fai qui?». L'uomo agitò il pugno e pronunciò queste sconnesse parole tra i denti. Avanzò verso Oliver come con l'intenzione di sferrargli un colpo ma piombò violentemente a terra torcendosi e con la bava alla bocca, in un attacco epilettico. Per un momento Oliver rimase a osservare le convulsioni del pazzo (perché tale gli sembrò) e poi si precipitò dentro a chiedere aiuto. Quando vide che lo trascinavano nella locanda e in buone mani, si volse verso casa correndo più veloce che poteva per riguadagnare il tempo perduto, ricordando con tanto stupore e un poco di paura lo strano comportamento della persona che aveva appena lasciata. Tuttavia non rimase a lungo con quella impressione poiché, raggiunta la casetta, ci fu abbastanza da fare per tenergli occupata la mente e scacciar via completamente dalla memoria ogni considerazione di sé. Rose Maylie si era improvvisamente aggravata e prima di mezzanotte delirava. Uno studente di medicina che risiedeva nei paraggi le era costantemente accanto per assisterla. Questo, dopo aver esaminato la paziente, aveva preso da parte la signora Maylie sentenziando che la natura della malattia era quanto mai pericolosa. «In effetti», disse, «sarebbe poco meno di un miracolo se si salvasse». Quante volte Oliver trasalì sul letto quella notte, e sgusciando fuori con passi felpati fino alle scale rimase in ascolto per cogliere il più lieve rumore dalla stanza della malata! Quante volte fu scosso da un fremito in tutto il corpo! E che fredde gocce di terrore gl'imperlarono la fronte quando un improvviso scalpiccio di passi gli fece temere che fosse accaduta qualcosa di tanto terribile che il pensiero ne era annientato! Cosa era mai il fervore delle preghiere che aveva levato in passato al confronto di quelle che levò allora, nell'angoscia e nel tormento che provava per la vita e la salute di quella gentile creatura sospesa sull'orlo dell'abisso della tomba! L'attesa, la terribile attesa di quando non si può nulla mentre la vita di chi amiamo è sempre più sospesa; la tortura dei pensieri che si affollano in mente e comprimono violentemente il cuore, rendendo il respiro affannoso per le immagini funeree che essi evocano; l'ansia disperata di voler fare qualcosa, e non potere in alcun modo alleviare il dolore o diminuire il pericolo; la prostrazione dell'animo e dello spirito alla rinnovata consapevolezza della nostra impotenza: quali torture possono mai eguagliare queste, e quali pensieri, quali azioni, nel pieno di quell'onda febbrile, possono alleviarle! Venne il mattino, e la casetta era vuota e silenziosa. Le persone parlavano a bisbigli; di tanto in tanto volti ansiosi si facevano vedere al cancello e le donne e i bambini andavano via in lacrime. Per tutto il giorno, e per ore dopo che era sceso il buio, Oliver camminò piano in su e in giù in giardino, ad ogni istante levando gli occhi verso la stanza dell'ammalata, rabbrividendo nel vedere la finestra buia, come se di dentro giacesse la morte. A tarda notte arrivò il signor Losberne. «È doloroso ammetterlo», disse il buon dottore voltandosi da un lato. «Così giovane, così amata... Ma ci sono pochissime speranze». Un altro mattino. Il sole splendeva, luminoso come se non splendesse sulla sofferenza e sugli affanni, e mentre ogni foglia e fiore intorno era in pieno rigoglio, e la vita, la salute, i suoni e i colori della gioia erano sparsi ovunque, la bella creatura giaceva deperendo rapidamente. Oliver cercò l'antico cimitero e sedendosi su uno dei verdi tumuli pianse per lei in silenzio. V'era una tale bellezza e una tale pace in quella scena, una tale luce e gioiosità nel paesaggio assolato, una tale dolcezza melodiosa nel canto degli uccelli dell'estate, una tale libertà e speditezza nel volo degli stormi di corvi che volteggiavano in alto, così tanta vita e gaiezza in tutto, che quando il ragazzo levò gli occhi dolenti per guardarsi intorno, pensò istintivamente che quello non era un tempo di morte, che sicuramente Rose non sarebbe morta quando le cose più umili erano tanto liete e gaie, e che le tombe erano per il freddo e triste inverno, non per la luce del sole e i soavi profumi. Pensò che i sudari erano per i vecchi e che mai avrebbero dovuto avvolgere forme giovani e graziose nelle loro pieghe spettrali. Un triste rintocco della campana della chiesa dissipò questi ingenui pensieri. Un altro! Ancora! Suonava per un servizio funebre. Un gruppo di umili persone in lutto entrò dal cancello portando sugli abiti nastri bianchi perché il morto era giovane. Stettero a capo scoperto accanto alla tomba e in quel corteo piangente c'era una madre, una madre un tempo, eppure il sole splendeva luminoso e gli uccelli continuavano a cinguettare. Oliver s'avviò verso casa pensando alle tante gentilezze che aveva ricevuto dalla giovane e sperando che potesse tornare ancora il tempo in cui avrebbe potuto mostrarle ogni ora quanto le fosse grato e affezionato. Non aveva niente da rimproverarsi quanto ad attenzioni e alle sollecitudini dei suoi pensieri per lei perché era stato devoto e servizievole, eppure gli vennero in mente centinaia di piccole occasioni in cui gli sembrò che avrebbe potuto essere più zelante, più sollecito, e desiderò di esserlo stato. Dobbiamo essere attenti a come ci comportiamo con coloro che ci sono accanto poiché ogni morte porta, alla piccola cerchia dei sopravvissuti, pensieri di così tante omissioni, e di così pochi atti compiuti; di così tante cose dimenticate, e di altrettante cui si sarebbe potuto porre rimedio. Non c'è rimorso tanto profondo quanto quello impotente, e se vogliamo risparmiarci le sue torture, ricordiamocelo in tempo. Quando giunse in casa trovò la signora Maylie seduta nel salottino. A Oliver venne un tonfo al cuore al vederla in quello stato, poiché mai prima ella aveva abbandonato il capezzale della nipote, e tremò al pensiero di quale cambiamento potesse averla allontanata da lì. Apprese che Rose era piombata in un sonno profondo dal quale si sarebbe destata o definitivamente fuori pericolo, oppure per dire loro addio e morire. Per ore sedettero, con l'orecchio teso, non osando dire parola. Il pasto, non consumato, fu portato via, e con sguardi che dicevano di pensieri che erano altrove, guardarono il sole calare sempre più e infine riversare sul cielo e sulla terra i vividi colori che annunciavano la sua dipartita. I loro orecchi tesi colsero un rumore di passi che s'avvicinavano, ed entrambi si precipitarono inconsapevolmente alla porta nel momento in cui entrava il signor Losberne. «Come sta Rose?», esclamò l'anziana signora. «Ditemelo subito! Non ce la faccio, qualsiasi cosa ma non questa incertezza! Oh, ditemelo, in nome del cielo!». «Restate calma», disse il dottore sostenendola. «Calmatevi, cara signora, vi prego». «Lasciatemi andare, in nome di Dio! La mia povera bambina! È morta! Sta morendo!». «No!», esclamò il dottore con foga. «Poiché Egli è buono e misericordioso, ella vivrà per essere per noi una benedizione per tanti anni a venire». La signora cadde in ginocchio e cercò di giungere le mani ma l'energia che così a lungo l'aveva sostenuta l'abbandonò per volarsene al cielo assieme alle sue prime parole di ringraziamento; poi s'accasciò nelle braccia amichevoli protese a raccoglierla. Capitolo XXXIV. Contiene informazioni preliminari relative a un giovane gentiluomo che non arriva mai in scena, e una nuova avventura di Oliver Fu una felicità così grande da esser quasi insopportabile. All'inattesa notizia Oliver rimase come stordito, senza poter né parlare, né piangere, né restare fermo. Era appena in grado di comprendere cosa fosse accaduto, fino a che, dopo una lunga camminata nella placida aria serale, scoppiò in un pianto liberatorio e d'un tratto sembrò svegliarsi alla piena percezione del gioioso cambiamento avvenuto e del quasi insopportabile peso di angoscia che non gli opprimeva più l'animo. Faceva buio rapidamente quando tornò a casa carico di fiori, raccolti con cura particolare per adornarne la camera della malata. Mentre camminava a passo rapido lungo la strada sentì dietro di sé il rumore d'un veicolo che avanzava di gran carriera. Voltatosi, vide che era una carrozza di posta lanciata a gran velocità, e poiché i cavalli andavano al galoppo e la strada era stretta si fermò contro il cancello per lasciarla passare. Mentre gli passava accanto a rotta di collo Oliver intravide un signore in cuffia da notte bianca, il cui volto non gli era sconosciuto, anche se, nel breve istante in cui lo vide, non fu capace di riconoscerlo. Dopo un altro secondo o due vide la cuffia agitata fuori dal finestrino e una voce stentorea urlò al conducente di accostare; e così questo fece, non appena gli riuscì di fermare i cavalli. A quel punto la cuffia ricomparve e la medesima voce chiamò Oliver per nome. «Qui!», esclamò quella voce. «Signorino Oliver, che notizie? La signorina Rose? Signorino O-li-ver!». «Siete voi, Giles?», esclamò Oliver correndo allo sportello della carrozza. Giles agitò di nuovo la cuffia, a preludio di una risposta, quando fu improvvisamente tirato indietro da un giovane che occupava l'angolo opposto della carrozza e che domandò con impazienza che novità ci fossero. «Insomma», esclamò il gentiluomo, «sta meglio o peggio?». «Meglio... molto meglio!», s'affrettò a rispondere Oliver. «Grazie al cielo!», esclamò il gentiluomo. «Ne siete certo?» «Assolutamente, signore», replicò Oliver. «Ha avuto un miglioramento appena poche ore fa, e il signor Losberne dice che è ormai fuori pericolo». Il giovane non disse altro ma, aperto lo sportello, si precipitò di fuori, afferrò Oliver per un braccio e lo condusse in disparte. «Siete proprio sicuro? Non c'è la possibilità che possiate sbagliarvi, ragazzo mio, eh?», chiese il giovane con voce tremante. «Vi prego di non ingannarmi suscitando speranze infondate». «Non lo farei per nulla al mondo, signore», replicò Oliver. «Veramente, potete credermi. Sono le parole del signor Losberne: lei vivrà e sarà una benedizione per tutti, per molti anni ancora. Gliel'ho sentito dire io». Le lacrime gonfiarono gli occhi di Oliver al ricordo della scena che aveva segnato l'inizio di tanta felicità e il giovane girò il viso da un'altra parte restando in silenzio per qualche minuto. A Oliver parve di sentirlo singhiozzare più d'una volta, ma temeva di essere indiscreto ad aggiungere altro - poiché ben poteva intuire la natura dei suoi sentimenti - e così restò in disparte facendo mostra di essere occupato a sistemare il mazzolino di fiori. Tutto quel tempo il signor Giles, con la cuffia da notte bianca, era rimasto seduto sul predellino della carrozza, con i gomiti sulle ginocchia, ad asciugarsi gli occhi con un fazzoletto di cotone blu a pallini bianchi. Che quel bravuomo non avesse simulato le proprie emozioni, a giudicare dagli occhi arrossati, fu ben visibile al giovane quando egli si voltò verso di lui per parlargli. «Penso che fareste meglio a recarvi da mia madre con la carrozza, Giles», disse. «Io preferisco fare una tranquilla passeggiata che mi lasci un po' di tempo prima di vederla. Potete dirle che sto arrivando». «Perdonatemi, signor Harry», disse il signor Giles tentando col fazzoletto di dare una ripulita complessiva al suo aspetto arruffato. «Ma se voleste mandare il ragazzo ad avvertirla ve ne sarei infinitamente grato. Non sarebbe decoroso per me farmi vedere dalle cameriere in questo stato, signore; non avrei più alcuna autorità su di loro». «Bene», ribatté Harry Maylie sorridendo. «Come preferite. Fate in modo che ci preceda con i bagagli, se volete, e venite quindi con noi. Prima però scambiate quella cuffia con un copricapo più adatto o altrimenti ci prenderanno per matti». Rendendosi conto allora del suo abbigliamento sconveniente, il signor Giles afferrò la cuffia e se la ficcò in tasca sostituendola con un cappello di foggia sobria e grave che pescò nella carrozza. Ciò fatto, il postiglione partì e il signor Giles, il signor Maylie e Oliver proseguirono senza fretta. Mentre camminavano Oliver guardava di tanto in tanto il nuovo arrivato con molto interesse e curiosità. Sembrava avere un venticinque anni, ed era di statura media, d'aspetto franco e avvenente, e portamento disinvolto e gradevole. Nonostante tutta la diversità che corre tra la vecchiaia e la giovinezza, tale era la rassomiglianza con l'anziana signora che Oliver non avrebbe avuto eccessive difficoltà ad immaginare la loro parentela anche se egli non si fosse riferito a lei come a sua madre. La signora Maylie stava ansiosamente aspettando il ritorno del figlio quando egli arrivò e l'incontro ebbe luogo non senza una grande emozione da entrambe le parti. «Mamma!», sussurrò il giovane. «Perché non hai scritto prima?» «L'ho fatto», rispose la signora Maylie, «ma poi, ripensandoci, decisi di non spedire la lettera finché non avessi sentito il parere del signor Losberne». «Ma perché», disse il giovane, «perché rischiare che accadesse ciò che stava quasi per accadere? Se Rose fosse... non riesco ora a pronunciare quella parola... se questa malattia fosse finita in altro modo come avresti potuto mai perdonarti? Come avrei potuto essere di nuovo felice?». «Se ciò fosse successo, Harry», disse la signora Maylie, «la tua felicità sarebbe forse svanita, temo, e arrivare qui un giorno prima o un giorno dopo avrebbe avuto poca importanza». «E chi si sarebbe meravigliato se fossi stato infelice, mamma?», interloquì il giovane. «E perché dico "se"?... Infelice sarei stato, mamma, lo sai... lo sai benissimo!». «So che ella merita l'amore più puro e sincero che un cuore di uomo possa donare», disse la signora Maylie; «so che la devozione e la generosità della sua natura chiedono un contraccambio non comune, un affetto profondo e duraturo. Se non ne fossi certa, e se non sentissi anche che le spezzerebbe il cuore se la persona da lei amata cambiasse verso di lei, non mi sarebbe così difficile agire secondo coscienza, e non sentirei tanto strazio nel seguire la condotta suggeritami dal dovere». «Questo è ingeneroso, mamma», disse Harry. «Mi credi ancora un ragazzo che non conosce i propri sentimenti e che fraintende gli impulsi del suo animo?» «Caro figlio mio», replicò la signora Maylie posandogli una mano sulla spalla, «io credo che i giovani abbiano molti impulsi di generosità che non durano, e che tra questi ve ne siano alcuni che, una volta soddisfatti, diventano ancora più fugaci. Credo, soprattutto», disse la signora fissando in viso il figlio, «che se un uomo dotato di entusiasmo, appassionato e ambizioso, prende una moglie con una macchia sul nome, anche se lei non ne ha colpa alcuna, persone ciniche e spregiudicate se ne approfitterebbero sia contro di lei sia contro i suoi figli, e tanto egli avrà fortuna nel mondo tanto egli diverrà oggetto di sorrisi di scherno. Forse, per quanto generosa e buona la sua natura, un giorno egli potrebbe pentirsi del legame contratto in gioventù e lei, sapendolo, soffrirebbe ancor più tormentosamente». «Mamma», disse il giovane con impazienza, «chi agisse così sarebbe un crudele egoista, indegno tanto di chiamarsi uomo quanto di avere in sposa una donna tale». «Così pensi adesso, Harry», replicò la madre. «E sempre lo penserò!», ribatté il giovane. «Il tormento che ho patito in questi ultimi due giorni mi giustifica nell'ammettere francamente la mia passione per lei, una passione che, come ben sai, non nasce né ieri né è stata concepita alla leggera. Il mio cuore è devoto a Rose, dolce e gentile ragazza, come mai cuore fu devoto ad una donna. Non ho nella mia vita pensieri, prospettive, speranze al di fuori di lei e se mi ostacolassi in questo mio desiderio mi strapperesti pace e felicità per gettarle al vento. Mamma, pensaci meglio e pensa meglio a me, e non di sprezzare i miei sentimenti tenendoli, a quanto sembra, in così poco conto». «Harry», disse la signora Maylie, «è proprio perché ho la massima considerazione di cuori sensibili e appassionati che non vorrei vederli feriti. Ma su questo argomento abbiamo detto abbastanza per ora, anzi più che abbastanza». «Lascia che sia Rose a decidere, allora», interloquì Harry. «O spingerai le tue recise opinioni fino al punto da porre ostacoli sul mio cammino?» «No, non fino a questo punto», ribatté la signora Maylie. «Ma vorrei che tu riflettessi...». «Io ci ho riflettuto!», fu l'irritata risposta. «Mamma, sono anni che ci rifletto. Ci ho riflettuto fin da quando ho raggiunto l'età della ragione. I miei sentimenti restano immutati, e sempre lo resteranno, e allora perché dovrei soffrire rinviando il momento di manifestarglieli se ciò non può portare a niente di buono al mondo? No! Prima che io parta da qui, voglio dire tutto a Rose». «Ti ascolterà», disse la signora Maylie. «Qualcosa nella tua espressione vorrebbe quasi avvertirmi che lei mi ascolterà con freddezza, mamma», disse il giovane. «Non con freddezza», interloquì l'anziana signora. «Tutt'altro». «E allora?», incalzò il giovane. «Prova forse qualcosa per un altro?» «No davvero», replicò la madre, «se non m'inganno, il suo affetto è già saldamente rivolto a te. Ciò che volevo dire è questo», riprese l'anziana signora interrompendo il figlio nel momento in cui stava per interloquire. «Prima di arrischiare tutto avventatamente, prima di cedere alle lusinghe delle più alte speranze, rifletti per un momento, figlio caro, sulla storia di Rose e considera quali conseguenze potrà avere sulla sua decisione la consapevolezza di avere oscuri natali, essendo a noi devota con tutto il cuore e con quella perfetta rinuncia di sé che è stata sempre la sua caratteristica in tutte le cose, grandi o piccole che fossero». «Cosa vuoi dire?» «Lascio a te scoprirlo», replicò la signora Maylie. «Devo tornare da lei. Dio ti benedica!». «Ti rivedrò ancora stasera?», s'affrettò a dire il giovane. «Fra poco», replicò la signora. «Non appena esco da Rose». «Le dirai che sono qui?», chiese Harry. «Naturalmente», rispose la signora Maylie. «E le dirai quanto sono stato in ansia, quanto ho sofferto e quanto ardentemente io desideri vederla? Vuoi rifiutarmi questo, mamma?» «No», disse l'anziana signora. «Le dirò tutto». E stringendo affettuosamente la mano del figlio, uscì in fretta dalla stanza. Mentre aveva luogo questo appassionato colloquio, il signor Losberne e Oliver erano rimasti in un angolo della stanza. Il primo tese ora la mano a Harry Maylie, e i due si salutarono con molta cordialità. Quindi, rispondendo alle incalzanti domande del giovane amico, il dottore dette un preciso resoconto della situazione della paziente, del tutto rassicurante e promettente, proprio come le anticipazioni di Oliver l'avevano incoraggiato a sperare, e il tutto non sfuggì alle avide orecchie del signor Giles che faceva mostra di essere occupato con i bagagli. «Avete sparato a qualcosa di particolare recentemente, Giles?», chiese il dottore quando ebbe concluso. «Niente di particolare, signore», replicò il signor Giles arrossendo fino alla radice dei capelli. «Non avete catturato neanche un ladro, né identificato scassinatori?», chiese il dottore. «Niente affatto, signore», replicò il signor Giles con accentuata gravità. «Beh», fece il dottore, «mi spiace sentirlo perché queste cose voi le fate con ammirevole perizia. Di grazia, come sta Brittles?» «Il ragazzo sta benissimo, signore, e vi manda i suoi rispettosi omaggi», disse il signor Giles riprendendo il consueto tono altezzoso. «Bene», disse il dottore. «E dato che siete qui mi sovviene, signor Giles, che il giorno precedente quello in cui sono stato chiamato così precipitosamente, su richiesta della vostra buona padrona, ho eseguito una piccola commissione in vostro favore. Permettete due parole in privato da questa parte, per cortesia?». Il signor Giles si avvicinò compiaciuto e un poco meravigliato, e in un angolo della stanza ebbe l'onore di un breve colloquio a bassa voce col dottore al termine del quale fece una quantità di inchini e si ritirò con passi insolitamente solenni. L'argomento di questa conversazione non fu reso noto in salotto, mentre se ne ebbero subito lumi in cucina poiché il signor Giles andò dritto da quella parte e, dopo aver chiesto un boccale di birra chiara, con un'aria davvero impressionante di solenne mistero annunciò che la padrona s'era compiaciuta di depositare nella cassa di risparmio della città la somma di venticinque sterline a suo esclusivo uso e consumo in considerazione della sua coraggiosa azione in occasione del tentativo di furto. Al che le due serve alzarono braccia e occhi al cielo e manifestarono il timore che il signor Giles avrebbe potuto giustamente inorgoglire, ma il signor Giles, tirando fuori la pettorina merlettata della camicia, replicò «No, no», e che se mai avessero notato in lui segni di altezzosità verso le sue inferiori sarebbe stato loro grato se glielo avessero detto. Si profuse poi in molte altre osservazioni non meno illustrative della sua umiltà, parimenti ricevute con entusiastici applausi, poiché erano per giunta tanto originali e pertinenti quanto lo sono di solito quelle dei grand'uomini. Di sopra, il resto della serata passò allegramente poiché il dottore era di ottimo umore, e per quanto all'inizio Harry Maylie potesse sentirsi stanco e preoccupato non potè resistere alla giovialità di quel buon uomo, la quale si manifestava con una caterva di battute e di ricordi professionali e in una quantità di barzellette, le cose più buffe mai sentite da Oliver, e dunque causa di corrispondente ilarità da parte sua, con palese soddisfazione del dottore che rideva senza riserve di se stesso e faceva ridere Harry altrettanto di cuore per semplice effetto di contagio. Così stettero in compagnia tanto allegramente quanto potevano esserlo in quelle circostanze, ed era notte fonda quando, col cuore lieto e grato, si ritirarono per un riposo che, dopo i dubbi e le attese recenti, era loro quanto mai necessario. Il mattino seguente Oliver si svegliò con cuore lieve e di buon'ora cominciò le sue solite occupazioni, più gioioso e speranzoso di quanto fosse stato nei giorni precedenti. Gli uccellini in gabbia furono di nuovo appesi al loro posto a cantare e ancora una volta si raccolsero i più soavi fiori di campo per allietare Rose con la loro bellezza e fragranza. La malinconia che nei giorni passati, agli occhi velati di tristezza e angoscia del ragazzo, era sembrata calare su ogni cosa, per quanto bella fosse, era adesso svanita come per incanto. La rugiada sembrava brillare più vivida sulle foglie verdi, l'aria sembrava farle stormire con più dolce musica, e perfino il blu del cielo pareva più luminoso: tale è l'influsso che l'animo nostro esercita anche sulle apparenze delle cose attorno a noi. Gli uomini che guardano la natura o i propri simili lamentandosi che tutto è buio e triste hanno ragione, ma quei colori spenti altro non sono che il riflesso dell'amarezza che hanno nel cuore e negli occhi. I veri colori sono delicati e si mostrano a sguardi più limpidi. È degno di nota - e Oliver non mancò di notarlo - che egli non era più solo in quelle spedizioni mattutine. Dopo che in quel primo giorno Hany Maylie incontrò Oliver di ritorno a casa, carico di fiori, fu preso da una tale frenesia di raccoglierne anch'egli e mostrò un tal gusto nel farne mazzolini da superare presto il suo giovane amico. Ma se Oliver era stato sopravanzato su questi punti, egli tuttavia sapeva dove trovare i più belli. Ogni mattina andavano assieme a perlustrare la campagna e riportavano a casa i fiori più freschi e belli. La finestra della giovane era ora aperta, poiché ella amava sentire le ricche brezze estive che la ravvivavano, ma all'interno, poco discosto dal graticcio, c'era sempre, nell'acqua, uno speciale mazzolino che veniva composto con grande cura ogni mattina. Oliver non potè non notare che i fiori appassiti non venivano però mai buttati via benché il portafiori ne avesse sempre di nuovi, né mancò di notare che ogni volta che il dottore scendeva in giardino volgeva invariabilmente gli occhi verso quell'angolo particolare e molto espressivamente annuiva mentre s'avviava alla passeggiata mattutina. Frattanto, i giorni passavano e Rose riacquistava rapidamente salute. Né durante questo tempo Oliver restò ozioso, benché la giovane non fosse ancora uscita dalla sua stanza e non si fossero ancora riprese le passeggiate serali, tranne qualcuna ogni tanto, non lunga, con la signora Maylie. Con raddoppiato zelo seguì le istruzioni dell'anziano gentiluomo e studiò così duramente che egli stesso si stupì dei propri progressi. Fu mentr'era così impegnato che un evento assolutamente imprevisto venne a turbarlo. La stanzetta nella quale si metteva a studiare era al piano tena, sul retro della casa. Era proprio la stanzetta di una casa rustica, con i gelsomini attorcigliati alla finestra a graticcio e abbarbicati al muro dell'edificio, che spandevano soave profumo. Guardava sul giardino, dal quale un cancello si apriva in un praticello; oltre, si estendevano bei prati e boschi. Non c'erano altre abitazioni nei paraggi e la prospettiva che si godeva da lì era molto ampia. Una bella sera, quando già scendevano le prime ombre del crepuscolo, Oliver sedeva vicino a quella finestra, chino sui libri. Era già un po' che studiava, e poiché quel giorno aveva fatto un caldo insolito ed egli si era applicato parecchio, non torna a discredito degli autori di quei libri, chiunque essi fossero, ammettere che, poco a poco, Oliver s'addormentò. A volte ci coglie un tipo particolare di sonno che, mentre sembra impadronirsi del corpo, non libera però la mente dal senso di ciò che le accade intorno e la lascia libera di vagare a proprio piacere. Se definiamo sonno ciò che arreca con sé una pesantezza invincibile, ci priva di forze e determina la totale incapacità di controllo dei nostri pensieri e del movimento, quello di Oliver era sonno. In esso tuttavia noi conserviamo la consapevolezza di ciò che accade intorno a noi e, se in quel mentre noi sogniamo, le parole effettivamente pronunciate, i suoni realmente percepibili si adeguano con sorprendente prontezza alle nostre visioni, finché realtà e immaginazione si fondono in modo così strano che poi è quasi impossibile discernerle di nuovo. Né questa è la cosa più strana di quella condizione. È un fatto indubbio che, sebbene i sensi del tatto e della vista siano allora spenti, i nostri pensieri addormentati e le scene che immaginiamo saranno influenzati, parecchio influenzati, dalla presenza pur silenziosa di qualche oggetto esterno che magari non era lì quando abbiamo chiuso gli occhi e della cui vicinanza non avevamo precisa coscienza. Oliver sapeva perfettamente bene di trovarsi nella sua stanzetta, di avere innanzi a sé i propri libri sul tavolo e che una dolce brezza agitava le foglie delle piante rampicanti all'esterno, eppure dormiva. Improvvisamente la scena mutò, l'aria si fece asfittica e chiusa e in un lampo di terrore pensò di trovarsi ancora nella casa dell'ebreo. Ed eccolo là, quell'uomo odioso, al suo solito angolo, che lo additava e sussurrava a qualcun altro seduto accanto a lui, col volto nascosto. «Zitto, mio caro!», gli parve di sentir dire dall'ebreo. «È lui, più che certo. Andiamo via». «È lui!», sembrò rispondere l'altro. «Credi che non lo vedo? Se una banda di diavoli dovesse assumere le sue sembianze e lui si trovasse confuso tra loro, qualcosa mi direbbe subito come riconoscerlo. Se tu lo seppellissi cinquanta piedi sottoterra e mi facessi passare sulla sua tomba, pure senza nessun segno io saprei dov'è sepolto. Lo saprei!». L'uomo sembrò dire questo con un odio così spaventoso che Oliver, trasalendo, si svegliò per la paura. Cielo misericordioso! Cos'era che gli aveva raggelato il sangue nelle vene e gli aveva tolto la voce e la capacità di muoversi! Là, là... alla finestra, vicinissimo a lui; così vicino che quasi avrebbe potuto toccarlo prima che di scatto si ritraesse, con gli occhi che perlustravano la stanza e incontravano i suoi: eccolo lì, l'ebreo! E accanto a lui, bianco di rabbia, o di paura, o tutt'e due, ecco i lineamenti dello stesso uomo che gli si era parato innanzi nel cortile della locanda. Non fu che un istante, uno sguardo, un lampo innanzi ai suoi occhi; poi scomparvero entrambi. Ma essi l'avevano riconosciuto, come lui aveva riconosciuto loro, e il loro volto gli si era impresso nella mente come se fosse stato scolpito nella pietra e l'avesse avuto innanzi dalla nascita. Per un istante restò come trafitto. Poi, saltando dalla finestra giù in giardino, urlò aiuto. Capitolo XXXV. Contiene l'esito insoddisfacente dell'avventura di Oliver e il colloquio, d'una certa importanza, tra Harry Maylie e Rose Quando gli abitanti della casa, attirati dalle grida di Oliver, si precipitarono nel punto da cui queste provenivano, lo trovarono pallido e agitato, che indicava i campi sul retro, a malapena in grado di articolare «L'ebreo, l'ebreo!». Il signor Giles non riusciva a comprendere cosa volesse dire quel grido ma Harry Maylie, con migliore intuito, avendo sentito la storia di Oliver da sua madre, capì immediatamente. «Che direzione ha preso?», domandò afferrando un pesante bastone appoggiato in un angolo. «Quella», replicò Oliver indicando dove si erano allontanati i due. «Li ho persi di vista in un momento». «Allora devono essersi nascosti nel fossato!», disse Harry. «Seguitemi! e tenetevi vicino a me più che potete». Così dicendo saltò la siepe e si lanciò all'inseguimento a tale velocità da rendere estremamente difficile agli altri seguirlo. Giles gli stava dietro come poteva; anche Oliver lo tallonava a distanza, e dopo un minuto o due il dottor Losberne, che tornava proprio allora da una passeggiata, ruzzolò oltre la siepe e, rialzandosi con insospettabile agilità, si precipitò dietro gli altri a velocità tutt'altro che trascurabile, chiedendo a squarciagola cosa stesse succedendo. Corsero tutti, senza fermarsi neanche un istante per riprender fiato, finché la loro guida, giunta in quella parte del campo indicatagli da Oliver, si mise a perlustrare il fossato e la siepe di confine, il che lasciò più tempo agli altri per ricongiungersi al gruppo e a Oliver per comunicare al dottor Losberne le circostanze che avevano portato a quell'inseguimento così precipitoso. La ricerca non ebbe esito. Non si poterono trovare neanche tracce fresche di passi. Erano giunti, a quel punto, sulla sommità di una collinetta che dominava i campi aperti per un raggio di circa tre miglia. Nell'avvallamento sulla sinistra c'era il villaggio, ma per raggiungerlo, dopo aver percorso il tratto che Oliver aveva indicato, i fuggitivi avrebbero dovuto fare tutto un giro in aperta campagna ed era impossibile che l'avessero compiuto in così poco tempo. Dall'altra parte c'era un fitto bosco che limitava i campi, ma ugualmente non avrebbero fatto in tempo a cercarvi riparo. «Dev'essere stato un sogno, Oliver», disse Harry Maylie. «Oh no, signore, no», replicò Oliver rabbrividendo al solo ricordo dell'aspetto del vecchio furfante. «L'ho visto troppo bene per essere stato un sogno. Ho visto tutti e due così come vedo voi ora». «Chi era l'altro?», domandarono contemporaneamente Harry e il dottor Losberne. «Lo stesso uomo con cui mi sono scontrato nei pressi della locanda», rispose Oliver. «Ci siamo fissati negli occhi e potrei giurare che era lui». «E hanno preso da questa parte? Sei sicuro?», chiese Harry. «Come sono sicuro d'averli visti alla finestra», replicò Oliver, nel mentre indicando giù la siepe che divideva il giardino della casa dai campi. «Quello più alto è saltato proprio in quel punto mentre l'ebreo, correndo un poco più a destra, si è infilato in quel varco». I due scrutavano il volto serio di Oliver mentre parlava; poi, scambiatosi uno sguardo, sembrarono persuasi della accuratezza di ciò che aveva raccontato. Da nessuna parte però trovarono tracce dei passi dei due uomini, che sembravano essersi dileguati, e benché l'erba fosse alta non appariva schiacciata se non dove i loro stessi piedi l'avevano calpestata. Le scarpate e i bordi dei fossati erano di argilla umida, eppure non si vedevano impronte di scarpe, nessun minimo indizio, che indicasse che qualche piede aveva premuto il terreno di recente. «È molto strano!», disse Harry. «Strano!», fece eco il dottore. «Gli stessi Blathers e Duff non avrebbero cavato un ragno dal buco». Ma a dispetto della evidente inutilità delle ricerche non desistettero finché il calare della notte non rese disperata ogni ulteriore prosecuzione; e anche allora desistettero con molta riluttanza. Giles fu spedito alle diverse locande del villaggio munito della migliore descrizione che Oliver potè dare dell'aspetto e dell'abbigliamento dei due estranei. Comunque sia, per quanto l'ebreo più dell'altro fosse abbastanza notevole per non passare inosservato nel caso fosse entrato a bere in qualche locale, o fosse andato in giro nei paraggi, tuttavia tornò senza alcuna informazione utile per svelare in tutto o in parte quel mistero. Il giorno seguente si fecero ulteriori ricerche e si rinnovarono le domande ma senza miglior successo. Il giorno dopo ancora Oliver e il signor Maylie tornarono alla cittadina nella speranza di vedere o udire qualcosa dei due, ma anche questo tentativo fu infruttuoso, e dopo alcuni giorni l'episodio cominciò a esser dimenticato, come sono dimenticate tante altre cose, quando la sorpresa iniziale, non trovando fresco alimento, man mano scompare. Nel frattempo Rose riacquistava salute rapidamente. Aveva lasciato la stanza e, di nuovo in grado di uscire e di stare in compagnia della famiglia, portava gioia nel cuore di tutti. Tuttavia, sebbene questo felice cambiamento avesse un visibile effetto su quella piccola comunità e sebbene in casa si sentissero di nuovo voci allegre e risa gioiose, c'era chi, di tanto in tanto, sembrava provare una qualche preoccupazione; tra questi la stessa Rose, come Oliver non potè fare a meno di notare. La signora Maylie e suo figlio discutevano spesso, in lunghi colloqui, e più di una volta si vide il volto di Rose con tracce di lacrime. Dopo che il signor Losberne ebbe fissato il giorno della sua partenza per Chertsey, questi sintomi s'accrebbero e divenne evidente che stava accadendo qualcosa che turbava la pace della giovane, e non solo. Infine, un giorno, trovandosi Rose da sola nella stanza da pranzo, entrò Harry Maylie e con qualche esitazione le chiese il permesso di poterle parlare un minuto. «Un minuto appena basterà, Rose», disse il giovane avvicinando la sua sedia a lei. «Ciò che ho da dirti, il tuo cuore forse lo sa già. Le mie più fervide speranze non ti sono sconosciute, credo, sebbene io non te le abbia mai manifestate con parole». Dal momento in cui era entrato Rose era impallidita, ma poteva trattarsi soltanto dell'effetto della sua recente malattia. Si limitò a fare un inchino e, curvatasi su qualche pianta che stava lì vicino, aspettò in silenzio che lui continuasse. «Io... io... sarei dovuto andar via da qui prima», disse Harry. «Sì, avresti dovuto», ribatté Rose. «Perdonami se lo dico, ma vorrei che tu fossi andato via». «Mi ha condotto qui l'ansia più terribile e tormentosa», disse il giovane. «La paura di perdere la persona che porta in sé tutte le mie speranze e i miei desideri. Eri quasi in punto di morte, in bilico tra cielo e terra, e quando una giovane, bella e buona, è colpita dalla malattia, l'anima pura di lei si volge insensibilmente verso la luminosa dimora dell'eterno riposo; si sa, e il cielo ci aiuti, che i migliori e più belli tra noi appassiscono mentre sono ancora in boccio». Spuntarono lacrime agli occhi della ragazza mentre venivano pronunciate queste parole, e quando una di esse cadde sul fiore sul quale ella era curva e brillò luminosa nel suo calice rendendolo ancor più bello, sembrò come se l'effondersi del suo giovane e tenero cuore dichiarasse la sua parentela con quanto di più leggiadro vi è sulla terra. «Un angelo», continuò il giovane appassionatamente, «una creatura leggiadra e pura come gli angeli più vicini a Dio era sospesa tra cielo e terra. Oh! Quando il regno lontano al quale lei apparteneva quasi le apriva le sue porte, chi avrebbe potuto sperare che lei sarebbe tornata alle sofferenze e alle calamità di questo mondo! Rose, Rose, sapere che svanivi come l'impalpabile ombra d'una luce eccelsa; non vedere alcuna speranza che tu potessi essere risparmiata per coloro che dimorano quaggiù, senza riuscire a comprendere perché così dovesse essere; sentire che appartenevi a quella sfera luminosa alla quale tante delle più leggiadre e più buone creature sono ascese anzitempo; e tuttavia, a dispetto di questi tanti motivi di consolazione, pregare che tu fossi restituita a coloro che ti amavano... tutto questo era quasi insopportabile. Quei pensieri m'accompagnavano notte e giorno, e lacrime m'inondavano gli occhi, e m'assalivano tali apprensioni e rimorsi all'idea che tu potessi morire senza che avessi potuto dirti quanto devotamente ti amassi da averne sconvolti i sensi e la ragione. Poi, hai cominciato a star meglio; giorno dopo giorno, quasi ora dopo ora, riacquistavi stille di salute che, confluendo nella debole, esile corrente vitale che languidamente circolava in te, la gonfiavano fino a farne un impetuoso flusso. Ti ho vista passare quasi dalla morte alla vita, con gli occhi umidi d'angoscia e profondo affetto. Non dirmi che mi avresti preferito lontano da questo, perché ciò che ho veduto ha reso più buono il mio cuore verso tutto il genere umano». «Non volevo dir questo», disse Rose piangendo. «Ti avrei voluto lontano solo perché tu, altrove, avessi potuto dedicarti di nuovo ai tuoi alti e nobili scopi, agli scopi che son degni di te». «Non c'è scopo più degno di me, o degno delle più nobili nature al mondo, del cercare d'avvincere un cuore come il tuo», disse il giovane prendendole la mano. «Rose, mia cara Rose; per anni, per anni ti ho amata sperando prima di raggiungere la fama e poi tornare orgogliosamente a casa e dirti che l'avevo cercata solo perché tu potessi condividerla con me, sognando di poterti rammentare in quel felice momento dei tanti, silenziosi pegni d'affetto di quand'ero ragazzo, e chiederti la mano a sigillo di un'antica e muta devozione. Quel momento non è ancora giunto, ma qui, senza che io abbia acquistato alcuna fama, realizzato nessun sogno, ti consegno il cuore già tuo da tanto tempo, e tutto affido alle parole con le quali vorrai accogliere ciò che t'offro». «Ti sei sempre comportato gentilmente e nobilmente», disse Rose dominando le emozioni che l'agitavano. «Ascolta quanto ho da dirti, e credimi, non sono né insensibile né ingrata». «E posso cercare di meritarti, non è vero, cara Rose?» «Devi cercare di dimenticarmi», replicò Rose, «dimenticarmi non come l'affettuosa e devota compagna che sono stata per te - questo mi ferirebbe profondamente - ma come l'oggetto del tuo amore. Guarda al mondo, pensa a quanti cuori vi sono che saresti orgoglioso di conquistare. Confidami pure la tua passione per altre, se credi, e allora sarò per te la più sincera, affettuosa e riservata amica». Ci fu una pausa durante la quale Rose, coprendosi il volto con una mano, dette sfogo alle sue lacrime mentre Harry le teneva l'altra. «E quali sono i motivi, Rose», egli disse infine in tono sommesso. «Quali sono i motivi di questa decisione?» «È tuo diritto conoscerli, anche se non puoi fare nulla per mutare la mia decisione», ribatté Rose. «È mio dovere dirteli. Lo devo agli altri e anche a me stessa». «A te stessa?» «Sì, Harry. Lo devo a me stessa: una giovane senza amicizie e senza beni, con una macchia sul nome, non deve dare adito ai tuoi amici di sospettare di aver approfittato della tua prima passione e di aver posto su di te, su tutte le tue speranze e progetti, il suo pesante giogo. E devo a te e alla tua famiglia l'impedirti che, con la tua irruenta e generosa natura, tu frapponga questo grande ostacolo al tuo avanzamento nel mondo». «Se le tue inclinazioni concordano con ciò che senti doveroso...», cominciò Harry. «No, non concordano», replicò Rose accendendosi. «Allora ricambi il mio amore?», disse Harry. «Dimmi solo di sì, dimmi solo di sì, e addolcisci l'amarezza di questa profonda delusione!». «Se avessi potato dirlo senza nuocere gravemente a colui che amo», riprese Rose, «avrei...». «Accolto la mia dichiarazione in modo molto diverso?», disse Harry. «Almeno non nascondermi questo, Rose». «L'avrei accolta...», disse Rose. «Basta», aggiunse liberando la sua mano. «Perché prolungare questo colloquio penoso? È molto penoso per me, anche se promette felicità futura; io sarò felice nel ricordare quanto in alto mi colloca ora la tua stima e ogni successo che avrai nella vita m'infonderà nuovo vigore e determinazione. Addio, Harry! Non ci incontreremo più come ci siamo incontrati oggi; saremo uniti ma con legami diversi da quelli che questo colloquio avrebbe voluto stabilire. Tutte le benedizioni che le preghiere di un animo sincero e appassionato possono invocare su di te dalla fonte di ogni verità ti diano gioia e prosperità». «Ancora una parola, Rose», disse Harry. «Vorrei esser certo che quanto mi hai detto viene da te sola. Vorrei che tu me lo assicurassi». «S'aprono innanzi a te brillanti prospettive», rispose Rose fermamente, «e ti attendono onori per raggiungere i quali possono essere d'aiuto il talento e le relazioni altolocate. Ma quelle relazioni sono altere e io non desidero né mischiarmi con chi disprezzerebbe colei che mi dette la vita, né portare onta e disonore al figlio di colei che con tanta bontà ha preso il posto della mia madre naturale. In conclusione», disse la giovane nel voltarsi, sentendo che la sua temporanea fermezza stava per abbandonarla, «c'è una macchia sul mio nome che il mondo farebbe ricadere su dei piccoli innocenti. Non la trasmetterò ad altro sangue oltre al mio, e di ciò io sola sarò da biasimare». «Ancora una parola, Rose. Diletta Rose! Ti prego!», esclamò Harry gettandosi ai suoi piedi. «Se la mia condizione fosse stata meno fortunata... meno fortunata, come si dice; se mi fosse toccata in sorte una vita oscura e tranquilla, se fossi stato povero, malato e solo, mi avresti rifiutato ugualmente? O sono solo le mie prospettive di ricchezze ed onori il motivo dei tuoi scrupoli?» «Non insistere con queste domande», disse Rose. «Non hanno senso ora, e non ne avranno in futuro, e non è né giusto né cortese da parte tua insistere». «Se la tua risposta fosse quella sperata», ribatté Harry, «farebbe scendere un raggio di felicità sul triste e solitario cammino che mi sta innanzi. Non è vano cercare di saperlo, con poche e ultime parole, da parte di chi t'ama sopra ogni cosa. Oh Rose! In nome del mio fervido e imperituro affetto, in nome di tutto ciò che ho sofferto per te e di tutto ciò che mi condanni a patire, rispondi a questa domanda soltanto!». «Ebbene, se il tuo destino fosse stato diverso», riprese Rose, «se tu fossi stato un poco - non tanto - al di sopra di me, se io avessi potuto esserti d'aiuto e di conforto in qualche umile stazione di tranquillità e di sereno ritiro, e non una macchia o un impedimento tra gente ambiziosa e altolocata, questa prova mi sarebbe stata risparmiata. Ho ogni ragione d'esser felice, molto felice adesso, ma ancor più felice sarei stata allora, Harry». E nell'ammetterlo, ricordi di antiche speranze nutrite da ragazza, tanto tempo prima, le si affollarono in mente e la fecero piangere, così come accade quando contempliamo antiche speranze ormai spente. Ma furono lacrime di sollievo. «Perdonami questa debolezza, ma essa mi fa ancor più salda nel mio proposito», disse, protendendo la mano. «E ora devo lasciarti davvero». «Ti chiedo soltanto una promessa», disse Harry. «Lascia che di questo io possa parlarti di nuovo un'ultima volta, una volta, una volta soltanto... magari fra un anno, se non persino molto prima». «Non dovrai insistere però a volermi distogliere dalla mia determinazione», replicò Rose con un sorriso malinconico. «Sarebbe inutile». «No», disse Harry. «Ma vorrei sentirti ripeterla, se vorrai; ripeterla un'ultima volta. Sarò ai tuoi piedi, quali che siano le mie fortune o la mia condizione, e se tu confermerai la tua decisione di adesso, non cercherò più di cambiarla, in alcun modo». «Allora così sia», concesse Rose. «È solo una spina che si aggiunge alle tante altre, e per quel tempo spero d'essere in grado di sopportarle meglio». Protese ancora la mano. Ma il giovane se la strinse al petto, e schioccandole un bacio sulla bella fronte uscì precipitosamente dalla stanza. Capitolo XXXVI. Brevissimo e di per sé, sembrerebbe, poco importante. Tuttavia va letto perché continuazione dell'ultimo, e fondamentale per il capitolo che a suo tempo seguirà «E così siete deciso ad essermi compagno di viaggio stamani, eh?», disse il dottore quando Harry Maylie si unì a lui e a Oliver a tavola per la colazione. «Però! Cambiate decisione ogni mezz'ora, mi pare». «Potreste considerare le cose in tutt'altra luce, uno di questi giorni», disse Harry arrossendo senza alcuna ragione evidente. «Spero che abbiate un buon motivo per affermarlo», replicò il signor Losberne, «benché, lo confesso, non credo possibile ravvedermi. Ieri mattina v'eravate precipitosamente deciso a restare qui per accompagnare vostra madre al mare, da bravo figliolo. Prima di mezzogiorno, annunciavate che mi avreste fatto l'onore di accompagnarmi per un tratto sulla vostra strada per Londra. E a sera mi sollecitavate misteriosamente a partire prima che le signore fossero in piedi, e per conseguenza il piccolo Oliver qui presente è inchiodato alla colazione quando invece dovrebbe già scorrazzare per i campi in cerca d'ogni sorta di fenomeni botanici. Non va bene, vero Oliver?» «Mi sarebbe dispiaciuto molto non essere in casa quando voi e il signor Maylie foste partiti, signore», affermò Oliver. «Bravo ragazzo», disse il dottore, «quando torni verrai a trovarmi. Ma parlando seriamente, Harry. Per caso la tua improvvisa ansia di partire dipende da qualche comunicazione venuta dai pezzi grossi?» «I pezzi grossi», replicò Harry, «una designazione sotto la quale includete, devo presumere, il mio importantissimo zio, non hanno comunicato in alcun modo con me da quando sono qui, né è probabile, in questo momento dell'anno, che accada qualcosa per cui si renda necessaria la mia immediata presenza tra loro». «Bene», disse il dottore. «Siete un tipo strano. Ma naturalmente vi faranno ottenere un seggio al parlamento alla prossima elezione prima di Natale, sicché questi vostri improvvisi mutamenti non sono per nulla una cattiva preparazione alla vita politica. Serve anche quello; un buon allenamento è sempre auspicabile, sia quando si corre per un posto, o per una coppa, sia quando si scommette su qualcosa». Harry Maylie sembrò come sul punto di proseguire questo breve dialogo con una o due osservazioni che avrebbero colpito non poco il dottore, però si limitò a dire «vedremo», senza aggiungere altro. Poco dopo la carrozza si fermò alla porta, ed entrato Giles per i bagagli, il dottore li seguì di fuori per sorvegliarne la sistemazione. «Oliver», disse Harry Maylie a bassa voce, «vorrei dirti una parola». Oliver seguì il signor Maylie nel vano della finestra dove l'aveva invitato ad andare con un cenno, parecchio sorpreso della commistione di tristezza ed euforia che traspariva in tutto il suo modo di fare. «Sei in grado di scrivere bene, adesso?», chiese Harry poggiandogli una mano sul braccio. «Lo spero, signore», replicò Oliver. «Forse non tornerò a casa per un po'. Vorrei che mi scrivessi... diciamo ogni quindicina di giorni, un lunedì sì e uno no, all'Ufficio Postale Centrale di Londra. Lo farai?» «Oh! Certamente, signore! Ne sarò orgoglioso», esclamò Oliver molto gratificato per l'incarico ricevuto. «Mi farebbe piacere essere informato... su come stanno mia madre e la signorina Maylie», disse il giovane, «e potresti riempire una pagina per dirmi quali passeggiate fate, di che parlate e se lei... cioè, voglio dire loro, stanno bene e sono felici. Mi capite?» «Oh! Benissimo, signore benissimo», replicò Oliver. «Preferirei che non ne sapessero nulla», disse Harry accavallando le parole, «altrimenti mia madre potrebbe mettersi in ansia per scrivermi più spesso, e per lei sarebbe un pensiero e una preoccupazione. Che resti un segreto tra me e te, e bada di riferirmi ogni cosa. Conto su di te». Oliver, inorgoglito e compiaciuto di quella responsabilità, promise di mantenere il segreto e di riferire tutto fedelmente; quindi il signor Maylie lo salutò, assicurandogli con calore il suo interesse e la sua protezione. Il dottore era in carrozza; Giles (che era stato stabilito sarebbe rimasto lì) teneva aperta la portiera, e le domestiche erano in giardino a seguire il tutto. Harry gettò una fuggevole occhiata alla finestra col graticcio e saltò in carrozza. «Partite!», esclamò. «Al galoppo, ventre a terra. Neanche una saetta riuscirà a starmi dietro, oggi». «Ehilà!», fece il dottore abbassando in fretta il finestrino anteriore e gridando al postiglione. «Anche qualcosa di molto meno veloce d'una saetta riuscirà a starci dietro, oggi. Mi sentite?». Tintinnando e sferragliando finché la distanza non rese impercettibili i suoni e il suo rapido avanzare fu percepibile soltanto allo sguardo, il veicolo correva lungo la strada sinuosa, quasi occultato in una nuvola di polvere, a tratti scomparendo del tutto e a tratti, quando le cose che venivano a frapporsi o gli intrichi della strada lo permettevano, di nuovo visibile. Soltanto quando non si vide nemmeno più la nuvola di polvere, gli osservatori si dispersero. Ma uno di questi era rimasto con gli occhi fissi sul punto dove la carrozza era scomparsa, anche quando ne fu parecchie miglia lontana, giacché dietro la tendina bianca che l'aveva nascosta alla vista di Harry nel momento in cui lui aveva sollevato lo sguardo alla finestra, sedeva Rose in persona. «Sembra felice e pieno d'entusiasmo», disse infine. «Per un po' ho temuto il contrario. Mi ingannavo. Mi fa molto, molto piacere». Le lacrime sono il segno della gioia oltreché del dolore, ma quelle che scesero lungo le gote di Rose, mentr'ella sedeva pensosamente alla finestra con lo sguardo ancora rivolto nella stessa direzione, sembravano manifestare più dolore che gioia. Capitolo XXXVII. Nel quale il lettore avvertirà un contrasto non insolito nelle relazioni matrimoniali Il signor Bumble sedeva nel salottino dell'ospizio fissando cupamente la grata del focolare freddo dal quale, poiché era estate, non provenivano altri bagliori tranne i pallidi raggi di sole riflessi sulla sua fredda e lucida superficie. Pendeva dal soffitto una striscia di carta moschicida, alla quale egli, assorto in cupi pensieri, di tanto in tanto sollevava lo sguardo, e mentre gli ignari insetti vi ronzavano intorno in allegri svolazzi il signor Bumble sospirava profondamente e un'ombra funesta gli si allungava sul volto. Il signor Bumble meditava assorto, e forse quegli insetti richiamavano alla memoria qualche penosa circostanza della vita passata. E non era soltanto l'aspetto abbattuto del signor Bumble che avrebbe potuto destare una dolente malinconia nel petto di un osservatore. Non mancavano altri indizi, strettamente legati alla sua persona, a segnalare qualche clamoroso mutamento nello stato dei suoi affari: dov'erano mai il soprabito coi galloni e il tricorno? Egli indossava ancora braghe al ginocchio, abbinate a calzettoni di cotone scuro nella parte inferiore della gamba, ma non erano più le braghe. Il soprabito era a falde larghe, e dunque, sotto quell'aspetto, esattamente come il soprabito; eppure, quanto diverso! Al posto dell'imponente tricorno, poi, c'era un modesto copricapo tondo. Insomma il signor Bumble non era più custode. Nella vita ci sono promozioni che, indipendentemente dalle concrete soddisfazioni che offrono, acquistano particolare valore e dignità dai soprabiti e dai panciotti a loro peculiari. Un maresciallo ha la sua uniforme; un vescovo la sua sottana di seta; un consigliere la sua toga di seta; e un custode ha il suo tricorno. Togliete al vescovo la sua sottana, al custode il cappello e i galloni, e cosa sono mai? Uomini, semplici uomini. La dignità, e perfino la santità, a volte, sono questioni più di soprabito e panciotto di quanto qualche persona possa immaginare. Il signor Bumble aveva sposato la signora Corney, ed era quindi direttore dell'ospizio. Un altro custode era subentrato, con ciò acquisendo anche il tricorno, il soprabito coi galloni e la mazza. «E domani saranno passati due mesi da allora!», disse il signor Bumble con un sospiro. «Mi sembra un secolo». Il signor Bumble intendeva forse dire che aveva concentrato un'intera esistenza di felicità nel breve tempo di otto settimane ma il sospiro... com'era eloquente quel sospiro. «Mi sono dato via», disse il signor Bumble seguitando nei suoi pensieri, «per sei cucchiaini, un paio di molle da zucchero, e un bricco del latte, più una modesta mobilia di seconda mano e venti sterline. Mi sono venduto a un prezzo ragionevolissimo. A buon mercato, maledettamente a buon mercato!». «A buon mercato!», strillò una voce all'orecchio del signor Bumble. «Saresti stato caro a qualsiasi prezzo; e Dio solo sa se t'ho pagato a caro prezzo!». Voltandosi, il signor Bumble incontrò la faccia della sua accattivante consorte la quale, carpite imperfettamente solo poche parole di quella lamentosa esternazione, aveva replicato alla cieca con l'osservazione suddetta. «Signora Bumble, cara!», disse il signor Bumble con sentimentale imponenza. «Beh?», strillò la signora. «Guardatemi, da brava!», disse il signor Bumble fissandola negli occhi. «Se potrà resistere a codesto sguardo», si disse tra sé il signor Bumble, «allora potrà resistere a tutto. Non ha mai fallito con i poveri, e se fallisce con lei vuol dire che il mio potere è andato». È opinabile se basti una minima dilatazione dell'occhio per soggiogare dei poveri orfanelli che, in conseguenza di una dieta leggera, non oppongono di solito resistenza, o se la ex signora Corney fosse particolarmente impermeabile agli sguardi aquilini. Fatto sta che la matrona non fu affatto intimorita dal cruccio del signor Bumble, ma, al contrario, lo snobbò totalmente ed esplose in una risata di vero cuore. A questo suono inatteso il signor Bumble restò prima incredulo e poi stupefatto. Ricadde quindi nello stato meditativo di prima né si riscosse finché la sua attenzione non fu di nuovo destata dalla voce della sua compagna. «Hai intenzione di startene lì seduto a ronfare tutto il giorno?», domandò la signora Bumble. «Ho intenzione di starmene qui seduto finché mi pare e piace, signora», rispose il signor Bumble, «e sebbene non stessi ronfando, ronferò, sbadiglierò, starnutirò, riderò o piangerò, come meglio mi aggrada, poiché tale è la mia prerogativa». «La tua prerogativa!», ghignò la signora Bumble con ineffabile disprezzo. «Proprio così, madama!», osservò il signor Bumble. «La prerogativa dell'uomo è comandare». «E qual è la prerogativa di una donna, di grazia?», gridò la spoglia vedovile dello scomparso signor Corney. «Obbedire, madama», tuonò il signor Bumble. «Se il vostro sventurato e defunto marito ve lo avesse insegnato, forse oggi sarebbe ancora vivo... E vorrei che lo fosse, pover'uomo!». La signora Bumble, compresa immediatamente la crucialità del momento, e consapevole che il primo colpo per la supremazia infetto dall'una o dall'altra parte avrebbe deciso definitivamente la questione, non appena udì l'allusione alla buon'anima, s'accasciò su una sedia strillando al signor Bumble che era un bruto, che aveva un cuore di pietra, e finì con un profluvio di lacrime. Ma le lacrime non fecero breccia nell'animo del signor Bumble. Il suo cuore era refrattario. I suoi nervi si fecero più saldi e vigorosi a quello scroscio di lacrime, tal quali i cappelli di castoro impermeabili che migliorano quanta più pioggia prendono; quelle lacrime, in quanto segno di debolezza e dunque tacite ammissioni del suo potere, lo gratificavano e lo esaltavano. Con espressione soddisfatta guardò la sua buona signora e la pregò, condiscendente, di piangere più che poteva, poiché la scienza medica riteneva quell'esercizio estremamente favorevole alla buona salute. «Dilata i polmoni, idrata l'incarnato, spurga gli occhi, e molcisce il carattere», disse il signor Bumble. «Perciò, piangete pure». Con tale sfogo faceto, il signor Bumble prese il cappello dall'appendiabiti, se lo sistemò in testa di sguincio, alla malandrina, come chi avesse affermato la propria superiorità in modo incontrovertibile, si ficcò le mani in tasca e s'avviò a bell'agio verso la porta, la perfetta immagine della spavalderia. La ex signora Corney tuttavia era ricorsa alle lacrime sol perché le trovava meno impegnative di un assalto fisico, ma era assolutamente preparata all'eventualità di dover imboccare questa seconda strada, come il signor Bumble avrebbe di lì a poco scoperto. Il primo indizio che n'ebbe fu un tonfo sordo immediatamente successivo al volo del suo cappello all'angolo opposto della stanza. Con ciò avendogli denudato il capo, l'esperta signora l'agguantò alla gola con una mano, e con l'altra scaricò sul di lui cranio una gragnuola di colpi, tutti portati con singolare vigore e precisione. Fatto questo, operò una piccola variazione, graffiandogli la faccia e strappandogli i capelli; quindi, dopo avergli inflitta quella punizione che ritenne commisurata all'offesa, lo spinse su una sedia che, per buona sorte, si trovava nella traiettoria di caduta, e lo sfidò a blaterare ancora di prerogative, se aveva il coraggio. «Alzati!», disse la signora Bumble con voce imperiosa, «e togliti dai piedi se non vuoi che compia qualche atto disperato». Il signor Bumble s'alzò con espressione ammansita, domandandosi cosa intendesse per "atto disperato" e, raccogliendo il cappello, si diresse alla porta. «Allora, te ne vai o no?», domandò la signora Bumble. «Certo, mia cara, certo», rispose il signor Bumble con uno scatto in direzione della porta. «Io non volevo.... Sto andando, mia cara! Siete così violenta che veramente io...». E poiché in quell'istante la signora Bumble scattò in avanti per risistemare il tappeto smosso dalle pedate nel corso della colluttazione, il signor Bumble si precipitò immediatamente fuori della stanza senza preoccuparsi minimamente di lasciar la frase a mezzo e la vedova Corney restò padrona assoluta del campo. Il signor Bumble era stato colto di sorpresa e nettamente battuto. Aveva un'accentuata disposizione alla prepotenza e traeva non poco piacere dall'infliggere piccole crudeltà. Dunque, inutile dirlo, era un codardo, anche se questo non va affatto a detrimento della sua alta levatura, poiché molti funzionari pubblici di un certo livello, tenuti in gran rispetto e considerazione, soggiacciono ugualmente a tali debolezze. Invero, l'osservazione va piuttosto in suo favore, poiché comunica al lettore il giusto senso delle sue doti per quel mestiere. Ma la misura della sua degradazione non era ancora colma. Dopo aver fatto un giro per l'ospizio, riflettendo per la prima volta che la legge sui poveri trattava le persone troppo duramente e che un uomo che abbandonava la moglie lasciandola sulle spalle della parrocchia, non solo non avrebbe dovuto essere condannato ma, in tutta giustizia, avrebbe dovuto essere ricompensato in quanto lo meritava e in quanto persona che già troppo aveva sofferto, il signor Bumble giunse in una stanza dove di solito si mettevano le donne a lavare la biancheria della parrocchia e da dove s'udiva provenire un fitto cicaleccio. «Hem!», fece il signor Bumble facendo appello a tutta la sua naturale dignità. «Almeno queste donne avranno rispetto delle mie prerogative. Ehilà, ehilà! Che significa tutto questo baccano, petulanti che non siete altro?». Con queste parole il signor Bumble aprì la porta ed entrò con un'espressione irata e feroce, che subito trapassò in un'altra di sottomissione e mansuetudine, allorché i suoi occhi caddero, sorpresi, sulle fattezze della sua donna e signora. «Mia cara», disse il signor Bumble. «Non sapevo che voi foste qui». «Non sapevi che ero qui?», ripetè la signora Bumble. «Tu, piuttosto, cosa ci fai qui!». «Mi pareva che chiacchierassero un po' troppo per svolgere bene il lavoro, mia cara», replicò il signor Bumble con un'occhiataccia a due vecchie che lavavano in una tinozza e che si scambiavano commenti compiaciuti sull'umiltà del direttore dell'ospizio. «Ti pareva che chiacchierassero un po' troppo?», disse la signora Bumble. «Perché, è forse affar tuo?» «Ecco, mia cara...», insistette il signor Bumble tutto umile. «Ma è forse affar tuo?», domandò ancora la signora Bumble. «È verissimo, siete voi la direttrice qui, mia cara», concesse il signor Bumble, «ma non pensavo che ci foste già voi». «Ti dico una cosa, signor Bumble», ribatté la signora. «Non vogliamo nessuna interferenza da parte tua. Sei fin troppo pronto a ficcare il naso in faccende che non ti riguardano, rendendoti ridicolo a ogni ora del giorno e facendo ridere tutte quelle dell'ospizio appena volti le spalle. Sgombra. Sciò!». Nella bruciante umiliazione di vedere la gioia delle due vecchie che cinguettavano estasiate tra loro, il signor Bumble esitò un istante. La signora Bumble, la cui pazienza non sopportava ritardi, afferrò un mastello d'acqua e sapone, e indicandogli l'uscita gli ordinò di andarsene immediatamente, sotto pena di vedersene rovesciato il contenuto sulla sua corpulenta figura. Cosa poteva fare il signor Bumble? Si guardò attorno con aria smarrita e sgattaiolò via, con le vecchie che, mentre raggiungeva la porta, ridacchiavano di gioia incontenibile. Non ci mancava che questo. Degradato anche ai loro occhi; aveva perduto il suo carisma e il suo rango di fronte alle stesse donne della parrocchia; era caduto dalla pompa e dignità di un custode fino alle infime profondità della sottomissione coniugale. «E tutto questo in due mesi!», disse il signor Bumble affranto. «Due mesi! Non più di due mesi fa ero non soltanto padrone di me stesso ma anche di tutti gli altri, in ciò che concerneva l'ospizio parrocchiale, e ora!...». Era troppo. Il signor Bumble assestò un ceffone sull'orecchio al ragazzo che gli aprì il cancello (giacché così perso nei suoi pensieri era giunto all'ingresso), e come assente s'incamminò per la strada. Andò su per una strada e giù per un'altra, finché quell'esercizio non gli ebbe placato il primo empito del dolore; poi, quel turbine dei sentimenti gli fece sentir sete. Passò accanto a diverse locande finché infine si fermò innanzi a una che stava in una stradina laterale e la cui saletta, come potè intuire da un'occhiata di sfuggita al di sopra delle tendine, era deserta a parte un avventore solitario. Ma la pioggia che in quel momento si scatenò lo fece decidere. Il signor Bumble entrò e ordinando qualcosa da bere mentre passava accanto al bancone andò nella saletta in cui aveva sbirciato dalla strada. L'uomo che vi stava seduto era alto e bruno, avvolto in un ampio mantello. Aveva l'aria d'un forestiero e, a giudicare dal suo aspetto piuttosto provato e dalla polvere sugli abiti, sembrava venire da parecchio lontano. Guardò Bumble di sottecchi mentre entrava ma, rispondendo al suo saluto, lo degnò appena di un cenno della testa. Il signor Bumble aveva dignità e riserbo da vendere, anche nel caso che avesse conosciuto meglio il forestiero, sicché bevette in silenzio il suo gin allungato con acqua e lesse il giornale ostentando una dignitosa solennità. Ma come spessissimo accade quando ci si trova in compagnia in simili circostanze, di tanto in tanto il signor Bumble sentì il forte impulso, cui non seppe resistere, di gettare un'occhiata furtiva all'estraneo e, ogni qualvolta ciò si verificava, ritraeva gli occhi confuso, poiché in quello stesso istante l'estraneo gettava a sua volta un'occhiata furtiva a lui. L'imbarazzo del signor Bumble fu tanto più grande per la stranissima espressione degli occhi dell'estraneo, acuti e vividi, ma incupiti da un cipiglio sospettoso e diffidente; diversa da ogni altra espressione incontrata mai prima, e veramente repulsiva. Quando i loro sguardi si furono così incrociati parecchie volte l'estraneo, con una voce aspra e cupa, ruppe il silenzio. «Cercavate me quando vi siete affacciato dalla finestra?», egli chiese. «Non che io sappia, a meno che voi non siate il signor...». E qui il Bumble troncò la frase a mezzo poiché era curioso di sapere il nome dell'estraneo e credè, nella sua impazienza, che potesse con ciò indurlo a completarla. «È evidente che no, allora», disse l'estraneo con un'espressione di freddo sarcasmo disegnata sulla bocca, «altrimenti avreste saputo il mio nome. Non lo sapete, e vi consiglio di non indagare a riguardo». «Senza offesa, giovanotto», osservò maestoso il signor Bumble. «Senza offesa», disse l'estraneo. A questo breve dialogo seguì un altro silenzio, che fu di nuovo rotto dall'estraneo. «Vi ho già visto, mi pare», disse. «Eravate vestito diversamente allora, e vi ho solo incrociato per strada, ma vi riconosco. Eravate custode allora, non è così?» «Lo ero», disse il signor Bumble piuttosto sorpreso. «Custode parrocchiale». «Proprio», interloquì l'altro annuendo. «È in quel ruolo che vi conobbi. Cosa siete adesso?» «Direttore dell'ospizio», rispose il signor Bumble con lentezza calcolata per soffocare sul nascere ogni sconveniente familiarità alla quale l'estraneo potesse sentirsi portato. «Direttore dell'ospizio, giovanotto!». «Ma sempre con un occhio di riguardo al vostro interesse privato, come un tempo, oppure no?», riprese l'estraneo guardando il signor Bumble dritto negli occhi, che egli aveva sollevato sorpreso a quella domanda. «Non fatevi scrupolo di rispondermi francamente, amico; io vi conosco abbastanza bene, come vedete». «Suppongo che un uomo ammogliato», replicò il signor Bumble coprendosi gli occhi con la mano e squadrando l'estraneo da capo a piedi evidentemente perplesso, «non sia più contrario d'uno scapolo ad accettare un penny guadagnato onestamente, potendo. I funzionari della parrocchia non sono così ben pagati da potersi permettere di rifiutare qualche piccolo extra se c'è modo di procacciarselo civilmente e degnamente». L'estraneo sorrise e annuì di nuovo come a dire che non s'era sbagliato sul suo conto, e quindi suonò il campanello. «Riempitelo ancora», disse porgendo il bicchiere vuoto del signor Bumble al proprietario della locanda. «Che sia forte e bollente. Vi piace così, nevvero?» «Non troppo forte», replicò il signor Bumble con un colpetto di tosse. «Avete inteso, padrone?», disse secco l'estraneo. L'oste sorrise, scomparve e ritornò subito dopo con un bel bicchiere fumante: al primo sorso, al signor Bumble vennero le lacrime agli occhi. «Ora ascoltatemi», disse l'estraneo dopo aver chiuso la porta e la finestra. «Sono venuto qui oggi per trovare voi, e per una di quelle combinazioni che il diavolo a volte mette sulla strada dei suoi amici, siete entrato proprio nella stanza dov'ero seduto, e nel momento stesso in cui eravate in cima ai miei pensieri. Voglio da voi qualche informazione, ma non gratis, sebbene sia del tutto trascurabile. Intascate queste, tanto per iniziare». Così dicendo, con cautela, spinse verso il suo compagno, dall'altra parte del tavolo, un paio di sovrane, come per evitare che il loro tintinnio potesse sentirsi dall'esterno. Dopo che il signor Bumble ebbe scrupolosamente esaminato le monete per accertarsi che fossero autentiche e se l'ebbe ficcate molto soddisfatto nel taschino del panciotto, continuò: «Andate indietro con la memoria... lasciatemi vedere... dodici anni lo scorso inverno». «È un sacco di tempo», disse il signor Bumble. «Benissimo. Ci sono». «La scena è l'ospizio». «Bene!». «A un'ora di notte». «Sì». «E il luogo l'incredibile camera, dovunque essa si trovi, in cui quelle miserabili megere aiutano a partorire quella vita e quella salute che a loro spesso manca, e assistono alla nascita di piagnucolosi neonati affinché li allevi poi la parrocchia, occultando nella tomba le altrui vergogne!». «La stanza delle partorienti, suppongo?», disse il signor Bumble seguendo non troppo bene l'eccitata descrizione dell'estraneo. «Sì», disse quello. «Vi nacque un bambino». «Parecchi bambini», osservò il signor Bumble scuotendo la testa sconsolato. «La peste se li porti quei piccoli diavoli!», gridò l'estraneo. «Voglio dire uno dall'aspetto mite, un pallido bastardino che è stato apprendista di un impresario di pompe funebri di qua - e magari ne avesse approfittato per costruirsi una bara, inchiodandocisi dentro. Uno che dev'essere scappato a Londra, a quanto se ne sa». «Ah! Volete dire Oliver! Il piccolo Twist!», disse il signor Bumble. «Naturale che me lo ricordo. Non c'era furfantello più ostinato...». «Non è di lui che voglio sapere; ne ho sentito già abbastanza», disse l'estraneo bloccando il signor Bumble sul punto d'attaccare coi vizi del povero Oliver. «Voglio sapere di una vecchia, la megera che ha assistito la madre. Dov'è?» «Dov'è?», fece eco il signor Bumble reso faceto dal gin e acqua. «Difficile dirlo. Non si partorisce da quelle parti, ovunque si trovi, sicché penso almeno che sia disoccupata». «Cosa volete dire?», domandò l'estraneo serio. «Che è morta l'inverno passato», ribatté il signor Bumble. A questa informazione, l'uomo lo guardò fisso, e benché per un po' non distogliesse gli occhi da lui, il suo sguardo si perse man mano nel vuoto, lontano, come se egli fosse assorto nei propri pensieri. Per un po' parve incerto se sentirsi sollevato o deluso dalla notizia ma alla fine respirò più rilassato, e distogliendo lo sguardo osservò che non importava molto. Quindi s'alzò, come per andarsene. Il signor Bumble era abbastanza scaltro e vide immediatamente un'opportunità di guadagno nello svelare il segreto posseduto dalla sua dolce metà. Ricordava bene la notte in cui morì la vecchia Sally, perché si collegava ad altri eventi memorabili di quel giorno: proprio in quell'occasione si era dichiarato alla signora Corney e benché quella signora non gli avesse mai confidato il segreto della cui rivelazione era stata l'unica testimone, aveva sentito abbastanza per sapere che si riferiva a qualcosa successa mentre la povera vecchia, come infermiera dell'ospizio, assisteva la giovane madre di Oliver Twist. Richiamando rapidamente alla memoria la particolare circostanza, con aria misteriosa informò l'estraneo che una donna si trovava nella stanza con la vecchia poco prima che morisse e che aveva ogni ragione di credere che ella fosse in grado di far luce sull'oggetto del suo interesse. «Come posso rintracciarla?», chiese l'estraneo colto di sorpresa, lasciando vedere chiaramente che le sue paure (qualsiasi esse fossero) s'erano di nuovo acuite a quella notizia. «Solo per mio tramite», rispose il signor Bumble. «Quando?», gridò ansiosamente l'estraneo. «Domani», ribatté il signor Bumble. «Alle nove domani sera», disse l'estraneo tirando fuori un foglietto di carta e scrivendovi sopra uno strano indirizzo presso la riva del fiume con una calligrafia che tradiva il suo nervosismo. «Alle nove domani sera portatela qui. Non c'è bisogno di raccomandarvi il segreto. È nel vostro interesse». Con queste parole, dopo aver pagato le consumazioni, s'avviò alla porta e, osservando bruscamente che le loro strade si dividevano, s'allontanò, senza altre cerimonie se non il ricordargli l'ora dell'appuntamento per la sera seguente. Guardando l'indirizzo il funzionario parrocchiale notò che mancava il nome e poiché l'estraneo non era ancora troppo lontano gli corse dietro per domandarglielo. «Chi è?», gridò l'uomo volgendosi di scatto allorché Bumble lo toccò sul braccio. «Mi state seguendo!». «Solo una cosa», disse l'altro indicando il foglietto di carta. «Di chi debbo chiedere?» «Di Monks!», rispose l'uomo, allontanandosi frettolosamente a grandi passi. Capitolo XXXVIII. Contiene un resoconto di quanto avvenne tra i coniugi Bumble e Monks, e il loro colloquio notturno Era una sera estiva fosca, afosa, opprimente, e le nuvole, che avevano minacciato pioggia per tutto il giorno, spandendosi in una densa e pigra massa di vapore, cominciavano già a lasciar cadere grosse gocce, quasi preannuncio di una violenta tempesta, quando il signore e la signora Bumble, svoltando dalla strada principale della città, diressero i loro passi verso un gruppo sparso di case in rovina, distanti più o meno un miglio e mezzo, costruite in un avvallamento malsano e paludoso ai margini del fiume. Entrambi erano avvolti in vecchi abiti sdruciti che avevano forse il duplice scopo di proteggerli dalla pioggia e di camuffarli per non essere riconosciuti. Il marito reggeva una lanterna dalla quale, tuttavia, non veniva alcuna luce e avanzava pesantemente precedendo di alcuni passi la moglie, come se, su quella strada infangata, le concedesse il beneficio di calcare i suoi passi. Procedettero in profondo silenzio; di tanto in tanto il signor Bumble rallentava il passo e si girava come per assicurarsi che la sua metà lo seguisse, dopodiché, vedendo che lei gli era alle calcagna, sveltiva la cadenza e procedeva più velocemente verso il luogo della loro destinazione. Era un luogo, questo, di più che dubbia reputazione, poiché era conosciuto da tempo come la residenza, nientemeno, che di ruffiani della peggior sorta i quali, facendo variamente mostra di vivere del loro lavoro, sopravvivevano principalmente di furti e crimini. Era un campionario di tuguri, alcuni costruiti frettolosamente con mattoni a secco, altri con legni tarlati di navi accatastati alla rinfusa senza alcuna pretesa di ordine o regolarità e per la maggior parte piantati a pochi passi di distanza dalla riva del fiume. Alcune barche in disarmo, tirate a secco sul fango e assicurate al muro di argine del molo, e un remo o un viluppo di fune qui e là sembravano sulle prime indicare che gli abitanti di queste misere dimore avessero delle attività connesse col fiume, ma un successivo sguardo alla condizione di disperata inutilità degli articoli in questione avrebbe condotto i passanti a congetturare, senza troppa difficoltà, che si trovavano lì collocati più per conservare le apparenze che per essere pronti ad un effettivo impiego. Al centro di questo mucchio di baracche, sul margine del fiume, con i piani più alti che sembravano pendere sull'acqua, stava un grosso edificio, adibito un tempo a qualche sorta di manifattura e che allora aveva probabilmente dato lavoro agli abitanti delle case attorno. Da parecchio, tuttavia, era andato in rovina. I topi, i vermi e l'azione dell'umidità avevano indebolito e fatto marcire i piloni sul quale poggiava e una parte consistente dell'edificio era già sprofondata nell'acqua di sotto mentre il resto, piegato e in bilico sulla fosca corrente, sembrava attendere una favorevole opportunità per seguire il grosso e accoglierne il medesimo destino. Fu innanzi a questo cadente edificio che la degna coppia si fermò mentre nell'aria echeggiava la prima scarica di tuoni lontani e la pioggia iniziava a rovesciarsi giù con violenza. «Il posto dovrebbe essere questo, più o meno», disse il signor Bumble consultando un foglietto che reggeva in mano. «Ehilà!», gridò una voce dall'alto. Seguendone la provenienza il signor Bumble sollevò il capo e intravide un uomo che si sporgeva con tutto il busto da una portafinestra al secondo piano. «State fermi là un minuto», gridò la voce. «Sono subito da voi». Col che la testa disparve e la finestra si chiuse. «È lui?», chiese la brava moglie del signor Bumble. Il signor Bumble annuì. «Allora ricordati quello che ti ho detto», disse la direttrice, «e sta' attento a non dire più dello stretto necessario, altrimenti finirai per tradirci subito». Il signor Bumble, che aveva scrutato l'edificio con sguardo apprensivo, era evidentemente sul punto di esprimere i suoi dubbi sulla opportunità di proseguire nell'impresa quando, proprio in quel momento, fu anticipato dall'apparizione di Monks il quale, aperta la porticina presso cui si trovavano, fece loro segno di entrare. «Forza!», gridò con impazienza battendo il piede a terra. «Non restiamo qua impalati!». La donna, esitante sulle prime, entrò impettita senza attendere altri inviti. Il signor Bumble, vergognandosi d'essersi fatto precedere oppure temendo di rimanere indietro, la seguì, visibilmente a disagio e con appena un pizzico di quell'alta dignità che era stata la sua caratteristica primaria. «Perché diavolo ve ne stavate lì sotto l'acqua?», disse Monks girandosi e rivolgendosi a Bumble dopo che ebbe serrato la porta dietro di loro. «Stavamo... stavamo solo rinfrescandoci un poco», balbettò Bumble guardandosi apprensivamente intorno. «Rinfrescandoci un poco!», ribatté Monks. «Neanche tutta la pioggia caduta dai tempi dei tempi o che cadrà d'ora in poi spegnerà il fuoco infernale che qualcuno si porta dentro. Non sarà facile rinfrescarsi; non illudetevi!». Con questo simpatico discorso Monks si rivolse bruscamente alla direttrice e la fissò dritto negli occhi fino a che lei, pure non facile da intimidire, non fu sul punto di distogliere il suo sguardo e abbassarlo a terra. «Così questa è la donna?», chiese Monks. «Ehm! È lei», replicò il signor Bumble memore dell'avvertenza della moglie. «Pensate che una donna sia incapace di mantenere un segreto, suppongo?», disse la direttrice intromettendosi e ricambiando lo sguardo penetrante di Monks. «So che uno sanno mantenerlo, finché non viene scoperto», ribatté Monks sprezzante. «E quale sarebbe?», chiese la direttrice nello stesso tono. «La perdita del loro buon nome», rispose Monks. «Sicché, secondo la stessa regola, se una donna è a parte di un segreto che può mandarla impiccata o ai lavori forzati, non ho la minima paura che possa dirlo ad altri; per niente. Mi capite?» «No», rispose la direttrice arrossendo leggermente. «Non capite, naturalmente!», disse Monks. «E come potreste?». Rivolgendo ai due compagni qualcosa che stava a mezzo tra un sorriso e una smorfia minacciosa e facendo loro di nuovo segno di seguirlo, si affrettò ad attraversare un ambiente piuttosto vasto ma col soffitto basso. Si accingeva a salire la ripida scalinata, o scala piuttosto, che portava al piano di sopra del magazzino quando attraverso l'apertura in alto si vide un lampo abbagliante, seguito da una scarica di tuoni che scosse il traballante edificio da cima a fondo. «Sentite!», gridò ritraendosi di scatto. «Sentite! Tuona e crepita che sembra l'eco delle mille caverne dove i diavoli cercano di ripararsi. Odio questo fragore!». Rimase in silenzio per alcuni istanti e quindi, togliendosi improvvisamente le mani dalla faccia, mostrò quanto essa fosse stravolta e pallida, con indicibile sbigottimento del signor Bumble. «Ogni tanto mi prendono questi attacchi», disse Monks accorgendosi dell'allarme di Bumble. «Certe volte sono i tuoni a provocarli, ma non preoccupatevi per me; per ora è già passato». Così dicendo fece strada su per la scala e, chiudendo frettolosamente le imposte della finestra nella stanza in cui entrarono, abbassò per mezzo di una puleggia agganciata ad una delle pesanti travi del soffitto una lanterna appesa al capo di una corda, dalla quale una fioca luce cadeva su un vecchio tavolo e tre sedie posti sotto di essa. «Dunque», disse Monks quando si furono seduti tutti e tre. «Prima veniamo agli affari, meglio è per tutti. La donna sa di che si tratta, non è vero?». La domanda era rivolta al signor Bumble ma la moglie anticipò la risposta informandolo che era perfettamente edotta della cosa. «Lui dice che vi trovavate con quella vegliarda la sera che morì e che lei vi rivelò qualcosa...». «Sulla madre del bambino che avete nominato», rispose la direttrice interrompendolo. «Sì». «La prima domanda è: di che natura è stata quella rivelazione?», disse Monks. «È la seconda, piuttosto», osservò la donna con determinazione. «La prima è: quanto può valere quella rivelazione?» «E chi diavolo può stabilirlo, se prima non si sa di che genere è stata?», chiese Monks. «Nessuno meglio di voi, questo è certo», rispose la signora Bumble che non difettava di spirito, come il soggiogato marito poteva abbondantemente testimoniare. «Uhm!», fece espressivamente Monks, con uno sguardo indagatore. «Vorremmo ricavarci qualche soldo, eh?» «Forse», fu la riservata risposta. «Qualcosa che fu preso alla giovane», disse Monks. «Qualcosa che portava addosso. Qualcosa...». «Dovreste fare un'offerta», interruppe la signora Bumble. «Ho già sentito abbastanza per esser certa che voi siete la persona giusta con cui dovrei parlare». Il signor Bumble, che dalla sua dolce metà non era stato ammesso a condividere una parte maggiore di quel segreto di quanta non ne conoscesse dall'inizio, ascoltò questo dialogo col collo proteso e occhi sgranati, volgendoli a turno verso sua moglie e Monks, in uno stupore che non si curava di dissimulare e che crebbe, perfino, quando il secondo chiese seccamente quanto volevano per spiattellare tutto. «Quanto vale per voi?», chiese la donna senza scomporsi. «Forse niente; forse venti sterline», replicò Monks. «Parlate, così posso sapere se è l'una o l'altra». «Aggiungete cinque sterline alla somma che avete indicata, datemi venticinque sterline d'oro», disse la donna, «e vi dirò tutto quello che so. Non prima». «Venticinque sterline!», esclamò Monks ritraendosi. «Ho parlato più chiaramente che potevo», replicò la signora Bumble. «E non si tratta di una cifra strabiliante». «Non sarà strabiliante, ma è per un segreto che potrebbe rivelarsi privo di valore, morto e sepolto da dodici anni, o anche più!», gridò spazientito Monks. «Queste cose si conservano bene e, come il buon vino, spesso raddoppiano il loro valore col tempo», rispose la direttrice, sempre con l'indifferente distacco che aveva assunto all'inizio. «Quanto al morto e sepolto, parecchi resteranno morti e sepolti per i prossimi dodicimila anni, o dodici milioni, per quanto ne possiamo sapere io o voi, ma alla fine potrebbero raccontare storie incredibili!». «E se io pagassi quella somma per niente?», domandò Monks esitando. «Potreste facilmente recuperarla», replicò la direttrice. «Non sono che una donna, sola e indifesa». «Non sola, mia cara, e neanche indifesa», azzardò il signor Bumble con voce tremante di paura. «Ci sono qua io, mia cara, e poi», disse il signor Bumble battendo i denti, «il signor Monks è troppo gentiluomo per usare violenza contro qualcuno o qualcuna della parrocchia. Il signor Monks sa bene che non sono un giovanotto, mia cara, e anzi sono piuttosto attempato, se m'è lecito dire; ma lui sa, dico: lui sa, senz'alcun dubbio, che sono un funzionario estremamente determinato e dotato di forza non comune, quando mi si provoca. Non c'è che da provocarmi, ecco tutto». Così dicendo, il signor Bumble tentò pateticamente di afferrare la lanterna con feroce determinazione, mostrando nei tratti alterati del viso che in effetti occorreva una non piccola provocazione per scatenarne lo spirito bellicoso, a meno che non avesse come avversari gli orfanelli od ogni altra persona o persone educate a tale scopo. «Siete uno sciocco, e avreste fatto meglio a tenere la lingua a freno», disse per tutta risposta la signora Bumble. «Meglio avrebbe fatto a tagliarsela prima di venire, se non è capace a parlare a bassa voce», osservò Monks con asprezza. «Sicché è vostro marito, eh?» «Mio marito!», sogghignò la direttrice eludendo la domanda. «L'ho pensato appena siete entrati», ribatté Monks cogliendo lo sguardo rabbioso che la signora, così dicendo, indirizzò al suo sposo. «Tanto meglio. Sono meno restio a trattare con due persone quando so che tra loro non hanno che un'unica volontà. Dico seriamente. Guardate qua!». Ficcò la mano in una tasca laterale, e traendone fuori una borsa di tela contò venticinque sovrane sul tavolo e le spinse poi verso la donna. «Ora», disse, «raccoglietele e quando sarà passata questa dannata scarica di tuoni che pare piombare proprio sul tetto della casa, raccontate tutto». I tuoni, che sembravano in effetti scaricarsi fragorosamente proprio sulle loro teste, infine cessarono, e Monks, sollevando lo sguardo dal tavolo, si protese in avanti per sentire ciò che la donna avrebbe detto. I loro volti quasi venivano a contatto, poiché i due uomini erano curvi sul tavolinetto nell'ansia di udire, e la donna, dal suo canto, si piegava per far sì che sentissero il suo bisbiglio. La fioca luce della lanterna sospesa, cadendo direttamente su di loro, accentuava il pallore e la tensione dei loro lineamenti, i quali, sullo sfondo della tenebra e dell'oscurità più profonda, erano spettrali al massimo. «Quando quella donna che chiamavamo la vecchia Sally mori», cominciò la direttrice, «io e lei eravamo sole». «Non c'era nessun altro vicino?», chiese Monks nel medesimo bisbiglio afono. «Nessun altro idiota o disgraziato in qualche altro letto? Nessun altro che potesse udire e magari capire?» «Neanche un'anima», replicò la donna. «Eravamo sole. C'ero solo io accanto a quel corpo quando l'afferrò la morte». «Bene», disse Monks scrutandola con attenzione. «Andate avanti». «Mi disse di una giovane», riprese la direttrice, «che qualche anno prima aveva messo al mondo un bambino, in quella stessa stanza, addirittura in quello stesso letto in cui lei giaceva morente». «Ah!», fece Monks col labbro che gli tremava e guardandosi dietro le spalle. «Sangue di...! Come tutto riaffiora!». «Il bambino era quello di cui parlavate l'altra sera», disse la direttrice annuendo distrattamente verso il marito. «La donna derubata da questa vecchia era la madre». «La derubò quando era ancora viva?», chiese Monks. «No, era morta», replicò la donna, come scossa da un brivido. «Da quel corpo che era appena diventato cadavere, ella rubò ciò che la morta, col suo ultimo respiro, le aveva pregato di conservare per darlo al bimbo». «Lo vendette?», domandò Monks fremendo di impazienza. «Lo vendette o no? Dove? Quando? A chi? Quanto tempo fa?» «Subito dopo avermi detto questo, in un estremo sforzo, ricadde supina e mori». «Senza dire altro?», gridò Monks con una voce che pareva tanto più furente quanto più cupa. «È una menzogna! Non abbindolate nessuno. Ha detto dell'altro, e saprò cosa, a costo di cavarvi il sangue». «Non pronunciò neanche un'altra parola», insistè la donna senza scomporsi (lo stesso non si sarebbe potuto affermare del marito), alla strana furia dell'uomo. «Però mi strattonò la veste stringendo qualcosa in mano, e quando mi resi conto che era morta gliela aprii a forza e trovai che stringeva un pezzo di carta sudicia». «Con dentro?...», interloquì Monks protendendosi in avanti. «Niente», replicò la donna; «era la copia d'una ricevuta da un banco di pegni». «Ricevuta di che?», domandò Monks. «Ve lo dirò a suo tempo», disse la donna. «Conservò l'oggetto per un po', credo, sperando di ricavarne qualcosa, in un modo o nell'altro, e poi lo impegnò, racimolando e mettendo da parte i soldi per pagare gli interessi al banco dei pegni, anno dopo anno, dimodoché non scadesse e potesse essere riscattato se si fosse presentata l'occasione buona; ma non si presentò e, come v'ho detto, morì con in mano quel pezzetto di carta lacero e sbiadito. Mancavano due giorni alla scadenza. Pensai anch'io che un giorno o l'altro sarebbe potuto servire a qualcosa e così riscattai il pegno». «Dov'è adesso?», s'affrettò a chiedere Monks. «Qui», replicò la donna; e come contenta di potersene liberare gettò sul tavolo un borsellino di capretto grande abbastanza per poter contenere un orologino francese e Monks, afferratolo precipitosamente, lo aprì con mano fremente, strappandolo. Conteneva un medaglione d'oro nel quale c'erano due ciocche di capelli e una fede matrimoniale d'oro. «C'è il nome di Agnese inciso dal lato interno», disse la donna. «C'è uno spazio vuoto per il cognome e poi la data, di meno di un anno prima della nascita del bambino, come ho scoperto». «E questo è tutto?», disse Monks dopo un'attenta e ansiosa ispezione del contenuto del borsellino. «È tutto», replicò la donna. Il signor Bumble tirò un lungo sospiro, come lieto di vedere che il racconto era terminato senza nessun accenno al recupero delle venticinque sterline da parte di Monks, e osò a quel punto detergersi il sudore che gli era stillato indisturbato lungo il naso durante tutto il dialogo precedente. «Non so altro di questa storia, tranne quello che posso congetturare», dichiarò la moglie rivolgendosi a Monks dopo un breve silenzio. «E non voglio sapere altro; è più sicuro. Ma mi permettete un paio di domande?» «Fatele», disse Monks mostrando una certa sorpresa. «Ma se vi risponderò o meno è un'altra questione». «E così avremmo tre questioni...», osservò il signor Bumble azzardando una facezia. «È ciò che vi aspettavate di ottenere da me?», domandò la direttrice. «Sì», replicò Monks. «L'altra domanda?» «Come userete queste informazioni? Potreste usarle contro di me?» «Mai», replicò Monks. «Sarebbe come usarle contro me stesso. Guardate qua! Ma non muovetevi neanche di un passo, o la vostra vita non vale un fico secco!». Con queste parole spinse il tavolo da un lato e, tirando un anello di ferro sull'impiantito, sollevò una grossa botola che si apriva vicinissima ai piedi del signor Bumble il quale, di conseguenza, indietreggiò precipitosamente di alcuni passi. «Guardate giù», disse Monks calando la lanterna in quella voragine. «Non abbiate paura di me. Avrei potuto farvi precipitare senza troppo chiasso quando ci eravate seduti sopra se fosse stato quello il mio gioco». Così incoraggiata, la direttrice s'avvicinò all'orlo e, spinto dalla curiosità, lo stesso signor Bumble ardì imitarla. La cupa corrente sul fondo, gonfia per la forte pioggia recente, precipitava giù rapida e ogni altro rumore si perdeva nel suo fragoroso frangersi e urtare contro i pali verdognoli e viscidi. Un tempo c'era stato un mulino, e il flusso di marea, schiumando e cozzando contro assi marce e frammenti del macchinario superstite, sembrava scagliarsi in avanti con rinnovato vigore, dopo aver scavalcato gli ostacoli che invano avevano contrastato il suo corso precipitoso. «Se vi si gettasse un uomo, chissà dove sarebbe domattina», disse Monks facendo ondeggiare la lanterna avanti e indietro in quel nero pozzo. «Dodici miglia più in basso, e fatto a pezzi, per giunta», replicò Bumble rabbrividendo al solo pensiero. Monks trasse il borsellino dalla tasca dove l'aveva frettolosamente riposto, e legatolo a un peso di piombo tolto da una puleggia abbandonata sul pavimento lo lasciò cadere nella corrente: precipitò in verticale, fendette l'acqua appena udibilmente e scomparve. I tre, guardandosi reciprocamente, sembrarono respirare più liberamente. «Ecco!», disse Monks chiudendo la botola, che ricadde pesantemente nella sua sede. «Se mai il mare restituirà i suoi morti, come si legge nei libri, l'argento e l'oro lo terrà per sé assieme a quello che c'è dentro. Non abbiamo altro da dirci, e possiamo sciogliere il nostro piacevole incontro». «Certamente», convenne subito il signor Bumble. «Voi terrete la lingua a freno, nevvero?», disse Monks con uno sguardo minaccioso. «Di vostra moglie, non dubito». «Potete contare su di me, giovanotto», rispose il signor Bumble chinandosi lentamente con esagerata gentilezza mentre s'avviava alla scala. «Per il bene di tutti, giovanotto; e mio, ovviamente, signor Monks». «Sono contento per voi di sentirvelo dire», osservò Monks. «Accendete la vostra lanterna e andate via di qua più velocemente possibile». Fu una fortuna che la conversazione finisse a questo punto, o il signor Bumble, che s'era inchinato a non più di sei pollici dalla scala, sarebbe sicuramente precipitato giù nella stanza di sotto. Accese la sua lanterna da quella che Monks aveva staccato dalla corda e la resse in mano, e senza ulteriori tentativi per prolungare la conversazione scese in silenzio seguito dalla moglie. Monks seguì in retroguardia, dopo essersi fermato in cima alle scale per accertarsi che non si sentissero altri rumori oltre al picchiettare della pioggia di fuori e il fragore dell'acqua di sotto. Attraversarono il camerone di sotto lentamente, con circospezione, giacché Monks trasaliva ad ogni ombra, e il signor Bumble, con la lanterna a un piede dal suolo, procedeva non soltanto con estrema cautela ma anche con passo sorprendentemente leggero per un uomo della sua stazza, scrutando nervosamente attorno nel timore di botole nascoste. Monks aprì la serratura e schiuse il cancello (lo stesso dal quale la coppia era entrata), e i due si trovarono fuori nell'umida tenebra. Appena furono andati via Monks, che sembrava nutrire un'invincibile ripugnanza a restar solo, chiamò un ragazzo rimasto nascosto da qualche parte di sotto e, intimandogli di precederlo reggendo la lampada, ritornò nella stanza che aveva da poco lasciata. Capitolo XXXIX. Introduce qualche rispettabile personaggio già noto al lettore e mostra come Monks e l'ebreo stringano un patto non indegno di loro La sera seguente quella in cui le tre degne persone menzionate nell'ultimo capitolo sistemarono le loro faccende come lì narrato, il signor William Sikes, destandosi da un sonnellino, domandò ringhiando che ora della notte fosse. La stanza in cui Sikes formulò questa domanda non apparteneva all'abitazione che possedeva quando si era svolta la spedizione a Chertsey, benché si trovasse nello stesso quartiere della città e fosse situata a non grande distanza da essa. Era evidente che la nuova dimora non era altrettanto confortevole della precedente, consistendo di un appartamento di risicate dimensioni, squallido e spoglio, illuminato solo da una finestrella sul tetto e prospiciente un vicolo lercio e angusto. Né mancavano altri segnali che le fortune mondane del signore in questione fossero precipitate piuttosto in basso, giacché una grande penuria di mobilia e una totale assenza di comodità, assieme alla mancanza di cosucce del tipo capi di vestiario e lenzuola, tradivano uno stato di estrema povertà, e l'aspetto smagrito ed emaciato dello stesso Sikes avrebbe confermato in pieno questi indici se avessero avuto bisogno di conferma. Il ladro giaceva sul letto, avvolto nel suo cappotto bianco come fosse una veste da camera, con i lineamenti per nulla più accattivanti a causa della tinta cadaverica della malattia, a cui s'aggiungeva una sudicia cuffia da notte e una setolosa barba nera di una settimana. Il cane era accucciato a lato del letto, ora scrutando il suo padrone con sguardo ansioso, ora grattandosi le orecchie ed emettendo un sordo ringhio quando qualche rumore dalla strada o più giù nella casa attirava la sua attenzione. Seduta presso la finestra, intenta a rattoppare un vecchio panciotto che era parte dell'abbigliamento consueto del ladro, c'era una donna così pallida e smunta per le veglie e le privazioni che a malapena si sarebbe riconosciuta in lei la stessa Nancy già comparsa in questa storia, se non fosse stato per la voce che rispose alla domanda di Sikes. «Le sette passate da poco», disse la giovane. «Come ti senti stasera, Bill?» «Debole come l'acqua», replicò Sikes maledicendo i propri occhi e il corpo tutto. «Qua; dammi una mano, comunque, e aiutami a togliermi da questo dannato letto». La malattia non aveva migliorato l'umore del signor Sikes, il quale non appena Nancy l'ebbe aiutato ad alzarsi e a sistemarsi su una sedia, inveì contro di lei per essere stata maldestra in quelle operazioni e la colpì. «Ora piagnucoli, eh?», disse Sikes. «Su! Smettila di frignare. Se questo è tutto quello che sai fare allora sgombera. Mi senti?» «Ti sento», replicò la ragazza nascondendo il viso da una parte, con una risata forzata. «Che idea ti piglia?» «Oh! Ci hai ripensato, eh?», ringhiò Sikes notando una lacrima sul ciglio. «Meglio per te, se è così». «Non avrai intenzione di trattarmi male, stasera, no Bill?» «No?», esclamò Sikes. «E perché no?» «Quante notti», disse la giovane con una nota di tenerezza femminile che restituiva qualche dolcezza perfino alla sua voce, «quante notti sono rimasta accanto a te, ti ho assistito pazientemente e ti ho curato come se tu fossi stato un bambino: e tu appena riprendi conoscenza te la prendi con me. Se avessi pensato a questo, non mi avresti trattata così proprio adesso, non è vero? Di'. Dimmi che non lo avresti fatto». «E va bene», concesse Sikes. «Non lo avrei fatto. Cribbio... accidenti, s'è messa a frignare un'altra volta!». «Non è niente», disse la ragazza lasciandosi cadere su una sedia. «Non far caso a me. Ora mi passa». «Ora ti passa cosa?», domandò Sikes con voce rabbiosa. «Cosa ti frulla in testa adesso? Alzati e datti da fare, e non importunarmi con queste sciocchezze di donna». In qualsiasi altro momento questa ramanzina e il tono con cui fu pronunciata avrebbero ottenuto l'effetto desiderato, ma poiché la ragazza era davvero spossata e al limite delle forze, piegò la testa sulla spalliera della sedia e svenne prima che il signor Sikes avesse potuto proferire qualcuna delle adeguate bestemmie con cui, in casi del genere, accompagnava le sue minacce. Non sapendo bene cosa fare in quella eccezionale situazione, poiché di solito gli attacchi isterici della signorina Nancy erano violente sfuriate dalle quali veniva fuori da sé, senza troppa assistenza, il signor Sikes provò con qualche bestemmia. Trovando però che quella terapia era del tutto inefficace chiamò aiuto. «Che succede, amico mio?», disse l'ebreo affacciandosi dall'uscio. «Da' una mano a questa ragazza, vuoi?», replicò Sikes impaziente. «Non startene lì a balbettarmi e ghignarmi in faccia!». Con un'esclamazione di sorpresa Fagin si affrettò ad assistere la ragazza mentre il signor John Dawkins (altrimenti noto come Dodger), che aveva seguito il suo venerabile compare nella stanza, depositò in fretta sull'impiantito il fagotto che reggeva e, afferrata una bottiglia dalle grinfie di mastro Charley Bates che lo tallonava, in un attimo ne tolse il sughero coi denti e versò una parte del suo contenuto giù per la gola della paziente, non senza prima averne ingollato un sorso lui stesso a scanso di equivoci. «Mandale un po' d'aria fresca col soffietto, Charley», disse il signor Dawkins. «E tu, dalle dei colpetti sulla mano, Fagin, mentre Bill le slaccia la veste». L'azione combinata di questi corroboranti, impartita con grande vigore, specialmente per quanto riguarda la sezione a carico di mastro Bates, il quale pareva considerare la parte che gli toccava un incomparabile spasso, non tardò a produrre i suoi effetti. Gradualmente la ragazza riprese i sensi, e barcollando fino a una sedia accanto al letto nascose il volto sul cuscino lasciando il signor Sikes a trattare con i nuovi venuti, alquanto sorpreso alla loro inattesa comparsa. «Allora, quale vento di sciagura ti porta?», chiese a Fagin. «Nessuna sciagura, mio caro», replicò l'ebreo, «perché certi venti non portano niente di buono a nessuno e io invece ho con me qualcosa di buono che sarai contento di vedere. Dodger, mio caro, sciogli il fagotto e da' a Bill le cosette che ci son costate tutti i nostri soldi per comprarle, stamattina». Ottemperando alla richiesta del signor Fagin, Dodger sciolse il fagotto che era piuttosto grosso (una vecchia tovaglia annodata) e porse ad una ad una le cose che conteneva a Charley Bates il quale le sistemò sul tavolo con svariati encomi sulla loro rarità ed eccellenza. «Pasticcio di coniglio, Bill!», esclamò quel giovanotto mostrando un enorme sformato. «Animali così delicati, d'una carne così tenera, Bill, che le stesse ossa ti si sciolgono in bocca senza neanche bisogno di sputarle; mezza libbra di tè verde da sette scellini e sei pence, così bello forte che se lo metti nell'acqua bollente quasi quasi ti fa saltar su il coperchio della teiera; una libbra e mezza di zucchero di canna che i negri mica l'hanno dovuto lavorare per farne questa delizia, no, no! Due pagnotte di pane nero; una libbra di burro freschissimo, un pezzo di formaggio stagionato di Glo'ster, e, per finire, un poco del succo più squisito che ci si possa scolare!». Pronunciando quest'ultimo panegirico mastro Bates tirò fuori da una delle sue capaci tasche una bella bottiglia di vino accuratamente tappata, mentre contemporaneamente il signor Dawkins versava dall'altra bottiglia un bicchiere di gin che l'infermo trangugiò senza un attimo di esitazione. «Ah!», disse l'ebreo fregandosi le mani compiaciuto. «Ti gioverà Bill, ti gioverà». «Mi gioverà!», esclamò Sikes; «avrei potuto tirare le cuoia venti volte prima che voi faceste qualcosa per aiutarmi. Che significa lasciarmi in questo stato per tre settimane e più, furfante traditore?» «Ma sentitelo, ragazzi!», esclamò l'ebreo stringendosi nelle spalle. «E noi che siamo venuti a portargli queste squisitezze». «Sì, niente da obbiettare su questo», osservò Sikes un po' addolcito da uno sguardo furtivo alla tavola, «ma come giustifichi l'avermi lasciato qui affamato, malato, senza soldi e senza niente, tutto questo maledetto tempo, senza curarti di me più che se fossi stato quel cane. Portalo giù Charley!». «Non ho mai visto un cane più simpatico di questo», esclamò mastro Bates eseguendo l'ordine. «Ti annusa le cibarie come una vecchia signora al mercato! Questo cane farebbe fortuna a teatro, e riporterebbe sulla breccia il dramma!». «Piantala con queste ciarle», gridò Sikes mentre il cane si rifugiava sotto il letto continuando a ringhiare rabbioso. «Come ti giustifichi, ricettatore decrepito che non sei altro?» «Sono stato fuori Londra per più di una settimana a preparare un piano», replicò l'ebreo. «E gli altri quindici giorni?», domandò Sikes. «E gli altri quindici giorni che mi hai lasciato steso qui, come un topo malato nella sua tana?» «Non ho potuto fare altrimenti Bill» replicò l'ebreo. «Ora non posso dilungarmi a spiegarti davanti a tutti, ma non ho potuto fare altrimenti, sul mio onore!». «Sul tuo cosa?», ringhiò Sikes col massimo sprezzo. «Qua! Ragazzi, uno di voi, tagliatemi un pezzo di quello sformato per togliermi di bocca il sapore di questa corbelleria o altrimenti mi ci strozzo». «Non scaldarti, mio caro», esortò l'ebreo in tono mansueto. «Non ti ho mai dimenticato, Bill, neanche una volta». «No! Sicuro che non m'hai dimenticato», replicò Sikes con un ghigno amaro. «Sei stato a complottare e architettare tutto il tempo che sono rimasto con le convulsioni e il fuoco dentro: e Bill farà questo, e Bill farà quello, e Bill farà tutto quanto, per quattro soldi, appena si rimette; è povero quanto basta per accettare il tuo lavoro! Se non fosse stato per la ragazza, sarei morto». «Ehi Bill, Bill!», protestò l'ebreo cogliendo al volo quel richiamo. «Se non fosse stato per la ragazza! Però chi se non il vecchio Fagin si è adoperato per farti avere una così brava ragazza per assisterti?» «Questo è vero, Sikes», osservò Nancy facendosi subito innanzi. «Lascialo perdere, lascialo perdere». L'intervento di Nancy diede un nuovo indirizzo alla conversazione giacché i ragazzi, a una strizzatina d'occhi del furbo vecchio, cominciarono a offrirle il gin, anche se lei ne prese solo qualche sorso, mentre Fagin, sfoderando un insolito spirito, portava gradualmente il signor Sikes a un umore più trattabile, ricevendo le sue minacce come burbere amenità e ridendo di cuore a un paio di rozze battute che gli vennero, dopo successivi ricorsi alla bottiglia di liquore. «Sta bene», disse Sikes, «ma devo avere un po' di pecunia da voi stasera». «Non ho neanche un soldo con me», replicò l'ebreo. «Però ce ne hai parecchi a casa», ribatté Sikes, «e me ne devi anticipare una parte». «Parecchi!», gridò l'ebreo levando in alto le mani. «Ma se non ce ne ho neanche per...». «Non so quanti ce n'hai, e forse non lo sai bene neanche tu, visto che ci vorrebbe un bel po' di tempo per contarli», disse Sikes, «però ne devo avere un po' stasera, punto e basta». «E va bene!», disse l'ebreo sospirando, «manderò Dodger a prenderli». «Non farai niente del genere», ribatté Sikes. «Dodger è troppo furbo e si dimenticherebbe di tornare, o perderebbe la strada, o glielo impedirebbero i poliziotti che l'inseguono, o qualsiasi altra scusa, se tu gli dessi quell'incarico. Per maggiore sicurezza ci andrà Nancy a prendere i soldi al covo, mentre io mi stendo un po' e schiaccio un pisolino». Dopo parecchio batti e ribatti, l'ebreo ridusse da cinque sterline a tre sterline, quattro scellini e sei pence la somma chiesta in anticipo, protestando con molti e solenni giuramenti che gli sarebbero rimasti soltanto otto pence per mandare avanti la casa. Il signor Sikes brontolò che se non poteva avere di più si sarebbe accontentato di quello e Nancy si preparò ad accompagnare il vecchio a casa mentre Dodger e mastro Bates riponevano le vettovaglie nella dispensa. L'ebreo, allora, prendendo congedo dai suoi affezionati amici, se ne tornò a casa accompagnato da Nancy e dai ragazzi, mentre il signor Sikes si rimise a letto per dormire fino al ritorno della giovane. Dopo un po', Fagin e Nancy giunsero a casa dell'ebreo, dove trovarono Toby Crackit e il signor Chitling intenti alla loro quindicesima partita a cribbage - tutte perdute, neanche a dirlo, dal secondo, a sei pence a botta, fino ai suoi ultimi sei pence, con gran divertimento dei suoi giovani amici. Il signor Crackit, evidentemente vergognandosi di essersi fatto sorprendere a divertirsi con un giovanotto tanto inferiore a lui per condizione e doti intellettuali, sbadigliò, e chiedendo di Sikes prese il cappello per uscire. «Non è venuto nessuno, Toby?», chiese l'ebreo. «Nemmeno un cane», rispose il signor Crackit, tirandosi su il bavero. «Un mortorio, peggio della birra svaporata. Mi dovresti offrire una bella bevuta, Fagin, come ricompensa per aver badato a casa tua tanto tempo. Cribbio, ho la gola secca come quella di un prete e me ne sarei andato a letto all'ora dei carcerati se non avessi avuto la bontà di far divertire un poco questo giovanotto. Una noia da darsi i pizzichi; che sia dannato se non è così!». Con queste e altre simili esclamazioni il signor Toby Crackit radunò le sue vincite e se le ficcò nel taschino del panciotto con aria distaccata, come se quelle monetine d'argento fossero assolutamente indegne della considerazione di un uomo della sua statura. Fatto questo caracollò fuori della stanza con tanta eleganza e finezza che il signor Chitling, dopo aver gettato svariate occhiate entusiastiche alle gambe e alle scarpe di lui finché non scomparvero, assicurò la compagnia che riteneva di aver pagato quella conoscenza assai poco cara, ad appena mezzo scellino a partita, per quindici volte, e che le sue perdite ammontavano a meno di un'unghia. «Quanto sei buffo, Tom!», disse mastro Bates parecchio divertito da questa dichiarazione. «Neanche per sogno», replicò il signor Chitling. «Non è vero Fagin?» «Sei un tipo in gamba, mio caro», disse l'ebreo battendogli sulla spalla e facendo l'occhiolino agli altri suoi discepoli. «E il signor Crackit è un bell'elegantone, non è vero, Fagin?», chiese Tom. «Su questo non c'è dubbio, mio caro», replicò l'ebreo. «E si può essere orgogliosi d'aver fatto la sua conoscenza, non è vero Fagin?», continuò Tom. «Proprio così, mio caro», replicò l'ebreo. «Sono solo gelosi perché non ha dato loro la stessa possibilità». «Uh!», esclamò Tom trionfante. «Proprio! Mi ha pelato, però posso rifarmi i soldi quando mi pare, non è vero, Fagin? Basta qualche giretto per strada». «Ma certo!», replicò l'ebreo. «E prima esci meglio è, Tom, dimodoché ti rifai delle perdite senza perder tempo. Dodger! Charley! È ora di guadagnarvi la giornata. Su! Sono quasi le dieci, e qui si sta battendo la fiacca». Obbedendo al suggerimento i ragazzi, con un cenno di saluto a Nancy, presero i cappelli e lasciarono la stanza. Mentre andavano Dodger e i suoi allegri compagni si scambiarono parecchie battute a proposito del signor Chitling nella cui condotta, a onor del vero, non v'era stato nulla di straordinario o singolare, poiché la città abbonda di giovani di spirito che pagano un prezzo ben maggiore del signor Chitling per esser visti in società, e di personcine raffinate (gli appartenenti alla detta società) che fondano la loro reputazione sulle stesse e medesime basi di Toby Crackit l'elegantone. «Allora», disse l'ebreo non appena ebbero lasciata la stanza, «ti vado a prendere quei soldi, Nancy. Questa è solo la chiave di una piccola credenza dove tengo le cianfrusaglie che mi portano i ragazzi, mia cara. Non chiudo mai a chiave i soldi, perché non ne ho proprio, mia cara... ah!, ah! ah!... non ne ho proprio. È un mestiere che rende poco, e non ti ringrazia nessuno, ma mi piace vedermi attorno la gioventù, e perciò sopporto tutto, sopporto tutto. Zitta!», disse affrettandosi a nascondere la chiave in un taschino. «Chi è? Ascolta!». La ragazza, seduta al tavolo a braccia conserte, non sembrò per nulla interessata a quell'arrivo, né curarsi se la persona in questione, chiunque fosse, arrivasse o andasse via, finché non le giunse all'orecchio il borbottio di una voce maschile. Non appena l'udì, si tolse la cuffia e lo scialle e con la rapidità del lampo li gettò sotto il tavolo. L'istante dopo, voltandosi l'ebreo verso di lei, farfugliò un lamento sul caldo soffocante, in un tono languido che contrastava singolarmente con l'estrema rapidità e violenza del suo gesto. Fagin comunque, che in quel momento le voltava le spalle, non l'aveva notato. «Bah!», bisbigliò l'ebreo come perplesso da quella interruzione. «È la persona che aspettavo prima. Sta scendendo da noi. Non una parola sui soldi finché resta qua, Nancy. Non si fermerà per molto. Neanche dieci minuti, mia cara». Mentre s'udivano dei passi scendere le scale l'ebreo, portandosi il dito ossuto alle labbra, prese una candela e andò alla porta. Vi arrivò contemporaneamente al visitatore, il quale, entrando a precipizio nella stanza, si trovò accanto alla ragazza prima di accorgersene. Era Monks. «È solo una delle mie ragazze», disse l'ebreo osservando che Monks, notando la sconosciuta, indietreggiava. «Non muoverti, Nancy!». La ragazza s'accostò ancor di più al tavolo e, dopo aver dato un'occhiata a Monks con aria distratta, distolse gli occhi. Quando però lui si volse verso l'ebreo lo guardò ancora, ma con una occhiata così scrutatrice e inquisitiva, che se qualcuno fosse stato lì a notare il cambiamento a stento avrebbe potuto credere che le due occhiate potessero provenire dalla stessa persona. «Novità?», domandò l'ebreo. «Grandi». «E... e... buone...?», chiese l'ebreo esitando, come temendo di infastidire l'altro con la troppa insistenza. «Non cattive, ad ogni modo», replicò Monks con un sorriso. «Questa volta sono stato abbastanza pronto. Posso dirvi una parola in privato?». La ragazza si avvicinò ancora al tavolo ma non si offrì di lasciare la stanza, sebbene potesse vedere che Monks indicava proprio lei. Forse temendo che potesse sfuggirle qualcosa circa il denaro se avesse tentato di sbarazzarsi di lei, l'ebreo fece un cenno verso il piano di sopra e condusse Monks fuori dalla stanza. «Non quel buco infernale dell'altra volta», Nancy udì l'uomo dire mentre i due salivano di sopra. L'ebreo rise, e replicando qualcosa che ella non potè intendere - a causa, probabilmente, dagli scricchiolii delle tavole - sembrò condurre il compagno al secondo piano. Prima che il calpestio dei loro passi cessasse di echeggiare per la casa, la ragazza s'era tolte le scarpe e s'era sfilata la veste dalla testa. Fasciatesi con quella le braccia, si fermò in piedi accanto alla porta trattenendo il respiro e tendendo le orecchie. Nel medesimo istante in cui i rumori cessarono scivolò fuori della stanza, salì le scale con incredibile silenziosità e scomparve nell'oscurità. La stanza rimase deserta per un quarto d'ora o più. La ragazza ridiscese con lo stesso passo spettrale con cui era salita. Sentì i due uomini scendere e subito dopo Monks uscì in strada mentre l'ebreo risalì di nuovo per i soldi. Quando rientrò nella stanza la ragazza si stava aggiustando lo scialle e la cuffia, come preparandosi a uscire. «Ehi, Nancy», esclamò l'ebreo con uno scatto all'indietro non appena ebbe sistemato la candela sul tavolo. «Come sei pallida!». «Pallida!», fece eco la ragazza riparandosi gli occhi con la mano come per osservarlo meglio. «Tremendo», disse l'ebreo. «Cos'hai combinato?» «Niente, che io sappia, tranne restare seduta qui dentro per chissà quanto tempo», rispose con distacco la ragazza. «Su! Spicciamoci». Sospirando ad ogni moneta, Fagin le contò in mano la somma convenuta. Si separarono senza scambiare altre parole a parte il saluto di "buona notte". Raggiunta una strada ampia, la ragazza sedette sui gradini di un portone, e per alcuni momenti sembrò completamente spaesata e incapace di proseguire il cammino. Improvvisamente s'alzò, e affrettandosi nella direzione opposta a quella dalla quale Sikes attendeva il suo ritorno, accelerò il passo fino a che, mano a mano, non lo mutò in una corsa forsennata. Infine, spossata, si fermò a riprender fiato e, come se tornasse improvvisamente in sé e biasimasse la sua incapacità a condurre a termine il suo compito, stringendosi le mani scoppiò a piangere. Improvvisamente, fosse stato il pianto a darle sollievo, o avvertisse la totale disperazione del suo stato, si girò, precipitandosi nella direzione opposta e, in parte per recuperare il tempo perduto, in parte adeguando l'andatura al turbine dei propri pensieri, raggiunse subito la casa dove aveva lasciato il ladro. Sikes non s'avvide se ella tradisse una qualche agitazione quando entrò nella stanza, poiché si limitò a chiederle se avesse portato il denaro; avuta una riposta affermativa, con un grugnito di soddisfazione adagiò di nuovo la testa sul cuscino e riprese il sonno interrotto dal suo arrivo. Il giorno seguente, per sua fortuna, il denaro ricevuto fece sì che Sikes indulgesse al mangiare e al bere, e ciò produsse un effetto così benefico, addolcendo le asperità del suo carattere, che non ebbe né il tempo né la disposizione giusta per sorvegliare con attenzione l'aspetto e il comportamento di lei. Che ella avesse quel fare assente e nervoso di chi s'accinge a compiere qualche passo rischioso e ardito, quando assumere una decisione implica una tremenda lotta interiore, sarebbe risultato piuttosto ovvio all'occhio di lince dell'ebreo, che si sarebbe immediatamente messo in allarme; ma il signor Sikes, incapace di discriminazioni sottili, e non turbato da altri presentimenti se non quelli che si risolvono in una burbera scontrosità di modi verso chiunque, e trovandosi inoltre in una condizione di insolita affabilità, come si è già osservato, non vide nulla di eccezionale nella sua condotta e per la verità si dava così poco pensiero di lei che, anche se la sua agitazione fosse stata di gran lunga più percepibile di quanto non era, molto difficilmente se ne sarebbe insospettito. Verso sera la ragazza parve più nervosa, e quando scese la notte, mentre, seduta, aspettava che il ladro s'addormentasse dopo il gran bere, le si vedeva un così insolito pallore sulle guance e un tal fuoco negli occhi che perfino Sikes, sorpreso, lo notò. Sikes, debole per la febbre, giaceva a letto bevendo gin allungato con acqua bollente e aveva spinto il suo bicchiere verso Nancy perché glielo riempisse per la terza o quarta volta, quando questi indizi lo colpirono. «Cribbio!», disse l'uomo alzandosi sulle braccia mentre fissava in viso la ragazza. «Sembri un cadavere ambulante. Che ti succede?» «Che mi succede!», replicò la ragazza. «Niente. Perché mi fissi a quel modo?» «Che idee ti passano per la testa?», domandò Sikes afferrandola per il braccio e scuotendola rudemente. «Cosa c'è? Che intenzioni hai? A che pensi?» «A tante cose, Bill», replicò la ragazza tremando e premendosi le mani sugli occhi. «Dio mio! Cosa dovrebbe succedermi?». Il tono di forzata gaiezza con cui furono pronunciate queste ultime parole sembrò produrre su Sikes un'impressione più profonda dell'aspetto rigido e sconvolto che le aveva precedute. «Te lo dico io cosa», fece Sikes. «Se non ti sei buscata una febbre o non ti viene proprio adesso, c'è qualcosa di parecchio strano nell'aria, e pericoloso per giunta. Non è che stai... no, dannazione! Non saresti capace!». «Capace di cosa?», chiese la ragazza. «No», disse Sikes fissando gli occhi su di lei e borbottando tra sé, «non c'è una ragazza più fidata di lei, in giro, o le avrei già tagliato la gola tre mesi fa. Si sta buscando una febbre, ecco tutto». Così rassicuratosi, Sikes scolò il bicchiere e poi, borbottando imprecazioni, chiese la sua medicina. La ragazza scattò in piedi, la versò prontamente volgendogli le spalle, e poi gli resse il bicchiere alle labbra mentre lui ne beveva il contenuto. «Allora», disse il ladro, «vieni a sederti vicino a me e metti su la tua solita faccia oppure ti cambio talmente i connotati che tu stessa non ti riconoscerai più». La ragazza obbedì. Sikes, prendendole una mano nella sua, ricadde sul cuscino tenendo gli occhi sul viso di lei. Si chiusero, si riaprirono, si richiusero, si riaprirono di nuovo. Egli si voltava nel letto senza pace, e dopo aver sonnecchiato per due o tre minuti una prima e una seconda volta, dopo un'improvvisa scossa per girare attorno uno sguardo atterrito e vacuo, cadde di colpo, proprio mentre tentava di sollevarsi, in un sonno pesante e profondo. La stretta della mano si allentò, il braccio sollevato gli ricadde al fianco privo di forze e giacque come in catalessi. «Il laudano ha avuto effetto finalmente», mormorò la ragazza alzandosi. «Ma forse è già troppo tardi». Indossò in fretta la cuffia e lo scialle, di tanto in tanto guardandosi intorno impaurita come se, nonostante il sonnifero, s'aspettasse di sentire da un momento all'altro la pressione della pesante mano di Sikes sulla spalla. Quindi, chinandosi piano sul letto, baciò le labbra del ladro e, aperta e richiusa la porta della stanza senza far rumore, si affrettò ad allontanarsi dalla casa. Una ronda stava gridando le nove e mezza in un buio vicolo per il quale ella doveva passare per raggiungere la via principale. «È passata da molto la mezza?», chiese la ragazza. «Manca un altro quarto al tocco», rispose l'uomo alzandole la lanterna in viso. «E mi ci vorrà più di un'ora per arrivarci», mormorò Nancy sfiorandolo nel passare oltre e scivolando rapidamente lungo la strada. Molti negozi stavano già chiudendo nei vicoli e nelle strade attraverso cui passava per recarsi da Spitalfields al West-End. L'orologio batté le dieci, accrescendo la sua impazienza. Facendosi largo tra i passanti con gomitate a destra e a sinistra, si precipitava lungo gli stretti marciapiedi, e quasi lanciandosi sotto il muso dei cavalli, attraversava strade affollate a lato delle quali gruppi di persone attendevano nervosamente l'opportunità di passare. «Quella donna è pazza!», diceva la gente voltandosi a guardarla mentre s'allontanava. Quando raggiunse il quartiere più ricco della città le strade si fecero relativamente spopolate e la sua andatura forsennata suscitò una curiosità ancora più grande nei passanti che incontrava. Alcuni acceleravano il passo dietro di lei, come curiosi di vedere dove stesse andando così spedita; altri le passavano davanti e si voltavano sorpresi della andatura che non subiva rallentamenti; ma uno a uno cedevano, e quando fu prossima al luogo di destinazione, nessuno più la seguiva. Era giunta presso un hotel familiare in una graziosa e quieta stradina vicino a Hyde Park. Mentre la vivida luce della lampada accesa sulla porta la guidava in quella direzione, l'orologio batté le undici. Rimase come incerta se proseguire, ma quel rintocco la fece decidere ed entrò nell'edificio. La guardiola del portiere era vuota. Scrutò intorno incerta e si diresse verso le scale. «Ehi, giovane!», disse una donna elegantemente vestita affacciandosi da una porta dietro di lei. «Chi cercate qui?» «Una signorina che alloggia in questa casa», rispose la ragazza. «Una signorina», fu la risposta accompagnata da uno sguardo sprezzante. «Quale signorina?» «La signorina Maylie», disse Nancy. La giovane donna, prendendo nel frattempo nota del suo aspetto, si limitò ad uno sguardo di virtuoso sdegno e chiamò un uomo affinché potesse risponderle. A lui Nancy ripetè la sua domanda. «Chi devo annunciare?», domandò il cameriere. «Non serve il nome», replicò Nancy. «E neanche il motivo?» disse l'uomo. «No, neanche quello», ribatté la ragazza. «Devo vedere la signorina». «Via!», disse l'uomo mettendola alla porta. «Questo non va! Andate via». «Mi dovrete trascinare a viva forza per scacciarmi», replicò la ragazza adirata, «e darei filo da torcere anche a due di voi. Non c'è nessuno qui», disse guardandosi intorno, «che voglia portare un semplice messaggio per una povera sciagurata come me?». Questo appello produsse un certo effetto sul cuoco dalla faccia bonaria che, assieme a qualche altro servitore, osservava la scena e che intervenne chiedendo: «Prendiglielo tu Joe, vuoi?» «Ma è inutile!», replicò l'uomo. «Non crederai che la signorina voglia vedere una così, non è vero?». Questa allusione alla dubbia reputazione di Nancy sollevò una notevole, casta indignazione nel petto delle quattro cameriere le quali, infervorate, osservarono che quella lì disonorava il loro sesso e perorarono vibratamente affinché fosse gettata nel canale, senza pietà. «Disponete di me come vi piace», ribatté la ragazza rivolgendosi di nuovo agli uomini, «ma prima fate quello che vi chiedo, e cioè: consegnate questo messaggio, in nome di Dio onnipotente». Al che il cuoco dal cuore tenero fece seguire la sua intercessione e il risultato fu che l'uomo uscito per primo s'offri di recapitarlo. «Cosa devo riferire?», chiese, già con un piede sullo scalino. «Che una giovane chiede di poter parlare da sola con la signorina Maylie», disse Nancy, «e che se vorrà ascoltare anche soltanto la prima parola di ciò che ha da dirle, si renderà conto se è il caso di ascoltare il resto o di buttarla fuori dalla porta come una sfrontata». «Ma», obbiettò l'uomo, «non state calcando la mano un po' troppo?» «Portate questo messaggio e datemi la risposta», ribatté la ragazza con fermezza. L'uomo corse di sopra. Nancy pallida e trafelata, con le labbra tremanti, dovette ascoltare le udibilissime e copiose parole di disprezzo pronunciate dalla bocca delle caste cameriere, ancor più copiose quando l'uomo tornò dicendo che la giovane era desiderata di sopra. «Non serve a nulla comportarsi per bene in questo mondo», esclamò la prima cameriera». «L'ottone vale più dell'oro temprato al fuoco», disse la seconda. La terza si limitò a chiedersi «cosa rendeva signora una signora» e la quarta si riallacciò alla prima dando avvio ad un "Vergogna!" a quattro voci, che fu la loro nota conclusiva. Incurante di ciò, poiché aveva a cuore faccende più importanti, Nancy, tremando tutta, seguì l'uomo in una piccola anticamera illuminata da una lampada appesa al soffitto. Qui egli la lasciò e si ritirò. Capitolo XL. Uno strano colloquio, che è il seguito del capitolo precedente La vita della ragazza s'era sciupata nelle strade, nei postriboli e nei covi più degradati di Londra, ma in lei c'era ancora qualcosa dell'originaria natura femminile. Quando perciò sentì un passo leggero avvicinarsi alla porta di fronte a quella da cui era entrata e pensò al forte contrasto che presto ci sarebbe stato in quella stanza, fu sopraffatta dalla propria vergogna e indietreggiò come se non potesse sopportare la presenza della persona con cui aveva voluto parlare. Contrastava però con questi sentimenti l'orgoglio, vizio delle creature più basse e degenerate non meno di quelle più in alto e tutte d'un pezzo. Lei, miserabile compagna di ladri e ruffiani, rifiuto delle case più malfamate, complice di avanzi di galera, sulla cui esistenza incombeva la forca, perfino lei, nella sua abiezione, sentiva troppo orgoglio per tradire finanche un barlume di tenerezza femminile. La riteneva una debolezza, pur se essa soltanto la legava a quella umanità della quale la sua vita sciagurata aveva cancellato così tante tracce fin da quando era bambina. Sollevò gli occhi quanto bastava per notare che la persona entrata era una giovane graziosa e snella; quindi, volgendoli a terra, con uno scatto della testa e ostentando indifferenza disse: «Difficile riuscire a vedervi, signora. Se mi fossi offesa e fossi andata via, come tante avrebbero fatto, un giorno avreste potuto pentirvene e a buon motivo anche». «Mi dispiace se qualcuno vi ha trattata male», replicò Rose. «Non pensateci più. Ditemi perché volevate vedermi. Sono io la persona di cui avete chiesto». Il tono di questa risposta, la voce dolce, le maniere gentili, l'assenza di ogni accento altezzoso o di fastidio colsero la ragazza di sorpresa, e la fecero piangere. «Oh signora, signora!», ella disse giungendo le mani supplichevole, «se ce ne fossero di più come voi, sarebbero meno quelle come me, sì... sì...!». «Sedete», disse Rose premurosa, «mi mettete a disagio. Se patite la miseria o siete afflitta, sarò veramente lieta di aiutarvi, se posso... veramente! Sedete». «Vorrei restare in piedi, signorina», disse le ragazza sempre piangendo, «e non parlatemi tanto gentilmente prima di conoscermi meglio. Si fa tardi. La porta... è chiusa?» «Sì», disse Rose indietreggiando di alcuni passi come per essere più vicina ad un aiuto in caso ne avesse bisogno. «Perché?» «Perché sto per mettere la vita mia e quella di altri nelle vostre mani», disse la ragazza. «Io ho riportato Oliver dal vecchio Fagin, l'ebreo, la sera in cui uscì dalla casa di Pentonville». «Voi!», esclamò Rose Maylie. «Io, signorina!», replicò la ragazza. «Sono io l'infame creatura di cui voi avete sentito parlare, che vive con i ladri e che, dal primo momento in cui i suoi occhi e i suoi sensi frequentarono le strade di Londra, non ha mai conosciuto una vita migliore o parole più gentili di quelle dei bassifondi, che Dio m'aiuti! Sì, allontanatevi da me, signora. Sono più giovane di quanto non dica il mio aspetto, ma a questo ci sono fin troppo abituata. Anche le donne più povere mi scansano quando passo lungo i marciapiedi affollati». «Sono parole terribili queste!», esclamò Rose involontariamente ritraendosi da quella strana compagna. «Ringraziate il Cielo in ginocchio, cara signorina», gridò la ragazza, «di avere avuto amici che si curassero di voi e vi proteggessero nell'infanzia e di non aver mai dovuto patire il freddo e la fame, le risse e l'ubriachezza e... qualcos'altro di peggio ancora... così come li ho patiti io fin da piccina. Lo dico a ragion veduta, perché un vicolo e una cunetta furono la mia culla, così come saranno il mio letto di morte». «Vi compatisco!», esclamò Rose con voce rotta. «Mi si stringe il cuore a sentirvi!». «Il Cielo vi benedica per la vostra bontà», riprese la ragazza. «Se sapeste come sono, a volte, mi compatireste davvero. Ma non posso far insospettire con una assenza troppo lunga chi sicuramente mi ucciderebbe se sapesse che sono venuta qui a raccontarvi ciò che ho sentito. Conoscete un uomo che si chiama Monks?» «No», rispose Rose. «Lui vi conosce», replicò la ragazza, «e sapeva che eravate qui, giacché proprio sentendo menzionare da lui questo indirizzo ho potuto trovarvi». «Non ho mai sentito quel nome», disse Rose. «Allora significa che va sotto altro nome», riprese la ragazza. «Più d'una volta me n'è venuto già il sospetto. Qualche tempo fa, subito dopo che Oliver fu portato a casa vostra, la notte del furto, sospettando di lui, ho origliato al buio una conversazione che ebbe con Fagin. Da quello che sentii, ho scoperto che Monks, l'uomo di cui vi ho chiesto prima, ricordate?» «Sì», disse Rose. «Ricordo». «Quel Monks», continuò l'altra, «lo aveva visto per caso con due dei nostri ragazzi il giorno che lo perdemmo la prima volta, e subito lo riconobbe per lo stesso ragazzo di cui lui era alla ricerca, per motivi che mi rimasero sconosciuti. Fece un patto con Fagin: se riportavano indietro Oliver gli avrebbe pagato una certa somma, e poi dell'altro denaro ancora se avesse fatto di lui un ladro, cosa su cui questo Monks insisteva molto per qualche suo disegno particolare». «E quale?», domandò Rose. «Purtroppo intravide la mia ombra sul muro mentre origliavo per scoprirlo», disse la ragazza, «e non ce n'è molte capaci di sgusciar via in tempo senza farsi pizzicare come me. Ma ci riuscii, e poi non l'ho più visto fino alla notte passata». «E cosa è successo dopo?» «Ora vi racconto, signorina. La notte passata è tornato. Lui e Fagin se ne sono andati di sopra un'altra volta e io, avvolgendomi con degli indumenti di modo che l'ombra non mi tradisse, mi appostai di nuovo per origliare da dietro la porta. Le prime parole che sentii da Monks furono queste: "e così le uniche prove dell'identità del ragazzo giacciono in fondo al fiume, e la vecchia che l'aveva saputa dalla madre marcisce nella bara". Risero e parlarono di come tutto gli fosse riuscito felicemente. Poi Monks, parlando ancora del ragazzo e infuriandosi parecchio, disse che, sebbene si fosse ormai impadronito definitivamente dei soldi di quel piccolo demonio, desiderava tenerlo in pugno, e che sarebbe stato un bello spasso, ribaltando l'orgoglioso testamento paterno, se fossero riusciti a spedire il ragazzo in ogni prigione della città e poi all'impiccagione per qualche crimine da pena capitale in cui Fagin avrebbe potuto facilmente coinvolgerlo dopo averlo prima sfruttato per un po'». «Cosa dite!», esclamò Rose. «La verità, signorina, anche se pronunciata dalle mie labbra», replicò la ragazza. «Poi, con bestemmie a cui il mio orecchio è abituato, ma non il vostro, disse che se avesse potuto soddisfare il suo odio uccidendo il ragazzo senza rischiare il proprio collo, l'avrebbe spacciato volentieri, ma poiché questo non era possibile lo avrebbe costantemente tenuto sott'occhio in ogni passo della sua vita, e nel caso il ragazzo avesse tirato in ballo i suoi natali e la sua storia, avrebbe sempre potuto rovinarlo all'istante. "Insomma, Fagin", disse, "sarai pure ebreo, ma non hai mai architettato una trappola come quella tesa da me al mio fratellino Oliver"». «Suo fratello!», esclamò Rose. «Queste sono state le sue parole», disse Nancy guardandosi intorno inquieta, non avendo mai cessato di farlo da quando aveva iniziato a parlare, poiché era ossessionata dal fantasma di Sikes. «Anzi, quando ha parlato di voi e dell'altra signora dicendo che sembrava un complotto del Cielo o del diavolo contro di lui se Oliver era finito tra le vostre braccia, si mise a ridere e osservò che anche in questo c'era del buono, poiché chissà quante migliaia o centinaia di migliaia di sterline sareste stata disposta a dare, se le aveste avute, per conoscere l'identità di questo bastardo a due zampe». «Non vorrete raccontarmi che dicesse tutto questo seriamente», disse Rose sbiancando. «Era più che mai serio e determinato», replicò la ragazza scuotendo la testa. «L'odio lo rende spietato, e pure se conosco parecchi più feroci di lui, preferirei ascoltarli tutti una dozzina di volte, piuttosto che risentire quel Monks una volta soltanto. Si sta facendo tardi e devo tornare a casa prima che mi sospettino d'essere andata in giro a spifferare cose. Devo andare via subito». «Ma io cosa posso fare?», chiese Rose. «Come posso usare ciò che mi avete rivelato se ora ve ne andate? Perché volete tornare tra coloro che dipingete con colori così terribili? Se ripetete tutto ad una persona che potrei chiamare subito dalla stanza accanto, nel giro d'una mezz'ora potremmo condurvi in un luogo sicuro». «Voglio tornare», disse la ragazza. «Devo tornare perché... ma come lo spiego a una giovane innocente come voi?... perché tra gli uomini di cui vi ho parlato ce n'è uno, il più sciagurato di tutti, che io non posso lasciare, no, neanche per salvarmi dalla vita che conduco». «Vi siete già esposta a difesa del ragazzo», disse Rose, «e siete venuta qui correndo un rischio grandissimo per raccontarmi ciò che avete udito. I vostri modi, che mi fanno persuasa della verità di ciò che dite, e il vostro evidente pentimento e la vergogna che provate m'inducono a credere che potreste ancora salvarvi. Oh!», supplicò la giovane giungendo le mani mentre le scendevano lacrime sul viso, «non chiudete il cuore alle suppliche di un'altra donna; la prima... la prima, credo, che vi abbia mai supplicato con la voce della pietà e della compassione. Date ascolto alle mie parole e lasciate che vi salvi per una vita più degna». «Signorina», gridò la ragazza cadendo in ginocchio, «caro, dolce angelo, voi siete la prima che mi abbia mai benedetta con tali parole, e se le avessi sentite diversi anni fa, forse avrebbero potuto togliermi da una vita di peccato e sofferenza; ma è troppo tardi... troppo tardi!». «Non è mai troppo tardi per pentirsi e cambiare», disse Rose. «Lo è», gridò la ragazza col tormento nell'animo. «Non posso lasciarlo proprio ora! Non posso essere la causa della sua morte». «Perché la sua morte?», chiese Rose. «Non potrebbe evitarla», esclamò la ragazza. «Se dicessi ad altri ciò che ho detto a voi, e li catturassero tutti, lui sarebbe sicuramente mandato a morte. È il più temerario e ha commesso terribili crudeltà!». «Possibile», esclamò Rose «che per un uomo come questo voi possiate rinunciare ad ogni speranza futura e alla certezza di un soccorso immediato? È una follia». «Forse», rispose la ragazza, «ma è così, e non soltanto per me ma per centinaia di altre sciagurate come me. Devo tornare. Non so se sia l'ira di Dio a causa del male compiuto, ma ogni sofferenza e ogni maltrattamento paiono ricondurmi a lui e così sarebbe, credo, anche se sapessi di dover morire per mano sua». «Cosa devo fare?», disse Rose. «Non posso lasciarvi andar via così». «È meglio di sì, e so che lo farete», ribatté la ragazza alzandosi. «Non mi impedirete di andare via perché ho avuto fiducia nella vostra bontà e non vi ho strappato nessuna promessa quando avrei potuto benissimo ottenerla». «Ma allora come potrò usare le informazioni che mi avete date?», disse Rose. «Questo mistero dev'essere sviscerato; altrimenti, se resta confinato solo a me, come può andare a beneficio di Oliver, che siete tanto ansiosa di aiutare?» «Dovrete confidarlo a qualche gentiluomo di cui vi fidate e che possa consigliarvi sul da farsi», replicò la ragazza. «Dove potrò ritrovarvi se fosse necessario?», chiese Rose. «Non voglio sapere dove vivono queste orribili persone, ma dove e quando potervi trovare in strada, d'ora in poi». «Mi promettete di custodire gelosamente questo segreto e di venire da sola, o soltanto con la persona a cui lo confiderete, e di non farmi seguire o sorvegliare?», chiese la ragazza. «Ve lo prometto solennemente», rispose Rose. «Ogni sabato notte, dalle undici fino al tocco delle dodici», disse la ragazza senza esitare, «passeggerò su London Bridge, se sono viva». «Restate ancora un minuto», pregò Rose interponendosi quando la ragazza si diresse in fretta verso la porta. «Pensate ancora una volta alla vostra condizione e all'opportunità che vi si presenta per uscirne. Io ho un debito con voi, non solo perché mi avete volontariamente portato queste informazioni ma perché a voi non può giungere altro aiuto. Volete tornare da questa banda di ladri e da quest'uomo quando una sola parola può salvarvi? Che fascino subite per tornare indietro ad abbracciare malvagità e squallore? Oh! Non c'è nessuna corda nel vostro cuore che io possa toccare? Non vi è rimasto nulla a cui io possa appellarmi contro questa terribile infatuazione!». «Quando donne giovani, belle e buone come voi», replicò la ragazza appassionatamente, «donano il proprio cuore, l'amore farà superare loro ogni ostacolo... perfino a chi, come voi, ha una casa, amici, ammiratori, e ogni altra fortuna. Quando una come me - che non ha tetto più certo di un coperchio di bara e nessun amico, nella malattia o nell'agonia, tranne un'infermiera di ospedale - dà il suo cuore marcio a un uomo qualsiasi e lascia che lui occupi un posto rimasto vuoto per tutta la sua sciagurata vita, chi può sperare di guarirla? Compatiteci, signorina, compatiteci, perché non ci resta che un ultimo sentimento di donna, e perché per una dura legge, invece di darci conforto e orgoglio, è soltanto causa di nuovo dolore e afflizione». «Accettereste da me del denaro che possa permettervi di vivere non disonestamente... almeno finché non ci incontriamo di nuovo?» «Neanche un penny», replicò la ragazza con un diniego della mano. «Non chiudete di nuovo il cuore a ogni mio sforzo per aiutarvi», disse Rose avvicinandosi cautamente. «Voglio sinceramente aiutarvi». «Mi aiutereste di più», replicò la ragazza torcendosi le mani, «se poteste liberarmi della vita all'istante, perché ho provato più dolore stasera sentendo ciò che sono, di quanto ne abbia mai provato, e sarebbe già qualcosa non morire nello stesso inferno in cui sono sempre vissuta. Dio vi benedica, dolce signora e vi riversi sul capo altrettanta felicità della vergogna che ho gettato sul mio!». Così dicendo, scossa dai singhiozzi, l'infelice creatura andò via, mentre Rose Maylie, sopraffatta da questo straordinario colloquio che somigliava più a un sogno turbinoso che a un evento reale, si accasciava su una sedia cercando di riordinare il caos dei propri pensieri. Capitolo XLI. Contiene nuove scoperte e mostra che le sorprese, come le disgrazie, di rado arrivano sole La situazione che aveva di fronte era, in effetti, di non comune difficoltà. Se da un lato provava un intensissimo, bruciante desiderio di penetrare il mistero in cui era avvolta la storia di Oliver, dall'altro non poteva non considerare sacra la fiducia che la sventurata giovane, con la quale aveva appena parlato, aveva riposto in lei, sua innocente coetanea. Le parole e le maniere di lei avevano toccato il cuore di Rose Maylie che, oltre all'amore per il piccolo amico, provava il non meno sincero e appassionato desiderio di portare al ravvedimento e alla speranza quella reietta. S'era proposta, con la zia, di restare a Londra tre soli giorni prima di recarsi a trascorrere qualche settimana in una lontana località marina. Era la mezzanotte del primo di quei giorni. Ma quale piano di azione avrebbe potuto escogitare da condurlo a termine nel giro di quarantott'ore? O come avrebbe potuto posticipare il viaggio senza suscitare sospetti? Era con loro, e vi sarebbe rimasto per altri due giorni, il signor Losberne ma Rose conosceva troppo bene l'irruenza di quel perfetto gentiluomo per non prevedere, fin troppo chiaramente, con quale esplosione di rabbia egli avrebbe considerato colei che sarebbe dovuta essere strumento del ritrovamento di Oliver, e ciò la dissuadeva dal rivelargli il segreto, a meno che le sue parole in favore della giovane non fossero state sostenute da una persona matura. Eran tutte ragioni queste, per usare la massima cautela e circospezione nel comunicare la cosa alla signora Maylie, il cui primo impulso sarebbe stato certamente il cercare un colloquio su quell'argomento con il degno dottore. Per le stesse ragioni, non c'era neanche da pensare a ricorrere al consiglio di un avvocato, anche se avesse saputo dove trovarlo. Ebbe anche l'idea di cercare l'aiuto di Harry, ma le tornò il ricordo della loro separazione, e le sembrò poco dignitoso da parte sua richiamarlo ora che lui - e le sgorgarono lacrime nel corso di questi pensieri - aveva forse imparato a dimenticarla e a essere felice lontano da lei. Turbata da queste varie riflessioni, propensa ora a seguire una certa linea d'azione, ora un'altra, e poi di nuovo scartando entrambe allorché ci rifletteva meglio, Rose passò una notte d'angoscia insonne. Il giorno seguente, dopo essersi di nuovo arrovellata su tali pensieri, giunse alla conclusione disperata di consigliarsi con Harry. «Se sarà per lui doloroso tornare qui», pensò, «tanto più lo sarà per me! Ma forse non verrà; o forse scriverà, o forse verrà cercando in ogni modo di non incontrarmi... come quando andò via. Non credevo che si sarebbe allontanato, ma è stato meglio per entrambi». E qui, Rose lasciò cadere la penna e nascose il viso, come se la stessa carta a cui affidava il messaggio potesse vederla piangere. Una cinquantina di volte aveva ripreso e lasciato cadere quella penna, e aveva pensato e ripensato a come iniziare la lettera senza riuscire a scrivere neanche la prima parola allorché Oliver, che aveva fatto una passeggiata fuori in strada, con il signor Giles come guardia del corpo, si precipitò nella stanza così trafelato e in così violenta agitazione da far temere che portasse l'annuncio di qualche nuovo motivo di allarme. «Perché sei così agitato?», chiese Rose andandogli incontro. «Non lo so neanche io. Mi sento come soffocare», replicò il ragazzo. «Santo cielo! Pensare che l'ho ritrovato, alla fine; e voi potrete vedere che vi ho sempre detto la verità!». «Non ho mai pensato diversamente», disse Rose cercando di calmarlo. «Ma cosa vuoi dire?... Di chi parli?» «Ho rivisto il gentiluomo», replicò Oliver a mala pena in grado di articolare, «il gentiluomo che è stato tanto buono con me... il signor Brownlow; ne abbiamo parlato tante volte». «Dove?», domandò Rose. «Scendeva da una carrozza», rispose Oliver con lacrime di gioia. «Ed entrava in una casa. Non gli ho parlato... Non potevo parlargli perché non mi aveva visto e tremavo così tanto che non potevo avvicinarmi a lui. Ma Giles è andato a chiedere se abitava lì e gli hanno risposto di sì», esclamò Oliver spiegando un pezzettino di carta, «ecco qua; ecco dove abita... ci vado subito! Oh santo cielo, santo cielo! Cosa farò quando lo rivedrò; cosa mi dirà?». Distratta non poco da queste e parecchie altre esclamazioni di gioia, Rose lesse l'indirizzo, che era Craven Street, sullo Strand, e immediatamente decise di sfruttare quella scoperta. «Presto!», esclamò, «di' ai servitori di noleggiare una carrozza e tenersi pronti ad accompagnarci. Ti ci porto immediatamente senza perdere un minuto. Vado soltanto ad avvisare la zia che andiamo via per un'oretta, e sarò pronta per quando torni». Oliver non aveva bisogno d'incitamenti per sbrigarsi e in poco più di cinque minuti partivano alla volta di Craven Street. Lì giunti, Rose lasciò Oliver nella carrozza con la scusa di dover preparare il vecchio gentiluomo a riceverlo, e mandò per mezzo di un servitore il suo biglietto da visita con la richiesta di poter vedere il signor Brownlow per questioni urgentissime. Il servitore fu subito di ritorno per pregarla di salire di sopra, e la signorina Maylie, dopo averlo seguito in una stanza al piano superiore, si trovò innanzi un attempato gentiluomo dall'aspetto benevolo in giacca verde bottiglia. A non grande distanza da lui sedeva un altro anziano gentiluomo in pantaloni di nanchino al ginocchio e ghette, che non aveva un aspetto particolarmente benevolo e che sedeva con le mani giunte sul pomo di un pesante bastone e il mento appoggiato sopra. «Santo cielo!», disse il gentiluomo in giacca verde bottiglia subito alzandosi con grande gentilezza, «vi chiedo perdono, signorina... credevo che fosse qualche seccatore che... vi chiedo umilmente scusa. Sedete, vi prego». «Il signor Brownlow, suppongo?», chiese Rose trasferendo lo sguardo dal secondo gentiluomo al primo. «In persona», rispose l'anziano signore. «E questo è il mio amico, signor Grimwig. Grimwig, volete per cortesia lasciarci per un paio di minuti?» «Credo che per ora», interloquì la signorina Maylie, «non ci sia bisogno di scomodare il signore chiedendogli di uscire. Se le mie informazioni sono giuste, egli è al corrente della questione di cui vorrei parlarvi». Il signor Brownlow fece un inchino con la testa. Il signor Grimwig, che aveva già fatto un rigidissimo inchino alzandosi dalla sedia, con un secondo e altrettanto rigido inchino si rimise a sedere. «Sono certa che vi sorprenderò non poco», disse Rose naturalmente imbarazzata, «ma voi un tempo mostraste compassione e bontà verso un mio carissimo, piccolo amico, e sono sicura che vi interessa ancora sapere di lui». «Davvero?», disse il signor Brownlow. «Lo conoscevate come Oliver Twist», replicò Rose. Non appena ebbe pronunciate queste parole, il signor Grimwig, che aveva finto di essere profondamente assorto in un libro di grosse dimensioni poggiato sul tavolo, lo rovesciò con un gran tonfo, e ricadendo indietro sulla sedia scacciò dai suoi lineamenti ogni altra espressione tranne quella della più pura meraviglia, restando per un po' con lo sguardo fisso nel vuoto. Poi, come vergognandosi di tradire tanta emozione, con uno scatto improvviso riprese la sua posizione di prima e guardando dritto innanzi a sé emise un fischio lungo e profondo che sembrò, infine, non disperdersi in aria ma spegnersi negli intimi recessi del suo petto. Il signor Brownlow non fu meno sorpreso, sebbene la sua meraviglia non si esprimesse alla stessa eccentrica maniera. Avvicinò la sedia alla signorina Maylie e disse:«Per cortesia, mia cara giovane, tralasciate ogni riferimento alla mia bontà e compassione, della quale nessun altro sa niente, e se è in vostro potere mostrarmi qualche prova che possa alterare la cattiva opinione che fui indotto a formarmi di quel povero ragazzo, in nome del Cielo, ditemela». «Un cattivo soggetto! Mi mangio la testa se non è un cattivo soggetto», bofonchiò il signor Grimwig come un ventriloquo, senza muovere neanche un muscolo del viso. «È un ragazzo di carattere nobile e affettuoso», disse Rose arrossendo, «e quella Virtù che ha ritenuto giusto metterlo duramente alla prova già da bambino ha impiantato nel suo cuore affetti e sentimenti che farebbero onore a molti che hanno vissuto sei volte più di lui». «Ho solo sessantuno anni», disse il signor Grimwig sempre rigido in viso. «E, corpo del diavolo, se questo Oliver ne ha almeno dodici, non vedo a chi possa riferirsi questa osservazione». «Non badate al mio amico, signorina Maylie», disse il signor Brownlow. «Non voleva dire questo». «Sì, voleva», borbottò il signor Grimwig. «No, non voleva», ribatté il signor Brownlow comprensibilmente adirato. «Si mangerà la testa, se non lo voleva», ringhiò il signor Grimwig. «Meriterebbe che gliela staccassero, se voleva», disse il signor Brownlow. «E vorrebbe proprio vedere chi avrebbe il coraggio», rispose il signor Grimwig battendo il bastone a terra. «Dunque, signorina Maylie», tagliò corto il signor Brownlow, «tornando all'argomento che desta in voi tanta compassione, vorreste mettermi al corrente delle notizie in vostro possesso su questo povero bambino? Lasciatemi premettere anche che sono ricorso a ogni mezzo a mia disposizione per rintracciarlo e che, da quando ho lasciato questo paese, la mia prima convinzione che fosse stato indotto dai suoi amici di un tempo a derubarmi è stata considerevolmente scossa». Rose che nel frattempo aveva avuto modo di riordinare i suoi pensieri, immediatamente riferì, in poche e semplici parole, tutto ciò che era accaduto a Oliver da quando aveva lasciato la casa del signor Brownlow, riservando l'informazione di Nancy per il suo orecchio soltanto, e concludendo con l'assicurazione che, nei mesi scorsi, il dolore più grande del bambino era stato di non poter rivedere il suo amico e benefattore. «Grazie a Dio!», disse l'anziano signore. «Questo è per me una grande felicità; una grande felicità. Ma non mi avete ancora detto dove si trova ora, signorina Maylie. Mi dovete scusare se ho qualcosa da ridire sul vostro modo di agire... ma perché non l'avete portato qui?» «Sta aspettando in una carrozza ferma alla porta», replicò Rose. «Alla mia porta?», gridò l'anziano gentiluomo. E senza aggiungere altro si precipitò fuori della stanza, giù per le scale, sul predellino della carrozza e dentro la vettura. Quando la porta della stanza si chiuse dietro di lui, il signor Grimwig sollevò la testa e facendo perno su una delle gambe posteriori della sedia, aiutandosi col bastone e col tavolo, sempre restando seduto, descrisse tre cerchi distinti. Attuata questa evoluzione si alzò e saltellò velocissimo su e giù per la stanza una dozzina di volte almeno; poi, fermandosi improvvisamente davanti a Rose, la baciò senza il minimo preavviso. «Zitta!», disse mentre la giovane si alzava alquanto allarmata dell'insolita condotta. «Non temete. Sono vecchio abbastanza per esservi nonno. Voi siete una carissima ragazza e mi piacete. Arrivano!». In effetti, mentre con una piroetta si ricollocava sulla sedia, il signor Brownlow rientrava accompagnato da Oliver, accolto molto cortesemente dal signor Grimwig; e se la soddisfazione di quel momento fosse stata l'unica ricompensa di tutte le sue ansie e preoccupazioni per Oliver, Rose Maylie sarebbe stata ben ripagata. «A proposito, c'è ancora qualcuna di cui non dobbiamo dimenticarci», disse il signor Brownlow suonando il campanello. «Fate venire qui la signora Bedwin, per piacere». La vecchia governante si affrettò a rispondere alla chiamata e, con una riverenza alla porta, restò in attesa di ordini. «Santo Cielo! Ci vedete sempre meno, signora Bedwin», esclamò il signor Brownlow piuttosto brusco. «Beh, è vero, signore», replicò l'anziana signora. «Alla mia età la vista non migliora col passare degli anni». «Questo lo so benissimo», ribatté il signor Brownlow, «ma rimettetevi gli occhiali e cercate di capire il motivo per cui siete stata chiamata, volete?». L'anziana signora cominciò a rovistare nella tasca cercando le lenti, ma la pazienza di Oliver non resistette a questa nuova prova. Cedendo al suo primo impulso, si gettò tra le sue braccia. «Dio sia lodato!», esclamò l'anziana signora abbracciandolo, «è il mio innocente piccino!». «La mia cara tata!», esclamò Oliver. «Lo sapevo... lo sapevo che sarebbe tornato», disse l'anziana signora stringendolo tra le braccia. «Che bell'aspetto che ha ora, e di nuovo vestito come un signorino! Ma dove siete stato tutto questo lungo, lunghissimo tempo? Ah! Lo stesso visino dolce ma non più così pallido; lo stesso sguardo tenero, ma non più così triste. Non l'ho mai potuto dimenticare, e neanche ho dimenticato il suo dolce sorriso; giorno dopo giorno me li vedevo innanzi assieme a quelli del mio caro piccino morto quando io ero una bella giovane». E così, ora allontanando Oliver per vedere quanto fosse cresciuto, ora stringendolo a sé e passandogli amorevolmente le dita tra i capelli, la buona signora passava dal riso al pianto sulle spalle di lui. Lasciando lei e Oliver alle tante cose che avevano da raccontarsi, il signor Brownlow precedette gli altri in un'altra stanza e là ascoltò il resoconto completo del colloquio di Rose con Nancy con non poca sorpresa e preoccupazione. Rose chiarì anche le sue ragioni per non aver comunicato il segreto al signor Losberne fin dall'inizio. L'anziano gentiluomo osservò che ella aveva agito con prudenza e si assunse prontamente il compito di parlare lui stesso molto seriamente al dottore, e per mettere in atto il più rapidamente possibile questo disegno, stabilirono che dovesse fargli visita all'albergo alle otto di quella sera stessa e che la signorina Maylie dovesse essere discretamente e tempestivamente informata di quanto sarebbe accaduto. Fissati questi preliminari, Rose e Oliver fecero ritorno a casa. Rose non aveva affatto esagerato nell' immaginare a qual grado sarebbe giunta l'ira del buon dottore. Non appena egli seppe la storia di Nancy, investì quella sventurata con bordate di esecrazioni e improperi; minacciò di farne la prima vittima degli ingegni combinati dei signori Blathers e Duff e in effetti indossò il cappello preparandosi a partire immediatamente per procacciarsi l'intervento di quelle autorità. Senza dubbio, in quel primo scatto d'ira, avrebbe portato la sua intenzione ad effetto, senza preoccuparsi delle conseguenze neanche per un istante, se non fosse stato trattenuto in parte da una corrispondente veemenza del signor Brownlow, lui stesso di temperamento irascibile, e in parte da chiarimenti e spiegazioni studiati per poterlo più facilmente dissuadere da quel testardo proposito. «Che cosa diavolo dobbiamo fare allora?», disse l'irruente dottore quando furono tornati dalle due signore. «Dovremmo forse offrire i nostri ringraziamenti a tutti questi marioli, maschi e femmine, e pregarli di accettare un centinaio di sterline a testa come un piccolo segno della nostra stima e parziale ricompensa della loro bontà verso Oliver?» «Non esattamente», ribatté il signor Brownlow ridendo. «Dobbiamo però procedere con grande cautela e discernimento». «Cautela e discernimento!», esclamò il dottore. «Io li spedirei tutti quanti al...». «Lasciamo perdere la destinazione», interloquì il signor Brownlow. «Consideriamo piuttosto se il mandarli da qualche parte possa aiutarci a raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissi». «Quale obiettivo?», domandò il dottore. «Scoprire i genitori di Oliver e recuperare l'eredità che, se questa storia è vera, gli è stata fraudolentemente sottratta». «Ah! Quasi me ne dimenticavo», disse il signor Losberne rinfrescandosi col suo fazzoletto. «Vedete», continuò il signor Brownlow, «lasciando completamente fuori da questa faccenda la povera ragazza e supponendo che fosse possibile consegnare alla giustizia questi furfanti senza comprometterne la sicurezza, che risultati otterremmo?» «L'impiccagione di almeno qualcuno di loro con ogni probabilità», suggerì il dottore, «e la deportazione degli altri». «Benissimo», replicò il signor Brownlow sorridendo. «Ma senza dubbio, tempo al tempo, saranno loro stessi a procurarsi quest'esito, e mi pare che, se noi ci intromettiamo per anticiparlo, faremmo un gesto alla Don Chisciotte, nettamente contrario al nostro interesse... o almeno a quello di Oliver, che è la stessa cosa». «Sarebbe a dire?», chiese il dottore. «Sarebbe a dire questo: è chiaro che ci sarebbe estremamente difficile andare fino in fondo a questo mistero, a meno che non inchiodiamo con le spalle al muro questo tale Monks. Questo lo possiamo ottenere soltanto con qualche stratagemma, cogliendolo di sorpresa quando non è assieme ai suoi compari. Supponiamo infatti che sia arrestato. Noi non abbiamo alcuna prova contro di lui. Per quanto ne sappiamo, o non dicano i fatti, non è nemmeno implicato in qualche furto compiuto da quella banda di ladri. Se anche non fosse subito rimesso in libertà, sarebbe pur sempre molto improbabile che gli fosse inflitta una condanna più pesante della prigione per vagabondaggio. Da allora in poi terrebbe la bocca così cucita che, per i nostri scopi, potrebbe altrettanto bene essere sordo, muto, cieco o totalmente idiota». «Allora», replicò il dottore con veemenza, «vi domando di nuovo se ritenete ragionevole considerare vincolante la promessa fatta a quella ragazza, una promessa fatta senza dubbio con le migliori intenzioni ma in effetti...». «Non mettetevi a discutere con lui su questo punto, mia cara giovane», disse il signor Brownlow interrompendo Rose sul punto di replicare, «la promessa sarà mantenuta e non credo che ciò interferirà minimamente con il nostro piano. Ma prima di poter decidere una qualsiasi linea d'azione, sarà necessario incontrare la ragazza per accertarci se ella abbia intenzione di indicarci questo Monks con l'intesa che saremo noi ad occuparcene senza consegnarlo alla legge; oppure, se non vorrà o non potrà far questo, per ottenere da lei una descrizione così precisa della sua persona e di dove abita da poterci consentire di identificarlo. Incontrarla prima del prossimo sabato notte è impossibile. Oggi è martedì. Suggerirei, nel frattempo, di restarcene assolutamente tranquilli, tenendo celate queste cose perfino a Oliver». Benché il signor Losberne accogliesse questa proposta, che implicava una dilazione di ben cinque giorni, storcendo la bocca, dovette ammettere che sul momento non sapeva pensare niente di meglio, e poiché sia Rose sia la signora Maylie appoggiavano incondizionatamente il signor Brownlow, la proposta fu accettata all'unanimità. «Vorrei chiedere un aiuto al mio amico Grimwig», disse Brownlow. «È un tipo strano ma molto intelligente, e potrebbe darci un grosso aiuto. Dovete sapere che ha studiato da avvocato e ha lasciato il foro con disgusto perché, in vent'anni, gli erano state affidate soltanto un paio di controversie; se questo, poi, ne raccomandi o meno il carattere, sta a voi deciderlo». «Non ho nessuna obiezione a chiedere l'aiuto del vostro amico se io posso chiedere l'aiuto del mio», disse il dottore. «Dobbiamo metterlo ai voti», replicò il signor Brownlow. «Di chi si tratta?» «Del figlio di questa signora», disse il dottore indicando la signora Maylie, «e un vecchio... amico di questa giovane», aggiunse, con un espressivo sguardo alla nipote. Rose arrossì fino alla radice dei capelli ma non obbiettò nulla alla proposta, forse avvertendo che si sarebbe trovata in netta minoranza. Harry Maylie e il signor Grimwig vennero dunque senz'altro aggregati al gruppo. «Naturalmente resteremo in città», disse la signora Maylie, «almeno finché c'è un'esile speranza che l'indagine possa dare qualche risultato. Non lesinerò né denaro né energie per raggiungere lo scopo che sta così a cuore a tutti noi, e resterò volentieri qui anche per dodici mesi, se necessario, finché ho la vostra assicurazione che ci sono ancora speranze». «Bene!», interloquì il signor Brownlow. «E poiché ovunque mi giri leggo sui vostri volti la domanda: "perché non ti facesti avanti per confermare il racconto di Oliver e lasciasti invece il Paese così improvvisamente?", stabiliamo che non mi si dovranno porre domande del genere fin quando non riterrò opportuno anticiparle raccontando tutta la mia storia. Credetemi, avanzo questa richiesta con buone ragioni, giacché altrimenti potrei suscitare speranze destinate a non essere mai esaudite, accrescendo soltanto difficoltà e delusioni già abbastanza numerose. Su! La cena è pronta e il piccolo Oliver, che è rimasto solo nella stanza accanto, avrà cominciato a pensare, a questo punto, che ci siamo stancati della sua compagnia e stiamo ordendo qualche tenebrosa congiura per buttarlo in mezzo a una strada». Con queste parole l'anziano gentiluomo porse il braccio alla signora Maylie e la scortò nella stanza da pranzo, seguito dal signor Losberne che accompagnava Rose. Il consiglio, pertanto, fu momentaneamente sospeso. Capitolo XLII. Una vecchia conoscenza di Oliver assurge a ruolo pubblico nella metropoli, con ciò dando prova d'indiscutibile genialità La stessa notte in cui Nancy, dopo aver messo a dormire il signor Sikes, si affrettava a compiere la propria missione incontrando Rose Maylie, due persone alle quali è tempo che questa storia presti qualche attenzione avanzavano lungo la grande arteria dal Nord. Erano un uomo e una donna, o forse sarebbe meglio descriverli come un maschio e una femmina, poiché il primo era uno di quei spilungoni, ossuti, con le ginocchia in dentro ai quali è difficile assegnare un'età precisa, quando sono ancora ragazzi avendo l'aspetto di adulti e quando sono quasi uomini maturi sembrando ragazzi cresciuti in fretta; la seconda era giovane ma di costituzione solida e robusta - e non poteva non esserlo, a giudicare dal peso del grosso fardello che portava sulle spalle. Il suo compagno non era appesantito da troppi bagagli, i quali consistevano unicamente d'un fagottino avvolto in un normale fazzoletto, a ogni evidenza piuttosto leggero, che dondolava appeso ad un bastone poggiato sulla spalla. Questa circostanza, aggiunta alla lunghezza delle sue gambe, alquanto insolita, gli consentiva di marciare agevolmente una mezza dozzina di passi avanti alla sua compagna, verso cui egli di tanto in tanto si volgeva con uno scatto spazientito della testa quale rimprovero alla sua lentezza e incitamento a una maggiore solerzia. In tal modo avanzavano lungo la strada polverosa, poco badando a ciò che si vedeva intorno, tranne quando si facevano da parte per dare strada alle carrozze di posta che uscivano a tutta andatura dalla città, finché non giunsero all'arco di Highgate, allorché il viandante di testa si fermò e chiamò con impazienza la compagna. «Forza, dai! Che razza di lumaca sei, Charlotte». «È un bel fardello, t'assicuro», fece la donna raggiungendolo quasi senza fiato per la fatica. «Un bel fardello! Che dici? Vuoi battere la fiacca, allora?», replicò il viaggiatore mentre spostava il peso del suo fagottino sull'altra spalla. «Oh, ma insomma! Ancora una sosta! Beh, se non fai perdere la pazienza tu, non vedo chi altri possa riuscirci!». «Quanto manca?», chiese la donna riposandosi appoggiata ad un muretto e guardandolo con la faccia tutta sudata. «Quanto manca? Ci siamo quasi», disse lo spilungone indicando innanzi. «Guarda! Quelle sono le luci di Londra». «Ma ci sono almeno altre due miglia ancora», disse la donna scoraggiata. «Non preoccuparti se sono ancora due miglia oppure venti», disse Noah Claypole - giacché di lui si trattava - «ma mettiti in piedi e cammina o ti prendo a calci; sei avvisata». Poiché il naso di Noah diveniva paonazzo di rabbia e poiché egli attraversava allora la strada come se fosse assolutamente intenzionato a dar seguito alle sue minacce, la donna si alzò senza aggiungere altro e seguitò il faticoso cammino al suo fianco. «Dove pensi di fermarti per la notte, Noah?», domandò dopo aver percorso qualche centinaio di iarde. «E come posso saperlo?», replicò Noah il cui umore era stato notevolmente compromesso dal lungo camminare. «Vicino, spero», disse Charlotte. «No, non vicino», replicò Claypole. «Non vicino, va bene? Perciò non pensarci». «Perché no?» «Quando ti dico che non ho intenzione di fare una cosa, tanto basta, senza né perché né percome», ribatté con stizza. «Beh, non c'è bisogno d'essere sgarbato», disse la compagna. «Bella cosa sarebbe, non è vero, andare a fermarsi alla prima locanda fuori città, dimodoché Sowerberry, se c'inseguisse, potrebbe far capoccetta e noi si sarebbe rispediti indietro ammanettati su un carretto», fece il signor Claypole sprezzante. «No! Voglio far perdere le mie tracce in un labirinto di stradicciole, senza fermarmi finché non arriviamo all'osteria più fuori mano che scoverò. Cribbio, ringrazia la tua stella che ho la testa sulle spalle, perché se non avessimo preso da subito una strada diversa e non fossimo passati per i campi, saresti già in gattabuia da una settimana, signora mia. E te lo saresti meritato, perché sei una sciocca». «Lo so che non sono furba come te», replicò Charlotte, «ma non dare tutta la colpa a me dicendo che io sarei stata già in gattabuia. Tanto, ci saresti stato pure tu insieme a me». «Tu hai preso i soldi dalla cassa, e lo sai», disse Claypole. «Li ho presi per te, Noah caro», replicò Charlotte. «Li ho tenuti io forse?», chiese Claypole. «No, ti sei fidato e li hai lasciati portare a me, caro il mio tesoruccio», disse la signora solleticandolo sotto il mento e infilando un braccio sotto al suo. Le cose stavano effettivamente così; ma per rendere giustizia a quel gentiluomo, è bene precisare che non era affatto costume del signor Claypole riporre scioccamente fiducia in qualcuno, e aveva fatto affidamento su Charlotte soltanto perché, se fossero stati acciuffati, i soldi sarebbero stati trovati addosso a lei, e questo gli avrebbe dato modo di protestare la sua totale innocenza da ogni furto accrescendo di molto le sue possibilità di farla franca. Ovvio del resto che in quel frangente non entrasse in spiegazioni intorno ai propri motivi e i due continuarono a camminare amorevolmente insieme. Conformemente al suo prudente piano, il signor Claypole proseguì senza fermarsi finché non giunsero all'Angelo a Islington, dove meditò sulla folla dei viaggiatori e sul numero della carrozze, e concluse saggiamente che lì Londra iniziava per davvero. Fermandosi solo il tempo necessario per capire quali fossero le strade più battute e di conseguenza quelle più da evitare, attraversò Saint John's Road e si trovò subito immerso nell'oscurità dell'intrico di sporche stradine che, tra Gray's Inn Lane e Smithfield, rendono quella parte della città una delle peggiori e più squallide che lo sviluppo di Londra abbia abbandonato dietro di sé nella sua avanzata. Per queste stradine camminò Noah Claypole trascinandosi dietro Charlotte, ora andando al lato della strada, nel canale di scolo, per abbracciare con un solo sguardo tutto l'aspetto esterno di qualche piccola locanda, e ora scattando di nuovo innanzi, allorché qualche forma intravista lo induceva a ritenerla troppo frequentata per i suoi gusti. Si fermò infine innanzi a una dall'aspetto più dimesso e sporco di quante ne avesse viste e, dopo aver attraversato la strada e averla esaminata dal marciapiede di fronte, annunciò graziosamente la sua intenzione di fermarsi là per la notte. «Perciò dammi questo fagotto», disse Noah slacciandolo dalle spalle della donna e gettandolo sulle sue. «E non dir nulla se non sei interrogata. Com'è che si chiama la locanda... i tre... cosa?» «I Tre Storpi», rispose Charlotte. «I Tre Storpi», ripetè Noah. «Davvero una bella insegna, per giunta. E allora! Stammi dietro ed entriamo». Con queste raccomandazioni spinse con la spalla la porta cigolante ed entrò seguito da presso dalla compagna. Non c'era nessuno al bar tranne un giovane ebreo che, con i gomiti appoggiati al bancone, leggeva un sudicio giornale. Fissò lo sguardo su Noah e Noah lo fissò su di lui. Se Noah avesse avuto addosso la tenuta da orfano, l'ebreo avrebbe avuto un buon motivo per sgranare così gli occhi, ma poiché si era liberato della giacca e del distintivo e indossava un corto camiciotto sui pantaloni di pelle, non sembrava esserci una ragione particolare perché il suo aspetto destasse così tanta attenzione in una locanda. «È "I Tre Storpi" qui?», chiese Noah. «Così si chiaba questa locadda», replicò l'ebreo. «Un signore che abbiamo incontrato per strada, venendo dalla campagna, ce l'ha raccomandata», disse Noah dando di gomito a Charlotte, forse per richiamare la sua attenzione su questo ingegnosissimo trucco per guadagnarsi rispetto e forse anche per avvisarla di non tradire sorpresa. «Vorremmo una stanza per stanotte». «Dod so se c'è posto», disse Barney che era il garzone di servizio, «ma vado a chiedere». «Dateci un tavolo, e portateci un po' di carne fredda e un goccio di birra intanto che andate a chiedere, volete?», disse Noah. Barney obbedì conducendoli in una saletta sul retro e portando loro le vivande richieste, dopodiché informò i viandanti che avrebbero potuto alloggiare lì per la notte e lasciò l'amabile coppia al suo pasto. Ora, questa stanzetta si trovava immediatamente dietro al bar, qualche gradino più in basso, cosicché chiunque del personale della locanda, tirando una tendina che nascondeva una finestrella di vetro fissata nel muro divisorio a circa cinque piedi dal pavimento, non solo avrebbe potuto tener d'occhio ogni cliente in quella stanza senza correre un grosso rischio di essere notato (poiché il vetro si trovava in un angolo buio della parete, e l'osservatore si doveva porre tra quello e una grossa trave verticale di sostegno) ma poteva anche, accostando l'orecchio ad esso, ascoltare con accettabile chiarezza l'argomento della loro conversazione. Per cinque minuti buoni il proprietario della locanda, lì appostato, non aveva staccato gli occhi da quei due, e Barney era appena allora tornato portando la comunicazione di quanto sopra allorché Fagin, nel corso dei suoi giri serali, entrò nel bar per chiedere di qualche suo giovane discepolo. «Ziddo!», disse Barney, «ci sodo forestieri della stazza accaddo». «Forestieri!», ripetè il vecchio bisbigliando. «Ah-ah! E tipi curiosi, per giudda», aggiunse Barney. «Dei cabbagnoli, ba potrebbero fare per voi, ci giurerei». Fagin sembrò molto interessato a questa comunicazione. Salendo su uno sgabello, pose cautamente l'occhio al pannello di vetro. Da quella postazione segreta poteva vedere il signor Claypole mangiare la carne dal piatto e bere birra scura dal boccale, contemporaneamente elargendo dosi omeopatiche di entrambe a Charlotte la quale gli sedeva pazientemente accanto. «Aha!», sussurrò l'ebreo volgendosi a Barney, «mi piace l'aspetto di quel tale. Ci potrebbe riuscire utile; sa già come istruire una ragazza. Non farti sfuggire nessunissimo rumore, mio caro, e lasciami ascoltare... lasciami ascoltare». L'ebreo pose di nuovo il suo occhio al vetro e accostando l'orecchio al divisorio ascoltò attentamente, con l'espressione furba di un vecchio folletto. «E così voglio essere un gentiluomo», disse il signor Claypole stendendo le gambe e proseguendo una conversazione il cui inizio Fagin aveva perduto. «Non più quelle maledette bare, Charlotte, ma una vita da gentiluomo per me, e se vuoi, tu sarai una signora». «Mi piacerebbe tanto, caro», replicò Charlotte, «ma non è che uno possa svuotare cassetti ogni giorno sperando di farla sempre franca». «Alla malora i cassetti!», disse il signor Claypole, «c'è ben altro da svuotare oltre ai cassetti». «Che vuoi dire?», chiese la sua compagna. «Tasche, borsette di donna, case, carrozze di posta, banche!», disse il signor Claypole euforico per la birra. «Ma non puoi fare tutte queste cose, caro», disse Charlotte. «Vedrò di accompagnarmi a gente del mestiere», replicò Noah. «Sapranno bene che uso farne di noi in un modo o nell'altro. Perbacco, solo tu vali cinquanta donne messe insieme. Non ho mai visto una furba e falsa come sai essere tu quando vuoi». «Cielo, che bello sentirtelo dire!», esclamò Charlotte stampando un bacio su quel brutto muso. «Basta, basta così! Non fare la sdolcinata, se no mi urto», disse Noah liberandosi con ostentata gravità. «Mi piacerebbe essere il capo di qualche banda, e comandare gli altri a bacchetta e spedirli di qua e di là senza che neanche mi conoscano. Mi piacerebbe, questo, se desse un buon profitto; e se ci consentisse di aggregarci a qualche gentiluomo di quella specie, io dico che questo assegno da venti sterline che hai sarebbe ben speso... specialmente perché non sappiamo bene come disfarcene». Manifestata questa opinione, il signor Claypole, con aria di profonda saggezza, fissò lo sguardo nel boccale di birra, e avendone agitato il contenuto, annuì condiscendente a Charlotte e ne ingollò un sorso che parve gratificarlo parecchio. Stava meditando se ingollarne un altro, quando l'improvviso aprirsi della porta e l'ingresso di uno sconosciuto l'interruppero. L'estraneo era il signor Fagin, col più amabile degli aspetti. Venendo innanzi fece un profondissimo inchino, e sedendosi al tavolo accanto, ordinò qualcosa da mangiare al ghignante Barney. «Una piacevole serata, signore, ma un po' fresca di questo periodo», disse Fagin fregandosi le mani. «Dalla campagna, vedo, signore». «E come fate a vederlo?», chiese Noah Claypole. «Non abbiamo così tanta polvere a Londra», replicò l'ebreo indicando prima le scarpe di Noah, poi quelle della compagna, e poi ancora i due fagotti. «Siete un tipo sveglio», disse Noah. «Ah-ah! Sentilo, Charlotte!». «Beh, bisogna essere svegli in questa città, mio caro», replicò l'ebreo, abbassando la voce fino a un confidenziale sussurro, «è la pura verità». In coda a questa osservazione, l'ebreo si picchiettò la punta del naso con l'indice destro... gesto che Noah tentò di imitare ma con non grande successo giacché il suo naso non era grosso abbastanza per lo scopo. Il signor Fagin, tuttavia, sembrò interpretarlo come il tentativo di esprimere una perfetta convergenza di opinioni e liberalmente versò il liquore portato proprio allora da Barney. «Roba buona», osservò il signor Claypole schioccando le labbra. «Caro, piuttosto!», disse Fagin. «Se uno vuole berlo regolarmente, bisogna si dia da fare a svuotare cassetti, o tasche, o borsette di donne, o case, o carrozze di posta, o banche». Al sentire questo estratto del suo discorso, il signor Claypole s'appoggiò alla spalliera della sedia e, terrorizzato e mortalmente pallido, guardò dall'ebreo a Charlotte. «Non badate a me, mio caro», disse Fagin avvicinandosi con la sedia. «Ah, ah! Fortuna che t'ho sentito solo io, per caso. È proprio una fortuna che t'ho sentito solo io». «Non li ho presi io», balbettò Noah, non più a gambe stese come un gentiluomo indipendente, ma ripiegate più che poteva sotto la sedia; «ha fatto tutto lei. Ce li hai tu, Charlotte, lo sai». «Non importa chi ce l'ha, o chi l'ha fatto, mio caro!», replicò Fagin tuttavia osservando con occhio di falco la ragazza e i due fagotti. «Io stesso sono del mestiere, e tu mi stai simpatico». «Che mestiere?», chiese il signor Claypole riprendendosi un poco. «Il mestiere della compravendita», soggiunse Fagin, «e questo vale anche per la gente della locanda. Hai fatto centro venendo qui, e non potresti essere più al sicuro. In tutta la città, non c'è posto più sicuro dei Tre Storpi; sempreché, così mi vada a genio e tu e la tua mogliettina mi stiate simpatici. Insomma, ho detto quello che dovevo dire, e voi potete stare tranquilli». Può darsi che l'animo di Noah Claypole fosse tranquillo, dopo tale assicurazione, ma certamente non lo era il corpo, che si contorceva e si agitava in posizioni alquanto scomode, mentre osservava la sua nuova conoscenza con diffidenza e paura. «Vi dirò di più», disse l'ebreo dopo aver assicurato la ragazza con cenni amichevoli della testa e mugolii d'incoraggiamento. «Ho un amico che potrà soddisfare ogni vostro desiderio e mettervi sulla strada giusta in qualunque branca del mestiere vi piaccia inserirvi all'inizio per poi istruirvi nelle altre». «A quanto pare, parlate sul serio», replicò Noah. «Che vantaggio avrei a parlare altrimenti?», domandò l'ebreo scrollando le spalle. «Venite! Scambiamo qualche parola qui di fuori». «Non c'è motivo di scomodarsi», disse Noah che, poco a poco, aveva di nuovo steso e allargato le gambe. «Nel frattempo lei porterài bagagli di sopra. Charlotte! Occupati di quei fagotti!». Questo ordine, maestosamente impartito, fu eseguito senza la minima esitazione e Charlotte fece del suo meglio per portar via i bagagli mentre Noah le teneva aperta la porta e ne sorvegliava l'allontanarsi. «Non c'è male come la tengo sotto, non è vero?», domandò, tornando alla sedia, col tono di un mandriano che avesse domato qualche animale selvatico. «Assolutamente perfetto», replicò Fagin battendogli sulla spalla. «Sei un genio, mio caro». «Beh, se non lo fossi, non sarei qui, suppongo», replicò Noah. «Però guarda che se perdi tempo, quella ritorna». «Dunque, che ne pensi?», disse l'ebreo. «Se il mio amico ti dovesse piacere, cosa potresti fare di meglio se non associarti a lui?» «Sta in un ramo buono del mestiere, non è così?», rispose Noah strizzando uno dei suoi occhietti. «In cima all'albero», rispose l'ebreo. «Ha un sacco di gente sotto di lui e si accompagna ai migliori della sua professione». «Tutti londinesi-londinesi?», domandò il signor Claypole. «Non c'è neanche un campagnolo tra di loro, e anche con la mia raccomandazione, credo che non prenderebbe neppure te, se giusto adesso non si trovasse un po' a corto di assistenti», replicò l'ebreo. «In compenso devo sganciare questo?», disse Noah battendosi la tasca dei pantaloni. «Non si può proprio evitare», replicò Fagin in tono deciso. «Sono venti sterline però... È un sacco di soldi!». «Non se si tratta di un assegno difficile da piazzare», replicò Fagin. «Avrannno preso nota di numero e data e la banca avrà bloccato il pagamento, credo... Ah! Non vale molto per lui. Bisognerà mandarlo fuori, e non potrà piazzarlo sul mercato a un buon prezzo». «Quando potrò vederlo?», chiese Noah dubbioso. «Domani mattina», replicò l'ebreo. «Dove?» «Qui». «Uhm!», disse Noah. «A quali condizioni?» «Vita da gentiluomo.... vitto e alloggio, tabacco e liquori, a gratis; in più la metà del vostro bottino e la metà dei guadagni della giovane», replicò il signor Fagin. È assai dubbio se Noah Claypole, la cui rapacità non era per nulla delle più contenute, avrebbe acconsentito perfino a queste brillanti condizioni potendo agire in piena libertà; ma poiché rammentò che, in caso di rifiuto, la sua nuova conoscenza era in grado di consegnarlo immediatamente alla giustizia (sapeva di casi ancor più inverosimili), a poco a poco si persuase, e disse che gli stava bene. «Ma vedete», osservò Noah, «siccome lei sarà capace di guadagnare un bel po', per me vorrei qualcosa di non troppo pesante». «Magari ruffiano, ogni tanto?», suggerì Fagin. «Ah! Qualcosa del genere», replicò Noah. «Secondo voi cosa mi si attaglia? Qualcosa di non troppo faticoso e non troppo pericoloso, sapete. Quel genere lì!». «Vi ho sentito parlare a proposito di spiare, mio caro», disse l'ebreo. «Il mio amico darebbe chissà cosa per qualcuno che sappia farlo a dovere». «Beh, ho accennato alla cosa, e non mi dispiacerebbe applicarmici di tanto in tanto», riprese il signor Claypole con lenta ponderazione, «ma non ci si ricaverebbe molto solo con quello, sapete». «È vero!», osservò l'ebreo meditando o fingendo di meditare. «No, forse no». «Cosa pensate allora?», chiese Noah, guardandolo ansiosamente. «Qualcosa nel ramo alleggerimenti, che sono lavoretti sicuri e non molto più rischiosi del restarsene a casa». «Che ne direste delle signore anzianotte?», domandò l'ebreo. «Ci si può fare un bel po' di soldi rubando loro borse e pacchetti e scantonando a tutta velocità». «Ma non capita, qualche volta, che si mettano a strillar forte e a graffiare?», chiese Noah scuotendo la testa. «Non credo che farebbe al caso mio. Non ci sarebbe qualche altra prospettiva?» «Un momento!», disse l'ebreo posando la mano sul ginocchio di Noah. «Fregapischello». «E che vuol dire?», domandò Claypole. «"Pischello" mio caro», disse l'ebreo, «è un ragazzino che le mamme mandano a sbrigare commissioni affidandogli scellini e mezzi scellini; e "frega" sarebbe alleggerirli di quei soldi... ce li hanno sempre beli'e pronti in mano... poi, con una botta, li stendi in una cunetta e te la squagli alla chetichella, come se si trattasse soltanto di un bambino che si fosse fatto male cadendo. Ah, ah, ah!». «Ah, ah!», scoppiò a ridere Claypole dimenando in aria le gambe come in estasi. «Santo cielo, ecco quello che mi ci vuole!». «Sicuro», replicò Fagin, «e potranno segnarti col gesso i posti buoni a Camden Town e Battle Bridge e quartieri del genere dove li mandano spesso per commissioni; così potrai accalappiare quanti pischelli vuoi, a qualsiasi ora del giorno. Ah, ah, ah!». Con queste parole Fagin sgomitò il fianco di Claypole, ed esplosero entrambi in una lunga e fragorosa risata. «Bene, allora siamo d'accordo!», disse Noah quando si fu ripreso e Charlotte fu tornata. «A che ora ci vediamo, domattina?» «Diciamo alle dieci?», chiese l'ebreo; aggiungendo, al cenno di assenso di Claypole: «Che nome devo dire al mio amico?» «Il signor Bolter», replicò Noah che era preparato all'evenienza d'una simile domanda. «Il signor Morris Bolter. Questa è la signora Bolter». «Vostro umile servitore, signora Bolter», disse Fagin con un inchino di grottesca compitezza. «Spero di potervi conoscere meglio molto presto». «Sentite questo gentiluomo, Charlotte?», tuonò il signor Claypole. «Sì, caro Noah!», rispose la signora Bolter porgendo la mano. «Mi chiama Noah quando siamo in vena di vezzeggiarci», disse il signor Morris Bolter, già Claypole, rivolgendosi all'ebreo. «Capite?» «Oh sì, capisco... perfettamente», replicò Fagin, una volta tanto dicendo la verità. «Buona notte! Buona notte!». Con molti cerimoniosi addii e auguri, il signor Fagin se ne andò per la sua strada. Noah Claypole, richiesta l'attenzione della sua brava moglie, procedette a illuminarla riguardo gli accordi presi, con tutta l'aria di distacco e superiorità che si confaceva non soltanto a un membro del sesso forte ma anche a un gentiluomo che sapeva apprezzare la dignità d'un incarico speciale come fregapischelli, a Londra e dintorni. Capitolo XLIII. Dove si mostra come Dodger lo Svelto finisca nei guai «E così eri tu quel famoso amico, eh?», chiese Claypole, alias Bolter, quando il giorno seguente, in virtù del patto stabilito, si trovò in casa dell'ebreo. «Ciascuno è il miglior amico di se stesso, mio caro», replicò Fagin col suo ghigno più insinuante. «Non se ne trova l'uguale, da nessuna parte». «Tranne qualche volta», replicò Morris Bolter assumendo l'aria d'un uomo vissuto, «quando certi sono i peggiori nemici di se stessi, sai». «Non crederci!», disse l'ebreo. «Quando uno è il suo peggi or nemico, è solo perché è troppo il suo migliore amico, non perché si preoccupi di qualcun altro. Via, via! Una cosa del genere è contro natura». «E se non fosse contro, ci dovrebbe essere», replicò il signor Bolter. «Questo è ragionare», disse l'ebreo. «Qualche negromante dice che il tre è il numero magico, e qualcun altro dice il sette; ma non è né il primo né il secondo, amico mio, né il primo né il secondo. È l'uno». «Ah, ah!», esclamò il signor Bolter. «E numero uno sia!». «In una piccola comunità come la nostra, mio caro», disse l'ebreo avvertendo la necessità di precisare la sua posizione, «abbiamo un numero uno collettivo, ossia che non ti puoi considerare il numero uno senza considerarci pure me, e tutti gli altri ragazzi». «Oh, demonio!», esclamò Bolter. «Vedi», continuò l'ebreo ignorando l'interruzione, «siamo così annodati tra noi, i nostri interessi così coincidenti, che non potrebbe essere altrimenti. Per esempio, è tuo interesse preoccuparti del numero uno, ossia me». «Certo», replicò il signor Bolter. «Ci hai ragione, costà». «Bene! Non puoi preoccuparti di te, numero uno, se non ti preoccupi di me, numero uno uguale». «Numero due, vuoi dire», disse il signor Bolter largamente dotato della virtù dell'amor proprio. «No, no!», replicò l'ebreo. «Per te, io sono importante quanto te stesso». «Dico», interloquì il signor Bolter, «tu sei un tipo in gamba, e mi sei simpatico, però non siamo parenti così stretti, in conclusione». «Pensa solo a questo», disse l'ebreo scrollando le spalle e protendendo le braccia. «Considera solo questo. Tu hai fatto un bel lavoretto, che è degno della mia stima ma che, al tempo stesso, potrebbe annodarti al collo una cravatta facile da stringere ma piuttosto difficile da allentare... ovvero, senza peli sulla lingua, il nodo scorsoio!». Il signor Bolter si passò le dita nel fazzoletto da collo come se lo sentisse fastidiosamente stretto, e mormorò un sì condizionato più nel tono che nella sostanza. «La forca», continuò Fagin, «la forca, mio caro, è il brutto segnale d'una netta e brusca svolta che, sulle vie maestre, ha messo fine alla carriera a più di qualche spavaldo. Tenertene alla larga, battendo una strada tranquilla, è il tuo obiettivo numero uno». «Certo che è così», replicò il signor Bolter. «Ma perché lo racconti proprio a me?» «Solo per farti capire bene il mio pensiero», disse l'ebreo sollevando le sopracciglia. «Per riuscire in questo, tu dipendi da me; per mandare tranquillamente avanti i miei affarucci, io dipendo da te. La prima cosa è il numero uno-te, la seconda è il numero uno-me. Più dai valore al numero uno-te, più devi preoccuparti del numero uno-me, sicché in conclusione arriviamo a quello che ti dicevo prima... avere a cuore il numero uno ci tiene tutti uniti, e così dev'essere, a meno di andare alla malora tutti quanti insieme». «È vero», soggiunse il signor Bolter pensoso. «Che vecchia volpe sei, ohe!». Il signor Fagin vide con piacere che questo omaggio alle sue abilità non era un semplice complimento. Aveva realmente impressionato la sua recluta col senso della propria geniale astuzia, ed era importantissimo che così fosse fin dall'inizio del loro sodalizio. Al fine di rafforzare questa desiderabile e utile impressione, assestò un altro colpo col renderlo edotto, in qualche dettaglio, della grandezza e dell'estensione delle sue operazioni, unendo insieme verità e fantasia come meglio serviva al suo scopo e usò dell'una e dell'altra con tale arte che il rispetto del signor Bolter si accrebbe visibilmente, temperandosi allo stesso tempo con quella misura di pura e semplice paura che era estremamente utile essere riusciti a instillargli. «È questa reciproca fiducia che abbiamo l'uno nell'altro che mi consola anche nelle più pesanti perdite», disse l'ebreo. «Proprio ieri mattina è venuto a mancarmi il mio miglior discepolo». «Non vorrai dire che è morto?», gridò il signor Bolter. «No, no», replicò Fagin. «Non è finita così male. Non è finita così male». «No? Allora è...» «Sotto custodia», interloquì l'ebreo. «Sì, sotto custodia». «Accuse pesanti?», domandò il signor Bolter. «No», replicò l'ebreo, «non proprio. È stato accusato di tentato borseggio, e gli hanno trovato addosso una tabacchiera d'argento... la sua, mio caro, la sua, poiché sniffava tabacco lui stesso, e gli piaceva parecchio. Lo hanno trattenuto fino ad oggi perché pensavano di sapere chi era il proprietario. Ah! Valeva cinquanta tabacchiere e darei il loro equivalente in denaro per riaverlo indietro. Avresti dovuto conoscere Dodger, mio caro; avresti dovuto conoscerlo». «Beh, lo conoscerò spero, non pensi?», disse il signor Bolter. «Ho qualche dubbio in proposito», replicò l'ebreo con un sospiro. «Se non riescono a trovare altre prove, sarà solo un arresto temporaneo, e lo riavremo qui dopo un sei settimane circa, ma se ci riescono, è un caso da deportazione. Sanno bene che ragazzo in gamba egli sia; andrà in colonia penale a vita. Niente di meno che la colonia penale a vita, per Dodger». «Che mi significa colonia penale a vita?», chiese il signor Bolter. «A che ti giova parlarmi a questo modo? Perché non mi parli in modo che possa capirti?» Fagin era sul punto di parafrasare quelle misteriose espressioni nella lingua del volgo e, ricevendole così tradotte, il signor Bolter avrebbe compreso che quelle parole equivalevano a "deportazione a vita", allorché il loro dialogo fu interrotto dalla comparsa di mastro Bates con le mani in saccoccia e il volto contratto in una maschera di dolore semiserio. «È spacciato, Fagin», disse Charley dopo le presentazioni col suo nuovo compagno. «Che vuoi dire?», domandò l'ebreo con labbra tremanti. «Hanno trovato il signore che era proprietario della tabacchiera; altri due o tre stanno andando per l'identificazione e Dodger ha ormai un posto riservato per l'Australia», replicò mastro Bates. «Dovrò avere un completo scuro, Fagin, e pure un nastro al cappello per potergli far visita prima che lo spediscano in crociera. Pensa, Jack Dawkins... l'impareggiabile Jack... Dodger... Dodger lo Svelto... spedito all'estero per una misera tabacchiera da due penny e mezzo! Non avrei mai pensato che potesse accadergli per meno di un orologio d'oro con catena e dondolini. Oh, perché non ha derubato di tutte le sue cose qualche vecchio riccone! Almeno avrebbe potuto andarne fiero invece di essere spedito via così, come un volgare ladruncolo, senza né onore né gloria!». Con queste esternazioni di affetto per il suo sfortunato amico, mastro Bates si accasciò sulla sedia più vicina con un'espressione d'inconsolabile sconforto. «Ma che vai dicendo, senza né onore né gloria!», esclamò Fagin lanciando uno sguardo rabbioso al suo discepolo. «Non è stato sempre il migliore per voi tutti! Chi di voi gli sta a pari, o ha un fiuto anche lontanamente paragonabile al suo? Eh?» «Nessuno», replicò mastro Bates, con una voce cupa per il disappunto. «Nessuno». «E allora che dici?», replicò l'ebreo adirato. «Che vai blaterando?» «Ma se non è neanche iscritto a registro!», disse Charley spinto dal flusso dei suoi rimpianti alla ribellione contro il suo venerando amico. «Non figurerà nemmeno sul bollettino e nessuno saprà mai neanche la metà di quello che ha fatto. Come potrà figurare sull'annuario di Newgate? Forse non vi comparirà affatto. Oh, accidenti, accidenti, che brutto colpo!». «Ah, ah!», esplose l'ebreo protendendo la mano destra e volgendosi verso il signor Bolter in un attacco di risa che lo scosse come se avesse l'epilessia. «Vedi come inorgogliscono della loro professione, mio caro. Non è meraviglioso?». Il signor Bolter accennò di sì e l'ebreo, dopo aver contemplato per alcuni secondi il dolore di Charley Bates con visibile soddisfazione, si avvicinò a quel giovane e gli batté sulla spalla. «Non preoccuparti, Charley», disse Fagin consolandolo. «Ne uscirà alla grande. Ne uscirà alla grande, di sicuro. Sappiamo benissimo quanto sia in gamba, e lui lo dimostrerà non disonorando i suoi amici e maestri. Pensa a come è giovane! Che distinzione, Charley, essere deportato alla sua età!». «Beh, è un bell'onore, ecco cos'è!», disse Charley un po' sollevato. «Avrà tutto ciò che desidera», continuò l'ebreo. «Sarà tenuto al fresco, Charley, da gentiluomo. Da gentiluomo! Con la sua birra giornaliera e soldi in tasca per giocarseli a testa e croce se non li potrà spendere». «No! Davvero?», esclamò Charley Bates. «Sicuro», replicò l'ebreo «e gli procureremo un parruccone, Charley, il meglio del meglio per la sua difesa; e potrà fare anche un suo discorso, se vorrà, e noi lo leggeremo sui giornali... Dodger... esplosione di risa... la corte esilarata... eh, Charley?». «Ah, ah!», rise mastro Bates. «Eccome, se gliela canterebbe, non è vero, Fagin? Dico, lo Svelto li piglierà per i fondelli tutti quanti, no, Fagin?» «Altro che», gridò l'ebreo. «Li piglierà per i fondelli tutti quanti!». «Ah, sicuro, sicuro», replicò Charley fregandosi le mani. «Mi par di vederlo», esclamò l'ebreo volgendo lo sguardo al discepolo. «E pure io», esclamò Charley Bates. «Ah, ah, ah! E pure io. Me lo vedo davanti, me lo vedo, giuro, Fagin. Che spasso! Che spasso grandioso! Tutti i parrucconi che s'atteggiano e Jack Dawkins che gli parla tranquillo e a bell'agio come se fosse il figlio del giudice, per una chiacchierata dopo cena... ah, ah, ah!». L'ebreo, in effetti, aveva così ben assecondato l'eccentrica disposizione di mastro Bates che questo, inizialmente portato a considerare l'amico in arresto piuttosto come una vittima, lo vedeva ora come l'attore protagonista di una scena singolarissima e spassosissima, e attese con impazienza l'ora in cui il suo vecchio compagno avrebbe avuto una così favorevole opportunità di mostrare tutte le sue risorse. «Dobbiamo assolutamente sapere come se la sta passando entro oggi, in un modo o nell'altro», disse Fagin. «Lasciami pensare». «Ci vado io?», chiese Charley. «Per nulla al mondo», replicò l'ebreo. «Sei pazzo, mio caro, completamente pazzo ad andarti a cacciare proprio nel posto dove... No, Charley, no! È già abbastanza averne perduto uno, per ora». «Non vorrai mica andarci tu!», osservò Charley con un ghigno divertito. «Non sarebbe una mossa azzeccata», replicò Fagin scuotendo la testa. «Perché allora non mandi questa recluta qui?», chiese mastro Bates poggiando la mano sul braccio di Noah. «A lui nessuno lo conosce». «Beh, se non ha niente in contrario...», osservò l'ebreo. «In contrario!», interloquì Charley. «E cosa dovrebbe avere in contrario?» «In effetti, nulla, mio caro, nulla», replicò Fagin volgendosi al signor Bolter. «Oh, mi sa tanto, invece, sapete...», osservò Noah retrocedendo verso la porta scuotendo la testa in segno di moderato allarme. «No, non se ne parla. Non ci sono tagliato, per niente». «Per cosa è tagliato allora, Fagin?», chiese mastro Bates squadrando da capo a piedi, disgustato, la forma dinoccolata di Noah. «Squagliarsela quando qualcosa va male, e abbuffarsi quando tutto va bene. Per questo è tagliato?» «Non t'impicciare», replicò Bolter. «E non prenderti libertà con i tuoi superiori, o potresti trovarti a mal partito». Mastro Bates scoppiò a ridere così forte a questa grandiosa minaccia che occorse del tempo prima che Fagin potesse intromettersi per spiegare al signor Bolter che non correva alcun pericolo a presentarsi alla stazione di polizia in quanto nessuna notizia dell'affaruccio in cui era implicato né descrizione alcuna della sua persona erano state ancora trasmesse alla metropoli; era poi molto probabile che non lo si sospettasse neanche di essersi rifugiato lì e che se si fosse travestito in modo adeguato, quello sarebbe stato per lui un posto altrettanto sicuro da visitare di qualsiasi altro in città in quanto, di tutti i luoghi, sarebbe stato quello in cui meno lo si sarebbe sospettato di volersi recare di sua propria volontà. In parte persuaso da questi argomenti, ma soprattutto dalla paura che aveva dell'ebreo, il signor Bolter, molto malgrado, accondiscese infine a compiere quella missione. Istruito da Fagin, cambiò immediatamente abbigliamento, sostituendo ai suoi abiti la parannanza di un carrettiere, braghe di velluto e gambali di pelle, articoli che l'ebreo aveva a portata di mano. Al tempo stesso fu dotato di un cappello di feltro, fornito di tagliandi di barriere a pedaggio e di una frusta. Così equipaggiato egli sarebbe dovuto capitare come per caso nella stazione di polizia, come avrebbe potuto fare qualche campagnolo arrivato dal mercato di Covent Garden per soddisfare la propria curiosità, e poiché era goffo, malmesso e dinoccolato come si richiedeva, il signor Fagin non dubitava che sarebbe stato perfettamente all'altezza della parte. Completati questi preparativi, fu edotto sui necessari segnali e gesti mediante i quali si potesse far riconoscere da Dodger, e attraverso un intrico di tortuose e buie stradine mastro Bates l'accompagnò a brevissima distanza da Bow-Street. Dopo aver descritta la precisa ubicazione della stazione, con l'aggiunta di abbondanti indicazioni su come dovesse andare dritto per il corridoio e, una volta nel cortile, prendere la porta in cima a dei gradini sulla destra togliendosi il cappello quando sarebbe entrato nell'aula, Charley Bates lo sollecitò a sbrigarsi a proseguire da solo assicurandogli che avrebbe atteso il suo ritorno in quel punto preciso. Noah Claypole, o Morris Bolter, come più piace al lettore, seguì puntualmente le istruzioni ricevute le quali, data l'estrema familiarità di mastro Bates con quel luogo, erano così precise da consentirgli di giungere a quella augusta presenza senza chiedere altre informazioni o trovare intoppi lungo la strada. Finì spinto in mezzo ad una folla di gente, donne soprattutto, ammassate insieme in una stanza sporca e ammuffita in fondo alla quale si levava una pedana recintata, con una sbarra per gli accusati sulla sinistra contro il muro, un banco per i testimoni nel mezzo, e un seggio per i magistrati sulla destra, settore, quest'ultimo, protetto da un divisorio che nascondeva la corte agli sguardi del popolo, lasciando che questo immaginasse, se poteva, tutta la maestà della giustizia. Alla sbarra degli accusati due donne facevano cenni con la testa ai loro amici e ammiratori, mentre il cancelliere leggeva qualche deposizione a un paio di poliziotti e a un uomo modestamente vestito curvo su un tavolo. Una guardia stava appoggiata alla sbarra degli accusati e con aria distratta si picchiettava il naso servendosi di una grossa chiave, tranne quando soffocava una inopportuna tendenza alla conversazione tra gli sfaccendati del pubblico proclamando a gran voce "silenzio" o quando guardava severo in fondo per ordinare a qualche donna di "portar fuori il bambino" allorché la gravità della giustizia era disturbata dai deboli vagiti di qualche smagrito neonato mezzo soffocato nello scialle materno. La stanza sapeva di chiuso e di malsano; le pareti erano scolorite dallo sporco e il soffitto tutto annerito. C'era un vecchio busto affumicato sulla mensola del camino e un orologio polveroso in alto sopra la sbarra degli accusati, la sola cosa di quell'ambiente che sembrava andare avanti a dovere, poiché la depravazione e la povertà, o la protratta contiguità con entrambe, avevano lasciato su tutto quanto vi era di animato un marchio non meno sgradevole dello spesso strato di sudiciume deposto su ogni oggetto inanimato che incupiva quella scena. Noah guardò attentamente intorno cercando Dodger, ma sebbene vi fossero diverse donne che avrebbero potuto essere benissimo la madre o la sorella di quel distinto personaggio, e più di un uomo che poteva plausibilmente far pensare a suo padre, non si vedeva nessuno corrispondente alla descrizione che gli era stata data del signor Dawkins. Attese in uno stato di grande ansia e incertezza finché le donne, rinviate a giudizio, uscirono imprecando con aria di sfida, per essere in breve appagato dalla comparsa di un altro prigioniero: non altri - avvertì subito - se non l'oggetto della sua visita. Era in effetti il signor Dawkins il quale, scivolato silenziosamente nell'aula con le grandi maniche del cappotto rimboccate come al solito, la mano sinistra in tasca e il cappello nella destra, precedeva la guardia carceraria con un'andatura ondeggiante impossibile a descriversi, e, preso posto alla sbarra, con voce stentorea richiese di sapere come mai fosse stato messo in quella sgradevole situazione. «Fate silenzio, per favore», disse il carceriere. «Sono un cittadino inglese, no?», replicò Dodger. «Dove sono i miei privilegi?» «Te li diamo noi i tuoi privilegi», rispose il carceriere, «e pure con gli interessi». «Vedremo quello che dirà il ministro degli interni ai piedi piatti, se non mi saranno riconosciuti», replicò il signor Dawkins. «Allora! Di che si tratta? Sarò grato ai magistrati se vorranno sbrigare questo affaruccio senza leggere il giornale mentre mi trattengono qui, perché ho un appuntamento in città con un signore e io sono un uomo di parola e ci tengo alla puntualità negli affari e lui se ne andrà via se non sono lì in tempo. Citerò per danni quelli che m'hanno trattenuto. State a vedere!». A questo punto Dodger, mostrando di essere molto ben addentro alla procedura e al corso dei dibattimenti, richiese al carceriere di comunicare «i nomi dei due tizi sul seggio», il che tanto divertì gli spettatori che risero di cuore quasi quanto avrebbe fatto mastro Bates se avesse sentito quella richiesta. «Silenzio laggiù!», gridò il carceriere. «Cosa abbiamo adesso?», chiese uno dei magistrati. «Un caso di borseggio, vostra eccellenza». «È già comparso qualche altra volta il ragazzo?» «Sarebbe dovuto comparire qui diverse altre volte», replicò il carceriere. «Ma è comparso piuttosto spesso in ogni altra stazione di polizia. Lo conosco bene, vostro onore». «Allora mi conoscete, sì?», gridò Dodger prendendo nota dell'affermazione. «Benissimo. Comunque sia, questo è un caso di diffamazione». A questo punto ci furono altre risate e ancora un grido di far silenzio. «Dunque, dove sono i testimoni?», disse il cancelliere. «Ah, giusto!», aggiunse Dodger. «Dove sono? Sono proprio curioso di vederli». La sua curiosità fu immediatamente soddisfatta, poiché si fece avanti un poliziotto che aveva veduto l'accusato mentre tentava di borseggiare un signore tra la folla e gli aveva in effetti rubato un fazzoletto dalla tasca; trovandolo però piuttosto liso, glielo aveva rimesso prontamente a posto dopo averne fatto uso personale. Per questa ragione, l'agente aveva arrestato Dodger non appena aveva potuto accostarlo e sulla persona del detto Dodger, in seguito a perquisizione, era stata trovata una tabacchiera d'argento con sul coperchio inciso il nome del proprietario. Questo signore era stato rintracciato mediante il registro delle denunce, e poiché si trovava lì presente giurò che la tabacchiera era sua e che non se l'era trovata più dal giorno prima, quando cioè era riuscito a svincolarsi dalla folla summenzionata. Aveva anche notato tra la folla un giovanotto particolarmente indaffarato a farsi strada nella calca, e quel giovanotto era l'arrestato che gli stava innanzi. «Avete niente da chiedere a questo testimone, ragazzo?», disse il magistrato. «Mica posso abbassarmi a conversare con costui, io!», replicò Dodger. «Avete comunque qualcosa da aggiungere?» «Avete sentito che sua eccellenza vi ha chiesto se avete qualcosa da aggiungere?», chiese il carceriere dando una gomitata al silenzioso Dodger. «Vi chiedo scusa», disse Dodger sollevando lo sguardo con aria svagata. «Stavate dicendo a me, brav'uomo?» «Non ho mai visto un vagabondo così sfrontato, vostra eccellenza», osservò l'agente con un ghigno. «Vuoi dire qualcosa, ladruncolo?» «No», replicò Dodger, «non qui, perché questa non è la casa della giustizia; secondo poi, stamattina il mio avvocato sta a colazione con il vicepresidente della Camera dei Comuni, ma avrò da dire qualcosa altrove, e pure lui, e così pure parecchie altre rispettabili persone della mia cerchia di conoscenze, ragion per cui questi piedipiatti preferirebbero non essere mai nati, o essere stati impiccati agli appendiabiti dai loro servitori prima di venirsene qui stamattina a tentare la medesima operazione con me. Quanto è vero che...». «Basta! È rinviato a giudizio!», interloquì il cancelliere. «Portatelo via». «Forza!», disse il carceriere. «Ah, oh! Vengo, vengo», replicò Dodger lisciandosi il cappello col palmo della mano. «Ah! (alla corte). Non serve a niente fare quella faccia impaurita; non avrò pietà per voi, neanche un poco. Me la pagherete per questo, cari miei. Non vorrei essere al vostro posto per nulla al mondo! E non accetterei la scarcerazione adesso, neanche se cadeste in ginocchio per supplicarmelo. Dai, portatemi in prigione! Portatemi via!». Con quest'ultime parole, afferrato per il colletto, Dodger si lasciò condurre via e finché non raggiunsero il cortile minacciò di fare arrivare la questione in Parlamento. Poi si mise a sghignazzare in faccia alla gente, più allegro e compiaciuto che mai. Avendo visto che lo rinchiudevano da solo in una celletta, Noah fece del suo meglio per tornare indietro al più presto lì dove aveva lasciato mastro Bates. Poco dopo fu raggiunto da quel giovanotto, il quale aveva prudentemente evitato di farsi vedere finché, da un nascondiglio sicuro, non aveva attentamente esaminato la zona intorno e non s'era accertato che il suo nuovo amico non era stato seguito da qualche ficcanaso. I due si affrettarono a tornare insieme dal signor Fagin per portargli la brillante notizia che Dodger stava rendendo piena giustizia all'educazione ricevuta e che stava guadagnandosi una gloriosa reputazione. Capitolo XLIV. Per Nancy giunge l'ora di mantenere la promessa fatta a Rose Maylie, ma non può Addentro com'era in ogni arte dell'inganno e della dissimulazione, la giovane Nancy non potè tuttavia nascondere del tutto gli effetti che la consapevolezza del passo intrapreso esercitava sul suo animo. Ella ricordava che tanto il furbo ebreo quanto il brutale Sikes le avevano confidato piani che erano stati tenuti nascosti a tutti gli altri, nell'assoluta sicurezza che ella fosse affidabile e al di sopra di ogni sospetto. Per scellerati che fossero quei piani e disperato chi li aveva concepiti, per quanto amareggiati fossero i suoi sentimenti verso l'ebreo che passo dopo passo, sempre più a fondo, l'aveva condotta negli abissi del crimine e della perdizione da cui non v'era via d'uscita, ella a volte sentiva qualche rimorso perfino verso di lui temendo che ciò che aveva rivelato potesse condurlo a quei ceppi a cui egli era così a lungo riuscito a sfuggire e che infine dovesse cadere giustiziato, sebbene lo meritasse ampiamente, proprio per mano sua. Ma erano, queste, elucubrazioni di una mente incapace di distaccarsi totalmente dai suoi vecchi compagni e soci, sebbene fosse in grado di tenersi salda in un proposito particolare e decisa a non farsi distogliere da nessun'altra considerazione. Le sue paure per Sikes sarebbero stati motivi più potenti per farla desistere finché c'era ancora tempo, ma ella aveva concordato che il suo segreto dovesse rimanere strettamente circoscritto, non aveva fornito alcun indizio che potesse condurre alla sua cattura, e aveva perfino rifiutato, per amor suo, uno scampo da tutte le colpe e le miserie che la circondavano! Cosa avrebbe potuto fare di più per lui? Era decisa. Ma seppure tutte le sue lotte mentali finivano immancabilmente a questa conclusione, sempre di nuovo tornavano a tormentarla lasciando le loro tracce. Nel giro di pochi giorni si fece pallida e smagrita. A volte sembrava non accorgersi di ciò che le accadeva intorno e non prendeva parte a conversazioni che l'avrebbero un tempo parecchio accalorata. Altre volte rideva senza allegria o dava in escandescenze senza motivo. Altre volte ancora, spesso dopo pochi istanti soltanto, rimaneva seduta a rimuginare, abbattuta e silenziosa, con la testa appoggiata sulle mani, mentre lo stesso sforzo con cui si scuoteva diceva, più fortemente perfino di questi indizi, che era inquieta e che i suoi pensieri erano presi da cose molto lontane e diverse da quelle di cui discutevano i suoi compagni. Era domenica notte, e la campana della chiesa più vicina batté l'ora. Sikes e l'ebreo, che stavano parlando, si fermarono in ascolto. La ragazza sollevò lo sguardo dalla bassa seggiola sulla quale sedeva e tese l'orecchio anche lei. Le undici. «Manca un'ora alla mezzanotte», disse Sikes sollevando la tendina per guardare fuori e poi tornando a sedere. «Buia e coperta, per giunta. Sarebbe una buona notte per qualche colpetto». «Ah!», replicò l'ebreo. «Che peccato, mio caro Bill, che non ne abbiamo pronto nessuno». «Una volta tanto hai ragione», bofonchiò Sikes. «È un peccato, perché mi sento in vena». L'ebreo sospirò e scosse la testa sconsolato. «Dovremo recuperare il tempo perduto quando rimetteremo tutto in sesto. Questo è quanto», disse Sikes. «Questo è parlare, mio caro», replicò l'ebreo azzardandosi a dargli un colpetto sulla spalla. «Mi fa bene sentirti parlare così». «Ah, ti fa bene, eh?», gridò Sikes. «Mi fa piacere!». «Ah, ah, ah!», rise l'ebreo come divertito da questa concessione. «Sei di nuovo te stesso, Bill! Di nuovo te stesso». «Non mi ci sento, me stesso, quando mi metti quella vecchia zampa rugosa sulle spalle, perciò toglila», disse Sikes scansando la mano dell'ebreo. «Nervoso, eh, Bill?... Ti fa pensare ad altre grinfie, non è vero?», disse l'ebreo deciso a non raccogliere le offese. «Mi fa pensare alle grinfie del diavolo», replicò Sikes. «Non s'è mai visto nessuno con una faccia come la tua, tranne tuo padre e immagino che a quest'ora gli si stia bruciacchiando quella sua irsuta barba rossa, a meno che tu non discenda direttamente dal demonio senza altri padri di mezzo, del che non mi meraviglierei per nulla». Fagin non replicò nulla a questo complimento, ma tirando Sikes per una manica, puntò il dito verso Nancy che aveva approfittato della precedente conversazione per mettersi la cuffia, e s'accingeva ora a lasciare la stanza. «Ehi!», gridò Sikes. «Nancy. Dove se ne va la pupa di bello a quest'ora di notte?» «Non lontano». «E che risposta è questa?», ribatté Sikes. «Dove stai andando?» «Non lontano, ho detto». «E dove, ho detto io», replicò Sikes. «Mi senti?» «Non lo so, dove», rispose la ragazza. «Allora te lo dico io», fece Sikes più per spirito di contraddizione che per qualche reale obiezione a lasciarla andare dove le pareva. «Da nessuna parte. Siediti». «Non mi sento bene. Te l'ho già detto», continuò la ragazza. «Ho bisogno di un po' d'aria». «Metti la testa fuori della finestra», replicò Sikes. «Ma non c'è abbastanza aria», protestò la ragazza. «Ho bisogno del fresco della strada». «E allora niente», replicò Sikes, e con quella assicurazione si alzò, serrò la porta, prese la chiave e, strappandole la cuffia dal capo, la gettò sopra una vecchia dispensa. «Ecco», disse il ladro. «E ora resta buona dove sei, capito?» «Non sarà certo una cuffia a fermarmi», disse la ragazza sbiancando. «Che cosa vuoi, Bill? Sai cosa stai facendo?» «Se lo so?... Oh!», gridò Sikes rivolto a Fagin. «Deve aver perso la testa, sai, o non oserebbe parlarmi a quel modo». «Di questo passo la perdo davvero», borbottò la ragazza premendosi le mani al petto come per soffocare un'esplosione di rabbia. «Lasciami andare, sai... subito... in quest'istante». «No!», disse Sikes. «Digli di lasciarmi andare, Fagin. È meglio. Sarà meglio per lui. Mi avete sentito?», gridò Nancy pestando il piede a terra. «Ti abbiamo sentito!», ripetè Sikes girandosi sulla sedia per guardarla in faccia. «Sì! E se ti sento ancora per mezzo minuto quel cane t'azzannerà alla gola così forte da strapparti via pure quella tua vociacela. Che cosa ti succede sgualdrina! Eh?» «Lasciami andare», disse la ragazza caparbia; poi, sedendosi sul pavimento innanzi alla porta, continuò: «Bill, lasciami andare; non sai cosa stai facendo. Veramente, non lo sai. Soltanto per un'ora... per piacere...». «Che mi possano sbranare pezzo a pezzo!», gridò Sikes afferrandola senza tanti complimenti per il braccio, «la pupa ha dato veramente di testa, credo. Alzati». «No, fino a che non mi lasci andare... no... no!», strillò la ragazza. Sikes rimase a guardarla per un minuto aspettando l'occasione buona e poi, afferrandole improvvisamente le mani, mentre lei lottava e si dimenava, la trascinò in una stanzetta adiacente dove, sedutosi su una panca e spinta lei su una sedia, la tenne giù a forza. Lei si dibatté e implorò finché non suonò la mezzanotte; quindi, spossata ed esausta, cessò di ribellarsi. Avvertendola, con molte minacce e imprecazioni, di non fare altri tentativi di uscire per quella notte, Sikes la lasciò a riprendersi per conto suo e tornò da Fagin. «Caspita!», disse il ladro asciugandosi il sudore dalla faccia. «Che strano soggetto!». «Puoi ben dirlo, Bill», replicò l'ebreo pensoso. «Puoi ben dirlo». «Chissà perché s'era messa in testa d'uscire stanotte. Che ne pensi?», chiese Sikes. «Su; dovresti conoscerla meglio di me. Che significa?» «Caparbietà; caparbietà femminile, suppongo, mio caro», replicò l'ebreo scrollando le spalle. «Beh, dev'essere così», ringhiò Sikes. «Pensavo d'averla ammansita, ma è sempre una brutta gatta da pelare». «Bruttissima», disse l'ebreo pensoso. «Non l'avevo mai vista così prima d'ora, e per una sciocchezza simile». «Neppure io», disse Sikes. «Deve avere ancora un po' di febbre nel sangue, che non vuole andar via... eh?» «Probabile», replicò l'ebreo. «Gliene cavo un po' io e senza incomodare il dottore, se ripianta questa grana», disse Sikes. L'ebreo annuì espressivamente alla prospettiva di una tale terapia. «M'è stata vicina notte e giorno quando giacevo ferito mentre tu, lupo dal cuore nero che sei, giravi alla larga», disse Sikes. «Per tutto quel tempo siamo rimasti senza un soldo, e questo deve averla provata, in un modo o nell'altro, e restare chiusa qui tanto tempo l'ha resa inquieta e nervosa... eh?» «Proprio così, mio caro», replicò l'ebreo in un bisbiglio. «Zitto!». Mentre diceva queste parole la ragazza rientrò e sedette dov'era prima. Aveva gli occhi gonfi e arrossati, si dondolò avanti e indietro, scosse la testa e dopo un po' scoppiò a ridere. «Beh, adesso ha cambiato musica!», esclamò Sikes volgendo uno sguardo alquanto sorpreso al compagno. L'ebreo gli fece cenno di non badarci per un po', e nel giro di pochi minuti la ragazza, calmata, tornò ai suoi modi abituali. Sussurrando a Sikes che non c'era da temere una ricaduta, Fagin prese il cappello e gli augurò la buona notte. Quando fu sulla porta si fermò un attimo e guardando intorno chiese se qualcuno volesse fargli luce giù per le scale buie. «Sarebbe un peccato», disse Sikes riempiendo la pipa, «se si rompesse l'osso del collo giù per le scale, da solo, togliendoci il piacere di vederlo impiccato. Fagli luce». Nancy, reggendo una candela, accompagnò il vecchio giù per le scale. Quando raggiunsero il corridoio egli si portò il dito alle labbra e accostandosi alla ragazza le bisbigliò: «Cosa c'è, cara Nancy?» «Che vuoi dire?», replicò la ragazza con un altro bisbiglio. «Il motivo di tutto questo», replicò Fagin. «Se lui...», e indicò di sopra con l'indice ossuto, «ti strapazza così - è un bruto, Nancy, una vera bestia - perché tu non...». «Beh?», fece la ragazza quando Fagin s'interruppe, con la bocca che quasi le sfiorava l'orecchio e gli occhi fissi nei suoi. «Niente, niente...», disse l'ebreo. «Ne riparliamo più in là. Ma io sono tuo amico, Nancy, un amico vero, e ho i mezzi a portata di mano, segreti e sicuri, per vendicarti di quelli che ti trattano come una cagna... come una cagna! Peggio del suo cane, perché a quello dà soddisfazione qualche volta... vieni da me. Lui è lo spasso d'un giorno; me, invece, mi conosci da una vita, Nancy». «Ti conosco bene», replicò la ragazza senza manifestare la minima emozione. «Buona notte». Si tirò indietro quando Fagin tentò di posare la sua mano sulla propria, ma ricambiò la buona notte con voce ferma; poi, rispondendo al suo sguardo di saluto con un cenno d'intesa, richiuse la porta dietro di lui. Fagin camminò verso casa rimuginando i pensieri che gli si agitavano in mente. Aveva concepito l'idea, non a causa di ciò che era appena accaduto, sebbene questo tendesse a confermarla, ma a poco a poco, per gradi, che Nancy, stanca della brutalità del ladro, si fosse incapricciata di qualche nuovo amico. I modi diversi dal solito, le ripetute uscite di casa, da sola, la relativa indifferenza agli interessi della banda per cui un tempo era così zelante e, aggiunta a ciò, la forsennata impazienza di uscire di casa quella notte a una certa ora confermavano la sua supposizione e la rendevano, per lo meno ai suoi occhi, una quasi certezza. L'oggetto del capriccio di lei non si trovava nella cerchia dei suoi mirmidoni. Con l'aiuto di Nancy, sarebbe stata un'utilissima nuova recluta, e bisognava assicurarsela al più presto - argomentò tra sé Fagin. C'era però un altro e più sinistro obiettivo da raggiungere. Sikes sapeva troppo, e sebbene Fagin nascondesse bene le ferite, non per questo era meno esacerbato dalle sue pesanti battute. La ragazza non poteva dubitare che se avesse scaricato Sikes non sarebbe sfuggita alla sua furia, la quale avrebbe sicuramente travolto l'oggetto della sua recente infatuazione, fino a lasciarlo mutilato, o morto. «Con un po' di persuasione», pensò Fagin, «niente di più probabile che acconsenta ad avvelenarlo! Le donne hanno fatto questo e peggio, prima d'ora, per raggiungere lo stesso scopo. Quel pericoloso furfante, l'uomo che odio, sarebbe spacciato; un altro subentrerebbe al suo posto e la mia influenza sulla ragazza, rafforzata dal conoscere il suo crimine, sarebbe praticamente senza limiti». Questi i pensieri al vaglio della mente di Fagin già nel breve tempo che rimase seduto nella stanza del ladro. Quando, rimuginandoci sopra, aveva colto l'occasione che gli si era presentata, subito dopo, di sondare la ragazza con le velate allusioni lasciate cadere lì prima d'andarsene, non c'era stata nessuna espressione di sorpresa da parte sua, né aveva finto di non aver capito ciò che aveva inteso. La ragazza aveva capito chiaramente. Il suo sguardo di congedo l'aveva rivelato senza dubbio. Ma lei si sarebbe forse rifiutata di prender parte ad un complotto per uccidere Sikes, ed era questo uno dei suoi principali obiettivi. «Come posso rafforzare la mia influenza, e come posso acquistare nuovo potere su di lei?». Menti del genere sono feconde di espedienti: se, senza strapparle confessioni, le avesse messo una spia alle calcagna; se avesse scoperto l'oggetto del suo nuovo interesse e l'avesse minacciata di rivelare tutta la storia a Sikes (del quale aveva un terrore fuori dal comune) a meno che lei non avesse assecondato i propri disegni, questo non l'avrebbe resa sua complice? «Certo», disse Fagin quasi ad alta voce. «Non avrebbe il coraggio di rifiutarsi, in quel caso. Non a rischio della vita! Non a rischio della vita. Ti ho in pugno. I mezzi ci sono, e saranno adoperati. Ti ho in pugno!». Con uno sguardo cupo e un gesto minaccioso della mano verso il luogo in cui aveva lasciato il ladro - certo con più fegato di lui proseguì per la sua strada, e nascosti i pugni sotto i propri abiti laceri prese a stringerne forte le pieghe, come se ogni contrazione delle dita serrasse la gola dell'odiato nemico. Capitolo XLV. Fagin affida una missione a Noah Claypole Il mattino seguente il vecchio si era levato per tempo, e attendeva con impazienza l'arrivo del nuovo discepolo; con un ritardo che parve interminabile, questi infine si presentò e s'accinse a un vorace assalto alla colazione. «Bolter», disse l'ebreo accostando una sedia e sedendoglisi di fronte. «Morris Bolter». «Beh, eccomi qua», replicò Noah. «Cosa c'è? Non rifilarmi incarichi prima che abbia finito la colazione. È un grosso difetto di questo posto. Non si concede abbastanza tempo alla tavola». «Puoi parlare mentre mangi, no?», disse Fagin maledicendo dal profondo del cuore l'ingordigia del giovane. «Oh sì, posso parlare. Mi giova di più se parlo», disse Noah tagliandosi un'enorme fetta di pane. «Dov'è Charlotte?» «In giro», disse Fagin. «L'ho mandata fuori stamane con l'altra ragazza perché volevo restar solo con te». «Oh!», rispose Noah. «Era meglio se le dicevi di prepararmi prima il pane tostato col burro. Bene, sputa fuori; io intanto mangio». In effetti, non sembrava temesse ulteriori interruzioni, giacché s'era accomodato deciso a rendere onore alla tavola. «Ieri hai fatto un bel lavoretto, mio caro», osservò l'ebreo. «Bello! Sei scellini e nove pence e mezzo solo il primo giorno! Fregapischello farà la tua fortuna». «Ci devi aggiungere i tre boccali da una pinta e il paiolo di latte», disse il signor Bolter. «Sicuro, mio caro», replicò l'ebreo. «I tre boccali sono stati dei colpi di genio, ma il paiolo del latte è stato un vero capolavoro». «Non male, credo, per uno alle prime armi», replicò il signor Bolter compiaciuto. «I boccali li ho presi da dietro l'inferriata d'un seminterrato, e il paiolo del latte se ne stava solo soletto alla porta d'una locanda. Ho pensato che si sarebbe potuto arrugginire, o avrebbe potuto beccarsi una gelata, sapete. Eh? Ah, ah, ah!». L'ebreo fece mostra di ridere di cuore mentre il signor Bolter, finito di ridere, dette una serie di morsi spropositati mediante i quali spacciò la sua trancia di pane e burro prima di averne approntata una seconda. «Voglio affidarti un lavoretto per me, mio caro, ma bisogna usare molta prudenza e attenzione». «Dico», soggiunse Bolter, «basta cacciarmi in mezzo ai pericoli, o spedirmi in altri uffici di polizia. Non fa per me, questo, no! Voglio dirtelo». «Non c'è nessun pericolo... assolutamente nessun pericolo», fece l'ebreo. «C'è solo da pedinare una donna». «Una vecchia?», chiese il signor Bolter. «Una giovane», rispose Fagin. «Questo posso farlo abbastanza facilmente, sicuro», disse Bolter. «Ero uno spione in gamba quando andavo a scuola. Perché devo pedinarla? Non per...». «Non devi far altro», interruppe l'ebreo, «che dirmi dove va, chi incontra e se possibile quello che dice; ricordarti la strada, se si tratta di strada, o la casa se si tratta di casa, e portarmi tutte le informazioni che puoi». «Quanto mi dai?», chiese Noah posando la tazza e guardando avidamente in faccia il suo datore di lavoro. «Se farai bene, una sterlina, mio caro. Una sterlina», disse Fagin, per adescarlo il più possibile all'impresa. «Una somma che non ho mai dato prima, se non per lavori che dovessero fruttare notizie importanti». «Oh Cribbio!», gridò Noah arricciando il naso. «Sospetti di lei, è così?» «Ha trovato nuovi amici, mio caro, e io devo sapere chi sono», replicò l'ebreo. «Capisco», disse Noah. «Solo per il piacere di conoscerli perché sono persone rispettabili, eh? Ah, ah, ah! Sono il tipo che fa per te». «Lo sapevo», gridò Fagin entusiasmato al successo della proposta. «Naturalmente, naturalmente», rispose Noah. «Dov'è lei? Dove dovrò aspettarla? Quando devo andare?» «Ti farò sapere tutto quanto, mio caro. Te la indicherò a tempo debito», disse Fagin. «Tieniti pronto e lascia il resto a me». Quella sera, e la sera seguente, e la seguente ancora, la spia rimase seduta, equipaggiata con abiti e scarpe da carrettiere, pronta a muoversi a una parola di Fagin. Passarono sei notti, lunghe e pesanti; sei notti Fagin tornò a casa deluso, annunziando che non era ancora giunto il momento. La settima notte tornò prima, con un'esultanza che non poteva mascherare. Era domenica. «Esce stanotte», disse Fagin, «e sono certo che va dove interessa a noi perché è rimasta sola in casa tutto il giorno e l'uomo che lei teme non tornerà se non poco prima dell'alba. Vieni con me. Svelto!». Noah scattò in piedi senza dire una parola, contagiato dallo stato di intensa agitazione dell'ebreo. Lasciarono furtivamente la casa e, passando in fretta per un labirinto di strade, giunsero infine in una locanda che Noah riconobbe come quella in cui aveva dormito la notte del suo arrivo a Londra. Erano le undici passate e la porta era chiusa. S'aprì senza alcun rumore quando l'ebreo emise un fischio basso. Entrarono silenziosamente e la porta si richiuse dietro di loro. Non osando neanche bisbigliare, ma sostituendo pantomime alle parole, Fagin e il giovane ebreo che aveva aperto indicarono a Noah il pannello di vetro e gli fecero cenno di salire su e osservare la persona nella stanza attigua. «È quella la donna?», chiese con un filo di voce. L'ebreo accennò di sì. «Non riesco e vederla bene in faccia», bisbigliò Noah. «Ha gli occhi bassi e la candela le sta dietro». «Resta là», bisbigliò Fagin. Fece cenno a Barney che scomparve. L'istante dopo il garzone entrò nella stanza attigua e, facendo mostra di smoccolare la candela, la spostò nella posizione opportuna e parlando alla ragazza fece sì che ella sollevasse il volto. «Adesso la vedo», esclamò la spia. «Distintamente?», chiese l'ebreo. «La riconoscerei tra mille». Ridiscese rapidamente mentre s'apriva la porta della stanza e ne usciva la ragazza. Fagin lo tirò dietro un angolo riparato da una tenda. Trattennero il respiro mentre lei passava a pochi passi dal loro nascondiglio e usciva dalla porta dalla quale erano entrati. «Zitti!», esclamò il garzone alla porta. «Giù, via!». Noah scambiò un'occhiata con Fagin e si precipitò fuori. «A sidistra», bisbigliò il garzone. «A mado sidistra, e riediti dall'altro lato». Così fece e alla luce dei lampioni intravide a distanza la sagoma della giovane che s'allontanava. S'avvicinò fin quanto ritenne prudente, tenendosi dal lato opposto della strada per meglio sorvegliare i suoi movimenti. Due o tre volte ella si guardò attorno nervosamente e una volta si fermò per far passare due uomini che la seguivano dappresso. Sembrava acquistare coraggio man mano che procedeva, e camminare con passo più fermo e deciso. La spia la seguì, tenendole gli occhi addosso e mantenendo sempre la stessa distanza. Capitolo XLVI. Appuntamento mantenuto L'orologio della chiesa vicina batteva i tre quarti dopo le undici quando due figure vennero a stagliarsi su London Bridge. Una, quella di una donna, avanzava con passo rapido e veloce e si guardava ansiosamente intorno come in attesa di qualcuno; l'altra, quella di un uomo, seguiva a qualche distanza, dove trovava l'ombra più fitta, adattando il suo passo a quello di lei, fermandosi quand'ella si fermava, e strisciando furtivamente innanzi quand'ella riprendeva a muoversi, senza però mai, nell'eccitazione del pedinamento, accorciare la distanza. Attraversarono così il ponte, dal lato del Middlesex a quello del Surrey; poi, di colpo, la donna, evidentemente delusa perché non vedeva tra i passanti chi s'attendeva, tornò indietro. Fu un movimento improvviso, ma il pedinatore non se ne fece sorprendere: accucciandosi in uno degli anfratti che sormontano i piloni del ponte e affacciandosi dal parapetto per meglio nascondere la sua figura, lasciò che lei gli passasse innanzi sul marciapiede dalla parte opposta. Quando ella si trovò tanto innanzi a lui quanto era prima, egli scivolò fuori silenziosamente e riprese a seguirla. Quasi a metà del ponte ella si fermò. Anche l'uomo si fermò. Era una notte tenebrosa. Aveva fatto brutto tempo, di giorno, e a quell'ora, in quel luogo, poche persone passavano e, quelle poche, passavano in fretta, molto probabilmente senza neanche vedere, ma di certo senza notare, né la donna né l'uomo che la pedinava. Il loro abbigliamento non era tale da attirare gli sguardi indiscreti di quella parte indigente della popolazione londinese che poteva trovarsi a passare sul ponte in cerca di qualche fredda arcata o di qualche rifugio aperto dove posare il capo per la notte. Rimasero lì in silenzio, senza rivolgere la parola a nessuno dei passanti e senza che nessuno la rivolgesse a loro. Sul fiume s'abbassava una nebbia pesante diffondendo sulle piccole imbarcazioni ormeggiate ai diversi moli i bagliori rossastri dei fuochi accesi e rendendo più cupe e indistinte le tenebrose sagome degli edifici sulle sponde. I vecchi magazzini affumicati, su ciascun lato, s'ergevano pesanti e cupi sulla massa di tetti e abbaini, guardando con severo cipiglio un'acqua troppo nera per rifletterne le incombenti sagome. Nell'oscurità s'intravedevano la torre della vecchia chiesa del Santo Salvatore e il campanile di Saint Magnus, i giganti da lungo tempo custodi dell'antico ponte, ma la foresta di alberature sotto di esso e i numerosi, fitti campanili delle chiese al di sopra erano pressoché nascosti alla vista, indistinguibili. La ragazza, attentamente sorvegliata dal suo pedinatore, aveva nervosamente camminato in su e in giù quando la pesante campana di St. Paul annunciò la morte di un altro giorno. La mezzanotte era scesa sulla città formicolante: sui palazzi e sui tuguri, sulle prigioni e sui manicomi, sulle stanze dove si nasceva e su quelle dove si moriva, dove c'era salute e dove c'era malattia, il volto irrigidito di un cadavere o il placido sonno di un bimbo. Non erano passati neanche due minuti dal tocco delle ventiquattro quando una giovane donna e un gentiluomo dai capelli grigi scesero da una carrozza a non grande distanza dal ponte. Ripartito il veicolo, si diressero alla volta del ponte, ed erano appena giunti sul marciapiede quando la ragazza che attendeva trasalì e mosse immediatamente verso di loro. I due avanzarono, guardandosi intorno con l'aria di chi nutre ben poche speranze di incontrare la persona cercata, quando furono all'improvviso avvicinati dalla donna. Si fermarono con un'esclamazione di sorpresa, ma la soffocarono immediatamente, perché proprio in quell'istante un uomo in abiti campagnoli passò loro accanto sfiorandoli. «Non qui», disse Nancy in fretta. «Ho paura a parlare qui. Venite via... togliamoci dalla strada... scendiamo per quegli scalini!». Mentre così diceva, e indicava con la mano dove voleva che si dirigessero, il campagnolo si voltò e, domandando sgarbatamente perché ostruissero tutto il marciapiede, passò innanzi. I gradini indicati dalla ragazza erano quelli che, sulla riva del Surrey e sullo stesso lato del ponte della chiesa del San Salvatore, permettono l'attracco dal fiume. Proprio qui si diresse, in fretta e senza farsi scorgere, l'uomo che pareva un campagnolo, e dopo aver esaminato un momento il luogo cominciò a scendere. Quegli scalini, parte integrante del ponte, scendono in tre rampe. Alla fine della seconda, il muro di pietra sulla sinistra termina in un piedistallo o cippo ornamentale rivolto verso il Tamigi. Da qui, i gradini più in basso si allargano dimodoché chi giri l'angolo di quel muro risulterà necessariamente nascosto a persone che si trovino più in alto sulle scale, foss' anche di un solo gradino. Giunto a questo punto, il campagnolo si guardò rapidamente intorno e, non scorgendo nascondiglio migliore e poiché il riflusso della marea aveva lasciato ampio spazio, scivolò di lato, spalle al piedistallo, e lì attese, quasi certo che essi non sarebbero scesi più in basso e che, se anche non avesse potuto sentire ciò che avrebbero detto, avrebbe potuto però riprendere il pedinamento in tutta sicurezza. Così lentamente passava il tempo in quel luogo desolato e così ansiosa era la spia di penetrare il segreto di un colloquio tanto diverso da quello che era stato indotto ad attendersi che più di una volta dette tutto per perso e si persuase che si fossero fermati molto più in alto, oppure che si fossero appartati in tutt'altro luogo per il loro misterioso colloquio. Stava per venir fuori dal suo nascondiglio per riportarsi in strada quando sentì un rumore di passi e subito dopo udì voci vicinissime al suo orecchio. Si schiacciò dritto contro il muro e, appena respirando, tese l'orecchio in ascolto. «Siamo abbastanza lontani adesso», disse una voce che doveva essere quella del gentiluomo. «Non permetterò che questa giovane scenda più in basso. Molti non sarebbero arrivati neanche fin qua, non fidandosi di voi, ma come vedete sono disposto a venire incontro ai vostri desideri». «Venire incontro!», esclamò la voce della ragazza. «Siete davvero premuroso, signore. Venire incontro! Via, via! Non importa». «Ma a quale scopo», disse il gentiluomo in tono più gentile, «a quale scopo ci avete portato in questo strano luogo? Perché non parlare di sopra, dove c'è luce e dove c'è in giro qualcuno, invece di condurci in quest'angolo buio e lugubre?» «Ve l'ho già detto», replicò Nancy. «Ho paura a parlare là. Non so perché», disse la ragazza rabbrividendo, «ma tale è la paura e il terrore che m'attanagliano stanotte che a malapena mi reggo in piedi». «Paura di che?», chiese il gentiluomo sembrando compatirla. «Non lo so neanch'io», replicò la ragazza. «Vorrei saperlo. Orribili pensieri di morte, sudari intrisi di sangue, e un terrore che mi brucia da dentro, come fossi in mezzo alle fiamme: questo per tutto il giorno. Leggevo un libro stasera, per ingannare il tempo, e nelle righe che scorrevo non vedevo altro». «Immaginazione», disse il gentiluomo per consolarla. «Non immaginazione», replicò la ragazza con voce fosca. «Giuro che su ogni pagina del libro vedevo scritto "bara" a grossi caratteri neri... già, e proprio vicino a me, stanotte, ne passava una». «Questo non è tanto strano», disse il gentiluomo. «Spesso sono passate anche accanto a me». «Quelle reali», riprese la ragazza. «Ma questa non lo era». V'era qualcosa di così insolito nei modi della ragazza che, a sentirla pronunciare quelle parole, un brivido corse lungo la schiena di colui che origliava nascosto e il sangue gli si gelò nelle vene; mai perciò fu così sollevato come quando sentì la voce della giovane donna invitare con dolcezza l'altra a calmarsi e a non cedere a tali orribili fantasie. «Parlatele gentilmente», disse la giovane al suo accompagnatore. «Povera creatura! Deve averne bisogno». «Certe persone, quelle altezzose e a dir loro tanto religiose, m'avrebbero guardato dall'alto in basso vedendomi come sono stanotte, e m'avrebbero ammonito con le fiamme dell'inferno e le pene da scontare», esclamò la ragazza. «Oh, cara signora, perché quelle che dicono di essere devote a Dio non sono gentili verso delle povere sciagurate, come lo siete voi; voi, che pur avendo gioventù, bellezza, e tutto quanto esse hanno perduto, potreste giustamente mostrare sdegno invece che tanta umiltà?» «Ah!», disse il gentiluomo. «Quando dice le sue preghiere un turco volge la sua fronte verso l'Est, dopo essersi lavato il viso; la nostra brava gente, atteggiando il volto ad una maschera priva d'ogni sorriso verso il mondo, non meno sistematicamente si volge al lato più cupo del cielo. Tra un musulmano e un fariseo, preferisco il primo!». Queste parole sembravano rivolte alla giovane, forse con lo scopo di dare tempo a Nancy di riprendersi. Poco dopo il gentiluomo si rivolse direttamente a lei. «Non siete venuta domenica scorsa», disse. «Non ho potuto», replicò Nancy. «Sono stata trattenuta con la forza». «Da chi?» «Da quello di cui ho già parlato alla giovane». «Non vi sospettano di parlare a qualcuno dell'argomento che ci ha portati qui questa notte, spero?», chiese l'anziano gentiluomo. «No», replicò la ragazza scuotendo la testa. «È che non mi lascia allontanare facilmente se non sa il motivo; mi sarebbe stato impossibile anche incontrare questa giovane se non gli avessi fatto bere del laudano prima di uscire». «S'era già svegliato al vostro ritorno?», domandò il gentiluomo. «No; e né lui né altri sospettano di me». «Bene», disse il gentiluomo. «Ora ascoltatemi». «V'ascolto», replicò la ragazza vedendolo esitare. «Questa giovane», cominciò, «ha riferito a me e a qualche altro amico assolutamente fidato ciò che le avete detto una quindicina di giorni fa. Vi confesso che all'inizio nutrivo dubbi se fidarci di voi o meno, ma ora sono fermamente convinto che dite la verità». «È così», fece seria la ragazza. «Ripeto, ne sono fermamente convinto. E per provarvi che son disposto a fidarmi di voi, vi dirò senza riserve che intendiamo strappare il segreto da Monks, quale che sia, mettendogli paura. Ma se...», proseguì il gentiluomo, «se questo non dovesse riuscirci..., oppure, anche riuscendoci, non potremo usarlo come speriamo, allora dovrete consegnarci l'ebreo». «Fagin», gridò la ragazza trasalendo. «Solo voi potete consegnarci quell'uomo». «Non lo farò! Non lo farò mai!», replicò la ragazza. «Per quanto sia un demonio, e sia stato peggio d'un demonio per me, non lo farò». «Non volete?» «No!», rispose la ragazza. «E la ragione?» «Una soltanto», ribatté la ragazza con fermezza, «una soltanto, che la ragazza sa e comprende, sono sicura, perché m'ha dato la sua parola; e poi anche perché, sebbene lui abbia condotto una vita scellerata, la mia non è stata diversa, e così quella di molti altri di noi, e io non tradirò nessuno... nessuno di loro... perché avrebbero potuto tradire me e non l'hanno fatto, per quanto loschi siano». «Allora», s'affrettò a dire il gentiluomo, come se proprio a questo punto avesse voluto arrivare, «consegnatemi Monks e lasciate che me la sbrighi io con lui». «E se compromette gli altri?» «In quel caso, se riusciamo a strappargli a forza la verità, vi prometto che non si ritorcerà contro di loro; devono esservi circostanze nella piccola storia di Oliver che sarebbe penoso trascinare innanzi al pubblico, e perciò, spuntata una confessione da Monks, lasceremo gli altri a piede libero». «E se non confessa?», interloquì la ragazza. «Allora», proseguì il gentiluomo, «l'ebreo sarà consegnato alla giustizia solo col vostro consenso. In tal caso, potrei svelarvi motivi che vi persuaderebbero, credo». «La giovane mi dà la sua parola su questo?», chiese la ragazza. «Vi do la mia parola», replicò Rose. «In tutta coscienza». «Monks non saprà mai come siete venuto a conoscenza di queste cose?», disse la ragazza dopo una breve esitazione. «Mai», replicò il gentiluomo. «Useremo le informazioni contro di lui in modo che neanche sospetti». «Sono stata una bugiarda tra bugiardi fin da quando ero bambina», disse la ragazza dopo un'altra pausa di silenzio, «ma mi fido della vostra parola». Dopo aver ricevute assicurazioni, da entrambi, che poteva star sicura, ella continuò a voce così bassa che spesso era difficile per l'ascoltatore anche soltanto afferrare il senso di quello che diceva mentre descriveva, per filo e per segno, la medesima locanda dalla quale, quella notte, egli aveva iniziato a pedinarla. Dalle pause intervallate nel discorso, sembrava che il gentiluomo prendesse qualche rapido appunto di tutte quelle informazioni. Quando ella ebbe spiegato in ogni dettaglio i dintorni del luogo, la migliore posizione per poterlo sorvegliare senza destare sospetti, e le sere e l'ora in cui Monks era solito frequentarlo, sembrò riflettere per qualche istante, per richiamarne alla memoria con più forza la fisionomia e l'aspetto. «È alto», disse la ragazza, «piuttosto corpulento ma non massiccio; cammina in modo furtivo guardandosi sempre dietro le spalle, prima da un lato e poi dall'altro. Non dimenticatelo, poiché ha occhi così infossati nelle orbite, più profondamente di chiunque altro, che potreste riconoscerlo anche solo da quel particolare. È scuro di carnagione, con capelli e occhi pure scuri, e benché non debba avere più di ventisei o ventott'anni, ha la pelle grinzosa e cadente. Spesso le labbra sono esangui e portano i segni dei denti che vi ci sono affondati, poiché cade spesso in crisi epilettiche e a volte si morde persino le mani che ha piene di cicatrici... perché trasalite?», disse la ragazza fermandosi bruscamente. Il gentiluomo s'affrettò a rispondere che non se n'era reso conto, e la pregò di continuare. «Parte di queste cose le so indirettamente», disse la ragazza, «da quello che ho sentito da altri nella locanda di cui v'ho parlato, giacché io l'ho visto soltanto un paio di volte, e l'una e l'altra era sempre nascosto in un ampio mantello. È tutto quanto posso dirvi, credo, per farvelo riconoscere. Un momento, però», aggiunse. «Sulla gola, in un punto tale che quando gira il capo potete vederla spuntare sotto il fazzoletto da collo, ha...». «Una grossa macchia rossa, come una bruciatura o un'ustione», esclamò il gentiluomo. «Cosa?», disse la ragazza. «Lo conoscete?». Alla giovane sfuggì un grido di sorpresa e per alcuni istanti rimasero così immobili che l'ascoltatore poteva quasi udire il loro respiro. «Credo di sì», disse il gentiluomo rompendo il silenzio. «Dovrei riconoscerlo dalla vostra descrizione. Vedremo. Molte persone si rassomigliano in modo stranissimo. Forse non è la stessa». Mentre con finta indifferenza manifestava quest'opinione, si spostò di un passo o due verso il nascondiglio della spia, come questa potè intuire udendolo mormorare più distintamente: «Ma dev'essere lui!». «Dunque», disse tornando al posto di prima, o così parve al pedinatore, «voi ci avete aiutato moltissimo, e vorrei ricompensarvi. Cosa posso fare per voi?» «Niente», replicò Nancy. «Non siate così recisa», riprese il gentiluomo con un tono e un'enfasi che avrebbero toccato un cuore ben più duro e coriaceo del suo. «Pensateci. Ditemelo». «Niente, signore», continuò la ragazza piangendo. «Non potete far nulla per aiutarmi. Non ho più speranze, davvero». «Voi stessa ve le precludete», disse il gentiluomo. «Il vostro passato è stato una tremenda rovina, le vostre qualità giovanili sciupate nel male, e quei tesori inestimabili che il Creatore non concede che una e una volta soltanto sono dissipati; ma nel futuro dovete sperare. Non dirò che è in nostro potere offrirvi la pace del cuore e dell'animo, poiché son cose che vengono, se cercate; ma un sicuro asilo o in Inghilterra o in qualche paese straniero se avete timore a restare qui, non soltanto possiamo ma desideriamo ardentemente garantirvelo. Prima che spunti il nuovo giorno, prima che questo fiume si risvegli al nuovo palpito di luce, vi trovereste completamente fuori della portata dei vostri compari d'un tempo, senza lasciar dietro di voi più tracce che se foste scomparsa dalla terra in questo medesimo istante. Su! Vorrei che non tornaste indietro per parlare ancora coi vostri vecchi compagni o rivedere neanche per una volta il vostro vecchio rifugio né respirare quell'aria che vi infetta e vi appesta. Lasciate tutto, finché c'è modo e occasione!». «Si persuade», esclamò la giovane. «Lo desidera, ne sono sicura». «Temo di no, mia cara», disse il gentiluomo. «No, signore, non mi persuado», replicò dopo un po' la tormentata ragazza. «Sono incatenata alla mia vita passata. Ora la odio e la maledico, eppure non posso lasciarla. Forse sono andata troppo oltre per poter invertire rotta... eppure, non so, perché se mi aveste detto queste cose qualche tempo fa ci avrei riso sopra. Ma...», disse guardandosi ansiosamente intorno, «ecco la mia paura di prima. Devo tornare a casa». «Casa!», replicò la giovane calcando la parola. «Casa, signorina», replicò la ragazza. «A quella casa che mi son data con le azioni di una vita intera. Separiamoci. Potrei essere seguita, o vista. Andate! Andate! Se vi ho reso qualche servizio, vi chiedo solo di lasciarmi andare, andare per la mia strada, da sola». «È inutile», disse il gentiluomo con un sospiro. «Forse la mettiamo in pericolo restando ancora qui. Forse l'abbiamo trattenuta già più di quanto pensasse». «Sì, sì», esclamò la ragazza, «è così». «Come finirà la vita di questa povera creatura!», proruppe la giovane. «Come finirà!», replicò la ragazza. «Guardate giù, signora. Guardate quell'acqua tenebrosa. Quante volte si legge di persone come me che si buttano giù con la marea senza che nessuna creatura vivente se ne preoccupi o le pianga. Passerà forse qualche anno, o forse solo qualche mese, ma lì finirà». «Non dite così, vi prego», replicò la giovane singhiozzando. «Non arriverà al vostro orecchio, cara signora, e Dio non voglia che dobbiate sentire di tali orrori!», replicò la ragazza. «Buona notte, buona notte!». Il gentiluomo si girò per risalire. «Questo borsellino», esclamò la giovane. «Prendetelo per amor mio e perché possa esservi d'aiuto in caso di bisogno e di difficoltà». «No!», replicò la ragazza. «Non l'ho fatto per denaro. Lasciatemi questo conforto. Però... datemi qualcosa che avete portato addosso, vorrei mi deste qualcosa... no, no, non un anello... i vostri guanti, o la sciarpa... qualsiasi cosa appartenuta a voi che io possa tenere, cara giovane. Ecco. Dio vi benedica. Buona notte, buona notte!». Lo stato di forte agitazione della ragazza e la paura che, se fosse stata scoperta, avrebbe subito percosse e violenze indussero il gentiluomo a lasciarla, com'ella chiedeva. S'udirono passi allontanarsi e le voci cessarono. Le sagome della giovane e dell'uomo sbucarono poco dopo sul ponte. Si fermarono in cima alle scale. «Ascoltate!», esclamò la giovane tendendo l'orecchio. «Ha chiamato! Mi pare d'aver sentito la sua voce». «No, cara piccola», replicò il signor Brownlow guardando tristemente indietro. «Non s'è mossa, e non si muoverà finché non saremo andati via». Rose Maylie restò immobile ma l'anziano signore la prese a braccetto e con gentile fermezza la condusse via. Mentre essi s'allontanavano scomparendo la ragazza s'accasciò su uno dei gradini e sfogò l'angoscia che le stringeva il cuore in amare lacrime. Dopo un poco s'alzò e con passi incerti e traballanti risalì fin sulla strada. Il pedinatore rimase immobile al suo posto fino a qualche minuto dopo allorché, dopo essersi accertato di esser di nuovo solo, guardandosi intorno ripetutamente, scivolò pian piano fuori del suo nascondiglio e risalì furtivo, tenendosi nell'ombra del muro, così com'era disceso. Raggiunta la sommità, più d'una volta voltandosi indietro per accertarsi di non essere osservato, Noah Claypole si precipitò a rotta di collo verso la casa dell'ebreo. Capitolo XLVII. Conseguenze fatali Mancavano poco meno di due ore all'alba. In autunno, morendo l'anno, quel momento può a ragione dirsi il cuore della notte, quando le strade sono silenziose e deserte, quando perfino i suoni sembrano sopiti, e dissolutezza e bagordi son tornati a casa barcollando a sognare: in quell'ora silenziosa e immobile l'ebreo sedeva aspettando nella sua vecchia tana, con il volto così stravolto e pallido, e gli occhi così iniettati di sangue che non sembrava neanche più simile a un uomo, ma a qualche orribile fantasma, esalato dalla tomba e tormentato da uno spirito maligno. Sedeva curvo sopra il focolare freddo, avvolto in una coperta vecchia e lacera, con la faccia rivolta a un mozzicone di candela agli sgoccioli posta sul tavolo a fianco a lui. Aveva portato la mano destra alle labbra e mentre, assorto nei pensieri, si mordeva le unghie nere e lunghe, scoprì denti così aguzzi, benché pochi gliene fossero rimasti, da sembrare le zanne d'un cane o d'un ratto. Sdraiato su di un tappeto, sul pavimento, giaceva Noah Claypole profondamente addormentato. Verso di questo il vecchio volgeva ogni tanto gli occhi per poi riportarli subito sulla candela; ma lo stoppino lungo e bruciacchiato, appeso all'ingiù, e la cera che cadeva calda e solidificava in grumi sul tavolo mostravano chiaramente che i suoi pensieri erano altrove. Così era, in effetti. La mortificazione per il suo bel piano andato in fumo; l'odio per la ragazza che aveva osato confabulare con degli sconosciuti; la totale sfiducia nella sincerità di lei che non lo avrebbe tradito; l'amaro disappunto della svanita vendetta su Sikes; la paura di essere scoperto, rovinato, e condannato a morte; un aspro risentimento contro tutti indistintamente: questi erano i cupi pensieri che gli saettavano in mente susseguendosi rapidi l'uno all'altro in un turbine incessante, mentre i propositi più neri e malvagi gli brulicavano in cuore. Sedeva nell'immobilità più assoluta, senza curarsi minimamente del tempo, finché il suo orecchio teso non captò un rumore in strada. «Finalmente», borbottò l'ebreo passandosi la mano sulla bocca riarsa. «Finalmente». Mentre così diceva il campanello suonò piano. Si trascinò alla porta sulle scale e subito tornò accompagnato da un uomo imbacuccato fino al mento e con un fagotto sotto il braccio. Sedendosi e buttando il cappotto dietro di sé, Sikes palesò la sua massiccia fisionomia. «Ecco!», disse posando il fagotto sul tavolo. «Mettilo da parte e vedi di cavarci più che puoi. M'è costato un bel po' di fatica; pensavo che sarei arrivato qui tre ore prima». Fagin agguantò il fagotto e, dopo averlo chiuso nello stipo, sedette senza parlare. Frattanto, non distolse gli occhi dal ladro neanche un istante, e quando furono seduti uno di fronte all'altro, faccia a faccia, lo guardò fisso con le labbra che gli tremavano così violentemente e con il volto così stravolto dalle emozioni di cui era preda che il ladro tirò indietro la sedia involontariamente e lo guardò con espressione di autentico spavento. «Che c'è adesso?», gridò Sikes. «Che hai da guardarmi a quel modo?». L'ebreo levò in alto la mano agitando in aria l'indice tremante, ma era così sconvolto che in quel momento non fu in grado di parlare. «Dannazione!», disse Sikes portando la mano nella tasca interna della giacca con un'espressione di allarme: «È pazzo. Meglio stare in guardia, qui». «No, no», interloquì Fagin ritrovando la voce. «Non è... non si tratta di te, Bill. Non ce l'ho con te... tu non ne hai colpa». «Ah, non ne ho colpa, giusto?», disse Sikes guardandolo in cagnesco e sistemando ostentatamente la pistola in una tasca più facilmente raggiungibile. «È una fortuna... per uno di noi due. Chi non importa». «Quello che ho da dirti, Bill», disse l'ebreo avvicinando la sedia, «ti farà star peggio di me». «Sì?», replicò il ladro diffidente. «Sputa fuori! Sta' attento, però, o Nancy mi darà per spacciato». «Spacciato!», gridò Fagin. «Se è per questo, ho paura che non se ne sta con le mani in mano». Sikes guardò l'ebreo con un'espressione parecchio perplessa, ma, non trovando una soddisfacente spiegazione alle misteriose parole, l'afferrò per il bavero del cappotto con la mano enorme e lo scrollò violentemente. «Parla, forza!», disse, «altrimenti non potrai più farlo per mancanza di fiato. Apri quella boccaccia, e di' quello che devi dire in chiaro inglese. Sputa fuori, bastardo ringhioso, sputa fuori!». «Supponi che quel ragazzo addormentato lì...», cominciò Fagin. Sikes si voltò verso dove dormiva Noah come se non l'avesse ancora notato. «Ebbene!», disse tornando alla posizione di prima. «Supponi che quel ragazzo», continuò l'ebreo, «faccia la spia, ci tradisca tutti quanti... prima cercandosi le persone giuste per farlo e poi, incontrandole per strada per fornire i nostri connotati, descrivendo ogni nostro segno particolare per identificarci, con tutti i dettagli su come e dove poterci trovare più agevolmente. Supponi che faccia tutto questo e poi ancora riveli un piano nel quale siamo tutti implicati, più o meno... e di sua spontanea volontà, senza essere né in arresto, né intrappolato, né forzato, né atterrito dal parroco e portato a tanto da una dieta di pane e acqua... ma per suo capriccio, per suo proprio piacere, sgattaiolando fuori di casa, di notte, per incontrare quelli che hanno più interesse a rovinarci, spiattellando tutto a loro. Capisci?», gridò l'ebreo, con lampi di rabbia negli occhi. «Supponi tutto questo. Tu che faresti?» «Che farei?», replicò Sikes con una tremenda bestemmia. «Se rimanesse vivo fino al mio ritorno, gli sbriciolerei il cranio sotto il tacco ferrato del mio scarpone, a minuzzoli più numerosi dei capelli che ha in testa». «E se lo facessi io?», fece l'ebreo quasi urlando. «Io, che so tante cose, e potrei portare con me al patibolo tanti altri?» «Non lo so», replicò Sikes serrando i denti e sbiancando alla sola idea. «In cella ti concerei per le feste anche se mi mettessero ai ferri; e se fossimo processati assieme ti salterei addosso in aula e ti farei schizzar fuori le cervella davanti a tutti. Mi verrebbe una forza tale», ringhiò il ladro protendendo il braccio nerboruto, «da poterti ridurre il cranio peggio che se ci fosse passato sopra un carro». «Davvero?» «Altro che!», disse il ladro. «Non mettermi alla prova!». «E se fosse stato Charley, o Dodger, o Bet, o...». «Non m'importa chi», rispose Sikes nervosamente. «Chiunque fosse, avrebbe lo stesso trattamento». Fagin fissò di nuovo il ladro e, con un cenno di far silenzio, si curvò sul giaciglio sul pavimento e scrollò l'addormentato per svegliarlo. Sikes si spinse in avanti sulla sedia osservando la scena con le mani poggiate sulle ginocchia, come curioso di vedere dove andassero a finire tutte quelle domande e preliminari. «Bolter! Bolter! Povero ragazzo!», disse Fagin guardando Sikes dal basso con un'espressione di diabolica anticipazione e parlando lentamente, con marcata enfasi. «È stanco... stanco per averla sorvegliata tanto tempo... sorvegliato lei, Bill». «Che vuoi dire?», domandò Sikes indietreggiando. L'ebreo non rispose nulla ma di nuovo curvandosi sul dormiente lo tirò su a sedere. Sentendo il suo nome falso ripetuto più volte, Noah si stropicciò gli occhi e con un enorme sbadiglio si guardò intorno assonnato. «Ridimmelo un'altra volta... un'altra volta, così lo sente pure lui», fece l'ebreo, nel mentre indicando Sikes. «Ridirti cosa?», chiese l'assonnato Noah scuotendosi infastidito. «Di... Nancy», disse l'ebreo afferrando al polso Sikes come a prevenire che scappasse via prima di aver sentito abbastanza. «L'hai seguita?» «Sì». «A London Bridge?» «Sì». «Dove ha incontrato delle persone?» «Sì, preciso». «Un signore e una giovane dai quali era andata già prima, di sua spontanea volontà, che le hanno chiesto di consegnare tutti i suoi compagni, e Monks prima di tutti, e lei ha acconsentito? E le hanno chiesto di descriverlo... cosa che lei ha fatto... di dire in che locanda andiamo e ci incontriamo, cosa che lei ha fatto... e da dove si può meglio sorvegliarla, cosa che lei ha fatto... e a che ora ci andavamo, cosa che lei ha fatto. Ha fatto tutto questo. Ha spifferato tutto, parola per parola, senza aver subito una minaccia, senza esitare... l'ha fatto, non è vero?», gridò l'ebreo quasi folle di rabbia. «Beh!», replicò Noah grattandosi la testa. «È andata proprio così!». «Cos'hanno detto di domenica scorsa?», domandò l'ebreo. «Di domenica scorsa?», fece eco Noah pensando. «Ma ve l'ho già detto». «Ridimmelo. Ridimmelo ancora!», gridò Fagin stringendo con più forza Sikes con una mano e brandendo l'altra in aria, schiumando rabbia. «Le hanno chiesto», riprese Noah mentre, man mano che si destava, sembrava formarsi un'idea più precisa di chi fosse Sikes, «le hanno chiesto perché non fosse venuta la domenica precedente, come aveva promesso. Ha risposto che non aveva potuto». «Perché?... Perché?», interruppe l'ebreo trionfante. «Diglielo». «Perché era stata trattenuta a forza a casa da Bill, l'uomo di cui aveva già parlato loro», replicò Noah. «E che altro ha detto di lui?», gridò l'ebreo. «Che altro, dell'uomo di cui aveva già parlato loro? Diglielo, diglielo». «Insomma, che non le era facile uscire di casa se lui non sapeva dove andava», rispose Noah, «sicché la prima volta che era andata dalla giovane lei... Ah, ah, ah! mi veniva da ridere quando ha detto quello che aveva combinato... gli aveva propinato un poco di laudano». «Fiamme dell'inferno!», gridò Sikes divincolandosi dalla stretta dell'ebreo. «Lasciami andare!». Scagliando il vecchio lontano si precipitò fuori della stanza e con furia selvaggia salì le scale. «Bill, Bill!», gridò l'ebreo inseguendolo immediatamente. «Una parola. Una parola soltanto». Quella parola non sarebbe stata udita se il ladro fosse riuscito ad aprire la porta che egli invano, imprecando, scuoteva con violenza allorché l'ebreo arrivò in cima alle scale senza più fiato. «Fammi uscire», fece Sikes. «Non parlarmi, è pericoloso. Fammi uscire, dico». «Una parola soltanto, Bill», soggiunse l'ebreo portando la mano al chiavistello. «Non sarai...». «Cosa?», replicò l'altro. «Non sarai troppo... troppo violento, Bill?», piagnucolò l'ebreo. Stava ormai albeggiando, e c'era abbastanza luce perché i due si vedessero in faccia. Scambiarono una rapida occhiata. Non v'era dubbio su che fuoco ardesse negli occhi di entrambi. «Voglio dire», riprese Fagin mostrando di saper bene che a quel punto era inutile fingere, «non troppo violento per la nostra sicurezza. Sta' attento, Bill, non essere irruente». Sikes non rispose nulla ma spalancando la porta, aperta nel frattempo dall'ebreo, si precipitò nelle strade silenziose. Senza pensare un attimo, senza un attimo di pausa, senza voltarsi neanche una volta a destra o a sinistra, senza sollevare gli occhi al cielo o abbassarli a terra, ma tenendo lo sguardo fisso innanzi a sé con furiosa determinazione, i denti così serrati che la mascella sembrava volesse uscire dalla pelle, Sikes s'affrettò senza un mormorio, senza mai allentare un muscolo finché non giunse alla porta di casa. Girata la chiave aprì piano, salì le scale a passi felpati e entrando nella sua stanza richiuse la porta a doppia mandata. Poi, barricatala con un pesante tavolo, scostò la tendina del letto. Vi dormiva, semivestita, la ragazza, ma lui doveva averla già svegliata giacché ella, con espressione allarmata, si stava tirando su in fretta. «Alzati!», disse. «Sei tu, Bill!», esclamò la ragazza sembrando contenta del suo ritorno. «Già», fu la risposta. «Alzati». C'era una candela che ardeva ma l'uomo la strappò dal candeliere e la gettò sulla grata del camino. Vedendo fuori la pallida luce del primo mattino la ragazza s'alzò per tirare le tendine. «Lascia stare», disse Sikes frapponendo la sua mano. «C'è luce abbastanza per quello che devo fare». «Bill», disse la ragazza a voce bassa, allarmata, «perché mi guardi a quel modo?». Il ladro sedette fissandola per qualche istante; poi, con le narici dilatate e il respiro affannoso, afferrandola per la gola e la testa, la trascinò nel mezzo della stanza e, data un'occhiata alla porta, le chiuse la bocca con la grossa mano. «Bill, Bill!», annaspò la ragazza dibattendosi con la forza che le veniva dall'avvertire il pericolo mortale. «Io... non griderò... non griderò... ascoltami... parlami... dimmi che ho fatto!». «Lo sai, demonio d'una donna!», replicò il ladro con un sibilo. «Sei stata pedinata stanotte; ogni parola che hai detta è stata udita». «Allora risparmiami la vita, per amor del Cielo, come io ho risparmiato la tua», riprese la ragazza stringendolo. «Bill, Bill caro, non puoi aver cuore d'uccidermi. Oh! Pensa a cosa ho rinunciato, soltanto questa notte, per amor tuo. Pensaci un attimo, e non commettere questo crimine. Io non ti lascio, non potrai allontanarmi. Bill, Bill, per amore di Dio, per amor tuo e mio, non versare il mio sangue! Non t'ho tradito, sull'anima mia colpevole, non t'ho tradito!». L'uomo cercò di liberare le braccia ma invano, perché la ragazza lo stringeva forte nelle sue. «Bill», gridò la ragazza provando a poggiargli la testa sul petto, «stanotte quel signore e quella cara giovane m'hanno detto di un rifugio in un paese straniero dove avrei potuto finire i miei giorni in pace e tranquillità. Lasciami andare ancora da loro, a supplicarli in ginocchio di avere la stessa bontà e pietà per te e andiamocene tutti e due da questo luogo orribile per cambiare vita, altrove, lontano. Ricordiamoci della vita passata solo nelle preghiere, e non vediamoci più. Non è mai troppo tardi per pentirsi. Così m'hanno detto... e ora lo sento... ma ci vuole del tempo... un po' di tempo!». Il ladro liberò un braccio e impugnò la pistola. Furente com'era, gli balenò in mente la certezza d'essere immediatamente scoperto se avesse sparato, ma usò l'arma per colpire due volte, con tutta la forza di cui era capace, sul viso di lei, proteso verso il suo. Ella barcollò e cadde, quasi accecata dal sangue che le usciva a fiotti da una profonda ferita sulla fronte, ma sollevandosi con grande difficoltà sulle ginocchia prese un fazzoletto bianco che teneva in seno... quello di Rose Maylie... e tendendolo nelle mani giunte, tanto in alto, verso il cielo, quanto lo consentivano le sue esigue forze, con l'ultimo respiro supplicò pietà dal Creatore. Che scena terribile. L'assassino barcollò indietreggiando fino al muro e, coprendosi gli occhi con la mano, afferrò un pesante bastone e la colpì. Capitolo XLVIII. La fuga di Sikes Di tutte le azioni criminali che, col favore delle tenebre, erano state commesse entro gli ampi confini di Londra da quando era scesa la notte, quella era la peggiore. Di tutti gli orrori che si levavano come miasmi alla fredda aria mattutina, quello era il più pestilenziale e crudele. Il sole - il sole splendente che riporta all'uomo non soltanto la luce ma nuova vita, e speranza, e freschezza - si levò sulla città formicolante in chiara e radiosa gloria. Attraverso i costosi vetri multicolori o finestre coi rattoppi di cartone, attraverso cupole di cattedrali o fenditure marcite, spandeva egualmente la sua luce. Illuminò la stanza dove giaceva la donna uccisa; anche quella. Lui cercò di impedirlo, ma la luce ostinatamente filtrava. Se la scena era stata spettrale nella penombra del mattino, quanto più lo era allora, nel chiarore pieno! Non si era mosso; aveva paura a muoversi. C'era stato un lamento, un movimento della mano, e con terrore misto a odio egli l'aveva colpita ripetutamente. Una volta ci buttò sopra un tappeto, ma era peggio immaginarseli, gli occhi, e immaginare che erano fissi su di lui; peggio del vederli sbarrati e rivolti in alto, come osservando il riflesso della pozza di sangue che, alla luce, vibrava e danzava sul soffitto. Aveva tolto rabbiosamente il tappeto. E lì era il corpo - solo carne e sangue, nient'altro - ma quale carne! E quanto sangue! Accese un fiammifero, attizzò un fuoco e ci gettò dentro la mazza. Ad una estremità c'erano dei capelli, che bruciarono arricciandosi e disfacendosi in una fine cenere che, catturata da un vortice d'aria, fuggì su per la cappa del camino. Anche questo lo spaventò, massiccio e robusto com'era, ma tenne l'arma sul fuoco finché non si spezzò e poi la buttò sui carboni perché finisse di bruciare e si disfacesse in cenere. Si lavò, e pulì gli abiti. C'erano macchie che non volevano andar via, ma egli tagliò via i pezzi di stoffa sporchi e li gettò nel fuoco. Quante macchie erano sparse per la casa! perfino le zampe del cane erano insanguinate. Per tutto questo tempo non aveva mai voltato le spalle al cadavere, no, neanche un momento. Completati questi preparativi, procedette all'indietro verso la porta trascinando con sé il cane per paura che si sporcasse di nuovo le zampe e portasse quelle ulteriori prove del crimine fino in strada. Passò sul marciapiede opposto e guardò su verso la finestra per accertarsi che non si vedesse nulla. La tenda che lei voleva aprire per far entrare quella luce che mai più avrebbe visto era ancora tirata. Lei giaceva quasi sotto di essa, lo sapeva. Santo cielo, il sole cadeva proprio in quel punto. Distolse subito lo sguardo. Era un sollievo essere fuori da quella stanza. Fischiò al cane e andò via in fretta. Passò per Islington, salì a lunghe falcate su per Highgate, dove c'è il monumento in pietra a Whittington, svoltò giù per Highgate Hill, incerto sul da farsi e sul dove andare, prese di nuovo a destra dopo un breve tratto in discesa e, imboccando un sentiero per i campi, costeggiò Caen Wood e sbucò quindi a Hampstead Heath. Passando l'avvallamento vicino alla Vale of Heath salì lungo il pendio opposto e attraversando la strada che congiunge i villaggi di Hampstead e Highgate percorse il tratto restante della collina in direzione dei campi del North End; in uno di questi, al riparo di una siepe, s'addormentò. Si rimise presto in piedi per proseguire - non oltre nella campagna ma indietro, verso Londra - lungo la strada maestra; poi tornò di nuovo indietro; poi attraversò da un'altra parte il medesimo terreno pel quale era già passato; poi errò in su e in giù per i campi, stendendosi sul margine dei fossi per riposarsi, subito rialzandosi per andare da qualche altra parte a ripetere le stesse cose, vagando ancora. Dove poteva andare, che fosse vicino e non troppo frequentato, per cercare della carne e da bere? Hendon. Quello era un buon posto, non troppo lontano e su una strada non battuta. Lì diresse i suoi passi, a volte correndo, a volte, con curiosa perversione, vagando a passo di lumaca, oppure fermandosi del tutto e battendo le siepi col bastone, senza scopo. Quando vi giunse, però, sembrava che tutte le persone che incontrava, gli stessi bambini sulle porte, lo guardassero con sospetto. Tornò di nuovo indietro, senza il coraggio di comprarsi un boccone o qualcosa da bere, sebbene non avesse preso cibo da parecchio tempo, e ancora una volta vagò sulla collina, incerto su dove andare. Vagò per miglia e miglia per i campi, sempre tornando al punto di partenza. Era passata la mattinata e mezzodì; il giorno declinava, e ancora egli vagava avanti e indietro, su e giù, finendo sempre per girare attorno al punto d'inizio. Infine partì deciso, in direzione di Hatfield. Erano le nove di sera quando l'uomo, esausto, col cane zoppicante, non uso a quell'esercizio, girò giù per la collina accanto alla chiesa di quel tranquillo villaggio, e trascinandosi lungo una stradina s'infilò in una piccola locanda, guidato dalle sue fievoli luci. V'era un fuoco acceso nel locale del bar e alcuni contadini stavano bevendo. Fecero posto all'estraneo ma egli sedette nell'angolo più lontano mangiando e bevendo da solo, o piuttosto in compagnia del cane al quale, di tanto in tanto, gettava un pezzo di cibo. Gli uomini lì riuniti discutevano dei terreni adiacenti e dei loro fattori; poi, esaurito quell'argomento, dell'età di un vecchio che era stato sepolto la domenica precedente - i giovani considerandolo vecchissimo e i vecchi piuttosto giovane - non più vecchio, come disse un canuto vegliardo, di quanto fosse lui, che aveva ancora davanti una decina o una quindicina di anni almeno, se avesse avuto cura di sé. Non c'era niente in tutto questo che attirasse particolare attenzione, o suscitasse allarme. Saldato il conto, il ladro restò in silenzio, senza esser notato, nel suo angolo, e stava quasi per essere sorpreso dal sonno quando lo riscosse il fragoroso ingresso di un nuovo venuto. Era un tipo curioso, mezzo venditore ambulante mezzo ciarlatano, che correva il paese a piedi vendendo pietre pomici, dolci, rasoi, saponette, grasso per il cuoio, medicinali per cani e cavalli, profumi scadenti, cosmetici e simili mercanzie, contenute in una valigetta legata dietro le spalle. Il suo ingresso dette l'abbrivio a svariate e gioviali battute con i contadini che non diminuirono di rapidità se non quando ebbe cenato ed ebbe aperto il suo scrigno di tesori, allorché s'industriò con grande ingegno di unire gli affari al divertimento. «E che sarebbe questa roba? Si mangia, Harry?», chiese ghignando un contadino indicando certe tavolette in un angolo. «Questa», disse quel tale prendendone una, «questa è una mistura infallibile e inestimabile per togliere ogni genere di macchie, ruggine, grasso, muffe, unto, bisunto, patacche e schizzi, dalla seta, dal raso, dal lino, dal cotone, dal panno, dal crespo, dalla tela, dai tappeti, dal merino, dalla mussolina, dal misto seta o dalla lana. Macchie di vino, di frutta, di birra, di acqua, di tinta, di pece; qualsiasi macchia se ne vien via in un sol colpo con questa mistura infallibile e inestimabile. Se una signora macchia il suo onore, non ha che da ingoiare una di queste tavolette e guarisce immediatamente... giacché si tratta di veleno. Se qualche gentiluomo vuol riscattare il suo, non ha che da ingoiarne un pezzettino e risolve subito la questione... perché è efficace quanto un colpo di pistola ma di sapore molto più sgradevole, per cui tanto maggior merito ad ingoiarne un po'. Un penny la tavoletta. Con tutte queste proprietà, soltanto un penny la tavoletta!». Due avventori ne comprarono immediatamente, mentre altri erano chiaramente interessati. Notandolo, il venditore fu ancor più loquace. «La produzione non riesce a star dietro alle vendite», disse. «Quattordici fabbriche che girano ad acqua, sei macchine a vapore e una a batteria galvanica sono costantemente in opera a sfornarne quanto più è possibile senza che riescano a star dietro alla domanda, anche se gli operai si ammazzano di fatica, e alle vedove si dà subito la pensione, con venti sterline all'anno a figlio e una regalia di cinquanta per due gemelli. Un penny la tavoletta. Due mezzi penny fa lo stesso, e quattro soldi sono ugualmente bene accetti. Un penny la tavoletta! Macchie di vino, di frutta, di birra, d'acqua, di vernice, di pece, di fango, di sangue! Ecco una macchia sul cappello di questo signore della compagnia che ripulirò immantinente, prima che possa ordinare per me una birra chiara». «Eh!», gridò Sikes sussultando. «Ridatemelo». «Lo ripulisco immantinente, signore», replicò l'uomo strizzando l'occhio alla compagnia, «prima che attraversiate la stanza per riprendervelo. Signori, osservate la macchia scura sul cappello di questo gentiluomo, non più grande d'uno scellino ma più spessa d'una mezza corona: macchia di vino, di frutta, di birra, d'acqua, di vernice, di pece, di fango, oppure di sangue...». Non andò oltre, poiché Sikes, con una terribile imprecazione rovesciò il tavolo e strappandogli di mano il cappello si precipitò fuori. Con lo stesso turbine di sentimenti e la stessa irresoluzione che, a dispetto della sua natura, s'era impossessata di lui per tutto il giorno, non vedendosi seguito e reputando che, con ogni probabilità, l'avevano creduto un balordo ubriacone, si diresse di nuovo verso la città, e tenendosi fuori dal fascio di luce delle lanterne di una carrozza di posta, ferma in strada, stava passando oltre quando si rese conto che proveniva da Londra e sostava davanti al piccolo ufficio postale prima di ripartire. Intuendo ciò che sarebbe potuto accadere, attraversò la strada e rimase in ascolto. Il fattorino stava sulla porta, aspettando il sacco della posta. In quel mentre sopraggiunse un uomo in abiti di guardiacaccia, al quale il fattorino consegnò un cestino già pronto, posato a terra. «È per la tua gente», disse. «Allora, diamoci una mossa, là dentro, su! Accidenti al sacco; non era pronto neanche l'altra sera. Non va bene, sapete!». «Che si dice in città, Ben?», chiese il guardiacaccia, avvicinandosi alla finestra per meglio ammirare i cavalli. «Niente, che io sappia», replicò l'altro infilandosi i guanti. «Il grano è andato un po' su. Ho sentito pure d'un assassinio giù sulla strada di Spitalfields, ma non ne so molto». «Oh, è verissimo», disse un signore che si sporgeva dal finestrino della carrozza. «Ed è stato un assassinio terribile». «Davvero, signore?», interloquì il fattorino toccandosi il cappello. «Era uomo o donna, signore?» «Una donna», replicò quello. «Si ritiene...». «Allora, Ben», gridò il postiglione impaziente. «Accidenti a quel sacco», disse il fattorino. «Vi state facendo un sonno, là dentro?» «Arriva!», gridò l'impiegato postale precipitandosi fuori. «Arriva», borbottò il fattorino. «Pure la giovane ereditiera che dovrebbe innamorarsi di me arriva, però non so quando. Date qua. Tutto apostoooo!». La cornetta suonò qualche gaia nota, e la carrozza partì. Sikes rimase fermo in strada; sembrava che quanto era stato detto non avesse avuto alcun effetto su di lui e che fosse agitato da sentimenti non più forti dell'incertezza sul dove andare. Infine tornò di nuovo indietro e prese la strada che porta da Hatfields a St. Albans. Ostinatamente andò avanti, ma lasciandosi dietro la cittadina e affondando nella solitudine e nella tenebra della strada, si sentì pervaso da una paura, da un terrore, che lo scosse fino al midollo. Ogni cosa innanzi a lui, fosse ombra o solida sostanza, ferma o in movimento, prendeva sembianze spaventose. Queste paure tuttavia non erano nulla in confronto all'ossessione di avvertire alle calcagna la spettrale figura di quel mattino. Poteva rintracciarne i contorni nell'oscurità, aggiungere ogni minimo dettaglio della figura, e osservare che sembrava seguirlo rigida e solenne. Poteva sentirne le vesti frusciare tra le foglie, e ogni alito di vento era pregno del suo estremo, sommesso lamento. Lo stesso se si fermava. Se correva... lo inseguiva... ma non di corsa - questo sarebbe stato un sollievo ma come un cadavere dotato del semplice meccanismo della vita, portato da un vento malinconico e lento, che mai accelerava o rallentava. Benché mortalmente atterrito, a volte, con disperata determinazione, si girava, risoluto ad avere la meglio di quel fantasma ma gli si drizzavano i capelli in testa e gli si gelava il sangue nelle vene, poiché la cosa s'era girata assieme a lui e gli era alle spalle. La mattina gli era stata sempre innanzi, ma ora gli era dietro, sempre. Si distese con le spalle contro una scarpata, ma la sentì sopra di lui, visibile contro il freddo cielo notturno. Si gettò supino, sulla strada, e gli stava vicino alla testa, silenziosa, eretta e immobile... una lapide vivente con l'epitaffio scritto col sangue. Nessuno parli di assassini che sfuggono alla giustizia, e dia ad intendere che la Provvidenza non vede. In quell'angosciosa paura, il delitto si ripetè venti dozzine di volte. Nel campo che attraversava c'era un capanno, un riparo buono per la notte. Tre alti pioppi, davanti alla porta, rendevano il buio all'interno ancor più fitto e producevano un agghiacciante lamento quando il vento li attraversava. Non poteva proseguire, finché non fosse sorto il giorno, e qui si allungò, contro il muro... per soffrire una nuova tortura. Poiché ora gli si presentava innanzi una nuova visione, altrettanto ostinata e più terribile di quella da cui era fuggito. Quegli occhi sbarrati, così velati e vitrei che quasi preferiva il vederli all'immaginarli, gli apparivano nel buio, con una sorta di luce smorta. Erano solo due occhi, ma gli sembrava di vederli ovunque. Se cancellava quella vista, allora vedeva la stanza con tutti gli oggetti che ben conosceva - alcuni di essi, in effetti, dimenticati dalla sua memoria cosciente - ciascuno al suo posto solito. Anche il cadavere era al suo posto e quegli occhi erano lì, come li aveva veduti quand'era fuggito. S'alzò precipitandosi fuori per i campi. La sagoma gh era sempre dietro. Rientrò nel capanno e di nuovo s'accasciò a terra. Ma gh occhi erano lì, prima che si fosse steso del tutto. Lì rimase, tra terrori che solo lui sa, tremando da capo a piedi, sudando freddo da ogni poro, quando improvvisamente il vento della notte si sollevò portando il suono di grida lontane, l'urlo di voci commiste di sorpresa e allarme. In quel luogo desolato, qualsiasi suono umano gli era un sollievo, benché carico di motivi d'allarme. Il pericolo che correva gli fece tornare le forze e le energie. Scattando in piedi si precipitò all'aria aperta. Il vasto cielo sembrava in fiamme. Levandosi in aria e seminando scintille, avvolgendosi l'una sull'altra, ondate di fiamme accendevano l'atmosfera per miglia intorno e spingevano nubi di fumo verso dove si trovava. Il frastuono si faceva più intenso, giacché nuove voci s'univano alle altre in quel clamore, e potè sentire il grido di "Al fuoco!" misto all'allarme di campane, allo schianto di corpi pesanti, al crepitare delle fiamme quando avvolgevano qualche nuovo ostacolo e spiccavano in alto come rinvigorite dal nuovo alimento. Mentre guardava, il frastuono cresceva. Si vedevano persone... uomini e donne... bagliori, trambusto. Per lui, era come nuova vita. Si precipitò innanzi, a capo fitto, gettandosi attraverso cespugli e pruni, saltando forsennatamente cancelli e staccionate, come il cane che gli correva innanzi abbaiando a piena gola. Giunse sul posto. C'erano figure semivestite che andavano avanti e indietro, alcune tentando di far uscire i cavalli imbizzarriti dalle stalle, altre spingendo il bestiame fuori dai recinti e dalle rimesse, ed altre uscendo cariche dalla enorme pira, tra una pioggia di scintille e il precipitare rovinoso delle travi carbonizzate. I vuoti, dove un'ora prima erano porte e finestre, rivelavano l'incendio rombante; le mura vacillavano e si schiantavano in frantumi nella voragine di fuoco; il piombo e il ferro liquefatti colavano, incandescenti, a terra. Donne e bambini strillavano, e gli uomini si incoraggiavano reciprocamente con grida e urla. Il fracasso delle pompe, lo scroscio e il sibilo dell'acqua nel cadere sul legno ardente aumentavano quel tremendo fragore. Gridò anche lui, fino a divenir rauco e, fuggendo dalla memoria e da se stesso, si tuffò nella mischia. Quella notte corse da un luogo all'altro, ora lavorando alle pompe, ora fendendo il fumo e le fiamme, sempre spingendosi proprio laddove più intenso era il fragore e più fitta la ressa. Su e giù per le scale, sui tetti degli edifici, sugli impiantiti che vacillavano e cedevano sotto il suo peso, esposto ai mattoni e alle pietre che precipitavano, dovunque in quel grande incendio c'era lui; ma egli viveva come per incanto, non aveva né graffi né ferite, né stanchezza né pensiero, finché non spuntò il nuovo giorno e non rimase altro che fumo e macerie annerite. Tuttavia, passata quella folle eccitazione, la terribile consapevolezza del crimine tornò con forza decuplicata. Volgeva intorno uno sguardo sospettoso, poiché gli uomini conversavano a gruppetti ed egli temeva di essere l'oggetto della loro conversazione. Il cane obbedì all'eloquente cenno del dito, e insieme sgusciarono via furtivi. Passò accanto a una pompa vicino alla quale sedevano degli uomini che l'invitarono a favorire qualcosa da mangiare e da bere. Mangiò del pane e della carne, ma mentre beveva un sorso di birra sentì i pompieri venuti da Londra parlare ad alta voce dell'assassinio. «È andato a Birmingham, dicono», fece uno, «ma l'acciufferanno comunque, perché le guardie stanno setacciando dappertutto e per domani sera si darà l'allarme per tutto il circondario». S'affrettò ad andarsene e camminò fin quasi a cadere esausto a terra; poi si stese in un sentiero e fece un sonno lungo, seppure tormentato e interrotto. Continuò a vagare, irresoluto e incerto, oppresso dalla paura di un'altra notte solitaria. D'un tratto prese la risoluzione disperata di tornare a Londra. «Almeno lì c'è qualcuno con cui parlare», pensò. «E anche un buon nascondiglio. Non penseranno mai ad acchiapparmi lì, dopo avermi fiutato in campagna. Posso starmene al coperto per una settimana, più o meno, e poi, con l'aiuto di Fagin, squagliarmela in Francia! Dannazione, correrò il rischio». Senza esitare agì secondo questo impulso e, cercando di scegliersi le strade meno frequentate, iniziò il viaggio di ritorno, determinato a nascondersi non appena arrivato alla periferia della metropoli per poi, entrandovi al crepuscolo con un giro largo, procedere dritto verso la parte che s'era prefissa come destinazione. Però il cane... se avevano mandato in giro una sua descrizione, non avrebbero trascurato il fatto che il cane era scomparso e che probabilmente l'aveva seguito. Passando per le strade, questo avrebbe potuto portare alla sua cattura. Decise perciò di affogarlo sicché, mentre camminava, cercava di scorgere qualche stagno; raccolse anche una grossa pietra e la legò al fazzoletto. Mentre il padrone compiva questi gesti l'animale lo scrutava in volto e, fosse l'istinto a fargli intuire qualcosa delle sue intenzioni, o fosse lo sguardo, più bieco del solito, trotterellò un poco più indietro che d'abitudine, acquattandosi quando lui rallentava per avvicinarglisi. Quando il padrone si fermò sul margine di uno stagno e si voltò per chiamarlo, si fermò a sua volta. «Qua, mi senti? Qua, ti dico!», gridò Sikes. L'animale s'avvicinò per mera forza di abitudine, ma appena Sikes si inginocchiò per legargli il fazzoletto al collo arretrò con un ringhio minaccioso. «Torna qua!», disse il ladro pestando il piede in terra. Il cane scosse la coda ma non si mosse. Sikes fece un nodo scorsoio e lo chiamò di nuovo. Il cane avanzò, arretrò, si fermò un istante, si voltò, e scappò quanto più veloce poteva. L'uomo gli fischiò più d'una volta, poi sedette attendendo il suo ritorno. Ma il cane non tornò ed egli, infine, riprese il suo viaggio. Capitolo XLIX. Monks e il signor Brownlow infine s'incontrano. Il loro colloquio, e la notizia che l'interrompe Calava il crepuscolo quando il signor Brownlow scese da una carrozza da nolo davanti al portone di casa e bussò piano. Quando la porta fu aperta, un uomo robusto scese dalla carrozza e si posizionò a lato dei gradini mentre un altro, che era seduto a cassetta, sceso anche lui, si collocò dal lato opposto. A un cenno del signor Brownlow fecero scendere un terzo uomo e lo scortarono rapidamente in casa stretto tra di loro. Quest'uomo era Monks. Così scortandolo, salirono le scale senza dire parola, preceduti dal signor Brownlow che li guidò in una stanza sul retro. Alla porta di questa stanza Monks, che era salito con evidente riluttanza, si fermò. I due guardarono l'anziano signore come per ricevere istruzioni. «Sa bene qual è l'alternativa», disse il signor Brownlow. «Se esita, o muove appena un dito contravvenendo ai vostri ordini, trascinatelo in strada, chiamate la polizia, e fatelo arrestare a mio nome, con l'accusa di frode». «Come osate parlare di me in questo modo?», domandò Monks. «Come osate sfidarmi a farlo, giovanotto?», replicò il signor Brownlow affrontandolo con sguardo fermo. «Siete tanto pazzo da voler uscire da questa stanza? Lasciatelo. Ecco, signore. Siete libero di andare, come noi di seguirvi. Ma vi avverto, su ciò che ho di più sacro, che nello stesso momento in cui metterete piede in strada, vi farò arrestare con l'accusa di frode e di furto. Sono deciso, irremovibile. Se volete esserlo pure voi, allora che il vostro sangue ricada sul vostro capo!». «In virtù di quale autorità mi si rapisce per strada e mi si fa condurre qui da questi due scagnozzi?», chiese Monks guardando dall'uno all'altro i due che gli stavano al fianco. «In virtù della mia», replicò il signor Brownlow. «Queste persone agiscono per mio incarico. Se protestate perché vi si toglie la vostra libertà - ma avevate modo e occasione per riprendervela venendo qui, anche se avete ritenuto più prudente restarvene buono - vi ripeto, potete anche appellarvi alla legge. Mi ci appellerò anch'io; ma quando vi sarete spinto troppo innanzi per poterci ripensare e vi sarete consegnato in altre mani, non cercate compassione da me, e non dite che sono stato io a gettarvi nel gorgo in cui vi siete cacciato da solo». Monks era visibilmente turbato e allarmato. Esitò. «Decidetevi alla svelta», disse il signor Brownlow con fermezza e senza scomporsi minimamente. «Se preferite che io v'accusi in pubblico e vi lasci ad una punizione la cui gravità, sebbene possa prevederla rabbrividendo, non avrò alcun potere di rendere più lieve, ripeto, ancora una volta, che sapete la strada. Se invece volete appellarvi alla mia clemenza, e alla compassione di quelli a cui tanto male avete fatto, sedetevi su quella sedia, senza fiatare. Vi attendeva già da due giorni». Monks borbottò qualche parola incomprensibile, ma tentennava ancora. «Svelto», disse il signor Brownlow. «Una mia parola, e questa possibilità svanirà per sempre». L'uomo tentennava ancora. «Non sono disposto a trattative», disse il signor Brownlow, «e poiché difendo i più cari interessi di altre persone, non ne ho neanche il diritto». «Non c'è...», chiese Monks balbettando, «non c'è un'altra via d'uscita?» «Nessuna». Monks guardò dubbioso l'anziano signore, ma leggendogli sul viso soltanto determinazione e severità entrò nella stanza, e scrollando le spalle si sedette. «Chiudete la porta da fuori», disse il signor Brownlow ai suoi aiutanti, «ed entrate quando suono». Gli uomini obbedirono e i due restarono soli. «È un bel modo di trattare il figlio del vostro più vecchio amico», disse Monks togliendosi cappello e mantello. «È proprio perché sono il più vecchio amico di vostro padre, giovanotto», replicò il signor Brownlow, «è proprio perché le mie speranze e le aspirazioni della felice giovinezza erano intrecciate alle sue e a quella bella creatura del suo stesso sangue e della sua famiglia che s'è ricongiunta a Dio ancor giovane, lasciandomi quaggiù solo e desolato; è proprio perché s'è inginocchiato con me accanto al letto di morte della sua unica sorella quando era appena un bambino, il giorno in cui sarebbe dovuta diventare - ma il cielo volle altrimenti - la mia giovane moglie; è proprio perché da allora in poi il mio cuore infranto restò attaccato a lui fino alla sua morte, a dispetto di tutte le sue sventure e dei suoi errori; è proprio perché i vecchi ricordi e le antiche associazioni mi colmano l'animo, e perfino la vostra vista mi riporta in mente lui; è proprio per tutto questo che sono propenso a trattarvi con riguardo... sì, Edward Leeford, perfino adesso... e arrossisco di vergogna pensando a quanto indegnamente portate questo nome». «Che cosa c'entra adesso il nome?», chiese l'altro osservando in silenzioso stupore l'agitazione del suo interlocutore. «Che cosa mi importa del nome?» «Niente», replicò il signor Brownlow. «Non v'importa niente. Ma era quello di lei, e anche a distanza di tanto tempo, ora che sono vecchio, mi riporta alla memoria l'emozione e il palpito di allora al solo sentirlo ripetere, fosse pure da un estraneo. Sono contento che l'abbiate cambiato; molto contento». «Tutto questo va benissimo», disse Monks (per chiamarlo col falso nome), dopo un lungo silenzio nel corso del quale aveva continuato a muoversi infuriato avanti e indietro in atto di sfida mentre il signor Brownlow era rimasto seduto coprendosi il volto con una mano. «Ma cosa volete da me?» «Voi avete un fratello», disse il signor Brownlow scuotendosi, «un fratello, il cui nome, quando ve lo sussurrai all'orecchio raggiungendovi per strada, è bastato quasi da solo a indurvi a seguirmi fin qui, sorpreso e allarmato. «Io non ho fratelli», replicò Monks. «Sapete che sono figlio unico. Perché mi parlate di fratelli? Sapete meglio di me...». «Attento ora a quello che io so e che forse voi non sapete», disse il signor Brownlow. «V'interesserà sicuramente. So di quel disgraziato matrimonio al quale, per orgoglio di famiglia e per le più meschine e sordide ambizioni, fu costretto il vostro infelice padre quand'era appena un ragazzo, e del quale voi foste l'unica e snaturata progenie». «Queste parole insultanti non mi toccano», interloquì Monks con un ghigno di derisione. «Conoscete i fatti, e tanto basta per me». «So anche», continuò l'anziano signore, «la miseria, la lenta tortura, l'angoscia infinita di quella unione male assortita. So che di quella infelice coppia ciascuno trascinava stancamente e svogliatamente le proprie pesanti catene in un mondo che per loro sapeva di fiele. So come gli aperti litigi si succedessero alle fredde formalità; come l'indifferenza desse luogo all'antipatia, l'antipatia all'odio, l'odio al ribrezzo, finché essi non spezzarono quelle oppressive catene, e fuggendo lontano l'uno dall'altra ne portarono via ciascuno un'amara parte, i cui anelli niente, se non la morte, avrebbe potuto rompere, per nasconderle sotto le apparenze più gaie che potessero assumere nella loro nuova società. Vostra madre ci riuscì; dimenticò presto. Ma esse rosero come un cancro il cuore di vostro padre, per anni e anni». «Beh, si sono separati», disse Monks, «e allora?» «Qualche tempo dopo la separazione», riprese il signor Brownlow, «vostra madre, presa dalla vita di frivolezze del continente, aveva completamente dimenticato il marito, di dieci anni più giovane, mentre lui, crollate tutte le sue speranze e rimasto in patria, conobbe un'altra famiglia. Questo, almeno, lo saprete già». «No», disse Monks nascondendo gli occhi e battendo il piede a terra come chi voglia negare ogni cosa. «No». «I vostri modi, non meno delle vostre azioni, m'assicurano che non l'avete dimenticato né avete cessato di pensarvi con livore», replicò il signor Brownlow. «Mi riferisco a quindici anni fa, quando non avevate più di undici anni, e vostro padre ne aveva trentuno... giacché, ripeto, non era che un ragazzo quando suo padre gli impose di sposarsi. Devo tornare ad eventi che gettano un'ombra sulla memoria dei vostri genitori, o volete risparmiarmelo rivelandomi la verità?» «Non ho niente da rivelare», interloquì Monks. «Tocca a voi parlare, se volete». «Dunque, la famiglia che conobbe», disse in signor Brownlow, «era di un ufficiale di marina in pensione, la cui moglie era morta circa mezzo anno prima lasciandogli due figlie... sarebbero stati più figli ma, di tutti loro, solo due sopravvissero... una bella ragazza di diciannove anni e una bambina di appena tre anni». «E cosa importa a me?», chiese Monks. «Abitavano», continuò il signor Brownlow senza apparentemente far caso all'interruzione, «in una regione del paese dove vostro padre s'era fermato nei suoi vagabondaggi e dove aveva fissato la sua dimora. Conoscenza, frequentazione, amicizia seguirono rapidamente l'una all'altra, poiché vostro padre aveva non comuni qualità. Aveva lo spirito e il carattere della sorella. Man mano che la loro conoscenza si approfondiva, l'ufficiale gli si affezionava sempre più, e magari le cose non fossero andate oltre! Anche sua figlia infatti gli si affezionò». L'anziano signore fece una pausa, e Monks si mordette il labbro con gli occhi rivolti a terra. Notandolo, l'altro riprese immediatamente: «Alla fine dell'anno era fidanzato, solennemente fidanzato alla figlia; era stato l'oggetto della sua prima, sincera, ardente e unica passione di ragazza ignara del mondo e di accortezze». «È una storia parecchio lunga, la vostra», osservò Monks agitandosi nervosamente nella sua poltrona. «È una storia vera di dolore, di prove e patimenti, giovanotto», replicò il signor Brownlow, «come ve ne sono di solito in simili storie; se fosse stata d'imperturbata gioia e felicità, sarebbe durata pochissimo. Alla fine, uno di quella ricca famiglia alla quale vostro padre era stato sacrificato allo scopo di rafforzare i legami d'interesse e la posizione sociale - come altre volte è accaduto... non è affatto un caso insolito - mori, e per riparare in parte all'infelicità da lui causata, gli lasciò in eredità la panacea per ogni dolore... parecchi soldi. Vostro padre avrebbe dovuto recarsi immediatamente a Roma, dove quell'uomo s'era precipitosamente recato per recuperare la salute, e dove morì, lasciando i suoi affari in grande confusione. Ma, lì giunto, vostro padre fu colto da una malattia mortale, e non appena la notizia arrivò a Parigi, vostra madre lo raggiunse, portando voi con lei; egli mori il giorno dopo il vostro arrivo senza lasciare testamento... nessun testamento... sicché l'intera proprietà andò a lei e a voi». A questo punto del racconto Monks trattenne il respiro. Gli si leggeva in viso l'estrema attenzione con cui ascoltava, benché gli occhi fossero distolti da chi parlava. Una pausa del racconto gli dette come un sollievo inatteso: cambiò posizione e s'asciugò il volto e le mani accaldate. «Prima di partire per Roma, lui dovette passare per Londra», disse lentamente il signor Brownlow fissando gli occhi in faccia all'altro, «e venne da me». «Non ne ho mai saputo nulla», interruppe Monks con un tono che voleva sembrare d'incredulità ma che appariva piuttosto di spiacevole sorpresa. «Venne da me e tra le altre cose mi lasciò un ritratto... un ritratto dipinto di sua mano... la rozza effigie della povera ragazza dipinta da un dilettante... che non voleva né lasciare indietro né poteva portare con sé in quell'improvviso viaggio. Si consumò fin quasi a diventare un'ombra per l'angoscia e il rimorso; parlava in modo sconnesso e quasi folle della rovina e del disonore che aveva causato; mi confidò la sua intenzione di convertire tutte le sue proprietà in denaro, a costo di qualsiasi perdita, e, dopo averne lasciata una parte a sua moglie e a voi, fuggire dal paese (non sarebbe fuggito solo, pensai), per non tornarci mai più. Perfino a me, il suo primo e più vecchio amico, a cui era legato da un affetto radicato sulla terra che ricopriva una persona carissima ad entrambi... persino a me egli non rivelò altro, promettendo che m'avrebbe scritto per raccontarmi tutto, dopodiché mi avrebbe incontrato un'altra volta soltanto, in vita. Ahimè! Quella fu l'ultima volta. Non ricevetti nessuna lettera, e non lo vidi mai più». «Quando tutto fu finito», riprese il signor Brownlow dopo una breve pausa, «mi recai sulla scena del suo... userò il termine che il mondo userebbe senza remore, poiché la riprovazione o il favore di questo ormai non fanno differenza per lui... del suo colpevole amore. Mi recai lì con la determinazione che, se avessi trovato ciò che temevo, quell'infelice figlia avrebbe trovato un cuore e una dimora, asilo e compassione da parte mia. Ma la famiglia era fuggita da quel luogo una settimana prima. Avevano regolato i loro piccoli debiti più urgenti, ed erano partiti nottetempo. Perché, o per dove, nessuno può dirlo». Monks respirò con più agio, e si guardò intorno con un sorriso di trionfo. «Quando vostro fratello», disse il signor Brownlow accostandosi alla sedia dell'altro, «quando vostro fratello, un bambino fragile, cencioso e vagabondo fu posto sulla mia strada da una mano più forte di quella del caso, e fu da me salvato da una vita di crimini e infamia...». «Cosa?», gridò Monks. «Eravate avvertito che vi avrei presto sorpreso», disse il signor Brownlow. «Quando fu salvato da me, dico - vedo che il vostro furbo compare v'ha taciuto il mio nome, sebbene, per quanto ne sapesse, vi sarebbe giunto completamente sconosciuto - quando lo tolsi dalla strada e lo portai a casa mia, dove restò riprendendosi da una brutta febbre, fui colpito allora dalla straordinaria rassomiglianza col quadro di cui vi dicevo. Perfino quando lo vidi per la prima volta, sporco ed esausto, qualcosa nell'espressione del suo viso mi colpì come l'immagine fugace di un vecchio amico in un sogno vivido. Inutile dirvi che il bambino fu rapito, prima che potesse raccontarmi la sua storia...». «Perché inutile?» «Perché sapete benissimo ogni particolare». «Io!». «Negarlo è inutile», replicò il signor Brownlow. «E vi mostrerò che io so ancora di più». «Voi.... voi... non potete provare nulla contro di me», balbettò Monks. «Vi sfido a farlo!». «Vedremo», replicò l'anziano signore con un'occhiata inquisitrice. «Persi il ragazzo, e per quanti sforzi facessi non riuscii a ritrovarlo. Essendo morta vostra madre, sapevo che soltanto voi avreste potuto sciogliere il mistero, e poiché l'ultima volta che ebbi notizie di voi vi trovavate nelle vostre proprietà in India - dove, come ben sapete, siete scappato alla morte di vostra madre per sfuggire alle conseguenze d'una cattiva condotta in patria - mi ci recai. Avevate già lasciato quel paese mesi prima, e si pensava che foste tornato a Londra, ma nessuno sapeva dire dove precisamente. Tornai anch'io. I vostri agenti non avevano idea della vostra residenza. Andavate e tornavate irregolarmente, come avevate sempre fatto - mi dissero - a volte per giorni, a volte per mesi, apparentemente frequentando gli stessi luoghi malfamati e la stessa indegna combriccola con cui vi eravate associato quando eravate un ragazzo intrattabile e ribelle. Non detti loro tregua con le mie domande. Perlustrai le strade notte e giorno, ma fino a due ore fa tutti i miei sforzi sono risultati vani, e non vi ho visto mai neanche per un istante». «E ora mi vedete», disse Monks alzandosi sfrontatamente. «E allora? Frode e furto sono parole grosse... giustificate, credete voi, da una presunta rassomiglianza tra un piccolo demonio e il ritratto impiastricciato da un morto. Fratello! Non sapete neanche se da quel miserabile matrimonio sia nato un figlio, non sapete neanche questo». «Non lo sapevo fino a poco fa», replicò il signor Brownlow anch'egli alzandosi, «ma nelle ultime due settimane ho saputo tutto. Voi avete un fratello e lo sapete, e lo conoscete. Ma un testamento c'era, distrutto da vostra madre affinché, alla morte di lei, poteste ereditare tutto ed essere il solo depositario del segreto. Menzionava un bambino che sarebbe probabilmente nato da quella infelice unione; che nacque, in effetti, e voi lo incontraste, e per la prima volta si destarono i vostri sospetti sulla rassomiglianza con suo padre. Tornaste nel luogo in cui era nato. Lì esistevano prove... prove a lungo occultate... della sua nascita e della sua famiglia. Quelle prove furono da voi distrutte e ora, come voi stesso avete testualmente detto al vostro complice ebreo, "le sole prove dell'identità del ragazzo, giacciono sul fondo del fiume, e la vecchia megera che le ebbe dalla madre morente marcisce in una bara". Figlio indegno, codardo, bugiardo; voi che nottetempo avete tenuto conciliaboli con ladri e assassini in stanze tenebrose; voi, le cui macchinazioni e le cui trappole hanno condotto a morte prematura lei che valeva un milione di volte più di voi; voi, che fin dalla culla avete avvelenato il cuore di vostro padre, e che avete dato ampio nutrimento alle più maligne passioni, a vizi e nefandezze d'ogni genere, finché esse non sono eruttate in una orribile malattia che ha reso il volto indice del vostro animo; voi, Edward Leeford, osate ancora sfidarmi!». «No, no, no!», replicò quel codardo, schiacciato dal peso di tante accuse. «M'è nota ogni parola», gridò l'anziano signore, «ogni parola pronunciata da voi e da quell'abietto malfattore. I vostri bisbigli sono stati ascoltati da ombre dietro i muri, e sono giunti al mio orecchio. La vista di quel ragazzo perseguitato ha toccato il vizio stesso infondendogli il coraggio, e persino le qualità, della virtù. È stato commesso un assassinio del quale voi siete moralmente se non materialmente complice». «No, no», interloquì Monks. «Io... io... non ne so nulla. Andavo soltanto per sapere cos'era successo quando m'avete raggiunto. Non sapevo il motivo. Credevo che si trattasse di una delle solite litigate». «Parte dei vostri segreti sono stati svelati», replicò il signor Brownlow. «Confesserete il resto?» «Sì, sì». «Firmerete una trascrizione fedele e veritiera dei fatti, impegnandovi a confermarla di fronte a testimoni?» «Va bene, va bene». «Rimarrete fermo qui finché questo documento non sarà pronto e verrete con me dove riterrò più opportuno, per confermarne il contenuto?» «Se vi preme tanto, farò anche questo», replicò Monks. «Dovrete fare anche più», disse il signor Brownlow. «Dovrete restituire tutto a un ragazzo innocente e buono, perché tale egli è, nonostante sia il frutto di un amore colpevole e infelicissimo. Voi non avete dimenticato i termini del testamento. Attuateli nella misura in cui riguardano vostro fratello e poi andatevene dove volete. Non c'è bisogno che vi incontriate ancora, in questo mondo». Mentre Monks camminava su e giù, foscamente meditando su questa proposta e le possibilità di sfuggirle, diviso tra le sue paure da un lato e il suo odio dall'altro, la porta si aprì di colpo e un gentiluomo - il signor Losberne - entrò nella stanza in violenta agitazione. «L'acciufferanno», gridò. «L'acciufferanno stanotte!». «L'assassino?», chiese il signor Brownlow. «Sì, sì», replicò l'altro. «Il suo cane è stato visto gironzolare attorno al suo vecchio covo, e non c'è da dubitare che, col favore delle tenebre, ci tornerà anche il padrone. Ci sono spie appostate tutto attorno. Ho parlato agli uomini che sono incaricati di catturarlo e mi hanno detto che non ha alcuno scampo. Una taglia di cento sterline sarà bandita dalle autorità stanotte». «Io aggiungerò altre cinquanta sterline», disse il signor Brownlow, «e lo proclamerò con la mia stessa voce non appena mi sarà possibile raggiungere quel luogo. Dov'è il signor Maylie?» «Harry? Appena ha visto il vostro amico qui presente al sicuro con voi in una carrozza si è precipitato là», replicò il dottore, «e, saltato a cavallo, è partito per raggiungere i primi inseguitori da qualche parte, in periferia, dove avevano già concordato di incontrarsi». «L'ebreo», disse il signor Brownlow. «Che notizie avete di lui?» «L'ultima volta che ne ho sentito parlare non era stato ancora acciuffato, ma lo sarà, o sta per esserlo proprio in questo momento. Non ha vie di scampo, dicono». «Vi siete deciso?», chiese a voce bassa il signor Brownlow a Monks. «Sì», replicò. «Rimarrà... rimarrà tra noi?» «Rimarrà tra noi. Aspettatemi qua finché non torno. È la vostra sola speranza di salvezza». Lasciarono la stanza, e la porta fu richiusa di nuovo a chiave. «Cosa gli avete cavato?», bisbigliò il dottore. «Tutto quello che speravo. Persino di più. Mettendo assieme le informazioni della povera ragazza con ciò che già sapevo e con i risultati dell'inchiesta del nostro buon amico sul posto, non gli ho lasciato alcuno spiraglio di fuga, e gli ho sciorinato innanzi tutta la serie di crimini ormai palesi, chiari come la luce del sole. Scrivete, e fissate un incontro per dopodomani sera, alle sette. Ci troveremo là qualche ora prima, ma avremo bisogno di riposo, specialmente la nostra giovane, a cui occorrerà più forza d'animo di quanto non possiamo immaginare ora. Ma fremo d'impazienza per render giustizia a quella povera donna assassinata. Da che parte sono andati?» «Prendete una carrozza e andate dritto alla stazione di polizia», disse il signor Losberne. «Arriverete in tempo. Io resto qui». I due gentiluomini si congedarono in fretta, ciascuno in una eccitazione febbrile e incontenibile. Capitolo L. Caccia e fuga Vicino quel tratto del Tamigi su cui guarda la chiesa di Rotherhithe, sulle cui sponde gli edifici son più sudici e le barche son tutte annerite per la fuliggine delle carbonaie e il fumo delle casupole schiacciate l'una sull'altra, c'è la più sozza, la più incredibile, la più squallida delle tante zone che Londra nasconde, sconosciuta persino nel nome alla grande massa dei suoi abitanti. Per raggiungere questo luogo il visitatore deve penetrare in un labirinto di strade segrete, anguste e fangose, frequentate dalle persone più miserabili e grette tra quelle che popolano le sponde del fiume, dedite a quei traffici che si può immaginare prosperino in tali luoghi; nei negozi, sono esposte ammucchiate le derrate più a buon mercato e grossolane; appesi alle porte dei negozi o pendenti dai parapetti delle case e dalle finestre si vedono i capi di vestiario più grezzi e dozzinali. Spintonato da operai disoccupati dell'infimo ordine, da scaricatori di porto, carbonai, donne perdute, ragazzi cenciosi e da tutta la peggior feccia del fiume, chi attraversa quei luoghi s'apre la strada con difficoltà, assalito da spettacoli e olezzi disgustosi provenienti dagli angusti vicoli che diramano da un lato e dall'altro, assordato dal clangore di pesanti carri su cui s'ammucchiano a pile le mercanzie di depositi e magazzini che sorgono in ogni angolo. Giungendo infine nelle strade più lontane e meno frequentate, egli s'insinua tra facciate di case pericolanti incombenti sul marciapiede, mura cadenti che paiono vacillare al suo passaggio, comignoli a metà caduti, a metà sul punto di crollare, finestre difese da sbarre di ferro arrugginite che il tempo e la sporcizia hanno quasi del tutto eroso, e ogni immaginabile segno di desolazione e abbandono. In questa zona, oltre Dockhead, nella municipalità di Southwork, si trova Jakob's Island, circondata da una fossa fangosa, profonda tra i sei e gli otto piedi e larga tra i quindici e i venti quando c'è la marea alta, nota un tempo come Mill Pond, ma conosciuta ai nostri giorni come Folly Ditch. È un lembo o un'escrescenza del Tamigi, durante l'alta marea si riempie aprendo le chiuse di Lead Mills, dalle quali ha preso il suo antico nome. Allora il visitatore, affacciandosi da uno dei ponti di legno che scavalcano l'isolotto all'altezza di Mill Lane, può vedere gli inquilini delle case, dall'uno e dall'altro lato, calare dalle loro porte sul retro e dalle finestre secchie, paioli e recipienti d'ogni genere per tirar su l'acqua, e quando il suo sguardo passa da queste operazioni a contemplare le case stesse stupirà alquanto della scena che avrà innanzi: traballanti e contorti ballatoi di legno che corrono sul retro di una mezza dozzina di case, con buche dalle quali potersi affacciare sulla melma sottostante; finestre rotte sistemate alla meglio, con bastoni sporgenti su cui poter asciugare la biancheria, mai peraltro visibile; stanze così anguste, così sudice, così chiuse da render l'aria ancor più fetida per il lereiume e lo squallore che racchiudono; camere di legno aggettanti sul fango e che minacciano di crollarvi giù da un momento all'altro, come non di rado accade; pareti insudiciate e fondamenta marcescenti; ogni ributtante tratto della miseria, ogni odioso indice di sporcizia, di marciume e rifiuto; tutti questi sono gli ornamenti di Folly Ditch. A Jakob's Island i magazzini sono vuoti e privi di tetto; le pareti crollanti; le finestre non più finestre; le porte cadenti sulla strada; i comignoli anneriti senza che più ne esca fumo. Trenta o quarant'anni fa, prima che cadesse vittima della speculazione e delle cause legali, era un luogo fiorente, ma ora è un'isola desolata davvero. Le case non hanno proprietari; sono sfondate e occupate da chiunque abbia il coraggio di appropriarsene, per poi viverci e morire. Deve avere una ben disperata esigenza d'un buon nascondiglio o deve patire una ben misera condizione chi cerca rifugio a Jakob's Island. In una stanza ai piani superiori d'una di quelle case - un edificio isolato, di ampie dimensioni, in rovina per molti aspetti ma puntellato alla porta e alle finestre, dalla parte posteriore affacciato sul fossato, come già descritto - erano riuniti tre uomini i quali, di tanto in tanto scrutandosi l'un l'altro con occhiate che tradivano sgomento e attesa, sedevano da un po' in profondo e cupo silenzio. Uno di questi era Toby Crackit; l'altro era il signor Chitling e il terzo un ladro di cinquant'anni, col naso quasi completamente schiacciato in conseguenza di una passata zuffa e con la faccia segnata da una terribile cicatrice, probabile retaggio della medesima occasione. Quest'uomo era un ex deportato, di nome Kags. «Sarebbe stato meglio», disse Toby rivolgendosi a Chitling, «che ti fossi trovato qualche altro nascondiglio quando i due precedenti hanno cominciato a scottare troppo, e che non fossi venuto qui, mio caro compare». «Perché non ti sei tenuto alla larga, testa di legno?», disse Kags. «Beh, credevo che sareste stati un po' più contenti di vedermi», replicò Chitling con aria malinconica. «Vedi, amico», disse Toby, «quando qualcuno se ne sta ritirato come me, dopo essersi assicurato un tetto confortevole al riparo da curiosi e ficcanaso, è un disappunto avere l'onore di una visita da parte di un giovanotto nella tua situazione, per quanto in altre occasioni ti trovi persona rispettabile e simpatica nel gioco a carte». «E specialmente quando questo signore ritirato ci ha un amico che sta con lui, tornato dall'estero prima del previsto, e troppo timido per voler essere presentato al giudice in occasione della rimpatriata», aggiunse il signor Kags. Seguì un breve silenzio, dopo del quale Toby Crackit, sembrando abbandonare come disperato ogni tentativo di mantenere la sua solita aria di spavaldo disincanto, si rivolse a Chitling dicendo: «Quando è stato preso Fagin, dunque?» «Oggi, proprio all'ora di pranzo... alle due di pomeriggio. Charley e io ce la siamo svignata su per la cappa della lavanderia, e Bolter s'è ficcato in un barile vuoto a testa in giù ma le sue gambe erano così lunghe che spuntavano fuori, sicché hanno preso pure lui». «E Bet?» «Povera Bet! È andata a vedere la salma per riconoscerla», replicò Chitling col muso sempre più lungo, «e ci è diventata pazza. Strillava e si dimenava come un ossesso, e picchiava la testa sulle tavole; allora le hanno messo una camicia di forza e l'hanno portata all'ospedale... dove sta ancora adesso». «E che ne è del giovane Bates?», chiese Kags. «Vaga per strada, perché non vuole avvicinarsi prima di notte, ma arriverà presto», replicò Chitling. «Non c'è altro posto dove andare perché tutta la gente dei Tre Storpi è in gattabuia e il bar della locanda... ci sono andato per vedere coi miei propri occhi... è pieno di piedipiatti». «Questa non ci voleva», osservò Toby mordendosi le labbra. «Più di uno ci lascerà le penne». «La sessione dei processi è già iniziata», disse Kags. «Se finiscono l'inchiesta e Bolter testimonia per l'accusa, come sicuramente farà, perché qualcosa ha già spifferato, proveranno che Fagin è stato complice nel delitto, sarà processato per venerdì e penderà dalla forca fra sei giorni, Cribbio!». «Avreste dovuto sentire come urlava la folla», disse Chitling. «I poliziotti hanno dovuto lottare come diavoli per evitare che lo facessero a pezzi. A un certo punto era stato buttato a terra, ma loro hanno fatto cerchio attorno a lui e poi si sono aperti un varco così. Avreste dovuto vederlo come si guardava intorno, lercio e sanguinante, aggrappandosi a loro come fossero stati i suoi migliori amici. Me li vedo davanti come fosse ora, con i poliziotti che quasi non reggevano alla pressione della calca mentre lo trascinavano avanti stretto tra loro; e quelli che li inseguivano, saltandosi addosso per sopravanzarsi, che tentavano di assalirlo come belve selvatiche, con i denti di fuori. Rivedo il sangue sui suoi capelli e sulla barba, e risento le strida con cui le donne, agli angoli delle vie, s'aprivano un varco fino al centro di quella calca e giuravano che gli avrebbero strappato il cuore!». L'inorridito testimone di quelle scene si premette le mani contro le orecchie e ad occhi chiusi s'alzò e cominciò a camminare in su e in giù, come un folle. Mentre era così occupato, e gli altri due sedevano in silenzio con gli occhi fissi al suolo, s'udirono su per le scale dei passi felpati di animale, e subito dopo il cane di Sikes irruppe nella stanza. Corsero giù alla finestra, e in strada. Il cane era entrato saltando da una finestra aperta. Non dette alcun cenno di volerli seguire; il padrone non si vedeva. «Cosa significa!», disse Toby quando furono rientrati. «Non può venir qui. Spero... spero che non venga». «Se voleva venir qui, sarebbe venuto col cane», disse Kags, chinandosi per esaminare l'animale che era steso a terra ansante. «Qua! Portategli dell'acqua; s'è spolmonato per correre». «L'ha bevuta tutta, fino all'ultima goccia», disse Chitling dopo aver guardato per un po' il cane in silenzio. «Coperto di fango... mezzo zoppo... e accecato... deve aver fatto un bel po' di strada». «Da dove può venire mai!», esclamò Toby. «Di certo è passato negli altri covi, e trovandoli pieni di estranei è tornato qua, dove è stato già altre volte. Ma da dove può essere venuto, e perché da solo, senza il padrone?» «Lui... - nessuno di loro chiamava l'assassino col suo vecchio nome - non si sarà suicidato? Che dite?», chiese Chitling. Toby scosse la testa. «In quel caso», disse Kags, «il cane avrebbe voluto condurci fino al cadavere. No. Sarà fuggito dal paese abbandonando il cane. Deve avergli dato il benservito, o non starebbe così calmo». Questa ipotesi, sembrando la più probabile, fu presa per buona e il cane, infilandosi sotto una sedia, si acciondolò, addormentandosi senza più badare ad altri. Era ormai buio. Chiusero le imposte, accesero una candela e la misero sul tavolo. I terribili avvenimenti degli ultimi due giorni avevano fatto su tutti e tre una profonda impressione, acuita dalla pericolosa condizione in cui versavano. Avvicinarono le loro sedie, sobbalzando a ogni minimo rumore. A parte poche parole, sussurrate ogni tanto, il terrore li aveva ammutoliti, come se le spoglie mortali della donna uccisa giacessero nella stanza accanto. Erano rimasti seduti a quel modo per un po' quando improvvisamente s'udì un picchiare concitato alla porta d'ingresso. «Il giovane Bates», disse Kags, guardandosi intorno in cagnesco, come per scacciare la paura che sentiva. S'udì bussare di nuovo. No, non era lui. Non bussava mai a quel modo. Crackit andò alla finestra e, tremando come una foglia, tirò in dentro la testa. Non c'era alcun bisogno che dicesse loro chi era: il pallore della faccia era abbastanza eloquente. Il cane saltò su allarmato e corse guaendo alla porta. «Dobbiamo lasciarlo entrare», disse, prendendo la candela. «Non c'è un'altra soluzione?», chiese l'altro uomo con voce roca. «No. Deve entrare». «Non lasciarci al buio», disse Kags prendendo una candela dalla mensola del camino. Cercò di accenderla, ma tanto gli tremava la mano che si sentì bussare altre due volte prima che ci riuscisse. Crackit scese alla porta e tornò seguito da un uomo con un fazzoletto che gli copriva la parte inferiore del viso e un altro che gli avvolgeva il capo, sotto il cappello. Se li tolse lentamente. Sbiancato in volto, gh' occhi infossati, le guance scavate, la barba di tre giorni, smunto, e con il respiro affannoso, era lo spettro di Sikes. Poggiò la mano su una sedia che stava in mezzo alla stanza, ma pure scosso da brividi e sul punto di lasciarcisi cadere sopra, guardandosi rapidamente alle spalle, la tirò con la spalliera contro il muro, più vicino possibile, la puntellò e si sedette. Non una parola era stata pronunciata. Guardò dall'uno all'altro in silenzio. Se qualche occhio si sollevava furtivamente e incontrava il suo, veniva immediatamente distolto. Quando la sua voce cavernosa ruppe il silenzio sussultarono tutti e tre. Era come se non l'avessero mai sentita prima. «Come è venuto qui quel cane?», chiese. «Da solo. Tre ore fa». «I giornali della sera dicono che Fagin è stato arrestato. È vero o è una fandonia?» «È vero». Rimasero ancora in silenzio. «Maledetti voi», disse Sikes passandosi la mano sulla fronte. «Non avete nulla da dirmi?» Ci fu qualche movimento nervoso tra loro, ma nessuno parlò. «Questa è casa tua», disse Sikes guardando in faccia Crackit, «hai intenzione di vendermi o vuoi nascondermi qua finché non è finita la caccia?» «Resta qui, se ti senti al sicuro», replicò l'altro dopo aver esitato. Sikes portò lentamente gli occhi sul muro dietro di lui più nel tentativo di girare la testa che di muoverla effettivamente, dicendo: «L'hanno... il cadavere... l'hanno seppellito?». Scossero il capo. «Perché no!», ribatté con lo stesso sguardo rivolto all'indietro. «Perché lasciano queste cose terribili alla luce del sole? Chi è che bussa?». Con un gesto della mano mentre usciva dalla stanza, Crackit fece segno che non c'era nulla da temere, e fu subito di ritorno seguito da Charley Bates. Sikes sedeva di fronte alla porta, sicché nel momento stesso in cui mise piede nella stanza il ragazzo lo vide. «Toby», disse il ragazzo ritraendosi mentre Sikes fissava lo sguardo su di lui, «perché non m'hai avvisato quando eravamo giù?». V'era qualcosa di così terribile nel terrore dei tre uomini che il disgraziato ladro pareva ansioso di propiziarsi persino questo ragazzo. Gli rivolse perciò un cenno con la testa e fece mostra di volergli stringere la mano. «Lasciatemi andare in un'altra stanza», disse il ragazzo ancora indietreggiando. «Ehi, Charley!», disse Sikes muovendo qualche passo verso di lui. «Non... non mi riconosci?» «Non avvicinarti», ribatté il ragazzo retrocedendo ancora con occhi sbarrati dall'orrore e fissi sull'assassino. «Mostro!». L'uomo si fermò a metà strada e si guardarono, ma gli occhi di Sikes scivolarono a poco a poco in basso. «Mi siete testimoni voi», gridò il ragazzo agitando freneticamente il pugno. «Tutti e tre mi siete testimoni che non ho paura di lui... se vengono a cercarlo qui, lo denuncio. Lo farò. Ve lo dico subito. Può pure uccidermi se vuole, o se ha il coraggio, ma se sono qua lo denuncio. Lo denuncio, anche se dovessero bollirlo vivo. Assassino! Aiuto! Se c'è un uomo tra voi, aiutatemi. Assassino! Aiuto! Dategli addosso!». Con queste grida, accompagnate da gesti violenti, il ragazzo si scagliò effettivamente, da solo, contro quell'uomo nerboruto e nell'intensità del proprio assalto, cogliendolo di sorpresa, lo fece cadere pesantemente a terra. I tre spettatori restarono come impietriti. Non accennarono ad intromettersi e il ragazzo rotolò a terra con l'uomo, senza accusare i colpi che gli piovevano addosso, afferrando per il risvolto del cappotto l'assassino e mai smettendo, nel frattempo, di chiamare aiuto più forte che poteva. La lotta, tuttavia, era troppo impari per poter durare a lungo. Sikes, gettatolo spalle a terra, gli premeva un ginocchio alla gola quando Crackit lo tirò via con uno sguardo atterrito indicando la finestra. Un bagliore di lampade proveniva da sotto, voci concitate e preoccupate, il rumore di passi affrettati... tantissimi, sembravano... che attraversavano il più vicino ponte di legno. Tra la folla, sembrava esservi un uomo a cavallo, giacché s'udiva lo scalpicciare di zoccoli sul selciato sconnesso. Il bagliore delle lampade si fece più intenso, e i passi più fitti e sonori. Poi s'udì bussare forte alla porta, e poi ancora il cupo vociare di una moltitudine infuriata che avrebbe messo la tremarella addosso anche ai più spavaldi. «Aiuto!», strillò il ragazzo con una voce che lacerò l'aria. «È qui! Abbattete la porta!». «In nome di sua maestà», gridarono da fuori, mentre il cupo vociare saliva d'intensità. «Abbattete la porta!», strillò il ragazzo. «Non l'apriranno mai, vi dico. Correte nella stanza dove vedete luce. Abbattete la porta!». Quando la sua voce cessò, una raffica di pesanti colpi si abbatté sulla porta e sulle finestre del piano inferiore, e la folla esplose in un grido così potente che per la prima volta trasmise l'idea della propria immensità. «Aprite una stanza dove posso rinchiudere questo demonietto urlante», gridò inferocito Sikes correndo in su e in giù e trascinando il ragazzo, ora, con la stessa facilità che se fosse stato un sacco vuoto. «La porta. Svelti!». Gettò dentro il ragazzo, tirò il chiavistello e chiuse a chiave. «La porta giù è serrata bene?» «Col catenaccio e doppio lucchetto», replicò Crackit rimasto, come gli altri due, impotente e quasi paralizzato. «Le imposte... sono solide?» «Rinforzate con sbarre di ferro». «Anche le finestre?» «Sì, anche le finestre». «Maledetti!», gridò il malfattore alle strette, sollevando il saliscendi della finestra e minacciando la folla. «Fatevi sotto! Venite a pigliarmi!». Di tutti i boati agghiaccianti che hanno mai colpito orecchie mortali, nessuno fu mai tanto terribile quanto l'urlo di quella folla infuriata. Alcuni incitarono a gran voce il vicino ad incendiare immediatamente la casa; altri urlarono agli agenti di sparare e ucciderlo. Ma nessuno di loro mostrò più foga dell'uomo a cavallo il quale, smontato d'un balzo e gettandosi tra la folla come se stesse fendendo l'acqua, gridò di sotto la finestra, con voce che si levò su tutte le altre: «Venti ghinee a chi porta una scala!». I più vicini raccolsero l'invito e centinaia di altre bocche lo propagarono. Chi invocava una scala, chi dei martelli; chi correva avanti e indietro con le torce come per cercarli, tornando poi indietro per unirsi al grido collettivo; chi sprecava il fiato in vane imprecazioni e bestemmie; chi spingeva come invasato, così impedendo che potessero avanzare quelli più distanti; chi, più temerario, tentava la scalata aggrappandosi ai condotti di scolo e alle fessure del muro. Tutti ondeggiavano, avanti e indietro, nel buio, come un campo di grano agitato da un vento furioso, di tanto in tanto esplodendo in un clamore tremendo. «La marea», gridò l'assassino ritraendosi nella stanza per togliersi dagli occhi quelle facce, «c'era l'alta marea quando sono venuto. Datemi una corda, una corda lunga. Stanno tutti davanti. Forse riesco a buttarmi nel canale di Folly Ditch e squagliarmela da quella parte. Datemi una corda, o v'uccido tutti e tre prima d'uccidermi». Spaventati a morte, gli uomini gli indicarono dove le tenevano. L'assassino, scegliendo in fretta la più lunga e robusta, salì rapido sul tetto della casa. Tutte le finestre sul retro erano state da tempo murate, eccetto una finestrella nella stanza dov'era rinchiuso il ragazzo, troppo piccola però perché perfino lui potesse passarci. Da questa apertura tuttavia egli non aveva mai smesso di allertare a gran voce quelli di sotto affinché sorvegliassero anche il retro, e così, quando infine l'assassino sbucò sul tetto attraverso una botola, un urlo acuto proclamò la cosa a quelli sul davanti, i quali cominciarono immediatamente a riversarsi dall'altro lato, schiacciandosi l'un l'altro in una fiumana impetuosa. Con una tavola portata con sé allo scopo, l'assassino aveva puntellato saldamente la botola in modo da rendere estremamente difficile aprirla dall'interno. Strisciando sulle tegole guardò in giù, oltre il basso cornicione. L'acqua era già rifluita, e il fossato non era che un letto di fango. In quel mentre, seguendo i movimenti del ladro, la folla zittì, incerta sui suoi propositi, ma non appena l'intuirono e videro la sua sconfitta levarono un urlo trionfante la cui intensità cresceva vieppiù, e a confronto del quale i precedenti sembravano bisbigli. Chi era troppo lontano per comprenderne il senso lo raccolse tuttavia, e lo trasmise ad altri; sembrava che Londra avesse riversato lì tutta la sua popolazione per maledirlo. Coloro che prima erano innanzi ora spingevano sugli altri, come in un ingorgo di facce stravolte, con qua e là il bagliore d'una torcia che le illuminava e ne mostrava tutta la rabbia. Le case dal lato opposto della fossa erano state già prese d'assalto dalla folla; le ghigliottine delle finestre erano state sollevate, o erano state divelte senza tanti complimenti; file di teste s'affacciavano da ogni finestra o sbucavano a gruppi agli abbaini delle case. I ponticelli, di cui solo tre erano visibili, si piegavano sotto il peso delle persone accalcate sopra, e tuttavia il fiume umano premeva per scovare e occupare ogni minimo spazio vuoto, dal quale si potesse scorgere il criminale almeno per un istante, e urlare e inveire. «Ce l'hanno in pugno», gridò uno dal ponticello più vicino. «Urrà!». La folla gettò in aria i cappelli, e di nuovo l'urlo salì. «Cinquanta sterline», disse l'anziano signore dalla stessa parte, «cinquanta sterline a chi lo prende vivo. Rimarrò qui, finché non saranno reclamate». Esplose un altro urlo. In quel momento si trasmise la voce tra la folla che la porta era stata forzata e che la persona che per prima aveva chiesto una scala era salito nella stanza. Mentre la notizia correva di bocca in bocca, il fiume mutò improvvisamente il suo corso, e le persone alle finestre, vedendo quelli sul ponte riversarsi indietro, lasciarono le loro postazioni e, precipitatesi in strada, si unirono alla fiumana che premeva per tornare là da dove era venuta, ciascuno schiacciando e lottando col vicino, tutti esagitati e impazienti per giungere vicino la porta e poter vedere il criminale portato via dagli agenti. Terribili erano le grida e le urla di coloro che erano schiacciati fin quasi a soffocare, o erano calpestati a terra nella confusione. Le strade, già anguste, erano completamente ostruite, sicché tra la foga di alcuni per riguadagnare il posto davanti alla casa e i vani sforzi di altri per svincolarsi dalla massa, si fece meno caso all'assassino sebbene l'universale desiderio di vederne la cattura fosse, se possibile, ancor più intenso. L'uomo s'era acquattato sopra il tetto, annichilito dalla ferocia della folla e dalla impossibilità della fuga, ma rendendosi conto della situazione nel frattempo mutata, balzò in piedi, deciso a compiere un estremo tentativo di salvarsi la vita gettandosi nella fossa e, a rischio di soffocare, cercare di sgusciar via nel buio e nella confusione. Facendo appello alle ultime energie, spronato dai rumori provenienti dall'interno della casa - segno che erano effettivamente riusciti ad entrare - si puntellò col piede a un comignolo, vi legò saldamente un capo della corda e con l'altro, in un attimo, fece un nodo scorsoio aiutandosi con i denti. Con la corda poteva calarsi giù fino a distare da terra meno di quanto era alto, e in mano avrebbe avuto pronto un coltello col quale, a quel punto, tagliarla e saltare. Nel momento stesso in cui si faceva scivolare la corda annodata intorno alla testa per passarla poi sotto le ascelle, e l'anziano signore summenzionato (aggrappatosi saldamente alla ringhiera del ponte per resistere all'impeto della folla e mantenere quella posizione) segnalava ai più vicini che il ladro stava per calarsi giù - in quel momento stesso l'assassino, voltatosi indietro verso il tetto, sollevò un braccio come per ripararsi e gridò dal terrore. «Ancora quegli occhi!», esclamò in un urlo agghiacciante. Barcollando come se fosse stato colpito da un fulmine, perse l'equilibrio e precipitò oltre il parapetto. Il nodo scorsoio che aveva al collo si strinse col peso della sua persona; la corda si tese come quella di un arco, fulminea come una freccia scoccata. Precipitò per trentacinque piedi. Ci fu uno strappo improvviso, una terrificante convulsione delle membra, ed eccolo appeso, col coltello aperto stretto nella mano irrigidita. A quello strappo, il vecchio comignolo tremò ma resse bravamente. L'assassino penzolò privo di vita contro il muro, e il ragazzo, scostando di lato il cadavere oscillante che lo nascondeva alla vista, chiese aiuto a quelli di sotto affinché lo liberassero, per amor di Dio. Un cane, fino ad allora rimasto nascosto, correva avanti e indietro lungo il cornicione ululando in modo agghiacciante; poi s'acquattò per spiccare un salto, e cercò di piombare sulle spalle del morto. Mancò il bersaglio, e rigiratosi completamente nel volo, cadde nel fossato, batté la testa su un sasso e gli schizzò fuori il cervello. Capitolo LI. Spiega più di un mistero e contiene inoltre una proposta di matrimonio che non fa cenno a denaro o proprietà Non erano passati neanche due giorni dagli eventi narrati nell'ultimo capitolo quando Oliver, alle tre del pomeriggio, si trovò a bordo di una carrozza che correva velocemente verso la sua cittadina natale. Erano con lui la signora Maylie, Rose, la signora Bedwin e il buon dottore. Il signor Brownlow seguiva in una carrozza di posta, accompagnato da un'altra persona il cui nome non era stato rivelato. Non avevano parlato molto lungo la strada, poiché Oliver era in uno stato di incertezza e agitazione tale da essere incapace di riordinare i pensieri e quasi di parlare; pressoché lo stesso effetto aveva sui suoi compagni che lo provavano almeno in ugual misura. Con molta cautela, lui e le due signore erano stati informati dal signor Brownlow sulla natura delle ammissioni strappate a Monks, e benché sapessero che lo scopo del loro viaggio era completare l'opera che era stata iniziata tanto bene, tutta la faccenda era però ancora avvolta in dubbi e misteri da lasciarli in balia della più ansiosa attesa. Quel premuroso amico, con l'aiuto del signor Losberne, aveva delicatamente interrotto ogni canale di comunicazione attraverso il quale potessero avere notizia degli ultimi e terribili avvenimenti. «Verissimo che dovranno conoscerli tra non molto», disse, «ma ci sarà un momento più opportuno, e nessuno peggiore di questo». Così continuarono il viaggio in silenzio, ciascuno sprofondato nelle proprie riflessioni sullo scopo per cui si trovavano così assieme, e nessuno disposto a manifestare quegli stessi pensieri che occupavano la mente di tutti. Ma se, sotto queste impressioni, Oliver era rimasto in silenzio mentre procedevano verso il suo luogo natio per una strada che non aveva mai visto, quando svoltarono per quella che egli aveva percorso a piedi, un povero ragazzo vagabondo e senza casa, senza un amico che potesse aiutarlo e senza un tetto per ripararsi, il fiume dei suoi pensieri corse indietro ai vecchi tempi, e che folla di emozioni gli si destò nell'animo! «Guardate là, là!», gridò Oliver afferrando emozionato la mano di Rose e indicando fuori dal finestrino; «ecco il cancelletto che ho scavalcato; ed ecco la siepe dietro la quale mi sono nascosto per paura che qualcuno potesse raggiungermi e riportarmi a forza indietro! E laggiù c'è il sentiero attraverso i campi che porta alla vecchia casa dove sono stato da bambino! Oh Dick, Dick, mio vecchio e caro amico, se solo potessi rivederti ora!». «Lo vedrai presto», replicò Rose gentilmente prendendogli le mani tra le sue. «Potrai dirgli quanto sei felice, e come sei diventato ricco, e che di tutte le tue felicità la più grande è quella di poter tornare a render felice anche lui». «Sì, sì», disse Oliver, «e lo porteremo via di qua, gli daremo degli abiti nuovi e lo faremo studiare, e lo manderemo in qualche posto tranquillo in campagna dove possa crescere bene, e forte... non è vero?». Rose annuì, non riuscendo a parlare, poiché vide il sorriso del ragazzo bagnato da lacrime di felicità. «Voi sarete gentile e buona con lui perché lo siete con tutti», disse Oliver. «Piangerete a sentire la sua storia, lo so, ma non importa, non importa, passerà e poi sorriderete di nuovo - sento anche questo - pensando a come sarà cambiato; avete fatto lo stesso con me. Quando sono scappato mi disse, "Dio ti benedica"», esclamò il ragazzo in un empito d'affetto, «e ora gli dirò io "Dio ti benedica" e gli mostrerò quanto bene gli voglio!». Mentre s'avvicinavano alla cittadina, e infine ne percorsero le strette viuzze, contenere l'entusiasmo del ragazzo entro ragionevoli confini divenne cosa di non trascurabile difficoltà. C'era Sowerberry l'impresario di pompe funebri, proprio com'era un tempo, soltanto più piccolo e d'aspetto meno imponente di come lo ricordasse... c'erano tutti i negozi e le case che ben conosceva e quasi tutti quelli con cui, in qualche modo, aveva avuto a che fare... c'era il carretto di Gamfield, proprio il carretto che un tempo aveva visto fermo alla porta della vecchia locanda... c'era l'ospizio, la cupa prigione della sua infanzia, con le lugubri finestre che davano sulla strada... c'era lo stesso allampanato guardiano che stava al cancello e alla vista del quale Oliver si ritrasse involontariamente, e poi rise di se stesso a quella sua sciocchezza; poi pianse, e poi rise di nuovo... le dozzine di facce, alle porte e alle finestre, egli le conosceva benissimo... e quasi ogni cosa era come se l'avesse lasciata soltanto ieri, e come se tutta la sua vita recente non fosse che un bel sogno. Ma era pura, solida, gioiosa realtà. Proseguirono fino alla soglia dell'albergo principale della cittadina (che un tempo Oliver aveva guardato con un sentimento di venerazione credendolo un palazzo superbo ma che ora aveva perduto grandezza e imponenza) e lì c'era il signor Grimwig prontissimo a riceverli, a baciare le giovani donne e anche le anziane quando smontarono dalla carrozza, come se fosse il nonno dell'intero gruppo, tutto sorrisi e gentilezze, senza più proferire minacce di mangiarsi la testa... no, neanche una volta; neanche quando litigò con un vecchissimo postiglione su quale fosse la strada più breve per Londra, sostenendo che la conosceva meglio di lui, sebbene non l'avesse percorsa che una volta sola e per giunta profondamente addormentato. La cena era pronta, le stanze pure, e ogni cosa era preparata come per incanto. Ciò nonostante, passata l'agitazione della prima mezz'ora, ricaddero nello stesso silenzio e nello stesso riserbo che avevano caratterizzato il loro viaggio. Il signor Brownlow non scese a cena, ma rimase acquartierato in una stanza. Gli altri due gentiluomini uscivano e rientravano con espressioni di ansia dipinte sul volto e, nei brevi intervalli in cui erano presenti entrambi, conversavano tra loro. Ad un certo punto fu chiamata la signora Maylie che, dopo esser rimasta via per un'ora circa, tornò con gli occhi gonfi dal pianto. Tutto ciò rese Oliver e Rose, che non erano stati messi a parte di nessuna nuova notizia riservata, nervosi e agitati. Sedevano in perplesso silenzio, oppure, se scambiavano qualche parola, parlavano a bisbigli, come temessero di sentire il suono delle loro stesse voci. Infine, quando furono le nove e cominciarono a pensare che non avrebbero appreso altro per quella sera, entrarono nella stanza il signor Losberne e il signor Grimwig, seguiti dal signor Brownlow e da un uomo vedendo il quale Oliver quasi gridò dalla sorpresa, poiché si trattava della stessa persona che aveva incontrato nella cittadina e il cui volto, assieme a quello di Fagin, aveva sorpreso a spiare alla finestra della sua stanzetta; e ora gli dissero che era suo fratello. Monks lanciò al ragazzo uno sguardo carico d'odio che perfino in quel momento non riuscì a contenere e sedette accanto alla porta. Il signor Brownlow, con dei fogli in mano, si diresse al tavolo vicino al quale sedevano Oliver e Rose. «È un compito penoso», disse, «ma queste dichiarazioni, che sono state firmate a Londra innanzi a diverse persone, vanno ripetute qui nel loro contenuto. Avrei voluto risparmiarvi questa degradazione, però è necessario che le sentiamo dalle vostre labbra prima che ci separiamo, e sapete il perché». «Andate avanti», disse colui al quale s'era rivolto, distogliendo lo sguardo. «Spicciamoci. Ho fatto quasi tutto quanto volevate, mi pare. Non trattenetemi qui oltre». «Questo ragazzo», disse Brownlow avvicinando a sé Oliver e poggiandogli una mano sul capo, «vi è fratellastro, figlio illegittimo di vostro padre, il mio caro amico Edwin Leeford, e della povera Agnes Fleming, la giovane che morì nel darlo alla luce». «Sì», disse Monks con uno sguardo minaccioso al ragazzo che tremava e il battito del cui cuore avrebbe quasi potuto sentire. «Quello è il loro figlio bastardo». «Il termine che usate», disse severo il signor Brownlow, «è un rimprovero a coloro che da lungo tempo non sono più passibili della censura del mondo. Di nessun altro torna a discapito se non di voi che l'usate. Ma lasciamo stare. È nato in questa cittadina». «Nell'ospizio di questa città», mugugnò l'altro. «Tutta la storia è scritta là», disse, indicando nervosamente le carte. «Devono sentirlo anche loro», disse il signor Brownlow girando lo sguardo sui presenti. «Ascoltate allora!», ribatté Monks. «Quando suo padre si ammalò, a Roma, fu raggiunto dalla moglie, mia madre, dalla quale era stato separato a lungo. Ella lasciò Parigi portandomi con sé solo per venire in possesso delle sue proprietà, a quanto ne so io, perché non nutriva per lui alcun affetto, né lui per lei. Non ci riconobbe affatto avendo perduto coscienza, e rimase in un sonno torpido fino al giorno dopo, quando morì. Tra le carte, nella sua scrivania, c'erano due lettere, datate la notte in cui s'era ammalato e indirizzate a voi», disse, rivolgendosi al signor Brownlow. «Allegate c'erano poche righe per voi, e sull'esterno della busta che le conteneva la raccomandazione di trasmettervela solo dopo la sua morte. Uno di questi fogli era una lettera a quella tale Agnes; l'altro era un testamento». «Che diceva la lettera?», chiese il signor Brownlow. «La lettera?... Era con tantissime cancellature, una confessione contrita, che invocava su di lei l'aiuto divino. Voleva far capire alla ragazza che un qualche misterioso motivo - che un giorno le avrebbe rivelato - gli impediva di sposarla subito. Lei aveva atteso, confidando pienamente in lui, finché trascorse così tanto tempo da perdere ciò che nessuno avrebbe mai potuto restituirle: era giunta a pochi mesi dalla fine della sua gravidanza. Lui le diceva tutto ciò che avrebbe voluto fare per riparare alla sua vergogna se fosse vissuto, e la pregava, se fosse morto, di non maledire la sua memoria e di non pensare che le conseguenze del loro peccato sarebbero ricadute su di lei o sul loro figlio, perché la colpa era soltanto sua. Le ricordava il giorno in cui le aveva dato il piccolo medaglione e l'anello con su inciso il suo nome di battesimo e uno spazio vuoto per il cognome che sperava un giorno non lontano di poterle dare... la pregava di conservarli e di portarli vicino al cuore, come aveva sempre fatto... e poi seguitava, ripetendo sempre le stesse, concitate parole, come se fosse impazzito, e credo che lo fosse davvero». «Il testamento...», disse il signor Brownlow mentre Oliver versava copiose lacrime. Monks taceva. «Il testamento», disse il signor Brownlow parlando in sua vece, «era dello stesso tenore della lettera. Egli diceva dell'infelicità causatagli dalla moglie, della sua scontrosità, furbizia e cattiveria, delle premature e insane passioni vostre, il suo unico figlio, che era stato educato a odiare il padre, e lasciava a voi e a vostra madre un vitalizio annuale di ottocento sterline ciascuno. La maggior parte delle sue sostanze la divideva in due parti eguali, una per Agnes Fleming e l'altra per suo figlio nel caso fosse nato vivo, al raggiungimento della maggiore età. Se fosse nata una bambina, avrebbe ereditato senza condizioni; ma se fosse stato un bambino, avrebbe ereditato solo se, nella sua minore età, non avesse macchiato il proprio nome con azioni disonorevoli, con bassezze, viltà o inganni. Questo, diceva, per riaffermare la sua fiducia nella madre e la sua convinzione... ancor più rafforzata dalla morte imminente... che il bambino avrebbe preso da lei gentilezza e nobiltà d'animo. Se la sua attesa fosse stata delusa, allora i soldi sarebbero toccati a voi, poiché allora, e soltanto allora, egli designava come principale erede del suo denaro voi; voi, che v'eravate estraniato dal suo affetto e che fin da bambino lo avevate respinto con freddezza e ostilità». «Mia madre ha fatto ciò che ogni donna avrebbe fatto», disse Monks alzando la voce, «bruciò il testamento. La lettera non fu mai spedita, ma ella la conservò, insieme ad altre prove, nell'eventualità di dover rivangare quelle colpe. Informò il padre della ragazza sui fatti con ogni dovizia di particolari - quanto l'ammiro e l'amo, per questo - e con tutte le aggravanti che il suo odio violento potè aggiungervi. Sopraffatto dalla vergogna e dal disonore, il padre fuggì assieme ai figli in uno sperduto angolo del Galles cambiando il suo stesso nome affinché persino i suoi amici non potessero mai scoprire il rifugio dove, non molto tempo dopo, fu trovato morto nel suo letto. La ragazza aveva abbandonato la casa, di nascosto, alcune settimane prima. Lui l'aveva cercata a piedi in ogni città e villaggio dei dintorni e fu la notte in cui tornò a casa, certo ormai che ella avesse posto fine ai suoi giorni per nascondere la propria vergogna, che morì di crepacuore». Ci fu un breve silenzio; poi il signor Brownlow riprese il filo del racconto. «Molti anni dopo», disse, «venne da me la madre di costui, Edward Leeford. Egli l'aveva abbandonata quando aveva diciott'anni, rubandole soldi e gioielli; aveva giocato d'azzardo, scialacquato, falsificato, per poi fuggire a Londra, dove per due anni s'era associato con la feccia della feccia. Ella deperiva a causa d'una malattia dolorosa e incurabile, e voleva rivederlo prima di morire. Domandò in lungo e in largo, e fece compiere minuziose ricerche, rimaste a lungo vane. Infine, però, ebbero successo, ed egli tornò con lei in Francia». «Là ella morì», seguitò Monks, «dopo una lunga malattia, e sul letto di morte mi confidò questi segreti, assieme al suo inestinguibile e mortale odio per coloro che vi erano implicati - sebbene non ve ne fosse alcun bisogno, poiché l'odio l'avevo ereditato già molto tempo prima. Non credeva che la ragazza avesse posto fine ai suoi giorni e a quelli della creatura che portava in grembo; era convinta che avesse dato alla luce un bambino, e che egli vivesse. Le giurai che se mai me ne fosse giunta notizia gli avrei dato la caccia senza remissione, l'avrei perseguitato con l'accanimento più violento e implacabile, gli avrei rovesciato addosso l'odio che nutrivo per lui, avrei sputato fiele sulle vuote smargiassate di quel testamento umiliante, e l'avrei trascinato, se mi fosse riuscito, fino ai piedi del patibolo. Mia madre aveva ragione. Dopo tanto m'imbattei nel ragazzo. Iniziai bene la mia opera, e se non fosse stato per qualche ruffiano ficcanaso, l'avrei anche portata a termine!». Mentre quel furfante si stringeva a braccia conserte, borbottando imprecazioni contro se stesso e l'impotenza della malvagità sconfitta, il signor Brownlow, volgendosi all'atterrito gruppo che gli stava accanto, spiegò che l'ebreo, che era stato suo confidente e complice, aveva ricevuto un grosso compenso per tener prigioniero Oliver, dovendone però restituire una parte nel caso Oliver gli fosse stato sottratto, e che una disputa su questo punto aveva condotto i due furfanti a spiare nella casa di campagna allo scopo di identificarlo. «Il medaglione e l'anello?», disse il signor Brownlow rivolgendosi a Monks. «Li ho comprati dall'uomo e dalla donna di cui vi ho parlato; questi due li avevano presi dalla vecchia serva che, a sua volta, li aveva sottratti dal cadavere», rispose Monks senza sollevare lo sguardo. «Il resto lo sapete». Il signor Brownlow si limitò ad un cenno al signor Grimwig il quale, uscito lestamente, rientrò subito dopo spingendo innanzi a sé la signora Bumble e, dietro, il suo riluttante consorte. «Ho le traveggole!», esclamò il signor Bumble con forzato entusiasmo, «o questo è il piccolo Oliver? Oh, O-li-ver, se sapessi quanto sono stato in pena...!». «Stai zitto, sciocco», mormorò la signora Bumble. «È la natura, la natura, signora Bumble!», ribatté il direttore dell'ospizio. «Non nutro forse sentimenti... io che l'ho allevato parrocchialmente... e non devo manifestarli forse quando me lo vedo seduto qui, tra persone del più affabile aspetto? Ho sempre voluto bene al ragazzo come se fosse stato mio... mio... mio nonno», disse il signor Bumble fermandosi per cercare un paragone adeguato. «Signorino Oliver, mio caro, vi ricordate quel signore in panciotto bianco? Ah! Se n'è andato in cielo la settimana scorsa, in una bara di quercia con le maniglie di ottone, Oliver». «Via, signore», disse Grimwig caustico, «controllate i vostri sentimenti». «Ci proverò, signore» replicò Bumble. «Come state, signore? Bene, spero». Il saluto era all'indirizzo del signor Brownlow, il quale s'era avvicinato a pochi passi dalla rispettabile coppia. Indicando Monks chiese: «Conoscete quella persona?»«No», replicò recisa la signora Bumble. «Lo conoscete voi, forse?», ribatté il signor Brownlow rivolgendosi allo sposo. «Non l'ho mai visto in vita mia», rispose il signor Bumble. «Né gli avete mai venduto nulla?» «No», replicò la signora Bumble. «Non siete mai stata in possesso, forse, d'un medaglione d'oro e di un anello?», chiese il signor Brownlow. «Certamente no», replicò la direttrice. «Ci avete trascinato qui solo per rispondere a queste sciocchezze?». Di nuovo il signor Brownlow accennò al signor Grimwig, e di nuovo quel gentiluomo saltò su con straordinaria prontezza. Questa volta, non rientrò con un uomo corpulento e consorte ma con due vecchiette tremanti e malferme nei loro passi. «Voi chiudeste la porta quando la vecchia Sally morì», disse quella che precedeva sollevando la mano avvizzita, «ma non poteste fermare le voci o tappare le fessure». «Già», disse l'altra guardandosi attorno, con un tremolio della mascella sdentata. «Proprio così». «Sentimmo che voleva raccontarvi quello che aveva fatto, e vi vedemmo prendere un foglietto di carta dalla sua mano, e il giorno dopo vi seguimmo fino al banco dei pegni», aggiunse la prima. «Sì», proseguì la seconda, «era la ricevuta per "un medaglione e un anello d'oro". Questo scoprimmo, e li vedemmo quando ve li consegnarono. Eravamo vicinissime. Oh sì! Vicinissime!». «E sappiamo anche dell'altro», riprese la prima, «giacché ci raccontava spesso, molto tempo fa, che quella povera giovane, sentendo che non sarebbe sopravvissuta al parto, le aveva confidato che la febbre l'aveva colta mentre stava recandosi a morire accanto alla tomba del padre del bambino». «Volete vedere l'impiegato del banco dei pegni in persona?», chiese il signor Grimwig indicando in direzione della porta. «No», rispose la donna accennando a Monks, «se lui, a quanto vedo, è stato tanto vigliacco da confessare e avete interrogato tutte le vecchie fino a trovare quelle giuste, io non ho altro da dire. Ho venduto quelle due cose, e adesso si trovano dove non potrete più trovarle. Dunque?». «Dunque niente», replicò il signor Brownlow, «ci sincereremo che nessuno di voi due abbia mai più un incarico pubblico. Potete andare». «Io spero», disse il signor Bumble guardandosi intorno con aria molto contrita, mentre il signor Grimwig usciva assieme alle due vecchie, «io spero che in conseguenza di questa deprecabile circostanza non mi si priverà del mio incarico parrocchiale, signore?». «Questo è certo», replicò il signor Brownlow. «Potete mettervi l'anima in pace a riguardo, e ritenervi anche fortunato a cavarvela così». «È stata tutta opera della signora Bumble. Tutta opera sua», insistette il marito, guardandosi prima intorno per accertarsi che la sua consorte fosse uscita. «Non è una scusante», replicò il signor Brownlow. «Voi eravate presente quando vi sbarazzaste dei gioielli, e in effetti, agli occhi della legge, siete il più colpevole dei due, giacché la legge pone la moglie sotto la potestà del marito». «Se la legge pone questo», disse il signor Bumble schiacciando eloquentemente il cappello tra le mani, «allora la legge è un'asina... è un'idiota. Se questi sono gli occhi della legge, allora sono gli occhi d'uno scapolo, e il peggio che possa augurarle è che glieli apra l'esperienza... l'esperienza». Ripetendo con parecchia enfasi l'ultima parola, il signor Bumble si calcò il cappello in testa e, ficcandosi le mani in tasca, seguì la consorte dabbasso. «Figliola», disse il signor Brownlow rivolgendosi a Rose, «datemi la mano. Non tremate. Ascoltate senza paura le poche parole che mi restano da dirvi». «Se in qualche modo mi riguardano... non so immaginare come, ma se mi riguardano», disse Rose, «vi prego, lasciate che le ascolti in un altro momento. Non ne ho la forza ora». «No», replicò l'anziano signore prendendola sotto braccio, «siete più forte di quanto pensiate, ne sono sicuro. Conoscete questa giovane, signore?». «Sì», rispose Monks. «Io non v'ho mai visto prima d'ora», disse Rose con un filo di voce. «Vi ho vista spesso», replicò Monks. «Il padre della povera Àgnes aveva due figlie», disse il signor Brownlow. «Cosa accadde all'altra... figlia?». «Quando il padre morì all'estero, con un nome non suo, senza una lettera, un quaderno, uno straccio di carta che potesse dare il minimo indizio per risalire ai suoi amici o parenti», rispose Monks, «dei poveri campagnoli presero con loro quella figlia e la allevarono come fosse la propria». «Andate avanti», disse il signor Brownlow facendo segno alla signora Maylie di avvicinarsi. «Andate avanti». «Voi non riusciste a trovare il luogo dove questi campagnoli si erano stabiliti», disse Monks, «ma dove l'amore fallisce, spesso l'odio trova la strada. Mia madre lo scoprì dopo un anno di intense ricerche, sì... e trovò la bambina». «E la portò via?». «No. Erano povera gente, e cominciavano a sentire specialmente l'uomo - quanto costava quella loro bontà. Così mia madre gliela lasciò, dando loro una piccola somma di denaro che non sarebbe bastata a lungo e promise loro altri soldi che non aveva nessuna intenzione di inviare. Ma non s'affidò soltanto al loro risentimento e alla loro povertà perché quella figlia vivesse infelice: raccontò la storia vergognosa della sorella con tutte le alterazioni del caso, li ammonì a stare ben attenti alla piccola perché aveva cattivo sangue, e raccontò loro che era illegittima e che prima o poi sarebbe finita male. Tutte le circostanze sembravano confermarlo. Quella gente credette alla storia e la piccola ebbe con loro un'esistenza abbastanza infelice, con nostra soddisfazione, finché una vedova, una signora che risiedeva allora a Chester, vide per caso la ragazza, ne ebbe compassione e l'accolse in casa sua. Qualche strana maledizione ci perseguitava, credo, giacché ella rimase lì e visse felice nonostante tutti i nostri sforzi. Or'è due o tre anni, la persi di vista e non l'ho più veduta fino a qualche mese fa». «E la vedete adesso?» «Sì. Appoggiata al vostro braccio». «Ma è sempre la mia nipotina», gridò la signora Maylie abbracciando la fanciulla sul punto di svenire, «è sempre la mia cara figlia. Non vorrei perderla adesso per tutti i tesori del mondo; la mia dolce compagna, la mia cara figlia!». «Siete la sola amica che abbia mai avuto», gridò Rose stringendosi a lei. «La più cara e gentile delle amiche. Mi si spezza il cuore. Non reggo, non reggo a tutto questo». «Avete sopportato ben altro, e siete stata la migliore e più dolce creatura che mai abbia dato felicità a chi le era vicino», disse la signora Maylie abbracciandola teneramente. «Vieni, vieni mia cara, ricordati di chi attende di poterti stringere tra le sue braccia, povero figliolo! Eccolo... Guarda, guarda mia cara!». «Non la chiamerò zia», gridò Oliver gettandole le braccia al collo, «ma sorella; la mia cara sorella che fin dall'inizio, spinto da non so cosa, ho amato così profondamente! Cara, cara Rose!». Benedette le lacrime che furono versate allora e le parole spezzate che i due orfani scambiarono in quel lungo abbraccio. In un medesimo istante furono perduti e trovati un padre, una sorella e una madre. Gioia e dolore eran misti nella stessa coppa, e le lacrime senza amarezza, poiché lo stesso dolore sgorgava lenito e lieve, avvolto in così dolci e teneri ricordi da perdere ogni aspetto di pena per trasformarsi in contenuta felicità. Rimasero soli tanto, tanto tempo. Infine un leggero bussare alla porta annunciò che fuori qualcuno attendeva. Oliver aprì e si scostò per far entrare Harry Maylie. «So tutto», disse sedendosi accanto all'amabile ragazza. «So tutto, cara Rose». «Non sono qui per caso», aggiunse dopo un lungo silenzio, «e ieri - non stanotte - m'è stato raccontato tutto quanto; ieri! Puoi immaginare che sono venuto a ricordarti della tua promessa?» «Un momento», disse Rose. «Sai proprio tutto?» «Tutto. Mi dicesti che avrei potuto, entro un anno, riprendere l'argomento del nostro ultimo colloquio». «È così». «Non per forzarti a mutare la tua decisione», continuò il giovane, «ma per sentirti ripeterla se tu avessi voluto. Io avrei posto ai tuoi piedi ogni mia fortuna o posizione raggiunta, e se tu avessi confermato la precedente decisione, m'impegnavo a non cercare di mutarla più, in nessun modo». «Le stesse ragioni che mi spinsero allora a quella decisione, m'inducono a confermarla adesso», disse Rose con fermezza. «Se mai ho avuto doverosi obblighi verso chi, con la sua bontà, mi ha salvato da una vita di miseria e di sofferenza, quando dovrei sentirli se non questa sera? Sono combattuta», disse Rose, «ma questa è una lotta che sono orgogliosa di affrontare; è una pena che il mio cuore sosterrà». «Le rivelazioni di questa sera...», esordì Harry. «Le rivelazioni di questa sera», replicò Rose con dolcezza, «mi lasciano nei tuoi confronti nella stessa condizione in cui ero allora». «Tu indurisci il tuo cuore contro di me, Rose», rimostrò il suo innamorato. «Oh, Harry, Harry», disse la giovane scoppiando in lacrime, «magari lo potessi, risparmiandomi tutta questa pena». «Allora perché te la infliggi tu stessa?», disse Harry prendendole la mano. «Pensa, cara Rose, pensa a ciò che hai sentito stasera». «E cosa ho sentito? Cosa ho sentito?», proruppe Rose, «che su mio padre piombò un senso di così profonda vergogna da indurlo a fuggire da tutti... ecco, non c'è altro da dire Harry, non c'è altro da dire». «Non ancora, non ancora», disse il giovane trattenendola mentre ella si alzava. «Tutto è mutato: le mie speranze, i miei desideri, le mie attese, i miei interessi; ogni mio pensiero, tranne il mio amore per te. Ora ti offro non più una posizione tra persone ambiziose; non un posto in un mondo di malvagità e di calunnie dove l'onestà arrossisce di colpe e vergogne non sue; ma soltanto una casa... un cuore e una casa... sì, cara Rose; questo, e soltanto questo, ho da offrirti ora». «Cosa vuoi dire?», balbettò lei. «Semplicemente questo... che ti ho lasciato col fermo proposito di abbattere ogni presunta barriera che mi separava da te; e che se non avessi potuto render tuo il mio mondo, avrei fatto mio il tuo; e che mi sarei allontanato da chi per orgoglio di famiglia vi avrebbe sdegnata. Ed è ciò che ho fatto. Quelli che di conseguenza mi hanno evitato hanno evitato te, con ciò provando la verità di quanto dicevi. Il potere, le protezioni, le parentele, le relazioni di rango che allora mi sorridevano, ora mi guardano con freddezza; ma nella più rigogliosa terra d'Inghilterra ci sono campi ridenti e alberi con le fronde che stormiscono al vento; e presso la chiesa d'un villaggio... il mio... c'è una rustica dimora di cui potresti rendermi ancora più orgoglioso, Rose cara, e mille volte più orgoglioso che se tutte le mie passate speranze, a cui ho rinunciato, si fossero realizzate. Questo è ora il mio rango e la mia condizione, e io li metto ai tuoi piedi!». «È dura dover aspettare due innamorati per la cena», disse il signor Grimwig scuotendosi e passandosi il fazzoletto sulla testa. In effetti, la cena era pronta da un bel pezzo, e né la signora Maylie, né Harry, né Rose, nell'entrare tutti assieme, seppero come scusarsi. «Pensavo che mi sarei davvero mangiata la testa, stasera», disse il signor Grimwig, «cominciando a temere che non ci sarebbe stato altro di commestibile. Mi prendo la libertà, se voi permettete, di salutare come si deve la nostra futura sposa». Il signor Grimwig non perdette tempo a mettere in atto l'intenzione manifestata dando un bacio alla ragazza e il suo esempio, contagiando gli altri, fu seguito sia dal dottore sia dal signor Brownlow. Alcuni affermano che Harry Maylie l'avesse dato per primo in una stanza adiacente in penombra ma le migliori autorità reputano questo un vero e proprio scandalo, data la sua giovane età e gli ordini religiosi che aveva preso. «Oliver, piccolo mio», disse la signora Maylie, «dove sei stato e perché hai un aspetto così triste? Perché quelle lacrime in un momento come questo? Cosa c'è?». Il nostro è un mondo di disillusioni, e spesso son deluse proprio le nostre speranze più vive e che più fanno onore alla nostra natura. Il povero Dick era morto! Capitolo LII. L'ultima notte dell'ebreo Dal pavimento al soffitto, l'aula del tribunale era tappezzata di volti. Da ogni centimetro di spazio spuntavano occhi che bramavano, curiosi. Dalla balaustra di fronte al banco degli accusati e ovunque, fino all'angolo più angusto delle gallerie, tutti gli sguardi erano fissi su un solo uomo: l'ebreo. Li aveva innanzi e alle spalle, di sopra e di sotto, a destra e a sinistra; sembrava circondato da un firmamento di occhi lucenti. Stava lì, in quel palpito di luce vivente, con una mano appoggiata alla sbarra di legno innanzi a lui, l'altra accostata all'orecchio, e la testa protesa in modo da poter afferrare il più distintamente possibile ogni parola pronunciata dal giudice, mentre ripeteva i capi di imputazione alla giuria. Ogni tanto egli volgeva lo sguardo su questa, ansioso di cogliervi l'effetto del più tenue elemento a proprio vantaggio, e quando ogni capo d'accusa contro di lui fu dichiarato con terribile precisione, girò lo sguardo al suo avvocato in un muto appello a che egli, perfino in quel momento, obbiettasse qualcosa in suo favore. A parte queste manifestazioni di angoscia però, egli non muoveva muscolo. Da quando il processo era iniziato era rimasto pressoché immobile e adesso che il giudice aveva smesso di parlare restò in quella medesima attitudine di tesa attenzione, con lo sguardo fisso su di lui, come se stesse ancora ascoltandolo. Un leggero movimento nell'aula lo ricondusse a sé. Guardandosi intorno vide che i membri della giuria si stavano consultando per emettere il verdetto. Mentre volgeva lo sguardo alla galleria vedeva teste che cercavano di protendersi sopra le altre per poterlo scrutare in faccia, alcuni che s'affrettavano a sistemarsi gli occhiali, altri che sussurravano ai loro vicini con espressioni d'orrore dipinte in volto. Ve n'erano alcuni, poi, che sembravano non curarsi di lui e guardavano solo la giuria, chiedendosi impazienti perché tardassero tanto. Ma su nessuno di quei volti, neanche su quello delle donne, presenti in gran numero, potè cogliere la minima traccia di compassione, né altri sentimenti se non un travolgente desiderio che fosse condannato. Mentre osservava tutto questo con sguardo allucinato, l'aula ripiombò in una calma mortale ed egli, girandosi, vide che i giurati si stavano rivolgendo al giudice. Silenzio! Chiedevano soltanto il permesso di ritirarsi. Mentre passavano, uno per uno, li guardò in volto ansioso, come per leggere da che parte propendesse la maggioranza, ma invano. Il carceriere lo toccò su una spalla. Lo seguì meccanicamente fino all'angolo più lontano della zona degli accusati e sedette su una sedia. Gliela indicò il carceriere, altrimenti non l'avrebbe nemmeno veduta. Guardò di nuovo su, verso la galleria. Tra il pubblico, qualcuno mangiava; qualcun altro si faceva vento con i fazzoletti, poiché in quel posto affollato si scoppiava. Un giovane disegnava uno schizzo del suo volto su un taccuino. Si chiese come l'avesse ritratto, e quando l'artista ruppe la punta della matita e la rifece servendosi di un coltellino, continuò a guardarlo, come avrebbe potuto fare il più disinteressato degli spettatori. Allo stesso modo, quando tornò a guardare il giudice, la sua mente fu attratta dalla foggia del suo abito, da quanto costasse e da come lo indossava; e poi da un signore grasso sul banco del giudice che era uscito una mezz'ora prima e rientrava adesso. Si chiese tra sé se quest'uomo fosse andato a mangiare, cosa avesse preso, e dove, e seguì trasognato il corso di tali pensieri finché l'occhio non gli cadde su un nuovo oggetto che a sua volta li spinse in altra direzione. In tutto questo tempo, neanche un istante la sua mente fu libera dalla sensazione opprimente della fossa che gli si spalancava sotto i piedi; seppure in forma vaga e indistinta, era sempre lì presente, senza che però il pensiero cosciente potesse soffermarcisi sopra. Così, pur tremando e bruciando all'idea della morte imminente, si metteva a contare le sbarre di ferro innanzi a lui, chiedendosi come si fosse potuta rompere la punta di una e se l'avrebbero aggiustata o lasciata così com'era. Poi pensò a tutti gli orrori della forca e del patibolo; poi s'interruppe per osservare un uomo che cospargeva d'acqua il pavimento per rinfrescarlo; e poi riprese i suoi pensieri. Alla fine si sentì gridare silenzio, e trattenendo il respiro tutti volsero gli occhi alla porta. I giurati rientrarono passandogli vicinissimo. Non potè leggere nulla sui loro volti, non più che se fossero stati di pietra. Seguì un silenzio totale... neanche un fruscio... neanche un respiro... Colpevole. L'edificio fu scosso da un tremendo boato, e poi da un altro, e da un altro ancora, e poi echeggiò di grida profonde che crebbero come un'onda, come un rabbioso tuonare. Era l'esultanza della gente di fuori alla notizia che sarebbe stato giustiziato il lunedì seguente. Il tumulto si placò, e al condannato fu chiesto se avesse qualcosa da dire perché fosse sospesa l'esecuzione della condanna a morte. Egli era di nuovo proteso per sentire meglio, e mentre risuonava quella domanda guardò attentamente chi l'interrogava; gliela si dovette però ripetere due volte prima che sembrasse comprenderla, e balbettò soltanto che era un vecchio... un vecchio... un vecchio, con voce sempre più esile, finché non ammutolì di nuovo. Il giudice indossò il berretto nero, mentre il condannato sembrava irrigidito in ascolto. Una donna in galleria gridò qualcosa, quasi a voler rompere quella terribile solennità; egli volse subito lo sguardo da quella parte come irritato da tale interruzione e poi riprese la sua postura, ancor più concentrato. La requisitoria del giudice fu solenne e impressionante; la sentenza, terribile a udirsi; ma lui restò immobile, senza muovere il più piccolo muscolo, come impietrito. Il suo volto disfatto era ancora proteso, la mascella appesa, e gli occhi fissi nel vuoto quando il carceriere gli mise la mano sul braccio facendogli cenno di muoversi. Per un momento volse intorno uno sguardo attonito; poi obbedì. Lo condussero attraverso una stanza pavimentata sotto l'aula, dove alcuni carcerati attendevano il loro turno e altri parlavano con i loro amici stretti contro un'inferriata che dava sul cortile. Non c'era nessuno che volesse parlare con lui. Mentre passava però i carcerati si fecero da parte affinché le persone che si aggrappavano alle sbarre potessero vederlo meglio. Gli rovesciarono contro improperi, fischi e urla. Lui agitò il pugno e avrebbe voluto sputar su di loro ma i carcerieri lo spinsero avanti per un buio corridoio illuminato da poche e fioche lampade fino all'interno della prigione. Qui egli fu perquisito, per tema che avesse strumenti per anticipare la legge. Espletata questa funzione, lo condussero alle celle dei condannati e lì lo lasciarono... solo. Sedette su un sedile di pietra, che fungeva anche da letto, di fronte alla porta, e con gli occhi iniettati di sangue volti a terra cercò di riordinare i pensieri. Dopo un po' cominciò a ricordare alcune frammentate parole di ciò che il giudice aveva detto, benché sul momento gli fosse sembrato di non aver udito nulla. A poco a poco esse ritrovarono la loro collocazione, prendendo gradualmente significato. Così, in poco tempo, ricostruì il tutto, quasi come era stato detto. Impiccato... questa era la fine che l'attendeva. Impiccato. Quando scese una fitta tenebra, cominciò a pensare a tutti quelli che aveva conosciuto, morti sul patibolo, tra cui quelli che ci erano finiti per causa sua. Gli si pararono innanzi in una successione così rapida da non riuscire neanche a contarli. Alcuni li aveva visti morire, e li aveva anche derisi perché morivano con le preghiere sulle labbra. Con quale terrificante scricchiolio cadeva la botola, e come istantaneamente quegli uomini forti e vigorosi si mutavano in un mucchio di stracci appesi! Alcuni di loro erano forse stati in quella stessa cella... s'erano seduti in quello stesso angolo. Era molto buio. Perché non gli portavano una luce? La cella doveva essere stata costruita molti anni prima. Dozzine di uomini dovevano averci passato le loro ultime ore. Era come essere seduti in un antro zeppo di cadaveri, col cappuccio, il nodo scorsoio, le braccia legate, i volti che ben conosceva, anche in quella tenebra... Luce! Luce! Alla fine, quando ebbe le mani sanguinanti dal battere contro la pesante porta e contro i muri, entrarono due uomini, uno portando una candela che ficcò in un candeliere di ferro fissato al muro; l'altro, trascinando un materasso sul quale potessero distendersi la notte, poiché il carcerato non doveva più restar solo. Venne quindi la notte... buia, lugubre, silenziosa. Chi è insonne trae conforto dal battere degli orologi delle chiese, perché esso annuncia l'avvicinarsi del mattino. All'ebreo portò solo disperazione. Il rintocco di ogni campana giungeva carico di un solo tono profondo e cupo... quello della morte. Cosa poteva mai significare per lui l'attività e il trambusto del lieto mattino che giungeva fin dentro la cella? Era un frastuono che aggiungeva derisione alla minaccia. Passò quel giorno... un giorno, che non era stato tale! Era trascorso non appena spuntato... ed era di nuovo notte; una notte tanto lunga e tanto breve ad un tempo; lunga nel suo terribile silenzio, breve nella rapida fuga delle sue ore. Un momento inveiva e bestemmiava; un altro, gridava e si strappava i capelli. Uomini di rango nella gerarchia della sua religione eran venuti per pregare con lui, ma li aveva allontanati maledicendoli. Avevano tentato di nuovo, e li aveva scacciati a viva forza. Sabato notte. Gli restava soltanto una notte di vita. Con questo pensiero, sopraggiunse il mattino... domenica. Non prima della notte di quel tremendo, ultimo giorno, la sua anima atterrita avvertì pienamente il tormento della propria condizione disperata e sola. Non che avesse mai nutrito qualche speranza di pietà, ma questo perché aveva sempre considerato come estremamente improbabile morire così presto. Aveva parlato poco con le due guardie, ciascuna delle quali traeva conforto dall'altra nel sorvegliarlo, ed esse, dal canto loro, non avevano fatto alcun tentativo di destare la sua attenzione. Era rimasto lì seduto, sveglio ma come stordito. Adesso, ogni minuto si scuoteva, annaspando e sentendo il corpo bruciare; andava in su e in giù, in un tale parossismo di paura e terrore che perfino loro, abituati a quegli spettacoli, si ritraevano da lui con orrore. Infine, in tutti i tormenti della sua cattiva coscienza, divenne uno spettacolo così terribile anche ai loro occhi, che uno di loro ebbe paura a restare seduto a sorvegliarlo da solo sicché restarono desti entrambi. L'ebreo si rannicchiò sul suo letto di pietra, pensando al passato. Il giorno del suo arresto era stato ferito da oggetti lanciatigli contro dalla folla, e una benda gli fasciava alla meglio la testa. I capelli rossi gli pendevano sul volto esangue; la barba era a ciocche strappate, o aggrovigliate; gli occhi rilucevano terribilmente; le membra, non lavate da tempo, screpolate per la febbre che lo bruciava. Le otto... le nove... le dieci. Se quello non era un trucco per spaventarlo, e quelle erano realmente ore che si rincorrevano una dopo l'altra, dove sarebbe finito al prossimo rintocco! Le undici! Un'altra batteva prima che la voce della precedente avesse cessato di vibrare. Alle otto, avrebbe seguito da solo il corteo del proprio funerale; alle undici... Le terribili mura di Newgate, che hanno nascosto queste sofferenze e angosce indicibili non soltanto agli occhi ma spesso anche al pensiero degli uomini, non videro mai spettacolo così terrificante come quello. I pochi che rallentavano passando, e si chiedevano cosa facesse l'uomo che sarebbe stato impiccato l'indomani, non avrebbero dormito un sonno tranquillo quella notte, se avessero potuto vederlo. Già sul far della sera e fin quasi a mezzanotte, gruppetti di due o tre persone si avvicinavano al cancello d'ingresso per chiedere, preoccupati, se nel frattempo la pena fosse stata commutata. Avuta risposta negativa, trasmettevano la buona notizia ai gruppetti di persone in strada che sostavano indicandosi vicendevolmente la porta dalla quale sarebbe uscito e il luogo dove sarebbe stato eretto il patibolo, e allontanandosi quasi riluttanti, tornavano a voltarsi per evocare la scena. Gradualmente, a uno a uno, disparvero, e per un'ora, nel cuore della notte, la strada fu deserta e tenebrosa. Lo spazio antistante la prigione era stato sgombrato e robuste transenne dipinte di nero erano state già collocate di traverso la strada per contenere la pressione della folla che si prevedeva sarebbe accorsa, quando il signor Brownlow e Oliver si presentarono al cancello con un permesso di visita al condannato, sottoscritto da uno dei vice-direttori. Furono immediatamente ammessi al posto di guardia. «Deve venire anche il ragazzo, signore?», disse l'uomo che aveva l'incarico di accompagnarli. «Non è uno spettacolo per ragazzi, signore». «Non lo è, amico mio», ribatté il signor Brownlow, «ma la ragione della visita riguarda proprio lui, e poiché questo ragazzo l'ha già veduto al culmine del suo successo e delle sue malefatte, io credo che sia un bene se lo vede adesso... dovesse pure costargli paura e sofferenza». Dissero questo in disparte, sì da non essere uditi da Oliver. L'uomo si toccò il cappello e scrutando Oliver con una qualche curiosità aprì un altro cancello, opposto a quello da cui erano entrati, e li guidò per un tragitto buio e tortuoso fino alle celle. «Per di qua», disse l'uomo chinandosi in un tetro corridoio dove un paio di operai erano intenti a qualche preparativo in profondo silenzio, «per di qua deve passare. Se venite da questa parte potrete vedere la porta da cui dovrà uscire». Li condusse in una cucina con mura di pietra, fornita di pentole e padelle per cucinare il cibo dei carcerati e indicò una porta. La sovrastava una grata traverso la quale giungevano voci di uomini miste al fragore dei colpi di martello e delle tavole buttate giù. Stavano erigendo il patibolo. Da questo luogo passarono attraverso pesanti porte inferriate aperte dall'interno dai secondini; poi, entrati in un cortile aperto, salirono per una stretta rampa di scale fino a un corridoio con una fila di porte blindate, dal lato sinistro. Facendo loro cenno di restare dov'erano, la guardia bussò a una di queste col suo mazzo di chiavi. I due sorveglianti, dopo essersi consultati a bassa voce, uscirono sul corridoio stiracchiandosi, sollevati a quella temporanea distrazione, e accennarono ai visitatori di seguire la guardia nella cella. Così essi fecero. Il condannato era seduto sul letto, e dondolava da un alto e dall'altro, più con l'aspetto di una bestia intrappolata che di un uomo. La sua mente era evidentemente persa nella sua vita passata poiché continuò in un balbettio indistinto, senza rendersi conto della loro presenza se non come parte della sua immaginazione. «Bravo Charley... ben fatto...», farfugliò. «E anche Oliver. Ah, ah, ah! Anche Oliver... proprio un signorino adesso... proprio un... via, portatelo a letto!». La guardia prese la mano di Oliver bisbigliandogli di non avere paura. Continuarono a osservarlo in silenzio. «Via, portatelo a letto!», gridò l'ebreo. «Mi sentite, voialtri? Alla fin fine, è stato lui... lui... la causa di tutto questo. Mette conto addestrarlo... La gola, a Bolter, Bill; lascia perdere la ragazza... taglia la gola a Bolter, affonda il coltello più che puoi. Spiccagli la testa!». «Fagin», disse la guardia. «Sono io!», gridò l'ebreo ricadendo immediatamente in quell'attitudine di concentrata attenzione che aveva tenuta nel corso del processo. «Un vecchio, vostra eccellenza, un povero vecchio; tanto vecchio!». «C'è qualcuno che vuole vederti», disse il secondino poggiandogli una mano sul petto per tenerlo giù. «C'è qualcuno che vuole vederti per farti qualche domanda, credo. Fagin. Fagin! Siate uomo!». «Non sarò più niente, fra poco», replicò l'ebreo volgendo in su uno sguardo che non recava altra espressione umana se non rabbia e terrore. «Uccidili tutti. Che diritto hanno di macellarmi?». Così dicendo vide Oliver e il signor Brownlow. Arretrando fino all'angolo più lontano del sedile domandò cosa ci facessero lì. «Sta' buono», disse la guardia sempre tenendolo giù. «Adesso chiedetegli ciò che v'interessa, signore, svelto, per piacere, perché peggiora a vista d'occhio». «Voi siete in possesso di carte», disse il signor Brownlow avanzando, «che vi furono consegnate da un certo Monks affinché le custodiste». «È tutta una menzogna», replicò l'ebreo. «Non ho niente... niente». «Per carità di Dio», esclamò solennemente il signor Brownlow, «non dite così ora che siete prossimo alla morte; rivelateci dove si trovano. Sapete che Sikes è morto, che Monks ha confessato, che non c'è alcuna speranza di trarne vantaggio. Dove si trovano quelle carte?» «Oliver», gridò l'ebreo facendo cenno a Oliver di avvicinarsi. «Qua, qua! Te lo sussurro all'orecchio». «Non ho paura», disse Oliver piano, lasciando la mano del signor Brownlow. «Le carte», disse l'ebreo tirandoselo vicino, «si trovano in una borsa di tela in un buco poco in alto, dentro la cappa del camino, nella stanza in cima, sul davanti. Devo parlarti, mio caro, devo parlarti». «Sì, sì», replicò Oliver. «Lasciatemi dire una preghiera. Ditene una soltanto con me, in ginocchio, e parleremo fino a domattina». «Di fuori, di fuori», replicò l'ebreo spingendo il ragazzo innanzi a sé verso la porta con lo sguardo stravolto. «Di' che sono andato a dormire... a te crederanno. In questa maniera puoi portarmi fuori. Dai, dai!». «Oh, Dio perdoni questo poveretto!», gridò il ragazzo scoppiando in lacrime. «Va bene così, va bene così», disse l'ebreo. «Questo ci sarà d'aiuto. Prima questa porta. Se mi metto a tremare quando passiamo innanzi alla forca, non ci far caso, tira dritto. Su, su, su!». «Non avete altro da chiedergli, signore?», domandò la guardia. «Nient'altro», replicò il signor Brownlow. «Se ci fosse una speranza di poterlo ricondurre a sé... ». «Nessuna, signore», replicò l'uomo scuotendo il capo. «È meglio che lo lasciate». La porta della cella si riaprì e rientrarono i due sorveglianti. «Spingi, spingi», gridò l'ebreo. «Piano, ma non così lentamente. Più svelto, più svelto!». Gli uomini l'agguantarono e, liberando Oliver dalla sua stretta, lo tennero fermo. Per un istante, egli lottò con la forza della disperazione; poi cacciò tali urli da trapassare persino quelle massicce mura, e da risuonare attenuate all'orecchio di Oliver e Brownlow finché non ebbero raggiunto il cortile aperto. Il mattino s'avvicinava quando uscirono. S'era già riunita una grande folla; la gente s'accalcava alle finestre, a fumare e a giocare a carte per ingannare l'attesa; nella ressa spingeva, litigava, scherzava. Tutto manifestava vita e animazione, tranne alcuni cupi strumenti al centro del piazzale: il palco nero, la forca, la fune, e gli altri orribili apparati della morte. Capitolo LIII. E ultimo Le fortune di coloro che sono comparsi in questa storia volgono ormai al termine, e il poco che resta da dire al narratore è presto detto. Prima che passassero tre mesi, Rose Fleming e Harry Maylie s'erano sposati nella chiesetta dello stesso villaggio che da quel momento in poi sarebbe stata la scena dell'opera del giovane pastore; in quel medesimo giorno entrarono nella loro nuova e felice casa. La signora Maylie andò ad abitare con suo figlio e con la nuora per godersi, per tutti i tranquilli giorni che le restavano, la più grande gioia che l'età e la rettitudine possano conoscere, e cioè contemplare la felicità di coloro ai quali si sono costantemente devoluti i più caldi affetti e le attenzioni più premurose di una vita ben spesa. Dopo accurata e completa verifica risultò che, se i beni superstiti ancora in possesso di Monks (niente affatto incrementati, né per merito suo né di sua madre) fossero stati divisi in parti uguali tra lui e Oliver, avrebbero reso a ciascuno poco più di tremila sterline. Secondo la disposizione testamentaria paterna, Oliver avrebbe dovuto avere tutto quanto, ma il signor Brownlow, non volendo togliere al figlio maggiore la possibilità di riscattare la sua passata malvagità in una più onesta carriera, propose questa distribuzione, accettata con gioia dal suo pupillo. Monks, conservando il suo falso nome, si ritirò con la sua parte in un lontano angolo del Nuovo Mondo e lì, dopo averla rapidamente dilapidata, ricadde nelle sue vecchie abitudini e, dopo aver scontato una lunga pena per qualche nuova frode o truffa, fu infine vittima di un attacco della sua antica malattia e morì in prigione. I principali esponenti della banda di Fagin superstiti morirono altrettanto lontani. Il signor Brownlow adottò Oliver come suo figlio. Esaudì l'ultimo desiderio dell'affettuoso e trepido cuore di Oliver, trasferendosi con lui nel vecchio casotto di guardia a circa un miglio dalla canonica dove abitavano gli sposi novelli, e fu il centro di una piccola comunità la cui condizione tanto s'avvicinava alla perfetta felicità quanto è dato di conoscere in questo mondo mutevole. Subito dopo il matrimonio dei due giovani il buon dottore ritornò a Chertsey dove, privo della compagnia dei suoi vecchi amici, sarebbe sicuramente immalinconito se il suo temperamento avesse permesso un tale sentimento, e dove non avrebbe finito più di lamentarsi se la sua natura avesse contemplato tale possibilità. Per due o tre mesi s'accontentò di insinuare che l'aria cominciava forse a non essergli più congeniale; poi, trovando che quel posto non era più per lui quello che era stato un tempo, lasciò l'attività al suo assistente, si prese una casetta da scapolo appena fuori del villaggio di cui era pastore il suo giovane amico e si ristabilì immediatamente. Qui si dedicò al giardinaggio, alla coltivazione, alla pesca, alla falegnameria e svariate altre occupazioni del genere, tutte perseguite con la sua consueta irruenza e in ciascuna delle quali è da allora conosciuto in tutto il vicinato come un'autorità indiscussa. Prima del suo trasferimento, aveva stabilito un rapporto di fortissima amicizia con il signor Grimwig, cordialmente ricambiata da quel gentiluomo. Ne riceve perciò spesso e volentieri la visita nel corso di ogni anno. In ciascuna di tali occasioni il signor Grimwig pianta, pesca e s'industria nell'arte della falegnameria con grande ardore, svolgendo quelle attività in modo nuovo e singolare ma sempre sostenendo, con la solita testardaggine, che il suo è il metodo giusto. Non manca mai, la domenica, di rimproverare al pastore ciò che non andava nella predica, informando poi sempre il signor Losberne, in stretta confidenza, che la riteneva eccellente ma che non riteneva opportuno rivelarglielo. Una delle facezie favorite e ricorrenti del signor Brownlow è quella di rinfacciargli la sua vecchia profezia su Oliver, ricordandogli di quella notte in cui sedevano, con l'orologio tra di loro, aspettandone il ritorno. Il signor Grimwig replica tuttavia che nel complesso egli aveva ragione e a prova di ciò ricorda che, in effetti, Oliver non era tornato; e allora esplode in una risata che accresce la sua giovialità. Il signor Noah Claypole, graziato dalla Corona per aver reso piena testimonianza contro l'ebreo, ritenendo il suo mestiere non così sicuro come avrebbe desiderato, restò per qualche tempo sprovvisto di mezzi di sussistenza e niente affatto oberato di lavoro. Dopo averci meditato sopra, si mise in affari in qualità di informatore, arte mediante la quale raggiunge un reddito al di sopra del volgo. Il suo piano è di andare in giro una volta a settimana all'ora della funzione religiosa, accompagnato da Charlotte vestita con decoro. La signora finge lo svenimento alla porta di tavernieri di buon cuore e il degno marito, ottenuti tre penny di brandy per farle tornare i sensi, denuncia il proprietario il giorno dopo e intasca metà della multa. A volte il signor Claypole sviene di persona, ma il risultato è lo stesso. Il signore e la signora Bumble, privi della loro carica, finirono progressivamente in grande miseria ed indigenza, per divenire infine ospiti di quello stesso ospizio nel quale, un tempo, avevano spadroneggiato incontrastati a danno di altri poveri. Il signor Bumble sembra abbia affermato che, in tale rovescio di fortune, non sapeva più neanche gioire di esser separato dalla moglie. Quanto al signor Giles e al signor Brittles, essi restano al loro posto d'un tempo, benché il primo abbia perso tutti i capelli e l'attempato ragazzo sia incanutito. Dormono in canonica, ma dividono così equamente le loro attenzioni tra chi vi abita, Oliver, il signor Brownlow e il signor Losberne, che a tutt'oggi gli abitanti del villaggio non sono stati in grado di scoprire da quale casa dipendano. Mastro Charley Bates, atterrito dal delitto di Sikes, cominciò a pensare che forse una vita onesta era la migliore. Giungendo alla conclusione che sicuramente era così, voltò le spalle al passato deciso ad emendarsi in qualche nuova sfera di azione. Per un po' dovette lottare duramente e soffrire parecchio, ma alla fine, mantenendo i buoni propositi e accontentandosi, passò da ragazzo tuttofare d'un agricoltore a garzone di carrettiere, ed è ora il più allegro mandriano di tutto il Northamptonshire. Ma adesso, vicina a compiere la sua opera, la mano che traccia queste parole esita, e vorrebbe tessere ancora per un po' il filo di queste avventure. Volentieri rimarrei tra coloro che ho seguito così a lungo, condividendone la felicità mentre cerco di rappresentarla. Mostrerei Rose Maylie in tutta la sua grazia e beltà di sposa novella soffondere d'una luce così dolce e delicata il corso della sua vita e tutti coloro che ne erano parte, da riscaldarne il cuore; vorrei dipingerla quale vita e gioia del focolare, e fulcro d'un'allegra brigata estiva; vorrei seguirla per gli assolati campi del meriggio, e ascoltarne i toni della voce soavi e tranquilli nelle passeggiate al chiaro di luna; ne vedrei tutta la bontà e carità tra la gente, o il sorridente e infaticabile disbrigo degli affari domestici; la dipingerei assieme al figlio della sorella morta, nel loro reciproco amore e nelle ore passate assieme a ricordare i cari così tristemente scomparsi; evocherei innanzi a me, ancora una volta, i piccoli volti gioiosi che si radunavano attorno alle sue ginocchia; sentirei ancora il loro allegro chiacchierio; richiamerei il suono di quel suo riso argentino, e vedrei ancora spuntare la lacrima di tenerezza che le illuminava i dolci occhi azzurri. Questo, e mille altri sguardi e sorrisi, pensieri e parole... ogni singola cosa vorrei di nuovo evocare. Come il signor Brownlow continuasse, giorno dopo giorno, a infondere tesori di conoscenza nella mente del suo figlio adottivo; come gli si affezionasse sempre di più vedendolo crescere e vedendo germogliare in lui i semi di tutto ciò che poteva desiderare; come ritrovasse in lui sempre di nuovo i tratti di quando lo aveva conosciuto e come questi risvegliassero nel suo animo antichi ricordi, malinconici eppure dolci e grati; come i due orfani avessero imparato a volgere le avversità patite in compassione per gli altri, e amore reciproco e fervide preghiere a Colui che li aveva protetti e salvaguardati; son tutte cose, queste, che è inutile raccontare. Ho già detto che erano davvero felici, e la vera felicità non si raggiunge senza solidi affetti, senza bontà di cuore, senza gratitudine verso quell'Essere la cui legge è la pietà e il cui grande attributo è la Benevolenza verso tutto ciò che vive. Vicino all'altare della vecchia chiesetta del villaggio c'è una lapide di marmo con su inscritta una sola parola: "Agnes"! Non c'è bara in quella tomba, e che passino molti, moltissimi anni prima che vi sia iscritto sopra un altro nome! Ma se mai le anime dei morti tornano sulla terra a visitare i luoghi benedetti dall'amore di coloro che conobbero in vita - un amore che vince la morte - allora lo spirito di Agnes certamente s'aggira, di tanto in tanto, per quel luogo solenne; e a maggior ragione lo credo perché esso si trova in una chiesa, e perché lei peccò, perdendosi. David Copperfield Il frontespizio dell’edizione originale di «David Copperfield», 1850. Premessa David Copperfield, ottavo romanzo scritto da Dickens, è pubblicato alla metà precisa di quel secolo, l’Ottocento, di cui costituisce una delle testimonianze più vitali. Fu pubblicato a fascicoli mensili dal maggio del 1849 al novembre del 1850 dagli editori Bradbury and Evans, e corredato - consuetudine per i romanzi dickensiani - delle illustrazioni dell’incisore H.K. Browne (più noto con lo pseudonimo di “Phiz” che egli adottò per corrispondere al “Boz” che fu lo pseudonimo di Charles Dickens). Ma non è solo la simbologia “storica” che fa di David Copperfield un romanzo particolare; anche agli occhi dell’autore, e per più personali motivi, costituisce qualcosa di speciale secondo quanto si legge nella prefazione alla ristampa del 1869 (la “Charles Dickens Edition”): «come tanti genitori amorevoli, anch’io nel profondo del cuore ho un figlio prediletto. Risponde al nome di David Copperfield». Per spiegare perché proprio David Copperfield sia il figlio prediletto dobbiamo guardare alla genesi del romanzo, che si lega ad un periodo di crisi produttiva che investe il periodo intorno alla metà degli anni ’40. Essa si manifesta come disagio avvertito durante un soggiorno in Svizzera, che è parte di un tour (in cui è incluso anche un soggiorno in Italia, sulla costa ligure) intrapreso da Dickens per recuperare il ritmo creativo che gli era stato proprio fino ad allora. Da lì egli scrive al suo amico e biografo J. Forster che gli mancano le strade di Londra, città definita una lanterna magica senza la quale ogni tentativo di scrittura è per lui una «fatica immensa». Uno dei critici dickensiani più acuti, Steven Marcus, ha però mostrato il rapporto strettissimo tra l’esplorazione spaziale che Dickens condusse della metropoli londinese con un più o meno esplicito percorso interiore a ritroso nel tempo. «Per lui lo scrivere era misteriosamente e definitivamente connesso con l’epoca della sua vita in cui egli, solo, vagava letteralmente per la città». La crisi si lega dunque alla esistenza di un nodo irrisolto nel proprio passato, pure continuamente, subliminarmente toccato da tutta l’opera narrativa. Un caso manifesta a Dickens la necessità di tornare con consapevolezza su esperienze cruciali e rimosse della propria infanzia-adolescenza, quali il trasferimento dalla idillica campagna a Londra, la frantumazione della propria famiglia per le difficoltà economiche, il trovarsi solo e sperduto, all’età di undici anni, a Londra, l’incarcerazione del padre, e il visitarlo nel carcere di Marshalsea; e, soprattutto, l’essersi sentito abbandonato dai genitori - nell’ottica del bambino, del tutto ingiustificatamente e crudelmente a un umiliante lavoro in una fabbrica per lucido da scarpe a Hungerford Stairs, sulle sponde di uno squallido e degradante Tamigi, in compagnia di coetanei di cui avverte, risentito, solo la volgarità, frantumate e anzi derise tutte le speranze di “gentility” e distinzione sociale che dapprima era stato incoraggiato a nutrire. C’è un episodio che con brutale casualità fa riaffiorare il nodo più dolente di questo passato: accade infatti che un amico del padre, Charles Wentworth Dilke, accenni a Forster che aveva veduto Dickens ragazzo in quel luogo di lavoro allorché si accompagnò a John Dickens in una visita, e avendogli allora regalato una mezza corona, ricevette in cambio un profondo inchino. Quando Forster chiede conferma a Dickens della veridicità di quell’episodio, si rende conto d’aver «toccato senza volerlo un angolo doloroso della sua memoria». Inizialmente infatti Dickens nega tutto; solo successivamente ammette la conoscenza di Dilke, e solo successivamente ancora, a distanza di giorni, Forster riceve il racconto-confessione di quella fase della sua vita. E ancora: nessun altro tranne Forster viene a conoscenza di quei particolari, non esclusa la moglie, e il frammento autobiografico relativo che Dickens consegna all’amico è pubblicato solo postumo. Ma, a dispetto delle reticenze, queste casuali sollecitazioni della vita invitano e portano Dickens a scandagliare più profondamente il proprio io. Da ciò nasce l’idea di scrivere la propria autobiografia (databile attorno agli anni 1845-6), avviando quella sorta di autoanalisi in cui il ricordo è in funzione di una guarigione, e la scrittura vale per la sua qualità terapeutica. Tuttavia questo progetto rimane poco più che un frammento dell’infanzia, e i blocchi psichici si rivelano essere più di uno, come scrive il biografo E. Johnson: «Dopo essercisi affannato per un certo tempo Dickens trovò che era troppo penoso e l’abbandonò. La parte che tratta della sua infanzia, fino ai giorni della fabbrica di lucido da scarpe e fino ai giorni di scolaro alla Wellington House Academy, egli la dette da leggere a Forster. Ma quando giunse alle umiliazioni del suo disperato amore per Maria Beadnell trovò insopportabile l’idea che qualcun altro oltre a lui la leggesse e non fu capace neanche di proseguire». L’autobiografia interrotta è così l’immediato antecedente del David Copperfield, riconsiderazione fittizia del proprio passato da parte dell’omonimo protagonista, le cui iniziali, come J. Forster fece notare all’allibito autore, invertono quelle del nome e cognome Charles Dickens (e in tal senso, si osservi come per tutto il romanzo c’è un continuo gioco con la lettera “D” e con i nomi, tendente a ribadire che si parla sempre, obliquamente, di Dickens stesso). Vari episodi della vita dell’autore sono quindi più o meno fedelmente trasposti in David Copperfield. Ad esempio, la cruciale esperienza di sfruttamento e umiliazione lavorativa patita dal Dickens alla Warren’s House, rivissuta accentuando lapiccolezza di David e anche la lunghezza del periodo lì trascorso, nei capitoli in cui questo, per volontà del patrigno, è messo a lavorare da Murdstone and Grinby. Quel culmine di infelicità del giovane protagonista è messo pienamente in rilievo dalla narrazione, che mostra quanto egli fosse estraneo persino a sentimenti di solidarietà con gli altri ragazzi con cui si trova a condividere il lavoro. E anzi, non solo non v’è sollievo in un sentimento di amicizia, ma quei compagni sono visti quasi ugualmente colpevoli: colpevoli di trascinarlo in una degradazione, di involgarirne la “gentility”. Totalmente egoistiche dunque le ragioni e le pulsioni del piccolo David e forse perciò totalmente credibili alla luce della psicologia infantile, e totalmente coerenti con le ragioni ultime della narrazione, che traccia il formarsi di uno scrittore: non è un caso che in rapporto ai poveri incolti che gli sono accanto David soffra soprattutto di essere stato sottratto alla scuola e agli amati libri. Questi fattori di credibilità mi pare rendano ingiusto rimproverare a Dickens il non aver messo sulla penna del David maturo nessuna nota di riprovazione per quell’atteggiamento del piccolo David, il non aver affiancato nessuno sguardo maturo a quello dell’infanzia; va pure considerato che sentimenti e convinzioni del genere sono plausibilmente sempre vivi in uno scrittore quanto mai sensibile allo sfruttamento minorile fin da Oliver Twist (1838) e alle condizioni del lavoro in fabbrica in Hard Times (1854) e alle ingiustizie sociali e vuote pretese di distinzione e “gentility” in Grandi Speranze (1860). Vero è anche che già in Oliver Twist Dickens rivive con tale inconscia intensità quell’episodio da attribuire il nome del ragazzo che più degli altri aveva cercato di aiutarlo e difenderlo dalla “gang”, Fagin, al capo e principale sfruttatore della “gang” di piccoli delinquenti dai quali Oliver viene irretito e reso prigione. Altri episodi seguono da vicino la vita di Dickens: il difficile percorso di elevazione sociale e di conquista di un mestiere, l’apprendistato di David nell’ambiente dei Collegi di legge londinesi; l’impiego dagli avvocati Spenlow and Jorkins; l’apprendimento della stenografia per divenire reporter parlamentare e giornalista, inizio della avventura di scrittore. Altri ancora però si presentano notevolmente trasformati. L’improvvido ma generoso carattere paterno, ad esempio, è attribuito al signor Micawber, presso la cui famiglia David va ad alloggiare quando si trova sperduto e solo a Londra. Il periodo di carcerazione del padre e le visite a lui nel londinese carcere per insolventi di Marshalsea si ritrova nella reclusione di Micawber; l’innamoramento per Maria Beadnell e le frustrazioni dell’essere rifiutato dalla famiglia di lei sono trasformate nel rapporto con Dora Spenlow, che egli riesce a conquistare e sposare, ma con cui poi ha un critico ménage familiare, lei incapace di comprendere le aspirazioni del marito e di reggere l’economia domestica. In realtà, dunque, il ricordo autobiografico di Dickens, pur necessario come operazione terapeutica, è subordinato alla dimensione estetica del racconto e alla necessità di risolvere il trauma personale in una dimensione più ampia. Intorno a questi nuclei biografici, a tratti anche profondamente modificati, facendo di Copperfield il centro e il punto di focalizzazione di una intera società, Dickens costruisce una vasta impresa narrativa-rappresentativa. Intorno, e lungo la storia di David, infatti, altre se ne dipartono o vi convergono, spesso appena abbozzate, sviluppabili in altro narrabile, e tali da rimandare a ogni possibile zona dell’esperienza, a ogni possibile tipo umano e sociale. Quanto all’ambiente, che pure spazia dagli idilli di Blunderstone e di Dover, all’Italia in cui si consuma il disonore della piccola Emily, alle romantiche Alpi evocatrici dei grands tours, esso è principalmente, ancora, quello tipico della modernità: la metropoli, Londra, quintessenza del secolo e dello sviluppo borghese. Come affermava Pavese, in questa ambizione totalizzante, l’ottica dickensiana, come quella di Balzac, è profondamente ingenua. Ma l’associazione con Balzac è in parte fuorviante: quell’intento enciclopedico, che nel coevo narratore francese è quasi preludio alla poetica naturalista, è estraneo a Dickens e qui, forse, più che in altre sue opere, poiché tutto è infine subordinato all’unico carattere del protagonista. Più vera è in questo caso la città, proprio perché soltanto accennata, ricordata in particolari non troppo esplicati e che presumono un lettore competente nella geografia urbana, nella “storia” dell’Inghilterra del XIX secolo (Murdstone e Grinby sulle rive del Tamigi, il Monte dei pegni, l’ambiente avvocatesco e dei Collegi di legge, le stanze in affitto, i teatri, la Londra aristocratica, e quella che David attraversa fuggendone, o tornandovi). O per dirla altrimenti, Dickens “implica ” un lettore (moderno) che sia passato attraverso il suo corpus narrativo, e abbia già acquisito le immagini dell’Inghilterra del suo tempo, di Londra e dei suoi “misteri”, mediate dai successivi narratori impersonali. David Copperfield non si attarda su Londra quanto sulle figure che hanno popolato il suo passato, i coprotagonisti della sua storia. Se sezionassimo i passaggi descrittivi, li troveremmo certo in percentuale molto minore, rispetto alle parti dialogate o a quelle narrative, di quanto non accada in altri romanzi. Numerosi personaggi rimangono indelebilmente impressi nella memoria, evocati scenicamente, con taglio di commediografo o drammaturgo, nella cura con cui ne è riportato il modo di enunciare. Il ricordo di David caratterizza qui attraverso il linguaggio, attraverso le peculiarità enunciative e discorsive di ciascun personaggio: il signor Micawber, infatuato delle sue parole e orazioni scritte o declamate, la sua avvedutezza teorica e sprovvedutezza pratica nel campo dell’economia; la zia Betsey Trotwood, irruenta, tagliente, quanto soccorrevole e generosa; Dick, il pazzo che da indicazioni (domestica sibilla) di straordinario e lapalissiano buon senso e fa volare aquiloni di parole sulla scogliera di Dover; la materna e illetterata domestica Peggotty; l’untuoso e ambizioso Uriah Heep votato alla “umbleness” (“umiltà", affettata sopprimendo la “h” iniziale); la ormai proverbiale coppia di avvocati Spenlow and Jorkins, nella loro commedia dei ruoli; il leale compagno di scuola Traddles, e tante altre figure che, pur minori, non sono tuttavia meno memorabili, come la vedova Gummidge, il vetturaio Barkis, il patetico maestro Mell, di Salem House, licenziato perché la madre vive in un pensionato per poveri, il truce Creakle, preside di Salem House, il Dr. Strong, l’avvocato Wickfield, e Omer, impresario di pompe funebri (si ripete qui uno degli episodi più memorabili anche dell’infanzia di Oliver Twist) con l’assistente, partner e poi genero Joram, la cui comicità contempera l’occasione luttuosa in cui David conosce lui e la tristezza del suo mestiere. E poi ancora Mowcher, Crupp, Maldon, Pidger, Sophia, Clarissa... Personaggi tratteggiati - a volte quasi soltanto nominati - con umana simpatia e con straordinaria forza comica, da un David maturo, affezionato e grato al proprio passato e agli altri “eroi” che hanno preso parte alla sua storia. Altri come Ham, Little Emily, Dan, Rosa Dartle (ribelle, come e più di Emily, e perciò singolare e plausibile ritratto di donna) e Steerforth e Littimer, che volgono al melodrammatico, opponendo alla trama comica principale, per cui tutto trova infine una felice o giusta risoluzione, una trama cupa, in cui gli errori si pagano e la morte è irreparabile. Essi, afferma M. Praz, danno vita a una sorta di romanzo nel romanzo. Certo, quanto più memorabili questi personaggi tanto più schematici (Murdstone e sorella, ad esempio, sono una versione dei “cattivi " e basta, senza nessuna articolazione psicologica). Riserve si appuntano oggi su questo tipo di caratterizzazione, che discendono dal valutare Dickens col metro di poetiche che hanno piuttosto badato allo sviluppo interiore del personaggio e che gli sono evidentemente estranee (ma tante - scriveva giustamente Cesare Pavese in un saggio premesso alla sua traduzione del romanzo - sono le strade che conducono alla poesia). Altri lettori e critici, sulle orme di G.K. Chesterton, hanno reso un truismo ormai che del romanzo siano soprattutto straordinari i primi capitoli, dove Dickens «sembra avviato a raccontare la viva verità di un vivo ragazzo e uomo» e dove l’io narrante, che spesso affiora sulla pagina, ricorda sopra tutti il se stesso di un tempo, quasi come fosse un altro personaggio (ma non si tratta solo di un ricordo volontario, per cui il bambino è presentato nelle sue peculiari meraviglie, intuizioni, sofferenze e anche limitatezze dal narratore che sa e che ha già vissuto interamente la sua storia; che, quindi, lo controlla e lo giudica. Si tratta anche di un ricordo che diventa spesso totale immedesimazione nell’io di un tempo, sicché il tono peculiare della narrazione risulta essere quasi un proustiano “rivivere", e la memoria, l’unica e vera, secondo il narratore francese, farsi “involontaria"). In questa ottica, superata la fase infantile, con la nettezza, precisione e verità delle impressioni, la capacità di avvertire con peculiare forza alcuni aspetti delle cose, il romanzo diviene meno interessante. Il personaggio maturo di David che dovrebbe restarne saldamente il centro, è relativamente scialbo, sicché per converso, le figure di contorno assumono sulle loro fragili spalle il peso della narrazione. Tale giudizio limitante non tiene conto però delle peculiarità della scrittura dickensiana, ed è condizionato da una chiave interpretativa autobiografica che a volte non funziona. Vanno infatti esplorate e messe in rilievo, nel discorso obliquo dell’immaginazione, le procedure orchestrative di Dickens. Basti ad esempio vedere in che modo il tema dei rapporti familiari, paradigmaticamente impostato dalla esperienza infantile di David, organizzi e unifichi l’intera narrazione. C’è qualcosa di fondamentale e fondante (le fairy tales significano con pari nettezza), persino di mitico, nel fatto che David nasca orfano di padre, che veda la madre dapprima corteggiata e poi sposa succube del truce Murdstone (grande tema edipico) e, subito morta, lasciarlo in totale balia del patrigno e della arcigna sorella... Al paradiso perduto di Blunderstone, ad un mondo fattosi improvvisamente, prematuramente ostile, si oppone il cottage di Dover dove vive la zia Betsey: qui abbiamo un concentrato di maltrattamenti che i singoli componenti della casa hanno subito all’interno delle rispettive famiglie di provenienza, che cercano riscatto in una comunità di affinità elettive, a contatto con una natura vasta e ariosa. Betsey è li riparata a condurre vita da single dopo che s’è separata da un marito crudele, ma tiene la storia sepolta finché lui non muore. Questo nascosto spiega a posteriori il carattere di lei, apparentemente scontroso e inflessibile; spiega il suo “protofemminismo ”, comicamente esposto quando, saputo dell’imminenza del parto di Clara, si reca a Blunderstone e poi lascia sdegnata la casa perché, al posto della femmina che nelle sue attese sarebbe necessariamente dovuta nascere, nasce invece David; oppure quando, meno capricciosamente, disapprova il matrimonio di David con Dora, cosi come aveva disapprovato il matrimonio del padre di David con una “pupattola ” (e si noti qui, come esempio, quali gerarchie di rapporti il romanzo istituisca al suo interno: nell’ambito della tematica familiare, infatti, ecco che David, nella sua prima scelta matrimoniale, ripete esattamente l’errore paterno e sposa la persona che più ricorda la madre perduta prematuramente). Quanto a Dick, ancora più forte è stato il tormento che ha dovuto patire dalla sua famiglia, culminato nell’esito di follia e nella intenzione di rinchiuderlo in manicomio: evento scongiurato appunto dall’intervento di Betsey. Se perciò il secondo matrimonio di David con l’angelica, devota e assennata Agnes, può infine apparirci edulcorato nella sua stabilità e soddisfazione borghese - versione dell’ideale matrimoniale e femminile che si usa emblematizzare nell’opera L’angelo del focolare del vittoriano Coventry Patmore, quasi che questa fosse la voce rappresentante del secolo - è anche vero che tutto il resto del David Copperfield sembra raccontare altro. È quasi una costante delle famiglie dickensiane il loro essere scombinate, mancanti, disarmoniche e alla base di numerosi rapporti familiari tratteggiati vi sono psicopatologie più o meno nascoste. La casa degli aristocratici Steerforth, ad esempio, condannata in quanto aristocratica, ci rappresenta uno smodato amore materno per il figlio che favorisce, se non determina, la tragica fine di lui. È lo sfregio sulla guancia della parente che convive con madre e figlio, Rosa Dartle, nell’ambiguo ruolo di sorella e figlia acquisita e di mantenuta, testimonia di un odio sepolto, sempre vivo, per il giovane che gliel’ha procurato in una esplosione di irritazione e violenza. Sul versante opposto della scala sociale, il povero e ambizioso Uriah è limitato al rapporto esclusivo con la madre. Questa volta è il figlio che è quasi incestuosamente devoto, sicché sterile e presuntuoso risulta il suo ambire ad Agnes; e vittorianamente incestuoso è il legame di Murdstone con la sorella, di puritano utilitarismo che spiega il tipo di rapporto che egli istituisce con la giovane madre di David: si passa dall’uno all’altro, in un deterministico trasferirsi di una patologia precedente ad un’altra seguente: poco angelici questi focolari domestici. L’autobiografia fittizia di David Copperfield è dunque più che mai un romanzo orchestrato, di cui va colta la molteplicità dei rapporti interni. A questa legge non sfugge neanche il personaggio principale, che tutto sembra condizionare e a sé subordinare. Una ulteriore prova di ciò va colta proprio in rapporto alla narrazione che il protagonista fa di sé in quanto scrittore. David Copperfield è infatti uno straordinario «romanzo dell’artista» e si collega da un lato al Prelude di W. Wordsworth, il cui sottotitolo potrebbe in certi limiti riadottare, fatta salva una necessaria variazione, in «The growth of a novelist’s mind»; dall’altro, per l’alta considerazione che ha dello scrittore borghese, a T. Carlyle, alla visione dello scrittore come “eroe” (a Carlyle Dickens dedica un suo romanzo, Hard Times). Se, con peculiare nota, rievocando la sua formazione, David ci si presenta anche sotto il più pedestre e vittoriano aspetto del selfmade man, l’uomo che si è fatto da sé, che si è elevato nella società, e attraverso la letteratura ha riconquistato in essa un posto, una “gentility”, originariamente posseduta (non è perciò il ritratto di artista cui ci hanno abituato i romanzi del Novecento), l’infanzia del protagonista, e la sua prima educazione, propongono un rapporto quanto mai originale e vivido di David con la scrittura. Basti in tal senso riandare al primo confronto con l’alfabeto: «Posso persino debolmente ricordare quando imparavo le lettere dell’alfabeto sulle sue [della madre] ginocchia. Ancora oggi, quando guardo le lettere grosse e nere del sillabario, la divertente novità delle loro forme e la bonarietà della O, della Q e della S, mi si ripresentano alla mente come allora» (IV, p. 75); o al ribaltarsi della prima fascinazione delle lettere in angoscia quando l’educazione è quella coercitiva del patrigno Murdstone e di sua sorella: «le parole che con infinita fatica ho infilate nella mia testa, cominciano a scivolar via, e ad andarsene non so dove» (ibidem); o alle solitarie, ardenti letture in un ambiente domestico intristito, in una stanzetta al piano superiore della casa (episodio che ripete vicende analoghe nella biografia dickensiana): «Roderick Random, Peregrine Pickle, Humphrey Clinker, Tom Jones, il Vicario di Wakefield, Don Chisciotte, Gil Blas e Robinson Crusoe, uscirono - una corte gloriosa - per tenermi compagnia» (IV, p. 77), e sentendo i coetanei giocare fuori, «io seduto sul letto, leggendo come se si fosse trattato d’una questione di vita o di morte» (IV, p. 78); sono solo i primi tratti del filo rosso tematico sulla scrittura legato specialmente al personaggio David. Ad un giudizio che scorge nel David maturo un personaggio scialbo si deve perciò opporre la sorprendente diramazione degli atti e modelli di scrittura che riflettono da particolari angolazioni sull’attività di David, la arricchiscono e la variano, secondo quella che giustamente è stata definita procedura contrastiva della scrittura dickensiana. Numerosi altri personaggi scrivono “autobiograficamente " in David Copperfield. Iniziamo da Uriah Heep, non a caso una sorta di “alter ego" di David per altri aspetti. Uriah è infatti l’oggettivazione di impulsi che David non vuole ammettere, e di pretese di avanzamento sociale condannate in quel “pariah" e ambiguamente giustificate nel solo protagonista. Indicativo, soprattutto, l’ambire di Heep alla mano della figlia del suo datore di lavoro, Agnes Wickfield (David con Dora Spenlow fa esattamente la stessa cosa: e peraltro, quando David colpisce Uriah per punirlo di tali pretese, denuncia nel contatto fisico una «odiosa complicità» con lui). Il desiderio di scalata sociale, e una strategia di finzione per raggiungere tale obiettivo si associano a un rapporto di Heep con la scrittura che mette evidentemente David (Dickens) in guardia da un’altra particolare scissione: quella tra i suoi falsi libri contabili pubblici e i “real memoranda", su cui egli registra, solo per sé, le tracce degli inganni perpetrati ai danni di Wickfield. Lo stesso discorso vale per il processo di apprendimento, da autodidatta, e di lettura. Quello di Heep è caratterizzato come ripugnante, eppure egli adotta la stessa strategia di studio e di lavoro di David. David lo coglie a lume di candela, nel piccolo ufficio, e ne è perciò come affascinato e disgustato insieme: «leggeva un grosso librone, con una tale accanita attenzione che il suo indice ossuto seguiva riga per riga durante la lettura lasciando una traccia umida sulla pagina (o così credevo), come una lumaca». Importante perciò anche il momento dello smascheramento finale di Heep, oggettivazione delle paure di David di vedere derise e smascherate le sue proprie aspirazioni alla “gentility" (si veda come sia sempre a disagio e intimorito da Littimer, il maggiordomocomplice dell’aristocratico Steerforth). Insomma, Heep mette David di fronte ai segni ancora indecifrati della propria ambiguità, e ai nodi problematici del proprio mestiere, della propria scrittura. Quei “personal memoranda" evidentemente «non intesi per la pubblicazione» hanno un parallelo nel frammento autobiografico di Dickens, così come i registri pubblici falsificati lo hanno con la deriva fantastica, con la trasposizione immaginativa, la “oratio obliqua” del David Copperfield, e sottolineano l’esigenza di raccordare pubblico e privato, interiorità ed esteriorità. Micawber è un ulteriore esempio nella serie di variazioni paradigmatiche sul tema della scrittura. Come sottolinea Alan Horsman, «Il più grande dei personaggi per cui il David Copperfield è famoso emerge da questo interesse per l’artista. Micawber ha il suo completo trionfo nell’immaginazione, sotto l’influsso delle parole». Micawber vive del suo piacere di fare discorsi e poi, spostatosi in Australia, di scrivere lettere, «gioiosa parodia, equivalente ad una celebrazione, della natura dell’artista che lotta per esser libero e che, a suo modo, riesce». Micawber anche vuole liberarsi con le parole dalle ansie della vita quotidiana, evadere da una realtà spiacevole di povertà e sotterfugi trascendendola linguisticamente. Il principio di realtà fa difetto anche a questo fanciullo nell’uomo. Come Heep, Micawber attende ad un progetto di avanzamento sociale, vago e fallimentare il più delle volte, fiducioso comunque che «qualcosa verrà fuori». Ma la sua fiducia in un futuro migliore lo mette al riparo da errori irrimediabili, finché è coronata da successo nella sua nuova vita «disciplinata» della colonia australiana. Ciò che fa di lui uno specchio rivelatore, è che la sua scrittura, dopo quella di David, ha l’estensione più ampia all’interno della narrazione principale. Le sue lettere, cui vanno aggiunte quelle della moglie, sono collegabili in una sorta di romanzo epistolare. Ma, all’esatto opposto della visione retrospettiva di David, le lettere di Micawber sono tutte versate nel presente. Quanto all’aspetto di autoriflessione (egli compie a suo modo un’operazione autoanalitica e autorappresentativa), va notato un ulteriore legame di parentela con la scrittura di David, giacché le lettere di Micawber mettono in campo una “dislocazione” simile a quella che ha luogo nella narrazione principale. Micawber si riferisce a se stesso in terza persona, con «egli» obbiettivandosi in immagine deformata rispetto alla realtà; e mentre, in particolare, lo sguardo di David vede nel suo proprio «egli» di volta in volta un essere fragile, indifeso, ingenuo, che incorre in errori a non finire, degno di commiserazione e rimpiccolito, Micawber ingrandisce ed eroizza se stesso alle prese con le immani difficoltà della sopravvivenza economica. D’altra parte, la scrittura di Micawber si propone come assoluta diseconomicità e sperpero di parole. Diviene perciò immagine di fallimento possibile per David, e funziona da monito a trovare un’economia della circolazione sociale del discorso che lo renda vendibile. Ciò implica anche la ricerca di “misura ” espressiva, come può vedersi dall’aperto contrasto tra l’epopea eroico-martirologica che Micawber disegna per sé e la prudenza con cui David mette in questione sia la sua centralità di personaggio, sia la sua statura eroica fin dalla prima frase della sua narrazione: «Queste pagine diranno se sono proprio io l’eroe della mia vita o se questo posto tocca a qualcun altro» (I, p. 29). Accanto alla retorica di Micawber è poi da collocare quella di un’altra scrittrice, Miss Mills, del cui diario sono direttamente riportate pagine all’interno della narrazione principale. Scrittura autobiografica in presa diretta sebbene il diario (come il personaggio) abbia un’importanza ridotta in termini di plot rispetto a Micawber e alla sua scrittura. Ciò che la associa alla retorica di Micawber è uno stesso tipo di copertura del reale, e di soddisfazione del desiderio nella parola. Miss Mills, che funge da intermediaria nel corteggiamento di David a Dora, anela ad un rapporto sentimentale e matrimoniale. Tale desiderio, che resta insoddisfatto nella realtà, trova compenso nel dialogo con se stessa che ella inscena nel diario, e nella romanticizzazione della propria figura. David comunque fa uso - plausibilmente ironico - del modello retorico in esame riferendosi a Dora in quanto «saldezza e àncora della mia navicella sballottata dai flutti» nel suo viaggio sul «mare della confusione»; e attraverso lei e il suo gioco di segretezza con la lettera “D”, a indicare l’amica Dora, rafforza l’insistito rimandare di quella lettera al Dickens stesso. Due altri personaggi offrono ancora variazioni del tema della scrittura, e cioè il Dr. Strong e Dick. Essi si rapportano direttamente a David; il primo, suo istitutore del periodo di Dover; il secondo, figura paterna vicaria sotto lo stesso tetto di Betsey Trotwood e lontano parente. Curiosamente, la data della rivoluzione inglese del 1649 unisce i due personaggi: al ritmo lento e sincopato della compilazione del dizionario del Dr. Strong, viene infatti calcolato che l’opera sarebbe stata completata in 1649 anni; e il memoriale di Dick non riesce ad andare avanti per l’ossessivo ritorno dell’immagine della testa decapitata di Carlo primo. Il Dr. Strong entra in rapporto con David Copperfield (con l’autore) senz’altro, attraverso le allusioni alfabetiche, in quanto il suo dizionario, quando ne vediamo rilevato per sempre lo stato di avanzamento, è fermo alla lettera “D”. Ma il Dr. Strong è innanzi tutto una parodia, è la figura comica del pedagogo e dell’erudito. L’assenza di disciplina nel lavoro lessicografico, per lo meno, si oppone alla dedizione assoluta di David al proprio lavoro di scrittura. Non è un caso se una significativa accelerazione del ritmo di compilazione si ha solo in concomitanza con l’arrivo di David. Corollario di tale dilettantismo, e altro indice di disvalore che David dovrà imparare ad evitare, è la confusione delle carte, l’assenza di un ordine o di un metodo. Il distacco dalla realtà di Miss Mills e di Micawber è caratteristico anche del Dr. Strong, la cui perenne distrazione e pensosità è attribuibile «al fatto che era sempre occupato a cercare radici greche; il che, nella mia ingenuità e ignoranza, supposi essere una specie di furore botanico del dottore, specie perché egli guardava sempre per terra quando passeggiava, finche appresi che si trattava di radici di parole» (cap XVI, p. 238). Tale spiegazione sottolinea un ulteriore punto di contatto con David, poiché anche la scrittura del Dr. Strong ha a suo modo a che fare col passato: è una ricerca di radici, sebbene in senso filologico. Pertanto, ad un David che improvvisamente deve ridisegnare il suo futuro scoprendosi “povero ”, il soccorso del Dr. Strong giunge come offerta di collaborare al dizionario anche se, in seconda istanza, è lo stesso lessicografo a scorgerne i limiti formativi per l’allievo. In aggiunta, nel coadiuvare alla compilazione del dizionario, a David si offre una ulteriore immagine polarizzata di sé in Jack Maldon, segretario del Doctor e seduttore della moglie del lessicografo. David osserva che: «le sue carte erano un poco in disordine, dato che mr. Jack Maldon aveva ultimamente offerto i suoi servigi occasionali di amanuense» (XXXVI, p. 491); e che questi «non s’era limitato a fare numerosi errori, ma aveva altresì, disegnato tanti soldati e tante teste di donna, sul manoscritto del dottore che spesso mi trovai sperso in labirinti di oscurità» (ibidem). Questo “villain”, nel paradigma di Steerforth o Heep come attentatore dell’onore femminile, è contestualmente anche un villain della parola. E veniamo infine a Dick, un personaggio che si richiama alla tradizione letteraria del folsage. Dick rinvia a David per le iniziali, ma più direttamente a Dickens perché il suo nome abbrevia il cognome dell’autore, mentre al nome Charles rinvia attraverso l’ossessiva immagine del re decapitato Carlo primo che continua a interrompere la redazione della sua “autobiografia”. La testa decapitata di Carlo e la figura della follia di Dick, personaggio che offre quindi una quanto mai interessante variante di scrittura memoriale, giacché essa costituisce una sorta di “painkiller”, di terapia della follia, e questa è caratteristicamente originata nella colpevole negligenza parentale o della famiglia: «È un memoriale sulla sua storia, che sta scrivendo zia?» «Sì, bambino», disse mia zia, stropicciandosi di nuovo il naso. «È un memoriale al Lord Cancelliere, o al Lord Qualcosa o Qualcosaltro... uno di quelli, insomma, che sono pagati per ricevere memoriali... sulle sue faccende. Suppongo che lo spedirà, uno di questi giorni. Finora non e stato capace di stenderlo senza introdurvi quel modo di esprimersi; ma ciò non significa nulla: lo tiene occupato» (XIV, p. 209). Va notato poi che, in linea con l’autobiografia di Dickens e col dizionario del Dr. Strong, il memoriale va fatalmente in stallo, e non riesce a superare il punto di frattura; finché, finalmente, la scrittura come terapia prende a funzionare e Dick, guidato da David, recupera equilibrio personale e utilità sociale. Gli basta, appunto, allontanarsi dalla “lettera ” del memoriale per scrivere di qualcos’altro da sé: Su un tavolo accanto alla finestra a Buckingham Street ponemmo il lavoro che Traddles gli procurava - che consisteva nel fare non ricordo quante copie di un documento legale sul diritto di passaggio - e su un altro tavolo spiegammo l’ultimo incompleto originale del grande memoriale. Ammonimmo mr. Dick che doveva copiare esattamente cio che aveva davanti a se, senza mai discostarsi dall’originale; e che quando sentiva la necessita di fare la piu piccola allusione a re Carlo primo, doveva rivolgersi al memoriale (XXXVI, p. 495). Come Dickens, dunque, Dick supera in qualche modo il blocco che impedisce il confronto col proprio passato nella scrittura: lo rimuove spostando il proprio lavoro in un’altra scrittura, oggettivata eppure emblematicamente, indissolubilmente vicina, sul tavolo di lavoro, a quella memorialistica. MARIO MARTINO Prefazione dell’Autore Rilevai, nella prefazione originale a questo libro, che non mi riusciva facile allontanarmi abbastanza da esso, appena dopo averlo terminato, per giudicarlo con il distacco che questa formale presentazione richiederebbe. Il mio interesse ad esso era così recente e così forte, e la mia mente era così divisa tra il piacere e il rimpianto - il piacere di avere realizzato un lungo progetto, rimpianto per la separazione da tanti amici - che rischiavo di annoiare il lettore con confidenze personali ed emozioni private. A parte ciò, tutto quello che posso dire su questa storia, in ogni modo, ho cercato di dirlo in essa. Forse interesserebbe poco al lettore sapere come a malincuore si deponga la penna dopo due anni di lavoro di immaginazione; o che un Autore ha la sensazione di avere abbandonato una parte di sé in un mondo di ombre, quando una folla di creature del suo cervello si allontana da lui per sempre. Così, non ho null’altro da dire, sebbene, invece, debba confessare (il che deve essere anche meno importante) che nessuno potrà mai credere in questo racconto nel leggerlo più di quanto ci abbia creduto io nello scriverlo. Così sincere sono queste dichiarazioni, oggi, che posso ora solo fare al lettore un’altra confidenza. Di tutti i miei libri, quello che più amo è questo. Si potrà credere facilmente che sono un padre amoroso per ogni figlio della mia fantasia, e che nessuno può amare questa famiglia più teneramente di quanto l’ami io. Ma, come molti genitori amorosi, ho nel cuore del mio cuore un figlio preferito. E il suo nome è David Copperfield. Londra, «la moderna Babilonia», mappa disegnata da Chris Barlow. I. Sono nato Queste pagine diranno se sono proprio io l’eroe della mia vita o se questo posto tocca a qualcun altro. Per cominciare dall’inizio la mia storia, registrerò qui il fatto che nacqui (come mi dissero e come credo) di venerdì, a mezzanotte. Venne notato che l’orologio cominciò a suonare e io a piangere, simultaneamente. In considerazione del giorno e dell’ora della mia venuta al mondo la levatrice ed alcune sagge comari nostre vicine, che si erano interessate vivamente di me parecchi mesi prima che potessimo conoscerci di persona, dichiararono che, in primo luogo, ero destinato ad una vita infelice; secondo, che avrei avuto il privilegio di vedere spiriti e fantasmi: essendo queste capacità, secondo la loro opinione, inevitabilmente collegate agli infelici bambini d’ambo i sessi nati nelle ore piccole di una notte di venerdì. Non ho bisogno di dir nulla sul primo punto, perché nulla più della mia stessa storia può dimostrare se questa predizione venne poi più o meno verificata dai fatti. Per quanto riguarda la seconda questione, voglio solo notare che, salvo che non abbia usufruito di questa parte della mia eredità quando ero ancora in fasce, non l’ho ancora ricevuta. Ma non è che sia molto spiacente di essere privato di questa proprietà: e se qualcuno ne sta godendo al posto mio, gliela cedo di tutto cuore. Nacqui con una cuffia1 che venne offerta in vendita, attraverso il giornale, al modico prezzo di quindici ghinee. Non so se i marinai fossero in quel periodo a corto di denaro o di fede, preferendo perciò cinture di salvataggio. Ciò che so è che vi fu una sola offerta, da parte d’un procuratore interessato in affari di cambio, che offrì due sterline in contanti e il rimanente in sherry, ma rifiutò di garantirsi dall’annegamento per un prezzo più elevato. Perciò l’avviso venne ritirato in pura perdita (perché quanto allo sherry, la mia povera cara mamma stava cercando a sua volta di vendere il suo) e dieci anni dopo la mia cuffia venne messa in una riffa che si tenne dalle nostre parti, tra cinquanta membri, a mezza corona a testa, il vincitore essendo obbligato a sborsare altri cinque scellini. Ero io stesso presente, e ricordo di essermi sentito piuttosto imbarazzato e confuso nel vedere disporre in tal modo di una parte di me. La cuffia fu vinta, ricordo, da una vecchia signora con un manicotto, dal quale, con molta riluttanza, estrasse i cinque scellini pattuiti, tutti in mezzi penny, e consegnando due penny e mezzo in meno. Venne spesa invano una grande quantità di tempo ed un notevole sforzo aritmetico venne prodotto nel vano tentativo di provarglielo. Fu ricordato a lungo, da quelle parti, che ella non annegò mai, anzi morì trionfalmente nel proprio letto, a novantadue anni. Ho sentito dire che fino all’ultimo ella era orgogliosissima di non essere mai stata sull’acqua, tranne che attraversando un ponte, e che, bevendo il suo tè (a cui teneva molto) fino all’ultimo era solita esprimere la sua indignazione per l’empietà dei marinai e di chiunque avesse l’audacia di andare «vagabondando» per il mondo. Invano mai le si faceva notare che alcune cose utili, compreso probabilmente il suo tè, erano dovute a questa discutibile pratica. Ogni volta replicava, con grande enfasi e con una istintiva fiducia nella forza della sua obiezione: «Non vagabondiamo!». Per non vagabondare a mia volta, tornerò alla mia nascita. Sono nato a Blunderstone, nel Suffolk, o «da quelle parti», come si dice in Scozia. Ero un figlio postumo. Gli occhi di mio padre si erano chiusi alla luce di questo mondo sei mesi prima che io aprissi i miei. Ancora adesso mi sembra strano il pensiero che non mi vide mai; e v’è qualcosa di ancora più strano nell’oscuro ricordo che ho dei miei primi puerili pensieri sulla sua bianca pietra tombale, nel cimitero della chiesa, e della indefinibile compassione che sentivo per il suo giacere solo nell’oscura notte, quando il nostro salottino era caldo e luminoso per il fuoco, e per le candele, e le porte di casa erano - a volte mi sembrava quasi con crudeltà - chiuse e sprangate, ad escluderlo. Una zia di mio padre, e quindi una mia prozia, della quale parlerò più estesamente in seguito, era il personaggio principale della nostra famiglia. Miss Trotwood, o miss Betsey, come la chiamava la mia povera madre quando vinceva abbastanza il suo timore reverenziale verso questo formidabile personaggio da nominarlo (il che accadeva di rado), era stata sposata ad un marito più giovane di lei, che era molto bello, tranne che nel senso indicato dal familiare adagio: «È bello colui il cui agire è bello». Perché v’e- rano forti sospetti che avesse picchiato spesso miss Betsey, e anche che una volta, durante una disputa per una questione d’interesse, avesse fatto frettolosi ma energici tentativi di lanciarla da una finestra, al secondo piano. L’evidente incompatibilità di carattere indusse miss Betsey a dargli dei quattrini per ottenere una separazione consensuale. Lui si recò in India col suo gruzzolo e qui, secondo una singolare leggenda di famiglia, fu visto una volta cavalcare un elefante insieme ad un babuino: ma io penso piuttosto che si trattasse d’un Babu o di una Begun2. Ad ogni modo, dopo dieci anni giunse dall’india notizia della sua morte. Nessuno sa che effetto facesse su mia zia; perché subito dopo la separazione ella aveva ripreso il suo nome di ragazza, acquistato un villino in un villaggio sul mare piuttosto remoto, e vi si era stabilita avendo con sé solo una donna come domestica. Si diceva che vi vivesse come una reclusa, in un inflessibile ritiro. Mio padre era stato una volta il suo preferito, credo. Ma essa era rimasta mortalmente offesa dal suo matrimonio, nella convinzione che mia madre non fosse altro che una «bambola di cera». Non l’aveva mai vista, ma sapeva che non aveva ancora vent’an- ni. Da allora mio padre e miss Betsey non si erano più incontrati. Mio padre aveva il doppio dell’età di mia madre, ed era di salute delicata. Morì un anno dopo, come dissi, sei mesi prima ch’io venissi al mondo. Così stavano le cose il pomeriggio di quel venerdì che potrò essere perdonato se chiamo un venerdì importante e ricco di eventi. Ovviamente io non potevo sapere, allora, come stavano le cose, né ho alcun ricordo, fondato sulla evidenza dei sensi, di ciò che accadde. Mia madre sedeva accanto al fuoco, piuttosto malandata e molto depressa, con gli occhi velati dalle lacrime, chiedendosi cosa sarebbe stato di lei e di quel piccolo estraneo orfano, la cui prossima venuta in un mondo che non sarebbe stato per niente emozionato dal suo arrivo era già annunziata da alcune dozzine di profetiche spille da balia al piano di sopra; mia madre, dicevo, sedeva al fuoco in quel limpido e ventoso pomeriggio di marzo, triste e spaventata, dubbiosa d’uscir viva dalla prova che l’attendeva, quando alzando gli occhi per asciugarli scorse una strana signora che attraversava il giardino. Alla seconda occhiata mia madre fu sicura che si trattava di miss Betsey. Il sole al tramonto illuminava, al di là della siepe del giardino, la strana donna, ed essa avanzava verso la porta con un piglio così rigido e pieno di contegno che non avrebbe potuto essere scambiata con nessun’altra. Quando raggiunse la casa diede un’altra prova della sua identità. Mio padre aveva spesso affermato che raramente essa si comportava come un qualsiasi cristiano; ed ora, invece di bussare, si avvicinò e guardò dentro, proprio da quella finestra, premendo con tanta forza contro il vetro la punta del naso che mia madre soleva dire che l’aveva vista diventare perfettamente schiacciata e bianca. Diede così un tale scossone a mia madre, che sono stato sempre convinto di dovere a miss Betsey l’essere nato di venerdì. Mia madre, agitata, aveva lasciato la sua poltrona e si era rifugiata in un angolo. Miss Betsey volse lo sguardo in giro per la stanza, lentamente e inquisitivamente, cominciando dalla parte opposta e girando gli occhi come una testa di Saraceno in un orologio olandese, finché raggiunse mia madre. Allora aggrottò le sopracciglia e fece cenno a mia madre, come una abituata ad essere obbedita, di avvicinarsi ed aprirle la porta. Mia madre eseguì. «Mrs. David Copperfield, credo», disse miss Betsey, con una sottolineatura che forse si riferiva agli abiti da lutto e alle condizioni di mia madre. «Sì», rispose questa debolmente. «Miss Trotwood», disse la nuova venuta, «ne avete sentito parlare, direi?». Mia madre rispose che aveva avuto quel piacere, ma con la spiacevole coscienza che la frase non sembrava implicare che s’era trattato d’un piacere molto grande. «Ora la vedete», affermò miss Betsey. Mia madre chinò la testa e la pregò di accomodarsi dentro. Entrarono nel salottino da dove era uscita mia madre, perché il fuoco non era acceso nel salotto buono, dall’altra parte del corridoio: non era stato acceso dal giorno dei funerali di mio padre. Quando si furono sedute, miss Betsey in silenzio, mia madre, dopo avere tentato invano in tutti i modi di trattenersi, scoppiò in lacrime. «Oh, no, no, no», esclamò in fretta miss Betsey, «non fate così! Su, su...». Ma mia madre non riusciva a dominarsi, e pianse finché ebbe da piangere. «Levatevi la cuffia, piccola», ordinò miss Betsey, «e lasciatevi vedere». Mia madre era troppo intimorita per sottrarsi a questa singolare richiesta, se pure ne avesse avuto voglia. Fece perciò come l’altra le aveva ordinato, e con gesti così incerti che i capelli (che erano folti e bellissimi) le ricaddero sul volto. «Diamine, Dio mi benedica», commentò miss Betsey, «siete proprio una bambina!». Mia madre aveva senza dubbio un aspetto eccezionalmente giovanile anche per la sua età. Abbassò il capo, come se si trattasse d’una colpa, poverina, e disse, singhiozzando, che temeva infatti di essere una vedova assai puerile, e che se fosse sopravvissuta sarebbe stata una mamma puerile. Nella breve pausa che seguì, le parve che miss Betsey le sfiorasse i capelli, e con mano non priva di gentilezza, ma rialzando lo sguardo con timida speranza, vide che la signora sedeva con la sottana rimboccata, le mani intrecciate sulle ginocchia e i piedi sugli alari, fissando severamente il fuoco. «In nome del Cielo», esclamò improvvisamente miss Betsey, «perché Rookery?»3 «Vuol dire la casa, signora?», chiese mia madre. «Perché Rookery?», continuò miss Betsey. «Cookery4 sarebbe stato più adatto allo scopo, se voi altri, tutti e due, aveste avuto una idea pratica della vita». «Il nome fu scelto da mr. Copperfield», replicò mia madre, «quando comprò la casa, gli piaceva immaginare che vi fossero delle cornacchie qui attorno». Il vento della sera sibilò forte, proprio allora, fra alcuni vecchi e alti olmi in fondo al giardino, così forte che né mia madre né miss Betsey potettero trattenersi dal guardare in quella direzione. Gli olmi si curvavano l’un verso l’altro, come giganti che si sussurrano segreti, e dopo qualche attimo cominciarono ad agitarsi violentemente, sbattendo i loro lunghi rami, quasi che le confidenze ricevute fossero troppo amare per la pace del loro animo, e i rami più alti apparvero carichi di vecchi nidi di cornacchie, sbattuti dal vento, oscillanti come battelli naufragati in una tempesta. «Dove sono gli uccelli?», chiese miss Betsey. «Gli...», mia madre stava pensando ad altro. «Le cornacchie. Che è accaduto di loro?», domandò miss Betsey. «Non vi sono mai state, da che abitiamo qui», rispose mia madre. «Noi pensavamo... Mr. Copperfield pensava... che vi doveva essere una grossa colonia di cornacchie: ma i nidi erano molto vecchi, gli uccelli li hanno abbandonati da parecchio». «Tutto David Copperfield!», gridò miss Betsey. «David Copperfield dalla testa ai piedi! Chiamare una casa “cornacchiaio” quando non c’è una sola cornacchia nei dintorni, ed avere fiducia negli uccelli solo perché ha visto i nidi!». «Mr. Copperfield», replicò mia madre, «è morto, e se voi osate parlarne scortesemente...». La mia povera mamma, credo, aveva qualche momentanea intenzione di assalire e picchiare mia zia, che avrebbe potuto respingerla con una sola mano anche se mia madre fosse stata ben più preparata ad un simile scontro di quanto non fosse quel pomeriggio. Ma la sua azione si limitò a sollevarsi dalla poltrona; poi ricadde giù molto docilmente e svenne. Quando rinvenne, o quando miss Betsey la fece rinvenire, comunque fosse, la scorse ritta davanti la finestra. Il crepuscolo in quel momento scivolava verso l’oscurità, e si scorgevano indistintamente l’un l’altra solo per il fioco bagliore del fuoco. «Bene?», domandò miss Betsey, tornando alla sua poltrona come se avesse solo dato una occhiata casuale al panorama. «E per quando aspettate...». «Tremo tutta», balbettò mia madre, «non so cosa sia. Sto per morire, ne sono sicura...». «No, no, no», disse miss Betsey, «prendete del tè». «Povera me, povera me, pensate che mi farà bene?», pianse desolatamente mia madre. «Certamente», affermò miss Betsey, «non è che una fantasia. Come chiamate la ragazza?» «Non so ancora se sarà una ragazza, signora», rispose innocentemente mia madre. «Benedetta creatura!», esclamò miss Betsey, involontariamente citando la seconda sentenza ricamata sull’appuntaspilli nel cassettone al piano di sopra, ma applicandola a mia madre invece che a me. «Non volevo dir questo. Intendevo la vostra domestica». «Peggotty», disse mia madre. «Peggotty!», ripetè indignata miss Betsey. «Volete dire, bambina, che esiste un essere umano ch’è entrato in una chiesa cristiana e s’è dato il nome di Peggotty?» «Èil suo cognome», spiegò fievolmente mia madre: «mr. Copperfield la chiamava così, perchè il suo nome di battesimo è lo stesso del mio». «Qui, Peggotty!», gridò miss Betsey, aprendo la porta del salotto. «Tè. La tua padrona non sta bene. Non bighellonare!». Avendo lanciato il comando con tanta energia come se fosse stata una autorità riconosciuta in casa fin da quando questa era una casa, ed avendo squadrato la stupefatta Peggotty, che attraversava il corridoio con una candela al suono di quella voce sconosciuta, miss Betsey chiuse di nuovo la porta e sedette come prima: i piedi sugli alari, la sottana tirata su e le mani intrecciate sulle ginocchia. «Parlavate d’una ragazza», disse poi: «io sono sicura che si tratta d’una bambina. Ho il presentimento che debba essere una bambina. Ora, piccola, dal momento della nascita di questa bambina...». «Forse sarà un bambino», osò interferire mia madre. «V’ho detto che ho il presentimento che si tratti d’una bambina», replicò miss Betsey, «non contradditemi. Dal momento della nascita di questa bambina, piccola, io voglio essere sua amica. Intendo farle da madrina, e vi prego di chiamarla Betsey Trotwood Copperfield. Non vi saranno errori, nella vita di questa Betsey. Nessuno scherzerà coi suoi sentimenti, povera cosetta. Dovrà crescere bene ed essere ben guardata dal riporre una sciocca fiducia dove non la si merita. Questo sarà mio compito». La testa di miss Betsey si muoveva, ad ognuna di queste affermazioni, come se le sue vecchie delusioni si destassero, e si sforzassero di reprimere con forza ogni più aperto riferimento. Così sospettava, almeno, mia madre, osservandola al fioco bagliore del fuoco: troppo spaventata da miss Betsey, troppo infelice ella stessa e sgomenta insieme per osservare con maggiore chiarezza ogni cosa o per sapere cosa dire. «E David era buono con voi, piccola?», chiese miss Betsey, dopo un breve silenzio e quando quel moto della sua testa fu cessato. «Stavate bene insieme?» «Eravamo molto felici», mormorò mia madre, «mr. Copperfield era fin troppo buono con me». «Ah, vi viziava, immagino?», domandò miss Betsey. «Ho paura di sì... per poi lasciarmi sola sola e affidata a me stessa, in questo duro mondo», singhiozzò mia madre. «Bene, non piangete», disse miss Betsey: «non eravate ben assortiti (se mai due persone possono essere ben assortite) e perciò ve l’ho chiesto. Voi eravate orfana, vero?» «Sì». «E facevate la governante?» «Ero bambinaia in una famiglia che mr. Copperfield frequentava. Mr. Copperfield fu molto gentile con me, mi chiese tante cose di me, mi rivolse molte attenzioni. E alla fine mi si offrì. E io l’accettai. E così ci sposammo», spiegò con semplicità mia madre. «Ah! povera bambina!», mormorò miss Betsey, guardando sempre aggrottata il fuoco. «Cosa sapete voi?» «Chiedo scusa, signora...», balbettò mia madre. «Per dirigere la casa, ad esempio», disse miss Betsey. «Non molto, temo», replicò mia madre. «Non tanto come vorrei. Ma mr. Copperfield mi stava insegnando». «Ne sapeva molto lui stesso», borbottò tra parentesi miss Betsey. «E speravo di migliorare, desideravo tanto imparare, e lui era molto paziente a spiegarmi, se la grande sventura della sua morte...», mia madre si interruppe e non riuscì a proseguire. «Bene, bene», disse miss Betsey. «Tenevo regolarmente il libro dei conti, e facevo il bilancio tutte le sere con mr. Copperfield», pianse mia madre in una nuova esplosione di dolore, interrompendosi di nuovo. «Basta, basta», disse miss Betsey, «non piangete più». «E sono sicura che non abbiamo mai avuto divergenze su ciò, tranne quando mr. Copperfield criticava i miei tre e cinque, che si somigliavano troppo, o perché mettevo le codine arricciate ai sette e ai nove», rievocò mia madre con un altro scoppio di singhiozzi, interrompendosi ancora una volta. «Vi farà male, così», osservò miss Betsey, «e voi sapete che questo non è giusto per voi né per la mia figlioccia. Su! Non fate così!». Questo argomento ebbe qualche effetto nel calmare mia madre, sebbene il suo crescente malessere avesse forse una causa ben maggiore. Vi fu una pausa di silenzio, rotta solo dagli «Ah!» che miss Betsey ogni tanto emetteva, sempre seduta coi piedi sugli alari. «David aveva investito i suoi denari nell’acquisto di una rendita, a quanto so», chiese poi. «Che ha fatto per voi?» «Mr. Copperfield», rispose con qualche difficoltà mia madre, «è stato così saggio e buono da assicurarmi la reversione di una parte della sua rendita...». «Quanto?», domandò miss Betsey. «Centocinque sterline all’anno», rispose mia madre. «Avrebbe potuto far peggio», osservò mia zia. La parola «peggio» era adatta al momento. Mia madre stava tanto peggio che Peggotty, entrando col vassoio del tè e con le candele, e vedendo in una occhiata quanto stava male - come avrebbe fatto prima miss Betsey se vi fosse stata luce a sufficienza la condusse in fretta nella sua stanza, al piano di sopra; e subito dopo spedì Ham Peggotty, suo nipote, che da alcuni giorni era nascosto in casa senza che lo sapesse mia madre, come messaggero speciale in caso di emergenza, perché andasse a chiamare medico e levatrice. Queste potenze alleate rimasero abbastanza stupite quando, arrivate a distanza di pochi minuti l’una dall’altra, trovarono una signora dall’aspetto imponente seduta davanti al fuoco, col cappello legato al braccio sinistro, che si riempiva le orecchie di ovatta. Peggotty non sapeva nulla di lei, e mia madre non le aveva detto nulla; era dunque una specie di enigma seduto nel salottino, e il fatto che avesse nella tasca un intero magazzino di ovatta, e si infilasse questo articolo nelle orecchie, in quel modo, non diminuiva nulla della solennità della sua presenza. Il dottore, dopo essere stato di sopra, tornò giù, ed essendosi probabilmente convinto che c’erano parecchie possibilità che lui e quella signora sconosciuta sedessero lì, faccia a faccia, per alcune ore, si accinse a dimostrarsi cortese e socievole. Era il più mansueto del suo sesso, un dolcissimo ometto. Entrava ed usciva di sbieco da una stanza, per occupare meno spazio. Camminava sofficemente come il Fantasma dell’Amleto, e più lentamente. Reclinava la testa su un lato, in parte in segno di modesto disprezzo di se stesso, in parte per propiziarsi timidamente gli altri. Non è niente dire che non era capace di buttare una parola a un cane. Non avrebbe potuto gettare una parola ad un cane arrabbiato. Avrebbe potuto offrirgliene gentilmente una, o mezza, o un pezzetto, perché parlava lentamente come camminava; ma non sarebbe stato mai rude con lui, così come non era capace di agire rapidamente per nessun motivo al mondo. Mr. Chillip, guardando timidamente mia zia, con la testa piegata di lato e facendole un piccolo inchino, disse, alludendo all’ovatta e toccandosi piano l’orecchio sinistro: «Qualche irritazione locale, signora?» «Cosa?», rispose mia zia, levandosi come un tappo l’ovatta da un orecchio. Mr. Chillip fu così spaventato dalla sua rudezza - come raccontò poi a mia madre - che fu per miracolo che non perse la sua presenza di spirito. Ma riuscì a ripetere dolcemente: «Qualche irritazione locale, signora?» «Sciocchezze!», replicò mia zia, e si tappò di nuovo d’un colpo. Dopo ciò, mr. Chillip non poté fare altro che sedersi e guardarla timidamente mentre essa sedeva e guardava il fuoco, finché venne di nuovo chiamato di sopra. Dopo una assenza di circa un quarto d’ora tornò: «Allora?», domandò mia zia, levandosi l’ovatta dall’orecchio più vicino a lui. «Ecco, signora», rispose mr. Chillip, «stiamo... stiamo, lentamente, andando avanti, signora...». «Ba-a-ah!», esclamò mia zia, accompagnando con uno scrollone l’interiezione spregiativa. E si tappò come prima. Effettivamente... effettivamente... come mr. Chillip disse a mia madre, era quasi offeso; parlando solo da un punto di vista professionale, era quasi offeso. Ma sedette e la guardò, ciò nonostante, per circa due ore, mentre lei sedeva guardando il fuoco, finché venne chiamato di nuovo. Quando tornò dopo un’altra assenza: «Dunque?», chiese mia zia, togliendosi l’ovatta dallo stesso orecchio di prima. «Bene, signora», ripetè mr. Chillip, «stiamo... lentamente stiamo progredendo, signora...». «Ya-a-ah!», urlò mia zia. Fu un tale ringhio che mr. Chillip non potè assolutamente sopportarlo. Era stato fatto apposta per abbattere il suo spirito, disse poi. Preferì andarsene e sedersi sulle scale, nel buio e in mezzo alle correnti d’aria, fin quando venne chiamato ancora una volta. Ham Peggotty, che andava alla scuola pubblica ed era un vero mostro in catechismo, e che deve perciò venire ritenuto un testimone degno di fede, riferì il giorno dopo che avendo ficcato la testa oltre la porta del salottino, un’ora dopo, venne immediatamente scorto da miss Betsey, che ora camminava nervosamente avanti e indietro. Costei lo afferrò prima che potesse fuggire. Adesso si sentivano di sopra ogni tanto rumori, passi e voci, che l’ovatta non riusciva ad escludere, come si potè dedurre dal fatto che Ham venne afferrato dalla signora come una vittima sulla quale sfogare la sua sovrabbondante agitazione, quando i rumori si facevano più forti. Così, trascinandolo sempre avanti e indietro per il colletto (come se avesse bevuto troppo laudano) essa al tempo stesso lo scrollava, gli scompigliava i capelli, gli gualciva la camicia, tappava le sue orecchie, come se le confondesse con le proprie, e in altri modi ancora lo maltrattava e strapazzava. Ciò fu in parte confermato da sua zia, che lo vide alla mezza dopo mezzanotte, e affermava che in quel momento era rosso quanto me. Il mite mr. Chillip non era capace di serbare astio in un tale momento, se pure avesse potuto farlo in qualsiasi momento della sua vita. Entrò di sghembo nel salottino, appena fu libero, e disse a mia zia nel suo modo più gentile: «Bene, signora, sono felice di congratularmi con voi...». «Per che cosa?», domandò aspramente mia zia. Mr. Chillip fu nuovamente sconvolto dalla estrema rudezza dei modi di miss Betsey. Perciò le fece un piccolo inchino, e la gratificò, nella speranza di ammorbidirla, d’un piccolo sorriso: «Benedetto costui, che sta facendo?», gridò impazientemente mia zia. «Non sapete parlare?» «State calma, signora cara», disse mr. Chillip col suo accento più soave, «non v’è più motivo d’essere nervosa... state calma...». È stato sempre considerato quasi un miracolo che mia zia non l’avesse afferrato e scrollato per fargli dire ciò che aveva da dire. Si limitò a scuotere la testa nella sua direzione, ma con tal piglio da terrorizzarlo. «Allora, signora», riprese mr. Chillip, appena ebbe recuperato coraggio a sufficienza, «sono felice di congratularmi con voi. Tutto è finito, adesso, ed è finito bene...». Durante i cinque minuti o giù di lì che mr. Chillip impiegò a pronunziare questa orazione, mia zia lo fisso acutamente: «Come sta lei?», domandò poi, incrociando le braccia, da una delle quali pendeva ancora il suo cappello. «Bene, signora, starà presto abbastanza bene, spero», rispose mr. Chillip. «Bene quanto ci si può aspettare che stia una giovane madre in queste tristi circostanze domestiche. Non vi sono ostacoli a che voi la vediate, adesso, signora. Ciò le farà bene...». «È lei? Come sta lei?», domandò aspramente mia zia. Mr. Chillip piegò ancora di più di lato la testa e guardò interrogativamente miss Betsey, come un amabile uccello. «La bambina», spiegò mia zia, «come sta?» «Signora», rispose mr. Chillip, «credevo lo sapeste. È un maschio». Mia zia non disse una parola. Afferrò il suo cappello per le stringhe, come se fosse una fionda, e con quello colpì alla testa mr. Chillip, se lo infilò, uscì fuori e non tornò mai più. Svanì come una fata arrabbiata o come uno di quegli esseri sovrannaturali che, secondo la voce popolare, avevo il diritto di vedere; e non tornò mai più. No. Io giacevo nella mia culla e mia madre nel suo letto, ma Betsey Trotwood Copperfield era per sempre nella terra dei sogni e delle ombre, l’oscura regione dalla quale io ero appena arrivato, e la luce della finestra della nostra stanza illuminava la meta terrestre di tutti i viaggiatori di questo genere, e il tumulo sulla cenere e la polvere che una volta erano state colui senza il quale non sarei mai nato. 1 Equivalente inglese del «nascere con la camicia». 2 Babu è il nome d’un grado di nobiltà indiana. Begun, il titolo della moglie d’un ma- rajah. 3 Letteralmente: «Cornacchiaio», nido di cornacchie. 4 Pollaio. II. Prime osservazioni I primi oggetti che mi appaiono distinti, se guardo indietro nell’oscurità della mia infanzia, sono mia madre, coi suoi bei capelli e la sagoma giovanile, e Peggotty, senza sagoma del tutto e con occhi così scuri che sembravano rabbuiarle il viso tutt’intorno, e guance e braccia così rosse e dure che mi stupivo che gli uccelli non le beccassero, scambiandole per mele. Credo di poterle ricordare entrambe, l’una a poca distanza dall’altra, più piccole ai miei occhi perché curve o inginocchiate sul pavimento, mentre andavo traballando dall’una all’altra. Ho la sensazione, nella mia mente, che non riesco a distinguere da più attuali ricordi, del tocco dell’indice che Peggotty usava tendermi, reso ruvido dalle punture degli aghi, come una piccola grattugia per noci moscate. Può essere una fantasia, sebbene io creda che la memoria di molti di noi possa andare più indietro in queste epoche della vita di quanto molti suppongano; così come credo che la capacità di osservazione di parecchi bambini molto piccoli sia pressocché meravigliosa per la sua accuratezza e precisione. Ed anzi penso che di molti adulti che sono rimarchevoli sotto questo aspetto si possa dire con più verità che non hanno perso questa facoltà, piuttosto che l’abbiano acquistata; e infatti ho generalmente notato che questi uomini conservano una certa freschezza e gentilezza, una capacità di godere che è un altro retaggio della loro infanzia. Potrei avere il dubbio di stare “vagabondando”, fermandomi a dire queste cose, ma ciò invece mi conduce ad osservare che io fondo queste conclusioni in parte sulla mia propria esperienza; e se traspare da qualcosa in questa narrazione ch’io ero da bambino un acuto osservatore, o che, da adulto, ricordo fortemente la mia infanzia, senza dubbio rivendico entrambe queste caratteristiche. Guardando indietro, come dicevo, nell’oscurità della mia infanzia, i primi oggetti che posso ricordare distaccati da una massa confusa sono mia madre e Peggotty. Cos’altro ricordo? Lasciatemi vedere. Esce fuori dalla nube la nostra casa, non nuova per me, ma già familiare nei primi ricordi. Al pianterreno la cucina di Peggotty, aperta su un cortiletto, con una piccionaia su un palo, al centro, senza nemmeno un piccione; un grande canile in un angolo, senza un cane; ed una quantità di polli che mi sembravano terribilmente grandi, e passeggiavano minacciosi e feroci. V’era un gallo che saltava su un pilastro per cantare, e sembrava scrutarmi con attenzione, quando lo guardavo attraverso la finestra di cucina, facendomi rabbrividire, tanto era fiero. Delle oche, al di là del cancello, che mi seguivano dondolandosi col lungo collo teso quando passavo di lì e le sognavo la notte, come un uomo circondato da belve feroci deve probabilmente sognare leoni. V’era un lungo corridoio - che enorme prospettiva mi apriva! - che conduceva alla cucina di Peggotty dall’ingresso. Vi si apriva la porta d’una buia dispensa, ed era un posto davanti al quale passavo di corsa, quando era buio, perché non sapevo chi vi fosse tra quelle casse e tinozze e vecchie scatole di tè, se non v’era nessuno a rischiararla con una lampada fioca, facendo uscire un odore di muffa dalla porta, un miscuglio di sapone, sottaceti, pepe, candele e caffè, in una sola zaffata. Vi erano due salotti: quello dove sedevamo la sera mia madre, io e Peggotty - perché Peggotty era la nostra compagnia, quando il suo lavoro era finito ed eravamo soli - e il salotto buono, dove sedevamo la domenica: più grande, ma non così comodo. Mi sembrava che in quella stanza vi fosse un’aria di dolore, perché Peggotty m’aveva detto - non ricordo quando, ma mi sembrava sere prima - dei funerali di mio padre e della gente vestita di nero. Una domenica sera, proprio lì, mia madre lesse a me e a Peggotty come Lazzaro resuscitò da morte. Rimasi così terrorizzato che furono costrette a tirarmi dal letto e mostrarmi dalla finestra della stanza da letto il sereno cimitero della chiesa, con tutti i morti che giacevano tranquilli nelle loro tombe, sotto la solenne luna. Non ho mai visto altrove qualcosa che fosse così verde come l’erba del cimitero; nulla così ombroso, come i suoi alberi, nulla così quieto come le sue lapidi. Le pecore vi pascolavano quando io, al mattino presto, inginocchiato nel mio lettino in un séparé accanto alla camera di mia madre, lo guardavo dalla finestra. È vedevo la luce rossa dell’alba scintillare sulla meridiana, e mi chiedevo: “Sarà contenta la meridiana di potere di nuovo segnare il tempo?”. Ecco il nostro banco nella chiesa. Che alto schienale! Aveva accanto una finestra, dalla quale si poteva vedere la nostra casa; e infatti, veniva guardata parecchie volte, durante la funzione del mattino da Peggotty che voleva rassicurarsi che non ci fossero i ladri o che non stesse andando a fuoco. Ma mentre gli occhi di Peggotty giravano, si offendeva molto se i miei facevano lo stesso, e con un’occhiata mi ordinava, mentre mi sollevavo sul sedile, di guardare il pastore. Ma non potevo guardarlo sempre. Lo conoscevo anche senza quella veste bianca e temevo che si seccasse a vedersi così fissato, e forse sospendesse il servizio per chiedermi che volessi. Cosa potevo fare? È terribile sbadigliare, ma qualche volta lo facevo. Guardavo mia madre, ma lei fingeva di non vedermi. Guardavo un ragazzino nella navata, e lui mi faceva le boccacce. Guardavo il raggio di sole che entrava dalla porta aperta sul portico, e vedevo una pecora smarrita - intendo dire un montone, non un peccatore indeciso se entrare o no in chiesa. Sentivo che se l’avessi guardato ancora avrei avuto la tentazione di chiamarlo: e cosa mai sarebbe stato allora di me! Guardavo le grandi lapidi sulle pareti, e provavo ad immaginarmi mr. Bodger, defunto parrocchiano, e cosa aveva sentito mrs. Bodger quando «mr. Bodger fu vinto dal male sopportato a lungo con cristiana fermezza, e vana fu l’arte medica». Mi chiedevo se avevano chiamato il dottor Chillip, e se la sua arte fu vana; e se le cose stavano così, come si sentiva a vederselo ricordato ogni settimana. Passai lo sguardo da mr. Chillip, con la sua cravatta domenicale, al pulpito: e pensai che era un posto adatto per giocarci, avrebbe potuto essere una fortezza, con un altro ragazzo che salisse per i gradini per attaccare, per ricevere in testa il cuscino di velluto ornato di nappe. Poco alla volta i miei occhi si chiudevano e mi sembrava di udire il pastore cantare nell’afa un inno sonnolento, finché non udivo più nulla e cadevo con fracasso dal sedile, e venivo portato fuori, più morto che vivo, da Peggotty. Questo era l’esterno della casa, con le finestre munite di grate della stanza da letto, aperte all’aria profumata, e i malconci nidi di cornacchie ancora dondolanti sugli olmi, in fondo al giardino. Mi vedo nel giardino sul retro, al di là del cortile dove erano la piccionaia e il canile vuoti: una vera riserva di farfalle, come la ricordo, con un’alta staccionata e un cancello col catenaccio. Lì vi erano frutti a grappoli sugli alberi, i più grossi e succosi che siano mai cresciuti in un giardino, e mia madre ne raccoglieva alcuni in un canestro mentre io cercavo di sembrare immobile quando furtivamente inghiottivo uvaspina. Si alzava un grande vento, e l’estate era già finita. Giocavamo nel crepuscolo invernale, ballando nel salottino. Quando mia madre rimaneva senza fiato, e si buttava sulla poltrona, la guardavo avvolgersi attorno alle dita i riccioli lucenti, e nessuno sapeva meglio di me che essa amava apparire così bella, ed era orgogliosa di essere tanto graziosa. Questa è tra le mie primissime sensazioni. Come quella che entrambi temevamo un po’ Peggotty, e ci sottomettevamo in molte cose alle sue direttive; queste le prime opinioni - se così si può chiamarle - che mi venivano da ciò che osservavo. Una sera Peggotty ed io sedevamo accanto al fuoco nel salottino. Leggevo a Peggotty qualcosa intorno ai coccodrilli. Debbo aver letto molto poco chiaramente, o la poveretta non doveva essere molto interessata, perché ricordo che quando ebbi finito ella aveva la vaga sensazione che si trattasse d’una sorta di vegetali. Ero stanco di leggere e morto di sonno; ma avendo ottenuto, in via eccezionale, di rimanere in piedi finché mia madre fosse tornata a casa da una visita pomeridiana ai vicini, sarei morto sul posto, naturalmente, piuttosto che andare a letto. Avevo raggiunto quella sonnolenza che mi faceva sembrare che Peggotty si gonfiasse ed ingrandisse fino a diventare immensa. Sollevai le palpebre con gli indici e fissai la donna, che sedeva al lavoro; guardai il pezzetto di candela sul quale faceva passare il filo - come sembrava vecchio, così raggrinzito da tutte le parti! -, la casetta dal tetto di paglia dove conservava il metro, la sua scatola da lavoro col coperchio scorrevole sul quale era dipinta una veduta della cattedrale di St. Paul, con la cupola rosa; il ditale d’ottone al suo dito, e lei stessa, che mi apparve assai amabile. Mi sentivo tanto assonnato che sapevo che se mi fossi distratto un attimo sarei crollato. «Peggotty», chiesi improvvisamente, «sei mai stata sposata?» «Dio mio, signorino Davy», esclamò Peggotty, «chi t’ha messo in testa il matrimonio?». Rispose con un tale scatto che mi destò del tutto. E smise di lavorare, guardandomi con l’ago ancora tirato in lungo. «Ma eri sposata, Peggotty?», domandai. «Tu sei una donna molto bella, vero?». La giudicavo, certamente, molto diversa da mia madre, ma come una campionessa d’un altro tipo di bellezza. V’era un poggiapiedi di velluto rosso, nel salotto buono, sul quale mia madre aveva dipinto un mazzolino di fiori. Il fondo dello sgabello e la carnagione di Peggotty mi sembravano la stessa cosa. Lo sgabello era soffice e Peggotty ruvida, ma questo non faceva differenza. «Io bella, Davy?», esclamò Peggotty. «Oh, Dio mio, no, caro! Ma chi t’ha messo in testa il matrimonio?» «Non so. Non potresti sposare più d’una persona alla volta, vero Peggotty?» «Certamente no», affermò risolutamente Peggotty. «Ma se sposi una persona e questa muore, tu puoi sposare un’altra persona, eh, Peggotty?» «Si può», precisò Peggotty, «se si vuole, caro. È questione di opinioni». «E qual è la tua opinione, Peggotty?», le domandai. La guardavo con curiosità, parlando, perché lei mi fissava con curiosità. «La mia opinione», disse Peggotty, distogliendo gli occhi da me dopo un attimo d’indecisione e rimettendosi a lavorare, «è che non sono mai stata sposata, signorino Davy, e non aspetto di esserlo mai. Questo è tutto ciò che so su questo argomento». «Non sei arrabbiata, spero, Peggotty?», le dissi, dopo essere rimasto tranquillo un minuto. Pensavo davvero che lo fosse, perché era stata così brusca con me, ma mi sbagliavo: essa depose il lavoro (era una sua calza) ed aprendo le braccia strinse con forza tra esse la mia testa ricciuta. Era una stretta ben potente perché, essendo piuttosto robusta, ogni volta che faceva anche un minimo sforzo quando era vestita, alcuni bottoni le saltavano dalla schiena dell’abito. E ne udii schioccar via due dalla parte opposta del salotto, mentre mi abbracciava. «Ora fammi sentire qualcosa sui Crocrodili», disse Peggotty, che ancora non s’era imprat