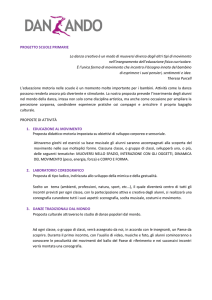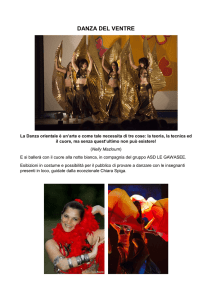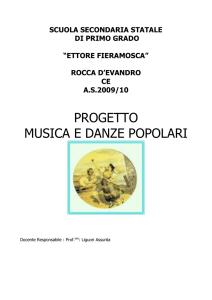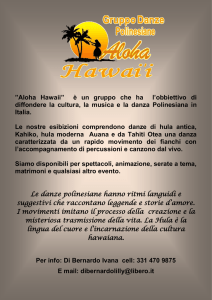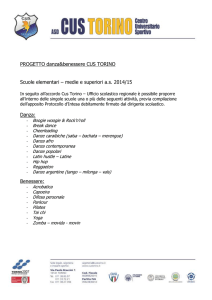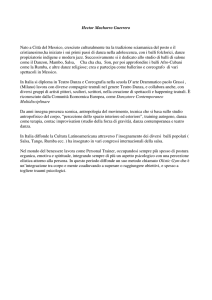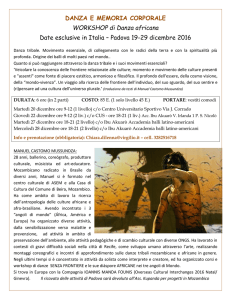caricato da
common.user4515
La Danza nel repertorio strumentale per organo e liuto

La Danza nel repertorio strumentale per organo e liuto Pistoia - aprile 2014 DANZA Insieme organizzato di movimenti ritmici del corpo Impressione trasformata in espressione Arte di esprimere le emozioni attraverso movimenti ritmici del corpo DANZA DA BALLARE DANZA PER RACCONTARE DANZA DA SUONARE RAPPORTI • Rito: partecipazione ai fondamenti della vita di una società • Religione: presenza ‘teatrale’ nelle cerimonie di adorazione • Piacere: qualità del privato e abbellimento dell’esistenza dei potenti • Guerra (caccia, lotta, sport): preparazione e festeggiamento • Eros: iniziazione, fertilità, matrimonio • Aldilà: pre-figura il mondo delle ombre PRIMITIVI gioco-divertimento-teatro-religione-ritualità Salti di gioia attorno alla preda cacciata che descrivono la cattura = danza prima individuale poi collettiva Respirazione sincronizzata Sensazioni interne Tensione verso il risultato Immaginazione per evocare immagini Sistema di segni MOTIVAZIONI • Libertà di movimento per esternare e interpretare i sentimenti • Ritmo proprio e individuale: percussioni • Col gruppo: codificazione • Differenziazione dei balli per le occasioni SUDDIVISIONI SOCIALI CULTURA ALTA CULTURA POPOLARE Ballo in tondo Scioglimento e formazione Diversificazione ritmica Sovrapposizione con le voci Tessuto sonoro complesso Molte gamme espressive Riti propri della collettività Vive con la tradizione colta No idee di tecnica UTILIZZO Cerimonia laica e religiosa tutto stabilito significati chiari balli onesti bellezza Divertimento gioia privata o pubblica colta a palazzo popolare in piazza tutto libero balli disonesti peccato La danza originaria è casuale e tonda, poi si fa rito i gesti sono simbolo di ciò che si vuole onorare o evocare RITUALITA’ MATERIALE + RITUALITA’ SPIRITUALE La religione raddoppia i simboli Il rito collettivo e sociale associa la danza alla festa Prima c’è il rito poi c’è il consumo della festa CONTROLLO DELLA REALIZZAZIONE MUSICALE Modello ritmico primitivo con percussioni Modello melodico con aggiunta di strumenti RIASSUMENDO • Da spontanea a controllata (non più lasciata alla spontaneità estemporanea ma ubbidiente a determinati simboli collettivi) • Da rito personale a fatto sociale (rito religioso ringrazia Dio - rito personale è piacere edonistico) • Dalla festa allo spettacolo (separazione tra palco e platea, organizzazione del balletto, individuazione della categoria professionale del danzatore) ANTICHITA’ E MEDIO EVO inizio del processo storico BIBBIA moltissime danze perché nelle religioni danza/gioia Danze buone: estasi comunitaria della cerimonia con la quale ci si appropria della divinità. Danze cattive: depravazione (vitello d’oro e Salomé) ANTICA GRECIA mescola mito e influssi orientali • • • • Presente nei poemi epici e nella tragedia Separazione tra gli utilizzi Dignità = danza dignitosa Imbarbarimento = danza volgare di chi è pazzo o ubriaco ROMA • Depravazione da Oriente • Inizia il discredito sociale • Inizia il processo di professionalizzazione • Nascita della pantomima (rappresentazione danzata) PRIMA EPOCA CRISTIANA • I-V sec.: sacralità sacerdotale e danza/rito come in Oriente. Vescovo=praesule=salta davanti • Dal VI sec. : regolamentazione e separazione tra pagano (festa) cristiano (severo) • Dal VI sec: si voltano le spalle agli spettacoli e al teatro considerato NON immorale MA idolatro XI-XIII SECOLO - LA CHIESA rivaluta la danza nella religiosità popolare riorganizza la presenza nella liturgia strumento di evangelizzazione Francesco: giullare di Dio Chiesa d’Occidente - San Tommaso San Bonaventura Guglielmo Durante Pantomime nelle sacre rappresentazioni - Danze dei suddiaconi Chiesa d’Oriente le danze religiose ottengono una organizzazione liturgica REGOLAMENTAZIONE Concilio di Toledo (589) – Concilio di Auxerre ( 603) Concilio di Chalon (639) = - regolamenta le pratiche del culto - elimina contaminazioni sacro/profano - eliminazione pratiche coreutiche perché pagane - sovrappone feste pagane e cristiane per dare dignità alle feste popolari - riti e danze popolari: feste in onore dei santi XI-XIII SECOLO - LAICI Riappropriazione culturale laica Società feudale nei castelli Si separano i mondi colto e popolare Mondo popolare Nelle danze collettive si mescolano pagano e cristiano Mondo colto Nei castelli si mescolano influssi diversi, determinati dagli incroci culturali IL GIULLARE La rivalutazione in ambito cortese del mestiere dell’attore scopre la figura del giullare - IX-XII sec:ai margini del sistema sociale - Guida cinetica delle danze collettive - Attore nel teatro religioso - Nomade, diffonde le conoscenze - XIII sec: ruolo sociale oltre che spettacolare - Carole, estampie e ballate: canzoni a ballo con pantomima del contenuto CANTI E DANZE Mai più bella carola era stata fatta finora, essi volteggiavano tutt’intorno e si dimenavano di qua e di là. si sentivano risuonare liuti tamburi, sonagli, flauti. lievemente fanno i piedi strisciare e subito dopo saltano. (XIII sec.) Là stavano i menestrelli che s'apprestavano bel belli a suonare sui flauti e sempre di nuovo le danze che essi conoscevano, e appena sentivano cessare le estampies che essi ballavano, questi e quelle che si divertivano a danzare senza posa cominciarono a darsi la mano per la carola. (XIII sec.) ROMAN DE LA ROSE (XIII sec.) Queste genti di cui i o parlo Erano intente a carolare. Una dama il canto intonava Che Leece si chiamava. Ben sapeva cantare e piacevolmente, Nessuno piú di lei graziosarnente Né bene i ritornelli cadenzava. Cantare a meraviglia le donava, Perché aveva la voce chiara e sana. Ed ella non era una villana, Cosí si sapeva ben regolare Battere il piede e volteggiare Sempre stava a costumare Il canto ad intonare Perché cantare era il mestiere Ch'ella faceva con piú piacere. Lor vedrete in carola volare E gente con grazia ballare E fare sempre una bella tresca E tanti giri sull'erba fresca Lí, vedete zufolare, E il menestrello e il giullare; Se alcuno i rondò cantava Altri le lorene suonava, Perché le note che fanno in Lorena Sono piú belle di alcuna regina. Le nacchere assai so usare Le donne i tamburini suonare, E sanno molto ben fare, Che non cessano mai di toccare, ln alto lanciati li raccolgono Su un dito, cosí che mai cadono. Due damigelle molto belle, Che stavano in pure gonnelle, E a una treccia intrecciate, La nobile Deduiz teneva legate E in carola faceva ballare; Ma di tal cosa non c”è da parlare Come ballassero contamente: L'una veniva bel prestamente. Contro l”altra, e quando stavano Assai da presso, s'accostavano Con la bocca, sí ch”appariva Che al bacio essa s'apríva. TRECENTO E QUATTROCENTO la danza comincia ad assumere anche altre connotazioni che la allontanano dal ruolo antropologico e collettivo intrattenimento sociale puro divertimento = strutture regolari eliminazione dell’improvvisazione scansioni ritmiche adatte al ballo prassi esecutive sempre più precise Si danza per intrattenere Si danza per divertirsi NUOVI USI • • Danza-simbolo danza passatempo di corte Epoca della rinascita (Comuni e Signorie) • Benessere sociale • • • Cambiano i termini: Ballo (fr. Bal, greco Ballizo) Danza (ted.dannezan, franco danjan: muoversi qua e là) • Differenza di scopi e usi grazie all’iconografia e alla vastissima letteratura MODI DI DANZARE • DANZA A CAROLA • tonda-astratta-corale • stile carolante • DANZA A COPPIE • di fronterappresentativaindividuale • stile danzante QUATTROCENTO • Si organizza e si struttura • Presenza del maestro di ballo a corte • Non più lasciata all’estro dei singoli • Fa parte di educazione e cerimoniale • Non più libertà corporea ma repertorio di forme • Codificazione rigida • Valorizzazione dell’arte e recupero di dignità dell’artista • Codifica la danza come scienza • Assegna in gestione al principe la definizione del tempo festivo • Definisce la danza come intrattenimento sociale e forma spettacolo DANZE QUATTROCENTESCHE • Bassadanza Danza di apertura Danza dei signori e della corte Bassadanza strisciata Deriva da estampie medievale Piva Danza campestre adottata dalla nobiltà. Contenuta già nelle intavolature per Liuto di Petrucci (1508). • Saltarello Danza di chiusura Danza dei contadini. Altadanza dai movimenti ampi e saltati TRATTATI TRA 400 E 500 • Raccontano lo stato delle cose e la posizione estetica della danza • Documentano i modelli esecutivi e di opportunità della danza • Fonti dirette per i pochissimi documenti musicali di un genere tramandato oralmente DOMENICO DA PIACENZA • • • • • • • • • Aristotelico chiude il Medioevo “De arte saltandi et chorea ducendi” (1416) È arte ed esibizione Non deve esserci casualità Chi danza deve sapere le regole La danza è spettacolo e divertimento Usa la retorica per illustrare i sentimenti, gli usi e le passioni Propone repertori stabilendo il rapporto con contesto Parla per primo di ‘seguite’ o ‘suites’ GUGLIELMO EBREO “la danza nasce da un moto dello spirito che si accorda con un suono che entra dall’orecchio, entra nel profondo e genera commozione” - Allievo di Domenico da Piacenza Musica e danza sono arti liberali. “De pratica seu arte tripudii vulgare opusculum” (metà XV sec.) 4 parti della musica = 4 elementi. Danza = ordine naturale dei movimenti Unendo necessario e piacevole. Unione platonica di SENSO (si percepisce) e SENTIMENTO (si prova). Supera il dualismo tra teorico ed esecutore Indispensabile rapporto con la musica DE PRATICA SEU ARTE TRIPUDI GUILIELMI HEBRAEI PESAURENSIS VULGARE OPUSCULUM INCIPIT Dal harmonia suave il dolce canto Che per l'audito passa dentro al cuore Di gran dolceza nasce un vivo ardore: Da cui il danzar poi vien che piace tanto. Pero chi di tal scienza vuol il vanto Convien che sei partite senza errore Nel suo concetto apprenda e mostri fuora Si come io qui discrivo insegno et canto Misura e prima e seco vuol memoria. Partir poi di terren con aire bella. Dolce mainiera, e movimento e poi Queste ne danno del danzar la gloria. Con dolce gratia, a chi l`ardente stella Più favoreggia con gli raggi suoi. E i passi et gesti tuoi Sian ben composti et destra tua persona Con lo intelletto attento a quel che suona. GUILIELMI HEBRAEI PESAURENSIS FINIS LIBRI II Il bel danzar che con virtu s'acquista Per dar piacer all'anima gentile Conforta il cuor e fal più signorile. E porge con dolceza allegra vista. E 'l senso natural ch'arnor contrista Et fal languendo spesso cangiar stile Rinuova le sue forze e fal virile Lieto danzando in amorosa lista. Per sua natura il pellegrin ingegno Che gusta del sonar la melodia Diletto prende e fassi d'honor degno. Pero chi tal virtù irnparar disia Disponga la sua mente et il cuor con degno Seguendo me che mostro altrui la via. e con quest’opra mia Insegno con vagheza di tal arte La pratica gentil elle sue parte. MARCO FABRIZIO CAROSO - “Il Ballarino” (1581) costruisce il senso tra una danza e l’altra - Base di partenza per la suite - Senso di attesa tra una danza e l’altra con senso drammaturgico - Costruzione da ricreare nella musica strumentale ALTRI TRATTATI • Cesare Negri (1525): “Le gracie d’amore”, con nuove invenzioni di balli • Thoinot Arbeau (1588): “Orchéstographie” dialogo che descrive i passi in rapporto con la musica IL BALLETTO • punto di arrivo della danza • rinascimentale • sintesi delle correnti artistiche • e musicali della saltatio • spettacolare • sintesi di poesia – coreografia – scenografia – scenotecnica RINASCIMENTO E BAROCCO Metà 500: Milano capitale della coreografia dove convergono da tutta Europa e da dove partono tutti (maestro Pompeo Diobono ) - Inizio 600: in Francia si incrociano le Danze Francesi gentili e le Danze Italiane saltate (adagio-allegro) - Metà 600: decadenza della danza italiana ed espatrio di tutti verso Parigi SISTEMAZIONE Danza astratta Stabilizzazione strumentale assenza di immagini movimenti stretti riduzione dinamica stilizzazione della prassi da casuale a stabile suonare con la carta distribuzione strumentale fusione delle sonorità Danza imitativa figurata e spettacolare movimenti ampi pantomima professionalità Giudizio sociale ciarlatano chi suona da ballo vagabondi chi strumenti a fiato disprezzo DANZE MORESCHE- ORIGINI del califfato di Cordoba (VIII-XII) morisco= nome del moro rimasto nel paese riconquistato e che ha abbracciato il cristianesimo. La moresca riflette e ricorda il periodo arabo nell’Europa meridionale. zambra – zorongo – zarabanda - - nflusso arabo-gitano e grecio-fenicio Danze di corte di coppia diffusissime XII-XV Pantomima la lotta tra cristiani e saraceni “endemoniado son de la zarabanda” (canto e ballo scurrile, vietata in Spagna, è cerimoniosa in Francia e Italia Simboli amorosi di corteggiamento Zambra: da zamr, arabo, oboe DANZE MORESCHE -XVI SEC. Sono talmente importanti e diffuse che - Confluiscono negli intermedi - Diventano sinonimo di balletto - Fanno parte del ballet de court - Si trasformano in ‘morris dances’ BALLI AMERINDI derivati spesso da riti funebri, in Europa perdono la carica simbolica sono balli di strada che acquistano carica grandiosa e mistica Ciaccona (Chacona): “musica selvaggia e appassionata da las Indias a Sevilla” (Lope de Vega,1619). Menzionata per la prima volta alle nozze di Filippo II (1599) come proveniente da Tampico (Mex). Quevedo: chacona mulata, Cervantes: Indiana amulatada “i piedi si muovono all’impazzata”, danza sfrenata. Ostinato (Instruccion de musica sobre la Guitarra espanola, 1674) Passacaglia (pasacalle): Formalmente vicina alla ciaccona Movimenti più determinati con ostinato, ma sempre ‘pericolosa’ Escuela de danzar (Ribera, 1640) DANZE INGLESI alla corte di Elisabetta I si mescolano folk inglese e balli latini, salti rituali e danze locali. E tutti si mescolano alla moresca (morris dance) • Giga: folk scozzese che porta a corte un carattere improvvisativo focoso. Origine della quadriglia • Contraddanza: “country danze”, danza popolare di origine sacrale, a circolo o a catena, che diventa sociale. Non una danza, ma tante danze diverse • Playford (1651): “il maestro inglese per ballare e dirigere contraddanze”. DANZE TEDESCHE mentre gli inglesi sono aperti alle danze latine, i tedeschi hanno le loro danze popolari (Laendler) sin dal medioevo. Rifioriscono quando la borghesia ingloba le danze popolari (valzer). Danza non arte aulica e raffinata, ma abbandono alle forze dell’istinto • Tanz: tranquilla in 2, vicina all’aulica bassadanza, vive fino all’Ottocento col nome di Allemanda • Nachtanz: veloce, derivata dalle danze rotatorie e riddanti MICHAEL PRAETORIUS (1571-1621) • Compositore, teorico tedesco segna il passaggio tra Rinascimento e Barocco • “Syntagma musicum” (1619) • Prima parte: musica sacra dagli ebrei e dai greci all’attualità con relazioni con l’etica e la poesia • Seconda parte: organologia completa di tutti gli strumenti dall’antichità con definizione e disegno • Terza parte: definizioni di tutte le forme musicali e di tutti i termini musicali PAVANA • • • Danza di apertura: “danza del pavone” dal portamento superbo e pomposo dove gli esecutori si pavoneggiano. Di origine spagnola, in un testo del XVI sec fu confusa con una ‘danza padovana’. • Le prime pavane sono contenute nel IV libro di Intabolatura de leuto di Petrucci (1508). • Le prime Pavane francesi si trovano nella pubblicazione di Attaignant (1529) • Le prime pavane ‘padovane’ nella raccolta per liuto di Antonio Rotta (1546) GAGLIARDA • Danza di chiusura • Appare in Lombardia a fine 400 • Presenza in Attaignant (1529), Inghilterra (1541), Antonio Rotta (1546) • Rimpiazza il saltarello • Va eseguita con salti e a capo scoperto • Nel 600 diviene sfrenata, anche se “deve essere eseguita senza l’abuso della velocità, con un ritmo più lento, senza il quale non si possono raggiungere gli effetti voluti” (Vierdanck, 1641) Sopra quelli a ballare incominciorno Ed a saltare all’usanza lombarda Che chi piace è un modo molto adorno E chiamasi ballare alla gagliarda (Boiardo, 1480) ALLEMANDA • Detta anche Drehtanz • Germania lontana dal mondo delle corti del 500: i tedeschi “ballavano come giullari muovendosi qua e là” (1598). • Danza tonda e chiusa, con le mani sulle spalle del partner, antenata del Ländler, vivace pantomima amorosa • Alla corte di Luigi XIV diventa “piena di grazia e precisione, bella e piacevole, dal portamento elegante e nelgrazioso intrecciarsi della braccia” CORRENTE • Di origine francese menzionata per la prima volta da Clement Marot (1515) • Pantomima di corteggiamento • Ritmo non ben definito: “una corsa di andare e venire” (Mersenne). Danza vivace ancora a fine 600 in Germania • In Francia nello stesso periodo viene definta “danza molto grave” e indicata con ‘largo’ (Bassani, 1677) • Dopo il 1700 non viene più ballata in società. SARABANDA • Mistero della musica: dalla Spagna o dalla Nuova Spagna (Yucatan)? • Etimologia: ‘sar-band’, persiano, corona? • Dalle Indie e poi assimilata dagli andalusi • Da fine 500. Gesuita Juan de Mariana (1583): “danza lasciva e con movimenti così osceni che persino i più rispettabili ne sono infiammati: la zarabanda” • Ma forse viene America Centrale: la nomina a panama (1539) poema di Fernando Mexía. • Oscena nelle mosse, nacchere e tamburelli • Nel 600 è veloce, ma nello Zodiacus musicus (1698) è indicatga “adagio e staccato” e Kunhau (1689) la vuole lenta. • Ma già a fine 600 non viene più danzata GIGA • Danza di coppie derivata dall’inglese jig (danzare) • Citata come danza campestre da Playford • Il modello irlandese o scozzese è molto libero e ballo di gruppo, opposto alle “insipide danza formali degli italiani” • Diventa danza di corte con Elisabetta I e passa in Europa con Luigi XIV • Citata da Haywood in “Country measures, rounds and Jiggs” (1603) RAOUL-AUGER FEUILLET (1650– 1709) • Membro dell’Académie Royale de Danze • “Chorégraphie ou Art de décrire la dance par caractères, signes et figures démonstratives” (1713) è il primo trattato sul primo sistema di notazione della danza che descrive passi e successione delle figure • Contiene la documentazione sulle danze alla corte di Luigi XIV aggiornata continuamente con le danze di moda ‘SEGUITE’ ovvero ‘SUITES’ • L’idea di collegare le danze è molto antica • Prima ‘seguita’: Lamento di Tristano e Rotta o Manfredina • Si inizia con una “passeggiata cerimoniale per il basso” (cioè strisciata, bassadanza) • Si conclude con il “passo brabante” librato e vivace (cioè saltata, altadanza) • Metà 400: BD sostituita con Pavana e AD con Gagliarda • Petrucci (1508) fino a 3 danze • Monteverdi (Scherzi musicali 1615) fino a 7 • Dal primo 600 la coppia P-G considerata in Europa come perfetta sintesi stilistica italiana, arricchita da danze locali ORIGINI ITALIA 300: successioni di danze ma senza l’obbligo di esecuzione come erano. Estampite. • • 400: coreografi propongono tenori in coppia BD + saltarello • 400: coreografi propongono tenori in copia BD magg + AD minore • Se ‘per ballare’, solo l’indicazione ritmica • Attaignant (1530) pubblica chansons musicales, cioè strumentali, basate su tenori di danza • Se ‘per suonare’, varianti su CF • Estienne de Tetre (Settimo libro di danze,1557): per la prima volta definisce ‘suite’ una successione di branles. • Libro del Valet de chambre del Marchese di Maulny (1631): “Branles de Belleville e le suites di quelle con le diminuzioni e i balletti di manoscritto, con tutte le suites per il violino” • Costantin Du Mont (1655): “Vi ho fatto copiare anche tutte le suites di queste allemande” • • Gli strumenti improvvisano e idiomizzano • Ambrogio Dalza (1546): “nota che tutte le pavane hanno il suo saltarello e piva” • Antonio Rotta e Domenico Bianchini: “passemezzo, la sua padoana e il suo saltarello” • Collegate attraverso lo stesso materiale • Giorgio Mainero (1578): grande perché grande consumo. Le varianti sottolineano i movimenti FRANCIA 300: successioni di danze ma senza l’obbligo di esecuzione come erano. Estampite. TERMINOLOGIE • Thomas Mace (Music Monuments, 1676): primo che descrive una suite convenzionale. (Preludio/Allemanda/Aaria/Corrente/Sarabanda) • Afferma che il termine è di origine francese, indica gruppi di danze uguali ed è stato ideato dai liutisti che avevano mescolato stili inglesi • Dietrich Becker : violinista che compone “Sonate e suites primo libro” (1674) • Roger North: “The musical grammarian” (1728) mette insieme un po’ di tutto in questa ‘grammatica della musica’ • J. Gottfried Walther: “Musicalisches Lexicon” (1732) ne dà l’ultima definizione. • In Germania chiamano Sonata la Suite, perché la fanno derivare dalla ‘sonata da camera’ italiana. • Confusione di termini e ‘suites’ mascherate con titoli fantasiosi (frutti freschi, delizie musicali, hortus musicus ecc.) • A metà 700 il termine viene sostituito definitivamente con Sonata. • La Francia è l’ultimo paese ad abbandonare il termine (suites de pièces’ ancora nel primo Ottocento) DANZE PER SUONARE • Allemanda e Corrente: tedeschi e francesi (1570 c.a) • Sarabanda: francesi (1595) • Giga: inglesi (40 del 600), i liutisti francesi in Inghilterra e vedono il masque • Robert Ballard (1611): primo che scrive ‘suites’ di danze da ascoltare con ‘legami di senso’ • Primo 600: diffusione di ‘stili nazionali’ in Europa, con influsso sulle raccolte di danze • Le danze rinascimentali sono affiancate da moltissime altre danze • Gli italiani (Lorenzo Allegri, 1618), aggiungono Canario e Gavotta • Antonio Brunelli: “da sonare solo” (1616) • I tedeschi (Valentin Haussmann, 1602), aggiungono danze polacche e russe • Dapprima i liutisti sviluppano e compattano, poi, da inizio 600, tastieristi (Sweelinck) • Giovanni Picchi: Intavolatura di Balli (1618) • Froberger: suite completa ad imitazione dei liutisti MUSICA E DANZA • Guillaume Dumanoir: “Le Mariage de la Musique avec la Danse” (1664) “Quando si diploma un maestro nella comunità dei violinisti, non ci si accontenta di fargli suonare il violino, ma soprattutto gli si fa fare esercizio di danza, al fine di giudicare se sa fare il suo mestiere, che comprende l’arte della danza altrettanto e forse più del suonare gli strumenti. • George Muffat: “Florilegium” (1695) Ma per conoscer meglio il vero andamento di ciascuna aria, oltre il frequente esercizio con i Liutisti, trovo che la notizia dell’arte di ballare è d'un gran soccorso; la quale intendendo bene la più gran parte de ' suonatori di Francia, non è meraviglia che sappiano trovar, e ritener così giusto, il vero movimento del tempo.