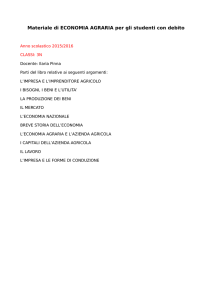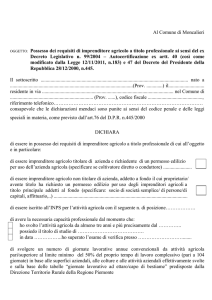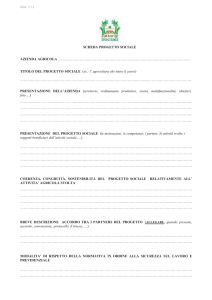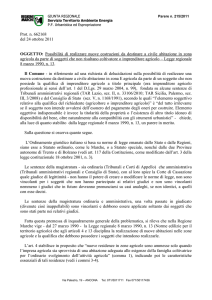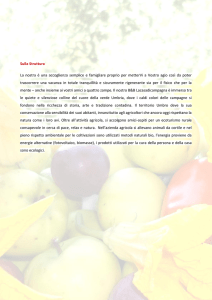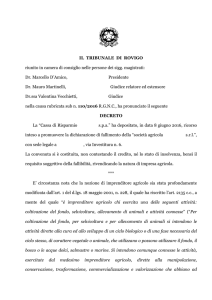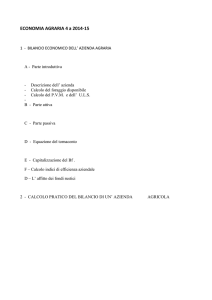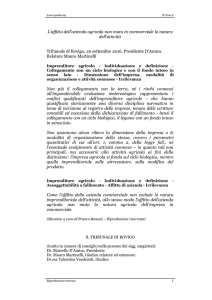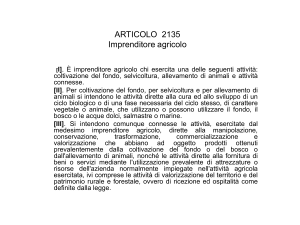caricato da
clarissa9103
Diritto agrario
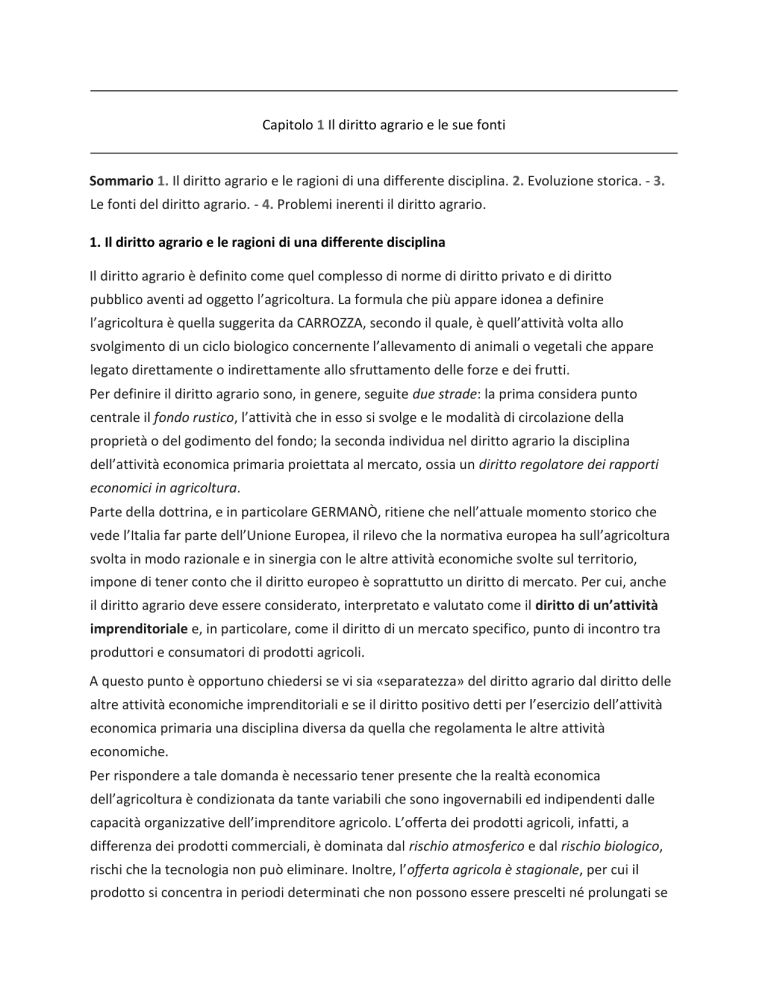
Capitolo 1 Il diritto agrario e le sue fonti Sommario 1. Il diritto agrario e le ragioni di una differente disciplina. 2. Evoluzione storica. - 3. Le fonti del diritto agrario. - 4. Problemi inerenti il diritto agrario. 1. Il diritto agrario e le ragioni di una differente disciplina Il diritto agrario è definito come quel complesso di norme di diritto privato e di diritto pubblico aventi ad oggetto l’agricoltura. La formula che più appare idonea a definire l’agricoltura è quella suggerita da CARROZZA, secondo il quale, è quell’attività volta allo svolgimento di un ciclo biologico concernente l’allevamento di animali o vegetali che appare legato direttamente o indirettamente allo sfruttamento delle forze e dei frutti. Per definire il diritto agrario sono, in genere, seguite due strade: la prima considera punto centrale il fondo rustico, l’attività che in esso si svolge e le modalità di circolazione della proprietà o del godimento del fondo; la seconda individua nel diritto agrario la disciplina dell’attività economica primaria proiettata al mercato, ossia un diritto regolatore dei rapporti economici in agricoltura. Parte della dottrina, e in particolare GERMANÒ, ritiene che nell’attuale momento storico che vede l’Italia far parte dell’Unione Europea, il rilevo che la normativa europea ha sull’agricoltura svolta in modo razionale e in sinergia con le altre attività economiche svolte sul territorio, impone di tener conto che il diritto europeo è soprattutto un diritto di mercato. Per cui, anche il diritto agrario deve essere considerato, interpretato e valutato come il diritto di un’attività imprenditoriale e, in particolare, come il diritto di un mercato specifico, punto di incontro tra produttori e consumatori di prodotti agricoli. A questo punto è opportuno chiedersi se vi sia «separatezza» del diritto agrario dal diritto delle altre attività economiche imprenditoriali e se il diritto positivo detti per l’esercizio dell’attività economica primaria una disciplina diversa da quella che regolamenta le altre attività economiche. Per rispondere a tale domanda è necessario tener presente che la realtà economica dell’agricoltura è condizionata da tante variabili che sono ingovernabili ed indipendenti dalle capacità organizzative dell’imprenditore agricolo. L’offerta dei prodotti agricoli, infatti, a differenza dei prodotti commerciali, è dominata dal rischio atmosferico e dal rischio biologico, rischi che la tecnologia non può eliminare. Inoltre, l’offerta agricola è stagionale, per cui il prodotto si concentra in periodi determinati che non possono essere prescelti né prolungati se non con un aumento dei costi di produzione. I prodotti agricoli, inoltre, sono estremamente deperibili, per cui è necessario consumarli in brevi periodi di tempo, salvo un aumento dei costi necessari per la conservazione. A ciò bisogna aggiungere che i prodotti agricoli soddisfano il bisogno primario dell’alimentazione, quindi bisogni primari per i quali vige la legge dell’utilità decrescente, nel senso che quanto più si possiede un bene, tanto minore è il desiderio di averne dosi addizionali. Ne consegue la non elasticità della domanda agricola rispetto al prezzo del prodotto (il consumo non varia al variare del prezzo) e la non elasticità della domanda agricola rispetto al reddito del consumatore, nel senso che la spesa totale per i consumi alimentari non cresce con il crescere del reddito. Tutte queste considerazioni spiegano la diversità sia dei rapporti giuridici che intercorrono tra l’agricoltore e i soggetti che partecipano alla costituzione e all’esercizio dell’impresa agricola, sia dei rapporti giuridici che intercorrono tra imprenditore agricolo, terzi e organizzazione dei poteri pubblici. 2. Evoluzione storica Ai fini di una più agevole assimilazione della materia, appare proficuo un excursus storico sui rapporti tra i diversi fattori di produzione: proprietà, lavoro e impresa. Essenzialmente, possiamo distinguere tre momenti: la fase post-unitaria. In essa si riscontrava la compresenza di due distinte normative: il codice di commercio del 1882, che raccoglieva i cosiddetti atti di commercio, e il codice civile del 1865, che aveva un contenuto residuale rispetto all’altro. In questo periodo si registrava un’assoluta mancanza di autonomia dell’attività produttiva agraria, in quanto quest’ultima veniva finalizzata esclusivamente allo sviluppo della proprietà privata, considerata, per quei tempi (unitamente al contratto) l’espressione fondamentale dei rapporti giuridici economici. Di conseguenza, si assisteva ad un’ingiusta svalutazione dell’opera dell’uomo, la cui prestazione lavorativa veniva confinata nell’angusta previsione legislativa della locatio operarum, che prevedeva come unica salvaguardia del lavoratore il divieto di assunzione, mediante contratto, di impegni perpetui; nessuna previsione, invece, relativa alla tutela della libertà ed individualità del lavoratore, attraverso la corresponsione di «una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa» (art. 30 Cost.); la fase della legislazione fascista, che ha costituito l’antecedente logico e cronologico dell’attuale normativa codicistica. In essa si assiste all’emanazione di leggi speciali, che dettano una disciplina del lavoro minorile, femminile e dell’assicurazione contro gli incidenti sul lavoro, prima facoltativa, poi obbligatoria. L’obiettivo perseguito dal regime fascista era essenzialmente quello di vincolare il lavoratore alla terra, in vista del perseguimento di obiettivi superiori quali la produzione nazionale. Un esempio di questa tendenza è dato dalla disciplina dei contratti associativi, in particolare di quello di mezzadria. Il legislatore fascista si proponeva di superare i conflitti di classe attraverso una visione corporativa della proprietà, assegnando la direzione dell’impresa al concedente che avrebbe dovuto esercitarla in conformità delle disposizioni imposte dallo Stato fascista; la fase successiva all’emanazione del codice civile del 1942, che ha operato l’unificazione delle precedenti normative, dettando una disciplina omogenea applicabile a tutte le categorie di soggetti (senza distinzione alcuna tra commercianti e agricoltori). Il legislatore del ’42 ha riunito in un unico genere, l’impresa (la cui connotazione può desumersi dalla definizione di imprenditore di cui all’art. 2082 c.c.), le due specie dell’attività agricola e dell’attività commerciale; tale innovazione è stata dettata soprattutto da una lettura diversificata del rapporto proprietà-impresa, nel senso che attualmente è la prima ad essere considerata strumentale rispetto alla seconda, e non viceversa. In altre parole, è stata accolta una concezione non più statica, bensì dinamica del diritto di proprietà, inteso come strumento per svolgere funzioni anche socialmente utili: elemento primario e imprescindibile di tale concezione è la prestazione lavorativa dell’uomo, ossia l’attività che imprime nuova forza rivitalizzante, nella dinamica dell’impresa, alla terra e alla proprietà terriera. Nel senso di una sempre maggiore valorizzazione del lavoro vanno citate le leggi speciali intervenute, terminata la guerra, a favore del coltivatore diretto. Va, infine, ricordata la normativa comunitaria che si è occupata in maniera determinante dell’agricoltura partendo dal dato della particolarità dell’attività agricola per le sue caratteristiche strutturali e naturali. 3. Le fonti del diritto agrario A) La Costituzione Con l’avvento della Costituzione repubblicana si è assistito all’introduzione di alcuni principi che hanno radicalmente mutato la concezione dei rapporti proprietà-lavoro. Il nucleo fondamentale delle disposizioni riguardanti il diritto agrario si rinviene essenzialmente nella parte prima, titolo III, dedicata ai rapporti economici (artt. 35-47). In tali norme si individuano i fattori della produzione e precisamente: lavoro. Le garanzie costituzionali di equa e proporzionata retribuzione di cui all’art. 36 si estendono anche ai rapporti di lavoro caratterizzati da una subordinazione socio-economica, quali, sicuramente, i rapporti associativi in agricoltura, e al lavoro autonomo (si pensi al caso dell’affittuario, che coltiva il fondo direttamente con il lavoro proprio e della propria famiglia); iniziativa economica. L’agricoltura, come attività economica svolta sulla terra e con la terra, implica due istituti: l’impresa e la proprietà terriera. Essa, dunque, si ricollega ai principi costituzionali espressi, rispettivamente, dagli artt. 41 e 44 Cost. Il limite dell’utilità sociale alla iniziativa economica privata e pubblica ex art. 41 viene estesa anche all’attività agraria. Di notevole importanza è anche l’intervento statale, attuato mediante la predisposizione di piani con imposizione di obblighi e vincoli determinati, finalizzati a conseguire «il razionale sfruttamento del suolo» di cui all’art. 44; proprietà. Se la terra è destinata a produrre, se cioè essa non può essere intesa solo con riferimento al suo titolare ma altresì con riguardo alla società che ha interesse a che venga coltivata e produca ricchezza, la volontà dell’individuo trova la sua misura nel vincolo finalistico impresso alla cosa. La gestione produttiva della terra, dunque, è un obbligo per il proprietario di essa, che non può restare inerte, deviando altrimenti dal fine in vista del quale il diritto di proprietà della terra gli è riconosciuto e tutelato. Nell’art. 42 si rinviene, insieme al riconoscimento della proprietà privata e alla sua legittimazione, l’imposizione al diritto di limitazioni allo scopo di «assicurarne la funzione sociale». Questi limiti assumono una configurazione più precisa se posti in collegamento con l’art. 44 Cost., che si riferisce ad un tipo di proprietà relativo ad un bene determinato: la terra; cooperazione. L’art. 45, comma primo, esalta il ruolo della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata cui riconosce una funzione sociale. La legge ne promuove e favorisce l’incremento e ne assicura il carattere e le finalità. La cooperazione ha un ruolo indubbiamente essenziale nel mondo agricolo e ad essa il legislatore ordinario ha dedicato e dedica continua attenzione. B) Il codice civile La materia del diritto agrario trova la sua fonte più importante nel codice civile, che raccoglie, tra le altre, numerose disposizioni in tema di proprietà, impresa agricola e contratti agrari. Pur essendo in atto un processo di «decodificazione», attuato attraverso l’emanazione di leggi speciali, che si propongono di adeguare la realtà agricola ai principi consacrati nella Costituzione repubblicana, il diritto agrario si mantiene ancora abbastanza aderente all’impianto codicistico di base. In tema di proprietà si segnalano le seguenti norme: l’art. 838 c.c., che sanziona il comportamento assenteista del proprietario, che abbandona la cura di «beni che interessano la produzione nazionale»; l’art. 844 c.c., in tema di immissioni, che svolge un ruolo rilevante a causa dell’incalzante inquinamento industriale; la Sezione seconda del libro III del codice, intitolata «del riordinamento della proprietà rurale» (artt. 846-856 c.c.); le disposizioni in tema di enfiteusi (artt. 957-977 c.c.), istituto ormai superato che ha svolto in passato un ruolo determinante nella redistribuzione fondiaria; le disposizioni in tema di usufrutto, di servitù e di possesso, in relazione alle quali è stato introdotto l’istituto speciale dell’usucapione agraria (art. 1159bis c.c.). In tema di impresa agricola, il nucleo rilevante è costituito dagli artt. 2135-2139 c.c.: in particolare, l’art. 2135 che fornisce la definizione di imprenditore agricolo e va letto in connessione con l’art. 2082 (nozione di imprenditore in generale). Vanno inoltre menzionati l’art. 230bis sull’impresa familiare, e gli artt. 2555 ss., che disciplinano l’azienda. In tema di contratti agrari il nucleo fondamentale è costituito dai contratti associativi (artt. 2141-2187 c.c.), quali la mezzadria, la colonia e la soccida. La L. 203/1982 ha vietato per il futuro la stipula di nuovi contratti appartenenti alle dette categorie, prevedendo la conversione in affitto dei contratti di mezzadria, colonia parziaria, soccida e, in alcuni casi, di compartecipazione agraria. L’affitto di fondi rustici è invece disciplinato dagli artt. 1628-1654 c.c., collocati dopo la locazione, per l’affinità presentata con tale contratto. C) La legislazione speciale Come abbiamo accennato fonti del diritto agrario sono anche le numerose leggi speciali emanate successivamente al codice. Particolare importanza hanno le norme dettate nel campo previdenziale e dell’assicurazione contro gli infortuni e in materia fiscale (ad es. la L. 1655/1965 e la L. 240/1984). Altre leggi hanno riguardato determinati settori come l’avicoltura (L. 419/1971), l’agriturismo (L. 730/1985), l’acquacoltura (L. 102/1992). In seguito a tutti questi interventi si è posta la necessità della rivisitazione dell’intera materia anche al fine di un miglior coordinamento e adeguamento al diritto comunitario. Il Parlamento è quindi intervenuto con la L. 57/2001 recante «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati» con cui ha delegato il Governo «a emanare uno o più decreti legislativi contenenti norme per l’orientamento e la modernizzazione nei settori dell’agricoltura, delle foreste, della pesca, dell’acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici» (art. 7, comma 1). In forza della legge delega sono stati emanati nel 2001 tre decreti legislativi intitolati all’orientamento e modernizzazione dei settori, rispettivamente, della pesca e acquicoltura (D.Lgs. 226/2001), forestale (D.Lgs. 227/2001) e agricolo (D.Lgs. 228/2001), che non hanno attuato in modo completo la legge delega, ma hanno avuto il merito di aver riportato l’attenzione sui problemi attuali dell’agricoltura italiana, che ha bisogno di moderni strumenti normativi per porsi sul mercato europeo e mondiale in termini di efficienza e competitività. Visto che i tre decreti legislativi del 2001 non avevano esaurito la possibilità di intervento che la legge delega 57/2001 aveva proposto, il Parlamento ha dato al Governo una nuova delega al fine di intervenire per la modernizzazione dei settori dell’agricoltura, della pesca, dell’acquicoltura, dell’agroalimentare, dell’alimentazione e delle foreste (L. 38/2003). In attuazione di tale delega sono stati adottati diversi decreti legislativi in materia di semplificazione amministrativa in agricoltura (D.Lgs. 99/2004), di pesca e itticoltura (D.Lgs. 153/2004), di modernizzazione dei settori dell’agricoltura e delle foreste (D.Lgs. 101/2005). D) Le competenze legislative di Stato e Regioni La modifica del titolo V della Costituzione ad opera della legge costituzionale n. 3/2001 ha comportato la piena devoluzione dei poteri in materia agricola alla competenza delle Regioni. Con riferimento alla materia «agricoltura» la Corte Costituzionale si è più volte pronunciata. Si ricorda la sentenza 8 giugno 2005 n. 219, nella quale si è precisato come occorra comportarsi quando vi sia una «concorrenza di competenze»: poiché la Costituzione non prevede espressamente un criterio di composizione delle interferenze, e qualora non si possa ravvisare la sicura prevalenza di un complesso normativo rispetto ad altri, si deve ricorrere al canone della «leale collaborazione», che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento della Regioni, a salvaguardia delle loro competenze. Tuttavia, lo Stato, se da un lato è costituzionalmente tenuto a rispettare la competenza specifica delle Regioni in materia agricola, dall’altro è il soggetto cui è imputabile l’inadempimento degli impegni presi nei confronti dell’Unione europea. Per questo motivo lo Stato è intervenuto con la c.d. legge La Loggia (chiamata cosi dal suo proponente), nella quale è prevista una specifica procedura per l’esercizio sostitutivo dello Stato, onde questi eviti di essere chiamato a rispondere davanti alla Corte di giustizia per l’inattuazione delle direttive spettante alle Regioni. Va precisato che nell’esercizio del potere sostitutivo, è consentito al Governo di «sostituirsi agli organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di grave pericolo per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica e dell’unità economica, e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali» (art. 120 Cost.). Il nuovo art. 117 Cost. rivoluziona i rapporti tra Stato e Regioni e, ispirandosi al principio di sussidiarietà e applicando un principio di ispirazione federalista (anche se l’assetto delineato dalla riforma non può ancora definirsi federale), indica le competenze specificamente devolute allo Stato, lasciando le altre alle competenze regionali. L’art. 117 Cost. elenca le materie di competenza esclusiva dello Stato (comma 2), quelle di legislazione concorrente (comma 3) e sancisce, al comma 4, che le materie non riservate espressamente allo Stato sono di competenza delle Regioni. Nell’elenco del comma 2, relativo alle competenze esclusive dello Stato sono ricordate, tra le altre, la tutela della concorrenza e dell’ambiente e in quello del comma 3 relativo alle competenze concorrenti sono riportate, tra le altre, la tutela della salute, dell’alimentazione, del governo del territorio e della valorizzazione dei beni ambientali. Mancano, quindi, nei suddetti elenchi, le materie dell’agricoltura, delle foreste, della montagna, della pesca, della caccia, dello sviluppo rurale. Ciò dovrebbe far pensare che tali materie rientrano nell’elenco residuale del comma 4, ovvero che esse sono riservate in modo esclusivo alle Regioni. Tuttavia si deve evidenziare che altre materie, comunque collegate con l’agricoltura, come l’impresa, il lavoro e l’ambiente sono di competenza dello Stato; altre appartengono alla competenza concorrente come la tutela della salute o l’alimentazione. Ancora, vi è un settore della materia agricola, quello relativo ai contratti che i privati possono stipulare (contratti di lavoro agricolo, di assicurazione contro le avversità atmosferiche, di utenze irrigue, i contratti agro-industriali che legano agricoltori e industriali alimentari ecc.) che rientrano nell’area del diritto privato, limite invalicabile alla legislazione regionale per il principio di uguaglianza che impone che i cittadini abbiano uguale trattamento su tutto il territorio nazionale, e che ora parte della dottrina ritiene appartenga alla materia di competenza esclusiva dello Stato del cd. ordinamento civile, di cui al comma 2, lett. l), art. 117 Cost. Nella pratica, quindi, può essere anche complicato stabilire i confini precisi tra una materia e l’altra. E) L’agricoltura nella normativa dell’Unione Europea La disciplina dell’agricoltura è di competenza dell’Unione Europea, che deve compiere interventi programmatici e regolativi incidenti sia sulla produzione che sul mercato dei prodotti. In tale disciplina, l’Unione europea incontra una serie di finalità che condizionano il suo agire, finalità che sono ravvisate nell’incremento della produttività attraverso lo sviluppo del progresso tecnico e l’impiego migliore dei fattori della produzione; nell’assicurazione di un tenore di vita equo alla popolazione agricola; nella stabilizzazione dei mercati agricoli; nell’assicurazione di prezzi ragionevoli per i consumatori ecc. Per l’ordinamento comunitario, l’Unione Europea ha competenze esclusive e competenze concorrenti. Le competenze concorrenti sono quelle per le quali esistono due livelli di governo (quello dell’Unione e quello statale) che hanno uguali possibilità di intervenire. Il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1°dicembre 2009, ha esplicitamente inserito l’agricoltura nell’elenco delle competenze concorrenti. L’art. 2 TFUE spiega il significato del termine concorrente, chiarendo che tale competenza concorrente non è identica a quella che noi intendiamo con riferimento al nostro diritto, ovvero che all’istituzione principale spetti la normazione di principio e alle altre istituzioni la normazione di dettaglio. Nel diritto europeo è affermato espressamente che «quando i Trattati attribuiscono all’Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore (tra cui l’agricoltura), l’Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore», con la precisazione che «gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l’Unione non ha esercitato la propria» e tornano ad esercitarla nella misura in cui l’Unione ha deciso di cessare la propria. Con tale formula contenuta nel TFUE si vuole fare forza al principio di sussidiarietà, ridisegnando gli spazi di sovranità legislativa degli Stati membri. Nella vigente politica delle strutture agricole, infatti, sono assegnati agli Stati compiti sempre più estesi (GERMANÒ). L’agricoltura, date le disparità naturali esistenti tra le varie aree geografiche europee, occupa un posto particolare nell’ordinamento giuridico comunitario, nel senso che gli articoli 38 e 44 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), che la riguardano, hanno valenza speciale rispetto alle regole del Trattato di valenza generale. F) La consuetudine Tale espressione designa, in senso lato, ogni forma di diritto non scritto e, in particolare, quelle fonti di produzione normativa originate dall’organizzazione o dalle istituzioni sociali. È importante chiarire che la consuetudine, pur inquadrandosi tra le fonti extra-legislative del diritto, ha rango formale di fonte vera e propria, anche se, abitualmente, è subordinata alla legge. Secondo gli insegnamenti della dottrina tradizionale, due sono i caratteri essenziali della consuetudine: l’uno oggettivo, dato dalla reiterazione, per un periodo di tempo indefinito, di un determinato comportamento da parte della generalità dei consociati; l’altro, soggettivo, dato dalla consapevolezza di tali soggetti di porre in essere un comportamento giuridicamente necessario (la cd. opinio iuris ac necessitatis). In passato, la consuetudine ha rivestito un ruolo determinante nel sistema delle fonti del diritto agrario, dimostrandosi la fonte più congeniale a tali rapporti improntati, alle origini, su di un’economia di tipo rurale. G) Gli usi MAROI riconosceva nell’importanza degli usi il carattere distintivo del diritto agrario. Il codice civile contiene ancora alcuni richiami agli usi (da non confondere con gli usi civici). Essi sono: quelli relativi ai contratti associativi (art. 2187); l’ultimo comma dell’art. 230bis contiene un richiamo agli usi per le comunioni tacite familiari nell’esercizio dell’agricoltura; l’art. 1496 per la vendita di animali; una residua importanza ha l’art. 2139 che rinvia agli usi per regolare lo scambio di mano d’opera o di servizi tra i piccoli imprenditori agricoli; da ultimo, si richiama l’art. 2138 che rinvia agli usi per la determinazione dei poteri del dirigente agricolo o del fattore di campagna, qualora non vi sia una loro individuazione in forza di contratto scritto. 4. Problemi inerenti il diritto agrario Il diritto agrario muta in funzione del momento storico e del luogo in cui si applica, pertanto i problemi e le regole agrarie si presentano sotto molteplici sfaccettature, a seconda, appunto, del momento storico e del paese al quale si riferiscono. I paesi in via di sviluppo, ad esempio, affrontano questioni di natura agricola diverse da quelle che interessano i paesi industrializzati. Lo studio del diritto agrario comporta l’analisi di un insieme di norme di diritto privato e pubblico oltre che diritto nazionale e comunitario. Il diritto comunitario riguardante l’agricoltura fa riferimento anche al diritto alimentare, con particolare attenzione alla natura incerta dei prodotti agricoli destinati all’industria alimentare ed alla conseguente tutela igienico-sanitaria del consumatore. La tecnologia, infatti, potrebbe favorire la produzione di beni contenenti sostanze nocive. Un’altra importante questione affrontata in sede di analisi del diritto agrario è il problema ambientale. L’agricoltura, infatti, ha avuto una posizione non sempre univoca nei confronti della natura; basti pensare alla differenza di mentalità che sussiste tra il colonizzatore di spazi sconfinati, per il quale il progresso ha significato abbattimento di alberi, e quella dei coloni che nel XVIII e XIX secolo hanno duramente lavorato per rendere coltivabili i terreni delle colline toscane. Come si vede, dunque, il diritto agrario è un sistema di norme non più tendenti a proteggere (solo) l’agricoltura, ma anche a preservare l’ambiente, ad assicurare la qualità igienico-sanitaria dei prodotti agricoli e a mantenere la presenza dell’uomo in territori anche marginali altrimenti destinati all’abbandono. In questo senso si può dire che il diritto dell’agricoltura sembra traslocare in diritto rurale o territoriale (ALBISINNI). Questionario 1. Quali sono i motivi fondamentali della differente disciplina del diritto agrario rispetto alle altre attività economiche? (par. 1) 2. Come si è modificata nel tempo la concezione dell’attività agricola? (par. 2) 3. Quali sono le fonti del diritto agrario? (par. 3) 4. Come sono ripartite le competenze legislative tra Stato e Regioni in materia agricola? (par. 3) 5. Cosa si intende per competenza concorrente nel diritto europeo? (par. 3) 6. Quali sono i problemi inerenti lo studio del diritto agrario? (par. 4) Capitolo 2 Il diritto agrario nell’Unione Europea Sommario 1. L’agricoltura nella normativa dell’Unione Europea. - 2. La disciplina degli aiuti di Stato nel settore dell’agricoltura. - 3. L’organizzazione comune dei mercati agricoli: la politica comunitaria dei prezzi. - 4. La politica agricola comune (PAC). - 5. Qualità e sicurezza degli alimenti. 1. L’agricoltura nella normativa dell’Unione Europea Durante il negoziato che doveva dare origine alla CEE, si discusse a lungo sull’opportunità di escludere i prodotti agricoli dal mercato comune che si voleva creare con il Trattato; ma alla fine prevalse l’idea che non si poteva escludere da un sistema, rilevante anche sotto il profilo politico, l’agricoltura ed i suoi prodotti, e, pertanto, si dedicarono alcuni articoli (oggi, gli articoli da 38 a 44 del TFUE) a questo argomento. La competenza L’articolo 4 del TFUE elenca, tra le materie di competenza concorrente, l’agricoltura e la pesca, ad eccezione della conservazione delle risorse biologiche del mare, in quanto materia di competenza esclusiva dell’Unione. Si osserva quanto disposto dall’articolo 2, par. 2, TFUE, per il quale «quando trattati attribuiscono all’Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, l’Unione e gli Stati membri possono esercitare la loro competenza nella misura in cui l’Unione non ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui l’Unione ha deciso di cessare nuovamente la propria». È chiaro che il concetto di competenza concorrente nel diritto dell’UE è profondamente diverso da quello esistente nell’ordinamento nazionale (si veda in materia di competenze legislative regionali ex articolo 117 Costituzione). Per il diritto dell’Unione europea, la competenza concorrente non postula un concorso di norme (di principio e di dettaglio), ma una competenza solo residuale degli Stati membri che possono intervenire con proprie norme solo se e in quanto l’Unione europea abbia deciso di non adottare proprie norme giuridiche. Il Trattato di Lisbona ha introdotto, per quanto qui interessa, un nuovo primo comma all’articolo 38 TFUE, in forza del quale si dispone che «l’Unione definisce ed attua una politica comune dell’agricoltura e della pesca». Specialità Le norme del TFUE che individuano poteri e compiti dell’Unione europea nel settore agrario, agli articoli da 38 a 44 TFUE, sono caratterizzate da specialità ed eccezionalità rispetto alle regole generali dello stesso TFUE. La specialità si evince dal fatto che le linee direttrici della PAC sono individuate dal Trattato (art. 39 TFUE) e dalla peculiarità della PAC rispetto alle altre politiche (es., sottrazione del campo agrario dall’applicazione delle regole della concorrenza di cui all’articolo 42 TFUE). L’articolo 38, al comma 2, afferma che «il mercato interno comprende l’agricoltura, la pesca ed il commercio dei prodotti agricoli. Per i prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell’allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti». Successivamente, l’articolo 38 specifica il significato della definizione, stabilendo che i prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 39 a 44 sono solo quelli elencati nell’Allegato I, escludendo, dunque, l’articolo 38 dal richiamo. L’Allegato I contiene, dunque, un elenco tassativo di prodotti considerati agrari dall’Unione europea. Non vi è piena corrispondenza tra i prodotti elencati nell’Allegato I e la definizione di «prodotto agricolo» contenuta nel paragrafo 2 dell’articolo 38 TFUE. Le discrasie concernono tanto la presenza di prodotti che non potrebbero considerarsi agricoli (perchè di seconda o successiva trasformazione), quanto l’assenza di prodotti che sono comunque prodotti del suolo (è il caso di beni quali il cotone, la seta ed il legno). Per cui, mentre è il prodotto agricolo l’elemento che costituisce il punto di riferimento dell’insieme delle norme del Titolo III della Parte III del TFUE, intitolato all’agricoltura e alla pesca, l’oggetto diretto della politica agricola comune, invece, è l’attività che si qualifica in ragione del rapporto con il fondo e non più esclusivamente in ragione di finalità produttive (GERMANÒ). La pesca Significativa è la modifica (con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona) alla denominazione del Titolo III del TFUE, il quale è ora intitolato «Agricoltura e pesca». Inoltre, nel testo dell’articolo 38, il comma 1, paragrafo 1, fa espresso riferimento alla politica comune dell’agricoltura e della pesca, mentre nel comma 2 si è specificato che il mercato interno comprende non solo l’agricoltura ma anche la pesca. È stato anche aggiunto un periodo che dispone che «i riferimenti alla politica agricola comune o all’agricoltura e l’uso del termine «agricolo» si intendono applicabili anche alla pesca, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di questo settore». Tale modifica ha carattere formale, dal momento che già in precedenza pesca ed agricoltura erano assoggettate alle medesime norme del Trattato, poiché nella definizione di prodotto agricolo erano sin dall’origine compresi i prodotti della pesca, i quali erano stati da sempre inseriti nell’elenco dell’Allegato I. A) Le fonti del diritto dell’Unione europea L’ordinamento giuridico dell’Unione europea è costituito dall’insieme di norme che regolano l’organizzazione e lo sviluppo dell’Unione e i rapporti tra questa e gli Stati membri. Il diritto dell’Unione europea si distingue in: diritto originario. Esso comprende i Trattati istitutivi, nonché gli atti successivi che ne hanno operato una modifica o li hanno completati (tra i principali l’Atto Unico europeo, il Trattato sull’Unione europea, il Trattato di Amsterdam, il Trattato di Nizza e da ultimo il Trattato di Lisbona). A questi atti, che vanno a formare insieme al diritto derivato il diritto scritto, devono aggiungersi i principi generali del diritto, enucleati ad opera della Corte di giustizia dell’Unione europea, che costituiscono il diritto non scritto; diritto derivato. Rientrano in questa categoria tutte le norme giuridiche emanate dalle istituzioni dell’Unione per la realizzazione degli obiettivi posti in essere dai trattati: i cd. atti tipici, che comprendono regolamenti, direttive, decisioni e pareri, e i cd. atti atipici, quali ad esempio atti di autorizzazione e concessione, atti interni con i quali le istituzioni regolano il proprio funzionamento, proposte, richieste dichiarazioni etc., che si sono sviluppati nella prassi. Il diritto originario, e con esso gli accordi con gli Stati terzi che traggono la loro validità giuridica dagli stessi trattati, rappresenta una fonte di primo grado del diritto cd. diritto primario dell’Unione: le norme in essi contenute formano il quadro giuridico costituzionale dell’Unione; esse non possono essere disattese dagli atti delle istituzioni e non possono essere oggetto di interventi giurisdizionali. Il diritto derivato, invece, costituisce una fonte di secondo grado in quanto gli atti che lo costituiscono sono gerarchicamente subordinati ai trattati. Il sistema normativo dell’Unione è completato dalle fonti di terzo grado costituite dai regolamenti di attuazione della Commissione di atti emanati dal Consiglio. I trattati istitutivi non prevedono alcuna forma di gerarchia degli atti dell’Unione, né per diversità di rango né di valore formale. Il Trattato sul funzionamento della Unione all’art. 288, indica gli atti che le istituzioni devono adottare per svolgere la propria azione, strumenti differenziati in ragione della natura, del livello di azione prescelta e delle finalità che si intendono perseguire. Quando il trattato non indica il tipo di atto da adottare, la scelta è lasciata alla discrezionalità delle istituzioni. Nemmeno la diversa procedura di adozione degli atti può costituire una condizione di differenziazione gerarchica, poiché essa cambia a seconda della materia da trattare e non a seconda del tipo di atto. La questione della gerarchia degli atti è stata spesso oggetto di discussione, tanto che la dichiarazione n. 16 allegata al Trattato di Maastricht sull’Unione europea auspicava che la conferenza intergovernativa del 1996 esaminasse il problema. Anche il trattato di Lisbona, ad eccezione della formulazione secondo cui i due trattati (TUE e TFUE) hanno lo stesso valore giuridico, non fa alcuna menzione sulla gerarchia tra le norme. B) La prevalenza del diritto dell’UE sul diritto interno Le norme dei regolamenti e le norme dettagliate delle direttive hanno piena efficacia obbligatoria nello Stato, senza necessità di leggi di ricezione e di adattamento; di conseguenza se la norma comunitaria è posteriore alla norma interna, statale o regionale, quest’ultima è caducata per la sopravvenienza della norma comunitaria, mentre se la norma interna sopravvenuta è incompatibile con la norma comunitaria, il giudice nazionale può constatarne direttamente l’incompatibilità e quindi non applicare la norma interna. Ai fini della comprensione del diritto agrario vigente, bisogna tener presente che il nostro sistema normativo «agricolo» non è il prodotto esclusivo delle fonti previste dall’ordinamento dello Stato; occorre, infatti, anche considerare l’efficacia del diritto europeo negli Stati membri. Infatti, il diritto europeo integra e modifica continuamente l’ordinamento nazionale, con la conseguente necessità di giudicare la conformità al nostro ordine costituzionale delle norme comunitarie. Ci si chiede, in pratica, in che modo la nostra Carta costituzionale esercita il suo ruolo di garante dell’assetto costituzionale di fronte al processo di integrazione europea. Preliminarmente si osserva che la Corte di Giustizia ha da tempo affermato che le norme comunitarie «fanno parte integrante», con rango superiore rispetto alle norme interne, dell’ordinamento giuridico vigente nel territorio dei singoli Stati membri (causa «Simmenthal» n. 106/77 del 9-3-1978) e che il diritto comunitario «allo stesso modo in cui impone ai singoli degli oblighi, attribuisce loro dei diritti» che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare, sicchè il diritto statuale non potrà in nessun caso e modo pregiudicare l’applicazione del diritto comunitario. Il riconoscimento di questa prevalenza del diritto comunitario non è stato altrettanto rapido ad opera della nostra Corte Costituzionale. Basta solo ricordare che dopo un graduale avvicinamento, la Corte concluse il suo cammino con la sentenza GRANITAL con la quale affermò che «quando, poi, vi sia un’irriducibile incompatibilità fra la norma interna e quella comunitaria, è quest’ultima, in ogni caso, a prevalere» e che le norme della Comunità, applicabili immediatamente, devono, «al medesimo titolo, entrare e permanere in vigore nel territorio italiano, senza che la sfera della loro efficacia possa essere intaccata dalla legge ordinaria dello Stato. Non importa, al riguardo, se questa legge sia anteriore o successiva. Il regolamento fissa, comunque, la disciplina della specie». In definitiva, per la Corte di Giustizia, che abbraccia la teoria monista, il diritto comunitario e diritto interno formano un unico ordinamento, nel quale le norme dell’UE sono di grado inferiore. Per la Corte Costituzionale che abbraccia, invece, la teoria della molteplicità degli ordinamenti, l’ordinamento comunitario e quello interno sono distinti e separati, anche se tra loro coordinati. 2. La disciplina degli aiuti di Stato nel settore dell’agricoltura Nel nostro Ordinamento, l’art. 44 della Costituzione sancisce l’obbligo del legislatore di aiutare la piccola e la media proprietà terriera, ovverosia la piccola e media impresa agricola, quindi, la necessità di sovvenzioni pubbliche all’agricoltura è riconosciuta a livello costituzionale. Per quanto riguarda l’atteggiamento dell’Unione Europea, l’articolo 107 TFUE vieta «salvo deroghe contemplate nei Trattati» aiuti alle imprese, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri e falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Il successivo articolo 108 TFUE stabilisce che spetta alla Commissione valutare i regimi di aiuti previsti dagli Stati membri, concedendo specifiche autorizzazioni una volta che gli Stati glieli abbiano regolarmente notificati. Tutto ciò vale per gli operatori economici dell’industria. Per quelli agricoli, invece, l’articolo 42 TFUE sancisce l’applicazione degli articoli 101-109 TFUE alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli solo nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio. In sintesi, l’art. 42 TFUE consente al Parlamento e al Consiglio di decidere in che misura applicare l’intero pacchetto delle norme del Trattato a tutela della concorrenza al settore della produzione e commercio dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I. Inoltre, il secondo comma dell’art. 42 TFUE prevede la possibilità che solo il Consiglio, su proposta della Commissione, autorizzi la concessione di aiuti per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali, nel quadro di programmi di sviluppo economico. Le aziende sono da intendersi come aziende agricole, in quanto la norma è sotto il Titolo III del TFUE intitolato, appunto, «agricoltura e pesca». Quindi, la deroga al divieto degli aiuti pubblici agli agricoltori che l’art. 107 TFUE prevede come possibile solo se sia contemplata dai Trattati, è prevista e disciplinata dall’articolo 42 TFUE, che, appunto, sottrae, nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, le imprese agricole dalle disposizioni restrittive dettate dagli articoli 101-109 TFUE, quindi esclude gli agricoltori dal divieto di aiuti di Stato e dal divieto delle intese anticoncorrenziali. Il diritto agrario comunitario quindi, si caratterizza per questa notevole specificità (GERMANÒ). In applicazione di quanto disposto dall’art. 42, il Consiglio approvò il Reg. (CEE) 26/62, più volte modificato e poi sostituito dal Reg. (CE) n. 1184/06, la cui disciplina è oggi trasposta, quanto ai prodotti agricoli assoggettati all’OCM unica, all’interno dello stesso Reg. n. 1234/03 e, ora, all’interno del vigente Reg. (UE) n. 1308/13. Inoltre, a seguito dell’adozione del Reg. (UE) n. 1379/2013 relativo all’OCM nel settore della pesca ed agricoltura è stato modificato l’art. 1 del Reg. 1184/06, il quale ora chiarisce la sua inapplicabilità non solo per i prodotti oggetto di OCM unica, ma anche per quelli disciplinati dal Reg. 1379/2013. 3. L’organizzazione comune dei mercati agricoli: la politica comunitaria dei prezzi Il prezzo dei prodotti agricoli non è determinato dalla perfetta interrelazione dell’offerta e della domanda, dato che se l’offerta aumenta, il prezzo non scende in modo proporzionale ma tende a crollare (legge di King). Per la loro incapacità di variare la produzione in relazione alla domanda, quindi, le imprese agricole non sono capaci di influire sui prezzi. Ciò spiega il particolare interesse che l’Unione europea ha posto per l’organizzazione comune del mercato (OCM) dei prodotti agricoli. L’art. 40 TFUE, infatti, stabilisce che «per raggiungere gli obiettivi previsti dall’art. 39 è creata un’organizzazione comune dei mercati agricoli», mettendo l’accento sul mercato, mentre alle strutture non è riservata una disposizione altrettanto importante. Infatti, (al par. 1) indica in modo vincolante che l’organizzazione comune dei mercati agricoli deve assumere la forma di regole comuni in materia di concorrenza o quella di un coordinamento delle organizzazioni nazionali di mercato ovvero quella di organizzazione europea del mercato. Inoltre, al paragrafo 2, si afferma che l’OMC può comprendere «tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti dall’art. 39», pur indicandone, poi (a titolo esemplificativo) alcune, cui si aggiungono quelle previste al comma 3 del par. 2, secondo cui «un’eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniforme». Cos’è l’OCM? La Corte di Giustizia (sentenza in cause riunite 90 e 91/91 del 13/11/1963) ha affermato che l’OCM è «l’insieme di norme e di meccanismi comunitari destinati a garantire la regolazione del mercato di un prodotto o di un gruppo di prodotti determinati». Attualmente, l’OCM è disciplinata da un unico regolamento (Reg. (UE) n. 1308/2013). L’articolo 40 si conclude con il suo par. 4 che prevede la creazione di uno o più fondi agricoli di orientamento e garanzia, norma che ebbe rapidissima applicazione fin dal 1962 ad oggi, con i fondi FEAGA e FEASR. Politica dei prezzi Per ogni tipologia di prodotto (OCM) veniva stabilito un prezzo indicativo che avrebbe dovuto assicurare un equo reddito agricolo. Il prezzo indicativo rappresentava l’obiettivo da raggiungere: occorreva far tendere il prezzo di mercato al prezzo indicativo. Se il prezzo di mercato si abbassava al di sotto del prezzo indicativo, l’Ue interveniva acquistando il prodotto agricolo per far rialzare il prezzo di mercato fino a che questo non raggiungeva di nuovo il prezzo indicativo. L’Ue acquistava il prodotto agricolo ad un prezzo di intervento, poi lo stoccava o lo trasformava in attesa di rivenderlo una volta rialzati i prezzi di mercato. 4. La politica agricola comune (PAC) La Politica Agricola Comune (Pac) identifica quell’insieme di regole, norme e meccanismi che governano la produzione, lo scambio e la lavorazione dei prodotti agricoli all’interno dell’Unione Europea con precise finalità, di cui all’art. 39, comma 1 TFUE. Esse sono: a. incrementare la produttività dell’agricoltura, sviluppando il processo tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera; b. assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell’agricoltura; c. stabilizzare i mercati; d. garantire la sicurezza degli approvigionamenti; e. assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. Oltre alle finalità (di cui sopra) specifiche della PAC, occorre considerare anche quanto disposto da altri articoli del TFUE e segnatamente: l’art. 11, secondo cui le «esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione»; l’art. 12 che impone di prendere in considerazione nell’attuazione delle politiche dell’Unione le «esigenze inerenti alla protezione dei consumatori»; l’art. 13, secondo cui l’Unione, nella formulazione e attuazione di alcune politiche, tenga «pienamente conto» delle «esigenze in materia di benessere degli animali». A) Organi della PAC La specialità della PAC, fino all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, consisteva nella previsione di una specifica procedura di adozione degli atti previsti per la realizzazione della politica agricola comune (PAC), che consisteva nella votazione a maggioranza dei Ministri dell’agricoltura riuniti in seno al Consiglio, su proposta della Commissione, sentito il parere obbligatorio, ma non vincolante, del Parlamento europeo (art. 37 TCE). Ora, l’odierno art. 43 TFUE stabilisce che tutti gli atti normativi necessari al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell’agricoltura o della pesca sono adottati dal Consiglio e dal Parlamento europeo, secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale. Il tutto in favore di un accresciuto ruolo del Parlamento europeo. Tuttavia, il comma 3 prevede una procedura speciale (con competenza esclusiva del Consiglio) per l’adozione di misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca. B) PAC 2014/2020: il pacchetto legislativo Il 26 giugno 2013 è stato raggiunto un accordo politico sulla PAC destinata ad applicarsi nel periodo 2014-2020, tra la Presidenza del Consiglio UE, Commissione e Parlamento europeo, a seguito delle proposte di regolamento presentate dalla Commissione nell’ottobre 2011. A seguito dell’accordo sono stati adottati una serie di Regolamenti, disciplinanti i vari aspetti della PAC: 1. Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune; 2. Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli; 3. Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 4. Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune; 5. Regolamento (UE) n. 1370/2013 recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli; 6. Regolamento (UE) n. 671/2012 recante modifiche del Regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all’applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013; 7. Regolamento (UE) n. 1028/2012 che modifica il regolamento (CE) n. 12344/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori. I ritardi nel negoziato hanno comportato il rinvio al 2015 (anziché a partire dal 2014) dall’entrata in vigore del regolamento sui pagamenti diretti agli agricoltori e di talune misure previste dal Regolamento OCM Unica e, contestualmente, la necessità di prevedere un Regolamento transitorio per garantire la prosecuzione degli aiuti anche per il 2014: Regolamento (UE) n. 1310/2013 («Regolamento transitorio»). C) Il percorso della pac 2014-2020 3 marzo 2010 pubblicazione del documento Europa 2020 «una strategia per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» 12 aprile 2010 lancio della consultazione pubblica sul futuro della PAC da parte del Commissario Ciolos 16 giugno 2010 adozione della strategia Europa 2020 da parte del Consiglio europeo dei capi di Stato e di Governo 19-20 luglio 2010 conferenza europea a Bruxelles sul futuro della PAC 19 ottobre 2010 primi orientamenti sul futuro delle politiche comunitarie e sul bilancio 20142020, con la Comunicazione Revisione del bilancio dell’Unione europea (COM 2010 (700) defl) 18 novembre 2010 primi orientamenti sul futuro della PAC con la Comunicazione della Commissione La politica agricola comune verso il 2020 (COM 2010 (672) def) 25 maggio approvazione della relazione sulla nuova PAC da parte della Commissione 2011 Agricoltura del Parlamento europeo (Rapporto Dess) 22-23 giugno 2011 approvazione della relazione sulla nuova PAC da parte del Parlamento europeo in seduta plenaria 29 giugno 2011 proposte legislative sul Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020 (COM 2011 (500) def) 12 ottobre 2011 proposte legislative sulla nuova PAC entro il 2012 accordo sul nuovo Quadro Finanziario Pluriennale entro il 2012 accordo sulla nuova PAC 2013 approvazione dei Regolamenti 10 agosto 2013 adozione delle opzioni nazionali sulla nuova PAC 1° gennaio entrata in vigore della nuova PAC 2014 LE RIFORME DELLA PAC Periodo di applicazione 1993/1999 Riforma Riforma Mc Sherry 2000/2004 Agenda 2000 2005/2009 Riforma Fischles 2010/2013 Health Check 2014/2020 Europa 2020 D) Obiettivi e priorità della nuova PAC La strategia Europa 2020 indica che la futura crescita economica nell’Unione europea dovrebbe essere intelligente, sostenibile e inclusiva. La strategia è incentrata su cinque traguardi ambiziosi in materia di occupazione, istruzione, riduzione della povertà e clima/energia, per i quali fissa specifici obiettivi principali. In linea con la strategia Europa 2020 e con gli obiettivi generali della PAC (comunicazione della Commissione europea «La PAC verso il 2020»), è possibile individuare tre obiettivi strategici a lungo termine per la politica di sviluppo rurale dell’UE nel periodo 2014-2020: il miglioramento della competitività dell’agricoltura; la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima; uno sviluppo territoriale equilibrato per le zone rurali. Al fine di gestire l’utilizzo della politica di sviluppo rurale attraverso i programmi di sviluppo rurale (PSR), questi obiettivi generali sono stati tradotti più concretamente nelle seguenti sei priorità: promuovere il trasferimento di conoscenze nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali; potenziare la competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole; incentivare l’organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo; preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall’agricoltura e dalla silvicoltura; incoraggiare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale; promuovere l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali. A sua volta, per ciascuna priorità dei PSR saranno identificate specifiche aree di intervento (aree principali o prioritarie). Le priorità e le aree prioritarie del PSR costituiranno la base per programmare e garantire il sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) alle zone rurali dell’UE. Unitamente al sostegno del FEASR, le zone rurali possono beneficiare del sostegno supplementare erogato nell’ambito di altri fondi UE, e precisamente: il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). Al fine di apportare un maggiore valore aggiunto europeo e massimizzare le sinergie, nel 2014-2020 tutti i Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi ESI) concentreranno il loro sostegno sul raggiungimento degli obiettivi principali della strategia Europa 2020 e saranno coordinati nell’ambito di un Quadro strategico comune (QSC). Le disposizioni comuni sui Fondi strutturali (Proposte legislative per la politica di coesione 2014-2020) prevedono un quadro legislativo comune per tutti i fondi ESI per armonizzare e semplificare la regolamentazione laddove possibile e appropriato. Vengono identificati 11 obiettivi tematici in linea con le priorità della strategia Europa 2020. Gli accordi di partenariato rifletteranno l’approccio strategico comune dell’UE a livello nazionale, definendo per ciascuno Stato membro le modalità di coordinamento delle diverse politiche e il relativo utilizzo dei fondi ESI. In questo quadro, la politica di sviluppo rurale manterrà la sua identità distintiva e opererà nell’ambito di un regolamento specifico (Proposta della Commissione europea sul sostegno allo sviluppo rurale), nonché di disposizioni comuni sul finanziamento e sulla gestione della PAC (Proposta della Commissione relativa al regolamento orizzontale sulla PAC). 5. Qualità e sicurezza degli alimenti L’Unione Europea valorizza il proprio patrimonio gastronomico e sensibilizza i consumatori in merito alla qualità e sicurezza degli alimenti. A tal fine, il diritto comunitario difende l’agricoltura biologica e i prodotti di qualità e segnala la presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) nelle derrate alimentari. A) Sicurezza alimentare La Comunità europea, al fine di ricostruire la fiducia dei consumatori dopo la crisi della cd. «mucca pazza» e dei «polli alla diossina» ha deciso di affrontare in maniera più sistematica la circolazione degli alimenti, adottando in primis il Libro Verde sui «Principi generali della legislazione in materia alimentare dell’Unione europea» e, successivamente, il Libro Bianco sulla «Sicurezza alimentare », nel quale si possono rilevare alcuni spunti in materia di «rintracciabilità» per istituire la cd. politica «dai campi alla tavola» e l’opportunità di istituire un’Autorità alimentare europea indipendente. Il Libro Bianco è stato la base sul quale è stato costruito il Regolamento (UE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Nel 2004, al fine di garantire la salubrità dei prodotti alimentari e di prevenire l’immissione in commercio di alimenti imperfetti, la Comunità europea ha adottato la direttiva 93/43 (cd. HACCP). L’articolo 3, paragrafo 2 della direttiva stabilisce che «le imprese del settore alimentare devono individuare nelle loro attività ogni fase che potrebbe rilevarsi critica per la sicurezza degli alimenti e garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le opportune procedure di sicurezza avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema HACCP». Anche in relazione all’entrata in vigore dei nuovi Paesi membri e, quindi, delle possibili difficoltà che ad essi si sarebbero presentate ad adottare norme in materia di HCCP trasfondendo una direttiva nel diritto interno, nel 2004 sono stati pubblicati tre Regolamenti comunitari: Regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari; Regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano. I tre Regolamenti, unitamente al Regolamento (CE) 882/2004, relativo ai controlli ufficiali su mangimi ed alimenti, costituiscono il cd. pacchetto igiene. B) Politica agricola di qualità La politica europea di qualità si è evoluta con la pubblicazione del Regolamento (UE) 1151/2012 sui «regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di Dop, Igp e Stg», conosciuto come «Pacchetto Qualità». Al Regolamento è seguito , in Italia, il Decreto recante le disposizioni nazionali per l’attuazione. Il Pacchetto qualità assume la caratteristica di vero e proprio strumento che accompagna la riforma della PAC in quanto si collega alla nuova OCM Unica e al Pacchetto latte, offrendo nuove possibilità di valorizzazione delle filiere di qualità. Il nuovo Regolamento disciplina in un unico testo le Dop, Igp e le Stg, semplifica e rafforza il sistema delle protezioni e rende possibile l’uso, assieme ai segni della qualità, di rappresentazioni grafiche, testi e simboli dell’area di appartenenza e dei marchi collettivi geografici. DOP: la denominazione di origine è un nome che identifica un prodotto originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinato, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani e le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata. IGP: l’indicazione geografica è un nome che identifica un prodotto originario di un determinato luogo, regione o paese, alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche e la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata. STG: è un nome che designa uno specifico prodotto o alimento ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento o ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente. Una vera novità del Regolamento (UE) 1151/2012 è rappresentata dalla possibilità di utilizzare elementi di differenziazione dell’origine dei prodotti Dop e Igp mediante l’uso di indicazioni facoltative di qualità (articolo 29). Le aree che beneficiano della possibilità di usare indicazioni facoltative per le loro IGP sono quelle di montagna e insulare (articoli 31 e 32). C) Produzione biologica La produzione ed il commercio di prodotti agricoli e alimentari biologici sono disciplinati dal Regolamento (CE) n. 834/2007 che sostituisce ed abroga il precedente Regolamento (CE) n. 2092/1991. Il metodo biologico vieta l’impiego di fattori produttivi ottenuti per sintesi chimica; limita l’uso di additivi, coloranti e aromi; esclude il ricorso al trattamento con radiazioni ionizzanti e ad organismi geneticamente modificati. Posto che nell’UE esiste una specifica disciplina (Regolamenti nn. 1829/2003 e 1830/2003) che impone precisi obblighi di etichettatura e di rintracciabilità degli OGM e degli alimenti geneticamente modificati, l’articolo 9 del Regolamento (CE) n. 834/2007 chiarisce che, se gli alimenti e i mangimi acquistati non sono etichettati, né accompagnati da un documento redatto ai sensi dei suddetti regolamenti, gli operatori sono legittimati a presumere che nella produzione degli stessi non si sia fatto uso di OGM o di prodotti derivati da OGM, a meno che non dispongano di altre informazioni secondo le quali l’etichettatura dei prodotti in questione non è conforme ai citati regolamenti del 2003. Ne deriva che detti alimenti o mangimi possono essere etichettati come biologici, o essere impiegati nella produzione di altri alimenti da etichettare come biologici (COSTATO). Le imprese attive nel settore biologico devono possedere il certificato di conformità rilasciato da un organismo di controllo, autorizzato dall’Autorità nazionale di controllo. La disciplina sulla produzione biologica interessa tanto la produzione primaria, quanto la produzione di alimenti trasformati, nonché la produzione di mangimi biologici e di materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione. Inoltre, il Regolamento (CE) n. 834/2007 stabilisce specifici requisiti in materia di etichettatura che si sommano a quelli generali previsti dal Regolamento (UE) n. 1169/2011. In particolare, è obbligatoria l’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materia prime agricole di cui il prodotto è composto, che compare nello stesso campo visivo del logo. Per i prodotti trasformati, l’uso del termine biologico è subordinato al fatto che almeno il novantacinque per cento degli ingredienti di origine agricola sia biologico. D) Gli organismi geneticamente modificati (OGM) Sono OGM quegli organismi viventi, vegetali o animali, che hanno subìto variazioni genetiche attraverso tecniche che intervengono con interpolazioni o sostituzioni di elementi del DNA dell’essere da modificare. La regolamentazione sugli OGM trae le mosse dalla Direttiva 90/220 «sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati», poi sostituita con la Direttiva 2001/18. Oggi, le regole sono state cambiate con l’adozione dei Regg. nn. 1829-1830/2003. Il Regolamento CE 1829/2003, modificato da ultimo dal Regolamento CE 298/2009, integra il Regolamento CE 1830/2003 concernente la tracciabilità e l’etichettatura degli organismi geneticamente modificati. Il regolamento si applica a tre tipi di prodotti: gli organismi geneticamente modificati destinati all’alimentazione umana e animale; gli alimenti e i mangimi contenenti OGM; gli alimenti e i mangimi prodotti a partire da o che contengono ingredienti prodotti a partire da OGM. Il regolamento prevede una procedura unica di autorizzazione per i prodotti alimentari contenenti OGM. L’operatore industriale presenta un’unica domanda per gli utilizzi alimentari e per la coltivazione. Ciò significa che l’OGM che ha ottenuto un’autorizzazione non solo può essere utilizzato nell’alimentazione, ma può anche essere utilizzato per la coltivazione o l’emissione deliberata nell’ambiente. I prodotti alimentari che contengono OGM devono essere etichettati come tali. La loro etichetta deve chiaramente riportare la dicitura «geneticamente modificato» o «prodotto da (nome dell’ingrediente) geneticamente modificato». Gli alimenti che contengono OGM in una proporzione non superiore allo 0,9% per ciascun ingrediente non vengono etichettati come OGM, purché la presenza di organismi geneticamente modificati sia accidentale o tecnicamente inevitabile. Tutti gli organismi geneticamente modificati e i prodotti derivati destinati all’alimentazione devono soddisfare i requisiti di etichettatura previsti dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 1830/2003 sulla tracciabilità e l’etichettatura degli OGM. La presenza di OGM nelle coltivazioni tradizionali è difficile da evitare. Tracce minime di OGM nei prodotti alimentari sono tollerate se la loro presenza è accidentale o se risulta da una contaminazione tecnicamente inevitabile nel corso della coltivazione, del raccolto, del trasporto o della lavorazione. Gli operatori devono essere in grado di dimostrare alle autorità la natura accidentale o tecnicamente inevitabile della presenza di OGM in un prodotto alimentare. L’Unione europea garantisce la tracciabilità e l’etichettatura degli organismi geneticamente modificati e dei prodotti ottenuti da OGM, lungo tutta la catena alimentare. La tracciabilità degli OGM consente il controllo e la verifica delle indicazioni figuranti sulle etichette, la sorveglianza degli effetti sull’ambiente e il ritiro degli OGM potenzialmente pericolosi per la salute dell’uomo o degli animali. Il regolamento CE 1830/2003 concernente la tracciabilità e l’etichettatura degli OGM e dei prodotti ottenuti da OGM prevede l’obbligo della tracciabilità lungo tutta la filiera alimentare. Tale misura ha due obiettivi principali: informare i consumatori grazie all’etichettatura obbligatoria di questo tipo di prodotti; creare una «rete di sicurezza» grazie alla tracciabilità di tali prodotti in tutte le fasi della fabbricazione e della commercializzazione. Questa «rete di sicurezza» permetterà il controllo e la verifica delle indicazioni nutrizionali che figurano sulle etichette, la sorveglianza degli effetti potenziali per la salute umana o per l’ambiente e il ritiro dei prodotti qualora si constati un rischio inatteso per la salute umana o l’ambiente. L’etichettatura riguarda tutti i prodotti alimentari prodotti utilizzando OGM. Tutti i prodotti autorizzati in base al regolamento devono essere oggetto di etichettatura obbligatoria, la quale consente al consumatore di essere meglio informato sui prodotti OGM destinati al consumo da parte dell’uomo ovvero degli animali. La sicurezza del consumatore è garantita grazie alla tracciabilità dei prodotti OGM o che contengono OGM. Per migliorare la tracciabilità degli OGM e proteggere l’ambiente, il regolamento richiede che gli operatori trasmettano le seguenti informazioni: l’indicazione che i prodotti sono OGM o ne contengono; l’identificatore alfanumerico corrispondente agli OGM contenuti nei prodotti. Questo sistema di identificazione unico degli OGM consente di conoscere gli aspetti e le caratteristiche peculiari di tali prodotti ai fini della sorveglianza della tracciabilità. Nel caso di prodotti OGM o contenenti miscele di OGM, l’operatore industriale può trasmettere una dichiarazione di utilizzazione di tali prodotti unitamente ad un elenco degli identificatori unici assegnati a tutti gli OGM che sono stati utilizzati per costituire la miscela. Inoltre, il regolamento prevede che chi commercializza un prodotto preconfezionato OGM o che contenga OGM, debba ad ogni livello della catena di produzione e di distribuzione controllare che l’indicazione «questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati» o «questo prodotto contiene (nome dell’organismo)» figuri su un’etichetta apposta sul prodotto. Se si tratta di prodotti, anche in grandi quantità, non confezionati e se l’utilizzazione di un’etichetta risulta impossibile, l’operatore deve fare in modo che tali informazioni siano trasmesse unitamente al prodotto. Esse possono configurarsi, ad esempio, come documenti di accompagnamento. In occasione della commercializzazione di prodotto alimentare elaborato utilizzando OGM, l’operatore industriale deve trasmettere in forma scritta all’operatore che riceve il prodotto le seguenti informazioni: un’indicazione di ogni ingrediente alimentare prodotto utilizzando OGM; un’indicazione di ogni materia prima o additivo per alimenti per animali prodotti utilizzando OGM; se non vi è un elenco di ingredienti, sul prodotto si deve perlomeno indicare che è stato elaborato utilizzando OGM. Questionario 1. Le imprese agricole sono soggette al divieto degli aiuti di Stato? (par. 2) 2. Come funziona la politica dei prezzi in ambito agricolo? (par. 3) 3. Quali sono le finalità della PAC? (par. 4) 4. Cosa è il «Pacchetto qualità»? (par. 5) 5. Cosa si intende per metodo biologico? (par. 5) Capitolo 3 L’impresa e l’azienda agricola Sommario 1. Definizione e requisiti dell’impresa agricola. - 2. L’azienda agraria. - 3. I beni dell’azienda agraria. - 4. Gli instrumenta fundi. - 5. Gli altri beni dell’azienda agraria. - 6. Limitazioni alla proprietà agraria. - 7. Modi tipici di costituzione dell’impresa agricola. 8. Modi speciali di costituzione. 1. Definizione e requisiti dell’impresa agricola Il legislatore del 2001, riformulando l’art. 2135 c.c., ha ribadito la scelta operata dal legislatore del 1942 di offrire non la definizione di impresa bensì quella di imprenditore agricolo, ossia di colui il quale esercita l’attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Oggi non può essere messo in dubbio che la nuova formulazione dell’imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 c.c. si ricolleghi alla definizione dell’art. 2082 c.c., dando atto di un soggetto che «esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi». In altre parole, l’impresa agricola è un’impresa in senso tecnico e l’imprenditore agricolo, come definito dall’art. 2135 c.c., non è mai stato un semplice produttore (GERMANÒ). L’impresa agricola gode, in linea di massima, di un trattamento di favore rispetto a quella commerciale, in ragione delle particolarità legate all’esercizio dell’attività agricola da individuarsi nel rischio ambientale, da un lato, che ha inevitabili ripercussioni sui cicli produttivi, e nel rischio di mercato, dall’altro, a causa della non elasticità della domanda sia rispetto al prezzo del prodotto (cd. legge di King) sia rispetto al reddito del consumatore (cd. legge di Engel). Tali privilegi consistono nell’esonero per l’impresa agricola, ancorché esercitata in forma societaria, dalle procedure di fallimento e concorsuali e dall’esenzione dell’obbligo della tenuta delle scritture contabili. Le imprese agricole sono state esonerate dall’obbligo di iscrizione al registro delle imprese di cui all’art. 2188 c.c. sino all’entrata in vigore dell’art. 8 della L. 29 dicembre 1993 n. 580 sul riordino delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; tale legge impose l’obbligo di iscrizione, con funzione di mera pubblicità notizia e di certificazione anagrafica, nella sezione speciale del registro delle imprese, obbligo successivamente ribadito dall’art. 2 del D.P.R. 14-121999, n. 558 che ha provveduto ad un riordino delle varie sezioni speciali del registro. Con l’art. 2 del D.Lgs. 228/2001 si è fatto un ulteriore, decisivo, passo avanti verso l’omologazione delle imprese agricole con quelle commerciali. Gli imprenditori agricoli, infatti, sono ora tenuti a registrare tutti i «fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione» se li vogliono opporre ai terzi, salvo non provino che tali terzi non ne abbiano avuto altrimenti conoscenza. Sempre i terzi non potranno invocare la loro ignoranza qualora tali fatti siano stati iscritti nel registro delle imprese. In questo modo è stata riconosciuta, anche all’iscrizione delle imprese agricole nella sezione speciale, efficacia dichiarativa. Nell’impresa agricola ritroviamo i connotati distintivi dell’impresa in generale, con qualche ulteriore caratterizzazione: economicità: questo requisito denota l’attitudine dell’attività a produrre ricchezza, come pure il relativo fine di lucro e la potenziale destinazione dei suoi risultati al mercato. Si ricordi, tuttavia, che per alcuni autori (OPPO, BIGIAVI) ricorre il fenomeno dell’impresa anche laddove il risultato dell’attività non venga destinato a terzi, ma fatto proprio dal produttore e dai suoi familiari (la cd. impresa per conto proprio); professionalità: tale espressione postula un’attività abituale, stabile e continuativa svolta dall’imprenditore. Resta esclusa, in altre parole, l’attività occasionale o sporadica. La continuità è una caratteristica intrinseca all’attività agricola che non può, per sua natura, consistere in un unico atto economicamente rilevante (l’arare, il seminare, il raccogliere, non possono essere considerati isolatamente). Non è inconciliabile con il requisito in esame neanche la circostanza che l’attività svolta non sia unica: in altre parole si ammette pacificamente la contestuale titolarità, da parte dello stesso soggetto, di un’impresa agricola e di una commerciale. Si precisa che il requisito della professionalità, riferito al settore agricolo, viene caricato da una più incisiva presenza dell’imprenditore nell’attività d’impresa. Si pensi, ad esempio, all’art. 1647 c.c. che, in tema di affitto a coltivatore diretto, richiede all’affittuario un rapporto lavorativo prevalentemente personale e della sua famiglia; organizzazione: l’attività deve essere espletata in una struttura composita costituita da persone e beni. L’organizzazione non pretende ampie e rilevanti proporzioni: anche l’organizzazione del proprio lavoro, sia se elementare, sia se altamente sofisticato, è sufficiente affinché ricorra tale requisito; inoltre, non è necessario che il capitale sia rappresentato da impianti industriali o da stabilimenti più o meno imponenti, ma è sufficiente quel minimo di beni che sono indispensabili per l’esercizio dell’attività economica organizzata. 2. L’azienda agraria L’art. 2555 c.c. recita: «l’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa». Da questa nozione si evince la strumentalità dell’azienda rispetto all’impresa, ponendosi la prima come un’organizzazione di beni (non necessariamente di proprietà dell’imprenditore, che può averne anche solo la mera disponibilità, come nel caso dell’affitto), finalizzati all’esercizio dell’impresa. Quando si tratta di aziende agricole è necessario dare rilievo al concetto di fondo attrezzato che rappresenta il «complesso pertinenziale posto in essere dal titolare del diritto reale sul bene principale (la terra) che può non coincidere con il conduttore» (L. Costato, 2008). A ben vedere, la nozione di fondo non coincide con l’azienda, poiché in essa sono compresi contratti, crediti e debiti, oltre ad altri possibili beni immateriali facenti capo ad essa, quali i marchi, ditta etc. Elementi costitutivi del fondo sono: il suolo, i corsi d’acqua e i miglioramenti in esso incorporati per opera dell’uomo o della natura. Considerato dal punto di vista dell’organizzazione produttiva, rientrano nel fondo anche le pertinenze e i diritti strumentali (cd. iura fundi) al funzionamento dell’impresa (vedi amplius infra). Quali sono le differenze tra azienda agricola e fondo attrezzato? Autorevole dottrina ritiene che non possa accettarsi la tesi secondo la quale vi sia, in agricoltura, perfetta assimilazione tra fondo rustico ed aziendale, tesi ricorrente nella manualistica italiana e secondo cui «esercitare il diritto di proprietà sul fondo attrezzato equivale ad esercitare l’impresa agricola» (VALERI). L’azienda agricola (ovvero il complesso aziendale di cui all’art. 2555 c.c.), invece, tanto più si distingue dal fondo attrezzato quanto più si proceda a tenere distinte la proprietà della terra e l’attività economica su di essa esercitata, posto che non è facile cogliere tale differenza quando sia imprenditore agricolo lo stesso proprietario del fondo rustico (GERMANÒ). Si ritiene che l’equivoco della manualistica italiana sia da attribuire al momento storico di entrata in vigore del codice del 1942, in cui la fisionomia del fondo così come era stato attrezzato dal proprietario non subiva modifiche nel caso di affitto, visto che l’art. 1617 c.c. obbligava il locatore a consegnare la cosa con le sue pertinenze. Il legislatore del 1942, quindi, aveva optato per un perfetto parallelismo tra impresa agricola e fondo attrezzato da un lato, e impresa commerciale e azienda dall’altro, nel senso che l’azienda agricola non fosse altro che il fondo con le sue pertinenze. Oggi, però, la realtà è più complessa, in quanto concorrono nell’organizzazione necessaria per un esercizio moderno dell’agricoltura non solo il fondo e gli attrezzi, ma anche altre entità che sono acquisite solo ed esclusivamente da colui che svolge l’attività imprenditoriale (GERMANÒ). Lo spostamento dell’attenzione verso l’imprenditore quale costitutore dell’organizzazione è stato provocato dalla stessa legislazione speciale sull’affitto di fondi rustici che, per il fatto che il canone era quantificato sulla base del reddito dominicale del terreno, senza che avesse rilevanza l’attrezzatura occorrente per la coltivazione, ha spinto i proprietari ad escludere le pertinenze dalla concessione del godimento dei loro terreni e, quindi, ad affittare fondi prevalentemente privi di res accessorie. Se si richiamano alla mente le ricchezze che un agricoltore può organizzare per l’esercizio della sua attività, si può concludere che, oltre al fondo rustico e agli attrezzi, l’operatore agricolo può servirsi dei beni immateriali della ditta, dell’insegna, del marchio, del brevetto di nuove varietà vegetali ecc. Si tratta di situazioni soggettive attive che, per l’essere prive del tratto della corporalità, non possono essere le cose del complesso pertinenziale e si tratta di beni esclusivi di aziende organizzabili nel settore economico dell’agricoltura. Per cui, non può essere messa in dubbio l’esistenza, sul piano dell’Ordinamento, di complessi di beni cui spetti la qualifica di azienda agricola (GERMANÒ). A) L’avviamento Si definisce avviamento l’attitudine del complesso aziendale a produrre un risultato economico positivo. I singoli beni che compongono l’azienda hanno un determinato valore; i macchinari utilizzati, ad esempio, hanno un prezzo e a quel prezzo vengono acquistati dall’imprenditore. Ma l’azienda nel suo complesso, cioè tutti i beni che la compongono e che sono organizzati dall’imprenditore, ha sempre un valore maggiore rispetto alla somma dei valori dei singoli beni: questo maggior valore è detto avviamento, il quale trova espresso riconoscimento nella legge. L’avviamento rappresenta, quindi, la capacità produttiva dell’azienda, la sua attitudine a una probabilità di guadagni e, perciò, l’aspettativa di lucri, di cui coefficiente è la clientela, ovverosia l’insieme delle persone che, tendenzialmente in modo permanente, domandano i prodotti e i servizi di quell’imprenditore (GERMANÒ). Così definito l’avviamento, la qualità dell’azienda dipende: a) dall’ubicazione, o avviamento di posizione; b) dall’organizzazione oggettivamente intesa (qualità degli impianti, utilizzabilità di brevetti, competenza dei dipendenti) o avviamento oggettivo; c) dalla capacità e prestigio dell’imprenditore (avviamento soggettivo). Ma poiché, in ultima analisi, tutto dipende dall’imprenditore (anche la scelta del luogo dove impiantare l’azienda e dei dipendenti e collaboratori), l’avviamento esprime la capacità del soggetto di avere successo negli affari. Quest’ultima interpretazione, trasferita all’agricoltura, non era però accolta dalla dottrina, e ciò era dovuto all’assimilazione dell’azienda agricola con il fondo attrezzato, per cui si attribuiva alla qualità della terra la capacità di profitto del complesso organizzato dall’agricoltore. In altre parole, le possibilità di guadagno dell’agricoltore si facevano dipendere esclusivamente da fattori connessi al suolo e da questo inscindibili, come la posizione geografica del fondo rustico, la natura geologica del terreno che incide sulla fertilità ecc. Oggi, invece, non si può negare che la probabilità di guadagni dell’agricoltore dipende non solo dal fatto che ha impiantato l’azienda su un terreno fertile, ma anche perchè ha introdotto coltivazioni adatte, eseguito miglioramenti, scelto collaboratori agricoli efficienti, procurato ai suoi prodotti rilevanti sbocchi sul mercato, attratto la clientela con marchi di prestigio, con attestati di qualità ecc., quindi tutti fattori che vanno oltre le qualità connesse al fondo. B) La cessione dell’azienda L’azienda può essere alienata dall’imprenditore o, anche, data in affitto o in usufrutto: in tutte queste ipotesi la legge pone a carico dell’imprenditore alienante o dante causa un divieto di concorrenza. L’art. 2557 c.c. dispone, infatti, che l’alienante un’azienda commerciale deve astenersi, per un periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova attività che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta. Due sono, a tal proposito, le considerazioni da farsi: innanzitutto, nell’ipotesi di trasferimento dell’azienda per compravendita, per usufrutto ed affitto, il cessionario aspira all’intero potenziale economico espresso dall’organizzazione aziendale e, dunque, anche alla clientela la cui conservazione è, poi, quel coefficiente su cui occorre contare per sperare in futuri guadagni. In secondo luogo, tra i possibili concorrenti del cessionario è il cedente quello che riveste la posizione più pericolosa, non solo perchè conosce i punti deboli dell’azienda ceduta, ma anche perchè per lui è facile recuperare la vecchia clientela. Ne consegue che, se in seguito alla cessione dell’azienda non fosse imposto al cedente un divieto di concorrenza, si vanificherebbero le aspettative dell’acquirente, perchè in sostanza gli si impedirebbe di subentrare nella titolarità di un’azienda corrispondente a quella del cedente (GERMANÒ). Per quanto riguarda l’azienda agricola, il legislatore detta una specifica disciplina per la sua cessione. Il comma 5 dell’art. 2557 c.c. stabilisce che il divieto di concorrenza è imposto al cedente l’azienda agricola solo nel caso in cui siano svolte attività connesse e quando rispetto ad esse sia possibile lo sviamento di clientela. In altre parole, il principio del divieto temporaneo di concorrenza in caso di cessione di azienda non vale nell’ipotesi di cessione di azienda agricola, ma torna a valere quando si tratti di cessione di azienda agricola organizzata anche per l’esercizio di attività connesse, quindi di attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti (anche altrui purché non prevalenti), nonché la fornitura di servizi, l’esercizio di attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, l’esercizio di ricezione e ospitalità di tipo turistico. La ratio di questa eccezione si spiega considerando che il cedente, qualora volesse continuare a fare l’agricoltore, dato il carattere finito del fattore produttivo terra, non ha la possibilità di costituire ex novo un’azienda, potendosi solo insediare su altra azienda agricola già esistente, migliorandone, se ne è capace, l’organizzazione. Conseguentemente, qualora voglia fare (o non sappia fare altro che) l’agricoltore, non gli si può impedire di impiantare un’altra azienda su un altro fondo rustico, purché la sua nuova impresa sia limitata alle attività essenzialmente agricole della coltivazione, della silvicoltura e dell’allevamento, senza estendersi, per cinque anni, alle attività connesse in precedenza esercitate nell’azienda ceduta (GERMANÒ). C) Il subentro del cessionario nei contratti dell’azienda ceduta L’azienda è composta da una pluralità di beni che possono appartenere all’imprenditore anche a titolo diverso dalla proprietà. Beni aziendali, infatti, sono non solo le cose corporali, ma anche beni immateriali, servizi, diritti di credito, contratti, autorizzazioni e concessioni amministrative, che costituiscono, appunto, la «ricchezza» dell’azienda. Se l’acquirente dell’azienda deve acquistarne l’intero potenziale economico, c’è bisogno che con l’unico negozio di trasferimento dell’azienda si realizzi la circolazione dei diritti sui beni corporali e immateriali e delle posizioni giuridiche attive e passive correlate ai contratti e alle autorizzazioni o concessioni amministrative che la compongono. È per questo che il codice disciplina, in caso di cessione di azienda, la circolazione dei contratti (art. 2558 c.c.); dei crediti (art. 2559 c.c.); dei debiti aziendali (art. 2560 c.c.); dei contratti di consorzio (art. 2610 c.c.) e di quelli di lavoro (art. 2112 c.c.); di mezzadria e colonia parziaria (art. 2160 c.c.), derogando alle norme ordinarie di circolazione dei contratti, dei crediti e dei debiti. Gli articoli 2559 e 2560 c.c., relativi alla circolazione dei crediti e debiti aziendali, trovano applicazione anche nell’ipotesi di alienazione delle aziende agricole, essendo richiesto, per i crediti, che il trasferimento dell’azienda venga iscritto nel registro delle imprese e, per i debiti, che gli stessi risultino dai libri contabili (dato che gli obblighi di iscrizione e di tenuta dei libri sono imposti anche all’imprenditore agricolo). Per quanto riguarda la disciplina dei contratti conclusi dall’imprenditore alienante, essa è la stessa in tutte le ipotesi: l’acquirente subentra nel contratto, salvo la possibilità del contraente ceduto di recedere dallo stesso, entro un anno o tre mesi dalla notizia del trasferimento, qualora sussista una giusta causa o per mera sua volontà contraria nei casi di contratto di lavoro o di contratto agrario associativo. Al di là dei casi specifici di circolazione dei contratti di consorzio, di lavoro, nonché dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura (per i quali è stabilito espressamente che il cedente debba dichiarare, nell’atto di cessione dell’azienda, l’esistenza di tali contratti e il cessionario debba impegnarsi a rispettarne le clausole e a garantirne l’esecuzione, pena il risarcimento dei danni), il legislatore detta all’art. 2558 c.c. la disciplina generale del subentro, da parte dell’acquirente dell’azienda, dei contratti stipulati dall’imprenditore alienante, stabilendo che se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale. È necessario fare tre considerazioni: il subentro nella posizione attiva e passiva di contraente avviene ex lege, quale effetto automatico del contratto di trasferimento di azienda senza che occorra il procedimento di cui all’art. 1406 c.c. che, per la cessione del contratto, pretende il consenso del contraente ceduto; la possibilità di escludere pattiziamente dal trasferimento dell’azienda alcuni contratti è limitata ai contratti dell’impresa, cioè quei contratti che l’imprenditore stipula per l’esercizio della sua attività, dovendosi escludere dall’eventuale patto contrario i contratti con cui sono stati acquistati i beni essenziali per la stessa esistenza dell’azienda; infine, è necessario che i contratti non abbiano carattere personale, cioè non siano caratterizzati dalla natura strettamente infungibile della prestazione che, per sua natura o per disciplina legale, non è trasmissibile mortis causa né cedibile inter vivos (GERMANÒ). A questo punto bisogna dire che se il trasferimento dell’azienda comporta necessariamente il trasferimento dei beni essenziali, mentre quelli non essenziali (come la ditta e il marchio individuale) possono anche non essere trasferiti, ne deriva che la cessione dell’azienda agricola comporta che il cessionario acquisti sulla terra e sul bosco lo stresso diritto che il cedente aveva su tali beni. Non sorge nessun problema quando l’imprenditore agricolo è proprietario della terra o del bosco, in quanto la funzionalità di tali beni per l’esercizio dell’attività di coltivazione del campo o della selva fanno sì che la terra sia necessariamente oggetto di cessione, quindi che faccia parte dell’azienda ceduta. Il problema si pone, invece, se l’imprenditore agricolo è titolare del diritto di godimento della terra in forza di un contratto di affitto. In tal caso, poiché la terra è bene fondamentale dell’azienda agricola, se il titolare dell’azienda non fosse in grado di far subentrare l’acquirente nel contratto di affitto del fondo rustico e si limitasse a trasferirgli solo gli altri beni (trattori, macchine ecc.) non si avrebbe cessione di azienda perchè l’acquirente non potrebbe esercitare la stessa attività del cedente. D) La cessione dell’azienda costituita su terreno altrui: la cessione dell’affitto inter vivos Per quanto riguarda la possibilità di cedere il contratto di affitto di fondo rustico, l’art. 21 L. 203/1982 vieta i contratti di subaffitto, di sublocazione e comunque di subconcessione dei fondi rustici, tralasciando di inserire, nel divieto, la cessione dell’affitto. L’omissione della fattispecie della cessione dell’affitto nella formula del divieto di cui all’art. 21 della L. 203/1982 è stata volutamente disposta dal legislatore, per cui oggi la cessione del contratto di affitto di fondi rustici non è vietata e la sua disciplina è rimessa alle regole ordinarie del codice civile, cioè gli articoli 1406 e 1594 che richiedono solo il consenso del ceduto. La conferma di tale conclusione può essere rinvenuta anche nella considerazione secondo cui l’ammissibilità della cessione dell’affitto secondo la regola degli articoli 1406 e 1594 c.c., da un lato, e il divieto di subaffitto a norma dell’art. 21 della L. 203/1982, dall’altro, sono perfettamente coerenti con la dottrina che riconosce nell’affitto un contratto costitutivo di impresa. Infatti, nella cessione del contratto si ha sempre un solo contratto di affitto, ovvero un solo contratto per l’impresa, mentre nel subaffitto si avrebbero due contratti di affitto ma una sola impresa, e cioè quella del subaffittuario, con la conseguenza che la condotta dell’affittuario che subaffitti è molto più grave rispetto a quella di colui che cede il suo contratto, perchè tramite il mantenimento del proprio originario contratto e la stipulazione del contratto di subconcessione, il subaffittante opera una speculazione (GERMANÒ). 3. I beni dell’azienda agraria L’imprenditore, per esercitare l’impresa, ha bisogno di un’organizzazione: l’organizzazione di beni di cui si serve è detta azienda (art. 2555 c.c.). Tali beni non sono semplicemente cose, come i beni mobili ed immobili, ma anche beni immateriali che, tramite l’organizzazione, assumono la qualità di elementi dell’azienda. Tra i beni dell’azienda rientrano, innanzitutto, la terra, il bosco e il bestiame; poi, gli attrezzi e le macchine; i vari beni immateriali di cui l’agricoltore può servirsi per l’immissione dei suoi prodotti e servizi sul mercato; i contratti necessari all’imprenditore nell’organizzazione della sua attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento. La caratteristica dell’azienda agricola, che la distingue nettamente dall’azienda commerciale, è la presenza di un bene – la terra, per l’impresa di coltivazione; il bosco, per l’impresa silvicolturale; il bestiame per l’impresa zootecnica – che è al centro dell’organizzazione, la quale si svolge in modo concentrico, posto che gli altri beni vengono combinati e coordinati con riferimento alla superficie e alla qualità del terreno o al numero e al genere degli animali. Si tratta di beni fondamentali che finiscono con il «condizionare» tutti gli altri (GERMANÒ). A) Il fondo rustico Per il combinato disposto degli artt. 41 e 44 Cost., l’iniziativa economica che ha ad oggetto un fondo rustico è doverosa, perchè la conversione di esso a strumento di produzione dell’impresa agricola è prevista direttamente dall’Ordinamento che, appunto, stabilisce vincoli e impone obblighi al proprietario terriero in vista del reale sfruttamento del suolo e dello stabilimento di equi rapporti sociali. La destinazione della terra all’agricoltura discende dall’attività programmatoria della pubblica amministrazione, diretta a stabilire l’uso corretto delle risorse e la corretta gestione del territorio. Quando, mediante gli strumenti urbanistici (piani territoriali delle Regioni e delle Province e piani regolatori dei Comuni) si individuano le aree urbane e quelle agricole differenziandone l’impiego, tale qualificazione del terreno come area agricola è capace di elevarlo a strumento produttivo dell’impresa che doverosamente su di esso dovrà costituirsi. L’attribuzione alla P.A. della potestà conformativa dei beni immobili con la determinazione della destinazione d’uso dei suoli incide, indirettamente, sulla libertà di iniziativa economica del soggetto sul terreno di sua proprietà. Sicché può dirsi che la pubblica amministrazione svolge un ruolo nella creazione dell’impresa in agricoltura. La volontà del titolare del diritto di godimento di un terreno di esercitarvi l’attività economica primaria presuppone, infatti, che il terreno sia contrassegnato, nel programma pubblico di governo del territorio, dalla sua destinazione agricola (GERMANÒ). B) Il suolo È questo il principale elemento costitutivo del fondo che, da un lato, rappresenta l’oggetto dell’attività di coltivazione; dall’altro, si configura come espressione dell’incremento di ricchezza dovuta al lavoro umano. Ai fini dell’individuazione del fondo rustico, il suolo rileva nella sua estensione, ovverosia per la sua superficie e per i suoi confini, per i quali bisogna distinguere: per i confini in senso verticale vige attualmente il criterio della possibilità, nel senso che il titolare del fondo è abilitato ad esercitare i suoi diritti nella misura in cui ciò può avvenire senza ledere la sfera altrui. Emblematico è l’art. 840 c.c., dal quale si evince che i poteri del titolare sopra e sotto il suolo incontrano i limiti della protezione dell’interesse pubblico, nonché dei possibili danni al vicinato: in ogni caso, il proprietario del fondo non può legittimamente opporsi a che terzi svolgano attività a profondità o altezze tali che egli non abbia interesse ad escludere; per i confini in senso orizzontale (che circoscrivono l’attività di coltivazione del titolare del fondo) il codice detta tutta una serie di disposizioni (artt. 897-899 c.c.), da osservarsi in caso di incertezza e inerenti: alle distanze legali nelle costruzioni; alle luci e vedute; alle distanze per fossi e canali; alle distanze per gli alberi; alla comunione di fossi, siepi e alberi. In merito ai confini orizzontali del fondo il proprietario ne può richiedere la chiusura, costruendo recinti o mura ma deve permettere l’accesso e il passaggio a terzi per l’esercizio della caccia (art. 842 1); la costruzione o riparazione di un muro o di altra opera del vicino o comune (art. 843 1); il recupero da parte del confinante della sua cosa che si trovi sul fondo accidentalmente, o del suo animale sfuggito alla custodia (art. 843 2). Inoltre, la legge appronta due diverse azioni a tutela dei diritti dei proprietari del suolo: l’azione di regolamento dei confini (art. 950 c.c.), in cui non si contesta la titolarità del diritto, bensì si vuole accertare l’esatto confine tra fondi; l’azione di apposizione di termini (art. 951 c.c.), che si esperisce quando è certa l’espansione dei relativi fondi, ma difettano o sono divenuti irriconoscibili i confini. Anche se il fondo come detto rimane ancora l’elemento prevalente dell’attività agricola va tenuto conto che oggi esiste una vasta tipologia di aziende agricole. Ad esempio, nelle imprese che svolgono attività di allevamento di vegetali o animali acquatici la terra è sostituita dagli specchi d’acqua mentre nelle imprese di produzione di funghi dalle grotte o dai capannoni. C) Le acque Tra gli elementi del fondo rustico erano comprese le acque qualora queste, sia superficiali che sotterranee, non avessero avuto attitudine ad usi di pubblico generale interesse, ovvero non fossero pubbliche. Il proprietario del fondo, infatti, poteva da esso estrarre acqua con il divieto, tuttavia, di recisioni delle vene altrui, così come poteva servirsi delle acque, non pubbliche, scorrenti sul suo terreno o al confine di esso. La L. 36/1994 ha dichiarato pubbliche tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal suolo, affermandone la qualità di risorsa da salvaguardare e da utilizzare secondo criteri di solidarietà, e la disposizione risulta ora inserita nell’art. 144 del D.Lgs. 152/2006 (Codice ambientale). Di conseguenza, è venuto meno il diritto, a titolo di proprietà, di apprendere le acque sorgenti nel fondo o fluenti sopra o sotto di esso, essendo rimasto al titolare del terreno, per le situazioni pregresse, un diritto di derivazione dell’acqua nella misura già utilizzata o, per le situazioni nuove, la possibilità di chiedere alla pubblica amministrazione una concessione di utenza. D) I miglioramenti In linea di massima, il miglioramento consiste in un’opera posta in essere dall’uomo, avente ad oggetto un bene preesistente, al fine di aumentarne il valore o la produttività. Il risultato di questa attività resta strettamente legato al bene tanto da non essere più possibile distaccarlo. Si distingue dal miglioramento l’addizione, che non necessariamente comporta un aumento di valore della cosa principale e, di regola, può essere da quest’ultima agevolmente distaccata poiché conserva una propria individualità. Il miglioramento agrario si caratterizza, rispetto a quello civilistico, perché non determina soltanto un generico aumento di valore, ma soprattutto un incremento della capacità produttiva del fondo. In altre parole, esso opera su un preesistente fondo adibito ad una destinazione agricola. I miglioramenti, in quanto opere nuove e investimenti di capitale, non possono essere confusi con le spese di conservazione (es., riparazione del tetto della casa colonica o degli edifici aziendali) e vanno distinti anche da quelle operazioni che producono sì un aumento di valore del fondo, senza però incidere sulla produttività (es., costruzione della casa padronale). È utile distinguere, relativamente al miglioramento agrario, due profili: quello soggettivo, che individua i legittimati attivi all’esecuzione della miglioria nei titolari del fondo (ad esempio, oltre al proprietario, l’enfiteuta, il possessore o l’acquirente nella vendita con patto di riservato dominio). Tali soggetti, in quanto agiscono nel proprio interesse, non hanno diritto in genere ad alcun compenso per i miglioramenti apportati. Regole particolari valgono, tuttavia, per l’usufruttuario che, ai sensi dell’art. 985 c.c. ha diritto a un’indennità pari alla minor somma tra l’importo della spesa e l’aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti; per il possessore che, se in buona fede, al momento della restituzione dell’immobile ha diritto ad un’indennità «nella misura dell’aumento di valore conseguito dalla cosa, per effetto dei miglioramenti»; se di mala fede ha diritto alla «minor somma tra l’importo della spesa e l’aumento di valore» (art. 1150 c.c.); quello oggettivo, che permette di distinguere i miglioramenti dalle spese fatte per la conservazione del fondo. Queste ultime, infatti, attengono più alla gestione patrimoniale che non all’incremento produttivo del fondo e, inoltre, spesse volte non hanno carattere duraturo, essendo limitate a pochi cicli agrari. Esempi di miglioramento fondiario possono considerarsi: la plantatio, che ha ad oggetto la trasformazione delle colture, oppure la inaedificatio, che ha ad oggetto la costruzione sul fondo rustico di fabbricati rurali o altri manufatti (come gli impianti di irrigazione). Da evidenziare, infine, che in caso di affitto agrario, la legge riconosce ad entrambe le parti il potere di eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni, stabilendo però che, in ipotesi di mancato accordo, debba essere richiesta dall’interessato un’apposita autorizzazione all’ispettorato provinciale dell’agricoltura (art. 16 L. 203/1982). Nel caso siano rispettate le previsioni di legge il locatore che abbia realizzato dette opere può chiedere l’aumento del canone corrispondente alla nuova classificazione del fondo, mentre l’affittuario che abbia eseguito le opere medesime ha diritto ad un’indennità corrispondente all’aumento di valore del fondo stesso (art. 17 L. 203/1982). 4. Gli instrumenta fundi Sono questi i cd. elementi accessori del fondo che, unitamente a quelli costitutivi, formano l’impianto dell’impresa agricola. Rientrano in tale nozione le pertinenze e i diritti del fondo, il cui carattere comune consiste nella loro destinazione a servizio del fondo medesimo, al fine di incrementarne la produttività. A) Le pertinenze Ai sensi dell’art. 817 c.c. «Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima». È questa la nozione di pertinenza accolta dal legislatore del codice civile, che ne ha evidenziato la componente soggettiva, identificabile nell’atto di volontà del titolare della cosa principale di destinare una cosa (per lo più mobile) al servizio od ornamento della prima. La nozione di pertinenza agraria, invece, appare più specifica, dal momento che concorre ad integrare il profilo soggettivo una non meno rilevante componente oggettiva, che conferisce al concetto quella peculiarità data dalla presenza di un fondo rustico. Pertanto, pertinenza agraria sarà quella cosa che il titolare (chi è proprietario o vanta un altro diritto reale) del fondo agricolo ha destinato stabilmente con un suo atto di volontà al servizio del medesimo fondo, al fine di incrementarne la produttività. Di conseguenza, tratti comuni tra la nozione suesposta e quella civilistica sono: la presenza di un atto di destinazione proveniente dal proprietario o dal titolare di un diritto reale diverso sulla cosa principale, che non ha natura negoziale, ma si esprime attraverso un comportamento che incide sulla situazione preesistente, modificandola; la creazione di un nesso funzionale tra la cosa principale e l’accessoria, nel senso che quest’ultima viene posta in modo duraturo al servizio della prima. La pertinenza agraria, rispetto a quella civile, richiede inoltre un’obiettiva idoneità della cosa alla destinazione accessoria (elemento oggettivo). Si rileva che, nel settore agricolo, la cosa principale è il fondo, mentre le pertinenze si identificano con tutte quelle cose (mobili o immobili) poste al servizio del primo al fine di realizzarne una maggiore produttività (si pensi, ad esempio, alle sementi, ai concimi, alle macchine agricole). Dottrina Contrariamente alla giurisprudenza, che accoglie la suesposta nozione estensiva, alcuni autori (GALLONI) ritengono che possano costituire pertinenze solo le cose mobili, configurandosi quelle immobili o come parte del fondo (come nel caso di un piccolo appezzamento di terreno annesso al fondo rustico) o come miglioramenti dello stesso. Sotto il profilo soggettivo si rileva un atto non negoziale (che, come tale, può essere sempre revocato da chi ne ha il relativo potere), mediante il quale il titolare del fondo rustico pone a servizio durevole (e non occasionale) dello stesso le pertinenze, al fine di trasformare quello che è solo un terreno nudo in un vero e proprio fundus instructus, ossia organizzato per fini produttivi. Anche se, nel linguaggio codicistico, i due termini sono spesso usati come sinonimi, differiscono dalle pertinenze le scorte. Queste ultime, infatti, pur ricomprendendo beni dello stesso genere delle pertinenze, differiscono sotto il profilo soggettivo (in quanto l’atto proviene da un soggetto diverso dal titolare del fondo) e, di conseguenza, nel regime di circolazione (in quanto le scorte non seguono pedissequamente le sorti del fondo rustico). Proprio questo potere di destinazione ha fatto sorgere il problema della sua conciliazione con l’iniziativa dell’imprenditore il quale, pur essendo titolare del potere di organizzazione dell’azienda (art. 2555 c.c.), è tenuto a rispettarne la destinazione pertinenziale. Si reputa, in dottrina, che l’imprenditore, al termine della gestione dovrà restituire le pertinenze unitamente al fondo, ma potrà gestirle e integrarle, sempre coerentemente con i suoi piani di organizzazione dell’azienda. Sotto il profilo oggettivo, la nozione di pertinenza ricomprende quelle cose che, in base al criterio della normalità, sono le più adeguate alle esigenze del fondo (non del suo titolare), ossia funzionali ad un incremento di produttività. Esempi sono dati dalle macchine e dagli attrezzi agricoli, proporzionati alle necessità del fondo. Resta invece escluso il cd. capitale circolante, tra cui le sementi e il concime, che attengono all’esercizio dell’impresa, a meno che non siano destinati in quantità fissa ai fabbisogni del fondo. Gli effetti del vincolo pertinenziale consistono nel mantenere unita l’unità produttiva (fondopertinenze) venutasi a creare, anche nel momento della circolazione del fondo (ad esempio, in caso di vendita, ipoteca, affitto, pignoramento ecc.). In altre parole, in tali vicende si trasferiscono sia il fondo che le pertinenze, salva la facoltà del titolare di fornire la prova dell’avvenuta revoca del vincolo pertinenziale in epoca antecedente alla circolazione. I rapporti pertinenziali cessano con il venir meno del requisito della destinazione, con la distruzione o perimento della cosa principale e/o della funzione di servizio o ornamento della cosa principale o se il proprietario o altro titolare di diritto reale sulla cosa principale, revoca tale vincolo pertinenziale. B) I diritti del fondo Con questa espressione ci si riferisce ai diritti esercitati dal titolare del fondo al fine di soddisfare le necessità allo stesso inerenti, in vista di un incremento della produzione agricola. In tale categoria rientrano le servitù, che l’art. 1027 c.c. definisce come un «peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo, appartenente a diverso proprietario». Da una lettura delle norme codicistiche (cfr. artt. 1033, 1077 e 1078 c.c.) si evince che il soggetto legittimato a costituire le servitù è non solo il proprietario, ma anche l’usufruttuario, l’enfiteuta o il titolare di un diritto personale di godimento: in altre parole, tutti i soggetti titolari di un potere di destinazione del fondo. Mentre in passato, per il diritto romano, le servitù coincidevano con le pertinenze (essendo configurate come res mancipi, unitamente agli schiavi, al bestiame, agli attrezzi, al concime ecc.), attualmente questa identificazione non è più possibile, essendosi fatta strada una concezione anche privatistica della proprietà, ed essendosi il concetto di fondo ampliato sino a ricomprendere quello urbano. L’atto di destinazione da parte del titolare, presente in entrambi gli istituti, trasforma la servitù in pertinenza o, meglio, in ius fundi laddove si ponga come finalizzato ad accrescere la produttività del fondo. Ad esempio, il titolare (sia esso possessore, proprietario, acquirente con patto di riservato dominio) di un fondo intercluso, anche laddove non abbia diritto di imporre una servitù coattiva, potrà, in ogni caso, vedersi riconosciuto un diritto di passaggio sul fondo confinante: non si tratterà di un diritto reale e perpetuo, bensì di un diritto personale e temporaneo (il cd. ius fundi). 5. Gli altri beni dell’azienda agraria A) Gli attrezzi Il termine generico di «attrezzi» ci consente di accomunarvi tutti quei beni mobili che vengono destinati, in modo durevole, all’esercizio dell’attività agricola in un rapporto di servizio con il bene principale. Si tratta di entità materiali che hanno una propria individualità fisica e che, per la loro destinazione funzionale ad altro bene, sono idonee a renderlo capace di utilità (GERMANÒ). C’è da dire che, quando vi è un bene principale, che di regola è un bene immobile ma può essere anche un bene mobile, la cosa che vi accede con un rapporto di servizio durevole assume la qualifica di pertinenza, a norma dell’art. 817 c.c., ma solo quando la destinazione sia opera del proprietario della cosa principale o di colui che su di essa vanti un diritto reale. Ciò significa che si è fuori dalle regole proprie della disciplina del complesso pertinenziale (artt. 817-819 c.c.) quando gli attrezzi vengono destinati al bene principale da colui che di questo è semplicemente titolare di un diritto personale di godimento (come l’affittuario del fondo rustico). Vediamo, quindi, che vi è una diversa qualifica giuridica che viene assunta dagli attrezzi e dalle macchine che l’imprenditore agricolo organizza per l’esercizio della sua impresa: quando la destinazione è opera di un imprenditore che non è il proprietario del bene principale, tali attrezzi e macchine si qualificano soltanto come beni aziendali; se la destinazione è opera di un imprenditore che è il proprietario della terra, essi si qualificano anche come pertinenze, oltre che come elementi aziendali. Da queste considerazioni consegue che l’azienda agricola non coincide, giuridicamente, con il fondo attrezzato. Infatti, chi organizza i beni dell’azienda e li destina e li coordina all’esercizio dell’attività economica, può essere anche chi non è il proprietario del fondo, cioè chi non vanta sul bene principale quel diritto di proprietà che per l’art. 817 c.c. è necessario avere per la sussistenza del complesso pertinenziale. B) I beni immateriali: la ditta e l’insegna La ditta è il nome sotto il quale l’imprenditore esercita la sua attività e che, per il principio della verità, deve contenere il cognome o la sigla di costui e che non può essere trasferito senza l’azienda. Essa consente al pubblico di ricondurre una certa attività di impresa a un determinato soggetto. Per la caratteristica della ditta di essere il nome sotto il quale l’operatore economico esercita la sua attività, non vi è dubbio che rilevi come ditta il cognome con cui di regola, nel nostro paese, l’agricoltore individuale opera (GERMANÒ). Ne consegue l’applicazione, nel mondo agricolo, delle disposizioni sul trasferimento della ditta che si trasferisce soltanto con l’azienda ma solo con il consenso dell’alienante nei casi di trasferimento inter vivos, mentre solo se non c’è diversa volontà del testatore nel caso di successione mortis causa. L’insegna è il segno distintivo della sede in cui si esercita l’attività imprenditoriale, quindi contraddistingue il luogo in cui il complesso di beni occorrenti per l’impresa sono organizzati. Nelle nostre campagne è difficile che all’ingresso sia riportata l’insegna, ma sarebbe possibile che l’agricoltore segni l’ingresso della sua fattoria con un cartello con impressi nomi o figure o simboli costituenti, appunto, l’insegna (GERMANÒ). È più facile, però, che questo serva a contrassegnare la sede stabile in cui gli agricoltori possono vendere, senza necessità di licenza di commercio, i propri prodotti non perdendo, con questo modo di commercializzare, la qualità di imprenditori agricoli. C) Il marchio individuale e i marchi collettivi Il marchio è il segno con cui i beni e i servizi di un’impresa possono essere distinti dai beni e servizi di altra impresa. Gli imprenditori, quindi, affidano al marchio la funzione di differenziare i loro prodotti da quelli dei concorrenti, in modo che il pubblico possa riconoscere con facilità i prodotti provenienti da una determinata fonte di produzione e selezionare, tra molti prodotti similari, quello ritenuto migliore per qualità e/o prezzo orientando consapevolmente le proprie scelte. Oggi, però, il marchio ha acquisito un valore diverso da quello della mera differenziazione del prodotto in relazione alla sua origine; oggi il marchio è divenuto un valore di per sé, a prescindere dal prodotto contraddistinto e dalla sua origine, essendo divenuto esso stesso elemento di appetibilità per il consumatore, a causa della proiezione extramerceologica del valore del marchio che, per la sua notorietà, ha acquisito soprattutto una funzione suggestiva (GERMANÒ). Il marchio può essere registrato anche da chi non è imprenditore; cioè colui che sta procedendo all’organizzazione di una nuova attività agraria (e anche chi non vi procederà mai) potrà registrare il marchio con il quale intenderà, poi, contrassegnare i prodotti ottenuti. Il marchio individuale contraddistingue i prodotti di un solo imprenditore, che ne è titolare ed ha diritto esclusivo alla sua utilizzazione. È importante, in questa sede, prendere atto che gli agricoltori, singoli o associati, si servono sempre di più di marchi per conquistare il mercato (si pensi, ad esempio, ai bollini sulle banane o alle veline per avvolgere le arance). Oggi è consentito trasferire un marchio indipendentemente dagli altri beni aziendali, con l’unico limite che in ogni caso, dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico (art. 2573 c.c.). È vietato, quindi, un peggioramento qualitativo dei beni contraddistinti dallo stesso marchio in mancanza di un’adeguata informazione. Tale disposizione mal si presta a consentire il trasferimento del marchio di prodotti agricoli separatamente dall’azienda, in quanto le qualità organolettiche del prodotto agricolo rievocate dal marchio individuale saranno presenti nei successivi prodotti immessi sul mercato solo se continueranno ad essere prodotti negli stessi terreni. Ciò distingue l’impresa agricola da quella commerciale: in quest’ultima, infatti, i prodotti industriali sono qualificati da un Know-how che può essere separato dal luogo di originaria produzione, mentre i prodotti agricoli sono qualificati soprattutto dalla localizzazione geografica, che potrebbe essere essenziale per la realizzazione di un determinato prodotto. Per i consumatori, infatti, assume particolare importanza il fatto che le mele siano della Val di Non, che le arance provengano dalla Sicilia, ecc. È per questo che, a norma dell’art. 13 del Codice della proprietà industriale, non possono costituire oggetto di registrazione come marchio individuale d’impresa quei segni privi di carattere distintivo, e in particolare quei segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o sevizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, cioè i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio. I marchi collettivi svolgono una funzione in gran parte diversa da quella dei marchi individuali, in quanto possono avere anche una funzione di indicazione di provenienza, ma più tipicamente svolgono una funzione di garanzia e di qualità. Ciò si pone come una deroga al divieto posto dall’art. 13 del Codice della proprietà industriale, di costituire marchi costituiti esclusivamente da una denominazione geografica. Titolare del marchio collettivo può essere qualunque soggetto che svolge, appunto, la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, assoggettandosi all’osservanza degli standard qualitativi fissati dal titolare ed ai relativi controlli. Di regola, si tratta o di enti pubblici o di strutture associative private, che non svolgono attività di impresa in proprio ma hanno la facoltà di concedere in uso i marchi in questione a produttori o commercianti che si impegnano all’osservanza di specifici regolamenti. In agricoltura è ricorrente l’uso di marchi collettivi, in quanto è molto importante mettere in evidenza il luogo di produzione, le qualità del suolo e del sottosuolo e del clima, che sono capaci di imprimere al prodotto profumi e sapori particolari. Essendo vietato l’uso del marchio geografico individuale, al fine di impedire al singolo imprenditore (che per primo ha l’accortezza di riferire al suo prodotto la rinomanza dell’area geografica in cui lo produce) di godere di un diritto esclusivo sul toponimo adoperato come marchio, l’Ordinamento ammette l’uso del marchio collettivo, diretto a contrassegnare i prodotti di una serie plurima di produttori di una determinata località, anche al fine di identificarli e separarli dai prodotti identici di aree geografiche diverse. In tal caso il segno adoperato non è altro che un’indicazione di origine e di provenienza in funzione descrittiva della reputazione del luogo. Il marchio collettivo, quindi, si confonderebbe con l’indicazione di origine se non vi fosse la presenza importantissima, nel primo, del soggetto (ente o consorzio) titolare del marchio collettivo e della soggezione dei vari produttori al potere di controllo di essi per quanto concerne il rispetto degli standard di qualità. In ogni caso, chi operi nella zona potrà usare la denominazione geografica in modo conforme alla correttezza professionale. Il D.Lgs. 131/2010 ha eliminato un limite ulteriore all’utilizzabilità del marchio collettivo da parte di terzi per fini commerciali (quello dell’uso limitato alla funzione di indicazione di provenienza), disponendo semplicemente che l’uso sia conforma alla correttezza professionale. I marchi collettivi, però, valgono soprattutto per garantire la qualità dei prodotti, ed è ciò che spinge i produttori agricoli di zone geografiche rinomate per l’agricoltura a collegarsi ad enti pubblici o ad associarsi in consorzi per ottenere il diritto di uso di un marchio collettivo che garantisca l’origine, quindi, la qualità dei propri prodotti. D) Le indicazioni geografiche protette e le denominazioni geografiche protette Diverse dai marchi collettivi sono le indicazioni geografiche, che sono utilizzate per contraddistinguere prodotti le cui caratteristiche qualitative sono legate ad una determinata zona geografica per l’influsso di fattori ambientali o per la presenza di particolari tecniche produttive. In questo quadro assumono rilievo sia l’indicazione (generica) di provenienza, sia l’indicazione geografica protetta (IGP) o la denominazione di origine protetta (DOP). In precedenza, per la dottrina italiana le differenze esistenti tra la mera indicazione di provenienza e la denominazione di origine controllata (DOC) erano date dal fatto che alla prima era attribuito il ruolo di segnalare semplicemente il luogo di produzione del prodotto, mentre con la seconda si dava conto non solo dei fattori geografici, ma anche di fattori umani, nel senso che la qualità del prodotto era attribuibile, oltre che al clima, al suolo e al sottosuolo di quel determinato territorio, anche agli usi sperimentati e costanti di produzione ed elaborazione (GERMANÒ). La conseguenza era che, nel caso di indicazione di provenienza, era necessario che fosse garantita solo la veridicità del messaggio; nell’ipotesi di denominazione di origine controllata, invece, occorreva che il produttore di quell’area geografica fosse rispettoso del disciplinare che regolava la concessione dell’uso della DOC. Dato, però, che oggi la registrazione a livello comunitario dei nomi dell’IGP e della DOP è compiuta sulla base di un disciplinare cui i produttori devono adeguarsi per poter utilizzare i loro prodotti con il segno corrispondente alla IGP o alla DOP, ne deriva che il fattore umano oggi rileva anche nella IGP. La differenza, quindi, sulla base dei requisiti, tra la IGP e la DOP sta nel fatto che con la seconda viene indicato il prodotto agricolo il cui intero ciclo produttivo, dalla produzione della materia prima fino all’ottenimento del prodotto finito, sia localizzato in una determinata area geografica (comprensiva sia di fattori naturali che di fattori umani) alla quale siano attribuibili le qualità o le caratteristiche del prodotto; con la prima, invece, viene designato un prodotto agricolo il cui processo produttivo non è necessario che si svolga interamente all’interno di una determinata area geografica alla quale, tuttavia, possa farsi risalire una delle qualità o delle caratteristiche del prodotto stesso. Le denominazioni di origine sono liberamente fruibili da tutti gli imprenditori della zona di produzione nel rispetto delle regole indicate nel disciplinare di produzione. Esse hanno trovato una tutela specifica in disposizioni legislative particolari e nelle convenzioni internazionali. L’Unione Europea, infatti, attribuisce una grande importanza alla protezione comunitaria e internazionale delle indicazioni geografiche al fine di offrire ai consumatori informazioni adeguate sulla qualità dei prodotti, e ai produttori una giusta remunerazione degli investimenti realizzati. A partire dal 1992, il Consiglio ha adottato due regolamenti: il regolamento CEE 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; il regolamento CEE 2082/1992, relativo alle specialità tradizionali garantite. Tuttavia, il quadro legislativo comunitario si è dimostrato, negli ultimi anni, poco adatto a rispondere a una serie di mutamenti intervenuti all’interno dell’Europa e a livello globale. In particolare, le richieste sotto forma di contenziosi introdotte presso l’Organizzazione Mondiale del Commercio da parte di paesi terzi, nonché problemi tecnici nell’attuazione dei due regolamenti hanno dimostrato la necessità di un cambiamento globale: ciò ha portato all’adozione, dei regolamenti 509/2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari e 510/2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, oggi abrogati dal Reg. UE 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli. In Italia, invece, alle indicazioni geografiche è dedicata la Sezione II del Capo II del Codice della Proprietà industriale. La sezione è composta da due articoli, dei quali il primo, l’art. 29, indica l’oggetto della tutela, mentre il secondo, l’art. 30, indica la disciplina applicabile alle fattispecie. Il Codice individua l’oggetto della tutela nelle indicazioni geografiche e nelle denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione e caratteristiche siano dovute esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico di origine, comprensivo di fattori naturali, umani e di tradizione. Anche la tutela di questi segni è predisposta, innanzitutto, ad evitare l’inganno del pubblico. In questa direzione, infatti, l’art. 30 dispone che, salva la disciplina della concorrenza sleale e quella delle convenzioni internazionali in materia e salvi altresì i diritti di marchi anteriormente acquistati in buona fede, è vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta, l’uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l’uso di qualsiasi mezzo di designazione o presentazione di un prodotto, che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un’indicazione geografica. La tutela prevista dalla norma, prima dell’intervento del D.Lgs. 131/2010 era limitata alla condizione che la violazione invocata fosse idonea ad ingannare il pubblico. Tale ultimo decreto, invece, ha previsto che le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine devono essere protette – vietandone l’uso – non solo quando il loro uso sia idoneo ad ingannare il pubblico sulla provenienza del prodotto, ma anche quando il loro uso comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta, anche se il prodotto provenga effettivamente dal luogo al quale si riferisce l’indicazione geografica o la denominazione di origine. Si è voluto, quindi, comprendere nella tutela anche le ipotesi di parassitismo non confusorio (ad esempio, l’adozione della denominazione protetta accompagnata da espressioni quali «tipo», «modello» ecc.), la cui illiceità è disposta dai Regolamenti comunitari. La L. 99/2009, inoltre, ha introdotto nel codice penale, all’art. 517quater, il reato di «contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari», che punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro chiunque contraffà o altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. 6. Limitazioni alla proprietà agraria Considerata l’importanza del fondo nell’impianto dell’impresa agricola, sia dal punto di vista della produzione che da quello dell’investimento fondiario o mobiliare, non deve stupire che la legge sia intervenuta per regolarne l’organizzazione, mediante l’imposizione di vincoli od obblighi. È opportuno distinguere, in ragione dello scopo perseguito, tra due ordini di limitazioni: quelle che gravano sulla proprietà fondiaria a prescindere dalla funzione produttiva, in vista del perseguimento di un interesse pubblico: si pensi all’espropriazione per motivi di interesse generale (art. 42 Cost.); ai vincoli delle antichità e delle belle arti (artt. 839 e 840 c.c.; D.Lgs. 22-1-2004, n. 42); ai vincoli idrogeologici (art. 866 c.c. e R.D.L. 30-12-1923, n. 3267); ai vincoli idraulici (artt. 840 e 868 c.c. e R.D. 25-7-1904, n. 523); alle servitù militari (L. 24-12-1976, n. 898); quelle che gravano sulla proprietà fondiaria in considerazione della sua funzione produttiva, esemplificate nell’art. 44 Cost. Le manifestazioni più frequenti sono date, in concreto: dalla bonifica, che configura una sorta di intervento coattivo, volto a realizzare, in origine mediante opere idrauliche, il prosciugamento di terreni paludosi (bonifica idraulica) e, col passare del tempo, programmi più vasti di messa a coltura dei fondi o di trasformazione delle colture degli stessi (bonifica agraria). Queste due forme di bonifica sono superate dalla bonifica integrale, che si prefigge anche finalità demografiche e sociali. Attraverso la stessa, infatti, vengono effettuati lavori e opere (fabbricati, strade, acquedotti ecc.) che rendono possibile l’incremento demografico nelle zone bonificate. Alla bonifica integrale (secondo quanto dispone il R.D. 13-2-1933, n. 215) si provvede per scopi di pubblico interesse, mediante opere di bonifica e di miglioramento fondiario. Le opere di bonifica sono quelle che si compiono in base ad un piano generale di lavori e di attività coordinate, con rilevanti vantaggi igienici, demografici, economici o sociali, in Comprensori in cui cadano laghi, stagni, paludi e terre paludose, o costituiti da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, ovvero da terreni, estensivamente utilizzati per gravi cause d’ordine fisico e sociale, e suscettibili, rimosse queste, di una radicale trasformazione dell’ordinamento produttivo. Le opere di miglioramento fondiario sono quelle che si compiono a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica. La finalità di tale intervento è di favorire la cooperazione tra pubblici poteri e privati, riuniti nei consorzi di bonifica (che raggruppano i proprietari fondiari dei vari comprensori); in altre parole, l’autorità pubblica subentra ai privati nell’esecuzione di opere che per questi sarebbero troppo onerose (anche se residua, comunque, un onere di spesa a carico dei privati stessi); dalla riforma fondiaria, con la quale il legislatore si propone di sostituire ad un’impresa agricola scarsamente produttiva, in quanto basata sulla coltivazione estensiva, una nuova impresa, basata su un tipo di conduzione intensiva. In realtà, non esiste nella nostra legislazione un provvedimento generale che disponga dei limiti precisi all’estensione della proprietà fondiaria. Tuttavia, sono state emanate leggi sporadiche che, partendo dall’espropriazione a danno dei titolari delle aziende agricole più estese, il cui intento era di procedere alla redistribuzione delle terre così trasformate e appoderate a favore di consorzi e cooperative agricole; dall’assegnazione, anche in via temporanea, delle terre incolte o non sufficientemente coltivate appartenenti a titolari inerti, a soggetti diversi (singoli lavoratori o cooperative di contadini); dalle disposizioni contro il frazionamento dei terreni che hanno lo scopo di realizzare l’efficienza economica delle aziende agricole. Il codice civile ha affrontato il problema con l’istituto della minima unità colturale (artt. 846 e 847 c.c.) che ha il fine di impedire l’eccessivo frazionamento del fondo, che lo renderebbe inadeguato a soddisfare le esigenze del coltivatore e della di lui famiglia. Altre norme, contenute sia nel codice civile (artt. 849 e ss. c.c.) che in altre disposizioni di legge (D.Lgs. n. 114/1948, L. n. 841/1960) sono state disposte allo scopo di accorpare le unità produttive insufficienti. In realtà, tale politica non ha riscosso grande successo ed è rimasta di fatto inattuata per cui si è proceduto all’abrogazione di gran parte di tale disciplina preferendo l’utilizzo di strumenti diversi di natura volontaria di cui si tratterà oltre (si pensi, ad esempio, al diritto di prelazione del confinante). Del maso chiuso al compendio unico Un antico istituto locale avente per scopo l’indivisibilità di unità fondiarie è quello del maso chiuso attualmente disciplinato dalla legge provinciale Bolzano 28-11-2001, n. 17. Il fondo costituito in maso chiuso deve avere una casa di abitazione e produrre reddito per una famiglia di almeno quattro persone ma non può superare il triplo di tale reddito. Particolari limitazioni sono previste alla facoltà di disporre del maso e una disciplina particolare è prevista anche per il caso di successione ereditaria. Nella divisione ereditaria, infatti, il maso chiuso, comprese le pertinenze, va considerato unità indivisibile e non può essere assegnato che ad un unico erede o legatario. L’obiettivo di determinare dimensioni adeguate delle imprese agricole è stato perseguito con l’art. 5bis del D.Lgs. 228/2001, aggiunto dal D.Lgs. 99/2004 che ha previsto o meglio generalizzato l’istituto del compendio unico già previsto per i terreni siti nei comuni montani. Per compendio unico si intende l’estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l’erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999, e successive modificazioni. La costituzione di compendio unico avviene con dichiarazione resa dalla parte acquirente o cessionaria nell’atto di acquisto o di trasferimento; la costituzione di compendio unico può avvenire anche in riferimento a terreni agricoli e relative pertinenze già di proprietà della parte, mediante dichiarazione unilaterale del proprietario resa innanzi a notaio nelle forme dell’atto pubblico. Possono essere costituiti in compendio unico terreni agricoli anche non confinanti fra loro purché funzionali all’esercizio dell’impresa agricola. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, sono considerati unità indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Sono nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del compendio unico. Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento si applicano delle agevolazioni fiscali. dalla liquidazione degli usi civici, che configura un procedimento amministrativo di liberazione dei terreni (pubblici o privati) gravati da diritti di uso civico, attraverso il trasferimento in piena proprietà di una quota degli stessi al Comune del quale fanno parte. A tal fine la L. n. 1766/1927 ha creato il commissario liquidatore degli usi civici il quale riuniva in sé funzioni amministrative e funzioni giurisdizionali fino a quando, con l’emanazione del D.P.R. n. 11/1972, le funzioni amministrative dei commissari sono state trasferite alle Regioni e la competenza dei commissari si è ristretta all’attività giurisdizionale. Tuttavia, il riconoscimento, tra le funzioni dello Stato, della tutela e della salvaguardia dell’ambiente e la sottoposizione a vincolo paesaggistico dei territori gravati dagli usi civici (ex art. 1, lett. h), L. n. 431/1985) hanno restituito al Commissario una funzione di tutela dell’ambiente. 7. Modi tipici di costituzione dell’impresa agricola Rientrano in questa categoria alcuni modi di acquisto disciplinati dal diritto comune: la concessione in godimento del fondo rustico (affitto, comodato) oppure il trasferimento della proprietà dello stesso, che può avvenire mortis causa o inter vivos, a titolo oneroso o gratuito, a titolo originario o derivativo. In particolare, tra questi modi di acquisto rientrano i contratti agrari che verranno trattati oltre, la cui causa va ben oltre una semplice concessione in godimento del fondo, proponendosi gli stessi di costituire una vera e propria impresa agricola. 8. Modi speciali di costituzione Con alcuni interventi il legislatore si è proposto l’incremento della produttività dell’impresa agricola attraverso agevolazioni concesse ai lavoratori che già coltivano i fondi o sono in grado di coltivarli, consistenti nell’acquisto della proprietà sui medesimi. In realtà, spesso si è trattato di interventi su istituti tipicamente civilistici (ad esempio, l’usucapione), procedendo a delle modifiche, volte a conferire loro una connotazione più aderente alle esigenze dell’impresa agricola. Il fondamento normativo di questi interventi si rinviene nell’art. 42 Cost., che riconosce e tutela la proprietà privata nei limiti in cui svolge una funzione sociale. È importante sottolineare che, mentre gli interventi limitativi della proprietà agraria si concretizzano in procedimenti amministrativi impositivi di vincoli od obblighi (ad esempio, la bonifica delle terre), l’acquisto della proprietà fondiaria avviene su iniziativa del soggetto interessato configurandosi abitualmente come l’estrinsecazione di un diritto potestativo (ad esempio, la prelazione) o di un diritto soggettivo (ad esempio, l’usucapione speciale agraria). A) La prelazione agraria L’istituto della prelazione in diritto civile consiste nel diritto di un determinato soggetto ad essere preferito a terzi, a parità di condizioni, nell’acquisto di un bene, ove il legittimo proprietario intenda alienarlo. Il proprietario non ha un obbligo di contrarre e di vendere, ma semplicemente di preferire il prelazionario a terzi qualora intenda alienare. Il diritto di prelazione si configura come un diritto potestativo grazie al quale il titolare dello stesso, con una semplice manifestazione di volontà, ha il potere di costringere il proprietario del fondo a preferirlo a terzi, a parità di condizioni, nell’acquisto del fondo stesso. La ratio dell’istituto, nel diritto agrario, è di consentire la formazione o l’ampliamento delle dimensioni territoriali dell’azienda diretta coltivatrice. A tutela del diritto del prelazionario la legge attribuisce a quest’ultimo un diritto di riscatto (o retratto), ossia un’azione reale che si manifesta in un diritto di seguito sul fondo anche nelle successive alienazioni. In altre parole, il prelazionario potrà riscattare il fondo venduto in spregio al suo diritto dall’acquirente o dai successivi aventi causa subentrando a questi ultimi come se fosse stato parte del contratto ab origine. Importante sottolineare che il diritto di prelazione sorge in capo al soggetto legittimato solo qualora l’alienazione sia volontaria e si traduca in un negozio di compravendita. Pertanto non danno diritto alla prelazione le ipotesi di vendita forzata e di espropriazione né tanto meno la permuta, la transazione, la datio in solutum, il negotium mixtum cum donatione (salvo dimostrare che il negozio così concluso è in frode alla legge o il frutto di una simulazione volta ad aggirare il diritto di prelazione). Quanto all’oggetto, deve trattarsi di un fondo rustico, quindi di un terreno destinato al solo sfruttamento agricolo. La legge non fissa peraltro una superficie minima ma utilizza un criterio che attiene all’acquirente, infatti, non si ha diritto di prelazione qualora le esigenze lavorative del fondo alienato e degli altri fondi già in proprietà di colui che ha diritto alla prelazione superino di un terzo la forza lavorativa di costui e della sua famiglia. Da un punto di vista soggettivo, chi esercita la prelazione deve essere coltivatore diretto, affittuario o confinante, come specificato in seguito; inoltre non deve aver venduto nel biennio precedente alcun appezzamento di terreno per un imponibile superiore, un tempo, a centomila delle vecchie lire, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria. Il diritto di prelazione diventa attuale con la formazione del contratto preliminare con un ben individuato soggetto terzo. La stipula del preliminare, cioè, rappresenta il momento temporale del sorgere dell’obbligo del proprietario del fondo di notificare copia del preliminare, e di dare tutte le notizie in esso contenute, al concessionario o al vicino: obbligo di denuntiatio. Qualora non si sia rinunciato alla prelazione (rinuncia possibile, ma solo dopo la notifica del preliminare), essa deve essere esercitata per iscritto ed entro trenta giorni dalla denuntiatio o dall’avvenuta integrale conoscenza del contratto preliminare con il terzo. Il contratto, che si perfeziona con l’esercizio della prelazione, non produce effetti reali immediati poiché resta sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo. Rimedi a tutela della prelazione agraria Trattandosi di un contratto perfetto, sia pure sottoposto a condizione sospensiva, e trattandosi di un contratto preliminare (perchè è in questo che il concessionario o il vicino si è sostituito al terzo), nell’ipotesi in cui il proprietario del fondo promesso in vendita si rifiuti di stipulare il contratto definitivo, il titolare del diritto di prelazione può esperire il rimedio previsto dall’art. 2932 c.c., cioè ricorrere al giudice per ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Inoltre, qualora venga omessa la denuntiatio o qualora in essa sia indicato un prezzo superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l’avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto, esercitare il diritto potestativo di riscatto del fondo dell’acquirente e da ogni altro successivo dante causa. Analizzato l’istituto in generale, veniamo ora ad esaminare nella specie i casi di prelazione agraria: la prelazione ai sensi dell’art. 8 L. 26 maggio 1965, n. 590 coordinato con l’art. 16 della L. 14 agosto 1971, n. 817; in questo caso la legittimazione attiva spetta al concessionario, ossia l’affittuario coltivatore diretto, il mezzadro, il colono, il compartecipante (escluso quello stagionale). Oltre ai requisiti generali il legislatore richiede che il concessionario sia insediato sul fondo da almeno due anni. Il proprietario che intende alienare il fondo è tenuto alla cd. denuntiatio, con lettera raccomandata, con le modalità di cui all’art. 8, comma quarto della L. 590/1965 così come modificato dall’art. 8 della L. 817/1971. Giurisprudenza Si segnala l’esistenza di un acceso dibattito circa la natura della denuntiatio, ossia se essa sia una proposta contrattuale o una mera notizia da cui decorra il termine per l’esercizio del diritto. Parte della giurisprudenza la considera proposta contrattuale, da redigersi quindi necessariamente per iscritto in quanto concernente l’acquisto di un diritto reale e pretende che anche l’accettazione debba avvenire per iscritto. Non mancano però sentenze che negano tale natura riducendola a semplice comunicazione per la quale quindi è sufficiente anche la forma verbale (da ultimo Cass. 19 maggio 2003, n. 7768). la prelazione di cui all’articolo unico della L. 10 maggio 1976, n. 265 in caso di alienazione a titolo oneroso di fondi rustici da parte di enti pubblici o fondazioni. Titolare del diritto è l’affittuario «che anche se non dedito abitualmente alla coltivazione della terra, coltivi il fondo da almeno due anni con il lavoro proprio o della sua famiglia sempre che tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo»; la prelazione del confinante ai sensi dell’art. 7 della L. 14 agosto 1971, n. 817, che ha esteso il diritto di prelazione «al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti». Il fatto che la prelazione sia riconosciuta a favore del proprietario coltivatore diretto confinante, impone di verificare cosa si intenda per «terreno confinante», essendo la dottrina e la giurisprudenza divise tra la tesi per cui è necessaria la contiguità materiale e quella secondo cui è sufficiente un’adiacenza funzionale e quindi non necessariamente fisica, non interrompendo il confine, le strade vicinali e quelle private o i piccoli corsi d’acqua, né tantomeno la piccola striscia di terreno trattenuta dal venditore allo scopo di eludere le norme sulla prelazione. Inoltre, poiché il fondo ha più lati, questione di altrettanto rilievo concerne la spettanza di tale diritto qualora vi siano più confinanti e tutti abbiano la qualifica di coltivatori diretti. Sono state prospettate diverse soluzioni: 1. il diritto di prelazione va esercitato congiuntamente da tutti i confinanti, analogamente a quanto previsto per gli affittuari dall’art. 8, comma 9, della L. 26 maggio 1965, n. 590; 2. il conflitto tra più confinanti va risolto a favore del primo che lo ha esercitato; 3. tra i diversi confinanti aventi diritto si costituisce una comunione poiché il diritto di prelazione di ciascuno è riferito al fondo intero; 4. la scelta del confinante compete al proprietario del fondo posto in vendita; 5. la preferenza va attribuita al confinante che, accorpando il suo fondo con quello posto in vendita, crea un’impresa efficiente sia sul piano tecnico sia sul piano economico. Nell’incertezza la giurisprudenza ha comunque sempre affermato che spetta all’insindacabile giudizio del giudice la decisione e la scelta del criterio da applicarsi. Nel contrasto si è inserito oggi il legislatore che, all’art. 7 del D.Lgs. 228/2001, ha disposto che «ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione di cui all’art. 7 della L. 817/1971, nel caso di soggetti confinanti, si intendono quali criteri preferenziali, nell’ordine, la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale di età compresa tra i 18 e i 40 anni o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di essi nonché il possesso da parte degli stessi di conoscenze e di competenze adeguate ai sensi dell’art. 8 del regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999». Attraverso tale disposizione il legislatore ha inteso colmare una lacuna dell’ordinamento che tanti problemi aveva provocato agli interpreti. Essa si applica come espressamente indicato dal legislatore sia all’ipotesi di prelazione o riscatto di cui all’art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, sia a quella di cui all’art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817. Di particolare apprezzamento è l’introduzione per la prima volta nell’area della prelazione agraria dell’imprenditore agricolo a titolo principale giovane, con una visione di prospettiva dello sviluppo aziendale (BUSETTO). Permane però il problema qualora vi siano più confinanti aventi i requisiti indicati dalla legge e ancor più qualora nessuno dei confinanti sia in possesso dei criteri preferenziali elencati dal legislatore. Si ritiene che, tra i criteri elencati, quello inerente il numero dei giovani imprenditori agricoli presenti non abbia una propria autonomia, per cui i criteri risultano in sostanza essere due: la presenza di giovani imprenditori agricoli e il possesso da parte degli stessi di competenze e conoscenze adeguate ai sensi dell’art. 8 del regolamento 1257/1999/CE; la prelazione disciplinata dall’ultimo comma dell’art. 16 della L. 14 agosto 1971, n. 817 che estende tale diritto alle cooperative agricole proprietarie di terreni finitimi con quelli posti in alienazione; la prelazione dei partecipanti all’impresa familiare di cui all’art. 230bis c.c., comma quinto, qualora abbia ad oggetto un’attività agricola. La legittimazione attiva all’esercizio del diritto spetta al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. L’esercizio compete loro nei due casi previsti dall’art. 230bis c.c.: a. trasferimento dell’azienda, intendendosi per tale ogni atto inter vivos a titolo oneroso che abbia ad oggetto l’intera azienda o parte di essa; b. divisione ereditaria, che ricorre quando, in seguito all’apertura della successione ereditaria, i beni aziendali vengono divisi tra i coeredi. Dottrina Secondo la dottrina prevalente (BUSNELLI, MESSINETTI), la disposizione in esame non costituisce una riproduzione dell’art. 732 c.c. essendone diversa la ratio: la prelazione nell’impresa familiare trova il suo titolo nella gestione produttiva dell’impresa, e come tale spetta a tutti i familiari che abbiano prestato un’effettiva collaborazione nell’impresa, anche se non eredi. È d’uopo sottolineare che la prelazione ex art. 732 c.c. prevale su qualsiasi altra prelazione, in quanto, secondo la costante giurisprudenza, detto istituto è volto ad evitare che si intromettano nella comunione ereditaria estranei con fini speculativi. Generalmente si ritiene ammissibile una rinunzia alla prelazione, ma solo nei casi in cui il titolare del diritto sia posto in grado di valutare tutti gli aspetti, positivi e negativi, della sua scelta in seguito ad una tempestiva e regolare conoscenza della volontà del proprietario di alienare il fondo, anche in conformità al generale principio secondo il quale non è ammessa la preventiva rinuncia di un diritto non ancora sorto e del quale dunque il soggetto non può disporre. Si esclude pertanto la validità della rinuncia al diritto di prelazione effettuata anteriormente alla notifica della denuntiatio. B) L’affrancazione Con questo termine l’art. 971 c.c. si riferisce al diritto potestativo dell’enfiteuta di acquistare la proprietà della terra «mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell’interesse legale» secondo le modalità stabilite da leggi speciali. Si ricorda che l’enfiteusi è un diritto reale di godimento su cosa altrui che attribuisce al titolare lo stesso potere di godimento e utilizzazione che spetta al proprietario, con l’obbligo, però, di migliorare il fondo, di non deteriorarlo e di pagare un canone periodico (art. 960 c.c.). Riassumendone brevemente la disciplina è da rilevare come l’enfiteusi possa essere costituita mediante titolo (contratto o testamento) oppure per usucapione; il titolo che costituisce il rapporto non può però derogare alcune norme quali quelle che prevedono la durata minima ventennale (art. 958 c.c.), la facoltà dell’enfiteuta di poter disporre del proprio diritto (art. 965 c.c.), il divieto di subenfiteusi (art. 968 c.c.) e, per l’appunto, il potere di affrancazione dell’enfiteuta. Esercitando tale potere l’enfiteuta diventa proprietario del fondo mediante il pagamento di una somma corrispondente a 15 volte il canone annuo (art. 1 L. n. 607/1966). Lo scopo dell’affrancazione, insieme a quello della devoluzione (cfr. art. 972 c.c.) è quello di unificare il diritto di proprietà nelle mani, rispettivamente, dell’enfiteuta o del proprietario, superando la distinzione tra dominio utile e dominio diretto. Si precisa, infine, che, configurandosi il diritto di affrancazione come diritto potestativo, il concedente non può opporsi al relativo esercizio, dal momento che il giudice può attribuire, anche contro la volontà di quest’ultimo, la proprietà della terra mediante sentenza costitutiva. L’enfiteusi, l’usufrutto, le colonìe miglioratarie e il compascolo A differenza della prelazione che attribuisce al coltivatore un diritto ad acquistare il fondo, ma non ancora il diritto reale su di esso, l’enfiteusi e l’usufrutto concedono al loro titolare un diritto reale, più o meno ampio, sul bene in proprietà di altri. È possibile, quindi, costituire l’azienda agraria acquisendo la terra in usufrutto o in enfiteusi, cioè senza ricorrere al contratto di compravendita. Rispetto all’enfiteuta, i cui diritti sul bene sono amplissimi, l’usufruttuario è fortemente compresso, nell’esercizio dell’attività agricola sul fondo, dal suo obbligo di rispettarne la forma e la sostanza, ovverosia la destinazione economica. In particolare, i poteri di migliorare il fondo di cui gode l’usufruttuario quale titolare di un diritto reale sono molto meno ampi di quelli che l’ordinamento ha riconosciuto all’affittuario benché costui sia titolare di un diritto personale di godimento. Trattandosi di fondo rustico, sia l’enfiteuta (anche per la sua obbligazione di migliorare) quanto l’usufruttuario (perchè, dovendo restituire il bene rispettandone la destinazione economica, deve mantenere il livello di produttività) sono tenuti ad esercitare l’attività agricola e, quindi, ad assumere la terra, oggetto del loro diritto reale, a bene centrale dell’organizzazione aziendale (GERMANÒ). Con specifico riferimento all’usufrutto, può dirsi che solo la gestione produttiva del fondo agricolo dà luogo a quelle utilità che all’usufruttuario, in virtù del suo diritto reale limitato, spettano. Ciò che rileva ai fini dell’indagine sui modi di apprensione della terra è il diritto di affrancazione riconosciuto all’enfiteuta. Si tratta di un diritto potestativo in forza del quale l’enfiteuta ha il potere di acquistare la proprietà del fondo mediante il pagamento di una somma di denaro pari a 15 volte l’ammontare del canone cui egli è tenuto. Le colonìe miglioratarie (colonìe ad meliorandum) erano un istituto consuetudinario che si caratterizzavano per la concessione, in cambio di un modesto canone, di un terreno nudo che, a cura del colono, doveva essere sistemato con colture arboree o arbustive. La L. 327/1963 e la L. 607/1966 hanno, secondo alcuni, convertito le colonìe miglioratarie in enfiteusi o, secondo altri, le hanno assimilate all’enfiteusi per l’attribuzione, al colono, del diritto potestativo di affrancazione, esercitabile dopo trent’anni dalla concessione e ad avvenuta esecuzione del programma di miglioramento necessariamente con colture arboree o arbustive. Altro istituto regolato dalla consuetudine e che nasce in funzione dell’esercizio dell’attività di allevamento del bestiame è il compascolo, attraverso il quale i proprietari di piccoli fondi hanno il diritto di far pascolare, ciascuno, i propri animali sul terreno dei vicini, venendosi così a formare, nell’interesse della pastorizia, una più ampia superficie a pascolo rappresentata dall’insieme delle distinte particelle di terreno dopo che su ciascuna di esse sia stato effettuato il raccolto e non si sia ancora proceduto alla semina. C) La successione agraria La successione mortis causa rientra indubbiamente tra i modi di acquisto della proprietà agraria. Le regole successorie sono quelle ordinarie, ma l’intento del legislatore è di garantire la continuità nella gestione a vantaggio di colui il quale è titolare del potere di conduzione sul bene. Si riconosce pertanto una posizione privilegiata a coloro che tra gli eredi abbiano prestato in concreto la collaborazione propria e dei propri familiari nella gestione dell’impresa. Il principale riferimento normativo dell’argomento è rintracciabile nell’art. 49 delle L. 3 maggio 1982, n. 203 e nel già esaminato art. 230bis c.c. Il primo comma dell’art. 49 L. 203/1982 introduce un’ipotesi di successione anomala valida su tutto il territorio dello Stato e per tutte le fattispecie di conduzione o di coltivazione del fondo rustico da parte del de cuius o di alcuni suoi eredi. Esso prevede che «nel caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, quelli tra gli eredi che, al momento dell’apertura della successione, risultino aver esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attività agricola, in qualità di imprenditori agricoli a titolo principale o di coltivatori diretti, hanno diritto di continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di esse». Ancora più rilevante è l’ultimo comma dello stesso articolo, ove il legislatore ha disposto che in caso di morte dell’affittuario, mezzadro, colono, compartecipante o soccidario, il contratto si scioglie alla fine dell’annata agraria in corso, salvo che tra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare attività agricola in qualità di coltivatore diretto imprenditore agricolo a titolo principale. Il legislatore del 2001 è intervenuto anche nella materia successoria all’art. 8 del D.Lgs. 228/2001, concernente la «conservazione dell’integrità dell’azienda agricola». Rispondendo agli avvertimenti della dottrina circa la necessità di garantire a chi svolge professionalmente attività agricola nell’ambito familiare una tutela sia in ordine al riconoscimento e alla conservazione di una propria posizione fino a quando perduri la compresenza attiva del capofamiglia, sia, al momento della morte di costui, in ordine alla gestione dell’azienda e di mantenere l’integrità nel concorso dei diritti degli eredi (CASAROTTO), il legislatore delegato ha generalizzato la disciplina di cui agli artt. 4 e 5 della L. 31 gennaio 1994, n. 97. Ha infatti stabilito che la disciplina relativa alla conservazione dell’integrità delle aziende agricole site nei comuni montani si debba applicare anche alle aziende agricole ubicate in comuni non montani. La dottrina aveva più volte evidenziato infatti il paradosso tra l’esistenza di una legislazione che promuove la formazione e l’ampliamento della proprietà coltivatrice anche attraverso ingenti risorse finanziarie e le disposizioni codicistiche in materia di successione che puntualmente provocano la frammentazione dei fondi attraverso la divisione della comunione ereditaria. L’art. 4 della L. 31 gennaio 1994 n. 97 stabilisce che gli affittuari (ai sensi dell’art. 49 della L. 203/1982), oltre al diritto di continuare nella conduzione hanno il diritto, da esercitarsi entro sei mesi dalla scadenza del contratto di affitto, all’acquisto della proprietà delle porzioni del fondo rustico da lui condotte cadute in successione. Per poter esercitare tale diritto, di natura evidentemente potestativa, è necessario che si sia compiuto il quindicennio di coltivazione, che l’erede assuma l’obbligo di coltivare il fondo per almeno ulteriori sei anni, che egli non abbia venduto fondi nel triennio precedente oltre al rispetto del rapporto superficie/capacità lavorativa (come nella prelazione agraria) e l’iscrizione all’INPS come coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale. Il diritto di acquisto può inoltre essere esercitato a prescindere dalla sussistenza dello stato di comunione legale tra gli eredi. L’art. 5 della L. 31 gennaio 1994, n. 97 indica, poi, le modalità di esercizio del diritto e il termine per il pagamento del prezzo. Esso deve avvenire entro sei mesi dalla scadenza del rapporto di affitto, con dichiarazione trasmessa mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Si tratta di una dichiarazione unilaterale recettizia. Il valore viene determinato sulla base del valore agricolo medio come indicato dalla Commissione provinciale competente. La proprietà si trasferisce con il versamento del prezzo da effettuarsi entro tre mesi dall’avvenuta notificazione della dichiarazione di esercizio del diritto; qualora il proprietario rifiuti di riceverlo, l’eredeaffittuario deve depositare la somma presso un istituto di credito dandone comunicazione alla controparte con raccomandata. La proprietà si acquista alla data della notificazione. D) L’usucapione agraria L’usucapione è un modo di acquisto di diritti a titolo originario in virtù del possesso protratto per un certo tempo, il quale produce l’acquisto della proprietà o degli altri diritti reali di godimento a seconda del differente animus del possessore. Questo modo di acquisto speciale della proprietà agraria è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla L. 10-5-1976, n. 346, che ha inserito nel codice civile l’art. 1159bis, intitolato della «usucapione speciale per la piccola proprietà rurale». Scopo precipuo del legislatore è di ridurre i termini dell’usucapione ordinaria a vantaggio della proprietà terriera finalizzata alla produzione agraria. Dottrina Secondo parte della dottrina (GALLONI) l’usucapione speciale agraria avrebbe la stessa natura dell’usucapione ordinaria, differenziandosene unicamente per la particolare disciplina, dettata soprattutto a tutela dell’interesse superiore dell’impresa agricola. Altri autori (CARROZZA), al contrario, ritengono inconciliabile con i principi generali dell’usucapione il fatto che costituisca titolo per la trascrizione dell’acquisto il decreto del giudice che accerti l’avvenuto decorso del tempo. Interessante è il particolare procedimento che la L. 346/1976 ha introdotto per il riconoscimento giudiziario della intervenuta usucapione agraria. Di regola, infatti, l’usucapione viene opposta a chi contesti, di fatto o giudizialmente, al possessore dell’immobile la proprietà di esso; qui, invece, il possessore ha facoltà di instaurare davanti al giudice competente un procedimento di volontaria giurisdizione in incertam personam che può, per opposizione degli interessati, trasformarsi in un giudizio contenzioso ordinario. Si assiste poi ad una eccezione al principio resoluto iure dantis, et resolvitur ius accipientis in quanto il legislatore dispone che sono salvi i diritti che i terzi di buona fede hanno acquistato da colui che ha ottenuto il decreto o la sentenza di riconoscimento della proprietà purché l’acquisto abbia avuto luogo in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale con cui si faccia valere sull’immobile una situazione giuridica di proprietà incompatibile con il vantato possesso ad usucapionem (art. 3 ult. co. L. n. 346/1976). Il legislatore, quindi, tutela quei terzi che in buona fede abbiano trascritto, prima della domanda giudiziale di rivendica del bene, il loro atto di acquisto da colui che aveva ottenuto il decreto o la sentenza di riconoscimento della proprietà, terzi che divengono proprietari del bene immediatamente ed erga omnes anche se nel nuovo giudizio si accertasse che il loro dante causa non aveva usucapito il fondo rustico poi venduto. E) Incentivi per la formazione della proprietà coltivatrice Gli interventi che, dal secondo dopoguerra in poi, hanno caratterizzato la promozione della formazione della proprietà diretto-coltivatrice, favorendo l’accesso alla terra da parte della categoria dei coltivatori diretti, con lo scopo di realizzare le finalità di natura sociale di riunire nella stessa persona le qualità di proprietario e di coltivatore del fondo e attuando così, direttamente e mediatamente, i precetti costituzionali di cui agli artt. 3, 42, 44 e 47 Cost., hanno fatto sostanzialmente ricorso a strumenti agevolativi di natura sia tributaria che creditizia (ZANON). Il D.Lgs. 24 febbraio 1948, n. 114 (Provvidenze a favore della piccola proprietà contadina), contenente una serie di incentivi di credito agevolato e riduzioni del carico fiscale inerente gli atti di trasferimento dei fondi rustici, rappresenta il punto di partenza di una serie articolata d’interventi. Detto decreto in particolare disponeva la concessione, a favore dei coltivatori diretti intenzionati ad acquistare fondi rustici, di agevolazioni rappresentate, in ambito fiscale, dalla riduzione della metà dell’imposta di registro e di quella ipotecaria per gli atti di compravendita e di concessione in enfiteusi e, in ambito creditizio, dalla concessione di mutui trentennali. La fruizione di tali agevolazioni comportava però l’impossibilità di trasferire volontariamente il fondo acquistato o di cessare, salvo giusta causa, dalla coltivazione per un periodo di dieci anni, pena la perdita di tutti i benefici fiscali e creditizi. Tali limitazioni erano imposte per evitare operazioni di natura speculativa. A questo decreto fece seguito nello stesso anno il D.Lgs. 121/1948 che istituì la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina con il compito di curare l’acquisto o la vendita dei terreni a coltivatori diretti o associati in cooperative. Seguirono ancora negli anni sessanta numerosi interventi legislativi di agevolazione, culminati con la L. 26 maggio 1965, n. 590 titolata «Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice», nella quale si passò al finanziamento cosiddetto globale dell’acquisto del fondo da parte della struttura pubblica, accompagnato sempre da agevolazioni fiscali, allo scopo di favorire la «costituzione di aziende che abbiano caratteristiche e suscettività di realizzare imprese familiari efficienti, sotto il profilo tecnico ed economico» (art. 1). Lo stesso comma disponeva che «l’estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i benefici della presente legge non possono aver luogo prima che siano decorsi anni dieci dall’acquisto». Una siffatta disposizione è stata oggetto di lunga disputa sia in sede dottrinale sia in giurisprudenza, culminata con la sentenza della Corte di Cassazione n. 7159 del 11 giugno 1992 la quale affermò che la rivendita del fondo rustico acquistato con i benefici fiscali della proprietà coltivatrice prima della scadenza del decennio dall’acquisto sarebbe stata nulla (nello stesso senso si veda Cass. 29 gennaio 2001, n. 1226). L’art. 11 del D.Lgs. 228/2001 ha sovvertito tale impostazione, disponendo che «il periodo di decadenza dai benefici previsti dalla vigente legislazione in materia di formazione ed arrotondamento di proprietà coltivatrice è ridotto da dieci a cinque anni». Inoltre l’estinzione anticipata del mutuo o la vendita è consentita sempre decorsi cinque anni dall’acquisto. Il legislatore delegato ha poi previsto che non incorre nella decadenza dei benefici l’acquirente che, durante il periodo vincolativo, effettui la rivendita o la concessione in godimento a favore dei componenti della propria famiglia, coniuge o parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo esercenti l’attività agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c. L’art. 11, comma 5, della L. 14 agosto 1971, n. 817, «Disposizioni per il rifinanziamento della provvidenza per lo sviluppo della proprietà coltivatrice» prevedeva, invece, un vincolo di durata trentennale di indivisibilità dei fondi acquistati con le agevolazioni per la formazione della proprietà coltivatrice. La L. 15 dicembre 1998, n. 441 sull’imprenditoria giovanile si era già occupata di questo vincolo prevedendo la possibilità di revocarlo, decorsi quindici anni dalla sua iscrizione, su domanda di un partecipante all’impresa familiare avente età inferiore a quarant’anni. Il quarto comma dell’art. 11 del D.Lgs. 228/2001 ha oggi generalizzato detta previsione, con effetto retroattivo nei confronti degli acquisti posti in essere fino a cinque anni prima dell’entrata in vigore del decreto. Il D.Lgs. 228/2001 prevede tre mezzi di sostegno per la formazione della proprietà coltivatrice: l’acquisto effettuato dagli Enti di sviluppo, sostenuto dal finanziamento della Cassa per la formazione della proprietà coltivatrice (ISMEA), di terreni che vengono accorpati al fine di creare unità produttive efficienti e successivamente ceduti a coltivatore diretti; la concessione di finanziamenti agevolati ai coltivatori diretti per l’acquisto di fondi rustici sul mercato a condizione che il prezzo d’acquisto sia congruo e che i fondi siano idonei «alla costituzione di aziende che abbiano caratteristiche per realizzare imprese familiari efficienti, sotto il profilo tecnico ed economico (art. 1, L. 590/65); un trattamento fiscale molto agevolato. Questionario 1. Quali sono i requisiti dell’impresa agricola? (par. 1) 2. Quali sono le differenze tra azienda agricola e fondo attrezzato? (par. 2) 3. 4. In quale caso il divieto di concorrenza è imposto al cedente un’azienda agricola? (par. 2) È possibile cedere il contratto di affitto di fondi rustici? (par. 2) 5. Cosa caratterizza il miglioramento agrario? (par. 3) 6. Quali cose possono costituire pertinenze agrarie? (par. 4) 7. Cosa sono i marchi collettivi? (par. 5) 8. Quali sono le differenze tra indicazioni geografiche protette (IGP) e denominazioni di origine (DOP)? (par. 5) 9. Quali sono le caratteristiche della prelazione agraria? (par. 8) 10. Quali particolarità sono previste per la successione agraria? (par. 8) 11. In cosa consiste l’usucapione speciale per la piccola proprietà rurale? (par. 8) Capitolo 4 L’attività agricola Sommario 1. Le attività agricole principali. - 2. Le attività connesse. 3. L’agriturismo. 4. L’esercizio dell’attività di vendita. 1. Le attività agricole principali Con l’attuale formulazione dell’articolo 2135 c.c. non è in dubbio che l’imprenditore agricolo si ricolleghi alla definizione di imprenditore di cui all’articolo 2082 c.c. Nel leggere in modo congiunto l’art. 2135 c.c. con l’art. 2082 c.c. (che reca la nozione di imprenditore in generale), si rileva che è imprenditore agricolo colui che esercita professionalmente e mediante un’organizzazione una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, al fine della produzione per il mercato. Queste tre specifiche attività sono poste sullo stesso piano e lo svolgimento di una sola di esse costituisce l’oggetto di un’impresa agricola e qualifica imprenditore agricolo il relativo operatore economico. La scelta del legislatore è stata nel senso di sostituire il precedente orientamento (l’atto commerciale individuare il commerciante) con quello facente capo all’impresa; nel senso, cioè, di porre al centro del sistema la figura del produttore che opera per il mercato in luogo dell’uomo d’affari-commerciante (COSTATO). Lo stretto collegamento tra gli articoli 2082 e 2135 c.c. trova conferma nel fatto che la disposizione immediatamente successiva all’articolo 2082, e cioè l’articolo 2083 c.c., definendo il piccolo imprenditore si richiama ad un agricoltore (coltivatore diretto), ad un industriale (l’artigiano) e ad un negoziante (il piccolo commerciante), ovvero sia a soggetti svolgenti le attività elencate, rispettivamente, nell’articolo 2135 quanto al primo, e nell’art. 2195, quanto agli altri due. Dunque, se alla definizione dell’articolo 2082 c.c. si rifanno le definizioni degli articoli 2135 e 2195 e se quest’ultime due esprimono i fini specifici dell’impresa agricola e dell’impresa commerciale, si deve prendere atto che l’individuazione delle specifiche attività dell’articolo 2135 fa sì che tutte le altre attività economiche vengono a far parte di quelle indicate, con formule generiche, nell’articolo 2195 (GERMANÒ). A) La coltivazione del fondo L’art. 2135 conserva la formula «coltivazione del fondo» che comporta problemi interpretativi; se, infatti, per fondo si intende il campo aperto, dovrebbe dedursi che non è imprenditore agricolo chi si avvale ad esempio di serre. Tale interpretazione non appare però condivisibile poiché per coltivazione del fondo deve intendersi ogni attività che ha come fine di conseguire dalla terra, sfruttandone le risorse naturali, la maggiore quantità e la migliore qualità dei prodotti vegetali. In altri termini l’espressione «coltivazione del fondo» va intesa come «coltivazione di piante». Ciò è confermato anche dalle indicazioni date dallo stesso legislatore che ad esempio nella L. 35-1982, n. 203 considera affitto di fondo rustico l’affitto di un terreno con serre fisse e nella L. 5-4-1985, n. 126 definisce attività agricola la coltivazione dei funghi realizzata in grotte o capannoni a tal fine allestiti. Poiché il secondo comma dell’art. 2135, nel chiarire il significato della formula coltivazione del fondo, fa riferimento alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, se ne deduce che l’attività agricola non può esplicarsi in un singolo atto isolato come ad esempio l’arare e il seminare e quindi che la coltivazione del fondo vuol dire coltivazione delle piante; che coltivazione vuol dire cura e attenzione del ciclo biologico dell’essere vegetale; che la cura del ciclo biologico può riguardarlo nella sua interezza, ma anche per una parte essenziale dello stesso. Perciò la serricoltura, la funghicoltura, la vivaistica, la produzione di fiori, di semi, di radici e non solo di frutti sono attività da imprenditore agricolo. E non solo la produzione di alimenti, ma anche la realizzazione di vegetali destinati a produrre biogas, carburante ed energia elettrica è attività agricola. La necessità, per aversi impresa agricola, della cura del ciclo biologico di essere vegetali (sancita dal 2° comma dell’art. 2135 c.c.) ha come conseguenza il fatto che la semplice raccolta di frutti naturali, anche se organizzata e destinata al mercato, non costituisce attività di impresa agricola, ma si è in presenza di un’impresa commerciale. Il possesso del fondo Il secondo comma dell’art. 2135 c.c. sancisce che per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. L’espressione «utilizzano o possono utilizzare il fondo» chiarisce, in modo inequivocabile, che il possesso del fondo non è più elemento indispensabile per l’attività dell’imprenditore. Ciò in linea con il processo evolutivo dell’impresa agricola che attraverso il progresso tecnologico è in grado di ottenere prodotti merceologicamente agricoli, con metodi che prescindono dallo sfruttamento della terra. Coerentemente, l’aver visto il fondo non più elemento essenziale ha portato, altresì, il legislatore ad indicare come agricole le imprese che svolgono dette attività anche in acque marine, ampliando l’attività di acquacoltura limitatamente alle acque dolci e salmastre. B) La selvicoltura L’espressione individua quell’attività economica diretta a ricavare dal bosco, attraverso i vari cicli di riproduzione, il legname mediante tagli periodici delle relative piante, disponendo inoltre la cura e la rinnovazione delle stesse previa autorizzazione. Sotto un certo profilo, la selvicoltura potrebbe definirsi come coltivazione del suolo boschivo. Il bosco, però, non dà solo legname, ma «produce ambiente», garantendo la saldezza del suolo, la purezza dell’aria, la conformazione del paesaggio. Questa ulteriore funzione del bosco è stata ritenuta la più importante, infatti, il D.Lgs. 227/2001, nonostante fosse intitolato all’orientamento e modernizzazione del settore forestale, contiene soprattutto disposizioni che collocano la coltura boschiva nella prospettiva di un’agricoltura di protezione, piuttosto che in un’ottica di tipo imprenditoriale (GERMANÒ). Tuttavia non si può negare la funzione produttiva di ricchezza del legname e il rilievo che nella produzione dello stesso ha l’osservanza di regole tecniche affinché l’albero non perda la sua capacità di produrre nuovamente. Ciò in un’ottica sia imprenditoriale sia di salvaguardia idrogeologica del territorio e ambientale. Il D.Lgs. 227/2001 (orientamento e modernizzazione del settore forestale) si propone come fine la valorizzazione della selvicoltura quale elemento fondamentale per lo sviluppo socioeconomico e per la salvaguardia ambientale del territorio nonché per la conservazione, l’incremento e la razionale gestione del patrimonio forestale nazionale. Ciò, appunto, allo scopo di conciliare le esigenze della produzione con la tutela ambientale. Dalla selvicoltura deve ritenersi distinta l’arboricoltura da legno cui fa riferimento l’art. 2 del D.Lgs. 227/2001. L’arboricoltura è la coltivazione di alberi in terreni non boscati finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e di biomassa; l’arboricoltura, quindi, non è una forma di utilizzo del bosco poiché si svolge su terreni diversi da quelli dei boschi, si può piuttosto ritenerla una forma di coltivazione di vegetali. Tra le attività connesse alla selvicoltura sono da annoverare quelle di pura trasformazione del legname (come lo scortecciamento e il taglio), il relativo immagazzinamento e la stagionatura. Il ciclo biologico È necessario fare una riflessione sull’inciso contenuto al secondo comma dell’art. 2135 c.c. «sviluppo di una fase necessaria del ciclo biologico», in quanto anche in presenza soltanto di una fase di tale ciclo, la cura della pianta costituisce attività agricola capace, se sussistono i requisiti richiesti dall’art. 2082 c.c., di assurgere ad attività di impresa agricola. Tale riflessione vale non solo con riguardo alla coltivazione delle piante, ma anche con riferimento all’allevamento di animali. L’espressione «una fase necessaria del ciclo biologico vegetale e animale» va intesa nel senso di una tappa di apprezzabile durata, onde evitare che importatori di animali, mercanti di piante e di fiori recisi, conservatori di frutta non ancora perfettamente matura siano definiti agricoltori (GERMANÒ). L’allevamento con mangimi, ad esempio, sarà attività agricola se avrà una durata non minima, cioè se si svolgerà lungo un periodo di tempo che apparirà adeguato per lo svolgimento del ciclo biologico, sicché non sarà agricoltore il mercante di bestiame che lo nutre in attesa di rivenderlo. C) L’allevamento di animali La precedente formula dell’art. 2135 faceva riferimento all’allevamento del bestiame, espressione che aveva posto diversi problemi interpretativi. La norma era stata elaborata nel periodo in cui si enumeravano tra il bestiame i soli bovini, equini, caprini e ovini. L’evoluzione delle tecniche di allevamento ha imposto una riflessione sul significato della parole «bestiame» volta ad omologare l’allevamento del bestiame «grosso» (secondo le classificazioni tradizionali) all’allevamento di quello cosiddetto «minuto» (capre, pecore) e «da cortile» (conigli, pollame, e volatili in generale) prima esclusi dal novero. La giurisprudenza restava, però, arroccata su posizioni tradizionaliste, fondate sull’esistenza del necessario nesso allevamento-coltivazione. Da più parti pertanto si invocava un intervento del legislatore, che con il D.Lgs. 228/2001 ha finalmente abbandonato il termine «bestiame» per adottare quello chiaro e semplice di «animali». Sono state così riconosciute a tutta una serie di tipologie di allevamento il presupposto per il riconoscimento di una attività imprenditoriale nel settore dell’agricoltura, indipendentemente dalla presenza o meno di un fondo. Ne consegue che, oltre ai tradizionali allevamenti connessi ad un fondo (allevamenti da carne, da lavoro, da latte e da lana) sono da ricomprendere a titolo di attività imprenditoriale agricola tutta una serie di allevamenti quali l’avicoltura, cunicoltura, apicoltura, bachicoltura ecc., anche se non necessariamente correlate alla titolarità di un fondo da parte dell’imprenditore. Si può concludere dicendo che l’allevamento di animali è agricolo quando consiste nella cura e nello sviluppo del ciclo biologico dell’animale o di una fase di tale ciclo. Dunque, è esclusa la necessità dell’attività di riproduzione per qualificare agricolo l’allevatore, ma è necessario che l’allevatore agricolo si occupi almeno di una fase della vita biologica dell’animale, per cui mai potrà essere considerato tale colui che alimenta gli animali nell’immediatezza della macellazione. L’imprenditore ittico è imprenditore agricolo? La pesca e la caccia, visto che manca l’attività dell’uomo per quanto riguarda la cura e lo sviluppo degli esseri animali pescati o cacciati, non sono mai state considerate dalla legislazione italiana come facenti parte dell’attività agricola. Quando, però, il Trattato di Roma, all’art. 32 (ora art. 38 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea), ha compreso tra i prodotti agricoli, accanto ai prodotti del suolo e dell’allevamento, quelli della pesca, il sistema giuridico italiano si è trovato a vivere due diverse normative a seconda che si fosse trattato di applicare disposizioni nazionali o comunitarie sulla cattura e raccolta dei pesci nei fiumi, nei laghi e nel mare. Per questo il Parlamento ha delegato il Governo di disciplinare l’attività di pesca come equiparata all’attività agricola. Ciò è avvenuto con D.Lgs. 226/2001, che all’art. 2 equiparava l’imprenditore ittico all’imprenditore agricolo, per cui, anche chi non cura il ciclo biologico dei pesci ma esercita l’attività di pesca professionale, diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci è, per il diritto, nella stessa situazione dell’agricoltore la cui caratteristica è, invece, la cura e lo sviluppo di esseri vegetali e animali. Non si tratta, quindi, di un’identità, ma di un’equiparazione ai fini della disciplina giuridica (GERMANÒ). La nuova definizione di imprenditore ittico (prima riportata nel D.Lgs. 226/2001) è oggi contenuta nel D.Lgs. 4/2012, recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura». È imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l’attività di pesca professionale di cui all’articolo 2 e le relative attività connesse. Quanto alla pesca professionale, l’art. 2 del D.Lgs. 4/2012 fornisce la relativa definizione, secondo cui la pesca professionale è l’attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all’ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca. Secondo quanto disposto dal comma 2 della stessa norma, come sostituito dal D.L. 83/2012, conv. in L. 134/2012, rientrano nelle attività di pesca professionale, se effettuate dall’imprenditore ittico di cui al citato art. 4, le seguenti attività: imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su navi da pesca a scopo turisticoricreativo, denominata «pesca-turismo»; attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell’imprenditore stesso, denominate «ittiturismo». Il comma 2bis della norma in esame, inserito dal D.L. 83/2012, conv. in L. 134/2012, infine, definisce le attività connesse alla pesca professionale, innovando rispetto alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 226/2001 attraverso l’eliminazione dal novero di tali attività di quelle riferite alla prima lavorazione e alla conservazione a bordo, che diventano a pieno titolo attività professionali (non più connesse). All’imprenditore ittico, al quale vengono considerate applicabili le disposizioni previste per l’imprenditore agricolo, viene equiparato l’acquacoltore. Non viene più riportata, invece, l’equiparazione tra imprenditore ittico e gli esercenti attività commerciali di prodotti ittici e tra le imprese di acquacoltura e l’imprenditore ittico. D) L’apicoltura Secondo la formulazione del vecchio testo dell’articolo 2135 c.c., e una volta accettata la tesi per la quale occorreva escludere il rapporto tra allevamento e coltivazione del fondo e occorreva comprendere nella nozione di allevamento la cura dei cicli biologici animali, la dottrina agraria si era divisa tra chi riteneva che la cura del ciclo biologico come caratteristica dell’allevamento agricolo non consentisse discriminazioni, per cui tutti gli animali potevano assurgere alla categoria di prodotti agricoli e chi si batteva per la ricerca di un criterio che consentisse di restringere l’elenco degli animali che potessero essere allevati da un imprenditore agricolo. Il D.Lgs. 228/2001 ha risolto tale problema, prevedendo che sono agricole le attività sì dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico di carattere animale, ma che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. In questo modo è stato limitato l’oggetto dell’allevamento agricolo ai soli animali che, in una ricostruzione sociologica dell’ambiente agrario, sono allevati sul fondo (GERMANÒ). Ne deriva l’esclusione, dall’impresa di allevamento agricolo, delle attività di allevamento di animali carnivori, come gatti, visoni, volpi, nonchè di quelle di allevamento di scimmie, serpenti, e altri animali non rientranti nell’idea di agricoltura. Devono, invece, ritenersi incluse la fauna selvatica allevata nelle aziende agro-turisitiche, al fine di offrire ai turisti occasioni e possibilità di caccia e le api, del cui allevamento si occupa la L. 313/2004. Il legislatore, con la L. 313/2004 sull’apicoltura, ha rinnovato la consuetudine delle leggi speciali per determinati tipi di attività. Tale norma dispone che «la conduzione zootecnica delle api, denominata apicoltura, è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del c.c., anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno» (art. 2). La legge, inoltre, al fine di evitare il diffondersi di malattie (come la varroasi), sancisce: che chiunque possieda alveari debba farne denuncia ai servizi veterinari dell’ASL competente (art. 6); l’introduzione dell’art. 896-bis nel codice civile sulla distanze minime per gli apiari (art. 8); che le Regioni adottino misure per l’incentivazione dell’apicultura anche nella forma «nomade» (quando si verificano uno o più spostamenti di alveari nel corso dell’anno); che gli enti pubblici aiutino la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o da loro detenuti (art. 7). 2. Le attività connesse Anche nella sua attuale formulazione, l’art. 2135 c.c. elenca, accanto alle tre attività cosiddette principali (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali), altre attività denominate connesse, ponendo l’interprete di fronte a problemi analoghi a quelli che si erano presentati sotto la vigenza della precedente versione dello stesso articolo. Cosa si intende per connessione? Poiché l’art. 2135 c.c. indica che lo stretto collegamento non è tra due attività poste sullo stesso piano, ma tra attività che si distinguono per essere, una, la principale e, l’altra, la secondaria, accessoria e collaterale, ciò significa che il legame tra le attività avviene perchè l’attività collaterale interferisce nel processo tecnico-economico dell’attività principale. In altre parole, l’attività connessa deve «servire» allo svolgimento dell’attività agricola principale o nel momento della produzione o nel momento dell’esercizio o nel momento dell’utilizzazione dei prodotti, servendo ad integrare il reddito dell’attività agricola principale, consentendo il raggiungimento del profitto cui tende l’agricoltore con l’esercizio della coltivazione del fondo, della selvicoltura e dell’allevamento (GERMANÒ). Del criterio della connessione tratta il comma 3 dell’art. 2135 c.c., a norma del quale «si intendono comunque connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge». Dal testo riportato si possono ricavare le seguenti considerazioni: è confermato il ricorso al principio dell’unisoggettività: occorre che sia lo stesso soggetto a svolgere l’attività principale e quella connessa perché possa parlarsi, giuridicamente, di connessione (cd. criterio soggettivo di connessione); altro elemento la cui presenza è indispensabile nella nozione di connessione è quello della uniaziendalità, che implica che l’attività collaterale deve essere inserita all’interno dell’organizzazione creata per lo svolgimento dell’attività principale, onde si abbia unità dell’organizzazione aziendale delle cui attrezzature l’imprenditore si avvale per l’esercizio dell’attività collaterale. La conseguenza dell’integrazione e dell’inserimento dell’attività collaterale nel processo produttivo organizzato dall’imprenditore fa sì che si abbia un’unica impresa; l’uso dell’avverbio «comunque» segnala che l’elenco delle attività indicate dal codice è puramente esemplificativo. Tale avverbio inoltre ha un importante rilievo probatorio in quanto l’attività si ritiene «comunque connessa salvo prova contraria», prova che graverà dunque su chi intenda contestare la connessione; le attività, per poter essere definite connesse, dovrebbero essere di per sé attività commerciali con una proiezione diretta sul mercato, ma la connessione con l’attività agricola le sottrae alla sfera del commercio e le assoggetta alla stessa disciplina dell’agricoltura. Pertanto, ad esempio, la manipolazione e la conservazione non possono consistere, ad esempio, nella separazione dei chicchi di grano dalla spiga o nella conservazione del grano nei silos: tali attività fanno parte della stessa attività di coltivazione organizzata ai fini del mercato e non acquistano alcuna rilevanza propria; per quanto riguarda il criterio oggettivo di connessione, esso è rappresentato dalla prevalenza, e più precisamente dalla necessità che l’attività accessoria riguardi prodotti prevalentemente provenienti dall’attività principale (criterio implicito nel vecchio art. 2135 c.c. che compare invece espressamente in altre discipline come, ad esempio, quella tributaria). Permane anche nell’attuale art. 2135 c.c. la distinzione tra attività connesse nominate e innominate (altrimenti definite tipiche o atipiche): sono attività connesse nominate (o tipiche) quelle indicate espressamente dal 3° comma e cioè: manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo e del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità. Per trasformazione si deve intendere una modifica della forma o della consistenza del frutto naturale tale per cui si ottiene un altro bene che assume la qualifica di bene finale, rispetto al quale il frutto allo stato naturale è strumentale, come ad esempio il vino rispetto all’uva. Alla trasformazione si ricollegano sia la commercializzazione, ossia l’alienazione del prodotto (vedasi oltre), sia la valorizzazione del prodotto, ossia quell’attività con cui si provvede a dare al prodotto un quid pluris, un valore aggiunto grazie all’inserimento di altre sostanze nutritive o aromatiche nel corso delle operazioni di trasformazione. Per quanto riguarda la vendita (commercializzazione e valorizzazione) va però evidenziato che in realtà essa è connaturata alla stessa attività imprenditoriale (l’agricoltore che non produce per il mercato è un autoconsumatore e non un imprenditore); si deve perciò ritenere che questa precisazione ha lo scopo di evitare qualsiasi interpretazione contraria. È imprenditore agricolo chi trasforma e commercializza prodotti altrui? È importante stabilire quando un’attività intrinsecamente commerciale possa qualificarsi come agricola per connessione. Sono due le condizioni necessarie: a) è necessario che il soggetto che la esercita sia già qualificabile imprenditore agricolo in quanto svolge in forma di impresa una delle tre attività agricole tipiche. È sicuramente imprenditore commerciale, quindi, chi commercializza prodotti agricoli altrui, o chi trasforma in vino e vende l’uva prodotta da altri, mentre resta imprenditore agricolo chi trasforma e vende a terzi l’uva da lui stesso prodotta; b) inoltre, è necessaria anche una connessione oggettiva, nel senso che è richiesto che si tratti di attività aventi ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dall’esercizio dell’attività agricola principale, ovvero di beni o servizi forniti mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzatura o risorse dell’azienda agricola. È, quindi, sufficiente che le attività connesse non prevalgano, per rilievo economico, sull’attività agricola principale (CAMPOBASSO). Dalla vigente formulazione dell’art. 2135 c.c. si ricava che un soggetto non perde la sua qualità di imprenditore agricolo quando manipola, conserva, trasforma, commercializza e valorizza, assieme ai prodotti propri, prodotti altrui che ha acquistato, appunto, per manipolarli, conservarli, trasformarli e valorizzarli per poi commercializzarli con i (prevalenti) propri, e ciò al fine di ottenere anche un mero aumento quantitativo della produzione e un più efficiente sfruttamento della struttura produttiva. Il fatto che l’esercente di tali attività debba essere lo stesso imprenditore agricolo consente di ritenere che i prodotti prevalenti di cui si sta parlando sono quelli provenienti dalla sua attività agricola principale, essendo cioè sufficiente che essi prevalgano sui prodotti da lui manipolati, conservati, trasformati, commercializzati e valorizzati assieme ai propri, ma derivanti dalla coltivazione o dagli allevamenti di altri operatori economici (GERMANÒ). Rientrano, infine, nella fornitura di beni o servizi ad esempio le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e quelle di ricezione e di ospitalità (vedi paragrafo successivo). Le attività di servizio non possono essere svolte da sole ma devono porsi in una logica di uniaziendalità. Il criterio dell’uniaziendalità si pone come discrimen dell’attività agricola connessa e dell’attività commerciale. È necessario, cioè, che le attrezzature aziendali adoperate non solo siano prevalenti sul complesso di macchine e attrezzi utilizzato nell’attività a favore dei terzi, ma soprattutto devono essere quelle che normalmente vengono impiegate nella stessa attività agricola esercitata dallo specifico imprenditore di cui si tratta. Tanto dovrebbe valere a fugare il timore che un agricoltore con un parco macchine adeguato agli ettari da lui coltivati svolga una prevalente attività di contoterzista, approfittando del più favorevole regime di attività connessa per fare concorrenza ai veri contoterzisti, che continuano ad essere imprenditori commerciali. Infatti, se egli ha pochi ettari, le sue macchine non potranno «normalmente» che essere poche e modeste, per cui egli avrà più interesse a rivolgersi ad un contoterzista per l’aratura e la trebbiatura, anziché indebitarsi a comprare trattori e trebbiatrici; se, invece, ha macchine adeguate alle sue vaste superfici, non avrà tempo per offrire un’attività di contoterzista agli agricoltori vicini. Le stesse considerazioni valgono anche per le attività connesse alla pesca, con riferimento alla disposizione per la quale le attività di prima lavorazione del pescato, la sua conservazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione sono connesse purché effettuate mediante attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’impresa ittica in considerazione. Tra le attività connesse tipiche, va segnalato l’art. 5 D.Lgs. 99/2004, che reca una disposizione concernente l’attività agromeccanica, stabilendo che è definita tale «quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agroforestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell’attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all’industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha eseguito la raccolta»; sono attività connesse innominate (o atipiche) le altre attività connesse diverse da quelle tipiche genericamente indicate come attività connesse nella parte finale dell’art. 2135 c.c. Anche per le attività connesse atipiche è richiesta l’identità soggettiva tra chi compie almeno una delle tre attività essenziali e l’attività connessa e quella oggettiva per cui l’attività connessa deve riguardare l’azienda agricola condotta dall’imprenditore agricolo. Per quanto riguarda l’individuazione delle attività connesse atipiche il loro numero appare ridotto anche in conseguenza dell’ampliamento del novero di quelle tipiche ad opera del 3° comma dell’attuale art. 2135 c.c. ; si considerano ad esempio attività connesse atipiche le attività preparatorie a quella agricola quali spianamenti di terreni o escavo di fossi. 3. L’agriturismo L’agriturismo trova la sua disciplina organica nella legge quadro 20 febbraio 2006, n. 96 che all’art. 2 stabilisce: «per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell’art. 230bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari». L’agriturismo è quindi attività agricola per connessione. Per potersi parlare di attività agrituristica non solo è necessario l’elemento dell’unisoggettività, ma anche quello dell’uniaziendalità: infatti, le attività di ricezione ed ospitalità devono essere esercitate dagli imprenditori agricoli attraverso l’utilizzazione della propria azienda, l’ospitalità deve essere data in edifici o parte di essi già esistenti nel fondo, nonché in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, la consumazione di pasti e bevende, la degustazione di prodotti aziendali e la mescita di vini devono avvenire sul posto, le bevande e i cibi devono essere prodotti, lavorati e trasformati nell’azienda agricola ma possono essere ricavati da materie prime dell’azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne. Il concetto di prodotto aziendale nell’impresa agrituristica Per l’art. 2135 c.c., il prodotto aziendale dell’imprenditore agricolo non è solo quello ottenuto dai suoi campi, dal suo bosco o dal suo allevamento, ma anche quello, purché non prevalente, ottenuto sui campi, nei boschi e dagli allevamenti di altri che il primo ha acquistato, manipolato, conservato, trasformato e commercializzato assieme ai propri. Per cui, l’imprenditore dell’agriturismo non dovrebbe perdere tale qualifica se offre cibi provenienti, se pur non in modo prevalente, da materie prime agricole altrui, o che altri abbiano lavorato fuori dalla sua azienda agricola e che egli offre in degustazione o somministra ai turisti. Ciò trova conferma nel comma 3 dell’art. 2135 c.c., quando fa riferimento ai beni forniti «mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda», intendendo per risorsa la stessa produzione aziendale, facendo intravedere la possibilità che vi concorrano, a scopo integrativo, risorse extraziendali. La nuova legge sull’agriturismo (L. 96/2006) conferma tale conclusione, prevedendo che, anche al fine di contribuire alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali, spetta alle Regioni disciplinare la somministrazione di pasti o di bevande da parte dell’imprenditore dell’agriturismo prevedendo che, non solo una quota significativa dei prodotti somministrati debba provenire da aziende agricole collocate in ambito regionale o in zone omogenee contigue di regioni limitrofe, ma anche che in casi di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o in zona limitrofa e di loro effettiva necessità ai fini del completamento dell’offerta enogastronomica, possono essere presi in considerazione, ma in una quota limitata, prodotti di altra provenienza. Tale allargamento risponde alle direttive del programma politico-economico dell’Unione Europea, miranti a sostenere il reddito degli imprenditori agricoli attraverso aiuti a coloro che, in zone svantaggiate, effettuino nell’azienda agricola attività di carattere turistico e artigianale o che svolgano nell’azienda agricola attività forestali, turistiche, artigianali. La L. 96/2006, che ha abrogato e sostituito la L. 730/1985, è stata emanata anche per armonizzare la disciplina nazionale con i programmi di sviluppo rurale provenienti dal diritto comunitario che prevedono, ai fini del sostegno delle attività agricole e della loro riconversione, misure a favore della incentivazione di attività agrituristiche. É, infatti, la citata legge all’art. 1 individua come finalità da perseguire: a. tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio; b. favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali; c. favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli; d. favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell’ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l’incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita; e. recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche; f. sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche; g. promuovere la cultura rurale e l’educazione alimentare; h. favorire lo sviluppo agricolo e forestale. Rientrano fra le attività agrituristiche: a. dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori; b. somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP e IGP, o compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell’articolo 4, comma 4; c. organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini; d. organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale. È, infine, compito delle Regioni stabilire criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività agrituristica, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale. In particolare, nei criteri che le Regioni devono adottare per ritenere sussistente il rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, affinché l’organizzazione dell’attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione, rispetto all’attività agricola, vengono in evidenza: il tempo di lavoro necessario all’esercizio delle stesse attività; il numero di ospiti che, se non è superiore a dieci, garantisce la prevalenza dell’attività agricola principale. Inoltre, occorre che sia prevalente «una quota significativa di prodotto proprio» quando vengono somministrati pasti e bevande, salvo che destinatari di essi siano le persone alloggiate, che sia presente un’ulteriore quota di apporto di prodotti di aziende agricole della zona e che la parte rimanente dei prodotti impiegati nella somministrazione dei pasti e delle bevande deve provenire da artigiani alimentari della zona. Produzione di energia elettrica tra le attività agricole Un’importante novità è contenuta nel comma 423 dell’art. 1 della Finanziaria 2006, che ha stabilito che «la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario». Il processo relativo alla valorizzazione delle fonti agro-forestali per scopi energetici è iniziato, in particolare, con il D.Lgs. 387/2003 che ha attuato la direttiva 2001/77/Ce relativa alla produzione di energia elettrica, alimentata da biomasse o simili. Gli effetti – Questa classificazione ha i seguenti effetti: l’attività ha natura agricola, ma la norma richiama il terzo comma dell’art. 2135 c.c. e quindi è necessario che le fonti agro-forestali siano ottenute prevalentemente dal fondo, dal bosco o dall’allevamento di animali condotti dalla medesima impresa; il comma 423 prevede che l’attività rientra nel reddito agrario; le costruzioni destinate alla produzione di energia elettrica hanno la natura di fabbricati rurali; i titolari dell’impresa mantengono la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (D.Lgs. 99/2004); l’attività di produzione di energia elettrica può essere svolta anche da società semplice. La Finanziaria 2008 ha introdotto una modifica al comma 423 dell’art. 1 della Finanziaria del 2006, in base alla quale, relativamente alla produzione di energia elettrica e calorica, nonché di carburanti e prodotti chimici ottenuti con produzioni vegetali, è concessa la facoltà di determinare il reddito nei modi ordinari. In sostanza, le imprese agricole che producono energia rientrano naturalmente nel reddito agrario, ma possono facoltativamente determinare il reddito in base alla differenza tra costi e ricavi. A) Scelta della forma societaria Le forme giuridiche maggiormente utilizzate sono: la ditta individuale, quando l’imprenditore è l’unico titolare dell’attività e risponde in proprio con tutto il patrimonio personale dei risultati di gestione (forma societaria adatta alle attività svolte a livello artigianale); l’impresa familiare, che consiste in un’impresa individuale in cui partecipano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, che prestano la propria attività in modo continuativo e senza che sia riscontrabile alcun tipo di rapporto dipendente; le società di persone (soc. semplice, s.n.c., s.a.s.), nella quale la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è illimitata. Tale forma giuridica risulta adatta per chi intende avviare un’attività di dimensioni limitate, con un numero di soci e di capitali ridotto; le società di capitali (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l.), in cui la responsabilità è limitata al capitale sociale e resta la responsabilità personale civile penale del socio/amministratore per atti illeciti nella gestione. B) Locali per attività turistiche L’art. 3 della L. 96/2006 tratta la valorizzazione delle risorse naturali e culturali delle aree rurali, della diversificazione delle attività e del recupero del patrimonio edilizio nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e paesaggistico-ambientali. Le attività agrituristiche possono essere svolte negli edifici, o parte di essi, già esistenti nel fondo. Spetta alle Regioni disciplinare gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell’imprenditore agricolo ai fini dell’esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi. L’eventuale utilizzo del patrimonio edilizio esistente, ai fini di tali attività, deve essere condotto nel rispetto delle specifiche caratteristiche del paesaggio e dell’ambiente. C) Norme igienico-sanitarie I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle Regioni. Si tiene, principalmente, conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, oltre che delle limitate dimensioni dell’attività esercitata. La valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e di somministrazione di sostanze alimentari e del piano aziendale di controllo igienico sanitario è condotta dall’autorità sanitaria. Qust’ultima deve tener conto, nel corso di tale analisi, della limitata quantità delle produzioni e dell’utilizzo di metodi tradizionali di lavorazione. 4. L’esercizio dell’attività di vendita L’art. 4 del D.Lgs. 228/2001 (poi modificato dal D.L. 2/2006, conv. in L. 81/2006) contiene la disciplina dell’esercizio della vendita di prodotti agricoli. Tale disciplina facilita la loro alienazione, al fine di favorire il completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa, quale necessario e connaturale sbocco dell’attività imprenditoriale. È stata, infatti, riconosciuta la possibilità per gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di esercitare la vendita diretta dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende. I punti principali della disciplina, che ha sostituito quella risalente alla L. 9-2-63, n. 59 sono i seguenti: alla vendita diretta di prodotti agricoli non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 114/1998, vale a dire la normativa di riferimento per il settore commerciale (art. 4, comma 7, D.Lgs. 228/2001); i soggetti legittimati all’attività di vendita al dettaglio sono gli imprenditori agricoli (in luogo dei «produttori agricoli», genericamente menzionati dalla precedente L. 59/63) iscritti nel registro delle imprese; sono notevolmente ridotti i requisiti soggettivi richiesti per compiere detta attività. Infatti mentre in forza della precedente L. 59/1963, l’agricoltore era ammesso alla vendita al dettaglio dei soli prodotti ottenuti nel proprio fondo per coltura o allevamento, alla stregua delle nuove disposizioni, invece, l’imprenditore agricolo può vendere al dettaglio anche prodotti non agricoli o comunque non provenienti dalla propria azienda, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. È stato rinnovato, quindi, l’iter amministrativo per gli agricoltori che intendono commercializzare le proprie produzioni. Gli imprenditori agricoli, se iscritti nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio nazionale, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante, effettuata cioè con mezzi mobili o con banchi di vendita trasportabili non ancorati a terra, è possibile previa comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Dal tenore letterale della norma, sembrerebbe non rendersi obbligatoria alcuna comunicazione da parte degli agricoltori intenzionati a vendere sul luogo di produzione. È in ogni caso obbligatoria l’iscrizione al Registro delle Imprese e l’osservanza delle norme in materia di igiene e sanità. Qualora s’intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante, ma su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al Sindaco del Comune in cui avrà luogo la commercializzazione. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche, mediante l’utilizzo di un posteggio, la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo al Sindaco. La stessa disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa. Di fatto, è stata superata la L. 59/1963 che limitava la vendita diretta ai prodotti di propria produzione, anche se non è stata espressamente prevista l’abolizione. Non possono esercitare l’attività di vendita diretta le persone condannate con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività. Alla vendita diretta come sopra esposta, continua a non applicarsi la disciplina relativa al settore del commercio, sempreché l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende, conseguito nell’anno solare precedente, sia inferiore ad euro 160.000 (per gli imprenditori individuali) ovvero ad euro 4.000.000 (perle società). Tale rilievo sull’ammontare dei ricavi della vendita dei prodotti agricoli per riportare l’agricoltorevenditore nell’area del commercio consente di ribadire la natura imprenditoriale del produttore agricolo. L’individuazione dell’origine del prodotto agricolo (tracciabilità) e l’etichettatura Oggi, il mercato, è il luogo in cui il venditore mette in offerta i suoi prodotti già confezionati e l’acquirente si limita a preferire una merce invece di un’altra. Tale scelta consiste in un’operazione di preferenza, per cui essa è necessariamente preceduta dalla fase della «conoscenza> dei dati offerti, insieme ai beni, dai produttori. Il dialogo tra produttori e consumatori consiste in un flusso di informazioni dai primi ai secondi, tramite tecniche di presentazione e di spiegazione delle singole merci, ossia attraverso la pubblicità e l’etichetta. L’etichetta è, appunto, il «luogo» in cui il produttore riporta le informazione che ritiene opportune (es., il luogo di origine del prodotto), mentre il consumatore ricava tutto ciò che gli serve per sapere che cosa sia quel determinato prodotto che sta acquistando, quali sono le sue qualità e da quali pregi o manchevolezze sia caratterizzato. Con l’approvazione della L. 4/2011, recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari», per vendere in Italia prodotti agroalimentari «made in Italy», diventa obbligatorio indicare su tutti i cibi, nell’etichetta, luogo di origine o di provenienza (oltre alle altre informazioni già previste dalla normativa vigente), dando informazioni precise ai consumatori su cosa consumano ogni giorno. L’articolo centrale della legge è l’attuale articolo 4, relativo all’etichettatura dei prodotti alimentari. Esso prevede, al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, che è obbligatorio riportare nell’etichettatura di tali prodotti l’indicazione del luogo di origine o di provenienza. Tale obbligo di indicazione è stato esteso anche a pasta, salumi, frutta e verdura trasformata, formaggi, derivati dei cereali, latte a lunga conservazione, quindi tutti prodotti che, da questo punto di vista, finora non erano etichettati. Ad oggi, infatti, l’indicazione di provenienza era presente solo su carne bovina, carne di pollo e derivati, frutta e verdura fresche, uova, latte fresco, olio extravergine di oliva. Inoltre, in conformità alla normativa dell’Unione europea, è stato introdotto l’obbligo di indicare in etichetta l’eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale. Per i prodotti non trasformati, il luogo d’origine riguarda il paese di produzione; per quelli trasformati dovranno essere indicati il luogo dove è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione o allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata. Entro sessanta giorni dall’approvazione della legge dovranno essere emanati decreti interministeriali da parte del Ministero dello Sviluppo economico e di quello delle Politiche Agricole, con cui verranno definite le modalità per l’indicazione obbligatoria, nonché le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale. Con gli stessi saranno definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all’obbligo dell’indicazione nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti. È previsto, inoltre, all’articolo 5 della legge, che la pubblicità dei prodotti non potrà essere ingannevole: le informazioni relative al luogo di origine o di provenienza delle stesse materie prime sono necessarie al fine di non indurre in errore il consumatore medio e l’omissione delle stesse costituisce pratica commerciale ingannevole. In questo modo si assicura la fine delle pratiche commerciali sleali nella presentazione degli alimenti per quanto riguarda la reale origine geografica degli ingredienti utilizzati. All’articolo 2 della legge è stato introdotto anche il divieto di inserire il nome di formaggi Dop nell’etichetta delle miscele di formaggi. Il nome potrà comparire solo tra gli ingredienti e a patto che la presenza di formaggio Dop non sia inferiore al 20 per cento della miscela. La legge contiene anche altri provvedimenti che vanno dalla promozione di contratti di filiera e di distretto a livello nazionale all’istituzione di un Sistema di qualità nazionale di produzione integrata dei prodotti agroalimentari. In pratica i produttori, aderendo al sistema, su base volontaria, potranno utilizzare l’apposito logo che certificherà la qualità superiore a patto che: applichino la disciplina di produzione integrata che prevede, tra l’altro, un basso uso di sostanze chimiche; si sottopongano ai relativi controlli di Organismi terzi accreditati. Questionario 1. Cosa si intende per coltivazione del fondo? (par. 1) 2. Qual è la differenza tra selvicoltura e arboricoltura? (par. 1) 3. Cosa si intende per fase necessaria del ciclo biologico? (par. 1) 4. L’imprenditore ittico è imprenditore agricolo? (par. 1) 5. Cosa si intende per attività connesse? (par. 2) 6. Quali sono i criteri affinché un’attività possa considerarsi connessa? (par. 2) 7. In cosa consiste l’attività agrituristica? (par. 3) 8. Qual è la disciplina della vendita diretta dei prodotti agricoli? (par. 4) Capitolo 5 L’imprenditore agricolo Sommario 1. Nozioni introduttive. - 2. La rappresentanza dell’imprenditore agricolo. - 3. Il piccolo imprenditore agricolo: il coltivatore diretto. - 4. Altri soggetti cui si applica la disciplina dell’impresa agricola. - 5. Gli agricoltori «giovani». - 6. L’Imprenditore Agricolo a Titolo Principale (IATP) e l’Imprenditore Agricolo Professionale (IAP). - 7. L’impresa familiare. - 8. Le società agricole. 9. Le organizzazioni dei produttori. - 10. Le organizzazioni interprofessionali. - 11. Soggetti collettivi ed enti pubblici come imprenditori agricoli. - 12. L’iscrizione nel registro delle imprese. - 13. L’assetto del registro delle imprese. 1. Nozioni introduttive Come osservato nel capitolo precedente, lo svolgimento dell’attività agricola è considerato a pieno titolo attività d’impresa della quale l’imprenditore agricolo, come ogni imprenditore, assume la piena e totale responsabilità civile, penale e amministrativa, nel rispetto, innanzitutto, dei fondamentali principi costituzionali di cui all’art. 41 Cost. che riconosce la libertà dell’iniziativa economica privata purché non svolta in contrasto con l’utilità sociale o in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Ai sensi del nuovo art. 2135 c.c. «è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse». Il comma 2 dell’art. 1 D.Lgs. 228/2001 precisa altresi che «si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2135 del codice civile…, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico». Nella disciplina codicistica, quindi, è ancora prevalente la figura dell’imprenditore agricolo singolo, ed è limitata l’attenzione rivolta alle società di capitali o a forme societarie diverse rispetto a cooperative e consorzi, a differenza di quanto a più riprese invocato da molti operatori del settore e dalla migliore dottrina; tuttavia non si deve trascurare l’importante passo compiuto dal legislatore nella normativa speciale. Oltre a quanto previsto, come si è detto, dal comma 2 dell’art. 1 del D.Lgs. 228/2001 va evidenziato quanto previsto dal D.Lgs. 99/2004 (modificato dal D.Lgs. 101/2005) il quale all’art. 1 stabilisce i criteri perché anche società di persone, cooperative e società di capitali possano considerarsi imprenditore agricolo professionale e all’art. 2 prevede una specifica disciplina per le società agricole. Comunque, siamo in presenza di un imprenditore agricolo ogni volta in cui un soggetto eserciti l’attività di coltivazione del fondo, o di silvicoltura o quella di allevamento di animali con lo scopo di immettere la produzione sul mercato. I rapporti con la definizione di imprenditore dell’art. 2082 c.c. Non si può mettere in dubbio che la nuova formula di cui all’art. 2135 c.c. si ricolleghi alla definizione dell’art. 2082 c.c., secondo cui è imprenditore chi «esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi». D’altronde lo stesso legislatore del 1942 aveva mostrato in modo palese che si dovesse inserire l’art. 2135 c.c. nell’orbita della definizione dell’art. 2082 c.c., sia con l’organizzare sotto il capo «dell’impresa in generale» gli altri due capi rispettivamente intitolati «dell’impresa agricola» e «delle imprese commerciali e delle imprese soggette a registrazione», sia con il riferirsi nell’art. 2083 c.c. al coltivatore diretto come ad uno dei piccoli imprenditori (GERMANÒ). L’immagine che si offriva all’interprete era quella di una piramide il cui vertice era costituito dall’art. 2082 c.c. e gli angoli di base dall’art. 2135 c.c. da un lato e l’art. 2195 c.c. dall’altro. Oggi invece, sotto la nuova formula, l’affermazione che l’agricoltore, come preso in considerazione dal codice civile, è un operatore economico per il mercato, balza in modo nitido dallo stesso contesto normativo. 2. La rappresentanza dell’imprenditore agricolo Prima di vedere le diverse «figure» che il soggetto imprenditore assume nell’esercizio della agricoltura è utile osservare che nell’esercizio di un’impresa agricola di rilevanti dimensioni, il potere organizzativo relativo alla stessa può essere esercitato da soggetti diversi dall’imprenditore, ai quali viene trasferito, quindi, l’esercizio e non la titolarità del potere stesso. Ciò implica che i soggetti in questione non acquistano la qualifica di imprenditore, bensì quella di ausiliari dello stesso. Recita al riguardo l’art. 2138 c.c. «I poteri dei dirigenti preposti all’esercizio dell’impresa agricola e quelli dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto dal preponente, sono regolati dagli usi». Da questa norma si evince che gli ausiliari dell’imprenditore agricolo sono, in sostanza, due: il dirigente agricolo e il fattore di campagna. Le due figure summenzionate presuppongono, abitualmente, l’esistenza di un’impresa agricola non piccola, dal momento che, diversamente, l’imprenditore sarebbe tenuto ad esercitare personalmente l’attività d’impresa, da solo o coadiuvato dai propri familiari. Tratto comune agli ausiliari dell’imprenditore è il contratto di lavoro subordinato, che li legittima a compiere l’attività organizzativa dell’impresa in rappresentanza dell’imprenditore (sia nei confronti dei dipendenti — rappresentanza interna, sia nei confronti dei terzi — rappresentanza esterna). Secondo la dottrina prevalente, è preferibile parlare di rappresentanza organica, ossia di un rapporto funzionale e necessario allo svolgimento dell’attività produttiva. In altre parole, non è concepibile che un soggetto venga preposto all’esercizio dell’impresa, senza essere fornito dei poteri di rappresentanza ad esso strumentali. La rappresentanza degli ausiliari trova il suo fondamento: a. ove sussista una procura scritta da parte dell’imprenditore, in un contratto di mandato: poteri e relative limitazioni saranno, di conseguenza, desumibili dalla procura; b. ove la procura scritta manchi, invece, la legge fa espresso riferimento agli usi. Secondo la teoria preferibile (GALLONI), in questo caso si tratterebbe di rappresentanza organica desumibile dal collegamento con il contratto di lavoro dell’ausiliario. In altre parole, come la rappresentanza organica si innesta su un rapporto di lavoro subordinato in virtù del quale il rappresentante non agisce in nome proprio, ma come organo dell’ente rappresentato, così anche il dirigente e il fattore di campagna agiscono traendo i loro poteri dal contratto di lavoro subordinato (che attribuisce loro la rappresentanza). Dottrina Secondo parte della dottrina (IRTI), invece, si tratterebbe di rappresentanza legale o necessaria, regolata per analogia dalle disposizioni contenute nell’art. 2204 c.c., relative all’institore. Si obietta, però, (BELVISO) che la figura degli ausiliari è regolata da una norma apposita (speciale e diversa da quella dell’imprenditore commerciale), l’art. 2138 c.c., e che, pertanto, non è necessario ricorrere all’analogia. Altri autori (ROSSI) parlano di contratto tacito di mandato o di rappresentanza volontaria. Si obietta al riguardo che, a differenza della teoria diffusa sotto la vigenza del codice civile del 1865 (il cd. mandato presunto, in virtù del quale c’era un legame necessario tra rappresentanza e mandato), attualmente non c’è più questo nesso imprescindibile, nel senso che si ammette pacificamente un mandato senza rappresentanza, come pure il fatto che la rappresentanza trovi la sua fonte in un contratto diverso dal mandato (ad esempio, un contratto di lavoro subordinato). A) Il dirigente agricolo Il codice, all’art. 2138, pur individuando i poteri dei dirigenti preposti all’esercizio dell’impresa agricola e dei fattori di campagna, non fornisce una definizione del dirigente o del fattore di campagna per cui, in assenza di una definizione codicistica, gli interpreti hanno fatto riferimento alla definizione di dirigente contenuta nei contratti collettivi. La dottrina e la giurisprudenza hanno considerato decisivo, ai fini dell’attribuzione della qualifica di dirigente, il fatto che il soggetto si ponga come alter ego dell’imprenditore, considerando che le funzioni del dirigente agricolo sono molto simili a quelle demandate al dirigente che opera nel settore commerciale, ed accostando così la figura del dirigente a quella dell’institore di impresa commerciale. In sostanza, il dirigente agricolo deve esercitare l’attività organizzativa dell’impresa non per proprio conto, bensì nell’interesse dell’imprenditore, nei confronti del quale si pone come ausiliario. Ciò non toglie, comunque, l’alto grado di autonomia che residua al dirigente agricolo, nel rispetto delle direttive generali impartitegli dal datore di lavoro. In sintesi il dirigente agricolo organizza l’attività dei lavoratori subordinati ed impartisce loro direttive, come specifica l’art. 2104 c.c., ed è abilitato a stipulare quei contratti di lavoro strumentali all’esercizio dell’impresa, con il limite che gli deriva dall’originaria destinazione del fondo. B) Il fattore di campagna In tale categoria venivano in origine ricondotti gli esperti agricoli dotati di notevole capacità pratica acquisita nella lunga esperienza di lavoro nei campi e legati all’imprenditore agricolo da un rapporto fiduciario. Attualmente, in seguito ad una sempre maggiore tecnicizzazione ed industrializzazione delle strutture aziendali, la figura del fattore di campagna sta sempre più scomparendo in quanto sostituita dalla figura del dirigente agricolo, nella cui categoria si fanno rientrare anche quei soggetti che hanno conseguito un titolo di studio presso un istituto agrario. Il fattore di campagna può assumere la figura di lavoratore autonomo in quei casi in cui collabori con i titolari di grandi amministrazioni nella direzione dell’azienda agricola anche se nei limiti della normale conduzione dei fondi. Anche questa è una figura vicaria dell’imprenditore, preposta all’attività organizzativa dell’impresa agricola. Si distingue dal dirigente agricolo, in quanto il fattore di campagna non riveste una qualifica superiore a quella di impiegato e trova la disciplina dei propri poteri in consuetudini consolidate. Il fattore di campagna, che si assume la cura e l’organizzazione dell’impresa agricola, è conosciuto soprattutto in quelle zone fondate su di una economia di stampo precapitalista (in particolare, quelle mezzadrili). 3. Il piccolo imprenditore agricolo: il coltivatore diretto Il codice civile, dopo la definizione generale di imprenditore (art. 2082 c.c.) detta quella, anch’essa generale, di piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.) e vi include i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Al momento della redazione del codice civile, coltivatore diretto poteva essere sia il proprietario del fondo sia l’affittuario di esso, e si caratterizzava, come tutti gli altri piccoli imprenditori, per il modo personale di svolgere l’attività, in quanto svolgeva un lavoro esecutivo e non si limitava all’attività di direzione e di organizzazione propria dell’imprenditore. Oggi, sono coltivatori diretti tutti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempre che tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo. Ci si chiede cosa debba intendersi per «lavoro esecutivo» del coltivatore diretto. All’origine della fattispecie del coltivatore diretto si faceva riferimento solo al suo lavoro «con le braccia»; successivamente si è preso in considerazione, ai fini del calcolo del terzo, anche l’uso delle macchine, per cui oggi, il lavoro esecutivo che si richiede al coltivatore diretto è un lavoro tecnico esecutivo proprio degli operai, ma anche di operai specializzati (GERMANÒ). Ai fini del calcolo del terzo, ci si chiede se è solo questo lavoro tecnicoesecutivo ad essere preso in considerazione. La dottrina dominante ritiene che il lavoro personale del coltivatore diretto da prendere in considerazione ai fini della comparazione con il lavoro esecutivo svolto dai suoi dipendenti è solo un lavoro esecutivo che si aggiunge al normale lavoro direttivo che è proprio di ogni imprenditore e che, per questo motivo, non può rientrare nel computo del terzo. Tratti caratteristici della figura del coltivatore diretto sarebbero: l’abitualità e la tipicità del lavoro prestato, individuata, prevalentemente, nella attività di coltivazione della terra e di allevamento degli animali, come pure nel potere di direzione dell’azienda. La Corte di Cassazione (Cass. 5456/91 e Cass. 759/95) ha interpretato il concetto di abitualità nel senso di attività non occasionale, con la conseguenza che il coltivatore diretto, oltre alle attività agricole, potrà esercitare anche attività diverse, e che le prime non debbono necessariamente prevalere sulle seconde (Cass. 15438/2000). Da ultimo, la Corte di Cassazione (Cass. 2019/2011) ha fornito un’interpretazione del concetto di «diretta e abituale coltivazione del fondo». La Corte ha ribadito che tale requisito va inteso quale normale e usuale svolgimento di lavori agricoli, in maniera tale che l’attività agricola venga realizzata in modo stabile e continuativo, prevalentemente con lavoro proprio o dei componenti della famiglia, traendo da tale attività un reddito, pur se secondario; la prestazione del lavoro da parte del coltivatore diretto e della propria famiglia in misura non inferiore ad un terzo delle forze normalmente occorrenti per la coltivazione del fondo. Non si esclude, tuttavia, che possa definirsi coltivatore diretto anche un soggetto privo di famiglia, il quale, grazie all’apporto lavorativo proprio e al sostegno dei macchinari, produca forza lavorativa pari ad almeno un terzo delle necessità della sua impresa. Una conferma indiretta di tale assunto si rinviene nell’art. 48, 2° comma, L. n. 203/1982, ai sensi del quale «Il rapporto continua anche con un solo familiare, purché la sua forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo». È importante sottolineare che, relativamente al coltivatore diretto, vige il principio di effettività, nel senso che l’acquisto e il mantenimento della qualifica sono subordinati all’esercizio in concreto dell’attività agricola. In altre parole, la qualifica in esame può anche perdersi ove intervengano mutamenti nella compagine familiare suscettibili di influire sulla capacità lavorativa complessiva. I soggetti equiparati al coltivatore diretto ai fini dell’affitto L’art. 7 della L. n. 203/1982 ha equiparato al coltivatore diretto «le cooperative costituite dai lavoratori agricoli e i gruppi di coltivatori diretti, riuniti in forme associate» nonché «i laureati o diplomati di qualsiasi scuola di indirizzo agrario o forestale e i laureati in veterinaria per le aziende a prevalente indirizzo zootecnico, in età non superiore ai cinquantacinque anni, che si impegnino ad esercitare in proprio la coltivazione dei fondi, per almeno nove anni». Per quanto riguarda quest’ultima categoria di equiparati al coltivatore diretto, si è posta la necessità di un distinguo rispetto alla figura dell’imprenditore dato che l’art. 7 della L. 203/1982 afferma che l’equiparato deve impegnarsi «ad esercitare in proprio la coltivazione dei fondi». La dottrina concordemente ritiene che la lettera dell’art. 7 L. 203/1982 non può essere intesa nel senso di esercizio dell’impresa a proprio nome e proprio rischio di cui all’art. 2082 c.c., formula che definisce la figura dell’imprenditore in generale; né può essere intesa come attività manuale o esecutiva perché altrimenti si avrebbe una assoluta identità e non una «equiparazione» al coltivatore. La formula secondo la quale l’equiparato «deve impegnarsi ad esercitare in proprio» la coltivazione non può essere intesa come attività manuale o esecutiva, perché altrimenti non si avrebbe equiparazione, ma assoluta identità con la figura del coltivatore diretto. La soluzione del problema, quindi, si basa innanzitutto sulla distinzione tra lavoro direttivo ed esecutivo; infatti il lavoro che il laureato od il diplomato deve prestare nell’azienda è lo specifico lavoro che il relativo titolo di studio gli consente di apportare all’impresa e non l’attività direttiva ed organizzativa propria dell’imprenditore. Tale lavoro deve sostituire o aggiungersi a quello specifico di tecnici o di professionisti che sarebbe necessario assumere a seconda della specifica attività imprenditoriale esercitata. Così ad esempio, il veterinario, equiparato al coltivatore diretto nell’ipotesi di un’azienda a prevalente indirizzo zootecnico ex art. 7 L. 203/1982, svolgerà attività di veterinario al posto o in aggiunta di dipendenti veterinari. Si precisa che, relativamente ai diplomati e laureati, l’impegno di «esercitare in proprio la coltivazione dei fondi» non si riferisce all’attività lavorativa manuale, bensì all’attività tecnico professionale svolta in conformità al titolo di studio e che l’equiparazione in parola è valida unicamente nell’ambito del rapporto di affitto. 4. Altri soggetti cui si applica la disciplina dell’impresa agricola Il legislatore ha espressamente disposto l’estensione a determinati soggetti dei vantaggi riservati agli imprenditori agricoli. Sono considerati imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli ceduti dai soci. Inoltre, sono considerati imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi quando utilizzano, per la coltivazione del fondo, la selvicoltura e l’allevamento di animali, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero prevalentemente ai soci forniscono beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico. Sono, invece, equiparati agli imprenditori agricoli gli imprenditori ittici, ovvero coloro che svolgono un’attività professionale e organizzata, diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci, dovendosi riconoscere che il richiamo ai termini «cattura» e «raccolta» fa sì che siano, invece, veri imprenditori agricoli coloro che «allevano» i pesci, cioè che ne curano il ciclo biologico (GERMANÒ). Inoltre, sono equiparati agli imprenditori agricoli le cooperative che forniscono servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, ossia quando esercitano attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali. Partendo dal fatto che imprese di struttura e sostanza «commerciale» sono state equiparate alle imprese agricole, ci si è chiesti, infine, se nei distretti rurali di cui tratta il D.Lgs. 228/2001, sia possibile immaginare imprese che, svolgendo una delle fasi dell’attività di coltivazione del fondo (aratura, semina, raccolta) o di allevamento di animali (monta, mungitura, tosatura), possano qualificarsi come imprese agricole. In altre parole, visto che all’interno di ciascun distretto le produzioni dovrebbero essere ripartite in fasi distinte, di estrema specializzazione ma tutte tra loro funzionalmente collegate, aventi ognuna per destinazione non il cliente finale, ma un’altra impresa operante nello stesso territorio in una fase diversa della filiera, si è prospettata la tesi che ciascuna impresa della filiera agricola, dato che svolge una fase del ciclo produttivo, possa essere qualificata impresa agricola (GERMANÒ). A tal fine bisogna tener presente che la «fase» di cui si parla nell’art. 2135 c.c. è una fase del ciclo biologico e non della complessiva attività di filiera della cura e dello sviluppo del ciclo biologico degli essere vegetali o animali, rispettivamente, coltivati o allevati. 5. Gli agricoltori «giovani» Il diritto comunitario favorisce i giovani agricoltori, cioè soggetti che non hanno ancora compiuto i quaranta anni e che, avendo competenza ed esperienza professionale, si dedicano all’agricoltura. In particolare, gli aiuti previsti dal diritto comunitario sono accordati dalle Regioni prioritariamente ai giovani agricoltori che si insediano nelle zone di montagna o svantaggiate, nonché ai giovani agricoltori che succedano al titolare dell’azienda che abbia aderito al regime di aiuti a favore del prepensionamento disposti dall’Unione Europea. Inoltre, l’Agenzia del demanio, di intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, individua i beni di proprietà dello Stato aventi destinazione agricola non utilizzabili per altri fini istituzionali, che possono essere ceduti in affitto ai giovani imprenditori agricoli sulla base degli indirizzi adottati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 6. L’Imprenditore Agricolo a Titolo Principale (IATP) e l’Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) La figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale nasce dalle Direttive (CEE) 17 aprile 1972, n. 159, 160 e 161, le quali, introducendo questa figura con specifico riferimento alle aziende destinatarie delle misure finanziarie in esse previste, assumevano a parametro di identificazione la combinazione tempo-reddito quantificata sulla base del principio di maggioranza (ossia 50 % reddito complessivo e 50% tempo di lavoro). Nel nostro ordinamento invece faceva il suo ingresso con l’art. 12 della L. 153/1975, legge di attuazione delle direttive comunitarie per la riforma dell’agricoltura, la quale considerò a titolo principale l’imprenditore agricolo che dedicava all’attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavava dall’attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro. L’art. 3 della Direttiva 159/72/CEE operava inoltre l’estensione della figura di IATP ai produttori, persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dallo stato giuridico conferito dal diritto nazionale all’associazione, ossia indipendentemente dalla forma assunta dalla società. Il legislatore italiano all’art. 12 della L. 153/1975 scelse, invece, di riferire la nozione di IATP unicamente alle persone fisiche, ponendo l’accento sulla prestazione personale dell’attività. Con l’apertura alle società avvenuta con il D.M. 12 settembre 1985 si ritenne tuttavia ammissibile l’attribuzione della professionalità alle sole società di persone e cooperative, provocando a più riprese l’intervento di censura della Corte di giustizia comunitaria. La definizione di IATP, fissata dal 1° comma dell’art. 12 della 153/1975 era la seguente: «si considera a titolo principale l’imprenditore che dedichi all’attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall’attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale di lavoro risultante dalla propria posizione fiscale». Importante per la fruizione delle provvidenze previste dalla normativa comunitaria era il possesso della capacità professionale, previsto sempre dalla L. 153/1975, che veniva presunto quando l’imprenditore avesse conseguito una laurea in scienze agrarie, naturali o veterinarie oppure un diploma di maturità tecnica o professionale nel settore agrario o di altra scuola con titolo equipollente, oppure quando avesse esercitato per tre anni l’attività agricola come capo azienda o come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo. Era rimasto, tuttavia, aperto il problema di dare una generale definizione normativa delle persone diverse da quelle fisiche, problema che si è provveduto a risolvere soltanto con l’art. 10 del D.Lgs. 228/2001; tale provvedimento, infatti, modificando l’art. 12 della L. 153/1975, ha completato (a distanza di quasi trenta anni dal provvedimento comunitario), l’adeguamento della legge italiana all’ordinamento comunitario, estendendo tout court la qualifica di IATP non solo alle società di persone, ma anche alle società di capitali. Il D.Lgs. 99/2004 (poi modificato dal D.Lgs. 101/2005) ha abrogato l’art. 12 L. 153/1975, ha soppresso la denominazione di imprenditore agricolo a titolo principale e l’ha sostituita con quella di imprenditore agricolo professionale (IAP). È però un mutamento soltanto formale dettato dalla necessità di adeguarsi alla normativa europea che non nomina più la figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale. L’attributo «professionale» dimostra che l’agricoltore costituisce una figura di imprenditore a sé stante poiché se l’imprenditore agricolo dovesse possedere tutti i requisiti previsti dall’art. 2082, la qualifica «professionale» costituirebbe un’inutile ripetizione visto che ai sensi dell’art. 2082 è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi; piuttosto l’imprenditore agricolo in generale è quello descritto dall’art. 2135 che di fatto coincide con il produttore di prodotti agricoli. Come detto, le differenze tra le nozioni di IATP e di IAP non sono sostanziali se non per l’aspetto quantitativo; ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 99/2004, come modificato dal D.Lgs. 101/2005, infatti, è imprenditore agricolo professionale colui che, in possesso di conoscenze e competenze professionali dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società di persone o cooperative o di amministratore di società di capitali, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Si richiede dunque che l’imprenditore agricolo, per poter essere qualificato professionale, si dedichi principalmente allo svolgimento delle attività agricole dalle quali è essenziale che faccia derivare la parte maggiore del proprio reddito senza con ciò escludere che lo stesso imprenditore possa realizzare anche redditi di diversa specie, seppure in misura ridotta rispetto all’attività principale esercitata. La figura dell’imprenditore agricolo professionale di cui al D.Lgs. 99/2004 ha subito alcune modifiche e precisazioni. Il D.Lgs. 101/2005, infatti, ha riconosciuto la qualifica di IAP ai soci delle società di persone e delle cooperative in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, di tempo-lavoro e di reddito; ed ugualmente, in presenza degli stessi requisiti, ha riconosciuto tale qualifica agli amministratori di società di capitali. Quindi, gli imprenditori agricoli individuali, i soci di società agricole di persone, i soci di cooperative agricole, gli amministratori di società agricole di capitali sono tutti IAP quando in essi sono presenti i requisiti della capacità professionale, del tempo-lavoro agricolo di almeno il 50% del rispettivo tempo di lavoro complessivo, nonché del reddito agricolo almeno nella misura del 50% del rispettivo reddito globale da lavoro. L’impresa agricola può essere esercitata in forma societaria? Il D.Lgs. 99/2004 si occupa, inoltre, delle società, prevedendo che le società di persone, cooperative e di capitali sono considerate imprenditori agricoli professionali a condizione che: nelle società di persone (società semplice e in nome collettivo) almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita occorre far riferimento ai soci accomandatari; nelle società di capitali e nelle società cooperative un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (nelle società cooperative l’amministratore deve essere anche socio). Tali società sono definite società agricole e devono contenere tale indicazione nella ragione o denominazione sociale. Inoltre, in forza delle integrazioni compiute dal D.Lgs. 101/2005, la qualifica di Iap è riconosciuta anche a: a. soci di società di persone e cooperative, incluse le cooperative di lavoro, che svolgono la loro attività nella società, e che siano in possesso dei seguenti requisiti: competenze e conoscenze professionali in agricoltura; dedichino a tale attività almeno il 50% del proprio tempo di lavoro; ricavino da tale attività almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro; b. amministratori di società di capitali, che svolgano la loro attività nella società in presenza dei requisiti di cui al punto precedente. Le società che intendono assumere la veste di «società agricole» devono necessariamente indicare tale termine nella propria denominazione o ragione sociale. Anche per le società agricole, pertanto, è disposto il passaggio dalla qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale (Iatp), espressamente prevista, nel rispetto dei requisiti sopra descritti, a quella di imprenditore agricolo a titolo professionale (Iap), qualora sussistano le condizioni prescritte dal decreto legislativo in commento. In tal modo sembra ormai acquisita la consapevolezza che i modelli di società tassativamente previsti dal codice civile siano ampiamente idonei a venire incontro alle peculiarità del settore primario, favorendo l’afflusso di capitali in agricoltura. 7. L’impresa familiare L’impresa familiare è stata introdotta nel nostro ordinamento, all’art. 230bis c.c., dalla L. 151/1975 di riforma del diritto di famiglia. Il fine perseguito dal legislatore si sostanzia, essenzialmente, nella tutela del lavoro familiare (in particolare, di quello della donna), attraverso il superamento della presunzione di gratuità dalla quale il lavoro domestico è stato normalmente assistito. Dottrina Secondo una teoria minoritaria (BUSNELLI) l’impresa spetterebbe in contitolarità a tutti i familiari che prestano lavoro nella famiglia o nell’impresa stessa, con la conseguenza che a tutti (non solo al capofamiglia) spetterebbe la qualifica di imprenditori. Tale interpretazione si fonda su una auspicata maggiore aderenza alla nuova concezione costituzionale della famiglia, basata sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, nonché improntata a principi di unità e solidarietà (art. 29 Cost.). Di conseguenza, i familiari acquisterebbero un diritto reale sugli utili e sugli incrementi dell’azienda e sarebbero parimenti responsabili delle obbligazioni contratte con i terzi. Si ritiene che, non disciplinando la legge espressamente i temi della rappresentanza e della responsabilità, debba applicarsi analogicamente la normativa societaria (artt. 2257 ss. c.c.), configurandosi l’impresa familiare come collettiva. La dottrina dominante sostiene la teoria dell’impresa individuale, configurando il capofamiglia come unico imprenditore e titolare esclusivo dell’impresa. Anche la giurisprudenza prevalente accoglie la natura individuale dell’impresa familiare per due ragioni. Innanzitutto, è un elemento indicativo il fatto che l’istituto in esame è stato collocato nel Libro del codice civile dedicato alle persone e alla famiglia, anziché in quello del lavoro e delle società. Inoltre, la configurabilità dell’impresa familiare come impresa individuale ha come conseguenza che è imprenditore il solo familiare titolare dell’impresa, escludendo ogni forma di partecipazione alla gestione ordinaria della stessa da parte dei familiari, il che avviene, invece, nell’azienda coniugale. L’impresa familiare rappresenta, comunque, un istituto residuale, che opera cioè solo quando l’attività svolta non può configurarsi come altro tipo di rapporto, ad esempio una società, un rapporto di lavoro subordinato o un’associazione in partecipazione. In caso contrario, tuttavia, la disciplina relativa (art. 230bis c.c.) diviene inderogabile: non è possibile, vale a dire, derogare a quella minima tutela giuridica che il legislatore ha inteso assicurare al lavoro familiare nell’impresa (CAMPOBASSO). Tratti caratterizzanti dell’impresa familiare sono costituiti dal diritto al mantenimento, alla partecipazione agli utili, alla liquidazione spettante ad ogni familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado); dalla retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato; dalla equiparazione del lavoro della donna a quello dell’uomo; dall’adozione del criterio della maggioranza per le decisioni più importanti relative alla gestione dell’impresa; dalla prelazione sull’azienda in caso di divisione ereditaria e di vendita del fondo. A) L’impresa familiare coltivatrice Questo istituto è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 48 della L. 203/1982 e rappresenta ciò che le consuetudini chiamavano comunione tacita familiare. Dall’analisi della normativa si evince che l’art. 48 «regola i rapporti tra concedente e impresa familiare coltivatrice» nella mezzadrìa, nella colonìa parziaria, nell’affitto e in ogni altro tipo di rapporto agrario. Restano esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina sia l’impresa familiare coltivatrice su fondo proprio, sia l’impresa familiare che non provveda alla coltivazione diretta del fondo (collegando il 1° comma con il 2° e 4° comma). Anche se l’art. 48 della L. 203/1982 considera l’organismo familiare in relazione al contratto agrario, la dottrina agraristica ritiene che il collegamento dell’art. 48 con l’art. 230bis c.c. permette di considerare l’impresa familiare coltivatrice anche al di fuori dei rapporti contrattuali e, dunque, con una rilevanza esterna. Dottrina Si deve sottolineare che la dottrina, per individuare la nozione di famiglia su cui si fonda l’istituto dell’impresa familiare coltivatrice, si è divisa in due orientamenti contrapposti: da una parte, si ritiene di poter ricavare tale nozione dalle consuetudini relative alle comunioni tacite familiari; dall’altra parte, considerando l’accentuata tutela per il «familiare» e non per gli estranei, ricavabile dall’art. 48 della L. 203/1982, si sostiene che il modello di famiglia coltivatrice cui si richiama tale norma sia quello delineato dall’art. 230bis che disciplina il lavoro familiare nell’impresa e cioè quella costituita dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo. Nell’articolo 48 l’impresa familiare coltivatrice viene identificata con l’intera famiglia che presta la sua opera nel fondo ai fini della titolarità del rapporto agrario, quindi come soggetto collettivo di diritto. La Suprema Corte afferma che la famiglia coltivatrice integra un organismo collettivo finalizzato all’esercizio in comune di un’impresa agricola (Cass., 22-6-2001, n. 8598), la cui regolazione interna è data dall’art. 230bis c.c., mentre l’aspetto esterno della responsabilità è dato dall’art. 48 L. 203/1982. Il concedente può chiedere che nei rapporti intercorrenti con la famiglia coltivatrice questa venga rappresentata da uno solo dei suoi componenti (art. 48, 1° comma). Nel caso in cui non venga richiesta la nomina del rappresentante, ogni componente della impresa familiare coltivatrice potrà agire nei confronti del concedente potendosi applicare nella fattispecie, l’amministrazione disgiunta prevista dall’art. 2257 del c.c. per le società semplici. Importante è anche porre in risalto quanto previsto dal 3° comma del già citato art. 48 in merito alle responsabilità dei componenti della famiglia coltivatrice. Questi sono responsabili con i beni comuni per le obbligazioni assunte nello svolgimento del rapporto agrario. Inoltre, i creditori possono rivalersi sul patrimonio personale di tutti i componenti della famiglia che hanno agito in nome e per conto della stessa e, «salvo patto contrario», sul patrimonio degli altri. Se tutti rispondono delle obbligazioni sociali, secondo la regola propria della società semplice, ciò avviene perché tutti decidono e gestiscono. La gestione della società, sempre applicando in via analogica le norme della società semplice, avviene in modo disgiunto, spettando a ciascun familiare anche la rappresentanza dell’impresa familiare. Ogni familiare dirige, partecipa alle decisioni di straordinaria amministrazione e, qualora un familiare non tenga conto delle delibere prese a maggioranza ma prevarichi agendo in contrasto con esse, l’atto da cui posto in essere non vincolerebbe la famiglia (GERMANÒ). Il rapporto agrario continua anche se rimane un solo familiare, purché sia in grado di soddisfare almeno un terzo del fabbisogno lavorativo normale del fondo (in pratica sia coltivatore diretto). Il rapporto può essere ceduto, anche senza il consenso del concedente, dal concessionario ad altri componenti la propria famiglia, quando non sussista impresa familiare, purché i concessionari: continuino la diretta conduzione o coltivazione del fondo; siano imprenditori agricoli a titolo principale da almeno tre anni. B) La comunione tacita familiare Questo istituto costituisce il retaggio di antiche tradizioni consuetudinarie, come testimonia il fatto che l’art. 2140 c.c., che lo disciplinava, è stato abrogato dalla L. 151/1975, che ha cercato, tuttavia, di mantenere una limitata operatività nell’ultimo comma dell’art. 230bis c.c., ai sensi del quale «Le comunioni tacite familiari nell’esercizio dell’agricoltura sono regolamentate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme». La comunione tacita familiare designa un aggregato di soggetti, accomunati dalla conduzione a carattere familiare di un’impresa agricola (su terra propria o altrui). Il nucleo che la costituisce è essenzialmente aperto, dal momento che ne fanno parte familiari appartenenti a stirpi diverse (quella di provenienza e quelle derivate dai figli della coppia originaria) ed affini, affiliati, adottati, estranei allevati e cresciuti nella stessa famiglia, collaboratori che sostituiscono familiari non più abili al lavoro. Caratteristica essenziale è la comunione di mensa e di tetto, che presuppone l’esistenza di un podere attrezzato (casa colonica e accessori), in modo tale da consentire la convivenza dei componenti la comunione. I beni di quest’ultima danno vita al patrimonio familiare, che si distingue in vecchio (beni conferiti per l’uso comune che, in caso di scioglimento della comunione, vengono attribuiti secondo le regole della divisione e della successione); nuovo (utili non distribuiti, che garantiscono per le obbligazioni contratte per l’esercizio dell’impresa e che in caso di scioglimento della comunione vengono attribuiti secondo quote proporzionate all’apporto lavorativo di ogni componente); frutti di annata (quella parte di raccolto destinata al consumo o attribuita alla fine dell’annata agraria). Circa i criteri di distribuzione, gli incrementi patrimoniali vengono ripartiti in proporzione al lavoro prestato (per braccia), mentre i frutti destinati al consumo, in relazione alla necessità dei componenti (per bocche). Sovrano assoluto dell’istituzione in parola è il capofamiglia, che svolge la sua opera libero da ogni controllo e senza obbligo di rendiconto affiancato dalla massaia che aveva in attribuzione il governo della casa. Il capofamiglia poteva essere destituito dai suoi familiari solo in casi gravi. Differenze con l’impresa familiare La comunione tacita familiare si distingue dall’impresa familiare per le categorie dei componenti (familiari estesi ed estranei); per il tipo di organizzazione (comunione di tetto e di mensa). Inoltre l’impresa familiare, a differenza della comunione tacita, può essere anche capitalista, ossia sorgere tra imprenditori non coltivatori. Quanto appena esposto mette in luce come la comunione tacita familiare sia oramai un istituto obsoleto, contrastante con la recente evoluzione nell’ambito della famiglia. Tuttavia, il legislatore le ha riservato un margine di vitalità, per quanto limitato all’istituto in esame, consentendone l’operatività nei limiti in cui gli usi che lo regolano non contrastino con i principi dell’impresa familiare. In altre parole, ove gli usi non arrechino pregiudizio ai diritti dei partecipanti all’impresa familiare, potrà ammettersi una comunione tacita familiare. 8. Le società agricole Ogni tipo di società (di persone o di capitali) può essere imprenditore agricolo. Tuttavia, questo strumento è poco utilizzato in Italia a causa di alcuni svantaggi stabiliti per le società agricole; a causa del sottodimensionamento delle imprese agricole e a causa dell’insussistenza di agevolazioni sotto il profilo fiscale. Detto questo, forme societarie per l’esercizio dell’agricoltura di gruppo sono: le società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata) e le società cooperative. La società semplice è la forma giuridica prevista per l’esercizio di attività non commerciali, per cui, data anche la sua duttilità, è considerata la forma tipica di società cui possano ricorrere gli agricoltori (GERMANÒ). Ciò non esclude, però, che per l’esercizio collettivo dell’agricoltura si ricorra anche alle forme della società a responsabilità limitata e per azioni le quali, pur avendo forma commerciale, sono considerate escluse dal fallimento a causa della natura agricola dell’attività da esse esercitata. Fino a poco tempo fa, la dottrina agraristica riteneva che a differenza delle società (di forma e di sostanza) commerciali, la cui causa è data dallo scopo di perseguire fini di divisione degli utili tra i soci, le società di forma commerciale e di materia agricola si costituivano per l’esercizio di una specifica attività agricola, con la conseguenza che non era possibile il passaggio da un tipo di società ad un altro, in quanto tale modifica avrebbe provocato il mutamento della stessa causa sociale, e dunque il venir meno del contratto di società. Oggi, tale tesi dottrinale appare trasfusa nell’art. 2 del D.Lgs. 99/2004, da ultimo modificato dal D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, che prende in considerazione l’esistenza di società agricole e, pur non dettando specifiche forme che potrebbero assumere, detta specifiche disposizioni dal cui rispetto conseguono una serie di effetti (GERMANÒ). Le società di persone, cooperative e di capitali sono considerate imprenditori agricoli professionali a condizione che: nelle società di persone (società semplice e in nome collettivo) almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita occorre far riferimento ai soci accomandatari; nelle società di capitali e nelle società cooperative un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (nelle società cooperative l’amministratore deve essere anche socio). A questo punto occorre un’importante precisazione. L’art. 2 del D.Lgs. 99/2004, prima dell’intervento del Decreto crescita bis (D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012) considerava società agricole soltanto quelle che, nei propri patti o statuti sociali, prevedevano l’esercizio «esclusivo» delle attività agricole indicate dall’art. 2135 c.c (coltivazione del fondo, allevamento di animali e attività connesse) e che avevano integrato, nella propria denominazione e ragione sociale, l’intera locuzione «società agricola». Tali condizioni, per esempio, non permettevano di affidare a pagamento e in godimento (affitto o locazione) al proprio amministratore un’unità abitativa di proprietà della società, in quanto il ricavo realizzato (affitto), sebbene irrisorio, non era contemplato nell’esercizio «esclusivo» delle attività agricole indicate dal citato art. 2135 c.c. Il Decreto crescita bis, invece, ha previsto che non si considerano «distrattive», dall’esercizio delle attività agricole: la concessione in locazione, comodato o affitto di fabbricati a uso abitativo o strumentale e dei terreni, purché i ricavi ottenuti dalla concessione in godimento siano «marginali» rispetto a quelli realizzati dalla normale attività agricola. Detta marginalità risulta rispettata quando l’ammontare dei ricavi, relativi alla concessione in godimento delle unità immobiliari e dei terreni, non supera il 10% dell’ammontare complessivo dei ricavi. Vi sono, infine, determinati soggetti che sono «considerati» imprenditori agricoli, quindi senza esserlo per loro natura: si tratta delle società di persone e delle società a responsabilità limitata che sono costituite da imprenditori agricoli e che esercitano esclusivamente attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli ceduti dai soci, cioè quelle attività che verrebbero qualificate come connesse se fossero svolte dagli stessi soggetti che svolgono la coltivazione del fondo, la selvicoltura o l’allevamento di animali. In riferimento a questa fattispecie, introdotta dalla L. 296/2006, la natura dell’oggetto è ciò che attribuisce la qualificazione «agricola» alla società, la quale non svolge alcuna attività essenzialmente agricola, ma solo operazioni sui prodotti dei soci (GERMANÒ). La circostanza che questa società rappresenti il momento di prosecuzione dello svolgimento delle imprese individuali è parsa al legislatore sufficiente ad attribuire natura agricola alla stessa società esercitante solo questa tipologia di servizi a favore dei soci. A) Le cooperative agricole È un dato incontrovertibile che l’ordinamento italiano riconosca un ruolo centrale alla cooperazione, come è attestato dalla previsione contenuta nell’art. 45 Cost., che ne valorizza la funzione sociale. L’aspetto rilevante della cooperativa è la diversa «logica» che sta alla base della spartizione dei vantaggi cooperativi, rispetto a quella che sta alla base delle altre società. Se, infatti, in queste ultime si ha remunerazione del capitale conferito, nella cooperativa si ha valorizzazione del lavoro apportato dal socio, nel senso che i soci cooperatori ricavano vantaggi proporzionalmente alla loro partecipazione all’attività sociale, e non proporzionalmente al capitale versato (GERMANÒ). Ogni socio, quale che sia il capitale conferito, ha un voto; la cooperativa si costituisce tra soggetti che svolgono la stessa professione o mestiere; la gestione dei servizi della cooperativa è fatta dai soci e per gli stessi soci, senza intermediazione, sono tutti elementi che spiegano sia la mancanza (o riduzione) della divisione degli utili, sia il fatto che il godimento, da parte dei soci, dei vantaggi mutualistici, avviene attraverso l’effettiva utilizzazione dei servizi offerti dalla cooperativa. In sostanza, nelle società cooperative, i soci e i destinatari dell’attività sociale sono le stesse persone; pertanto, mediante l’eliminazione di qualsiasi figura di intermediario, il costo dei prodotti e dei servizi risulta ridotto ed è possibile, altresì, aumentare la retribuzione per le prestazioni lavorative offerte. Espressione di questa tendenza si possono considerare, in materia agricola, i rilevanti interventi legislativi, grazie ai quali le cooperative agricole possono fruire di benefici e agevolazioni fiscali. Gli stessi agricoltori prediligono la forma delle cooperative per lo svolgimento dell’impresa agricola in forma associata, soprattutto in considerazione del fatto che tali società permettono loro di svolgere attività particolari che sarebbero, ove esercitate in forma individuale, troppo onerose. Senza procedere alla disamina dell’organizzazione delle cooperative in generale, che richiede una sede più consona quale la manualistica commerciale, ci limitiamo a ricordare che le società cooperative sono predisposte per l’esercizio collettivo a scopo mutualistico di imprese commerciali e non. La partecipazione alle stesse, pertanto, si determina essenzialmente in relazione alla identità dei bisogni sentiti dai soci ed alla possibilità di una soddisfazione di essi attraverso lo svolgimento dell’attività sociale. Anche se il legislatore non dà una definizione di scopo mutualistico e non esiste una nozione univoca in dottrina, è importante sottolineare la contrapposizione del fine mutualistico a quello di lucro tipico delle società commerciali. Ciò che caratterizza l’impresa cooperativa è l’intento di fornire beni, servizi ed occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato. Relativamente alla disciplina va ricordato che in seguito alla riforma societaria ad opera del D.Lgs. 17-1-2003, n. 6 è possibile distinguere tra cooperative a mutualità prevalente che svolgono la loro attività soprattutto in favore dei soci e in cooperative, che pur avendo scopo mutualistico, operano soprattutto in rapporto con i terzi. La riforma, inoltre, ha introdotto un unico regime di responsabilità prevedendo che per le obbligazioni sociali è esclusivamente responsabile la società con il suo patrimonio. Possiamo distinguere tra diverse forme di cooperative agricole: quelle di conduzione, caratterizzate dal conferimento, da parte dei soci, di fondi rustici, di prestazioni lavorative o di entrambi; quelle di servizi agricoli, finalizzate ad agevolare gli imprenditori agricoli associati, consentendo loro di offrire servizi come l’aratura, la semina, le disinfestazioni, la raccolta etc.; quelle d’acquisto, caratterizzate dalle attività di acquisto dei beni necessari alla produzione agricola quali sementi, diserbanti, insetticidi, mangimi, concimi etc. quelle di conservazione, trasformazione e alienazione finalizzate alle attività di conservazione (es. essiccazione), trasformazione e vendita. Connotato distintivo è dato dal fatto che, in tal modo, viene eliminata la figura dell’intermediario nel processo produttivo, con conseguente beneficio per i soci ai quali va il relativo margine di utili. Le cooperative di trasformazione e vendita di prodotti agricoli Affinché vi siano società cooperative agricole è necessario che la forma societaria risponda sia alle disposizioni sulla cooperativa, sia a quelle sull’impresa agricola. Con riguardo all’agricoltura, le cooperative di lavoro sono sia quelle di conduzione di terreni, sia quelle di allevamento (es. stalle sociali) ed esse sono di per se stesse imprenditori agricoli dato che i soci esercitano in comunione la coltivazione del fondo e allevano in comune gli animali. Inoltre, la cooperativa agricola è IAP se almeno un amministratore, che sia anche socio, è IAP. Problemi più rilevanti sono sorti, invece, dalle cooperative di trasformazione e vendita di prodotti agricoli per due ordini di motivi: a) innanzitutto di discuteva se, nelle fattispecie dei servizi svolti su prodotti dei soci agricoltori o a favore dei soci agricoltori, si fosse in presenza di attività agricola per connessione o di attività commerciale; b) inoltre, si poneva un’ulteriore questione per il fatto che la disciplina delle cooperative a mutualità prevalente richiede che esse svolgano la loro attività prevalentemente in favore dei soci quali consumatori o utenti, o che si avvalgano prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci. Il D.Lgs. 228/2001 ha fornito un’interpretazione autentica, stabilendo che si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2135 c.c., prevalentemente prodotti dei soci. Per cui, la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti dei soci da parte delle cooperative costituite da agricoltori non intaccano il rapporto di connessione e attribuiscono alla stessa cooperativa la qualificazione di imprenditorie agricolo, per quella sorta di traslazione della qualità agricola dai soci alla società e che consente di considerare tali cooperative imprenditori agricoli. Tale decreto riconosce, inoltre, la qualifica di imprenditori agricoli anche alle cooperative che forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico. B) I Consorzi Senza soffermarci sulla figura e la disciplina dei consorzi ricordiamo che il consorzio è il contratto con cui più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Il fine individuale dei singoli consorziati è sempre un fine economico e si identifica nell’utilità economica che il singolo si propone di raggiungere associandosi con gli altri. In agricoltura, i consorzi sono tra le forme associative più antiche, nati per svolgere compiti di interesse comune come la bonifica o l’irrigazione. Simili alle cooperative se ne differenziano perché mentre le cooperative possono avere anche soci non imprenditori, i consorzi sono costituiti solo da imprenditori o da cooperative. Negli anni si sono succedute diverse modifiche di disciplina, che hanno riconosciuto ai consorzi agrari la natura di cooperativa a mutualità prevalente, indipendentemente dai criteri stabiliti dall’art. 2513 c.c. (che, appunto, specifica i criteri per la definizione della prevalenza), ma purché rispettino i requisiti di cui all’art. 2514 c.c. (che evidenzia i requisiti che le cooperative a mutualità prevalente devono avere nei propri statuti). 9. Le organizzazioni dei produttori Le organizzazioni di produttori hanno come scopo principale la commercializzazione della produzione dei produttori aderenti e trovano la loro disciplina negli artt. 2 e ss. del D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102 che hanno sostituito gli artt. 26-29 del D.Lgs. 228/2001. Le organizzazioni di produttori hanno sostituito le precedenti associazioni di produttori (agricoli e ortofrutticoli) da cui si distinguono per la tipologia associativa. Mentre le associazioni di produttori erano associazioni riconosciute, il D.Lgs. 102/2005 stabilisce che le organizzazioni di produttori debbano assumere la forma di società di capitali, società cooperative agricole, o loro consorzi, consorzi con attività esterna dotati di autonomia patrimoniale, società consortili costituite ex art. 2615ter c.c.; le organizzazioni dei produttori devono, infatti, avere personalità giuridica ed autonomia patrimoniale perfetta. Le società di capitali, in particolare, devono avere per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli e i loro soci devono essere imprenditori agricoli o società consortili costituite da imprenditori agricoli. Le cooperative devono, invece, essere agricole ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 102/2005; i consorzi e le società consortili devono essere costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie. Il riconoscimento avviene ad opera delle Regioni, alle quali sono demandati i compiti di controllo e vigilanza circa il rispetto dei requisiti imposti dalla legge. Spetterà invece al Ministero delle politiche agricole e forestali (ora Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali) il riconoscimento, il controllo e la vigilanza sulle forme associate di organizzazioni di produttori agricoli. I requisiti essenziali per il riconoscimento sono, empiricamente, suddivisi dalla dottrina in tre categorie (art. 3, D.Lgs. 102/2005): obblighi gravanti sui soci. Essi sono finalizzati ad assicurare la concentrazione dell’offerta in capo alle organizzazioni di produttori: i loro statuti devono prevedere per i soci l’obbligo di seguire, per la produzione, la commercializzazione e la tutela ambientale, le regole indicate dall’organizzazione. Inoltre i soci devono aderire ad una sola associazione; devono far vendere almeno il 75% della loro produzione direttamente dall’organizzazione; devono mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e in caso di recesso preavvisare entro il termine di almeno sei mesi dall’inizio della campagna di commercializzazione; adempimenti di carattere organizzativo. Deve essere garantito ai soci il controllo democratico dell’organizzazione; devono prevedersi sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari; devono prevedersi regole di natura contabile e di bilancio; requisiti dimensionali. Ai fini del riconoscimento, l’organizzazione deve avere un numero minimo di produttori aderenti e un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali (ora Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni; ma le Regioni possono incidervi imponendo limiti più restrittivi. L’art. 2 del D.Lgs. 102/2005 individua i programmi di attività che devono essere propri delle organizzazioni dei produttori e le relative fonti di finanziamento rappresentate per lo più da contribuzioni dei soci e aiuti pubblici. Le organizzazioni di produttori in particolare devono: assicurare la programmazione della produzione e l’adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; concentrare l’offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati; partecipare alla gestione delle crisi di mercato; ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione; promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell’ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l’igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità, nonché favorire processi di rintracciabilità, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi comunitari; assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti; realizzare iniziative relative alla logistica; adottare tecnologie innovative; favorire l’accesso a nuovi mercati, anche attraverso l’apertura di sedi o uffici commerciali. Per la realizzazione di tali scopi le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti da parte dello Stato dalla legislazione vigente. 10. Le organizzazioni interprofessionali Le organizzazioni interprofessionali possono svolgere un ruolo importante facilitando il dialogo fra i diversi soggetti della filiera promuovendo le migliori prassi e la trasparenza del mercato. Così il considerando 132 del Regolamento (UE) N. 1308/2013 (del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio) introduce la disciplina europea delle organizzazioni interprofessionali meglio definita negli articoli 157 e ss.. In Italia, la disciplina è stata recepita con l’articolo 3 recante «Disposizioni urgenti per favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore lattiero caseario e per l’attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in materia di organizzazioni interprofessionali nel settore agricolo», del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito nella legge del 2 luglio 2015, n. 91, che ha, peraltro, abrogato l’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. Le organizzazioni interprofessionali sono associazioni costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle seguenti fasi della catena di approvvigionamento: trasformazione o commercio/distribuzione, di prodotti di uno o più settori agricoli. Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni interprofessionali che: sono costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che le compongono; operano in una o più regioni del territorio di cui trattasi; costituiscono una quota significativa delle attività economiche connesse; non sono attive nella produzione, trasformazione o nel commercio, salvo i settori dell’olio e del tabacco. Le O.I. perseguono una finalità specifica, tenendo conto degli interessi dei loro aderenti e dei consumatori, che può includere segnatamente uno dei seguenti obiettivi: redigere contratti tipo per la vendita di prodotti agricoli o di prodotti trasformati, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato; valorizzare il potenziale dei prodotti, sviluppare iniziative per rafforzare la competitività economica e l’innovazione; svolgere ricerche per innovare, razionalizzare, migliorare e orientare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e dei consumatori, es. peculiarità dei prodotti a Dop e Igp, protezione dell’ambiente; ricercare metodi atti a gestire meglio i fattori di produzione, a garantire la qualità dei prodotti, la salvaguardia del suolo, delle acque, a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti, la salute e il benessere degli animali; mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della commercializzazione; realizzare azioni atte a difendere, proteggere e promuovere l’agricoltura biologica e le produzioni di qualità regolamentata; promuovere ed eseguire la ricerca sulla produzione integrata e sostenibile o su altri metodi di produzione rispettosi dell’ambiente; incoraggiare il consumo sano e responsabile dei prodotti sul mercato interno e/o informare dei danni provocati da abitudini di consumo pericolose; promuoverne il consumo e/o fornire informazioni sui prodotti sul mercato interno ed esterno; contribuire alla gestione dei sottoprodotti e alla riduzione e gestione dei rifiuti. I criteri e le modalità di riconoscimento ed i controlli sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il riconoscimento può essere concesso, su richiesta, ai sensi della vigente normativa europea, ad una sola organizzazione interprofessionale operante nel rispettivo settore economico ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del medesimo settore, a livello nazionale ovvero in ciascuna circoscrizione economica. Nel caso di concorso tra più domande di riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali relative al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento è concesso all’organizzazione maggiormente rappresentativa. Gli accordi conclusi all’interno dell’organizzazione interprofessionale non possono comportare una restrizione della concorrenza a meno che ciò non sia finalizzato ad un miglioramento della qualità o all’individuazione di nuovi sbocchi di mercato. 11. Soggetti collettivi ed enti pubblici come imprenditori agricoli Esistono beni agricoli in proprietà collettiva i cui gestori non possono non essere considerati imprenditori agricoli (GERMANÒ). Si tratta, in particolare, delle Associazioni e Università agrarie dell’Italia meridionale, delle Comunanze, delle Partecipanze, delle Comunioni familiare montane, ecc., che hanno l’obbligo di farsi imprenditori agricoli, in quanto l’elemento caratterizzante non è solo il godimento personale e diretto del bene da parte di ogni membro dell’associazione, ma anche lo sfruttamento collettivo dei boschi, dei pascoli e dei campi, con immissione dei frutti sul mercato e ripartizione delle utilità tra i comproprietari. Anche gli enti pubblici possono essere imprenditori agricoli. Vi sono, infatti, enti pubblici imprenditori commerciali (enti pubblici economici), che svolgono attività commerciale in via esclusiva o principale e come tali sono soggetti alla registrazione, alle norme del Libro V del codice civile sugli imprenditori, ma non al fallimento, ed enti pubblici che svolgono attività economica in via non esclusiva, quindi in via secondaria, i quali non sono soggetti a registrazione, né al fallimento, né alle norme del Libro V del codice civile relative ai soggetti, ma solo a quelle relative alle attività. È possibile che l’ente pubblico che svolge un’attività economica in modo non principale, eserciti un’attività imprenditoriale agricola, quindi che sia imprenditore agricolo. Ciò trova conferma nell’art. 4quinquies del D.L. 78/2009, conv. in L. 102/2009, che dispone che i beni liberi di proprietà dello Stato aventi destinazione agricola non utilizzabili per altri fini istituzionali possono essere ceduti in affitto a giovani imprenditori agricoli. 12. L’iscrizione nel registro delle imprese L’art. 2 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma della l. 5 marzo 2001, n. 57) stabilisce che: « L’iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del Registro delle Imprese di cui all’art. 2188 e seguenti del c.c., oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha efficacia di cui all’art. 2193 del codice civile». Dall’iscrizione dell’imprenditore agricolo nel Registro delle Imprese scaturisce una serie di effetti tra cui si ricordano: la pubblicità legale e dichiarativa, avente funzione di valorizzare l’azienda e renderla più visibile e competitiva sul mercato; la possibilità di conoscere o dimostrare la qualifica di coltivatore diretto in presenza di esercizio del diritto di prelazione; il riconoscimento, ex art. 4, D.Lgs. 228/2001, della possibilità di esercitare su tutto il territorio nazionale la vendita diretta, al dettaglio, dei prodotti «provenienti in misura prevalente» dall’azienda agricola. Nella sezione speciale degli imprenditori agricoli possono essere iscritte, oltre agli imprenditori individuali ed alle società semplici, anche le società di persone o di capitali, a condizione che: lo statuto contempli espresse prescrizioni (art. 1, c. 1, D.Lgs. 228/2001); i soci delle cooperative siano imprenditori agricoli; l’attività agricola sia svolta in modo prevalente; l’esercizio delle attività connesse sia svolto con uso prevalente dei prodotti della propria azienda agricola; l’esercizio delle attività connesse sia svolto con uso prevalente di attrezzature e risorse della propria azienda agricola principale. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti al Registro delle Imprese, possono vendere al dettaglio in tutto il territorio nazionale, prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende. La vendita diretta sul fondo di prodotti provenienti esclusivamente da propria produzione non è soggetta a comunicazione al proprio Comune. Sono soggette a comunicazione al Comune di competenza le vendite di prodotti provenienti in modo prevalente da propria produzione, in locali aperti al pubblico, su aree pubbliche, in forma itinerante o in forma elettronica, specificando i prodotti che s’intendono vendere. Gli adempimenti presso il registro delle imprese per la modifica della denominazione o ragione sociale L’art. 2 del D.Lgs. 99/2004, successivamente modificato dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 101/2005, stabilisce che le società agricole, che hanno quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., hanno l’obbligo di riportare nella ragione sociale o nella denominazione sociale l’indicazione «Società agricola». Bisogna subito precisare che si tratta di un obbligo. Il tenore della norma non lascia dubbi: «la ragione sociale … deve contenere ….»; «le società …. devono inserire nella ragione sociale …». L’obbligo dell’indicazione della locuzione «Società agricola» ricade infine anche sulle società che già contengono il riferimento all’attività agricola (quali, ad esempio, «Agricola del Serrano SRL» o simili). Al fine di agevolare tale adempimento, il legislatore ha previsto l’esenzione dal pagamento di qualsiasi tributo e diritto per tutti gli adempimenti eventualmente dovuti per tale aggiornamento. 13. L’assetto del registro delle imprese L’assetto del Registro delle Imprese, fino al 6 dicembre 2000 (data di entrata in vigore del d.P.R. 558/1999), secondo quanto previsto dall’art. 8 della L. 580/1993, prevedeva una sezione ordinaria e quattro sezioni speciali. Successivamente, le quattro sezioni speciali sono state accorpate in un’unica sezione: gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori e coltivatori diretti e le società semplici sono iscritte in un’unica sezione speciale del Registro. Nella medesima sezione vengono anche «annotati» gli imprenditori artigiani iscritti nei rispettivi Albi provinciali (persone fisiche, società e consorzi). Il D.Lgs. 96/2001 ha previsto l’iscrizione in una sezione speciale del Registro delle Imprese delle società tra avvocati. Pertanto, a decorrere dal 6 dicembre 2000, il Registro delle Imprese è costituito da due sole sezioni: una «ordinaria o generale», dove continuano ad iscriversi i medi e grandi imprenditori commerciali, sia individuali sia società; una «speciale», dove vanno iscritti i piccoli imprenditori e coltivatori diretti, gli imprenditori agricoli, le società semplici e gli artigiani iscritti al relativo albo, soggetti precedentemente esonerati da tale adempimento. L’iscrizione per questi soggetti, però, ha solo funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia (l’iscrizione consente solo di prendere conoscenza dell’atto o del fatto trascritto, ma non lo rende di per sé opponibile ai terzi, dovendosi a tal fine sempre provare l’effettiva conoscenza). Fanno eccezioni solo gli imprenditori agricoli, per i quali il D.Lgs. 228/2001 ha previsto l’efficacia di opponibilità ai terzi (efficacia dichiarativa). Si è trattato, indubbiamente, di una semplificazione di notevole importanza da cui deriva, anzitutto, una maggiore chiarezza in materia di pubblicità legale e non può che facilitare il compito di tutti quegli utenti che si trovano nella condizione di denunciare contemporaneamente l’esercizio di più attività economiche. Questionario 1. Chi sono gli ausiliari dell’imprenditore agricolo? (par. 2) 2. Quali sono i requisiti per assumere la qualifica di coltivatore diretto? (par. 3) 3. 4. Quali soggetti sono equiparati al coltivatore diretto ai fini dell’affitto? (par. 3) Quali soggetti sono considerati imprenditori agricoli e quali, invece, sono ad essi equiparati? (par. 4) 5. Chi è l’imprenditore agricolo a titolo principale? (par. 6) 6. Quali sono le differenze tra l’imprenditore agricolo a titolo principale e l’imprenditore agricolo professionale? (par. 6) 7. Qual è la natura della impresa familiare? (par. 7) 8. Cosa si intende per comunione tacita familiare? (par. 7) 9. Per quali motivi la cooperativa ha un ruolo determinante in ambito agricolo? (par. 8) 10. Quale disciplina è prevista per le società agricole? (par. 8) 11. Quali sono gli scopi delle organizzazioni interprofessionali e delle organizzazioni di produttori? (par. 9) e (par. 10) 12. Quali sono gli effetti dell’iscrizione dell’imprenditore agricolo nel registro delle imprese? (par. 12) Capitolo 6 I contratti agrari Sommario 1. Nozione ed evoluzione storica. - 2. Elementi strutturali. 3. I contratti costitutivi dell’impresa: caratteristiche. - 4. Il contratto di affitto di fondi rustici. - 5. I soggetti. - 6. I poteri derivanti dal contratto di affitto. - 7. La durata e la risoluzione del contratto agrario. - 8. Il subaffitto. - 9. I contratti di utilizzazione dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili. - 10. I contratti per colture stagionali. - 11. Mezzadrìa e colonìa parziaria. - 12. I contratti di anticresi e di comodato. - 13. La soccida. - 14. I contratti di organizzazione dell’impresa: caratteristiche. 15. Credito agrario. - 16. Cambiale agraria. - 17. Compravendita di fondo rustico. - 18. Contratti di integrazione verticale: i contratti agro-industriali. 1. Nozione ed evoluzione storica Attualmente la categoria dei contratti agrari ricomprende quegli strumenti convenzionali preordinati alla costituzione dell’impresa agricola (e al relativo esercizio), nonché al servizio di un’impresa preesistente già operativa. Il codice civile del 1942, infatti, ha evidenziato l’aspetto dinamico dell’attività agricola, individuando l’oggetto dei contratti agrari non più nel godimento e nello sfruttamento del fondo rustico, bensì nell’organizzazione dell’attività produttiva agricola. Si parla, infatti, di contratti dell’organizzazione stipulati dall’agricoltore per l’esercizio dell’impresa e che sono capaci di costruire, all’interno dell’organizzazione produttiva, nuova ricchezza in termini di aspettative giuridicamente rilevanti, e che sono distinti dai contratti costitutivi dell’impresa o contratti di organizzazione (ad esempio, l’affitto o la soccida). In realtà, dal 1942 ad oggi il legislatore ha stravolto l’assetto normativo posto dal codice tanto che le leggi successive (cd. speciali) si sostituiscono largamente allo stesso finendo per creare un sistema nuovo. Tali leggi sono numerosissime; tra quelle più significative si possono indicare, per i contratti associativi, la L. 756/1964 e, per l’affitto, le leggi n. 567/1962, 606/1966, 11/1971 e 814/1973. Per tutti i tipi contrattuali poi, accanto alle disposizioni che attribuiscono al concessionario coltivatore diretto il diritto di prelazione in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi del fondo (L. 590/1965 e successive modifiche ed integrazioni), si deve richiamare la L. 203/1982 che, con le modifiche ed integrazioni della L. 29/1990, è il provvedimento più incisivo e più ampio, tanto da costituire il punto di riferimento al quale deve riportarsi la disciplina dei contratti agrari inclusa la residuale disciplina dei codici. Secondo la dottrina più convincente (BOLLA e FRASSOLDATI), è possibile enucleare una serie di elementi unificatori da ciascun contratto agrario, riconducendo ad unità la categoria. Tali elementi sono relativi: ai soggetti, all’oggetto (il fondo rustico), alla causa (attività produttiva), al tempo (nel senso che tutti i contratti agrari sono di durata) e alla prevalenza dell’interesse pubblico su quello privato. Dottrina Altri autori, invece, limitano la portata degli elementi comuni: MILANI all’oggetto (il fondo) o alla natura dei fatti che influiscono sull’attività agraria (ad esempio, la durata del ciclo agrario); CARRARA all’aspetto strumentale svolto dai contratti agrari nei confronti dell’impresa agricola; SERPILERI al profilo economico dell’assemblamento dei vari fattori produttivi. L’individuazione di tali elementi unificatori può fornire un valido aiuto per un inquadramento adeguato dei singoli contratti agrari, di cui alcuni (soccida, mezzadrìa, colonìa parziaria) trovano una collocazione nel Libro quinto del codice civile (intitolato «del lavoro»), altri (l’affitto) sono disciplinati nel Libro quarto (intitolato «delle obbligazioni»), senza che sia indicato alcun richiamo o collegamento tra gli stessi. Il susseguirsi di numerose leggi speciali in materia ha evidenziato una netta evoluzione secondo alcune direttrici fondamentali: una tendenza alla limitazione dell’autonomia privata, con conseguente tipizzazione degli strumenti agrari convenzionali, inquadrati all’interno di schemi normativi ben definiti; una rimeditazione della materia alla luce dei principi costituzionali (artt. 35, 36, 41, 42, 44 Cost.) da cui sono emerse una tutela rafforzata del lavoro (in tutte le sue forme) e una prevalenza dell’interesse dell’impresa e del lavoro sull’interesse della proprietà. Attualmente si possono individuare due categorie di contratti agrari: quelli associativi e di tipo locativo, costitutivi dell’impresa agricola, e quelli di impresa, preordinati al servizio di quest’ultima. In ultima analisi, comune denominatore di tutti i contratti agrari è, sotto il profilo funzionale, l’impresa agricola che, in alcuni tipi di contratto (quelli costitutivi di impresa) è in collegamento genetico con quest’ultima (ad esempio, affitto di fondo rustico); in altri (quelli di impresa) si trova in rapporto strumentale con la stessa (ad esempio, il contratto di credito agrario). 2. Elementi strutturali Secondo la dottrina preferibile (GALLONI) elementi costitutivi dei contratti agrari valutati sotto il profilo funzionale dell’impresa agricola sono: la consensualità, intesa nel senso che il contratto nasce da un accordo delle parti volto alla costituzione, all’esercizio o al servizio dell’impresa agricola; la comunione di scopo, individuata nella costituzione, nell’esercizio o nella strumentalità nei confronti dell’impresa agricola; la durata, individuata nella corrispondenza tra lo svolgimento del ciclo produttivo dell’impresa agricola e la durata del contratto. Di contrario avviso appare CARROZZA, che non ritiene caratterizzanti i predetti elementi, essendo questi ultimi presenti anche in altri tipi contrattuali. Per l’autore, l’unico elemento distintivo è dato dalla causa. A) Consensualità Il contratto agrario si perfeziona con il semplice consenso delle parti (e non con la consegna della cosa). L’accordo delle parti è finalizzato alla costituzione e all’esercizio dell’impresa agricola, o alla prestazione a vantaggio della stessa di un determinato servizio. Tale finalità si compenetra a tal punto con la causa del contratto in esame, da determinarne la risoluzione ove mai, nonostante il consenso inizialmente manifestato, l’impresa non dovesse venire ad esistenza o il servizio non dovesse essere prestato. Inoltre, il requisito della consensualità va messo in relazione con il carattere della tipicità dei contratti agrari, nel senso che le parti non sono libere di manifestare il loro consenso su un qualunque assetto di interessi, bensì devono ripiegare su uno schema tipico disciplinato dall’ordinamento giuridico. In altre parole, le parti hanno una facoltà di scelta limitata ai tipi contrattuali desumibili dall’ordinamento giuridico, o per espresso recepimento legislativo (tipicità legale) o attraverso usi consolidati (tipicità sociale). La marcata tendenza alla tipizzazione normativa dei contratti agrari, in particolare, di quelli costitutivi d’impresa (essendo quelli di servizio ancora improntati ad una piena autonomia contrattuale) risponde all’esigenza di sottrarre la materia in esame, particolarmente complessa e delicata, alla regolamentazione privata o consuetudinaria. In altre parole, si assiste, in tema di contratti agrari, ad una sorta di riserva di legge, avente ad oggetto la predeterminazione del tipo contrattuale, con conseguente preclusione, per le parti, di effettuare liberamente siffatta scelta. Le stesse potranno, eventualmente, una volta adottato un tipo legale di contratto, integrarlo con clausole aggiuntive, purché ciò avvenga sempre nel rispetto delle norme di legge. B) Comunione di scopo Secondo la dottrina preferibile (GALLONI, BETTI), tale requisito assume una connotazione particolare nei contratti agrari: la comunione di scopo, infatti, non si esaurisce nel dovere di cooperazione e buona fede imposto alle parti nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, ma si concretizza nella realizzazione dell’interesse comune dell’impresa. In altre parole, nei contratti agrari costitutivi dell’impresa aventi una struttura di scambio (ad esempio, l’affitto di fondi rustici), lo scopo comune è dato dall’organizzazione e dall’esercizio dell’impresa. In essi si realizza un contemperamento di interessi collettivi che riflettono, cioè, la posizione di determinate categorie sociali (ad esempio, nell’affitto, il concedente e l’affittuario). Nei contratti agrari per l’impresa aventi parimenti una struttura di scambio, la comunione di scopo si incentra, ugualmente, sull’impresa che, però, nel caso di specie, preesiste. Altri autori, invece, contestano che la comunione di scopo sia un requisito caratterizzante i contratti agrari. In ultima analisi, la comunione di scopo nei contratti agrari (a differenza di quanto avviene per qualsiasi altro contratto commutativo) si caratterizza perché comporta un quid pluris rispetto ad altre fattispecie: l’obbligo a carico delle parti di porre in essere un comportamento attivo a contenuto positivo che diviene particolarmente qualificato, essendo le stesse portatrici di un interesse non solo individuale, ma anche collettivo. Da un excursus sulle varie disposizioni legislative dettate in tema di contratti agrari è possibile evincere che l’interesse comune delle parti è proprio l’interesse alla produzione e all’esercizio dell’impresa e non è circoscritto al solo spostamento patrimoniale a favore del concedente. C) Durata Il requisito in esame, comune a tutti i contratti ad esecuzione continuata o periodica, indica la circostanza che l’esecuzione della prestazione non si esaurisce in un solo istante, bensì si protrae nel tempo. Tuttavia, nei contratti agrari la durata è strettamente compenetrata con la causa, nel senso che essa coincide con la durata dell’impresa agricola, non può essere fissata liberamente dalle parti, ma deve essere pari, come minimo, ad un ciclo agrario biologico vegetale od animale. Ove la durata sia inferiore, il contratto non si potrebbe più definire agrario, venendo meno il suo collegamento con l’impresa. Oltre alla suesposta durata minima naturale esiste anche una durata minima legale, corrispondente a più annate agrarie (ossia più cicli). Ove le parti stabiliscano una durata inferiore a quella legale, il contratto resterà in vita fino al termine prefissato dalla legge. Anche sotto questo aspetto i contratti agrari divergono dalla disciplina dettata in via generale per gli altri tipi di contratti, in relazione ai quali le parti sono libere di determinare la durata. L’intendimento del legislatore nel disporre una durata legale minima è di garantire un assetto stabile all’impresa agricola. La funzione della durata legale massima prevista da alcune disposizioni codicistiche (cfr. artt. 1573 e 1629 c.c.), invece, è di tutelare il diritto di proprietà, ponendo un freno all’eventualità che il protrarsi del contratto possa trasformare in diritto reale i diritti obbligatori dell’affittuario o del colono. 3. I contratti costitutivi dell’impresa: caratteristiche Si può definire come costitutivo dell’impresa agricola quel contratto consensuale, con comunione di scopo, di durata, nel quale due o più parti conferiscono i fattori produttivi (capitale e lavoro) al fine di costituire ed esercitare un’impresa agricola. Rientrano in tale categoria sia contratti bilaterali (quelli di concessione in godimento, tra cui l’affitto) che plurilaterali (tra cui le società cooperative di conduzione agricola). Dalla suesposta definizione si evincono alcune peculiarità inerenti alla causa e all’oggetto del contratto. Quanto alla causa, la funzione dei contratti costitutivi d’impresa consiste nel predisporre la nascita della stessa e nel regolarne l’esercizio. Come vedremo in prosieguo, la funzione dei contratti d’impresa, invece, è quella di fornire alla stessa un adeguato supporto mediante la conclusione di negozi preparatori, che rimangono autonomi rispetto all’impresa stessa (la quale, abitualmente, preesiste). Relativamente all’oggetto del contratto, invece, può affermarsi che esso è costituito dal complesso dei beni o servizi conferiti dalle parti (o che le stesse si impegnano a conferire) allo scopo di agevolare la produzione. Peculiare dei contratti costitutivi d’impresa è la bilateralità, intesa nel senso che, a prescindere dal numero dei soggetti che le compongono, le parti sono sempre due: concedente e concessionario, ciascuno con tipi diversi di obbligazioni che consistono rispettivamente nella responsabilità del controllo e nella responsabilità diretta di gestione dell’impresa. La parte che conferisce il fondo non abdica totalmente alle sue prerogative in quanto svolge attività di controllo sulla gestione dell’impresa; l’altra parte, invece, acquista la qualità di imprenditore come contropartita della responsabilità di gestione. Anche i contratti agrari di concessione in godimento si caratterizzano per la struttura bilaterale, individuata nella concessione del fondo rustico ad un soggetto che assume l’impegno di gestire la relativa impresa, contribuendovi con apporto di capitale e di lavoro (es.: mezzadrìa). Nel tempo si è registrata una tendenza all’unificazione dei contratti agrari di concessione, disciplinati a grandi linee dal codice civile del 1942 (affitto di fondo rustico, affitto a coltivatore diretto, mezzadrìa, colonìa parziaria e soccida). Espressione della summenzionata tendenza sono: il divieto legislativo di stipulare nuovi contratti di mezzadrìa, colonìa parziaria, compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali e quelli di soccida (L. n. 756/1964 e L. n. 203/1982); la riconduzione a schemi tipici di tutti i contratti agrari atipici e, in particolare, la riconduzione all’affitto di tutti i contratti agrari aventi per oggetto la concessione di fondi rustici, stipulati dopo l’entrata in vigore dalla L. n. 203/1982; l’attribuzione di un certo grado di tipicità legale ad una nuova figura di contratto agrario di concessione, risultante dalla fusione di enfiteusi agraria e colonìa perpetua; la conversione legale in affitto, su richiesta del coltivatore, dei contratti di mezzadrìa, colonìa parziaria, compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali, soccida con conferimento di pascolo e alcuni tipi di soccida parziaria (L. n. 203/1982). Nell’ambito dei contratti agrari plurilaterali rientrano, invece, alcune figure diversificate che hanno acquistato una tipicità sociale: si pensi alle cooperative di conduzione agraria, oppure alle società per azioni in agricoltura (il fenomeno della cd. agricoltura di gruppo). La struttura di tali contratti è aperta e si caratterizza per la circostanza di prevedere un’effettiva parità tra tutti i contraenti. I contratti agrari di concessione in godimento hanno, invece, una struttura bilaterale chiusa e prevedono obbligazioni diversificate per i due contraenti. Tratto comune ai contratti di concessione e a quelli plurilaterali, è quello di esprimere un accordo prefigurato alla costituzione e all’esercizio di un determinato tipo di impresa agricola. La particolare configurazione di questi contratti non deve poi indurre a credere che l’impresa agricola nasca con la stipula del contratto: non c’è alcuna deroga al principio di effettività, in virtù del quale la nascita dell’impresa coincide con quello dell’inizio effettivo dell’attività economica. 4. Il contratto di affitto di fondi rustici La terra e il bosco, oltre che in proprietà, possono essere acquisiti in affitto. Tale contratto è il prototipo dei contratti costitutivi d’impresa, in particolare, dei contratti agrari di concessione in godimento: infatti, nell’affitto di fondi rustici il concedente non attribuisce all’affittuario un mero diritto di godimento sul bene, ma, piuttosto, il potere di organizzare e gestire un complesso produttivo, con la conseguenza che il titolare del fondo, alla scadenza del contratto, riacquista la pienezza della sua posizione imprenditoriale. Si può dire che oggi, venuta meno la facoltà di concludere contratti di concessione del diritto di godimento del fondo rustico diversi dall’affitto, non vi è altra possibilità qualora non si possa o non si voglia ricorrere alla compravendita. Il codice civile del 1865 non dedicava un’apposita trattazione al contratto in esame, che veniva considerato solo una variante della locazione. Nel codice civile del 1942, invece, si è operato un distinguo tra i due contratti conferendo all’affitto una sua autonomia, che è stata ulteriormente precisata dalle leggi speciali che si sono susseguite. Le leggi speciali hanno modificato e sostituito in larga parte la normativa codicistica: si pensi alle leggi 567/1962, 11/1971 e 203/1982 con sue modifiche e integrazioni, le quali hanno evidenziato come la principale funzione che il contratto di affitto si propone di realizzare sia accrescere la produttività dell’impresa. È proprio questa finalità che comporta l’esclusione dal novero dei contratti assoggettati alla L. 203/1982 di quelli in cui il terreno viene preso in considerazione in funzione puramente strumentale e cioè dei casi in cui: il terreno viene utilizzato dal conduttore per un periodo limitato dell’anno per il solo compimento di colture la cui produzione si esaurisce in tale tempo; il terreno nel restante periodo dell’anno rimane nella disponibilità del concedente. Si tratta pertanto di contratti in cui al coltivatore è concesso di sfruttare il terreno per una singola coltura stagionale laddove al concedente rimangono tutte le altre utilità che il terreno può offrire. Locazione e affitto: differenze Dall’art. 1615 c.c. si evince come il contratto di affitto, pur essendo disciplinato nell’ambito della locazione, presenta una spiccata autonomia rispetto a quest’ultima. La prima distinzione riguarda l’oggetto del godimento che, nella locazione è un bene improduttivo, mentre nell’affitto è un bene produttivo. In altre parole, introdotto nel nostro ordinamento il concetto d’impresa, può affermarsi che l’affitto legittima l’affittuario alla costituzione di un vero e proprio ordinamento produttivo, con la conseguenza che il concedente conserva il suo diritto di controllare la gestione del fondo (cfr. artt. 1618 e 1619 c.c.). La locazione, invece, si configura come un contratto di cessione di un diritto di godimento sulle cose, con conseguente divieto per il locatore di intromettersi nell’esercizio dei diritti spettanti al locatario. Dal momento che la posizione dell’affittuario va ben oltre una semplice facoltà di godimento, ricomprendendo anche il potere di sfruttare il fondo rustico, si deduce che questi ha il dovere-potere di svolgere un’attività produttiva finalizzata allo sviluppo dell’impresa. Diversamente avviene per la locazione, in cui il locatario può esercitare soltanto il diritto di godimento conferitogli dal locatore ossia un’attività materiale cui corrisponde l’obbligazione del concedente di non interferire con tale facoltà per tutta la durata del contratto. È importante ribadire, infine, che il locatore, nell’affitto, ha un interesse proprio ad intervenire nell’attività produttiva, come attesta la disciplina codicistica, che gli consente di «accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se l’affittuario osserva gli obblighi che gli incombono» (art. 1619 c.c.). Tale interesse esprime qualcosa in più del semplice diritto alla restituzione del bene integro, che sarebbe stato sufficientemente salvaguardato, invece, da una mera stima all’atto della riconsegna. A) Le leggi speciali Nel periodo dal dopoguerra ad oggi si è assistito ad un susseguirsi di numerose leggi speciali, che hanno modificato, se non addirittura sostituito, l’impianto codicistico. Il legislatore ha reagito attraverso interventi diversificati alla crisi dei contratti agrari latente nell’immediato dopoguerra, originata, soprattutto, dal conflitto mondiale e dal relativo crescendo di tensioni sociali. Fino al 1962 c’è stato un tentativo di mantenere inalterata la situazione preesistente, mentre, in epoca successiva, si è sviluppata una tendenza contraria finalizzata alla riconduzione all’affitto di tutti i contratti agrari (stiamo parlando soprattutto dei contratti associativi tradizionali, che solo inizialmente vennero reputati idonei alla composizione degli interessi legati ai fattori produttivi terra-lavoro). Punto culminante di questa evoluzione è stata la L. 3-5-1982, n. 203, in materia di controversie e contratti agrari, che ha fissato alcuni principi fondamentali: la conversione in affitto. Il fenomeno indica la sostituzione di un contratto valido (ma non più adeguato alle esigenze dell’economia) con un altro egualmente valido, l’affitto, reputato idoneo al proseguimento dell’interesse generale. La conversione, disciplinata dall’art. 25 della L. 203/1982, riguardava i contratti di mezzadrìa e di colonìa parziaria anche con clausola miglioritaria, oltre alcuni tipi di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali di sòccida con conferimento di pascolo e sòccida parziaria, quando il soccidante apportava del bestiame con una quota inferiore al 20% del valore dell’intero bestiame conferito dalle parti. La conversione avveniva su richiesta di una delle parti, che doveva comunicare la propria decisione all’altra a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della fine dell’annata agraria, entro quattro anni dall’entrata in vigore della L. 203/1982. La conversione non poteva aver luogo, ai sensi dell’art. 29 della L. 203/1982, nell’ipotesi in cui nella famiglia del mezzadro, colono, compartecipante o soccidario non vi fosse almeno un’unità che si dedicasse alla coltivazione dei campi o all’allevamento del bestiame di età inferiore ai sessanta anni e nell’ipotesi in cui il mezzadro, colono, compartecipante o soccidario dedicasse all’attività agricola meno dei due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo; successivamente l’art. 2 della L. 29/1990 ha previsto un’ulteriore caso di esclusione, nell’ipotesi in cui il concedente avesse fornito un apporto adeguato alla condirezione dell’impresa da almeno un biennio antecedente l’entrata in vigore della summenzionata legge. L’adeguatezza dell’apporto è disciplinata dall’art. 4 della L. 29/1990. Come si evince dalla disciplina in esame, l’intento del legislatore è stato quello di concentrare il fondo rustico (dal punto di vista della titolarità e del godimento) nelle mani di chi effettivamente lo lavora ponendo un freno alla negligenza del proprietario, il quale si limitava, il più delle volte, a percepire una rendita, disinteressandosi di qualsiasi tipo di investimento. Gli interventi della Corte Costituzionale Le disposizioni in tema di conversione hanno suscitato dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 (principio di eguaglianza), 4 (possibilità di scelta dell’attività lavorativa), 41 (tutela dell’iniziativa economica pubblica o privata), 43 (espropriazione per fini di utilità generale), 44 (limiti e vincoli alla proprietà terriera privata finalizzati al «razionale sfruttamento del suolo» e all’instaurazione di «equi rapporti sociali»), e 46 (diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende) Cost., in quanto dissimulerebbero una vera e propria espropriazione dell’impresa. La Corte Costituzionale, tuttavia, con sentenze n. 138 e 139 del 7-5-1984 ha rigettato tale eccezione, sostenendo che non si tratta di espropriazione, ma di una lecita limitazione dell’autonomia negoziale, in quanto il diritto reale del proprietario resta integro, nella sua consistenza, con l’unica peculiarità della sostituzione del rapporto originario con l’affitto. Da questa decisione si evince come la consulta, pur aderendo all’intento del legislatore di porre un freno all’assenteismo dei proprietari, non ha voluto penalizzarli tutti indiscriminatamente, precisando che, nel caso di imprenditori a titolo principale o di proprietari che abbiano dato un adeguato contributo alla gestione dell’impresa, è necessario il consenso del concedente per l’operatività della conversione, in omaggio al principio della parità di trattamento. la riconduzione all’affitto. Con l’art. 27 della L. 203/1982 il legislatore ha voluto estendere la disciplina dell’affitto a tutti i contratti agrari (associativi o meno) stipulati «dopo l’entrata in vigore» della legge in esame. Caratteristiche della riconduzione sono: a. l’ambito applicativo, circoscritto ai contratti stipulati ex novo dopo l’entrata in vigore della L. 203/1982; b. l’operatività automatica (anche contro la volontà delle parti); c. l’efficacia retroattiva. Diversamente accadeva per la conversione in affitto, la quale, pur producendo i medesimi effetti della riconduzione, si estende ai contratti associativi preesistenti alla legge in esame e richiede l’iniziativa di parte, nonché la presenza di determinati presupposti soggettivi e oggettivi. È importante precisare che l’art. 27 pone una deroga ai principi generali in tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, consentendone la sopravvivenza, pur con una diversa disciplina, a vantaggio del conduttore. Restano esclusi dall’ambito della riconduzione alcuni rapporti precari in cui il fondo rustico è utilizzato in via residuale rispetto alle colture principali (ad esempio i contratti di concessione per coltivazioni intercalari, che si svolgono, cioè, nel periodo intercorrente tra la fine e l’inizio di due colture principali), nonché l’enfiteusi, per il trattamento deteriore che verrebbe a subire l’enfiteuta in seguito all’applicazione della normativa sull’affitto. Dottrina Giova ricordare che è aperto un dibattito dottrinario e giurisprudenziale su alcune fattispecie diverse dai contratti associativi, sospettate di venire utilizzate al fine di eludere il dettato normativo sulla riconduzione. Le ipotesi sono essenzialmente due: a. il comodato di fondi rustici che, attraverso lo strumento dell’art. 1809 c.c., potrebbe trasformarsi in un rapporto analogo all’affitto con durata minima. Secondo la dottrina preferibile (CAPIZZANO) tale rapporto andrebbe invariabilmente ricondotto all’affitto, ponendosi altrimenti in contrasto con le finalità dell’art. 27, L.203/1982; b. il conferimento di fondi rustici in società. Secondo la dottrina prevalente (CARROZZA) il rapporto in esame si differenzia dal contratto di affitto per la circostanza che quest’ultimo si propone la composizione di interessi contrapposti, mentre il contratto di società si contraddistingue per la comunione di scopo. In linea generale, le disposizioni delle leggi speciali in materia di contratti agrari sono imperative e non liberamente derogabili dalle parti. La stessa legge, però, prevede talvolta eccezioni a questo principio. È infatti prevista la possibilità di stipulare accordi in deroga. L’art. 45 della L. 203/1982 stabilisce la validità tra le parti degli accordi stipulati anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari tramite le rispettive organizzazioni professionali agricole reputate maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le convenzioni stipulate in contrasto con la legge, invece, senza assistenza professionale, sono nulle e la loro nullità può essere rilevata anche d’ufficio. Giurisprudenza Per il disposto dell’art. 58 della legge n. 203 del 1982 sull’affitto di fondi rustici, le norme della legge in questione si configurano come imperative, e perciò inderogabili, tutte le volte in cui le parti contraenti non siano, ai sensi dell’art. 45, assistite dalle organizzazioni professionali; assistenza che si risolve in un onere specifico, assolto il quale , quelle norme medesime si degradano a meramente dispositive. Ne consegue che, nell’eventualità in cui si configuri, invece, la inderogabilità delle norme in questione, le singole pattuizioni nulle per contrasto con quelle medesime norme, conoscono la loro sostituzione con le disposizioni legali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, cod. civ., alla cui operatività non si rende di ostacolo il fatto che il legislatore non abbia altresì espressamente previsto la sostituzione delle clausole e pattuizioni in contrasto con le disposizioni della legge n. 203 cit. (Cass. 21 agosto 1997, n. 7822). Il regime di deroga, appena illustrato, pur non disconoscendo l’eventualità di un abuso del titolare del fondo, avverte l’esigenza di verificare caso per caso l’andamento del rapporto. Viene, pertanto, adottata una soluzione di compromesso, che, da un lato, accorda maggiore spazio all’autonomia negoziale, dall’altro circoscrive quest’ultima all’iniziativa collettiva (non individuale), ossia delle organizzazioni professionali agricole. In altre parole, saranno ammessi gli accordi in deroga alla legge, purché venga prestato il consenso delle predette organizzazioni, che garantiscono la posizione della parte che si presume economicamente più debole, ripristinando l’equilibrio contrattuale. B) La natura giuridica dell’affitto Era insegnamento tradizionale che il contratto di affitto fosse un contratto intuitu personae, cioè che la prestazione dovuta dal debitore – l’affittuario – non consentisse sostituzione ad opera di altri se non con il consenso del creditore, l’unico che potesse valutarne la legittimità e la convenienza. Oggi, il fatto che la legge prevede il diritto dell’erede dell’affittuario di succedere nel contratto, nonché una serie di ipotesi di cedibilità del contratto senza il consenso del locatore, ha indebolito tale impostazione. Natura di diritto reale o personale dell’affitto Parte della dottrina ritiene che il contratto di affitto dia luogo ad un diritto reale. In realtà, dal contratto di affitto non nasce l’impresa, ma unicamente l’obbligo del concedente di mettere a disposizione dell’affittuario gli strumenti di produzione e l’obbligo di quest’ultimo di avviare un’attività produttiva e di corrispondere un canone. Non è possibile, però, trascurare il fatto che, pur essendo il potere dell’affittuario autonomo rispetto a quello del concedente, costui conserva pur sempre un ampio potere di controllo sull’attività di impresa, attribuitogli dalla legge per salvaguardare il suo interesse alla produttività del fondo (art. 1619 c.c.). Secondo questa ricostruzione, il diritto dell’affittuario non verrà mai trasformato da obbligatorio in reale, restando sempre assoggettato al potere di controllo del concedente. C) La causa dell’affitto Dalla disciplina normativa dell’affitto si ricava l’idea che la funzione dell’affitto sia quella di attribuire al soggetto non proprietario il potere di esercitare l’attività agricola su un bene produttivo altrui. Invero, non è tanto la natura produttiva del bene, quanto invece l’intenzione di esercitare l’attività su di esso ciò che fa della concessione del godimento temporaneo e personale di un fondo rustico un affitto che lo distingue dalla locazione. Si può quindi concludere che il trasferimento (da parte del proprietario) e l’assunzione (da parte dell’affittuario) dell’esercizio del potere-dovere (verso la collettività) della gestione produttiva del bene-terra, ovverosia dell’esercizio dell’impresa, assumono il rilievo di motivi, comuni e determinanti, delle parti che pattuiscono lo scambio del godimento temporaneo di un bene contro un prezzo e, come tali, concorrono ad integrare la causa concreta dell’operazione economica divenendo interessi che, nella specie, il contratto è diretto a realizzare (GERMANÒ). D) La forma del contratto di affitto La forma è un elemento essenziale del contratto, forma che per principio generale è libera, ma in alcuni casi è stabilito che debba essere scritta. Gli atti che, dal punto di vista economico, sono più importanti richiedono a pena di nullità la forma scritta e, talvolta, una forma solenne. La forma scritta, inoltre, è necessaria per far conoscere ai terzi il contratto mediante la trascrizione, che lo rende ad essi opponibile. Per quanto riguarda i contratti aventi ad oggetto diritti personali di godimento di beni immobili, gli articoli 1350, n. 8, c.c. e 2643, n. 8, c.c. stabiliscono per le locazioni ultranovennali la forma scritta e la pubblicità attraverso la trascrizione. La giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che solo l’affitto a coltivatore diretto non richiede né la forma scritta per essere valido tra le parti, né la trascrizione per essere opponibile ai terzi; mentre l’affitto a conduttore trova la sua disciplina nella specifica disposizione dell’art. 3 della L. 606/1966 che richiede la forma scritta, ma solo ad probationem e la trascrizione per la sua opponibilità. I patti in deroga ex art. 45 L. 203/1982 L’art. 45 della L. 203/1982 accorda alle parti la facoltà di derogare alla disciplina legale dell’affitto, ricorrendo all’assistenza delle organizzazioni professionali agricole. Ci si chiede quale sia la sorte di un contratto stipulato in deroga delle norme della L. 203/1982 ma senza l’assistenza delle associazioni sindacali. Per l’art. 58 della L. 203/1982, che sancisce l’inderogabilità delle norme sull’affitto, salvo che non vi sia stata detta assistenza, in caso di difformità delle clausole contrattuali da quanto impone la legge, si dovrebbe pervenire all’affermazione della nullità del contratto perchè in contrasto con norme imperative. Ma lo stesso ordinamento non sempre giunge alla conclusione della nullità totale: infatti, l’art. 1418 c.c. prevede che la legge possa disporre diversamente e l’art, 1419 c.c. stabilisce che la nullità di singole clausole non determina la nullità dell’intero contratto quando esse sono sostituite da norme imperative. È questo che si verifica nell’ipotesi di contratto in deroga stipulato senza l’assistenza di sindacati: la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito con diverse sentenze che quando un contratto di affitto di fondi rustici sia stipulato in deroga alle norme imperative della L. 203/1982 ma senza l’intervento delle organizzazioni professionali, la nullità che ne deriva non travolge l’intero contratto, ma solo le clausole in contrasto con i precetti della legge, dai quali le clausole nulle vengono sostituite. Inoltre, in tema di patti in deroga, ci si chiede se sia necessaria la presenza dei rappresentanti delle due contrapposte organizzazioni professionali e se la loro presenza sia necessaria al momento dell’effettiva stipulazione del contratto, o sia sufficiente che le parti rimettano ad una successiva omologazione delle organizzazioni quanto da esse pattuito. Per quanto riguarda il primo aspetto, la giurisprudenza accetta la possibilità che i rappresentanti sindacali che prestano l’assistenza richiesta appartengano alla medesima organizzazione. Per quanto riguarda il secondo aspetto, invece, la formula della norma tende ad escludere che sia sufficiente rinviare ad una successiva omologazione del contratto da parte delle organizzazioni sindacali, in quanto la legge pretende che l’assistenza si concreti in un’attività di consulenza, di indirizzo e di cooperazione protettiva da parte sindacale, anche se non necessariamente sin dall’inizio delle trattative purché contestuale alla sottoscrizione dell’atto o non necessariamente contestuale alla sottoscrizione dell’atto purché svoltasi nel corso delle trattative. La libertà che l’art. 45 della L. 203/1982 concede alle parti, quindi, non è una libertà piena, ma una libertà «assistita» (GERMANÒ). 5. I soggetti A) Il concedente Generalmente, i contratti agrari sono bilaterali ed il proprietario del fondo rustico è il concedente. Tuttavia, anche l’enfiteuta e l’usufruttuario possono essere concedenti, in caso di stipula di un contratto agrario che riguardi beni avuti in enfiteusi (terreni) o in usufrutto (terreni e/o animali). Le obbligazioni del concedente consistono essenzialmente: 1. nella consegna del fondo rustico; 2. nell’adoperarsi affinché sia garantito al conduttore l’esercizio dell’impresa. Circa l’obbligo di consegna del fondo, secondo la dottrina preferita (GALLONI), oggetto dell’obbligazione non è il nudo fondo, bensì il terreno attrezzato in concreto per la produzione cui è destinato (il cd. fundus instructus). Il concedente è tenuto a consegnare il fondo nell’estensione prevista dal contratto: la regola è l’affitto a misura, con la conseguenza che, in caso di difformità tra estensione pattuita ed estensione effettiva, si farà riferimento, ai sensi dell’art. 1631 c.c., alle disposizioni «contenute nel capo della vendita» (artt. 1537-1539 c.c.). Il fondo deve essere consegnato unitamente agli accessori e alle pertinenze, così come si rilevano dallo stato di consistenza, redatto al momento della conclusione del contratto, al fine di agevolare la verifica finale al tempo della riconsegna. Il concedente poi, come evidenziato, deve garantire al conduttore l’esercizio dell’impresa per la durata del contratto. L’affitto di fondi rustici è essenzialmente un contratto di durata ad esecuzione continuata: la durata, infatti, è un elemento costitutivo fondamentale, essendo commisurato allo svolgimento di almeno un ciclo produttivo, proprio allo scopo di garantire un assetto stabile all’impresa che l’affittuario è tenuto a condurre. Il legislatore ha disposto una: durata massima dell’affitto, che viene ricondotta a quella della locazione prevista dall’art. 1573 c.c. (trent’anni). Fanno eccezione i terreni boschivi il cui affitto può essere stipulato per un termine massimo di 99 anni. durata minima dell’affitto, da intendersi in una duplice accezione: a. naturale, nel senso che non può essere inferiore a quella di un ciclo agrario; b. legale. La L. 3-5-1982, n. 203, che ha abrogato la proroga dei contratti di affitto a coltivatore diretto, ha disposto per tutti i contratti di affitto una durata minima unica di quindici anni. L’art. 3 della predetta legge, tuttavia, pone un’eccezione nel caso in cui oggetto del contratto siano «appezzamenti di terreno non costituenti, neppure unitariamente ad altri fondi condotti dall’affittuario, una unità produttiva idonea»: è il cd. affitto particellare, relativamente al quale viene disposta una riduzione a sei anni della durata minima. Si precisa che il dettato legislativo vincola il solo concedente, conservando il conduttore la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, purché ne dia avviso al concedente «mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno un anno prima della scadenza dell’annata agraria» (art. 5). L’art. 4 dispone una tacita rinnovazione del contratto di affitto in caso di mancata disdetta di una delle parti. La disdetta deve essere comunicata almeno un anno prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il D.Lgs. 228/2001 ha inserito l’art. 4bis alla L. 203/1982, concernente il diritto di prelazione in caso di nuovo affitto. Il procedimento è ricalcato su quello della prelazione agraria di cui all’art. 8 della L. 26 maggio 1965 n. 590, sia pure con le debite e opportune differenze. Il proprietario del terreno deve comunicare al conduttore le offerte ricevute (si badi bene: non il preliminare del contratto d’affitto), che possono essere sia offerte libere dei terzi, sia la comunicazione di un contratto in deroga ex art. 45 L. 203/1982. La comunicazione dovrebbe avvenire almeno novanta giorni prima della scadenza del contratto di affitto con lettera raccomandata, dall’invio della quale decorrono quarantacinque giorni perché il conduttore manifesti la sua volontà di «offrire condizioni uguali a quelle comunicategli dal conduttore». Tale diritto, evidentemente di natura potestativa, permane anche dopo la scadenza del contratto qualora il locatore entro i sei mesi successivi alla scadenza del contratto abbia concesso il fondo in affitto ad altri senza preventivamente comunicare le offerte ricevute. Il conduttore in tal caso conserva il diritto di prelazione da esercitarsi entro un anno dalla scadenza del contratto non rinnovato. Il diritto di prelazione viene ovviamente meno nel caso in cui il conduttore abbia comunicato di non voler rinnovare il rapporto di affitto, o quando il rapporto sia venuto meno (o stia venendo meno) per grave inadempimento (ex art. 5 L. 203/1982) o per recesso del conduttore stesso. In caso di contrasto sull’applicazione di tale norma la competenza spetta evidentemente alla Sezione specializzata agraria. La risoluzione del contratto di affitto può essere richiesta dal concedente: per grave inadempimento dell’affittuario, intendendo per tale ogni violazione degli obblighi di pagamento del canone, di razionale e normale coltivazione del fondo di conservazione e manutenzione dello stesso nonché l’istaurazione, in dispregio del divieto legislativo, di rapporti di subaffitto o subconcessione (art. 5, comma 2 L. 203/1982); per realizzare opere urbanistiche per le quali sia stata rilasciata la concessione ai sensi della L. 10/1977 (oggi permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001) (art. 50 L. 203/1982); per poter coltivare il fondo direttamente o con un componente della propria famiglia (il cd. diritto di ripresa ex art. 42), sempre che sia diventato proprietario del fondo stesso da almeno un anno. Un’altra novità introdotta dalla legge in esame riguarda il diritto del concessionario a vedersi corrispondere un equo indennizzo in caso di risoluzione incolpevole, «il cui ammontare, in mancanza di accordo fra le parti, è stabilito dal giudice» (art. 43, comma 3). La misura dell’indennizzo non può essere superiore a dodici annualità del canone, né inferiore alla somma dei canoni relativi alle annualità residue di durata del contratto, purché non superiori a dodici (art. 43, comma 3). L’istituto si applica, in altre parole, nei casi di risoluzione dovuta ad una causa diversa dall’inadempimento del concessionario o di interruzione del rapporto per causa diversa dal recesso volontario di quest’ultimo. Per garantire l’effettiva corresponsione dell’indennizzo al concessionario «compete il diritto di ritenzione del fondo» (art. 43 u.c.). B) Il concessionario L’affittuario può essere il coltivatore diretto o non coltivatore. Al primo si applica il modello di affitto e quindi la L. 203/1982, mentre solo alcune disposizioni richiamano la figura del non coltivatore. La L. 203/1982 ha ridotto ad un numero quantitativamente scarso le differenze tra i sudetti tipi di affitto. Le differenze a favore dell’affittuario coltivatore diretto attengono solo al suo potere di compiere i c.d. piccoli miglioramenti e alla forma libera del contratto, oltre che al suo diritto di prelazione, posizioni giuridiche soggettive tutte giustificate dal lavoro personale, ovvero dall’esercizio diretto dell’attività (esecutiva) di coltivazione. L’art. 23 della L. 203/1982 opera un’estensione di quanto dettato per il coltivatore diretto, stabilendo che: « Al contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto si applicano le norme previste negli artt. 3, 5, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 42, 43 e 45». In particolare i suddetti articoli si riferiscono ai seguenti casi: l’art. 3 riguarda l’affitto particellare e afferma che tale affitto si ha «quando oggetto del contratto siano uno o più appezzamenti di terreno non costituenti, neppure unitamente ad altri fondi condotti dall’affittuario, una unità produttiva idonea ai sensi dell’art. 31 della presente legge» e quindi capace «di una produzione annuale media….pari almeno alla retribuzione annuale di un salariato fisso comune occupato in agricoltura». Alla luce di quanto esposto dall’art. 23, i limiti indicati nell’art. 3 possono assumere finalità oggettive e non soggettive. Non sarebbe, dunque, escluso da questo tipo di contratto il coltivatore non diretto, ma i limiti si riferirebbero alla restrizione della facoltà di porre in essere questa tipologia di affitti determinando indirettamente la dimensione dei fondi; l’art. 5 si riferisce al recesso dell’affittuario ed alla risoluzione per grave inadempimento dello stesso; l’art. 15 determina i conguagli per i canoni pagati prima della L. 203 e dichiaratamente provvisori; gli artt. 16, 17, 18 e 20 riguardano i miglioramenti; l’art. 21 tratta il subaffitto; gli artt. 42, 43 e 45 rientrano nel Titolo III della L. 203/1982, intitolato «Norme generali e finali». L’affittuario è obbligato, in primo luogo, a corrispondere un canone, cioè un prezzo, dovuto per il godimento del fondo rustico: l’affitto si connota, infatti, come contratto a prestazioni corrispettive. È importante sottolineare che proprio sull’elemento del canone ha inciso in maniera determinante la legislazione speciale, che ha suscitato spesso questioni di costituzionalità relativamente all’incongruità dei coefficienti da seguire per la sua determinazione. Il canone dell’affitto Dispone l’art. 1639 c.c.: «Il fitto può consistere anche in una quota ovvero in una quantità fissa o variabile dei frutti del fondo locato». Dal dettato normativo emerge, dunque, che la materia era interamente devoluta all’autonomia negoziale delle parti ed era improntata al principio della libera contrattazione, potendo queste ultime accordarsi tanto per un fitto corrisposto in denaro, o in una quota fissa di beni, quanto per un fitto in denaro corrispondente al valore di determinati prodotti agricoli. Successivamente, il D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 277 ha introdotto il principio della perequazione del canone, poi regolata dall’art. 8 della L. 11-2-1971, n. 11: la peculiarità del procedimento era che veniva conservata l’autonomia negoziale dei privati, lasciando però libero ciascun contraente di adire il giudice per ristabilire l’equilibrio eventualmente turbato, sulla scorta di un parere fornito dalle autorità amministrative. Gradatamente si assisté all’abbandono del principio della libera contrattazione con la emanazione della L. 12-6-1962, n. 567, che ha introdotto il criterio della cd. forcella, in base al quale spettava alle Commissioni tecniche provinciali la determinazione del canone, mediante l’individuazione, a seconda delle zone agrarie, di varie tabelle recanti ciascuna i canoni da considerarsi equi (con un’oscillazione tra un minimo e un massimo prestabiliti). L’autonomia contrattuale è stata ulteriormente compressa con l’entrata in vigore della L. 112-1971, n. 11, che ha ancorato la determinazione delle tabelle inerenti al canone ad un criterio rigido: quello del reddito catastale, che andava aggiornato ad opera delle Commissioni provinciali per ogni tipo di coltura, con coefficienti definiti nel minimo e nel massimo. Il tormentato iter legislativo sembrava aver trovato fine con la L. 203/1982, che relativamente alla procedura per la determinazione del canone affidava alle Commissioni tecniche provinciali la determinazione delle tabelle per i canoni fondate sul reddito dominicale. Tuttavia la Corte costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità delle norme che dettavano i criteri di determinazione del canone (artt. 9 e 62 L. 203/1982) poiché i dati catastali non sono idonei a rappresentare le caratteristiche dei terreni (Corte Cost., 5-7-2002, n. 318). Ne è derivato un vuoto legislativo con le conseguenti difficoltà nella individuazione dei criteri da seguire. La soluzione apparsa preferebile è stata quella di attenersi ai criteri previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni professionali agricole. 6. I poteri derivanti dal contratto di affitto Come innanzi precisato, le posizioni attive scaturiscono non dal contratto di affitto o dalla legge (che rilevano unicamente come fonte mediata), bensì dall’impresa, che nasce con l’esercizio effettivo dell’attività economica da parte dell’affittuario. In altre parole l’impresa, da un lato attribuisce a quest’ultimo la qualità di imprenditore, conferendogli i poteri strumentali al relativo esercizio; dall’altro, conferisce al concedente ampi poteri di controllo sulla gestione esercitata dall’affittuario. A) I poteri dell’affittuario È l’aspetto dei poteri dell’affittuario ciò che oggi caratterizza il contratto di affitto, perché esprime chiaramente la posizione di imprenditore agricolo che il concessionario del godimento del fondo assume con la sua doverosa gestione produttiva della terra (GERMANÒ). Consistono essenzialmente nella prerogativa dell’affittuario di fare propri i frutti naturali del fondo e quelli del bestiame. Restano invece esclusi i frutti civili. L’art. 10 della L. n. 11/1971 conferisce all’affittuario tutti i poteri rientranti nelle prerogative dell’imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 c.c., in particolare, le iniziative di organizzazione (ad esempio, acquisto di beni strumentali alla produzione, quali macchinari e sementi) e di gestione, funzionali ad una razionale attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Sono da ritenersi connaturali alla qualità di imprenditore e, come tali, imprescindibili, i poteri di gestione, ovverosia quelli che attengono alla libertà di esercizio dell’impresa, alla determinazione delle colture da praticare, ai tempi e ai modi di coltivazione, alla scelta dei destinatari della produzione ecc. Rilevanti sono, altresì, i poteri di organizzazione dell’azienda e anche essi non possono essere compressi, pena la perdita della qualità di imprenditore, quando si riferiscono agli elementi aziendali diversi dalla terra presa in affitto. Quando, invece, l’organizzazione riguarda il fattore produttivo della terra, il fatto che essa appartenga ad altri determina una situazione in cui la libertà di coltivazione dell’affittuario deve necessariamente contemperarsi con il diritto del locatore a riavere indietro, al termine del rapporto, la stessa terra che ha dato in affitto. B) I poteri del concedente L’art. 1619 c.c. legittima il concedente ad effettuare un controllo di merito sull’attività dell’affittuario in nome non tanto del suo interesse alla restituzione del bene oggetto del contratto, bensì dell’interesse specifico alla gestione effettiva dell’impresa da parte dell’affittuario. Da una lettura combinata degli artt. 1618 e 1619 c.c. si evince che il controllo del concedente è finalizzato a verificare l’osservanza, da parte del conduttore, dei seguenti obblighi: quello di «destinare al servizio della cosa i mezzi necessari per la gestione di essa». In altre parole, l’affittuario è tenuto (obbligo quantitativo) ad organizzare i fattori produttivi, in particolare accollandosi l’onere delle anticipazioni colturali, della dotazione del fondo e dell’impiego della mano d’opera necessaria; quello di osservare «le regole della buona tecnica». In altre parole, l’affittuario è tenuto a combinare i fattori produttivi nelle giuste proporzioni, nonché a garantire la continuità nelle coltivazioni evitando, nel contempo, le forme di sfruttamento intensivo (obbligo qualitativo); quello di non mutare «stabilmente la destinazione economica della cosa». In altre parole, anche alla luce dell’art. 16 della L. 203/1982, all’affittuario è fatto divieto unicamente di destinare il fondo ad un’attività diversa da quella agricola, e non di mutare il tipo di coltura impressovi dal concedente. È importante ricordare come, oltre agli obblighi espliciti sopra indicati, grava sul conduttore il generico obbligo di osservare, nella coltivazione, la diligenza del buon padre di famiglia. C) Poteri concorrenti Nel contratto di affitto di fondi rustici si realizza una cooperazione tra concedente e conduttore, finalizzata all’incremento della produttività dell’impresa, che si evidenzia sia relativamente alla dotazione del fondo, sia relativamente ai miglioramenti. Dispone l’art. 1617 c.c.: «Il locatore è tenuto a consegnare la cosa con i suoi accessori e le sue pertinenze, in istato da servire all’uso e alla produzione a cui è destinata». La norma appena citata ha ad oggetto le pertinenze, ossia le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa e nella specie l’espressione indica qualsiasi cosa, collegata a quella affittata, che consente di trarre da questa la maggiore utilità possibile (ad esempio, i macchinari agricoli e gli animali); la norma va coordinata con gli artt. 1640-1645 c.c., nei quali è contenuto il regime delle «scorte» del fondo. È importante precisare che, di regola, il concedente conserva la titolarità delle dotazioni del fondo consegnate all’affittuario «con determinazione della specie, qualità e quantità», per tutta la durata del contratto (art. 1640 c.c.). Diversamente accade per le dotazioni «consegnate con la sola indicazione del valore» (art. 1640, comma 3 c.c.), che passano, invece, in proprietà dell’affittuario. Contrariamente a quanto disposto nell’ipotesi di vendita, il rischio inerente alle dotazioni grava interamente sul conduttore al momento della consegna: questi è tenuto a restituirle «nella stessa specie, qualità e quantità», ricorrendo al conguaglio in denaro per eliminare le eventuali differenze. Da questa disciplina, emerge: un incisivo potere del conduttore di organizzare le dotazioni, integrandole a sua discrezione con altre scorte vive o morte, per garantire un’efficiente gestione (cui fa da contropartita l’elevato rischio, ordinario o straordinario, anche dovuto a caso fortuito, inerente alle dotazioni aziendali che grava sull’affittuario); un ampio potere del concedente di predisporre un’efficiente organizzazione del fondo, approntando le necessarie dotazioni allo stesso legate da un vincolo pertinenziale. Relativamente ai miglioramenti, è importante precisare che l’attuale disciplina speciale si propone di superare i potenziali conflitti tra contraenti, legittimando entrambi a promuovere i miglioramenti agrari in corso di contratto, in nome dei concorrenti interessi delle parti: quello del concedente ad accrescere la produttività del fondo e quello dell’affittuario ad accrescere la produzione; in altre parole, ciascuno dei contraenti può prendere l’iniziativa, operando sotto il controllo dell’altro. L’abrogata disciplina codicistica disponeva all’art. 1651 che, ove non fosse stato raggiunto sul punto un accordo fra le parti, si sarebbe dovuto ricorrere all’autorità giudiziaria. Tale disposizione, mai attuata, fu superata dall’art. 11 della L. 11-21971, n. 11, che provvide a sostituire il ricorso all’autorità giudiziaria con un ricorso all’autorità amministrativa (nella specie, l’Ispettorato Agrario Provinciale). A tale disciplina è subentrato il disposto degli artt. 16-20 della L. 203/1982. Dal dettato normativo è possibile evincere un ampliamento della nozione di miglioramenti, volta a ricomprendere anche le addizioni e le trasformazioni degli ordinamenti produttivi. Parallelamente, la legge stabilisce che i miglioramenti non debbono modificare «la destinazione agricola del fondo» e devono eseguirsi «nel rispetto dei programmi regionali di sviluppo oppure, ove tali programmi non esistano, delle vocazioni colturali delle zone in cui è ubicato il fondo». Secondo la dottrina prevalente l’affittuario ha l’obbligo di salvaguardare la destinazione agricola del fondo, non la sua destinazione economica. Dal combinato disposto dagli artt. 1621 e 1622 c.c. si evince che le spese di manutenzione sono così ripartite: sul concedente gravano le riparazioni straordinarie, sul conduttore le riparazioni ordinarie. Il dettato normativo si giustifica considerando che l’esecuzione delle riparazioni straordinarie da parte del concedente può determinare una perdita a danno dell’affittuario, causata dall’interruzione, per un periodo più o meno lungo, dell’attività produttiva: di qui l’esigenza di concedere all’affittuario «una riduzione del fitto in ragione della diminuzione del reddito oppure, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto». Infine, tra concedente e conduttore vige una forma di solidarietà, nel difendere l’azienda dalle intromissioni dei terzi: in particolare, il concedente sarà tenuto a difendersi dalle molestie di diritto consistenti nelle pretese giuridiche accampate dai terzi sul bene locato; il conduttore reagirà, invece, servendosi delle azioni possessorie, contro le molestie di fatto, ossia le attività poste in essere da terzi che diminuiscono il godimento del bene locato. D) Procedura ed effetti dei miglioramenti fondiari La L. 203/1982 disciplina le procedure e gli effetti dei miglioramenti fondiari, che possono essere eseguiti dalle parti sempre che: non alterino la destinazione agricola del fondo; siano eseguiti nel rispetto dei piani regionali di sviluppo delle vocazioni colturali della zona agricola in cui il fondo è ubicato. I miglioramenti si classificano in: intrinseci (scassi, prosciugamenti di terreni umidi ecc); addizioni (edifici, frutteti ecc.); trasformazioni riguardanti gli ordinamenti produttivi (da cerealicozootecnico a frutti-viticolo). I miglioramenti fondiari possono essere eseguiti da entrambe le parti, concedente ed affittuario, nel rispetto delle procedure previste. Il rilievo del tema dei miglioramenti nella disciplina dell’affitto è dato dalle conseguenze: se a migliorare è il proprietario, egli ha diritto di chiedere l’aumento del canone con riferimento alle nuove qualità e classe catastali del fondo; se a migliorare è l’affittuario, egli ha diritto, al termine dell’affitto, ad un’indennità pari all’aumento del valore del fondo, nonché a ritenerlo fino a quando l’indennità non gli venga pagata. In mancanza di un accordo preliminare, la parte che intende eseguire le opere miglioratorie lo comunica all’altra parte e all’Ispettorato Provinciale Agrario, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con allegato il progetto delle stesse con la specificazione delle caratteristiche e delle finalità delle stesse (art. 16, comma 2). L’Ispettorato Agrario deve tentare un accordo tra le parti, convocandole; in mancanza dello stesso deve pronunciarsi sul miglioramento, in senso positivo o negativo, entro 60 giorni dalla comunicazione, notificandola alle parti. Nel caso di parere di congruità del miglioramento, il concedente deve far conoscere entro 60 gg. dalla comunicazione se intende eseguire le opere, oppure se è contrario. Nel caso che lo stesso concedente: non esegua le opere di miglioramento; inizi i lavori per le opere, ma non le porti a termine; non risponda alla comunicazione dell’Ispettorato Agrario; l’affittuario può subentrare nella esecuzione delle opere approvate dall’I.P.A. con diritto di surroga. All’affittuario sono anche riconosciuti, in quest’ultimo caso, i diritti di chiedere eventuali autorizzazioni e finanziamenti pubblici. La legge differenzia i detti miglioramenti dai cosiddetti «piccoli miglioramenti», che vengono eseguiti dall’affittuario con il lavoro proprio e della propria famiglia e che non comportano trasformazioni all’ordinamento produttivo, ma servono a rendere più efficienti e produttivi i sistemi di coltivazione in atto (art. 19, comma 2 della L. 203/1982). I «piccoli miglioramenti» operati dall’affittuario possono essere eseguiti derogando alla normativa degli artt. 16 e segg. della L. 203/1982, previo invio di una comunicazione al concedente, tramite lettera raccomandata, 20 gg. prima dell’esecuzione delle opere (art. 19). Il diritto di ritenzione Abbiamo già visto che qualora i miglioramenti siano stati effettuati dall’affittuario, egli ha diritto, al termine dell’affitto, ad un’indennità pari all’aumento del valore del fondo, nonché a ritenerlo fino a quando l’indennità non gli venga pagata. Ci si è posti, quindi, il problema di quale fosse la disciplina del rapporto di fatto che si frappone tra il retentore e il fondo rustico. In un primo momento la Suprema Corte aveva escluso che il retentore potesse far suoi i frutti della cosa e che, di conseguenza, non dovesse pagare il canone. La questione, però, è che nel nostro ordinamento non è ammesso che la terra non sia coltivata, per cui la soluzione preferibile sarebbe quella secondo cui anche il retentore ha l’obbligo della gestione produttiva per dovere costituzionale, per cui può far suoi i frutti che sono, appunto, il risultato della sua attività imprenditoriale. La Suprema Corte, infatti, con sentenza del 2 marzo 2007, n. 6964 ha stabilito che l’esercizio, da parte dell’affittuario, del diritto di ritenzione comporta l’obbligo di custodia con la diligenza del buon padre di famiglia e vincola il detentore ad assicurare la conservazione del fondo in buono stato, tale da assicurare la produttività secondo la sua destinazione, condizione che invece verrebbe a mancare se il terreno venisse lasciato abbandonato ed incolto: con la conseguenza che l’affittuario è tenuto al pagamento del canone convenzionale quale corrispettivo del godimento del fondo, includente, come tale, la percezione dei frutti. 7. La durata e la risoluzione del contratto agrario A) Durata del contratto La L. 203/1982 ha stabilito che la durata ordinaria minima del contratto di affitto fosse di 15 anni, sia per i coltivatori diretti sia per i non coltivatori. La durata massima resta, invece, quella prevista dal codice civile per le locazioni in generale, ossia di 30 anni (in caso di affitto di fondi rustici destinati al rimboschimento tale durata è estesa a 99 anni). Nel caso dell’affitto particellare la durata minima prevista dalla L. 203 è di sei anni. B) Risoluzione del contratto La prima causa di risoluzione del contratto agrario è rappresentata dal caso in cui le parti risolvono consensualmente il contratto; essa rappresenta l’unica situazione in cui le parti hanno gli stessi diritti rispetto alla durata del contratto. Generalmente, infatti, è il solo concessionario ad avere la facoltà di risolvere anticipatamente il rapporto, fornendone, un anno prima, comunicazione a mezzo lettera con A.R. Tuttavia, il concedente può richiedere lo scioglimento anticipato del rapporto quando si verifichi un caso di grave inadempimento dell’affittuario (tra cui: morosità, violazione dell’obbligo di normale e razionale coltivazione, violazione dell’obbligo di conservazione e manutenzione del fondo, subaffitto o subconcessione). Altre cause di scioglimento del contratto sono: l’interdizione, l’inabilitazione o l’insolvenza dell’affittuario (art. 1626 c.c.). Il concedente che verifichi un grave inadempimento da parte dell’affittuario e sia intenzionato a sciogliere il contratto dovrà invitare l’affittuario stesso, mediante lettera A.R., ad eliminare l’inadempimento entro 3 mesi, trascorsi i quali dovrà attivare il tentativo di conciliazione, previsto dall’art. 46 della L. 203/1982, concluso il quale potrà rivolgersi alla sezione agraria specializzata del tribunale. L’art. 50, L. 203/1982, prevede come ulteriore causa di cessazione anticipata del rapporto: il rilascio di concessione edilizia, ma se la concessione richiede esclusivamente l’utilizzo di una parte del fondo, il rapporto dovrà proseguire per la parte del fondo non interessata dalla concessione. Quali sono le differenze tra il contratto di affitto di fondo rustico e contratto di affitto di azienda agricola? Se l’azienda agricola è diversa dal fondo attrezzato, ci si chiede se si possa pensare ad un contratto di affitto di azienda agricola che sfugga alla legislazione speciale che ha ad oggetto l’affitto di fondi rustici. La dottrina è divisa, in quanto la L. 203/1982 dispone la riconduzione all’affitto di tutti i contratti agrari aventi ad oggetto la concessione di fondi rustici o tra le cui prestazioni vi sia il conferimento di fondi rustici. Partendo da questo dato, è necessario passare alla lettura combinata degli articoli 58, 45 della L. 203/1982. L’art. 58 afferma il principio dell’inderogabilità della legislazione speciale e ciò comporta la nullità delle clausole pattizie difformi dalla legge e la loro sostituzione di diritto con le clausole fissate dalla legge. Tale principio, però, può essere eluso qualora le parti contraenti vengono assistite da associazioni sindacali a norma dell’art. 45. Tale libertà negoziale sancita dall’art. 45, però, deve essere intesa solo come possibilità di modificare le clausole legali del contratto agrario di affitto, l’unico oggi ammesso dall’ordinamento. Per cui, se l’ordinamento ritiene che l’unico contratto meritevole di tutela avente ad oggetto fondi rustici sia l’affitto di fondi rustici, l’art. 45 non può essere utilizzato per stipulare contratti che, per le loro prestazioni, fuoriescono dal tipo dell’affitto. Se si addivenisse alla tesi che non sussiste alcuna differenza tra azienda agricola e fondo attrezzato, l’affitto di azienda, in quanto affitto di fondo attrezzato, cadrebbe sotto il disposto della legislazione speciale secondo il principio dell’inderogabilità sancito dall’art. 58 L. 203/1982. Se, invece, si accoglie la tesi della distinzione tra azienda agricola e fondo attrezzato, occorre riconoscere che nel nostro sistema giuridico esiste una norma specifica che disciplina l’affitto di azienda (art. 2562 c.c.): per cui è necessario ammettere che vi è un tipo di affitto di bene produttivo (azienda) che si distingue dal tipo dell’affitto di fondo rustico. Il contenuto del contratto, la prestazione, non è, nell’ipotesi di affitto di azienda, un fondo rustico, ma un complesso organizzato di beni: per cui, quando si discute di contratti agrari aventi ad oggetto la concessione di un fondo, si parla di un qualcosa di estremamente diverso dal contratto il cui oggetto è la concessione di un’azienda. Né, quando si è in presenza di un’azienda, si può intendere che colui che la concede ad altri in godimento si impegna a compiere più prestazioni tra cui vi è il conferimento del fondo rustico, dato che, invece, la sua prestazione è unica perchè unico è il bene, l’azienda appunto, che egli consegna all’altra parte (GERMANÒ). Inoltre, è la stessa realtà che non consente di ricondurre all’affitto di fondo rustico l’affitto di azienda. Se, ad esempio, potesse essere trattato come affitto di fondo rustico l’affitto di un’azienda vitivinicola, con i relativi impianti di trasformazione ed imbottigliamento, allora si dovrebbe consentire all’affittuario di restituire al concedente, già organizzatore di quel genere di azienda e imprenditore vitivinicolo, un fondo costituito da prati o da un uliveto. Ciò è chiaramente insostenibile, mentre accogliendo la tesi dell’affitto di azienda, si rileva che la disciplina circolatoria del complesso di beni organizzati impone all’affittuario di gestire l’azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni delle scorte, onde possa restituirla al locatore nel medesimo stato in cui l’ha ricevuta. 8. Il subaffitto L’art. 21 della L. 203/1982 sancisce il divieto dei «contratti di subaffitto, di sublocazione e comunque dei fondi rustici». Tale norma stabilisce che «la violazione del divieto, ai fini della dichiarazione di nullità del subaffitto o della subconcessione, della risoluzione del contratto d’affitto e della restituzione del fondo, può essere fatta valere soltanto dal locatore, entro quattro mesi dalla data in cui ne è venuto a conoscenza». Appare evidente come non preveda la nullità in senso proprio del contratto, proprio in funzione del fatto che essa può essere fatta valere solo dal concedente. Molte dottrine si sono espresse a riguardo, alcune ritenendo che si tratti di inopponibilità (G. CIAN) altre riconoscendo un caso di annullabilità speciale (P. FANILE) o relativa (B. GRASSO). 9. I contratti di utilizzazione dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili L’art. 6 del D.Lgs. 228/2001 ha esteso ai terreni demaniali e patrimoniali indisponibili a vocazione agricola le disposizioni di cui alle leggi 12 giugno 1962, n. 567, 11 febbraio 1971, n. 11 e 3 maggio 1982, n. 203, che disciplinano in modo cogente il contratto di affitto dei fondi rustici, ponendo in tal modo fine alle dispute interpretative che si erano presentate sotto la vigenza della precedente normativa. Resta il procedimento di assegnazione dei beni, ossia tramite licitazione privata o trattativa privata, mentre è stata definitivamente accantonata l’asta pubblica. Il quarto comma dell’art. 6 del decreto stabilisce che gli enti pubblici, alla scadenza delle concessioni amministrative o dei contratti agrari, «possono avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 23 terzo comma della L. 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell’art. 45 della L. 3 maggio 1982, n. 203», ossia di accordi in deroga. Le leggi sull’affitto si applicano interamente ed integralmente a tutti i rapporti giuridici posti in essere con la pubblica amministrazione, siano essi contratti privatistici, concessioni amministrative o concessioni-contratto. Importante limite è quello di cui al secondo comma, con il quale si concede all’ente proprietario di recedere dal contratto con preavviso di almeno sei mesi per il caso in cui il terreno demaniale debba essere improcrastinabilmente destinato al fine per il quale la demanialità o l’indisponibilità è posta. Altro limite è dato dal terzo comma dell’art. 6 in questione: sui terreni demaniali o soggetti al regime demaniale di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici, sono ammessi soltanto i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni concordati tra le parti o quelli eseguiti a seguito del procedimento di cui all’art. 16 della L. 3 maggio 1982 n. 203. Non vi possono, invece (e qui si rinviene il limite rispetto alla disciplina generale), essere trasformazioni dei fabbricati rurali. Anche la procedura avanti l’Ispettorato provinciale dell’agricoltura di cui all’art. 16 della L. 203/1982 non muta; oltre a non modificare l’utilizzazione agricola dei terreni, le opere compiute devono essere eseguite nel rispetto dei programmi regionali di sviluppo o delle vocazioni colturali della zona. Essendo disposta la totale applicabilità delle leggi sui fondi rustici, la competenza in caso di controversia è devoluta alle Sezioni specializzate agrarie. 10. I contratti per colture stagionali In agricoltura sono possibili contratti, oltre che tra agricoltori da un lato e industriali dall’altro, anche tra imprenditori agricoli diversi volti ad integrare economicamente le rispettive imprese. Bisogna premettere che l’ordinamento colturale classico è quello che comprende, in successione, per un anno il maggese (terreno lavorato ma non seminato) e per due anni consecutivi il cereale, con una rotazione nei tre campi in cui è suddivisa l’azienda. Talvolta, il maggese è sostituito dalla cd. coltura da rinnovo, cioè da colture che, per il genere di vegetali e per le caratteristiche degli interventi colturali, lasciano nel terreno un residuo di effetti positivi a vantaggio delle coltivazioni successive. Gli intervalli di tempo rimasti liberi dalle colture principali possono, poi, essere utilizzati per colture di più breve durata, denominate stagionali o di secondo raccolto, rispettivamente perchè impegnano il terreno tra due colture principali o per un periodo a cavallo tra due stagioni o per il modesto reddito economico trattandosi di colture di minore importanza agronomica. Nella realtà italiana possono ricorrere contratti con i quali un imprenditore agricolo concede ad altro imprenditore agricolo i propri terreni o parte del proprio fondo per l’impianto di colture stagionali. Il contratto di concessione per colture stagionali crea un rapporto tra due imprenditori agricoli: uno di essi attribuisce all’altro lo sfruttamento di quella parte del proprio fondo che, per lo specifico sistema colturale da lui organizzato, resterebbe per un certo periodo di tempo privo della coltura principale, e lo attribuisce al secondo non tanto per riscuotere il canone, ma per riottenere, al termine del ciclo agrario del maggese o delle colture secondarie, il terreno in condizioni più fertili. In tali casi, per espressa disposizione di legge (art. 56 L. 203/1982) tali concessioni non sono contratti assoggettati alle norme inderogabili di disciplina dell’affitto di fondi rustici. Si può dire che tali contratti disciplinati dall’art. 56 della L. 203/1982 si pongono come strumentali all’interno della stessa organizzazione del concedente, essendo funzionalmente legati e rapportati al tipo di coltivazione e di rotazione colturale da lui praticato; ma essi possono anche dirsi strumentali anche all’organizzazione aziendale dell’imprenditore agricolo concessionario, perchè i nuovi terreni così acquisiti gli permettono forme di ricomposizione aziendale che, altrimenti, non gli sarebbe possibile attuare (si pensi, ad esempio, alla coltivazione del tabacco che pretende la rotazione su terreni sempre diversi) (GERMANÒ). 11. Mezzadrìa e colonìa parziaria Sono attualmente inquadrabili, per la dottrina unanime (ARCANGELI, BASSANELLI), nello schema dei contratti associativi e sono inserite nel libro quinto del codice civile del 1942, intitolato «Del lavoro». Sotto la vigenza del codice civile del 1865, invece, prevaleva la tendenza (ABELLO, RICCI, BIANCHI) ad inquadrare i contratti in esame, nello schema della locazione, anche se con qualche connotato della società o della locazione di opere. Successivamente, all’epoca del primo conflitto mondiale, ad alcuni contratti agrari (tra cui la mezzadrìa e la colonìa parziaria) fu riconosciuta (BREGLIA, BARASSI), natura parziaria, in virtù della relativa clausola negli stessi inserita. Come innanzi precisato, la legge ha disposto l’abolizione dei contratti agrari associativi, mediante il divieto di stipularne nuovi (in proprio e quale capo di una famiglia colonica) e, nel contempo, la loro forzosa conversione in affitto. A) Natura giuridica e struttura La mezzadrìa è quel contratto con cui concedente e mezzadro si associano, dando vita ad una gestione in comune del podere e delle attività connesse alla coltivazione dello stesso, al fine di dividerne i prodotti e gli utili (art. 2141 c.c.). La colonìa parziaria è quel contratto con cui il concedente e il colono (uno o più) si associano, dando vita ad una gestione in comune del fondo e delle attività allo stesso connesse, al fine di dividerne gli utili (art. 2164 c.c.). La ripartizione della produzione è del 60% al colono e del 40% al concedente quando le spese vengono divise al 50%. Si applica anche a tale istituto il disposto dell’art. 37 della L. 203/1982, che prevede una maggiorazione della quota del colono in caso di mancata conversione in affitto. Sia la mezzadrìa che la colonìa parziaria appartengono alla categoria dei contratti consensuali: si perfezionano al momento dell’incontro dei consensi, ma diventano produttivi di effetti solo nel momento in cui viene esercitata l’impresa. È questo, infatti, il dato caratterizzante che accomuna le figure in esame: l’esercizio in comune dell’impresa agricola. I contratti in oggetto presentano fondamentali differenze, relative: alla struttura, nel senso che nella mezzadrìa si riscontra la presenza di un’oculata organizzazione sul fondo, adibito a podere: in altre parole, si richiede, oltre alla predisposizione di strutture organizzate aziendali, anche che il lavoro provenga dalla famiglia colonica, e che questa sia insediata sul fondo stesso. Nella colonìa parziaria, al contrario, difetta il requisito dell’organizzazione, in quanto il colono si impegna unicamente ad una prestazione di lavoro, mentre non è tenuto ad insediarsi nel fondo, da solo o con i propri familiari; al conferimento che, pur richiedendo in entrambi i casi una prestazione lavorativa del colono, si connota per una preesistente organizzazione nella mezzadrìa. Si tenga presente, tuttavia, che i due contratti non hanno sempre avuto lo stesso rilievo: la mezzadrìa, infatti, ha conosciuto un maggiore favor legislativo nel periodo compreso tra i due conflitti mondiali, dal momento che coniuga l’organizzazione di impresa con i criteri di efficienza ed economicità della gestione, effettuata dalla famiglia contadina. Tuttavia, con l’avvento di nuovi ritrovati della tecnica, la situazione si ribaltò, essendosi dimostrato che la mezzadrìa non si teneva al passo con i tempi. La sussistenza di siffatta tendenza si evince, ad esempio, dal divieto posto dall’art. 3 L. 15-91964, n. 756 e sanzionato, a pena di nullità di stipulare nuovi contratti di mezzadrìa (previsione non rispettata per la colonìa parziaria). Siffatta preclusione, tuttavia, ha un rilievo limitato dal momento che la nullità non colpisce i contratti già vigenti, come pure non si estende, relativamente ai contratti stipulati nell’inosservanza del divieto, al periodo in cui gli stessi hanno avuto esecuzione. L’iter legislativo culminerà poi nella L. 3-5-1982, n. 203, modificata dalla L. 29/1990 che, disponendo la conversione dei contratti agrari associativi in affitto ha sostanzialmente messo su un piano di parità la mezzadrìa e la colonìa parziaria. B) La gestione dell’impresa agricola Come già accennato, può affermarsi che elemento comune ad entrambi i contratti è l’esercizio dell’attività di impresa. Sostanzialmente, le obbligazioni delle parti consistono: per il concedente, nel conferimento del fondo, organizzato in modo tale da consentire al colono di cominciare subito l’attività di produzione. Recita infatti l’art. 2145 c.c.: «Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato di quanto occorre per l’esercizio dell’impresa e di un’adeguata casa per la famiglia colonica»; per il colono, nel conferimento di una prestazione lavorativa più o meno organizzata. Ai sensi dell’art. 6 della L. 756/1964, il colono e il concedente collaborano nella direzione dell’impresa, con la prerogativa, per il primo, di apporre il suo veto a tutte le iniziative del concedente reputate inidonee alla produttività del fondo. Per evitare la paralisi dell’attività, in caso di mancata composizione dei conflitti tra i due contraenti, è previsto l’intervento conciliatore dell’Ispettorato provinciale agrario. Dall’art. 2147 c.c. si evince che, oltre all’obbligo di conferire la propria prestazione lavorativa in forma organizzata, grava sul colono anche l’obbligazione strumentale di gestire il fondo, in modo da mantenerlo in condizioni di normale produttività (ad esempio, effettuando le relative riparazioni) e di custodirlo diligentemente. In altre parole, il colono dispone di un potere di organizzare il proprio lavoro, in merito al quale il concedente non potrà interferire, limitandosi quest’ultimo a fissare degli obiettivi generali. Il colono, in funzione dell’adempimento di questi obblighi, ha la detenzione del fondo messogli a disposizione del concedente. In particolare il mezzadro è tenuto anche ad insediarsi con la propria famiglia. È importante precisare che, oltre alle obbligazioni esaminate, sussiste anche quella di conferire il cd. capitale d’esercizio, costituito dalle scorte vive (bestiame) e morte (macchine e attrezzi agricoli) e dal capitale circolante (strumenti, mangime, etc.), come disposto dall’art. 2146 c.c. Questa previsione, dettata per la mezzadrìa, non viene ripetuta per la colonìa parziaria. Si tratta di un elemento che, unitamente al fondo e al lavoro, appare decisivo per l’attività produttiva. Relativamente alle spese affrontate nel corso della gestione, può affermarsi che: gravano sul concedente le spese di conservazione e manutenzione del fondo, come disposto dell’art. 2151 c.c.; gravano sul colono le spese relative al conferimento della prestazione lavorativa, come disposto dall’art. 2147 c.c. e le spese di piccola manutenzione, in ossequio al disposto dell’art. 2153 c.c.; gravano su entrambi le spese inerenti all’uso e alla manutenzione del capitale fisso, in ragione del cinquanta per cento e le spese inerenti al capitale circolante (anticipazioni colturali quali mangimi, concimi etc.), ripartite in maniera diversa nella mezzadrìa e nella colonìa parziaria. Si ricorda che dalla mancanza, nei contratti agrari associativi, di un patrimonio comune, deriva che ciascun contraente manterrà il proprio patrimonio separato, mentre diventeranno comuni i frutti e gli incrementi patrimoniali che derivano dalla gestione. In particolare, può affermarsi che ciascuno dei contraenti è titolare di un vero e proprio diritto reale sulla quota che gli spetta dei frutti e degli incrementi patrimoniali; la disponibilità della proprietà dei frutti si otterrà al momento della divisione. 12. I contratti di anticresi e di comodato La terra può essere acquistata anche con un contratto di comodato e può venire nella disponibilità di un soggetto con un contratto di anticresi. Applicando queste due fattispecie contrattuali all’ipotesi del fondo rustico, si rileva che il comodato è il contratto per il quale il proprietario della terra la consegna ad altri perchè se ne serva gratuitamente per un certo tempo e la restituisca al termine del rapporto; mentre l’anticresi è il contratto per il quale un debitore consegna il fondo rustico, di cui è proprietario, al creditore, affinché questi ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale. Una volta acquisita la terra, il comodatario e il creditore anticretico si trovano in quella situazione in relazione alla quale l’art. 44 della Costituzione impone di esercitare l’impresa agricola, e questa è la conseguenza del fatto che il diritto di usare la terra si converte nell’obbligo di gestirla produttivamente. Sotto questo profilo, quindi, si può escludere che il comodato (il vero comodato, quello cioè che non prevede alcun obbligo a carico del comodatario) e l’anticresi siano contratti agrari, proprio perchè non sono strumenti di organizzazione dell’attività produttiva (GERMANÒ). 13. La soccida L’art. 2170 c.c. definisce la soccida come il contratto nel quale «il soccidante e il soccidario si associano, per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l’esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l’accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano». Dal dettato normativo si evince che la figura in esame si inquadra nei contratti agrari associativi costitutivi d’impresa, pur avendo ad oggetto non il fondo rustico, bensì il bestiame. Diversa configurazione assumeva la sòccida nel codice civile del 1865, laddove veniva inquadrata come una sottocategoria della locazione. Parti del contratto sono: il soccidante, che è tenuto al conferimento del bestiame; il soccidario, che è tenuto al conferimento della prestazione lavorativa, effettuata eventualmente con la collaborazione dei propri familiari (regolata dalla disciplina di cui all’art. 230bis c.c. sull’impresa familiare) o di terzi estranei, la cui assunzione «deve essere fatta col consenso del soccidante anche quando secondo la convenzione o gli usi la relativa spesa è posta a carico del soccidario» (art. 2173 c.c.). L’art. 2172 c.c., dopo aver fissato la durata minima della soccida in tre anni (ove le parti non abbiano stabilito un termine diverso), ne dispone anche una rinnovazione tacita in mancanza di disdetta di una delle parti. In sintesi, il soccidante attribuisce al soccidario il potere-dovere di curare il bestiame, ma si riserva un potere di direzione dell’impresa che si estrinseca nella facoltà di impartire direttive e di fissare obiettivi di carattere generale. Si distinguono tre tipi di soccida: soccida semplice, nella quale il bestiame viene conferito interamente dal soccidante, che ne conserva la titolarità per tutta la durata del contratto, assumendone il relativo rischio dovuto al perimento o alla diminuzione del valore. Si precisa che il valore del bestiame si modifica in termini reali, in conseguenza, cioè, della variazione del peso e del numero dei capi; soccida parziaria, nella quale il bestiame viene conferito da entrambi i contraenti, con la conseguenza che la titolarità spetta a entrambi, unitamente al rischio del perimento o della diminuzione del valore. In ossequio a tale peculiarità deve ritenersi che il potere di direzione della impresa spetti a ciascuno dei contraenti in proporzione all’entità del conferimento; soccida con conferimento di pascolo, nella quale il soccidante è tenuto a conferire il fondo, mentre il soccidario è tenuto a conferire il bestiame e la propria prestazione lavorativa. Secondo la dottrina prevalente la soccida con conferimento di pascolo si inquadra tra i contratti agrari associativi; secondo altri autori, invece, farebbe parte dei contratti agrari di scambio. L’art. 25 L. 203/1982 ha stabilito la convertibilità in affitto sia delle soccide con conferimento di pascolo che di quelle parziarie quando l’apporto di bestiame da parte del soccidante sia inferiore al 20% del valore dell’intero bestiame conferito. Cause di scioglimento del contratto sono: la disdetta, la risoluzione per inadempimento, l’impossibilità di prosecuzione del rapporto, la morte del soccidario in dipendenza della quale potranno subentrare nella titolarità dell’impresa i chiamati all’eredità in possesso dei requisiti richiesti per la gestione dell’attività (l’accertamento è demandato agli eredi del soccidario). 14. I contratti di organizzazione dell’impresa: caratteristiche Con tale espressione si definiscono i contratti in cui una parte è l’imprenditore agricolo, che addiviene alla stipula per salvaguardare le particolari esigenze della sua impresa. Più precisamente, i contratti di organizzazione sono volti a predisporre tutti i fattori produttivi necessari all’impresa agricola: di qui la loro caratteristica peculiare, ossia l’attinenza della relativa causa alla vita dell’impresa. Diversamente avviene per i contratti costitutivi dell’impresa agraria; questi, infatti, costituiscono ex novo l’impresa e ne regolano l’esercizio, mentre nei contratti di organizzazione l’impresa preesiste o si verrà a costituire indipendentemente dagli stessi. In altre parole, l’impresa penetra nella causa del contratto perché costituisce la ragione fondamentale della tutela accordata dal legislatore ai contratti in esame. Storicamente, i contratti di organizzazione hanno preso il posto dei contratti commerciali, che l’abrogato codice di commercio del 1882 contrapponeva ai contratti civili: i primi si caratterizzavano, infatti, per un elemento soggettivo (una delle parti era un commerciante) e un elemento oggettivo (il perseguimento di uno scopo commerciale ulteriore rispetto a quello tipico del contratto civile). 15. Credito agrario Il credito agrario ha ad oggetto la concessione di finanziamenti bancari, da impiegare nelle «attività agricole e zootecniche» nonché in «quelle ad esse connesse o collaterali» (art. 43 del D.Lgs. 1-9-1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Sono attività connesse o collaterali l’agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti. Il decreto legislativo appena citato costituisce, allo stato, la fonte principale di regolamentazione delle operazioni di credito agrario e, in particolare, della cambiale agraria. L’attuale disciplina ha abrogato la L. 5-7-1928, n. 1760, eliminando ogni distinzione tra credito agrario di esercizio e di miglioramento; inoltre, ha unificato la trattazione del credito agrario e della pesca, vista la sostanziale omogeneità tra i due tipi di finanziamento, recependo quindi le indicazioni del diritto comunitario che include la pesca tra le attività agricole riservandole lo stesso trattamento giuridico. La normativa precedente È opportuno ricordare che la L. n. 1760/1928 distingueva due tipi di finanziamento: il credito agrario di esercizio, consistente in prestiti o anticipazioni destinati tanto alla conduzione dell’azienda (fornitura di concimi, sementi, retribuzione di manodopera straordinaria) quanto all’acquisto delle relative dotazioni (scorte, macchinari, bestiame) erogati a favore di imprenditori individuali o associati. Essendo, pertanto, finalizzata a consentire una normale gestione dell’azienda, questa forma di credito era normalmente a breve termine, coincidente con l’annata agraria (si presumeva, infatti, che tali finanziamenti venissero rimborsati con il ricavato del raccolto). Il credito agrario di esercizio era assistito da un privilegio legale, nel caso di prestiti di conduzione, che aveva ad oggetto i frutti pendenti e quelli raccolti nell’anno di scadenza: ove questi fossero insufficienti il privilegio si trasferiva per la parte residua sui frutti dell’anno successivo. Relativamente ai prestiti di dotazione, oggetto del privilegio erano le cose mobili acquistate con le somme mutuate (ad esempio, macchinari). Era fatta salva la configurabilità di un privilegio convenzionale che, in taluni casi, poteva coesistere con quello legale; il credito agrario di miglioramento, consistente in prestiti o anticipazioni destinati all’incremento della produttività della proprietà agricola: si pensi alle opere di bonifica e irrigazione dei terreni, oppure alla costruzione di fabbricati e impianti destinati all’uso collettivo di più fondi. Essendo finalizzato a dotare l’azienda dei capitali necessari ad eseguire opere di miglioramento dei fondi, questa forma di credito era, normalmente, a medio e lungo termine. 16. Cambiale agraria Essa costituisce, insieme alla cambiale pesca, la forma creditizia più utilizzata: l’art. 43 del D.Lgs. n. 385/1993 ne ha unificato la disciplina che, in epoca antecedente, era contenuta in diverse fonti normative. La cambiale agraria è un titolo di credito all’ordine contenente l’impegno del debitore di pagare una determinata somma ad una scadenza prefissata, come in un normale vaglia cambiario (non assumendo mai la cambiale agraria la forma della tratta). Oltre agli elementi che deve contenere una qualsiasi cambiale, quella agraria deve indicare «lo scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono, nonché il luogo dell’iniziativa finanziata» (lo stesso fondo o il luogo in cui sono custodite le scorte). Dottrina Secondo la dottrina preferibile (PIERI, TRIDICO) e la giurisprudenza della Suprema Corte, la cambiale agraria è una cambiale ordinaria qualificata sia per la sua specifica finalità (realizzare un investimento produttivo a favore dell’impresa agricola), sia per i requisiti ulteriori che presenta (indicazione del luogo e dello scopo del finanziamento), sia per le particolari garanzie (privilegio speciale, garanzia sussidiaria del Fondo interbancario etc.). Altri autori (ASQUINI, MESSINEO, ZAPPULLI), invece, non rilevano alcuna differenza tra le due figure. Secondo la dottrina prevalente (PAVONE LA ROSA, ASQUINI, MOSCHELLI, GERMANI, DE SEMO, TORRENTE, GUALTIERI) è possibile convertire la cambiale agraria in cambiale ordinaria, ai sensi dell’art. 1424 c.c., ove la prima, pur difettando dei requisiti prescritti dalla legge speciale, presenti gli elementi essenziali della seconda. Di avviso opposto sono altri autori (MAROI, DONADIO), che desumono dalla natura causale del titolo la non convertibilità perché nell’emittente mancherebbe la volontà specifica di sottoscrivere una cambiale ordinaria. La cambiale agraria è un titolo: causale: infatti, secondo la dottrina prevalente (DE SEMO, GERMANI), dato lo stretto collegamento tra il prestito agrario e il titolo di credito, le vicende del rapporto sottostante si riverberano sul titolo stesso, con la conseguenza che anche il terzo portatore potrebbe chiedere, ove ne sussistano i presupposti, la risoluzione. Altri autori (PAVONE LA ROSA, ANGELONI, GRECO, MORSILLO, RAGUSA MAGGIORE), invece, ritengono che la cambiale agraria presenti comunque il requisito dell’astrattezza, in quanto contiene l’impegno del debitore di pagare una somma determinata puramente e semplicemente, non essendo questi obbligato ad adempiere le obbligazioni derivanti dal prestito agrario; letterale: infatti, gli elementi essenziali del prestito devono risultare dal titolo, pur potendo essere integrati da ulteriori elementi descrittivi del rapporto di credito sottostante; autonomo: infatti, la concessione del prestito e l’emissione del titolo sono due atti tra loro indipendenti. Le peculiarità della cambiale agraria sono costituite: dallo scopo del finanziamento; dal luogo dell’iniziativa finanziata; dalla scadenza, in quanto la durata dell’apertura di credito non può essere superiore a quella della cambiale che ne è all’origine; delle garanzie che assistono il prestito. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve termine, effettuati mediante utilizzo di cambiale agraria e di cambiale pesca, sono assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili dell’impresa finanziaria: frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione; bestiame, merci, scorte, materie prime e altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso; crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio possono anche essere assistiti dal privilegio previsto dall’articolo 46, avente ad oggetto beni mobili non registrati quali impianti e materie (si parla, in questo caso, di privilegio convenzionale). Il privilegio convenzionale, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell’atto devono essere esattamente descritti i beni e i crediti sui quali il privilegio viene costituito, la banca creditrice, il debitore e il soggetto che ha concesso il privilegio, l’ammontare e le condizioni del finanziamento nonché la somma di denaro per la quale il privilegio viene assunto. La cambiale agraria circola mediante girata, con la conseguenza che l’obbligazione del girante è autonoma nei confronti di quella dell’emittente: parimenti, il regime delle eccezioni è uguale a quello previsto per la cambiale ordinaria. 17. Compravendita di fondo rustico Il modo più usuale per divenire proprietari di beni è quello della loro compravendita. Ciò vale anche con riguardo al fondo rustico: sicché costante è il ricorso all’istituto civilistico del contratto di compravendita (art. 1470 c.c.) da parte di chi, intendendo svolgere imprenditorialmente l’attività di coltivazione del fondo e/o di silvicoltura, inizia con il rifornirsi della terra quale fondamentale fattore dell’azienza agricola che va costituendo. Non vi sono sostanziali diversità di trattamento della compravendita di fondo rustico rispetto allo schema generale del contratto di cui all’art. 1470 c.c. La natura del bene rileva, invece, sotto il profilo fiscale. Il contratto di trasferimento di un fondo rustico a titolo oneroso fruisce di particolari agevolazioni, in vista della finalità, comune ad entrambe le parti, di dare vita ad un’impresa agricola. Il contratto in esame attiene alla fase preparatoria dell’impresa agricola, in quanto preordinato a procurare alla stessa il capitale fondiario per il suo futuro esercizio. È importante sottolineare che alcune leggi speciali hanno disciplinato la concessione di particolari agevolazioni fiscali (esenzione dalle imposte di bollo, riduzione di quelle ipotecarie e di registro, concessione di mutui agevolati etc.) per incentivare l’acquisto di fondi rustici destinati alle imprese agricole. L’imposta di registro dell’atto di acquisto di terreni agricoli, che è pari al 15%, scendeva all’8% se l’acquirente era un imprenditore agricolo a titolo principale (D.P.R. 131/1986), mentre è dovuta in misura fissa e fino al 31 dicembre 2010 (D.L. 194/2009, conv. in L. 25/2010) se l’acquirente è coltivatore diretto o se l’imprenditore agricolo professionale è iscritto nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale e se il fondo acquistato è idoneo alla formazione o all’arrotondamento della proprietà coltivatrice. E poiché l’imprenditore agricolo professionale è equiparato al coltivatore diretto per le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta, l’imposta di registro sugli atti di acquisto di terreni idonei alla formazione o all’arrotondamento della proprietà coltivatrice è dovuta in misura fissa anche quando l’acquirente è un imprenditore agricolo professionale. In ogni caso, tali agevolazioni si perdono se l’acquirente rivende il fondo prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto. 18. Contratti di integrazione verticale: i contratti agro-industriali Le associazioni di produttori agricoli possono stipulare, con le contrapposte organizzazioni professionali degli industriali o dei commercianti alimentari, degli accordi economici, ossia contratti normativi che rientrano nella categoria dei contratti collettivi, i quali, però, anziché intercorrere tra rappresentanti dei datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori, vengono posti in essere da organizzazioni professionali di contrapposte categorie (GERMANÒ). Il D.Lgs. 102/2005 prevede che gli organismi maggiormente rappresentativi nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro stipulano, nell’ambito del Tavolo agroalimentare istituito presso il MIPAAF dal D.Lgs. 228/2001, le cd. intese di filiera. Con esse, agricoltori, industriali e distributori di alimenti provvedono a definire, tenendo conto dell’intero percorso della filiera, le azioni: per migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato; per valorizzare e tutelare le DOP e le IGP e i marchi di qualità; per valorizzare il legame delle produzioni al territorio di provenienza; per suggerire metodi di produzione rispettosi dell’ambiente; per stilare schemi contrattuali, compatibili con la normativa comunitaria, che serviranno come modello per i successivi passaggi dell’integrazione agro-industriale. Sulla base delle intese di filiera, le organizzazioni rappresentative del settore agricolo da un lato — le associazioni di produttori — e degli altri settori agro-alimentari, dall’altro, concludono contratti quadro, con cui disciplinano la quantità e la qualità della produzione agricola per equilibrare l’offerta alla domanda, prestabilendo i criteri e le condizioni della produzione e della vendita dei prodotti e il prezzo del loro ritiro da parte di industriali e commercianti. Nell’ambito di questo accordo economico, i singoli agricoltori e i singoli industriali o commercianti stipulano poi, per iscritto, i propri contratti individuali che prendono il nome di contratti di coltivazione, allevamento e fornitura e che, per il fatto di coinvolgere agricoltori e industriali, sono detti contratti agro-industriali. I contratti di coltivazione, allevamento, e fornitura sono diventati contratti tipici e nominati, visto che l’ordinamento ne detta una disciplina compiuta attraverso la tecnica legislativa di diretta regolamentazione (artt. 12-14, D.Lgs. 102/2005) combinata ad una tecnica legislativa di rinvio ai contratti quadro quale fonte normativa di secondo grado. Il legislatore, quindi, ha creato un nuovo schema contrattuale caratterizzato dal contemperamento degli opposti interessi e dal riequilibrio delle posizioni delle parti. Il regolamento del contratto di coltivazione, allevamento e fornitura è costruito attorno ad una «garanzia reciproca di fornitura», ovvero all’obbligo dell’imprenditore agricolo di trasferire, in cambio di un prezzo predeterminato, la proprietà di tutta la produzione al momento della raccolta dei frutti, dopo aver seguito, nello svolgimento dell’attività, determinate tecniche di coltivazione e di allevamento, al fine di realizzare quella standardizzazione qualitativa dei prodotti su cui conta la controparte industriale o commerciale. Segue poi l’obbligo dell’imprenditore industriale e/o commerciale di ritirare tutta la produzione oggetto del contratto e di pagarne il prezzo prefissato in base ai contratti quadro, dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti qualitativi concordati. In questo modo si è dato vita ad un contratto con cui si consegue l’integrazione economica delle imprese di entrambe le parti, in quanto da un lato l’imprenditore non agricolo si assicura, nei tempi a lui opportuni e con le qualità desiderate, i prodotti necessari per la sua attività e, dall’altro, l’imprenditore agricolo può confidare nell’allocazione certa dell’intera sua produzione. Visto che l’agricoltore si assicura l’allocazione della sua produzione ad un prezzo stabilito, il contratto agro-industriale viene a far parte degli elementi dell’azienda agraria per l’utilitas che esso, all’interno dell’organismo aziendale, presenta: infatti, essendosi in tal modo garantita la commercializzazione della produzione, tale contratto è volto a contenere il rischio dell’impresa agricola di non trovare acquirenti per i propri prodotti (GERMANÒ). Questionario 1. Come si distinguono i contratti agrari? (par. 1) 2. Quali sono le caratteristiche comuni dei contratti agrari? (par. 2) 3. Quali sono le differenze tra la locazione e l’affitto? (par. 4) 4. Cosa prevede l’art. 45 della L. 203/1982 in materia di patti in deroga? (par. 4) 5. Quali sono le principali obbligazioni a carico del concedente? (par. 5) 6. Quali sono i poteri dell’affittuario e del concedente che scaturiscono dall’affitto? (par. 6) 7. Qual è la disciplina dei miglioramenti fondiari? (par. 6) 8. Quali sono le cause di risoluzione del contratto agrario? (par. 7) 9. In cosa consiste il diritto di ritenzione? (par. 7) 10. Quali sono le differenze tra contratto di affitto di fondo rustico e contratto di affitto di azienda agricola? (par. 7) 11. I contratti per colture stagionali sono soggetti alla disciplina dell’affitto di fondi rustici? (par. 10) 12. In cosa consistono i contratti di mezzadria e colonia? (par. 11) 13. Quanti tipi di soccida esistono? (par. 13) 14. In cosa consiste il credito agrario? (par. 15) 15. Quali elementi devono essere indicati nella cambiale agraria? (par. 16) 16. Quali sono le peculiarità del contratto di compravendita di fondo rustico? (par. 17) 17. Che cosa sono i contratti agro-industriali? (par. 18) Capitolo 7 I rapporti con la Pubblica Amministrazione Sommario 1. Generalità. - 2. I contratti di collaborazione. - 3. I contratti di promozione. - 4. Le convenzioni. 1. Generalità Con la «legge di orientamento» (D.Lgs. n. 228/2001), il legislatore nazionale ha cercato di recepire nell’ordinamento italiano il concetto di multifunzionalità attraverso una riscrittura dell’articolo 2135 c.c. Tra le attività dirette alla fornitura di beni o servizi esercitabili dall’imprenditore agricolo, nell’esplicare la vocazione multifunzionale dell’impresa agricola, gli articoli 14 e 15 della legge di orientamento disciplinano nuovi strumenti convenzionali di governo dell’agricoltura (BRUNO), con l’obiettivo di individuare nell’imprenditore agricolo il partner privilegiato per la fornitura di servizi «ambientali» e l’esecuzione di lavori di manutenzione del territorio. Essi sono: i contratti di collaborazione tra imprenditori agricoli e pubblica amministrazione per la «promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali» (art. 14, co. 1); i contratti di promozione tra imprenditori agricoli e pubblica amministrazione nei quali, in cambio di aiuti l’agricoltore si impegna «nell’esercizio dell’attività di impresa ad assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale» (art. 14, co. 3); le convenzioni tra pubblica amministrazione e imprenditore agricolo «al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell’assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio» (art. 15, co. 1). Come risulta dalla relazione che accompagna il testo approvato dal Consiglio dei Ministri, l’inserimento di tali disposizioni è diretto ad ottemperare ai principi e criteri direttivi della legge delega per quanto attiene alla multifunzionalità ed alla pluriattività delle aziende agricole. 2. I contratti di collaborazione Gli accordi di collaborazione hanno la finalità di assicurare il sostegno e lo sviluppo dell’imprenditoria agricola locale anche attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di qualità. I primi commentatori del D.Lgs. 228/2001 hanno osservato che non è facilmente desumibile dal testo cosa sia un contratto di collaborazione (BRUNO). La fattispecie di cui all’art. 14, infatti, presenta una marcata componente contrattualistica inserita all’interno di quella che altro non è se non una misura di sostegno e di incentivo per il settore agricolo. Detti contratti paiono assumere un particolare ruolo in rapporto all’istituzione, prevista dall’art. 13 dello stesso decreto, dei distretti rurali e agroalimentari. I distretti rurali, in base al primo comma, sono quei «sistemi produttivi locali … caratterizzati da un’identità storica e territoriale omogenea derivante dall’integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali». Sono invece distretti agroalimentari «di qualità i sistemi produttivi locali, anche se a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole ed agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale, oppure da produzioni tradizionali tipiche». I distretti sono individuati dalle Regioni. Si crea perciò un collegamento tra imprese agricole, pubblica amministrazione, industria agroalimentare allo scopo di «tutela economica ed ecologica» di un determinato territorio. In tale progetto si inseriscono i contratti di collaborazione, con i quali la pubblica amministrazione concorda con gli imprenditori agricoli un programma di gestione di un determinato territorio, prevedendo investimenti finalizzati al perseguimento di determinati obiettivi di pubblico interesse e di promozione dei prodotti locali. Gli accordi così sottoscritti parrebbero rientrare nell’ambito degli accordi procedimentali di cui all’art. 11 della L. 241/1990 (modificata dalla L. 11-2-2005, n. 15). 3. I contratti di promozione Ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D.Lgs. 228/2001, gli agricoltori possono concludere con la pubblica amministrazione contratti di promozione impegnandosi, nell’esercizio dell’impresa, ad assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità e del patrimonio paesaggisticoculturale agrario e forestale. L’amministrazione pubblica può erogare aiuti (ancora una volta si tratta di forme di sostegno all’attività agricola) «al fine di assicurare un’adeguata informazione ai consumatori e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima e della peculiarità delle produzioni», in cambio dell’impegno a svolgere un servizio per le collettività, nell’esercizio dell’attività d’impresa. Il legislatore ha dunque ritenuto che il solo esercitare un’attività d’impresa quale quella agricola possa produrre un servizio di interesse pubblico. In questi contratti l’attività del privato deve comunque volgersi ad un miglioramento ambientale-territoriale. 4. Le convenzioni L’art. 15 del D.Lgs. 228/2001 introduce le convenzioni tra pubblica amministrazione e imprenditore agricolo, il quale si impegna a mantenere il territorio, a salvaguardare il paesaggio agrario e forestale, a curare l’assetto idrogeologico ed a promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio in cambio di «finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche». A differenza di quanto avviene nei contratti di promozione, ove l’utilità collettiva scaturisce dal solo compimento dell’attività imprenditoriale, nelle convenzioni la prestazione dell’imprenditore agricolo consiste in un quid collegato all’attività agricola principale, secondo il criterio di connessione di cui all’art. 2135 c.c. L’art. 15 stabilisce, inoltre, che la pubblica amministrazione possa stipulare «contratti d’appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata»; parrebbe che, attraverso tale previsione, si sia voluto esonerare l’imprenditore agricolo che si impegna alla costruzione di un’opera pubblica collegata alla gestione del territorio, dalla procedura di formazione del contratto prevista nella legge quadro sui lavori pubblici (BRUNO). Questionario 1. Qual è lo scopo dei contratti di collaborazione? (par. 2) 2. In cosa consistono i contratti di promozione? (par. 3) 3. Quali sono le differenze tra contratti di promozione e convenzioni? (par. 4) Capitolo 8 Ambiente e territorio Sommario 1. L’ambiente. - 2. La tutela del suolo dall’inquinamento di fonte agricola. - 3.Vas, Via e gestione dei rifiuti. - 4. Tutela delle acque dall’inquinamento di fonte agricola. - 5. La multifunzionalità dell’esercizio razionale dell’agricoltura. 1. L’ambiente Importante è il rapporto dell’agricoltura con l’ambiente. Il concetto di ambiente è spesso impiegato nel linguaggio comune secondo un’accezione generica e metagiuridica, per indicare una serie di fenomeni e di contesti, sia naturali sia frutto della continua azione umana di trasformazione del territorio, estremamente eterogenei e non suscettibili di reductio ad unum. Nell’accezione comune di ambiente rientrano entità quali l’aria, l’acqua, la flora, la fauna, il suolo, le bellezze naturali, oggetto di tutele giuridiche diverse, il cui comune denominatore è rappresentato dalla qualità della vita. Solo la qualità della vita, infatti, strettamente connessa a tutte le esigenze di salvaguardia ambientale, rende possibile la corrispondenza tra tutela della salute umana e tutela dell’ambiente. La maggioranza della dottrina italiana, facendo ricorso a diverse pronunce della Corte costituzionale, ritiene che l’ambiente rappresenti un valore, sia come obiettivo dell’azione delle pubbliche autorità, sia come dovere di solidarietà per tutti gli appartenenti all’Ordinamento. Il legislatore italiano, solo con la riforma introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha inserito nella Carta Costituzionale il termine ambiente. L’art. 117 Cost., infatti, indica la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali tra le materia di competenza esclusiva dello Stato, ma non è presente una definizione giuridica del concetto. Anche nel D.Lgs. 152/2006 (Codice ambientale) è possibile rintracciare il concetto di ambiente solo attraverso la lettura di alcuni articoli che vi fanno riferimento indirettamente. Così, ad esempio, l’art. 5, nel dare la definizione di impatto ambientale, quale alterazione dell’ambiente in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani, programmi o progetti, o di malfunzionamenti, intende quest’ultimo come «sistema di relazioni tra fattori antropici, naturalistici, chimicofisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici». La tutela dell’ambiente nella normativa europea A livello comunitario l’Atto Unico Europeo ha segnato l’inizio di una svolta relativamente alle basi giuridiche della Comunità in materia di salute, ambiente e protezione dei consumatori. Per quanto riguarda l’ambiente, dopo il Trattato di Lisbona abbiamo: l’art. 11 TFUE, secondo il quale «Le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile»; ai sensi dell’art. 4 TFUE, l’ambiente è inserito tra le materie di competenza concorrente tra UE e Stati membri; gli artt. da 191 a 193 TFUE disciplinano la politica dell’UE in materia ambientale. Dalle disposizioni-base dell’Unione Europea in materia ambientale si ricavano alcuni principi fondamentali: il primo è quello secondo cui nell’attuazione delle politiche comunitarie occorre perseguire l’obiettivo di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche; il principio dell’azione preventiva, secondo cui è necessario predisporre tutte le misure volte a prevenire eventi nocivi per l’ambiente; il principio della correzione dei danni ambientali, intervenendo prioritariamente sulla fonte di essi (i danni ambientali vanno contrastati il più presto possibile per evitare che i loro effetti si moltiplichino); il principio della precauzione, che prevede che laddove sussista una minaccia ad uno degli interessi tutelati dall’art. 191 TFUE, siano adottate misure appropriate per impedire che questa si concretizzi. In assenza di una definizione nel Trattato o in altri testi europei, il principio in esame è stato analizzato in un’apposita comunicazione emessa dalla Commissione il 2 febbraio 2000, secondo la quale esso può essere invocato quando gli effetti potenzialmente pericolosi di un fenomeno, di un prodotto o di un processo sono stati identificati tramite una valutazione scientifica e obiettiva che, però, non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza. La tutela dell’ambiente non rientra tra le materie di competenza esclusiva dell’Unione, ma in quelle di competenza concorrente (art. 4, lett. e del TFUE), per cui l’Unione interviene solo quando gli obiettivi dell’azione prevista a sua tutela non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri o possono esserlo meglio a livello europeo. 2. La tutela del suolo dall’inquinamento di fonte agricola Come l’esercizio delle attività industriali, anche l’esercizio dell’attività agricola può produrre inquinamento, e ciò per l’uso di concimi chimici, di fitofarmaci, per la dispersione delle deiezioni degli animali allevati e per lo smaltimento dei rifiuti delle attività di trasformazione dei prodotti agricoli. Nell’azienda agricola, però, a differenza dell’industria, vi è una regola della natura che l’agricoltore deve tenere in considerazione, e cioè che l’abuso di fertilizzanti, producendo la deumidificazione del suolo e la desertificazione, annulla qualsiasi vantaggio di produzione con danno dell’azienda stessa. Ciò è stato provocato, nel tempo, anche dalla superproduzione agricola. Il sistema comunitario dei prezzi di intervento, garantendo agli agricoltori la riscossione di un prezzo per tutta la produzione ritirata dagli organismi a ciò preposti, li ha portati a coltivare intensamente i propri fondi per poter realizzare quei prodotti agricoli assistiti dall’intervento, ad intensificare la concimazione con mezzi artificiali e ad abbandonare sempre più la concimazione naturale e il sistema del maggese, cioè il riposo del terreno per consentirgli di recuperare la fertilità naturale esaurita. Inoltre, la ricerca di ricavi sempre maggiori con minori costi ha portato all’utilizzo di macchine sempre più grandi che richiedono appezzamenti estesi, pianeggianti e regolari, con conseguente eliminazione di siepi, boschi e stagni, così come l’esigenza di garantire la produzione dalle malattie, dai parassiti e dalle erbe infestanti ha portato all’uso crescente di insetticidi ed erbicidi. L’aumento della produzione, quindi, si è combinato necessariamente con il problema dell’inquinamento delle falde acquifere, della deumidificazione e desertificazione del terreno e, in generale, con i danni al paesaggio agrario e alla salute umana. La Pac, pertanto, è orientata alla tutela dell’ambiente nel suo realizzarsi. Molteplici sono le interrelazioni tra agricoltura e ambiente contenute nel Regolamento UE n. 1307/2013 in tema di pagamenti diretti agli agricoltori: a partire dalla definizione di attività agricola e al c.d. pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente (c.d. greening). Il Reg. (UE) n. 1306/2013 contiene la disciplina in tema di condizionalità che impone agli agricoltori che ricevono gli aiuti comunitari il rispetto di alcune condizioni (cd. criteri di gestione obbligatori) in materia di protezione ambientale, sanità pubblica, biodiversità, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e regole per l’uso sostenibile dei terreni agricoli, pena la riduzione o l’annullamento degli aiuti finanziari. Quanto al Reg. (UE) n. 1305/2013 sullo sviluppo rurale, l’attenzione è ancora maggiore, rintracciabile negli obiettivi e, dopo, nelle priorità, tra cui la tutela, il ripristino e la valorizzazione degli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura, nonché l’incentivazione dell’uso efficiente delle risorse e il passaggio ad un’economia a basse emissioni di carbonio e resilente al clima nel settore agroalimentare e forestale. 3. Vas, via e gestione dei rifiuti Alcune opere di organizzazione dell’azienda agraria potrebbero rappresentare modifiche territoriali e/o colturali di tale ampiezza da avere gravi impatti ambientali. Per questo, la direttiva 2001/42/CE, che ha introdotto la VAS, ha previsto che, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, non solo sia elaborato un procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) dell’impatto sull’ambiente dei piani o dei programmi concernenti i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, della gestione dei rifiuti e delle acque, della destinazione dei suoli, ma anche che siano sottoposti ad un’apposita procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA). Secondo la definizione contenuta nell’art. 5 del Codice ambientale, per valutazione di impatto ambientale si intende il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull’ambiente di un progetto. La finalità generale della VIA (come della VAS) è quella di assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica. Per mezzo di essa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione. Un altro problema è quello relativo alla gestione dei rifiuti. Secondo l’art. 183 del nostro Codice ambientale, per «rifiuto» si intende qualsiasi sostanza od oggetto il cui detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi. A norma dell’art. 184 del Codice ambientale, i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali. Tra i rifiuti speciali sono annoverati, appunto, i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c. Sono esclusi, però, dalla disciplina in materia di gestione dei rifiuti le materie fecali, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana. Sono esclusi, ancora, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: le acque di scarico; i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio; le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione (art. 185 del Codice ambientale). Le aziende agricole, a differenza di quelle commerciali, hanno la possibilità di riutilizzare i propri rifiuti come fertilizzanti, concimi e ammendanti. La concreta possibilità di riciclo di quasi tutti i rifiuti prodotti dall’impresa agricola si inserisce perfettamente nel quadro dei principi ispiratori della normativa comunitaria sui rifiuti che è indirizzata a favorire il loro autosmaltimento ad opera dello stesso imprenditore, divenendo così la gestione dei rifiuti parte integrante della stessa attività imprenditoriale (GERMANÒ). Dal momento che queste operazioni di autosmaltimento non prevedono obblighi di autorizzazione, ma talvolta di sola comunicazione, si può concludere che è meno pesante per gli agricoltori il regime per essi dettato in tema di misure di eliminazione dei rifiuti. Nel nostro ordinamento, un trattamento privilegiato era previsto, a favore degli imprenditori agricoli, in tema di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi e di comunicazione al catasto rifiuti. L’esonero era stato prima abrogato, poi reintrodotto e alla fine trasfuso nell’art. 193 del Codice ambientale, che prevede la non applicazione della disciplina relativa ai formulari di identificazione ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri (art. 193, co. 5, Codice ambientale). 4. Tutela delle acque dall’inquinamento di fonte agricola Il legislatore fa una distinzione tra acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali e acque reflue scaricate da insediamenti residenziali e derivanti dal metabolismo umano e da attività domestiche. Il Codice ambientale, infatti, all’art. 74 distingue tra acque reflue industriali e acque reflue domestiche ed equipara alle seconde, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, le acque reflue provenienti: da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura; da imprese dedite ad allevamento di bestiame; da imprese dedite alla coltivazione del terreno, silvicoltura e allevamento di bestiame che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità; da impianti di acquacoltura e piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio d’acqua o in cui venga utilizzata una portata d’acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo (art. 101, co. 7 del Codice ambientale). In altre parole, le acque provenienti da tutte le attività, che per l’art. 2135 c.c. sono definibili agricole, sono parificate alle acque reflue domestiche, purché l’attività si svolga sul fondo o con i prodotti prevalenti del fondo o possa utilizzare, sia pure secondo determinati parametri, un terreno agricolo o uno specchio d’acqua. La rilevanza dell’inserimento delle imprese agricole nella categoria delle imprese che danno luogo a scarichi di acque reflue parificate a quelle domestiche è data dal fatto che gli obblighi, cui gli edifici residenziali sono soggetti, sono attenuati rispetto agli obblighi gravanti sugli stabilimenti produttivi. Tutti gli scarichi – ovvero qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante – sono soggetti ad autorizzazione; ma per gli scarichi di acque reflue domestiche – e quindi per le acque reflue provenienti dalle aziende agricole – il regime autorizzatorio è definito dalle Regioni nell’ambito della disciplina generale degli scarichi e con condizioni attenuate rispetto a quelle occorrenti per l’autorizzazione degli scarichi di acque reflue industriali. Inoltre, mentre la condotta contra legem degli imprenditori industriali è, di regola, sanzionata penalmente, quella degli imprenditori agricoli è punita, di regola, con sanzioni amministrative. 5. La multifunzionalità dell’esercizio razionale dell’agricoltura Il cultore del diritto dell’agricoltura attribuisce alla terra, oggetto di attività agricola, non solo un ruolo produttivo, ma anche una funzione conservatrice e tutelatrice dell’ambiente (GERMANÒ) ed è cosciente del fatto che, così come una dissennata politica agricola potrebbe causare seri danni all’ambiente, anche la non-utilizzazione del bene terra provoca degrado ambientale. L’uso produttivo della terra, quindi, imposto dagli articoli 41 e 44 Cost., si manifesta come uso produttivo e come uso conservativo. Basta soffermarci sul significato dell’espressione «razionale sfruttamento del suolo», dettato dal legislatore all’art. 44 Cost., per dedurre che la terra svolge, con il proprio ciclo vegetale, la funzione di assicurare all’uomo alimenti essenziali alla sua vita, esigendo però una sorta di autoconservazione affinché non si interrompa la catena delle risorse rinnovabili. La conseguenza è che, in sostanza, l’Ordinamento riconosce alla terra funzioni che obbligano il titolare del diritto all’utilizzazione della stessa. Ma, se per produrre è necessario conservare, produrre vuol dire anche conservare. Occorre, quindi, prendere consapevolezza che la razionale coltura della terra e del bosco comporta anche salvaguardia dell’ecosistema e, in quanto tale, costituisce una premessa indispensabile alla tutela della salute e della vita. Oggi si parla, infatti, di multifunzionalità dell’agricoltura (GERMANÒ). Un’agricoltura razionale, il cui esercizio consente non solo la produzione di alimenti, ma anche il mantenimento degli elementi che caratterizzano gli equilibri ambientali con i quali essa interagisce, è un’agricoltura ecocompatibile. Questionario 1. A chi spetta, nel nostro ordinamento, la competenza in materia di tutela ambientale? (par. 1) 2. Che cosa prevede il principio di precauzione? (par. 1) 3. Cosa si intende per VIA? (par. 3) 4. Cosa prevede la normativa in materia di gestione dei rifiuti derivanti da attività agricole? (par. 3) 5. A cosa sono equiparate le acque reflue derivanti dall’esercizio delle attività agricole? (par. 4)