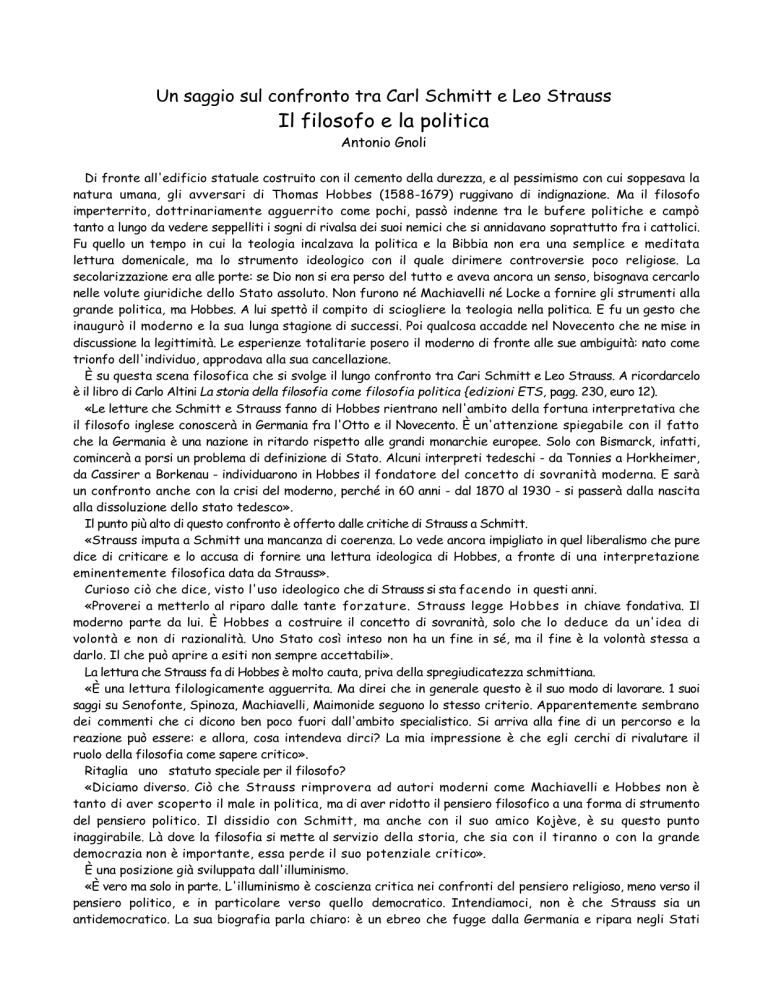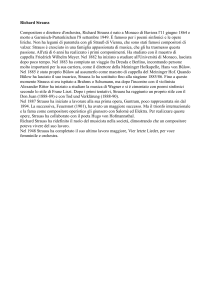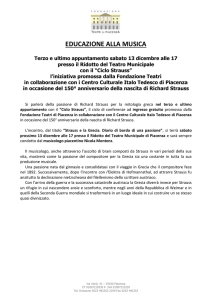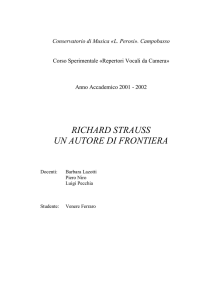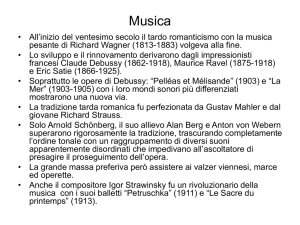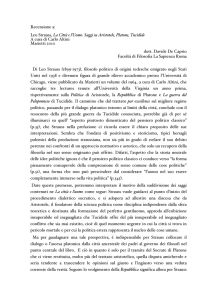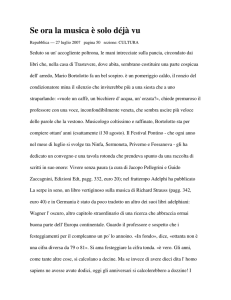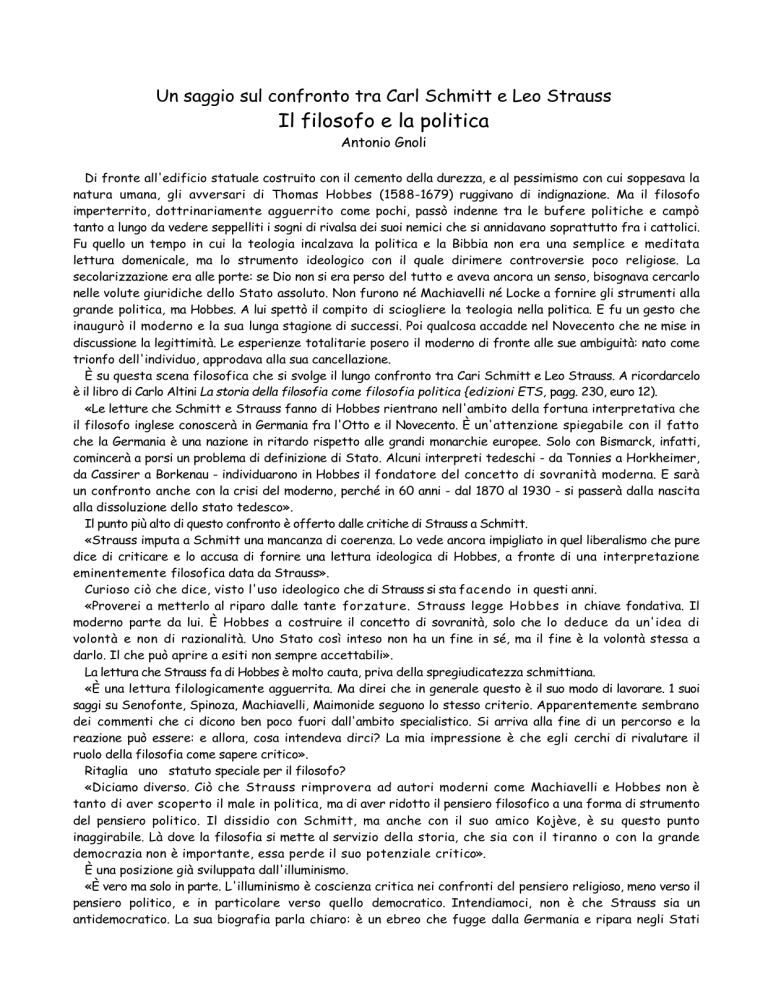
Un saggio sul confronto tra Carl Schmitt e Leo Strauss
Il filosofo e la politica
Antonio Gnoli
Di fronte all'edificio statuale costruito con il cemento della durezza, e al pessimismo con cui soppesava la
natura umana, gli avversari di Thomas Hobbes (1588-1679) ruggivano di indignazione. Ma il filosofo
imperterrito, dottrinariamente agguerrito come pochi, passò indenne tra le bufere politiche e campò
tanto a lungo da vedere seppelliti i sogni di rivalsa dei suoi nemici che si annidavano soprattutto fra i cattolici.
Fu quello un tempo in cui la teologia incalzava la politica e la Bibbia non era una semplice e meditata
lettura domenicale, ma lo strumento ideologico con il quale dirimere controversie poco religiose. La
secolarizzazione era alle porte: se Dio non si era perso del tutto e aveva ancora un senso, bisognava cercarlo
nelle volute giuridiche dello Stato assoluto. Non furono né Machiavelli né Locke a fornire gli strumenti alla
grande politica, ma Hobbes. A lui spettò il compito di sciogliere la teologia nella politica. E fu un gesto che
inaugurò il moderno e la sua lunga stagione di successi. Poi qualcosa accadde nel Novecento che ne mise in
discussione la legittimità. Le esperienze totalitarie posero il moderno di fronte alle sue ambiguità: nato come
trionfo dell'individuo, approdava alla sua cancellazione.
È su questa scena filosofica che si svolge il lungo confronto tra Cari Schmitt e Leo Strauss. A ricordarcelo
è il libro di Carlo Altini La storia della filosofia come filosofia politica {edizioni ETS, pagg. 230, euro 12).
«Le letture che Schmitt e Strauss fanno di Hobbes rientrano nell'ambito della fortuna interpretativa che
il filosofo inglese conoscerà in Germania fra l'Otto e il Novecento. È un'attenzione spiegabile con il fatto
che la Germania è una nazione in ritardo rispetto alle grandi monarchie europee. Solo con Bismarck, infatti,
comincerà a porsi un problema di definizione di Stato. Alcuni interpreti tedeschi - da Tonnies a Horkheimer,
da Cassirer a Borkenau - individuarono in Hobbes il fondatore del concetto di sovranità moderna. E sarà
un confronto anche con la crisi del moderno, perché in 60 anni - dal 1870 al 1930 - si passerà dalla nascita
alla dissoluzione dello stato tedesco».
Il punto più alto di questo confronto è offerto dalle critiche di Strauss a Schmitt.
«Strauss imputa a Schmitt una mancanza di coerenza. Lo vede ancora impigliato in quel liberalismo che pure
dice di criticare e lo accusa di fornire una lettura ideologica di Hobbes, a fronte di una interpretazione
eminentemente filosofica data da Strauss».
Curioso ciò che dice, visto l'uso ideologico che di Strauss si sta facendo in questi anni.
«Proverei a metterlo al riparo dalle tante forzature. Strauss legge Hobbes in chiave fondativa. Il
moderno parte da lui. È Hobbes a costruire il concetto di sovranità, solo che lo deduce da un'idea di
volontà e non di razionalità. Uno Stato così inteso non ha un fine in sé, ma il fine è la volontà stessa a
darlo. Il che può aprire a esiti non sempre accettabili».
La lettura che Strauss fa di Hobbes è molto cauta, priva della spregiudicatezza schmittiana.
«È una lettura filologicamente agguerrita. Ma direi che in generale questo è il suo modo di lavorare. 1 suoi
saggi su Senofonte, Spinoza, Machiavelli, Maimonide seguono lo stesso criterio. Apparentemente sembrano
dei commenti che ci dicono ben poco fuori dall'ambito specialistico. Si arriva alla fine di un percorso e la
reazione può essere: e allora, cosa intendeva dirci? La mia impressione è che egli cerchi di rivalutare il
ruolo della filosofia come sapere critico».
Ritaglia uno statuto speciale per il filosofo?
«Diciamo diverso. Ciò che Strauss rimprovera ad autori moderni come Machiavelli e Hobbes non è
tanto di aver scoperto il male in politica, ma di aver ridotto il pensiero filosofico a una forma di strumento
del pensiero politico. Il dissidio con Schmitt, ma anche con il suo amico Kojève, è su questo punto
inaggirabile. Là dove la filosofia si mette al servizio della storia, che sia con il tiranno o con la grande
democrazia non è importante, essa perde il suo potenziale critico».
È una posizione già sviluppata dall'illuminismo.
«È vero ma solo in parte. L'illuminismo è coscienza critica nei confronti del pensiero religioso, meno verso il
pensiero politico, e in particolare verso quello democratico. Intendiamoci, non è che Strauss sia un
antidemocratico. La sua biografia parla chiaro: è un ebreo che fugge dalla Germania e ripara negli Stati
Uniti. Politicamente è un conservatore, un moderato. Il problema che a lui preme sottolineare è la mancata
attenzione da parte del pensiero filosofico ai miti fondativi della società politica, e fra i miti fondativi egli ve
de anche la democrazia e il liberalismo».
Quando si dice miti fondativi, si parla di qualcosa che è ineliminabile dalla politica. Quella di Strauss non
rischia allora di essere una battaglia inutile?
«Egli era perfettamente consapevole che un confronto del genere non dovesse neppure incominciare. La
politica, ai suoi occhi, insieme alla religione, alla credenza e al costume, stabilisce i piani della nostra vita
quotidiana. E ha una caratteristica che è del tutto estranea alla filosofia».
L'irrazionalità?
«Direi piuttosto l'appartenenza, l'essere qui e ora. Il problema che si pone Strauss non è tanto quello di
criticare le forme dell'esistente, sempre e comunque. Ma di avvertirci che anche la democrazia, che è un
bene che va conservato, non è una forma di conoscenza assoluta, poiché se analizziamo le sue origini,
attraverso la riflessione di Hobbes, Locke e Spinoza, vediamo che quell'origine non è scientificamente
fondata».
Di qui il ricorso al pensiero antico e al tema della verità.
«Con un avvertenza: Strauss è interessato solo marginalmente al tema della polis. Ciò che gli preme è la
forma del pensiero filosofico che si stabilisce. E quella forma ai suoi occhi vuoi dire soprattutto una rilettura
di Platone più che di Aristotele. Ma non il Platone teorico delle idee, ma quello della dialettica. Non a caso
apprezzerà il moderato scetticismo di Socrate che distrugge le credenze empiriche, e accetta le opinioni
comuni solo per metterle in contraddizione, mostrandone l'infondatezza».
È una battaglia che la filosofia ha spesso intrapreso.
«Occorre combatterla, ma Strauss sa che è perdente. E non è casuale che proprio su questo punto si
inserisce il tema della scrittura reticente».
La conseguenza è che di filosofia si devono occupare in pochi.
«Lui sostiene che esiste una pluralità di tipi umani e che la tipologia del filosofo si costituisce come
gruppo separato. È una sorta di straniero in patria. Il ricorso alla scrittura reticente, da questo punto di
vista, è necessario per proteggersi sia da forme di persecuzione intellettuale che materiale».
Che conseguenze presenta un'opzione filosofica di questo tipo?
«Quella più vistosa è aver creato piccole sette che elaborano ed esercitano conoscenze separate dal
resto della società. Ora finché sei un gruppo che pratica discipline orientali non dai fastidio a nessuno. Ma
se il tuo agire si intreccia con la grande politica, la cosa rischia di farsi preoccupante».
E questo è accaduto con Strauss?
«E accaduto soprattutto attraverso i suoi allievi più vicini, in particolare Allan Boom. La nostra società è
basata sulla rilevanza della sfera pubblica. Se un filosofo maschera in modo pressoché totale le proprie
opinioni politiche, è chiaro che la sfera pubblica perde la propria essenza di luogo del libero scambio di
idee».
Strauss, o un suo allievo, obietterebbero che immaginare la sfera pubblica come lo spazio trasparente in cui si
incontrano e si confrontano le opinioni è l'ennesimo mito fondativo.
«Ma sarebbe un'obiezione machiavellica del ruolo del filosofo nella società. La verità è che Strauss non ha
mai giustificato la menzogna politica detta o avallata dal filosofo. Lui ha solo sostenuto che il filosofo deve
essere cauto in ciò che dice. Perché la nostra vita è fatta molto più di credenze che di conoscenze».
Che rapporto ebbe con la democrazia americana?
«Le fu grato. Ma da conservatore non gli piaceva il dominio della cultura di massa, gli esiti propagandistici
che essa conteneva. Di fronte a un conflitto come quello che si sta combattendo fra una parte
dell'Occidente e l'Iraq, non avrebbe condiviso l'asserzione islamica che tutto va ricondotto sotto la legge
coranica. Ma non avrebbe neppure accettato l'idea che la democrazia si esporta. La lezione che ci ha
lasciato è di un radicalismo filosofico per certi versi simile a quello di Heidegger». Traduca. «Siamo in
qualche modo preda del nichilismo, ma è una questione che deve riguardare solo i filosofi, giacché il
filosofo nei riguardi della vita civile non può essere un radicale».
Ma può diventare il consigliere del principe?
«Strauss non era dell'idea che il principe avesse bisogno di un consigliere filosofo. Ciò non esclude che in casi
particolarmente felici questo possa essere accaduto».
Alcuni allievi hanno accreditato una lettura diversa del maestro.
«Questo è normale. Lo è meno essersene serviti utilizzando la teoria della reticenza per far
convergere la religione sulla politica. Strauss intuiva il pericolo di certe posizioni. Il suo saggio dedicato ad
Al Faharabi vedeva il filosofo come il nemico potenziale del politico».
la repubblica 24 marzo 2005